Tutte le opere. Edizioni integrali con testo latino a fronte 9788854159648
Seneca fu un miscuglio di idealità e di realismo. Affascinato dalla morale stoica, la piegò alle esigenze della vita pra
2,234 481 10MB
Italian Pages 2222 Year 2015
Polecaj historie
Table of contents :
Indice......Page 2219
Frontespizio......Page 5
Introduzione generale......Page 6
Bibliografia......Page 11
Nota alle traduzioni......Page 18
Dialoghi......Page 20
Premessa......Page 21
Consolatio ad Marciam......Page 26
Consolazione a Marcia......Page 45
Liber primus......Page 71
Liber secundus......Page 83
Liber tertius......Page 101
L’arte di non adirarsi......Page 124
Libro primo......Page 125
Libro secondo......Page 142
Libro terzo......Page 165
Consolatio ad Helviam matrem......Page 197
Consolazione alla madre Elvia......Page 212
Consolatio ad Polybium......Page 233
Consolazione a Polibio......Page 246
De brevitate vitae......Page 262
Come vivere a lungo......Page 276
De constantia sapientis......Page 296
La fermezza del saggio......Page 308
De vita beata......Page 326
La felicità......Page 342
De tranquillitate animi......Page 366
La serenità......Page 383
De otio......Page 409
L’ozio o della contemplazione......Page 414
De providentia......Page 422
La provvidenza......Page 431
Lettere a Lucilio e altre opere......Page 445
Liber primus......Page 446
Liber secundus......Page 460
Liber tertius......Page 474
Liber quartus......Page 486
Liber quintus......Page 498
Liber sextus......Page 512
Liber septimus......Page 527
Liber octavus......Page 543
Liber nonus......Page 558
Liber decimus......Page 574
Liber undecimus......Page 585
Liber quartus decimus......Page 605
Liber quintus decimus......Page 623
Liber sextus decimus......Page 643
Liber septimus decimus......Page 653
Liber undevicensimus......Page 675
Liber vicensimus......Page 694
Lettere a Lucilio......Page 711
Libro primo......Page 712
Libro secondo......Page 731
Libro terzo......Page 750
Libro quarto......Page 766
Libro quinto......Page 782
Libro sesto......Page 800
Libro settimo......Page 819
Libro ottavo......Page 838
Libro nono......Page 857
Libro decimo......Page 876
Libro undicesimo......Page 890
Libro quattordicesimo......Page 914
Libro quindicesimo......Page 936
Libro sedicesimo......Page 960
Libro diciassettesimo......Page 973
Libro diciannovesimo......Page 999
Libro ventesimo......Page 1022
Apokolokyntosis......Page 1043
Apocolocintosi......Page 1052
Prooemium......Page 1064
Pars prima......Page 1065
Pars secunda......Page 1066
Pars tertia......Page 1069
La clemenza......Page 1083
Proemio......Page 1084
Parte prima......Page 1087
Parte seconda......Page 1088
Parte terza......Page 1091
Liber primus......Page 1109
Liber secundus......Page 1118
Liber tertius......Page 1133
Liber quartus......Page 1149
Liber quintus......Page 1167
Liber sextus......Page 1182
Liber septimus......Page 1200
I benefìci......Page 1215
Libro primo......Page 1216
Libro secondo......Page 1229
Libro terzo......Page 1249
Libro quarto......Page 1270
Libro quinto......Page 1293
Libro sesto......Page 1312
Libro settimo......Page 1336
Liber primus......Page 1355
Liber secundus......Page 1373
Liber tertius......Page 1393
Liber quartus......Page 1412
Liber quintus......Page 1425
Liber sextus......Page 1434
Liber septimus......Page 1452
Questioni naturali......Page 1467
Libro primo......Page 1468
Libro secondo......Page 1491
Libro terzo......Page 1516
Libro quarto......Page 1540
Libro quarto B......Page 1550
Libro quinto......Page 1557
Libro sesto......Page 1569
Libro settimo......Page 1592
De matrimonio......Page 1611
Libro primo......Page 1617
Tragedie......Page 1625
Introduzione......Page 1626
Hercules furens......Page 1648
Ercole furioso......Page 1682
Troades......Page 1714
Troiane......Page 1744
Phoenissae......Page 1773
Le Fenicie ⠀漀 䰀愀 吀攀戀愀椀搀攀)......Page 1790
Medea......Page 1806
Medea......Page 1832
Phaedra......Page 1856
Fedra......Page 1888
Oedipus......Page 1916
Edipo......Page 1943
Agamemnon......Page 1968
Agamennone......Page 1994
Thyestes......Page 2019
Tieste......Page 2048
Hercules Oetaeus......Page 2074
Ercole sull’Eta......Page 2123
Octavia......Page 2168
Ottavia......Page 2194
Citation preview
484
Titoli originali: Dialogi (Consolatio ad Marciam, De ira, Consolatio ad Helviam matrem, Consolatio ad Polybium, De brevitate vitae, De constantia sapientis, De vita beata, De tranquillitate animi, De otio, De providentia), Epistulae morales, Apokolokyntosis, De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones, De matrimonio: traduzione di Mario Scaffidi Abbate Hercules furens, Troades, Phoenissae, Medea, Phaedra, Oedipus, Agamemnon, Thyestes, Hercules Oetaeus, Octavia: traduzione di Ettore Paratore Prima edizione ebook: maggio 2015 © 2015 Newton Compton editori s.r.l. Roma, Casella postale 6214 ISBN 978-88-541-5964-8 www.newtoncompton.com
Lucio Anneo Seneca
Tutte le opere Dialoghi, Lettere a Lucilio, Apocolocintosi, La clemenza, I benefìci, Questioni naturali, Sul matrimonio Cura e traduzione di Mario Scaffidi Abbate
Tragedie Cura e traduzione di Ettore Paratore
Edizioni integrali con testo latino a fronte
Newton Compton editori
Introduzione generale
Seneca fu un miscuglio d’idealità e di realismo. Affascinato dalla morale stoica, la piegò alle esigenze della vita pratica, anche se in un primo tempo visse quasi da asceta, attenendosi, sotto l’influsso della dottrina pitagorica, a un regime vegetariano, da cui lo distolsero il padre e il timore di poter essere confuso con gli ebrei quando Tiberio prese a perseguitarne certe sette che si astenevano appunto dalla carne. Si tenne però sempre lontano dal vino e da cibi come i funghi e le ostriche, che considerava uno stimolo all’intemperanza, un «invito a mangiare ancora quando si è già sazi» (Epist. ad Luc., 108, 15 ss.). Disdegnava i profumi perché, diceva, «il miglior profumo è il non averne alcuno», e riteneva una «cosa inutile e segno di ricercatezza cuocere il corpo e stancarlo col sudore» nelle terme: Omnis sudor per laborem exeat: «il sudore esca solo con la fatica», cioè in modo naturale (op. cit.). Se non fu un oceano di difetti, com’egli stesso si definisce (De vita beata, XVI, 4), certamente ne ebbe molti, e molte furono le sue contraddizioni: si faceva l’esame di coscienza ogni sera (De ira, III, 36), mettendo a nudo i suoi peccati, e si esibiva come esempio insuperabile di vita (Giusto Lipsio ha raccolto dalle sue opere tutti i passi in cui loda se stesso, facendo di lui un modello di eroismo, Diderot ne ha esaltato il carattere morale in Essai sur le règne de Claude et de Néron, Opere, vol. III). Voleva essere un santo, ma in vetrina, esposto all’ammirazione e agli applausi di tutti. Un guazzabuglio, per dirla col Manzoni. Rimproverava il lusso, e possedeva cinquecento tripodi di cedro con i piedi d’avorio, biasimava gli adulatori, e di Nerone diceva che «poteva vantare una virtù che non aveva avuto alcun altro imperatore, cioè l’innocenza», e che «oscurava persino i tempi di Augusto» (De clementia, I, 1). Precettore e consigliere di Nerone pur in mezzo a tante nefandezze, a tante stragi, non lo abbandonò neppure dopo il matricidio compiuto da lui. (Tacito dice che accondiscese all’uccisione di Agrippina perché diversamente sarebbe morto Nerone.) Cassio Dione, che pure lo elogia, gli rimprovera quelle complicità. Il Cantù non gli perdona soprattutto di avere «vilmente oltraggiato morto colui che vilmente avea esaltato vivo», descrivendone la «metamorfosi in zucca» nell’Apokolokyntosis. «Bassezze», commenta. Certo i tempi e le circostanze non favorirono Seneca nell’attuazione dei suoi ideali, anzi lo contrastarono, sicché sotto quel peso «cadde lo spirto anelo», piegandosi a un encomio servile. Video meliora proboque, deteriora sequor: «Conosco il meglio ed al peggior m’appiglio», come traduce Foscolo, il quale, a questo proposito, osservava che «gli uomini sono perpetuamente e necessariamente mossi dalla più forte sensazione; e si opera il male presente a onta delle ragioni poste innanzi dalla esperienza del passato e dalle
previdenze del futuro pel solo motivo che le cose presenti fanno più forza all’animo nostro». Così fu di Seneca, un saggio a cui, come dice il Paratore, «le paradossali contingenze della vita pratica tarparono le ali, spruzzandole di fango». Ma da quel fango lo purgò, riscattandolo, il suicidio. Ecco, in sintesi, come Tacito descrive la sua morte: «Dopo aver ricevuto dal tribuno l’ordine dell’imperatore, senz’esitare chiese le tavolette per il testamento, e poiché queste gli vennero negate si rivolse agli amici, dicendo loro che gli lasciava l’unico bene che ancora possedeva, l’immagine della propria vita, quindi abbracciò la moglie, pregandola di frenare il dolore, e come lei dichiarò di voler morire con lui, nel timore che, sopravvivendogli, potesse essere esposta a qualche offesa, le disse: “Io t’ho insegnato gli agi della vita e tu preferisci l’onore della morte: scegli come ti sembra meglio”. Dopodiché si ferirono entrambi con lo stesso stiletto. Seneca, il cui corpo vecchio e fiaccato dalla scarsità del vitto lasciava uscire il sangue troppo lentamente, si tagliò anche le vene delle gambe e delle ginocchia, e straziato da terribili dolori, per non affliggere con l’immagine della sua sofferenza l’animo della moglie, la fece trasportare in un’altra stanza, quindi, poiché il sangue gli usciva a stento, pregò Stazio Annèo di porgergli il veleno che già da molto tempo si era preparato, lo bevve, ma invano. Allora entrò in una vasca piena d’acqua calda: il vapore di questa lo uccise. Quanto alla moglie, Nerone, che non aveva motivo per odiarla e temeva che la sua morte potesse farlo apparire ancora più crudele, ordinò che venisse salvata» (Ann., XV, 62-64).
Vita e opere Lucio Annèo Seneca nasce il 4 a.C. a Cordova, in Spagna, da Lucio (o Marco) Annèo Seneca, detto “il Vecchio” – maestro di eloquenza (autore di un manuale di retorica, Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores) – e da Elvia, donna bellissima e virtuosa, che avrà gran parte nella sua formazione morale. (Furono suoi fratelli Marco Annèo Novato, più grande di lui, che prese il nome di Gallione, e Marco Annèo Mela, padre di Lucano, l’autore del poema Pharsalia.) Venuto a Roma ancora bambino con la famiglia (Mela resta in Spagna), intraprende gli studi di grammatica e di retorica, mostrando subito, però, un vivo interesse per i grandi problemi filosofici, e dell’etica in particolare. Sotto la guida e l’influsso dei suoi maestri, gli stoici Attalo e Papirio Fabiano, il cinico Demetrio e, soprattutto, il neopitagorico Sozione, si avvia verso un ideale di vita ascetica, imponendosi rigide rinunce a mortificazione del corpo, fra cui l’astensione dalla carne. Gracile di natura e piuttosto cagionevole, affetto da una grave malattia (forse una forma acuta di asma), il 16 d.C. si trasferisce in Egitto, dove rimane per circa quindici anni presso una zia materna (moglie del prefetto del luogo
Gaio Galerio), non solo per curare la propria salute, ancora più compromessa da quel suo tenore di vita, ma anche per un bisogno di raccoglimento interiore. Nel 19 una crisi fisica e morale lo porta a meditare il suicidio. Nel 31 ritorna a Roma, dove, distolto dal padre dal suo ideale di vita, intraprende la carriera forense, rivelandosi un brillante oratore. Il Foro e gli appoggi della zia, tornata a Roma con lui, gli aprono la strada alla carriera politica e ottiene la questura (33). Affermatosi ormai come avvocato e oratore, salito al potere Caligola, la sua eloquenza suscita le gelosie del Senato e dello stesso imperatore, che la definisce arena sine calce e che dopo avere ascoltato una sua orazione (come narra Cassio Dione, LIX, 19, 7) decide di dargli la morte, ma poi lo risparmia perché convinto da una sua favorita che in breve morirà per consunzione. Nel 40 scrive la Consolatio ad Marciam, nel 41, salito al trono Claudio, nominato pretore, in seguito a un intrigo di corte e comunque a opera della gelosa Messalina, che non vede di buon occhio la sua amicizia con Giulia Livilla, sorella di Caligola e di Agrippina, viene accusato di adulterio insieme alla giovane principessa e condannato all’esilio in Corsica. Giulia Livilla, esiliata anch’essa, sarà poi messa a morte. Alcuni non escludono un suo rapporto anche con Agrippina (v. Cassio Dione, LXI, 10). Sono otto anni di una vita solitaria e triste, durante i quali scrive il De ira, la Consolatio ad Helviam matrem e la Consolatio ad Polybium (liberto dell’imperatore, al quale è morto un fratello), in cui elogia Claudio, probabilmente per ingraziarselo, definendolo «forza e consolazione», «splendido come un dio», e rivolgendo un invito alla fortuna affinché lo lasci in vita, sì che possa «rimediare ai lunghi patimenti del genere umano; sempre rifulga quest’astro sul mondo, le cui tenebre furono ricreate dalla sua luce». È la sua opera più discussa per piaggeria e incoerenza. Nel 49 è richiamato a Roma per intercessione di Agrippina, che, sposato Claudio dopo la morte di Messalina, gli affida l’educazione del figlio Domizio Enobarbo, il futuro Nerone. Si affermano il suo prestigio e il suo potere a corte. È rieletto pretore, sempre per i buoni uffici di Agrippina che ne ha ottenuto il ritorno per attirarsi i favori del popolo che lo stima e giovarsi del suo aiuto per conseguire il principato. Nel 50 scrive il De brevitate vitae. Nel 54, morto Claudio (avvelenato probabilmente dalla stessa Agrippina) e salito al trono Nerone, forse per ingraziarsi quest’ultimo, scrive l’Apokolokyntosis (tale è il titolo tramandatoci da Cassio Dione, che i copisti hanno reso con Divi Claudi apotheosis per satyram, o, più semplicemente, con Ludus de morte Cl.), in cui celebra ironicamente e con uno sfogo vendicativo a dir poco ingeneroso, la «zucchificazione», o «trasformazione in dio in forma di zucca» dell’imperatore che lo ha condannato all’esilio e che prima ha esaltato, oltre che nella Consolatio ad Polybium, in un discorso scritto per Nerone da pronunciarsi in Senato. Con l’ascesa al trono di Nerone la sua influenza a
corte cresce ancora di più, al punto da fare di lui quasi l’arbitro e il moderatore della politica imperiale, l’astuto intermediario fra l’imperatore, sempre più tirannico, e il Senato, sempre più servile. Ispiratore di saggi consigli e provvedimenti (fra cui uno a favore degli schiavi più un progetto di riforma fiscale), accondiscende tuttavia a certi atteggiamenti e misfatti di Nerone, per evitare, dice, mali peggiori. Così, ad esempio, giustifica l’assassinio di Britannico, figlio di Claudio e Messalina, ordinato dall’imperatore. Accumula immense ricchezze, con possedimenti disseminati un po’ dovunque, per un valore di trecento milioni di sesterzi, divenendo oggetto di dure critiche, tanto più perché il suo tenore di vita contrasta con i suoi insegnamenti, e viene addirittura trascinato in tribunale da un certo Publio Suillio, che lo accusa di guadagni illeciti, di traffici, e persino di essere un usuraio e cacciatore di testamenti. Comunque vince la causa e Suillio, accusato a sua volta di peculato, è condannato all’esilio. Nel 55 scrive il De constantia sapientis e il De clementia, nel 58 il De vita beata. La sua autorità va intanto indebolendosi, mentre Nerone comincia a diventare insofferente di lui, il quale non solo non riesce a trattenergli la mano dal matricidio, ma finisce col giustificarlo in nome della ragion di Stato, scrivendo probabilmente egli stesso la lettera indirizzata da Nerone al Senato per rendere conto del misfatto, nella quale si dice che Agrippina s’è uccisa di sua mano per il fallimento di una sua cospirazione contro Nerone. Nella totale e passiva accettazione solo lo stoico Trasea Peto manifesta apertamente il suo dissenso. Nel 61 scrive il De tranquillitate animi. Con la morte di Burro, prefetto del pretorio e consigliere (insieme a lui) di Nerone, e con l’elezione di Tigellino a quella carica, la sua situazione a corte si fa sempre più insostenibile. Sfuggito a un tentativo di avvelenamento da parte di Nerone, si ritira a vita privata, dopo avere offerto all’imperatore tutti i suoi beni. Tacito, in Ann., XIV, 53, descrive la scena di lui che si presenta a Nerone e gli dice: «Tu m’hai colmato di onori e ricchezze al di là d’ogni misura, e ciò mi ha reso oggetto d’immensa invidia; è ora che io mi ritiri a una condizione di vita più modesta, in cui la mia anima possa dedicarsi a se stessa e non alla amministrazione di tanti beni». Si rifugia in una sua villa in Campania, conducendo una vita da anacoreta, confortato dall’affetto della seconda moglie, Paolina, e dell’amico Lucilio, a cui indirizza il suo epistolario (che concluderà nel 65), le Epistulae morales, il suo capolavoro, contenente 124 lettere in 20 libri. Scrive intanto anche il De otio e conclude il De beneficiis. Nel 63 scrive le Naturales quaestiones, nel 64 il De providentia. Coinvolto nella congiura di Calpurnio Pisone contro Nerone, insieme ad altri noti personaggi, senatori, consoli, filosofi e poeti, per ordine dell’imperatore si toglie la vita svenandosi (65). Va incontro alla morte con
decisione e grande serenità, così come aveva insegnato, ma non senza una certa posa teatrale, che era un po’ una caratteristica della sua natura. Oltre alle opere citate (le cui date di composizione sono approssimative) Seneca scrisse pure 9 tragedie, che ci sono pervenute anch’esse in un ordine non cronologico e che non sappiamo neppure se appartengano al periodo giovanile o a quello della maturità, benché alcuni propendano per quest’ultimo, collocandole fra il 59 e il 62. Esse sono, nell’ordine riportato dal codice Etrusco-Laurenziano, le seguenti: Hercules furens, Troades, Phoenissae, Medea, Phaedra, Oedipus, Agamemnon, Thyestes, Hercules Oetaeus. Ci è pervenuta inoltre l’Octavia, una pretesta (l’unica di tutta la letteratura latina e per questo importante), inclusa nell’elenco come decima tragedia, che però è ritenuta spuria, perché vi è descritto il suicidio di Nerone, profetizzato dall’ombra vendicatrice di Agrippina, con particolari troppo vicini alla realtà. Ci sono giunti, ancora, circa 70 epigrammi, di cui soltanto tre portano il nome di Seneca, contenenti notizie biografiche, dell’esilio, invocazioni e celebrazioni. Le opere perdute sono: De situ et sacris Aegyptiorum, De situ Indiae, De forma mundi (in cui è affermata la sfericità del mondo), De piscium natura, De lapidum natura, De motu terrarum, Exhortationes, il trattato De officiis, il dialogo De superstitione, De matrimonio, De immatura morte, De remediis fortuitorum ad Gallionem, Quomodo amicitia continenda sit, Libri moralis philosophiae, Epistulae ad Novatum, De vita patris. È singolare come nel Medioevo il nome “Seneca” lo si facesse derivare da se necans = «colui che si uccide», e come in molti dialetti (v. Bruno Migliorini, Dal nome proprio al nome comune, Ginevra 1917) la parola abbia il significato di «persona pallida e magra». MARIO SCAFFIDI ABBATE
Bibliografia
Manoscritti Dialogorum libri: AMBROSIANUS C. 90 inf. (A), XI sec. De clementia e De beneficiis: NAZARIANUS (Vat. Pal. 1547), VIII-IX sec. Epistulae morales ad Lucilium: LAURENTIANUS 76, 40 (IX-X sec.); MARCIANUS VENETUS CCLXX arm. 22,4 (IX-X sec.); QUIRINIANUS di Brescia (B. II, 6). Naturales quaestiones: PARISINUS LAT 8624 (XII-XIII sec.); MONTEPESSULANUS 116 (XIII sec.). Tragedie: ETRUSCUS (Laurentianus 37, 13), IX-X sec. Edizioni critiche dei Dialoghi Dialogorum libri XII: M.G. GERTZ, Hauniae 1886. Dialogorum libri XII: E. HERMES, Lipsia 1905. Dialogues: R. WALTZ, A. BOURGERY, Paris 1923. Dialogorum libri XII, R.D. REYNOLDS, Oxford 1977. E inoltre l’edizione italiana dell’Istituto Editoriale Italiano, Milano, a cura di N. Sacerdoti, il cui testo latino è riprodotto nella presente edizione. Edizioni delle Epistulae morales Editio Mentelina. Strasbourg 1475, prima edizione a stampa. F. HAASE, Leipzig 1852 (edizione teubneriana). O. HENSE, Leipzig 1898, 1914. A. BELTRAMI, Roma 1916, 1931. F. PRECHAC e H. NOBLOT (Belles Lettres), Paris 1945-1964. L.D. REYNOLDS, Oxford 1965. Edizioni delle altre opere Tragedie: F. LEO, Berlino 1878-79; U. MORICCA, Torino 1917-25; R. PEIPER - G. RICHTER, Lipsia 1921; L. HERRMANN, Paris 1924-26; G.C. GIARDINA, 2 voll., Bologna 1966; O. ZWIERLEIN, Oxford 1986. Epigrammi: A. BAEHRENS, in PLM, IV, Lipsia 1881; C. PRATO, Roma 1964. De beneficiis e De clementia: C. HOSIUS, Lipsia 1900. Naturales quaestiones: A. GERCKE, Lipsia 1907; P. OLTRAMARE, Paris 1929. Epistulae morales ad Lucilium: O. MENSE, Lipsia 1914; A. BELTRAMI, Roma 1931; F. PRECHAC, Paris 1945; R.D. REYNOLDS, Oxford 1965. Apocolocyntosis: A. ROSTAGNI, Milano 1948. Studi L. F. GELPKE, De Senecae vita et moribus, Bern 1848; F. BOHM, Seneca und sein Wert auch für unsere Zeit, Berlin 1856; BROLÉN, De philosophia Senecae, Uppsala 1880; P. HOCHART, Études sur la vie de Sénèque, Paris 1885; A. DIEPENBROCK, L. Annaei Senecae philosophi vita, Amsterdam 1888; A. GERCKE, Seneca-Studien, in «Jahrbuch für Philologie», Supplementb., 1895; C. PASCAL, Seneca, Messina 1906; R. WALTZ, Vie de Sénèque, Paris 1909 (opera tuttora fondamentale); D. BASSI, Seneca morale, Firenze 1914; C. MARCHESI, Seneca, Messina 1a ediz. 1920, 2a ediz. 1934 (anch’essa fondamentale); F. HOLLAND, Seneca, London 1920; P. FAIDER, Études sur Sénèque, Gand 1921; L. CASTIGLIONI, Studi intorno a Seneca prosatore e filosofo , in «Rivista di fil. class.», 1924, pp. 350 sgg.; A. BAILLY, La vie et les pensées de Sénèque, Paris 1929; H. W. KAMP, A critical biography of L.A.S.,
Illinois Stud. 1931; M. GENTILE, I fondamenti metafisici della morale di Seneca, Milano 1932; U. KNOCHE, Der Philosoph Seneca, Frankfurt 1933; B. AXELSON, Senecastudien, Lund 1933 e 1939; A. BOURGERY, Sénèque le Philosophe, Paris 1938; F. DE PAOLA, Philosophia tarsensis in Senecae scriptis, Firenze 1940; F. MARTINAZZOLI, Seneca, Firenze 1945 (pone l’accento sul sostanziale immanentismo di Seneca); P. GRIMAL, Sénèque, Paris 1948; F. GIANCOTTI, Il posto della biografia nella problematica senechiana, in «Rendiconti dell’Accademia dei Lincei», 1953-55; V. CAPOCCI, Chi era Seneca, Torino 1955; I. LANA, Lucio Anneo Seneca, Torino 1955; F. GIANCOTTI, Cronologia dei «Dialoghi» di Seneca, Torino 1957; E. PARATORE, voce Seneca, in «Enciclopedia dello spettacolo», Firenze 1961; ID., voce Seneca, in «Enciclopedia Dantesca» V, pp. 156-159; ID., La tensione drammatica nell’opera di Seneca, in «Actas del Congreso internacional de Filosofia en commemoración de Seneca», Cordoba 1965, pp. 207-28; G. SCARPAT, La lettera 65 di Seneca, Brescia 1965; E. PARATORE, Seneca e Lucano (nel diciannovesimo centenario della morte), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1966; ID., Indizi di natura sociale nel teatro latino, in «Atti III Congresso intern. st. dr. ant.», Siracusa 1969, pp. 3758; ID., La letteratura latina dell’età imperiale, Firenze-Milano 1969; G.C. GIARDINA: Caratteri formali del teatro di Seneca, Bologna 1972; A. TRAINA: Lo stile «drammatico» del filosofo Seneca, Bologna 1974; M.T. GRIFFIN: Seneca. A Philosopher in Politics, Oxford 1976; G. SCARPAT: Il pensiero religioso di Seneca, Brescia 1977; A. SETAIOLI: Seneca e i Greci, Bologna 1988; M. ROZELHAR, Seneca. Eine Gesamtdarstellung, Amsterdam 1976; A. GIL ARROYO, Die Chorlieder in Senecas Tragödien. Eine Untersuchung zu Senecas Philosophie und Chorthemen, Diss. Köln 1979; E. PARATORE, Seneca autore di teatro , in «Dioniso, Seneca e il teatro», 1985, pp. 29-46; ID., Séneca entre Uscatescu y yo, in Cultura y existencia humana, Madrid 1985, pp. 1275-80; V. SÖRENSEN, Seneca, Roma 1988. Traduzioni italiane Dialoghi:De ira: A. BARRIERA, Torino 1915; Dialogorum libri IX, X (De tranquillitate animi – De brevitate vitae): L. CASTIGLIONI, Augustae Taurinorum 1946; Dialogorum libri III, IV; V (De Ira): G. VIANSINO, Augustae Taurinorum 1963; Dialogorum libri VI, XI, XII (Consolationes): G. VIANSINO, Augustae Taurinorum 1963; Dialoghi, a cura di G. MANCA, Torino 2006; La consolazione a Marcia: introduzione, testo, traduzione e note a cura di A. TRAGLIA, Roma 1965; De providentia – De constantia sapientis, testo, commento e traduzione a cura di G. VIANSINO, Roma 1968; La Provvidenza: introduzione, testo, traduzione e note a cura di E. ANDREONI, Roma 1971; Dell’Ira Libri III: introduzione, testo, traduzione e note a cura di A. BORTONE POLI, Roma 1977; R. LAURENTI, 2 voll. Roma-Bari 1978; A. MARASTONI, Milano 1979; A. TRAINA (Le consolazioni), Milano 1987; R. DEL RE, Bologna 1989; N. MARZIANO, voll. 3, Milano 1990; N. SACERDOTI, Milano 1990. Lettere a Lucilio: B. GIULIANO, Bologna 1953-1962; U. BOELLA, Torino 1969; E. LEVI, Milano 1957; G. MONTI; Milano 1985; C. BARONE (con un saggio di L. Canfora), Milano 1989; M. GREMIGNAI, Sant’Arcangelo di Romagna 2008. Apocolocintosi: R. MUGELLESI, Milano 1996. Medea, Fedra: G.C. BIONDI, Milano 1989. Questioni naturali: D. VOTTERO, Torino 1989; R. MUGELLESI, Milano 2004. Come vivere a lungo e La provvidenza: M. Scaffidi Abbate, Roma, Newton Compton, 1993. Guida alla saggezza: M. SCAFFIDI ABBATE, Roma, Newton Compton, 1995. Tutti gli scritti in prosa: dialoghi, trattati e lettere : a cura di GIOVANNI REALE, con la coll. di ALDO MARASTONI e MONICA NATALI, Milano, Rusconi, 1994. Dialoghi morali: trad. di GAVINO MANCA; intr. e note di CARLO CARENA; testo latino a fronte; Torino, Einaudi, 1995. L’ozio e La serenità: M. SCAFFIDI ABBATE, Roma, Newton Compton, 19994. Dialoghi: a cura di PAOLA RAMONDETTI, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1999. Tutte le opere: dialoghi, trattati, lettere e opere in poesia : a cura di GIOVANNI REALE, con la coll. di ALDO MARASTONI, MONICA NATALI e ILARIA RANELLI, Milano, Bompiani, 2000. L’arte di essere felici e vivere a lungo: M. SCAFFIDI ABBATE, Roma, Newton Compton, 2006. M. S. A.
Tragedie
Edizioni A cura di R. PEIPER e G. RICHTER, Leipzig 1a ediz. 1867, 2a ediz. 1937; a cura di F. LEO, Berlin 1878-79 (fondamentale, con un complesso di studi introduttivi e accessori): da essa dipende quella particolare di G. RICHTER, Leipzig 1902 e 1921. Indi: a cura di L. HERMANN, Paris 1924-26; a cura di U. MORICCA, Torino 1a ediz. 1917-23, 2a ediz. 1947 (con introduzioni alle singole tragedie, in cui si dibattono i problemi delle fonti); a cura di G. VIANSINO, Torino 1965; a cura di E. LEFÈVRE, Darmstadt 1972; a cura di O. ZWIERLEIN, Oxford 1986; Tragedie: G.C. GIARDINA, R. CUCCIOLI MELLONI, Torino 1987; E. PARATORE, Roma, Newton Compton, 2006.
Opere concernenti tutto il teatro I fondamenti della critica sul teatro di Seneca in LESSING, Samtliche Schriften ed. Lachmann-Muncker, 3a ediz., vol. VI, pp. 167 sgg. Indi: G. BOISSIER, Les tragédies de Sénèque ont-elles été représentées?, Paris 1861; G. RICHTER, De Senecae tragoediarum auctore, Bonn 1862 (fissa in breve tutta la problematica essenziale sul teatro di Seneca); F. JONAS, De ordine librorum Senecae philosophi , Berlin 1870 (sulla cronologia delle tragedie); C. E. SANDSTROM, De L. A. Senecae tragoediis, Uppsala 1872; A. PAIS, Il teatro di L. A. Seneca, Torino 1890; C. LINDSKOG, Studien zur antiken Drama II, Lund 1897; F. LEO, Die Komposition der Chorlieder Senecas, in «Rheinisches Museum», 1897; P. SCHAEFER, De philosophiae Annaeanae in Senecae tragoediis vestigiis, Jena 1909; F. FRENZEL, Die Prologe der Tragöd. Senecas, Leipzig 1914; Index verborum delle tragedie di Seneca, a cura di W. A. OLDFATHER, A. S. PEASE e H. V. CANTER, Illinois Stud., voll. 3, 1918; K. MÜNSCHER, Senecas Werke , in «Philologus», Supplementb., 1922, pp. 84 sgg.; J. KEUNE, De L. A. Senecae arte tragica, Göttingen 1923; L. HERRMANN, Le théatre de Sénèque, Paris 1924 (con ricca bibliografia); J. HIPPLER, Annaeanae quaestiones scaenicae, Darmstadt 1924; H. V. CANTER, Rhetorical elements in the trag. of Seneca, lllinois Stud., 1925; HERZOG, Datierung der Trag. des Senecas, in «Rheinisches Museum», 1928, pp. 51 sgg. (faticosamente cervellotico); S. LANDMAN, Seneca quatenus in mulierum personis effingendis ab exemplaribus graecis recesserit, in «Eos», 1928, p. 492; J. SMEREKA, De Senecae tragoediis dinosis colore fucatis, in «Eos», 1929, pp. 615 sgg.; W. MARX, Funktion und Form der Chorlieder in Senecas Trag., Heidelberg 1931; E. CESAREO, Le tragedie di Seneca, Palermo 1932; w. H. FRIEDRICH, Untersuchungen zu Senecas dramat. Technik , Leipzig 1933; E. HANSEN, Die Stellung der Affektrede in den Tragödien des Senecas, Berlin 1934; W. SCHULZE, Untersuchungen zur Eigenart der Tragödien Senecas, Halle 1937; M. DAL MONTE-CASONI, Coro e azione nelle tragedie di Seneca, Napoli 1937; L. STRZELECKI, De Senecae trimetro iambico, Krakow 1938; M. HADAS, The Roman stamp of Seneca’s tragedies , «Amer. Journ. of. Philol.», 1939, pp. 220 sgg.; N. T. PRATT jr., Dramatic suspense in Seneca, Princeton Univ. 1939; C. W. MENDELL, Our Seneca, New Haven 1941 (il miglior bilancio del particolare influsso di Seneca sulla cultura anglosassone); B. M. MARTI, Seneca’s Tragedies, in «Transac. of Amer. Philol. Assoc.», 1945, pp. 216 sgg.; G. CARLSSON, Seneca’s Tragedies , in «Classica et Mediaevalia», 1948, pp. 39 sgg.; L. STRZELECKI, De polymetris Senecae canticis, in «Eos», 1951, pp. 93 sgg.; K. H. TRABERT, Studien zur Darstellung des Pathologischen in den Tragödien des Senecas, Erlangen 1953; F. GIANCOTTI, Saggio sulle tragedie di Seneca, Città di Castello 1953 (asciutto tentativo di rivendicare solo la coerenza del contenuto morale nelle tragedie di Seneca, sussumendole sotto la categoria dell’oratoria; il che non ha evitato che, contro le sue intenzioni, P. GRIMAL, recensendo l’opera in «Revue des ét. anc.» 1955, pp. 211-13, ne traesse ispirazione per proporre una nuova insostenibile cronologia delle tragedie); J. ANDRIEU, Le dialogue antique, Paris 1954; B. GENTILI, Il coro nel teatro romano , in «Enciclopedia dello Spettacolo», vol. III, s.v.; M. BIEBER, Wurden die Tragoedien des Seneca in Rom aufgeführt?, in «Römische Mitteilungen», 1953-54, pp. 100 sgg. (sulla base di dati archeologici e dell’arte figurativa sostiene che le tragedie di Seneca erano destinate alla scena); E. PARATORE, Storia del teatro latino, Milano 1957; ID., Originalità del teatro di Seneca, in «Dioniso» 1957, pp. 53-74; K. ANLIKER, Prologe und Akteinteilung in Senecas Tragödien , in «Noctes Romanae», 1960, pp. 98 sgg.; G. RUNCHINA, Tecnica drammatica e retorica nelle Tragedie di Seneca , in «Ann. Fac. Lett. Cagliari», 1960, pp. 103 sgg.; A. CATTIN, Les thèmes lyriques dans les tragédies de Sénèque, Neuchâtel 1963; O. REGENBOGEN, Schmerz und Tod in den Tragödien Senecas , Darmstadt 1963; E. PARATORE, Il teatro latino nei suoi rapporti col pubblico antico e nei suoi riflessi sulla spiritualità moderna, in «Dioniso», 1965, pp. 57-81; G. PETRONE, Paesaggio dei morti e paesaggio del male: il modello dell’oltretomba virgiliano nelle tragedie di Seneca , ibid., pp. 131-143; O. ZWIERLEIN, Die Rezitationsdramen Senecas, mit einem kritisch-exegetischen Anhang, Meisenheim am Glan 1966, pp. 72-
87; E. PARATORE, El teatro y sus sombras, in «Revista de estudios politicos», 1969, pp. 133-37; B. SEIDENSTICKER, Die Gesprächsverdichtung in den Tragödien Senecas , Heidelberg 1969; G. MAZZOLI, Seneca e la poesia, Milano 1970; E. PARATORE, Il teatro latino nel mondo contemporaneo, in «Dioniso», 1971, pp. 511-31; I. OPELT, Senecas Konzeption des Tragischen, Darmstadt 1972; E. PARATORE, Il teatro latino, in Introduzione allo studio della cultura classica, Milano 1972, pp. 259-61; W. L. LIEBERMANN, Studien zu Senecas Tragödien, Meisenheim am Glan 1974; S. FORTHEY-J. GLUCKER, Actus tragicus: Seneca on the Stage, in «Latomus», 1975, pp. 699-715; J. A. SEGURADO E CAMPOS, Sur la typologie des personnages dans les tragédies de Sénèque, in «Nerone», 1977, pp. 224 sgg.; R. J. TARRANT, Senecan Drama and its Antecedents, in «Harvard St.», 1978, pp. 213 sgg.; A. TRAINA, Due note a Seneca tragico, in «Maia», 1979, pp. 273 sgg.; G. ARICÒ, Seneca e la tragedia latina arcaica, in «Dioniso», 1981, pp. 339-356; A. DE ROSALIA, Echi acciani in Seneca tragico, in «Atti dell’VIII Congresso internazionale di studi sul dramma antico: Seneca e il teatro. Siracusa, settembre 1981», «Dioniso», 1981, pp. 221 sgg.; D. LANZA, Riflessioni sulla testualità drammatica di Seneca, in «Dioniso», 1981, pp. 463-76; J. M. ANDRÉ, La présence de Virgile chez Sénèque, in «Helmantica», 1982, pp. 219-33; L. BRAUN, Sind Senecas Tragödien Bühnenstücke oder Rezitationsdrame?, in «Res publ. litt.», 1982, pp. 43-52; N. T. PRATT, Seneca’s Drama , Chapel Hill and London 1983; S. TIMPANARO, La tipologia delle citazioni poetiche in Seneca: alcune considerazioni, in «Giorn. it. filol.», 1984, pp. 163-82; D. e E. HENRY, The mask of Power. Seneca’s Tragedies and Imperial Rome, Wiltshire-Chicago 1985; O. HILTBRUNNER, Seneca als Tragödiendichter in der Forschung von 1965 bis 1975, in «Auf. und Nied. der röm. Welt» II, Berlin-New York 1985, pp. 969 sgg.; J. DINGEL, Senecas Tragödien: Vorbilder und poetische Aspekte , ibid., pp. 1052 sgg.; D. F. SUTTON, Seneca on the Stage, Leiden 1986; O. ZWIERLEIN, Kritischer Kommentar zu den Tragödien Senecas, Mainz 1986; G. MAZZOLI, Funzioni e strategie dei cori nella tragedia senecana, in «Quaderni di cultura e di tradizione classica», «Atti del I seminario di studi sulla tragedia romana (Palermo 26-28 ottobre 1987)», pp. 99-112; G. RAINA, La fuga di notizie nella tragedia di Seneca, in «Atti sem. st. della tragedia romana», Palermo 1988-89; V. SALVIONI, Metafore ‘burocratiche’ nel teatro di Seneca? , ibid.; M. TREBBI, La struttura dei prologhi senecani, ibid.; R. TROMBINA, Il nostos nel teatro di Seneca, ibid.; P. VENINI, Seneca ed Euripide, ibid.; G. DIHLE, Seneca und die Aufführungpraxis der römischen Tragödie, in «Ant. und Abendl.», 1989, pp. 162-171. Sulla fortuna di Seneca in età moderna: J. CUNLIFFE, The influence of Seneca on Elizabethan tragedy, London 1893; J. ENGEL, Die Spuren Senecas in Shakespeares Dramen , in «Preussische Jahrbücher», 1903, pp. 60 sgg.; E. PARATORE, Nuove prospettive sull’influsso del teatro classico nel ’500, Accademia Naz. dei Lincei, Roma 1970; ID., Seneca tragico e la poesia tragica francese del siècle d’or, in «Studi urbinati», 1973, pp. 32-60; E. LEFÈVRE, Der Einfluss Senecas auf das europäische Drama, Darmstadt 1978; E. PARATORE, L’influsso dei classici, e particolarmente di Seneca, sul teatro tragico latino del Tre e Quattrocento , in La rinascita della tragedia nell’Italia dell’Umanesimo, Viterbo 1980, pp. 21-45.
Sulle singole tragedie Ercole furioso WERNER, De L. Ann. Senecae Hercule, Troad., Phoen. quaestiones; U. LIMENTANI, L’«Hercules furens» di Seneca, Padova 1901; L. CASTIGLIONI, La tragedia di Ercole in Euripide e Seneca, in «Rivista di fil. class.», 1926, pp. 176 sgg.; R. M. HAYWOOD, in «Class. Journ.», 1942, pp. 421 sgg.; TH. B. SIEMERS, Seneca’s Hercules Furens , Utrecht 1951; V. USSANI jr., Seneca, Hercules furens , Roma 1959; E. PARATORE, Ercole in Euripide e Seneca, in «Annali del Liceo “G. Garibaldi” di Palermo», 1964, pp. 221-26; ID., Il prologo dello «Hercules Furens» di Seneca e l’«Eracle di Euripide» , in «Annali del Liceo “G. Garibaldi” di Palermo», 1965, pp. 277-308; J. A. SHELTON, Seneca’s Hercules Furens. Theme, Structure and Style, Göttingen 1978; F. CAVIGLIA, Il furore di Ercole , Roma 1979; S. TIMPANARO, Un nuovo commento dell’Hercules Furens di Seneca nel quadro della critica recente , in «Atene e Roma», 1981, pp. 113 sgg.; G. GASPAROTTO, Dante e l’Hercules furens di Seneca , in «Atti del I Seminario di studi sulla tragedia romana», Palermo 1987, pp. 227-43; II, «Atti» 1988-89.
Troiane
A. PAIS, in «Riv. fil. class.», 1888, pp. 277 sgg.; BRAUN, De Senecae fabula quae inscribitur Troades; G. AMMENDOLA, Le «Troadi» di Seneca , S. Marino 1917; W. STEIDLE, Zu Senecas Troerinnen, in «Philologus», 1939-40, pp. 266 sgg.; E. PARATORE, Seneca (nel XIX centenario della morte), in «Studi Romani», 1965, pp. 405-23; W. SCHETTER, Sulla struttura delle Troiane di Seneca (trad. it.), in «Riv. di filol.», 1965, pp. 396 sgg.; W. OWEN, Time and Event in Seneca’s Troades , in «Wien. St.», 1970, pp. 118-37; E. PETTINE, Studio dei caratteri e poesia nelle tragedie di Seneca – Le Troiane , Salerno 1974; E. FANTHAM, Seneca’s Troades , Princeton 1982; Le Troiane , a cura di F. CAVIGLIA, Roma 1981-82; F. AMOROSO, Seneca uomo di teatro? Le Troiane e lo spettacolo , Palermo 1984; F. STOK, Modelli delle Troades di Seneca , in «Atti del I Seminario di studi sulla tragedia romana», Palermo 1987, I; M. TREBBI, Aporie senecane nelle Troiane , ibid., pp. 167-76; E. LEFÈVRE, Die Funktion der Götter in Senecas Troades, in «Atti sem. st. sulla trag. rom.», Palermo 1988-89.
Fenicie A. CIMA, Sulla composizione delle «Fenicie», in «Riv. di fil. class.», 1904, pp. 255 sgg.; J. MESK, Senecas Phoenissen, in «Wiener Studien», 1915, pp. 289 sgg.; A. PAUL, Untersuchungen zur Eigenart von Senecas Phoenissen, Bonn 1953; E. PARATORE, Ancora delle rubriche di scena e delle sigle dei personaggi nelle Phoenissae di Seneca, in «Arch. Pal. It.», 1957, pp. 223-41; G. CAJANI, Odium atque regnum. Appunti di lettura delle Phoenissae di Seneca, alla ricerca di una gnomica del potere , in «Studi Romani», 1965, pp. 177-79; A. BARCHIESI, Le Fenicie, Padova 1988; G. PETRONE, Potere e parentela nelle Phoenissae di Seneca, in «Atti sem. st. trag. rom.», Palermo 1988-89.
Medea P. RAJNA, La Medea di Seneca esaminata, Piacenza 1872; BRAUN, Die Medea des Seneca, in «Rheinisches Museum», 1877, pp. 68 sgg.; HABRUCKER, Quaestiones Annaeanae; A. CIMA, La Medea di Seneca e la Medea di Ovidio, in «Atene e Roma» 1904, pp. 224 sgg.; H. L. CLEASBY, L’originalità di Seneca nella sua Medea, ibid., 1907, pp. 306 sgg., cui rispose A. CIMA, ibid., 1908, pp. 64 sgg.; TH. VENTE, Die Medea-Tragödie Senecas, Strassburg 1909; versione di B. GENTILI, in «Teatro di tutti i tempi», Roma 1952, pp. 151 sgg.; B. GENTILI, L’ultimo atto della «Medea» di Seneca, in «Maia», 1953, pp. 43 sgg.; A. HEMPELMANN, Senecas Medea als eigenständiges Kunstwerk, Diss. Kiel 1960; J. D. BISHOP, The Choral Odes of Seneca’s Medea , in «Class. Journ.», 1965, pp. 313-26; G. MAURACH, Jason und Medea bei Seneca, in «Ant. und Abendl.», 1966, pp. 125 sgg.; E. PARATORE, Seneca e Lucano, Medea ed Erichto, in «Hispania Romana», Accademia dei Lincei, Roma 1974, pp. 169-79; G. PICONE, La Medea di Seneca come fabula dell’inversione, ibid., pp. 181-93; F. AMOROSO, Lo specifico teatrale della Medea di Seneca, ibid., pp. 195-205; CH. SEGAL, Nomen sacrum Medea and other Names in Senecan Tragedy, in «Maia», 1982, pp. 241 sgg.; N. KUWAHARA, On the surrounding problems of Seneca’s Medea 301-379 , in «Mediterranea», 1983, pp. 57 sgg.; G. G. BIONDI, Il nefas argonautico. Mythos e logos nella Medea di Seneca, Bologna 1984; R. MARINO, Il monologo in Seneca tragico. Una indagine sulla Medea, in «Atti sem. st. trag. rom.», Palermo 1991; A. MARTINA, La Medea di Seneca, Euripide e Ovidio, ibid.; M. TREBBI, La scena finale della Medea di Seneca, ibid.
Fedra U. MORICCA, Le fonti della «Fedra» di Seneca, in «Studi it. di fil. class.», 1915, pp. 158 sgg.; V. USSANI, Motivi religiosi e morali nelle tragedie di Fedra, in «Atene e Roma», 1915, pp. 11 sgg.; E. PARATORE, Sulla «Phaedra» di Seneca, in «Dioniso», 1952, pp. 199 sgg. (con relativa bibliografia); edizione critica con introduzione e commento, a cura di R. GIOMINI, Roma 1955 (con ampia bibliografia); R. GIOMINI, Saggio sulla «Fedra» di Seneca, Roma, 1955; C. ZINTZEN, Analytisches Hypomnema zu Senecas Phaedra, Meisenheim am Glan 1960; E. LEFÈVRE, Die Monomanie der senecaischen Phaedra, in «Class. Journ.», 1965, pp. 207-18; P. GRIMAL, L. Annaei Senecae Phaedra, Paris 1965; E. PARATORE, La morte di Fedra in Seneca e nel D’Annunzio, in «Essays presented to Mario Praz», 1966, pp. 413-34; H. HERTER, Phaedra in griechischer und römischer Gestalt, in «Rhein. Mus.», 1971, pp. 4477; S. LEFÈVRE, Quid ratio possit? Senecas Phaedra als stoisches Drama, Darmstadt 1972, pp. 343-75;
E. PARATORE, Lo ÔIppovluto" kaluptovmeno" di Euripide e la Phaedra di Seneca, in «St. class. Quint. Cataudella», Catania 1972, pp. 303-46; C. DE MEO, Il prologo della «Phaedra» di Seneca, Bologna 1978; P. L. DAVIS, A Reading of Seneca’s Phaedra , in «Essays on Senecan Drama», Cambridge 1983, pp. 114-27; A. J. BOYLE, In Nature’s Bonas: A Study of Seneca’s «Phaedra» , in «Auf. u. Nied. der röm. Welt», II, Berlin-New York 1985, pp. 1284 sgg.; CH. SEGAL, Language and Desire in Seneca’s Phaedra, Princeton 1986; O. ZWIERLEIN, Senecas Phaedra und ihre Vorbilder , Mainz 1987, pp. 12-17; F. CAVIGLIA, La morte di Ippolito, in «Atti sem. st. trag. rom.», Palermo 1991.
Edipo KOEHLER, Senecae trag. quae Oedipus inscribitur, Neuss 1865; BRAUN, Der Oedipus des Seneca, in «Rhein. Mus.», 1867, pp. 245 sgg.; specimen di edizione critica, a cura di TH. H. SLUITER, Groningen 1941; G. MUELLER, Senecas Oedipus als Drama, in «Hermes», 1953, pp. 447 sgg.; E. PARATORE, La poesia nell’Oedipus di Seneca, in «Giorn. it. filol.», 1956, pp. 97 sgg.; E. LEFÈVRE, Das erste Chorlied in Senecas Oedipus: Ein innerer Monolog?, in «Orpheus», 1980, pp. 293 sgg.; ID., Die politische Bedeutung der römischen Tragödie und Senecas «Oidipus», in «Auf. und Nied. der röm. Welt», II, Berlin-New York 1985, pp. 1242-61; G. D’IPPOLITO, Modi della intertestualità teatrale: l’Edipo di Seneca, in «Atti sem. st. trag. rom.», Palermo 1988-89.
Agamennone SIEDLOFF, Die Nachbildung griech. und rom. Muster in Sen. Troades und Agam., Grimma 1902; C. BRAKMAN, De Senecae Agamemnone, in «Mnemosyne», 1914, p. 392; L. STRZELECKI, De Senecae Agamemnone Euripidisque Alexandro, Wratislavia 1949; K. STACKMANN, Senecas Agamemnon, in «Classica et Mediaevalia», 1950, pp. 180 sgg.; J. LANOWSKI, La tempête des nostoi dans la tragédie romaine, in «Tragika», vol. I, Wroclaw 1952, pp. 133 sgg.; edizione critica con introduzione e commento, a cura di R. GIOMINI, Roma 1956; R. GIOMINI, De canticis polymetris in Agamemnone et Oedipode Annaeanis, Roma 1959; P. MELONI, N. Treveti expositio Senecae Agamemnonis , Roma 1961; G. STREUBEL, Senecas Agamemnon, Diss. Wien 1963; E. LEFÈVRE, Die Schuld des Agamemnon, in «Hermes», 1973, pp. 82 sgg.; E. PARATORE, L’Agamemnon di Seneca e l’Agamennone dell’Alfieri, in «Studi Sapegno», Roma 1974, pp. 517-56; R. J. TARRANT, Seneca, Agamemnon, Cambridge 1976; J. A. SHELTON, Revenge or Resignation in Seneca’s Agamemnon , in «Seneca Tragicus. Essays on Seneca Drama», Victoria 1983; F. CAVIGLIA, Elementi di tradizione epica nell’Agamemnon di Seneca, in in «Atti del I Seminario di studi sulla tragedia romana», Palermo 1987, I, pp. 145-165; G. ARICÒ, La visione di Cassandra, ibid., II; E. PARATORE, La scena finale dell’Agamemnon di Seneca, ibid.; G. MAZZOLI, Ultra Mycenas: ‘lysis’ e ‘katastrophe’ dei valori nell’epilogo dell’Agamemnon di Seneca , in «Atti sem. st. trad. rom.», Palermo 1988-89.
Tieste C. MARCHESI, Il Tieste di L. Anneo Seneca, Catania 1908; U. KNOCHE, Senecas Atreus, in «Die Antike», 1941, pp. 60 sgg.; G. KROKOWSKI, De Thyeste Annaeana, Wroclaw 1952; versione e adattamento a cura di V. GASSMAN con introduzione di E. PARATORE, Bologna 1953; I. LANA, L’Atreo di Accio e la leggenda di Atreo e Tieste nel teatro tragico romano , in «Atti Accad. Sc.», Torino 1958-59, pp. 293 sgg.; A. LA PENNA, Atreo e Tieste sulle scene romane , in «Studi in onore di Q. Cataudella», Catania 1972, pp. 357 sgg.; O. PICONE, Il significato politico di alcuni anacronismi nel Thyestes di Seneca, in «Pan», 1976, pp. 61-67; G. CIPRIANI, Una scena dell’Atreus di Accio e Seneca, in «Riv. st. class.», 1978, pp. 210 sgg.; A. MARTINA, Il mito della casa di Atreo nella tragedia di Seneca, in «Atti dell’VIII Congresso internazionale di studi sul dramma antico», Siracusa 1981, «Dioniso» 1981, pp. 165 sgg.; E. PARATORE, Il prologo dell’Agamemnon e quello del Thyestes di Seneca, in «Miscellanea in mem. Fr. Arnaldi», «Vichiana», 1982, pp. 226-34; P. MANTOVANELLI, La metafora di Tieste, Verona 1984; G. PICONE, La fabula e il regno. Studi sul Thyestes di Seneca, Palermo 1984; R. J. TARRANT, Seneca’s Thyestes, Atlanta 1985; G. PADUANO, La climax della volontà di potenza nel Tieste di Seneca, in «Atti sem. st. trag. rom.», Palermo 1989.
Ercole sull’Eta GRIMM, Der Herc. Oet. des Seneca, Petersburg 1876; L. TACHAU, Zu Senecas Tragödien, in «Philologus», 1888, pp. 378 sgg.; P. MELZER, De Hercule Oetaeo Annaeana, Chemnitz 1890; W. C. SUMMERS, The authorship of the Herc. Oet., in «Class. Review», 1905, pp. 40 sgg.; E. ACKERMANN, De Seneca Hercule Oetaeo, in «Philologus», Supplementb., 1905, pp. 323 sgg.; ID., Der leidende Hercules des Seneca, in «Rhein. Mus.», 1912, pp. 425 sgg.; A. S. PEASE, On the authenticity of the H.O., in «Trans. of Amer. philol. Assoc.», 1918; G. CARLSSON, Le personnage de Déjanire, in «Eranos», 1947, pp. 59 sgg.; B. M. MARTI, Place de l’Hercule sur l’Oeta, in «Revue des ét. lat.», 1949, pp. 189 sgg.; W. H. FRIEDRICH, Sprache und Stil des Hercules Oetaeus, in «Hermes», 1954, pp. 51 sgg. (ultima asserzione della non autenticità della tragedia); E. PARATORE, Note critiche ed esegetiche al testo dello «Hercules Oeltaeus», in Ut pictura poesis, Studia Latina Petro Enk oblata, Leiden 1955, pp. 129 sgg.; ID., Sui versi 725 e 1199 dello Hercules Oetaeus, in «Hommage à L. Herrmann», Bruxelles 1960, pp. 58488; P. MELONI, N. Treveti expositio Senecae Herculis Oetaei , Roma 1962; E. PARATORE, De gentilitatis sumpuaria ratione apud Senecam, in «Latinitas», 1965, pp. 166-71; A. R. L. DEWEY, The Chorus in Senecan Tragedy exclusive Hercules Oetaeus and Octavia , Diss. Columbia Univ. 1969, pp. 34-382; E. PARATORE, Lo Hercules Oetaeus è di Seneca ed è anteriore al Furens , in «St. in onore di T. Y. Haarhoff», Darmstadt 1972, pp. 545-48; F. CAVIGLIA, Il furore di Ercole, Roma 1979.
Ottavia F. LADEK, De Octavia praetexta, Wien, 1891; edizione a cura di A. SANTORO, Bologna, 1919; E. FLINK, De Octaviae praetextae auctore, Helsingfors 1919; L. HERRMANN, L’Octavie prétexte, Paris 1924; A. SANTORO, L’autore e la lingua della pretesta Ottavia , in «Nuova cultura», 1927, pp. 55 sgg. (si sostiene che la tragedia è del sec. III d.C.); R. HELM, Die praetexta Octavia, in «Sitzungsber. Preuss. Akad. d. Wiss.», 1934, pp. 283 sgg. (se ne fissa la composizione al tempo di Domiziano); V. CIAFFI, Intorno all’autore dell’Octavia, in «Riv. di fil. class.», 1937, pp. 246 sgg. (tentativo di attribuire la tragedia a Cornuto). Finalmente i recenti tentativi di rivendicarla a Seneca: S. PANTZERHIELM-THOMAS, De Octavia praetexta, in «Symbolae Osloenses», 1945, pp. 48 sgg.; B. M. MARTI, Seneca’s Apocolocyntosis and Octavia: a Diptych, in «Amer. Journ. of Philol.», 1952, pp. 24 sgg.; F. GIANCOTTI, L’«Octavia» attribuita a Seneca, Torino, 1954 (con ricca bibliografia); P. RIZZA, La pretesta «Octavia», Firenze 1970. E. P.
Nota alle traduzioni
Esiste la traduzione limite? Una traduzione, cioè, al di là della quale non ne sia possibile una migliore? Madame De Staël, dopo aver letto la celebre traduzione dell’Iliade eseguita da Vincenzo Monti, esclamò: «Personne ne traduira plus l’Iliade, après lui!». Giacomo Leopardi nel Preambolo alle Operette morali di Isocrate scriveva: Nei volgarizzamenti che vengono giornalmente in luce, di buone e classiche scritture antiche, non solo non si prova diletto uguale a quello che danno le medesime opere leggendole nelle lingue loro, ma né anco si sente diletto alcuno, anzi in quella vece un tedio infinito, eccetto al più in materie di storia e in poche altre simili… Non è maraviglia che per lo più in tutte o in quasi tutte le lingue, i volgarizzamenti che si hanno o che si crede avere dei libri classici antichi, sieno poco meno che intollerabili e impossibili a leggere interi. Ora che direi dei nostri volgarizzamenti più moderni, i quali sono lodati io non so perché? dove io trovo un dire fatto di un raccozzamento in foggia mostruosa e barbara, composto tutto di errori d’intelligenza e d’interpretazione? E tuttavia, non senza nostra vergogna, è riputato universalmente in Italia per volgarizzamento non pur vero e buono, anzi egregio e classico!… Gl’Italiani oggi in universale non hanno, a voler dire il vero, alcun sentimento delle virtù e dei vizi del favellare e dello stile, e giudicano in queste materie per lo più a caso, confondendo il mediocre coll’ottimo, ed ancora il buono col tristo, e spesso anche l’ottimo col pessimo… Non si trova una traduzione che non pecchi spesso e gravemente circa la vera intelligenza ed interpretazione del testo, e che possa stare al confronto di quelle pubblicate in Inghilterra e massime in Germania: traduzioni che non lasciano una minima cosa a desiderare quanto all’esattezza e all’acutezza dell’intendere i veri sensi degli autori. Le traduzioni dei libri classici cattive e mediocri sono ingloriose a chi le scrive, inutili agli altri, le traduzioni buone e perfette oltremodo difficile a farle, rarissime a ritrovarne. Né si speri alcuno di farsi immortale con traduzioni che non sieno eccellenti. E quelli che degli autori greci o latini esprimono solo i pensieri, e non le bellezze e le perfezioni dello stile, non si può pur dire che traducano. Queste cose giova ed è a proposito il dirle, e anche il ripeterle spesso, acciocché altri non presuma (come si fa in questo secolo tutto giorno) dovere con ingegno forse meno che comunale, con poca o nessuna arte e fatica, ottenere quella medesima gloria che spesso con somma arte, con fatiche grandissime, non ottengono gl’ingegni sommi.
Ebbene, tutto ciò è tanto più vero ai giorni nostri in cui salgono di continuo alla ribalta uomini mediocri (tutti applauditi, tutti magnifici, stupendi e addirittura mitici) e basta essere già noti per potere «con poca o nessuna arte e fatica» ottenere una fama che non ottiene chi lavora davvero con arte, ingegno e fatica somma. Indubbiamente non è facile dare dei classici, latini e greci, una versione letterale che sia al tempo stesso chiara, sciolta e gradevole. Per questo quando è stato necessario io mi sono sempre attenuto più che alla lettera al concetto, per evitare quella farraginosità e quelle inesattezze da cui non sono immuni molte traduzioni. Oppure ho fatto ricorso alla parentesi quadra per completare o chiarire meglio il pensiero dell’Autore. Ho poi cercato di evitare le ripetizioni (frequenti nel testo originale come nelle traduzioni) e apportato qualche modifica lessicale, quando mi è parso che l’Autore volesse dare alla parola usata un significato diverso da quelli riportati dai vocabolari. La mia principale preoccupazione è sempre stata quella di dare alla
narrazione una prosa fluida e pulita, tenendo per così dire un occhio al passato e l’altro al presente e al futuro, rispettoso, cioè, dell’originale per quel che riguarda lo spirito del testo e la voce dell’Autore, ma al tempo stesso attento ai gusti e alle esigenze dei lettori di oggi e di domani. Questo mi sembra che debba essere il compito di un traduttore moderno che voglia mantenere desto o risvegliare negli animi l’interesse e l’amore per il mondo greco e latino. Un testo classico è come un mobile antico abbandonato in una soffitta o in una cantina: si può restaurarlo, ma non si deve togliergli la patina del tempo. M.S.A.
Dialogi Dialoghi
Consolazione a Marcia, L’arte di non adirarsi, Consolazione alla madre Elvia, Consolazione a Polibio, Come vivere a lungo, La fermezza del saggio, La felicità, La serenità, L’ozio o della contemplazione, La provvidenza Cura e versione di Mario Scaffidi Abbate
Premessa
Composti nell’arco di venticinque anni, i Dialoghi non sono stati ordinati da Seneca in una raccolta, quale a noi è pervenuta, né sappiamo da chi, quando e con quali criteri essa sia stata effettuata. Il codice più antico, che è anche il più autorevole, l’Ambrosianus (conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano), risalente all’XI secolo, li elenca in un ordine che non è cronologico e di cui ignoriamo la motivazione. Esso presenta inoltre degli errori di trascrizione, che sono stati corretti da mano ignota nel secolo successivo. Si può perciò determinare, in base al loro contenuto, il periodo in cui le singole monografie sono state scritte, ma non l’anno preciso, anche se poi, per comodità (come noi pure abbiamo fatto), se ne fissa uno ritenuto quale più probabile. Il primo dialogo, comunque, è la Consolatio ad Marciam, che risale secondo alcuni al 37, secondo altri al 40-41. Vengono poi: il De ira, collocato nel 41 (visto che vi è deplorata la crudeltà di Caligola, morto in quell’anno), la Consolatio ad Helviam, del 42-43, la Consolatio ad Polybium, del 43-44, il De brevitate vitae, del 49-50, il De constantia sapientis, del 55-56, il De vita beata, posto quasi unanimemente nel 58 (dato il riferimento personale a un’accusa mossa in quell’anno a Seneca da un certo Publio Suillio), il De tranquillitate animi, del 61, il De otio, del 62, il De providentia, del 64-65 (alcuni lo pongono invece all’inizio dell’esilio). Le opere sono 10, distribuite in 12 libri, e cioè 9 costituite da un solo libro ciascuna più il De ira che è diviso in tre libri. In realtà il titolo di dialogo può essere attribuito solo al De tranquillitate animi, giacché nelle altre monografie parla soltanto Seneca, rivolgendosi però a un dedicatario dal quale spesso fa porre alcune domande e obiezioni. Per quanto alcuni preferiscano ordinare questi dialoghi in base all’affinità dell’argomento trattato, noi, nell’esporne in sintesi il contenuto, li citeremo nell’ordine tradizionale, quale appare nel codice sopra accennato. 1. De providentia (La provvidenza). Dedicato a Lucilio, in 6 capitoli, muove dalla domanda Quare multa bonis adversa eveniunt, cioè per quale ragione anche ai buoni capitano molte avversità, a cui segue la risposta che nihil accidere bono viro mali potest: non miscentur contraria, ossia che all’uomo buono non può accadere mai alcunché che possa chiamarsi propriamente un male, inquantoché i contrari non sono mescolabili fra loro. In poche parole, nell’uomo buono il male ha lo scopo di fortificarlo, per cui si risolve praticamente in un bene. È il concetto della «provvida sventura». 2. De constantia sapientis (La fermezza del saggio). Dedicato a Sereno, in 19 capitoli, affronta il problema utrum sapientem extra indignationem an extra
iniuriam ponas, se cioè il saggio debba essere collocato al di là dello sdegno o al di là dell’offesa. La risposta è che invulnerabile est non quod non feritur, sed quod non laeditur, ovverosia che è invulnerabile non ciò che non viene colpito, ma ciò che non è danneggiato. 3. De ira (L’ira). Dedicato al fratello Novato, in tre libri, ha come argomento generale le passioni umane (già oggetto di studio in Grecia con Teofrasto e poi nella letteratura stoica del periodo ellenistico) e in particolare l’ira, definita terribile, furibonda, disumana e simile alla follia, la più pericolosa delle passioni, giacché le altre «hanno una componente di calma e di tranquillità» e in ogni caso «si notano», mentre l’ira «risalta». È infatti un vizio che non si sa utrum magis detestabile… sit an deforme, se cioè sia più detestabile o brutto, giacché trasforma anche i lineamenti del volto. Questo dialogo si può raffrontare con l’omonimo trattato Perì orghès di Plutarco, contenuto nelle sue Operette morali (Ethikà). 4. Consolatio ad Marciam (Consolazione a Marcia), in 26 capitoli. Rivolto alla figlia di Cremuzio Cordo (lo storico, autore degli Annales), che lamenta da tre anni la perdita del figlio Metilio, vuole dimostrare, in conclusione, che la morte è un bene, perché libera l’uomo dai molti mali che lo affliggono, che il saggio deve aspettare e accogliere con serenità quello che è l’evento più certo, inevitabile e improvviso della vita, cioè la morte, che nessun bene è coperto da garanzia e che perciò bisogna godere subito dei propri figli e farsi godere da loro, bere quella gioia sino all’ultima stilla, giacché nihil de hodierna nocte promittitur, nihil de hac hora: ciò che ci è dato può esserci tolto entro la prossima notte o addirittura in questo stesso momento. 5. De vita beata (La felicità). Dedicato al fratello Gallione, in 28 capitoli, vuole dimostrare, in polemica con la dottrina epicurea, che la felicità risiede non nel piacere, ma nella virtù (giacché voluptas humile, servile, imbecillum, caducum, mentre la virtù è altum quiddam, excelsum et regale, invictum, infatigabile), e che la saggezza consiste nel non allontanarsi dalla propria natura, che nell’uomo è razionale, per cui la felicità risiede nel conformarsi, appunto, alla propria natura. 6. De otio (La vita contemplativa). Dedicato a Sereno, in 8 capitoli, mutilo sia all’inizio che alla fine, è un elogio della vita contemplativa, la quale sola consente al saggio di vivere in piena comunione con Dio, giacché il mondo sensibile deve annoverarsi inter caduca et ad tempus nata, cioè fra le cose caduche e limitate nel tempo, mentre la contemplazione consente di uscire da tutto ciò che è perituro. Quanto al fatto se il saggio debba partecipare o no alla vita politica, in riferimento alla domanda posta da Sereno (Quid agis, Seneca? Deseris partes?), il filosofo, concludendo, risponde che purtroppo non esiste uno Stato in cui il sapiente possa agire coerentemente con i propri princìpi. 7. De tranquillitate animi (La tranquillità dell’animo). Dedicato ancora a Sereno, in 17 capitoli, tratta un argomento affine a quello del De otio,
ricercando quae possint tranquillitatem tueri, quae restituere, quae subrepentibus vitiis resistant, ossia quali cose possano difendere la tranquillità, quali restituirla e quali rimedi esistano contro i vizi che si annidano in noi. (A questo dialogo si richiama un’omonima monografia di Plutarco). 8. De brevitate vitae (La brevità della vita). Dedicato a Paolino, in 20 capitoli, tratta della durata della vita, che secondo l’opinione comune è breve, mentre in realtà non accipimus brevem… sed facimus, cioè essa non è breve di per sé, siamo noi che la rendiamo tale: la vita satis longa est… et in maximarum rerum consummationem large data est si tota bene collocaretur, ovvero, sarebbe bastevole e anzi anche abbondante per portare a termine grandi cose se fosse tutta spesa bene. 9. Consolatio ad Polybium (Consolazione a Polibio), in 18 capitoli. Indirizzato al potente liberto di Claudio, afflitto per la morte di un fratello, il dialogo è in realtà un pretesto per tessere un elogio sperticato dell’imperatore, allo scopo di ottenere il ritorno dall’esilio. Vi si mescolano i temi ricorrenti della letteratura consolatoria, l’ineluttabilità del destino, l’inutilità del dolore e l’esortazione a sopportare con animo forte e sereno le avversità della vita. È l’opera più discussa di Seneca. 10. Consolatio ad Helviam (Consolazione ad Elvia). Indirizzato alla madre, in 20 capitoli, con un tono ben diverso da quello del dialogo precedente e riprendendo un tema già accennato nel De vita beata (l’esilio è un «nome vano»: quid enim est mutare regiones?), vuole dimostrare che per il saggio la condizione dell’esule non è infelice, giacché per lui la vera patria è il mondo, l’esilio non è altro che un mutamento di luogo, e non può togliere all’uomo il vero bene, che è la virtù. I problemi trattati nei Dialoghi sono presenti in tutta l’opera di Seneca, perché ciò ch’egli si propone è sempre un intento morale. Sono i problemi dibattuti dallo stoicismo, da cui però l’Autore a volte si allontana per esporre il suo pensiero personale (est et mihi censendi ius, De vita beata, III, 2). Le fonti, relative a tutto il pensiero di Seneca, vanno ricercate oltre che nello stoicismo e nell’epicureismo anche nei pitagorici, nei Cinici, in Aristotele, Teofrasto, Posidonio, Panezio e Cicerone. Quella dei Dialoghi è una filosofia pratica (non priva di contraddizioni e di compromessi), che si propone di risolvere i problemi della vita, aiutare l’uomo a conoscersi, a entrare in intima comunione con se stesso, a liberarsi dalle passioni e dai timori, facendo uso della ragione, giacché questa è la prerogativa propria della nostra natura ed è lei, perciò, che bisogna seguire. Quello di Seneca è un cammino ideale – realizzabile solo nel profondo dell’animo – a cui non corrisponde, e forse non potrà mai corrispondere, sul piano pratico, una vita pienamente conforme, giacché la materia non è sorda solo all’intenzione dell’arte. In ciò sta il limite dell’uomo, nel non riuscire a fare esattamente e pienamente quello che si vuole, come nel non riuscire a dire
esattamente e pienamente quello che si pensa e si sente. Anche Seneca si trova in questa «disagguaglianza», nel senso che la parola, in quanto suono articolato convenzionale, molte volte non s’accorda, è insufficiente, «corta», al suo concetto, per cui egli risulta confuso, intricato, si ripete, compie passaggi bruschi, usa vocaboli non sempre appropriati, congiunzioni conclusive invece che dichiarative («dunque» al posto di «infatti») e viceversa. Di fronte a questi difetti un traduttore – che voglia rendere più chiaro e convincente il pensiero di Seneca (tanto più quando la sua opera è destinata al grande pubblico) – non può attenersi alla lettera. Che significa, per esempio, «Il tuo podere è più curato di quanto richiede la necessità naturale»? Sarà più esatto dire: «Il tuo podere produce più di quanto non richiedano i tuoi bisogni naturali». Così quando l’Autore dice che il saggio può non accedere alla vita politica «se la strada è impraticabile» sarà opportuno aggiungere «per lui», in quanto gli altri possono praticarla benissimo. Se poi traduciamo «Il piacere accompagni la virtù, come l’ombra che procede accanto al corpo», perché non precisare «senza confondersi con lui»? (Comunque solo gli esperti, che via via consultino il testo latino, possono comprendere le finezze e i pregi di una buona traduzione). C’è poi, nello stile di Seneca, un tono oratorio, che rispecchia non solo la cultura del suo tempo ma la sua stessa natura. Uno stile che non piacque a Quintiliano, a Frontone e a Gellio, che lo trovavano corruptum et omnibus vitiis fractum (Quint.), vedendovi verborum sordes et illuvies… verba modulate collocata et effeminate fluentia, e consideravano la sua eloquenza mollibus et febriculosis prunuleis insitam, cioè «disseminata di prugnettine sfatte e malaticce», di disgustose ripetizioni e noiose sentenze, nonché perniciosissima per i giovani, a causa dei molti e seducenti difetti. Dei quali probabilmente, sia pure in parte, era consapevole Seneca stesso, che, accanto all’analisi quotidiana del suo stile di vita, dei suoi vizi e delle sue passioni, avrà fatto anche quella del suo modo di scrivere. C’è un passo del De tranquillitate animi che, pur se messo in bocca a Sereno, il dedicatario, è sotto sotto una confessione dell’Autore. Scrive Seneca: Sono convinto che in un’opera si debba guardare principalmente al contenuto, ch’è la molla di ogni discorso, subordinando le parole all’argomento, in modo che questo possa svilupparsi senza sforzo e pervenire là dove si vuole arrivare. Scrivere in una forma semplice, per passatempo, senza battere la grancassa ma solo a nostro uso e consumo: ci si affatica di meno lavorando così, alla giornata. Questo mi dico, ma poi, quando la mente torna a innalzarsi a grandi e nobili concetti, allora ecco che mi riprende il gusto della parola forbita e non mi basta più solo pensare, voglio anche esprimermi in un modo più elevato, adeguato alla dignità del contenuto, sicché, dimentico di quelle norme e di quella semplicità che prima m’ero imposto, mi lascio trascinare dall’enfasi, parlando con un linguaggio che non è più mio.
Comunque, nell’antichità furono soprattutto i giovani a leggere Seneca e ad amarlo: solus hic fere in manibus adulescentium fuit, dice Quintiliano, il quale riconosce tuttavia che Seneca ebbe molte e grandi qualità, prontezza e
ricchezza d’ingegno, grande cultura, impegno eccezionale, ma che in filosofia fu parum diligens, ovvero poco preciso. Non c’è stata epoca che non lo abbia studiato e ammirato, perché al di là dei suoi difetti di stile, vuoi dell’uomo, vuoi dello scrittore, sprigiona una forza innegabile, che avvince e commuove. Concetto Marchesi, dopo aver esordito dicendo che Seneca «è lo scrittore più moderno della letteratura latina, ed è l’unico che ci parli ancora come fosse vivo nella lingua morta di Roma», conclude affermando che il suo stile, «fatto di frasi brevi, staccate, acute, luminose, improvvise, che incalzano spesso una medesima cosa per colpirla da più lati sino in fondo, è – fra le pagine degli scrittori latini – quello che parla a noi il linguaggio più vivo». M. S. A.
Consolatio ad Marciam
1. Nisi te, Marcia, scirem tam longe ab infirmitate muliebris animi quam a ceteris vitiis recessisse et mores tuos velut aliquod antiquum exemplar aspici, non auderem obviam ire dolori tuo, cui viri quoque libenter haerent et incubant, nec spem concepissem tam iniquo tempore, tam inimico iudice, tam invidioso crimine posse me efficere ut fortunam tuam absolveres. Fiduciam mihi dedit exploratum iam robur animi et magno experimento adprobata virtus tua. Non est ignotum qualem te in persona patris tui gesseris, quem non minus quam liberos dilexisti, excepto eo quod non optabas superstitem. Nec scio an et optaveris; permittit enim sibi quaedam contra bonum morem magna pietas. Mortem A. Cremuti Cordi parentis tui quantum poteras inhibuisti; postquam tibi apparuit inter Seianianos satellites illam unam patere servitutis fugam, non favisti consilio eius, sed dedisti manus victa, fudistique lacrimas palam et gemitus devorasti quidem, non tamen hilari fronte texisti, et haec illo saeculo quo magna pietas erat nihil impie facere. Ut vero aliquam occasionem mutatio temporum dedit, ingenium patris tui, de quo sumptum erat supplicium, in usum hominum reduxisti et a vera illum vindicasti morte ac restituisti in publica monumenta libros quos vir ille fortissimus sanguine suo scripserat. Optime meruisti de Romanis studiis: magna illorum pars arserat; optime de posteris, ad quos veniet incorrupta rerum fides, auctori suo magno inputata; optime de ipso, cuius viget vigebitque memoria quam diu in pretio fuerit Romana cognosci, quam diu quisquam erit qui reverti velit ad acta maiorum, quam diu quisquam qui velit scire quid sit vir Romanus, quid subactis iam cervicibus omnium et ad Seianianum iugum adactis indomitus, quid sit homo ingenio animo manu liber. Magnum mehercules detrimentum res publica ceperat, si illum ob duas res pulcherrimas in oblivionem coniectum, eloquentiam et libertatem, non eruisses: legitur, floret, in manus hominum, in pectora receptus vetustatem nullam timet; at illorum carnificum cito scelera quoque, quibus solis memoriam meruerunt, tacebuntur. Haec magnitudo animi tui vetuit me ad sexum tuum respicere, vetuit ad vultum, quem tot annorum continua tristitia, ut semel obduxit, tenet. Et vide quam non subrepam tibi nec furtum facere adfectibus tuis cogitem: antiqua mala in memoriam reduxi et, ut scires hanc quoque plagam esse sanandam, ostendi tibi aeque magni vulneris cicatricem. Alii itaque molliter agant et blandiantur, ego confligere cum tuo maerore constitui et defessos exhaustosque oculos, si verum vis magis iam ex consuetudine quam ex desiderio fluentis, continebo, si fieri potuerit, favente te remediis tuis, si minus, vel invita, teneas licet et amplexeris dolorem tuum, quem tibi in filii locum superstitem
fecisti. Quis enim erit finis? Omnia in supervacuum temptata sunt: fatigatae adlocutiones amicorum, auctoritates magnorum et adfinium tibi virorum; studia, hereditarium et paternum bonum, surdas aures inrito et vix ad brevem occupationem proficiente solacio transeunt; illud ipsum naturale remedium temporis, quod maximas quoque aerumnas componit, in te una vim suam perdidit. Tertius iam praeterit annus, cum interim nihil ex primo illo impetu cecidit: renovat se et corroborat cotidie luctus et iam sibi ius mora fecit eoque adductus est ut putet turpe desinere. Quemadmodum omnia vitia penitus insidunt nisi dum surgunt oppressa sunt, ita haec quoque tristia et misera et in se saevientia ipsa novissime acerbitate pascuntur et fit infelicis animi prava voluptas dolor. Cupissem itaque primis temporibus ad istam curationem accedere; leniore medicina fuisset oriens adhuc restringenda vis: vehementius contra inveterata pugnandum est. Nam vulnerum quoque sanitas facilis est, dum a sanguine recentia sunt: tunc et uruntur et in altum revocantur et digitos scrutantium recipiunt, ubi corrupta in malum ulcus verterunt. Non possum nunc per obsequium nec molliter adgredi tam durum dolorem: frangendus est. 2. Scio a praeceptis incipere omnis qui monere aliquem volunt, in exemplis desinere. Mutari hunc interim morem expedit; aliter enim cum alio agendum est: quosdam ratio ducit, quibusdam nomina clara opponenda sunt et auctoritas quae liberum non relinquat animum ad speciosa stupentibus. Duo tibi ponam ante oculos maxima et sexus et saeculi tui exempla: alterius feminae quae se tradidit ferendam dolori, alterius quae pari adfecta casu, maiore damno, non tamen dedit longum in se malis suis dominium, sed cito animum in sedem suam reposuit. Octavia et Livia, altera soror Augusti, altera uxor, amiserunt filios iuvenes, utraque spe futuri principis certa: Octavia Marcellum, cui et avunculus et socer incumbere coeperat, in quem onus imperii reclinare, adulescentem animo alacrem, ingenio potentem, sed frugalitatis continentiaeque in illis aut annis aut opibus non mediocriter admirandae, patientem laborum, voluptatibus alienum, quantumcumque inponere illi avunculus et, ut ita dicam, inaedificare voluisset laturum; bene legerat nulli cessura ponderi fundamenta. Nullum finem per omne vitae suae tempus flendi gemendique fecit nec ullas admisit voces salutare aliquid adferentis, ne avocari quidem se passa est; intenta in unam rem et toto animo adfixa, talis per omnem vitam fuit qualis in funere, non dico non ausa consurgere, sed adlevari recusans, secundam orbitatem iudicans lacrimas mittere. Nullam habere imaginem filii carissimi voluit, nullam sibi de illo fieri mentionem. Oderat omnes matres et in Liviam maxime furebat, quia videbatur ad illius filium transisse sibi promissa felicitas. Tenebris et solitudini familiarissima, ne ad fratrem quidem respiciens, carmina celebrandae Marcelli memoriae composita aliosque studiorum honores reiecit et aures suas adversus omne solacium clusit. A sollemnibus officiis seducta et ipsam magnitudinis fraternae nimis circumlucentem fortunam exosa defodit se et abdidit. Adsidentibus liberis, nepotibus lugubrem vestem non deposuit, non sine
contumelia omnium suorum, quibus salvis orba sibi videbatur. 3. Livia amiserat filium Drusum, magnum futurum principem, iam magnum ducem; intraverat penitus Germaniam et ibi signa Romana fixerat ubi vix ullos esse Romanos notum erat. In expeditione decesserat ipsis illum hostibus aegrum cum veneratione et pace mutua prosequentibus nec optare quod expediebat audentibus. Accedebat ad hanc mortem, quam ille pro re publica obierat, ingens civium provinciarumque et totius Italiae desiderium, per quam effusis in officium lugubre municipiis coloniisque usque in urbem ductum erat funus triumpho simillimum. Non licuerat matri ultima filii oscula gratumque extremi sermonem oris haurire; longo itinere reliquias Drusi sui prosecuta, tot per omnem Italiam ardentibus rogis, quasi totiens illum amitteret, inritata, ut primum tamen intulit tumulo, simul et illum et dolorem suum posuit, nec plus doluit quam aut honestum erat Caesare aut aequum salvo. Non desiit denique Drusi sui celebrare nomen, ubique illum sibi privatim publiceque repraesentare, libentissime de illo loqui, de illo audire: cum memoria illius vixit, quam nemo potest retinere et frequentare qui illam tristem sibi reddidit. Elige itaque utrum exemplum putes probabilius. Si illud prius sequi vis, eximes te numero vivorum: aversaberis et alienos liberos et tuos ipsumque quem desideras; triste matribus omen occurres; voluptates honestas, permissas, tamquam parum decoras fortunae tuae reicies; invisa haerebis in luce et aetati tuae, quod non praecipitet te quam primum et finiat, infestissima eris; quod turpissimum alienissimumque est animo tuo in meliorem noto partem, ostendes te vivere nolle, mori non posse. Si ad hoc maximae feminae te exemplum adplicueris moderatius, mitius, non eris in aerumnis nec te tormentis macerabis: quae enim, malum, amentia est poenas a se infelicitatis exigere et mala sua †non† augere! Quam in omni vita servasti morum probitatem et verecundiam, in hac quoque re praestabis; est enim quaedam et dolendi modestia. Illum ipsum iuvenem, dignissimum qui te laetam semper nominatus cogitatusque faciat, meliore pones loco, si matri suae, qualis vivus solebat, hilarisque et cum gaudio occurrit. 4. Nec te ad fortiora ducam praecepta, ut inhumano ferre humana iubeam modo, ut ipso funebri die oculos matris exsiccem. Ad arbitrium tecum veniam: hoc inter nos quaeretur, utrum magnus dolor esse debeat an perpetuus. Non dubito quin Iuliae Augustae, quam familiariter coluisti, magis tibi placeat exemplum: illa te ad suum consilium vocat. Illa in primo fervore, cum maxime inpatientes ferocesque sunt miseriae, consolandam se Areo, philosopho viri sui, praebuit et multum eam rem profuisse sibi confessa est, plus quam populum Romanum, quem nolebat tristem tristitia sua facere, plus quam Augustum, qui subducto altero adminiculo titubabat nec luctu suorum inclinandus erat, plus quam Tiberium filium, cuius pietas efficiebat ut in illo acerbo et defleto gentibus funere nihil sibi
nisi numerum deesse sentiret. Hic, ut opinor, aditus illi fuit, hoc principium apud feminam opinionis suae custodem diligentissimam: «usque in hunc diem, Iulia, quantum quidem ego sciam, adsiduus viri tui comes, cui non tantum quae in publicum emittuntur nota, sed omnes sunt secretiores animorum vestrorum motus, dedisti operam ne quid esset quod in te quisquam reprenderet; nec id in maioribus modo observasti, sed in minimis, ne quid faceres cui famam, liberrimam principum iudicem, velles ignoscere. Nec quicquam pulchrius existimo quam in summo fastigio conlocatos multarum rerum veniam dare, nullius petere; servandus itaque tibi in hac quoque re tuus mos est, ne quid committas quod minus aliterve factum velis. 5. Deinde oro atque obsecro ne te difficilem amicis et intractabilem praestes. Non est enim quod ignores omnes hos nescire quemadmodum se gerant, loquantur aliquid coram te de Druso an nihil, ne aut oblivio clarissimi iuvenis illi faciat iniuriam aut mentio tibi. Cum secessimus et in unum convenimus, facta eius dictaque quanto meruit suspectu celebramus; coram te altum nobis de illo silentium est. Cares itaque maxima voluptate, filii tui laudibus, quas non dubito quin vel inpendio vitae, si potestas detur, in aevum omne sis prorogatura. Quare patere, immo arcesse sermones quibus ille narretur, et apertas aures praebe ad nomen memoriamque filii tui; nec hoc grave duxeris ceterorum more, qui in eiusmodi casu partem mali putant audire solacia. Nunc incubuisti tota in alteram partem et oblita meliorum fortunam tuam qua deterior est aspicis. Non convertis te ad convictus filii tui occursusque iucundos, non ad pueriles dulcesque blanditias, non ad incrementa studiorum: ultimam illam faciem rerum premis; in illam, quasi parum ipsa per se horrida sit, quidquid potes congeris. Ne, obsecro te, concupieris perversissimam gloriam, infelicissima videri. Simul cogita non esse magnum rebus prosperis fortem se gerere, ubi secundo cursu vita procedit: ne gubernatoris quidem artem tranquillum mare et obsequens ventus ostendit, adversi aliquid incurrat oportet quod animum probet. Proinde ne summiseris te, immo contra fige stabilem gradum et quidquid onerum supra cecidit sustine, primo dumtaxat strepitu conterrita. Nulla re maior invidia fortunae fit quam aequo animo». Post haec ostendit illi filium incolumem, ostendit ex amisso nepotes. 6. Tuum illic, Marcia, negotium actum, tibi Areus adsedit; muta personam – te consolatus est. Sed puta, Marcia, ereptum tibi amplius quam ulla umquam mater amiserit – non permulceo te nec extenuo calamitatem tuam: si fletibus fata vincuntur, conferamus; eat omnis inter luctus dies, noctem sine somno tristitia consumat; ingerantur lacerato pectori manus et in ipsam faciem impetus fiat atque omni se genere saevitiae profecturus maeror exerceat. Sed si nullis planctibus defuncta revocantur, si sors inmota et in aeternum fixa nulla miseria mutatur et mors tenuit quidquid abstulit, desinat dolor qui perit. Quare regamur nec nos ista vis transversos auferat. Turpis est navigii rector cui gubernacula fluctus eripuit,
qui fluvitantia vela deseruit, permisit tempestati ratem; at ille vel in naufragio laudandus quem obruit mare clavum tenentem et obnixum. 7. «At enim naturale desiderium suorum est». Quis negat, quam diu modicum est? Nam discessu, non solum amissione carissimorum necessarius morsus est et firmissimorum quoque animorum contractio. Sed plus est quod opinio adicit quam quod natura imperavit. Aspice mutorum animalium quam concitata sint desideria et tamen quam brevia: vaccarum uno die alterove mugitus auditur, nec diutius equarum vagus ille amensque discursus est; ferae cum vestigia catulorum consectatae sunt et silvas pervagatae, cum saepe ad cubilia expilata redierunt, rabiem intra exiguum tempus extinguunt; aves cum stridore magno inanes nidos circumfremuerunt, intra momentum tamen quietae volatus suos repetunt; nec ulli animali longum fetus sui desiderium est nisi homini, qui adest dolori suo nec tantum quantum sentit sed quantum constituit adficitur. Ut scias autem non esse hoc naturale, luctibus frangi, primum magis feminas quam viros, magis barbaros quam placidae eruditaeque gentis homines, magis indoctos quam doctos eadem orbitas vulnerat. Atqui quae a natura vim acceperunt eandem in omnibus servant: apparet non esse naturale quod varium est. Ignis omnes aetates omniumque urbium cives, tam viros quam feminas uret; ferrum in omni corpore exhibebit secandi potentiam. Quare? Quia vires illis a natura datae sunt, quae nihil in personam constituit. Paupertatem luctum ambitionem alius aliter sentit prout illum consuetudo infecit, et inbecillum inpatientemque reddit praesumpta opinio de non timendis terribilis. 8. Deinde quod naturale est non decrescit mora: dolorem dies longa consumit. Licet contumacissimum, cotidie insurgentem et contra remedia effervescentem, tamen illum efficacissimum mitigandae ferociae tempus enervat. Manet quidem tibi, Marcia, etiamnunc ingens tristitia et iam videtur duxisse callum, non illa concitata qualis initio fuit, sed pertinax et obstinata; tamen hanc quoque tibi aetas minutatim eximet: quotiens aliud egeris, animus relaxabitur. Nunc te ipsa custodis; multum autem interest utrum tibi permittas maerere an imperes. Quanto magis hoc morum tuorum elegantiae convenit, finem luctus potius facere quam expectare, nec illum opperiri diem quo te invita dolor desinat! ipsa illi renuntia. 9. «Unde ergo tanta nobis pertinacia in deploratione nostri, si id non fit naturae iussu?». Quod nihil nobis mali antequam eveniat proponimus, sed ut immunes ipsi et aliis pacatius ingressi iter alienis non admonemur casibus illos esse communes. Tot praeter domum nostram ducuntur exequiae: de morte non cogitamus; tot acerba funera: nos togam nostrorum infantium, nos militiam et paternae hereditatis successionem agitamus animo; tot divitum subita paupertas in oculos incidit: et nobis numquam in mentem venit nostras quoque opes aeque in lubrico positas. Necesse est itaque magis corruamus: quasi ex inopinato ferimur;
quae multo ante provisa sunt languidius incurrunt. Vis tu scire te ad omnis expositum ictus stare et illa quae alios tela fixerunt circa te vibrasse? Velut murum aliquem aut obsessum multo hoste locum et arduum ascensu semermis adeas, expecta vulnus et illa superne volantia cum sagittis pilisque saxa in tuum puta librata corpus. Quotiens aliquis ad latus aut pone tergum ceciderit, exclama: «non decipies me, fortuna, nec securum aut neglegentem opprimes. Scio quid pares: alium quidem percussisti, sed me petisti». Quis umquam res suas quasi periturus aspexit? Quis umquam vestrum de exilio, de egestate, de luctu cogitare ausus est? Quis non, si admoneatur ut cogitet, tamquam dirum omen respuat et in capita inimicorum aut ipsius intempestivi monitoris abire illa iubeat? «Non putavi futurum». Quicquam tu putas non futurum quod scis posse fieri, quod multis vides evenisse? Egregium versum et dignum qui non e pulpito exiret: cuivis potest accidere quod cuiquam potest! Ille amisit liberos: et tu amittere potes; ille damnatus est: et tua innocentia sub ictu est. Error decipit hic, effeminat, dum patimur quae numquam pati nos posse providimus. Aufert vim praesentibus malis qui futura prospexit. 10. Quidquid est hoc, Marcia, quod circa nos ex adventicio fulget, liberi honores opes, ampla atria et exclusorum clientium turba referta vestibula, clarum nomen, nobilis aut formosa coniux ceteraque ex incerta et mobili sorte pendentia alieni commodatique apparatus sunt; nihil horum dono datur. Conlaticiis et ad dominos redituris instrumentis scaena adornatur; alia ex his primo die, alia secundo referentur, pauca usque ad finem perseverabunt. Itaque non est quod nos suspiciamus tamquam inter nostra positi: mutua accepimus. Usus fructusque noster est, cuius tempus ille arbiter muneris sui temperat; nos oportet in promptu habere quae in incertum diem data sunt et appellatos sine querella reddere: pessimi debitoris est creditori facere convicium. Omnes ergo nostros, et quos superstites lege nascendi optamus et quos praecedere iustissimum ipsorum votum est, sic amare debemus tamquam nihil nobis de perpetuitate, immo nihil de diuturnitate eorum promissum sit. Saepe admonendus est animus, amet ut recessura, immo tamquam recedentia: quidquid a fortuna datum est, tamquam exempto auctore possideas. Rapite ex liberis voluptates, fruendos vos in vicem liberis date et sine dilatione omne gaudium haurite: nihil de hodierna nocte promittitur – nimis magnam advocationem dedi – nihil de hac hora. Festinandum est, instatur a tergo: iam disicietur iste comitatus, iam contubernia ista sublato clamore solventur. Rapina rerum omnium est: miseri nescitis in fuga vivere. Si mortuum tibi filium doles, eius temporis quo natus est crimen est; mors enim illi denuntiata nascenti est; in hanc legem genitus est, hoc illum fatum ab utero statim prosequebatur. In regnum fortunae et quidem durum atque invictum pervenimus, illius arbitrio digna atque indigna passuri. Corporibus nostris
inpotenter contumeliose crudeliter abutetur: alios ignibus peruret vel in poenam admotis vel in remedium; alios vinciet – id nunc hosti licebit, nunc civi; alios per incerta nudos maria iactabit et luctatos cum fluctibus ne in harenam quidem aut litus explodet, sed in alicuius inmensae ventrem beluae decondet; alios morborum variis generibus emaceratos diu inter vitam mortemque medios detinebit. Ut varia et libidinosa mancipiorumque suorum neglegens domina et poenis et muneribus errabit. Quid opus est partes deflere? Tota flebilis vita est: urgebunt nova incommoda, priusquam veteribus satis feceris. Moderandum est itaque vobis maxime, quae inmoderate fertis, et in multos dolores humani pectoris vis dispensanda. 11. Quae deinde ista suae publicaeque condicionis oblivio est? Mortalis nata es mortalesque peperisti: putre ipsa fluidumque corpus et causis [morbos] repetita sperasti tam inbecilla materia solida et aeterna gestasse? Decessit filius tuus, id est decucurrit ad hunc finem ad quem quae feliciora partu tuo putas properant. Hoc omnis ista quae in foro litigat, in theatris plaudit, in templis precatur turba dispari gradu vadit: et quae diligis, veneraris et quae despicis unus exaequabit cinis. Hoc videlicet illa Pythicis oraculis adscripta vox: NOSCE TE. Quid est homo? Quolibet quassu vas et quolibet fragile iactatu. Non tempestate magna ut dissiperis opus est: ubicumque arietaveris, solveris. Quid est homo? Inbecillum corpus et fragile, nudum, suapte natura inerme, alienae opis indigens, ad omnis fortunae contumelias proiectum, cum bene lacertos exercuit, cuiuslibet ferae pabulum, cuiuslibet victima; ex infirmis fluidisque contextum et lineamentis exterioribus nitidum, frigoris aestus laboris inpatiens, ipso rursus situ et otio iturum in tabem, alimenta metuens sua, quorum modo inopia deficit, modo copia rumpitur; anxiae sollicitaeque tutelae, precarii spiritus et male haerentis, quod pavor repentinus aut auditus ex inproviso sonus auribus gravis excutit, sollicitudinis semper sibi nutrimentum, vitiosum et inutile. Miramur in hoc mortem, quae unius singultus opus est? Numquid enim ut concidat magni res molimenti est? Odor illi saporque et lassitudo et vigilia et umor et cibus et sine quibus vivere non potest mortifera sunt; quocumque se movit, statim infirmitatis suae conscium, non omne caelum ferens, aquarum novitatibus flatuque non familiaris aurae et tenuissimis causis atque offensionibus morbidum, putre causarium, fletu vitam auspicatum, cum interim quantos tumultus hoc tam contemptum animal movet, in quantas cogitationes oblitum condicionis suae venit! Inmortalia, aeterna volutat animo et in nepotes pronepotesque disponit, cum interim longa conantem eum mors opprimit et hoc quod senectus vocatur paucissimorum est circumitus annorum. 12. Dolor tuus, si modo ulla illi ratio est, utrum sua spectat incommoda an eius qui decessit? Utrum te in amisso filio movet quod nullas ex illo voluptates cepisti, an quod maiores, si diutius vixisset, percipere potuisti? Si nullas percepisse te dixeris, tolerabilius efficies detrimentum tuum; minus enim homines
desiderant ea ex quibus nihil gaudi laetitiaeque perceperant. Si confessa fueris percepisse magnas voluptates, oportet te non de eo quod detractum est queri, sed de eo gratias agere quod contigit; provenerunt enim satis magni fructus laborum tuorum ex ipsa educatione, nisi forte ii qui catulos avesque et frivola animorum oblectamenta summa diligentia nutriunt fruuntur aliqua voluptate ex visu tactuque et blanda adulatione mutorum, liberos nutrientibus non fructus educationis ipsa educatio est. Licet itaque nil tibi industria eius contulerit, nihil diligentia custodierit, nihil prudentia suaserit, ipsum quod habuisti, quod amasti, fructus est. «At potuit longior esse, maior». Melius tamen tecum actum est quam si omnino non contigisset, quoniam, si ponatur electio utrum satius sit non diu felicem esse an numquam, melius est discessura nobis bona quam nulla contingere. Utrumne malles degenerem aliquem et numerum tantum nomenque filii expleturum habuisse an tantae indolis quantae tuus fuit, iuvenis cito prudens, cito pius, cito maritus, cito pater, cito omnis officii curiosus, cito sacerdos, omnia tamquam properans? Nulli fere et magna bona et diuturna contingunt, non durat nec ad ultimum exit nisi lenta felicitas: filium tibi di inmortales non diu daturi statim talem dederunt qualis diu effici vix potest. Ne illud quidem dicere potes, electam te a dis cui frui non liceret filio: circumfer per omnem notorum, ignotorum frequentiam oculos, occurrent tibi passi ubique maiora. Senserunt ista magni duces, senserunt principes; ne deos quidem fabulae immunes reliquerunt, puto, ut nostrorum funerum levamentum esset etiam divina concidere. Circumspice, inquam, omnis: nullam tam miseram nominabis domum quae non inveniat in miseriore solacium. Non mehercules tam male de moribus tuis sentio ut putem posse te levius pati casum tuum, si tibi ingentem lugentium numerum produxero: malivolum solacii genus est turba miserorum. Quosdam tamen referam, non ut scias hoc solere hominibus accidere – ridiculum est enim mortalitatis exempla colligere – sed ut scias fuisse multos qui lenirent aspera placide ferendo. A felicissimo incipiam. L. Sulla filium amisit, nec ea res aut malitiam eius et acerrimam virtutem in hostes civesque contudit aut effecit ut cognomen illud usurpasse falso videretur, quod amisso filio adsumpsit nec odia hominum veritus, quorum malo illae nimis secundae res constabant, nec invidiam deorum, quorum illud crimen erat, Sulla tam felix. Sed istud inter res nondum iudicatas abeat, qualis Sulla fuerit – etiam inimici fatebuntur bene illum arma sumpsisse, bene posuisse: hoc de quo agitur constabit, non esse maximum malum quod etiam ad felicissimos pervenit. 13. Ne nimis admiretur Graecia illum patrem qui in ipso sacrificio nuntiata filii morte tibicinem tantum tacere iussit et coronam capiti detraxit, cetera rite perfecit, Pulvillus effecit pontifex, cui postem tenenti et Capitolium dedicanti mors filii nuntiata est. Quam ille exaudisse dissimulavit et sollemnia pontificii carminis verba concepit gemitu non interrumpente precationem et ad filii sui nomen Iove propitiato. Putasne eius luctus aliquem finem esse debere, cuius primus dies et primus impetus ab altaribus publicis et fausta nuncupatione non
abduxit patrem? Dignus mehercules fuit memorabili dedicatione, dignus amplissimo sacerdotio, qui colere deos ne iratos quidem destitit. Idem tamen, ut redit domum, et inplevit oculos et aliquas voces flebiles misit; sed peractis quae mos erat praestare defunctis ad Capitolinum illum redit vultum. Paulus circa illos nobilissimi triumphi dies quo vinctum ante currum egit Persen duos filios in adoptionem dedit, duos quos sibi servaverat extulit. Quales retentos putas, cum inter commodatos Scipio fuisset? Non sine motu vacuum Pauli currum populus Romanus aspexit. Contionatus est tamen et egit dis gratias quod compos voti factus esset; precatum enim se ut, si quid ob ingentem victoriam invidiae dandum esset, id suo potius quam publico damno solveretur. Vides quam magno animo tulerit? Orbitati suae gratulatus est. Et quem magis poterat permovere tanta mutatio? Solacia simul atque auxilia perdidit. Non contigit tamen tristem Paulum Persi videre. 14. Quid nunc te per innumerabilia magnorum virorum exempla ducam et quaeram miseros, quasi non difficilius sit invenire felices? Quota enim quaeque domus usque ad exitum omnibus partibus suis constitit, in qua non aliquid turbatum sit? Unum quemlibet annum occupa et ex eo magistratus cita, Lucium si vis Bibulum et C. Caesarem: videbis inter collegas inimicissimos concordem fortunam. L. Bibuli, melioris quam fortioris viri, duo simul filii interfecti sunt, Aegyptio quidem militi ludibrio habiti, ut non minus ipsa orbitate auctor eius digna res lacrimis esset. Bibulus tamen, qui toto honoris sui anno in invidiam collegae domi latuerat, postero die quam geminum funus renuntiatum est processit ad solita imperatoris officia. Quis minus potest quam unum diem duobus filiis dare? Tam cito liberorum luctum finivit qui consulatum anno luxerat. C. Caesar cum Britanniam peragraret nec oceano continere felicitatem suam posset, audit decessisse filiam publica secum fata ducentem. In oculis erat iam Cn. Pompeius non aequo laturus animo quemquam alium esse in re publica magnum et modum inpositurus incrementis, quae gravia illi videbantur etiam cum in commune cresceret. Tamen intra tertium diem imperatoria obit munia et tam cito dolorem vicit quam omnia solebat. 15. Quid aliorum tibi funera Caesarum referam? Quos in hoc mihi videtur interim violare fortuna ut sic quoque generi humano prosint, ostendentes ne eos quidem qui dis geniti deosque genituri dicantur sic suam fortunam in potestate habere quemadmodum alienam. Divus Augustus amissis liberis, nepotibus, exhausta Caesarum turba, adoptione desertam domum fulsit: tulit tamen tam fortiter quam cuius iam res agebatur cuiusque maxime intererat de dis neminem queri. Ti. Caesar et quem genuerat et quem adoptaverat amisit; ipse tamen pro rostris laudavit filium stetitque in conspectu posito corpore, interiecto tantummodo velamento quod pontificis oculos a funere arceret, et flente populo Romano non flexit vultum; experiendum se dedit Seiano ad latus stanti quam patienter posset suos perdere.
Videsne quanta copia virorum maximorum sit quos non excepit hic omnia prosternens casus, et in quos tot animi bona, tot ornamenta publice privatimque congesta erant? Sed videlicet it in orbem ista tempestas et sine dilectu vastat omnia agitque ut sua. Iube singulos conferre rationem: nulli contigit inpune nasci. 16. Scio quid dicas: «oblitus es feminam te consolari, virorum refers exempla». Quis autem dixit naturam maligne cum mulierum ingeniis egisse et virtutes illarum in artum retraxisse? Par illis, mihi crede, vigor, par ad honesta, libeat modo, facultas est; dolorem laboremque ex aequo, si consuevere, patiuntur. In qua istud urbe, di boni, loquimur? In qua regem Romanis capitibus Lucretia et Brutus deiecerunt: Bruto libertatem debemus, Lucretiae Brutum; in qua Cloeliam contempto et hoste et flumine ob insignem audaciam tantum non in viros transcripsimus: equestri insidens statuae in sacra via, celeberrimo loco, Cloelia exprobrat iuvenibus nostris pulvinum escendentibus in ea illos urbe sic ingredi in qua etiam feminas equo donavimus. Quod tibi si vis exempla referri feminarum quae suos fortiter desideraverint, non ostiatim quaeram; ex una tibi familia duas Cornelias dabo: primam Scipionis filiam, Gracchorum matrem. Duodecim illa partus totidem funeribus recognovit; et de ceteris facile est, quos nec editos nec amissos civitas sensit: Tiberium Gaiumque, quos etiam qui bonos viros negaverit magnos fatebitur, et occisos vidit et insepultos. Consolantibus tamen miseramque dicentibus «numquam» inquit «non felicem me dicam, quae Gracchos peperi». Cornelia Livi Drusi clarissimum iuvenem inlustris ingenii, vadentem per Gracchana vestigia inperfectis tot rogationibus intra penates interemptum suos, amiserat incerto caedis auctore. Tamen et acerbam mortem filii et inultam tam magno animo tulit quam ipse leges tulerat. Iam cum fortuna in gratiam, Marcia, reverteris, si tela quae in Scipiones Scipionumque matres ac filias exegit, quibus Caesares petit, ne a te quidem continuit? Plena et infesta variis casibus vita est, a quibus nulli longa pax, vix indutiae sunt. Quattuor liberos sustuleras, Marcia. Nullum aiunt frustra cadere telum quod in confertum agmen inmissum est: mirum est tantam turbam non potuisse sine invidia damnove praetervehi? «At hoc iniquior fortuna fuit quod non tantum eripuit filios sed elegit». Numquam tamen iniuriam dixeris ex aequo cum potentiore dividere: duas tibi reliquit filias et harum nepotes; et ipsum quem maxime luges prioris oblita non ex toto abstulit: habes ex illo duas filias, si male fers, magna onera, si bene, magna solacia. In hoc te perduc ut illas cum videris admonearis filii, non doloris. Agricola eversis arboribus quas aut ventus radicitus avolsit aut contortus repentino impetu turbo praefregit sobolem ex illis residuam fovet et in locum amissarum semina statim plantasque disponit; et momento (nam ut ad damna, ita ad incrementa rapidum veloxque tempus est) adolescunt amissis laetiora. Has nunc Metili tui filias in eius vicem substitue et vacantem locum exple et unum dolorem geminato solacio leva. Est quidem haec natura mortalium, ut nihil magis placeat quam quod amissum est: iniquiores sumus adversus relicta ereptorum desiderio. Sed si aestimare volueris quam
valde tibi fortuna, etiam cum saeviret, pepercerit, scies te habere plus quam solacia: respice tot nepotes, duas filias. Dic illud quoque, Marcia: «moverer, si esset cuique fortuna pro moribus et numquam mala bonos sequerentur: nunc video exempto discrimine eodem modo malos bonosque iactari». 17. «Grave est tamen quem educaveris iuvenem, iam matri iam patri praesidium ac decus amittere». Quis negat grave esse? Sed humanum est. Ad hoc genitus es, ut perderes ut perires, ut sperares metueres, alios teque inquietares, mortem et timeres et optares et, quod est pessimum, numquam scires cuius esses status. Si quis Syracusas petenti diceret: «omnia incommoda, omnes voluptates futurae peregrinationis tuae ante cognosce, deinde ita naviga. Haec sunt quae mirari possis: videbis primum ipsam insulam ab Italia angusto interscissam freto, quam continenti quondam cohaesisse constat; subitum illo mare inrupit et Hesperium Siculo latus abscidit. Deinde videbis (licebit enim tibi avidissimum maris verticem stringere) stratam illam fabulosam Charybdin quam diu ab austro vacat, at, si quid inde vehementius spiravit, magno hiatu profundoque navigia sorbentem. Videbis celebratissimum carminibus fontem Arethusam, nitidissimi ac perlucidi ad imum stagni, gelidissimas aquas profundentem, sive illas ibi primum nascentis invenit, sive inlapsum terris flumen integrum subter tot maria et a confusione peioris undae servatum reddidit. Videbis portum quietissimum omnium quos aut natura posuit in tutelam classium aut adiuvit manus, sic tutum ut ne maximarum quidem tempestatium furori locus sit. Videbis ubi Athenarum potentia fracta, ubi tot milia captivorum ille excisis in infinitam altitudinem saxis nativus carcer incluserat, ipsam ingentem civitatem et laxius territorium quam multarum urbium fines sunt, tepidissima hiberna et nullum diem sine interventu solis. Sed cum omnia ista cognoveris, gravis et insalubris aestas hiberni caeli beneficia corrumpet. Erit Dionysius illic tyrannus, libertatis iustitiae legum exitium, dominationis cupidus etiam post Platonem, vitae etiam post exilium: alios uret, alios verberabit, alios ob levem offensam detruncari iubebit, arcesset ad libidinem mares feminasque et inter foedos regiae intemperantiae greges parum erit simul binis coire. Audisti quid te invitare possit, quid absterrere: proinde aut naviga aut resiste». Post hanc denuntiationem si quis dixisset intrare se Syracusas velle, satisne iustam querellam de ullo nisi de se habere posset, qui non incidisset in illa sed prudens sciensque venisset? Dicit omnibus nobis natura: «neminem decipio. Tu si filios sustuleris, poteris habere formosos, et deformes poteris. Fortasse multi nascentur: esse aliquis ex illis tam servator patriae quam proditor poterit. Non est quod desperes tantae dignationis futuros ut nemo tibi propter illos male dicere audeat; propone tamen et tantae futuros turpitudinis ut ipsi maledicta sint. Nihil vetat illos tibi suprema praestare et laudari te a liberis tuis, sed sic te para tamquam in ignem inpositurus vel puerum vel iuvenem vel senem; nihil enim ad
rem pertinent anni, quoniam nullum non acerbum funus est quod parens sequitur». Post has leges propositas si liberos tollis, omni deos invidia liberas, qui tibi nihil certi spoponderunt. 18. Ad hanc imaginem agedum totius vitae introitum refer. An Syracusas viseres deliberanti tibi quidquid delectare poterat, quidquid offendere exposui: puta nascenti me tibi venire in consilium. «Intraturus es urbem dis hominibus communem, omnia complexam, certis legibus aeternisque devinctam, indefatigata caelestium officia volventem. Videbis illic innumerabiles stellas micare, videbis uno sidere omnia inpleri, solem cotidiano cursu diei noctisque spatia signantem, annuo aestates hiemesque aequalius[que] dividentem. Videbis nocturnam lunae successionem, a fraternis occursibus lene remissumque lumen mutuantem et modo occultam modo toto ore terris imminentem, accessionibus damnisque mutabilem, semper proximae dissimilem. Videbis quinque sidera diversas agentia vias et in contrarium praecipiti mundo nitentia: ex horum levissimis motibus fortunae populorum dependent et maxima ac minima proinde formantur prout aequum iniquumve sidus incessit. Miraberis collecta nubila et cadentis aquas et obliqua fulmina et caeli fragorem. Cum satiatus spectaculo supernorum in terram oculos deieceris, excipiet te alia forma rerum aliterque mirabilis: hinc camporum in infinitum patentium fusa planities, hinc montium magnis et nivalibus surgentium iugis erecti in sublime vertices; deiectus fluminum et ex uno fonte in occidentem orientemque diffusi amnes et summis cacuminibus nemora nutantia et tantum silvarum cum suis animalibus aviumque concentu dissono; varii urbium situs et seclusae nationes locorum difficultate, quarum aliae se in erectos subtrahunt montes, aliae †ripis lacu vallibus pavidae† circumfunduntur; adiuta cultu seges et arbusta sine cultore feritatis; et rivorum lenis inter prata discursus et amoeni sinus et litora in portum recedentia; sparsae tot per vastum insulae, quae interventu suo maria distinguunt. Quid lapidum gemmarumque fulgor et rapidorum torrentium aurum harenis interfluens et in mediis terris medioque rursus mari †terret† ignium faces et vinculum terrarum oceanus, continuationem gentium triplici sinu scindens et ingenti licentia exaestuans? Videbis hic inquietis et sine vento fluctuantibus aquis innare excedenti terrestria magnitudine animalia, quaedam gravia et alieno se magisterio moventia, quaedam velocia et concitatis perniciora remigiis, quaedam haurientia undas et magno praenavigantium periculo efflantia; videbis hic navigia quas non novere terras quaerentia. Videbis nihil humanae audaciae intemptatum erisque et spectator et ipse pars magna conantium: disces docebisque artes, alias quae vitam instruant, alias quae ornent, alias quae regant. Sed istic erunt mille corporum, animorum pestes, et bella et latrocinia et venena et naufragia et intemperies caeli corporisque et carissimorum acerba desideria et mors, incertum facilis an per poenam cruciatumque. Delibera tecum et perpende quid velis: ut ad illa venias, per illa exeundum est». Respondebis velle te vivere. Quidni? Immo, puto, ad id non accedes ex quo tibi aliquid decuti doles! Vive
ergo ut convenit. «Nemo» inquis «nos consuluit». Consulti sunt de nobis parentes nostri, qui, cum condicionem vitae nossent, in hanc nos sustulerunt. 19. Sed ut ad solacia veniam, videamus primum quid curandum sit, deinde quemadmodum. Movet lugentem desiderium eius quem dilexit. Id per se tolerabile esse apparet; absentis enim afuturosque dum vivent non flemus, quamvis omnis usus nobis illorum cum conspectu ereptus sit; opinio est ergo quae nos cruciat, et tanti quodque malum est quanti illud taxavimus. In nostra potestate remedium habemus: iudicemus illos abesse et nosmet ipsi fallamus; dimisimus illos, immo consecuturi praemisimus. Movet et illud lugentem: «non erit qui me defendat, qui a contemptu vindicet». Ut minime probabili sed vero solacio utar, in civitate nostra plus gratiae orbitas confert quam eripit, adeoque senectutem solitudo, quae solebat destruere, ad potentiam ducit ut quidam odia filiorum simulent et liberos eiurent, orbitatem manu faciant. Scio quid dicas: «non movent me detrimenta mea; etenim non est dignus solacio qui filium sibi decessisse sicut mancipium moleste fert, cui quicquam in filio respicere praeter ipsum vacat». Quid igitur te, Marcia, movet? Utrum quod filius tuus decessit an quod non diu vixit? Si quod decessit, semper debuisti dolere; semper enim scisti moriturum. Cogita nullis defunctum malis adfici, illa quae nobis inferos faciunt terribiles, fabulas esse, nullas imminere mortuis tenebras nec carcerem nec flumina igne flagrantia nec Oblivionem amnem nec tribunalia et reos et in illa libertate tam laxa ullos iterum tyrannos: luserunt ista poetae et vanis nos agitavere terroribus. Mors dolorum omnium exsolutio est et finis ultra quem mala nostra non exeunt, quae nos in illam tranquillitatem in qua antequam nasceremur iacuimus reponit. Si mortuorum aliquis miseretur, et non natorum misereatur. Mors nec bonum nec malum est; id enim potest aut bonum aut malum esse quod aliquid est; quod vero ipsum nihil est et omnia in nihilum redigit, nulli nos fortunae tradit. Mala enim bonaque circa aliquam versantur materiam: non potest id fortuna tenere quod natura dimisit, nec potest miser esse qui nullus est. Excessit filius tuus terminos intra quos servitur, excepit illum magna et aeterna pax: non paupertatis metu, non divitiarum cura, non libidinis per voluptatem animos carpentis stimulis incessitur, non invidia felicitatis alienae tangitur, non suae premitur, ne conviciis quidem ullis verecundae aures verberantur; nulla publica clades prospicitur, nulla privata; non sollicitus futuri pendet ex eventu semper †in certiora dependenti†. Tandem ibi constitit unde nil eum pellat, ubi nihil terreat. 20. O ignaros malorum suorum, quibus non mors ut optimum inventum naturae laudatur expectaturque, sive felicitatem includit, sive calamitatem repellit, sive satietatem ac lassitudinem senis terminat, sive iuvenile aevum dum meliora sperantur in flore deducit, sive pueritiam ante duriores gradus revocat, omnibus finis, multis remedium, quibusdam votum, de nullis melius merita quam de iis ad quos venit antequam invocaretur. Haec servitutem invito domino remittit; haec
captivorum catenas levat; haec e carcere educit quos exire imperium inpotens vetuerat; haec exulibus in patriam semper animum oculosque tendentibus ostendit nihil interesse infra quos quis iaceat; haec, ubi res communes fortuna male divisit et aequo iure genitos alium alii donavit, exaequat omnia; haec est post quam nihil quisquam alieno fecit arbitrio; haec est in qua nemo humilitatem suam sensit; haec est quae nulli non patuit; haec est, Marcia, quam pater tuus concupit; haec est, inquam, quae efficit ut nasci non sit supplicium, quae efficit ut non concidam adversus minas casuum, ut servare animum salvum ac potentem sui possim: habeo quod appellem. Video istic cruces ne unius quidem generis sed aliter ab aliis fabricatas: capite quidam conversos in terram suspendere, alii per obscena stipitem egerunt, alii brachia patibulo explicuerunt; video fidiculas, video verbera, et †membris singulis articulis† singula †docuerunt† machinamenta: sed video et mortem. Sunt istic hostes cruenti, cives superbi: sed video istic et mortem. Non est molestum servire ubi, si dominii pertaesum est, licet uno gradu ad libertatem transire. Caram te, vita, beneficio mortis habeo. Cogita quantum boni opportuna mors habeat, quam multis diutius vixisse nocuerit. Si Gnaeum Pompeium, decus istud firmamentumque imperii, Neapoli valetudo abstulisset, indubitatus populi Romani princeps excesserat: at nunc exigui temporis adiectio fastigio illum suo depulit. Vidit legiones in conspectu suo caesas et ex illo proelio in quo prima acies senatus fuit – quam infelices reliquiae sunt! – ipsum imperatorem superfuisse; vidit Aegyptium carnificem et sacrosanctum victoribus corpus satelliti praestitit, etiam si incolumis fuisset paenitentiam salutis acturus; quid enim erat turpius quam Pompeium vivere beneficio regis? M. Cicero si illo tempore quo Catilinae sicas devitavit, quibus pariter cum patria petitus est, concidisset, liberata re publica servator eius, si denique filiae suae funus secutus esset, etiamtunc felix mori potuit. Non vidisset strictos in civilia capita mucrones nec divisa percussoribus occisorum bona, ut etiam de suo perirent, non hastam consularia spolia vendentem nec caedes locatas publice nec latrocinia, bella, rapinas, tantum Catilinarum. M. Catonem si a Cypro et hereditatis regiae dispensatione redeuntem mare devorasset vel cum illa ipsa pecunia quam adferebat civili bello stipendium, nonne illi bene actum foret? Hoc certe secum tulisset, neminem ausurum coram Catone peccare: nunc annorum adiectio paucissimorum virum libertati non suae tantum sed publicae natum coegit Caesarem fugere, Pompeium sequi. Nihil ergo illi mali inmatura mors attulit: omnium etiam malorum remisit patientiam. 21. «Nimis tamen cito perit et inmaturus». Primum puta illi superfuisse – comprende quantum plurimum procedere homini licet: quantum est? Ad brevissimum tempus editi, cito cessuri loco venienti inpactum hoc prospicimus hospitium. De nostris aetatibus loquor, quas incredibili celeritate †convolvit†? Computa urbium saecula: videbis quam non diu steterint etiam quae vetustate gloriantur. Omnia humana brevia et caduca sunt et infiniti temporis nullam partem occupantia. Terram hanc cum urbibus populisque et fluminibus et ambitu maris
puncti loco ponimus ad universa referentes: minorem portionem aetas nostra quam puncti habet, si omni tempori comparetur, cuius maior est mensura quam mundi, utpote cum ille se intra huius spatium totiens remetiatur. Quid ergo interest id extendere cuius quantumcumque fuerit incrementum non multum aberit a nihilo? Uno modo multum est quod vivimus, si satis est. Licet mihi vivaces et in memoriam traditae senectutis viros nomines, centenos denosque percenseas annos: cum ad omne tempus dimiseris animum, nulla erit illa brevissimi longissimique aevi differentia, si inspecto quanto quis vixerit spatio comparaveris quanto non vixerit. Deinde sibi maturus decessit; vixit enim quantum debuit vivere, nihil illi iam ultra supererat. Non una hominibus senectus est, ut ne animalibus quidem: intra quattuordecim quaedam annos defetigavit, et haec illis longissima aetas est quae homini prima; dispar cuique vivendi facultas data est. Nemo nimis cito moritur, quia victurus diutius quam vixit non fuit. Fixus est cuique terminus: manebit semper ubi positus est nec illum ulterius diligentia aut gratia promovebit. Sic habe, te illum ex consilio perdidisse: tulit suum metasque dati pervenit ad aevi. Non est itaque quod sic te oneres: «potuit diutius vivere». Non est interrupta eius vita nec umquam se annis casus intericit. Solvitur quod cuique promissum est; eunt via sua fata nec adiciunt quicquam nec ex promisso semel demunt. Frustra vota ac studia sunt: habebit quisque quantum illi dies primus adscripsit. Ex illo quo primum lucem vidit iter mortis ingressus est accessitque fato propior et illi ipsi qui adiciebantur adulescentiae anni vitae detrahebantur. In hoc omnes errore versamur, ut non putemus ad mortem nisi senes inclinatosque iam vergere, cum illo infantia statim et iuventa, omnis aetas ferat. Agunt opus suum fata: nobis sensum nostrae necis auferunt, quoque facilius obrepat, mors sub ipso vitae nomine latet: infantiam in se pueritia convertit, pueritiam pubertas, iuvenem senex abstulit. Incrementa ipsa, si bene computes, damna sunt. 22. Quereris, Marcia, non tam diu filium tuum vixisse quam potuisset? Unde enim scis an diutius illi expedierit vivere, an illi hac morte consultum sit? Quemquam invenire hodie potes cuius res tam bene positae fundataeque sint ut nihil illi procedente tempore timendum sit? Labant humana ac fluunt neque ulla pars vitae nostrae tam obnoxia aut tenera est quam quae maxime placet, ideoque felicissimis optanda mors est, quia in tanta inconstantia turbaque rerum nihil nisi quod praeterit certum est. Quis tibi recipit illud fili tui pulcherrimum corpus et summa pudoris custodia inter luxuriosae urbis oculos conservatum potuisse tot morbos ita evadere ut ad senectutem inlaesum perferret formae decus? Cogita animi mille labes; neque enim recta ingenia qualem in adulescentia spem sui fecerant usque in senectutem pertulerunt, sed interversa plerumque sunt: aut sera eoque foedior luxuria invasit coepitque dehonestare speciosa principia, aut in
popinam ventremque procubuerunt toti summaque illis curarum fuit quid essent, quid biberent. Adice incendia ruinas naufragia lacerationesque medicorum ossa vivis legentium et totas in viscera manus demittentium et non per simplicem dolorem pudenda curantium; post haec exilium (non fuit innocentior filius tuus quam Rutilius), carcerem (non fuit sapientior quam Socrates), voluntario vulnere transfixum pectus (non fuit sanctior quam Cato): cum ista perspexeris, scies optime cum iis agi quos natura, quia illos hoc manebat vitae stipendium, cito in tutum recepit. Nihil est tam fallax quam vita humana, nihil tam insidiosum: non mehercules quisquam illam accepisset, nisi daretur ignorantibus. Itaque si felicissimum est non nasci, proximum est, puto, brevi aetate defunctos cito in integrum restitui. Propone illud acerbissimum tibi tempus, quo Seianus patrem tuum clienti suo Satrio Secundo congiarium dedit. Irascebatur illi ob unum aut alterum liberius dictum, quod tacitus ferre non potuerat Seianum in cervices nostras ne inponi quidem sed escendere. Decernebatur illi statua in Pompei theatro ponenda, quod exustum Caesar reficiebat: exclamavit Cordus tunc vere theatrum perire. Quid ergo? Non rumperetur supra cineres Cn. Pompei constitui Seianum et in monumentis maximi imperatoris consecrari perfidum militem? Consignatur subscriptio, et acerrimi canes, quos ille, ut sibi uni mansuetos, omnibus feros haberet, sanguine humano pascebat, circumlatrare hominem etiam illo periculo interritum incipiunt. Quid faceret? Si vivere vellet, Seianus rogandus erat, si mori, filia, uterque inexorabilis: constituit filiam fallere. Usus itaque balineo quo plus virium poneret, in cubiculum se quasi gustaturus contulit et dimissis pueris quaedam per fenestram, ut videretur edisse, proiecit; a cena deinde, quasi iam satis in cubiculo edisset, abstinuit. Altero quoque die et tertio idem fecit; quartus ipsa infirmitate corporis faciebat indicium. Complexus itaque te, «carissima» inquit «filia et hoc unum tota celata vita, iter mortis ingressus sum et iam medium fere teneo; revocare me nec debes nec potes». Atque ita iussit lumen omne praecludi et se in tenebras condidit. Cognito consilio eius publica voluptas erat, quod e faucibus avidissimorum luporum educeretur praeda. Accusatores auctore Seiano adeunt consulum tribunalia, queruntur mori Cordum, ut interpellarent quod coegerant: adeo illis Cordus videbatur effugere. Magna res erat in quaestione, an mortis ius rei perderent; dum deliberatur, dum accusatores iterum adeunt, ille se absolverat. Videsne, Marcia, quantae iniquorum temporum vices ex inopinato ingruant? Fles quod alicui tuorum mori necesse fuit? Paene non licuit. 23. Praeter hoc quod omne futurum incertum est et ad deteriora certius, facillimum ad superos iter est animis cito ab humana conversatione dimissis; minimum enim faecis, ponderis traxerunt. Antequam obdurescerent et altius terrena conciperent liberati leviores ad originem suam revolant et facilius quidquid est illud obsoleti inlitique eluunt. Nec umquam magnis ingeniis cara in corpore mora est: exire atque erumpere gestiunt, aegre has angustias ferunt,
vagari per omne sublimes et ex alto adsueti humana despicere. Inde est quod Platon clamat: sapientis animum totum in mortem prominere, hoc velle, hoc meditari, hac semper cupidine ferri in exteriora tendentem. Quid? Tu, Marcia, cum videres senilem in iuvene prudentiam, victorem omnium voluptatium animum, emendatum, carentem vitio, divitias sine avaritia, honores sine ambitione, voluptates sine luxuria adpetentem, diu tibi putabas illum sospitem posse contingere? Quidquid ad summum pervenit ab exitu prope est; eripit se aufertque ex oculis perfecta virtus, nec ultimum tempus expectant quae in primo maturuerunt. Ignis quo clarior fulsit citius extinguitur: vivacior est qui cum lenta ac difficili materia commissus fumoque demersus ex sordido lucet; eadem enim detinet causa quae maligne alit. Sic ingenia quo inlustriora, breviora sunt; nam ubi incremento locus non est, vicinus occasus est. Fabianus ait, id quod nostri quoque parentes videre, puerum Romae fuisse statura ingentis viri ante annos; sed hic cito decessit, et moriturum brevi nemo non prudens dixit; non poterat enim ad illam aetatem pervenire quam praeceperat. Ita est: indicium imminentis exitii nimia maturitas est; adpetit finis ubi incrementa consumpta sunt. 24. Incipe virtutibus illum, non annis aestimare: satis diu vixit. Pupillus relictus sub tutorum cura usque ad quartum decimum annum fuit, sub matris tutela semper. Cum haberet suos penates, relinquere tuos noluit et in materno contubernio, cum vix paternum liberi ferant, perseveravit. Adulescens statura, pulchritudine, certo corporis robore castris natus militiam recusavit, ne a te discederet. Computa, Marcia, quam raro liberos videant quae in diversis domibus habitant; cogita tot illos perire annos matribus et per sollicitudinem exigi quibus filios in exercitu habent: scies multum patuisse hoc tempus ex quo nil perdidisti. Numquam e conspectu tuo recessit; sub oculis tuis studia formavit excellentis ingeni et aequaturi avum nisi obstitisset verecundia, quae multorum profectus silentio pressit. Adulescens rarissimae formae in tam magna feminarum turba viros corrumpentium nullius se spei praebuit, et cum quarundam usque ad temptandum pervenisset inprobitas, erubuit quasi peccasset quod placuerat. Hac sanctitate morum effecit ut puer admodum dignus sacerdotio videretur, materna sine dubio suffragatione, sed ne mater quidem nisi pro bono candidato valuisset. Harum contemplatione virtutum filium gere quasi sinu. Nunc ille tibi magis vacat, nunc nihil habet quo avocetur; numquam tibi sollicitudini, numquam maerori erit. Quod unum ex tam bono filio poteras dolere, doluisti: cetera, exempta casibus, plena voluptatis sunt, si modo uti filio scis, si modo quid in illo pretiosissimum fuerit intellegis. Imago dumtaxat fili tui perit et effigies non simillima, ipse quidem aeternus meliorisque nunc status est, despoliatus oneribus alienis et sibi relictus. Haec quae vides circumiecta nobis, ossa nervos et obductam cutem vultumque et ministras manus et cetera quibus involuti sumus, vincula animorum tenebraeque sunt; obruitur his, offocatur inficitur, arcetur a veris et suis in falsa coiectus. Omne illi cum hac gravi carne certamen est, ne abstrahatur et sidat; nititur illo unde demissus est. Ibi illum aeterna requies manet
ex confusis crassisque pura et liquida visentem. 25. Proinde non est quod ad sepulcrum fili tui curras: pessima eius et ipsi molestissima istic iacent, ossa cineresque, non magis illius partes quam vestes aliaque tegimenta corporum. Integer ille nihilque in terris relinquens sui fugit et totus excessit; paulumque supra nos commoratus, dum expurgatur et inhaerentia vitia situmque omnem mortalis aevi excutit, deinde ad excelsa sublatus inter felices currit animas. Excepit illum coetus sacer, Scipiones Catonesque, interque contemptores vitae et mortis beneficio liberos parens tuus, Marcia. Ille nepotem suum – quamquam illic omnibus omne cognatum est – adplicat sibi nova luce gaudentem et vicinorum siderum meatus docet, nec ex coniectura sed omnium ex vero peritus in arcana naturae libens ducit; utque ignotarum urbium monstrator hospiti gratus est, ita sciscitanti caelestium causas domesticus interpres. Et in profunda terrarum permittere aciem iubet; iuvat enim ex alto relicta despicere. Sic itaque te, Marcia, gere, tamquam sub oculis patris filique posita, non illorum quos noveras, sed tanto excelsiorum et in summo locatorum. Erubesce quicquam humile aut vulgare cogitare et mutatos in melius tuos flere. Aeternarum rerum per libera et vasta spatia dimissos non illos interfusa maria discludunt nec altitudo montium aut inviae valles aut incertarum vada Syrtium: omnia in plano habent et ex facili mobiles et expediti et in vicem pervii sunt intermixtique sideribus. 26. Puta itaque ex illa arce caelesti patrem tuum, Marcia, cui tantum apud te auctoritatis erat quantum tibi apud filium tuum, non illo ingenio quo civilia bella deflevit, quo proscribentis in aeternum ipse proscripsit, sed tanto elatiore quanto est ipse sublimior dicere: «cur te, filia, tam longa tenet aegritudo? Cur in tanta veri ignoratione versaris ut inique actum cum filio tuo iudices quod integro domus statu integer ipse se ad maiores recepit suos? Nescis quantis fortuna procellis disturbet omnia, quam nullis benignam facilemque se praestiterit nisi qui minimum cum illa contraxerant? Regesne tibi nominem felicissimos futuros si maturius illos mors instantibus subtraxisset malis? An Romanos duces, quorum nihil magnitudini deerit si aliquid aetati detraxeris? An nobilissimos viros clarissimosque ad ictum militaris gladi composita cervice firmatos? Respice patrem atque avum tuum: ille in alieni percussoris venit arbitrium; ego nihil in me cuiquam permisi et cibo prohibitus ostendi tam magno me quam vivebam animo scripsisse. Cur in domo nostra diutissime lugetur qui felicissime moritur? Coimus omnes in unum videmusque non alta nocte circumdati nil apud vos, ut putatis, optabile, nil excelsum, nil splendidum, sed humilia cuncta et gravia et anxia et quotam partem luminis nostri cernentia! Quid dicam nulla hic arma mutuis furere concursibus nec classes classibus frangi nec parricidia aut fingi aut cogitari nec fora litibus strepere dies perpetuos, nihil in obscuro, detectas mentes et aperta praecordia et in publico medioque vitam et omnis aevi prospectum venientiumque? Iuvabat unius me saeculi facta componere in parte ultima mundi
et inter paucissimos gesta: tot saecula, tot aetatium contextum, seriem, quidquid annorum est, licet visere; licet surrectura, licet ruitura regna prospicere et magnarum urbium lapsus et maris novos cursus. Nam si tibi potest solacio esse desideri tui commune fatum, nihil quo stat loco stabit, omnia sternet abducetque secum vetustas. Nec hominibus solum (quota enim ista fortuitae potentiae portio est?) sed locis, sed regionibus, sed mundi partibus ludet. Totos supprimet montes et alibi rupes in altum novas exprimet; maria sorbebit, flumina avertet et commercio gentium rupto societatem generis humani coetumque dissolvet; alibi hiatibus vastis subducet urbes, tremoribus quatiet, et ex infimo pestilentiae halitus mittet et inundationibus quidquid habitatur obducet necabitque omne animal orbe submerso et ignibus vastis torrebit incendetque mortalia. Et cum tempus advenerit quo se mundus renovaturus extinguat, viribus ista se suis caedent et sidera sideribus incurrent et omni flagrante materia uno igni quidquid nunc ex disposito lucet ardebit. Nos quoque felices animae et aeterna sortitae, cum deo visum erit iterum ista moliri, labentibus cunctis et ipsae parva ruinae ingentis accessio in antiqua elementa vertemur». Felicem filium tuum, Marcia, qui ista iam novit!
Consolazione a Marcia
Premessa L’iniziatore del genere letterario delle “consolazioni” fu Crantore di Soli (morto nel 270 a.C.), che nello scritto Sul dolore (non pervenutoci) opponeva alla dottrina stoica dell’apatia quella della metriopatia (moderazione delle passioni), sostenendo che la vera forza dell’uomo risiede più che nel sopportare il dolore nella volontà di conservare la sensibilità anche nei mali fisici più atroci, «perché l’immunità dal dolore non si ottiene se non pagando un prezzo molto alto: l’abbrutimento dell’anima e la paralisi del corpo». Lo scritto di Crantore divenne il modello dei trattati che andarono sotto il nome di “consolazioni”. Marcia era una nobildonna romana, figlia di Cremuzio Cordo, senatore e storiografo, che negli Annali aveva elogiato Bruto e Cassio, uccisori di Cesare, e che per questo, accusato di lesa maestà da Seiano, prefetto del pretorio e consigliere dell’imperatore Tiberio, dopo essersi difeso, certo della condanna, si era suicidato. L’imperatore diede agli edili l’ordine di bruciare i suoi scritti, che però erano stati ben nascosti e furono poi pubblicati dalla figlia. In quell’occasione Marcia aveva dimostrato un grande coraggio nel sopportare la morte del padre. Ora, rimasta vedova (forse divorziata), dei suoi quattro figli aveva perso i due maschi, fra cui Metilio, il prediletto, morto suicida. Alla data di questa consolatoria erano passati tre anni, ma il rimpianto del figlio era ancora molto forte in Marcia, che, chiusa in un tacito dolore, si era isolata da tutti e usciva di casa solo per recarsi presso la tomba di Metilio. Seneca cerca di dimostrarle che la reazione al dolore per la perdita di una persona cara – che non esiste più – è dovuta a un impulso irrazionale, e che d’altra parte il nostro destino, compreso il momento della morte, è stabilito fin dall’atto della nostra nascita, per cui non serve prendersela con la cattiva sorte (mutari fata non possunt, dice Cicerone). La vita, aggiunge Seneca, comporta una lunga serie di mali e di sventure, e a conforto della propria tesi ricorda a Marcia molti esempi di personaggi illustri che seppero sopportare con animo forte la perdita dei loro cari, per dimostrarle che la malasorte non risparmia nemmeno i potenti. Il dolore può essere attenuato se lo si prevede, se si tiene sempre presente che le disgrazie possono colpirci in ogni momento (come dice Dante, «saetta previsa vien più lenta»). Occorre dunque conservare un ricordo sereno delle persone care che non ci sono più, pensando non al loro corpo e alla loro presenza fisica, ma alla loro anima, che, libera da qualsiasi male e da qualsiasi sofferenza, è tornata al suo luogo di origine, dove gode di una pace eterna e della contemplazione di tutto ciò che è limpido e puro, fuori dalla concretezza della materia. M. S. A.
1. Carissima Marcia, se non sapessi che sei lontana non solo dalle debolezze tipiche delle donne ma anche dai difetti degli altri in generale e che i tuoi costumi sono considerati quasi un esempio dell’antica virtù, non oserei contrastare il tuo dolore, tanto più perché anche gli uomini si lasciano prendere facilmente, sino a compiacersene, dal rimpianto delle persone care, né avrei concepito la speranza che tu stessa, da sola – in un momento così difficile, con un giudice tanto ostile e una tanto odiosa imputazione – potessi liberarti dalla sofferenza che ti ha inflitto la sorte. Di ciò mi hanno fatto sicuro la tua sperimentata forza d’animo e la tua virtù già confermata in una dura prova. Tutti sanno, infatti, come ti sei comportata di fronte a tuo padre,1 che amavi quanto i tuoi figli, non al punto, però, da desiderare che ti sopravvivesse, o forse lo
desideravi, perché l’affetto quando è grande può permettersi anche di opporsi alle leggi della natura. Hai cercato di impedire con tutte le tue forze il suicidio di lui, Aulo Cremuzio Cordo. Ma quando ti fu chiaro che di fronte agli sgherri di Seiano2 quello era per tuo padre il solo modo di sfuggire alla schiavitù, se non assecondasti il suo proposito, rinunciasti però a contrastarlo e, soffocando i tuoi gemiti ma senza nasconderli dietro un volto giulivo, versasti lacrime davanti a tutti, quando in quegli anni era un atto di grande rispetto il trattenersi dal pianto per non offendere l’imperatore. Non appena le mutate circostanze te ne offrirono l’occasione mettesti a disposizione di tutti l’ingegnosa opera di tuo padre, ch’era stata il pretesto per la sua condanna, e lo sottraesti così alla vera morte, restituendo alle pubbliche memorie i libri che quell’uomo tanto coraggioso aveva scritto col suo sangue. Sei davvero una benemerita della cultura romana (gran parte di quei libri era stata distrutta dal fuoco): benemerita al cospetto dei posteri, ai quali arriverà una fedele testimonianza dei fatti, pagata a così caro prezzo dal suo autore; benemerita di fronte a lui, la cui memoria vive e vivrà, finché sarà un vanto conoscere tutto ciò che è romano, finché esisterà qualcuno desideroso di risalire alle gesta dei padri, qualcuno che vorrà sapere cosa significhi essere romano, essere un uomo indomito quando tutti avevano piegato la testa e subìto il giogo di Seiano; un uomo libero di mente, d’animo e di azione. Se tu non lo avessi strappato all’oblio, mettendone in luce le doti migliori, l’eloquenza e la libertà, lo Stato, per Ercole, ne avrebbe avuto un danno non indifferente! Ora, invece, lo si legge, ritorna vivo, sta fra le mani e nei cuori di tutti, non teme più il tempo; dei suoi carnefici, invece, ben presto non si narreranno più nemmeno i delitti, che sono le sole azioni per cui sono ricordati. Questa tua grandezza d’animo è tale che io quasi non bado al tuo essere donna, al tuo volto segnato, come per tanti anni in passato, da un’ombra di continua tristezza. E guarda che io non cerco d’introdurmi di nascosto nei tuoi sentimenti per rubarti qualcosa: ti ho ricordato antiche sventure, mostrandoti la cicatrice di una ferita profonda affinché tu sappia che anche questa piaga può essere sanata. Altri usino carezze e blandizie, io intendo lottare contro il tuo dolore e porre un argine alle lacrime dei tuoi occhi ormai stanchi ed esausti, le quali scorrono, se vuoi sapere la verità, più per abitudine che per un bisogno effettivo. E lo farò col tuo aiuto, se sarà possibile, altrimenti contro la tua volontà, anche se ti terrai stretta al dolore che hai fatto tuo quasi per riempire il posto lasciato vuoto da tuo figlio. Non so come possa finire diversamente, visto che tutti i rimedi adottati sono stati vani: inutili le esortazioni degli amici, che hanno cercato di consolarti sino all’esaurimento, dei personaggi illustri della tua parentela, che hanno esercitato tutto il loro ascendente verso di te, inutili gli studi letterari, il bene più grande lasciatoti in eredità da tuo padre: le tue orecchie sono state sorde a tutto questo, o vi hanno prestato una fugace attenzione, tale da procurare al tuo animo solo un breve sollievo. Anche il tempo, la medicina più naturale, che riesce a placare gli affanni più gravi, non ha avuto alcuna presa su di te. Tre anni sono trascorsi,
ormai, e il dolore nulla ha perso del suo vigore iniziale, anzi, si rinnova di giorno in giorno e si ravviva, accampando così il suo diritto di durare a lungo e considerando un disonore abbandonare il campo. Come tutti i vizi, se non vengono estirpati al loro insorgere, si radicano nel profondo, così anche questi sentimenti tristi e miserevoli, che incrudeliscono contro sé stessi, si nutrono della loro stessa amarezza, finché il dolore diventa per l’animo infelice una voluttà cieca e perversa. Per questo motivo avrei voluto iniziare questa cura fin dall’insorgere del male, perché nella sua fase iniziale si sarebbe potuto circoscriverne la forza con una medicina più blanda, mentre contro i mali inveterati bisogna lottare più duramente. Così è anche per le ferite, che sono più facili da guarire quando il sangue è ancora fresco, quando invece si sono infettate, degenerando in piaghe purulenti, occorre cauterizzarle, esplorarle con le dita sino in fondo. Ora io non posso trattare un dolore così duro e resistente, qual è il tuo, con riguardo e delicatezza: bisogna che lo spezzi. 2. Generalmente quando si vogliono dare dei consigli si comincia con delle massime e si conclude con degli esempi. A volte, però, conviene invertire questa consuetudine, perché ci sono persone e persone: alcuni si lasciano guidare dai ragionamenti, altri hanno bisogno di esempi d’uomini illustri o autorevoli che siano in grado di far presa su di loro. A te piacciono le belle azioni, e allora io ti metterò davanti agli occhi due massimi esempi del tuo sesso e del tuo tempo, il primo di una donna che si lasciò vincere dal dolore, il secondo di un’altra che, colpita da un’analoga disgrazia e con un danno maggiore, non si lasciò dominare a lungo dal dolore, ma seppe riacquistare ben presto il suo stato d’animo abituale. Ottavia e Livia – rispettivamente sorella e moglie di Augusto – persero i propri figli ancor giovani, quando ciascuna di esse era certa che il suo sarebbe diventato imperatore. Ottavia aveva perduto Marcello, sul quale lo zio-suocero3 aveva già cominciato a fare affidamento addossandogli il peso del governo: un giovane portato all’azione, d’ingegno brillante, di una frugalità e di una continenza davvero ammirevoli per quell’età e per gli agi di cui godeva, tollerante delle fatiche, alieno dai piaceri e capace di sostenere qualsiasi carico gli fosse stato imposto o, per così dire, accumulato sulle spalle dallo zio. Augusto aveva oculatamente individuato in lui le fondamenta adatte a reggere qualunque peso. Ottavia per tutto il resto della sua vita non smise mai di piangere e di dolersi, né accettò parole di conforto da chicchessia, e nemmeno distrazioni, presa com’era da un solo pensiero e fissata unicamente in esso. Insomma, restò sempre quella che era stata il giorno del funerale, non perché le mancasse la forza di risollevarsi, ma perché rifiutò ogni conforto, convinta che se avesse smesso di piangere avrebbe come perso il figlio una seconda volta. Rifiutò di tenere presso di sé qualunque ritratto di lui, che pure aveva tanto amato, e non volle nemmeno sentirne parlare. Detestava tutte le madri e s’infuriava soprattutto contro Livia, convinta che al figlio di costei fosse passata quella felicità che lei si era augurata per il suo. Dedita al buio e alla solitudine e priva di riguardo
anche verso il fratello, disdegnava persino i versi composti per celebrare la memoria di Marcello e tutte le altre iniziative in onore di lui, sorda a ogni parola di conforto. Rifiutandosi di partecipare alle cerimonie ufficiali e detestando persino la gloria troppo splendida della grandezza fraterna, si ritirò isolandosi dal mondo, circondata solo dai figli e dai nipoti, senza mai deporre l’abito da lutto e provocando il risentimento di tutti i suoi familiari, perché pur essendo questi ancora vivi lei si comportava come se fossero morti. 3. Livia aveva perduto il figlio Druso, che doveva diventare un grande imperatore ed era già famoso come generale. Penetrato nel cuore della Germania, aveva piantato le insegne di Roma in una regione dove poco o nulla si sapeva dell’esistenza stessa dei Romani. Nel corso della spedizione si era guadagnato la simpatia dei nemici, i quali, dopo aver indetto una tregua per la sua malattia, ne avevano seguito rispettosamente il decorso senza nemmeno curarsi se quell’evento potesse tornare a loro vantaggio. Quando morì fu vivamente compianto da tutti i cittadini, dagli abitanti delle province e di tutta l’Italia, attraverso la quale le sue spoglie furono trasportate sino a Roma con un corteo funebre che sembrava un trionfo, mentre le popolazioni dei municipi e delle colonie si riversavano in massa lungo la strada per rendergli l’estremo omaggio. La madre non poté dunque ricevere gli ultimi baci del figlio e le estreme parole d’affetto dalla sua bocca. Dopo aver seguito in un lungo viaggio attraverso l’Italia le spoglie mortali di Druso, rinnovando via via il suo dolore davanti ai roghi eretti lungo la strada in onore del figlio, quasi che ogni volta ne intravedesse la morte, non appena lo ebbe deposto nel sepolcro, seppellì con lui anche il suo lutto, né si dolse più del lecito per il rispetto dovuto all’imperatore, né più del giusto per il fatto che le restava un altro figlio.4 Non cessò poi di celebrare il nome di Druso, di nominarlo sia in pubblico che in privato, di parlarne molto volentieri e di sentirne parlare: visse, insomma, col ricordo di lui, un ricordo che non si può custodire e ravvivare degnamente se lo si trasforma in un assillo crudele. Scegli, dunque, fra questi due esempi quello che ti sembra più apprezzabile. Se decidi di seguire il primo, ti escluderai dal numero dei viventi, respingerai i figli degli altri, i tuoi e quello stesso che rimpiangi; sarai un triste presagio per le madri che incontrerai, rifiuterai i piaceri onesti e leciti, come se fossero disdicevoli alla tua sorte, odierai la luce del giorno e detesterai la tua vita perché non ti precipita al più presto verso la fine, e – cosa assai più vergognosa e lontanissima dal tuo animo certamente migliore – dimostrerai di non voler vivere e di non saper morire. Se invece accetterai il secondo esempio, più moderato e più mite, dell’altra nobilissima donna, non vivrai più nell’angoscia né ti struggerai nel tormento. Che follia, insomma, è quella di aggiungere sofferenze all’infelicità, aumentando da sé stessi i propri mali? Conserva anche in questa circostanza quella probità di costumi e quella riservatezza che hai
osservato in tutta la tua vita, perché pure la sofferenza richiede un certo pudore. Quello stesso giovane, molto più degno se potrà allietarti ogni volta che lo nominerai o lo penserai, potrai onorarlo maggiormente se verrà incontro a sua madre ilare e gioioso quale soleva essere da vivo. 4. Non ti darò consigli troppo duri, tali da indurti a sopportare i casi umani in modo disumano: sarebbe come se pretendessi di asciugare gli occhi di una madre nel giorno stesso dei funerali del figlio. Andremo insieme da un arbitro e discuteremo fra noi se il dolore debba essere intenso o duraturo. Sono certo che l’esempio di Giulia Augusta, di cui sei stata intima amica, ti sarà maggiormente gradito: accetta dunque il consiglio che lei stessa ti dà. In un primo momento, quando il dolore nel suo impeto iniziale – come suole accadere – era più insopportabile e feroce, Giulia Augusta chiese conforto ad Areo, 5 il filosofo di suo marito, e alla fine confessò che i suoi insegnamenti le avevano giovato molto, più del popolo romano, che lei non voleva turbare con la sua tristezza, più di Augusto, il quale, privato di uno dei suoi due sostegni, vacillava e non poteva essere afflitto ancora di più dal pianto dei suoi familiari; più del figlio Tiberio, il cui affetto, in quella morte prematura e compianta da tutti, era tale che lei sentiva la mancanza del figlio solo perché ne aveva perso uno. Io penso che Areo, trovandosi di fronte a una donna tanto riservata e attenta alla propria reputazione, abbia introdotto il suo discorso in questo modo, cominciando più o meno così: «Cara Giulia, per quanto mi risulta, visto che frequento spesso tuo marito e conosco non solo ciò che la gente dice di voi due ma anche i vostri più segreti moti interiori, tu sino a oggi ti sei comportata in modo che nessuno potesse muoverti il minimo rimprovero, non solo nelle cose di grande importanza ma anche in quelle di poco conto, evitando così di dovertele poi far perdonare dall’opinione pubblica, che è la voce più critica e più schietta nei confronti dei potenti. E io credo che l’atto più bello per chi sta al di sopra di tutti sia il poter perdonare molte cose senza mai dover chiedere perdono per alcuna. Anche in questa circostanza, dunque, devi attenerti al tuo costume, quello, cioè, di non fare cosa che in seguito potresti rimproverarti, o che vorresti aver fatto diversamente. 5. Inoltre ti prego e ti scongiuro di non essere scontrosa e intrattabile con gli amici. Tieni presente, infatti, che tutti costoro non sanno come comportarsi in tua presenza, se parlare di Druso oppure no, in quanto se non ne fanno menzione temono di recare offesa alla sua memoria, visto ch’era un giovane molto famoso, se invece lo ricordano temono di fare un torto a te. Io e i miei amici, quando ci ritiriamo e ci riuniamo fra noi, commemoriamo le sue azioni e le sue parole con l’ammirazione che meritano, ma in tua presenza osserviamo su di lui un profondo e rispettoso silenzio. Tu ti neghi, così, le lodi di tuo figlio, che per te sarebbero la gioia più grande, lodi che tu, ne sono certo, vorresti si tramandassero nei secoli, possibilmente anche a prezzo della tua vita. Accetta, dunque, che si parli di lui, anzi, prendine tu stessa l’iniziativa e porgi volentieri le orecchie al nome e
al ricordo del tuo figliuolo: non prenderlo come un fatto doloroso, al pari di coloro che in situazioni analoghe considerano le parole di conforto un ingrediente della sventura. Ora tu sei tutta concentrata sul versante opposto, quello del dolore, e guardi la tua sorte dal lato peggiore, dimentica di quelli buoni, non volgi il tuo pensiero a quando tuo figlio viveva con te, a tutte le volte in cui ti veniva incontro felice, alle sue tenerezze di bimbo, ai suoi progressi nello studio: tu guardi e fissi solo l’ultimo aspetto della sua vita, accumulando pena su pena, come se la cosa non fosse già di per sé abbastanza terribile. Ti prego, non atteggiarti alla donna più infelice del mondo, che è la gloria più perversa a cui si possa aspirare! Al tempo stesso rifletti che non è un vanto mostrarsi forti nella prospera fortuna, quando la vita scorre liscia come l’olio: non è con un mare tranquillo e un vento favorevole che il timoniere rivela la sua abilità, occorre che intervenga qualche turbamento perché egli possa dimostrare tutta la sua bravura. Non abbatterti, dunque, anzi, poggia il piede ben fermo sul terreno, pronta a reggere qualunque peso stia per caderti addosso, spaventandoti, se mai, solo al suo primo schianto. Niente fa più dispetto alla malasorte che un animo sereno o rassegnato». Dopo queste parole Areo le ricordò che aveva ancora un figlio vivo e dei nipoti, figli del morto. 6. Questo, o Marcia, è anche il tuo caso, ed è come se Areo avesse assistito te. Mettiti dunque al posto di quella donna: Areo ha consolato te. Ora, però, immagina che ti sia stato tolto più di quanto abbia mai perduto una madre. Non cerco di lusingarti né intendo sottovalutare la tua disgrazia. Se il destino si vince con le lacrime, piangiamo pure, si trascini di giorno in giorno il nostro dolore e le notti passino insonni e piene di tristezza, anzi, squarciamoci il petto con le mani, sfiguriamoci il volto, magari, e diamo sfogo a un dolore così salutare con ogni genere di sevizie. Ma se non c’è pianto che possa resuscitare i morti, se non c’è sventura, per quanto disumana, che possa mutare il destino, fermo e scolpito nell’eternità, e la morte si tiene ciò che ci ha rapito, cessi, allora, il dolore, destinato anch’esso a perire. Controlliamoci, dunque, affinché questa forza non ci travolga! Indegno è quel nocchiero che si fa portar via il timone dalle onde, che lascia le vele svolazzare al vento e abbandona la nave alla tempesta; ammirevole, invece, è quello che il mare travolge e ricopre ancora stretto e abbracciato al timone. 7. «Ma rimpiangere i propri cari è cosa naturale», obietterai. Non lo nego: purché non si ecceda. Pure una partenza, un semplice distacco, provoca una stretta al cuore, un senso di amarezza, anche in un animo forte: non avviene soltanto con la morte. Ma l’opinione, cioè l’idea che uno si fa delle cose, aggiunge al dolore più di quanto richieda la legge di natura. Guarda come negli animali il dolore, anche se violento, sia di breve durata: il muggito delle mucche dura un giorno o due e non di più quell’errabondo e forsennato scorrazzare delle
cavalle, le fiere, dopo aver errato per la foresta in cerca delle orme dei loro piccoli e fatto inutilmente avanti e indietro dalle tane vuote, estinguono in breve tempo il loro furore; anche gli uccelli vanno con grandi strida sbattendo le ali di qua e di là attorno ai nidi vuoti ma poi, tranquilli, riprendono subito i loro voli. Fra tutte le creature soltanto l’uomo rimpiange a lungo i propri figli, restando attaccato al suo dolore e affliggendosi non per quel che soffre veramente ma per l’opinione che ha del dolore. Quanto sia innaturale lasciarsi abbattere dalle sventure puoi rilevarlo dal fatto che sono più le donne che gli uomini a piangere per la perdita di un figlio, più i barbari che le popolazioni civili e istruite, più gli ignoranti che i dotti. Del resto la forza che si riceve dalla natura resta in tutti sempre uguale, variano il modo e la misura in cui essa si esprime, che pertanto non sono naturali. Il fuoco non distingue fra persona e persona, brucia tutti indipendentemente dall’età, maschi e femmine, abitanti di ogni città; analogamente il ferro mostra su tutti i corpi indifferentemente la sua capacità di tagliare. Perché? Perché il fuoco e il ferro hanno ricevuto la loro forza dalla natura, che nelle sue leggi non fa distinzioni per nessuno. La povertà, il lutto, il disprezzo, invece, non tutti li sentono nello stesso modo e nella stessa misura, ciascuno li percepisce in base all’abitudine, o alla debolezza e all’intolleranza proprie della sua personalità, derivanti da una falsa opinione che porta a temere cose che in sé stesse non hanno nulla di spaventoso. 8. Inoltre tutto ciò che è naturale non diminuisce col tempo, mentre il dolore col passare dei giorni si attenua, anche quello più ostinato, che si rinnova quotidianamente e si ribella a ogni cura, è svigorito dal tempo, che è il rimedio più efficace contro qualsiasi eccesso. Anche in te, Marcia, persiste ancora una profonda tristezza che sembra ormai incallita, ma non è più violenta com’era all’inizio, però è tenace, ostinata, e tuttavia il tempo a poco a poco porterà via anche questa. Ogni volta che ti distrarrai, impegnandoti in qualche faccenda, il tuo animo si rasserenerà. Ora stai sempre all’erta, ma c’è già una grande differenza fra il piangere deliberatamente e il lasciarsi andare. Sarebbe più conforme alla nobiltà dei tuoi costumi se fossi tu stessa a porre fine al tuo lutto invece di aspettare che se ne vada lui. Meglio che non venga mai il giorno in cui il dolore ti abbandoni senza che tu ne sia cosciente! Lascialo dunque tu stessa! 9. Mi chiederai: «Da dove viene, allora, tutta questa nostra ostinazione nel piangere, se non è una legge di natura?». Dal fatto che il male ci coglie all’improvviso perché non pensiamo preventivamente che ci possa colpire: è come se ce ne ritenessimo immuni e percorressimo una strada più agevole di quella degli altri, senza renderci conto che le disgrazie altrui possono capitare a tutti. Quanti funerali passano davanti alla nostra casa, e tuttavia noi non pensiamo alla morte. Tanti muoiono prematuramente, ma noi pensiamo alla toga che un giorno indosseranno i nostri bambini, al loro servizio militare, ai beni che erediteranno dal padre. Vediamo coi nostri occhi molti ricchi impoverire
all’improvviso, ma non ci viene in mente che le nostre ricchezze sono altrettanto instabili. Ecco perché il crollo ci risulta più grave, perché la ferita ci coglie quando non ce l’aspettiamo: quelle previste molto tempo prima, invece, ci toccano più debolmente. Ti rendi conto che sei esposta a tutti i colpi possibili e che gli strali destinati agli altri potevano colpire anche te? Comportati, dunque, come se andassi disarmata e lungo una salita all’assalto di un muro o di un caposaldo presidiato da molti nemici: aspettati di essere colpita e pensa che i sassi, le frecce e i giavellotti che volano sopra la tua testa sono stati scagliati contro il tuo corpo. E ogni volta che uno cade al tuo fianco o dietro di te grida: «Non mi coglierai di sorpresa, o Fortuna, né mi abbatterai perché imprevidente o noncurante! So quello che mi prepari: hai colpito un altro, ma miravi a me». Quanti guardano ai loro beni come a cose passeggere? Chi di noi ha mai pensato di poter andare in esilio, diventare povero, subire un lutto familiare? E se mai gli prospettassero questa ipotesi chi non la respingerebbe considerandola un cattivo auspicio e scaricando il malaugurio sulla testa dei suoi nemici o dello sconsiderato che ha osato dargli un tale consiglio? «Non credevo che potesse accadere!», dirà qualcuno. Ma può mai non accadere nulla di ciò che sappiamo che può accadere e che vediamo già accaduto a molti altri di noi? C’è un bellissimo verso, degno di miglior provenienza che non da un palcoscenico: Può accadere a chiunque ciò che accade a qualcuno.6 Uno ha perduto i figli: puoi perderli anche tu; un altro è stato condannato: anche la tua innocenza può essere colpita. L’errore che c’inganna e ci rende senza difesa è quello di non aver pensato ieri a ciò per cui oggi soffriamo. Un male previsto perde la sua forza. 10. Quale che sia, o Marcia, tutto ciò che di provvisorio ci brilla intorno, i figli, gli onori, le ricchezze, le vaste sale e i vestiboli zeppi di clienti a cui non abbiamo potuto dare ascolto, un nome illustre, una moglie nobile o bella e tutte le altre cose che dipendono da una sorte incerta e mutevole, sono ornamenti che abbiamo avuto in prestito. Niente di tutto questo ci appartiene come se fosse un dono. La scena è arredata con suppellettili raccolte qua e là, che devono tornare ai loro padroni: alcune saranno restituite il primo giorno, altre il secondo, ben poche resteranno sino all’ultimo. Non abbiamo dunque motivo di vantarcene, come se fossimo circondati da beni di nostra proprietà: sono cose prestate, le abbiamo in usufrutto per un tempo stabilito non da noi ma da chi ce le ha date, e dobbiamo essere sempre pronti a restituirle dietro richiesta del proprietario in qualunque momento, senza sapere quando e senza protestare: è un pessimo debitore quello che litiga col suo creditore. Tanto più, dunque, dobbiamo amare i nostri cari, sia quelli che desideriamo ci sopravvivano per legge di nascita, sia quelli che giustamente si augurano di precederci, perché nessuno ci ha promesso la loro immortalità, e neppure la loro longevità. Dobbiamo ricordarci
continuamente di amare le cose che ci sono state date, proprio perché sappiamo che ci verranno tolte, anzi, che già stiamo per perderle. Insomma, tutto ciò che la fortuna ci ha dato lo possediamo senza alcuna garanzia. Gioite in fretta dei vostri figli e a vostra volta fate che loro godano di voi, assaporate senza indugio ogni possibile gioia, poiché nulla vi è promesso, neppure la notte che sta per arrivare, anzi, questo limite è già lungo, non vi è garantita nemmeno l’ora presente. Bisogna affrettarsi a vivere, c’incalza alle spalle il destino: presto questa compagnia sarà dispersa, questo gruppo sarà spazzato via in mezzo a un nugolo di grida, la vita è tutta una rapina, e in questa eterna fuga la vita stessa vi sfugge, o miseri mortali! Tu piangi la morte di tuo figlio, ma il delitto si è consumato il giorno stesso della sua nascita: è allora che gli è stata notificata la sentenza di morte. Ti era stato dato, infatti, a questa condizione, e quel destino lo ha accompagnato fin dal grembo materno. Siamo nati sotto il dominio duro e inflessibile della sorte e a suo arbitrio dobbiamo subire cose buone e cose cattive. Essa abuserà dei nostri corpi con atti di violenza, ingiurie e crudeltà: alcuni li brucerà col fuoco, per punirli o per sanarli, altri li sconfiggerà, per mezzo di stranieri o di concittadini; altri li sballotterà indifesi per mari infidi, e dopo che avranno lottato coi marosi non li getterà su una spiaggia o su una sponda ma li seppellirà nel ventre di qualche enorme mostro marino; altri ancora li lascerà a lungo sospesi tra la vita e la morte, consumati da malattie di ogni genere. Come una padrona volubile e capricciosa, che non si cura dei suoi schiavi, distribuirà premi e castighi, giusti o sbagliati che siano. Ma a che vale versare lacrime sui casi singoli? Tutta la vita è da compiangere: saremo assaliti da mali sempre nuovi prima ancora di avere smaltito quelli vecchi. Dobbiamo dunque imporci una regola di condotta, soprattutto voi, o donne, che siete particolarmente sensibili, distribuendo le forze del nostro compassionevole cuore fra i nostri tanti dolori. 11. Cos’è, poi, questo dimenticarti della tua condizione e di quella degli altri? Sei nata mortale e hai generato dei mortali; sei un corpo fragile e caduco, pieno di mali, come hai potuto sperare che una materia così debole potesse contenere degli esseri forti e immortali? Tuo figlio è morto: ciò significa che è giunto a quella meta verso la quale si affrettano tutti coloro che stimi più felici della tua creatura. Là si dirige, con passo diverso, tutta codesta gente che litiga nel foro, che assiste agli spettacoli teatrali, che prega nei templi: una medesima cenere livellerà chi ami e chi detesti. È questo il significato della frase attribuita all’oracolo di Apollo Pizio: 7 CONOSCI TE STESSO. Che cos’è l’uomo? Un vaso che può andare in frantumi alla minima scossa e al minimo urto. Non c’è bisogno di una grande tempesta per distruggerti: dovunque andrai a sbattere ti sfascerai. Che cos’è l’uomo? Un corpo debole e fragile, nudo, indifeso per sua stessa natura, bisognoso dell’aiuto altrui, esposto a tutte le offese della sorte; anche se ha i muscoli bene allenati e rinforzati una belva qualunque potrà ucciderlo e divorarlo. È un insieme di tessuti deboli e corruttibili, bello solo nei
suoi lineamenti esteriori, intollerante del freddo, del caldo, della fatica, soggetto al disfacimento anche se non si muove e non fa nulla; sempre occupato e preoccupato nel procurarsi il cibo, che se è scarso lo fa venir meno, se è eccessivo lo fa scoppiare; sempre agitato per il suo istinto di conservazione, dal respiro così precario e instabile che può essere bloccato da un rumore forte e improvviso che gl’infastidisca l’orecchio: insomma, un motivo di pericolo per sé stesso, continuo, inutile e dannoso. E ci meravigliamo che un essere simile muoia quando basta un singhiozzo a farlo morire? Ci vuole forse un grande sforzo per farlo cadere? Un odore, un sapore, la stanchezza, la veglia, una bevanda, un cibo, una qualunque di quelle cose senza le quali non può vivere possono farlo morire. Già solo come si muove si rende conto della sua debolezza: non sopporta tutti i climi, si ammala se beve un’acqua a cui non è abituato o se respira un’aria diversa da quella consueta, e così pure se va incontro anche al più piccolo o fastidioso accidente. È un essere corruttibile, soggetto a invalidità, che accoglie la vita piangendo, e tuttavia quanti sconvolgimenti provoca questo essere spregevole, quali cose non arriva a concepire, dimentico della sua condizione! Fantastica di immortalità e di eternità, fa progetti persino per i nipoti e i pronipoti, e nel momento stesso in cui è tutto proiettato verso il futuro lo ghermisce la morte. Anche la vecchiaia non è che un brevissimo volgere di anni. 12. Il tuo dolore, per poco ragionevole che sia, riguarda il danno arrecato a te o quello subìto dal morto? Cosa ti turba nella perdita di tuo figlio, il non aver avuto da lui alcuna gioia, o il pensiero che avresti potuto averne delle maggiori se fosse vissuto più a lungo? Se ritieni di non averne avuta nessuna il tuo danno sarà più sopportabile: l’uomo, infatti, prova minor rimpianto per quelle cose di cui non ha goduto o usufruito minimamente. Se invece riconosci di aver avuto da lui grandi soddisfazioni, più che dolerti di ciò che ti è stato tolto, devi essere grata per ciò che ti è toccato. Hai raccolto infatti frutti proporzionati alle tue fatiche già dalla sua buona educazione, poiché, come per chi alleva cagnolini, uccelli e altre analoghe frivolezze il piacere consiste nel vederli, nel toccarli e nel ricevere le loro carezze di bestie, così per chi educa i figli la ricompensa sta appunto nel vederli bene educati. Perciò, anche se la sua attività non ti ha recato alcuna soddisfazione, la sua diligenza non ti ha protetto abbastanza e la sua saggezza non t’ha elargito alcun consiglio, il solo averlo avuto e averlo amato è una ricompensa. «Ma avrei potuto riceverne di più». Certo, ma ciò che ne hai avuto è sempre meglio di niente: dovendo scegliere fra l’essere felici per breve tempo e il non esserlo mai ben venga un bene passeggero piuttosto che non aver nulla di cui godere. Avresti preferito un tipo degenere, che si limitasse solo a portare il nome di figlio e ad aumentare la tua prole, o uno pieno di doti come il tuo? Un giovane precocemente saggio e devoto, sposo e padre prima del tempo e prima del tempo sollecito a tutti i suoi doveri, precoce anche nella sua veste di sacerdote, come uno, insomma, che volesse fare tutto in fretta. Quasi a nessuno toccano contemporaneamente beni grandi e duraturi: solo una felicità tarda e
disinteressata può durare e giungere sino alla fine. Gli dèi immortali ti hanno concesso di avere subito – anche se non per molto tempo – un tale figlio quale può diventare solo uno che riesca a vivere a lungo. Non puoi nemmeno dire che gli dèi hanno scelto te quale madre a cui negare la gioia di godere del proprio figlio. Guarda la folla che ti sta d’intorno, persone che conosci e che non conosci: dovunque vedrai gente che ha sofferto più di te. Perdite come la tua le hanno patite grandi condottieri, le hanno avute principi e re, il mito non ha risparmiato neppure gli dèi, forse perché ci fosse di sollievo sapere che le nostre disgrazie toccano anche la divinità. Guardali tutti, ripeto: non troverai nessuna famiglia tanto disgraziata da non potersi consolare vedendone una più infelice di lei. Per Ercole, non stimo i tuoi costumi così poco da credere che sopporteresti meglio la tua sventura se ti facessi sfilare davanti un corteo di gente che piange: è da persone malevole trarre motivo di conforto ai propri guai dalle disgrazie di una moltitudine! Ma ti citerò alcuni casi, non per dimostrarti che la tua sventura è comune a tutti i mortali (è ridicolo raccogliere esempi di gente che ha avuto a che fare con la morte), ma perché tu sappia che sono molti coloro che mitigarono le loro pene sopportandole con animo sereno. Comincerò dal più felice. Lucio Silla perse un figlio, ma ciò non indebolì la sua crudeltà e la sua sfrenata spavalderia contro nemici e concittadini, né egli ritenne di essersi attribuito ingiustamente il soprannome di «Felice»8 dopo la morte del figlio, poiché non temeva l’odio degli uomini, dalle cui disgrazie derivava la sua fortuna, e neppure la collera degli dèi, perché riteneva che su di loro ricadesse la causa di quella sua «felicità». Ma il caso di Silla mettiamolo da parte, visto che rientra fra quelli non ancora risolti (i suoi avversari stessi, infatti, riconosceranno ch’egli prese le armi opportunamente e che opportunamente le depose), tuttavia del nostro discorso resterà evidente questa verità: non è poi così grande e insopportabile un male che colpisce anche gli uomini più felici. 13. I Greci non vadano troppo fieri di quel padre che, informato della morte del figlio mentre stava celebrando un sacrificio, non si scompose e, toltasi dal capo la corona e fatto tacere il flautista, portò a termine la cerimonia secondo quanto richiedeva il rito. Allo stesso modo si comportò il pontefice Pulvillo che, informato della morte del figlio mentre con la mano appoggiata allo stipite della porta9 dedicava a Giove il tempio capitolino, finse di non aver sentito e invocata nel nome del figlio la protezione del dio, pronunciò la formula rituale del carme pontificio senza che un solo gemito interrompesse la sua preghiera. Pensi che il dolore di quel padre dovesse fermarsi lì, quando al suo primo assalto non lo aveva distolto dai pubblici altari e dalle preghiere propiziatorie? Veramente degno, per Ercole, di quel rito memorabile e del suo alto sacerdozio fu questo padre che non smise di venerare gli dèi anche se incolleriti. E però, tornato a casa, versò copiose lacrime e proruppe in gemiti e lamenti. Ma non appena ebbe compiuto le onoranze che si usano per i morti, atteggiò nuovamente il volto nell’espressione che aveva tenuto in Campidoglio.
Paolo Emilio,10 all’epoca in cui celebrò quel suo grandioso trionfo durante il quale condusse Perseo in catene davanti al suo cocchio, aveva dato in adozione due dei suoi figli, tenendo gli altri, che si era riservati, sino alla loro morte. Pensa quali dovessero essere questi ultimi se fra quelli che aveva ceduto c’era Scipione! Ebbene, il popolo romano, vedendo che nel cocchio di Paolo non c’erano i suoi figli,11 non riuscì a trattenere la commozione. Tuttavia egli pronunciò il discorso e rese grazie agli dèi perché il suo desiderio era stato esaudito: aveva infatti chiesto che se per quella vittoria si doveva pagare un prezzo ciò avvenisse a carico suo, non a spese dello Stato. Vedi con quale forza d’animo sopportò quella tragedia: ringraziò gli dèi di esser rimasto senza figli! Eppure chi più di lui avrebbe dovuto abbattersi per un così tragico rovesciamento della sorte? Aveva perduto in un solo colpo il conforto e il sostegno dei suoi figli. Ma non diede a Perseo la soddisfazione di vederlo addolorato. 14. Ma a che pro passare in rassegna tanti esempi di uomini illustri per cercare fra loro gl’infelici quando è più difficile trovare quelli felici? Quante famiglie hanno conservato in vita tutti i loro componenti sino alla fine? Prendi un anno a caso e citamene i magistrati: Lucio Bibulo e Gaio Cesare.12 Due colleghi che si avversavano durissimamente accomunati da una medesima sorte. Lucio Bibulo, uomo più buono che coraggioso, perse contemporaneamente due figli, uccisi in Egitto dopo essere stati esposti al ludibrio dei soldati, e questo fu per il padre motivo di pianto ancor più della loro morte stessa. Bibulo, che per tutto l’anno del suo consolato era rimasto chiuso in casa per l’odio che nutriva verso il collega, il giorno successivo a quello in cui gli fu data notizia di quella duplice morte, uscì per adempiere ai consueti doveri che gl’imponeva la sua carica. Chi può dedicare meno di una giornata a due figli? Ebbene, quest’uomo che per un anno intero aveva osservato il lutto per il suo consolato tanto poco lo portò per la morte dei suoi figli! Gaio Cesare, mentre percorreva la Britannia, senza che neppure l’Oceano potesse porre un freno alla sua fortuna, venne a sapere che gli era morta la figlia,13 la quale insieme al suo si portava dietro il destino della repubblica. Egli sapeva che Pompeo non avrebbe tollerato di buon grado che nello Stato ci fosse un altro grande come lui, e che si sarebbe opposto a quei successi che, pur se volti all’interesse comune, avrebbero potuto metterlo in ombra. Tuttavia nel giro di tre giorni riprese nelle sue mani il comando supremo e vinse il dolore con la stessa rapidità con cui vinceva tutte le battaglie. 15. A che scopo elencarti i lutti degli altri Cesari? Credo che talvolta la cattiva sorte si abbatta su di loro affinché anche così possano essere utili all’umanità, dimostrando che pure loro, che si dicono nati dagli dèi e destinati a generare dèi, non hanno sul proprio destino quel potere che esercitano su quello degli altri. Il divino Augusto, perduti i figli e i nipoti e vista estinta la stirpe dei Cesari, rimediò al vuoto della sua casata con l’adozione, accettando l’idea della
propria morte con la forza di chi sente ormai che la cosa riguarda pure lui, e preoccupandosi principalmente che nessuno si lagnasse degli dèi.14 Tiberio Cesare, oltre a quello da lui generato, perse anche il figlio adottivo,15 e tuttavia ne pronunciò egli stesso dai Rostri l’elogio funebre, ritto davanti alla salma, dalla quale lo separava soltanto il velo che doveva nascondere al pontefice la vista dei cadaveri; e mentre il popolo piangeva lui rimase impassibile, dimostrando a Seiano che gli stava accanto con quale forza d’animo si possa sopportare la perdita dei propri cari. Vedi quanto sia lungo l’elenco degli uomini illustri che non furono risparmiati da questo evento a cui niente e nessuno può sottrarsi? Ed erano uomini colmi di tante virtù e di benemerenze sia nella vita pubblica che in quella privata. Perché questo flagello imperversa in tutto il pianeta e devasta ogni cosa senza eccezione alcuna, trascinandola come se fosse sua. Chiedi a ciascuno il resoconto: nessuno nasce senza doverne pagare lo scotto. 16. So cosa potresti dirmi: «Ti sei dimenticato che stai consolando una donna, e mi citi esempi di uomini!». Ma chi oserebbe affermare che la natura è stata avara con l’indole delle donne, limitandone le doti? Ti assicuro che esse posseggono lo stesso vigore degli uomini, altrettanta capacità di azioni onorevoli, se soltanto lo vogliano, e, con l’abitudine, altrettanta resistenza al dolore e alla fatica. Di quale città, buon dio, stiamo parlando? Di quella in cui una Lucrezia e un Bruto16 tolsero un re di dosso ai Romani: a Bruto dobbiamo la libertà, a Lucrezia siamo debitori di Bruto; della città in cui Clelia,17 a dispetto del fiume e del nemico, è stata così coraggiosa da essere ricordata quasi come un uomo: dall’alto della sua statua equestre, eretta sull’affollatissima via Sacra, rimprovera ai nostri giovani, che scendono dalle lettighe, di entrare in quel modo femmineo in una città in cui anche alle donne si regalava un cavallo. Per citarti esempi di donne che hanno sopportato con animo virile la perdita di loro familiari non ho bisogno di andare a cercarli di porta in porta. Da una sola famiglia ti citerò due Cornelie: la prima, figlia di Scipione, è la madre dei Gracchi. La sua vita registrò ben dodici parti e altrettanti funerali. Di tutti gli altri figli c’è poco da dire, visto che la città non ne avvertì né la nascita né la morte, ma Gaio e Tiberio 18 – dei quali si potrà negare la bontà ma non la grandezza – la madre li vide uccisi e insepolti. E a coloro che la consolavano chiamandola infelice rispondeva: «Mai potrò dirmi infelice, io che ho generato i Gracchi!». L’altra Cornelia, moglie di Livio Druso, perse un figlio 19 di notevole ingegno e molto famoso, che seguiva le orme dei Gracchi: fu ucciso nella sua abitazione da un assassino sconosciuto, lasciando in sospeso tanti progetti di legge. Ebbene, la madre ne sopportò la morte immatura e invendicata con lo stesso coraggio con cui il figlio aveva proposto le sue leggi. A questo punto, Marcia, devi riappacificarti con la fortuna e ringraziarla, visto che ti ha colpito con quegli stessi strali che ha scagliato contro gli Scipioni, le madri e le figlie degli Scipioni, e coi quali ha ferito persino i Cesari. La vita è
piena di disgrazie d’ogni genere, che concedono a stento qualche breve tregua, mai una pace durevole. Tu hai generato quattro figli. Ebbene, non c’è freccia scagliata contro una folta schiera di soldati che non colpisca qualcuno: che meraviglia, dunque, se una famiglia così numerosa ha incontrato lungo il suo cammino qualche incidente e qualche ostilità? «Ma la sorte», dirai, «è stata più crudele perché non solo mi ha portato via dei figli ma se li è pure scelti». D’accordo. Ma non si può parlare di offesa quando questa è condivisa con chi è più potente di noi. Del resto la sorte ti ha lasciato due figlie e i nipoti che quelle ti hanno dato; anche il figlio che piangi maggiormente, dimenticandoti del più anziano, non te lo ha portato via del tutto: hai le sue due figlie, che ti peseranno molto se mal sopporterai il tuo dolore, ma che saranno per te una grande consolazione se saprai sopportarlo con coraggio. Quando le guardi pensa a tuo figlio, non al tuo dolore. Il contadino, quando vede a terra le piante sradicate dal vento o spezzate dalla furia improvvisa di un uragano, cura i rami superstiti e appronta subito le talee e i germogli di quelli perduti, e presto (il tempo, infatti, è ugualmente rapido e pronto sia nel distruggere che nel far crescere) le piante rinverdiscono più rigogliose di quelle perdute. Rimpiazza, dunque, il tuo Metilio con queste due figlie, colma il vuoto lasciato da lui e allevia un dolore singolo con una duplice consolazione. La nostra natura è tale che spesso apprezziamo di più le cose che abbiamo perduto, e il rimpianto di ciò che ci è stato tolto ci rende ingiusti con quel che ci è rimasto. Ma se poni mente a ciò che di buono, pur nella sua crudeltà, ti ha lasciato la sorte, ti accorgerai che ti è rimasto molto di più di un semplice conforto: guarda quanti nipoti, oltre alle sue due figlie! E di’ anche questo, Marcia: «Sarebbe quasi un’ingiustizia se la sorte distribuisse fortune e disgrazie in base alla condotta di ciascuno e se il male non toccasse mai i buoni: ora capisco che buoni e cattivi sono trattati allo stesso modo, senza alcuna discriminazione». 17. «Non si può negare, tuttavia, che sia duro perdere un figlio dopo che l’hai allevato e proprio quando è di sostegno e di aiuto al padre e alla madre». Nessuno nega che sia duro. Ma tale è la vita degli uomini, ed è per questo che si nasce: per perdere quel che si ha, per andare in rovina, per sperare, per temere, per affliggere sé stessi e gli altri, per aver paura della morte o per desiderarla e, quel ch’è peggio, senza nemmeno sapere il perché di questa condizione. Sarebbe come se a uno che si accinge a partire per Siracusa si facesse questo discorso: «È bene che tu conosca in anticipo tutti i disagi e tutti i piaceri del viaggio che intendi fare, dopodiché imbarcati pure. Queste sono le cose che potrai ammirare: prima di tutto vedrai l’isola, separata dall’Italia da un angusto stretto di mare e che un tempo era unita al continente, finché all’improvviso vi irruppe il mare che divise il lido esperio da quello siculo.20 Poi (visto che a quel punto ti sarà lecito solcare l’insaziabile vortice
marino), vedrai la mitica Cariddi, calma quando non è battuta dall’Austro, ma pronta, se quel vento soffia con una certa violenza, a ghermire le navi di passaggio trascinandole nella sua vasta e profonda voragine. Vedrai la fonte Aretusa, cantata da moltissimi poeti, versare in uno stagno limpidissimo e trasparente sino al fondo le sue acque gelidissime, vuoi raccolte da sorgenti che sgorgano sul posto, vuoi riemerse da un fiume21 che, passato sotto tante terre e sotto un così vasto tratto di mare, sia rimasto intatto, senza mescolarsi con altre acque di peggior natura. Vedrai il porto più tranquillo fra tutti quelli naturali o costruiti dall’uomo a rifugio delle flotte, tanto sicuro che non lascia entrare nemmeno le più furiose tempeste. Vedrai il luogo in cui, dopo che fu sconfitta la potenza di Atene, vennero rinchiusi a migliaia i prigionieri, un carcere naturale fatto di rocce tagliate di grandissima altezza e profondità;22 vedrai quella grande città e il suo territorio, più vasto di quello costituito da molte città messe insieme, in cui gl’inverni sono mitissimi e non v’è un solo giorno senza sole. Ma dopo che avrai ammirato tutto questo, un’estate opprimente e malsana annullerà i benefìci del clima invernale; là vi sarà Dionigi,23 il tiranno distruttore della libertà, della giustizia, delle leggi, avido di dominio anche dopo l’incontro con Platone, desideroso di vivere pure dopo l’esilio: farà bruciare vive alcune persone, altre le farà frustare, altre decapitare anche per un’inezia; per soddisfare la sua libidine riunirà insieme maschi e femmine e nella turpitudine di quel gregge dissoluto poca cosa saranno gli accoppiamenti contemporanei di due uomini con una donna. Questo è ciò che può attirarti e dissuaderti: ora, o t’imbarchi, o rimani». Ecco, se dopo un avvertimento del genere uno decidesse di partire per Siracusa, con chi altro dovrebbe poi lamentarsi se non con sé stesso, visto che in quella città c’è andato non per caso ma di proposito e ben consapevole di quel che vi avrebbe trovato? La natura ci dice: «Io non inganno nessuno. Se vorrai dei figli potranno essere belli o brutti, deformi e forse anche minorati, fra di loro potrà esserci tanto un salvatore della patria quanto un traditore. Naturalmente tu puoi sperare che col tempo possano raggiungere una tale reputazione che nessuno osi maledirti per causa loro, ma prospettati anche l’ipotesi che diventino tanto malvagi da essere essi stessi per te una maledizione. Niente impedisce che siano loro a seppellire te, rendendoti gli estremi onori e pronunciando l’elogio funebre, ma preparati anche a dover essere tu a portarne qualcuno sul rogo, ancora bambino o giovinetto o nell’età matura: in questo caso non è questione di anni, un funerale seguìto da un genitore è sempre prematuro». Se questi sono i patti e tu, conoscendoli, metti al mondo dei figli, non dare poi colpa agli déi per non averti dato su di loro alcuna garanzia. 18. Applichiamo ora la stessa similitudine all’ingresso dell’uomo nella vita. Nell’esempio del viaggio a Siracusa ti ho esposto tutto ciò che di piacevole e di spiacevole poteva capitare. Adesso immagina di essere sul punto di nascere e che io ti faccia questo discorso: «Stai per entrare nella città che è comune agli uomini e agli dèi, che contiene ogni cosa ed è soggetta a leggi eterne e
immutabili, che col suo moto partecipa all’incessante orbitare dei corpi celesti. Qui vedrai brillare innumerevoli stelle di vario splendore e un astro che da solo illumina tutto: è il sole, che col suo giro quotidiano24 determina la durata del giorno e della notte e, con quello annuale, il regolare avvicendarsi dell’estate e dell’inverno. Vedrai succedergli di notte la luna che, incontrandosi col fratello, prende a prestito da lui una luce mite e discreta, e che ora si nasconde, ora domina la terra con tutto il suo volto, variabile a seconda che si trovi in fase crescente o calante, sempre diversa da quella del giorno prima. Vedrai cinque pianeti percorrere vie diverse rispetto a quelle degli astri e muoversi in direzione contraria al rapidissimo moto dell’universo, dai movimenti dei quali, anche se minimi, dipendono i destini dei popoli: sia gli eventi più importanti che quelli più insignificanti derivano dal modo di procedere, favorevole o sfavorevole, di ogni singolo astro. Vedrai l’addensarsi delle nubi, il cadere delle piogge, lo zigzagare dei fulmini, il rombo dei tuoni. Quando poi, sazia dello spettacolo delle cose celesti, volgerai gli occhi alla terra, ti colpirà un altro tipo di bellezza altrettanto meravigliosa: da un lato vaste distese di campagne che si aprono all’infinito, dall’altro cime di montagne che s’innalzano al cielo da immensi gioghi innevati, uno scorrere di fiumi che, sgorgati da un’unica fonte, si spandono a oriente e a occidente, foreste dalle cime ondeggianti e tanti boschi pieni di animali e risonanti delle varie voci degli uccelli, e poi città collocate in luoghi diversi, popolazioni chiuse in zone inaccessibili, alcune delle quali si rifugiano su ripidi monti, altre, per paura, si circondano con acque paludose, campi colmi di messi e alberi dai frutti spontanei; e il lieve scorrere dei ruscelli fra i prati, le amene insenature e i lidi che s’incurvano a formare dei porti, e, per finire, innumerevoli isole sparse per il mare immenso, che, spuntando qua e là, gli fanno da ornamento. Che dirti, poi, del fulgore delle pietre preziose e delle gemme, del luccichio dei rapidi torrenti che trascinano oro fra la sabbia, delle colonne di fuoco che si alzano nell’aria levandosi dal centro della terraferma e del mare, dell’oceano che circonda la terra e coi suoi tre golfi divide fra loro le genti e sempre ribolle con sfrenata violenza?25 In quelle acque irrequiete e burrascose anche senza vento vedrai nuotare animali ben più grandi di quelli terrestri, quali pesantissimi e che si muovono guidati da altri, quali più veloci e più rapidi di una barca spinta da incalzanti remi, altri che aspirano l’acqua e la soffiano con grande pericolo per i naviganti, e ancora navi in cerca di terre sconosciute. Vedrai che non c’è limite all’audacia degli uomini: tu stessa, oltre che spettatrice, sarai partecipe attiva di quegli sforzi, imparerai e insegnerai nuove arti che educano alla vita, altre che l’abbelliscono, altre che la governano. Ma vi saranno anche innumerevoli malanni per il corpo e per l’animo: guerre, rapine, avvelenamenti, naufragi, intemperie, febbri, perdite premature di persone care e la morte, che non sai se naturale o fra pene e tormenti. Pensaci, dunque, e soppesa bene la tua decisione: per giungere a quelle cose meravigliose devi passare per tutte le altre». Risponderai che vuoi vivere: come no? Anzi, credo che non potresti non
accettare alcunché di cui poi debba lamentarti perché te ne è stata tolta una parte! Vivi allora come convenuto. «Ma nessuno ci ha interpellati prima che nascessimo!», obietterai. Ci hanno pensato i nostri genitori, che, fatti esperti della vita, ci hanno dato la vita. 19. Ma, per tornare al tema della consolazione, vediamo prima quale sia il male da curare, poi il modo. Nel nostro caso è la perdita della persona amata che ci fa soffrire: la cosa di per sé appare tollerabile, visto che non ha senso piangere per persone che non ci sono più o che staranno lontane per tutta la vita, anche se ci si sente privati sia della loro vista che della loro compagnia. Il nostro dolore, dunque, è frutto di suggestione: ogni disgrazia vale per come la sentiamo noi, e, analogamente, il rimedio dipende da noi: dobbiamo pensare, cioè, che i nostri morti siano soltanto degli assenti e distogliere così il nostro animo dalla realtà. Ci siamo semplicemente congedati da loro, anzi, li abbiamo mandati avanti e li raggiungeremo. Ma c’è un altro particolare che c’induce a piangere i nostri morti: senza di loro – pensiamo – non avremo più chi ci difenda e ci protegga dalla noncuranza degli altri. Ebbene, farò ricorso a un tipo di conforto che, pur se poco apprezzabile, è tuttavia concreto ed efficace. Nella nostra città la perdita dei figli più che togliere considerazione ai genitori l’accresce, e la solitudine, che un tempo distruggeva la vecchiaia, ora le dà una tale forza che alcuni fingono l’odio dei figli e li rinnegano, immaginando di non averli più e di vivere così in solitudine.26 So cosa potresti dirmi: «Non piango per un danno mio personale». Capisco. Non merita consolazione chi si duole per la morte di un figlio come se fosse quella di uno schiavo e chi guarda al proprio figlio come se fosse un estraneo. Cos’è dunque, Marcia, che ti fa soffrire? Il fatto che tuo figlio è morto o che non è vissuto abbastanza? Se ne piangi la morte avresti dovuto piangere sempre, perché da sempre sapevi che sarebbe morto. Rifletti allora che chi è morto non soffre più alcun male, che sono favole quelle secondo cui l’aldilà sarebbe qualcosa di terribile: nessuna tenebra incombe sui morti, non ci sono prigioni né torrenti che ribollono di fuoco, né un fiume dell’Oblio, non ci sono tribunali e imputati, non c’è nessun tiranno in quella assoluta e totale libertà. Sono i poeti ad avere inventato tutte queste cose, spaventandoci con vani terrori. La morte è la soluzione di tutti i dolori, il confine che i nostri mali terreni non possono varcare; essa ci rimette in quella tranquillità in cui giacevamo prima di nascere. Chi piange i morti deve piangere anche coloro che, concepiti, non sono venuti al mondo. La morte non è né un bene né un male. Per poter parlare di bene o di male bisogna che vi sia qualcosa a cui attribuire quelle prerogative, ma il niente e ciò che si riduce a niente ci sottrae a qualsivoglia sorte: il male e il bene, infatti, agiscono solo su ciò che esiste, la sorte non ha presa su ciò che la natura ha licenziato, né può essere infelice chi non esiste più. Tuo figlio è uscito dai confini entro i quali si è schiavi ed è stato accolto in una grande ed eterna pace. Né più lo assalgono il timore della povertà, l’assillo della ricchezza, l’impulso della libidine che corrompe le anime con la
voluttà; non prova invidia per la felicità altrui e non è odiato per la propria, i suoi orecchi verecondi non sono più colpiti da alcuna offesa, nessuna calamità, pubblica o privata, si prospetta per lui, nessuna ansia per un futuro che promette cose sempre incerte. Egli, insomma, ormai si trova in un luogo da dove nulla può scacciarlo e dove nulla può spaventarlo. 20. Oh, come ben conoscono i loro mali coloro che apprezzano la morte e l’attendono come la migliore invenzione della natura! Sia che ponga fine a una vita felice, sia che ne tronchi una infelice, che giunga dopo una stanca e fastidiosa vecchiaia o si porti via la giovinezza in fiore nel momento in cui sono più belle le speranze, o, prima ancora, la puerizia, sottraendola alle prove più dure, la morte è per tutti la fine della vita, per molti un rimedio, per alcuni una grazia e mai più opportuna se non per chi non arriva al punto di doverla invocare! Essa libera lo schiavo anche senza il consenso del padrone, libera i prigionieri dalle catene e manda fuori dal carcere coloro a cui un potere tirannico aveva impedito di uscirne, dimostra agli esuli, che tengono sempre il cuore e gli occhi rivolti alla patria, che non importa sotto quale terra si sia sepolti; essa rende tutti uguali dopo che la fortuna ha suddiviso male i beni comuni e sottomesso gli uomini gli uni agli altri, quando essi sono nati tutti con i medesimi diritti. Dopo la morte nessuno soggiace all’arbitrio di altri, né si sente un reietto: lei ha sempre accolto tutti indiscriminatamente, è lei, o Marcia, che tuo padre ha sempre desiderato, è lei che dissolve nel suo seno il supplizio della nascita, che m’impedisce di abbattermi di fronte alle minacce della malasorte e mi dà la forza di conservare l’animo saldo e padrone di sé, perché so a chi posso appellarmi alla fine. Qui vedo strumenti di tortura di ogni genere, costruiti quali in un modo quali in un altro, condannati che vengono appesi a testa in giù, altri impalati con una pertica conficcata nelle parti basse, altri con le braccia aperte inchiodate sul patibolo; vedo corde e flagelli, e strumenti specifici approntati per ogni parte del corpo. Ma vedo anche la morte. Qui ci sono nemici sanguinari e cittadini prepotenti, ma vedo anche la morte. La schiavitù non ti pesa se, quando sei stanco del padrone, puoi, con un solo passo, raggiungere la libertà. Mi sei gradita, o vita, proprio per via della morte! Pensa ai vantaggi di una morte che giunge al momento opportuno e a quanti ha nociuto l’essere vissuti troppo. Gneo Pompeo, gloria e sostegno di questo impero, se fosse morto del suo male a Napoli, se ne sarebbe andato con la fama indiscussa di primo cittadino del popolo romano. Invece quel poco in più di vita lo fece precipitare dall’altezza che aveva raggiunto: si vide sterminare sotto gli occhi intere legioni, e da quella battaglia,27 che ebbe tutti i senatori nella prima schiera, fra quegli unici resti vide sopravvivere il comandante supremo, vide il carnefice egiziano e offrì a uno scherano il suo corpo che persino i vincitori consideravano inviolabile. Ma anche se ne fosse uscito incolume se ne sarebbe pentito: quale maggiore vergogna, per un Pompeo, di una vita risparmiata per concessione di un re? Marco Cicerone, se fosse morto quando sfuggì ai pugnali
di Catilina, che attentavano alla vita non solo di lui ma dello Stato stesso, se dopo aver liberato la repubblica, lui, salvatore della patria, avesse seguito la figlia28 nella tomba, sarebbe ancora potuto morire felice: non avrebbe visto le spade sguainate sulle teste dei cittadini, né gli uccisori dividersi i beni delle vittime, che così morivano a proprie spese, né vendere all’asta le spoglie dei consoli, né le stragi, le rapine appaltate dallo Stato, né le guerre, i saccheggi e tanti altri Catilina. E se il mare avesse inghiottito Marco Catone al suo ritorno da Cipro, dove aveva dato esecuzione al testamento del re,29 o se fosse affondato proprio con quel denaro che serviva a finanziare la guerra civile, non sarebbe forse stato un bene per lui? Avrebbe portato con sé la certezza che nessuno osava compiere un delitto in presenza di Catone. Ebbene, l’aggiunta di pochissimi anni di vita costrinse quest’uomo, nato non solo per la sua libertà ma anche per quella dello Stato, a fuggire Cesare per seguire Pompeo. Dunque la morte prematura non ha recato alcun male a tuo figlio, anzi, lo ha dispensato dal peso di tutti i mali possibili. 21. «Sì, però è morto troppo presto e impreparato». Prima di tutto immagina che gli rimassero tanti anni quanti al massimo può viverne un uomo. Quanti? Siamo destinati a una vita che già è brevissima di per sé, per lasciare poi il posto, non certo tranquillo, agli altri ospiti che verranno, come in un albergo. Questa è la nostra vita e, come tutti sanno, scorre rapidissimamente. Calcola gli anni delle città: vedrai quanto poco tempo siano durate persino quelle che si vantavano della loro antichità. Tutte le cose umane sono brevi e caduche e del tempo infinito non occupano che una porzione insignificante. Di fronte all’universo questa nostra terra, con le sue città, i suoi popoli, i suoi fiumi e l’Oceano che la circonda, non è che un punto, e meno ancora di un punto è la nostra vita, se la confrontiamo con l’eternità, la quale è ben più vasta dell’universo, che si rinnova, sì, continuamente, ma sempre all’interno dell’eternità. Che giova, quindi, estendere una cosa che, per quanto la si accresca, non sarà molto lontana dal nulla? Non c’è che un modo per prolungare la nostra vita: ritenerla comunque sufficiente. Anche la longevità degli uomini ricordàti per essere vissuti più degli altri, a un massimo, diciamo, di centodieci anni, paragonata all’eternità dimostra che non c’è differenza fra la vita più lunga e la più breve, soprattutto se si confronta la quantità del tempo che si vive con quella che non si è vissuta e non si vivrà. E poi tuo figlio è morto al tempo giusto per lui, altro non gliene restava, è vissuto quanto doveva vivere, la vecchiaia non è uguale per tutti gli uomini, come non lo è per gli animali: per alcuni di questi la fine viene a quattordici anni, un tempo lunghissimo per loro, che per l’uomo costituisce la prima età. A ciascuna vita è assegnata una durata diversa. Di nessuno si può dire che sia morto troppo presto, perché nessuno sarebbe potuto vivere più di quanto è vissuto. C’è una scadenza per ciascuno e resterà sempre quella stabilita in partenza: non c’è favore o espediente che possa prolungare la durata della vita. Convinciti che hai perduto tuo figlio per eterno decreto della
mente divina: egli ha avuto la sua giusta parte ed è giunto al termine del tempo a lui concesso.30 Non hai dunque motivo di affliggerti pensando: «Poteva vivere di più». La sua vita non è stata interrotta: il caso non può interrompere gli anni prima del tempo stabilito, a ciascuno è dato quanto gli è stato promesso, il destino va per la sua strada e non aggiunge e non toglie nulla a quanto una volta per tutte ha stabilito. È inutile pregare e desiderare: ciascuno avrà quanto gli è stato assegnato nel suo giorno di nascita; dal momento in cui ha visto per la prima volta la luce è entrato nella strada che conduce alla morte e si è avvicinato sempre più al suo destino finale: gli anni che si aggiungevano alla sua fanciullezza venivano al tempo stesso sottratti alla durata della sua vita. Cadiamo tutti nello stesso errore, quello di credere che alla morte si avviino solo i vecchi ormai decrepiti quando invece ci si va subito fin dall’infanzia, poi dall’adolescenza e da tutte le altre età. Il fato fa quel che deve: ci toglie il senso della morte, e questa, per insinuarsi in noi più facilmente, si nasconde sotto il nome di vita. La puerizia si succhia l’infanzia, la pubertà la puerizia, la vecchiaia la giovinezza. Se fai il conto, ogni guadagno è una perdita. 22. Ti lamenti, o Marcia, perché tuo figlio non è vissuto tanto quanto avrebbe potuto. Ma come puoi sapere se per lui sarebbe stato meglio vivere più a lungo o se, essendo morto in quell’età, non gli sia invece giovato? Puoi trovare forse qualcuno che goda di una posizione così stabile e sicura da non dover temere nulla in futuro? Le cose umane vacillano e si dileguano, e nessun periodo della nostra vita è tanto esposto e fragile quanto quello che più ci è gradito, perciò i più felici devono desiderare la morte, perché in tanta incertezza e confusione solo il passato è sicuro. Chi ti garantisce che quel bellissimo corpo di tuo figlio, così diligente nel conservare intatto il suo pudore di fronte a una città dissoluta, sarebbe riuscito a sfuggire a tante malattie e a portare inalterata sino alla vecchiaia la sua bellezza? Pensa alle mille brutture che possono corrompere l’animo: neppure le indoli più oneste conducono al traguardo della vecchiaia le speranze che da giovani avevano suscitato negli altri, per lo più si lasciano deviare, o li afferra una lussuria tarda e perciò più vergognosa, che comincia ad avvilire quel bell’inizio, o cedono completamente al bere e alla fame del ventre, che diventano la loro più grave preoccupazione. A tutto questo aggiungi gl’incendi, i crolli, i nubifragi e le operazioni dei medici che frugano nella carne viva per cercare un osso malato, o affondano l’intera mano nelle viscere, o curano le parti intime infliggendo dolori su dolori. Poi c’è l’esilio, e tuo figlio non era più innocente di Rutilio, c’è il carcere, e tuo figlio non era certo più saggio di Socrate, c’è il suicidio, e tuo figlio non era più virtuoso di Catone. Se consideri tutto ciò converrai che la natura è benevola con coloro che mette anzitempo al riparo da questo ulteriore tributo da dover pagare alla vita. Nulla è
tanto ingannevole o insidioso quanto la vita umana: nessuno di noi, per Ercole, l’accetterebbe se non ci fosse data a nostra insaputa. In definiva se la cosa migliore è non nascere, ciò che sta quasi alla pari con quella non esistenza è il ritornarci al più presto possibile. Pensa a quel tempo, per te dolorosissimo, in cui Seiano offrì tuo padre in pasto al suo cliente Satrio Secondo. Ce l’aveva con lui per una o due sue battute pronunciate in tutta libertà: tuo padre, infatti, non aveva sopportato in silenzio che Seiano non solo ci stesse alle spalle ma che addirittura ci salisse sopra. Si votava l’erezione di una statua in onore di lui nel teatro di Pompeo, che Cesare stava ricostruendo dopo l’incendio: a un certo punto Cordo esclamò: «Stavolta sì che il teatro crolla davvero!». E che? Poteva non scoppiare vedendo porre la statua di Seiano sulle ceneri di Pompeo e consacrare un soldato traditore accanto al monumento di un grande generale? Ebbene, si sottoscrive l’atto di accusa contro Cordo, e quei cani rabbiosi che Seiano nutriva di sangue umano per renderli feroci con tutti e mansueti con sé stesso incominciarono a latrare attorno a un uomo che anche in quel caso restava imperturbabile. Che cosa poteva fare? Se voleva vivere doveva pregare Seiano, se voleva morire doveva pregare sua figlia: ma entrambi erano irremovibili. Così decise d’ingannare la figlia. Fece un bagno per ridurre il più possibile le sue forze, si ritirò in camera, come se volesse mangiare, e, congedati gli schiavi, gettò dalla finestra parte del cibo, per far credere di aver pranzato. Alla sera non cenò, sostenendo di avere abbastanza mangiato in camera sua. L’indomani fece altrettanto, e così pure il giorno seguente. Al quarto non poté più nascondere la sua debolezza. Allora ti abbracciò e ti disse: «Figlia carissima, in tutta la mia vita ti ho nascosto solo questo: sono entrato nel sentiero della morte e mi trovo a metà strada. Non devi farmi tornare indietro, né più lo potresti, ormai». Quindi ordinò di chiudere le finestre e si nascose alla vista di tutti. La notizia di quella sua decisione fu un sollievo per i familiari, perché Cordo si sottraeva alle fauci di quegli avidissimi lupi. Ma gli accusatori, vedendosi sfuggire la preda, su istigazione di Seiano, si rivolsero al tribunale dei consoli protestando che Cordo cercava la morte per vanificare la loro iniziativa. La questione era controversa, non essendo chiaro se all’accusato fosse lecito morire di propria mano. Mentre si discuteva e gli accusatori si presentavano nuovamente in tribunale, Cordo era già libero. Vedi, Marcia, quante vicende impensabili ci piombano addosso in questi tempi crudeli? Tu piangi perché a uno dei tuoi toccò in sorte di morire, ma c’è stato chi per poco non lo poté neppure di sua mano. 23. A parte il fatto che il futuro è incerto e più propenso al peggio, la via verso il cielo è facilissima per le anime che si sono staccate presto dai rapporti con gli uomini, perché portano con sé una minore quantità di residui terreni. Liberatesi prima di indurirsi e assorbire troppo gli elementi terrestri, spiccano più leggere il volo verso la loro origine e si spogliano più facilmente di ciò che le insozza e le contamina. Inoltre ai grandi spiriti non è gradito un lungo
soggiorno nel corpo: essi sono impazienti di uscirne, di balzar fuori, mal sopportano queste strettoie, abituati come sono a innalzarsi al cielo per spaziarvi e guardare dall’alto le vicende umane. È per questo – dice Platone – che l’animo del saggio si protende tutto verso la morte, questo egli vuole, questo egli medita continuamente, spinto da un tale desiderio verso l’aldilà. E che? Quando tu, o Marcia, vedevi in quel giovane una saggezza degna di un vecchio, un animo che aveva trionfato su tutti i piaceri, senza macchie, senza vizi, che cercava sì la ricchezza ma senza avidità, gli onori ma senza ambizione, i piaceri ma senza lussuria, pensavi che avresti potuto tenertelo a lungo sano e salvo? Tutto ciò che giunge a perfezione è vicino alla fine, una virtù perfetta non è più visibile ai nostri occhi, i frutti precocemente maturi non aspettano la fine della stagione. Il fuoco, quanto più splendidamente sfolgora, tanto più presto si spegne, mentre se è alimentato da un legname resistente e poco combustibile e soffocato dal fumo dura di più, ma la sua luce è fuligginosa, lo tiene in vita proprio quel materiale che fa fatica a nutrirlo. Anche gl’ingegni quanto più sono brillanti tanto più poco durano, poiché dove non c’è più spazio o incremento per la crescita il tramonto è vicino. Fabiano31 racconta, e l’hanno visto anche i nostri genitori, che a Roma c’era un bambino di grande statura e molto robusto che però morì presto: l’avevano previsto tutti, perché non poteva più raggiungere quell’età che aveva raggiunto in anticipo. È così: una precocità eccessiva è indizio di morte precoce, la fine si avvicina quando la crescita è compiuta. 24. Comincia dunque a valutare tuo figlio sulla base delle sue virtù, non su quella degli anni, e ti renderai conto ch’è vissuto abbastanza a lungo. Rimasto orfano di padre, fu affidato ai tutori sino all’età di quattordici anni, ma sempre sotto la tutela di sua madre. Pur avendo una casa propria, non volle lasciare la tua e convisse con te per tutta l’adolescenza, l’età in cui i figli stentano ad accettare la convivenza col padre. Per la sua statura, la bellezza e la prestanza fisica, sembrava nato per la vita militare, ma vi rinunciò per non allontanarsi da te. Calcola, o Marcia, quanto poco vedano i propri figli quelle madri che non coabitano con loro, considera quanti anni risultino perduti o trascorrano nell’ansia per quelle madri i cui figli sono sotto le armi: ti renderai conto che è stato molto lungo quel tempo, del quale non hai perduto un solo momento: tuo figlio non si è mai allontanato da te, sotto i tuoi occhi ha plasmato con gli studi quell’ingegno straordinario che avrebbe eguagliato quello del nonno se non si fosse frapposta la modestia, che nasconde sotto il silenzio i progressi di molti. Giovane di eccezionale bellezza, non si offrì mai alle speranze di quelle numerosissime donne che corrompono gli uomini, e quando qualcuna di esse maliziosamente tentò di adescarlo ne arrossì, come se l’essere piaciuto gli sembrasse una colpa. Per questa santità di costumi ancora fanciullo parve degno del sacerdozio, certamente con l’appoggio di sua madre, che però non sarebbe valso a nulla se il candidato non fosse risultato idoneo. Riabbraccia dunque tuo figlio, se così posso dire, contemplando queste sue
virtù. Proprio ora egli sarà tutto tuo, perché ora non c’è nulla che possa allontanartelo, non avrai mai motivo di ansie e di pianto. Da un figlio tanto buono hai avuto il solo dolore che potevi avere, tutto il resto, sottratto a qualsiasi evento terreno, è colmo di gioia, purché tu sappia godere di tuo figlio e capire quanto in lui ci fosse di sommamente prezioso. Ti è venuta a mancare solo la sua immagine, che peraltro non corrispondeva pienamente al suo ritratto interiore, ora, invece, è eterno e in condizione migliore, libero da pesi non suoi e restituito a sé stesso: tutto ciò che ci è stato messo attorno, infatti, le ossa, i nervi, la pelle che ricopre il corpo e il volto, le mani operose e ogni altra cosa sono catene e tenebre per l’anima, che ne è sopraffatta, strozzata, contaminata, allontanata dalla sua verità e spinta all’errore. Tutta la sua lotta è rivolta contro il peso di questa carne; per non esserne coinvolta e paralizzata, essa tende a salire al luogo da cui è discesa, là l’attende una pace eterna, la contemplazione di tutto ciò che è limpido e puro, fuori dalla concretezza della materia. 25. Dunque non hai più motivo di piangere sulla tomba di tuo figlio: lì giace la parte deteriore e ingombrante di lui, proprio quella che gli fu più molesta, ossa e cenere, che ormai non gli appartiene più, come il corpo, le vesti e gli altri indumenti. Se n’è fuggito integro e senza lasciare nulla di sé sulla terra, se n’è andato completamente. Si è soffermato brevemente in uno spazio che sta sopra di noi per purificarsi e scuotersi di dosso tutte le imperfezioni della vita terrena, poi si è innalzato nella parte più alta del cielo e colà si muove liberamente, tra le anime felici. È stato accolto nella sacra compagnia degli Scipioni e dei Catoni e tra coloro che hanno disprezzato la vita e si sono dati da sé la libertà, come tuo padre, o Marcia, il quale tiene vicino a sé il nipote (sebbene lì formino tutti un’unica famiglia), lo vede godere della nuova luce, gli spiega i moti delle stelle vicine, non per ipotesi ma per esperienza diretta, e lo inizia con gioia ai misteri della natura. Come l’ospite è grato a colui che va mostrandogli città sconosciute, così tuo figlio, che lo interroga sulle cause dei fenomeni celesti, è grato a questo suo familiare che gli fa da interprete. E lo invita anche a volgere lo sguardo giù, verso gli abissi che cingono la terra, perché è bello rivedere dall’alto ciò che si è lasciato. Continua dunque a vivere, o Marcia, come se fossi ancora sotto lo sguardo di tuo padre e di tuo figlio, non però quali li hai conosciuti ma posti molto più in alto, nel luogo più sublime che vi sia; arrossisci di qualunque atteggiamento meschino o volgare, come quello di piangere i tuoi cari, ora che si sono fatti migliori. Entrati nei liberi e immensi spazi dell’eternità, entrambi non sono più divisi fra loro dagli interposti mari, da alte catene di monti, da valli impervie o dalle secche infìde delle Sirti: tutto è pianeggiante per loro, che, spostandosi con naturale agilità e scioltezza, si compenetrano reciprocamente e si mescolano con le stelle. 26. E ora immagina, o Marcia, che da quella rocca celeste ti parli tuo padre –
che su di te aveva tanta autorità quanta ne avevi tu su tuo figlio – non con quell’animo con cui pianse le guerre civili e condannò per l’eternità coloro che avevano scritto le lettere di proscrizione, e con ispirazione tanto più elevata in quanto è ancora più in alto, egli ti dica: «Perché, o figlia, ti lasci prendere così a lungo dalla tristezza? Perché persisti nel credere che sia stato fatto un torto a tuo figlio quando, senza arrecare alcun danno alla sua famiglia e incolume egli stesso, se n’è tornato dai suoi antenati? Non sai con quali tempeste la sorte sconvolga ogni cosa? E che non mostra benevolenza ad alcuno se non soltanto a coloro che non hanno avuto rapporti con lei? Vuoi che ti nomini dei re che sarebbero stati felicissimi se una morte precoce li avesse sottratti ai mali che incombevano su di loro? O dei condottieri romani che nulla perderebbero della loro grandezza se togliessi qualche anno alla loro vita? O uomini di grandissima nobiltà e fama, lasciati in vita dalla sorte per poter offrire il loro collo alla spada di un soldato? Ripensa a tuo padre e a tuo nonno: questi fu vittima di un sicario straniero, io non mi sono lasciato offendere da nessuno e, astenendomi dal cibo, ho mostrato nella mia vita lo stesso coraggio che aveva ispirato i miei scritti. Perché nella nostra famiglia si piange più a lungo chi ha avuto la morte più felice? Noi siamo tutti qui riuniti e, non più circondati dal buio della notte, vediamo che nel vostro mondo, contrariamente a quanto voi credete, nulla è degno di essere desiderato, nulla è elevato, nulla risplende, ma tutto è vile, pesante, angoscioso e riceve una ben piccola parte della luce che splende quassù. Qui non ci sono eserciti che infuriano gli uni contro gli altri, flotte che s’infrangono contro altre flotte, parricidi progettati e meditati, fori che strepitano di processi per intere giornate; qui nulla è nascosto, i pensieri sono palesi, il cuore è aperto, la vita si svolge in mezzo a tutti e davanti a tutti e si ha cognizione dei fatti di ogni tempo e di ogni paese. Quando stavo sulla terra amavo raccogliere gli avvenimenti di una sola epoca, svoltisi in una parte infinitesima del mondo e tra pochissimi uomini: ora posso vedere l’intera sequenza e l’intreccio di tanti secoli, di tante età, di tutti gli anni, posso vedere i regni che attendono di nascere e quelli che stanno per crollare, la caduta delle grandi città e il futuro fluire del mare. Quindi, se può recare consolazione al tuo rimpianto il fatto che siamo tutti accomunati da un medesimo destino, sappi che il tempo abbatterà tutto ciò che sulla terra adesso si trova, trascinandolo con sé. E non si befferà solo degli uomini (che sono una piccolissima parte del dominio della sorte), ma anche delle città, delle regioni e dei continenti: schiaccerà intere montagne e innalzerà altrove nuove rupi verso il cielo, prosciugherà i mari, devierà il corso dei fiumi e interrompendo i rapporti fra le genti scioglierà ogni alleanza e ogni società umana, seppellirà città in profonde voragini, le scuoterà con terremoti, farà schizzare dal profondo esalazioni pestifere, ricoprirà con alluvioni ogni luogo abitato sommergendo la terra e facendo morire ogni essere vivente, e con immensi fuochi incendierà e ridurrà in cenere ogni cosa mortale. Poi, quando starà per giungere l’alba di un mondo nuovo, il vecchio si distruggerà interamente con le sue stesse forze, le stelle si scontreranno fra loro e
in una universale conflagrazione della materia tutti i corpi celesti che ora splendono in bell’ordine ciascuno al suo proprio posto arderanno in un immenso fuoco. Anche noi, anime felici dall’eterno destino, quando dio riterrà giunto il momento di una nuova creazione, nata dalla distruzione dell’universo, noi, che siamo una piccola parte accessoria in quell’immenso e totale sconvolgimento, saremo ritrasformati negli elementi primordiali». Felice tuo figlio, o Marcia, che già conosce tutto questo!
1. Cremuzio Cordo, senatore e storico, autore di Annales, di cui si parla più avanti. 2. Lucio Elio Seiano, prefetto del pretorio e consigliere di Tiberio, si macchiò di molti delitti e tramò contro l’imperatore stesso, che lo fece giustiziare. 3. È l’imperatore Ottaviano Augusto, di cui Marcello aveva sposato la figlia Giulia. 4. Il futuro imperatore Tiberio. 5. Areo Didimo, filosofo stoico e consigliere spirituale di Augusto. 6. Il verso è di Publilio Siro di Antiochia, attore e autore di mimi del I secolo a.C. 7. Pizia è la nota sacerdotessa del tempio di Apollo a Delfi. 8. Nel De providentia Seneca ironizza sulla «felice èra di Silla» (III 7). 9. Era il gesto con cui il sacerdote consacrava il tempio. 10. Emilio Paolo è il vincitore di Perseo, re di Macedonia, nella battaglia di Pidna (168 a.C.). 11. Secondo la consuetudine i figli seguivano il trionfo sul cocchio del padre. 12. Lucio Calpurnio Bibulo e Caio Giulio Cesare furono colleghi nel consolato del 59 a.C. 13. È Giulia, che Cesare, per motivi politici, diede in sposa a Gneo Pompeo. 14. Perché Augusto alla sua morte sarebbe stato assunto fra gli dèi. 15. Si tratta di Germanico. Druso, figlio legittimo di Tiberio, morì avvelenato da Seiano. 16. Lucrezia, moglie del console Collatino, si diede la morte dopo essere stata violentata da Sesto, figlio di Tarquinio il Superbo. Il suo sacrificio fu uno dei motivi che determinarono la cacciata da Roma dei Tarquini e la conseguente fine della monarchia. 17. Clelia, data in ostaggio al re etrusco Porsenna, riuscì a fuggire passando a nuoto il Tevere. 18. Tiberio Sempronio e Caio Sempronio Gracco, figli di Cornelia e nipoti di Scipione l’Africano, furono i tribuni della plebe che si batterono per le leggi agrarie contro l’aristocrazia romana. 19. M. Livio Druso, tribuno della plebe nel 91 a.C., proseguì l’opera dei Gracchi e si batté per la concessione della cittadinanza romana agli Italici. 20. È una citazione dall’Eneide (III 418). 21. Da Alfeo, il fiume del Peloponneso che sfocia nel Mar Ionio, è derivata la leggenda della ninfa Aretusa, che fu mutata in fonte affinché potesse sottrarsi alle brame amorose di lui. 22. Sono le Latomie, dove, dopo la disfatta di Atene da parte di Siracusa (413 a.C.) durante la guerra del Peloponneso, furono rinchiusi migliaia di ateniesi. 23. È Dionigi il Giovane, a cui Platone consigliò invano di attuare riforme politiche. 24. Secondo la teoria tolemaica è il Sole che gira intorno alla terra, immobile al centro dell’universo, con tutti gli altri pianeti. 25. Gli antichi ritenevano che l’Oceano fosse un fiume che circondava la terra e che da lui avessero avuto origine tutte le acque. I tre golfi sono formati dal Mar Mediterraneo, dal Mar Caspio e dal Mar Rosso. 26. I coniugi senza figli, o che fingevano di non averne, erano corteggiati da coloro che andavano a caccia di eredità e che perciò si mostravano premurosi verso di loro. 27. È la battaglia di Farsalo (48 a.C.), in cui Pompeo fu sconfitto da Cesare. 28. È Tullia, figlia di Cicerone, morta nel 45 a.C. 29. Si tratta dell’immenso patrimonio di Tolomeo, re d’Egitto, lasciato in eredità a Roma. Catone ebbe l’incarico di definire la questione. 30. Citazione dall’Eneide (X 472).
31. Papirio Fabiano, autorevole retore, fu maestro di Seneca, che lo ricorda anche nel De brevitate vitae.
De ira
Liber primus 1. Exegisti a me, Novate, ut scriberem quemadmodum posset ira leniri, nec inmerito mihi videris hunc praecipue affectum pertimuisse maxime ex omnibus taetrum ac rabidum. Ceteris enim aliquid quieti placidique inest, hic totus concitatus et in impetu est, doloris armorum, sanguinis suppliciorum minime humana furens cupiditate, dum alteri noceat sui neglegens, in ipsa inruens tela et ultionis secum ultorem tracturae avidus. Quidam itaque e sapientibus viris iram dixerunt brevem insaniam; aeque enim inpotens sui est, decoris oblita, necessitudinum immemor, in quod coepit pertinax et intenta, rationi consiliisque praeclusa, vanis agitata causis, ad dispectum aequi verique inhabilis, ruinis simillima quae super id quod oppressere franguntur. Ut scias autem non esse sanos quos ira possedit, ipsum illorum habitum intuere; nam ut furentium certa indicia sunt audax et minax vultus, tristis frons, torva facies, citatus gradus, inquietae manus, color versus, crebra et vehementius acta suspiria, ita irascentium eadem signa sunt: flagrant ac micant oculi, multus ore toto rubor exaestuante ab imis praecordiis sanguine, labra quatiuntur, dentes comprimuntur, horrent ac surriguntur capilli, spiritus coactus ac stridens, articulorum se ipsos torquentium sonus, gemitus mugitusque et parum explanatis vocibus sermo praeruptus et conplosae saepius manus et pulsata humus pedibus et totum concitum corpus magnasque irae minas agens, foeda visu et horrenda facies depravantium se atque intumescentium. Nescias utrum magis detestabile vitium sit an deforme. Cetera licet abscondere et in abdito alere: ira se profert et in faciem exit, quantoque maior, hoc effervescit manifestius. Non vides ut omnium animalium, simul ad nocendum insurrexerunt, praecurrant notae ac tota corpora solitum quietumque egrediantur habitum et feritatem suam exasperent? Spumant apris ora, dentes acuuntur adtritu, taurorum cornua iactantur in vacuum et harena pulsu pedum spargitur, leones fremunt, inflantur inritatis colla serpentibus, rabidarum canum tristis aspectus est: nullum est animal tam horrendum tam perniciosumque natura ut non appareat in illo, simul ira invasit, novae feritatis accessio. Nec ignoro ceteros quoque affectus vix occultari, libidinem metumque et audaciam dare sui signa et posse praenosci; neque enim ulla vehementior intrat agitatio quae nihil moveat in vultu. Quid ergo interest? Quod alii affectus apparent, hic eminet. 2. Iam vero si effectus eius damnaque intueri velis, nulla pestis humano generi pluris stetit. Videbis caedes ac venena et reorum mutuas sordes et urbium clades et totarum exitia gentium et principum sub civili hasta capita venalia et
subiectas tectis faces nec intra moenia coercitos ignes sed ingentia spatia regionum hostili flamma relucentia. Aspice nobilissimarum civitatum fundamenta vix notabilia: has ira deiecit. Aspice solitudines per multa milia sine habitatore desertas: has ira exhausit. Aspice tot memoriae proditos duces mali exempla fati: alium ira in cubili suo confodit, alium intra sacra mensae iura percussit, alium intra leges celebrisque spectaculum fori lancinavit, alium filii parricidio dare sanguinem iussit, alium servili manu regalem aperire iugulum, alium in cruce membra diffindere. Et adhuc singulorum supplicia narro: quid si tibi libuerit, relictis in quos ira viritim exarsit, aspicere caesas gladio contiones et plebem inmisso milite contrucidatam et in perniciem promiscuam totos populos capitis damnatos… … tamquam aut curam nostram deserentibus aut auctoritatem contemnentibus. Quid? Gladiatoribus quare populus irascitur, et tam inique ut iniuriam putet quod non libenter pereunt? Contemni se iudicat et vultu gestu ardore ex spectatore in adversarium vertitur. Quicquid est tale, non est ira, sed quasi ira, sicut puerorum qui, si ceciderunt, terram verberari volunt et saepe ne sciunt quidem cur irascantur, sed tantum irascuntur, sine causa et sine iniuria, non tamen sine aliqua iniuriae specie nec sine aliqua poenae cupiditate. Deluduntur itaque imitatione plagarum et simulatis deprecantium lacrimis placantur et falsa ultione falsus dolor tollitur. 3. «Irascimur» inquit «saepe non illis qui laeserunt, sed iis qui laesuri sunt, ut scias iram non ex iniuria nasci». Verum est irasci nos laesuris, sed ipsa cogitatione nos laedunt, et iniuriam qui facturus est iam facit. «Ut scias» inquit «non esse iram poenae cupiditatem, infirmissimi saepe potentissimis irascuntur nec poenam concupiscunt quam non sperant». Primum diximus cupiditatem esse poenae exigendae, non facultatem; concupiscunt autem homines et quae non possunt. Deinde nemo tam humilis est qui poenam vel summi hominis sperare non possit: ad nocendum potentes sumus. Aristotelis finitio non multum a nostra abest: ait enim iram esse cupiditatem doloris reponendi. Quid inter nostram et hanc finitionem intersit, exequi longum est. Contra utramque dicitur feras irasci nec iniuria inritatas nec poenae dolorisve alieni causa, nam etiam si haec efficiunt, non haec petunt. Sed dicendum est feras ira carere et omnia praeter hominem; nam cum sit inimica rationi, nusquam tamen nascitur nisi ubi rationi locus est. Impetus habent ferae, rabiem feritatem incursum, iram quidem non magis quam luxuriam, et in quasdam voluptates intemperantiores homine sunt. Non est quod credas illi qui dicit: non aper irasci meminit, non fidere cursu cerva nec armentis incurrere fortibus ursi. Irasci dicit incitari, inpingi; irasci quidem non magis sciunt quam ignoscere.
Muta animalia humanis affectibus carent, habent autem similes illis quosdam impulsus: alioqui, si amor in illis esset et odium, esset amicitia et simultas, dissensio et concordia; quorum aliqua in illis quoque extant vestigia, ceterum humanorum pectorum propria bona malaque sunt. Nulli nisi homini concessa prudentia est, providentia diligentia cogitatio, nec tantum virtutibus humanis animalia sed etiam vitiis prohibita sunt. Tota illorum ut extra ita intra forma humanae dissimilis est; regium est illud et principale aliter ductum. Ut vox est quidem sed non explanabilis et perturbata et verborum inefficax, ut lingua, sed devincta nec in motus varios soluta, ita ipsum principale parum subtile, parum exactum. Capit ergo visus speciesque rerum quibus ad impetus evocetur, sed turbidas et confusas. Ex eo procursus illorum tumultusque vehementes sunt, metus autem sollicitudinesque et tristitia et ira non sunt, sed his quaedam similia: ideo cito cadunt et mutantur in contrarium et, cum acerrime saevierunt expaveruntque, pascuntur, et ex fremitu discursuque vesano statim quies soporque sequitur. 4. Quid esset ira satis explicitum est. Quo distet ab iracundia apparet: quo ebrius ab ebrioso et timens a timido. Iratus potest non esse iracundus: iracundus potest aliquando iratus non esse. Cetera quae pluribus apud Graecos nominibus in species iram distinguunt, quia apud nos vocabula sua non habent, praeteribo, etiam si amarum nos acerbumque dicimus, nec minus stomachosum rabiosum clamosum difficilem asperum, quae omnia irarum differentiae sunt; inter hos morosum ponas licet, delicatum iracundiae genus. Quaedam enim sunt irae quae intra clamorem considant, quaedam non minus pertinaces quam frequentes, quaedam saevae manu verbis parciores, quaedam in verborum maledictorumque amaritudinem effusae, quaedam ultra querellas et aversationes non exeunt, quaedam altae gravesque sunt et introrsus versae: mille aliae species sunt mali multiplicis. 5. Quid esset ira quaesitum est, an in ullum aliud animal quam in hominem caderet, quo ab iracundia distaret, quot eius species essent: nunc quaeramus an ira secundum naturam sit et an utilis atque ex aliqua parte retinenda. An secundum naturam sit manifestum erit, si hominem inspexerimus. Quo quid est mitius, dum in recto animi habitus est? Quid autem ira crudelius est? Quid homine aliorum amantius? Quid ira infestius? Homo in adiutorium mutuum genitus est, ira in exitium; hic congregari vult, illa discedere, hic prodesse, illa nocere, hic etiam ignotis succurrere, illa etiam carissimos petere; hic aliorum commodis vel impendere se paratus est, illa in periculum, dummodo deducat, descendere. Quis ergo magis naturam rerum ignorat quam qui optimo eius operi et emendatissimo hoc ferum ac perniciosum vitium adsignat? Ira, ut diximus, avida poenae est, cuius cupidinem inesse pacatissimo hominis pectori minime secundum eius naturam est. Beneficiis enim humana vita constat et concordia, nec terrore sed mutuo amore in foedus auxiliumque commune constringitur.
6. «Quid ergo? Non aliquando castigatio necessaria est?». Quidni? Sed haec sine ira, cum ratione; non enim nocet sed medetur specie nocendi. Quemadmodum quaedam hastilia detorta ut corrigamus adurimus et adactis cuneis, non ut frangamus sed ut explicemus, elidimus, sic ingenia vitio prava dolore corporis animique corrigimus. Nempe medicus primo in levibus vitiis temptat non multum ex cotidiana consuetudine inflectere et cibis potionibus exercitationibus ordinem imponere ac valetudinem tantum mutata vitae dispositione firmare. Proximum est ut modus proficiat. Si modus et ordo non proficit, subducit aliqua et circumcidit; si ne adhoc quidem respondet, interdicit cibis et abstinentia corpus exonerat; si frustra molliora cesserunt, ferit venam membrisque, si adhaerentia nocent et morbum diffundunt, manus adfert; nec ulla dura videtur curatio cuius salutaris effectus est. Ita legum praesidem civitatisque rectorem decet, quam diu potest, verbis et his mollioribus ingenia curare, ut facienda suadeat cupiditatemque honesti et aequi conciliet animis faciatque vitiorum odium, pretium virtutium; transeat deinde ad tristiorem orationem, qua moneat adhuc et exprobret; novissime ad poenas et has adhuc leves, revocabiles decurrat; ultima supplicia sceleribus ultimis ponat, ut nemo pereat nisi quem perire etiam pereuntis intersit. Hoc uno medentibus erit dissimilis, quod illi quibus vitam non potuerunt largiri facilem exitum praestant, hic damnatos cum dedecore et traductione vita exigit, non quia delectetur ullius poena (procul est enim a sapiente tam inhumana feritas) sed ut documentum omnium sint, et quia vivi noluerunt prodesse, morte certe eorum res publica utatur. Non est ergo natura hominis poenae adpetens; ideo ne ira quidem secundum naturam hominis, quia poenae adpetens est. Et Platonis argumentum adferam – quid enim nocet alienis uti ea parte qua nostra sunt? Vir bonus inquit non laedit. Poena laedit: bono ergo poena non convenit, ob hoc nec ira, quia poena irae convenit. Si vir bonus poena non gaudet, non gaudebit ne eo quidem affectu cui poena voluptati est: ergo non est naturalis ira. 7. «Numquid, quamvis non sit naturalis ira, adsumenda est, quia utilis saepe fuit? Extollit animos et incitat, nec quicquam sine illa magnificum in bello fortitudo gerit, nisi hinc flamma subdita est et hic stimulus peragitavit misitque in pericula audaces. Optimum itaque quidam putant temperare iram, non tollere, eoque detracto quod exundat ad salutarem modum cogere, id vero retinere sine quo languebit actio et vis ac vigor animi resolvetur». Primum facilius est excludere perniciosa quam regere et non admittere quam admissa moderari; nam cum se in possessione posuerunt, potentiora rectore sunt nec recidi se minuive patiuntur. Deinde ratio ipsa, cui freni traduntur, tam diu potens est quam diu diducta est ab affectibus; si miscuit se illis et inquinavit, non potest continere quos summovere potuisset. Commota enim semel et excussa mens ei servit quo impellitur. Quarundam rerum initia in nostra potestate sunt, ulteriora nos vi sua rapiunt
nec regressum relinquunt. Ut in praeceps datis corporibus nullum sui arbitrium est nec resistere morarive deiecta potuerunt, sed consilium omne et paenitentiam irrevocabilis praecipitatio abscidit et non licet eo non pervenire quo non ire licuisset, ita animus, si in iram amorem aliosque se proiecit affectus, non permittitur reprimere impetum; rapiat illum oportet et ad imum agat pondus suum et vitiorum natura proclivis. 8. Optimum est primum inritamentum irae protinus spernere ipsisque repugnare seminibus et dare operam ne incidamus in iram. Nam si coepit ferre transversos, difficilis ad salutem recursus est, quoniam nihil rationis est ubi semel affectus inductus est iusque illi aliquod voluntate nostra datum est: faciet de cetero quantum volet, non quantum permiseris. In primis, inquam, finibus hostis arcendus est; nam cum intravit et portis se intulit, modum a captivis non accipit. Neque enim sepositus est animus et extrinsecus speculatur affectus, ut illos non patiatur ultra quam oportet procedere, sed in affectum ipse mutatur ideoque non potest utilem illam vim et salutarem proditam iam infirmatamque revocare. Non enim, ut dixi, separatas ista sedes suas diductasque habent, sed affectus et ratio in melius peiusque mutatio animi est. Quomodo ergo ratio occupata et oppressa vitiis resurget, quae irae cessit? Aut quemadmodum ex confusione se liberabit in qua peiorum mixtura praevaluit? «Sed quidam» inquit «in ira se continent». Utrum ergo ita ut nihil faciant eorum quae ira dictat an ut aliquid? Si nihil faciunt, apparet non esse ad actiones rerum necessariam iram, quam vos, quasi fortius aliquid ratione haberet, advocabatis. Denique interrogo: valentior est quam ratio an infirmior? Si valentior, quomodo illi modum ratio poterit inponere, cum parere nisi inbecilliora non soleant? Si infirmior est, sine hac per se ad rerum effectus sufficit ratio nec desiderat inbecillioris auxilium. At irati quidam constant sibi et se continent. Quando? Cum iam ira evanescit et sua sponte decedit, non cum in ipso fervore est; tunc enim potentior est. «Quid ergo? Non aliquando in ira quoque et dimittunt incolumes intactosque quos oderunt et a nocendo abstinent?». Faciunt; Quando? Cum affectus repercussit affectum et aut metus aut cupiditas aliquid impetravit. Non rationis tunc beneficio quievit, sed affectuum infida et mala pace. 9. Deinde nihil habet in se utile nec acuit animum ad res bellicas. Numquam enim virtus vitio adiuvanda est se contenta. Quotiens impetu opus est, non irascitur sed exsurgit et in quantum putavit opus esse concitatur remittiturque, non aliter quam quae tormentis exprimuntur tela in potestate mittentis sunt in quantum torqueantur. «Ira» inquit Aristoteles «necessaria est, nec quicquam sine illa expugnari potest, nisi illa implet animum et spiritum accendit; utendum autem illa est non ut duce sed ut milite».
Quod est falsum; nam si exaudit rationem sequiturque qua ducitur, iam non est ira, cuius proprium est contumacia; si vero repugnat et non ubi iussa est quiescit sed libidine ferociaque provehitur, tam inutilis animi minister est quam miles qui signum receptui neglegit. Itaque si modum adhiberi sibi patitur, alio nomine appellanda est, desit ira esse, quam effrenatam indomitamque intellego; si non patitur, perniciosa est nec inter auxilia numeranda: ita aut ira non est aut inutilis est. Nam si quis poenam exigit non ipsius poenae avidus sed quia oportet, non est adnumerandus iratis. Hic erit utilis miles qui scit parere consilio; affectus quidem tam mali ministri quam duces sunt. 10. Ideo numquam adsumet ratio in adiutorium inprovidos et violentos impetus apud quos nihil ipsa auctoritatis habeat, quos numquam comprimere possit nisi pares illis similisque opposuerit, ut irae metum, inertiae iram, timori cupiditatem. Absit hoc a virtute malum, ut umquam ratio ad vitia confugiat! Non potest hic animus fidele otium capere, quatiatur necesse est fluctueturque, qui malis suis tutus est, qui fortis esse nisi irascitur non potest, industrius nisi cupit, quietus nisi timet: in tyrannide illi vivendum est in alicuius affectus venienti servitutem. Non pudet virtutes in clientelam vitiorum demittere? Deinde desinit quicquam posse ratio, si nihil potest sine affectu, et incipit par illi similisque esse. Quid enim interest, si aeque affectus inconsulta res est sine ratione quam ratio sine affectu inefficax? Par utrumque est, ubi esse alterum sine altero non potest. Quis autem sustineat affectum exaequare rationi? Ita inquit utilis affectus est, si modicus est. Immo si natura utilis est. Sed si inpatiens imperii rationisque est, hoc dumtaxat moderatione consequetur, ut quo minor fuerit minus noceat: ergo modicus affectus nihil aliud quam malum modicum est. 11. «Sed adversus hostes» inquit «necessaria est ira». Nusquam minus: ubi non effusos esse oportet impetus sed temperatos et oboedientes. Quid enim est aliud quod barbaros tanto robustiores corporibus, tanto patientiores laborum comminuat nisi ira infestissima sibi? Gladiatores quoque ars tuetur, ira denudat. Deinde quid opus est ira, cum idem proficiat ratio? An tu putas venatorem irasci feris? Atqui et venientis excipit et fugientis persequitur, et omnia illa sine ira facit ratio. Quid Cimbrorum Teutonorumque tot milia superfusa Alpibus ita sustulit ut tantae cladis notitiam ad suos non nuntius sed fama pertulerit, nisi quod erat illis ira pro virtute? Quae ut aliquando propulit stravitque obvia, ita saepius sibi exitio est. Germanis quid est animosius? Quid ad incursum acrius? Quid armorum cupidius, quibus innascuntur innutriunturque, quorum unica illis cura est in alia neglegentibus? Quid induratius ad omnem patientiam, ut quibus magna ex parte non tegimenta corporum provisa sint, non suffugia adversus perpetuum caeli rigorem? Hos tamen Hispani Gallique et Asiae Syriaeque molles bello viri, antequam legio visatur, caedunt ob nullam aliam rem opportunos quam
iracundiam. Agedum illis corporibus, illis animis delicias luxum opes ignorantibus da rationem, da disciplinam: ut nil amplius dicam, necesse erit certe nobis mores Romanos repetere. Quo alio Fabius affectas imperii vires recreavit quam quod cunctari et trahere et morari sciit, quae omnia irati nesciunt? Perierat imperium, quod tunc in extremo stabat, si Fabius tantum ausus esset quantum ira suadebat: habuit in consilio fortunam publicam et aestimatis viribus, ex quibus iam perire nihil sine universo poterat, dolorem ultionemque seposuit, in unam utilitatem et occasiones intentus; iram ante vicit quam Hannibalem. Quid Scipio? Non relicto Hannibale et Punico exercitu omnibusque quibus irascendum erat bellum in Africam transtulit, tam lentus ut opinionem luxuriae segnitiaeque malignis daret? Quid alter Scipio? Non circa Numantiam multum diuque sedit et hunc suum publicumque dolorem aequo animo tulit, diutius Numantiam quam Carthaginem vinci? Dum circumvallat et includit hostem, eo compulit ut ferro ipsi suo caderent. Non est itaque utilis ne in proeliis quidem aut bellis ira; in temeritatem enim prona est et pericula, dum inferre vult, non cavet. Illa certissima est virtus quae se diu multumque circumspexit et rexit et ex lento ac destinato provexit. 12. «Quid ergo?» inquit «Vir bonus non irascitur, si caedi patrem suum viderit, si rapi matrem?». Non irascetur, sed vindicabit, sed tuebitur. Quid autem times ne parum magnus illi stimulus etiam sine ira pietas sit? Aut dic eodem modo: «Quid ergo? Cum videat secari patrem suum filiumve, vir bonus non flebit nec linquetur animo?». Quae accidere feminis videmus, quotiens illas levis periculi suspicio perculit. Officia sua vir bonus exequetur inconfusus, intrepidus, et sic bono viro digna faciet ut nihil faciat viro indignum. Pater caedetur: defendam; caesus est: exequar, quia oportet, non quia dolet. Cum hoc dicis, Theophraste, quaeris invidiam praeceptis fortioribus et relicto iudice ad coronam venis: quia unusquisque in eiusmodi suorum casu irascitur, putas iudicaturos homines id fieri debere quod faciunt; fere enim iustum quisque affectum iudicat quem agnoscit. «Irascuntur boni viri pro suorum iniuriis». Sed idem faciunt, si calda non bene praebetur, si vitreum fractum est, si calceus luto sparsus est. Non pietas illam iram sed infirmitas movet, sicut pueris, qui tam parentibus amissis flebunt quam nucibus. Irasci pro suis non est pii animi sed infirmi: illud pulchrum dignumque, pro parentibus liberis amicis civibus prodire defensorem ipso officio ducente, volentem iudicantem providentem, non impulsum et rabidum. Nullus enim affectus vindicandi cupidior est quam ira, et ob id ipsum ad vindicandum inhabilis: praerapida et amens, ut omnis fere cupiditas, ipsa sibi in id in quod properat opponitur. Itaque nec in pace nec in bello umquam bono fuit; pacem enim similem belli efficit, in armis vero obliviscitur Martem esse communem
venitque in alienam potestatem dum in sua non est. Deinde non ideo vitia in usum recipienda sunt quia aliquando aliquid effecerunt; nam et febres quaedam genera valetudinis levant, nec ideo non ex toto illis caruisse melius est: abominandum remedi genus est sanitatem debere morbo. Simili modo ira, etiam si aliquando ut venenum et praecipitatio et naufragium ex inopinato profuit, non ideo salutaris iudicanda est: saepe enim saluti fuere pestifera. 13. Deinde quae habenda sunt, quo maiora eo meliora et optabiliora sunt. Si iustitia bonum est, nemo dicet meliorem futuram si quid detractum ex ea fuerit; si fortitudo bonum est, nemo illam desiderabit ex aliqua parte deminui. Ergo et ira quo maior hoc melior; quis enim ullius boni accessionem recusaverit? Atqui augeri illam inutile est; ergo et esse; non est bonum quod incremento malum fit. «Utilis» inquit «ira est, quia pugnaciores facit». Isto modo et ebrietas: facit enim protervos et audaces multique meliores ad ferrum fuere male sobrii; isto modo dic et phrenesin atque insaniam viribus necessariam, quia saepe validiores furor reddit. Quid? Non aliquotiens metus ex contrario fecit audacem, et mortis timor etiam inertissimos excitavit in proelium? Sed ira ebrietas metus aliaque eiusmodi foeda et caduca irritamenta sunt nec virtutem instruunt, quae nihil vitiis eget, sed segnem alioqui animum et ignavum paulum adlevant. Nemo irascendo fit fortior, nisi qui fortis sine ira non fuisset. Ita non in adiutorium virtutis venit, sed in vicem. Quid quod si bonum esset ira, perfectissimum quemque sequeretur? Atqui iracundissimi infantes senesque et aegri sunt, et invalidum omne natura querulum est. 14. «Non potest» inquit «fieri» Theophrastus «ut non vir bonus irascatur malis». Isto modo quo melior quisque, hoc iracundior erit: vide ne contra placidior solutusque affectibus et cui nemo odio sit. Peccantis vero quid habet cur oderit, cum error illos in eiusmodi delicta conpellat? Non est autem prudentis errantis odisse, alioqui ipse sibi odio erit. Cogitet quam multa contra bonum morem faciat, quam multa ex iis quae egit veniam desiderent: iam irascetur etiam sibi. Neque enim aequus iudex aliam de sua, aliam de aliena causa sententiam fert. Nemo, inquam, invenietur qui se possit absolvere, et innocentem quisque se dicit respiciens testem, non conscientiam. Quanto humanius mitem et patrium animum praestare peccantibus et illos non persequi sed revocare! Errantem per agros ignorantia viae melius est ad rectum iter admovere quam expellere. 15. Corrigendus est itaque qui peccat et admonitione et vi, et molliter et aspere, meliorque tam sibi quam aliis faciendus non sine castigatione, sed sine ira; quis enim cui medetur irascitur? «At corrigi nequeunt nihilque in illis lene aut spei bonae capax est». Tollantur e coetu mortalium facturi peiora quae contingunt, et quo uno modo
possunt desinant mali esse, sed hoc sine odio. Quid enim est cur oderim eum cui tum maxime prosum cum illum sibi eripio? Num quis membra sua tunc odit cum abscidit? Non est illa ira, sed misera curatio. Rabidos effligimus canes et trucem atque inmmansuetum bovem occidimus et morbidis pecoribus, ne gregem polluant, ferrum demittimus; portentosos fetus extinguimus, liberos quoque, si debiles monstrosique editi sunt, mergimus; nec ira sed ratio est a sanis inutilia secernere. Nil minus quam irasci punientem decet, cum eo magis ad emendationem poena proficiat, si iudicio lata est. Inde est quod Socrates servo ait: «Caederem te, nisi irascerer». Admonitionem servi in tempus sanius distulit, illo tempore se admonuit. Cuius erit temperatus affectus, cum Socrates non sit ausus se irae committere? 16. Ergo ad coercitionem errantium sceleratorumque irato castigatore non opus est; nam cum ira delictum animi sit, non oportet peccata corrigere peccantem. «Quid ergo? Non irascar latroni? Quid ergo? Non irascar venefico?». Non; neque enim mihi irascor, cum sanguinem mitto. Omne poenae genus remedi loco admoveo. «Tu adhuc in prima parte versaris errorum, nec graviter laberis sed frequenter: obiurgatio te primum secreta deinde publicata emendare temptabit; tu longius iam processisti quam ut possis verbis sanari: ignominia contineberis; tibi fortius aliquid et quod sentias inurendum est: in exilium et loca ignota mitteris; in te duriora remedia iam solida nequitia desiderat: et vincula publica et carcer adhibebitur; tibi insanabilis animus et sceleribus scelera contexens, et iam non causis, quae numquam malo defuturae sunt, impelleris, sed satis tibi est magna ad peccandum causa peccare, perbibisti nequitiam et ita visceribus immiscuisti ut nisi cum ipsis exire non possit, olim miser mori quaeris: bene de te merebimur, auferemus tibi istam qua vexas vexaris insaniam et per tua alienaque volutato supplicia id quod unum tibi bonum superest repraesentabimus, mortem». Quare irascar cui cum maxime prosum? Interim optimum misericordiae genus est occidere. Si intrassem valetudinarium exercitatus et sciens aut domus divitis, non idem imperassem omnibus per diversa aegrotantibus; varia in tot animis vitia video et civitati curandae adhibitus sum, pro cuiusque morbo medicina quaeratur: hunc sanet verecundia, hunc peregrinatio, hunc dolor, hunc egestas, hunc ferrum. Itaque et, si perversa induenda magistratui vestis et convocanda classico contio est, procedam in tribunal non furens nec infestus sed vultu legis et illa sollemnia verba leni magis gravique quam rabida voce concipiam et agi iubebo non iratus sed severus; et cum cervicem noxio imperabo praecidi et cum parricidas insuam culleo et cum mittam in supplicium militare et cum Tarpeio proditorem hostemve publicum imponam, sine ira eo vultu animoque ero quo serpentes et animalia venenata percutio. «Iracundia opus est ad puniendum».
Quid? Tibi lex videtur irasci iis quos non novit, quos non vidit, quos non futuros sperat? Illius itaque sumendus est animus, quae non irascitur sed constituit. Nam si bono viro ob mala facinora irasci convenit, et ob secundas res malorum hominum invidere conveniet. Quid enim est indignius quam florere quosdam et eos indulgentia fortunae abuti quibus nulla potest satis mala inveniri fortuna? Sed tam commoda illorum sine invidia videbit quam scelera sine ira; bonus iudex damnat improbanda, non odit. «Quid ergo? Non, cum eiusmodi aliquid sapiens habebit in manibus, tangetur animus eius eritque solito commotior?» Fateor: sentiet levem quendam tenuemque motum; nam, ut dicit Zenon, in sapientis quoque animo, etiam cum vulnus sanatum est, cicatrix manet. Sentiet itaque suspiciones quasdam et umbras affectuum, ipsis quidem carebit. 17. Aristoteles ait affectus quosdam, si quis illis bene utatur, pro armis esse. Quod verum foret, si velut bellica instrumenta sumi deponique possent induentis arbitrio: haec arma quae Aristoteles virtuti dat ipsa per se pugnant, non expectant manum, et habent, non habentur. Nihil aliis instrumentis opus est, satis nos instruxit ratione natura. Hoc dedit telum, firmum perpetuum obsequens, nec anceps nec quod in dominum remitti posset. Non ad providendum tantum, sed ad res gerendas satis est per se ipsa ratio; etenim quid est stultius quam hanc ab iracundia petere praesidium, rem stabilem ab incerta, fidelem ab infida, sanam ab aegra? Quid quod ad actiones quoque, in quibus solis opera iracundiae videtur necessaria, multo per se ratio fortior est? Nam cum iudicavit aliquid faciendum, in eo perseverat; nihil enim melius inventura est se ipsa quo mutetur: ideo stat semel constitutis. Iram saepe misericordia retro egit; habet enim non solidum robur sed vanum tumorem violentisque principiis utitur, non aliter quam qui a terra venti surgunt et fluminibus paludibusque concepti sine pertinacia vehementes sunt: incipit magno impetu, deinde deficit ante tempus fatigata, et, quae nihil aliud quam crudelitatem ac nova genera poenarum versaverat, cum animadvertendum est, iam fracta lenisque est. Affectus cito cadit, aequalis est ratio. Ceterum etiam ubi perseveravit ira, nonnumquam, si plures sunt qui perire meruerunt, post duorum triumve sanguinem occidere desinit. Primi eius ictus acres sunt: sic serpentium venena a cubili erepentium nocent, innoxii dentes sunt cum illos frequens morsus exhausit. Ergo non paria patiuntur qui paria commiserant, et saepe qui minus commisit plus patitur, quia recentiori obiectus est. Et in totum inaequalis est: modo ultra quam oportet excurrit, modo citerius debito resistit; sibi enim indulget et ex libidine iudicat et audire non vult et patrocinio non relinquit locum et ea tenet quae invasit et eripi sibi iudicium suum, etiam si pravum est, non sinit. 18. Ratio utrique parti tempus dat, deinde advocationem et sibi petit, ut excutiendae veritati spatium habeat: ira festinat. Ratio id iudicare vult quod
aequum est: ira id aequum videri vult quod iudicavit. Ratio nil praeter ipsum de quo agitur spectat: ira vanis et extra causam obversantibus commovetur. Vultus illam securior, vox clarior, sermo liberior, cultus delicatior, advocatio ambitiosior, favor popularis exasperant; saepe infesta patrono reum damnat; etiam si ingeritur oculis veritas, amat et tuetur errorem; coargui non vult, et in male coeptis honestior illi pertinacia videtur quam paenitentia. Cn. Piso fuit memoria nostra vir a multis vitiis integer, sed pravus et cui placebat pro constantia rigor. Is cum iratus duci iussisset eum qui ex commeatu sine commilitone redierat, quasi interfecisset quem non exhibebat, roganti tempus aliquid ad conquirendum non dedit. Damnatus extra vallum productus est et iam cervicem porrigebat, cum subito apparuit ille commilito qui occisus videbatur. Tunc centurio supplicio praepositus condere gladium speculatorem iubet, damnatum ad Pisonem reducit redditurus Pisoni innocentiam: nam militi fortuna reddiderat. Ingenti concursu deducuntur complexi alter alterum cum magno gaudio castrorum commilitones. Conscendit tribunal furens Piso ac iubet duci utrumque, et eum militem qui non occiderat et eum qui non perierat. Quid hoc indignius? Quia unus innocens apparuerat, duo peribant. Piso adiecit et tertium. Nam ipsum centurionem qui damnatum reduxerat duci iussit. Constituti sunt in eodem illo loco perituri tres ob unius innocentiam. O quam sollers est iracundia ad fingendas causas furoris! «Te» inquit «duci iubeo, quia damnatus es; te, quia causa damnationis commilitoni fuisti: te, quia iussus occidere imperatori non paruisti». Excogitavit quemadmodum tria crimina faceret, quia nullum invenerat. 19. Habet, inquam, iracundia hoc mali: non vult regi. Irascitur veritati ipsi, si contra voluntatem suam apparuit; cum clamore et tumultu et totius corporis iactatione quos destinavit insequitur adiectis conviciis maledictisque. Hoc non facit ratio, sed si ita opus est, silens quietaque totas domus funditus tollit et familias rei publicae pestilentes cum coniugibus ac liberis perdit, tecta ipsa diruit et solo exaequat et inimica libertati nomina exstirpat: hoc non frendens nec caput quassans nec quicquam indecorum iudici faciens, cuius tum maxime placidus esse debet et in statu vultus cum magna pronuntiat. «Quid opus est» inquit Hieronymus «cum velis caedere aliquem, tua prius labra mordere?». Quid si ille vidisset desilientem de tribunali proconsulem et fasces lictori auferentem et suamet vestimenta scindentem, quia tardius scindebantur aliena? Quid opus est mensam evertere? Quid pocula affligere? Quid se in columnas impingere? Quid capillos avellere, femur pectusque percutere? Quantam iram putas, quae, quia in alium non tam cito quam vult erumpit, in se revertitur? Tenentur itaque a proximis et rogantur ut sibi ipsi placentur. Quorum nil facit quisquis vacuus ira meritam cuique poenam iniungit. Dimittit saepe eum cuius peccatum deprendit: si paenitentia facti spem bonam pollicetur, si intellegit non ex alto venire nequitiam sed summo, quod aiunt, animo inhaerere, dabit impunitatem nec accipientibus nocituram nec dantibus; nonnumquam magna scelera levius quam minora compescet, si illa lapsu, non
crudelitate commissa sunt, his inest latens et operta et inveterata calliditas; idem delictum in duobus non eodem malo adficiet, si alter per neglegentiam admisit, alter curavit ut nocens esset. Hoc semper in omni animadversione servabit, ut sciat alteram adhiberi ut emendet malos, alteram ut tollat; in utroque non praeterita sed futura intuebitur (nam, ut Plato ait, «nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur; revocari enim praeterita non possunt, futura prohibentur») et quos volet nequitiae male cedentis exempla fieri palam occidet, non tantum ut pereant ipsi, sed ut alios pereundo deterreant. Haec cui expendenda aestimandaque sunt, vides quam debeat omni perturbatione liber accedere ad rem summa diligentia tractandam, potestatem vitae necisque: male irato ferrum committitur. 20. Ne illud quidem iudicandum est, aliquid iram ad magnitudinem animi conferre. Non est enim illa magnitudo: tumor est; nec corporibus copia vitiosi umoris intentis morbus incrementum est sed pestilens abundantia. Omnes quos vecors animus supra cogitationes extollit humanas altum quiddam et sublime spirare se credunt: ceterum nihil solidi subest, sed in ruinam prona sunt quae sine fundamentis crevere. Non habet ira cui insistat. Non ex firmo mansuroque oritur, sed ventosa et inanis est, tantumque abest a magnitudine animi quantum a fortitudine audacia, a fiducia insolentia, ab austeritate tristitia, a severitate crudelitas. Multum, inquam, interest inter sublimem animum et superbum. Iracundia nihil amplum decorumque molitur, contra mihi videtur veternosi et infelicis animi, imbecillitatis sibi conscii, saepe indolescere, ut exulcerata et aegra corpora quae ad tactus levissimos gemunt. Ita ira muliebre maxime ac puerile vitium est. «At incidit et in viros». Nam viris quoque puerilia ac muliebria ingenia sunt. Quid ergo? Non aliquae voces ab iratis emittuntur quae magno emissae videantur animo veram ignorantibus magnitudinem? Qualis illa dira et abominanda: «Oderint, dum metuant». Sullano scias saeculo scriptam. Nescio utrum sibi peius optaverit ut odio esset an ut timori. «Oderint». Occurrit illi futurum ut execrentur insidientur opprimant. Quid adiecit? Di illi male faciant, adeo repperit dignum odio remedium. «Oderint…» Quid? Dum pareant? Non. Dum probent? Non. Quid ergo? «Dum timeant». Sic ne amari quidem vellem. Magno hoc dictum spiritu putas? Falleris; nec enim magnitudo ista est sed immanitas. Non est quod credas irascentium verbis, quorum strepitus magni, minaces sunt, intra mens pavidissima. Nec est quod existimes verum esse quod apud disertissimum virum T. Livium dicitur: «Vir ingenii magni magis quam boni». Non potest istud separari: aut et bonum erit aut nec magnum, quia magnitudinem animi inconcussam intellego et introrsus solidam et ab imo parem firmamque, qualis inesse malis ingeniis non potest. Terribilia enim esse et tumultuosa et exitiosa possunt: magnitudinem quidem, cuius firmamentum roburque bonitas est, non habebunt. Ceterum sermone, conatu et omni extra paratu facient magnitudinis
fidem; eloquentur aliquid quod tu magni putes, sicut C. Caesar, qui iratus caelo quod obstreperetur pantomimis, quos imitabatur studiosius quam spectabat, quodque comessatio sua fulminibus terreretur (prorsus parum certis), ad pugnam vocavit Iovem et quidem sine missione, Homericum illum exclamans versum: h[ m∆ ajnaveir∆ h] ejgw; sev. Quanta dementia fuit! Putavit aut sibi noceri ne ab Iove quidem posse aut se nocere etiam Iovi posse. Non puto parum momenti hanc eius vocem ad incitandas coniuratorum mentes addidisse: ultimae enim patientiae visum est eum ferre qui Iovem non ferret. 21. Nihil ergo in ira, ne cum videtur quidem vehemens et deos hominesque despiciens, magnum, nihil nobile est. Aut si videtur alicui magnum animum ira producere, videatur et luxuria: ebore sustineri vult, purpura vestiri, auro tegi, terras transferre, maria concludere, flumina praecipitare, nemora suspendere; videatur et avaritia magni animi: acervis auri argentique incubat et provinciarum nominibus agros colit et sub singulis vilicis latiores habet fines quam quos consules sortiebantur; videatur et libido magni animi: transnat freta, puerorum greges castrat, sub gladium mariti venit morte contempta; videatur et ambitio magni animi: non est contenta honoribus annuis; si fieri potest, uno nomine occupare fastus vult, per omnem orbem titulos disponere. Omnia ista, non refert in quantum procedant extendantque se, angusta sunt, misera depressa; sola sublimis et excelsa virtus est, nec quicquam magnum est nisi quod simul placidum.
Liber secundus Primus liber, Novate, benigniorem habuit materiam; facilis enim in proclivi vitiorum decursus est. Nunc ad exiliora veniendum est; quaerimus enim ira utrum iudicio an impetu incipiat, id est utrum sua sponte moveatur an quemadmodum pleraque quae intra nos insciis nobis oriuntur. Debet autem in haec se demittere disputatio ut ad illa quoque altiora possit exsurgere: nam et in corpore nostro ossa nervique et articuli, firmamenta totius et vitalia, minime speciosa visu, prius ordinantur, deinde haec ex quibus omnis in faciem aspectumque decor est; post haec omnia, qui maxime oculos rapit, color ultimus perfecto iam corpore adfunditur. Iram quin species oblata iniuriae moveat non est dubium; sed utrum speciem ipsam statim sequatur et non accedente animo excurrat, an illo adsentiente moveatur quaerimus. Nobis placet nihil illam per se audere sed animo approbante; nam speciem capere acceptae iniuriae et ultionem eius concupiscere et utrumque coniungere, nec laedi se debuisse et vindicari debere, non est eius
impetus qui sine voluntate nostra concitatur. Ille simplex est, hic compositus et plura continens: intellexit aliquid, indignatus est, damnavit, ulciscitur: haec non possunt fieri, nisi animus eis quibus tangebatur adsensus est. 2. «Quorsus» inquis «haec quaestio pertinet?». Ut sciamus quid sit ira. Nam si invitis nobis nascitur, numquam rationi succumbet. Omnes enim motus qui non voluntate nostra fiunt invicti et inevitabiles sunt, ut horror frigida adspersis, ad quosdam tactus aspernatio; ad peiores nuntios surriguntur pili et rubor ad improba verba suffunditur sequiturque vertigo praerupta cernentis: quorum quia nihil in nostra potestate est, nulla quominus fiant ratio persuadet. Ira praeceptis fugatur; est enim voluntarium animi vitium, non ex his quae condicione quadam humanae sortis eveniunt ideoque etiam sapientissimis accidunt, inter quae et primus ille ictus animi ponendus est qui nos post opinionem iniuriae movet. Hic subit etiam inter ludicra scaenae spectacula et lectiones rerum vetustarum. Saepe Clodio Ciceronem expellenti et Antonio occidenti videmur irasci. Quis non contra Mari arma, contra Sullae proscriptionem concitatur? Quis non Theodoto et Achillae et ipsi puero non puerile auso facinus infestus est? Cantus nos nonnumquam et citata modulatio instigat Martiusque ille tubarum sonus; movet mentes et atrox pictura et iustissimorum suppliciorum tristis aspectus; inde est quod arridemus ridentibus et contristat nos turba maerentium et effervescimus ad aliena certamina. Quae non sunt irae, non magis quam tristitia est quae ad conspectum mimici naufragii contrahit frontem, non magis quam timor qui Hannibale post Cannas moenia circumsidente lectorum percurrit animos, sed omnia ista motus sunt animorum moveri nolentium, nec affectus sed principia proludentia affectibus. Sic enim militaris viri in media pace iam togati aures tuba suscitat equosque castrenses erigit crepitus armorum. Alexandrum aiunt Xenophanto canente manum ad arma misisse. 3. Nihil ex his quae animum fortuito impellunt affectus vocari debet: ista, ut ita dicam, patitur magis animus quam facit. Ergo affectus est non ad oblatas rerum species moveri, sed permittere se illis et hunc fortuitum motum prosequi. Nam si quis pallorem et lacrimas procidentis et irritationem umoris obsceni altumve suspirium et oculos subito acriores aut quid his simile indicium affectus animique signum putat, fallitur nec intellegit corporis hos esse pulsus. Itaque et fortissimus plerumque vir dum armatur expalluit et signo pugnae dato ferocissimo militi paulum genua tremuerunt et magno imperatori antequam inter se acies arietarent cor exiluit et oratori eloquentissimo dum ad dicendum componitur summa riguerunt. Ira non moveri tantum debet sed excurrere; est enim impetus; numquam autem impetus sine adsensu mentis est, neque enim fieri potest ut de ultione et poena agatur animo nesciente. Putavit se aliquis laesum, voluit ulcisci, dissuadente aliqua causa statim resedit: hanc iram non voco, motum animi rationi parentem:
illa est ira quae rationem transsilit, quae secum rapit. Ergo prima illa agitatio animi quam species iniuriae incussit non magis ira est quam ipsa iniuriae species; ille sequens impetus, qui speciem iniuriae non tantum accepit sed approbavit, ira est, concitatio animi ad ultionem voluntate et iudicio pergentis. Numquam dubium est quin timor fugam habeat, ira impetum: vide ergo an putes aliquid sine adsensu mentis aut peti posse aut caveri. 4. Et ut scias quemadmodum incipiant affectus aut crescant aut efferantur, est primus motus non voluntarius, quasi praeparatio affectus et quaedam comminatio; alter cum voluntate non contumaci, tamquam oporteat me vindicari cum laesus sim, aut oporteat hunc poenas dare cum scelus fecerit; tertius motus est iam impotens, qui non si oportet ulcisci vult sed utique, qui rationem evicit. Primum illum animi ictum effugere ratione non possumus, sicut ne illa quidem quae diximus accidere corporibus, ne nos oscitatio aliena sollicitet, ne oculi ad intentationem subitam digitorum comprimantur: ista non potest ratio vincere, consuetudo fortasse et adsidua observatio extenuat. Alter ille motus, qui iudicio nascitur, iudicio tollitur. 5. Illud etiamnunc quaerendum est, ii qui vulgo saeviunt et sanguine humano gaudent, an irascantur cum eos occidunt a quibus nec acceperunt iniuriam nec accepisse ipsos existimant: qualis fuit Apollodorus aut Phalaris. Haec non est ira, feritas est; non enim quia accepit iniuriam nocet, sed parata est dum noceat vel accipere, nec illi verbera lacerationesque in ultionem petuntur sed in voluptatem. «Quid ergo?». Origo huius mali ab ira est, quae ubi frequenti exercitatione et satietate in oblivionem clementiae venit et omne foedus humanum eiecit animo, novissime in crudelitatem transit: rident itaque gaudentque et voluptate multa perfruuntur plurimumque ab iratorum vultu absunt, per otium saevi. Hannibalem aiunt dixisse, cum fossam sanguine humano plenam vidisset: «O formosum spectaculum!». Quanto pulchrius illi visum esset, si flumen aliquod lacumque complesset! Quid mirum si hoc maxime spectaculo caperis, innatus sanguini et ab infante caedibus admotus? Sequetur te fortuna crudelitati tuae per viginti annos secunda dabitque oculis tuis gratum ubique spectaculum; videbis istud et circa Trasumennum et circa Cannas et novissime circa Carthaginem tuam. Volesus nuper, sub divo Augusto proconsul Asiae, cum trecentos uno die securi percussisset, incedens inter cadavera vultu superbo, quasi magnificum quiddam conspiciendumque fecisset, graece proclamavit: «O rem regiam!». Quid hic rex fecisset? Non fuit haec ira sed maius malum et insanabile. 6. «Virtus» inquit «ut honestis rebus propitia est, ita turpibus irata esse debet». Quid si dicat virtutem et humilem et magnam esse debere? Atqui hoc dicit qui
illam extolli vult et deprimi, quoniam laetitia ob recte factum clara magnificaque est, ira ob alienum peccatum sordida et angusti pectoris est. Nec umquam committet virtus ut vitia dum compescit imitetur; iram ipsam castigandam habet, quae nihilo melior est, saepe etiam peior iis delictis quibus irascitur. Gaudere laetarique proprium et naturale virtutis est: irasci non est ex dignitate eius, non magis quam maerere: atqui iracundiae tristitia comes est et in hanc omnis ira vel post paenitentiam vel post repulsam revolvitur. Et si sapientis est peccatis irasci, magis irascetur maioribus et saepe irascetur: sequitur ut non tantum iratus sit sapiens sed iracundus. Atqui si nec magnam iram nec frequentem in animo sapientis locum habere credimus, quid est quare non ex toto illum hoc affectu liberemus? Modus enim esse non potest, si pro facto cuiusque irascendum est; nam aut iniquus erit, si aequaliter irascetur delictis inaequalibus, aut iracundissimus, si totiens excanduerit quotiens iram scelera meruerint. 7. Et quid indignius quam sapientis affectum ex aliena pendere nequitia? Desinet ille Socrates posse eundem vultum domum referre quem domo extulerat? Atqui si irasci sapiens turpiter factis debet et concitari contristarique ob scelera, nihil est aerumnosius sapiente: omnis illi per iracundiam maeroremque vita transibit. Quod enim momentum erit quo non improbanda videat? Quotiens processerit domo, per sceleratos illi avarosque et prodigos et inpudentis et ob ista felices incedendum erit; nusquam oculi eius flectentur ut non quod indignentur inveniant: deficiet si totiens a se iram quotiens causa poscet exegerit. Haec tot milia ad forum prima luce properantia, quam turpes lites, quanto turpiores advocatos habent! Alius iudicia patris accusat quae mereri satius fuit, alius cum matre consistit, alius delator venit eius criminis cuius manifestior reus est, et iudex damnaturus quae fecit eligitur et corona proclamat pro mala causa, bona patroni voce corrupta. 8. Quid singula persequor? Cum videris forum multitudine refertum et saepta concursu omnis frequentiae plena et illum circum in quo maximam sui partem populus ostendit, hoc scito, istic tantundem esse vitiorum quantum hominum. Inter istos quos togatos vides nulla pax est: alter in alterius exitium levi compendio ducitur; nulli nisi ex alterius iniuria quaestus est; felicem oderunt, infelicem contemnunt; maiorem gravantur, minori graves sunt; diversis stimulantur cupiditatibus; omnia perdita ob levem voluptatem praedamque cupiunt. Non alia quam in ludo gladiatorio vita est cum isdem viventium pugnantiumque. Ferarum iste conventus est, nisi quod illae inter se placidae sunt morsuque similium abstinent, hi mutua laceratione satiantur. Hoc uno ab animalibus mutis differunt, quod illa mansuescunt alentibus, horum rabies ipsos a quibus est nutrita depascitur. 9. Numquam irasci desinet sapiens, si semel coeperit: omnia sceleribus ac vitiis plena sunt; plus committitur quam quod possit coercitione sanari; certatur
ingenti quidem nequitiae certamine. Maior cotidie peccandi cupiditas, minor verecundia est; expulso melioris aequiorisque respectu quocumque visum est libido se impingit, nec furtiva iam scelera sunt: praeter oculos eunt, adeoque in publicum missa nequitia est et in omnium pectoribus evaluit ut innocentia non rara sed nulla sit. Numquid enim singuli aut pauci rupere legem? Undique velut signo dato ad fas nefasque miscendum coorti sunt: non hospes ab hospite tutus, non socer a genero; fratrum quoque gratia rara est. Imminet exitio vir coniugis, illa mariti; lurida terribiles miscent aconita novercae, filius ante diem patrios inquirit in annos. Et quota ista pars scelerum est? Non descripsit castra ex una parte contraria et parentium liberorumque sacramenta diversa, subiectam patriae civis manu flammam et agmina infestorum equitum ad conquirendas proscriptorum latebras circumvolitantia et violatos fontes venenis et pestilentiam manu factam et praeductam obsessis parentibus fossam, plenos carceres et incendia totas urbes concremantia dominationesque funestas et regnorum publicorumque exitiorum clandestina consilia, et pro gloria habita quae, quam diu opprimi possunt, scelera sunt, raptus ac stupra et ne os quidem libidini exceptum. Adde nunc publica periuria gentium et rupta foedera et in praedam validioris quicquid non resistebat abductum, circumscriptiones furta fraudes infitiationes quibus trina non sufficiunt fora. Si tantum irasci vis sapientem quantum scelerum indignitas exigit, non irascendum illi sed insaniendum est. 10. Illud potius cogitabis, non esse irascendum erroribus. Quid enim si quis irascatur in tenebris parum vestigia certa ponentibus? Quid si quis surdis imperia non exaudientibus? Quid si pueris, quod neglecto dispectu officiorum ad lusus et ineptos aequalium iocos spectent? Quid si illis irasci velis qui aegrotant senescunt fatigantur? Inter cetera mortalitatis incommoda et hoc est, caligo mentium nec tantum necessitas errandi sed errorum amor. Ne singulis irascaris, universis ignoscendum est, generi humano venia tribuenda est. Si irasceris iuvenibus senibusque quod peccant, irascere infantibus: peccaturi sunt. Numquis irascitur pueris, quorum aetas nondum novit rerum discrimina? Maior est excusatio et iustior hominem esse quam puerum. Hac condicione nati sumus, animalia obnoxia non paucioribus animi quam corporis morbis, non quidem obtusa nec tarda, sed acumine nostro male utentia, alter alteri vitiorum exempla: quisquis sequitur priores male iter ingressos, quidni habeat excusationem, cum publica via erraverit? In singulos severitas imperatoris destringitur, at necessaria venia est ubi totus deseruit exercitus. Quid tollit iram sapientis? Turba peccantium. Intellegit quam et iniquum sit et periculosum irasci publico vitio.
Heraclitus quotiens prodierat et tantum circa se male viventium, immo male pereuntium viderat, flebat, miserebatur omnium qui sibi laeti felicesque occurrebant, miti animo, sed nimis inbecillo: et ipse inter deplorandos erat. Democritum contra aiunt numquam sine risu in publico fuisse; adeo nihil illi videbatur serium eorum quae serio gerebantur. Isticcine irae locus est ubi aut ridenda omnia aut flenda sunt? Non irascetur sapiens peccantibus: quare? Quia scit neminem nasci sapientem sed fieri, scit paucissimos omni aevo sapientis evadere, quia condicionem humanae vitae perspectam habet; nemo autem naturae sanus irascitur. Quid enim si mirari velit non in silvestribus dumis poma pendere? Quid si miretur spineta sentesque non utili aliqua fruge conpleri? Nemo irascitur ubi vitium natura defendit. Placidus itaque sapiens et aequus erroribus, non hostis sed corrector peccantium, hoc cotidie procedit animo: «Multi mihi occurrent vino dediti, multi libidinosi, multi ingrati, multi avari, multi furiis ambitionis agitati». Omnia ista tam propitius aspiciet quam aegros suos medicus. Numquid ille cuius navigium multam undique laxatis conpagibus aquam trahit nautis ipsique navigio irascitur? Occurrit potius et aliam excludit undam, aliam egerit, manifesta foramina praecludit, latentibus et ex occulto sentinam ducentibus labore continuo resistit, nec ideo intermittit quia quantum exhaustum est subnascitur. Lento adiutorio opus est contra mala continua et fecunda, non ut desinant, sed ne vincant. 11. «Utilis est» inquit «ira, quia contemptum effugit, quia malos terret». Primum ira, si quantum minatur valet, ob hoc ipsum quod terribilis est et invisa est; periculosius est autem timeri quam despici. Si vero sine viribus est, magis exposita contemptui est et derisum non effugit; quid enim est iracundia in supervacuum tumultuante frigidius? Deinde non ideo quaedam, quia sunt terribiliora, potiora sunt, nec hoc sapienti dici velim: «Quod ferae, sapientis quoque telum est, timeri». Quid? Non timetur febris, podagra, ulcus malum? Numquid ideo quicquam in istis boni est? At contra omnia despecta foedaque et turpia, ipsoque eo timentur. Sic ira per se deformis est et minime metuenda, at timetur a pluribus sicut deformis persona ab infantibus. Quid quod semper in auctores redundat timor nec quisquam metuitur ipse securus? Occurrat hoc loco tibi Laberianus ille versus qui medio civili bello in theatro dictus totum in se populum non aliter convertit quam si missa esset vox publici affectus: necesse est multos timeat quem multi timent. Ita natura constituit ut quicquid alieno metu magnum est a suo non vacet. Leonum quam pavida sunt ad levissimos sonos pectora! acerrimas feras umbra et vox et odor insolitus exagitat: quicquid terret et trepidat. Non est ergo quare concupiscat quisquam sapiens timeri, nec ideo iram magnum quiddam putet quia
formidini est, quoniam quidem etiam contemptissima timentur, ut venena et ossa pestifera et morsus. Nec mirum est, cum maximos ferarum greges linea pinnis distincta contineat et in insidias agat, ab ipso affectu dicta formido: vanis enim vana terrori sunt. Curriculi motus rotarumque versata facies leones redegit in caveam, elephantos porcina vox terret. Sic itaque ira metuitur quomodo umbra ab infantibus, a feris rubens pinna. Non ipsa in se quicquam habet firmum aut forte, sed leves animos movet. 12. «Nequitia» inquit «de rerum natura tollenda est, si velis iram tollere; neutrum autem potest fieri». Primum potest aliquis non algere, quamvis ex rerum natura hiems sit, et non aestuare, quamvis menses aestivi sint: aut loci beneficio adversus intemperiem anni tutus est aut patientia corporis sensum utriusque pervicit. Deinde verte istud: necesse est prius virtutem ex animo tollas quam iracundiam recipias, quoniam cum virtutibus vitia non coeunt, nec magis quisquam eodem tempore et iratus potest esse et vir bonus quam aeger et sanus. «Non potest» inquit «omnis ex animo ira tolli, nec hoc hominis natura patitur». Atqui nihil est tam difficile et arduum quod non humana mens vincat et in familiaritatem perducat adsidua meditatio, nullique sunt tam feri et sui iuris affectus ut non disciplina perdomentur. Quodcumque sibi imperavit animus optinuit: quidam ne umquam riderent consecuti sunt; vino quidam, alii venere, quidam omni umore interdixere corporibus; alius contentus brevi somno vigiliam indefatigabilem extendit; didicerunt tenuissimis et adversis funibus currere et ingentia vixque humanis toleranda viribus onera portare et in immensam altitudinem mergi ac sine ulla respirandi vice perpeti maria: mille sunt alia in quibus pertinacia impedimentum omne transcendit ostenditque nihil esse difficile cuius sibi ipsa mens patientiam indiceret. Istis quos paulo ante rettuli aut nulla tam pertinacis studii aut non digna merces fuit (quid enim magnificum consequitur ille qui meditatus est per intentos funes ire, qui sarcinae ingenti cervices supponere, qui somno non summittere oculos, qui penetrare in imum mare?) et tamen ad finem operis non magno auctoramento labor pervenit; nos non advocabimus patientiam, quos tantum praemium expectat, felicis animi immota tranquillitas? Quantum est effugere maximum malum, iram, et cum illa rabiem saevitiam crudelitatem furorem, alios comites eius affectus! 13. Non est quod patrocinium nobis quaeramus et excusatam licentiam, dicentes aut utile id esse aut inevitabile; cui enim tandem vitio advocatus defuit? Non est quod dicas excidi non posse: sanabilibus aegrotamus malis ipsaque nos in rectum genitos natura, si emendari velimus, iuvat. Nec, ut quibusdam visum est, arduum in virtutes et asperum iter est: plano adeuntur. Non vanae vobis auctor rei venio. Facilis est ad beatam vitam via: inite modo bonis auspiciis ipsisque dis bene iuvantibus. Multo difficilius est facere ista quae facitis. Quid
est animi quiete otiosius, quid ira laboriosius? Quid clementia remissius, quid crudelitate negotiosius? Vacat pudicitia, libido occupatissima est. Omnium denique virtutum tutela facilis est, vitia magno coluntur. Debet ira removeri (hoc ex parte fatentur etiam qui dicunt esse minuendam): tota dimittatur, nihil profutura est. Sine illa facilius rectiusque scelera tollentur, mali punientur et transducentur in melius. Omnia quae debet sapiens sine ullius malae rei ministerio efficiet nihilque admiscebit cuius modum sollicitius observet. 14. Numquam itaque iracundia admittenda est, aliquando simulanda, si segnes audientium animi concitandi sunt, sicut tarde consurgentis ad cursum equos stimulis facibusque subditis excitamus. Aliquando incutiendus est iis metus apud quos ratio non proficit: irasci quidem non magis utile est quam maerere, quam metuere. «Quid ergo? Non incidunt causae quae iram lacessant?» Sed tunc maxime illi opponendae manus sunt. Nec est difficile vincere animum, cum athletae quoque, in vilissima sui parte occupati, tamen ictus doloresque patiantur ut vires caedentis exhauriant, nec cum ira suadet feriunt, sed cum occasio. Pyrrhum, maximum praeceptorem certaminis gymnici, solitum aiunt iis quos exercebat praecipere ne irascerentur; ira enim perturbat artem et qua noceat tantum aspicit. Saepe itaque ratio patientiam suadet, ira vindictam, et qui primis defungi malis potuimus in maiora devolvimur. Quosdam unius verbi contumelia non aequo animo lata in exilium proiecit, et qui levem iniuriam silentio ferre noluerant gravissimis malis obruti sunt, indignatique aliquid ex plenissima libertate deminui servile in sese adtraxerunt iugum. 15. «Ut scias» inquit «iram habere in se generosi aliquid, liberas videbis gentes quae iracundissimae sunt, ut Germanos et Scythas». Quod evenit quia fortia solidaque natura ingenia, antequam disciplina molliantur, prona in iram sunt. Quaedam enim non nisi melioribus innascuntur ingeniis, sicut valida arbusta et laeta quamvis neglecta tellus creat et alta fecundi soli silva est: itaque et ingenia natura fortia iracundiam ferunt nihilque tenue et exile capiunt ignea et fervida, sed imperfectus illis vigor est ut omnibus quae sine arte ipsius tantum naturae bono exsurgunt, sed nisi cito domita sunt, quae fortitudini apta erant audaciae temeritatique consuescunt. Quid? Non mitioribus animis vitia leniora coniuncta sunt, ut misericordia et amor et verecundia? Itaque saepe tibi bonam indolem malis quoque suis ostendam; sed non ideo vitia non sunt si naturae melioris indicia sunt. Deinde omnes istae feritate liberae gentes leonum luporumque ritu ut servire non possunt, ita nec imperare; non enim humani vim ingenii, sed feri et intractabilis habent; nemo autem regere potest nisi qui et regi. Fere itaque imperia penes eos fuere populos qui mitiore caelo utuntur: in frigora septemtrionemque vergentibus immansueta ingenia sunt, ut ait poeta,
suoque simillima caelo. 16. «Animalia» inquit «generosissima habentur quibus multum inest irae». Errat qui ea in exemplum hominis adducit quibus pro ratione est impetus: homini pro impetu ratio est. Sed ne illis quidem omnibus idem prodest: iracundia leones adiuvat, pavor cervos, accipitrem impetus, columbam fuga. Quid quod ne illud quidem verum est, optima animalia esse iracundissima? Feras putem, quibus ex raptu alimenta sunt, meliores quo iratiores: patientiam laudaverim boum et equorum frenos sequentium. Quid est autem cur hominem ad tam infelicia exempla revoces, cum habeas mundum deumque, quem ex omnibus animalibus, ut solus imitetur, solus intellegit? «Simplicissimi» inquit «omnium habentur iracundi». Fraudulentis enim et versutis comparantur et simplices videntur quia expositi sunt. Quos quidem non simplices dixerim sed incautos: stultis luxuriosis nepotibusque hoc nomen inponimus et omnibus vitiis parum callidis. 17. «Orator» inquit «iratus aliquando melior est». Immo imitatus iratum; nam et histriones in pronuntiando non irati populum movent, sed iratum bene agentes; et apud iudices itaque et in contione et ubicumque alieni animi ad nostrum arbitrium agendi sunt, modo iram, modo metum, modo misericordiam, ut aliis incutiamus, ipsi simulabimus, et saepe id quod veri affectus non effecissent effecit imitatio affectuum. «Languidus» inquit «animus est qui ira caret». Verum est, si nihil habeat ira valentius. Nec latronem oportet esse nec praedam, nec misericordem nec crudelem: illius nimis mollis animus, huius nimis durus est; temperatus sit sapiens et ad res fortius agendas non iram sed vim adhibeat. 18. Quoniam quae de ira quaeruntur tractavimus, accedamus ad remedia eius. Duo autem, ut opinor, sunt: ne incidamus in iram, et ne in ira peccemus. Ut in corporum cura alia de tuenda valetudine, alia de restituenda praecepta sunt, ita aliter iram debemus repellere, aliter compescere. Ut vitemus, quaedam ad universam vitam pertinentia praecipientur: ea in educationem et in sequentia tempora dividentur. Educatio maximam diligentiam plurimumque profuturam desiderat, facile est enim teneros adhuc animos componere, difficulter reciduntur vitia quae nobiscum creverunt. 19. Opportunissima ad iracundiam fervidi animi natura est. Nam cum elementa sint quattuor, ignis aquae aeris terrae, potestates pares his sunt, fervida frigida arida atque umida: et locorum itaque et animalium et corporum et morum varietates mixtura elementorum facit, et proinde aliquo magis incumbunt ingenia
prout alicuius elementi maior vis abundavit. Inde quasdam umidas vocamus aridasque regiones et calidas et frigidas. Eadem animalium hominumque discrimina sunt: refert quantum quisque umidi in se calidique contineat; cuius in illo elementi portio praevalebit, inde mores erunt. Iracundos fervida animi natura faciet: est enim actuosus et pertinax ignis: frigidi mixtura timidos facit: pigrum est enim contractumque frigus. Volunt itaque quidam ex nostris iram in pectore moveri effervescente circa cor sanguine; causa cur hic potissimum adsignetur irae locus non alia est quam quod in toto corpore calidissimum pectus est. Quibus umidi plus inest, eorum paulatim crescit ira, quia non est paratus illis calor sed motu adquiritur: itaque puerorum feminarumque irae acres magis quam graves sunt levioresque dum incipiunt. Siccis aetatibus vehemens robustaque est ira, sed sine incremento, non multum sibi adiciens, quia inclinaturum calorem frigus insequitur: senes difficiles et queruli sunt, ut aegri et convalescentes et quorum aut lassitudine aut detractione sanguinis exhaustus est calor; in eadem causa sunt siti fameque tabidi et quibus exsangue corpus est maligneque alitur et deficit. Vinum incendit iras, quia calorem auget; pro cuiusque natura quidam ebrii effervescunt, quidam saucii. Neque ulla alia causa est cur iracundissimi sint flavi rubentesque, quibus talis natura color est qualis fieri ceteris inter iram solet; mobilis enim illis agitatusque sanguis est. 20. Sed quemadmodum natura quosdam proclives in iram facit, ita multae incidunt causae quae idem possint quod natura: alios morbus aut iniuria corporum in hoc perduxit, alios labor aut continua pervigilia noctesque sollicitae et desideria amoresque; quicquid aliud aut corpori nocuit aut animo, aegram mentem in querellas parat. Sed omnia ista initia causaeque sunt: plurimum potest consuetudo, quae si gravis est alit vitium. Naturam quidem mutare difficile est, nec licet semel mixta nascentium elementa convertere; sed in hoc nosse profuerit, ut calentibus ingeniis subtrahas vinum, quod pueris Plato negandum putat et ignem vetat igne incitari. Ne cibis quidem implendi sint; distendentur enim corpora et animi cum corpore tumescent. Labor illos citra lassitudinem exerceat, ut minuatur, non ut consumatur calor nimiusque ille fervor despumet. Lusus quoque proderunt; modica enim voluptas laxat animos et temperat. Umidioribus siccioribusque et frigidis non est ab ira periculum, sed inertiora vitia metuenda sunt, pavor et difficultas et desperatio et suspiciones. Mollienda itaque fovendaque talia ingenia et in laetitiam evocanda sunt. Et quia aliis contra iram, aliis contra tristitiam remediis utendum est nec dissimillimis tantum ista sed contrariis curanda sunt, semper ei occurremus quod increverit. 21. Plurimum, inquam, proderit pueros statim salubriter institui; difficile autem regimen est, quia dare debemus operam ne aut iram in illis nutriamus aut indolem retundamus. Diligenti observatione res indiget, utrumque enim et quod
extollendum et quod deprimendum est, similibus alitur, facile autem etiam adtendentem similia decipiunt. Crescit licentia spiritus, servitute comminuitur; assurgit si laudatur et in spem sui bonam adducitur, sed eadem ista insolentiam et iracundiam generant; itaque sic inter utrumque regendus est ut modo frenis utamur modo stimulis. Nihil humile, nihil servile patiatur: numquam illi necesse sit rogare suppliciter nec prosit rogasse, potius causae suae et prioribus factis et bonis in futurum promissis donetur. In certaminibus aequalium nec vinci illum patiamur nec irasci; demus operam ut familiaris sit iis cum quibus contendere solet, ut in certamine adsuescat non nocere velle sed vincere; quotiens superaverit et dignum aliquid laude fecerit, attolli non gestire patiamur: gaudium enim exultatio, exultationem tumor et nimia aestimatio sui sequitur. Dabimus aliquod laxamentum, in desidiam vero otiumque non resolvemus et procul a contactu deliciarum retinebimus; nihil enim magis facit iracundos quam educatio mollis et blanda. Ideo unicis quo plus indulgetur, pupillisque quo plus licet, corruptior animus est. Non resistet offensis cui nihil umquam negatum est, cuius lacrimas sollicita semper mater abstersit, cui de paedagogo satisfactum est. Non vides ut maiorem quamque fortunam maior ira comitetur? In divitibus et nobilibus et magistratibus praecipue apparet, cum quicquid leve et inane in animo erat secunda se aura sustulit. Felicitas iracundiam nutrit, ubi aures superbas adsentatorum turba circumstetit: «Tibi enim ille respondeat? Non pro fastigio te tuo metiris; ipse te proicis», et alia quibus vix sanae et ab initio bene fundatae mentes restiterunt. Longe itaque ab adsentatione pueritia removenda est: audiat verum. Et timeat interim, vereatur semper, maioribus adsurgat. Nihil per iracundiam exoret: quod flenti negatum fuerit quieto offeratur. Et divitias parentium in conspectu habeat, non in usu. Exprobrentur illi perperam facta. Pertinebit ad rem praeceptores paedagogosque pueris placidos dari: proximis applicatur omne quod tenerum est et in eorum similitudinem crescit; nutricum et paedagogorum rettulere mox adulescentium mores. Apud Platonem educatus puer cum ad parentes relatus vociferantem videret patrem: «Numquam» inquit «hoc apud Platonem vidi». Non dubito quin citius patrem imitatus sit quam Platonem. Tenuis ante omnia victus sit et non pretiosa vestis et similis cultus cum aequalibus: non irascetur aliquem sibi comparari quem ab initio multis parem feceris. 22. Sed haec ad liberos nostros pertinent; in nobis quidem sors nascendi et educatio nec vitii locum nec iam praecepti habet: sequentia ordinanda sunt. Contra primas itaque causas pugnare debemus; causa autem iracundiae opinio iniuriae est, cui non facile credendum est. Ne apertis quidem manifestisque statim accedendum; quaedam enim falsa veri speciem ferunt. Dandum semper est tempus: veritatem dies aperit. Ne sint aures criminantibus faciles: hoc humanae naturae vitium suspectum notumque nobis sit, quod quae inviti audimus libenter
credimus et antequam iudicemus irascimur. Quid quod non criminationibus tantum sed suspicionibus impellimur et ex vultu risuque alieno peiora interpretati innocentibus irascimur? Itaque agenda est contra se causa absentis et in suspenso ira retinenda; potest enim poena dilata exigi, non potest exacta revocari. 23. Notus est ille tyrannicida qui, imperfecto opere comprehensus et ab Hippia tortus ut conscios indicaret, circumstantes amicos tyranni nominavit quibusque maxime caram salutem eius sciebat. Et cum ille singulos, ut nominati erant, occidi iussisset, interrogavit ecquis superesset: «Tu» inquit «solus; neminem enim alium cui carus esses reliqui». Effecit ira ut tyrannus tyrannicidae manus accommodaret et praesidia sua gladio suo caederet. Quanto animosius Alexander! Qui cum legisset epistulam matris, qua admonebatur ut a veneno Philippi medici caveret, acceptam potionem non deterritus bibit: plus sibi de amico suo credidit. Dignus fuit qui innocentem haberet, dignus qui faceret! Hoc eo magis in Alexandro laudo quia nemo tam obnoxius irae fuit; quo rarior autem moderatio in regibus, hoc laudanda magis est. Fecit hoc et C. Caesar ille qui victoria civili clementissime usus est: cum scrinia deprendisset epistularum ad Cn. Pompeium missarum ab iis qui videbantur aut in diversis aut in neutris fuisse partibus, combussit. Quamvis moderate soleret irasci, maluit tamen non posse; gratissimum putavit genus veniae nescire quid quisque peccasset. 24. Plurimum mali credulitas facit. Saepe ne audiendum quidem est, quoniam in quibusdam rebus satius est decipi quam diffidere. Tollenda ex animo suspicio et coniectura, fallacissima inritamenta: «Ille me parum humane salutavit; ille osculo meo non adhaesit; ille inchoatum sermonem cito abrupit; ille ad cenam non vocavit; illius vultus aversior visus est». Non deerit suspicioni argumentatio: simplicitate opus est et benigna rerum aestimatione. Nihil nisi quod in oculos incurret manifestumque erit credamus, et quotiens suspicio nostra vana apparuerit, obiurgemus credulitatem: haec enim castigatio consuetudinem efficiet non facile credendi. 25. Inde et illud sequitur, ut minimis sordidissimisque rebus non exacerbemur. Parum agilis est puer aut tepidior aqua poturo aut turbatus torus aut mensa neglegentius posita: ad ista concitari insania est. Aeger et infelicis valetudinis est quem levis aura contraxit, affecti oculi quos candida vestis obturbat, dissolutus deliciis cuius latus alieno labore condoluit. Mindyriden aiunt fuisse ex Sybaritarum civitate qui, cum vidisset fodientem et altius rastrum allevantem, lassum se fieri questus vetuit illum opus in conspectu suo facere; bilem habere saepius questus est, quod foliis rosae duplicatis incubuisset. Ubi animum simul et corpus voluptates corrupere, nihil tolerabile videtur,
non quia dura sed quia mollis patitur. Quid est enim cur tussis alicuius aut sternutamentum aut musca parum curiose fugata in rabiem agat aut obversatus canis aut clavis neglegentis servi manibus elapsa? Feret iste aequo animo civile convicium et ingesta in contione curiave maledicta cuius aures tracti subsellii stridor offendit? Perpetietur hic famem et aestivae expeditionis sitim qui puero male diluenti nivem irascitur? Nulla itaque res magis iracundiam alit quam luxuria intemperans et impatiens: dure tractandus animus est ut ictum non sentiat nisi gravem. 26. Irascimur aut iis a quibus ne accipere quidem potuimus iniuriam, aut iis a quibus accipere iniuriam potuimus. Ex prioribus quaedam sine sensu sunt, ut liber quem minutioribus litteris scriptum saepe proiecimus et mendosum laceravimus, ut vestimenta quae, quia displicebant, scidimus: his irasci quam stultum est, quae iram nostram nec meruerunt nec sentiunt! «Sed offendunt nos videlicet qui illa fecerunt». Primum saepe antequam hoc apud nos distinguamus irascimur. Deinde fortasse ipsi quoque artifices excusationes iustas adferent: alius non potuit melius facere quam fecit, nec ad tuam contumeliam parum didicit; alius non in hoc ut te offenderet fecit. Ad ultimum quid est dementius quam bilem in homines collectam in res effundere? Atqui ut his irasci dementis est quae anima carent, sic mutis animalibus, quae nullam iniuriam nobis faciunt, quia velle non possunt; non est enim iniuria nisi a consilio profecta. Nocere itaque nobis possunt ut ferrum aut lapis, iniuriam quidem facere non possunt. Atqui contemni se quidam putant, ubi idem equi obsequentes alteri equiti, alteri contumaces sunt, tamquam iudicio, non consuetudine et arte tractandi quaedam quibusdam subiectiora sint. Atqui ut his irasci stultum est, ita pueris et non multum a puerorum prudentia distantibus; omnia enim ista peccata apud aequum iudicem pro innocentia habent imprudentiam. 27. Quaedam sunt quae nocere non possunt nullamque vim nisi beneficam et salutarem habent, ut di immortales, qui nec volunt obesse nec possunt; natura enim illis mitis et placida est, tam longe remota ab aliena iniuria quam a sua. Dementes itaque et ignari veritatis illis imputant saevitiam maris, immodicos imbres, pertinaciam hiemis, cum interim nihil horum quae nobis nocent prosuntque ad nos proprie derigatur. Non enim nos causa mundo sumus hiemem aestatemque referendi: suas ista leges habent, quibus divina exercentur. Nimis nos suspicimus, si digni nobis videmur propter quos tanta moveantur. Nihil ergo horum in nostram iniuriam fit, immo contra nihil non ad salutem. Quaedam esse diximus quae nocere non possint, quaedam quae nolint. In iis erunt boni magistratus parentesque et praeceptores et iudices, quorum castigatio sic accipienda est quomodo scalpellum et abstinentia et alia quae profutura torquent. Adfecti sumus poena: succurrat non tantum quid patiamur sed quid fecerimus, in consilium de vita nostra mittamur; si modo verum ipsi nobis dicere
voluerimus, pluris litem nostram aestimabimus. 28. Si volumus aequi rerum omnium iudices esse, hoc primum nobis persuadeamus, neminem nostrum esse sine culpa; hinc enim maxima indignatio oritur: «Nihil peccavi» et «Nihil feci». Immo nihil fateris! Indignamur aliqua admonitione aut coercitione nos castigatos, cum illo ipso tempore peccemus, quod adicimus malefactis arrogantiam et contumaciam. Quis est iste qui se profitetur omnibus legibus innocentem? Ut hoc ita sit, quam angusta innocentia est ad legem bonum esse! Quanto latius officiorum patet quam iuris regula! Quam multa pietas humanitas liberalitas iustitia fides exigunt, quae omnia extra publicas tabulas sunt! Sed ne ad illam quidem artissimam innocentiae formulam praestare nos possumus: alia fecimus, alia cogitavimus, alia optavimus, aliis favimus; in quibusdam innocentes sumus, quia non successit. Hoc cogitantes aequiores simus delinquentibus, credamus obiurgantibus; utique bonis ne irascamur (cui enim non, si bonis quoque?), minime diis; non enim illorum, sed lege mortalitatis patimur quicquid incommodi accidit. «At morbi doloresque incurrunt». Utique aliquo defungendum est domicilium putre sortitis. Dicetur aliquis male de te locutus: cogita an prior feceris, cogita de quam multis loquaris. Cogitemus, inquam, alios non facere iniuriam sed reponere, alios pro nobis facere, alios coactos facere, alios ignorantes, etiam eos qui volentes scientesque faciunt ex iniuria nostra non ipsam iniuriam petere: aut dulcedine urbanitatis prolapsus est, aut fecit aliquid, non ut nobis obesset, sed quia consequi ipse non poterat, nisi nos reppulisset; saepe adulatio dum blanditur offendit. Quisquis ad se rettulerit quotiens ipse in suspicionem falsam inciderit, quam multis officiis suis fortuna speciem iniuriae induerit, quam multos post odium amare coeperit, poterit non statim irasci, utique si sibi tacitus ad singula quibus offenditur dixerit: «Hoc et ipse commisi». Sed ubi tam aequum iudicem invenies? Is qui nullius non uxorem concupiscit et satis iustas causas putat amandi quod aliena est, idem uxorem suam aspici non vult; et fidei acerrimus exactor est perfidus, et mendacia persequitur ipse periurus, et litem sibi inferri aegerrime calumniator patitur; pudicitiam servulorum attemptari non vult qui non pepercit suae. Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt: inde est quod tempestiva filii convivia pater deterior filio castigat, et nihil alienae luxuriae ignoscit qui nihil suae negavit, et homicidae tyrannus irascitur, et punit furta sacrilegus. Magna pars hominum est quae non peccatis irascitur sed peccantibus. Faciet nos moderatiores respectus nostri, si consuluerimus nos: «Numquid et ipsi aliquid tale commisimus? Numquid sic erravimus? Expeditne nobis ista damnare?». 29. Maximum remedium irae mora est. Hoc ab illa pete initio, non ut ignoscat sed ut iudicet: graves habet impetus primos; desinet, si expectat. Nec universam
illam temptaveris tollere: tota vincetur, dum partibus carpitur. Ex iis quae nos offendunt alia renuntiantur nobis, alia ipsi audimus aut videmus. De iis quae narrata sunt non debemus cito credere: multi mentiuntur ut decipiant, multi quia decepti sunt; alius criminatione gratiam captat et fingit iniuriam ut videatur doluisse factam; est aliquis malignus et qui amicitias cohaerentis diducere velit; est aliquis suspicax et qui spectare ludos cupiat et ex longinquo tutoque speculetur quos collisit. De parvula summa iudicaturo tibi res sine teste non probaretur, testis sine iureiurando non valeret, utrique parti dares actionem, dares tempus, non semel audires; magis enim veritas elucet quo saepius ad manum venit: amicum condemnas de praesentibus? Antequam audias, antequam interroges, antequam illi aut accusatorem suum nosse liceat aut crimen, irasceris? Iam enim, iam utrimque quid diceretur audisti? Hic ipse qui ad te detulit desinet dicere, si probare debuerit: «Non est» inquit «quod me protrahas; ego productus negabo; alioqui nihil umquam tibi dicam». Eodem tempore et instigat et ipse se certamini pugnaeque subtrahit. Qui dicere tibi nisi clam non vult, paene non dicit: quid est iniquius quam secreto credere, palam irasci? 30. Quorundam ipsi testes sumus: in his naturam excutiemus voluntatemque facientium. Puer est: aetati donetur, nescit an peccet. Pater est: aut tantum profuit ut illi etiam iniuriae ius sit, aut fortasse ipsum hoc meritum eius est quo offendimur. Mulier est: errat. Iussus est: necessitati quis nisi iniquus suscenset? Laesus est: non est iniuria pati quod prior feceris. Iudex est: plus credas illius sententiae quam tuae. Rex est: si nocentem punit, cede iustitiae, si innocentem, cede fortunae. Mutum animal est aut simile muto: imitaris illud, si irasceris. Morbus est aut calamitas: levius transiliet sustinentem. Deus est: tam perdis operam cum illi irasceris quam cum illum alteri precaris iratum. Bonus vir est qui iniuriam fecit: noli credere. Malus: noli mirari; dabit poenas alteri quas debet tibi, et iam sibi dedit qui peccavit. 31. Duo sunt, ut dixi quae iracundiam concitant: primum, si iniuriam videmur accepisse, de hoc satis dictum est; deinde, si inique accepisse, de hoc dicendum est. Iniqua quaedam iudicant homines quia pati non debuerint, quaedam quia non speraverint. Indigna putamus quae inopinata sunt; itaque maxime commovent quae contra spem expectationemque evenerunt, nec aliud est quare in domesticis minima offendant, in amicis iniuriam vocemus neglegentiam. «Quomodo ergo» inquit «inimicorum nos iniuriae movent?». Quia non expectavimus illas aut certe non tantas. Hoc efficit amor nostri nimius: inviolatos nos etiam inimicis iudicamus esse debere, regis quisque intra se animum habet, ut licentiam sibi dari velit, in se nolit. Itaque nos aut insolentia iracundos facit aut ignorantia rerum: quid enim mirum est malos mala facinora edere? Quid novi est, si inimicus nocet, amicus offendit, filius labitur, servus
peccat? Turpissimam aiebat Fabius imperatori excusationem esse «Non putavi», ego turpissimam homini puto. Omnia puta, expecta: etiam in bonis moribus aliquid existet asperius. Fert humana natura insidiosos animos, fert ingratos, fert cupidos, fert impios. Cum de unius moribus iudicabis, de publicis cogita. Ubi maxime gaudebis, maxime metues. Ubi tranquilla tibi omnia videntur, ibi nocitura non desunt sed quiescunt. Semper futurum aliquid quod te offendat existima: gubernator numquam ita totos sinus securus explicuit ut non expedite ad contrahendum armamenta disponeret. Illud ante omnia cogita, foedam esse et execrabilem vim nocendi et alienissimam homini, cuius beneficio etiam saeva mansuescunt. Aspice elephantorum iugo colla summissa et taurorum pueris pariter ac feminis persultantibus terga impune calcata et repentis inter pocula sinusque innoxio lapsu dracones et intra domum ursorum leonumque ora placida tractantibus adulantisque dominum feras: pudebit cum animalibus permutasse mores. Nefas est nocere patriae: ergo civi quoque, nam hic pars patriae est (sanctae partes sunt, si universum venerabile est), ergo et homini, nam hic in maiore tibi urbe civis est. Quid si nocere velint manus pedibus, manibus oculi? Ut omnia inter se membra consentiunt quia singula servari totius interest, ita homines singulis parcent quia ad coetum geniti sunt, salva autem esse societas nisi custodia et amore partium non potest. Ne viperas quidem et natrices et si qua morsu aut ictu nocent effligeremus, si in reliquum mansuefacere possemus aut efficere ne nobis aliisve periculo essent: ergo ne homini quidem nocebimus quia peccavit, sed ne peccet, nec umquam ad praeteritum sed ad futurum poena referetur; non enim irascitur sed cavet. Nam si puniendus est cuicumque pravum maleficumque ingenium est, poena neminem excipiet. 32. «At enim ira habet aliquam voluptatem et dulce est dolorem reddere». Minime: non enim ut in beneficiis honestum est merita meritis repensare, ita iniurias iniuriis. Illic vinci turpe est, hic vincere. Inhumanum verbum est et quidem pro iusto receptum ultio. Non multum differt nisi ordine qui dolorem regerit: tantum excusatius peccat. M. Catonem ignorans in balineo quidam percussit imprudens (quis enim illi sciens faceret iniuriam?). Postea satis facienti Cato: «Non memini» inquit «me percussum». Melius putavit non agnoscere quam vindicare. «Nihil» inquis «illi post tantam petulantiam mali factum est?». Immo multum boni: coepit Catonem nosse. Magni animi est iniurias despicere; ultionis contumeliosissimum genus est non esse visum dignum ex quo peteretur ultio. Multi leves iniurias altius sibi demisere dum vindicant: ille magnus et nobilis qui more magnae ferae latratus minutorum canum securus exaudit. 33. «Minus» inquit «contemnemur, si vindicaverimus iniuriam». Si tamquam ad remedium venimus, sine ira veniamus, non quasi dulce sit
vindicari, sed quasi utile; saepe autem satius fuit dissimulare quam ulcisci. Potentiorum iniuriae hilari vultu, non patienter tantum ferendae sunt: facient iterum, si se fecisse crediderint. Hoc habent pessimum animi magna fortuna insolentes: quos laeserunt et oderunt. Notissima vox est eius qui in cultu regum consenuerat: cum illum quidam interrogaret quomodo rarissimam rem in aula consecutus esset, senectutem: «Iniurias» inquit «accipiendo et gratias agendo». Saepe adeo iniuriam vindicare non expedit ut ne fateri quidem expediat. C. Caesar Pastoris splendidi equitis Romani filium cum in custodia habuisset munditiis eius et cultioribus capillis offensus, rogante patre ut salutem sibi filii concederet, quasi de supplicio admonitus duci protinus iussit; ne tamen omnia inhumane faceret adversum patrem, ad cenam illum eo die invitavit. Venit Pastor vultu nihil exprobrante. Propinavit illi Caesar heminam et posuit illi custodem: perduravit miser, non aliter quam si fili sanguinem biberet. Unguentum et coronas misit et observare iussit an sumeret: sumpsit. Eo die quo filium extulerat, immo quo non extulerat, iacebat conviva centesimus et potiones vix honestas natalibus liberorum podagricus senex hauriebat, cum interim non lacrimam emisit, non dolorem aliquo signo erumpere passus est: cenavit tamquam pro filio exorasset. Quaeris quare? Habebat alterum. «Quid ille Priamus? Non dissimulavit iram et regis genua complexus est, funestam perfusamque cruore fili manum ad os suum rettulit, cenavit?» Sed tamen sine unguento, sine coronis, et illum hostis saevissimus multis solaciis ut cibum caperet hortatus est, non ut pocula ingentia super caput posito custode siccaret. Contempsissem Romanum patrem, si sibi timuisset: nunc iram compescuit pietas. Dignus fuit cui permitteretur a convivio ad ossa fili legenda discedere; ne hoc quidem permisit benignus interim et comis adulescens: propinationibus senem crebris, ut cura leniretur admonens, lacessebat; contra ille se laetum et oblitum quid eo actum esset die praestitit: perierat alter filius, si carnifici conviva non placuisset. 34. Ergo ira abstinendum est, sive par est qui lacessendus est sive superior sive inferior. Cum pare contendere anceps est, cum superiore furiosum, cum inferiore sordidum. Pusilli hominis et miseri est repetere mordentem: mures formicaeque, si manum admoveris, ora convertunt; imbecillia se laedi putant, si tanguntur. Faciet nos mitiores, si cogitaverimus quid aliquando nobis profuerit ille cui irascimur, et meritis offensa redimetur. Illud quoque occurrat, quantum nobis commendationis allatura sit clementiae fama, quam multos venia amicos utiles fecerit. Ne irascamur inimicorum et hostium liberis. Inter Sullanae crudelitatis exempla est quod ab re publica liberos proscriptorum submovit: nihil est iniquius quam aliquem heredem paterni odii fieri. Cogitemus, quotiens ad ignoscendum difficiles erimus, an expediat nobis omnes inexorabiles esse. Quam saepe veniam qui negavit petit! Quam saepe eius pedibus advolutus est quem a suis reppulit! Quid est gloriosius quam iram amicitia mutare? Quos populus Romanus fideliores habet socios quam quos
habuit pertinacissimos hostes? Quod hodie esset imperium, nisi salubris providentia victos permiscuisset victoribus? Irascetur aliquis: tu contra beneficiis provoca: cadit statim simultas ab altera parte deserta; nisi paria non pugnant. Sed utrimque certabit ira, concurritur: ille est melior qui prior pedem rettulit, victus est qui vicit. Percussit te: recede; referiendo enim et occasionem saepius feriendi dabis et excusationem; non poteris revelli, cum voles. Numquid velit quisquam tam graviter hostem ferire ut relinquat manum in vulnere et se ab ictu revocare non possit? Atqui tale ira telum est: vix retrahitur. Arma nobis expedita prospicimus, gladium commodum et habilem: non vitabimus impetus animi † hiis graves funerosos † et irrevocabiles? Ea demum velocitas placet quae ubi iussa est vestigium sistit nec ultra destinata procurrit flectique et cursu ad gradum reduci potest; aegros scimus nervos esse, ubi invitis nobis moventur; senex aut infirmi corporis est qui cum ambulare vult currit: animi motus eos putemus sanissimos validissimosque qui nostro arbitrio ibunt, non suo ferentur. 35. Nihil tamen aeque profuerit quam primum intueri deformitatem rei, deinde periculum. Non est ullius affectus facies turbatior: pulcherrima ora foedavit, torvos vultus ex tranquillissimis reddit; linquit decor omnis iratos, et sive amictus illis compositus est ad legem, trahent vestem omnemque curam sui effundent, sive capillorum natura vel arte iacentium non informis habitus, cum animo inhorrescunt; tumescunt venae; concutietur crebro spiritu pectus, rabida vocis eruptio colla distendet; tum artus trepidi, inquietae manus, totius corporis fluctuatio. Qualem intus putas esse animum cuius extra imago tam foeda est? Quanto illi intra pectus terribilior vultus est, acrior spiritus, intentior impetus, rupturus se nisi eruperit! Quales sunt hostium vel ferarum caede madentium aut ad caedem euntium aspectus, qualia poetae inferna monstra finxerunt succincta serpentibus et igneo flatu, quales ad bella excitanda discordiamque in populos dividendam pacemque lacerandam deae taeterrimae inferum exeunt, talem nobis iram figuremus, flamma lumina ardentia, sibilo mugituque et gemitu et stridore et si qua his invisior vox est perstrepentem, tela manu utraque quatientem (neque enim illi se tegere curae est), torvam cruentamque et cicatricosam et verberibus suis lividam, incessus vesani, offusam multa caligine, incursitantem vastantem fugantemque et omnium odio laborantem, sui maxime, si aliter nocere non possit, terras maria caelum ruere cupientem, infestam pariter invisamque. Vel, si videtur, sit qualis apud vates nostros est sanguineum quatiens dextra Bellona flagellum, aut scissa gaudens vadit Discordia palla aut si qua magis dira facies excogitari diri affectus potest.
36. Quibusdam, ut ait Sextius, iratis profuit aspexisse speculum. Perturbavit illos tanta mutatio sui, velut in rem praesentem adducti non agnoverunt se: et quantulum ex vera deformitate imago illa speculo repercussa reddebat! Animus si ostendi et si in ulla materia perlucere posset, intuentis confunderet ater maculosusque et aestuans et distortus et tumidus. Nunc quoque tanta deformitas eius est per ossa carnesque et tot inpedimenta effluentis: quid si nudus ostenderetur? Speculo quidem neminem deterritum ab ira credideris. «Quid ergo?». Qui ad speculum venerat ut se mutaret, iam mutaverat: iratis quidem nulla est formosior effigies quam atrox et horrida qualesque esse etiam videri volunt. Magis illud videndum est, quam multis ira per se nocuerit. Alii nimio fervore rupere venas et sanguinem supra vires elatus clamor egessit et luminum suffudit aciem in oculos vehementius umor egestus et in morbos aegri reccidere. Nulla celerior ad insaniam via est. Multi itaque continuaverunt irae furorem nec quam expulerant mentem umquam receperunt: Aiacem in mortem egit furor, in furorem ira. Mortem liberis, egestatem sibi, ruinam domui imprecantur, et irasci se negant non minus quam insanire furiosi. Amicissimis hostes vitandique carissimis, legum nisi qua nocent immemores, ad minima mobiles, non sermone, non officio adiri faciles, per vim omnia gerunt, gladiis et pugnare parati et incumbere. Maximum enim illos malum cepit et omnia exsuperans vitia. Alia paulatim intrant, repentina et universa vis huius est. Omnis denique alios affectus sibi subicit: amorem ardentissimum vincit, transfoderunt itaque amata corpora et in eorum quos occiderant iacuere complexibus; avaritiam, durissimum malum minimeque flexibile, ira calcavit, adactam opes suas spargere et domui rebusque in unum collatis inicere ignem. Quid? Non ambitiosus magno aestimata proiecit insignia honoremque delatum reppulit? Nullus affectus est in quem non ira dominetur.
Liber tertius 1. Quod maxime desiderasti, Novate, nunc facere temptabimus, iram excidere animis aut certe refrenare et impetus eius inhibere. Id aliquando palam aperteque faciendum est, ubi minor vis mali patitur, aliquando ex occulto, ubi nimium ardet omnique inpedimento exasperatur et crescit; refert quantas vires quamque integras habeat, utrum reverberanda et agenda retro sit an cedere ei debeamus dum tempestas prima desaevit, ne remedia ipsa secum ferat. Consilium pro moribus cuiusque capiendum erit; quosdam enim preces vincunt, quidam insultant instantque summissis, quosdam terrendo placabimus; alios obiurgatio, alios confessio, alios pudor coepto deiecit, alios mora, lentum praecipitis mali remedium, ad quod novissime descendendum est. Ceteri enim affectus dilationem recipiunt et curari tardius possunt, huius incitata et se ipsa rapiens violentia non
paulatim procedit sed dum incipit tota est; nec aliorum more vitiorum sollicitat animos, sed abducit et impotentes sui cupidosque vel communis mali exagitat, nec in ea tantum in quae destinavit sed in occurrentia obiter furit. Cetera vitia impellunt animos, ira praecipitat. Etiam si resistere contra affectus suos non licet, at certe affectibus ipsis licet stare: haec, non secus quam fulmina procellaeque et si qua alia irrevocabilia sunt quia non eunt sed cadunt, vim suam magis ac magis tendit. Alia vitia a ratione, hoc a sanitate desciscit; alia accessus lenes habent et incrementa fallentia: in iram deiectus animorum est. Nulla itaque res urget magis attonita et in vires suas prona et sive successit superba, sive frustratur insana; ne repulsa quidem in taedium acta, ubi adversarium fortuna subduxit, in se ipsa morsus suos vertit. Nec refert quantum sit ex quo surrexerit; ex levissimis enim in maxima evadit. 2. Nullam transit aetatem, nullum hominum genus excipit. Quaedam gentes beneficio egestatis non novere luxuriam; quaedam, quia exercitae et vagae sunt, effugere pigritiam; quibus incultus mos agrestisque vita est, circumscriptio ignota est et fraus et quodcumque in foro malum nascitur: nulla gens est quam non ira instiget, tam inter Graios quam inter barbaros potens, non minus perniciosa leges metuentibus quam quibus iura distinguit modus virium. Denique cetera singulos corripiunt, hic unus affectus est qui interdum publice concipitur. Numquam populus universus feminae amore flagravit nec in pecuniam aut lucrum tota civitas spem suam misit, ambitio viritim singulos occupat, impotentia non est malum publicum. Saepe in iram uno agmine itum est: viri feminae, senes pueri, principes vulgusque consensere, et tota multitudo paucissimis verbis concitata ipsum concitatorem antecessit; ad arma protinus ignesque discursum est et indicta finitimis bella aut gesta cum civibus; totae cum stirpe omni crematae domus, et modo eloquio favorabili habitus in multo honore iram suae contionis excepit; in imperatorem suum legiones pila torserunt; dissedit plebs tota cum patribus; publicum consilium senatus non exspectatis dilectibus nec nominato imperatore subitos irae suae duces legit ac per tecta urbis nobiles consectatus viros supplicium manu sumpsit; violatae legationes rupto iure gentium rabiesque infanda civitatem tulit, nec datum tempus quo resideret tumor publicus, sed deductae protinus classes et oneratae tumultuario milite; sine more, sine auspiciis populus ductu irae suae egressus fortuita raptaque pro armis gessit, deinde magna clade temeritatem audacis irae luit. Hic barbaris forte irruentibus in bella exitus est: cum mobiles animos species iniuriae perculit, aguntur statim et qua dolor traxit ruinae modo legionibus incidunt, incompositi interriti incauti, pericula appetentes sua; gaudent feriri et instare ferro et tela corpore urgere et per suum vulnus exire. 3. «Non est» inquis «dubium quin magna ista et pestifera sit vis: ideo quemadmodum sanari debeat monstra». Atqui, ut in prioribus libris dixi, stat Aristoteles defensor irae et vetat illam
nobis exsecari: calcar ait esse virtutis, hac erepta inermem animum et ad conatus magnos pigrum inertemque fieri. Necessarium est itaque foeditatem eius ac feritatem coarguere et ante oculis ponere quantum monstri sit homo in hominem furens quantoque impetu ruat non sine pernicie sua perniciosus et ea deprimens quae mergi nisi cum mergente non possunt. Quid ergo? Sanum hunc aliquis vocat qui velut tempestate correptus non it sed agitur et furenti malo servit, nec mandat ultionem suam sed ipse eius exactor animo simul ac manu saevit, carissimorum eorumque quae mox amissa fleturus est carnifex? Hunc aliquis affectum virtuti adiutorem comitemque dat, consilia sine quibus virtus nihil gerit obturbantem? Caducae sinistraeque sunt vires et in malum suum validae in quas aegrum morbus et accessio erexit. Non est ergo quod me putes tempus in supervacuis consumere, quod iram, quasi dubiae apud homines opinionis sit, infamem, cum sit aliquis et quidem de illustribus philosophis qui illi indicat operas et tamquam utilem ac spiritus subministrantem in proelia, in actus rerum, ad omne quodcumque calore aliquo gerendum est vocet. Ne quem fallat tamquam aliquo tempore, aliquo loco profutura, ostendenda est rabies eius effrenata et attonita apparatusque illi reddendus est suus, eculei et fidiculae et ergastula et cruces et circumdati defossis corporibus ignes et cadavera quoque trahens uncus, varia vinculorum genera, varia poenarum, lacerationes membrorum, inscriptiones frontis et bestiarum immanium caveae: inter haec instrumenta conlocetur ira dirum quiddam atque horridum stridens, omnibus per quae furit taetrior. 4. Ut de ceteris dubium sit, nulli certe affectui peior est vultus, quem in prioribus libris descripsimus: asperum et acrem et nunc subducto retrorsus sanguine fugatoque pallentem, nunc in os omni calore ac spiritu verso subrubicundum et similem cruento, venis tumentibus, oculis nunc trepidis et exilientibus, nunc in uno obtutu defixis et haerentibus; adice dentium inter se arietatorum ut aliquem esse cupientium non alium sonum quam est apris tela sua attritu acuentibus; adice articulorum crepitum cum se ipsae manus frangunt et pulsatum saepius pectus, anhelitus crebros tractosque altius gemitus, instabile corpus, incerta verba subitis exclamationibus, trementia labra interdumque compressa et dirum quiddam exsibilantia. Ferarum mehercules, sive illas fames agitat sive infixum visceribus ferrum, minus taetra facies est, etiam cum venatorem suum semianimes morsu ultimo petunt, quam hominis ira flagrantis. Age, si exaudire voces ac minas vacet, qualia excarnificati animi verba sunt! Nonne revocare se quisque ab ira volet, cum intellexerit illam a suo primum malo incipere? Non vis ergo admoneam eos qui iram summa potentia exercent et argumentum virium existimant et in magnis magnae fortunae bonis ponunt paratam ultionem, quam non sit potens, immo ne liber quidem dici possit irae suae captivus? Non vis admoneam, quo diligentior quisque sit et ipse se circumspiciat, alia animi mala ad pessimos quosque pertinere, iracundiam etiam eruditis hominibus et in alia sanis inrepere? Adeo ut
quidam simplicitatis indicium iracundiam dicant et vulgo credatur facillimus quisque huic obnoxius. 5. «Quorsus» inquis «hoc pertinet?» Ut nemo se iudicet tutum ab illa, cum lenes quoque natura et placidos in saevitiam ac violentiam evocet. Quemadmodum adversus pestilentiam nihil prodest firmitas corporis et diligens valetudinis cura (promiscue enim inbecilla robustaque invadit), ita ab ira tam inquietis moribus periculum est quam compositis et remissis, quibus eo turpior ac periculosior est quo plus in illis mutat. Sed cum primum sit non irasci, secundum desinere, tertium alienae quoque irae mederi, dicam primum quemadmodum in iram non incidamus, deinde quemadmodum nos ab illa liberemus, novissime quemadmodum irascentem retineamus placemusque et ad sanitatem reducamus. Ne irascamur praestabimus, si omnia vitia irae nobis subinde proposuerimus et illam bene aestimaverimus. Accusanda est apud nos, damnanda; perscrutanda eius mala et in medium protrahenda sunt; ut qualis sit appareat, comparanda cum pessimis est. Avaritia adquirit et contrahit, quo aliquis melior utatur: ira inpendit, paucis gratuita est. Iracundus dominus quot in fugam servos egit, quot in mortem! Quanto plus irascendo quam id erat propter quod irascebatur amisit! Ira patri luctum, marito divortium attulit, magistratui odium, candidato repulsam. Peior est quam luxuria, quoniam illa sua voluptate fruitur, haec alieno dolore. Vincit malignitatem et invidiam: illae enim infelicem fieri volunt, haec facere, illae fortuitis malis delectantur, haec non potest expectare fortunam: nocere ei quem odit, non noceri vult. Nihil est simultatibus gravius: has ira conciliat. Nihil est bello funestius: in hoc potentium ira prorumpit; ceterum etiam illa plebeia ira et privata inerme et sine viribus bellum est. Praeterea ira, ut seponamus quae mox secutura sunt, damna insidias perpetuam ex certaminibus mutuis sollicitudinem, dat poenas dum exigit; naturam hominis eiurat: illa in amorem hortatur, haec in odium; illa prodesse iubet, haec nocere. Adice quod, cum indignatio eius a nimio sui suspectu veniat, ut animosa videatur, pusilla est et angusta; nemo enim non eo a quo se contemptum iudicat minor est. At ille ingens animus et verus aestimator sui non vindicat iniuriam, quia non sentit. Ut tela a duro resiliunt et cum dolore caedentis solida feriuntur, ita nulla magnum animum iniuria ad sensum sui adducit, fragilior eo quod petit. Quanto pulchrius velut nulli penetrabilem telo omnis iniurias contumeliasque respuere! Ultio doloris confessio est; non est magnus animus quem incurvat iniuria. Aut potentior te aut imbecillior laesit: si imbecillior, parce illi, si potentior, tibi. 6. Nullum est argumentum magnitudinis certius quam nihil posse quo instigeris accidere. Pars superior mundi et ordinatior ac propinqua sideribus nec in nubem cogitur nec in tempestatem impellitur nec versatur in turbinem; omni
tumultu caret: inferiora fulminantur. Eodem modo sublimis animus, quietus semper et in statione tranquilla collocatus, omnia infra se premens quibus ira contrahitur, modestus et venerabilis est et dispositus; quorum nihil invenies in irato. Quis enim traditus dolori et furens non primam reiecit verecundiam? Quis impetu turbidus et in aliquem ruens non quicquid in se venerandi habuit abiecit? Cui officiorum numerus aut ordo constitit incitato? Quis linguae temperavit? Quis ullam partem corporis tenuit? Quis se regere potuit immissum? Proderit nobis illud Democriti salutare praeceptum, quo monstratur tranquillitas si neque privatim neque publice multa aut maiora viribus nostris egerimus. Numquam tam feliciter in multa discurrenti negotia dies transit ut non aut ex homine aut ex re offensa nascatur quae animum in iras paret. Quemadmodum per frequentia urbis loca properanti in multos incursitandum est et aliubi labi necesse est, aliubi retineri, aliubi respergi, ita in hoc vitae actu dissipato et vago multa inpedimenta, multae querellae incidunt: alius spem nostram fefellit, alius distulit, alius intercepit; non ex destinato proposita fluxerunt. Nulli fortuna tam dedita est ut multa temptanti ubique respondeat; sequitur ergo ut is cui contra quam proposuerat aliqua cesserunt impatiens hominum rerumque sit, ex levissimis causis irascatur nunc personae, nunc negotio, nunc loco, nunc fortunae, nunc sibi. Itaque ut quietus possit esse animus, non est iactandus nec multarum, ut dixi, rerum actu fatigandus nec magnarum supraque vires appetitarum. Facile est levia aptare cervicibus et in hanc aut illam partem transferre sine lapsu, at quae alienis in nos manibus imposita aegre sustinemus, victi in proximo effundimus; etiam dum stamus sub sarcina, impares oneri vacillamus. 7. Idem accidere in rebus civilibus ac domesticis scias. Negotia expedita et habilia sequuntur actorem, ingentia et supra mensuram gerentis nec dant se facile et, si occupata sunt, premunt atque abducunt administrantem tenerique iam visa cum ipso cadunt: ita fit ut frequenter irrita sit eius voluntas qui non quae facilia sunt adgreditur, sed vult facilia esse quae aggressus est. Quotiens aliquid conaberis, te simul et ea quae paras quibusque pararis ipse metire; faciet enim te asperum paenitentia operis infecti. Hoc interest utrum quis fervidi sit ingenii an frigidi atque humilis: generoso repulsa iram exprimet, languido inertique tristitiam. Ergo actiones nostrae nec parvae sint nec audaces et improbae, in vicinum spes exeat, nihil conemur quod mox adepti quoque successisse miremur. 8. Demus operam ne accipiamus iniuriam, quia ferre nescimus. Cum placidissimo et facillimo et minime anxio morosoque vivendum est; sumuntur a conversantibus mores et ut quaedam in contactos corporis vitia transsiliunt, ita animus mala sua proximis tradit: ebriosus convictores in amorem meri traxit, impudicorum coetus fortem quoque et (si liceat) virum emolliit, avaritia in
proximos virus suum transtulit. Eadem ex diverso ratio virtutum est, ut omne quod secum habent mitigent; nec tam valetudini profuit utilis regio et salubrius caelum quam animis parum firmis in turba meliore versari. Quae res quantum possit intelleges, si videris feras quoque convictu nostro mansuescere nullique etiam immani bestiae vim suam permanere, si hominis contubernium diu passa est: retunditur omnis asperitas paulatimque inter placida dediscitur. Accedit huc quod non tantum exemplo melior fit qui cum quietis hominibus viuit, sed quod causas irascendi non invenit nec vitium suum exercet. Fugere itaque debebit omnis quos irritaturos iracundiam sciet. «Qui sunt» inquis «isti?». Multi ex variis causis idem facturi: offendet te superbus contemptu, dicax contumelia, petulans iniuria, lividus malignitate, pugnax contentione, ventosus et mendax vanitate; non feres a suspicioso timeri, a pertinace vinci, a delicato fastidiri. Elige simplices faciles moderatos, qui iram tuam nec evocent et ferant; magis adhuc proderunt summissi et humani et dulces, non tamen usque in adulationem, nam iracundos nimia adsentatio offendit: erat certe amicus noster vir bonus sed irae paratioris, cui non magis tutum erat blandiri quam male dicere. Caelium oratorem fuisse iracundissimum constat. Cum quo, ut aiunt, cenabat in cubiculo lectae patientiae cliens, sed difficile erat illi in copulam coniecto rixam eius cui cohaerebat effugere; optimum iudicavit quicquid dixisset sequi et secundas agere. Non tulit Caelius assentientem et exclamavit: «Dic aliquid contra, ut duo simus!». Sed ille quoque, quod non irasceretur iratus, cito sine adversario desit. Eligamus ergo vel hos potius, si conscii nobis iracundiae sumus, qui vultum nostrum ac sermonem sequantur: facient quidem nos delicatos et in malam consuetudinem inducent nihil contra voluntatem audiendi, sed proderit vitio suo intervallum et quietem dare. Difficiles quoque et indomiti natura blandientem ferent: nihil asperum tetricumque palpanti est. Quotiens disputatio longior et pugnacior erit, in prima resistamus, antequam robur accipiat: alit se ipsa contentio et demissos altius tenet; facilius est se a certamine abstinere quam abducere. 9. Studia quoque graviora iracundis omittenda sunt aut certe citra lassitudinem exercenda, et animus non inter dura versandus, sed artibus amoenis tradendus: lectio illum carminum obleniat et historia fabulis detineat; mollius delicatiusque tractetur. Pythagoras perturbationes animi lyra componebat; quis autem ignorat lituos et tubas concitamenta esse, sicut quosdam cantus blandimenta quibus mens resolvatur? Confusis oculis prosunt virentia et quibusdam coloribus infirma acies adquiescit, quorundam splendore praestringitur: sic mentes aegras studia laeta permulcent. Forum advocationes iudicia fugere debemus et omnia quae exulcerant vitium, aeque cavere lassitudinem corporis; consumit enim quicquid in nobis mite placidumque est et acria concitat. Ideo quibus stomachus suspectus est, processuri ad res agendas
maioris negotii bilem cibo temperant, quam maxime movet fatigatio, sive quia calorem in media compellit et nocet sanguini cursumque eius venis laborantibus sistit, sive quia corpus attenuatum et infirmum incumbit animo; certe ob eandem causam iracundiores sunt valetudine aut aetate fessi. Fames quoque et sitis ex isdem causis vitanda est: exasperat et incendit animos. Vetus dictum est a lasso rixam quaeri; aeque autem et ab esuriente et a sitiente et ab omni homine quem aliqua res urit. Nam ut ulcera ad levem tactum, deinde etiam ad suspicionem tactus condolescunt, ita animus affectus minimis offenditur, adeo ut quosdam salutatio et epistula et oratio et interrogatio in litem evocent: numquam sine querella aegra tanguntur. 10. Optimum est itaque ad primum mali sensum mederi sibi, tum verbis quoque suis minimum libertatis dare et inhibere impetum. Facile est autem affectus suos, cum primum oriuntur, deprehendere: morborum signa praecurrunt. Quemadmodum tempestatis ac pluviae ante ipsas notae veniunt, ita irae amoris omniumque istarum procellarum animos vexantium sunt quaedam praenuntia. Qui comitiali vitio solent corripi iam adventare valetudinem intellegunt, si calor summa deseruit et incertum lumen nervorumque trepidatio est, si memoria sublabitur caputque versatur; solitis itaque remediis incipientem causam occupant, et odore gustuque quicquid est quod alienat animos repellitur, aut fomentis contra frigus rigoremque pugnatur; aut, si parum medicina profecit, vitaverunt turbam et sine teste ceciderunt. Prodest morbum suum nosse et vires eius antequam spatientur opprimere. Videamus quid sit quod nos maxime concitet: alium verborum, alium rerum contumeliae movent; hic vult nobilitati, hic formae suae parci; hic elegantissimus haberi cupit, ille doctissimus; hic superbiae impatiens est, hic contumaciae; ille servos non putat dignos quibus irascatur, hic intra domum saevus est, foris mitis; ille rogari iniuriam iudicat, hic non rogari contumeliam. Non omnes ab eadem parte feriuntur; scire itaque oportet quid in te imbecillum sit, ut id maxime protegas. 11. Non expedit omnia videre, omnia audire. Multae nos iniuriae transeant, ex quibus plerasque non accipit qui nescit. Non vis esse iracundus? Ne fueris curiosus. Qui inquirit quid in se dictum sit, qui malignos sermones etiam si secreto habiti sunt eruit, se ipse inquietat. Quaedam interpretatio eo perducit ut videantur iniuriae: itaque alia differenda sunt, alia deridenda, alia donanda. Circumscribenda multis modis ira est; pleraque in lusum iocumque vertantur. Socratem aiunt colapho percussum nihil amplius dixisse quam «molestum esse quod nescirent homines quando cum galea prodire deberent». Non quemadmodum facta sit iniuria refert, sed quemadmodum lata; nec video quare difficilis sit moderatio, cum sciam tyrannorum quoque tumida et fortuna et licentia ingenia familiarem sibi saevitiam repressisse. Pisistratum certe, Atheniensium tyrannum, memoriae proditur, cum multa in crudelitatem eius
ebrius conviva dixisset nec deessent qui vellent manus ei commodare et alius hinc alius illinc faces subderent, placido animo tulisse et hoc irritantibus respondisse, non magis illi se suscensere quam si quis obligatis oculis in se incucurrisset. 12. Magna pars querellas manu fecit aut falsa suspicando aut levia aggravando. Saepe ad nos ira venit, saepius nos ad illam. Quae numquam arcessenda est: etiam cum incidit, reiciatur. Nemo dicit sibi: «Hoc propter quod irascor aut feci aut fecisse potui»; nemo animum facientis sed ipsum aestimat factum: atqui ille intuendus est, voluerit an inciderit, coactus sit an deceptus, odium secutus sit an praemium, sibi morem gesserit an manum alteri commodaverit. Aliquid aetas peccantis facit, aliquid fortuna, ut ferre ac pati aut humanum sit aut utile. Eo nos loco constituamus quo ille est cui irascimur: nunc facit nos iracundos iniqua nostri aestimatio et quae facere vellemus pati nolumus. Nemo se differt: atqui maximum remedium irae dilatio est, ut primus eius fervor relanguescat et caligo quae premit mentem aut residat aut minus densa sit. Quaedam ex his quae te praecipitem ferebant hora, non tantum dies molliet, quaedam ex toto evanescent; si nihil egerit petita advocatio, apparebit iam iudicium esse, non iram. Quicquid voles quale sit scire, tempori trade: nihil diligenter in fluctu cernitur. Non potuit inpetrare a se Plato tempus, cum servo suo irasceretur, sed ponere illum statim tunicam et praebere scapulas verberibus iussit, sua manu ipse caesurus; postquam intellexit irasci se, sicut sustulerat manum suspensam detinebat et stabat percussuro similis; interrogatus deinde ab amico qui forte intervenerat quid ageret: «Exigo» inquit «poenas ab homine iracundo». Velut stupens gestum illum saevituri deformem sapienti viro servabat, oblitus iam servi, quia alium quem potius castigaret invenerat. Itaque abstulit sibi in suos potestatem et ob peccatum quoddam commotior: «Tu» inquit «Speusippe, servulum istum verberibus obiurga; nam ego irascor». Ob hoc non cecidit propter quod alius cecidisset. «Irascor;» inquit «plus faciam quam oportet, libentius faciam: non sit iste servus in eius potestate qui in sua non est». Aliquis vult irato committi ultionem, cum Plato sibi ipse imperium abrogaverit? Nihil tibi liceat dum irasceris. Quare? Quia vis omnia licere. 13. Pugna tecum ipse; si vis vincere iram, non potest te illa. Incipis vincere, si absconditur, si illi exitus non datur. Signa eius obruamus et illam quantum fieri potest occultam secretamque teneamus. Cum magna id nostra molestia fiet (cupit enim exilire et incendere oculos et mutare faciem), sed si eminere illi extra nos licuit, supra nos est. In imo pectoris secessu recondatur, feraturque, non ferat. Immo in contrarium omnia eius indicia flectamus: vultus remittatur, vox lenior sit, gradus lentior; paulatim cum exterioribus interiora formantur. In Socrate irae signum erat vocem summittere, loqui parcius. Apparebat tunc illum sibi obstare. Deprendebatur itaque a familiaribus et coarguebatur, nec erat illi exprobratio latitantis irae ingrata. Quidni gauderet quod iram suam multi intellegerent, nemo
sentiret? Sensissent autem, nisi ius amicis obiurgandi se dedisset, sicut ipse sibi in amicos sumpserat. Quanto magis hoc nobis faciendum est! Rogemus amicissimum quemque ut tunc maxime libertate adversus nos utatur cum minime illam pati poterimus, nec assentiatur irae nostrae; contra potens malum et apud nos gratiosum, dum consipimus, dum nostri sumus, advocemus. Qui vinum male ferunt et ebrietatis suae temeritatem ac petulantiam metuunt, mandant suis ut e convivio auferantur; intemperantiam in morbo suam experti parere ipsis in adversa valetudine vetant. Optimum est notis vitiis impedimenta prospicere et ante omnia ita componere animum ut etiam gravissimis rebus subitisque concussus iram aut non sentiat aut magnitudine inopinatae iniuriae exortam in altum retrahat nec dolorem suum profiteatur. Id fieri posse apparebit, si pauca ex turba ingenti exempla protulero, ex quibus utrumque discere licet, quantum mali habeat ira ubi hominum praepotentium potestate tota utitur, quantum sibi imperare possit ubi metu maiore compressa est. 14. Cambysen regem nimis deditum vino Praexaspes unus ex carissimis monebat ut parcius biberet, turpem esse dicens ebrietatem in rege, quem omnium oculi auresque sequerentur. Ad haec ille «Ut scias» inquit «quemadmodum numquam excidam mihi, approbabo iam et oculos post vinum in officio esse et manus». Bibit deinde liberalius quam alias capacioribus scyphis et iam gravis ac vinolentus obiurgatoris sui filium procedere ultra limen iubet allevataque super caput sinistra manu stare. Tunc intendit arcum et ipsum cor adulescentis (id enim petere se dixerat) figit rescissoque pectore haerens in ipso corde spiculum ostendit ac respiciens patrem interrogavit satisne certam haberet manum. At ille negavit Apollinem potuisse certius mittere. Di illum male perdant animo magis quam condicione mancipium! Eius rei laudator fuit cuius nimis erat spectatorem fuisse. Occasionem blanditiarum putavit pectus filii in duas partes diductum et cor sub vulnere palpitans: controversiam illi facere de gloria debuit et revocare iactum, ut regi liberet in ipso patre certiorem manum ostendere. O regem cruentum! O dignum in quem omnium suorum arcus verterentur! Cum execrati fuerimus illum convivia suppliciis funeribusque solventem, tamen sceleratius telum illud laudatum est quam missum. Videbimus quomodo se pater gerere debuerit stans super cadaver fili sui caedemque illam cuius et testis fuerat et causa: id de quo nunc agitur apparet, iram supprimi posse. Non male dixit regi, nullum emisit ne calamitosi quidem verbum, cum aeque cor suum quam fili transfixum videret. Potest dici merito devorasse verba; nam si quid tamquam iratus dixisset, nihil tamquam pater facere potuisset. Potest, inquam, videri sapientius se in illo casu gessisse quam cum de potandi modo praeciperet quem satius erat vinum quam sanguinem bibere, cuius manus poculis occupari pax erat. Accessit itaque ad numerum eorum qui magnis cladibus ostenderunt quanti
constarent regum amicis bona consilia. 15. Non dubito quin Harpagus quoque tale aliquid regi suo Persarumque suaserit, quo offensus liberos illi epulandos apposuit et subinde quaesiit an placeret conditura; deinde, ut satis illum plenum malis suis vidit, afferri capita illorum iussit et quomodo esset acceptus interrogavit. Non defuerunt misero verba, non os concurrit: «Apud regem» inquit «omnis cena iucunda est». Quid hac adulatione profecit? Ne ad reliquias invitaretur. Non veto patrem damnare regis sui factum, non veto quaerere dignam tam truci portento poenam, sed hoc interim colligo, posse etiam ex ingentibus malis nascentem iram abscondi et ad verba contraria sibi cogi. Necessaria ista est doloris refrenatio, utique hoc sortitis vitae genus et ad regiam adhibitis mensam: sic estur apud illos, sic bibitur, sic respondetur, funeribus suis arridendum est. An tanti sit vita videbimus: alia ista quaestio est. Non consolabimur tam triste ergastulum, non adhortabimur ferre imperia carnificum: ostendemus in omni servitute apertam libertati viam. Is aeger animo et suo vitio miser est, cui miserias finire secum licet. Dicam et illi qui in regem incidit sagittis pectora amicorum petentem et illi cuius dominus liberorum visceribus patres saturat: «Quid gemis, demens? Quid expectas ut te aut hostis aliquis per exitium gentis tuae vindicet aut rex a longinquo potens advolet? Quocumque respexeris, ibi malorum finis est. Vides illum praecipitem locum? Illac ad libertatem descenditur. Vides illud mare, illud flumen, illum puteum? Libertas illic in imo sedet. Vides illam arborem brevem retorridam infelicem? Pendet inde libertas. Vides iugulum tuum, guttur tuum, cor tuum? Effugia servitutis sunt. Nimis tibi operosos exitus monstro et multum animi ac roboris exigentes? Quaeris quod sit ad libertatem iter? Quaelibet in corpore tuo vena!». 16. Quam diu quidem nihil tam intolerabile nobis videtur ut nos expellat e vita, iram, in quocumque erimus statu, removeamus. Perniciosa est servientibus; omnis enim indignatio in tormentum suum proficit et imperia graviora sentit quo contumacius patitur. Sic laqueos fera dum iactat astringit; sic aves viscum, dum trepidantes excutiunt, plumis omnibus illinunt. Nullum tam artum est iugum quod non minus laedat ducentem quam repugnantem: unum est levamentum malorum ingentium, pati et necessitatibus suis obsequi. Sed cum utilis sit servientibus affectuum suorum et huius praecipue rabidi atque effreni continentia, utilior est regibus: perierunt omnia ubi quantum ira suadet fortuna permittit, nec diu potest quae multorum malo exercetur potentia stare; periclitatur enim ubi eos qui separatim gemunt communis metus iunxit. Plerosque itaque modo singuli mactaverunt, modo universi, cum illos conferre in unum iras publicus dolor coegisset. Atqui plerique sic iram quasi insigne regium exercuerunt, sicut Dareus, qui primus post ablatum mago imperium Persas et magnam partem orientis obtinuit. Nam cum bellum Scythis indixisset orientem
cingentibus, rogatus ab Oeobazo nobili sene ut ex tribus liberis unum in solacium patri relinqueret, duorum opera uteretur, plus quam rogabatur pollicitus omnis se illi dixit remissurum et occisos in conspectu parentis abiecit, crudelis futurus si omnis abduxisset. At quanto Xerses facilior! Qui Pythio quinque filiorum patri unius vacationem petenti quem vellet eligere permisit, deinde quem elegerat in partes duas distractum ab utroque viae latere posuit et hac victima lustravit exercitum. Habuit itaque quem debuit exitum: victus et late longeque fusus ac stratam ubique ruinam suam cernens medius inter suorum cadavera incessit. 17. Haec barbaris regibus feritas in ira fuit, quos nulla eruditio, nullus litterarum cultus imbuerat: dabo tibi ex Aristotelis sinu regem Alexandrum, qui Clitum carissimum sibi et una educatum inter epulas transfodit manu quidem sua, parum adulantem et pigre ex Macedone ac libero in Persicam servitutem transeuntem. Nam Lysimachum aeque familiarem sibi leoni obiecit. Numquid ergo hic Lysimachus felicitate quadam dentibus leonis elapsus ob hoc, cum ipse regnaret, mitior fuit? Nam Telesphorum Rhodium amicum suum undique decurtatum, cum aures illi nasumque abscidisset, in cavea velut novum aliquod animal et inusitatum diu pavit, cum oris detruncati mutilatique deformitas humanam faciem perdidisset; accedebat fames et squalor et illuvies corporis in stercore suo destituti; callosis super haec genibus manibusque, quas in usum pedum angustiae loci cogebant, lateribus vero attritu exulceratis non minus foeda quam terribilis erat forma eius visentibus, factusque poena sua monstrum misericordiam quoque amiserat. Tamen, cum dissimillimus esset homini qui illa patiebatur, dissimilior erat qui faciebat. 18. Utinam ista saevitia intra peregrina exempla mansisset nec in Romanos mores cum aliis adventiciis vitiis etiam suppliciorum irarumque barbaria transisset! M. Mario, cui vicatim populus statuas posuerat, cui ture ac vino supplicabat, L. Sulla praefringi crura, erui oculos, amputari linguam manus iussit, et, quasi totiens occideret quotiens vulnerabat, paulatim et per singulos artus laceravit. Quis erat huius imperii minister? Quis nisi Catilina iam in omne facinus manus exercens? Is illum ante bustum Quinti Catuli carpebat gravissimus mitissimi viri cineribus, supra quos vir mali exempli, popularis tamen et non tam immerito quam nimis amatus, per stilicidia sanguinem dabat. Dignus erat Marius qui illa pateretur, Sulla qui iuberet, Catilina qui faceret, sed indigna res publica quae in corpus suum pariter et hostium et vindicum gladios reciperet. Quid antiqua perscrutor? Modo C. Caesar Sex. Papinium, cui pater erat consularis, Betilienum Bassum quaestorem suum, procuratoris sui filium, aliosque et senatores et equites Romanos uno die flagellis cecidit, torsit, non quaestionis sed animi causa; deinde adeo impatiens fuit differendae voluptatis, quam ingentem crudelitas eius sine dilatione poscebat, ut in xysto maternorum hortorum qui porticum a ripa separat, inambulans quosdam ex illis cum matronis
atque aliis senatoribus ad lucernam decollaret. Quid instabat? Quod periculum aut privatum aut publicum una nox minabatur? Quantulum fuit lucem expectare denique, ne senatores populi Romani soleatus occideret! 19. Quam superba fuerit crudelitas eius ad rem pertinet scire, quamquam aberrare alicui possimus videri et in devium exire; sed hoc ipsum pars erit irae super solita saevientis. Ceciderat flagellis senatores: ipse effecit ut dici posset «Solet fieri»; torserat per omnia quae in rerum natura tristissima sunt, fidiculis talaribus, eculeo igne vultu suo. Et hoc loco respondebitur: «Magnam rem, si tres senatores quasi nequam mancipia inter verbera et flammas divisit homo qui de toto senatu trucidando cogitabat, qui optabat ut populus Romanus unam cervicem haberet, ut scelera sua tot locis ac temporibus diducta in unum ictum et unum diem cogeret?». Quid tam inauditum quam nocturnum supplicium? Cum latrocinia tenebris abscondi soleant, animadversiones quo notiores sunt plus in exemplum emendationemque proficiunt. Et hoc loco respondebitur mihi: «Quod tanto opere admiraris isti beluae cotidianum est; ad hoc vivit, ad hoc vigilat, ad hoc lucubrat». Nemo certe invenietur alius qui imperaverit omnibus iis in quos animadverti iubebat os inserta spongea includi, ne vocis emittendae haberent facultatem. Cui umquam morituro non est relictum qua gemeret? Timuit ne quam liberiorem vocem extremus dolor mitteret, ne quid quod nollet audiret; sciebat autem innumerabilia esse quae obicere illi nemo nisi periturus auderet. Cum spongeae non invenirentur, scindi vestimenta miserorum et in os farciri pannos imperavit. Quae ista saevitia est? Liceat ultimum spiritum trahere, da exiturae animae locum, liceat illam non per vulnus emittere. Adicere his longum est quod patres quoque occisorum eadem nocte dimissis per domos centurionibus confecit, id est, homo misericors luctu liberavit. Non enim Gai saevitiam sed irae propositum est describere, quae non tantum viritim furit sed gentes totas lancinat, sed urbes et flumina et tuta ab omni sensu doloris converberat. 20. Sic rex Persarum totius populi nares recidit in Syria, unde Rhinocolura loco nomen est. Pepercisse illum iudicas quod non tota capita praecidit? Novo genere poenae delectatus est. Tale aliquid passi forent et Aethiopes, qui ob longissimum vitae spatium Macrobioe appellantur; in hos enim, quia non supinis manibus exceperant servitutem missisque legatis libera responsa dederant, quae contumeliosa reges vocant, Cambyses fremebat et non provisis commeatibus, non exploratis itineribus, per invia, per arentia trahebat omnem bello utilem turbam. Cui intra primum iter deerant necessaria, nec quicquam subministrabat sterilis et inculta humanoque ignota vestigio regio: sustinebant famem primo tenerrima frondium et cacumina arborum, tum coria igne mollita et quicquid necessitas cibum fecerat; postquam inter harenas radices quoque et herbae defecerant apparuitque inops etiam animalium solitudo, decimum quemque sortiti alimentum habuerunt fame saevius. Agebat adhuc regem ira praecipitem, cum
partem exercitus amisisset, partem comedisset, donec timuit ne et ipse vocaretur ad sortem: tum demum signum receptui dedit. Servabantur interim generosae illi aves et instrumenta epularum camelis vehebantur, cum sortirentur milites eius quis male periret, quis peius viveret. 21. Hic iratus fuit genti et ignotae et inmeritae, sensurae tamen: Cyrus flumini. Nam cum Babylona oppugnaturus festinaret ad bellum, cuius maxima momenta in occasionibus sunt, Gynden late fusum amnem vado transire temptavit, quod vix tutum est etiam cum sensit aestatem et ad minimum deductus est. Ibi unus ex iis equis qui trahere regium currum albi solebant abreptus vehementer commovit regem; iuravit itaque se amnem illum regis comitatus auferentem eo redacturum ut transiri calcarique etiam a feminis posset. Hoc deinde omnem transtulit belli apparatum et tam diu adsedit operi donec centum et octoginta cuniculis divisum alveum in trecentos et sexaginta rivos dispergeret et siccum relinqueret in diversum fluentibus aquis. Periit itaque et tempus, magna in magnis rebus iactura, et militum ardor, quem inutilis labor fregit, et occasio aggrediendi imparatos, dum ille bellum indictum hosti cum flumine gerit. Hic furor (quid enim aliud voces?) Romanos quoque contigit. C. enim Caesar villam in Herculanensi pulcherrimam, quia mater sua aliquando in illa custodita erat, diruit fecitque eius per hoc notabilem fortunam; stantem enim praenavigabamus, nunc causa dirutae quaeritur. 22. Et haec cogitanda sunt exempla quae vites, et illa ex contrario quae sequaris, moderata, lenia, quibus nec ad irascendum causa defuit nec ad ulciscendum potestas. Quid enim facilius fuit Antigono quam duos manipulares duci iubere, qui incumbentes regis tabernaculo faciebant quod homines et periculosissime et libentissime faciunt, de rege suo male existimabant? Audierat omnia Antigonus, utpote cum inter dicentes et audientem palla interesset; quam ille leviter commovit et «Longius» inquit «discedite, ne vos rex audiat». Idem quadam nocte, cum quosdam ex militibus suis exaudisset omnia mala imprecantis regi, qui ipsos in illud iter et inextricabile lutum deduxisset, accessit ad eos qui maxime laborabant et cum ignorantis a quo adiuvarentur explicuisset: «Nunc» inquit «male dicite Antigono, cuius vitio in has miserias incidistis; ei autem bene optate qui vos ex hac voragine eduxit». Idem tam miti animo hostium suorum male dicta quam civium tulit. Itaque cum in parvulo quodam castello Graeci obsiderentur et fiducia loci contemnentes hostem multa in deformitatem Antigoni iocarentur et nunc staturam humilem, nunc conlisum nasum deriderent: «Gaudeo» inquit «et aliquid boni spero, si in castris Silenum habeo». Cum hos dicaces fame domuisset, captis sic usus est ut eos qui militiae utiles erant in cohortes discriberet, ceteros praeconi subiceret, idque se negavit facturum fuisse, nisi expediret iis dominum habere qui tam malam haberent linguam.
23. Huius nepos fuit Alexander, qui lanceam in convivas suos torquebat, qui ex duobus amicis quos paulo ante rettuli alterum ferae obiecit, alterum sibi. Ex his duobus tamen qui leoni obiectus est vixit. Non habuit hoc avitum ille vitium, ne paternum quidem; nam si qua alia in Philippo virtus, fuit et contumeliarum patientia, ingens instrumentum ad tutelam regni. Demochares ad illum Parrhesiastes ob nimiam et procacem linguam appellatus inter alios Atheniensium legatos venerat. Audita benigne legatione Philippus: «Dicite» inquit «mihi facere quid possim quod sit Atheniensibus gratum». Excepit Demochares et «Te» inquit «suspendere». Indignatio circumstantium ad tam inhumanum responsum exorta erat; quos Philippus conticiscere iussit et Thersitam illum salvum incolumemque dimittere. «At vos» inquit «ceteri legati, nuntiate Atheniensibus multo superbiores esse qui ista dicunt quam qui inpune dicta audiunt». Multa et divus Augustus digna memoria fecit dixitque ex quibus appareat iram illi non imperasse. Timagenes historiarum scriptor quaedam in ipsum, quaedam in uxorem eius et in totam domum dixerat, nec perdiderat dicta; magis enim circumfertur et in ore hominum est temeraria urbanitas. Saepe illum Caesar monuit, moderatius lingua uteretur, perseveranti domo sua interdixit. Postea Timagenes in contubernio Pollionis Asini consenuit ac tota civitate direptus est: nullum illi limen praeclusa Caesaris domus abstulit. Historias quas postea scripserat recitavit et libros acta Caesaris Augusti continentis in ignem imposuit; inimicitias gessit cum Caesare: nemo amicitiam eius extimuit, nemo quasi fulguritum refugit, fuit qui praeberet tam alte cadenti sinum. Tulit hoc, ut dixi, Caesar patienter, ne eo quidem motus quod laudibus suis rebusque gestis manus attulerat; numquam cum hospite inimici sui questus est. Hoc dumtaxat Pollioni Asinio dixit: «Qhriotrofei'"»; paranti deinde excusationem obstitit et «Fruere» inquit «mi Pollio, fruere!» et cum Pollio diceret «Si iubes, Caesar, statim illi domo mea interdicam», «Hoc me» inquit «putas facturum, cum ego vos in gratiam reduxerim?». Fuerat enim aliquando Timageni Pollio iratus nec ullam aliam habuerat causam desinendi quam quod Caesar coeperat. 24. Dicat itaque sibi quisque, quotiens lacessitur: «Numquid potentior sum Philippo? Illi tamen inpune male dictum est. Numquid in domo mea plus possum quam toto orbe terrarum divus Augustus potuit? Ille tamen contentus fuit a conviciatore suo secedere». Quid est quare ego servi mei clarius responsum et contumaciorem vultum et non pervenientem usque ad me murmurationem flagellis et compedibus expiem? Quis sum, cuius aures laedi nefas sit? Ignoverunt multi hostibus: ego non ignoscam pigris neglegentibus garrulis? Puerum aetas excuset, feminam sexus, extraneum libertas, domesticum familiaritas. Nunc primum offendit: cogitemus quam diu placuerit; saepe et alias offendit: feramus quod diu tulimus. Amicus est: fecit quod noluit; inimicus: fecit quod debuit.
Prudentiori credamus, stultiori remittamus; pro quocumque illud nobis respondeamus, sapientissimos quoque viros multa delinquere, neminem esse tam circumspectum cuius non diligentia aliquando sibi ipsa excidat, neminem tam maturum cuius non gravitatem in aliquod fervidius factum casus impingat, neminem tam timidum offensarum qui non in illas dum vitat incidat. 25. Quomodo homini pusillo solacium in malis fuit etiam magnorum virorum titubare fortunam et aequiore animo filium in angulo flevit qui vidit acerba funera etiam ex regia duci, sic animo aequiore fert ab aliquo laedi, ab aliquo contemni, cuicumque venit in mentem nullam esse tantam potentiam in quam non occurrat iniuria. Quod si etiam prudentissimi peccant, cuius non error bonam causam habet? Respiciamus quotiens adulescentia nostra in officio parum diligens fuerit, in sermone parum modesta, in vino parum temperans. Si iratus est, demus illi spatium quo dispicere quid fecerit possit: ipse se castigabit. Denique debeat poenas: non est quod cum illo paria faciamus. Illud non veniet in dubium, quin se exemerit turbae et altius steterit quisquis despexit lacessentis: proprium est magnitudinis verae non sentire percussum. Sic immanis fera ad latratum canum lenta respexit, sic irritus ingenti scopulo fluctus adsultat. Qui non irascitur, inconcussus iniuria perstitit, qui irascitur, motus est. At ille quem modo altiorem omni incommodo posui tenet amplexu quodam summum bonum, nec homini tantum sed ipsi fortunae respondet: «Omnia licet facias, minor es quam ut serenitatem meam obducas. Vetat hoc ratio, cui vitam regendam dedi. Plus mihi nocitura est ira quam iniuria. Quidni plus? Illius modus certus est, ista quo usque me latura sit dubium est». 26. «Non possum» inquis «pati; grave est iniuriam sustinere». Mentiris: quis enim iniuriam non potest ferre qui potest iram? Adice nunc quod id agis ut et iram feras et iniuriam. Quare fers aegri rabiem et phrenetici verba, puerorum protervas manus? Nempe quia videntur nescire quid faciant. Quid interest quo quisque vitio fiat imprudens? Imprudentia par in omnibus patrocinium est. «Quid ergo» inquis «impune illi erit?». Puta velle te, tamen non erit; maxima est enim factae iniuriae poena fecisse, nec quisquam gravius adficitur quam qui ad supplicium paenitentiae traditur. Deinde ad condicionem rerum humanarum respiciendum est, ut omnium accidentium aequi iudices simus; iniquus autem est qui commune vitium singulis obiecit. Non est Aethiopis inter suos insignitus color, nec rufus crinis et coactus in nodum apud Germanos virum dedecet: nihil in uno iudicabis notabile aut foedum quod genti suae publicum est. Et ista quae rettuli unius regionis atque anguli consuetudo defendit: vide nunc quanto in iis iustior venia sit quae per totum genus humanum vulgata sunt. Omnes inconsulti et improvidi sumus, omnes incerti queruli ambitiosi (quid lenioribus verbis ulcus publicum abscondo?)
omnes mali sumus. Quicquid itaque in alio reprenditur, id unusquisque in sinu suo inveniet. Quid illius pallorem, illius maciem notas? pestilentia est. Placidiores itaque invicem simus: mali inter malos vivimus. Una nos res facere quietos potest, mutuae facilitatis conventio. «Ille iam mihi nocuit, ego illi nondum». Sed iam aliquem fortasse laesisti, sed laedes. Noli aestimare hanc horam aut hunc diem, totum inspice mentis tuae habitum: etiam si nihil mali fecisti, potes facere. 27. Quanto satius est sanare iniuriam quam ulcisci! Multum temporis ultio absumit, multis se iniuriis obicit dum una dolet; diutius irascimur omnes quam laedimur. Quanto melius est abire in diversum nec vitia vitiis opponere! Numquis satis constare sibi videatur, si mulam calcibus repetat et canem morsu? «Ista» inquis «peccare se nesciunt». Primum quam iniquus est apud quem hominem esse ad impetrandam veniam nocet! Deinde, si cetera animalia hoc irae tuae subducit quod consilio carent, eodem loco tibi sit quisquis consilio caret; quid enim refert an alia mutis dissimilia habeat, si hoc quod in omni peccato muta defendit simile habet, caliginem mentis? Peccavit: hoc enim primum? Hoc enim extremum? Non est quod illi credas, etiam si dixerit: «Iterum non faciam» et iste peccabit et in istum alius et tota vita inter errores volutabitur. Mansuete immansueta tractanda sunt. Quod in luctu dici solet efficacissime, et in ira dicetur: utrum aliquando desines an numquam? Si aliquando, quanto satius est iram relinquere quam ab ira relinqui! An semper haec agitatio permanebit? Vides quam inpacatam tibi denunties vitam? Qualis enim erit semper tumentis? Adice nunc quod, cum bene te ipse succenderis et subinde causas quibus stimuleris renovaveris, sua sponte ira discedet et vires illi dies subtrahet: quanto satius est a te illam vinci quam a se! 28. Huic irasceris, deinde illi; servis, deinde libertis; parentibus, deinde liberis; notis, deinde ignotis: ubique enim causae supersunt nisi deprecator animus accessit. Hinc te illo furor rapiet, illinc alio, et novis subinde irritamentis orientibus continuabitur rabies: age, infelix, ecquando amabis? O quam bonum tempus in re mala perdis! Quanto nunc erat satius amicos parare, inimicos mitigare, rem publicam administrare, transferre in res domesticas operam, quam circumspicere quid alicui facere possis mali, quod aut dignitati eius aut patrimonio aut corpori vulnus infligas, cum id tibi contingere sine certamine ac periculo non possit, etiam si cum inferiore concurses! Vinctum licet accipias et ad arbitrium tuum omni patientiae expositum: saepe nimia vis caedentis aut articulum loco movit aut nervum in iis quos fregerat dentibus fixit; multos iracundia mancos, multos debiles fecit, etiam ubi patientem est nancta materiam. Adice nunc quod nihil tam imbecille natum est ut sine elidentis periculo pereat: imbecillos valentissimis alias dolor, alias casus exaequat. Quid quod pleraque
eorum propter quae irascimur offendunt nos magis quam laedunt? Multum autem interest utrum aliquis voluntati meae obstet an desit, eripiat an non det. Atqui in aequo ponimus utrum aliquis auferat an neget, utrum spem nostram praecidat an differat, utrum contra nos faciat an pro se, amore alterius an odio nostri. Quidam vero non tantum iustas causas standi contra nos sed etiam honestas habent: alius patrem tuetur, alius fratrem, alius patriam, alius amicum; his tamen non ignoscimus id facientibus quod nisi facerent improbaremus, immo, quod est incredibile, saepe de facto bene existimamus, de faciente male. At mehercules vir magnus ac iustus fortissimum quemque ex hostibus suis et pro libertate ac salute patriae pertinacissimum suspicit et talem sibi civem, talem militem contingere optat. 29. Turpe est odisse quem laudes; quanto vero turpius ob id aliquem odisse propter quod misericordia dignus est, si captivus in servitutem subito depressus reliquias libertatis tenet nec ad sordida ac laboriosa ministeria agilis occurrit, si ex otio piger equum vehiculumque domini cursu non exaequat, si inter cotidiana pervigilia fessum somnus oppressit, si rusticum laborem recusat aut non fortiter obiit a servitute urbana et feriata translatus ad durum opus! Distinguamus utrum aliquis non possit an nolit: multos absolvemus, si coeperimus ante iudicare quam irasci. Nunc autem primum impetum sequimur, deinde, quamvis vana nos concitaverint, perseveramus, ne videamur coepisse sine causa, et, quod iniquissimum est, pertinaciores nos facit iniquitas irae; retinemus enim illam et augemus, quasi argumentum sit iuste irascentis graviter irasci. 30. Quanto melius est initia ipsa perspicere quam levia sint, quam innoxia! Quod accidere vides animalibus mutis, idem in homine deprendes: frivolis turbamur et inanibus. Taurum color rubicundus excitat, ad umbram aspis exsurgit, ursos leonesque mappa proritat: omnia quae natura fera ac rabida sunt consternantur ad vana. Idem inquietis et stolidis ingeniis evenit: rerum suspicione feriuntur, adeo quidem ut interdum iniurias vocent modica beneficia, in quibus frequentissima, certe acerbissima iracundiae materia est. Carissimis enim irascimur quod minora nobis praestiterint quam mente concepimus quamque alii tulerunt, cum utriusque rei paratum remedium sit. Magis alteri indulsit: nostra nos sine comparatione delectent, numquam erit felix quem torquebit felicior. Minus habeo quam speravi: sed fortasse plus speravi quam debui. Haec pars maxime metuenda est, hinc perniciosissimae irae nascuntur et sanctissima quaeque invasurae. Divum Iulium plures amici confecerunt quam inimici, quorum non expleverat spes inexplebiles. Voluit quidem ille (neque enim quisquam liberalius victoria usus est, ex qua nihil sibi vindicavit nisi dispensandi potestatem) sed quemadmodum sufficere tam improbis desideriis posset, cum tantum omnes concupiscerent quantum unus poterat? Vidit itaque strictis circa sellam suam gladiis commilitones suos, Cimbrum Tillium, acerrimum paulo ante partium
defensorem, aliosque post Pompeium demum Pompeianos. Haec res sua in reges arma convertit fidissimosque eo compulit ut de morte eorum cogitarent pro quibus et ante quos mori votum habuerant. 31. Nulli ad aliena respicienti sua placent: inde dis quoque irascimur quod aliquis nos antecedat, obliti quantum hominum retro sit et paucis invidentem quantum sequatur a tergo ingentis invidiae. Tanta tamen importunitas hominum est ut, quamvis multum acceperint, iniuriae loco sit plus accipere potuisse. «Dedit mihi praeturam, sed consulatum speraveram; dedit duodecim fasces, sed non fecit ordinarium consulem; a me numerari voluit annum, sed deest mihi ad sacerdotium; cooptatus in collegium sum, sed cur in unum? Consummavit dignitatem meam, sed patrimonio nihil contulit: ea dedit mihi quae debebat alicui dare, de suo nihil protulit». Age potius gratias pro his quae accepisti; reliqua expecta et nondum plenum esse te gaude: inter voluptates est superesse quod speres. Omnes vicisti: primum esse te in animo amici tui laetare. Multi te vincunt: considera quanto antecedas plures quam sequaris. Quod sit in te vitium maximum quaeris? Falsas rationes conficis: data magno aestimas, accepta parvo. 32. Aliud in alio nos deterreat: quibusdam timeamus irasci, quibusdam vereamur, quibusdam fastidiamus. Magnam rem sine dubio fecerimus, si servulum infelicem in ergastulum miserimus! Quid properamus verberare statim, crura protinus frangere? Non peribit potestas ista, si differetur. Sine id tempus veniat quo ipsi iubeamus: nunc ex imperio irae loquemur; cum illa abierit, tunc videbimus quanto ista lis aestimanda sit. In hoc enim praecipue fallimur: ad ferrum venimus, ad capitalia supplicia, et vinculis carcere fame vindicamus rem castigandam flagris levioribus. «Quomodo» inquis «nos iubes intueri quam omnia per quae laedi videamur exigua misera puerilia sint!». Ego vero nihil magis suaserim quam sumere ingentem animum et haec propter quae litigamus discurrimus anhelamus videre quam humilia et abiecta sint, nulli qui altum quiddam aut magnificum cogitat respicienda. 33. Circa pecuniam plurimum vociferationis est: haec fora defetigat, patres liberosque committit, venena miscet, gladios tam percussoribus quam legionibus tradit, haec est sanguine nostro dilibuta, propter hanc uxorum maritorumque noctes strepunt litibus et tribunalia magistratuum premit turba, reges saeviunt rapiuntque et civitates longo saeculorum labore constructas evertunt ut aurum argentumque in cinere urbium scrutentur. Libet intueri fiscos in angulo iacentis: hi sunt propter quos oculi clamore exprimantur, fremitu iudiciorum basilicae resonent, evocati ex longinquis regionibus iudices sedeant iudicaturi utrius iustior avaritia sit. Quid si ne propter fiscum quidem sed pugnum aeris aut imputatum a servo denarium senex sine
herede moriturus stomacho dirrumpitur? Quid si propter usuram vel milesimam valetudinarius fenerator distortis pedibus et manibus ad computandum non relictis clamat ac per vadimonia asses suos in ipsis morbi accessionibus vindicat? Si totam mihi ex omnibus metallis quae cum maxime deprimimus pecuniam proferas, si in medium proicias quicquid thesauri tegunt, avaritia iterum sub terras referente quae male egesserat, omnem istam congeriem non putem dignam quae frontem viri boni contrahat. Quanto risu prosequenda sunt quae nobis lacrimas educunt! 34. Cedo nunc, persequere cetera, cibos potiones horumque causa paratas in ambitionem munditias, verba contumeliosa, motus corporum parum honorificos, contumacia iumenta et pigra mancipia, et suspiciones et interpretationes malignas vocis alienae, quibus efficitur ut inter iniurias naturae numeretur sermo homini datus: crede mihi, levia sunt propter quae non leviter excandescimus qualiaque pueros in rixam et iurgium concitant. Nihil ex iis quae tam tristes agimus serium est, nihil magnum: inde, inquam, vobis ira et insania est, quod exigua magno aestimatis. Auferre hic mihi hereditatem voluit; hic me diu in spem supremam captato criminatus est; hic scortum meum concupivit: quod vinculum amoris esse debebat seditionis atque odi causa est, idem velle. Iter angustum rixas transeuntium concitat, diffusa et late patens via ne populos quidem conlidit: ista quae appetitis, quia exigua sunt nec possunt ad alterum nisi alteri erepta transferri, eadem affectantibus pugnas et iurgia excitant. 35. Respondisse tibi servum indignaris libertumque et uxorem et clientem: deinde idem de re publica libertatem sublatam quereris quam domi sustulisti. Rursus, si tacuit interrogatus, contumaciam vocas. Et loquatur et taceat et rideat! «Coram domino?» inquis. Immo coram patre familiae. Quid clamas? Quid vociferaris? Quid flagella media cena petis quod servi loquuntur, quod non eodem loco turba contionis est, silentium solitudinis? In hoc habes aures, ut non modulata tantum et mollia et ex dulci tracta compositaque accipiant: et risum audias oportet et fletum, et blanditias et lites, et prospera et tristia, et hominum voces et fremitus animalium latratusque. Quid miser expavescis ad clamorem servi, ad tinnitum aeris aut ianuae inpulsum? Cum tam delicatus fueris, tonitrua audienda sunt. Hoc quod de auribus dictum est transfer ad oculos, qui non minus fastidio laborant si male instituti sunt: macula offenduntur et sordibus et argento parum splendido et stagno non ad solum perlucente. Hi nempe oculi, qui non ferunt nisi varium ac recenti cura nitens marmor, qui mensam nisi crebris distinctam venis, qui nolunt domi nisi auro pretiosiora calcare, aequissimo animo foris et scabras lutosasque semitas spectant et maiorem partem occurrentium squalidam, parietes insularum exesos rimosos inaequales. Quid ergo aliud est quod illos in publico non offendat, domi moveat, quam opinio illic aequa et patiens, domi morosa et
querula? 36. Omnes sensus perducendi sunt ad firmitatem: natura patientes sunt, si animus illos desit corrumpere, qui cotidie ad rationem reddendam vocandus est. Faciebat hoc Sextius, ut consummato die, cum se ad nocturnam quietem recepisset, interrogaret animum suum: «Quod hodie malum tuum sanasti? Cui vitio obstitisti? Qua parte melior es?». Desinet ira et moderatior erit quae sciet sibi cotidie ad iudicem esse veniendum. Quicquam ergo pulchrius hac consuetudine excutiendi totum diem? Qualis ille somnus post recognitionem sui sequitur, quam tranquillus, quam altus ac liber, cum aut laudatus est animus aut admonitus et speculator sui censorque secretus cognovit de moribus suis! Utor hac potestate et cotidie apud me causam dico. Cum sublatum e conspectu lumen est et conticuit uxor moris iam mei conscia, totum diem meum scrutor factaque ac dicta mea remetior; nihil mihi ipse abscondo, nihil transeo. Quare enim quicquam ex erroribus meis timeam, cum possim dicere: «Vide ne istud amplius facias, nunc tibi ignosco. In illa disputatione pugnacius locutus es: noli postea congredi cum imperitis; nolunt discere qui numquam didicerunt. Illum liberius admonuisti quam debebas, itaque non emendasti sed offendisti: de cetero vide, non tantum an verum sit quod dicis, sed an ille cui dicitur veri patiens sit: admoneri bonus gaudet, pessimus quisque rectorem asperrime patitur. 37. In convivio quorundam te sales et in dolorem tuum iacta verba tetigerunt: vitare vulgares convictus memento; solutior est post vinum licentia, quia ne sobriis quidem pudor est. Iratum vidisti amicum tuum ostiario causidici alicuius aut divitis quod intrantem summoverat, et ipse pro illo iratus extremo mancipio fuisti: irasceris ergo catenario cani? Et hic, cum multum latravit, obiecto cibo mansuescit. Recede longius et ride! Nunc iste se aliquem putat quod custodit litigatorum turba limen obsessum nunc ille qui intra iacet felix fortunatusque est et beati hominis iudicat ac indicium difficilem ianuam: nescit durissimum esse ostium carceris. Praesume animo multa tibi esse patienda: numquis se hieme algere miratur? Numquis in mari nausiare, in via concuti? Fortis est animus ad quae praeparatus venit. Minus honorato loco positus irasci coepisti convivatori, vocatori, ipsi qui tibi praeferebatur: demens, quid interest quam lecti premas partem? Honestiorem te aut turpiorem potest facere pulvinus? Non aequis quendam oculis vidisti, quia de ingenio tuo male locutus est: recipis hanc legem? Ergo te Ennius, quo non delectaris, odisset et Hortensius simultates tibi indiceret et Cicero, si derideres carmina eius, inimicus esset. Vis tu aequo animo pati candidatus suffragia!». 38. Contumeliam tibi fecit aliquis: numquid maiorem quam Diogeni philosopho Stoico, cui de ira cum maxime disserenti adulescens protervus inspuit? Tulit hoc ille leniter et sapienter: «Non quidem» inquit «irascor, sed
dubito tamen an oporteat irasci». Quanto Cato noster melius! Qui cum agenti causam in frontem mediam quantum poterat attracta pingui saliva inspuisset Lentulus ille patrum nostrorum memoria factiosus et inpotens, abstersit faciem et «Adfirmabo» inquit «omnibus, Lentule, falli eos qui te negant os habere». 39. Contigit iam nobis, Novate, bene componere animum: aut non sentit iracundiam aut superior est. Videamus quomodo alienam iram leniamus; nec enim sani esse tantum volumus, sed sanare. Primam iram non audebimus oratione mulcere: surda est et amens; dabimus illi spatium. Remedia in remissionibus prosunt; nec oculos tumentis temptamus vim rigentem movendo incitaturi, nec cetera vitia dum fervent: initia morborum quies curat. «Quantulum» inquis «prodest remedium tuum, si sua sponte desinentem iram placat!». Primum, ut citius desinat efficit; deinde custodit, ne recidat; ipsum quoque impetum, quem non audet lenire, fallet: removebit omnia ultionis instrumenta, simulabit iram ut tamquam adiutor et doloris comes plus auctoritatis in consiliis habeat, moras nectet et, dum maiorem poenam quaerit, praesentem differet. Omni arte requiem furori dabit: si vehementior erit, aut pudorem illi cui non resistat incutiet aut metum; si infirmior, sermones inferet vel gratos vel novos et cupiditate cognoscendi avocabit. Medicum aiunt, cum regis filiam curare deberet nec sine ferro posset, dum tumentem mammam leniter fovet, scalpellum spongea tectum induxisse: repugnasset puella remedio palam admoto, eadem, quia non expectavit, dolorem tulit. Quaedam non nisi decepta sanantur. 40. Alteri dices: «Vide ne inimicis iracundia tua voluptati sit», alteri: «Vide ne magnitudo animi tui creditumque apud plerosque robur cadat. Indignor mehercules et non invenio dolendi modum, sed tempus exspectandum est; dabit poenas. Serva istud in animo tuo: cum potueris, et pro mora reddes». Castigare vero irascentem et ultro obirasci incitare est: varie adgredieris blandeque, nisi forte tanta persona eris ut possis iram comminuere, quemadmodum fecit divus Augustus, cum cenaret apud Vedium Pollionem. Fregerat unus ex servis eius crustallinum: rapi eum Vedius iussit ne vulgari quidem more periturum: murenis obici iubebatur, quas ingentis in piscina continebat. Quis non hoc illum putaret luxuriae causa facere? Saevitia erat. Evasit e manibus puer et confugit ad Caesaris pedes, nihil aliud petiturus quam ut aliter periret, ne esca fieret. Motus est novitate crudelitatis Caesar et illum quidem mitti, crustallina autem omnia coram se frangi iussit complerique piscinam. Fuit Caesari sic castigandus amicus; bene usus est viribus suis. «E convivio rapi homines imperas et novi generis poenis lancinari? Si calix tuus fractus est, viscera hominis distrahentur? Tantum tibi placebis ut ibi aliquem
duci iubeas ubi Caesar est?». Sic cui tantum potentiae est ut iram ex superiore loco adggredi possit, male tractet, at talem dumtaxat qualem modo rettuli, feram immanem sanguinariam, quae iam insanabilis est nisi maius aliquid extimuit. 41. Pacem demus animo quam dabit praeceptorum salutarium adsidua meditatio actusque rerum boni et intenta mens ad unius honesti cupiditatem. Conscientiae satis fiat, nil in famam laboremus: sequatur vel mala, dum bene merentis. «At vulgus animosa miratur et audaces in honore sunt, placidi pro inertibus habentur». Primo forsitan aspectu; sed simul aequalitas vitae fidem fecit non segnitiem illam animi esse sed pacem, veneratur illos populus idem colitque. Nihil ergo habet in se utile taeter iste et hostilis affectus, at omnia ex contrario mala, ferrum et ignes. Pudore calcato caedibus inquinavit manus, membra liberorum dispersit, nihil vacuum reliquit a scelere, non gloriae memor, non infamiae metuens, inemendabilis cum ex ira in odium obcalluit. 42. Careamus hoc malo purgemusque mentem et exstirpemus radicitus quae quamvis tenuia undecumque haeserint renascentur, et iram non temperemus sed ex toto removeamus (quod enim malae rei temperamentum est)? Poterimus autem, adnitamur modo. Nec ulla res magis proderit quam cogitatio mortalitatis. Sibi quisque atque alteri dicat: «Quid iuvat tamquam in aeternum genitos iras indicere et brevissimam aetatem dissipare? Quid iuvat dies quos in voluptatem honestam inpendere licet in dolorem alicuius tormentumque transferre? Non capiunt res istae iacturam nec tempus vacat perdere. Quid ruimus in pugnam? Quid certamina nobis arcessimus? Quid imbecillitatis obliti ingentia odia suscipimus et ad frangendum fragiles consurgimus? Iam istas inimicitias quas implacabili gerimus animo febris aut aliquod aliud malum corporis vetabit geri; iam par acerrimum media mors dirimet. Quid tumultuamur et vitam seditiosi conturbamus? Stat supra caput fatum et pereuntis dies imputat propiusque ac propius accedit, istud tempus quod alienae destinas morti fortasse circa tuam est. 43. Quin potius vitam brevem colligis placidamque et tibi et ceteris praestas? Quin potius amabilem te dum vivis omnibus, desiderabilem cum excesseris reddis? Quid illum nimis ex alto tecum agentem detrahere cupis? Quid illum oblatrantem tibi, humilem quidem et contemptum sed superioribus acidum ac molestum, exterere viribus tuis temptas? Quid servo, quid domino, quid regi, quid clienti tuo irasceris? Sustine paulum: venit ecce mors quae vos pares faciat. Videre solemus inter matutina harenae spectacula tauri et ursi pugnam inter se conligatorum, quos, cum alter alterum vexarunt, suus confector expectat: idem facimus, aliquem nobiscum adligatum lacessimus, cum victo victorique finis et quidem maturus immineat. Quieti potius pacatique quantulumcumque superest
exigamus! Nulli cadaver nostrum iaceat invisum. Saepe rixam conclamatum in vicinia incendium solvit et interventus ferae latronem viatoremque diducit: conluctari cum minoribus malis non vacat, ubi metus maior apparuit. Quid nobis cum dimicatione et insidiis? Numquid amplius isti cui irasceris quam mortem optas? Etiam te quiescente morietur. Perdis operam: facere vis quod futurum est. «Nolo» inquis «utique occidere, sed exilio, sed ignominia, sed damno adficere». Magis ignosco ei qui vulnus inimici quam qui pusulam concupiscit; hic enim non tantum mali animi est sed pusilli. Sive de ultimis suppliciis cogitas sive de levioribus, quantulum est temporis quo aut ille poena sua torqueatur aut tu malum gaudium ex aliena percipias! Iam istum spiritum expuemus. Interim, dum trahimus, dum inter homines sumus, colamus humanitatem; non timori cuiquam, non periculo simus; detrimenta iniurias, convicia vellicationes contemnamus et magno animo brevia feramus incommoda: dum respicimus, quod aiunt, versamusque nos, iam mortalitas aderit».
L’arte di non adirarsi
Premessa Dedicato al fratello maggiore L. Anneo Novato (che prenderà in seguito il nome di Giunio Gallione dal retore che lo adotterà), il De ira è una delle prime opere di Seneca. Il punto di partenza è l’affermazione aprioristica che l’ira è una passione naturale solo nel suo moto iniziale, nella reazione immediata e istintiva di chi è stato o si è sentito offeso, alla quale non può sottrarsi neppure il saggio, che però riesce a trattenersi e a non infierire su chi ha recato l’offesa. Come Platone, ad esempio, che adiratosi contro uno schiavo incaricò un altro di bastonarlo perché lui l’avrebbe picchiato più del giusto. Quanto a Plutarco si racconta che un giorno, mentre faceva frustare uno schiavo, questi gli rinfacciò quello scatto d’ira, ricordandogli come biasimasse nei suoi scritti quel sentimento, al che lui, calmo e candido rispose: «Ho forse il viso infiammato? Mi è forse sfuggita una parola di cui debba vergognarmi? Sono questi i segni dell’ira che non si convengono agli uomini saggi». E poiché l’aguzzino nel frattempo s’era fermato gli disse: «Continua pure il tuo ufficio, mentre io e costui discutiamo». Sarebbe comunque stolto quel saggio che di fronte all’aggressione mortale o al rapimento di un suo familiare, trovandosi solo, se ne stesse imperturbabile senza muovere un dito. Del resto l’amore per il Padre suo non spinse Cristo ad adirarsi contro i mercanti che ne profanavano il tempio, a prenderli a frustate rovesciando i banchi con tutte le merci? L’ira vera, prosegue Seneca, viene in un secondo tempo, quando si passa all’offensiva, quando minacciamo, insultiamo e aggrediamo fisicamente chi ci ha offeso. Come dire che in un primo momento l’ira ha ragione, in quanto chi riceve l’offesa non può non risentirsi, e successivamente ha torto. Il fatto è che Seneca considera lo spirito (e in ciò si accosta alla visione cristiana) come un’entità distinta e divisa dal corpo, che possa quindi padroneggiarlo; ma al tempo stesso giudica il vizio come una schiavitù dello spirito. Per lui, quali che siano le condizioni fisiche di un uomo, il suo spirito, se vuole, può e quindi deve conservare la più lucida e tranquilla padronanza di sé. In realtà le cose non stanno così. A quella padronanza si può arrivare a sessanta, a ottant’anni, ma allora non è tanto la ragione che si rafforza quanto la passione che s’indebolisce, a causa della vecchiaia. La parte più interessante del dialogo è l’analisi che l’Autore fa dei fenomeni interiori dell’iracondo, a cui si aggiungono i consigli pratici e l’atteggiamento che si deve avere nel giudicare i colpevoli e nell’infliggere le pene. Nel punire un malfattore – spiega Seneca a Novato – non si deve essere adirati, giacché se l’ira è un vizio dell’animo non è giusto correggere un errore con un altro errore. La pena, poi, dev’essere considerata come una medicina e perciò adattata a ogni singolo caso, per cui se il reo è un principiante basterà un rimprovero, prima in privato e successivamente in pubblico, se è andato troppo avanti per poter essere guarito con una semplice ammonizione ci vorrà la gogna, poi l’esilio in luoghi lontani e sconosciuti, la prigione con le catene e infine, se il reo ha la malvagità talmente diffusa nel sangue e radicata nelle viscere e lui stesso pensa di farla finita, bisognerà dargli l’unica cosa buona che gli rimane: la morte. «Sì, la morte», conclude Seneca. «Perché dovrei essere adirato con uno a cui posso dispensare un così grande bene? Talvolta uccidere è la più alta forma di pietà». I delitti, dice Seneca, sono una conseguenza dell’ira, quindi l’ira è da condannarsi; ma nel malfattore si deve colpire non tanto la persona quanto il male stesso. Così a proposito di Caligola, dopo averne elencato i più atroci misfatti (faceva frustare i senatori con le verghe, li torturava con gli strumenti più terribili, corde, stringicaviglie, cavalletti e carboni accesi, e ordinava di uccidere anche i padri dei condannati perché così, diceva, li liberava dal dolore per la morte dei figli), aggiunge di aver voluto descrivere non tanto la crudeltà di Caligola quanto quella dell’ira. In questo suo atteggiamento nei confronti dei delitti e delle pene, Seneca anticipa Cesare Beccaria e quanti, positivisti o no, riversano sull’ambiente o sulla società la responsabilità di chi commette il male (cancellando di fatto il libero arbitrio, ma continuando a parlare di libertà). Dopo aver detto che chi ha il compito di punire deve fare come il medico o come chi governa una città, che non prescrive gli stessi rimedi a tutti, così continua:
Se io dovessi indossare la toga scura del magistrato e convocare con squilli di tromba l’assemblea, mi recherei in tribunale non con aria furiosa e ostile, ma col volto della legge, pronuncerei le formule di rito con voce calma e grave, non piena di rabbia, ordinerei che si proceda con tono severo ma non adirato. E quando dovessi imporre di tagliare la testa a un criminale, di cucire in un sacco un parricida, d’infliggere il supplizio militare, o di gettare dalla rupe Tarpeia un traditore o un nemico dello Stato, non sarei spinto dall’ira ma manterrei lo stesso animo e lo stesso volto di quando abbatto un serpente velenoso o un altro animale del genere. Poi, come Novato obietta che per punire bisogna pur essere adirati, risponde che l’uomo virtuoso potrà provare un lieve turbamento, perché anche nel saggio, quando la ferita si è rimarginata, resta la cicatrice. Ma sarà solo un sospetto, come l’ombra di una passione, come un fantasma, nient’altro. Nel De constantia sapientis Seneca paragona il saggio a quei corpi che il fuoco non riesce a distruggere, all’acciaio, contro cui si spuntano gli attrezzi che cercano di scalfirlo, o ancora a certi scogli che, per quanto flagellati per secoli dalle onde, non mostrano alcuna traccia della loro violenza. Le offese, aggiunge, le fanno gli sprovveduti e perciò non possono essere prese in considerazione, così come non si ritengono offensive le parole ingiuriose di un bambino. Cita poi Socrate, che accettò di buon animo e ridendovi sopra gli scherzi salaci rivoltigli nelle commedie, mostrandosi non meno tollerante di quando la moglie Santippe gli rovesciò addosso un secchio d’acqua sporca. E consiglia di tenere nello stesso conto sia le ingiurie che le lodi provenienti dal volgo, senza dolersi delle une e rallegrarsi delle altre. Le offese, dice, le parole oltraggiose, le infamie e tutti gli altri simili affronti vanno sopportati come si sopportano le urla dei nemici, i dardi scagliati da troppo lontano, e perciò meno pericolosi, come i sassi che crepitano sull’elmo senza recare alcuna ferita. Naturalmente non sempre Seneca è coerente coi consigli che dà, se solo si pensa che sfogò la sua ira contro l’imperatore Claudio, ch’era appena morto, scrivendo l’ Apocolocintosi, in cui, dopo aver esordito dicendo di voler consegnare alla memoria dei posteri il giorno di quell’evento, «inizio di un’epoca fortunatissima», aggiunge: «Non sarà fatta alcuna concessione né all’offesa né alla compiacenza: queste cose sono vere così». Poi dà del «cretino» a Claudio (sia pure per bocca di Ercole), dice che gli dèi non capiscono il suo strano linguaggio e che non sono nemmeno certi ch’egli sia un essere umano, lo fa giocare ai dadi con un bussolotto bucato e alla fine lo fa diventare schiavo di un liberto. Ma ciò non toglie valore al suo insegnamento. Già nel 1878 Nietzsche in Umano, troppo umano scriveva: «Bisogna confessare che il nostro tempo è povero di grandi moralisti, che Pascal, Epittèto, Seneca, Plutarco sono poco letti, che lavoro e attività – normalmente al seguito della gran dea Salute – sembrano a volte infuriare come una malattia. Poiché manca il tempo per pensare e la calma nel pensare, non si medita più sulle opinioni divergenti: ci si accontenta di odiarle». Il fine di ogni uomo dovrebbe essere la saggezza, la quale non consiste nel chiudere la porta alle passioni, in una aprioristica e sterile imperturbabilità: lo spirito progredisce non tanto nell’elevarsi, quanto nel chiarire tutto ciò che l’ingombra. È vero, chi si metta su questa strada in un primo tempo invece della luce scoprirà le tenebre, invece della pace troverà la guerra, ma è solo così che la vita si trasforma davvero, altrimenti, come dice un grande saggio, «resteremo a poetare e a spiritualizzare sulle cime, mentre al di sotto la vita traballa». M. S. A.
Libro primo 1. Caro Novato, il fatto che tu mi chieda come si possa placare l’ira è segno che temi in modo particolare, e giustamente, questa passione, che è la più sfrenata e la più spaventosa di tutte. Le altre, infatti, offrono almeno qualche spiraglio di calma e di respiro, mentre l’ira è tutta foga, come un’esplosione impetuosa e incontenibile di rabbia, una furia disumana assetata di battaglie e di
sangue, che pur di nuocere agli altri non esita a far del male a sé stessa con le sue stesse armi, avida di una vendetta che finisce col travolgere anche il vendicatore. Perciò alcuni saggi definiscono l’ira una breve follia1 perché anch’essa non sa dominarsi, dimentica ogni decoro, infrange i legami sociali, ostinata e decisa a portare a termine quel che ha intrapreso, chiusa alla voce della ragione e a qualsiasi consiglio, pronta a scattare al più futile motivo, incapace di distinguere il vero e il giusto, simile a quelle macerie che crollano e si sgretolano su ciò che hanno travolto. Per capire che uno preso dall’ira è uscito di senno basta guardarlo, poiché presenta gli stessi e indubitabili sintomi della follia: come il pazzo ha un’espressione insolente e minacciosa, la fronte accigliata, lo sguardo torvo, il passo nervoso, le mani irrequiete, il colorito alterato, il respiro affannoso e frequente, così l’adirato ha gli occhi accesi e fiammeggianti, il viso arrossato per via del sangue che sale e ribolle fin dai precordi, le labbra tremanti, i denti serrati, ispidi e dritti i capelli, il respiro faticoso e stridente, le articolazioni contorte e scricchiolanti, la voce spezzata e confusa mista di gemiti e brontolii, frequenti colpi delle mani, un pestar la terra coi piedi, mentre dal corpo tutto eccitato «schizzano grandi e minacciosi segnali»:2 turpe e orrendo è l’aspetto di un uomo sfigurato dall’ira. Tu non puoi sapere se questo vizio sia più detestabile o più vergognoso: gli altri si possono nascondere e coltivare in segreto, l’ira, invece, si mostra, prorompe sul viso, e quanto più è grande tanto più palesemente avvampa. Guarda gli animali: prima di assalire la preda mandano dei cenni, il corpo perde il consueto atteggiamento tranquillo, la loro bestialità tocca le punte più alte. I cinghiali schiumano dalla bocca e aguzzano i denti affilandoli, i tori dànno cornate nel vuoto e con lo zoccolo raspano e spargono la sabbia, i leoni fremono, i serpenti, irritati, gonfiano il collo, le cagne, rabbiose, assumono un aspetto malvagio: non c’è insomma animale, fra quelli terribili e pericolosi, che quando è in preda all’ira non manifesti un ulteriore aumento di ferocia. So bene che anche le altre passioni si fa fatica a tenerle nascoste, che la libidine, la paura, l’audacia hanno anch’esse i loro sintomi e si possono prevedere: non c’è infatti emozione, quando sia viva e intensa, che non alteri i lineamenti del volto. Qual è allora la differenza? Le altre passioni si vedono, l’ira risalta. 2. Se poi vuoi renderti conto dei suoi effetti rovinosi, sappi che nessuna peste ha procurato più danni all’umanità: stragi, avvelenamenti, accuse reciproche e infamanti, saccheggi, genocidi, teste di re e di personaggi eccellenti messe all’asta e vendute, case bruciate, incendi non solo dentro le mura cittadine ma in territori immensi balenanti di fiamme nemiche. Guarda le fondamenta di città famosissime riconoscibili a stento: è l’ira che le ha distrutte; guarda quante distese deserte per miglia e miglia senza un solo abitante: è l’ira che le ha spopolate; guarda quanti condottieri passati alla storia come esempi di un destino
funesto ha fatto fuori l’ira: uno lo ha pugnalato nel letto, un altro mentre banchettava, violando le sacre leggi dell’ospitalità, un altro lo ha sbranato nel foro zeppo di folla quando ancora il processo non si era concluso,3 un altro lo ha trucidato per mano del figlio parricida, un altro lo ha spinto a offrire la gola regale alla lama di uno schiavo, un altro a spaccarsi le membra sulla croce. E ho parlato solo di supplizi individuali: che penserai se da questi volgi lo sguardo su intere assemblee passate a fìl di spada, su plebi trucidate da soldataglie sfrenate, su intere popolazioni condannate a una morte sommaria?…4 … come se cessassero di occuparsi di noi o non tenessero in alcun conto la nostra autorità. E che dire del popolo che inveisce contro i gladiatori e così iniquamente da ritenersi offeso quando non accettano di buon grado la morte? Si sente sminuito e da spettatore, col volto, col gesto e tutto preso dall’eccitazione, si trasforma in nemico. Fatti di questo genere, tuttavia, non sono attribuibili propriamente all’ira: sono dovuti piuttosto a una specie di ira, simile a quella dei bambini che quando cadono vogliono che si picchi la terra e spesso non sanno nemmeno con chi arrabbiarsi, si adirano così, senza un motivo, senza aver ricevuto alcun affronto, e però si comportano come se fossero stati offesi e nutrissero non so che desiderio di vendetta. Perciò i familiari li placano picchiando con finte percosse la terra e simulando lacrime di scusa: un falso castigo pone fine a un cruccio inconsistente. 3. «Spesso, però, ci adiriamo non con chi ci ha offeso ma con chi sta per farlo, dunque l’ira non nasce necessariamente da un’offesa». È vero, ma chi dimostra di volerci offendere in realtà ci offende per il solo fatto che lo vuole, quindi l’offesa è già nell’intenzione. «Ma allora l’ira non consiste nell’impulso di punire chi ci ha offeso, visto che i più deboli si adirano con i potenti ma non per questo pensano d’infliggere loro una punizione, anzi, non lo sperano nemmeno». Io ho detto che l’ira nasce dal desiderio di vendicare l’offesa, non che ne abbia in concreto la capacità. E poi, come niente può impedire a uno di desiderare anche cose che non può ottenere, così non c’è uomo per quanto debole o di infime condizioni che non coltivi almeno l’idea di punire chi l’ha ingiuriato, fosse anche la persona più potente del mondo: tutti, infatti, siamo pronti a far del male. Aristotele dà dell’ira una spiegazione che non è poi tanto diversa, quando dice che l’ira è desiderio di ricambiare il male.5 Io non voglio sottilizzare sulla differenza fra la sua definizione e la mia, anche perché sarebbe un discorso troppo lungo. Dico solo che a entrambe viene mossa l’obiezione che le bestie si infuriano anche senza essere state offese e che non intendono infliggere ad altri un castigo o un dolore: il fatto che lo provochino non significa che l’hanno voluto. Va però precisato che le bestie e tutti gli altri animali non conoscono l’ira, la quale, pur essendo nemica della ragione, nasce proprio e soltanto là dove c’è la ragione, ovverosia nell’uomo. Le bestie seguono l’istinto, sono
soggette a moti di rabbia, di ferocia, di aggressività, ma non all’ira, e tanto meno alla lussuria, anche se in certi piaceri sono più sfrenate dell’uomo. Non devi prendere alla lettera Ovidio quando dice: l’ira il cinghiale oblìa, non ardisce correre il cervo, più non muove l’orso incontro ai robusti giovenchi.6 Per ira egli intende l’eccitazione, lo slancio, perché le bestie ignorano l’ira, così come il perdono. Gli animali, che non hanno il dono della parola, non conoscono i sentimenti, diversamente, oltre all’amore e all’odio, dovrebbero avere amicizia e inimicizia, discordia e concordia e così via: è vero, alcuni loro istinti somigliano ai moti dell’animo umano e magari ne hanno pure qualche traccia, ma in ogni caso i sentimenti, nel bene come nel male, sono tipici dell’uomo. Solo a lui la natura ha concesso doti come la prudenza, la preveggenza, la diligenza, la riflessione, mentre gli animali sono immuni da virtù e da vizi, che sono appunto una prerogativa umana. La loro stessa struttura, sia esterna che interna, è diversa da quella dell’uomo: la voce è inarticolata e incapace di tradursi in parola, la lingua non è in grado di sciogliersi in vari movimenti, la facoltà che li regge e li governa è poco raffinata e poco sviluppata, per cui le immagini e le percezioni delle cose, che stimolano gl’impulsi, sono agitate e confuse. Per questo i loro slanci e i loro turbamenti hanno una certa dose di violenza, ma non sono né paure né angosce, né avvilimenti, né ire, anche se vi somigliano, e perciò cessano presto e si mutano nel loro contrario: da eccessivamente furibondi o spaventati gli animali tornano a pascolare e subito ai loro fremiti e alle loro folli corse subentrano il sonno e il riposo. 4. Da quanto sin qui detto risulta evidente che l’ira differisce dall’irascibilità nella misura in cui l’ubriaco si differenzia dall’ubriacone e l’impaurito dal pauroso. Chi monta in collera non ha necessariamente un carattere collerico, e chi è iroso per natura può talora non essere adirato. Non sto qui a elencarti tutte le suddivisioni che con diversi nomi i Greci fanno dell’ira, anche perché in latino non ci sono vocaboli corrispondenti; del resto pure noi usiamo aggettivi come “mordace”, “sgarbato”, “collerico”, “rabbioso”, “strillone”, “intrattabile”, “aspro”, che sono tutti aspetti diversi dall’ira vera e propria: fra questi puoi anche mettere “brontolone”, che è una specie raffinata di irascibilità. Ci sono infatti ire che si limitano alle grida, altre ostinate e frequenti, altre avare di parole ma di fatto violente; alcune si sfogano con l’asprezza delle offese verbali, altre non vanno al di là della protesta e del disgusto, altre ancora sono profonde, cupe, introverse: mille sono insomma le sottospecie di questo male multiforme. 5. A questo punto, esaurita la prima parte della nostra ricerca sull’ira – se sia un male esclusivo dell’uomo, in che differisca dall’irascibilità e in quali forme si manifesti – chiediamoci se sia compatibile con la nostra natura, se presenti
qualche utilità e se, sia pure in misura ridotta, dobbiamo per forza tenercela dentro. Per vedere se sia conforme alla nostra natura basterà osservare attentamente l’uomo. In condizioni normali egli è senza dubbio il più mite fra tutti gli esseri: l’ira, invece, è la cosa più crudele che ci sia. L’uomo è portato ad amare più di qualunque altro essere: l’ira è l’esatto contrario dell’amore. L’uomo soccorre i suoi simili, l’ira distrugge tutto, l’uomo unisce, l’ira divide, l’uomo vuole essere utile agli altri, l’ira vuol nuocere, l’uomo è portato a prestare aiuto anche a chi non conosce, l’ira si getta nel baratro, pur di travolgere gli altri. Chi, dunque, si allontana di più dalla natura se non colui che scarica su di lei questo feroce e dannosissimo vizio come se fosse la più bella e la più perfetta delle sue creazioni? La natura non poteva inculcare nel pacifico cuore dell’uomo una tale passione, avida di vendetta e di castigo: la vita umana è fondata sul bene e sulla concordia, stretta in un vincolo di alleanza e di mutuo soccorso, non già per paura, ma in forza di un vicendevole amore. 6. «Allora la punizione non è necessaria, qualche volta?». Come no! A condizione che sia inflitta senza animosità e a ragion veduta, con l’intento non di nuocere, ma di guarire, dando però l’impressione di voler fare del male. Come per raddrizzare i giavellotti storti li mettiamo sul fuoco e strettili fra due zeppe li distendiamo, ma senza spezzarli, così col dolore, fisico o morale, correggiamo i caratteri corrotti dal vizio. Anche il medico, quando siamo lievemente indisposti, in un primo tempo cerca di rispettare le nostre abitudini quotidiane, limitandosi a regolare il cibo, le bevande, la nostra attività fisica, in modo, insomma, da rafforzare la nostra salute mutando semplicemente il nostro tenore di vita: queste restrizioni producono subito un miglioramento. Ma se a un certo punto si accorge che la regola e la misura imposteci sono insufficienti a debellare il male allora ci riduce o ci toglie qualche altro alimento; se poi neppure così ottiene un risultato ci proibisce di mangiare affinché il nostro corpo si liberi con l’astinenza. Infine se questi rimedi piuttosto blandi si sono rivelati inefficaci ci fa un salasso, cioè incide una vena e opera manualmente su quelle membra che danneggiano le vicine diffondendovi il male: nessuna terapia risulta dura se il suo effetto è salutare.7 Analogamente chi tutela le leggi e governa una città deve curare l’indole del popolo, prima con le parole, in modo benevolo e mite, inducendolo al bene e instillandogli il desiderio dell’onestà e della giustizia, l’odio dei vizi e la stima delle virtù; successivamente usi pure un linguaggio severo, ammonendo e rimproverando, e alla fine faccia ricorso alle pene, limitandosi alle più lievi e revocabili, e adotti quella capitale solo in casi estremi per i delitti più gravi, a condizione, però, che nessuno sia messo a morte se tale pena non giova anche al condannato. L’unica differenza fra il medico e il governante sta nel fatto che il primo, quando non c’è alcuna possibilità di salvargli la vita, dispensa ai pazienti la morte, una morte dolce e serena, il secondo infligge ai condannati una morte
disonorevole ed esposta al pubblico scherno, e non perché ciò gli faccia piacere (il saggio è alieno da una così disumana ferocia), ma affinché un tale esempio costituisca un monito per tutti e lo Stato stesso possa trarre un giovamento sicuro dalla morte di quelle persone che non hanno voluto giovare ad alcuno. Se dunque l’uomo, per sua natura, non è portato a punire, ne consegue che l’ira, bramosa com’è di castigare, non è conforme alla natura umana. Per dimostrarlo riporterò un ragionamento di Platone (non è un delitto tirare in ballo altri quando concordano con noi). L’uomo buono – egli dice – non fa del male, punire uno significa fargli del male, dunque all’uomo buono non si addice il punire e di conseguenza neppure l’ira, perché l’ira è legata alla punizione.8 Così se l’uomo buono non gioisce del castigo, non gioirà neppure di quel sentimento che comporta il piacere di castigare: ergo, l’ira non è conforme alla natura. 7. «D’accordo, l’ira non si addice alla natura, ma non è comunque accettabile, visto che spesso risulta utile? Intanto ci esalta e ci sprona, e poi in guerra il coraggio senza la spinta dell’ira non compirebbe alcuna nobile impresa: è necessario, infatti, che quella fiamma si accenda, perché solo in virtù di tale stimolo si può osare e lanciarsi contro il nemico. Per questo alcuni ritengono che l’ira non sia da eliminare del tutto e che si debba piuttosto moderarla togliendone il superfluo e riducendone la misura a quel tanto che possa tornare utile per dare slancio all’azione e caricare gli animi di quella forza e di quel vigore che diversamente verrebbero a mancare». Ebbene: cominciamo col dire che è più facile eliminare le passioni pericolose piuttosto che controllarle, tenerle lontane piuttosto che governarle dopo averle lasciate entrare, perché se riescono a sfondare le porte dell’animo è segno che sono più forti di chi presume di poterle poi dominare, e non si lascerebbero estirpare o diminuire. E poi anche la ragione, che tiene in mano le redini, esercita in pieno il suo potere solo finché rimane staccata dalle passioni, ma una volta che ne sia stata contagiata non è più in grado di controllarle. La mente, infatti, può bloccare il male, ma quando questo sia riuscito a violentarla e a indebolirla diventa schiava delle sue sollecitazioni. Ci sono in noi delle forze su cui la natura ci ha dato un potere iniziale, ma che se abbandonate a sé stesse finiscono con l’afferrarci e non ci consentono di tornare indietro. Come un corpo che precipita perde il controllo di sé, né può arrestare o rallentare la caduta perché questa è irrevocabile e perciò rende inutile qualsiasi ripensamento e la possibilità di non finire là dove prima era possibile non arrivare, così l’animo, se si abbandona all’ira, all’amore sfrenato e ad altre simili passioni, non è più in grado di trattenerne l’impeto, per cui fatalmente il peso stesso del vizio, che per natura tende verso il basso, lo trascina a precipizio nel fondo. 8. La cosa migliore, dunque, è rintuzzare subito il primo assalto dell’ira,
attaccandola alle radici e facendo di tutto per non cadere nelle sue grinfie, perché se si comincia a sbandare diventa poi difficile rimettersi in carreggiata: nulla può infatti la ragione una volta che quella follia ci si è infilata nell’animo, occupando col nostro beneplacito un margine di potere: da quel momento farà ciò che vorrà lei, non quel che vorremo noi. Bisogna quindi tenere il nemico lontano dai confini, perché se oltrepassa le porte saremo suoi prigionieri e nessun patto sarà possibile con lui. L’animo non è un cantuccio isolato che guardi le passioni dall’esterno impedendo loro di avanzare più del necessario, ma ne assume esso stesso i connotati e perciò non può sperare alcun aiuto da quella forza utile e salutare che è la ragione, visto che anch’essa è contagiata dal male e ridotta pressoché all’impotenza: come ho già detto, passione e ragione non sono due entità distinte e separate, che dimorino in due sedi diverse, esse altro non sono che due aspetti dell’animo, che muta ora verso il meglio, ora verso il peggio. Come può dunque la ragione, espugnata e schiacciata dal vizio, riscattarsi dall’ira? In che modo si libererà una volta che si trovi impastata in un ibrido e confuso miscuglio di elementi in cui i peggiori la fanno da padroni? «Ma alcuni, pur posseduti dall’ira, riescono a controllarsi». Sì, ma il controllo non impedisce all’ira di operare in qualche misura. Se uno non fa nulla di ciò che l’impulso gli suggerisce evidentemente non è l’ira che lo spinge, quell’ira a cui poc’anzi si pretendeva di far ricorso per certe imprese come a una forza maggiore della ragione. E allora la domanda è questa: l’ira è più forte o più debole della ragione? Se è più forte quale regola può imporle la ragione quando di solito sono i più deboli a ubbidire? E se è più debole che motivo avrebbe la ragione di far ricorso a lei quando è in grado di sistemare tutto da sola? Non ha senso, dunque, sostenere che alcuni, pur se afferrati dall’ira, si controllano e si frenano: in questo caso è l’ira stessa che si è raffreddata, perché se fosse nel pieno del suo bollore sarebbe più forte. «Ma come? Non è forse vero che alcuni proprio quando sono al colmo dell’ira lasciano andare indenni e intatti quelli che odiano, astenendosi dal fargli del male?». È vero, ma questo avviene perché all’ira si è sovrapposta un’altra passione, e la brama o il timore si sono appagati: non è stata la ragione a placare l’ira, ma la tregua, subdola e falsa, delle passioni. 9. Fra l’altro l’ira non ha in sé niente di utile e non è vero che accende l’animo in guerra: sarebbe come dire che la virtù non può sussistere senza la presenza del vizio. Non è l’ira che provoca quegli slanci, è la virtù, che s’innalza, che si stimola o si acquieta, a seconda della necessità, come accade coi giavellotti, la cui gittata dipende da chi li scaglia o da come è regolata la macchina preposta a quello scopo. «Aristotele dice che in guerra l’ira è necessaria, che nessuna vittoria è possibile se quella fiamma non accende e non riempie l’animo infondendogli
coraggio, ma che bisogna servirsene come di un soldato, non come di un capo». Non è vero: se quell’impulso ascolta la ragione, e la segue colà dove lei lo porta, non è più ira, poiché la prerogativa dell’ira è l’ostinazione, il persistere nel suo proposito; se invece la contrasta e, lungi dal calmarsi e dall’obbedire, si lascia trascinare dalla sua sfrenata ferocia, è un aiutante inutile, come un soldato che non rispetti il segnale della ritirata. Perciò se quello stimolo accetta di sottostare a certe regole bisogna dargli un altro nome, perché – ripeto – non è ira, o cessa di essere quella furia sfrenata e indomabile di cui appunto parlavo: l’ira fa solo disastri e non può essere annoverata fra i mezzi di soccorso. Dunque, o non è ira, o non serve: se uno, infatti, infligge un castigo non perché ne provi piacere ma solo perché lo ritiene necessario non può essere annoverato fra gli adirati. Soldato valido è quello che sa obbedire agli ordini, mentre le passioni non sono capaci né di servire né di comandare. 10. Per questo motivo la ragione non assumerà mai come aiutanti gl’impulsi folli e violenti, sui quali non ha alcun potere e che non sarebbe in grado di debellare se non opponendo loro altri impulsi equivalenti o simili, come il timore all’ira, l’ira all’indolenza, la cupidigia al timore. Stia lontana dalla virtù questa idea sciagurata di una ragione che fa ricorso ai vizi! Un animo che si sente protetto da passioni malvagie, che trova la sua forza solo nell’ira, che non sa lavorare senza la spinta di desideri smodati e starsene in pace senza timori, non potrà mai godere di una quiete sicura, ma sarà sempre agitato e indeciso: è come vivere sotto una tirannide, quando si è schiavi di una passione. E non è vergognoso ridurre tutte le virtù sotto la protezione dei vizi? Quale potere ha la ragione se non può fare nulla senza la passione e diventa uguale o simile a lei? Dov’è la differenza se la passione è sconsiderata perché priva di ragione e la ragione è debole senza la spinta della passione? Se l’una non può sussistere senza l’altra significa che sono uguali. Ma chi può sostenere una cosa del genere? Né serve obiettare che la passione è utile se controllata, in quanto quella utilità non deriva dalla sua intrinseca natura: poiché la passione non tollera il governo della ragione, se questa riuscirà comunque a indebolirla il risultato sarà che nocerà di meno. Come dire che una modica quantità fa meno male: ma sempre male fa. 11. «Ma l’ira, ripeto, è indispensabile nell’affrontare i nemici». E invece mai come in quel caso è inopportuna, perché è proprio allora che bisogna controllare tutti gl’impulsi e tenerli a freno. Cos’altro, infatti, rende deboli i barbari, pur così vigorosi e resistenti alla fatica, se non l’ira, che si ritorce rovinosamente contro sé stessa? Guarda i gladiatori: è la scaltrezza la loro difesa, l’ira invece li accèca e li disarma. A che serve poi l’ira, quando si può ottenere lo stesso risultato facendo ricorso alla ragione? È con l’ira che cattura la preda il cacciatore? Egli ne spia l’arrivo aspettandola al varco, e se gli sfugge le tiene dietro con accorto zelo:
ciò lo fa la ragione, non l’ira. E cosa fu se non l’ira a rovinare i Cimbri e i Teutoni,9 che a mille a mille, messo da parte il valore, erano calati giù dalle Alpi? Fu una tale strage che non ne scampò uno solo, sì che la fama stessa, non un messaggero, ne portò la voce alla loro gente. Anche se a volte abbatte e rovescia ciò che incontra sul suo cammino, assai più spesso l’ira causa la propria rovina. Quale popolo è più coraggioso dei Germani? Chi altrettanto irruente nell’attaccare il nemico? Chi più agguerrito di loro, che nascono e crescono fra le armi, a cui solo si dedicano senza curarsi di altro? Chi è più allenato a sopportare ogni disagio, visto che non si coprono più di tanto e non hanno riparo che li scampi dall’eterno rigore del clima? Con tutto ciò Ispani, Galli e soldati d’Asia e di Siria, pur così deboli in battaglia, li fanno a pezzi prima ancora che se ne veda una legione, sfruttando appunto nient’altro che la loro irascibilità. Ebbene, prova a dare una ragione, una disciplina, a quei corpi, a quegli animi che non conoscono agi, lusso e ricchezze. Ma basta a questo riguardo, e torniamo ai costumi romani. Con quale mezzo Fabio10 rianimò le forze indebolite della potenza di Roma se non temporeggiando, tirandola per le lunghe e sapendo aspettare il momento opportuno? Chi è in preda all’ira non conosce simili espedienti. Se Fabio avesse osato fare ciò che gli suggeriva l’ira, quella supremazia, che allora stava per declinare, sarebbe certamente finita. Egli invece non pensò ad altro che al bene dello Stato e dopo aver riflettuto che un’ulteriore perdita di soldati avrebbe provocato una catastrofe generale, mise da parte il dolore e la vendetta, preoccupandosi solo di sfruttare le occasioni favorevoli. Prima ancora che Annibale, egli sconfisse l’ira. E che dire di Scipione?11 Accantonati Annibale, l’esercito cartaginese e tutti coloro contro i quali avrebbe dovuto rivolgere la sua ira, portò la guerra in Africa e con una flemma tale che i maligni la presero per debolezza e indolenza. E l’altro Scipione?12 Se ne rimase a lungo tutt’intorno a Numanzia, sopportando serenamente il cruccio, suo e dello Stato, che per vincere Numanzia ci volesse più tempo di quel ch’era servito per piegare Cartagine. Ma intanto, serrandolo da ogni parte, chiuse al nemico ogni via di fuga, costringendolo a un suicidio generale. L’ira, dunque, non giova neppure in guerra perché è sconsiderata e mentre cerca di nuocere agli altri non vede i danni che può recare a sé stessa. Decisamente sicura è invece quella virtù che esamina a lungo e attentamente ogni cosa e sa controllarsi e procedere con calma e determinazione. 12. «Ma l’uomo virtuoso non deve adirarsi se gli malmenano il padre o gli rapiscono la madre?» No, non deve arrabbiarsi: deve difenderli e punire i colpevoli. Non credi che l’amore di un figlio sia già di per sé stesso un impulso sufficiente senza l’aggiunta dell’ira? E ti dirò di più. Quand’anche vedesse fare a pezzi suo padre o suo figlio neppure allora l’uomo virtuoso deve cedere alle lacrime e perdere il
controllo di sé. Queste sono cose che capitano alle donne quando le coglie il semplice sospetto di un pericolo. L’uomo virtuoso assolverà ogni suo compito senza minimamente turbarsi o trepidare, e nient’altro farà se non ciò che sia degno di un uomo buono e virtuoso. Vogliono uccidergli il padre? Lo difenderà. Gliel’hanno ucciso? Perseguirà i colpevoli, non per spirito di vendetta ma perché è suo dovere. O Teofrasto,13 quando dici così [che all’uomo virtuoso è lecito adirarsi], cerchi di screditare quelle norme che sono proprie degli animi forti, e, smessa la veste del giudice, porgi l’orecchio al volgo: visto che tutti si adirano quando casi di questo genere capitano ai propri cari, lasci che siano gli uomini a giudicare se sia giusto o non giusto quello che fanno; ciascuno, infatti, ritiene legittime le proprie passioni. «L’ira degli uomini virtuosi riguarda non già chi oltraggia i loro cari, quanto piuttosto l’offesa». Ma essi reagiscono così anche se non gli si porge l’acqua calda nel modo dovuto, se si rompe un bicchiere, se uno stivaletto si è sporcato di fango. Dunque non è l’amore filiale che suscita quell’ira, è la debolezza, come accade ai bambini, che piangono tanto la perdita dei genitori quanto quella delle noci. Chi monta in collera per un’offesa recata ai propri cari compie un gesto d’impotenza, non di pietà: è il dovere che deve spingerci e guidarci – come un imperativo categorico – in difesa dei genitori, dei figli, degli amici, dei concittadini, con giudizio e con prudenza, non con rabbiosa impulsività: questa è la condotta, bella e dignitosa, che si deve tenere. Nessuna passione, infatti, è assetata di vendetta più dell’ira, la quale proprio per questo in realtà non riesce a punire: impetuosa e dissennata, come in genere tutte le passioni, si dà la zappa sui piedi, poiché la troppa fretta le impedisce di raggiungere il fine che si propone. Perciò non ha mai prodotto nulla di buono, né in pace né in guerra: rende infatti la pace simile alla guerra, dimentica che quando si combatte è battaglia da entrambe le parti, e, incapace di dominare sé stessa, finisce col cadere sotto il dominio altrui. Il fatto che talvolta le passioni conseguano un buon risultato non deve spingerci a praticarle: anche le febbri alleviano certe indisposizioni, tuttavia è meglio non averne: dover la salute a una malattia è una ben detestabile cura. Lo stesso dicasi dell’ira, la quale, anche se a volte porta un giovamento del tutto inaspettato, come un veleno, una caduta, un naufragio, non per questo è da ritenersi salutare: anche dalla rovina può nascere la salvezza. 13. E ora ascolta. I beni – quelli che si devono possedere – quanto più sono grandi tanto più sono buoni e desiderabili. Se la giustizia è un bene non migliora se le si toglie qualcosa; se la fortezza d’animo è un bene non è desiderabile che perda un po’ del suo vigore. Ora, se l’ira è un bene, il suo accrescimento dovrebbe renderla migliore: questo è appunto ciò che vuole chi possiede qualcosa di buono. Ma un aumento dell’ira non porta alcun giovamento, ergo la
sua stessa esistenza è perfettamente inutile. D’altra parte ciò che aumentando diventa un male non può definirsi un bene. «Ma l’ira è utile, perché rende più energici, più combattivi».14 Per questo anche l’ubriachezza: chi beve troppo diventa spavaldo, arrogante, e molti se sono un po’ ebbri maneggiano meglio le armi. Ma se si ragiona così bisogna dire che anche il delirio e la pazzia sono utili, visto che spesso il furore rende più forti. E allora? La paura non rende a volte audaci per reazione? E il timore della morte non spinge a battersi anche i più indolenti? Ma l’ira, l’ubriachezza e la paura, come altri stati emotivi di questo genere, sono impulsi vergognosi e momentanei, che tirano un po’ su un animo pigro e codardo, ma nulla aggiungono alla virtù, che non ha bisogno di vizi. L’ira rende più forte soltanto chi non potrebbe diventarlo senza l’impulso di quella passione. Essa, dunque, non aiuta la virtù, la sostituisce. Ma poi se l’ira fosse un bene si accompagnerebbe con tutti gli uomini saggi. D’altra parte i bambini, i vecchi e i malati sono irritabilissimi, i deboli lagnosi per natura. 14. «L’uomo virtuoso, dice Teofrasto, non può non adirarsi contro i malvagi». Se fosse così si dovrebbe concludere che quanto più uno è buono tanto più è soggetto all’ira. E invece guarda tu se non è tutto il contrario: più uno è buono più è tranquillo, libero dalle passioni e incapace di odiare chicchessia. Per quale motivo l’uomo virtuoso dovrebbe odiare i malfattori quando è l’errore che li spinge al male? Chi ha senno e giudizio non odia chi sbaglia, altrimenti dovrebbe avere in odio sé stesso, se pensa alle cattive azioni che compie anche lui e a tutte quelle che dovrebbero essergli perdonate. Un giudice onesto non emette due sentenze diverse a seconda che la causa riguardi lui o altri. Voglio dire che nell’intimo nessuno potrà mai assolvere sé stesso, e chi si dichiara innocente guarda al testimone, non alla propria coscienza. Quanto è più umano mostrarsi mite e paterno con quelli che sbagliano, e non punirli, ma distoglierli dal male! Se c’imbattiamo in uno che si è smarrito per i campi dobbiamo rimetterlo sulla sua strada, non mandarlo alla malora. 15. Chi compie il male, dunque, è uno che sbaglia, e bisogna correggerlo o con l’ammonimento, o con la forza, con dolcezza o con durezza, al solo scopo di migliorarlo, per il bene suo e degli altri, punendolo, se occorre, ma senza ira, come si fa con un malato. «Ma i malfattori sono incorreggibili, in loro non c’è un minimo di bontà, nulla che possa far sperare in un cambiamento!». Allora si isolino dal contesto sociale, quando infettano tutto ciò su cui mettono le mani, e si distolgano dal male nell’unico modo che si ritenga possibile, ma senza odio. Perché, infatti, dovrei odiare una persona a cui faccio del bene sottraendolo alla sua rovina? Si odiano forse le proprie membra quando si è costretti a farsele amputare? In quel caso non si può parlare di ira: si tratta di
un rimedio penoso. Abbattiamo i cani rabbiosi, uccidiamo il bue selvaggio e feroce, trafiggiamo col ferro le bestie malate perché non infettino il gregge, sopprimiamo i parti mostruosi, anneghiamo persino i nostri figli se sono nati inabili e deformi, ma non è l’ira, è la ragione che c’induce a separare gli esseri inutili da quelli sani.15 Non l’ira deve spingerci a infliggere una punizione, dal momento che la pena serve a correggere, e tanto più se imposta con giudizio. Per questo Socrate disse al suo schiavo: «Se non fossi adirato ti picchierei».16 E rinviò il castigo a quando l’ira gli fosse passata, limitandosi, per il momento, a correggere sé stesso. Ora, se Socrate non volle compiere quel gesto sotto l’effetto dell’ira, perché non dev’essere possibile trovare un uomo che sia capace di frenare le proprie passioni? 16. Nel castigare un malfattore non si deve dunque essere adirati, giacché se l’ira è un vizio dell’animo non è giusto correggere un errore con un altro errore. «Ma come? Non devo adirarmi con un brigante? Con un avvelenatore?». Assolutamente no. Io mi arrabbio forse con me stesso quando mi tolgo del sangue facendomi un salasso? Quale che sia la pena la considero come una medicina. Così a uno dirò: «Tu sei ancora un principiante, sbagli spesso, ma non ti sei smarrito del tutto: per correggerti basterà un rimprovero, prima in privato, poi, se necessario, in pubblico». A un altro: «Tu sei già andato troppo avanti per poter essere guarito con una semplice ammonizione: ti metterò alla gogna, così ti calmerai». E ancora: «Tu devi essere punito con qualcosa di più forte, che ti si imprima come un marchio: sarai mandato in esilio, in luoghi lontani e sconosciuti». Oppure: «Tu sei un recidivo, un malvagio così incallito che per te ci vogliono pene ancora più dure: la prigione e le catene». Infine: «Tu non guarirai mai, passi da un delitto all’altro, e non ti spinge un qualche motivo specifico, che pur non manca ai malvagi, ma solo la volontà di far male, e già questo ti basta. Sei tanto intriso di malvagità, ce l’hai talmente nel sangue, così radicata nelle viscere, che bisogna strappartele per liberarti, e tu stesso, del resto, sciagurato, da molto tempo pensi di farla finita. Dunque ti farò un favore liberandoti da questa follia che tormenta te e gli altri: dopo tutti i supplizi in cui ti sei avvoltolato, fatti a te stesso e agli altri, ti darò l’unica cosa buona che ti rimane: la morte». Perché dovrei essere adirato con uno a cui posso dispensare un così grande bene? Talvolta uccidere è la più alta forma di pietà. Se fossi un medico, esperto e saggio, e mi trovassi in un ospedale, o nella casa di un ricco, non prescriverei gli stessi farmaci a tutti gl’infermi, se sono afflitti da malattie diverse. Così, se dovessi prendermi cura di una città, visto che i difetti sono tanti e che ogni animo ha i suoi, prescriverei un rimedio specifico per ciascuno: a chi un rimprovero, a chi un soggiorno in un paese lontano, a chi una qualche afflizione, a chi la povertà, a chi la spada. Analogamente, se dovessi indossare la toga scura del magistrato e convocare con squilli di tromba l’assemblea, mi recherei in tribunale non con aria furiosa e ostile, ma col volto
della legge, pronuncerei le formule di rito con voce calma e grave, non piena di rabbia, ordinerei che si proceda con tono severo ma non adirato. E quando dovessi imporre di tagliare la testa a un criminale, di cucire in un sacco un parricida, d’infliggere il supplizio militare, o di gettare dalla rupe Tarpeia un traditore o un nemico dello Stato, non sarei spinto dall’ira ma manterrei lo stesso animo e lo stesso volto di quando abbatto un serpente velenoso o un altro animale del genere.17 «Ma bisogna pur essere adirati per punire qualcuno!». Che cosa?! Come può la legge adirarsi contro individui che non conosce, che non ha mai visto e che non vorrebbe nemmeno ch’esistessero? La legge non si adira, sancisce: chi l’applica deve assumerne lo spirito, il senso vero e profondo. Se si ritiene giusto che un uomo buono si adiri per le azioni cattive, si dovrebbe anche ammettere che provi invidia per la fortuna che capita ai malvagi: cosa c’è di peggio, infatti, che il veder prosperare e godere della benevolenza della sorte degli individui per i quali non si potrebbe inventare un destino abbastanza crudele? Eppure l’uomo virtuoso non invidierà mai le fortune di costoro, così come riuscirà a guardare i loro misfatti senza adirarsi: il buon giudice condanna le azioni riprovevoli, ma non odia chi le compie. «E che dunque? L’uomo saggio che si trovi di fronte a fatti del genere non ne sarà toccato? Non si commuoverà più di quanto non sia solito?» Sì, certo: proverà un qualche lieve e sottile turbamento, perché – come dice Zenone – anche nel saggio, quando la ferita si è rimarginata, resta la cicatrice. Ma sarà solo un sospetto, come l’ombra di una passione, come un fantasma, nient’altro. 17. Aristotele dice che certe passioni, se bene utilizzate, sono come le armi. Lo sarebbero se al pari di quelle si potessero prendere e deporre a proprio piacimento. Ma le armi di cui parla Aristotele, attribuite alla virtù, combattono da sole, non aspettano una mano: si sostengono da sé, non sono sostenute.18 Non abbiamo bisogno di altri strumenti: la natura ci ha dato la ragione, e questa ci basti. È un’arma solida, durevole, ubbidiente, non a doppio taglio, tale che possa ritorcersi contro il suo padrone. Essa è di per sé sufficiente non solo a prevedere le cose ma anche a realizzarle. Nulla di più insensato, dunque, se la ragione chiedesse aiuto all’ira, lei stabile a una incostante, lei leale a una perfida, lei sana a una malata. D’altronde anche in quelle azioni che sembrano richiedere il concorso dell’ira la ragione è sempre molto più forte: quando infatti ha deciso che una cosa dev’essere fatta va sino in fondo, poiché niente può farle cambiare idea se non lei stessa, sicché una volta che ha preso una decisione lì resta. Spesso l’ira è vinta dalla compassione, perché la sua forza è fittizia, un gonfiore sterile: soltanto all’inizio è violenta, come certi venti che si levano dal suolo e mulinellano sui fiumi e sulle paludi, impetuosi ma di breve durata. Comincia con grande foga ma poi perde vigore, fiaccandosi prima del tempo, e
dopo avere architettato crudeltà a tutto spiano e supplizi mai visti e sentiti, quando viene il momento di mettere in atto i suoi folli progetti, si ammoscia e si spezza. La passione crolla subito, la ragione è costante. Peraltro non è raro che l’ira, pur se ostinata, quando i condannati a morte sono parecchi, smetta di uccidere dopo due o tre esecuzioni. I suoi primi colpi sono incisivi, come i denti velenosi dei serpenti quando si levano dai loro giacigli, che poi, però, a furia di mordere, diventano innocui. Perciò a delitti uguali, compiuti sotto l’impulso dell’ira, non corrispondono pene uguali e spesso uno meno grave paga di più perché commesso in una fase più recente [in cui si ha maggiore consapevolezza]. L’ira, poi, è sempre contraddittoria: ora trabocca più di quanto non serva al suo scopo, ora, invece, non supera il limite che si è proposto: procede infatti a casaccio, non segue un metro di giudizio; insensibile a ogni voce, non lascia spazio nemmeno alla difesa, tenendolo tutto per sé, e anche se sbaglia non accetta che le sia tolto l’errore. 18. Mentre in un processo la ragione dà alle due parti il tempo [di esprimere il loro punto di vista], e poi ne chiede un poco per sé onde accertare la verità, l’ira è frettolosa. La ragione vuol prendere la decisione giusta, l’ira vuole che sembri giusta la decisione che ha già preso in partenza. La ragione si tiene stretta ai fatti, l’ira si perde in divagazioni inutili e che niente hanno a che vedere con l’oggetto del dibattimento. La esasperano un volto troppo sereno, una voce troppo brillante, un linguaggio franco, un abbigliamento elegante, una Difesa ampollosa e il favore popolare. Spesso condanna l’imputato solo perché le è antipatico il difensore; anche se la verità balza evidente ai suoi occhi ama e sostiene l’errore; non vuole essere contraddetta e se vede vacillare le sue argomentazioni e le riconosce sbagliate ritiene più onorevole ostinarsi nell’errore piuttosto che cedere. Gneo Pisone,19 per tenerci ai tempi nostri, fu uomo di pochi vizi ma cattivo, e scambiava il rigore per fermezza d’animo. Ebbene, un giorno, in preda all’ira, ordinò che fosse messo a morte un soldato perché, partito con un commilitone per un rifornimento di viveri, era tornato senza di lui e perciò pensava che lo avesse ucciso. Il soldato, non essendo in grado di dimostrare che non era vero, chiese a Pisone di mandare qualcuno a cercare il compagno e di rinviare l’esecuzione. Ma quello non ne volle sapere. Il condannato fu condotto fuori del recinto e già stava per essere decapitato quando improvvisamente apparve il commilitone che si presumeva fosse stato assassinato. A quel punto il centurione incaricato dell’esecuzione ordinò alla guardia di riporre la spada e ricondusse il condannato da Pisone per rimettergli nelle mani la sua innocenza: al soldato l’aveva già restituita la buona sorte. I due militari, circondati dai compagni e abbracciati l’uno all’altro, si avviano fra l’esultanza di tutto l’accampamento. Pisone, allora, furibondo, sale sul palco e ordina che siano messi a morte entrambi, sia il soldato che non aveva ucciso, sia quello che non era morto. Quale atto più indegno di questo? Poiché uno si era rivelato innocente ne
morivano due. Ma Pisone ve ne aggiunse un terzo: ordinò infatti che fosse giustiziato anche il centurione che aveva ricondotto il condannato. Così, per l’innocenza di uno, furono schierati alla morte nel medesimo posto tre uomini. Oh, quanto è scaltra l’ira nell’inventare motivi per infuriarsi! «Ordino la tua morte perché sei stato condannato; la tua perché sei stato la causa della sua condanna; la tua, perché, incaricato di eseguire la sentenza, non hai ubbidito al tuo comandante». Così Pisone riuscì a compiere tre delitti, perché non ne aveva trovato nessuno. 19. L’ira ha questo di male: non vuole essere guidata, protesta anche contro la verità, se è contraria al suo volere, investe le sue vittime con grida, schiamazzi e movimenti scomposti di tutto il corpo, aggiungendovi ingiurie e insolenze. Queste cose la ragione non le fa, ma se è necessario, calma e silenziosa, demolisce dalle fondamenta interi quartieri, stermina famiglie con mogli e figli se sono funeste allo Stato, ne abbatte le case e le rade al suolo, cancella i nomi di coloro che attentano alla libertà: tutto questo senza digrignare i denti, senza scuotere il capo, senza far nulla che possa intaccare minimamente la dignità di un giudice, il cui volto dev’essere quanto mai sereno e impassibile, specialmente quando pronuncia sentenze severe. «Che bisogno hai di morderti le labbra», dice Geronimo,20 «quando stai per colpire qualcuno?». E cosa avrebbe detto se avesse visto un proconsole saltar giù dalla tribuna, strappare di mano i fasci ai littori, lacerare le proprie vesti perché ci voleva troppo tempo per stracciare quelle degli altri? A che serve rovesciare la tavola, fracassare bicchieri, dare del capo nelle colonne, strapparsi i capelli, prendersi a pugni sui fianchi e sul petto? Ti pare grande quell’ira che non potendo abbattersi sugli altri tanto presto come vorrebbe si sfoga contro sé stessa? Per questo chi s’infuria è trattenuto dai vicini e invitato a calmarsi. Nulla di tutto ciò fa una persona assennata quando, senza adirarsi, infligge a uno un giusto castigo. Spesso un giudice assolve un malfattore che è stato colto in flagrante: se vede che si pente e lascia bene sperare, o se capisce che la malvagità non viene dal profondo ma è rimasta, come si dice, attaccata alla superficie dell’animo, non punisce il colpevole, convinto che in quel caso l’impunità non può nuocere né a chi la riceve né a chi la concede. Talvolta mostrerà maggiore indulgenza verso i grandi delitti che non verso i più lievi, quando quelli siano stati commessi per errore, non per crudeltà, e questi nascondano una malizia subdola e inveterata; infliggerà pene diverse per un medesimo delitto quando uno dei colpevoli l’abbia commesso per disattenzione, l’altro con l’intento di nuocere. Nel comminare le pene terrà sempre conto che alcune sono volte a correggere i cattivi, altre a eliminarli, e più che al passato guarderà al futuro, perché, come dice Platone, «un uomo assennato punisce non perché si è commesso un errore ma affinché non lo si commetta più: il passato non si cancella, il futuro si può prevenire, impedendo [che si verifichino cose sgradite»].21 E quando renderà
pubblica un’esecuzione capitale il giudice lo farà per dimostrare chiaramente a tutti quale sia la fine riservata alla malvagità: non tanto perché i colpevoli muoiano, quanto perché la loro morte serva di esempio e di dissuasione agli altri. Vedi bene, dunque, come debba essere assolutamente libera da qualsiasi turbamento una persona a cui sia affidato il compito di soppesare e valutare casi di questo genere, un compito che dev’essere assolto con la massima diligenza, perché si tratta di decidere della vita e della morte: è da incoscienti mettere la spada della giustizia nelle mani di un iracondo.22 20. Non si deve neppure pensare che l’ira possa contribuire in qualche modo alla grandezza d’animo, perché quella non è grandezza, è gonfiore, spocchia, ampollosità: anche i corpi ingrossati da un eccesso di liquido marcio sono tali non perché semplicemente cresciuti ma perché gravati da un soprappeso pestifero. Molti, il cui animo esaltato vola al di sopra di ogni pensiero umano, credono di sprigionare chissà quali cose grandi e sublimi, ma quella è una crescita sterile, destinata a crollare, come tutto ciò che è inconsistente e senza fondamento. Così è l’ira: poggia sul vuoto, è volubile, non nasce da qualcosa di solido e di duraturo, ed è tanto lontana dalla grandezza d’animo quanto la temerarietà dal coraggio, la presunzione dalla sicurezza, il malumore dall’austerità, la crudeltà dal rigore. C’è molta differenza fra nobiltà d’animo e superbia. L’ira non costruisce nulla di grande e di bello, anzi, io credo che chi ne è affetto si renda conto di questa sua debolezza, tipica di un animo insoddisfatto e avvilito, e se ne lamenti, così come un malato che abbia il corpo cosparso di piaghe soffre e geme se qualcuno lo tocca. Per questo l’ira è un vizio tipicamente femminile e bambinesco. «Ma v’incappano anche gli uomini». Infatti: e sono appunto quelli che hanno un carattere effeminato e puerile. D’altra parte chi è in preda all’ira non dice a volte parole che per un profano sembrano veramente provenire da grandezza d’animo? Come l’espressione, crudele e detestabile, «Mi odino purché mi temano». Una massima che risale ai tempi di Silla.23 Non so quale delle due cose che si augurava [l’autore di quella frase] sia peggiore, se l’essere odiato o l’essere temuto. «Mi odino»: dunque [chi la pronunciava] era consapevole che sarebbe stato odiato, insidiato e magari ucciso. Perciò avrebbe dovuto aggiungere: «Che gli dèi mi stramaledicano per aver trovato una così odiosa soluzione!». «Mi odino, purché…». Purché che cosa? Purché mi obbediscano? No. Purché mi approvino? No. E allora? «Purché mi temano». Io a questo prezzo non vorrei neppure essere amato. Pensi che queste siano parole di un animo grande? Ti sbagli: questa non è grandezza d’animo, è mostruosità. Non devi credere a uno che parla sotto l’effetto dell’ira, perché per quanto baccano faccia, per quanto grandi siano le sue minacce, dentro è il più pavido
uomo che ci sia. E non devi credere nemmeno a quel modello di eloquenza che è lo storico Tito Livio, quando parla di un «uomo d’animo grande più che d’animo buono», perché queste due doti sono inscindibili: la grandezza d’animo comporta la bontà, e per me è qualcosa di solido e incrollabile, che alberga nel profondo, un che di compatto e di stabile, quale non può trovarsi in un malvagio: costui, infatti, può essere agitato, terribile, funesto, ma non sarà mai magnanimo, perché la magnanimità si regge appunto sulla bontà. I malvagi sembrano grandi all’apparenza, nel loro modo di parlare, negli sforzi che fanno, in ogni gesto esteriore; potranno anche dire cose molto apprezzabili da alcuni, come Caligola, il quale, adirato contro il cielo perché coi suoi tuoni disturbava i pantomimi (che sapeva imitare con una cura maggiore di quella che mostrava nel guardarli) e perché con i fulmini (piuttosto dubbi, in verità) gettava la paura e lo scompiglio nelle sue gozzoviglie, sfidò Giove a duello, sino all’ultimo sangue, addirittura, gridando quel famoso verso di Omero: Uccidimi, o io ucciderò te.24 Quanto fu pazzo! Pensò che neppure Giove potesse toccarlo, o che lui potesse nuocere addirittura a Giove. Sono convinto che quella battuta non sia stata estranea alla congiura ordita contro di lui, che anzi abbia contribuito non poco a infiammare gli animi dei cospiratori, ai quali, evidentemente, dovette sembrare il colmo della pazienza sopportare un uomo che non sapeva sopportare Giove. 21. Nulla di grande, dunque, nulla di nobile ha l’ira, nemmeno quando disprezza boriosamente gli uomini e gli dèi. E se sembra che possa indurre qualcuno alla magnanimità si dovrebbe pensare la stessa cosa del lusso, visto che anch’esso ama la magnificenza: si stende infatti sull’avorio, si veste di porpora, si copre d’oro, muove grandi distese di terre, imprigiona i mari, devìa il corso dei fiumi, s’inventa ingegnose cascate e boschi sospesi per aria. Idem dell’avarizia: se ne sta sdraiata su mucchi d’oro e d’argento, coltiva campi così vasti che prendono i nomi di province e dà da amministrare terreni più estesi di quelli toccati in sorte ai consoli. E a questo punto si dovrebbe pensare che anche l’amore sfrenato possa indurre alla magnanimità, quando vediamo alcuni attraversare a nuoto gli stretti,25 castrare intere schiere di fanciulli, finire sotto la spada di un marito ridendosene della morte. Lo stesso dovrebbe dirsi dell’ambizione: questa, infatti, non si accontenta di rivestire una carica all’anno, ma se potesse vorrebbe occupare tutti i giorni del calendario con un solo nome e inciderlo su apposite lapidi da piazzare in ogni angolo della terra. Tutte codeste passioni possono crescere quanto vogliono e abbracciare il mondo, ma sono e resteranno sempre anguste, basse e meschine: solo la virtù vola in alto, sino a toccare il cielo, né c’è alcunché di grande se non è anche mite e sereno.
Libro secondo 1. L’argomento del primo libro, caro Novato, era abbastanza facile, come lo è lo scendere lungo i pendii dei vizi. Ora dobbiamo affrontare questioni più sottili, cominciando col chiederci se l’ira sia frutto di un convincimento interiore o se invece nasca da un impulso spontaneo, come quei fenomeni che ci colgono all’improvviso senza alcuna iniziativa e consapevolezza da parte nostra. È da qui che dobbiamo partire, dal basso, per portare poi la discussione a livelli più alti e più degni, come avviene nel nostro corpo, in cui prima si dispongono ordinatamente le ossa, i nervi e le articolazioni, che non hanno nulla di bello a vedersi, ma che servono a sostenere tutte le parti vitali, poi si forma ciò che si conviene alla figura e all’aspetto esteriore, infine, dopo tutte queste cose, quando il corpo è ormai completo, si diffonde il colorito, che costituisce la principale attrattiva. Ora, dato per scontato che l’ira insorge nel momento in cui si riceve l’offesa, si tratta di vedere se la reazione sia istantanea e se lo sfogo avvenga con o senza la partecipazione e la consapevolezza dell’animo. Io credo che l’ira da sola non possa osare nulla e che per agire abbia bisogno del consenso dell’animo. Non è possibile, infatti, che un impulso spontaneo, insorto senza la nostra consapevolezza e la nostra volontà, possa concepire l’idea di aver ricevuto un’offesa e il desiderio della vendetta, collegando insieme i due elementi [in un rapporto logico], che cioè non dovevamo essere offesi e che dobbiamo vendicarci. L’impulso è semplice, la reazione è molteplice, poiché comporta diversi fattori: la percezione del fatto, lo sdegno, il senso di condanna e di vendetta, cose che non possono sussistere se l’animo, che ne è stato colpito, non ha dato loro il suo assenso. 2. «Mi chiedo a cosa miri questo tuo ragionamento». A farti sapere che cos’è l’ira. Se essa esplode senza che noi lo vogliamo non cederà mai alla ragione. Infatti tutti i moti che nascono al di fuori della nostra volontà sono inevitabili e insopprimibili, come il brivido che insorge a un getto di acqua fredda, la ripugnanza a certi contatti, il rizzarsi dei capelli alle cattive notizie, l’arrossire alle parole sfacciate, la vertigine di fronte a un precipizio. Poiché nessuna di queste reazioni è sotto il nostro controllo non esiste ragione che possa impedirle. L’ira, invece, può essere scacciata con una buona educazione, in quanto è un vizio volontario dell’animo, non una di quelle reazioni che derivano dal nostro stato di natura e a cui perciò sono soggetti anche i più saggi: tale è appunto quell’iniziale moto dell’animo che ci turba alla sola idea di essere stati offesi, e che ci coglie anche nel corso di divertenti spettacoli teatrali o alla lettura di storie del passato. Così, ad esempio, ci sentiamo presi da un moto di rabbia contro Clodio quando caccia in esilio Cicerone, o contro
Antonio che lo fa assassinare.26 E chi non si indigna per le violenze di Mario o le proscrizioni di Silla? Chi non prova avversione per Teodoto e Achilla, o per quel fanciullo che osò commettere un crimine tutt’altro che puerile?27 Spesso ci eccitiamo nell’ascoltare un canto, al ritmo di una melodia o al suono marziale delle trombe, ci turbiamo di fronte a un quadro raccapricciante, alla vista di supplizi anche se ben meritati, ed è per questo che sorridiamo a chi ci sorride, ci rattristiamo davanti a una folla di persone tristi, ci entusiasmiamo di fronte alle contese altrui. Ma tutti questi moti non sono riconducibili all’ira, così come non ha niente a che vedere con la tristezza il corrugare la fronte quando il mimo rappresenta un naufragio, e non è paura quel brivido che afferra il lettore quando Annibale, dopo Canne, assedia le mura di Roma. Tutti questi sono moti involontari dell’animo, sintomi che preludono alle passioni ma che non possono considerarsi propriamente delle passioni. Così lo squillo di una tromba, in un sereno clima di pace, fa sussultare un veterano che indossa ormai la toga da cittadino, e uno strepito d’armi ridesta gli ardori bellicosi in un cavallo da guerra. Dicono che Alessandro, udendo cantare Senofanto, ponesse mano alla spada.28 3. Non bisogna dunque chiamare passione nessuno di quegli impulsi involontari, i quali sono per così dire subìti dall’animo più che provocati. La passione consiste non nel turbamento che si prova di fronte a qualcosa d’imprevisto, ma nel lasciarsi prendere e trascinare da quella sensazione, assecondando un impulso del tutto casuale. È infatti errato pensare che il pallore del viso, lo sgorgare delle lacrime, l’eccitazione dovuta allo stimolo del liquido sessuale, un sospiro profondo, un subitaneo sguardo acceso più del consueto e altri fenomeni del genere siano la manifestazione di uno stato d’animo e perciò sintomi di una passione: chi così crede non capisce che sono impulsi del corpo. Anche l’uomo più coraggioso si fa pallido in volto mentre indossa le armi, al soldato più temerario tremano un poco le ginocchia al segnale della battaglia, persino il comandante supremo ha come un tuffo al cuore prima dello scontro e l’oratore più eloquente, quando si appresta a parlare, sente gelarsi le estremità del corpo. L’ira non solo dev’essere provocata ma ha bisogno di sfogarsi, perché è un impulso violento, e non c’è violenza senza l’avallo dell’animo: non è infatti possibile concepire a sua insaputa un’idea di vendetta e di punizione. Se uno si è sentito offeso e ha meditato di vendicarsi, ma subito, per un motivo qualsiasi, si è trattenuto e calmato non si può dire che il suo sia stato un moto d’ira, dal momento che ha obbedito alla ragione: l’ira la ragione la scavalca e se la trascina dietro. Insomma, quel turbamento dell’animo provocato dalla botta iniziale dell’offesa non è ira più di quanto non lo sia la percezione che se n’è avuta; ira è invece il momento successivo, quando quell’impulso non si limita a registrare la percezione dell’offesa ma l’approva, e l’animo, eccitato, muove alla vendetta con volontà e determinazione. Nessuno ha mai messo in dubbio che il
timore provochi la fuga, l’ira, l’attacco: vedi dunque se uno possa assalire o schivare qualcosa senza l’assenso della ragione. 4. Ora, affinché tu sappia come nascono, come crescono e come si esasperano le passioni, ti dirò che il moto iniziale è involontario, una sorta di preparazione o un’avvisaglia della passione; il secondo si accompagna a una volontà ancora capace di controllo, cioè l’idea che se sono stato offeso devo vendicarmi, o che chi mi ha offeso deve essere punito; il terzo ha ormai perso ogni freno e, soggiogata la ragione, esige la vendetta a ogni costo, anche se non necessaria. Ora al primo impulso non possiamo sottrarci con la ragione, così come non possiamo evitare quelle reazioni fisiche di cui abbiamo parlato, o di sbadigliare quando sbadigliano gli altri, di chiudere gli occhi quando qualcuno ci punta contro le dita: questi sono moti spontanei e quindi la ragione non può vincerli; forse possono attenuarli l’abitudine e una costante attenzione. Il secondo impulso, che nasce dalla riflessione, può essere vinto dalla riflessione stessa. 5. Ora dobbiamo chiederci se chi abitualmente è crudele e gode del sangue umano sia soggetto all’ira quando uccide una persona da cui non ha ricevuto né pensa di aver subìto alcuna offesa: come Apollodoro o Falaride. 29 Ebbene, questa non è ira, è ferocia, perché ha come fine il male per il male, al punto che chi lo compie, lungi dal vendicare un’offesa, che non ha ricevuto, accetterebbe di essere offeso pur di poter nuocere ad altri, e infligge frustate e torture non per vendicarsi ma per puro godimento. «Ma come può accadere ciò?». In realtà la ferocia è riconducibile all’ira, nel senso che questa, quando sia praticata costantemente sino alla sazietà e dopo che dall’animo siano stati banditi ogni residuo di clemenza e ogni vincolo di convivenza umana, sfocia appunto nella crudeltà; perciò chi infierisce sugli altri come per svago, ridendo, godendo e provandone un grande piacere, è molto dissimile da uno che agisce sotto l’impulso dell’ira. Dicono che Annibale, vedendo una fossa piena di sangue umano, esclamasse: «Che bello spettacolo!». E ancora di più ne avrebbe goduto se il sangue avesse riempito un lago o l’intero corso di un fiume! In verità non deve sorprendere che godesse di un tale spettacolo, visto ch’era nato in mezzo al sangue e fin da bambino aveva assistito a stragi su stragi. Per vent’anni, favorito dalla sorte, avrebbe saziato quella sua crudeltà beandosi alla vista di tali spettacoli: al Trasimeno, a Canne e finalmente presso la sua Cartagine. In tempi recenti Voleso,30 proconsole d’Asia sotto il divino Augusto, dopo aver fatto massacrare a colpi di scure in un solo giorno trecento persone, camminando tra i cadaveri con fiero cipiglio, come se avesse compiuto un’azione magnifica e stupenda, in lingua greca esclamò: «Soltanto un re avrebbe potuto compiere una simile impresa!». E che avrebbe fatto se re lo fosse stato davvero? Questa non era ira, ma un male più grave e inguaribile.
6. «Sì, però l’uomo virtuoso, com’è portato alle azioni oneste, così deve adirarsi di fronte a quelle disoneste». Già. È come dire che la virtù si comporta ora in un modo ora in un altro, che è nobile ma anche meschina. Questo lo dice chi vuole esaltarla e umiliarla, perché gioire per una bella azione è un sentimento elevato e che fa onore, mentre adirarsi per un errore altrui è cosa ignobile e gretta. La virtù non si permetterà mai di imitare quei vizi che reprime; il suo compito è quello di tenere a freno proprio l’ira, che non è per nulla migliore dei misfatti contro i quali si scaglia, e di cui anzi il più delle volte è di gran lunga peggiore. Gioire e rallegrarsi sono le prerogative specifiche e naturali della virtù; l’adirarsi è contrario alla sua dignità, e così pure il rattristarsi: l’ira, invece, si accompagna alla tristezza, in cui sempre ricade dopo ogni suo atto, vuoi per rimorso, vuoi per aver fallito lo scopo. D’altra parte, se fosse vero che il saggio si adira contro i misfatti, quanto più questi sono gravi tanto più grande e più frequente dovrebbe essere la sua ira, sicché egli non sarebbe soltanto uno che monta in collera saltuariamente, ma un irascibile abituale. Se dunque si ritiene che nell’animo del saggio non possano albergare né un’ira grande né un’ira frequente, perché non liberarlo del tutto da questa passione? Non si può infatti fissargli una misura a seconda che si arrabbi per l’azione di questo o di quello, altrimenti se si adira allo stesso modo per delitti diversi è un saggio ingiusto, se va in escandescenze a ogni misfatto è un uomo irascibilissimo. 7. Nulla è più sconveniente e contrario alla natura del saggio che il far dipendere i suoi sentimenti dalla malvagità altrui. Se fosse così quel grande Socrate non sarebbe mai potuto rientrare in casa con lo stesso volto pacato con cui ne era uscito. E in verità se il saggio dovesse adirarsi contro le cattive azioni e agitarsi e rattristarsi per ogni misfatto sarebbe l’uomo più travagliato del mondo: passerebbe tutta la vita fra l’ira e lo sconforto, perché dovunque e in qualsiasi momento vedrebbe azioni riprovevoli. Ogni volta che uscisse di casa gli toccherebbe camminare in mezzo a una folla di malvagi, di avari, di prodighi, di spudorati, tutti felici e soddisfatti di queste infami passioni; in qualunque angolo posasse lo sguardo troverebbe sempre un motivo per arrabbiarsi: sarebbe la fine per lui se si lasciasse prendere dall’ira ogni volta che la circostanza lo richiedesse. Tutte quelle migliaia di persone che di prima mattina si affrettano verso il foro in quali processi vergognosi si trovano implicate, e quanto ancora più vergognosi sono gli avvocati che le difendono! Uno impugna le disposizioni testamentarie del padre, quando avrebbe dovuto cercare di meritarne la stima, un altro si scaglia contro la propria madre, e c’è chi accusa altri di un delitto di cui egli stesso è notoriamente colpevole, mentre il magistrato ch’è stato eletto a giudice condanna azioni che ha commesso anche lui. Da parte sua la folla che fa corona al processo, sedotta dalla bella arringa della Difesa, va applaudendo una
causa sbagliata. 8. Ma perché raccontarti questi casi isolati? Quando vedrai il foro pieno di gente, i recinti elettorali stracolmi di folla, e soprattutto il circo31 dove il popolo si presenta al gran completo, ebbene, sappi che lì si trovano tanti vizi quante sono le persone. Tutti questi cittadini sono in continua guerra fra loro: per un piccolo vantaggio non si fanno scrupolo di rovinarsi a vicenda, nessuno di essi guadagna se non a danno di altri, odiano chi è felice, disprezzano chi soffre, oppressi dai più forti, si rifanno sui più deboli, eccitati da opposte passioni, non si peritano di fracassare ogni cosa per il piacere di ricavarne un bottino misero e caduco. Il mondo è come un’arena di gladiatori, in cui la vita lotta contro sé stessa. Una consorteria di animali, con la differenza che gli animali non combattono e non azzannano i propri simili, mentre gli uomini si sbranano a vicenda, perché solo così soddisfano la loro fame. Le bestie si ammansiscono di fronte a chi le nutre, gli uomini sfogano la loro rabbia contro quegli stessi che l’alimentano: in ciò sta la distinzione fra gli esseri umani e quelli che non hanno il dono della parola. 9. Dunque, una volta che avesse cominciato ad adirarsi, il saggio non potrebbe più smetterla, visto che il mondo è pieno di vizi e di misfatti e se ne producono più di quanti se ne possano sanare con la forza. È come una grande gara di iniquità: di giorno in giorno più cresce la smania della trasgressione, la volontà d’infrangere qualsiasi legge, più diminuisce il ritegno; bandito ogni riguardo per ciò ch’è migliore e più giusto, l’arbitrio si spinge dovunque gli pare, i delitti, che prima erano furtivi, ormai si compiono alla luce del sole, passano sotto i nostri occhi, la dissolutezza si è diffusa a tal punto fra la gente ed è così radicata nell’animo di tutti, che l’innocenza, nonché rara, è ormai del tutto scomparsa. Né sono solo singoli individui o piccoli gruppi a infrangere la legge. Da ogni parte, come a uno squillo di tromba, spuntano intere categorie di persone a mescolare il lecito con l’illecito: dell’ospite dubita l’ospite, teme il genero il suocero, tra fratelli incostante è l’affetto. Spiano dell’uno e dell’altro la morte il marito e la moglie; turpi veleni ai figliastri apprestano infami matrigne, conta in anticipo il figlio gli anni che restano al padre.32 E questa è solo una piccola parte dei misfatti: il poeta non parla di coloro che invece di essere uniti militano in campi contrapposti, di genitori e figli che hanno fedi diverse, delle fiamme appiccate alla patria dalle mani stesse dei suoi; non descrive le infeste schiere di cavalieri che scorrazzano di qua e di là cercando i nascondigli dei proscritti, sorgenti avvelenate, epidemie diffuse dalla mano stessa dell’uomo, figli che mettono sotto assedio i genitori scavandogli
intorno la fossa, incendi che bruciano intere città, funeste tirannidi, congiure segrete per abbattere regni e repubbliche, azioni di cui si mena gran vanto come di nobili imprese ma che una volta represse assumono l’aspetto di veri e propri delitti; e rapimenti, stupri, atti di libidine che non risparmiano neppure la bocca. A tutto ciò aggiungi i pubblici spergiuri dei popoli, i patti infranti, le rapine da parte dei più forti ai danni dei deboli e degli indifesi, e i soprusi, i furti, le frodi, le malversazioni, per cui non basterebbero i tre Fori.33 Ecco: se vuoi che il saggio si adiri nella misura che richiede l’infamia dei delitti, ebbene, più che adirarsi, egli dovrebbe impazzire. 10. Quanto agli errori sarai abbastanza assennato se riterrai che non ci si debba adirare contro di essi. Cosa diresti, infatti, se vedessi uno arrabbiarsi con chi brancola al buio? O con dei sordi che non sentono i comandi? Con dei ragazzi che, trascurando i loro doveri, si mettono a guardare i passatempi e i futili giochi dei coetanei? E potresti mai pensare di adirarti contro un malato, un vecchio, un debilitato? Fra i tanti inconvenienti della condizione umana c’è anche questo: l’ottenebrarsi della mente, che può rendere l’errore non solo inevitabile ma persino deliberato. E per non adirarti con i singoli devi assolvere tutti, perdonare l’intera umanità. Se ti adiri con i giovani e con i vecchi perché sbagliano, devi adirarti anche con i bambini, perché sbaglieranno. Ma ci si può arrabbiare con i bambini, quando l’età non gli consente ancora di distinguere bene le cose? È più giusto e più serio che si scusi un uomo piuttosto che un bambino. La nostra condizione è quella di esseri soggetti a malattie dell’animo non meno numerose di quelle del corpo, non già perché siamo ottusi e tardi, ma perché facciamo cattivo uso della nostra intelligenza, essendo ciascuno di noi un esempio di vizi per un altro; chi segue coloro che prima di lui hanno imboccato un non retto cammino non deve forse essere scusato per aver preso quella strada sbagliata quando la percorrono tutti? Un generale riversa sui singoli la sua severità, ma quando diserta l’intero esercito egli deve necessariamente perdonare. Cos’è che impedisce a un saggio di adirarsi? La folla innumerevole di quelli che sbagliano: egli infatti comprende quanto sia ingiusto e pericoloso adirarsi per un vizio ch’è comune a tutti. Eraclito ogni volta che usciva di casa, nel vedere intorno a sé tanta gente che se la passava male, e che anzi faceva una brutta fine, si metteva a piangere e provava compassione per tutti quelli che gli si facevano incontro contenti e felici, tanto era mite d’animo; ma anche troppo debole, e perciò pure lui era degno di commiserazione. Democrito, invece, dicono che ridesse sempre quando si trovava in mezzo alla gente, tanto non gli sembravano serie le cose che venivano fatte con serietà. Credi dunque che vi sia posto per l’ira dove tutto è da ridere o da piangere? Il saggio non si adirerà mai con chi sbaglia. E sai perché? Perché saggi non si nasce, si diventa, e lui, che ha studiato a fondo la condizione della vita umana,
sa che di saggi ne spuntano assai pochi in tutto il corso dei secoli e che nessuna persona assennata si adira con la natura. Sarebbe come stupirsi perché dai cespugli selvatici non pendano fichi o ciliegie. O perché i rovi e le siepi non si riempiano di frutti mangerecci. Nessuno si arrabbia quando un difetto rientra nelle leggi stesse della natura. Perciò il saggio, sereno ed equanime di fronte agli errori e non nemico ma critico verso chi li commette, esce ogni giorno di casa con questa disposizione d’animo, dicendo a sé stesso: «Incontrerò molti ubriaconi, molti dissoluti, molti ingrati, molti avari, molti agitati dalla smania dell’ambizione». E guarderà tutti questi difetti con quella benevolenza che mostra il medico per i malati. Forse che il padrone di una nave che imbarca acqua da ogni parte perché le tavole della fiancata si sono aperte se la prende con i marinai o con la nave stessa? No: cerca invece di porvi rimedio, scaricando l’acqua che è entrata, bloccando quella che viene da fuori, tappando tutte le falle che vede e opponendosi con indefessa fatica a quelle nascoste che zitte zitte gli allagano la stiva; e non demorde anche se vede che quanta acqua rigetta da sopra altrettanta ne sgorga da sotto. Contro mali che proliferano continuamente non bisogna mai smettere di intervenire, non con la presunzione di debellarli, ma affinché non ci sommergano del tutto. 11. «L’ira, però, ha una sua utilità, perché sfugge al disprezzo e perché spaventa i cattivi». Innanzitutto, se ha tanta forza quanta ne sprizza dalle sue minacce, per il fatto stesso di incutere terrore risulta detestabile, ed è più pericoloso essere temuti che disprezzati. Se invece non ha forza è maggiormente esposta al disprezzo e diventa persino ridicola: niente, infatti, è più insulso di un’ira che strepita a vuoto. D’altra parte il fatto che certe cose suscitano più timore che disprezzo non comporta che sia meglio essere temuti che disprezzati: sarebbe come mettere il saggio sullo stesso piano della bestia perché si serve dell’arma della paura. E che? Non temiamo noi la febbre, la gotta, la piaga maligna? E c’è forse qualcosa di buono in queste cose? Al contrario, esse sono spregevoli, turpi e disgustose. Così l’ira: di per sé è vergognosa e non ha nulla di temibile, però ai più fa paura, come ai bambini una maschera ripugnante. Che dire poi del fatto che il timore ricade sempre su chi lo provoca e che nessuno di quelli che incutono paura hanno una vita tranquilla? A questo proposito ti soccorra quel verso di Laberio, che, recitato in teatro nel bel mezzo della guerra civile, richiamò su di sé l’attenzione di tutti gli spettatori, risuonando come la voce unanime di un sentimento popolare: Molti deve temere colui che da molti è temuto.34 È legge di natura che chi costruisce il proprio potere sulla paura che incute negli altri debba temere anche lui. Quanto non trema il cuore di un leone al più
leggero rumore! Bastano un’ombra, un grido, un odore insolito a mettere in agitazione le belve più feroci: chi fa paura ha paura. Perché mai dunque il saggio dovrebbe desiderare di essere temuto, o ritenere l’ira qualcosa di forte e di grande per il fatto che incute timore, quando si temono anche le cose che si disprezzano, come i veleni, le fitte e le infezioni ossee? Né c’è da stupirsi se intere mandrie di animali selvatici si lasciano accalappiare in massa e spingere in trappola da una cordicella munita di penne chiamata spauracchio35 dal turbamento che provoca: gli sciocchi si spaventano per delle sciocchezze. La vista di una biga in movimento, delle ruote che girano, risospinge i leoni nelle gabbie,36 il grugnito di un porco atterrisce gli elefanti. Insomma, i più temono l’ira come i bambini un’ombra e le belve una piuma rossa. Priva di forza e instabile, essa impressiona solo chi è debole di carattere. 12. «Per eliminare l’ira bisognerebbe togliere dalla natura la cattiveria, il che, purtroppo, non è possibile». A parte il fatto che si può non aver freddo d’inverno e caldo d’estate, che pure sono due eventi naturali, sia perché ci si trova in un luogo protetto dal clima tipico delle due stagioni, sia perché il corpo riesce a tollerare o a controllare le sensazioni del freddo e del caldo, la tua obiezione potrebbe essere rovesciata così: affinché l’animo possa accogliere l’ira bisogna che prima elimini la virtù, dato che questa non può coabitare coi vizi e non si può essere buoni e al tempo stesso adirati, sani e malati contemporaneamente. «Ma se l’ira è un fatto naturale non è possibile eliminarla dall’animo completamente!». Eppure la natura umana riesce a superare anche le cose più difficili e faticose, rendendole familiari con l’uso di un esercizio continuo, e non esistono passioni così violente ed esclusive da non poter essere domate con una corretta educazione. Tutto ciò che l’animo impone a sé stesso l’ottiene: c’è chi riesce a non ridere mai, chi a non bere vino, chi a non fare l’amore, chi a non assumere qualsiasi tipo di bevanda, chi a dormire poco, dedicando più tempo al lavoro; alcuni hanno imparato a correre avanti e indietro su funi sottilissime e a portare pesi enormi pressoché insostenibili dalla forza dell’uomo, a immergersi a grandissime profondità marine trattenendo a lungo il respiro. E mille altri casi ancora ci sono in cui l’ostinazione riesce a superare ogni ostacolo, dimostrando che nulla è difficile quando la mente si è imposta di sopportarlo. E le persone a cui si riferiscono gli esempi sopra citati non hanno ricevuto alcuna ricompensa per un impegno così tenace, o ne hanno avuta una inadeguata (quale grande onore può pensare infatti di conseguire chi si mette in testa di camminare su delle funi tese, di caricarsi sulle spalle dei pesi enormi, di non concedere gli occhi al sonno o di immergersi nelle profondità marine?), e tuttavia quelle persone si sono impegnate per portare a termine un’impresa da cui non hanno ricavato un gran guadagno. E noi non dovremmo fare appello a tutta la nostra perseveranza in vista di un premio così grande qual è la stabile e serena tranquillità di un animo
felice? Che incomparabile cosa è fuggire l’ira, il più grande dei mali, e con essa la rabbia, la ferocia, la crudeltà, il furore e le altre passioni che l’accompagnano! 13. Non abbiamo bisogno d’inventarci delle scuse per giustificare i nostri vizi, dicendo che uno è utile, un altro è inevitabile, visto che non c’è vizio a cui sia mai mancato un avvocato difensore. Né vale sostenere che certi vizi non si possono estirpare, dato che vi sono malattie perfettamente guaribili, e del resto la natura stessa, che ci ha creati al bene, ci dà una mano, se vogliamo emendarci. Non è poi vero, come sembra ad alcuni, che il cammino verso la virtù sia erto e difficile: è piano e agevole, invece. Non vi dico cose infondate: la via della felicità è facile, bisogna solo intraprenderla sotto buoni auspici e confidando nell’aiuto degli dèi. È molto più difficile fare quello che fate. Cosa c’è di più inoperoso che starsene in pace, cosa di più faticoso che dare ascolto all’ira? Di più distensivo della clemenza, di più impegnativo della crudeltà? La pudicizia non ha alcun impegno, la libidine è sempre indaffarata. Insomma, tutte le virtù sono facili da mantenere, mentre i vizi si fa molta fatica a coltivarli. L’ira va estirpata, e in ciò concorda, sia pure in parte, anche chi ritiene che si debba piuttosto controllarla: togliamola di mezzo, allora, poiché non potrà darci alcuna utilità. Una volta eliminata lei, sarà più facile e più normale debellare i delitti, punire i cattivi e renderli migliori, e il saggio [che deve giudicare] svolgerà il suo dovere senza ricorrere ad alcunché di male e senza l’aggiunta di correttivi che poi debba più o meno preoccuparsi di regolare. 14. Non bisogna dunque mai lasciarsi prendere dall’ira, anche se a volte è necessario simularla, quando, ad esempio, occorre destare l’attenzione di ascoltatori svogliati, così come si eccitano alla corsa i cavalli con gli sproni e con fiaccole ai fianchi; o per incutere timore a chi non sa far buon uso della ragione: ma l’adirarsi non porta alcuna utilità, come l’affliggersi e l’avere paura. «Ma come? Non vi sono dunque motivi che provochino l’ira?». Ed è proprio allora che bisogna contrastarla quanto più possibile. Non è difficile vincere gl’impulsi dell’animo, visto che gli atleti, interessati soprattutto alla cura del corpo, che è l’aspetto materiale del nostro essere, sopportano colpi e dolori, pur di fiaccare le forze dell’avversario, e colpiscono al momento giusto, non quando lo vuole l’ira. Dicono che Pirro, il più grande maestro di atletica, fosse solito raccomandare ai suoi allievi di non lasciarsi prendere dall’ira [nel corso delle gare], perché per causa sua si sovverte ogni regola e si pensa solo a come nuocere agli altri. La ragione ci suggerisce di sopportare, l’ira di vendicarci, e noi, che inizialmente avremmo potuto sbarazzarci di un grosso guaio, rotoliamo in mali peggiori. Alcuni, per non aver saputo sopportare serenamente una sola parola ingiuriosa, sono finiti in esilio, altri, incapaci di tacere di fronte a una trascurabile offesa, sono stati sommersi da un cumulo di disgrazie, altri ancora, sdegnati per aver perso una piccola parte della loro
sfrenata libertà, si sono imposti con le proprie mani il vile giogo della schiavitù. 15. «Non si può negare, tuttavia che l’ira abbia una sua nobiltà: basta vedere i Germani e gli Sciti, che, come tutti i popoli liberi, sono molto irascibili». Ciò accade perché i caratteri forti e saldi per natura, prima di essere ammorbiditi dall’educazione, sono propensi all’ira. Certe inclinazioni naturali sbocciano solo in uomini superiori, così come in un terreno abbandonato crescono piante robuste e rigogliose e da un suolo fertile si sviluppa un alto bosco. Analogamente i caratteri forti per natura sono portati all’ira: pieni di fuoco e passione, non hanno nulla di fragile e delicato; ma la loro forza è imperfetta, incompiuta, come in chi cresce senza una regola, col solo aiuto della natura. Ora, se tali tendenze non sono prontamente addomesticate, questi individui, invece di sviluppare la forza di cui la natura li ha forniti, diventano per abitudine imprudenti e temerari. E poi, come le indoli più miti portano con sé difetti più lievi – la misericordia, il pudore, l’amore appassionato –, così anche in un buon carattere puoi trovare spesso dei difetti, i quali, pur essendo indizi di una natura migliore, non per questo cessano di essere vizi. D’altra parte, tutte queste popolazioni che sono libere in virtù della loro selvatichezza, alla stregua dei lupi e dei leoni, come non si assoggettano alla schiavitù, così non sono capaci di comandare, perché hanno una forza bruta e intrattabile, non quella dell’ingegno, che è tipica dell’uomo: non sa infatti comandare chi non sa anche ubbidire. Per questo motivo lo scettro del dominio e della conquista è quasi sempre nelle mani dei popoli che vivono in climi più temperati: quelli che sono esposti ai freddi del Settentrione hanno un carattere selvaggio, che, come dice il poeta, è quanto mai conforme al loro cielo.37 16. «Fra gli animali i più nobili sono quelli molto inclini all’ira». Non si può stabilire un confronto fra gli animali e l’uomo: gli animali hanno l’istinto al posto della ragione, l’uomo ha la ragione al posto dell’istinto. D’altra parte anche l’istinto non è lo stesso in tutti gli animali: ai leoni giova l’irascibilità, ai cervi la paura, allo sparviero lo slancio, alla colomba la fuga. E se ti dicessi che non è neppure vero che gli animali migliori sono i più irascibili? Ammetto che le belve, per il fatto che si procurano il cibo con la rapina, tanto sono migliori quanto più agiscono sotto l’impulso dell’ira, però vorrei anche lodare la pazienza dei buoi e dei cavalli che ubbidiscono al morso. Ma poi perché applichi all’uomo esempi così infelici quando puoi metterlo a confronto col mondo intero e soprattutto con dio, che solo l’uomo, tra tutti gli esseri viventi, è in grado di comprendere e imitare? «Ma gl’iracondi sono ritenuti gli esseri più schietti e più spontanei». Di fronte ai furbi e agl’imbroglioni senza dubbio, perché sono espliciti, aperti. Io, però, più che schietti li direi sprovveduti: è l’epiteto che diamo agli
sciocchi, ai dissoluti, agli scialacquatori e a tutti quei vizi che mancano di avvedutezza. 17. «Talvolta, però, un oratore è più efficace quando è adirato». Io direi quando finge di esserlo: come gli attori, che quando recitano riescono a commuovere il pubblico non perché siano delle persone adirate ma perché svolgono bene quella parte. Così anche davanti a un giudice, in un’assemblea e dovunque vogliamo piegare al nostro volere l’animo altrui simuleremo ora lo sdegno, ora la paura, ora la pietà, per suscitare negli altri quei sentimenti, anzi, spesso una passione simulata ottiene un risultato che una passione autentica non riuscirebbe a ottenere. «Ma un animo che non s’infiamma è fiacco». Lo è solo se non ha qualcosa di più efficace dell’ira. Non bisogna essere né ladri né derubati, né crudeli né compassionevoli, né troppo teneri né troppo duri: l’uomo saggio sia moderato e usi la forza, non l’ira, se vuole fare le cose con maggiore energia. 18. Ora, esaurito il discorso su tutto ciò che riguarda l’ira, passiamo ai rimedi. Che secondo me si riducono a due: non incorrere nell’ira e, se vi si cade, non commettere sbagli. Come per il corpo vi sono cure preventive per mantenergli la buona salute e altre per restituirgliela, così ce n’è una per tener lontano l’ira e un’altra per frenarla. Per evitarla esistono delle prescrizioni che riguardano l’intero arco della nostra vita e che qui distribuiremo in due momenti: il periodo dell’educazione e quello degli anni successivi. L’educazione richiede la massima diligenza, che gioverà moltissimo in seguito: è facile, infatti, plasmare gli animi in tenera età, difficile è invece recidere i vizi che sono cresciuti con noi. 19. Un temperamento focoso per natura è il più portato all’ira. Infatti, come gli elementi del mondo fisico sono quattro, il fuoco, l’acqua, l’aria e la terra, altrettante sono le forze corrispondenti: il caldo, il freddo, il secco e l’umido. La diversa combinazione degli elementi determina le differenze dei luoghi, degli esseri viventi, dei corpi e dei comportamenti, e i caratteri hanno questa o quella inclinazione a seconda che in loro prevalga l’uno o l’altro elemento. Perciò diciamo che vi sono regioni umide, aride, calde e fredde. Ebbene, le stesse differenze si trovano nell’uomo e negli animali, ed è importante la quantità di umido e di caldo che ciascuno di essi possiede, giacché la porzione dell’elemento che prevale ne determina il comportamento. Così un animo focoso per natura renderà irascibili, perché il fuoco è sempre in movimento e ostinato, una combinazione in cui prevalga il freddo renderà timidi, perché il freddo è inerte e chiuso in sé stesso. Per questo alcuni della nostra scuola sostengono che l’ira insorge nel petto quando il sangue ribolle intorno al cuore, il quale sarebbe la sede dell’ira per il solo fatto che il petto è la parte più
calda di tutto il corpo. In quelli in cui prevale l’umido l’ira cresce a poco a poco, perché in loro il calore non è ancora pronto ad agire ma si produce via via col movimento: perciò gli scatti d’ira dei bambini e delle donne inizialmente sono più leggeri e comunque più violenti che dannosi. Nell’età asciutta, infatti, l’ira è impetuosa e robusta ma non cresce e non fa in tempo a potenziarsi d’altro perché sopravviene subito il freddo che ne smorza il calore. I vecchi sono intrattabili e lagnosi, come gli ammalati, i convalescenti e tutti quelli in cui il calore si è esaurito per spossatezza o perdite di sangue; nelle stesse condizioni si trovano i rabbiosi per fame e per sete e in genere gli anemici, i denutriti e i soggetti a svenimenti. Il vino accende l’ira perché aumenta il calore, e c’è chi ribolle perché ubriaco, chi perché ferito: dipende dalla natura di ciascuno. Il motivo per cui i biondi e i rossi sono particolarmente collerici sta nel fatto che in loro quel colore è naturale – e per questo hanno il sangue veloce e agitato – mentre gli altri di solito si arrossano quando sono in preda all’ira. 20. Ora, se da un lato la natura crea degli individui già inclini all’ira, dall’altro sopravvengono molte cause che producono i medesimi effetti: c’è chi è condotto a quel vizio da una malattia o da una menomazione fisica, chi dalla fatica, dalle veglie continue, dalle ansie notturne e dai desideri d’amore: tutto ciò che nuoce al corpo o all’animo porta lo spirito malato a sfogarsi. Ma questi sono gl’inizi e le cause dell’ira: un notevole apporto le fornisce l’assuefazione, che quando è ostinata alimenta il vizio. Certo è difficile cambiare la natura di un individuo, perché una volta mescolatisi i vari elementi nel periodo della gestazione non è più possibile mutarne la combinazione; ma a tale scopo, per fare un esempio, giova l’aver scoperto che ai temperamenti caldi non si deve somministrare il vino, una bevanda che Platone vieta ai fanciulli perché, dice, non si deve alimentare il fuoco con altro fuoco. E non si dovrebbe neppure ingozzarli di cibo, perché ingrossandosi il corpo si gonfia anche l’animo. Il lavoro li tenga pure impegnati ma non sino all’estremo della fatica, inquantoché il calore deve diminuire, non estinguersi del tutto, e l’ardore eccessivo ha bisogno di sfogo. Anche i giochi potranno aiutare, perché il piacere, quando sia misurato, rilassa e ritempra gli animi. I temperamenti piuttosto umidi o secchi e quelli freddi sono generalmente immuni dagli attacchi dell’ira, ma devono guardarsi da vizi maggiori, come la paura, l’intrattabilità, la disperazione e il sospetto. Questi caratteri vanno addolciti, stimolati e richiamati a una visione lieta della vita. E poiché i rimedi contro l’ira e contro la tristezza sono differenti, per non dire addirittura opposti, dovremo prendere di petto il vizio che si è sviluppato di più. 21. Gioverà moltissimo impartire subito ai bambini una buona e sana educazione, con l’accortezza, però, dato che non è facile governarli, di non alimentare in loro l’ira e al tempo stesso di non limarne il carattere. Ciò comporta uno studio attento e meticoloso, perché i mezzi per eccitare e per
reprimere sono simili e le cose simili possono trarre in inganno anche le persone più scrupolose. La libertà arricchisce lo spirito, la schiavitù lo impoverisce; le lodi lo esaltano e lo inducono ad aver fiducia in sé stesso, ma possono anche renderlo irascibile e intollerante: perciò bisogna guidare il bambino fra questi due estremi, usando ora il morso, ora lo sprone. Non bisogna mai umiliarlo con cose ignobili o servili, mai metterlo in condizione di dover chiedere supplicando o che gli giovi averlo fatto: meglio che gli sia dato per merito suo, per quello che ha fatto in precedenza e per ciò che di buono si propone di fare in futuro. Nelle gare con i coetanei non gli sia consentito né di lasciarsi vincere, né di adirarsi; gli sia dato di frequentare coloro con i quali è solito gareggiare affinché si abitui a gareggiare per vincere, non per nuocere agli altri, e quando avrà vinto o fatto qualcosa degno di lode lasciamo che se ne compiaccia ma senza vantarsene: la gioia, infatti, accende l’entusiasmo, l’entusiasmo può diventare arroganza, presunzione ed eccessiva stima di sé. Gli concederemo qualche svago, facendo però in modo che non si svigorisca nella pigrizia e nell’ozio, e lo terremo lontano dall’influsso dei piaceri, poiché niente rende più irascibili che un’educazione debole e blanda: è per questo che i più corrotti d’animo sono i figli unici, che godono di maggior indulgenza, e gli orfani adottati, a cui tutto viene concesso. Non saprà sopportare un’offesa, una contrarietà, chi non s’è visto negare mai nulla, chi ha sempre avuto una madre pronta ad asciugargli le lacrime o a cui sia stata data soddisfazione davanti al suo pedagogo. Non vedi come a un maggior benessere si accompagni una maggiore irascibilità? Essa si manifesta soprattutto nei ricchi, nei nobili, in coloro che rivestono alte cariche, quando al minimo soffio di vento favorevole anche ciò che di insignificante e di inutile era nel loro animo cresce e s’innalza. La prosperità alimenta l’ira allorché una turba di adulatori assedia le orecchie di un presuntuoso: «E tu ti fai rimbeccare da quello lì? Ma come osa? Non ti stimi quanto meriti, ti mortifichi da te!». E altre cose del genere dicono, a cui a stento sanno resistere menti sane e ben salde da sempre. I fanciulli stiano alla larga dagli adulatori e prestino le orecchie al vero. Abbiano timore talvolta, siano sempre rispettosi e si alzino in piedi davanti agli adulti. Nulla ottengano con l’ira: ciò che chiedono piangendo glielo si dia solo quando si saranno calmati. Abbiano davanti agli occhi le ricchezze dei genitori, ma non sia loro concesso di usarle. E quando sgarrano si abbia il coraggio di rimproverarli. È inoltre opportuno che gli si mettano accanto precettori e maestri pacati, perché i fanciulli si appoggiano facilmente a chi gli sta vicino e crescono conformandosi a lui; poi, fattisi adolescenti, rispecchieranno i costumi delle nutrici e dei pedagoghi. Un giorno un ragazzo, che i genitori avevano mandato da Platone affinché fosse educato da lui, al suo ritorno in famiglia, vedendo il padre strillare, esclamò: «In casa di Platone non ho mai visto nulla del genere!». Ebbene, sono certo che di lì a poco avrà smesso d’imitare il filosofo e seguito l’esempio del padre.
Si diano infine ai fanciulli un vitto frugale innanzitutto, abiti non raffinati e un tenore di vita conforme a quello dei coetanei, così non si adireranno quando si dovessero fare dei paragoni fra loro e gli altri, visto che tutti, fin dall’inizio, sono stati messi sullo stesso piano. 22. Ma ciò riguarda i nostri figli; per noi, ormai, sia per la condizione di nascita che ci è toccata, sia per l’educazione ricevuta, non c’è più spazio né per i vizi né per gl’insegnamenti: dobbiamo solo pensare a darci una regola per il tempo che ci resta da vivere, affrontando l’ira alle origini, e poiché ciò che scatena l’ira è l’idea di essere stati offesi la prima cosa da fare è quella di non crederci. Né dobbiamo prestar subito fede a indizi che ci appaiono evidenti e inconfutabili, visto che spesso il falso si presenta sotto l’aspetto del vero. Bisogna insomma aspettare: col tempo la verità viene sempre fuori. Non dobbiamo credere facilmente alle accuse: diffidiamo, tenendolo sempre presente, di quel difetto, tipico dell’umana natura, che c’induce a prestar fede volentieri a tutto ciò che nostro malgrado ascoltiamo e che ci manda l’animo in bestia prima ancora che la mente abbia formulato un giudizio. Che dire poi del fatto che reagiamo non soltanto alle accuse ma anche ai sospetti, e che, scambiando un sorriso o una frase ingenua per un’offesa, ci adiriamo con degli innocenti? Dobbiamo dunque tenere l’ira in sospeso e assumere contro noi stessi le ragioni di chi riteniamo che ci abbia offeso: una punizione, infatti, può essere inflitta anche in ritardo, mentre una volta inflitta non può essere revocata. 23. È noto quel [mancato] tirannicida,38 che, fallita l’impresa di uccidere Ippia, catturato e messo alla tortura dal tiranno affinché denunciasse i suoi complici, fece i nomi degli amici di lui che gli facevano da guardia del corpo e che sapeva sommamente interessati alla sua salvezza. E quando Ippia, dopo averli fatti uccidere a uno a uno via via che lui li nominava, gli chiese se ce ne fosse ancora qualcun altro, rispose: «Tu solo: non ho lasciato infatti nessuno che ti fosse caro». Ebbene, l’ira indusse il tiranno a prestare al tirannicida la propria mano perché uccidesse con la sua stessa spada quelli che lo proteggevano. Ben più coraggioso fu Alessandro! Il quale, benché la madre 39 gli avesse inviato una lettera in cui lo esortava a guardarsi dal veleno del medico Filippo, per nulla spaventato, prese la pozione e la trangugiò, credendo più al proprio giudizio, riguardo alla lealtà dell’amico, che a quello della madre. Quanto più degno fu lui, che ritenne innocente l’amico e compì un simile gesto! E ancor di più lo lodo perché nessuno fu soggetto all’ira come lo era Alessandro: quanto più rara, infatti, è la moderazione nei re, tanto più è da lodare. Così si comportò anche Gaio Cesare, che dopo la vittoria nella guerra civile fu molto clemente coi vinti: impadronitosi degli scrigni contenenti le lettere spedite a Gneo Pompeo da persone che si diceva avessero militato nel partito avversario o fossero stati neutrali, le bruciò [senza nemmeno leggerle].40
Nonostante fosse solito controllarsi quando si adirava, quella volta preferì evitare di farsi prendere dall’ira, ritenendo che ignorare quale colpa avesse commesso ciascuno di loro fosse il più gradito genere di perdono. 24. La credulità è causa di moltissimi inconvenienti. Spesso non si dovrebbe nemmeno ascoltarle certe cose perché in quei casi è meglio l’inganno che il sospetto. Gli stimoli più insidiosi che si devono scacciare dall’animo sono proprio i sospetti e le congetture: «Quello mi ha salutato poco amabilmente, quello non ha ricambiato il mio bacio, quello m’ha tolto subito la parola, quello non mi ha invitato a cena, quello mi è parso che non mi guardasse nemmeno». Troveremo sempre qualche motivo per diffidare di qualcuno. Dobbiamo dunque guardare i fatti e valutarli con animo semplice e ben disposto, non credere a niente se non a ciò che ci balza agli occhi e ci appare ben chiaro, e ogni volta che i nostri sospetti si riveleranno infondati recitiamo il mea culpa per la nostra credulità: questo biasimo ci abituerà a non credere facilmente. 25. Da ciò consegue che non dobbiamo irritarci per cose banali e meschine. Lo schiavetto è poco sveglio, l’acqua da bere che mi ha portato non è fresca, il letto è in disordine, la tavola è apparecchiata male: è da dementi arrabbiarsi per cose del genere. Chi si raggomitola per una leggera corrente d’aria è malato o cagionevole di salute, sono sofferenti quegli occhi che restano infastiditi dal candore di una veste e un debosciato è colui che sente male ai fianchi nel vedere faticare gli altri. A questo proposito si narra di un certo Mindiride, 41 nativo di Sibari, che diede segni di stanchezza nel vedere uno zappare la terra e sollevare in alto il rastrello, e per questo gli vietò di fare quel lavoro in sua presenza. Spesso accusò un travaso di bile per aver dormito su petali di rosa sgualciti. Quando i piaceri insieme al corpo hanno corrotto anche l’animo nulla sembra più sopportabile, non perché siano moleste le cose ma perché chi se ne lamenta è un rammollito. Che motivo c’è di arrabbiarsi perché uno tossisce o starnuta, o è poco zelante nel cacciare una mosca, perché s’incontra un cane o perché al servo sbadato è caduta di mano la chiave? Un individuo simile potrà mai sopportare pazientemente le liti dei tribunali e le imprecazioni che volano nelle assemblee o nel senato se le sue orecchie si sentono offese dallo stridio di uno sgabello che viene spostato? Sopporterà la fame e la sete in una spedizione estiva se si arrabbia col servo che non gli scioglie bene il ghiaccio nel bicchiere? Non c’è cosa che alimenti l’ira più del lusso sfrenato e intemperante: l’animo va trattato con durezza, dimodoché fra i colpi che riceve senta solo quelli tosti. 26. Spesso ci adiriamo anche con cose o con persone che non hanno alcuna capacità di offenderci, o che lo potrebbero solo teoricamente. Fra le prime ci sono quelle prive di sentimenti, come un libro che a volte buttiamo in quanto è scritto con caratteri troppo piccoli, o che laceriamo perché zeppo di errori; così come strappiamo un vestito che non ci piace: quanto è sciocco arrabbiarsi con
degli oggetti, che non meritano e non possono neppure sentire la nostra ira! «Ma ci offendono quelli che li hanno fatti!». Innanzitutto questa distinzione la facciamo dopo, quando già ci siamo adirati. In secondo luogo anche gli artigiani che hanno prodotto quegli oggetti potrebbero addurre delle plausibili giustificazioni: uno non era in grado di far meglio e se ha imparato male il mestiere non lo ha certo fatto per offendere te; un altro non ha lavorato con quello scopo. E infine, cosa c’è di più stupido che scaricare sulle cose la bile accumulata contro gli uomini? E com’è irragionevole adirarsi con gli oggetti inanimati così lo è con gli animali, che non ci arrecano alcuna offesa perché non possono volerlo: l’offesa infatti è tale solo quando vi sia l’intenzione. Le bestie possono farci del male, come un ferro o una pietra, ma non ferirci nell’animo. Eppure c’è chi si ritiene offeso se un cavallo, docile con un altro cavaliere, fa il ribelle con lui: come se certi animali fossero più obbedienti con alcuni per deliberato proposito e non per abitudine o per il modo in cui sono trattati. E com’è irragionevole adirarsi con gli animali, così è sciocco prendersela con i bambini e con chi ha l’animo di un fanciullo: un giudice onesto, infatti, ritiene scusabili i loro errori perché dovuti a una scarsa capacità di riflessione. 27. Ci sono esseri che non possono fare alcun male e il cui potere, anzi, è solo benefico e salutare. Tali sono gli dèi immortali, la cui natura è mite e tranquilla, tanto aliena dal nuocere agli altri quanto a loro stessi. Sono dunque stolti e lontani dal vero quelli che imputano agli dèi la furia del mare, le piogge eccessive, il protrarsi della stagione invernale, quando in effetti nessuno dei fenomeni che ci danneggiano o ci giovano è propriamente indirizzato a noi: non siamo infatti noi la causa per cui sulla terra si alternano l’estate e l’inverno, questi eventi sono soggetti alle stesse leggi che governano i corpi celesti. Abbiamo di noi un concetto troppo alto se ci riteniamo tali che una così grande forza si muova per noi. Nulla di tutto questo è fatto per colpirci, nulla per aiutarci. Fra gli esseri che, come abbiamo detto, non possono nuocere o che non lo vogliono ci sono i buoni magistrati, i genitori, gli educatori e i giudici, le cui punizioni devono essere accettate come i ferri del chirurgo, la dieta e altre cose che ci fanno soffrire in vista di un bene futuro. Se siamo stati puniti non dobbiamo pensare soltanto a ciò che stiamo soffrendo ma anche a quel che abbiamo fatto, mettendo in discussione la nostra vita: se appena appena saremo capaci di confessare a noi stessi la verità, giudicheremo più severamente la questione che ci riguarda. 28. Se vogliamo essere sempre onesti nel giudicare le cose dobbiamo innanzitutto convincerci che nessuno è senza colpa. Il nostro maggiore risentimento è infatti quello che nasce dalla presunzione di non avere sbagliato: «Io non ho fatto niente!», protestiamo. La verità è che non vogliamo ammetterlo!
Ci indigniamo se siamo stati rimproverati o puniti, commettendo così un’altra colpa, perché al mal fatto aggiungiamo l’arroganza e la ribellione. Nessuno può dichiararsi innocente davanti a tutte le leggi. E anche se ciò fosse possibile, che innocenza ristretta è quella che induce a comportarsi rettamente solo per via della legge! Quanto è più estesa rispetto a questa la regola dei doveri! Quanti obblighi esigono la pietà, l’umanità, la liberalità, la giustizia, la lealtà, tutti valori che non sono inscritti nelle tavole della legge! Ma noi non riusciamo nemmeno a rispettare quella formula restrittiva dell’innocenza, poiché oltre alle colpe realmente commesse ne abbiamo anche pensate, desiderate, favorite, e di certe azioni siamo innocenti solo perché non hanno avuto alcun risultato. Riflettiamo, dunque, e siamo più giusti con chi sbaglia, confidiamo in chi ci rimprovera, non adiriamoci con i buoni (se lo facciamo con loro, con chi non dovremmo adirarci?), e soprattutto non prendiamocela con gli dèi, poiché non è per colpa loro, è per la nostra condizione di mortali che soffriamo i guai che ci accadono. «Ma ci piombano addosso malattie e dolori!». Comunque dovremo pure abbandonarla questa putrida dimora che ci è toccata in sorte. Ci dicono che Tizio ha parlato male di noi? Chiediamoci se non l’abbiamo fatto noi per primi, visto che parliamo di tante persone. Riflettiamo che alcuni in realtà non ci hanno offeso, ma si sono limitati a ricambiare l’offesa che gli abbiamo fatto noi, che altri ci offendono per il nostro bene, o perché vi sono costretti o perché non se ne accorgono, e che spesso anche chi ci ha offeso volutamente e consapevolmente non ne aveva l’intenzione, ma lo ha fatto o perché si è lasciato trascinare dal gusto di una battuta, o perché non poteva fare una determinata cosa senza offenderci: spesso l’adulazione mentre blandisce offende. Se teniamo a mente quante volte abbiamo nutrito sospetti infondati, quante volte le nostre attenzioni sono potute sembrare agli altri un’offesa e quante persone abbiamo preso ad amare dopo averle detestate, ebbene, allora possiamo evitare di adirarci, soprattutto se ogni volta che ci sentiamo offesi pensiamo: «Questo l’ho fatto anch’io». Ma dove lo trovi un giudice così onesto? Come uno che s’incapriccia solo di donne sposate, ritenendo che il motivo più giusto per innamorarsene sia proprio il fatto che sono mogli di altri, e poi si arrabbia se qualcuno guarda la sua: chi è sleale è il più esigente nel pretendere la lealtà, lo spergiuro non tollera le menzogne, il calunniatore non sopporta che gli si faccia causa e chi è senza pudore non vuole che si attenti a quello dei suoi schiavetti. I vizi altrui li abbiamo davanti agli occhi, i nostri dietro le spalle: ecco così che un padre crapulone rimprovera il figlio perché trascina a lungo i suoi banchetti, che un libertino impenitente nulla perdona alla lussuria degli altri, che il tiranno s’infuria con l’omicida e il sacrilego punisce i ladri. La maggior parte degli uomini si adira non contro i peccati ma contro i peccatori. Diventeremo più moderati se sapremo analizzare noi stessi
chiedendoci: «Forse che anche noi non abbiamo commesso qualcosa di simile? Non abbiamo sbagliato allo stesso modo? Ci conviene, dunque, condannare questi comportamenti?». 29. Il miglior rimedio dell’ira è l’indugio, l’attesa. All’inizio chiedile non di perdonare ma di riflettere: i suoi primi impulsi sono pesanti, ma se saprà aspettare si calmerà. E non cercare di scacciarla tutta in una volta, perché l’ira si piega soltanto se la s’indebolisce a poco a poco. Fra le cose che ci offendono, alcune ci vengono riferite, altre le ascoltiamo o le vediamo di persona. Alle prime non dobbiamo prestar subito fede: molti mentono per ingannare, molti perché sono stati ingannati, c’è chi cerca di entrare nelle tue grazie accusando qualcuno e s’inventa un’offesa per farsi vedere dispiaciuto che ti sia stata fatta; c’è poi il maligno, che vuole rompere le tue amicizie più strette, il sospettoso, colui che, come se si trattasse di un gioco, ama fare lo spettatore, guardando da lontano, e standosene al sicuro, quelli che ha fatto azzuffare. Se dovessi processare uno per il furto di una piccola somma di denaro non riterresti vero il fatto senza alcuna prova testimoniale, non accetteresti una testimonianza non giurata, ascolteresti entrambe le parti, e non una sola volta, ma concedendo loro il tempo necessario, perché la verità ci risulta più chiara ed evidente quanto più la giriamo fra le mani: tu lo condanneresti un amico seduta stante? Ti arrabbieresti prima di ascoltarlo, d’interrogarlo, prima che gli sia concesso di conoscere il suo accusatore o l’accusa che gli viene mossa? Hai già sentito le due parti? Se chiederai al delatore di addurre le prove lui la smetterà, dicendoti: «È inutile che tu mi tiri in ballo, se mi chiamerai a testimoniare io negherò tutto, e da quel momento non ti riferirò più nulla». Così nello stesso tempo quello provoca e si sottrae al rischio del confronto. Chi riporta una notizia ma di nascosto è come se non la raccontasse. Non c’è nulla di più ingiusto che credere a una notizia riferita in tutta segretezza e adirarsi pubblicamente. 30. Quanto alle offese di cui siamo testimoni diretti dobbiamo vagliare l’indole e le intenzioni di chi le fa. È un ragazzo? Lo si perdoni per l’età, poiché non si rende conto che sbaglia. È un padre? O lui ci ha già fatto tanto bene da avere anche il diritto di offenderci, o noi scambiamo per offesa un suo favore. È una donna? Sbaglia. È uno a cui l’offesa è stata imposta da altri? Solo una persona irragionevole può adirarsi con l’esecutore di un ordine. È uno che hai offeso? Non è un’offesa subire ciò che tu hai fatto per primo. È un giudice? Devi dare più credito al suo giudizio che al tuo. È un re? Se ti punisce perché sei colpevole, arrenditi alla giustizia, se invece sei innocente, arrenditi alla cattiva sorte. È un animale, o qualcosa di simile che ignora l’uso della parola? Se ti adiri diventi uguale a lui. È una malattia o una disgrazia? Passerà, e ti farà meno male se saprai sopportarla. È un dio? È fatica sprecata adirarsi con lui, quanto il pregarlo di adirarsi con altri. È un galantuomo colui che ti ha offeso? Fa’ conto
che non sia vero. È un malvagio? Non dartene pensiero: pagherà a un altro lo scotto che doveva pagare a te: a sé stesso lo ha già pagato, per il fatto di avere sbagliato. 31. Come ho detto, due sono le cause dell’ira: la prima nasce dall’idea di aver ricevuto un’offesa, e di questo abbiamo già parlato abbastanza, la seconda dalla convinzione di averla subìta ingiustamente, e questo è l’argomento che dobbiamo trattare. Noi giudichiamo ingiusti certi fatti che ci riguardano per due motivi: o perché riteniamo che non avremmo dovuto subirli, o perché non ce li aspettavamo: l’imprevisto, insomma, non ci appartiene, non lo meritiamo. Perciò ci turba moltissimo tutto ciò che accade contro le nostre attese e le nostre speranze, mentre non ci sentiamo offesi da quei piccolissimi sgarbi che riceviamo abitualmente fra le pareti domestiche, e ci guardiamo dal chiamare offesa la negligenza dimostrataci da un amico. «E perché allora ci turbano le offese dei nemici?». Perché non ce le aspettavamo, o certamente non così gravi. Ciò deriva dal nostro eccessivo amor proprio: pretendiamo, infatti, di non essere molestati nemmeno dai nostri nemici. Ciascuno ha l’animo di un re: massima libertà nei confronti degli altri, ma zero degli altri nei suoi confronti. L’inesperienza o l’ignoranza delle cose: ecco ciò che ci rende irascibili. Che meraviglia se i malvagi compiono azioni malvagie? Che c’è di strano se un nemico fa del male, se un amico offende, un figlio sbaglia, un servo commette qualcosa di storto? Quinto Fabio Massimo soleva ripetere che per un generale la scusa più vergognosa consiste nel dire: «Non ci avevo pensato». Ebbene, io la ritengo vergognosissima per ogni uomo. Bisogna pensare e aspettarsi di tutto: anche nei buoni costumi può esserci un che di sgradito. La natura umana non manca di animi perfidi, ingrati, avidi ed empi, perciò nel giudicare il comportamento di uno solo pensa a quello di tutti. Dove più avrai motivo di rallegrarti più dovrai stare in guardia. Dove tutto ti appare calmo e tranquillo c’è sempre qualcosa che cova ai tuoi danni: non lo vedi perché sonnecchia. Fa’ conto, insomma, che puoi sempre imbatterti in qualche malanno. Un nocchiero non spiega mai tranquillamente tutte le vele senza tenere pronti gli attrezzi necessari per ammainarle alla svelta. Ma soprattutto convinciti di questo, che la volontà di nuocere è vergognosa, esecrabile e del tutto estranea all’uomo, a cui la natura ha concesso il privilegio di rendere mansuete anche le bestie feroci, sicché si vedono elefanti che piegano il collo al giogo, tori che si lasciano cavalcare impunemente da ragazzi e da donne che vi saltellano sopra, serpenti che strisciano innocui fra le coppe e sui petti delle persone, mentre fra le mura domestiche orsi e leoni si fanno tranquillamente accarezzare il muso e terribili fiere blandiscono i loro padroni: pensa a tutto ciò e ti vergognerai di comportarti come gli animali. Come non è lecito nuocere alla patria così non si deve offendere un cittadino,
in quanto è parte della patria stessa: se infatti la comunità è sacra e inviolabile lo sono anche le parti che la compongono. Dunque non si deve nuocere ad alcuno, poiché tutti gli uomini sono nostri concittadini in una patria più grande. Cosa accadrebbe se le mani decidessero di nuocere ai piedi, o gli occhi alle mani? Come tutte le membra sono fra loro in armonia, perché l’efficienza di ognuna giova a tutto l’insieme, così gli uomini devono proteggere i singoli, perché sono stati generati per vivere in società, e una società non può reggersi se non sul rispetto e sull’amore fra le parti. Noi non ammazzeremmo neppure le vipere, le bisce acquatiche o le altre bestie dal morso o dalla puntura letale se potessimo renderle mansuete o fare in modo che non fossero pericolose per noi o per gli altri. Analogamente non faremo del male all’uomo se non per punirlo, e non perché ha sbagliato ma affinché non sbagli più, giacché il castigo deve guardare al futuro, non al passato: si punisce, infatti, non perché mossi dall’ira, ma per far sì che l’errore non si ripeta. D’altra parte, se si dovessero punire tutti coloro che sono d’indole empia o malvagia nessuno sfuggirebbe alla pena. 32. «È anche vero, però, che l’ira provoca un certo piacere ed è gratificante restituire il male che si è ricevuto». Assolutamente no, non deve accadere così: se infatti è bello ricambiare beneficio con beneficio non lo è altrettanto rendere offesa con offesa. Nel primo caso è sconveniente lasciarsi superare, nel secondo lo è il superare. La parola «vendetta» non si addice all’uomo, anche se è ritenuta giusta. Il contrappasso, l’occhio per occhio, differisce dall’offesa solo in quanto si verifica in un secondo momento: anche colui che ricambia il male commette una colpa, la differenza sta nel fatto che è più scusato. Un tale ai bagni percosse Marco Catone senza sapere chi fosse (nessuno, infatti, conoscendolo, lo avrebbe offeso), e quando poi si scusò, Catone gli rispose: «Non ricordo d’esser stato colpito», preferendo così ignorare l’offesa piuttosto che vendicarla. «Ma come, quel tizio non ha subìto alcun danno dopo tanta insolenza?». Al contrario, ne ha ricevuto un bene, poiché ha imparato a conoscere Catone. Non curarsi delle ingiurie ricevute è segno di magnanimità: la vendetta più infamante è far vedere all’offensore che non lo si ritiene meritevole di vendetta. La quale spesso fa apparire un’offesa di poco conto più grave di quanto non sia stata in realtà. Grande e nobile è colui che si mostra insensibile alle offese, come una grossa belva che ascolta senza battere ciglio l’abbaiare di innocui cagnolini. 33. «Ma se non ci vendichiamo andiamo incontro a un’offesa maggiore». Se pensiamo che la vendetta sia un rimedio, prendiamocela pure, ma senza adirarci, in vista della sua utilità, non per nostra personale soddisfazione. Spesso, però, è meglio fingere di ignorare l’offesa piuttosto che vendicarsi. Le ingiurie dei potenti vanno sopportate pazientemente e col sorriso sulle labbra, onde evitare che quelli, se ci mostriamo offesi, ci provino gusto. Chi insuperbisce della sua buona sorte ha questo pessimo difetto: odia tutti quelli che
offende. È nota la storiella di quel tale che, giunto alla vecchiaia dopo aver servito un re dietro l’altro, a uno che gli aveva chiesto come fosse arrivato a quell’età – visto che invecchiare, per chi viveva a corte, era piuttosto raro – rispose: «Ricevendo offese e ringraziando». Spesso, poi, la vendetta è così sconveniente che non giova nemmeno dire di essere stati offesi. Caligola aveva fatto incarcerare il figlio di Pastore, un illustre cavaliere romano, solo perché si sentiva offeso dalla sua eleganza e dalla sua accurata capigliatura. Avendolo il padre pregato di liberarlo, ordinò che il prigioniero venisse subito ucciso, come se il vecchio invece della grazia gli avesse chiesto la condanna a morte. Poi, per non incrudelire del tutto su di lui, in quello stesso giorno lo invitò a cena. Pastore vi andò senza mostrare nel volto alcuna espressione di rimprovero. Cesare ordinò che gli fosse versato mezzo litro di vino e gli mise accanto uno che lo sorvegliasse. Ebbene, quel poveretto ebbe la forza di resistere e trangugiò il liquido come se bevesse il sangue del figlio. Caligola gli fece portare unguenti e corone, sempre ordinando di controllare se accettava quei doni, e lui se li prese. Nel giorno stesso del funerale del figlio, anzi, nel giorno in cui gli era stato vietato di seppellirlo, se ne stava seduto a banchetto fra cento commensali, lui, vecchio e malato di podagra, trangugiando bevande che sarebbero state eccessive persino per festeggiare la nascita dei figli. E non versò una lacrima, non permise al dolore di manifestarsi minimamente: cenò come se avesse ottenuto la grazia per il figlio. Vuoi sapere perché? Gliene restava un altro. «E Priamo, allora? Non nascose l’ira anche lui, non abbracciò le ginocchia di Achille, non ne baciò l’infausta mano ancora intrisa del sangue del figlio, non si sedette anch’egli alla sua mensa?» Sì, ma senza unguenti, profumi e corone di fiori, e quel nemico spietato, pur nella sua crudeltà, lo esortò con molte parole di conforto a prender cibo, non lo costrinse a prosciugare enormi coppe di vino sotto lo sguardo di un controllore che incombeva sopra la sua testa. Quel padre romano sarebbe da disprezzare se avesse agito così perché temeva per la propria vita: fu invece l’amore per il figlio che l’indusse a comportarsi in quel modo e lo trattenne dall’ira. Però, almeno dopo il banchetto avrebbe meritato di andare a raccogliere le ossa del figlio, ma il giovane Caligola, che pur sapeva a volte essere benevolo e gentile, non gli permise neppure questo: continuava a provocare il vecchio con un brindisi dietro l’altro per lenire il suo dolore; ma quello si mostrò sereno e dimentico di ciò ch’era accaduto in quel giorno: se non fosse stato un commensale così garbato il carnefice gli avrebbe ucciso anche l’altro figlio. 34. Bisogna dunque non lasciarsi mai prendere dall’ira, chiunque sia colui contro cui vorremmo scagliarci, un nostro pari, un superiore o un inferiore. Nel primo caso, infatti, l’esito dello scontro è incerto, nel secondo sarebbe un’impresa pazzesca, nel terzo meschina. Mordere chi ci ha morso è cosa gretta e spregevole: i topi e le formiche come accosti la mano scappano; i deboli si
ritengono offesi se soltanto li sfiori con un dito. Pensiamo invece se la persona contro cui è rivolta la nostra ira ci è stata utile qualche volta: ciò ci renderà più indulgenti e i suoi meriti riscatteranno l’offesa. Non dimentichiamo poi il favore popolare che potrà procurarci la fama della nostra clemenza e quanti amici utili ci acquisterà il perdono. Tanto meno dobbiamo adirarci coi figli dei nostri nemici o avversari: nulla, infatti, è più esecrabile che il far ricadere sui figli l’odio che si ha per i padri. Come fece Silla, che fra i tanti esempi di crudeltà annovera anche quello di aver mandato in esilio i figli dei proscritti. Quando ci riesce difficile perdonare chiediamoci che cosa mai ci guadagniamo a essere tutti inesorabili: quante volte chi l’ha negato ha poi dovuto chiedere il perdono! O si è gettato ai piedi di colui che aveva respinto dai suoi! Cosa c’è di più nobile che trasformare l’ira in amicizia? Il popolo romano non ha forse tra i suoi più fedeli alleati quelli ch’erano stati i suoi più acerrimi nemici? Che impero sarebbe il nostro se una salutare lungimiranza non avesse fuso insieme vinti e vincitori? Uno si adira contro di te? E tu provocalo con un gesto di bontà. Una sfida se l’altra parte non la raccoglie cade subito nel vuoto: non si può combattere, infatti, se non si è in due. Ma se l’uno e l’altro fanno a gara a chi è più adirato lo scontro è inevitabile. Il migliore è quello che cede per primo: in pratica vince chi perde. Se ti colpisce, ritirati, se controbatti gli dài l’occasione e il pretesto per continuare a colpire e a quel punto non servirà più che tu decida di mollare. Nessuno vorrebbe colpire il nemico così pesantemente da lasciare la mano nella ferita senza potersi ritrarre dal colpo vibrato. L’ira, invece, è come un’arma che una volta lanciata diventa poi difficile ritirare. Nello scegliere un’arma la prima cosa a cui badiamo è la praticità: una spada dev’essere maneggevole ed efficace. Analogamente noi cerchiamo di evitare quegli impulsi dell’animo che sono pesanti, funesti e irrevocabili. Lodevole è infine quella velocità che quando riceve l’ordine di fermarsi si arresta, che non va oltre la meta stabilita, che sa cambiare direzione e passare dalla corsa all’andatura normale. È noto che i nervi si affaticano se li muoviamo contro voglia, e chi volendo camminare si mette a correre o è vecchio o è malato: sono da ritenersi quanto mai validi e sani quei moti dell’animo che seguono la nostra volontà, non quelli che vanno per conto loro. 35. Nulla, però, ci sarà tanto utile quanto il considerare prima di tutto l’aspetto ripugnante di questo vizio, poi il pericolo che ne deriva. L’ira è fra le passioni la più sconvolgente a vedersi: sfigura i visi più belli e rende torvi quelli più sereni. L’adirato perde ogni decoro: se prima portava il mantello sì che le pieghe cadessero a regola d’arte, ora invece se lo trascina dietro senza alcun riguardo; i capelli, che prima, per natura o per arte, stavano bene adagiati intorno alla testa, all’insorgere dell’ira si rizzano; le vene si ingrossano, il petto è scosso da un respiro affannoso, il collo si gonfia per il rabbioso erompere della voce, gli arti si fanno tremanti, le mani irrequiete, il corpo è tutto un
fremito. E dentro? Come pensi che sia l’animo di un uomo che offre esternamente un’immagine così ripugnante? Quanto dev’essere più terribile il suo volto interiore, quanto più furioso il respiro, più violenta la tensione, pronta a farlo scoppiare se non riesce a trovare uno sfogo! Quale è l’aspetto dei nemici o degli animali feroci quando sono intrisi di sangue o si dispongono alla strage, quali sono i mostri infernali raffigurati dai poeti col corpo avvolto da serpenti e con la bocca di fuoco, quali le più spaventose divinità degli inferi che erompono dal sottosuolo per suscitare guerre, seminare discordie e infrangere paci fra i popoli, tale dobbiamo immaginarci l’ira: strepitante di sibili, di muggiti, di gemiti, di grida e di ogni altro insopportabile suono, gli occhi ardenti di fiamme, irte e vibranti di strali entrambe le mani (poiché, tutta tesa a offendere, nulla porta a sua protezione), torvo lo sguardo, imbrattata di sangue, coperta di cicatrici, livida dei colpi che lei stessa si è inferti, furiosa nell’incedere, avvolta in un denso fumo, pronta ad assalire, a devastare, a volgere in fuga, agitata da un odio indiscriminato contro chiunque, e, se non può nuocere ad altri, persino contro sé stessa, smaniosa di distruggere terre, mari e cielo, ostile e osteggiata insieme. Così è l’ira. Ma, se si vuole, va anche bene la descrizione che ne fanno i nostri poeti: … e con la veste sbrindellata esulta la Discordia, seguita da Bellona col suo rosso flagello insanguinato.42 O qualunque altra, ancora più terribile, che si convenga a questa spaventevole passione. 36. «Sestio dice che guardarsi allo specchio quando si è adirati può essere di grande aiuto. Così è capitato ad alcuni, che messi come di fronte a un fatto nuovo e improvviso sono rimasti letteralmente sconvolti da quel loro totale cambiamento e non si sono riconosciuti. E l’immagine riflessa nello specchio dava solo una pallida idea della bruttezza reale. Se l’animo potesse mostrarsi, luccicando in qualcosa di materiale, ci stupiremmo [quando sia mosso dall’ira] nel vederlo tutto nero, pieno di macchie, ribollente, gonfio e deformato. Per quanto, anche in condizioni normali, a giudicare da quel che affiora attraverso le ossa, la carne e tutti gli altri impacci del corpo, non si può dire che faccia una bella figura. Come sarebbe se potesse mostrarsi senza tutti questi impedimenti?». In verità non è credibile che uno possa essere distolto dall’ira guardandosi in uno specchio. «E perché?». Perché chi va a mettersi davanti allo specchio per cambiarsi in effetti è già cambiato. Gli adirati, invece, tali sono e tali vogliono apparire: per loro nessun aspetto è più piacevole di quello atroce e terribile che hanno. Ma vediamo piuttosto quante sono le vittime provocate direttamente dall’ira.
La foga eccessiva fa scoppiar le vene, il gridare al di sopra delle proprie forze provoca emorragie, un flusso troppo violento agli occhi offusca la vista e frequenti sono negli ammalati le ricadute. Non c’è via più veloce alla pazzia: è così che molti vi sono arrivati, e non hanno più recuperato il senno perduto. Aiace Telamonio, preso dall’ira [perché privato delle armi di Achille], impazzì e si tolse la vita.43 Quelli che si adirano augurano la morte ai propri figli, la miseria a sé stessi, la rovina alla propria casa e negano di essere adirati, così come i pazzi negano di essere pazzi. Nemici dei loro amici più intimi, pericolosi per le persone più care, immemori delle leggi (ma non di quelle che prescrivono pene), mutevoli per un nonnulla, chiusi a ogni discorso e a ogni gesto di cortesia, fanno tutto con la violenza, pronti a metter mano alla spada, per nuocere agli altri o a sé stessi, schiavi come sono del più grande dei mali, che li supera tutti. Gli altri vizi, infatti, si insinuano nell’animo a poco a poco, mentre questo scatta istantaneo, con una forza totale. L’ira, infine, riduce in suo potere tutte le altre passioni: vince anche l’amore più ardente, visto che alcuni arrivano persino a uccidere la persona amata, per poi giacere abbracciati accanto a lei. Calpesta addirittura l’avarizia, che è il più duro dei vizi e per nulla disposto a piegarsi, costringendola a disfarsi delle ricchezze e a dare alle fiamme la casa con tutto quel che c’è dentro. E per lei l’ambizioso non getta via le insegne, che prima aveva tanto stimato, e non rifiuta le onorificenze che gli vengono offerte? Non c’è insomma passione che l’ira non riesca a padroneggiare.
Libro terzo 1. Ora, caro Novato, ti farò vedere – questo è infatti ciò che tu sommamente desideri – come si possa estirpare l’ira dall’animo, o quantomeno frenarla e contenerne l’impeto. È una cosa che a volte si deve fare in modo palese e al cospetto di tutti, quando la minore violenza del male lo consente, a volte, invece, di nascosto, quando l’ira è troppo accesa e ogni ostacolo la esaspera e l’accresce. È importante conoscere l’entità delle sue forze, se siano integre, se bisogna affrontarla e respingerla, o se si debba cederle, per dar modo alla tempesta di placarsi, visto ch’è ancora nella fase iniziale: ciò per evitare che una volta esplosa in tutta la sua potenza si porti via anche i rimedi. Occorre inoltre tenere presente il carattere delle singole persone e regolarsi di conseguenza: c’è infatti chi si lascia vincere dalle preghiere, chi si sfoga aggredendo i deboli; chi si placa con le minacce, chi con un rimprovero, chi desiste dall’ira confessandola o perché ne prova vergogna, chi, infine, ha bisogno di tempo per uscirne, e a questo rimedio, troppo lento per un male così pericoloso e sconvolgente, bisogna affidarsi solo come ultima ratio. Le altre passioni, infatti, consentono una dilazione e si possono curare con calma, mentre l’ira, che è tutta eccitazione e sconvolgimento, ha una violenza che quando insorge è già al suo massimo, non va crescendo via via. Inoltre non stuzzica gli animi come fanno gli
altri vizi, ma li strappa a sé stessi, rendendoli incapaci di dominarsi e desiderosi di nuocere, sia agli altri che a sé stessi, e si scaglia non solo contro i diretti interessati ma contro tutto ciò che incontra sul suo cammino. Gli altri vizi eccitano gli animi, l’ira li travolge precipitosamente. Anche se non è possibile resistere alle proprie passioni, tuttavia si può imporre loro un limite, mentre l’ira – come i fulmini, le tempeste e tutti gli altri fenomeni che sono inarrestabili in quanto non avanzano ma cadono dall’alto – va accrescendo la sua forza sempre di più. Gli altri vizi distolgono l’uomo dalla giusta condotta, l’ira lo allontana dalla ragione; gli altri vizi crescono lentamente e senza che ce ne accorgiamo, l’ira precipita l’animo in un baratro. Nessuna passione, dunque, è più insensata e schiava delle sue stesse forze quanto l’ira: superba se ha successo, folle se non raggiunge lo scopo, non cede neppure alla sconfitta, e se la sorte le ha sottratto l’avversario rivolge i suoi morsi contro sé stessa. E la sua reazione non è mai commisurata all’entità della causa che l’ha scatenata, ma pur muovendo da banalissimi motivi raggiunge le vette più alte. 2. Nessuna età, nessuna razza umana le sfugge. Ci sono popolazioni così povere che non sanno nemmeno cosa sia il lusso, altre che per essere nomadi e sempre in azione ignorano la pigrizia, altre che, avvezze a una vita primitiva e contadina, non conoscono l’inganno, la frode e tutti i mali del foro, ma non c’è popolo che non sia istigato dall’ira, la quale esercita il suo potere tanto fra i Greci quanto fra i barbari, non meno pericolosa per chi rispetta le leggi che per chi fonda il diritto sulla forza. Inoltre gli altri vizi colpiscono gl’individui, l’ira è l’unica passione capace di afferrare tutta una nazione. Non è mai accaduto che un popolo intero si sia innamorato di una stessa e unica donna o che tutta una città abbia riposto le sue speranze nel denaro o nel guadagno; parimenti l’ambizione prende gli uomini singolarmente e la prepotenza non è un male di massa. L’ira, invece, molte volte afferra in un colpo solo uomini e donne, vecchi e bambini, nobili e volgo, e questa enorme massa di persone, come una schiera unanime e concorde, eccitata da poche parole, supera persino colui che l’ha istigata, mettendo tutto a ferro e fuoco, dichiarando guerra ai popoli confinanti o addirittura combattendo all’interno di sé stessa, cittadini fra cittadini. Così si bruciano le case con dentro intere famiglie, e chi poco prima è stato tenuto in grande onore per la sua convincente eloquenza finisce col subire il furore di quelli stessi che l’hanno applaudito; si vedono eserciti ribellarsi e scagliare i giavellotti contro il loro generale, intere masse di popolo in discordia con i nobili, senatori che in barba a regolari arruolamenti e nomine legali di comandanti si scelgono capi improvvisati a servizio della propria ira, e che dopo aver dato la caccia, di casa in casa, a personaggi illustri si fanno giustizia da sé, membri di ambasciate percossi, in pieno dispregio del diritto delle genti, città intere travolte e trascinate da una rabbia feroce e indescrivibile, navi che scendono in mare cariche di soldati arruolati alla rinfusa sotto la spinta di un furore popolare a cui non si dà il tempo di placarsi. Così, senza alcun rispetto
per la tradizione e senza i preventivi auspici, in preda all’ira il popolo afferra e usa come armi qualunque cosa gli capiti fra le mani o riesca a rubare, per poi scontare con la sua stessa rovina l’impulso di un’ira sfrontata e temeraria. Questa è la fine degna di uomini barbari, che in guerra vanno all’assalto sconsideratamente: irritabili come sono per natura, si sentono colpiti anche solo dall’idea o dalla più piccola parvenza di un’offesa, s’inalberano subito e spinti dalla rabbia si gettano sulle legioni come una valanga, in disordine, senza timori e precauzioni di sorta, anzi, sfidando deliberatamente il pericolo, in quanto godono di esser colpiti, di gettarsi sulle spade nemiche, di fermare col proprio corpo i proiettili e di morire così, per le ferite ch’essi stessi hanno cercato. 3. «Non c’è dubbio che l’ira è una forza immensa e funesta. Dimmi dunque in che modo la si debba guarire». Ebbene, visto che Aristotele, come ho accennato nei libri precedenti, la difende e sconsiglia di debellarla, sostenendo ch’è uno sprone alla virtù e che senza di lei l’animo è inerme, pigro e incapace di compiere grandi imprese, bisogna prima rivelarne tutta la bruttezza e la ferocia, mostrando chiaramente quanto sia bestiale un uomo che si adira contro un suo simile e come l’impeto lo porti a nuocere agli altri anche a costo di far male a sé stesso, quando l’aggredito non può precipitare nell’abisso se non insieme a colui che ve lo spinge. E non è un folle chi, sorpreso da un uragano, invece di procedere attentamente si lascia travolgere dalla furia della tempesta? Tale è l’uomo preso dall’ira, che disdegnando di lasciare ad altri il compito di vendicarlo infierisce personalmente, con deliberato proposito, su chi l’ha offeso, facendosi spesso carnefice persino delle persone più care, di cui poco dopo piangerà la perdita. Come si fa a ritenere compagna e sostegno della virtù questa passione che distoglie la mente dalle decisioni assennate, senza le quali la virtù stessa non potrebbe realizzare nulla? Effimere, infauste e capaci solo di danneggiarlo sono quelle forze che ridanno vigore al malato, quando provengono dall’aggravarsi della malattia. Non credere ch’io stia perdendo tempo in discorsi inutili o superflui nel mettere l’ira sotto accusa, visto che gli uomini non hanno dubbi a tale riguardo: [mi sono dilungato in tutte queste considerazioni] solo perché c’è qualcuno – un filosofo, per giunta, e tra i più illustri – che le assegna una funzione e la invoca nelle battaglie, nelle azioni importanti e in tutto ciò che richiede un certo entusiasmo, ritenendola utile e capace d’infondere coraggio. Affinché l’ira non inganni nessuno, con l’idea di poter giovare in qualche caso o in qualche condizione particolare, bisogna che se ne mostri il furore sfrenato e sbigottito, elencando a uno a uno tutti gli strumenti di cui dispone: cavalletti, corde, lavori forzati, crocifissioni, roghi accesi sotto i corpi legati ai pali,44 l’uncino per trascinare i cadaveri, i vari tipi di catene, di supplizi, lo squarcio delle membra, il marchio sulla fronte, le gabbie di animali feroci. Facciamola vedere in mezzo a tutti questi attrezzi mentre stride sinistramente, orribile e disgustosa più degli
strumenti stessi del suo tetro furore. 4. Se mai ci sono dubbi su tutto il resto, è certo che nessuna passione mostra nell’uomo un aspetto peggiore di quello che genera l’ira. Ne abbiamo già parlato nei libri precedenti: volto aspro e crudele, ora pallido per il ritrarsi e il rifluire del sangue, ora rossastro per il calore e la collera che vi si riversano, o tutto insanguinato per il gonfiarsi delle vene; occhi ora tremuli e oscillanti di qua e di là, quasi a voler schizzare fuori dalle orbite, ora, invece, smarriti, immobili e fissi in un solo punto. Mettici poi i denti, che stridono e si arrotano come se volessero sbranare qualcuno, facendo lo stesso rumore di quello dei cinghiali quando affilano, sfregandole, le loro zanne; e lo schiocco delle dita per il torcersi delle mani fra loro, i ripetuti colpi sul petto, il respiro affannoso, i rantoli che salgono dal profondo, il corpo sempre in movimento, le parole inarticolate e incomprensibili per le improvvise esclamazioni, le labbra tremule e strette in un sibilo foriero di chissà quali orribili disastri. In fede mia l’aspetto di un uomo ribollente d’ira è più spaventoso di quello di una belva oppressa dalla fame, o che abbia il fianco trafitto da una lancia o, peggio ancora, che, ferita a morte, cerchi, in extremis, di azzannare il cacciatore. Ebbene, queste, se hai voglia di ascoltarle, sono le grida e le minacce che escono da un animo tormentato da una tale passione. Ed è possibile che uno non faccia nulla per liberarsene quando sia consapevole che il primo danno lo farà a sé stesso? Non credi che si debbano mettere in guardia quelli che pongono al servizio dell’ira tutte le proprie energie, convinti che sia una prova di forza e che l’avere una vendetta così a portata di mano sia una delle più grandi fortune? Che si debba dir loro che un uomo adirato non solo non è affatto potente, ma non può dirsi neppure libero? Non vuoi che li avverta – affinché siano più attenti e circospetti – che, mentre le altre passioni si diffondono solo negli animi malati, l’ira s’insinua anche nelle persone colte e sane sotto tutti gli aspetti? Anche perché alcuni ritengono che l’ira sia un segno di spontaneità e comunemente si crede che i più malleabili siano proprio coloro che vi si assoggettano. 5. «Ma dove vuoi arrivare con questo discorso?» A impedire che qualcuno si ritenga al sicuro dall’ira, visto che possono essere spinte alla ferocia e alla violenza anche le persone calme e tranquille per natura. Come la pestilenza colpisce indiscriminatamente i deboli e i forti, e a nulla giovano contro di lei un fisico robusto e un’attenta cura della salute, così l’ira aggredisce sia i temperamenti inquieti che quelli calmi e remissivi, salvo che con questi ultimi si mostra ancora più turpe e pericolosa perché in loro il cambiamento è più evidente. Ora, considerato che il primo punto della questione è non lasciarsi prendere dall’ira, il secondo allontanarla e il terzo aiutare anche gli altri a guarirne, vediamo innanzitutto come evitarla, poi come liberarsene, infine come frenare chi è adirato, come placarlo e restituirlo alla ragione.
Riusciremo a non adirarci se avremo ben chiari davanti agli occhi tutti gli aspetti negativi dell’ira e la valuteremo secondo giustizia. Dobbiamo processarla nell’intimo della nostra coscienza e condannarla. Dopo averne ricercato, esaminato e confessato apertamente i misfatti, la metteremo a confronto con i vizi peggiori affinché appaia in tutta la sua realtà. Così, ad esempio, mentre l’avarizia induce ad acquistare e accumulare beni di cui poi si gioveranno altri che non sono avari, l’ira, invece, è dispendiosa e solo a pochi non costa nulla: pensa quanti schiavi ha perduto un padrone per i suoi attacchi di collera, o perché sono scappati o perché sono morti per colpa sua! Quella perdita ha superato di gran lunga il valore della cosa per cui egli si era arrabbiato. L’ira a un padre può portare un lutto, a un marito il divorzio, a un magistrato l’odio, a un politico la sconfitta elettorale. L’ira è peggiore anche della lussuria, perché il collerico gode del dolore altrui, mentre il lussurioso gioisce del proprio piacere. Supera pure la malignità e l’invidia, perché mentre il malevolo e l’invidioso si limitano a desiderare l’infelicità altrui e gioiscono di disgrazie fortuite, l’adirato si adopera egli stesso per rendere gli altri infelici e non aspetta l’intervento del caso o del destino perché sia colpito chi odia ma vuole essere lui a fargli del male. Non c’è poi cosa più triste delle rivalità, che trovano appunto nell’ira il loro alimento: la guerra, ch’è il malanno di tutti i malanni, nasce dall’ira dei potenti; ma anche l’ira del volgo anonimo e dei privati è una guerra, sia pure senz’armi e senza esercito. Inoltre l’ira, anche a non prenderne in considerazione gli effetti immediati, come i danni, le insidie, l’ansia continua per le liti e gli scontri fra le due parti, nel momento stesso in cui cerca di punire resta punita, perché rinnega la natura umana: questa, infatti, invita all’amore, quella all’odio, l’una impone che si faccia del bene, l’altra del male. Per di più l’indignazione che fa scattare l’ira, pur sembrando un segno di magnanimità, in quanto nasce da un’elevata stima di sé, è un impulso gretto e meschino, poiché chi si ritiene snobbato da uno in realtà vale meno di lui. Un animo veramente grande e ben consapevole del proprio valore non raccoglie l’offesa, non la sente, e perciò non si vendica. Come una freccia rimbalza quando cade su una superficie solida, o come noi ci facciamo male se urtiamo contro qualcosa di duro, così l’offesa non è avvertita da un animo grande, perché è più debole di ciò che colpisce. Quanto è più bello lasciar cadere tutte le ingiurie e le contumelie, come se si fosse impenetrabili a ogni arma! Vendicarsi significa ammettere di essere stati feriti, e non è grande quell’animo che si lascia piegare dall’offesa. Chi ti offende o è più potente o è più debole di te: se è più debole, risparmialo, se è più potente, risparmia te stesso. 6. Non c’è prova più certa di grandezza del non lasciarsi toccare da qualunque cosa possa accadere. La parte superiore del cielo, quella che è più ordinata e vicina alle stelle, non si addensa in nuvole, non prorompe in tempeste, né si rivolge in vorticosi mulinelli d’aria, ma è priva di qualsiasi turbamento: è
nelle zone più basse che scoppiano tuoni e fulmini. Allo stesso modo uno spirito elevato, che sia sempre sereno e in continuo stato di tranquillità, capace di reprimere dentro di sé ogni impulso che possa risolversi in un accesso d’ira, si mantiene equilibrato, rispettabile e bene ordinato: niente di tutto questo si trova in un uomo soggetto a un attacco di collera. Chi, infatti, quando è in preda al dolore e s’infuria, non getta via il primitivo pudore? Chi, scagliandosi contro qualcuno perché sconvolto da una passione, non perde il suo consueto contegno? Chi, quando è eccitato, resta cosciente della quantità e della scala dei suoi doveri? Chi sa frenare la lingua, tener ferma una sola parte del corpo, controllarsi, insomma, una volta partito a briglia sciolta? Seguiamo quel salutare precetto di Democrito secondo cui la serenità, nella vita pubblica come in quella privata, consiste nel non fare cose eccessive o superiori alle nostre forze. Chi corre sempre ininterrottamente di qua e di là per sbrigare un affare dietro l’altro non riesce a passare un solo giorno tranquillo senza che qualcuno o qualche cosa gli procuri una contrarietà che lo disponga all’ira. Come chi si affretta per le strade affollate della città è inevitabile che si scontri con molte persone, e qui riesce a svicolare, là invece è bloccato da qualcuno o imbrattato [da un carro che passa], così, in questo nostro vivere dissipato e vagabondo c’imbattiamo in molti ostacoli e inconvenienti: uno delude una nostra speranza, un altro la rimanda, un altro ce la toglie del tutto: i nostri piani non sono andati come volevamo. Non c’è persona a cui la sorte sia così propizia da corrispondere sempre alle sue aspettative, per cui chi vede andare in fumo i suoi progetti diventa intollerante, degli uomini e delle cose, e se la prende per un nonnulla, coi suoi affari, con chi li tratta, col posto, con la sfortuna o con sé stesso. Perciò se vogliamo vivere tranquilli – come ho accennato poc’anzi – non dobbiamo affaticarci e impelagarci in tante faccende e per giunta al di sopra delle nostre forze: è facile caricarsi sulle spalle pesi non eccessivi e portarli da una parte e dall’altra senza cadere, mentre quei pesi che ci sono stati imposti da altri facciamo fatica a sostenerli e ben presto, sfiniti, li lasciamo andare; ma anche mentre li portiamo, se il carico è eccessivo, vacilliamo. 7. Come ho già detto, queste cose accadono sia nella vita pubblica che in quella privata. Gli affari semplici e di poco peso si fanno sbrigare facilmente, mentre quelli impegnativi e superiori alle nostre possibilità, che già sono difficili in partenza, appena li abbiamo avviati ci sovrastano e ci confondono, noi crediamo di padroneggiarli e quelli crollano insieme a noi. Così avviene che spesso la volontà di chi affronta imprese non facili con la presunzione di trovare facile tutto ciò che si accinge a fare, se ne va in frantumi. Ogni volta che vorrai fare qualcosa soppesa bene te stesso, l’impresa a cui ti accingi e i mezzi con cui affrontarla, perché poi il rammarico di non aver portato a termine l’opera non ti renda intrattabile. Tieni presente che c’è differenza fra un temperamento focoso e uno freddo o dimesso, che in un animo nobile
l’insuccesso provoca l’ira, in uno languido e inerte la tristezza. Le nostre azioni, dunque, non siano né meschine, né temerarie, né sproporzionate, la speranza ci stia sempre vicino, e asteniamoci da tentativi ardui il cui esito debba poi sorprenderci perché sono andati a buon fine. 8. Se non sappiamo tollerare le offese facciamo in modo di non riceverle, frequentando persone quanto più possibile calme, cordiali e per nulla ansiose o stravaganti: l’uomo, infatti, modella i suoi comportamenti su quelli di coloro che gli vivono intorno, e come certe malattie del corpo si trasmettono per contatto, così un animo infetto contagia quelli che gli stanno vicino: l’ubriaco trascina chi lo frequenta all’amore per il vino, una congrega di dissoluti rammollisce anche un uomo forte (se in quel caso si può parlare di uomo), l’avaro diffonde il suo veleno in quelli che lo circondano. Lo stesso, ma in senso opposto, accade con la virtù, la quale rende migliore tutto ciò che le sta accanto: una zona benefica o un clima salubre non giova tanto alla salute quanto a un carattere debole lo stare insieme con spiriti forti e risoluti. Per renderti conto del potere e dell’efficacia di un tale contatto, guarda come le belve si ammansiscono se vivono con noi. Non v’è infatti animale feroce che conservi il suo istinto violento dopo una lunga convivenza con l’uomo: in un ambiente tranquillo ogni sua asprezza si attenua e a poco a poco scompare. A questo aggiungi che chi vive in compagnia di gente calma diventa migliore non solo per l’esempio che ha davanti ma anche perché non trova occasioni e motivi per adirarsi e tirar fuori quel suo difetto. Egli, dunque, dovrà evitare tutte quelle persone che ritiene capaci di irritarlo. «Che tipi di persone?». Sono tanti quelli che possono offenderti, e per vari motivi: l’arrogante col disprezzo, lo sfrontato con la villania, l’insolente con l’insulto, l’invidioso con la malignità, il litigioso con la provocazione, lo spaccone e il bugiardo con la vanità; e tu non potrai tollerare di essere temuto da un sospettoso, messo a tacere da un testardo, snobbato da uno schizzinoso. Scegliti dunque amici semplici, affabili ed equilibrati, che non suscitino da parte tua alcuno scatto d’ira, o che comunque sappiano sopportarlo; ancora di più potranno giovarti i caratteri miti, amabili e indulgenti, non però sino all’adulazione, perché l’eccessiva condiscendenza infastidisce le persone irascibili: come quel nostro amico, indubbiamente buono ma molto facile all’ira, che quando montava in collera non sapevi se prenderlo con le buone o con le cattive. È noto che l’oratore Celio era sommamente irascibile.45 Ebbene, un suo cliente, ch’era dotato di un notevole spirito di sopportazione e sapeva quanto gli fosse difficile non litigare con chi gli stava accanto, invitato a cena da lui nella sua camera da letto, si era proposto di approvare tutto ciò che Celio avrebbe detto e di assecondarlo, come se questa fosse la cosa migliore. Ma Celio a un certo punto, stanco di tanta arrendevolezza, montando in collera esclamò: «Contraddicimi almeno in qualche cosa, così ci accorgeremo di essere in due!».
Poi anche lui, che si arrabbiava perché in mancanza di un contestatore non poteva arrabbiarsi, smise di arrabbiarsi. Dunque, se sappiamo di essere facili all’ira, è meglio che ci scegliamo come compagni delle persone che accettino i nostri atteggiamenti e le nostre parole. È vero che la loro frequentazione ci renderà sofistici e c’indurrà nella cattiva abitudine di non voler sentire nulla che sia contrario al nostro modo di pensare, ma servirà a dare un po’ di tregua e un po’ di pace al vizio dell’ira. Anche gli scontrosi e i ribelli per natura accettano chi li blandisce: una carezza non è mai sgradita o pericolosa. Quando ci rendiamo conto, fin dall’inizio, che la discussione tende ad andare per le lunghe e a farsi troppo accesa, fermiamoci prima che acquisti forza, poiché la disputa si alimenta da sé e [come un mare vorticoso] trascina avviluppati nel profondo quelli che vi si sono immersi: è più facile astenersi dalla lotta che venirne fuori. 9. Bisogna poi che chi è soggetto all’ira eviti le applicazioni troppo gravose, o quanto meno vi si dedichi senza arrivare alla stanchezza. Né egli deve impegnare la mente in varie attività ma la tenga occupata solo in quelle piacevoli, rasserenandola con la lettura di poesie e intrattenendola con narrazioni storiche: la tratti, insomma, con garbo e delicatezza. Pitagora placava con la lira i turbamenti dell’animo: è noto, infatti, che il suono dei corni e delle trombe è eccitante, mentre certi canti accarezzano la mente rilassandola. E come il verde fa bene agli occhi annebbiati e certi colori sono riposanti per una vista debole, mentre altri, per il loro splendore, l’abbagliano, così le occupazioni gradevoli placano le menti agitate. Per questo bisogna evitare le attività del foro, la professione di avvocato, i processi e tutto ciò che può esasperare il vizio dell’ira; parimenti occorre guardarsi dalla stanchezza fisica, che disperde quanto in noi c’è di mite e di tranquillo ed eccita la parte aspra dell’animo. Come i deboli di stomaco, se devono dedicarsi ad affari di un certo impegno, seguono una dieta idonea a calmare la bile – la quale viene eccitata soprattutto dalla stanchezza, che spinge il calore verso il centro del corpo rallentando la circolazione del sangue nelle vene affaticate – e come un corpo sfibrato e indebolito pesa sull’animo, così chi è fiaccato dalla malattia o dall’età è più propenso all’ira. Per lo stesso motivo si devono evitare la fame e la sete, che eccitano e infiammano l’animo. Un vecchio proverbio dice che chi è stanco cerca la lite: lo stesso fa chi ha fame, sete o qualche cosa che gli brucia dentro. Come un uomo coperto di piaghe prova dolore se lo si tocca, o anche solo al timore di essere sfiorato, così un animo che soffre si risente per un nonnulla, basta un saluto, una lettera, un discorso o una domanda per farlo arrabbiare: non puoi, insomma, toccare una parte malata senza provocare un lamento. 10. Bisogna dunque curarsi ai primi sintomi del male, cercando di parlare quanto meno possibile e contenendo lo sfogo. Non è difficile trattenere le proprie
passioni al loro primo insorgere: come le malattie, la pioggia e la burrasca, così anche l’ira, l’amore e tutte quelle tempeste che tormentano gli animi hanno dei segni premonitori. Chi è soggetto ad attacchi di epilessia percepisce l’arrivo del male quando le estremità del corpo diminuiscono di calore, e se gli gira la testa e sta per perdere la coscienza gli prende un tremito nervoso e gli si offusca la vista.46 Egli cerca così di prevenire il male ricorrendo ai rimedi consueti: rimuove tutto ciò il cui odore o il cui sapore provoca la perdita dei sensi e reagisce al freddo e all’irrigidimento con dei fomenti, e se quella cura non basta, per non farsi vedere dai presenti, si allontana e cade a terra lasciandosi andare. È utile conoscere le proprie malattie e soffocarne la forza prima che questa si espanda. Cerchiamo dunque di capire cos’è che ci eccita maggiormente: chi monta in collera per una parola, chi per un gesto, chi per una mancanza di riguardo, alla sua nobiltà o alla sua bellezza, chi perché vuol essere ritenuto più raffinato degli altri, chi più dotto, chi non sopporta l’arroganza, chi l’indisciplina. C’è poi chi ritiene che non valga la pena adirarsi con gli schiavi, chi è violento in casa sua e mite fuori, chi si offende se qualcuno lo prega, perché considera quel gesto un segno d’invidia, chi, al contrario, giudica un’offesa il non essere pregato. Inoltre non tutti sono vulnerabili dallo stesso lato: devi dunque sapere qual è il tuo punto debole per poter proteggere principalmente quello. 11. Non bisogna dar peso a tutto ciò che si vede e che si ascolta. Chiudiamo dunque gli occhi di fronte a certe offese, pensiamo che la maggior parte di esse ci sono sconosciute e quindi non ci toccano. Non vuoi adirarti? Non essere curioso: chi s’informa di tutto ciò che si dice di lui, chi va a scavare i discorsi malevoli, fatti magari in via del tutto privata e quindi chiusi nel segreto, si tormenta da sé. Se ci mettiamo a interpretare questo e quello finiamo col trovare offese dappertutto: perciò talvolta dobbiamo prender tempo, talvolta sorriderne, talvolta lasciar perdere. Restringiamo i confini dell’ira: possiamo farlo in molti modi. Il più delle volte una situazione può essere risolta con una battuta allegra, spiritosa, come fece Socrate, che ricevuto uno schiaffo esclamò: «È un guaio che gli uomini non sappiano quando devono uscire con l’elmo!». Più che il modo in cui l’offesa viene fatta bisogna vedere come la si sopporta, e io non credo che sia difficile controllarsi quando è noto che persino dei tiranni, gonfi di superbia per il potere o per la buona sorte, hanno saputo reprimere la loro abituale crudeltà. Si racconta che Pisistrato, tiranno d’Atene, avendo un suo invitato, alquanto brillo, sciorinato una sfilza di accuse contro la sua crudeltà – e chi era pronto a dargli una mano, chi in un modo o nell’altro lo incoraggiava – sopportò in tutta calma l’offesa e benché i suoi lo istigassero a reagire esclamò: «Costui non mi ha irritato più di quanto potrebbe fare uno che mi urtasse con gli occhi bendati».
12. Molti si fanno del male con le proprie mani, o perché s’inventano sospetti infondati o perché dànno peso a cose di scarsa importanza. Spesso è l’ira che viene da noi, ma più spesso siamo noi che andiamo da lei. E invece non dobbiamo mai cercarla, e anche quando c’imbattiamo in lei dobbiamo respingerla. Non c’è nessuno che dica a sé stesso: «Mi sono adirato per una cosa che ho fatto anch’io, o che avrei potuto fare». Bisogna poi considerare non solo l’offesa in sé stessa, ma anche l’intenzione con cui è stata arrecata, cosa che nessuno generalmente fa: occorre infatti vedere se l’autore ha agito volontariamente o accidentalmente, se perché costretto o perché ingannato, per odio o in vista di un qualche utile, se ha seguito un proprio impulso o ha posto la sua mano al servizio di altri, tenere presente la sua età, la sua condizione sociale o lo stato in cui si trova in quel momento, per poter dire se sopportare e rassegnarsi sia segno non di viltà, ma di umanità. Se ci mettiamo nella condizione della persona contro cui ci adiriamo vedremo che il nostro atteggiamento è dovuto a un’errata valutazione di noi stessi, al fatto che ci rifiutiamo di subire ciò che pure noi abbiamo avuto in mente di fare. Il miglior rimedio contro l’ira è prender tempo, perché ciò permette di smorzarne il bollore iniziale e di dissolvere o attenuare quella nebbia che ci offusca la mente. Basterà un’ora, nemmeno un giorno, perché alcuni di quegli impulsi precipitosi si plachino, altri, invece, svaniranno del tutto. Se poi il temporeggiare che ci siamo imposti non avrà alcun effetto vorrà dire che la nostra reazione, al di là di uno scatto d’ira istintivo, era già un processo con una sentenza bella e pronunciata. Se vuoi avere una conoscenza esatta di una cosa rimettiti al tempo: non si può distinguere chiaramente un oggetto in movimento. Un giorno Platone, adiratosi con un suo schiavo, non seppe aspettare, e dopo aver ordinato al colpevole di togliersi la tunica e di porgere le spalle alla frusta, alzò la mano, pronto a colpire. Ma in quel momento, accortosi di essersi lasciato trascinare dall’ira, si bloccò, e così rimase, tenendo la mano sospesa in aria, nell’atteggiamento, appunto, di chi sta per colpire. «Che cosa stai facendo?», gli domandò un amico sopraggiunto per caso. «Sto per punire un uomo adirato», rispose il filosofo. E come inebetito se ne stava in quell’atteggiamento aggressivo, disdicevole a un uomo saggio, senza pensare più allo schiavo, perché aveva trovato un altro che meritava di essere punito. Così rinunciò al potere che aveva sui suoi schiavi e piuttosto turbato per quella sua colpa, disse: «Ti prego, Speusippo, castiga tu con la frusta questo schiavo: io sono adirato». Ebbene, il motivo che lo indusse a non picchiare fu lo stesso che avrebbe indotto altri a farlo. «Sono adirato», si disse, «perciò farei più di quanto sia necessario, e lo farei troppo volentieri: questo schiavo non deve essere in potere di uno che non è padrone di sé». Come dunque si può affidare la vendetta a un uomo adirato quando Platone se ne tolse il diritto egli stesso? Niente ti sia lecito finché sei adirato. Vuoi sapere per quale ragione? Perché [in quel momento] vorresti che ti fosse lecito tutto.
13. Lotta con te stesso: l’ira non può vincerti se tu sei deciso a vincere lei. Ed è già una vittoria quando riesci a nasconderla, a non darle sfogo. Soffochiamone i sintomi e, per quanto ci è possibile, teniamola occulta e segreta. Ciò ci costerà non poca fatica, perché l’ira tende a esplodere, a infiammare gli occhi e stravolgere il viso, ma se la lasciamo uscir fuori prenderà il sopravvento. Sotterriamola nei bassifondi del cuore, sì che non sia lei a possederlo ma lui a possedere lei. Anzi, volgiamo al contrario ogni suo indizio, distendendo il volto, addolcendo la voce, rallentando il passo, così il nostro aspetto interiore a poco a poco si conformerà a quello esteriore. Socrate quando abbassava la voce e diventava sobrio nel parlare lasciava intravedere ch’era stato preso dall’ira, e allora era evidente che combatteva con sé stesso. Gli amici se ne accorgevano e lo biasimavano, ma a lui non dispiaceva il rimprovero per un’ira che riusciva a nascondere. E perché non avrebbe dovuto rallegrarsi che molti intuissero la sua ira quando nessuno ne subiva gli effetti? Se non avesse concesso loro il diritto di rimproverarlo – un diritto reciproco, che si era preso anche lui – allora sì gli amici ne avrebbero sentite le conseguenze! Ebbene, a maggior ragione noi dobbiamo fare lo stesso: concedere ai nostri migliori amici la più ampia libertà d’intervenire, specialmente quando siamo meno disposti a tollerarla, disapprovando i nostri scatti d’ira: chiamiamoli in nostro soccorso contro un male così potente e gratificante mentre siamo pienamente consapevoli e padroni di noi stessi. Chi non sopporta il vino e teme di poter incorrere nelle sventatezze e nelle insolenze tipiche degli ubriachi, prega gli amici di portarlo via dal banchetto, chi sa di essere sregolato nel cibo, e ne ha pagate le spese durante una malattia, chiede che quando sta male non si dia ascolto alle sue richieste. La miglior cosa da fare, dunque, è crearci degli ostacoli ai vizi che sappiamo di avere, e predisporre l’animo in modo che, per quanto sia scosso da eventi gravissimi e inattesi, o non si lasci prendere dall’ira o, se questa è scoppiata in conseguenza di un’offesa pesante e improvvisa, la rimandi giù, nel profondo, senza manifestare alcun risentimento. Per dimostrare chiaramente come ciò sia possibile prenderò dal gran mucchio pochi esempi che ci insegnano due cose: quanto male sia capace di produrre l’ira se utilizza tutti i mezzi di cui dispongono uomini potentissimi, e quanto riesca a contenersi sotto l’influsso di un timore più forte di lei. 14. Il re Cambise era troppo dedito al vino e perciò Prexaspe, uno dei suoi più cari amici, lo esortava a bere di meno:47 «L’ubriachezza», gli diceva, «è sconveniente per un re, il quale, qualunque cosa dica o faccia, è sempre spiato da tutti». Cambise allora gli rispose: «Affinché tu sappia che io non perdo mai il controllo di me stesso, ti dimostrerò che anche dopo aver bevuto i miei occhi e le mie mani assolvono al loro compito in modo inappuntabile». Dopodiché bevve più abbondantemente del solito e in coppe molto grandi,
poi, stordito completamente dal vino, ordinò al figlio del suo censore di entrare nella sala e di fermarsi tenendo la mano sinistra alzata sopra la testa. Allora tese l’arco e puntato dritto al cuore dell’adolescente, così come aveva detto, lo centrò in pieno, quindi, apertogli il petto, fece notare che la freccia s’era conficcata proprio lì dov’egli aveva mirato. Poi si rivolse al padre del ragazzo e gli chiese: «Ti sembra che la mia mano sia abbastanza ferma?». E lui: «Neppure Apollo avrebbe potuto tirare con maggior precisione». Maledetto sia sempre quell’uomo, così servile d’animo più di quanto non lo fosse per la sua condizione! Tessé l’elogio di un gesto a cui era già troppo ch’egli avesse assistito: il petto del figlio spaccato in due e il suo cuore palpitante sotto la ferita furono per lui lo spunto per una ennesima adulazione! Avrebbe invece dovuto contestargli quella bravura e chiedergli di ripetere il tiro per far vedere quanto fosse ancora più sicura la sua mano verso di lui che ne era il padre. Quanto fu sanguinario quel re! Degno che tutti gli archi dei suoi gli si volgessero contro! Ma se il gesto di quest’uomo, che concludeva i suoi banchetti con uccisioni e torture, ci lascia inorriditi, chi lodò quella freccia fu certamente più infame di colui che la scagliò. Dopo vedremo come avrebbe dovuto comportarsi quel padre davanti al cadavere del figlio, della cui morte era stato testimone e causa: per ora ciò che balza evidente [da quella sua condotta] – e che costituisce il tema del nostro discorso – è che l’ira può essere repressa. Quell’uomo, infatti, non insultò il re, non si lasciò sfuggire nemmeno un’espressione di dolore, anche se sentiva il suo cuore trafitto come quello del figlio. Si può giustamente dargli atto di essersi ingoiato le parole [che gli venivano alle labbra], perché se come uomo preso dall’ira poteva dire qualcosa, come padre non poteva far nulla. Io dico che in questa circostanza si dimostrò più saggio di quando dava a Cambise consigli di sobrietà, perché era meglio che bevesse vino piuttosto che sangue, e finché teneva in mano il bicchiere c’era la pace [per lui e per gli altri]. Così Prexaspe è entrato nel numero di coloro che con i propri lutti testimoniano quanto caro costino i buoni e amichevoli consigli dati a un re. 15. Anche Arpago, ministro di Astiage, re dei Persiani, 48 dovette consigliare qualcosa del genere al suo sovrano, il quale, risentito, gli fece imbandire le carni dei figli e gli chiese più volte se il modo in cui erano condite fosse di suo gradimento, e alla fine, quando lo vide abbastanza sazio dei suoi mali, fece portare le loro teste e gli domandò: «Che te n’è parso di questa mia ricetta?». Quel miserabile, invece di tenere chiusa la bocca, non esitò a rispondere: «Alla mensa di un re qualunque pasto è gradito». Forse questa adulazione gli evitò che il re lo invitasse a mangiare anche le teste dei figli. Ora, io non dico che un padre non debba condannare un atto del suo re, non gl’impedisco di chiedere un giusto castigo per una così orribile
mostruosità, ma intanto ne traggo [anche qui] la conclusione che persino quando è provocata dai mali più grandi e più dolorosi l’ira può essere tenuta nascosta e costretta a pronunciare parole contrarie al suo consueto modo di esprimersi. Saper frenare il dolore è necessario soprattutto a coloro che hanno avuto in sorte un tale genere di vita e sono invitati alla mensa dei re: questo è il prezzo che si paga quando si mangia, si beve e si conversa con loro: il dover ridere dei propri lutti. Se poi valga la pena pagare un tale prezzo per aver salva la vita, questa è un’altra questione, e ne parleremo più avanti. Io non intendo fornire un rimedio a consolazione di una così triste prigionia, non esorto ad accettare e sopportare la tirannia dei carnefici, voglio mostrare che in ogni schiavitù c’è una via verso la libertà. Chi è sofferente e infelice di per sé stesso, non per colpa di altri, può porre fine alla sua vita e al suo dolore. Lo dico sia a quelli che si sono messi al servizio di un re che scaglia frecce ai petti degli amici, sia a quelli il cui signore pasce i padri con le carni dei loro figli: «Sciocco, perché ti lamenti? Aspetti forse che venga un nemico a liberarti dalle tue sofferenze, uccidendo, insieme a te, tutta la tua gente, o che un re potente accorra in tuo aiuto da terre lontane? Guardati intorno: la fine dei tuoi mali è a portata di mano. Vedi quel precipizio? Per di lì si scende verso la libertà. Vedi quel mare, quel fiume, quel pozzo? Lì, sul fondo, sta la libertà. Vedi quell’albero, piccolo, rinsecchito e sterile? Da lì pende la libertà. Vedi il tuo collo, la tua gola, il tuo cuore? Sono vie di fuga dalla schiavitù. Ti sembrano soluzioni troppo faticose, che richiedono molto coraggio e molta forza fisica? Ebbene, una qualunque vena del tuo corpo può essere la strada della libertà». 16. Ma finché nulla ci sembra tanto intollerabile da indurci ad abbandonare la vita, teniamo lontana l’ira, quale che sia la nostra condizione. Essa è funesta a chi è costretto a servire, perché ogni sua irritazione gli accresce il tormento, e più egli si ribella agli ordini, più questi gli pesano: come una belva, quando, nel tentativo di liberarsi dai lacci che la imprigionano, finisce con lo stringerli ancora di più, e come gli uccelli, che mentre cercano di scrollarsi di dosso il vischio [usato per catturarli] se lo spargono su tutte le penne. Non c’è giogo tanto stretto che non ferisca egualmente chi lo sopporta e chi gli si ribella. C’è un solo sollievo ai grandi mali: sopportarli, facendo buon viso alla cattiva sorte. Ora, se a coloro che sono costretti a servire torna utile contenere le proprie passioni, e soprattutto l’ira, che è rabbiosa e sfrenata, maggior giovamento può venirne a un re: quando infatti si lascia che l’ira esprima tutte le sue potenzialità, chi ne è posseduto non ha più alcuno scampo, perché quel potere malefico – che non può durare a lungo giacché coinvolge molte persone – comincia a vacillare non appena il timore comune unisce coloro che gemono separatamente. Perciò molti tiranni sono stati uccisi, chi da individui isolati, chi dall’intera popolazione, quando il risentimento generale ha fatto di tutte quelle singole una collera sola. Ciononostante la maggior parte di loro considerarono l’ira un privilegio della regalità, come Dario I, il quale, tolto il regno al[l’usurpatore
Gaumata il] Mago, s’impadronì della Persia e di gran parte dell’Oriente. Poiché aveva dichiarato guerra agli Sciti, che accerchiavano l’Oriente, il nobile e vecchio Eobazio lo pregò di lasciargli a casa, a suo sostegno, uno dei tre figli e di prendersi gli altri due. «Farò più di quanto mi chiedi», gli rispose Dario: «te li rimanderò entrambi». Dopodiché li fece uccidere e gettare ai piedi del padre, esclamando: «Sarei troppo crudele se te li portassi via tutti e tre». Ma quanto più benevolo fu Serse! Pregato da Pizio, padre di cinque figli, di risparmiargliene almeno uno, prima glielo fece scegliere, poi ordinò che il giovane fosse squarciato in due e ne piazzò i tronconi sui lati della strada, facendone il capro espiatorio di tutto l’esercito. Ma ebbe la fine che si meritava: sconfitto e sbaragliato in lungo e in largo, dovette passare fra i cadaveri dei suoi, con negli occhi l’immagine di quella sua rovina disseminata da tutte le parti. 17. Tale era la ferocia dei re barbari quando si adiravano: essi, infatti, non avevano alcuna istruzione ed erano privi di qualsiasi cultura letteraria. Ma ora ti porterò l’esempio del re Alessandro, il quale, nonostante fosse cresciuto alla scuola di Aristotele, durante un banchetto trafisse di sua mano Clito,49 il suo più caro amico e condiscepolo, perché non lo adulava abbastanza e non voleva assoggettarsi – macedone e uomo libero com’era – all’ossequio servile dei Persiani. Un’altra volta gettò in pasto a un leone Lisimaco,50 che pure era suo amico, il quale, sfuggito per un pelo ai denti dell’animale, diventato re, non fu meno crudele di lui. Fece infatti tagliare il naso e gli orecchi a Telesforo di Rodi e lo tenne chiuso a lungo in una gabbia come una bestia strana e sconosciuta: e in verità quel volto orrendo, così mutilato, aveva perso l’aspetto umano. E a renderlo ancora più bestiale si aggiungevano la fame, l’incuria e la sporcizia di un corpo abbandonato sui suoi stessi escrementi. La gabbia era così stretta e lo spazio così esiguo che il poveretto per muoversi, invece dei piedi, doveva usare le ginocchia e le mani, che a lungo andare gli si erano fatte callose, oppure strisciare sui fianchi, tutti piagati per il continuo strofinio. A vederlo non sapevi se fosse più ripugnante o più spaventoso: ridottosi a un mostro, per quella sua penosa condizione, non faceva più nemmeno pietà. Ma se lui, che pativa quel castigo, non sembrava affatto un essere umano, ancor meno lo era chi glielo aveva inflitto. 18. E magari una simile crudeltà fosse solo un’usanza straniera! Purtroppo anche questa barbarie di supplizi e di furori è entrata nei nostri costumi, insieme con altri vizi importati da fuori. Lucio Silla, per esempio, a Marco Mario51 – a cui il popolo aveva eretto statue in tutti i quartieri di Roma e offriva suppliche con incenso e con vino – fece spezzare le gambe, cavare gli occhi, tagliare la lingua e le mani e, come a volerlo uccidere tante volte quante lo feriva, lo fece sbranare lentamente, membro dopo membro. E chi era l’esecutore di quell’ordine? Chi, se non Catilina, che fin da allora esercitava il suo braccio a ogni genere di delitti? Era lui che lo faceva a pezzi davanti alla tomba di Quinto
Catulo,52 spettacolo empio e irriguardoso per le ceneri di un uomo tanto mite, sulle quali colava a goccia a goccia il sangue di un altro uomo che s’era stato di cattivo esempio aveva però goduto del consenso popolare, amato forse troppo ma non immeritatamente. Era giusto che Mario patisse quel supplizio, come pure che Silla l’ordinasse e Catilina lo eseguisse, ma la repubblica non meritava di subire sul proprio corpo le spade di quegli uomini ch’erano al tempo stesso suoi nemici e suoi vendicatori. Ma perché andare tanto lontano? Recentemente Caligola in un solo giorno fece frustare e torturare, per capriccio, non per un fatto di giustizia, Sesto Papinio, il cui padre era stato console, Betilieno Basso, il suo questore, figlio di un suo procuratore, e alcuni senatori e cavalieri romani, poi, impaziente e desideroso di sfogare subito quel piacere incontenibile che la sua crudeltà richiedeva, sul far della notte ne fece decapitare altri, mentre insieme con delle matrone e dei senatori passeggiava sulla terrazza dei giardini materni, che divide il portico dal fiume. Quale pericolo così imminente lo minacciava, quale trama, privata o pubblica, poteva consumarsi contro di lui nel giro di una sola notte? In ogni caso non poteva pazientare un poco e aspettare che facesse giorno, evitando di uccidere, in pantofole, dei senatori del popolo romano? 19. È bene che si sappia quanto fu sfrontata la sua crudeltà, e non sembri che mi allontani dall’argomento perdendomi in digressioni inutili, perché anche questo è un tema che rientra nell’ira, quando essa incrudelisce più di quanto generalmente suole. Caligola faceva frustare i senatori con le verghe e la sua ferocia arrivò a tal punto che la gente finì col dire: «Sono cose che succedono!». Li torturava con gli strumenti che sono i più terribili fra quelli che si trovano in natura: corde, stringicaviglie, cavalletti, carboni accesi e persino la sua testa. Qualcuno potrebbe osservare che non è poi una cosa tanto orripilante se quest’uomo – che meditava di trucidare il senato intero e voleva che il popolo romano avesse una sola testa per potere con un colpo solo e in un solo giorno concentrare in una esecuzione unica tutti i delitti che aveva sparso in ogni luogo e in ogni circostanza – fece squartare con frusta e fiamme, come del resto si fa con gli schiavi, tre senatori. Ma cosa c’è di più inaudito, di più vergognoso, di una tortura eseguita di notte! I furti, di solito, si fanno di nascosto, col favore delle tenebre, ma le punizioni quanto più sono visibili tanto più servono di esempio e di lezione. A questo punto qualcuno mi dirà: «Di che ti meravigli? Ciò che fa questa belva è per lei un fatto abituale: Caligola vive per questo, per questo veglia e a questo pensa durante la notte». Certo, sarà molto difficile trovare un altro che abbia ordinato di mettere una spugna in bocca ai condannati a morte per impedirgli di gridare: a quale moribondo, infatti, viene negata la possibilità di lamentarsi? Ma Caligola temeva che il dolore giunto all’estremo potesse fare uscire di bocca al condannato qualche parola di troppo, che lui non voleva ascoltare: egli sapeva che soltanto in punto di morte uno poteva rinfacciargli gli innumerevoli delitti che aveva commesso. Una volta, poiché non si trovavano
spugne, strappò le vesti di dosso ai condannati e gli riempì la bocca con quegli stracci. Che crudeltà è mai questa? Che sia consentito almeno di esalare l’ultimo respiro, di lasciare all’anima una via di uscita, libera, non attraverso una ferita. Sarebbe troppo lungo aggiungere che in una sola notte egli fece uccidere da centurioni sguinzagliati per le case anche i padri dei condannati, come per dire che lui, compassionevole com’era, li liberava dal dolore. Con tutto ciò io ho voluto descrivere non tanto la crudeltà di Caligola quanto quella dell’ira, la quale non infuria solo contro i singoli, ma strazia intere popolazioni e flagella città, fiumi e ogni altra cosa che sia insensibile al dolore. 20. Così in Siria un re di Persia fece tagliare il naso a un’intera popolazione, tanto che il luogo prese il nome di Rinocolura. Ritieni tu che sia stato benevolo dal momento che non ordinò di tagliare le teste? Egli si compiacque di un supplizio così originale. E una cosa del genere si dice che abbiano subìto gli Etiopi, che per la loro straordinaria longevità sono chiamati Macrobi. Cambise si infuriò contro di loro perché invece di accettare la schiavitù a mani tese [con le palme rivolte al cielo] avevano risposto ai suoi ambasciatori con voce franca e schietta, una cosa che ai re suona come un’offesa. Così, senza nemmeno provvedersi di viveri, egli si tirò dietro attraverso un territorio ancora inesplorato, impraticabile e privo di acqua, tutta quella moltitudine di gente da utilizzare per la sua guerra. Fin dall’inizio di quella spedizione vennero a mancargli le cose necessarie, né poteva fornirgliene quella terra sterile, incolta e mai calpestata dal piede dell’uomo. In un primo momento quei disgraziati ingannarono la fame mangiando le foglie più tenere e i germogli delle piante, poi si cibarono con pezzi di cuoio bollito e con tutto ciò che la necessità poteva rendere commestibile. Alla fine, quando in quella distesa di sabbia vennero a mancare anche le radici e le erbe e si vide che il deserto era privo di animali, tirarono a sorte su ogni dieci uno di loro per ricavarne un cibo ancora più orrendo della fame stessa. L’ira, intanto, spingeva come un folle il re, il quale ormai aveva perso quasi tutto l’esercito, una parte perché stremata dalla fame, l’altra perché era stata mangiata. Alla fine fu preso dal timore di poter essere sorteggiato anche lui: solo allora ordinò la ritirata. Nel frattempo, mentre i suoi soldati tiravano a sorte chi di loro dovesse morire di quella orribile morte e chi vivere una vita ancora peggiore, a lui venivano riservati uccelli pregiati e stoviglie trasportate con i cammelli per i suoi banchetti.53 21. Se Cambise si adirò contro una popolazione sconosciuta e innocente, ma sensibile, Ciro s’infuriò contro un fiume. Mentre andava ad assediare Babilonia, conducendo quella spedizione in tutta fretta perché l’esito di una guerra è dovuto in massima parte a circostanze casuali, a un certo punto dovette guadare il Ginde,54 il quale, essendo straripato, rendeva quell’impresa pericolosa anche d’estate, quando è in secca e ridotto al minimo. E infatti all’improvviso uno dei
cavalli bianchi, che di solito trainavano il carro regale, fu travolto dalla corrente. Ebbene, Ciro, adiratosi come una furia, giurò che avrebbe ridotto quel fiume, che s’era ingoiato il suo seguito, in condizioni tali che anche le donne potessero attraversarlo a piedi, quindi trasferì lì tutto l’apparato bellico e attese a lungo ai lavori finché non ebbe diviso l’alveo del fiume in centottanta canali e disperso le acque in trecentosessanta ruscelli, riducendolo così in secca, poiché le acque scorrevano in tutte le direzioni. Quel ritardo – il tempo è un fattore molto importante nelle grandi imprese – smorzò l’entusiasmo dei soldati, sfiniti da un lavoro inutile, e fece svanire la possibilità di cogliere i nemici impreparati: Ciro, insomma, fece a un fiume la guerra che aveva dichiarato al nemico. Quella follia (non potrei infatti usare una parola diversa) contagiò anche i Romani, se si pensa che Caligola fece demolire una sua bellissima villa nei pressi di Ercolano solo perché in precedenza vi era stata tenuta prigioniera la madre.55 Così, però, la rese famosa, visto che quando era in piedi quelli che vi passavano davanti con le loro imbarcazioni non vi facevano caso, mentre ora tutti si chiedono perché sia stata demolita. 22. Ma questi sono esempi su cui riflettere per evitarli. Sono invece da seguire quelli di moderazione e di umanità, anche se non vi mancano motivi per adirarsi e il diritto di vendicarsi, come nel caso del re Antigono. 56 Due soldati sparlavano di lui standosene appoggiati alla sua tenda, una cosa che gli uomini fanno spesso e volentieri, non senza rischio e pericolo. Ebbene, il re avrebbe potuto facilmente mandarli al supplizio, poiché aveva udito tutto, essendoci di mezzo tra lui e i soldati soltanto un telo. Egli invece scostò appena il lembo della tenda e disse: «Andate più lontano, affinché il re non vi senta». Un’altra volta, di notte, avendo sentito alcuni soldati lanciare contro di lui ogni sorta di imprecazioni perché li aveva costretti a quella marcia forzata in mezzo a un pantano che non mostrava alcuna via di uscita, si avvicinò, senza farsi riconoscere, a quelli che si trovavano in maggiore difficoltà, e dopo averli tratti d’impaccio esclamò: «Adesso parlate pure male di Antigono, che ha commesso l’errore di cacciarvi in questo guaio, ma augurategli anche del bene perché vi ha tirati fuori da questo ingorgo melmoso». Egli sapeva sopportare con indulgenza sia le ingiurie dei nemici che quelle dei suoi sudditi. Una volta, mentre assediava un piccolo fortino occupato dai Greci, avendo udito che questi, forti della loro posizione, disprezzavano il nemico e prendevano in giro lui per la sua bruttezza, deridendo ora la sua bassa statura, ora il suo naso schiacciato, alla fine [riferendosi a sé stesso] esclamò: «Sono contento, e spero proprio che le cose mi vadano bene, visto che ho un Sileno nel mio accampamento».57 Dopo aver piegato per fame quei maldicenti, così trattò i prigionieri: distribuì nelle sue coorti quelli che erano abili al servizio militare, gli altri li fece vendere all’asta, precisando che non lo avrebbe fatto se non avesse ritenuto
giusto che delle lingue così malvagie dovessero avere un padrone. 23. Questo vizio l’aveva anche Alessandro, nipote di Antigono, 58 il quale scagliava lance contro i suoi commensali e una volta, come ho detto più sopra, gettò in pasto a un leone un amico, che riuscì a scamparla, mentre un altro l’uccise di sua mano. Ma non lo ereditò né dal nonno né dal padre Filippo, il quale fra le altre virtù aveva quella di sopportare le offese, che è una grande risorsa per un re che voglia mantenersi sul trono. Un giorno giunsero da Atene degli ambasciatori, fra i quali Democare, uno che per la sua lingua sfacciata e provocante era chiamato Parresiaste.59 Filippo, dopo averli ascoltati benevolmente, gli chiese: «Che cosa posso fare per gli Ateniesi?». «Impiccarti!», sbottò Democare. Quella risposta così sfrontata provocò una indignazione generale, ma Filippo, invitati tutti a tacere, lasciò che quel Tersite se ne andasse via sano e salvo. E rivolto agli altri ambasciatori disse: «Quanto a voi, riferite agli Ateniesi che chi offende in questo modo è molto più arrogante di chi lo ascolta senza infierire su di lui». Anche il divino Augusto diede spesso prova, con le parole e coi fatti, di non lasciarsi prendere dall’ira, e molti sono gli episodi degni di essere ricordati. Lo storico Timagene,60 per esempio, era solito sparlare di lui, della moglie e di tutta la famiglia: la sua maldicenza non andava a vuoto, poiché le battute più audaci circolano facilmente e finiscono sulla bocca di tutti. L’imperatore stesso lo aveva più volte pregato di tenere a freno quella sua linguaccia, finché, visto che non la smetteva, lo mise alla porta. Timagene invecchiò in casa di Asinio Pollione,61 conteso da tutta la città: l’essere stato cacciato dall’imperatore, infatti, non gli sbarrò nessun’altra porta. Egli poté leggere pubblicamente le opere storiche che compose in seguito, bruciò i libri in cui aveva narrato le gesta di Cesare Augusto e compì atti di aperta ostilità contro di lui, senza che alcuno avesse paura di tenerselo amico o di sfuggirlo come se fosse colpito da un fulmine, anzi ci fu chi gli diede ospitalità dopo ch’era caduto da tanta altezza. Ebbene, come ho detto, l’imperatore sopportò tutto con pazienza e non si arrabbiò neppure perché aveva manipolato la verità sulle sue imprese meritorie, né mai si lamentò con chi ospitava quel suo nemico. Ad Asinio Pollione disse soltanto: «Tu nutri una belva». E come quello cercava di trovare una scusa, interrompendolo, aggiunse: «Goditelo pure, Pollione mio, goditelo!». Al che Pollione rispose: «Se me lo ordini lo caccio subito da casa mia». Ma lui: «E tu pensi che io possa chiedertelo dopo che vi ho riconciliati?». Pollione, infatti, un tempo era stato in collera con Timagene, poi lo aveva perdonato, ma solo perché in collera con lui c’era andato Augusto. 24. Perciò, quando riteniamo che uno ci abbia offeso, diciamo a noi stessi: «Sono io forse più potente di Filippo? Eppure, lui si è lasciato insultare senza reagire. Ho più potere io che comando solo in casa mia di quanto non ne ebbe il
divino Augusto sul mondo intero? Nonostante ciò, egli si limitò ad allontanare dalla sua casa colui che lo ingiuriava. Per quale motivo, dunque, dovrei fare scontare a un mio schiavo, a suon di frustate e di catene, una sua risposta schietta, un atteggiamento che io non condivido, un brontolio che in effetti non mi tocca? Chi sono io per ritenermi offeso da una parola che mi ferisce solo l’orecchio? Molti perdonano i loro nemici e io non devo perdonare dei fannulloni, degli sprovveduti, dei chiacchieroni?».62 Un bambino sia scusato per l’età, una donna per il sesso, un forestiero perché è indipendente, un domestico perché è della famiglia. Alla prima volta che uno di costoro ci offende pensiamo a tutto il tempo in cui ci è stato simpatico, se ci ha offeso altre volte e spesso: sopportiamo come abbiamo fatto sino a quel momento. Se è un amico lo ha fatto involontariamente, se è un nemico ha fatto ciò che doveva. Ascoltiamo i più saggi, perdoniamo i più sciocchi, riflettiamo, a beneficio di tutti, che anche i più saggi spesso commettono errori, che nessuno è così accorto da non perdere qualche volta, almeno in parte, la sua prudenza, nessuno è così maturo da non incorrere mai, neppure casualmente, in qualche atto inconsulto, nessuno è così timoroso di offendere da non commettere egli stesso un’offesa proprio mentre cerca di evitarla. 25. Come a un poveruomo a cui capita una disgrazia è di conforto pensare che anche con i grandi la sorte non sempre è favorevole, come in un angolo della sua casa un padre piange con animo rassegnato la morte di un figlio quando sa che pure in una reggia ci sono fanciulli che muoiono, così se pensiamo che l’offesa può colpire anche i più potenti sopporteremo con maggior serenità di essere offesi o addirittura disprezzati. Se persino i più prudenti sbagliano, potrà mai esserci uno che commetta un errore senza avere bella e pronta la sua scusa? Pensiamo a quante volte da ragazzi siamo stati poco diligenti nell’adempiere ai nostri doveri, smodati nel parlare, poco temperanti nel bere. Ebbene, se uno si adira contro di noi, diamogli il tempo di rendersi conto del suo gesto: alla fine sarà egli stesso a punirsi. E non intestardiamoci a voler pareggiare i conti se siamo in credito con lui. Chi non si cura delle offese non solo si distingue dalla massa, ma si erge molto più in alto di chi invece vi dà peso: la vera grandezza di un uomo sta proprio nel non avvertire il colpo. Così una grossa belva si volta svogliata al latrare dei cani, così una forte ondata si rovescia invano contro un grande scoglio. Chi non si adira rimane saldo e immobile di fronte all’offesa, chi si adira ne resta ferito. Ma il saggio, che come ho detto si erge al di sopra degli eventi e tiene tra le braccia il sommo bene, così risponde agli uomini e alla sorte: «Fate quello che volete, siete troppo piccoli per potere intaccare la mia serenità. Merito della mia ragione, alla quale ho affidato il governo della mia vita. L’ira mi nuocerebbe più dell’offesa, perché l’offesa ha un limite, mentre l’ira non posso sapere fin dove potrebbe portarmi».
26. «Ma io non sono capace di sopportare un’offesa: è difficile, costa fatica tollerarla!». Tu menti: se si sopporta l’ira come si può non sopportare un’offesa? Aggiungo che in questo modo sopporti sia l’ira che l’offesa. Perché sopportiamo la rabbia di un ammalato, le parole di un pazzo, le mani sfacciate dei bambini? Evidentemente perché loro non sanno quello che fanno. Né serve distinguere tra vizio e vizio quando l’incoscienza è una scusante valida per tutti. «Dunque chi offende non deve essere punito?». Qualunque castigo è in sostanza inutile, perché la più grande punizione dell’offesa è la coscienza di averla fatta, e nessuna punizione è più grave di quella subìta da colui che è preso e tormentato dal rimorso. E poi, per poter giudicare obiettivamente ciò che accade bisogna tener conto delle varie situazioni: non è giusto, per esempio, addebitare a un singolo un vizio che è comune a tutti. In una folla di Etiopi tu non badi al colore della pelle di questo o di quello, così come tra i Germani non disdicono agli uomini i capelli biondi e annodati: non è mai criticabile e tanto meno vergognoso in un individuo ciò che rientra nell’uso comune della sua gente. E se giustifichiamo questi casi, che riguardano i costumi di una regione o di un angolo del mondo, pensa quanto sia più giusto perdonare quei difetti che appartengono all’intera umanità. Siamo tutti sconsiderati e sprovveduti, tutti indecisi, brontoloni, ambiziosi (perché nascondere con giri di parole una piaga comune?): siamo tutti dei malvagi. Ciò che oggi rimproveriamo agli altri domani ce lo ritroveremo in noi stessi. Perché vai segnando a dito il pallore di questo o la magrezza di quello? Siamo tutti appestati. Cerchiamo quindi di essere tolleranti l’uno con l’altro: siamo dei malvagi che vivono in mezzo ad altri malvagi. Una sola cosa può renderci sereni, uniti e concordi: la comprensione reciproca. «Ma se uno mi ha recato un danno senza che io gli abbia fatto nulla?». Forse hai offeso qualcun altro, o l’offenderai. Non guardare quest’ora o questo giorno, pensa al tuo comportamento in generale, rifletti che se non hai fatto nulla di male può sempre accaderti di farlo. 27. Ma poi è meglio sanare un’offesa piuttosto che vendicarla. La vendetta si espone a sua volta a molte offese, pur lamentandone una sola, e si trascina nel tempo. L’ira dura più della ferita che ne riceviamo. È meglio allora prendere un’altra strada e non combattere un vizio con un altro vizio. Ti sembrerebbe assennato uno che restituisse i calci alla sua mula o i morsi al suo cane?63 «Ma gli animali non sanno di fare del male!». Innanzitutto chi pensa che l’essere uomini renda impossibile o difficile il perdono sbaglia. In secondo luogo, se non ti adiri con tutti gli animali perché agiscono inconsciamente, devi comportarti allo stesso modo con chiunque non si renda conto di quello che fa. Uno può essere diverso dagli animali per tanti altri aspetti, ma se gli somiglia per l’incoscienza del male o degli errori che essi
fanno, per il loro cervello ottenebrato, in questo caso dov’è la differenza? Ha sbagliato, tu dici. È la prima volta? È l’ultima? Anche se dice «Non lo farò più» non devi credergli: egli sbaglierà ancora, così come gli altri sbaglieranno nei suoi confronti, e tutta la vita in questo modo volerà via fra gli sbagli. Chi non è buono va trattato con bontà. Si dica anche nell’ira ciò che si suole dire a sé stessi con efficacia nella sventura: la smetterai una buona volta, o no? Se la devi finire, quanto è più conveniente che abbandoni tu l’ira piuttosto che sia lei a lasciare te! O dovremo essere sempre in agitazione? Non vedi che vita tormentata ti prepari? E come sarà la vita di un uomo sempre infuriato? Aggiungi che quando ti sarai infiammato ben bene e avrai trovato sempre nuovi motivi per arrabbiarti, l’ira finirà con l’andarsene via da sé, perché il tempo le toglierà ogni forza. E allora? Meglio che sia sconfitta da te piuttosto che da sé stessa. 28. Ci si adira con tutti: si comincia con i domestici, poi con i genitori, con i figli, con le persone che si conoscono e con gli sconosciuti: i motivi sono tanti e si trovano sempre e dovunque, se non ci si mette l’animo a tenerli lontani. La collera trascina in tutte le direzioni, e a provocazione si aggiunge provocazione, sicché la rabbia non si ferma. Sventurato, non troverai mai, dunque, uno spazio per l’amore? Quanto tempo perduto, che avresti potuto utilizzare per una buona azione! Come sarebbe stato meglio se lo avessi speso procurandoti degli amici, rappacificandoti con i nemici, dedicandoti all’amministrazione dello Stato o agli affari di casa, invece di darti da fare studiando come ferire qualcuno nel suo prestigio, nei suoi beni e nella sua persona fisica! E per fare tutto questo devi lottare, andare incontro a rischi, anche se hai da fare con uno che vale meno di te. Pur s’egli fosse incatenato e sotto la tua completa volontà, a forza di infierire su di lui potresti anche slogarti un braccio, spezzarti un nervo rimasto impigliato nei suoi denti. Anche quando ha incontrato dei soggetti passivi, l’ira ha reso molte persone monche o invalide. Aggiungi che nessuno nasce così debole da morire senza pericolo di chi lo schiaccia: certe volte il dolore o le circostanze mettono i deboli alla pari coi più forti. Fra l’altro, nella maggior parte dei casi ciò che provoca la nostra ira sono le offese non le ferite. C’è differenza fra chi si oppone alla mia volontà e chi non la condivide, fra chi mi ruba e chi non mi dà. E invece noi mettiamo sullo stesso piano chi ci deruba e chi non ci dà, chi manda a monte i nostri progetti e chi li rinvia, chi agisce contro di noi e chi a proprio vantaggio, per amore di altri o per odio verso di noi. Alcuni poi si arrabbiano per motivi che sono non solo giusti ma anche nobili, come la difesa del proprio padre, del fratello, della patria o di un amico, eppure noi neppure in questo caso li giustifichiamo: se però non lo facessero li biasimeremmo, anzi – e ciò è davvero incredibile – molte volte giudichiamo bene un’azione e male la persona che la fa. Ma perdinci, dico, l’uomo magnanimo e giusto ammira anche i suoi nemici quando sono molto coraggiosi e difendono tenacissimamente la libertà e la salvezza della patria, e sono questi i concittadini e i soldati ch’egli desidera
avere. 29. È vergognoso odiare chi è meritevole di lode, ma ancor più vergognoso è odiare uno che dovrebbe ispirare compassione, come un prigioniero, che caduto improvvisamente in schiavitù, e perciò ancora memore della libertà di cui godeva, stenta ad accettare mansioni umilianti e faticose; o come uno schiavo, che infiacchito dal riposo non ce la fa a correr dietro al cavallo e alla carrozza del padrone, o cade dal sonno perché sfinito da giorni e giorni di veglia; così chi è passato dalla riposante schiavitù della città alla dura fatica dei campi si rifiuta di lavorare la terra o lo fa con fiacca e di malavoglia. Distinguiamo dunque chi non può da chi non vuole. Se prima di montare in collera esaminiamo le cose con giudizio ne assolveremo molti. Invece noi seguiamo il primo impulso, e anche quando riconosciamo che i motivi della nostra eccitazione erano futili non la smettiamo, per non dare l’impressione che abbiamo cominciato senza un motivo. Infine – e questa è l’ingiustizia più grave – l’iniquità della nostra ira ci rende più ostinati; ce la teniamo e l’aumentiamo, come se l’essere sommamente adirati fosse la prova che avevamo una buona ragione per adirarci. 30. È meglio quindi tenere sempre presente che l’ira al suo insorgere è legata a motivi futili e innocui. Anche l’uomo in certi casi si comporta come gli animali: ci turbiamo infatti per cose di nessun conto o campate in aria: il toro si eccita al colore rosso, il serpente si drizza per un’ombra, orsi e leoni si irritano alla sola vista di un fazzoletto; tutti gli esseri feroci e rabbiosi per natura si spaventano per cose da nulla. Lo stesso accade a chi è inquieto o sciocco per carattere: si sente ferito da un sospetto, tanto da giudicare offese persino quei piccoli benefìci che sono proprio la molla dell’ira più frequente e sconsiderata. Ci adiriamo, infatti, con le persone più care perché ci hanno dato meno di quanto noi pensavamo o di quanto ci hanno dato altri; eppure in entrambi i casi abbiamo un rimedio a portata di mano. Uno è stato più generoso con un altro? Rallegriamoci di ciò che abbiamo noi, senza fare confronti: non sarà mai felice chi si tormenta perché un altro è più felice. Ho meno di quanto speravo? Forse ho sperato troppo. Queste sono le cose che più si devono temere, perché è da lì che nascono le ire più funeste e capaci di intaccare anche gli affetti più sacri. Il divino Giulio ebbe tra i suoi uccisori più amici che nemici, perché non aveva soddisfatto le loro insaziabili brame. Ma per quanto egli lo volesse (nessuno fu più liberale di lui dopo una vittoria per la quale non chiese altro premio che quello di donare agli altri), non avrebbe mai potuto esaudire desideri così sfrenati, visto che ciascuno degli amici desiderava ciò che poteva essere dato a uno soltanto di loro. Così egli vide i suoi compagni d’armi circondare il suo seggio con le spade in pugno: Tillio Cimbro, 64 che sino a poco prima era stato un suo acceso sostenitore, e tanti altri, diventati pompeiani all’ultimo momento, quando Pompeo era ormai morto. L’ira è una passione che ha spinto interi eserciti a ribellarsi contro i loro re e uomini fidatissimi a progettare la
morte di coloro per i quali e al cospetto dei quali avevano giurato di morire. 31. L’uomo non si accontenta di ciò che possiede quando vede che altri hanno di più. Per questo ce la prendiamo anche con gli dèi se qualcuno ci passa davanti, dimenticando quanti sono quelli che ci seguono e quanta invidia si tira dietro chi ha pochi da invidiare. Ma gli uomini sono così sfrontati che anche quando hanno avuto molto si sentono offesi perché presumono di meritare di più. E così dicono «Mi ha dato la pretura, ma io aspiravo al consolato; mi ha dato i dodici fasci, ma non mi ha fatto console ordinario; ha voluto che si datasse l’anno col mio nome, ma mi ha negato il sacerdozio; sono stato eletto in un collegio, ma perché in uno solo?65 Mi ha fatto avere il massimo degli onori, ma non ha aggiunto un soldo al mio patrimonio: mi ha dato ciò che doveva pur dare a qualcuno, ma di suo non ci ha messo nulla». Ringrazia piuttosto per quello che hai ricevuto: il resto aspettalo e consolati di non essere pienamente soddisfatto: tra i piaceri c’è anche quello di aspettarsi ancora qualcosa. Hai superato tutti? Rallegrati di occupare il primo posto nell’animo del tuo amico. Molti ti passano davanti? Pensa che quelli che ti vengono dietro sono molto più numerosi di quelli che ti precedono. Vuoi sapere qual è il tuo più grande difetto? Sbagli nel fare i conti, valutando molto quello che dài e poco quel che ricevi. 32. Varie sono le ragioni che devono trattenerci dall’ira: con alcuni dobbiamo astenercene per timore, con altri per rispetto, con altri per disprezzo. Che bella impresa mandare in carcere per tutta la vita un povero schiavo! Perché affrettarsi a farlo frustare, a fargli spezzare subito le gambe? Avremo sempre la possibilità di farlo in un secondo momento. Aspettiamo di essere noi a dominare l’ira, perché ora obbediremmo ai suoi ordini: quando lei se ne sarà andata, allora vedremo quanto peso si debba dare alla questione. È questo, soprattutto, il nostro errore: mettiamo subito mano alla spada, condanniamo a morte o puniamo con catene, carcere e fame, una colpa che dovrebbe essere punita con qualche colpo di frusta. «Ma come? Vuoi farci vedere quanto siano insignificanti, misere e puerili cose che invece ci feriscono?». In verità il miglior consiglio che posso darvi è quello di essere magnanimi, facendovi capire quanto siano vili e meschine tutte queste cose per cui litighiamo e ci affanniamo, correndo di qua e di là: un animo nobile ed elevato non deve nemmeno prenderle in considerazione. 33. Ma è per il denaro che si litiga di più: è lui che dà lavoro ai tribunali, che semina la zizzania fra i padri e figli, che sparge veleni, che mette la spada in mano agli assassini e alle legioni, che si bagna del nostro sangue; è per lui che le notti risuonano degli alterchi di mogli e mariti, che masse di gente affollano le tribune dei magistrati, che i re incrudeliscono, saccheggiano e distruggono città,
costruite dalla fatica di intere generazioni, per frugare fra le loro ceneri l’oro e l’argento. Guarda gli scrigni accantonati in un angolo della casa: è per quelli che si grida fino a farsi uscire gli occhi dalle orbite, è per quelli che le basiliche risuonano dello strepito dei processi e che magistrati, venuti dalle regioni più lontane, si riuniscono per giudicare quale delle due avidità sia più giusta. Che dire, poi, se non si tratta nemmeno di uno scrigno, se un vecchio senza eredi crepa di bile per un pugno di monete o per un denaro messo in più nel conto da uno schiavo? Che dire se per un misero uno per mille di interesse un usuraio, malandato, coi piedi storti e le mani ormai incapaci di contare il denaro, grida e reclama negli accessi del male, i soldi che gli sono stati promessi, versati in tribunale come cauzione? Se tu mi portassi davanti tutta la ricchezza che si estrae dalla profondità delle miniere, se mettessi a mia disposizione tutto ciò che si cela nei tesori (gli avari rimettono sotto terra ciò che non doveva uscirne), io non riterrei che tutto quel mucchio meriti di far corrugare la fronte a un uomo virtuoso. Quante lacrime ci lasciamo strappare da cose che invece dovremmo accogliere con grandi risate! 34. E ora passiamo in rassegna tutte le altre cose [che possono spingerci all’ira]: il mangiare e il bere, con le loro ambiziose apparecchiature, le suppellettili, le parole offensive, i gesti irriguardosi, gli animali pigri e gli schiavi indolenti, i sospetti e le interpretazioni malevole dei discorsi altrui (per cui verrebbe da pensare che la natura ha concesso all’uomo la parola per farne un’arma di offesa). Credimi, non valgono nulla i motivi per i quali ci lasciamo andare in violente escandescenze; come quelli che spingono i bambini a litigare e a insultarsi. Di quel che facciamo quando siamo in collera nulla è serio e importante, perciò, ripeto, la vostra ira, la vostra pazzia, nasce dal fatto che date un valore eccessivo a cose da nulla. Costui – voi dite – ha voluto portarmi via un’eredità, quello mi ha calunniato presso persone che mi ero fatte amiche con tanta fatica, sperando che si ricordassero di me nei loro ultimi istanti; quell’altro si è invaghito della mia amante. Così ciò che dovrebbe unirci e affratellarci in un desiderio comune diventa motivo di odio e di discordia. Una strada stretta provoca risse tra i passanti, una strada larga e spaziosa fa sì che nemmeno le folle vi si scontrino. Ebbene, le cose che desideriamo perché sono scarse e che possiamo avere solo sottraendole ad altri suscitano liti e scontri fra coloro che se le contendono. 35. Ti indigni perché un tuo schiavo, un tuo liberto, tua moglie o un tuo cliente ti ha rimbeccato, e poi ti lamenti perché lo Stato ha soppresso quella libertà che tu hai abolito in casa tua. Se invece uno non risponde alle tue domande dici che è un arrogante. Ma lascialo parlare! Lascia che taccia, o che rida, se vuole! «Anche davanti al suo padrone?».
Anzi, davanti al padre di famiglia. Perché gridi, perché strilli, perché durante la cena fai frustare gli schiavi che parlano, quando dove c’è una folla da comizio non si può pretendere un silenzio da deserto? Gli orecchi ti sono stati dati affinché tu possa ascoltare non solo armoniose e languide melodie, dal suono dolce e modulato, ma anche risa e pianti, complimenti e litigi, notizie buone e notizie cattive, voci di uomini e muggiti e latrati di animali. Perché ti spaventi, miserabile, al grido di uno schiavo, al tintinnare di un vaso di bronzo, allo sbattere di una porta? I tuoni ci vogliono per te, visto che sei tanto delicato! Ciò che ho detto degli orecchi vale anche per gli occhi, che non sono meno schifiltosi se non hai saputo educarli. Si risentono per una macchiolina, per un po’ di sporcizia, per l’argento non lucidato a dovere, per una vasca che non lascia trasparire il fondo. E questi occhi, che non sopportano la vista di un marmo se non è ben chiazzato e lucidato, o di una tavola il cui legno non abbia tante venature, che in casa non vogliono che si calpestino pavimenti meno preziosi dell’oro, sono poi capaci di guardare in tutta tranquillità strade dissestate e fangose, passanti per lo più sporchi, muri di isolati corrosi, pieni di crepe e di sporgenze. Quale altro motivo può rendere uno calmo in pubblico e nervoso in privato se non una disposizione d’animo che fuori è benevola e tollerante, in casa invece bisbetica e lagnosa? 36. Dobbiamo indirizzare tutti i nostri sensi alla fermezza che gli ha dato la natura: essi, infatti, sono di per sé stessi resistenti, se non li guasta l’animo. Il quale, dunque, va chiamato quotidianamente a rapporto affinché renda conto del suo operato. È ciò che faceva Sestio: alla fine della giornata, non appena si era ritirato per dormire, interrogava la sua coscienza: «Quale tuo male hai guarito oggi? A quale vizio ti sei opposto? In che cosa sei migliorato?». Chi sa di dover comparire ogni giorno davanti al giudice si farà più moderato e l’ira cesserà. Cosa c’è di più bello di questa consuetudine di passare in rassegna un’intera giornata! Che sonno tranquillo, libero e profondo, dopo questa indagine interiore, dopo che l’animo è stato lodato o ammonito, e, fattosi esaminatore e censore intimo di sé stesso, ha preso atto del suo comportamento! Anch’io mi avvalgo di questa usanza e mi faccio ogni giorno il processo. Quando il lume è stato portato via e mia moglie,66 che sa di questa mia abitudine, tace, io comincio a indagare tutta la mia giornata e ripenso a quello che ho detto e che ho fatto, senza nulla nascondermi o tralasciare. Nessun mio errore mi turba o mi spaventa, se posso dire: «Questo cerca di non farlo più; per ora ti perdono. In quella discussione sei stato troppo polemico: d’ora in poi lascia perdere gli ignoranti, perché chi non ha mai imparato non vuole imparare. Hai rimproverato quel tale con eccessiva franchezza, sicché, invece di correggerlo, l’hai offeso; d’ora in avanti non guardare soltanto se dici la verità, ma chiediti anche se chi ti ascolta è disposto a tollerarla». L’uomo virtuoso accetta di buon grado un ammonimento, mentre il malvagio sopporta con animo ostile chi cerca di guidarlo.
37. Mettiamo che durante un pranzo ti abbiano colpito gli scherzi di alcuni e certe parole buttate lì per ferirti. Ebbene, ricordati di stare lontano dalla mensa di persone volgari, anche perché, dopo aver bevuto, la loro licenziosità, visto che non parlano pulito nemmeno quando sono sobri, si fa ancora più sboccata. Hai visto il tuo amico adirarsi col portinaio di un avvocato o di un ricco perché non lo aveva lasciato entrare, e anche tu ti sei adirato per lui con l’ultimo degli schiavi? È come se te la fossi presa con un cane da guardia: anche lui, dopo avere abbaiato molto, se gli getti del cibo, si calma. Vattene via, dunque, e facci sopra una risata. Quel custode si crede qualcuno perché fa la guardia a una porta assediata da una folla di litigiosi, mentre l’altro, che sta in casa, si sente felice e fortunato, convinto che sia segno di benessere e di potenza una porta difficile da aprirsi: non sa che quella della prigione rende ancora più difficile l’uscita.67 Tieni sempre presente che devi sopportare molte cose: ci meravigliamo forse di avere freddo d’inverno? Se ci viene la nausea quando andiamo per mare o se durante un viaggio per terra siamo sballottati di qua e di là? L’animo sa resistere a qualunque male se vi è preparato. Poiché a tavola ti è stato assegnato un posto di minor prestigio te la sei presa col padrone di casa, con chi ha fatto gli inviti, con quello stesso commensale che ti è stato anteposto: sei uno sciocco, che importa su quale parte del divano stai sdraiato? Un cuscino può forse renderti più nobile o più spregevole? Hai guardato di traverso un tale che ha parlato male del tuo ingegno. Secondo questo principio Ennio, che non ti piace, dovrebbe detestarti, Ortensio68 dichiararti il suo rancore e Cicerone, se deridessi i suoi versi, esserti ostile. Insomma, se ti candidi a qualche posto devi accettare di buon animo l’esito delle votazioni. 38. Se hai ricevuto un’offesa pensa che non è più grave di quella fatta allo stoico Diogene,69 il quale, proprio mentre stava discutendo animatamente sull’ira, ricevette in pieno viso uno sputo da un giovane insolente. Ebbene, il filosofo sopportò la cosa con serenità e saggiamente disse: «Non mi arrabbio, però ho i miei dubbi se sia giusto o no». Meglio ancora si comportò il nostro Catone! Mentre stava discutendo un processo, Lentulo,70 che i nostri padri ricordano come uomo fazioso e prepotente, tirata su una bella dose di saliva, gli sputò in piena fronte. Al che Catone, ripulitosi il viso, esclamò: «Davanti a tutti, o Lentulo, ti dico: sbaglia chi afferma che tu non hai la bocca».71 39. Sin qui, caro Novato, ti ho indicato la giusta condotta che l’animo deve tenere nei confronti dell’ira: o schiacciarla o non darle retta. Ora vediamo come calmare quella altrui, poiché vogliamo non soltanto essere sani noi, ma anche guarire gli altri. Non sprecheremo parole per dire come calmare l’ira al suo insorgere, perché in quella prima fase essa è pazza e sorda. Dobbiamo darle tempo: le medicine
giovano nei periodi di calma: quando gli occhi sono gonfi non stiamo lì a toccarli per scioglierne la rigidezza massaggiandoli. Tutte le malattie allo stato virulento vanno curate inizialmente col riposo. «Ma quanto può giovare un rimedio che placa l’ira quando già sta calmandosi da sé?». In primo luogo ne accelera la fine, poi ne evita le ricadute; trarrà persino in inganno quel primo impulso che non è facile placare; allontanerà tutti gli strumenti di vendetta, simulerà addirittura l’ira per avere così maggiore autorità nel dare consigli in qualità di sostenitore e partecipe del risentimento, inventerà rinvii, e fingendo di cercare vendette più dure ritarderà quella immediata. Farà insomma ricorso a ogni mezzo per dare una pausa al furore, e se questo sarà troppo violento gl’incuterà vergogna o un tale timore a cui non saprà resistere; se invece sarà piuttosto debole gli terrà discorsi piacevoli o insoliti e lo distrarrà incuriosendolo e stimolando in lui il desiderio di sapere. Si narra che un medico, dovendo curare la figlia del re e non potendo farlo senza operarla, mentre le applicava dei calmanti sulla mammella gonfia, vi affondò il bisturi che teneva nascosto sotto una spugna: se lo avesse accostato allo scoperto la fanciulla avrebbe reagito, ma poiché non se lo aspettava, sopportò il dolore. Ci sono dei mali che si guariscono solo con l’inganno. 40. A uno dirai: «Bada che la tua ira non rallegri i tuoi nemici!». A un altro: «Sta’ attento che la tua magnanimità e la tua ben nota reputazione non vadano in frantumi! Anch’io, diamine, sono indignato e non so contenere il mio risentimento, ma bisogna aspettare: chi ti ha offeso sarà punito, tieniti per ora il tuo rammarico, quando ti sarà possibile lo ricambierai con gl’interessi». Punire chi è adirato e adirarsi addirittura con lui è come eccitarlo ancora di più: devi invece prenderlo diversamente, con dolcezza; ammenoché tu non sia una persona così autorevole da spezzare la collera, come fece il divino Augusto un giorno in cui si trovava a pranzo da Vedio Pollione.72 Uno degli schiavi aveva rotto una coppa di cristallo, Vedio lo fece prendere per dargli una morte esemplare: buttarlo in pasto alle grosse murene che teneva in un vivaio. Qualcuno poteva pensare che lo facesse per eccentricità, invece era un vero atto di crudeltà. Lo schiavo riuscì a svincolarsi dalle mani di chi lo teneva e si rifugiò ai piedi dell’imperatore, non chiedendo altro che di morire in un modo diverso, di non fare cioè da esca ai pesci. Augusto rimase colpito da quel tipo di crudeltà e ordinò che lo schiavo fosse lasciato libero, che tutte le coppe di cristallo fossero rotte in sua presenza e gettate nel vivaio. Così l’imperatore punì un amico e fece buon uso della sua autorità. «Fai allontanare un uomo da un banchetto», gli disse, «per straziarlo con un supplizio insolito? Perché si è rotta una tua coppa devono essere sbranate le viscere di un uomo? Ti credi tanto importante da poter pronunciare una condanna a morte in presenza dell’imperatore?». Chi dunque è tanto potente da potersi permettere di aggredire l’ira dall’alto
lo faccia, a condizione che si tratti di un’ira quale quella che ho descritto sopra, feroce, brutale, sanguinaria, che non si piega se non l’afferra il timore di qualcosa ancora più forte di lei. 41. Diamo dunque al nostro animo quella pace che potrà venirgli dalla continua meditazione sui salutari insegnamenti, dalle buone azioni e da una mente concentrata solo nel desiderio della virtù. Pensiamo a soddisfare la nostra coscienza e non affatichiamoci per conseguire la fama, e anche se questa dovesse essere cattiva non importa: basterà che siano buone le nostre azioni. «Ma la gente ammira le imprese coraggiose e onora gli audaci: le persone tranquille le giudica indolenti». Forse a prima vista. Ma quando con un metodico tenore di vita hanno dimostrato che la loro non è pigrizia ma pace dell’animo, quella gente stessa le rispetta e le onora. Niente di utile ha in sé questa passione tetra e ostile, non porta altro che male, incendi e stragi. Calpestando ogni ritegno, si lorda le mani di sangue, disperde le membra dei figli, tutto quello che fa è criminoso; incurante della gloria e dell’infamia finisce col diventare incorreggibile quando, ormai incallita, si è trasformata in odio. 42. Teniamoci dunque alla larga da questo malanno, purifichiamo la nostra anima ed estirpiamo alla radice quei germogli che, per quanto esili possano essere, rinasceranno, trovando sempre un terreno in cui attecchire. E non limitiamoci a contenere l’ira, ma allontaniamola del tutto: come si può infatti moderare una cosa che è in sé stessa cattiva? Ce la faremo, basta un piccolo sforzo e niente ci aiuterà di più quanto il riflettere che siamo votati alla morte. Diciamo a noi stessi e agli altri: «Non siamo nati per l’eternità: a che serve adirarsi, perché sciupare una vita tanto breve? A che giova impiegare i nostri giorni nel far male agli altri quando possiamo utilizzarli in piaceri onesti? Queste attività non comportano perdite e noi non abbiamo tempo da sciupare. Perché ci gettiamo nella mischia? Perché andiamo a impelagarci in dispute verbali? Perché, immemori della nostra debolezza, ci attiriamo inimicizie enormi e, fragili come siamo, ci mettiamo a distruggere? Non passerà molto tempo che una qualche febbre o malattia ci impedirà di portarci dentro più oltre questi rancori che coviamo implacabilmente nell’animo; ben presto si frapporrà la morte tra questi due accanitissimi nemici. A che giova agitarsi e turbare la vita come dei rivoltosi? Il fato incombe sulle nostre teste, conta i giorni che passano e si fa sempre più vicino, e forse quell’ora che tu hai destinato alla morte di un altro è prossima alla tua. 43. È meglio, dunque, che ci teniamo stretti a questa nostra breve esistenza, cercando di stare in pace con noi stessi e con gli altri, rendendoci degni di essere amati da tutti finché viviamo e rimpianti quando non ci saremo più. Perché vuoi abbassare chi ti tratta troppo dall’alto? Perché vuoi schiacciare con tutte le tue
forze chi ti abbaia contro, quando non solo è un essere abietto e spregevole, ma infastidisce e avvelena anche quelli che stanno più in alto? Perché ti arrabbi col tuo schiavo, col padrone, col tuo re, col tuo cliente? Abbi un po’ di pazienza ed ecco che verrà la morte e vi farà tutti uguali. Come l’orso e il toro, che, legati insieme negli spettacoli mattutini, dopo avere inutilmente lottato nell’arena ed essersi tormentati a vicenda, vengono insieme uccisi dall’abbattitore. Così facciamo noi: ci azzuffiamo con chi ci sta legato accanto, senza pensare che siamo entrambi destinati alla morte, il vinto e il vincitore. Trascorriamo invece tranquilli e in pace con tutti quel poco tempo che ci resta, e quando saremo morti le nostre spoglie non siano invise ad alcuno. Spesso le grida per un incendio vicino hanno posto fine a una rissa e il sopraggiungere di una belva ha separato il viandante dal ladro. Non c’è tempo di lottare con i mali minori quando un timore più grande ci assale. E che c’entriamo noi con i combattimenti e gli agguati? A colui contro il quale ti adiri puoi forse augurare un male maggiore della morte? Egli morirà, comunque, anche se tu non muovi un dito. È una fatica sprecata la tua: vuoi fare ciò che comunque accadrà». «Ma io non penserei mai di ucciderlo: vorrei solo infliggergli l’esilio, l’infamia, nuocergli, insomma». Io perdono più facilmente chi minaccia al suo nemico una ferita che chi gli augura una pustola, poiché quest’ultimo non è soltanto malvagio, è anche vile. Che tu pensi di infliggere a uno il massimo o il minimo dei supplizi, la durata della sua pena sarà pari a quella dell’amara gioia che tu ne provi. Siamo nati e già stiamo esalando il respiro. Ma intanto, finché respiriamo, finché siamo fra gli uomini, comportiamoci da uomini: facciamo in modo di non essere mai motivo di paura o di pericolo per alcuno! Ignoriamo i danni, le offese, gl’insulti e gli scherni e sopportiamo con magnanimità le molestie passeggere. Come dice il proverbio: non facciamo in tempo a voltarci, a guardare indietro, che già ci sorprende la morte».
1. Orazio definisce l’ira un furor brevis . Significativo è l’intero passo: «Qui non moderabitur irae / infectum volet esse dolor quod suaserit et mens, / dum poenas odio per vim festinat inulto. / Ira furor brevis est: animum rege, qui nisi paret, / imperat; hunc frenis, hunc tu compesce catena»: «Chi cede all’ira vorrà poi sopprimere / ciò che lo sdegno e l’odio hanno prodotto. / Un breve fuoco è l’ira: frena dunque / l’animo tuo, non essere suo schiavo». (A Lollio, Epist. I, 2, 59-63). 2. L’espressione «schizzano grandi e minacciosi segnali» è forse ripresa da un verso di autore ignoto. 3. Si tratta forse del processo di Seiano (De tranquillitate animi, 11, 11). 4. Il passo è lacunoso: probabilmente continuava la descrizione dei mali provocati dall’ira. 5. Aristotele, L’anima, 403a 30. 6. Ovidio, Metamorfosi, VII 545-546. 7. Vedi Celso, Sulla medicina, proemio. 8. Platone, Repubblica, 1335D. 9. La prima vittoria fu sui Teutoni, sconfitti da Gaio Mario nel 102 a.C. alle Aquae Sextiae, la seconda,
riportata sempre da Gaio Mario sui Cimbri, avvenne nel 103 ai Campi Raudii. 10. Quinto Fabio Massimo, il Temporeggiatore. 11. Scipione l’Africano Maggiore. 12. Scipione l’Africano Minore: nel 133 espugnò Numanzia, che si era ribellata, e subì un’inchiesta per aver portato troppo a lungo l’assedio. 13. Teofrasto, famoso anche come naturalista, fu il più grande discepolo di Aristotele. Seneca qui si richiama alla obiezione espressa all’inizio del capitolo. 14. Aristotele, Etica Nicomachea (3, 8): Seneca non sembra tener conto della distinzione che lo Stagirita fa tra combattività e valore, forse perché attinge ad altri testi. 15. Tale soppressione era frutto di superstizione poiché si credeva che gli esseri mostruosi o menomati fossero una manifestazione dell’ira divina, da espiarsi appunto con la loro uccisione. Cicerone (De divinatione, 2, 60) non condivide la giustificazione avanzata da Seneca. 16. Cicerone, Tusculanae disputationes, IV 78. 17. I parricidi venivano flagellati, cuciti dentro un sacco e gettati in mare. Nel sacco venivano infilati anche una vipera (perché questa, nascendo, uccide la madre), un gallo (perché è solito beccare la madre), un cane (in quanto simboleggia la rabbia) e una scimmia (perché è l’immagine più bestiale dell’uomo). Il supplizio militare consisteva nella flagellazione e decapitazione. Dalla rupe Tarpeia venivano gettati i traditori. Quanto ai magistrati anche Plutarco scrive che devono giudicare con serenità, non spinti da odi privati e personali. (Consigli politici, 32). 18. La citazione è tratta da fonti indirette, non da Aristotele, nelle cui opere non appare. 19. Definito violento e crudele anche da Tacito, Gneo Pisone, governatore della Siria al tempo di Tiberio, fu costretto a suicidarsi perché sospettato di avere avvelenato Germanico, ch’era suo ospite. (Tacito, Annali, II 69). 20. Geronimo di Rodi era un filosofo peripatetico del III sec. a.C. 21. Platone, Leggi, XI 934A-B. 22. È un proverbio citato anche da Publilio Siro, un mimografo ricordato da Seneca nel De tranquillitate animi (11, 8) e nella Consolatio ad Helviam (9, 5). 23. La frase, ripresa da Cicerone (De officiis, I 97) dall’Atreo del poeta tragico Lucio Accio, era ripetuta spesso da Caligola e da altri imperatori. 24.Iliade, XXIII 724. 25. Allusione al mito di Ero e Leandro. 26. Seneca ne parla anche nel De constantia sapientis, laddove dice che Publio Clodio Pulcro (tribuno della plebe, autore della Lex Clodia, con cui fece appunto condannare all’esilio Cicerone), «insieme a Vatinio e a tutti gli altri peggiori», vendeva all’asta lo Stato. 27. Il fanciullo è Tolomeo XIII, fratello e marito di Cleopatra, che nel 48 a.C., dietro suggerimento di Teodoto e Achilla, suoi consiglieri, fece uccidere Pompeo, che si era rifugiato in Egitto dopo la sconfitta di Farsalo. 28. Si tratta di Alessandro Magno. Altre fonti riportano del cantore un nome diverso. 29. Apollodoro divenne nel 279 a.C. tiranno di Cassandria (l’antica Potidea, colonia di Corinto), la quale prese quel nome da Cassandre, che l’aveva ricostruita nel 316. Falaride era tiranno di Agrigento. Seneca lo cita anche nel De tranquillitate animi. 30. È Lucio Valerio Messalla Voleso, console nel 5 d.C. Fu messo sotto accusa da Augusto davanti al Senato (Tacito, Annali, III 68). 31. I recinti elettorali sono quelli del Campo Marzio, il circo è il Circo Massimo. 32. Ovidio, Metamorfosi, I 144-148. 33. Sono il Forum Romanum, il Forum Iulium e il Forum Augustum. 34. Il verso di Laberio (cavaliere e mimografo, in gara con Publilio Siro) allude alla tirannide di Cesare. 35. Lo «spauracchio» (formido) era un attrezzo costituito da penne rosse tenute insieme da una corda, anch’essa di color rosso, che veniva agitato dai cacciatori. 36. Plinio scrive che i leoni hanno paura della cresta e del canto dei galli (Naturalis Historia, VIII 52), Plutarco che il leone teme il gallo e l’elefante il porco (L’invidia e l’odio, 4). 37. Verso di poeta ignoto. 38. Zenone di Elea; del tiranno si tramandano diversi nomi, ma quanto a Ippia i tempi non corrispondono. 39. Altri, fra cui Plutarco, dicono Parmenione (il miglior generale di Filippo che seguì Alessandro e partecipò a tutte le grandi battaglie): la lettera avvertiva Alessandro che Filippo era stato corrotto da Dario con la promessa di grandi doni e della mano di sua figlia affinché appunto lo uccidesse. Alessandro, letta la lettera, la pose sotto il cuscino, poi, quando entrò Filippo recando la coppa con la pozione, tirò fuori la lettera
e gliela porse, quindi, tranquillamente, bevve la medicina (Plutarco, Vita di Alessandro, 19). 40. Scrive Plutarco: «Finite le guerre civili, Cesare… risparmiò molti di coloro che avevano combattuto contro di lui e ad alcuni conferì persino cariche e onori… Né tollerò che le statue di Pompeo fossero state abbattute o rimosse, ma le fece raddrizzare e rimettere al loro posto» (Vita di Cesare , 57). Quando hanno lottato, in buona fede, nell’interesse del proprio Paese, anche i vinti vanno rispettati («E tu onore di pianti, Ettore, avrai…»). 41. Mindiride era una fonte di aneddoti sui Sibariti (abitanti di Sibari, sul golfo di Taranto), noti appunto per la vita lussuosa ed effeminata. 42. Virgilio, Eneide, VIII 702-703. 43. Ma la morte gli rese giustizia. Dice Foscolo nei Sepolcri: «Né senno astuto, né favor di regi / all’Itaco le spoglie ardue serbava, / ché alla poppa raminga le ritolse / l’onda incitata dagl’inferni Dèi», portando «alle prode retèe l’armi d’Achille / sovra l’ossa d’Aiace». 44.Circumdati defossis corporibus ignes: non si tratta di «corpi sotterrati», ma di corpi legati a un palo che poi veniva drizzato e interrato alla base, intorno a cui si accendeva il fuoco, che quindi lambiva il corpo da sotto. Lo stesso supplizio veniva inflitto ai cristiani ma con la croce (vedi Tacito, Annali, XV 46). 45. È M. Celio Rufo, in difesa del quale Cicerone nel 56 a.C. pronunciò la nota orazione Pro Celio. 46. L’epilessia (di cui, come narra Plutarco, soffriva anche Cesare) era chiamata morbus comitialis, non perché si verificasse nei comizi ma perché al suo insorgere venivano sospese le operazioni elettorali. Era ritenuta una malattia sconveniente. 47. Cambise, re di Persia (529-521 a.C.), era figlio di Ciro il Grande. Prexaspe era suo corriere (vedi Erodoto, Le storie, III 34). 48. Astiage (584-549 a.C.) fu l’ultimo re dei Medi. Arpàgo, secondo una leggenda raccolta da Erodoto, fu incaricato da Astiage di sopprimere Ciro appena nato, ma, impietosito, lo fece invece esporre su un monte da un pastore, che lo salvò e lo allevò. Astiage, per vendicarsi, sgozzò il figlio di Arpago e ne imbandì le membra al padre, il quale si unì a Ciro e, conquistato il regno, ebbe il governo della Lidia. 49. Della morte di Clito, oltre a Cicerone (Tusculanae Disputationes, IV 79), parla anche Plutarco, il quale ne riporta la frase che gli fu fatale: «Beati quelli che sono morti prima di vedere i Macedoni battuti dalle fruste dei Medi e costretti a supplicare i Persiani per poter avvicinare il loro re!» (Vita di Alessandro , 51). 50. Si tratta di una leggenda. Lisimaco era un generale di Alessandro. 51. È Marco Mario Gaditano, nipote di Gaio Mario, il vincitore dei Cimbri e dei Teutoni. 52. Quinto Catulo fu console con Mario nella guerra contro i Cimbri. 53. L’episodio è riportato da Erodoto (Le storie, III 25). 54. Il Ginde è un affluente del Tigri (anche qui vedi Erodoto, I 189). 55. La demolizione della villa di Agrippina (la madre di Caligola) fu forse la conseguenza di una delle tante persecuzioni di Tiberio contro di lei, che fu poi mandata in esilio a Mandataria (Ventotene). 56. Si tratta forse di Antigono Gonata, re di Macedonia (283 a.C.). 57. Sileno, deforme e sempre ubriaco, accompagnava Bacco. Fu sfruttato come maschera nella Commedia. 58. In realtà Alessandro Magno, in quanto figlio di Filippo, era nipote di Aminta, non di Antigono. 59. Democare era oratore e storico: parresiaste in greco è il «parlare schietto». 60. Timagene, di Alessandria, fu condotto prigioniero a Roma (55 a.C.), dove insegnò retorica. 61. Caio Asinio Pollione, amico di Antonio e di Ottaviano, fu un grande personaggio nella vita politica e culturale del tempo: seguì Cesare e combatté in Spagna contro Pompeo. Virgilio gli dedicò la IV Egloga per aver avuto salvo dalla confisca il podere. Il figlio Asinio Gallo è il presunto puer profetizzato da Virgilio nella IV Egloga, in cui molti individueranno Gesù Cristo. 62. Sulla comprensione che si deve avere nei confronti degli schiavi Seneca obietta: «Non sono schiavi, sono uomini che vivono nella nostra stessa casa, sono umili amici, compagni di schiavitù. Ma a loro non è permesso neppure muovere le labbra per parlare: il più piccolo bisbiglio viene represso col bastone e non sfuggono alle percosse neppure i rumori casuali, come la tosse, gli starnuti e il singhiozzo. Così, non potendo parlare in presenza del padrone ne parlano male, mentre quelli che possono parlare non solo in presenza del padrone ma col padrone stesso sono pronti a dare la vita per lui». 63. Plutarco attribuisce questo gesto a un lottatore di nome Ctesifonte (Del trattenere l’ira, 5). 64. Seneca cita l’episodio anche nelle Lettere a Lucilio (83), inserendolo in una riflessione sui sillogismi falsi, del tipo: «Nessuno confida a un ubriaco un segreto, lo confida a un uomo onesto, dunque l’uomo onesto non sarà mai ubriaco». Ebbene, obietta Seneca, «per l’assassinio di Cesare ci si affidò sia a C. Cassio, ch’era completamente astemio, sia a Tillio Cimbro, ch’era un ubriacone e un attaccabrighe».
65. I consoli eletti per la prima volta entravano in carica il primo gennaio e davano il loro nome all’anno. 66. Probabilmente si tratta della prima moglie, non di Paolina. 67. Seneca dice solo «difficile», e così traducono tutti. Ma la porta della prigione è difficile ad aprirsi per uscirne, non per entrarvi! Cambia la prospettiva: prima è la porta chiusa vista dall’esterno, dove sta il portinaio, poi è la porta chiusa vista dall’interno, dove sta il padrone di casa, il quale, in realtà, così sembra dire Seneca, vive come in una prigione. Un altro esempio, fra i tantissimi, di imprecisione e superficialità. 68. Quinto Ortensio Ortalo (114-50 a.C.), famoso oratore e rivale di Cicerone (vedi Bruto, 228-230, 301-329). 69. Diogene di Babilonia, filosofo stoico (Seleucia, II sec. a.C.), fu discepolo di Crisippo e di Zenone di Tarso. 70. Si tratta probabilmente di P. Cornelio Lentulo Sura, che partecipò alla congiura di Catilina e fu condannato a morte da Cicerone. 71.Os non habere significa anche «essere sfacciato». 72. Di Vedio Pollione si sa che era un liberto a cui toccò la fortuna di diventare cavaliere, ma che non per questo smise di essere rozzo e crudele.
Consolatio ad Helviam matrem
1. Saepe iam, mater optima, impetum cepi consolandi te, saepe continui. Ut auderem multa me inpellebant: primum videbar depositurus omnia incommoda, cum lacrimas tuas, etiam si supprimere non potuissem, interim certe abstersissem; deinde plus habiturum me auctoritatis non dubitabam ad excitandam te, si prior ipse consurrexissem; praeterea timebam ne a me victa fortuna aliquem meorum vinceret. Itaque utcumque conabar manu super plagam meam inposita ad obliganda vulnera vestra reptare. Hoc propositum meum erant rursus quae retardarent: dolori tuo, dum recens saeviret, sciebam occurrendum non esse ne illum ipsa solacia inritarent et accenderent – nam in morbis quoque nihil est perniciosius quam inmatura medicina; expectabam itaque dum ipse vires suas frangeret et ad sustinenda remedia mora mitigatus tangi se ac tractari pateretur. Praeterea cum omnia clarissimorum ingeniorum monumenta ad compescendos moderandosque luctus composita evolverem, non inveniebam exemplum eius qui consolatus suos esset, cum ipse ab illis comploraretur; ita in re nova haesitabam verebarque ne haec non consolatio esset sed exulceratio. Quid quod novis verbis nec ex vulgari et cotidiana sumptis adlocutione opus erat homini ad consolandos suos ex ipso rogo caput adlevanti? Omnis autem magnitudo doloris modum excedentis necesse est dilectum verborum eripiat, cum saepe vocem quoque ipsam intercludat. Utcumque conitar, non fiducia ingenii, sed quia possum instar efficacissimae consolationis esse ipse consolator. Cui nihil negares, huic hoc utique te non esse negaturam, licet omnis maeror contumax sit, spero, ut desiderio tuo velis a me modum statui. 2. Vide quantum de indulgentia tua promiserim mihi: potentiorem me futurum apud te non dubito quam dolorem tuum, quo nihil est apud miseros potentius. Itaque ne statim cum eo concurram, adero prius illi et quibus excitetur ingeram; omnia proferam et rescindam quae iam obducta sunt. Dicet aliquis: «Quod hoc genus est consolandi, obliterata mala revocare et animum in omnium aerumnarum suarum conspectu conlocare vix unius patientem?». Sed is cogitet, quaecumque usque eo perniciosa sunt ut contra remedium convaluerint, plerumque contrariis curari. Omnis itaque luctus illi suos, omnia lugubria admovebo: hoc erit non molli via mederi, sed urere ac secare. Quid consequar? Ut pudeat animum tot miseriarum victorem aegre ferre unum vulnus in corpore tam cicatricoso. Fleant itaque diutius et gemant, quorum delicatas mentes enervavit longa felicitas, et ad levissimarum iniuriarum motus conlabantur: at quorum omnes anni per calamitates transierunt, gravissima quoque forti et inmobili constantia perferant. Unum habet adsidua infelicitas bonum, quod quos semper vexat novissime indurat. Nullam tibi fortuna vacationem dedit a gravissimis luctibus, ne natalem
quidem tuum excepit: amisisti matrem statim nata, immo dum nasceris, et ad vitam quodam modo exposita es. Crevisti sub noverca, quam tu quidem omni obsequio et pietate, quanta vel in filia conspici potest, matrem fieri coegisti; nulli tamen non magno constitit etiam bona noverca. Avunculum indulgentissimum, optimum ac fortissimum virum, cum adventum eius expectares, amisisti; et ne saevitiam suam fortuna leviorem diducendo faceret, intra tricesimum diem carissimum virum, ex quo mater trium liberorum eras, extulisti. Lugenti tibi luctus nuntiatus est omnibus quidem absentibus liberis, quasi de industria in id tempus coniectis malis tuis ut nihil esset ubi se dolor tuus reclinaret. Transeo tot pericula, tot metus, quos sine intervallo in te incursantis pertulisti: modo modo in eundem sinum ex quo tres nepotes emiseras ossa trium nepotum recepisti; intra vicesimum diem quam filium meum in manibus et in osculis tuis mortuum funeraveras, raptum me audisti: hoc adhuc defuerat tibi, lugere vivos. 3. Gravissimum est ex omnibus quae umquam in corpus tuum descenderunt recens vulnus, fateor; non summam cutem rupit, pectus et viscera ipsa divisit. Sed quemadmodum tirones leviter saucii tamen vociferantur et manus medicorum magis quam ferrum horrent, at veterani quamvis confossi patienter ac sine gemitu velut aliena corpora exsaniari patiuntur, ita tu nunc debes fortiter praebere te curationi. Lamentationes quidem et eiulatus et alia per quae fere muliebris dolor tumultuatur amove; perdidisti enim tot mala, si nondum misera esse didicisti. Ecquid videor non timide tecum egisse? Nihil tibi subduxi ex malis tuis, sed omnia coacervata ante te posui. 4. Magno id animo feci; constitui enim vincere dolorem tuum, non circumscribere. Vincam autem, puto, primum si ostendero nihil me pati propter quod ipse dici possim miser, nedum propter quod miseros etiam quos contingo faciam; deinde si ad te transiero et probavero ne tuam quidem gravem esse fortunam, quae tota ex mea pendet. Hoc prius adgrediar quod pietas tua audire gestit, nihil mihi mali esse. Si potuero, ipsas res quibus me putas premi non esse intolerabiles faciam manifestum; sin id credi non potuerit, at ego mihi ipse magis placebo, quod inter eas res beatus ero quae miseros solent facere. Non est quod de me aliis credas: ipse tibi, ne quid incertis opinionibus perturberis, indico me non esse miserum. Adiciam, quo securior sis, ne fieri quidem me posse miserum. 5. Bona condicione geniti sumus, si eam non deseruerimus. Id egit rerum natura ut ad bene vivendum non magno apparatu opus esset: unusquisque facere se beatum potest. Leve momentum in adventiciis rebus est et quod in neutram partem magnas vires habeat: nec secunda sapientem evehunt nec adversa demittunt; laboravit enim semper ut in se plurimum poneret, ut a se omne gaudium peteret. Quid ergo? Sapientem esse me dico? Minime; nam id quidem si profiteri possem, non tantum negarem miserum esse me, sed omnium fortunatissimum et in vicinum deo perductum praedicarem: nunc, quod satis est ad omnis miserias
leniendas, sapientibus me viris dedi et nondum in auxilium mei validus in aliena castra confugi, eorum scilicet qui facile se ac suos tuentur. Illi me iusserunt stare adsidue velut in praesidio positum et omnis conatus fortunae, omnis impetus prospicere multo ante quam incurrant. Illis gravis est quibus repentina est: facile eam sustinet qui semper expectat. Nam et hostium adventus eos prosternit quos inopinantis occupavit: at qui futuro se bello ante bellum paraverunt, compositi et aptati primum qui tumultuosissimus est ictum facile excipiunt. Numquam ego fortunae credidi, etiam cum videretur pacem agere; omnia illa quae in me indulgentissime conferebat, pecuniam honores gratiam, eo loco posui unde posset sine motu meo repetere. Intervallum inter illa et me magnum habui; itaque abstulit illa, non avulsit. Neminem adversa fortuna comminuit nisi quem secunda decepit. Illi qui munera eius velut sua et perpetua amaverunt, qui se suspici propter illa voluerunt, iacent et maerent cum vanos et pueriles animos, omnis solidae voluptatis ignaros, falsa et mobilia oblectamenta destituunt: at ille qui se laetis rebus non inflavit nec mutatis contrahit. Adversus utrumque statum invictum animum tenet exploratae iam firmitatis; nam in ipsa felicitate quid contra infelicitatem valeret expertus est. Itaque ego in illis quae omnes optant existimavi semper nihil veri boni inesse, tum inania et specioso ac deceptorio fuco circumlita inveni, intra nihil habentia fronti suae simile: nunc in his quae mala vocantur nihil tam terribile ac durum invenio quam opinio vulgi minabatur. Verbum quidem ipsum persuasione quadam et consensu iam asperius ad aures venit et audientis tamquam triste et execrabile ferit: ita enim populus iussit, sed populi scita ex magna parte sapientes abrogant. 6. Remoto ergo iudicio plurium, quos prima rerum species, utcumque credita est, aufert, videamus quid sit exilium. Nempe loci commutatio. Ne angustare videar vim eius et quidquid pessimum in se habet subtrahere, hanc commutationem loci sequuntur incommoda, paupertas ignominia contemptus. Adversus ista postea confligam: interim primum illud intueri volo, quid acerbi adferat ipsa loci commutatio. «Carere patria intolerabile est». Aspice agedum hanc frequentiam, cui vix urbis inmensae tecta sufficiunt: maxima pars istius turbae patria caret. Ex municipiis et coloniis suis, ex toto denique orbe terrarum confluxerunt: alios adduxit ambitio, alios necessitas officii publici, alios inposita legatio, alios luxuria opportunum et opulentum vitiis locum quaerens, alios liberalium studiorum cupiditas, alios spectacula; quosdam traxit amicitia, quosdam industria laxam ostendendae virtuti nancta materiam; quidam venalem formam attulerunt, quidam venalem eloquentiam. Nullum non hominum genus concucurrit in urbem et virtutibus et vitiis magna pretia ponentem. Iube istos omnes ad nomen citari et «unde domo» quisque sit quaere: videbis maiorem partem esse quae relictis sedibus suis venerit in maximam quidem ac pulcherrimam urbem, non tamen suam. Deinde ab hac civitate discede, quae veluti communis potest dici, omnes
urbes circumi: nulla non magnam partem peregrinae multitudinis habet. Transi ab iis quarum amoena positio et opportunitas regionis plures adlicit, deserta loca et asperrimas insulas, Sciathum et Seriphum, Gyaram et Cossuran percense: nullum invenies exilium in quo non aliquis animi causa moretur. Quid tam nudum inveniri potest, quid tam abruptum undique quam hoc saxum? Quid ad copias respicienti ieiunius? Quid ad homines inmansuetius? Quid ad ipsum loci situm horridius? Quid ad caeli naturam intemperantius? Plures tamen hic peregrini quam cives consistunt. Usque eo ergo commutatio ipsa locorum gravis non est ut hic quoque locus a patria quosdam abduxerit. Invenio qui dicant inesse naturalem quandam inritationem animis commutandi sedes et transferendi domicilia; mobilis enim et inquieta homini mens data est, nusquam se tenet, spargitur, et cogitationes suas in omnia nota atque ignota dimittit, vaga et quietis inpatiens et novitate rerum laetissima. Quod non miraberis, si primam eius originem aspexeris: non est ex terreno et gravi concreta corpore, ex illo caelesti spiritu descendit; caelestium autem natura semper in motu est, fugit et velocissimo cursu agitur. Aspice sidera mundum inlustrantia: nullum eorum perstat. Sol labitur adsidue et locum ex loco mutat et, quamvis cum universo vertatur, in contrarium nihilo minus ipsi mundo refertur, per omnis signorum partes discurrit, numquam resistit; perpetua eius agitatio et aliunde alio commigratio est. Omnia volvuntur semper et in transitu sunt; ut lex et naturae necessitas ordinavit, aliunde alio deferuntur; cum per certa annorum spatia orbes suos explicuerint, iterum ibunt per quae venerant: i nunc et humanum animum, ex isdem quibus divina constant seminibus compositum, moleste ferre transitum ac migrationem puta, cum dei natura adsidua et citatissima commutatione vel delectet se vel conservet. 7. A caelestibus agedum te ad humana converte: videbis gentes populosque universos mutasse sedem. Quid sibi volunt in mediis barbarorum regionibus Graecae urbes? Quid inter Indos Persasque Macedonicus sermo? Scythia et totus ille ferarum indomitarumque gentium tractus civitates Achaiae Ponticis inpositas litoribus ostentat: non perpetuae hiemis saevitia, non hominum ingenia ad similitudinem caeli sui horrentia transferentibus domos suas obstiterunt. Atheniensis in Asia turba est; Miletus quinque et septuaginta urbium populum in diversa effudit; totum Italiae latus quod infero mari adluitur maior Graecia fuit. Tuscos Asia sibi vindicat; Tyrii Africam incolunt, Hispaniam Poeni; Graeci se in Galliam inmiserunt, in Graeciam Galli; Pyrenaeus Germanorum transitus non inhibuit – per invia, per incognita versavit se humana levitas. Liberos coniugesque et graves senio parentes traxerunt. Alii longo errore iactati non iudicio elegerunt locum sed lassitudine proximum occupaverunt, alii armis sibi ius in aliena terra fecerunt; quasdam gentes, cum ignota peterent, mare hausit, quaedam ibi consederunt ubi illas rerum omnium inopia deposuit. Nec omnibus eadem causa relinquendi quaerendique patriam fuit: alios excidia urbium suarum hostilibus armis elapsos in aliena spoliatos suis expulerunt; alios domestica
seditio summovit; alios nimia superfluentis populi frequentia ad exonerandas vires emisit; alios pestilentia aut frequentes terrarum hiatus aut aliqua intoleranda infelicis soli vitia eiecerunt; quosdam fertilis orae et in maius laudatae fama corrupit. Alios alia causa excivit domibus suis: illud utique manifestum est, nihil eodem loco mansisse quo genitum est. Adsiduus generis humani discursus est; cotidie aliquid in tam magno orbe mutatur: nova urbium fundamenta iaciuntur, nova gentium nomina extinctis prioribus aut in accessionem validioris conversis oriuntur. Omnes autem istae populorum transportationes quid aliud quam publica exilia sunt? Quid te tam longo circumitu traho? Quid interest enumerare Antenorem Patavi conditorem et Evandrum in ripa Tiberis regna Arcadum conlocantem? Quid Diomeden aliosque quos Troianum bellum victos simul victoresque per alienas terras dissipavit? Romanum imperium nempe auctorem exulem respicit, quem profugum capta patria, exiguas reliquias trahentem, necessitas et victoris metus longinqua quaerentem in Italiam detulit. Hic deinde populus quot colonias in omnem provinciam misit! ubicumque vicit Romanus, habitat. Ad hanc commutationem locorum libentes nomina dabant, et relictis aris suis trans maria sequebatur colonos senex. Res quidem non desiderat plurium enumerationem; unum tamen adiciam quod in oculos se ingerit: haec ipsa insula saepe iam cultores mutavit. Ut antiquiora, quae vetustas obduxit, transeam, Phocide relicta Graii qui nunc Massiliam incolunt prius in hac insula consederunt, ex qua quid eos fugaverit incertum est, utrum caeli gravitas an praepotentis Italiae conspectus an natura inportuosi maris; nam in causa non fuisse feritatem accolarum eo apparet quod maxime tunc trucibus et inconditis Galliae populis se interposuerunt. Transierunt deinde Ligures in eam, transierunt et Hispani, quod ex similitudine ritus apparet; eadem enim tegmenta capitum idemque genus calciamenti quod Cantabris est, et verba quaedam; nam totus sermo conversatione Graecorum Ligurumque a patrio descivit. Deductae deinde sunt duae civium Romanorum coloniae, altera a Mario, altera a Sulla: totiens huius aridi et spinosi saxi mutatus est populus! Vix denique invenies ullam terram quam etiamnunc indigenae colant; permixta omnia et insiticia sunt. Alius alii successit: hic concupivit quod illi fastidio fuit; ille unde expulerat eiectus est. Ita fato placuit, nullius rei eodem semper loco stare fortunam. 8. Adversus ipsam commutationem locorum, detractis ceteris incommodis quae exilio adhaerent, satis hoc remedii putat Varro, doctissimus Romanorum, quod quocumque venimus eadem rerum natura utendum est; M. Brutus satis hoc putat, quod licet in exilium euntibus virtutes suas secum ferre. Haec etiam si quis singula parum iudicat efficacia ad consolandum exulem, utraque in unum conlata fatebitur plurimum posse. Quantulum enim est quod perdimus! duo quae pulcherrima sunt quocumque nos moverimus sequentur, natura communis et propria virtus. Id actum est, mihi crede, ab illo, quisquis formator universi fuit, sive ille deus est potens omnium, sive incorporalis ratio ingentium operum
artifex, sive divinus spiritus per omnia maxima ac minima aequali intentione diffusus, sive fatum et inmutabilis causarum inter se cohaerentium series – id, inquam, actum est ut in alienum arbitrium nisi vilissima quaeque non caderent. Quidquid optimum homini est, id extra humanam potentiam iacet, nec dari nec eripi potest. Mundus hic, quo nihil neque maius neque ornatius rerum natura genuit, et animus contemplator admiratorque mundi, pars eius magnificentissima, propria nobis et perpetua et tam diu nobiscum mansura sunt quam diu ipsi manebimus. Alacres itaque et erecti quocumque res tulerit intrepido gradu properemus, emetiamur quascumque terras: nullum inveniri exilium intra mundum potest; nihil enim quod intra mundum est alienum homini est. Undecumque ex aequo ad caelum erigitur acies, paribus intervallis omnia divina ab omnibus humanis distant. Proinde, dum oculi mei ab illo spectaculo cuius insatiabiles sunt non abducantur, dum mihi solem lunamque intueri liceat, dum ceteris inhaerere sideribus, dum ortus eorum occasusque et intervalla et causas investigare vel ocius meandi vel tardius, dum spectare tot per noctem stellas micantis et alias inmobiles, alias non in magnum spatium exeuntis sed intra suum se circumagentis vestigium, quasdam subito erumpentis, quasdam igne fuso praestringentis aciem, quasi decidant, vel longo tractu cum luce multa praetervolantis, dum cum his sim et caelestibus, qua homini fas est, inmiscear, dum animum ad cognatarum rerum conspectum tendentem in sublimi semper habeam, quantum refert mea quid calcem? 9. «At non est haec terra frugiferarum aut laetarum arborum ferax; non magnis nec navigabilibus fluminum alveis inrigatur; nihil gignit quod aliae gentes petant, vix ad tutelam incolentium fertilis; non pretiosus hic lapis caeditur, non auri argentique venae eruuntur». Angustus animus est quem terrena delectant: ad illa abducendus est quae ubique aeque apparent, ubique aeque splendent. Et hoc cogitandum est, ista veris bonis per falsa et prave credita obstare. Quo longiores porticus expedierint, quo altius turres sustulerint, quo latius vicos porrexerint, quo depressius aestivos specus foderint, quo maiori mole fastigia cenationum subduxerint, hoc plus erit quod illis caelum abscondat. In eam te regionem casus eiecit in qua lautissimum receptaculum casa est: ne tu pusilli animi es et sordide se consolantis, si ideo id fortiter pateris quia Romuli casam nosti. Dic illud potius: «istud humile tugurium nempe virtutes recipit? Iam omnibus templis formosius erit, cum illic iustitia conspecta fuerit, cum continentia, cum prudentia, pietas, omnium officiorum recte dispensandorum ratio, humanorum divinorumque scientia. Nullus angustus est locus qui hanc tam magnarum virtutium turbam capit; nullum exilium grave est in quod licet cum hoc ire comitatu». Brutus in eo libro quem de virtute composuit ait se Marcellum vidisse Mytilenis exulantem et, quantum modo natura hominis pateretur, beatissime viventem neque umquam cupidiorem bonarum artium quam illo tempore. Itaque adicit visum sibi se magis in exilium ire, qui sine illo rediturus esset, quam illum in exilio relinqui. O fortunatiorem Marcellum eo tempore quo exilium suum
Bruto adprobavit quam quo rei publicae consulatum! Quantus ille vir fuit qui effecit ut aliquis exul sibi videretur quod ab exule recederet! Quantus vir fuit qui in admirationem sui adduxit hominem etiam Catoni suo mirandum! Idem Brutus ait C. Caesarem Mytilenas praetervectum, quia non sustineret videre deformatum virum. Illi quidem reditum inpetravit senatus publicis precibus, tam sollicitus ac maestus ut omnes illo die Bruti habere animum viderentur et non pro Marcello sed pro se deprecari, ne exules essent si sine illo fuissent; sed plus multo consecutus est quo die illum exulem Brutus relinquere non potuit, Caesar videre. Contigit enim illi testimonium utriusque: Brutus sine Marcello reverti se doluit, Caesar erubuit. Num dubitas quin se ille tantus vir sic ad tolerandum aequo animo exilium saepe adhortatus sit: «quod patria cares, non est miserum: ita te disciplinis inbuisti ut scires omnem locum sapienti viro patriam esse. Quid porro? Hic qui te expulit, non ipse per annos decem continuos patria caruit? Propagandi sine dubio imperii causa; sed nempe caruit. Nunc ecce trahit illum ad se Africa resurgentis belli minis plena, trahit Hispania, quae fractas et adflictas partes refovet, trahit Aegyptus infida, totus denique orbis, qui ad occasionem concussi imperii intentus est: cui primum rei occurret? Cui parti se opponet? Aget illum per omnes terras victoria sua. Illum suspiciant et colant gentes: tu vive Bruto miratore contentus». 10. Bene ergo exilium tulit Marcellus nec quicquam in animo eius mutavit loci mutatio, quamvis eam paupertas sequeretur; in qua nihil mali esse, quisquis modo nondum pervenit in insaniam omnia subvertentis avaritiae atque luxuriae intellegit. Quantulum enim est quod in tutelam hominis necessarium est! et cui deesse hoc potest ullam modo virtutem habenti? Quod ad me quidem pertinet, intellego me non opes sed occupationes perdidisse. Corporis exigua desideria sunt: frigus summoveri vult, alimentis famem ac sitim extinguere; quidquid extra concupiscitur, vitiis, non usibus laboratur. Non est necesse omne perscrutari profundum nec strage animalium ventrem onerare nec conchylia ultimi maris ex ignoto litore eruere: di istos deaeque perdant quorum luxuria tam invidiosi imperii fines transcendit! Ultra Phasin capi volunt quod ambitiosam popinam instruat, nec piget a Parthis, a quibus nondum poenas repetimus, aves petere. Undique convehunt omnia nota fastidienti gulae; quod dissolutus deliciis stomachus vix admittat ab ultimo portatur oceano; vomunt ut edant, edunt ut vomant, et epulas quas toto orbe conquirunt nec concoquere dignantur. Ista si quis despicit, quid illi paupertas nocet? Si quis concupiscit, illi paupertas etiam prodest; invitus enim sanatur et, si remedia ne coactus quidem recipit, interim certe, dum non potest, illa nolenti similis est. C. Caesar, quem mihi videtur rerum natura edidisse ut ostenderet quid summa vitia in summa fortuna possent, centiens sestertio cenavit uno die; et in hoc omnium adiutus ingenio vix tamen invenit quomodo trium provinciarum tributum una cena fieret. O miserabiles, quorum palatum nisi ad pretiosos cibos non excitatur! Pretiosos autem non eximius sapor aut aliqua faucium dulcedo sed raritas et
difficultas parandi facit. Alioqui, si ad sanam illis mentem placeat reverti, quid opus est tot artibus ventri servientibus? Quid mercaturis? Quid vastatione silvarum? Quid profundi perscrutatione? Passim iacent alimenta quae rerum natura omnibus locis disposuit; sed haec velut caeci transeunt et omnes regiones pervagantur, maria traiciunt et, cum famem exiguo possint sedare, magno inritant. Libet dicere: «quid deducitis naves? Quid manus et adversus feras et adversus homines armatis? Quid tanto tumultu discurritis? Quid opes opibus adgeritis? Non vultis cogitare quam parva vobis corpora sint? Nonne furor et ultimus mentium error est, cum tam exiguum capias, cupere multum? Licet itaque augeatis census, promoveatis fines, numquam tamen corpora vestra laxabitis. Cum bene cesserit negotiatio, multum militia rettulerit, cum indagati undique cibi coierint, non habebitis ubi istos apparatus vestros conlocetis. Quid tam multa conquiritis? Scilicet maiores nostri, quorum virtus etiamnunc vitia nostra sustentat, infelices erant, qui sibi manu sua parabant cibum, quibus terra cubile erat, quorum tecta nondum auro fulgebant, quorum templa nondum gemmis nitebant; itaque tunc per fictiles deos religiose iurabatur: qui illos invocaverant, ad hostem morituri, ne fallerent, redibant. Scilicet minus beate vivebat dictator noster qui Samnitium legatos audit cum vilissimum cibum in foco ipse manu sua versaret – illa qua iam saepe hostem percusserat laureamque in Capitolini Iovis gremio reposuerat – quam Apicius nostra memoria vixit, qui in ea urbe ex qua aliquando philosophi velut corruptores iuventutis abire iussi sunt scientiam popinae professus disciplina sua saeculum infecit». Cuius exitum nosse operae pretium est. Cum sestertium milliens in culinam coniecisset, cum tot congiaria principum et ingens Capitolii vectigal singulis comisationibus exsorpsisset, aere alieno oppressus rationes suas tunc primum coactus inspexit: superfuturum sibi sestertium centiens computavit et velut in ultima fame victurus si in sestertio centiens vixisset, veneno vitam finivit. Quanta luxuria erat cui centiens sestertium egestas fuit! i nunc et puta pecuniae modum ad rem pertinere, non animi. Sestertium centiens aliquis extimuit et quod alii voto petunt veneno fugit. Illi vero tam pravae mentis homini ultima potio saluberrima fuit: tunc venena edebat bibebatque cum inmensis epulis non delectaretur tantum sed gloriaretur, cum vitia sua ostentaret, cum civitatem in luxuriam suam converteret, cum iuventutem ad imitationem sui sollicitaret etiam sine malis exemplis per se docilem. Haec accidunt divitias non ad rationem revocantibus, cuius certi fines sunt, sed ad vitiosam consuetudinem, cuius inmensum et incomprensibile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est, naturae satis est etiam parum. Nullum ergo paupertas exulis incommodum habet; nullum enim tam inops exilium est quod non alendo homini abunde fertile sit. 11. «At vestem ac domum desideraturus est exsul». Haec quoque ad usum tantum desiderabit: neque tectum ei deerit neque velamentum; aeque enim exiguo tegitur corpus quam alitur; nihil homini natura quod necessarium faciebat fecit operosum. Sed desiderat saturatam multo conchylio purpuram, intextam auro variisque et coloribus distinctam et artibus: non fortunae iste vitio sed suo pauper
est. Etiam si illi quidquid amisit restitueris, nihil ages; plus enim restituto deerit ex eo quod cupit quam exsuli ex eo quod habuit. Sed desiderat aureis fulgentem vasis supellectilem et antiquis nominibus artificum argentum nobile, aes paucorum insania pretiosum et servorum turbam quae quamvis magnam domum angustet, iumentorum corpora differta et coacta pinguescere et nationum omnium lapides: ista congerantur licet, numquam explebunt inexplebilem animum, non magis quam ullus sufficiet umor ad satiandum eum cuius desiderium non ex inopia sed ex aestu ardentium viscerum oritur; non enim sitis illa sed morbus est. Nec hoc in pecunia tantum aut alimentis evenit; eadem natura est in omni desiderio quod modo non ex inopia sed ex vitio nascitur: quidquid illi congesseris, non finis erit cupiditatis sed gradus. Qui continebit itaque se intra naturalem modum, paupertatem non sentiet; qui naturalem modum excedet, eum in summis quoque opibus paupertas sequetur. Necessariis rebus et exilia sufficiunt, supervacuis nec regna. Animus est qui divites facit; hic in exilia sequitur, et in solitudinibus asperrimis, cum quantum satis est sustinendo corpori invenit, ipse bonis suis abundat et fruitur: pecunia ad animum nihil pertinet, non magis quam ad deos inmortalis. Omnia ista quae imperita ingenia et nimis corporibus suis addicta suspiciunt, lapides aurum argentum et magni levatique mensarum orbes, terrena sunt pondera, quae non potest amare sincerus animus ac naturae suae memor, levis ipse, expeditus, et quandoque emissus fuerit ad summa emicaturus; interim, quantum per moras membrorum et hanc circumfusam gravem sarcinam licet, celeri et volucri cogitatione divina perlustrat. Ideoque nec exulare umquam potest, liber et deis cognatus et omni mundo omnique aevo par; nam cogitatio eius circa omne caelum it, in omne praeteritum futurumque tempus inmittitur. Corpusculum hoc, custodia et vinculum animi, huc atque illuc iactatur; in hoc supplicia, in hoc latrocinia, in hoc morbi exercentur: animus quidem ipse sacer et aeternus est et cui non possit inici manus. 12. Ne me putes ad elevanda incommoda paupertatis, quam nemo gravem sentit nisi qui putat, uti tantum praeceptis sapientium, primum aspice quanto maior pars sit pauperum, quos nihilo notabis tristiores sollicitioresque divitibus: immo nescio an eo laetiores sint quo animus illorum in pauciora distringitur. Transeamus [a pauperibus, veniamus] ad locupletes: quam multa tempora sunt quibus pauperibus similes sint! Circumcisae sunt peregrinantium sarcinae, et quotiens festinationem necessitas itineris exegit, comitum turba dimittitur. Militantes quotam partem rerum suarum secum habent, cum omnem apparatum castrensis disciplina summoveat! Nec tantum condicio illos temporum aut locorum inopia pauperibus exaequat: sumunt quosdam dies, cum iam illos divitiarum taedium cepit, quibus humi cenent et remoto auro argentoque fictilibus utantur. Dementes! hoc quod aliquando concupiscunt semper timent. O quanta illos caligo mentium, quanta ignorantia veritatis exercet, quam voluptatis causa imitantur! Me quidem, quotiens ad antiqua exempla respexi, paupertatis uti
solaciis pudet, quoniam quidem eo temporum luxuria prolapsa est ut maius viaticum exulum sit quam olim patrimonium principum fuit. Unum fuisse Homero servum, tres Platoni, nullum Zenoni, a quo coepit Stoicorum rigida ac virilis sapientia, satis constat: num ergo quisquam eos misere vixisse dicet ut non ipse miserrimus ob hoc omnibus videatur? Menenius Agrippa, qui inter patres ac plebem publicae gratiae sequester fuit, aere conlato funeratus est. Atilius Regulus, cum Poenos in Africa funderet, ad senatum scripsit mercennarium suum discessisse et ab eo desertum esse rus, quod senatui publice curari dum abesset Regulus placuit: fuitne tanti servum non habere ut colonus eius populus Romanus esset? Scipionis filiae ex aerario dotem acceperunt, quia nihil illis reliquerat pater: aequum mehercules erat populum Romanum tributum Scipioni semel conferre, cum a Carthagine semper exigeret. O felices viros puellarum quibus populus Romanus loco soceri fuit! Beatioresne istos putas quorum pantomimae deciens sestertio nubunt quam Scipionem, cuius liberi a senatu, tutore suo, in dotem aes grave acceperunt? Dedignatur aliquis paupertatem, cuius tam clarae imagines sunt? Indignatur exul aliquid sibi deesse, cum defuerit Scipioni dos, Regulo mercennarius, Menenio funus, cum omnibus illis quod deerat ideo honestius suppletum sit quia defuerat? His ergo advocatis non tantum tuta est sed etiam gratiosa paupertas. 13. Responderi potest: «Quid artificiose ista diducis quae singula sustineri possunt, conlata non possunt? Commutatio loci tolerabilis est, si tantum locum mutes; paupertas tolerabilis est, si ignominia abest, quae vel sola opprimere animos solet». Adversus hunc, quisquis me malorum turba terrebit, his verbis utendum erit: «Si contra unam quamlibet partem fortunae satis tibi roboris est, idem adversus omnis erit. Cum semel animum virtus induravit, undique invulnerabilem praestat. Si avaritia dimisit, vehementissima generis humani pestis, moram tibi ambitio non faciet; si ultimum diem non quasi poenam sed quasi naturae legem aspicis, ex quo pectore metum mortis eieceris, in id nullius rei timor audebit intrare; si cogitas libidinem non voluptatis causa homini datam sed propagandi generis, quem non violaverit hoc secretum et infixum visceribus ipsis exitium, omnis alia cupiditas intactum praeteribit. Non singula vitia ratio sed pariter omnia prosternit: in universum semel vincitur». Ignominia tu putas quemquam sapientem moveri posse, qui omnia in se reposuit, qui ab opinionibus vulgi secessit? Plus etiam quam ignominia est mors ignominiosa: Socrates tamen eodem illo vultu quo triginta tyrannos solus aliquando in ordinem redegerat carcerem intravit, ignominiam ipsi loco detracturus; neque enim poterat carcer videri in quo Socrates erat. Quis usque eo ad conspiciendam veritatem excaecatus est ut ignominiam putet Marci Catonis fuisse duplicem in petitione praeturae et consulatus repulsam? Ignominia illa praeturae et consulatus fuit, quibus ex Catone honor habebatur. Nemo ab alio contemnitur, nisi a se ante contemptus est. Humilis et proiectus animus est isti
contumeliae opportunus; qui vero adversus saevissimos casus se extollit et ea mala quibus alii opprimuntur evertit, ipsas miserias infularum loco habet, quando ita adfecti sumus ut nihil aeque magnam apud nos admirationem occupet quam homo fortiter miser. Ducebatur Athenis ad supplicium Aristides, cui quisquis occurrerat deiciebat oculos et ingemescebat, non tamquam in hominem iustum sed tamquam in ipsam iustitiam animadverteretur; inventus est tamen qui in faciem eius inspueret. Poterat ob hoc moleste ferre quod sciebat neminem id ausurum puri oris; at ille abstersit faciem et subridens ait comitanti se magistratui: «admone istum ne postea tam inprobe oscitet». Hoc fuit contumeliam ipsi contumeliae facere. Scio quosdam dicere contemptu nihil esse gravius, mortem ipsis potiorem videri. His ego respondebo et exilium saepe contemptione omni carere: si magnus vir cecidit, magnus iacuit, non magis illum contemni quam aedium sacrarum ruinae calcantur, quas religiosi aeque ac stantis adorant. 14. Quoniam meo nomine nihil habes, mater carissima, quod te in infinitas lacrimas agat, sequitur ut causae tuae te stimulent. Sunt autem duae; nam aut illud te movet quod praesidium aliquod videris amisisse, aut illud quod desiderium ipsum per se pati non potes. Prior pars mihi leviter perstringenda est; novi enim animum tuum nihil in suis praeter ipsos amantem. Viderint illae matres quae potentiam liberorum muliebri inpotentia exercent, quae, quia feminis honores non licet gerere, per illos ambitiosae sunt, quae patrimonia filiorum et exhauriunt et captant, quae eloquentiam commodando aliis fatigant: tu liberorum tuorum bonis plurimum gavisa es, minimum usa; tu liberalitati nostrae semper inposuisti modum, cum tuae non inponeres; tu filia familiae locupletibus filiis ultro contulisti; tu patrimonia nostra sic administrasti ut tamquam in tuis laborares, tamquam alienis abstineres; tu gratiae nostrae, tamquam alienis rebus utereris, pepercisti, et ex honoribus nostris nihil ad te nisi voluptas et inpensa pertinuit. Numquam indulgentia ad utilitatem respexit; non potes itaque ea in erepto filio desiderare quae in incolumi numquam ad te pertinere duxisti. 15. Illo omnis consolatio mihi vertenda est unde vera vis materni doloris oritur: «Ergo complexu fili carissimi careo; non conspectu eius, non sermone possum frui. Ubi est ille quo viso tristem vultum relaxavi, in quo omnes sollicitudines meas deposui? Ubi conloquia, quorum inexplebilis eram? Ubi studia, quibus libentius quam femina, familiarius quam mater intereram? Ubi ille occursus? Ubi matre visa semper puerilis hilaritas?». Adicis istis loca ipsa gratulationum et convictuum et, ut necesse est, efficacissimas ad vexandos animos recentis conversationis notas. Nam hoc quoque adversus te crudeliter fortuna molita est, quod te ante tertium demum diem quam perculsus sum securam nec quicquam tale metuentem digredi voluit. Bene nos longinquitas locorum diviserat, bene aliquot annorum absentia huic te malo praeparaverat: redisti, non
ut voluptatem ex filio perciperes, sed ut consuetudinem desiderii perderes. Si multo ante afuisses, fortius tulisses, ipso intervallo desiderium molliente; si non recessisses, ultimum certe fructum biduo diutius videndi filium tulisses: nunc crudele fatum ita composuit ut nec fortunae meae interesses nec absentiae adsuesceres. Sed quanto ista duriora sunt, tanto maior tibi virtus advocanda est, et velut cum hoste noto ac saepe iam victo acrius congrediendum. Non ex intacto corpore tuo sanguis hic fluxit: per ipsas cicatrices percussa es. 16. Non est quod utaris excusatione muliebris nominis, cui paene concessum est inmoderatum in lacrimis ius, non inmensum tamen; et ideo maiores decem mensum spatium lugentibus viros dederunt ut cum pertinacia muliebris maeroris publica constitutione deciderent. Non prohibuerunt luctus sed finierunt; nam et infinito dolore, cum aliquem ex carissimis amiseris, adfici stulta indulgentia est, et nullo inhumana duritia: optimum inter pietatem et rationem temperamentum est et sentire desiderium et opprimere. Non est quod ad quasdam feminas respicias quarum tristitiam semel sumptam mors finivit (nosti quasdam quae amissis filiis inposita lugubria numquam exuerunt): a te plus exigit vita ab initio fortior; non potest muliebris excusatio contingere ei a qua omnia muliebria vitia afuerunt. Non te maximum saeculi malum, inpudicitia, in numerum plurium adduxit; non gemmae te, non margaritae flexerunt; non tibi divitiae velut maximum generis humani bonum refulserunt; non te, bene in antiqua et severa institutam domo, periculosa etiam probis peiorum detorsit imitatio; numquam te fecunditatis tuae, quasi exprobraret aetatem, puduit, numquam more aliarum, quibus omnis commendatio ex forma petitur, tumescentem uterum abscondisti quasi indecens onus, nec intra viscera tua conceptas spes liberorum elisisti; non faciem coloribus ac lenociniis polluisti; numquam tibi placuit vestis quae nihil amplius nudaret cum poneretur: unicum tibi ornamentum, pulcherrima et nulli obnoxia aetati forma, maximum decus visa est pudicitia. Non potes itaque ad optinendum dolorem muliebre nomen praetendere, ex quo te virtutes tuae seduxerunt; tantum debes a feminarum lacrimis abesse quantum a vitiis. Ne feminae quidem te sinent intabescere vulneri tuo, sed leviori necessario maerore cito defunctam iubebunt exsurgere, si modo illas intueri voles feminas quas conspecta virtus inter magnos viros posuit. Corneliam ex duodecim liberis ad duos fortuna redegerat: si numerare funera Corneliae velles, amiserat decem, si aestimare, amiserat Gracchos. Flentibus tamen circa se et fatum eius execrantibus interdixit ne fortunam accusarent, quae sibi filios Gracchos dedisset. Ex hac femina debuit nasci qui diceret in contione, «Tu matri meae male dicas quae me peperit?». Multo mihi vox matris videtur animosior: filius magno aestimavit Gracchorum natales, mater et funera. Rutilia Cottam filium secuta est in exilium et usque eo fuit indulgentia constricta ut mallet exilium pati quam desiderium, nec ante in patriam quam cum filio rediit. Eundem iam reducem et in re publica florentem tam fortiter amisit quam secuta est, nec quisquam lacrimas eius post elatum filium notavit. In expulso virtutem ostendit,
in amisso prudentiam; nam et nihil illam a pietate deterruit et nihil in tristitia supervacua stultaque detinuit. Cum his te numerari feminis volo; quarum vitam semper imitata es, earum in coercenda comprimendaque aegritudine optime sequeris exemplum. 17. Scio rem non esse in nostra potestate nec ullum adfectum servire, minime vero eum qui ex dolore nascitur; ferox enim et adversus omne remedium contumax est. Volumus interim illum obruere et devorare gemitus; per ipsum tamen compositum fictumque vultum lacrimae profunduntur. Ludis interim aut gladiatoribus animum occupamus; at illum inter ipsa quibus avocatur spectacula levis aliqua desiderii nota subruit. Ideo melius est vincere illum quam fallere; nam qui delusus et voluptatibus aut occupationibus abductus est resurgit et ipsa quiete impetum ad saeviendum colligit: at quisquis rationi cessit, in perpetuum componitur. Non sum itaque tibi illa monstraturus quibus usos esse multos scio, ut peregrinatione te vel longa detineas vel amoena delectes, ut rationum accipiendarum diligentia, patrimonii administratione multum occupes temporis, ut semper novo te aliquo negotio inplices: omnia ista ad exiguum momentum prosunt nec remedia doloris sed inpedimenta sunt; ego autem malo illum desinere quam decipi. Itaque illo te duco quo omnibus qui fortunam fugiunt confugiendum est, ad liberalia studia: illa sanabunt vulnus tuum, illa omnem tristitiam tibi evellent. His etiam si numquam adsuesses, nunc utendum erat; sed quantum tibi patris mei antiquus rigor permisit, omnes bonas artes non quidem comprendisti, attigisti tamen. Utinam quidem virorum optimus, pater meus, minus maiorum consuetudini deditus voluisset te praeceptis sapientiae erudiri potius quam inbui! non parandum tibi nunc esset auxilium contra fortunam sed proferendum. Propter istas quae litteris non ad sapientiam utuntur sed ad luxuriam instruuntur minus te indulgere studiis passus est. Beneficio tamen rapacis ingenii plus quam pro tempore hausisti; iacta sunt disciplinarum omnium fundamenta: nunc ad illas revertere; tutam te praestabunt. Illae consolabuntur, illae delectabunt, illae si bona fide in animum tuum intraverint, numquam amplius intrabit dolor, numquam sollicitudo, numquam adflictationis inritae supervacua vexatio. Nulli horum patebit pectus tuum; nam ceteris vitiis iam pridem clusum est. 18. Haec quidem certissima praesidia sunt et quae sola te fortunae eripere possint. Sed quia, dum in illum portum quem tibi studia promittunt pervenis, adminiculis quibus innitaris opus est, volo interim solacia tibi tua ostendere. Respice fratres meos, quibus salvis fas tibi non est accusare fortunam. In utroque habes quod te diversa virtute delectet: alter honores industria consecutus est, alter sapienter contempsit. Adquiesce alterius fili dignitate, alterius quiete, utriusque pietate. Novi fratrum meorum intimos adfectus: alter in hoc dignitatem excolit ut tibi ornamento sit, alter in hoc se ad tranquillam quietamque vitam recepit ut tibi vacet. Bene liberos tuos et in auxilium et in oblectamentum fortuna disposuit: potes alterius dignitate defendi, alterius otio frui. Certabunt in te
officiis et unius desiderium duorum pietate supplebitur. Audacter possum promittere: nihil tibi deerit praeter numerum. Ab his ad nepotes quoque respice: Marcum blandissimum puerum, ad cuius conspectum nulla potest durare tristitia; nihil tam magnum, nihil tam recens in cuiusquam pectore furit quod non circumfusus ille permulceat. Cuius non lacrimas illius hilaritas supprimat? Cuius non contractum sollicitudine animum illius argutiae solvant? Quem non in iocos evocabit illa lascivia? Quem non in se convertet et abducet infixum cogitationibus illa neminem satiatura garrulitas? Deos oro, contingat hunc habere nobis superstitem! In me omnis fatorum crudelitas lassata consistat; quidquid matri dolendum fuit, in me transierit, quidquid aviae, in me. Floreat reliqua in suo statu turba: nihil de orbitate, nihil de condicione mea querar, fuerim tantum nihil amplius doliturae domus piamentum. Tene in gremio cito tibi daturam pronepotes Novatillam, quam sic in me transtuleram, sic mihi adscripseram, ut possit videri, quod me amisit, quamvis salvo patre pupilla; hanc et pro me dilige. Abstulit illi nuper fortuna matrem: tua potest efficere pietas ut perdidisse se matrem doleat tantum, non et sentiat. Nunc mores eius compone, nunc forma: altius praecepta descendunt quae teneris inprimuntur aetatibus. Tuis adsuescat sermonibus, ad tuum fingatur arbitrium: multum illi dabis, etiam si nihil dederis praeter exemplum. Hoc tibi tam sollemne officium pro remedio erit; non potest enim animum pie dolentem a sollicitudine avertere nisi aut ratio aut honesta occupatio. Numerarem inter magna solacia patrem quoque tuum, nisi abesset. Nunc tamen ex adfectu tuo qui illius in te sit cogita: intelleges quanto iustius sit te illi servari quam mihi inpendi. Quotiens te inmodica vis doloris invaserit et sequi se iubebit, patrem cogita. Cui tu quidem tot nepotes pronepotesque dando effecisti ne unica esses; consummatio tamen aetatis actae feliciter in te vertitur. Illo vivo nefas est te quod vixeris queri. 19. Maximum adhuc solacium tuum tacueram, sororem tuam, illud fidelissimum tibi pectus, in quod omnes curae tuae pro indiviso transferuntur, illum animum omnibus nobis maternum. Cum hac tu lacrimas tuas miscuisti, in huius primum respirasti sinu. Illa quidem adfectus tuos semper sequitur; in mea tamen persona non tantum pro te dolet. Illius manibus in urbem perlatus sum, illius pio maternoque nutricio per longum tempus aeger convalui; illa pro quaestura mea gratiam suam extendit et, quae ne sermonis quidem aut clarae salutationis sustinuit audaciam, pro me vicit indulgentia verecundiam. Nihil illi seductum vitae genus, nihil modestia in tanta feminarum petulantia rustica, nihil quies, nihil secreti et ad otium repositi mores obstiterunt quominus pro me etiam ambitiosa fieret. Hoc est, mater carissima, solacium quo reficiaris: illi te quantum potes iunge, illius artissimis amplexibus alliga. Solent maerentes ea quae maxime diligunt fugere et libertatem dolori suo quaerere: tu ad illam te, quidquid cogitaveris, confer; sive servare istum habitum voles sive deponere, apud illam invenies vel finem doloris tui vel comitem. Sed si prudentiam perfectissimae feminae novi, non patietur te nihil profuturo maerore consumi et
exemplum tibi suum, cuius ego etiam spectator fui, narrabit. Carissimum virum amiserat, avunculum nostrum, cui virgo nupserat, in ipsa quidem navigatione; tulit tamen eodem tempore et luctum et metum evictisque tempestatibus corpus eius naufraga evexit. O quam multarum egregia opera in obscuro iacent! Si huic illa simplex admirandis virtutibus contigisset antiquitas, quanto ingeniorum certamine celebraretur uxor quae oblita inbecillitatis, oblita metuendi etiam firmissimis maris, caput suum periculis pro sepultura obiecit et, dum cogitat de viri funere, nihil de suo timuit! Nobilitatur carminibus omnium quae se pro coniuge vicariam dedit: hoc amplius est, discrimine vitae sepulcrum viro quaerere; maior est amor qui pari periculo minus redimit. Post hoc nemo miretur quod per sedecim annos quibus Aegyptum maritus eius optinuit numquam in publico conspecta est, neminem provincialem domum suam admisit, nihil a viro petit, nihil a se peti passa est. Itaque loquax et in contumelias praefectorum ingeniosa provincia, in qua etiam qui vitaverunt culpam non effugerunt infamiam, velut unicum sanctitatis exemplum suspexit et, quod illi difficillimum est cui etiam periculosi sales placent, omnem verborum licentiam continuit et hodie similem illi, quamvis numquam speret, semper optat. Multum erat, si per sedecim annos illam provincia probasset: plus est quod ignoravit. Haec non ideo refero ut laudes eius exequar, quas circumscribere est tam parce transcurrere, sed ut intellegas magni animi esse feminam quam non ambitio, non avaritia, comites omnis potentiae et pestes, vicerunt, non metus mortis iam exarmata nave naufragium suum spectantem deterruit quominus exanimi viro haerens non quaereret quemadmodum inde exiret sed quemadmodum efferret. Huic parem virtutem exhibeas oportet et animum a luctu recipias et id agas ne quis te putet partus tui paenitere. 20. Ceterum quia necesse est, cum omnia feceris, cogitationes tamen tuas subinde ad me recurrere nec quemquam nunc ex liberis tuis frequentius tibi obversari, non quia illi minus cari sunt sed quia naturale est manum saepius ad id referre quod dolet, qualem me cogites accipe: laetum et alacrem velut optimis rebus. Sunt enim optimae, quoniam animus omnis occupationis expers operibus suis vacat et modo se levioribus studiis oblectat, modo ad considerandam suam universique naturam veri avidus insurgit. Terras primum situmque earum quaerit, deinde condicionem circumfusi maris cursusque eius alternos et recursus; tunc quidquid inter caelum terrasque plenum formidinis interiacet perspicit et hoc tonitribus fulminibus ventorum flatibus ac nimborum niuisque et grandinis iactu tumultuosum spatium; tum peragratis humilioribus ad summa perrumpit et pulcherrimo divinorum spectaculo fruitur, aeternitatis suae memor in omne quod fuit futurumque est vadit omnibus saeculis.
Consolazione alla madre Elvia
Premessa In questa consolatoria il tema è il dolore non per la morte ma per la lontananza della persona cara, e più precisamente per l’esilio. Qui, però, la situazione è rovesciata, perché colui che dovrebbe essere consolato si fa consolatore di chi soffre per la sua condizione. E il dolore è quello di una madre. La sventura non ha colpito solo Seneca, ma ha lasciato un vuoto nella sua famiglia, in cui gli affetti domestici sono molto sentiti, e quindi forte è il rimpianto per la lontananza dell’esule, che della famiglia era il centro. Elvia non ha potuto godere dell’affetto materno, poiché, come ricorda Seneca, non ha fatto in tempo a venire al mondo che ha perduto la madre. Poi le sono morti il marito e un nipotino. Ora vive con gli altri due figli, Novato e Mela, e si prende cura del figlioletto di Mela, Marco Lucano, bimbo allegro e vivace, e della figlia di Novato, Novatilla, la prediletta di Seneca che ha da poco perso la madre e si avvicina all’età delle nozze. Altra componente della famiglia è la sorella della madre, vedova anch’essa, che ha tenuto in braccio Seneca bambino durante il viaggio di trasferimento da Cordova a Roma, e lo ha assistito nel periodo di una lunga malattia, sicché per il filosofo la zia è come una seconda madre, tanto più amata perché, con un gesto eroico e a costo della propria vita, ha salvato il corpo del marito, morto in un naufragio, per rendergli l’onore della sepoltura. Seneca cerca di consolare la madre dicendole che l’esilio non è un male, e gliene spiega le ragioni, cominciando col dire che l’uomo per sua stessa natura è un nomade, un viaggiatore desideroso di conoscere non solo la sua terra natia ma anche il mondo a lui sconosciuto. Egli, dunque, tanto più perché è un uomo saggio, non prova rimpianto per la sua terra natale poiché la sua patria è il mondo («Come Antonino la mia patria è Roma, ma come uomo è il mondo», così dirà anche Marco Aurelio). L’esilio, dunque, conclude Seneca, è una sorte comune a tutti gli uomini e va sopportato con forza e coraggio perché ciò che conta non sono i beni materiali, sono le doti interiori e le virtù morali che l’uomo si porta dietro, dovunque egli vada. Seneca esorta la madre a ritrovare il coraggio e la forza d’animo che ha sempre dimostrato, e poiché è donna colta e sensibile, oltre che affidarsi all’affetto degli altri due figli, dei nipoti e della sorella, trovi conforto negli studi interrotti. D’altra parte egli è sereno e felice, perché ora può dedicarsi interamente allo studio e alla contemplazione delle cose divine. Non mancano, anche in questa consolatoria, esempi di personaggi illustri, quali Varrone, secondo cui «dovunque ci rechiamo continuiamo a vivere dentro la medesima natura», e Marco Bruto, che nel suo libro Sulla virtù, parlando dell’esilio di Marcello, scriveva: «Chi va in esilio può portare con sé la propria virtù». M. S. A.
1. Molte volte, mia ottima madre, ho sentito l’impulso di scriverti per consolarti e altrettante l’ho trattenuto. Diversi motivi mi spingevano ad assecondarlo, innanzitutto perché pensavo che se soltanto fossi riuscito ad asciugare per un momento le tue lacrime, visto che porvi fine non mi è possibile, mi sarei liberato da tutte le mie sofferenze; poi perché ero convinto che se prima avessi in qualche modo tranquillizzato me stesso avrei potuto rincuorarti più facilmente e con maggiore efficacia. Dall’altro lato temevo che, scrivendoti, la cattiva sorte, da me sconfitta, potesse rivalersi su qualcuno dei miei familiari. Per questo esitavo, e intanto mi sforzavo in tutti i modi di alleviare il mio dolore
per poter meglio curare le tue ferite. Ma c’erano altri motivi che m’inducevano ad aspettare prima di mettere in atto il mio proposito. Sapevo, cioè, che essendo il tuo dolore nella sua fase iniziale, e perciò molto intenso, le mie parole di conforto, invece di lenirlo, lo avrebbero irritato ancora di più, così come nelle malattie non c’è nulla di più dannoso che un rimedio intempestivo. Perciò aspettavo che il dolore stesso indebolisse le proprie forze, in modo che, reso dal tempo più disponibile alle cure, si lasciasse toccare e governare. Perdipiù, in tutti i libri da me consultati, in cui illustri studiosi insegnano come contenere e mitigare i dolori, non ho trovato un solo esempio di persona che consoli un suo familiare di un dolore per il quale è compianta lei stessa. Ecco perché esitavo di fronte alla singolarità di quella mia condizione, preso com’ero dal timore che invece di consolarti potessi inasprire la tua sofferenza. D’altra parte chi solleva il capo dal suo stesso rogo per consolare i suoi non può usare il banale linguaggio quotidiano, ma ha bisogno di parole insolite, anche se la violenza di un dolore eccessivo inevitabilmente ci inibisce la scelta delle parole, visto che non di rado ci toglie anche la voce. Ad ogni modo io ci proverò, non perché confidi nelle mie capacità, ma perché in definitiva il mio impulso consolatorio è di per sé stesso la più efficace delle consolazioni. Spero che tu, da cui nessun rifiuto potrebbe venirmi, non vorrai negarmi neppure questo gesto, e che, per quanto un dolore possa essere ostinato, accetterai che io cerchi di arginare in qualche misura il tuo rimpianto. 2. Vedi quanto io confidi nella tua comprensione: ho tanta forza da credere di poter aver ragione del tuo dolore, anche se questo per gli sventurati è il potere più forte che ci sia. Perciò non lo affronterò subito in campo aperto: prima lo asseconderò, fornendogli anzi materia perché si ravvivi, metterò a nudo le tue ferite e riaprirò quelle che sono già cicatrizzate. Qualcuno dirà: «Che razza di consolazione è questa? Riesumare dolori già dimenticati e sbattere in faccia all’animo tutte le sue disgrazie, quando a mala pena riesce a sopportarne una?». Ebbene, chi pensa così sappia che il male quando è tanto forte da crescere contro qualunque rimedio spesso va curato con medicine contrarie. Perciò io chiamerò a raccolta per la mia ammalata tutti i suoi lutti, tutte le sue disgrazie: sarà tutto un incidere e un bruciare, non una cura pietosa e delicata. Quale sarà il risultato? Che l’animo, dopo aver superato vittoriosamente tante battaglie contro il dolore, si vergognerà di non riuscire a sopportare una sola ferita in un corpo tutto coperto di cicatrici. Continuino dunque a piangere e a lamentarsi gli animi infiacchiti da una lunga felicità, crollino pure all’urto della più piccola offesa: quelli che hanno trascorso la vita in mezzo alle disgrazie sapranno sopportare con forte e stabile costanza anche i mali più gravi. Questo è il privilegio, unico, di una continua e insistente infelicità, quello, cioè, di rendere ancora più forti coloro che ne sono sempre vessati. La sorte non ha concesso un solo istante di tregua ai tuoi gravissimi lutti, neppure nel giorno della tua nascita: non hai fatto in tempo a venire alla luce che
hai perduto tua madre, sicché in un certo senso sei venuta al mondo in balìa della vita. Sei stata allevata da una matrigna, che tu hai reso madre riversando su di lei tutto il rispetto e tutta la devozione che solo una figlia può dare; né può aversi una buona matrigna se non a caro prezzo. Avevi uno zio 1 che ti era molto affezionato, uomo onestissimo e assai coraggioso, e lo perdesti mentre ne aspettavi l’arrivo; poi, come se la cattiva sorte non volesse alleviare la sua crudeltà distanziando i suoi colpi, meno di trenta giorni dopo conducesti alla tomba il tuo adorato marito,2 che ti aveva reso madre di tre figli: ti fu annunciata in pieno lutto questa nuova disgrazia, mentre tutti i tuoi figli erano lontani, talché sembrava che le sventure avessero deliberato di pioverti addosso tutte quante insieme per non dare neppure il minimo appiglio al tuo dolore. Non parlo dei tanti pericoli, dei tanti timori di cui hai sopportato gli assalti senza tregua. Ultimamente, in quel medesimo seno da cui si erano allontanati, hai raccolto le ossa di tre tuoi nipoti, finché, dopo appena venti giorni dalla morte di mio figlio, spirato fra le tue braccia e i tuoi baci, hai avuto notizia che anch’io ero stato strappato al tuo affetto. Solo questo ti mancava: dover piangere i vivi. 3. So bene che quest’ultima è la ferita più grave fra tutte quelle che hanno trafitto il tuo corpo: ti ha lacerato il cuore e le viscere, dopo averti strappato la pelle. Ma come le reclute, anche se colpite di striscio, urlano e temono più le mani dei medici che non il ferro nemico, mentre i veterani, benché trapassati da parte a parte, si lasciano operare pazientemente e senza gemito alcuno, quasi che il corpo non gli appartenga, così tu, con altrettanto coraggio, devi sottoporti alla mia cura. Metti da parte i lamenti, le grida e gli altri sfoghi con cui le donne abitualmente manifestano il proprio dolore: avresti sofferto inutilmente se non avessi imparato a essere infelice. Come vedi, non ho avuto tanti riguardi con te, se invece di nasconderti i tuoi mali te li ho ammucchiati davanti uno per uno. 4. L’ho fatto con grande coraggio, perché il mio scopo è vincere il tuo dolore, non circoscriverlo. E sono certo di vincerlo, se riuscirò a dimostrare prima di tutto che nulla di quanto mi accade può rendermi infelice e, di conseguenza, far soffrire i miei familiari. Dopodiché, venendo al caso tuo, dimostrerò che anche la tua sorte, legata alla mia vita, non è intollerabile. E affronterò subito la questione che ti sta più a cuore, dicendoti, cioè, che io non soffro alcun male, e spero di poterti dimostrare come le cose che tu ritieni per me motivo di sofferenza non siano poi insopportabili. Tu potrai pure non credermi, ma sappi per certo che io mi sento felice anche in quelle condizioni che di solito sono motivo d’infelicità. Perciò non dare retta a ciò che gli altri ti dicono di me, quando io stesso, per toglierti ogni dubbio di fronte a voci assolutamente prive di fondamento, ti assicuro che qui non sono affatto infelice. E a tua maggiore tranquillità aggiungerò che non è neppure possibile ch’io lo diventi.
5. La condizione umana, quando si nasce, è di per sé stessa buona, e tale resterebbe se non fossimo noi ad abbandonarla. La natura ha fatto in modo che ci fosse bisogno di poco per vivere bene: ciascuno basta a sé stesso per essere felice. I fattori esterni non contano, non influiscono più di tanto, sia nel bene che nel male: chi è saggio non si esalta nella buona sorte, come non si abbatte nella cattiva, proprio perché fa affidamento solo su stesso e in sé stesso si sforza di trovare ogni ragione per essere felice. Con ciò non dico di essere saggio, non me lo sogno nemmeno, inquantoché se soltanto potessi dire una cosa del genere non solo negherei di essere infelice ma andrei gridando ai quattro venti di essere l’uomo più fortunato del mondo, quasi alla pari con dio. Però ho rimesso tutta la mia vita nelle mani degli uomini saggi, e questo basta ad alleviare tutti i miei mali: non essendo ancora in grado di difendermi da solo, mi sono rifugiato in terre altrui, negli accampamenti di quelli che sanno come difendere sé stessi e i propri cari, e loro m’hanno consigliato di stare sempre all’erta, come una sentinella, per prevedere, prima che mi piombino addosso, tutti gli assalti della malasorte. Questa, infatti, è difficile da battersi solo per quelli a cui giunge improvvisa, ma chi sta sempre sul piede di guerra e sa che può arrivare da un momento all’altro la sostiene facilmente. Allo stesso modo l’assalto dei nemici travolge quelli che non se lo aspettano, mentre coloro che sono sempre pronti allo scontro e bene armati resistono con efficacia al primo urto, che è sempre il più impetuoso. Io non mi sono mai fidato della fortuna, nemmeno quando sembrava che mi portasse la pace, e tutti quei beni che mi elargiva generosamente, ricchezze, onori, favori, non me li sono mai tenuti stretti, ma ne ho fatto così poco conto che lei avrebbe potuto riprenderseli senza che io ne fossi minimamente toccato. Ho sempre guardato quei beni con grande distacco, a debita distanza, talché la fortuna, quando è accaduto, non me li ha strappati di mano, se li è semplicemente ripresi. La cattiva sorte stritola solo chi si è fidato troppo della buona, chi si è lasciato ingannare dai beni ricevuti come se fossero doni durevoli e personali, e per i quali voleva farsi bello agli occhi degli altri, sicché poi, una volta privato da queste false ed effimere gioie, il suo animo vuoto e puerile, che ignora i beni veri e duraturi, si abbatte e si dispera. Chi invece non insuperbisce nella prosperità non si scoraggia nell’avversità, ma in entrambi i casi conserva quella fermezza d’animo che ha già sperimentato nella buona sorte in quanto previdente e consapevole di ciò che serviva per far fronte a quella cattiva. È per questo che io ho sempre considerato vuote, perché rivestite di colori appariscenti e ingannevoli, tutte quelle cose che in genere gli uomini vedono e desiderano come se fossero beni reali, mentre dentro non hanno nulla che corrisponda al loro aspetto esteriore. Ora in quelle cose che gli altri chiamano mali non trovo nulla di così terrificante e insopportabile, come vorrebbe far credere e temere la gente comune. Anche la parola «esilio», per via di un giudizio e un consenso generale, suona dura all’orecchio, e chi l’ascolta ne rimane colpito, come da qualcosa di
odioso e di sinistro, perché codesta, appunto, è la voce del popolo. Ma i saggi non ne tengono conto, loro si fanno beffe dei decreti del volgo. 6. Scartata, dunque, l’opinione dei più, la quale, priva di un fondamento critico, è fallace in partenza in quanto muove dall’aspetto esteriore delle cose, vediamo ora che cos’è propriamente l’esilio. Sicuramente è un cambiamento di luogo. Ma, affinché non sembri che io con questa affermazione voglia diminuirne il valore e sottrargli tutto ciò che ha in sé di deteriore, dirò che questo cambiamento di luogo comporta dei disagi, come infamia, stenti e disprezzo. Ma questo lo vedremo dopo. Per ora mi limiterò a esaminare innanzitutto cosa vi sia di sgradevole in questo cambiamento. «Vivere lontano dalla patria è cosa intollerabile», si dice. Ebbene, guarda la gran folla di gente che le case di un’immensa città riescono a malapena a contenere: la maggior parte di quelle persone sono lontane dalla loro patria, sono confluite qui dai loro municipi, dalle loro colonie, da ogni angolo del mondo. Alcune ve le ha spinte l’ambizione, altre la necessità di un impiego pubblico, altre quella di un’ambasceria, altre perché cercavano un luogo in cui spadroneggiano i vizi e la lussuria, oppure per amore degli studi liberali, degli spettacoli, per crearsi più facilmente delle amicizie, o perché convinte di potervi esprimere e sviluppare maggiormente il proprio talento; alcune ancora vi sono venute per prostituirsi, altre per trarre profitto dalla loro eloquenza. Non c’è insomma razza umana che non sia affluita in questa grande città così generosa nel remunerare i vizi e le virtù. Prendi uno per uno tutti costoro, chiamali per nome e chiedi a ciascuno di quale paese sia: vedrai che la maggior parte di essi hanno lasciato la propria patria per venire in questa città grandissima e stupenda, che può dirsi comune a tutta l’umanità, ma che non è la loro. Fa’ poi il giro delle altre: non ce n’è una i cui abitanti non siano per lo più stranieri. Lascia stare quelle che attirano molti per l’amenità del luogo e la mitezza del clima, guarda le regioni deserte e le isole più selvagge, come Sciato, Serifo, Giaro, Cossira:3 non troverai nessuna terra d’esilio in cui qualcuno risieda di sua volontà. Cosa pensi che possa esserci al mondo di più squallido e più dirupato di questo scoglio in cui mi trovo? Quale luogo più sterile per chi voglia coltivarlo? Che cosa di più inospitale per gli uomini e di più orrendo a vedersi e con un clima più rigido? Eppure, qui vivono più forestieri che indigeni. Evidentemente il cambiamento di luogo non è poi di per sé così gravoso se persino un posto come questo ha strappato gente dalla sua terra natale. Alcuni sostengono che il cambiar sede e il trasferire il proprio domicilio sia un bisogno connaturato nell’animo dell’uomo, dovuto alla sua indole volubile e irrequieta: l’uomo, infatti, non sta mai fermo, si sparpaglia, è tutto un frantumarsi interiore, come se la sua mente fosse proiettata in mille direzioni, verso il mondo conosciuto ma anche verso l’ignoto; incostante, non ama l’immobilità e gode di tutto ciò che gli risulta insolito e nuovo. Non c’è da meravigliarsene se si considera la sua prima origine, che appartiene al cielo, non alla terra: l’uomo
non è composto di materiale pesante, ma discende da quello spirito celeste tipico degli astri, che per loro natura sono sempre in movimento, sempre in fuga, in una corsa incessante e vertiginosa. Guarda le stelle che illuminano il mondo: nessuna è stabile, il sole si muove continuamente passando da un luogo all’altro e pur ruotando insieme all’universo gira in senso contrario a quello del cielo stesso, attraversa tutte le costellazioni senza mai fermarsi in un moto perpetuo, come perpetuo è il suo migrare da una parte all’altra. Tutti i corpi celesti girano senza posa e sono sempre in movimento, si spostano da un luogo all’altro secondo una legge ineluttabile fissata dalla natura, e quando, dopo un certo numero di anni, avranno compiuto la loro orbita, ritorneranno indietro, rifacendo il cammino già percorso. Pensa dunque se l’animo dell’uomo, composto della stessa sostanza di quei corpi celesti, possa sentirsi a disagio nei suoi trasferimenti e mutamenti di sede, quando la divina natura degli astri si compiace di questo assiduo e rapidissimo movimento mediante il quale si conserva intatta. 7. Ora dal mondo celeste passa a quello degli uomini: vedrai quanti popoli in massa e quante generazioni hanno cambiato sede. Che significano le città greche situate in pieno territorio barbaro? E la lingua macedone che si parla in India e in Persia? Nella Scizia e in tutta quella regione abitata da genti indomite e selvagge sorgono città greche, erette sui lidi del Ponto: né il rigore del lungo inverno, né l’indole degli abitanti, aspra come il loro clima, hanno ostacolato gli uomini che trasferivano lì le loro case. L’Asia è piena di Ateniesi, la sola Mileto ha popolato la bellezza di settantacinque città sparse un po’ dovunque, tutta la costa dell’Italia bagnata dal Mare Inferiore4 ha creato la Magna Grecia. L’Asia rivendica gli Etruschi come suoi abitanti, i Tirii si sono insediati in Africa, i Cartaginesi in Spagna, i Greci si sono introdotti in Gallia e i Galli in Grecia, i Pirenei non hanno impedito ai Germani di attraversarli. Nel suo nomadismo l’uomo si è aperto strade attraverso l’impraticabile e l’ignoto, portandosi dietro i figli, le mogli, i genitori oppressi dalla vecchiaia. Alcuni, sballottati di qua e di là in un lungo peregrinare, non ebbero la possibilità di scegliersi a loro piacere la sede, ma, vinti dalla stanchezza, occuparono quella più vicina, mentre altri dovettero lottare con le armi per conquistarsi il diritto sopra una terra straniera. Per non parlare di quelle genti che, avventurandosi verso terre sconosciute, furono inghiottite dal mare, o si stabilirono là dove la totale mancanza di risorse li aveva fatti approdare. Varie furono le ragioni che spinsero tutti costoro a lasciare la loro patria e cercarsene un’altra: alcuni, sfuggiti allo sterminio delle proprie città e alle armi nemiche, spogliati d’ogni cosa, migrarono in terre altrui; altri dovettero sloggiare in seguito a lotte intestine, altri furono costretti ad andarsene per alleggerire il peso di una popolazione troppo numerosa, altri per sottrarsi ai rischi di pestilenze o di terremoti troppo frequenti, o a flagelli insopportabili di una terra disgraziata; altri, infine, perché incantati dalle voci di contrade fertili spacciate come migliori.
Comunque un fatto è certo: quali che siano stati i motivi per cui ognuno ha lasciato la propria casa, nessuna cosa è rimasta di quelle che lì sono nate. Incessante è il peregrinare dell’uomo. In un mondo così grande è inevitabile che ogni giorno cambi qualcosa: si pongono le fondamenta di nuove città, nascono popolazioni dai nomi nuovi, perché quelli vecchi o si estinguono di per sé o vengono assorbiti al sopraggiungere di una popolazione più forte. E cos’altro sono tutti questi spostamenti di popoli se non esilii in massa? Ma perché trascinarti in un giro così lungo? A che serve ch’io ti elenchi Antenore, fondatore di Padova, o Evandro, che portò il regno degli Arcadi sulla riva del Tevere? O Diomede e gli altri che la guerra di Troia, non solo tra i vinti ma anche tra i vincitori, disperse in terre straniere? Certo, l’impero romano ha come suo fondatore un esule che, profugo dopo la caduta della sua patria e portandosi dietro i pochi superstiti, spinto dalla necessità e dal timore dei vincitori a cercare terre lontane, approdò alla fine in Italia.5 E in seguito quel popolo quante colonie ha fondato in ogni sua provincia! Dovunque vinca, il Romano, lì pianta un’altra sua sede. E per questi cambiamenti di luogo si arruolavano volontari, fra cui c’erano anche dei veterani, che, lasciati i propri altari, seguivano i coloni attraversando i mari. Ma a che serve girare intorno e aggiungere elenchi a elenchi? Ti basti un solo esempio, che ho proprio qui davanti e mi s’imprime negli occhi. Quest’isola in cui mi trovo ha cambiato spesso i suoi abitanti. Tralasciando le popolazioni più antiche, di cui il tempo ormai ha cancellato il ricordo, i Greci che ora abitano Marsiglia, lasciata la Focide,6 si insediarono dapprima in quest’isola, da cui poi se ne andarono per motivi che noi non conosciamo, forse per l’inclemenza del clima, per le minacce che sembravano incombere su di lei dall’Italia troppo vicina, o per il mare privo di approdi naturali. Certo non fu lo stato selvaggio degli abitanti ad allontanarli, visto che da lì andarono a stabilirsi tra le fiere e rozze popolazioni della Gallia. Successivamente in quest’isola passarono i Liguri, quindi gli Ispani, come si ricava da certe usanze comuni: portano infatti gli stessi copricapo e gli stessi calzari dei Cantabri e ne conservano anche certe parole (ma sotto l’influsso dei Greci e dei Liguri la loro lingua è molto mutata rispetto a quella originaria). In seguito vi si installarono due colonie di cittadini romani, fondate una da Mario, l’altra da Silla.7 Sono tante le volte in cui è cambiata la popolazione di questo scoglio arido e tutto coperto di sterpi. In definitiva difficilmente potresti trovare una terra che sia abitata ancora oggi dagli aborigeni. Non c’è popolo che non abbia subìto incroci e mescolanze: gli uni si sono succeduti agli altri, e al nuovo venuto è piaciuto ciò che aveva finito col disgustare il precedente; uno viene cacciato da dove prima a sua volta aveva cacciato un altro. Così vuole il destino: che le cose non restino sempre nel medesimo posto, o nel medesimo stato. 8. Quanto al rimedio contro il cambiamento di luogo, a parte gli altri inconvenienti connessi con l’esilio, secondo Varrone, che è il più dotto dei
Romani,8 basta tener presente che, dovunque ci rechiamo, il nostro rapporto col mondo esterno resta immutato, poiché continuiamo a vivere sempre dentro i confini della natura. Per Marco Bruto,9 invece, l’antidoto dell’esilio sta nel portarsi dietro le proprie virtù. Presi singolarmente, questi due rimedi possono sembrare poco adatti a consolare un esule, ma se si mettono insieme bisogna riconoscere che sono efficacissimi. È ben poco, infatti, ciò che perdiamo quando ci spostiamo da un luogo all’altro: due cose ci seguono sempre, dovunque ci rechiamo, e sono i beni più belli: la natura, che è comune a tutti, e la virtù personale. Così ha stabilito – credimi – il creatore dell’universo, chiunque egli sia, un dio signore di tutte le cose, o una mente incorporea artefice di opere meravigliose, oppure uno spirito divino diffuso uniformemente in tutti gli esseri, grandi o piccoli che siano, o ancora il fato, quale serie immutabile di cause collegate tra loro; e tutto questo è stato fatto in modo che solo le cose e gli esseri più vili cadano sotto l’arbitrio altrui. Pertanto la parte migliore della natura umana non dipende da noi, e quaggiù non può esserci né data né tolta, perché insieme all’universo, che è la più grande e la più splendida creazione della natura, il nostro animo, che tale universo contempla e ammira e di cui rappresenta la parte più meravigliosa, ci è assegnato da sempre e per sempre e resterà con noi tanto più a lungo quanto più a lungo vivremo. Affrettiamoci, allora, solerti e fiduciosi, con passo pronto e sicuro, verso qualunque luogo ci sospinga la sorte. Potremo percorrere tutta la terra: nessun esilio ci sarà per noi perché non c’è luogo nel mondo che sia straniero all’uomo. In qualunque parte ci troviamo, se volgiamo lo sguardo al cielo, la distanza che intercorre fra noi e il divino è sempre la medesima. Dunque, purché in ogni momento io possa volgere gli occhi verso quello spettacolo divino che non mi stancherò mai di contemplare, guardare il sole e la luna, fissare gli astri e studiarne la nascita, il tramonto, le distanze, indagare le cause del loro moto, più lento o più veloce, ammirare le tante stelle che brillano nella notte, alcune fisse, altre che si spostano non già nell’infinito ma nell’ambito di una loro propria orbita, altre ancora che spuntano all’improvviso, altre che con un guizzo di fuoco abbagliano e sembra che stiano per cadere, oppure passano oltre lasciando una lunga scia luminosa; purché, dovunque mi trovi, io possa avere come compagni tutti questi corpi celesti e, per quanto possibile a un uomo, partecipare alla vita divina sino a confondermi con essa, purché, insomma, l’animo mio, che tende a tutto ciò ch’è nato con lui, sia sempre rivolto al cielo, che m’importa su quale terra poggi i miei piedi? 9. Ma questa terra, si dice, non produce né fiori né alberi da frutto, non è bagnata da grandi o navigabili corsi d’acqua, non ha nulla di ciò che richiedano altre popolazioni, anzi, fornisce appena quanto basta alla sopravvivenza dei suoi abitanti; non ha cave di marmi pregiati, miniere d’oro o d’argento. Ebbene, meschino è quell’animo che si compiace di beni terreni, invece di volgersi verso quelli che sono uguali dappertutto e che dovunque hanno il medesimo valore. Per
non dire che i beni terreni, per gli errori e i pregiudizi che comportano, sono di ostacolo alla conquista di quelli autentici. Quanto più si estendono i portici di un palazzo, s’innalzano le torri e crescono i caseggiati, quanto più profonde si scavano le grotte per ripararsi dal caldo dell’estate e più carichi di rivestimenti e di orpelli sono i soffitti nelle sale da pranzo, tanto meno si vede il cielo. Poniamo che la sorte ti abbia spinto in una regione in cui l’alloggio più sontuoso è una capanna. Ebbene, se ti adatti e sopporti la cosa con coraggio solo perché pensi che Romolo visse in una capanna,10 hai un animo meschino, che si accontenta di misere consolazioni. Di’ invece così: «Forse che anche un umile tugurio non può accogliere delle virtù? Sarà più bello e più accogliente di qualunque tempio, se vi si potranno vedere la giustizia, la continenza, la prudenza, la pietà, un retto criterio nella distribuzione dei compiti, la conoscenza delle cose umane e di quelle divine. Non è angusto un luogo che contiene una folla di così grandi virtù. E non v’è esilio che pesi quando vi si vada con una simile scorta». Nel suo libro Sulla virtù Bruto racconta di aver visto Marcello11 in esilio, a Mitilene, condurre una vita tranquilla e felice, quanto almeno è possibile all’uomo, e che mai prima di allora si era dedicato alle belle arti con tanta passione. E aggiunge che per questo motivo, nel congedarsi dall’amico, più che allontanarsi da un esule, gli parve di essere lui che se ne andava in esilio. Quanto più fortunato fu Marcello nel ricevere l’elogio di Bruto per il suo esilio che non quello della repubblica per il suo consolato! E che grande uomo fu quello che diede a un esule l’impressione di andarsene in esilio nel momento in cui si congedava da lui! Quanto grande ancora Marcello per essersi conquistato l’ammirazione di un uomo che godeva addirittura della stima e dell’amicizia di Catone!12 Bruto dice poi che Cesare non si fermò a Mitilene perché non sopportava di dover vedere un tale uomo umiliato in quel modo. E quando il Senato, con una supplica ufficiale13 rivolta a Cesare, chiese il ritorno di Marcello, tutti erano così ansiosi e così tristi, quel giorno, che sembravano condividere lo stato d’animo di Bruto e pregare non per Marcello ma per sé stessi, come se, risultando vana la supplica, dovessero continuare loro a subire l’esilio invece di lui. Ma il giorno in cui Marcello ottenne molto di più fu quello in cui Bruto non sopportò di dover partire lasciandolo in esilio e Cesare non osò vederlo. Si ebbe infatti da entrambi questa testimonianza: Bruto si dolse di dover tornare senza Marcello, Cesare se ne vergognò. Io credo che quell’uomo così grande, per farsi coraggio e poter sopportare serenamente l’esilio, abbia fatto queste riflessioni: «Essere privato della propria patria non è cosa miserevole per te, poiché i tuoi studi ti hanno insegnato che per il saggio la patria è il mondo. Dunque? Chi ti ha mandato in esilio non è stato forse anche lui un senza patria per dieci anni di seguito? D’accordo, se n’è andato per conquistare nuove terre all’impero, ma comunque ne è stato lontano. E ora lo chiama a sé l’Africa, minacciata dal riaccendersi di una guerra, lo chiama la Spagna, messa in subbuglio dalle fazioni vinte e umiliate, lo chiama l’infìdo Egitto, e infine il
mondo intero, sempre pronto a cogliere la minima occasione per abbattere il nostro dominio. Quale nemico affronterà per primo? A quale parte del mondo opporrà la sua spada? Ogni vittoria sarà una nuova terra per lui. I popoli lo esaltino e l’onorino: a te basti l’ammirazione di Bruto!». 10. Marcello, dunque, sopportò bene l’esilio: il cambiamento di luogo non mutò affatto il suo animo, pur nella povertà che ne conseguì. La quale di per sé stessa non è un male, come può capire chiunque, salvo che non si giunga a una tale avidità e dissolutezza da travisare ogni cosa. Quanto poco serve, infatti, per i bisogni materiali di un uomo! E quel poco non può mancare a chi abbia quel tanto di virtù necessaria. Quanto a me non le ricchezze sento di aver perduto ma gl’impegni e le preoccupazioni. Le esigenze del corpo sono ridotte al minimo: un riparo dal freddo e un’alimentazione che basti a placare la fame e la sete. Quel di più che si desidera riguarda i vizi, non le necessità materiali, né vale la pena affannarsi. Non è necessario scrutare tutto il fondo del mare, appesantire lo stomaco con una strage di animali, raccattar conchiglie su spiagge sconosciute dei mari più lontani. Gli dèi confondano coloro la cui dissolutezza travalica i confini di un così invidiabile regno! Pretendono che si catturi di là dal fiume Fasi14 ciò che serve ad arricchire la loro ambiziosa cucina e non si vergognano di chiedere uccelli ai Parti, coi quali abbiamo ancora dei conti in sospeso.15 Per i loro palati schizzinosi si fanno portare da tutti i paesi del mondo i cibi più prelibati, dal lontanissimo Oceano gliene arrivano di così strani che il loro stomaco, rovinato da tanta raffinatezza, a mala pena riesce a tollerare. Vomitano per mangiare, mangiano per vomitare, non degnandosi nemmeno di digerire quei cibi che mandano a cercare in tutto il mondo. Che danno può arrecare la povertà a chi disprezza tutti questi eccessi? Anzi, giova anche a chi li desidera, perché suo malgrado ne sta lontano, e quindi ne guarisce: infatti, pur se non accetta quel rimedio in quanto lo considera una costrizione, volente o non volente, si trova nelle stesse condizioni di chi si astiene volontariamente. Caligola – che la natura ha generato per dimostrare agli uomini sino a che punto possano giungere i vizi quando sono accompagnati da un’immensa fortuna – per una sola cena spese dieci milioni di sesterzi, e, sostenuto dall’estro inventivo di tutti, trovò il modo, anche se con fatica, di spendere per una sola cena le entrate di tre province. Infelici coloro il cui palato è sensibile solo ai cibi pregiati! I quali costano tanto non per il gusto squisito o la dolcezza che lasciano in bocca, ma per la loro rarità e la difficoltà di procurarseli. Ma se tutta questa gente riacquistasse l’uso della ragione si renderebbe conto che è una pazzia mettere tante arti al servizio del ventre. Che bisogno c’è di scambi commerciali, di devastare foreste, di scrutare il fondo del mare? Tutti possiamo attingere a quei cibi che la natura ha disseminato dovunque, in ogni angolo del mondo. Ma costoro passano oltre, come se non avessero occhi per vedere, percorrono tutte le regioni, valicano i mari e, pur potendo sedare la fame con poco, la stimolano con delle grandi abbuffate. Viene voglia di dirgli: «Perché mettete in mare le navi? Perché vi
armate contro le fiere e contro gli uomini? Perché correte di qua e di là con tanta ansia e fatica? Perché accumulate ricchezze su ricchezze? Non vi passa nemmeno per la mente quanto sia piccolo il vostro corpo? Non è follia, non è l’estremo inganno della ragione questo desiderare molto, quando puoi mettere dentro tanto poco? Potete accrescere le vostre entrate, estendere i confini delle vostre proprietà, ma non ingrandire il vostro corpo. Per quanto tu possa arricchirti nel campo del commercio, con la vita militare o con l’ammucchiare cibi scovati in ogni parte del mondo, non ci sarà spazio sufficiente per tutte le provviste che avrai accumulato. Perché, dunque, cercare tante cose? Dovremmo pensare, allora, che i nostri antenati, grazie alla cui virtù possiamo permetterci i nostri vizi, fossero degli infelici perché si procuravano il cibo con le loro mani, dormivano per terra, non avevano case dorate e templi luccicanti di pietre preziose? A quei tempi i giuramenti religiosi si facevano su statuette di argilla e chi aveva invocato gli dèi tornava a combattere disposto anche a morire per non tradire la parola data.16 Evidentemente quel nostro dittatore17 che ascoltò gli ambasciatori Sanniti – mentre sul focolare si cucinava un cibo poverissimo con quelle stesse mani che più di una volta avevano vinto il nemico e deposto la corona d’alloro nel grembo di Giove Capitolino – doveva condurre una vita assai meno felice di quella che, a nostra memoria, poteva permettersi Apicio,18 il quale, maestro di scienza culinaria nella capitale, da cui erano stati espulsi i filosofi perché accusati di corrompere la gioventù,19 infettò tutta un’epoca col suo bell’insegnamento!». E vale la pena conoscerne la fine. Dopo aver sperperato in cucina cento milioni di sesterzi e divorato, cena dopo cena, le innumerevoli largizioni degli imperatori e l’ingente tributo del Campidoglio, oberato dai debiti, fu costretto, per la prima volta, a fare i conti, e visto che gli restavano solo dieci milioni di sesterzi, come se con una simile cifra, da quel momento, fosse votato alla fame, si avvelenò. Quanto dev’essere grande la dissolutezza di un uomo che considera una miseria dieci milioni di sesterzi! Non venirmi dunque a dire che la ricchezza sta nelle cose, non nei beni dello spirito. Uno che teme per la sua sopravvivenza davanti a dieci milioni di sesterzi e fugge, avvelenandosi, ciò che tutti ardentemente desiderano! Certo, per quell’uomo dal cervello malato l’ultima bevanda fu quanto mai salutare, ma i veri veleni se li mangiava e se li beveva quando non solo si compiaceva dei suoi smodati banchetti ma se ne vantava pure, quando ostentava i suoi vizi e trascinava nella sua dissolutezza tutta la città, quando spingeva i giovani, già così facili a guastarsi anche senza cattivi esempi, a imitarlo. Questo capita a chi affida le proprie ricchezze non alla ragione, che ha limiti ben precisi, ma alla consuetudine del vizio, il cui arbitrio è immenso e incontrollato. All’ingordigia non c’è nulla che possa bastare, mentre alla natura anche il poco è sufficiente. La povertà, dunque, non arreca alcun disagio all’esule: non c’è luogo d’esilio, infatti, tanto sterile da non produrre più di quanto occorra per mantenere un uomo.
11. L’esule può sentire la mancanza di un vestito e di una casa, ma se li desidera solo perché gli sono necessari non gli mancheranno mai né un tetto né un panno per coprirsi: basta poco, infatti, per riparare il corpo, come poco è sufficiente a nutrirlo. La natura non ha mai reso difficile all’uomo procurarsi ciò che gli è indispensabile. Ma quando uno rimpiange una veste stracarica di porpora, intessuta d’oro, o variopinta e ricamata ad arte, se è povero la colpa è sua non certo della fortuna. E anche se tu gli restituissi tutto ciò che ha perduto per lui sarebbe sempre poco, perché continuerebbe ad avere nuovi desideri e a sentirsi egualmente più povero rispetto a un esule che ha perduto i suoi beni. E uno che desideri di possedere una suppellettile splendente di vasi d’oro e pezzi d’argenteria firmati dai più famosi artisti dell’antichità, bronzi diventati preziosi per la mania di pochi, una folla di schiavi che farebbe sembrare piccola anche la casa più grande, bestie da soma ben rimpinzate costrette a ingrassare ancora di più e marmi provenienti da ogni parte del mondo, anche se riuscisse ad accumulare tutto questo ben di dio non potrà mai saziare la sua anima insaziabile, così come non ci sarà mai acqua sufficiente a uno che senta il bisogno di bere non perché abbia sete ma perché divorato da un fuoco che gli brucia le viscere: quella, infatti, non è sete, è malattia. Ciò non accade solo col cibo e col denaro, è una prerogativa tipica di ogni desiderio che nasce non dal bisogno ma dal vizio, sicché per quanto si cerchi di soddisfare un simile desiderio l’avidità non si esaurisce, anzi, il vizio cresce ancora di più. Chi dunque saprà contenersi entro i limiti segnati dalla natura non sentirà la povertà, mentre chi li supererà l’avrà sempre come compagna, persino in mezzo alle più grandi ricchezze. Al necessario può provvedere anche un esilio, al superfluo non basta nemmeno un regno. È l’animo che ci fa ricchi. Ci segue nell’esilio e nei deserti più desolati, e quando ha trovato ciò che basta a sostentare il corpo si sente ricco dei suoi beni e ne gode: il denaro non riguarda l’animo, perché non tocca gli dèi. Tutte quelle cose che le persone ignoranti e troppo schiave del proprio corpo ammirano, come i marmi, l’oro, l’argento e le grandi tavole rotonde ben levigate, sono pesi terreni che un animo puro e consapevole della sua natura divina non può amare, perché è senza macchia e sa che una volta libero spiccherà il volo verso le sfere celesti. Nel frattempo, per quanto gli è consentito dall’ingombro delle membra e dal peso di questa grave soma che lo avvolge, va percorrendo con pensiero agile e alato le sedi degli dèi. Per questo un animo libero e imparentato con gli dèi, compagno indissolubile dell’universo e dell’eternità, non può mai sentirsi esule, in quanto il suo pensiero penetra tutto il cielo e tutto il tempo, presente, passato e futuro. Questo povero corpo, invece, prigione e catena dell’anima, è sbattuto ininterrottamente di qua e di là: su di lui si cimentano e si sfogano ogni tipo di tormenti, le violenze, le malattie: l’animo, al contrario, è per sua stessa natura sacro ed eterno e dunque tale che nulla può violentarlo. 12. Affinché tu non creda che per sminuire i danni di una povertà, gravosa
solo per chi la ritiene tale, io mi serva soltanto dei precetti di uomini saggi, ti faccio osservare in primo luogo che la grande maggioranza dei poveri non sono affatto più infelici o più preoccupati dei ricchi, anzi, forse sono più felici proprio perché il loro animo è meno afflitto da preoccupazioni. Ma lasciamo i poveri e veniamo ai ricchi: in quanti casi costoro somigliano ai poveri! Quando viaggiano devono dimezzare i loro bagagli e tutte le volte che per qualche necessità sono costretti ad affrettarsi licenziano il corteo degli accompagnatori. Sotto le armi quanta parte dei loro beni si portano dietro visto che la disciplina militare vieta ogni cosa superflua? E non sono solo situazioni particolari o le scarse risorse dei luoghi a porre i ricchi nella stessa condizione dei poveri: a volte, annoiati e stanchi di vivere in mezzo a tanta ricchezza e a tanta abbondanza, mangiano per terra e sdegnando l’oro e l’argento, usano stoviglie di coccio. Sono proprio pazzi. Hanno il terrore di ciò che spesso desiderano. Quanta nebbia c’è nelle loro menti, quanta ignoranza gl’impedisce di cogliere il valore di quella verità che imitano solo per il piacere di divertirsi! Io se penso agli esempi degli antichi mi vergogno di cercare motivi di consolazione alla mia povertà, perché il lusso della nostra epoca è tale che le spese necessarie al mantenimento di un esule superano il patrimonio dei grandi di una volta. Sappiamo con certezza che Omero ebbe un solo schiavo, Platone tre, Zenone, il fondatore della rigorosa e virile filosofia stoica, nemmeno uno. Ebbene, solo l’ultimo dei miserabili potrebbe dire che costoro sono vissuti miseramente! Menenio Agrippa,20 che aveva fatto da paciere tra il Senato e la plebe, non ebbe nemmeno i soldi per pagarsi il funerale, tanto che per seppellirlo si dovette fare una sottoscrizione. Attilio Regolo, mentre in Africa sgominava i Cartaginesi, scrisse al Senato che il bracciante addetto alla cura del suo podere se n’era andato lasciando il fondo in abbandono, al che il Senato lo fece coltivare a spese pubbliche finché Regolo non tornò. Gli pesò tanto non possedere uno schiavo quando si ebbe come colono il popolo romano? Le figlie di Scipione21 ricevettero la dote dall’erario, perché il padre non aveva lasciato nulla: era giusto, per Ercole, che il popolo romano pagasse, almeno una volta, un tributo a Scipione, visto che lo aveva sempre riscosso dai Cartaginesi. Beati gli sposi di quelle fanciulle che ebbero il popolo romano come suocero! Credi che siano più felici certi uomini di oggi le cui ballerine si sposano con un milione di sesterzi di dote, o Scipione, le cui figlie ricevettero in dote dal Senato, loro tutore, una moneta di rame?22 E di fronte a una povertà che vanta esempi di antenati così illustri c’è ancora chi la disdegna? Come può un esule indignarsi perché gli manca qualcosa quando Scipione non ebbe la dote per le figlie, Regolo un bracciante per il suo podere, Menenio il denaro per il suo funerale? Quando tutti costoro furono ricompensati dignitosamente con ciò che gli era mancato? Di fronte a simili esempi la povertà risulta non soltanto esente da preoccupazioni ma persino gradita. 13. A questo punto qualcuno potrebbe rispondermi: «Perché separi
artificiosamente delle cose che prese una per una sono tollerabili ma messe insieme non lo sono più? Il cambiamento di luogo di per sé stesso è sopportabile, così pure la povertà se non vi si aggiunge l’infamia, che basta da sola ad avvilire l’animo». A chi pensasse di spaventarmi mettendomi davanti una sequela di inconvenienti risponderò così: «Se hai forza sufficiente per resistere a qualunque tipo di sventura l’avrai anche contro tutte, perché l’animo, una volta irrobustito dalla virtù, sarà invulnerabile sempre». Se ti sei liberato dalla cupidigia, che è la piaga più terribile del genere umano, l’ambizione non ti metterà il bastone fra le ruote. Se guardi al tuo ultimo giorno non come a una pena, ma come a una legge di natura, nel tuo cuore, da cui hai bandito la paura della morte, non entrerà nessun altro timore. Se pensi che lo stimolo sessuale sia stato dato all’uomo non per un semplice piacere, ma per propagare la specie, e se di conseguenza non ti lascerai corrompere dalla peste della libidine che si annida insidiosa nelle nostre viscere stesse, nessun’altra passione ti guasterà. La ragione non sconfigge i vizi uno alla volta, li sgomina tutti insieme e in modo completo e definitivo. Credi che il disonore possa turbare il saggio che ripone tutto in sé stesso e si distacca dalle opinioni del volgo? Una morte infamante è più che un’infamia. Nonostante ciò, Socrate entrò nel carcere con lo stesso volto con cui poco prima aveva da solo riportato all’ordine i trenta tiranni, e con la sua presenza riscattò quel luogo dal disonore: non poteva infatti sembrare un carcere se c’era dentro Socrate. E chi è così lontano dalla verità da ritenere che i due insuccessi elettorali di Marco Catone, candidato alla pretura e al consolato, siano stati ignominiosi? Furono la pretura e il consolato a doversene vergognare, onorati com’erano stati dalla candidatura di Catone. L’offesa non tocca se non colui che tiene in poco conto sé stesso. Lascia che la senta un animo mediocre e avvilito, ma chi si erge contro le avversità e abbatte quei mali, da cui gli altri si lasciano sopraffare, considera le sue miserie come un ornamento sacro e inviolabile, perché noi siamo istintivamente portati ad ammirare più di ogni altro un uomo che sa esser forte nella miseria. Mentre Aristide, 23 ad Atene, veniva condotto a morte, tutti quelli che lo incontravano abbassavano gli occhi e piangevano, come se si stesse condannando non solo un giusto ma la giustizia stessa. Un tale, però, gli sputò in faccia, al che lui, che legittimamente poteva ritenersi offeso, convinto com’era che nessun uomo di bocca pura avrebbe osato tanto, invece di reagire, si ripulì il volto e sorridendo disse al magistrato che lo accompagnava: «Avverti costui che un’altra volta sia meno sgarbato quando sbadiglia». Fu questa la sua offesa a chi lo aveva offeso. So bene che per alcuni non c’è cosa più grave del disprezzo e che piuttosto di subirlo sarebbe meglio morire. A costoro rispondo che spesso pure l’esilio è esente da qualunque tipo di offesa, giacché un grand’uomo è tale anche se cade, e tutti lo rispettano, come colui che non disprezza le rovine di un tempio sulle quali cammina, ma prova per loro la stessa venerazione di quando l’edificio era in piedi.
14. Dunque, madre carissima, se non c’è nulla che possa indurti a versare tante lacrime per causa mia, evidentemente ti spingono motivi tuoi personali, e allora due sono le cose: o ti turba il pensiero di aver perduto un sostegno, o è la mia mancanza che non riesci a sopportare. Il primo caso mi basterà toccarlo solo di sfuggita, visto che conosco bene i tuoi sentimenti e so che ami i tuoi cari di per sé stessi, non per ciò che possiedono. A questo pensino quelle madri che, con dispotismo tipicamente femminile, sfruttano il potere dei loro figli, quelle che, non potendo ricoprire cariche pubbliche perché sono donne, sfogano la propria ambizione per mezzo di loro, quelle che arraffano e dilapidano il patrimonio dei figli o ne sfruttano l’eloquenza mettendola a servizio di altri. Tu hai sempre gioito moltissimo delle ricchezze dei tuoi figli, ma non te ne sei minimamente servita; hai sempre imposto un limite alla nostra liberalità, mai alla tua; per quanto ancora sotto tutela, hai contribuito ad arricchire i tuoi figli; hai amministrato i nostri patrimoni con la stessa cura che avresti avuto nei confronti dei tuoi e rispettandoli come se appartenessero a estranei; non hai mai approfittato dei successi riportati da noi, quasi che fossero d’altri, e dei nostri onori non ti sono toccati che il piacere e le spese: mai, insomma, la tua benevolenza è stata interessata. Non puoi dunque rimpiangere, in un figlio che ti è stato strappato, quelle cose che non hai mai pensato che ti riguardassero quando egli ti era vicino. 15. Bisogna che tutta la mia azione consolatrice io la diriga là dove nasce l’impulso autentico del tuo dolore di madre: «Eccomi priva dell’abbraccio del mio carissimo figlio!», tu dici. «Non posso gioire della sua vista, della sua voce! Dov’è colui alla cui sola presenza il mio volto si rasserenava e nel quale deponevo tutti i miei affanni? Dove sono quei suoi discorsi che mai mi rendevano sazia? Dove i suoi studi, ai quali partecipavo più volentieri di qualunque altra donna e con una familiarità che non trova riscontro in una madre? Dov’è quel suo venirmi incontro, quella giocondità fanciullesca che illuminava il suo viso ogni volta che mi vedeva?». A questi pensieri si aggiunge la vista dei luoghi in cui siamo vissuti insieme e felici, dei segni che testimoniano la nostra recente intimità, che sono i più efficaci a suscitare tormenti nell’animo. La sorte, infatti, ha predisposto per te anche questa crudeltà, che cioè tu partissi tranquilla e senza sospetto alcuno due giorni prima che io fossi colpito dalla condanna. Ed è stato un bene che in passato siamo vissuti divisi e lontani, che l’assenza di qualche anno ti abbia preparato a questa sventura. E poi sei tornata non per godere della presenza di tuo figlio ma per perdere l’abitudine di lamentarne l’assenza. Se fossi partita molto prima avresti potuto sopportare la mia mancanza con maggior forza, perché il tempo attenua il rimpianto. Però se non fossi partita avresti avuto l’estremo conforto di vedere tuo figlio per altri due giorni. Ora, invece, un crudele destino ha voluto che tu non fossi presente al momento della mia disgrazia, né ti ha dato il tempo di abituarti alla mia assenza. Ma quanto più
dolorose sono per te queste prove, tanto maggiore dev’essere il coraggio con cui affrontarle. Lotta come se avessi a che fare con un nemico già noto e sconfitto tante altre volte, poiché il tuo sangue sgorga non da un corpo indenne da ferite ma da colpi inferti sulle cicatrici. 16. Non addurre a tua scusa il fatto di essere donna, alla quale è concesso il diritto a un pianto smodato ma sempre entro certi limiti. Per questo i nostri padri diedero alle donne un periodo di dieci mesi per piangere i loro mariti, circoscrivendo con una legge dello Stato l’ostinazione del pianto femminile. Non vietarono il lutto, ma ne stabilirono un termine, giacché abbandonarsi a un dolore senza fine per la perdita di una tra le persone più care è un cedimento insensato, così come il non provarne alcuno è una crudeltà disumana: la giusta misura fra la pietà e la ragione sta nel sentire il rimpianto e saperlo soffocare. Non devi guardare quelle donne che una volta colpite da un lutto hanno finito di piangere solo con la morte. Tu ne conosci alcune che indossata la veste funebre per la morte dei figli non se la tolsero più: da te la vita pretende uno sforzo maggiore, visto che sei stata più forte fin dall’inizio. La scusa della femminilità non si conviene a una donna che è sempre stata immune dalle debolezze femminili. La spudoratezza, che è il male peggiore della nostra epoca e che porta a seguire la condotta dei più, non ti ha mai contagiato, né gemme e perle ti hanno sedotto, non ti hanno mai abbagliato le ricchezze, «bene supremo del genere umano», e – anche per la buona educazione che hai ricevuto in una famiglia severa e all’antica – ti sei sempre guardata dall’imitare le donne peggiori (un rischio che corrono anche le oneste); non ti sei mai vergognata della tua fecondità, quasi che potesse suonare come un rimprovero alla tua età; non hai mai nascosto, come fanno le donne che badano solo alla bellezza esteriore, il ventre gonfio per le tue gravidanze, come se queste fossero un peso vergognoso, né ti sei mai disfatta del promettente frutto del concepimento che portavi in grembo; non ti sei imbrattata il volto con colori e belletti; non ti sono mai piaciute quelle vesti che quando si tolgono non denudano più di tanto: tuo unico ornamento – bellezza somma, per nulla condizionata dall’età e tuo massimo titolo di onore – è sempre stata la pudicizia. Non puoi dunque, a difesa del tuo dolore, chiamare in causa la tua condizione di donna, dalla quale ti discosti per le tue virtù; devi tenerti lontana dalle lacrime femminili così come dai difetti. Anche le donne non ti permetteranno di struggerti nel tuo dolore, e dopo che avrai sfogato un giusto, breve e necessario pianto, ti inviteranno a risorgere, sempre che tu voglia ascoltare quelle donne che una riconosciuta virtù ha posto fra gli uomini grandi. Cornelia aveva dodici figli, la sorte gliene lasciò due. Se li conti, i suoi lutti furono dieci, se li pesi devi dire: «Erano i Gracchi!». Con tutto ciò, a quanti le piangevano intorno maledicendo il suo destino lei proibì di accusare la fortuna, che le aveva dato come figli i Gracchi. Non poteva nascere che da una simile donna colui che in pubblica assemblea esclamò: «Tu insulti Cornelia, colei che ha partorito Tiberio!». A me,
però, sembra molto più piena d’orgoglio la frase della madre, quando disse che il figlio si vantava della nascita dei Gracchi, lei anche della loro morte. Rutilia seguì il figlio Cotta24 in esilio: lo amava infatti a tal punto che preferì sopportare il peso di quella condizione piuttosto che la sua mancanza; né fece ritorno in patria se non quando vi rientrò lui. Poi, come il figlio fu ritornato e divenuto un personaggio eminente nella vita pubblica, ne accettò la morte con lo stesso coraggio con cui l’aveva seguito in esilio e nessuno la vide piangere dopo il suo funerale: coraggiosa quando il figlio fu esiliato, saggia quando lo perse. Nulla, infatti, la distolse dal suo affetto materno e nulla la trattenne in una sciocca e inutile tristezza. Fra queste donne voglio che tu sia annoverata: poiché ne hai sempre imitato la vita, ne seguirai ottimamente l’esempio contenendo e reprimendo il tuo dolore. 17. So che ciò non è in nostro potere, perché non c’è sentimento profondo che si possa piegare, tanto meno se nasce dal dolore: in questo caso è spietato e refrattario a ogni rimedio. Talvolta cerchiamo di soffocarlo e di inghiottire i nostri singhiozzi, ma anche se manteniamo un’espressione composta e impassibile le lacrime sgorgano sul nostro volto. Ogni tanto ci distraiamo recandoci ai giochi o alle lotte dei gladiatori, ma proprio durante lo spettacolo, che dovrebbe distrarci, basta un piccolo cenno a turbarci. Perciò è meglio vincerlo il dolore, piuttosto che ingannarlo, perché se lo distraiamo e lo allontaniamo coi piaceri o con altre attività, quello poi risorge, incrudelendo ancora di più per via dell’impulso che ha dovuto soffocare in quel periodo di tregua. Se invece cede alla ragione, resta sotto controllo per sempre. Non voglio dunque indicarti quei rimedi a cui so che ricorrono molti, come un lungo viaggio che ti porti lontano dalla tua casa e ti distragga con quelle amenità che comporta, un impegno che ti tenga occupata nel rivedere attentamente i tuoi conti, nell’amministrazione del tuo patrimonio o in qualche nuova attività: tutte queste cose giovano per poco tempo e più che un rimedio sono un ostacolo al dolore. Io, invece, non ho intenzione di ingannarlo, voglio farlo cessare, il dolore. Perciò ti conduco là dove si rifugiano coloro che vogliono evitare la cattiva sorte: agli studi umanistici. Essi guariranno la tua ferita e scacceranno da te ogni tristezza. È bene che tu vi faccia ricorso, anche se non ti ci sei mai accostata, per quanto, nei limiti imposti dalla severità di mio padre, ch’era un uomo all’antica, tu abbia avuto dimestichezza con tutte le materie di studio, pur senza approfondirle. Magari mio padre, che pure fu ottimo marito, fosse stato meno legato alle consuetudini dei suoi avi e ti avesse consentito di approfondire i precetti della filosofia, invece di lasciartene solo una infarinatura! Ora non avresti bisogno di preparartelo questo rimedio contro la sorte, dovresti solo tirarlo fuori. È stato a causa delle donne di oggi, che si dànno alle lettere non per farsi una cultura ma per poter entrare nei salotti mondani, che non ti ha permesso di dedicarti agli studi un po’ più del necessario. Tu, però, hai tratto un profitto maggiore dalla vivacità del tuo ingegno che non dal tempo che ti era concesso, per cui hai le
basi di tutte le discipline. Torna dunque a quegli studi: ti daranno sicurezza, diletto e conforto. Se il tuo animo troverà per loro un posto propizio non potranno più entrarvi il dolore, la preoccupazione, l’inutile tormento di una vana afflizione. Nessuno di questi mali potrà ferire il tuo cuore, visto che a ogni altra debolezza è già chiuso da tempo. 18. Queste sono le difese più valide e sicure, le sole capaci di sottrarti ai colpi che ti ha inferto la sorte. Ma poiché, fino a quando non sarai giunta a quel porto di serenità che gli studi ti promettono, hai bisogno di qualche altro appoggio, voglio mostrarti come puoi nell’attesa consolarti. Guarda i miei fratelli:25 finché ci sono loro, e stanno bene, non hai il diritto di prendertela col destino. In entrambi, per meriti diversi, puoi trovare motivo per rallegrarti: il primo, con la sua attività, ha conseguito importanti cariche pubbliche, l’altro, da uomo saggio, non se n’è curato. Godi degli onori del primo, della vita appartata del secondo e dell’affetto di entrambi. Conosco bene i sentimenti intimi dei miei fratelli: uno svolge la sua attività pubblica perché ciò ti sia motivo di orgoglio, l’altro è rimasto raccolto nella quiete della sua vita privata per dedicarsi a te. Bene ha disposto il destino affinché i tuoi figli ti fossero di sollievo e di aiuto, sicché tu puoi trovare nel primo una protezione materiale per l’attività che svolge, nel secondo un conforto morale per la sua vita tranquilla e libera da impegni. Faranno a gara nell’assisterti e col loro affetto ripagheranno il rimpianto che hai per il figlio lontano. Ti assicuro senza alcuna esitazione che per te, quanto ai tuoi figli, sarà solo questione di numero. Guarda poi i nipoti che hai avuto da loro: Marco,26 un bambino tenerissimo, la cui sola presenza basta per allontanare ogni tristezza. Non c’è dolore che incrudelisca nei nostri cuori, per quanto grande o recente, ch’egli non sappia lenire coi suoi abbracci e con le sue carezze. Quali lacrime non asciuga la sua gioia, quale animo angosciato non rasserena la sua vivacità? Chi non è coinvolto nei suoi giochi da quella sua gaiezza? Chi, per quanto preso dai suoi pensieri, non riesce quel bimbo a incantare, distraendolo con la sua instancabile loquacità? Ci concedano gli dèi che questo bimbo ci sopravviva! Che tutta la crudeltà del destino si sfoghi su di me sino a stancarsi. Che ogni dolore riservato a sua madre e a sua nonna si riversi su di me, e che tutta quanta la famiglia continui a vivere prospera e felice! Non mi lamenterò della perdita di mio figlio, né della mia condizione, se col mio sacrificio potrò evitare ai miei altri dolori. Tieniti ben stretta Novatilla, 27 che presto ti darà dei pronipoti: l’avevo assunta dentro di me e la sentivo così mia che ora, avendomi perduto, può sembrare orfana anche se il padre è vivo. Amala pure per me. Da poco la sventura le ha portato via la madre: il tuo affetto può far sì che lei ne soffra la perdita ma non la mancanza. Educala e plasma i suoi costumi: gli insegnamenti ricevuti in tenera età hanno più profonde radici. Si abitui al tuo parlare, impari a obbedirti: le darai molto, anche col tuo solo esempio. Un compito così impegnativo sarà già un rimedio al tuo dolore: un animo che soffre per l’affetto verso i suoi cari non può essere distolto dal suo
dolore se non con la ragione o con una nobile attività. Fra i grandi motivi di consolazione annovererei anche tuo padre, se non fosse lontano. Tuttavia dal tuo affetto per lui puoi dedurre quello ch’egli prova per te: capirai così quanto sia più giusto che tu ti conservi per lui piuttosto che consumarti per me. Ogni volta che il dolore ti afferrerà con maggior forza e misura e cercherà di trascinarti con sé, pensa a tuo padre. Con tutti i nipoti e i pronipoti che gli hai dato tu certamente non sei più l’unica per lui, ma è da te che dipende la possibilità ch’egli conduca felicemente a termine la sua esistenza. Finché vivrà lui non avrai il diritto di lamentarti d’essere vissuta. 19. E non ti ho ancora parlato di quello che può essere il tuo più grande conforto, cioè di tua sorella, quel cuore a te devotissimo che condivide in eguale misura ogni tuo dispiacere, un animo materno per tutti quanti noi. Hai mescolato alle sue lacrime le tue, ed è fra le sue braccia che hai ritrovato la vita. Ha sempre partecipato ai tuoi sentimenti, ma per quanto riguarda la mia persona non si limita solo a soffrire per te. Mi ha portato a Roma28 fra le sue braccia, per le sue affettuose cure materne sono guarito da una lunga malattia, ha usato tutta la sua influenza per farmi avere la questura, vincendo la sua timidezza per amor mio, lei che non ha mai avuto il coraggio di parlare o salutare ad alta voce. La sua vita appartata, il suo riserbo, che fra la sfacciataggine di tante donne sembra quasi un affronto, i suoi costumi, riservati alla casa e a una vita tranquilla, non le impedirono di darsi da fare per i miei successi. Questo, madre carissima, è il conforto che può risollevarti: stalle vicina il più possibile, tienila stretta fra le tue braccia. Di solito chi soffre evita la compagnia delle persone più care per dare libero sfogo al proprio dolore, ma tu, qualunque cosa decida, recati da lei: sia che intenda persistere in questo tuo atteggiamento, sia che lo voglia lasciare, la troverai sempre disposta o a liberarti dal tuo dolore o a farsene compagna. Ma, se ben conosco la saggezza di questa donna straordinaria, lei non ti permetterà di consumarti in un dolore inutile e dannoso e ti riferirà il suo esempio, di cui io sono stato testimone. Durante un viaggio per mare le morì l’amatissimo marito, un nostro zio, che aveva sposato giovinetta. Ebbene, vinto il dolore e la paura e cessata la tempesta, sfidando il naufragio, ne portò a terra la salma. Quante nobili azioni di donne restano sconosciute! Se le fosse toccato di vivere in quei tempi antichi in cui era così naturale l’amore per la virtù, con quale gara d’ingegni sarebbe stata celebrata quella moglie che, immemore della sua debolezza di donna e incurante di un mare terribile anche per i più coraggiosi, mise a repentaglio la propria vita per dare sepoltura al marito, e, preoccupata del funerale di lui, non ebbe timore del proprio! Tutti i poeti hanno celebrato Alcesti,29 colei che si offrì di morire al posto del suo sposo, ma è cosa ancora più ammirevole cercare una sepoltura per il marito a costo della propria vita: più grande è quell’amore che, a parità di rischio, trae un vantaggio minore. Di fronte a un simile esempio non c’è da meravigliarsi se nei sedici anni in cui suo marito amministrò l’Egitto non si fece mai vedere in pubblico, non ricevette
in casa alcun abitante della provincia, non chiese favori al marito e non lasciò che se ne chiedessero a lei. Perciò quella provincia, pettegola e capace solo di denigrare i suoi governanti, che calunniava persino coloro ch’erano immuni da colpe, la ammirò come esempio unico di integrità, e – cosa difficilissima per chi ama la satira pericolosa che può ritorcersi contro lui stesso – frenò ogni licenza verbale e ancora oggi, benché ormai non lo speri, continua a desiderare una donna simile a lei. Sarebbe stato molto se quella provincia l’avesse apprezzata per tutti quei sedici anni, ma è ancora più sorprendente che l’abbia ignorata per un periodo così lungo. Ti ho narrato questi fatti non per fare le sue lodi, che a volerle illustrare così brevemente sarebbe un diminuirle, ma affinché tu comprenda la magnanimità di questa donna, che non si lasciò vincere né dall’ambizione, né dalla cupidigia, compagne e flagelli di ogni potere, e neppure dal timore della morte, quando, con la nave distrutta e alla deriva, di fronte a quella rovina, si aggrappò al cadavere del marito non per salvare sé stessa ma per sottrarre lui al naufragio. Mostra dunque una virtù pari a quella di lei, risolleva il tuo animo dal lutto e comportarti in modo che nessuno ti creda pentita della tua condizione di madre. 20. Per concludere, visto che inevitabilmente, comunque tu decida di comportarti, i tuoi pensieri voleranno a me più di quanto non corrano agli altri tuoi figli (non perché questi ti siano meno cari, ma perché è naturale che si porti spesso la mano laddove più urge il dolore), pensami così: lieto e di buon animo come quando tutto va per il meglio. E tutto va davvero a gonfie vele, perché il mio animo, libero da ogni occupazione, attende alle sue attività più congeniali, e ora si diletta di studi poco impegnativi, ora s’innalza, avido di verità, a contemplare la sua natura e quella dell’universo. Prima studia le terre e la loro distribuzione, poi il comportamento del mare circostante e il suo alterno fluire e rifluire, quindi osserva lo spazio fra la terra e il cielo, pieno di fenomeni spaventosi e agitato da tuoni, fulmini, soffiar di venti, scrosci di piogge, di grandine e di nevi. Infine, dopo aver esplorato le zone meno elevate, si slancia verso le più eccelse e contempla estasiato il meraviglioso spettacolo delle cose divine: allora, memore della sua eternità, passa da un secolo all’altro, immergendosi in tutto ciò che fu e che sarà.
1. Nulla conosciamo di questo zio se non la data della morte, avvenuta intorno al 39 d.C. 2. È L. Anneo Seneca, detto il Vecchio. 3. Sono nomi di isole del Mar Egeo, dove venivano deportati gli esuli. 4. Il Mare Inferiore è il Mar Tirreno, a cui anticamente veniva dato quel nome. 5. Si tratta di Enea, l’eroe troiano, che dopo molto peregrinare approdò in Italia. 6. Non è la Focide, regione della Grecia settentrionale, ma Focea, città della Ionia, i cui abitanti fondarono Marsiglia.
7. Alesia fu la colonia fondata da Silla, Mariana quella fondata da Mario. 8. È Marco Terenzio Varrone (116-27 a.C.), autore di numerose opere, fra cui De lingua latina e De re rustica. 9. Il pensiero attribuito a Bruto, il figlio adottivo di Giulio Cesare e capo della congiura contro di lui, è tratto dalla sua opera De virtute, citata più avanti. 10. I Romani amavano ricordare le umili origini del fondatore della loro città e ne veneravano la sede in cui secondo la leggenda aveva abitato. 11. M. Claudio Marcello fu mandato in esilio da Cesare. Cicerone pronunciò in sua difesa una delle più famose orazioni. 12. Il personaggio è Bruto. 13. Le suppliche erano rivolte a Cesare affinché usasse clemenza a Marcello. 14. Il Fasi è un fiume della Colchide, regione del Mar Nero. 15. Si riferisce alla sfortunata campagna dei Romani guidati da Crasso nel 53 a.C. 16. Un richiamo frequente alle antiche virtù dei padri e alla sobrietà dei loro costumi. 17. Curio Dentato fu console e non dittatore: combatté contro i Sanniti, i Lucani, i Sabini e Pirro, re dell’Epiro. 18. Apicio, il famoso gastronomo autore di molte ricette, visse nel I sec. d.C. 19. Il bando con cui furono allontanati da Roma tutti i filosofi è del 161 a.C. 20. È il noto autore dell’apologo dello stomaco e delle membra, che convinse i plebei ritiratisi sull’Aventino a rientrare a Roma (494 a.C.). 21. Le due figlie di Publio Scipione, stando a Tito Livio, andarono spose a P. Sempronio Nasica e a T. Sempronio Gracco. 22. Le monete dell’antica Roma erano di rame. 23. Non Aristide, ma Focione, lo stratega ateniese accusato ingiustamente di tradimento e condannato a morte. 24. Aurelio Cotta era un politico ragguardevole del I secolo a.C. 25. I fratelli sono Novato e Mela. 26. Marco Lucano (figlio di Mela), autore della Farsaglia. 27. La figlia di Novato. 28. Seneca, nato a Cordova, in Spagna, fu portato a Roma ancora bambino. 29. È Alcesti, la mitica sposa di Admeto, re di Tessaglia, il cui amore spinto sino al sacrificio ispirò i grandi poeti tragici greci, fra cui Euripide.
Consolatio ad Polybium
* * * nostrae compares, firma sunt; si redigas ad condicionem naturae omnia destruentis et unde edidit eodem revocantis, caduca sunt. Quid enim inmortale manus mortales fecerunt? Septem illa miracula et si qua his multo mirabiliora sequentium annorum extruxit ambitio aliquando solo aequata visentur. Ita est: nihil perpetuum, pauca diuturna sunt; aliud alio modo fragile est, rerum exitus variantur, ceterum quidquid coepit et desinet. Mundo quidam minantur interitum et hoc universum quod omnia divina humanaque complectitur, si fas putas credere, dies aliquis dissipabit et in confusionem veterem tenebrasque demerget: eat nunc aliquis et singulas comploret animas, Carthaginis ac Numantiae Corinthique cinerem et si quid aliud altius cecidit lamentetur, cum etiam hoc quod non habet quo cadat sit interiturum; eat aliquis et fata tantum aliquando nefas ausura sibi non pepercisse conqueratur. Quis tam superbae inpotentisque adrogantiae est ut in hac naturae necessitate omnia ad eundem finem revocantis se unum ac suos seponi velit ruinaeque etiam ipsi mundo imminenti aliquam domum subtrahat? Maximum ergo solacium est cogitare id sibi accidisse quod omnes ante se passi sunt omnesque passuri; et ideo mihi videtur rerum natura quod gravissimum fecerat commune fecisse, ut crudelitatem fati consolaretur aequalitas. 2. Illud quoque te non minimum adiuverit, si cogitaveris nihil profuturum dolorem tuum, nec illi quidem quem desideras nec tibi; noles enim longum esse quod inritum est. Nam si quicquam tristitia profecturi sumus, non recuso quidquid lacrimarum fortunae meae superfuit tuae fundere; inveniam etiamnunc per hos exhaustos iam fletibus domesticis oculos quod effluat, si modo id tibi futurum bono est. Quid cessas? Conqueramur, atque adeo ipse hanc litem meam faciam: «Iniquissima omnium iudicio fortuna, adhuc videbaris eum hominem continuo fovisse, qui munere tuo tantam venerationem receperat ut, quod raro ulli contigit, felicitas eius effugeret invidiam. Ecce eum dolorem illi quem salvo Caesare accipere maximum poterat impressisti, et cum bene illum undique circuisses, intellexisti hac parte tantummodo patere ictibus tuis. Quid enim illi aliud faceres? Pecuniam eriperes? Numquam illi obnoxius fuit; nunc quoque quantum potest illam a se abigit et in tanta facilitate adquirendi nullum maiorem ex ea fructum quam contemptum eius petit. Eriperes illi amicos? Sciebas tam amabilem esse ut facile in locum amissorum posset alios substituere; unum enim hunc ex eis quos in principali domo potentes vidi cognovisse videor quem omnibus amicum habere cum expediat, magis tamen etiam libet. Eriperes illi bonam opinionem? Solidior est haec apud eum quam ut a te quoque ipsa concuti possit. Eriperes bonam valetudinem? Sciebas animum eius liberalibus disciplinis, quibus non innutritus tantum sed innatus est, sic esse fundatum ut supra omnis corporis
dolores emineret. Eriperes spiritum? Quantulum nocuisses! Longissimum illi ingeni aevum fama promisit; id egit ipse ut meliore sui parte duraret et compositis eloquentiae praeclaris operibus a mortalitate se vindicaret. Quam diu fuerit ullus litteris honor, quam diu steterit aut latinae linguae potentia aut graecae gratia, vigebit cum maximis viris quorum se ingeniis vel contulit vel, si hoc verecundia eius recusat, adplicuit. Hoc ergo unum excogitasti quomodo maxime illi posses nocere; quo melior est enim quisque, hoc saepius ferre te consuevit sine ullo dilectu furentem et inter ipsa beneficia metuendam. Quantulum erat tibi immunem ab hac iniuria praestare eum hominem in quem videbatur indulgentia tua ratione certa pervenisse et non ex tuo more temere incidisse!». 3. Adiciamus, si vis, ad has querellas ipsius adulescentis interceptam inter prima incrementa indolem. Dignus fuit ille te fratre: tu certe eras dignissimus qui ne ex indigno quidem quicquam doleres fratre. Redditur illi testimonium aequale omnium hominum; desideratur in tuum honorem, laudatur in suum. Nihil in illo fuit quod non libenter agnosceres; tu quidem etiam minus bono fratri fuisses bonus, sed in illo pietas tua idoneam nancta materiam multo se liberius exercuit. Nemo potentiam eius iniuria sensit, numquam ille te fratrem ulli minatus est; ad exemplum se modestiae tuae formaverat cogitabatque quantum tu et ornamentum tuorum esses et onus: suffecit ille huic sarcinae. O dura fata et nullis aequa virtutibus! antequam felicitatem suam nosset, frater tuus exemptus est. Parum autem me indignari scio; nihil est enim difficilius quam magno dolori paria verba reperire. Etiamnunc tamen, si quid proficere possumus, conqueramur: «quid tibi voluisti, tam iniusta et tam violenta fortuna? Tam cito te indulgentiae tuae paenituit? Quae ista crudelitas est in medios fratres impetum facere et tam cruenta rapina concordissimam turbam imminuere? Tam bene stipatam optimorum adulescentium domum, in nullo fratre degenerantem, turbare et sine ulla causa delibare voluisti? Nihil ergo prodest innocentia ad omnem legem exacta, nihil antiqua frugalitas, nihil felicitatis moderatio, nihil in summa potentia summa conservata abstinentia, nihil sincerus et tutus litterarum amor, nihil ab omni labe mens vacans? Luget Polybius et in uno fratre quid de reliquis possit metuere admonitus etiam de ipsis doloris sui solaciis timet. Facinus indignum! luget Polybius et aliquid propitio dolet Caesare! Hoc sine dubio, inpotens fortuna, captasti, ut ostenderes neminem contra te ne a Caesare quidem posse defendi». 4. Diutius accusare fata possumus, mutare non possumus: stant dura et inexorabilia; nemo illa convicio, nemo fletu, nemo causa movet; nihil umquam ulli parcunt nec remittunt. Proinde parcamus lacrimis nihil proficientibus; facilius enim nos illis dolor iste adiciet quam illos nobis reducet; qui si nos torquet, non adiuvat, primo quoque tempore deponendus est et ab inanibus solaciis atque amara quadam libidine dolendi animus recipiendus est. Nam lacrimis nostris nisi ratio finem fecerit, fortuna non faciet. Omnis agedum mortalis circumspice, larga
ubique flendi et adsidua materia est: alium ad cotidianum opus laboriosa egestas vocat, alium ambitio numquam quieta sollicitat, alius divitias quas optaverat metuit et voto laborat suo, alium sollicitudo, alium labor torquet, alium semper vestibulum obsidens turba; hic habere se dolet liberos, hic perdidisse: lacrimae nobis deerunt antequam causae dolendi. Non vides qualem nobis vitam rerum natura promiserit, quae primum nascentium hominum fletum esse voluit? Hoc principio edimur, huic omnis sequentium annorum ordo consentit. Sic vitam agimus, ideoque moderate id fieri debet a nobis quod saepe faciendum est et respicientes quantum a tergo rerum tristium immineat, si non finire lacrimas, at certe reservare debemus. Nulli parcendum est rei magis quam huic cuius tam frequens usus est. 5. Illud quoque te non minimum adiuverit, si cogitaveris nulli minus gratum esse dolorem tuum quam ei cui praestari videtur: torqueri ille te aut non vult aut non intellegit. Nulla itaque eius officii ratio est quod ei cui praestatur, si nihil sentit, supervacuum est, si sentit, ingratum. Neminem esse toto orbe terrarum qui delectetur lacrimis tuis audacter dixerim. Quid ergo? Quem nemo adversus te animum gerit, eum esse tu credis fratris tui, ut cruciatu tui noceat tibi, ut te velit abducere ab occupationibus tuis, id est a studio et a Caesare? Non est hoc simile veri; ille enim indulgentiam tibi tamquam fratri praestitit, venerationem tamquam parenti, cultum tamquam superiori; ille desiderio tibi esse vult, tormento esse non vult. Quid itaque iuvat dolori intabescere quem, si quis defunctis sensus est, finiri frater tuus cupit? De alio fratre, cuius incerta posset voluntas videri, omnia haec in dubio ponerem et dicerem: «sive te torqueri lacrimis numquam desinentibus frater tuus cupit, indignus hoc adfectu tuo est; sive non vult, utrique vestrum inhaerentem dolorem dimitte; nec impius frater sic desiderari debet nec pius sic velit». In hoc vero, cuius tam explorata pietas est, pro certo habendum est nihil esse illi posse acerbius quam si tibi hic casus eius acerbus est, si te ullo modo torquet, si oculos tuos, indignissimos hoc malo, sine ullo flendi fine et conturbat idem et exhaurit. Pietatem tamen tuam nihil aeque a lacrimis tam inutilibus abducet quam si cogitaveris fratribus te tuis exemplo esse debere fortiter hanc fortunae iniuriam sustinendi. Quod duces magni faciunt rebus adfectis, ut hilaritatem de industria simulent et adversas res adumbrata laetitia abscondant ne militum animi, si fractam ducis sui mentem viderint, et ipsi conlabantur, id nunc tibi quoque faciendum est: indue dissimilem animo tuo vultum et, si potes, proice omnem ex toto dolorem, si minus, introrsus abde et contine, ne appareat, et da operam ut fratres tui te imitentur, qui honestum putabunt quodcumque te facientem viderint, animumque ex vultu tuo sument. Et solacium debes esse illorum et consolator; non poteris autem horum maerori obstare, si tuo indulseris. 6. Potest et illa res a luctu te prohibere nimio, si tibi ipse renuntiaveris nihil horum quae facis posse subduci. Magnam tibi personam hominum consensus inposuit: haec tibi tuenda est. Circumstat te omnis ista consolantium frequentia et
in animum tuum inquirit ac perspicit quantum roboris ille adversus dolorem habeat et utrumne tu tantum rebus secundis uti dextere scias an et adversas possis viriliter ferre: obseruantur oculi tui. Liberiora sunt omnia iis quorum adfectus tegi possunt: tibi nullum secretum liberum est. In multa luce fortuna te posuit; omnes scient quomodo te in isto tuo gesseris vulnere, utrumne statim percussus arma summiseris an in gradu steteris. Olim te in altiorem ordinem et amor Caesaris extulit et tua studia eduxerunt; nihil te plebeium decet, nihil humile; quid autem tam humile ac muliebre est quam consumendum se dolori committere? Non idem tibi in luctu pari quod tuis fratribus licet; multa tibi non permittit opinio de studiis ac moribus tuis recepta, multum a te homines exigunt, multum expectant. Si volebas tibi omnia licere, ne convertisses in te ora omnium: nunc tantum tibi praestandum est quantum promisisti. Omnes illi qui opera ingenii tui laudant, qui describunt, quibus, cum fortuna tua opus non sit, ingenio opus est, custodes animi tui sunt. Nihil umquam ita potes indignum facere perfecti et eruditi viri professione ut non multos admirationis de te suae paeniteat. Non licet tibi flere inmodice, nec hoc tantummodo non licet; ne somnum quidem extendere in partem diei licet aut a tumultu rerum in otium ruris quieti confugere aut adsidua laboriosi officii statione fatigatum corpus voluptaria peregrinatione recreare aut spectaculorum varietate animum detinere aut ex tuo arbitrio diem disponere. Multa tibi non licent quae humillimis quoque et in angulo iacentibus licent: magna servitus est magna fortuna. Non licet tibi quicquam arbitrio tuo facere: audienda sunt tot hominum milia, tot disponendi libelli; tantus rerum ex orbe toto coeuntium congestus, ut possit per ordinem suum principis maximi animo subici, exigendus est. Non licet tibi, inquam, flere: ut multos flentes audire possis, ut periclitantium et ad misericordiam mitissimi Caesaris pervenire cupientium, lacrimae tibi tuae adsiccandae sunt. 7. Haec tamen etiamnunc levioribus te remediis adiuvabunt: cum voles omnium rerum oblivisci, Caesarem cogita. Vide quantam huius in te indulgentiae fidem, quantam industriam debeas: intelleges non magis tibi incuruari licere quam illi, si quis modo est fabulis traditus, cuius umeris mundus innititur. Caesari quoque ipsi, cui omnia licent, propter hoc ipsum multa non licent: omnium somnos illius vigilia defendit, omnium otium illius labor, omnium delicias illius industria, omnium vacationem illius occupatio. Ex quo se Caesar orbi terrarum dedicavit, sibi eripuit, et siderum modo, quae inrequieta semper cursus suos explicant, numquam illi licet subsistere nec quicquam suum facere. Ad quendam itaque modum tibi quoque eadem necessitas iniungitur: non licet tibi ad utilitates tuas, ad studia tua respicere. Caesare orbem terrarum possidente impertire te nec voluptati nec dolori nec ulli alii rei potes: totum te Caesari debes. Adice nunc quod, cum semper praedices cariorem tibi spiritu tuo Caesarem esse, fas tibi non est salvo Caesare de fortuna queri: hoc incolumi salvi tibi sunt tui, nihil perdidisti, non tantum siccos oculos tuos esse sed etiam laetos oportet; in hoc tibi omnia sunt, hic pro omnibus est. Quod longe a sensibus tuis prudentissimis
piissimisque abest, adversus felicitatem tuam parum gratus es, si tibi quicquam hoc salvo flere permittis. 8. Monstrabo etiamnunc non quidem firmius remedium sed familiarius. Si quando te domum receperis, tunc erit tibi metuenda tristitia. Nam quam diu numen tuum intueberis, nullum illa ad te inveniet accessum, omnia in te Caesar tenebit; cum ab illo discesseris, tunc velut occasione data insidiabitur solitudini tuae dolor et requiescenti animo tuo paulatim inrepet. Itaque non est quod ullum tempus vacare patiaris a studiis: tunc tibi litterae tuae tam diu ac tam fideliter amatae gratiam referant, tunc te illae antistitem et cultorem suum vindicent, tunc Homerus et Vergilius, tam bene de humano genere meriti quam tu et de omnibus et de illis meruisti, quos pluribus notos esse voluisti quam scripserant, multum tecum morentur: tutum id erit omne tempus quod illis tuendum commiseris. Tunc Caesaris tui opera, ut per omnia saecula domestico narrentur praeconio, quantum potes compone; nam ipse tibi optime formandi condendique res gestas et materiam dabit et exemplum. Non audeo te usque eo producere ut fabellas quoque et Aesopeos logos, intemptatum Romanis ingeniis opus, solita tibi venustate conectas. Difficile est quidem ut ad haec hilariora studia tam vehementer perculsus animus tam cito possit accedere; hoc tamen argumentum habeto iam corroborati eius et redditi sibi, si poterit a severioribus scriptis ad haec solutiora procedere. In illis enim quamvis aegrum eum adhuc et secum reluctantem avocabit ipsa rerum quas tractabit austeritas: haec quae remissa fronte commentanda sunt non feret, nisi cum iam sibi ab omni parte constiterit. Itaque debebis eum severiore materia primum exercere, deinde hilariore temperare. 9. Illud quoque magno tibi erit leuamento, si saepe te sic interrogaveris: «Utrumne meo nomine doleo an eius qui decessit? Si meo, perit indulgentiae iactatio et incipit dolor, hoc uno excusatus quod honestus est, cum ad utilitatem respicit, a pietate desciscere; nihil autem minus bono viro convenit quam in fratris luctu calculos ponere. Si illius nomine doleo, necesse est alterutrum ex his duobus esse iudicem. Nam si nullus defunctis sensus superest, euasit omnia frater meus vitae incommoda et in eum restitutus est locum in quo fuerat antequam nasceretur et expers omnis mali nihil timet, nihil cupit, nihil patitur: quis iste furor est, pro eo me numquam dolere desinere qui numquam doliturus est? Si est aliquis defunctis sensus, nunc animus fratris mei velut ex diutino carcere emissus, tandem sui iuris et arbitrii, gestit et rerum naturae spectaculo fruitur et humana omnia ex loco superiore despicit, divina vero, quorum rationem tam diu frustra quaesierat, propius intuetur. Quid itaque eius desiderio maceror qui aut beatus aut nullus est? Beatum deflere invidia est, nullum dementia». An hoc te movet, quod videtur ingentibus et cum maxime circumfusis bonis caruisse? Cum cogitaveris multa esse quae perdidit, cogita plura esse quae non timet: non ira eum torquebit, non morbus adfliget, non suspicio lacesset, non edax
et inimica semper alienis processibus invidia consectabitur, non metus sollicitabit, non levitas fortunae cito munera sua transferentis inquietabit. Si bene computes, plus illi remissum quam ereptum est. Non opibus fruetur, non tua simul ac sua gratia; non accipiet beneficia, non dabit: miserum putas quod ista amisit, an beatum quod non desiderat? Mihi crede, is beatior est cui fortuna supervacua est quam is cui parata est. Omnia ista bona quae nos speciosa sed fallaci voluptate delectant, pecunia dignitas potentia aliaque complura ad quae generis humani caeca cupiditas obstupescit, cum labore possidentur, cum invidia conspiciuntur, eos denique ipsos quos exornant et premunt; plus minantur quam prosunt; lubrica et incerta sunt, numquam bene tenentur; nam ut nihil de tempore futuro timeatur, ipsa tamen magnae felicitatis tutela sollicita est. Si velis credere altius veritatem intuentibus, omnis vita supplicium est. In hoc profundum inquietumque proiecti mare, alternis aestibus reciprocum et modo adlevans nos subitis incrementis, modo maioribus damnis deferens adsidueque iactans, numquam stabili consistimus loco, pendemus et fluctuamur et alter in alterum inlidimur et aliquando naufragium facimus, semper timemus; in hoc tam procelloso et ad omnes tempestates exposito mari navigantibus nullus portus nisi mortis est. Ne itaque invideris fratri tuo: quiescit. Tandem liber, tandem tutus, tandem aeternus est. Superstitem Caesarem omnemque eius prolem, superstitem te cum communibus habet fratribus. Antequam quicquam ex suo favore fortuna mutaret, stantem adhuc illam et munera plena manu congerentem reliquit. Fruitur nunc aperto et libero caelo; ex humili atque depresso in eum emicuit locum, quisquis ille est qui solutas vinculis animas beato recipit sinu, et nunc libere illic vagatur omniaque rerum naturae bona cum summa voluptate perspicit. Erras: non perdidit lucem frater tuus sed sinceriorem sortitus est. Omnibus illo nobis commune est iter: quid fata deflemus? Non reliquit ille nos sed antecessit. Est, mihi crede, magna felicitas in ipsa necessitate moriendi. Nihil ne in totum quidem diem certi est: quis in tam obscura et involuta veritate divinat utrumne fratri tuo mors inviderit an consuluerit? 10. Illud quoque, qua iustitia in omnibus rebus es, necesse est te adiuvet cogitantem non iniuriam tibi factam quod talem fratrem amisisti, sed beneficium datum quod tam diu tibi pietate eius uti fruique licuit. Iniquus est qui muneris sui arbitrium danti non relinquit, avidus qui non lucri loco habet quod accepit, sed damni quod reddidit. Ingratus est qui iniuriam vocat finem voluptatis, stultus qui nullum fructum esse putat bonorum nisi praesentium, qui non et in praeteritis adquiescit et ea iudicat certiora quae abierunt, quia de illis ne desinant non est timendum. Nimis angustat gaudia sua qui eis tantummodo quae habet ac videt frui se putat, et habuisse eadem pro nihilo ducit; cito enim nos omnis voluptas relinquit, quae fluit et transit et paene antequam veniat aufertur. Itaque in praeteritum tempus animus mittendus est, et quidquid nos umquam delectavit reducendum ac frequenti cogitatione pertractandum est: longior fideliorque est memoria voluptatum quam praesentia. Quod habuisti ergo optimum fratrem, in
summis bonis pone: non est quod cogites quanto diutius habere potueris, sed quam diu habueris. Rerum natura illum tibi sicut ceteris fratres suos non mancipio dedit sed commodavit; cum visum est deinde repetit nec tuam in eo satietatem secuta est sed suam legem. Si quis pecuniam creditam solvisse se moleste ferat, eam praesertim cuius usum gratuitum acceperit, nonne iniustus vir habeatur? Dedit natura fratri tuo vitam, dedit et tibi: quae suo iure usa si a quo voluit debitum suum citius exegit, non illa in culpa est, cuius nota erat condicio, sed mortalis animi spes avida, quae subinde quid rerum natura sit obliviscitur nec umquam sortis suae meminit nisi cum admonetur. Gaude itaque habuisse te tam bonum fratrem, et usum fructumque eius, quamvis brevior voto tuo fuerit, boni consule. Cogita iucundissimum esse quod habuisti, humanum quod perdidisti; nec enim quicquam minus inter se consentaneum est quam aliquem moveri quod sibi talis frater parum diu contigerit, non gaudere quod tamen contigit. 11. «At inopinanti ereptus est». Sua quemque credulitas decipit et in eis quae diligit voluntaria mortalitatis oblivio: natura nulli se necessitatis suae gratiam facturam esse testata est. Cotidie praeter oculos nostros transeunt notorum ignotorumque funera, nos tamen aliud agimus et subitum id putamus esse quod nobis tota vita denuntiatur futurum. Non est itaque ista fatorum iniquitas, sed mentis humanae pravitas insatiabilis rerum omnium, quae indignatur inde se exire quo admissa est precario. Quanto ille iustior qui nuntiata filii morte dignam magno viro vocem emisit: Ego cum genui, tum moriturum scivi. Prorsus non mireris ex hoc natum esse qui fortiter mori posset. Non accepit tamquam novum nuntium filii mortem; quid enim est novi hominem mori, cuius tota vita nihil aliud quam ad mortem iter est? Ego cum genui, tum moriturum scivi. Deinde adiecit rem maioris et prudentiae et animi: et huic rei sustuli. Omnes huic rei tollimur; quisquis ad vitam editur, ad mortem destinatur. Gaudeamus eo quod dabitur, reddamusque id cum reposcemur. Alium alio tempore fata comprendent, neminem praeteribunt: in procinctu stet animus et id quod necesse est numquam timeat, quod incertum est semper expectet. Quid dicam duces ducumque progeniem et multis aut consulatibus conspicuos aut triumphis sorte defunctos inexorabili? Tota cum regibus regna populique cum gentibus tulere fatum suum; omnes, immo omnia in ultimum diem spectant. Non
idem universis finis est: alium in medio cursu vita deserit, alium in ipso aditu relinquit, alium in extrema senectute, fatigatum iam et exire cupientem, vix emittit; alio quidem atque alio tempore, omnes tamen in eundem locum tendimus. Utrumne stultius sit nescio mortalitatis legem ignorare an inpudentius recusare. Agedum illa quae multo ingenii tui labore celebrata sunt in manus sume utriuslibet auctoris carmina, quae tu ita resolvisti ut, quamvis structura illorum recesserit, permaneat tamen gratia (sic enim illa ex alia lingua in aliam transtulisti ut, quod difficillimum erat, omnes virtutes in alienam te orationem secutae sint): nullus erit in illis scriptis liber qui non plurima varietatis humanae incertorumque casuum et lacrimarum ex alia atque alia causa fluentium exempla tibi suggerat. Lege quanto spiritu ingentibus intonueris verbis: pudebit te subito deficere et ex tanta orationis magnitudine desciscere. Ne commiseris ut quisquis exempto modo scripta tua mirabitur quaerat quomodo tam grandia tamque solida tam fragilis animus conceperit. 12. Potius ab istis te quae torquent ad haec tot et tanta quae consolantur converte ac respice optimos fratres, respice uxorem, filium respice: pro omnium horum salute hac tecum portione fortuna decidit. Multos habes in quibus adquiescas: ab hac te infamia vindica, ne videatur omnibus plus apud te valere unus dolor quam haec tam multa solacia. Omnis istos una tecum perculsos vides nec posse tibi subvenire, immo etiam ultro expectare ut a te subleventur intellegis; et ideo quanto minus in illis doctrinae minusque ingeni est, tanto magis obsistere te necesse est communi malo. Est autem hoc ipsum solacii loco, inter multos dolorem suum dividere; qui quia dispensatur inter plures, exigua debet apud te parte subsidere. Non desinam totiens tibi offerre Caesarem: illo moderante terras et ostendente quanto melius beneficiis imperium custodiatur quam armis, illo rebus humanis praesidente non est periculum ne quid perdidisse te sentias; in hoc uno tibi satis praesidii, solacii est. Attolle te, et quotiens lacrimae suboriuntur oculis tuis, totiens illos in Caesarem derige: siccabuntur maximi et clarissimi conspectu numinis; fulgor eius illos, ut nihil aliud possint aspicere, praestringet et in se haerentes detinebit. Hic tibi, quem tu diebus intueris ac noctibus, a quo numquam deicis animum, cogitandus est, hic contra fortunam advocandus. Nec dubito, cum tanta illi adversus omnes suos sit mansuetudo tantaque indulgentia, quin iam multis solaciis tuum istud vulnus obduxerit, iam multa quae dolori obstarent tuo congesserit. Quid porro? Ut nihil horum fecerit, nonne protinus ipse conspectus per se tantummodo cogitatusque Caesar maximo solacio tibi est? Di illum deaeque terris diu commodent. Acta hic divi Augusti aequet, annos vincat! Quam diu inter mortales erit, nihil ex domo sua mortale esse sentiat. Rectorem Romano imperio filium longa fide adprobet et ante illum consortem patris quam successorem aspiciat. Sera et nepotibus demum nostris dies nota sit qua illum gens sua caelo asserat! 13. Abstine ab hoc manus tuas, fortuna, nec in isto potentiam tuam nisi ea
parte qua prodes ostenderis. Patere illum generi humano iam diu aegro et adfecto mederi, patere quidquid prioris principis furor concussit in suum locum restituere ac reponere. Sidus hoc, quod praecipitato in profundum et demerso in tenebras orbi refulsit, semper luceat. Hic Germaniam pacet, Britanniam aperiat, et paternos triumphos ducat et novos; quorum me quoque spectatorem futurum, quae ex virtutibus eius primum optinet locum, promittit clementia. Nec enim sic me deiecit ut nollet erigere, immo ne deiecit quidem, sed inpulsum a fortuna et cadentem sustinuit et in praeceps euntem leniter divinae manus usus moderatione deposuit: deprecatus est pro me senatum et vitam mihi non tantum dedit sed etiam petit. Viderit: qualem volet esse existimet causam meam; vel iustitia eius bonam perspiciat vel clementia faciat bonam: utrumque in aequo mihi eius beneficium erit, sive innocentem me scierit esse sive voluerit. Interim magnum miseriarum mearum solacium est videre misericordiam eius totum orbem pervagantem; quae cum ex hoc ipso angulo in quo ego defixus sum complures multorum iam annorum ruina obrutos effoderit et in lucem reduxerit, non vereor ne me unum transeat. Ipse autem optime novit tempus quo cuique debeat succurrere; ego omnem operam dabo ne pervenire ad me erubescat. O felicem clementiam tuam, Caesar, quae efficit ut quietiorem sub te agant vitam exules quam nuper sub Gaio egere principes! Non trepidant nec per singulas horas gladium expectant nec ad omnem navium conspectum pavent; per te habent ut fortunae saevientis modum ita spem quoque melioris eiusdem ac praesentis quietem. Scias licet ea demum fulmina esse iustissima quae etiam percussi colunt. 14. Hic itaque princeps, qui publicum omnium hominum solacium est, aut me omnia fallunt aut iam recreavit animum tuum et tam magno vulneri maiora adhibuit remedia. Iam te omni confirmavit modo, iam omnia exempla quibus ad animi aequitatem compellereris tenacissima memoria rettulit, iam omnium praecepta sapientium adsueta sibi facundia explicuit. Nullus itaque melius has adloquendi partes occupaverit: aliud habebunt hoc dicente pondus verba velut ab oraculo missa; omnem vim doloris tui divina eius contundet auctoritas. Hunc itaque tibi puta dicere: «Non te solum fortuna desumpsit sibi quem tam gravi adficeret iniuria: nulla domus in toto orbe terrarum aut est aut fuit sine aliqua comploratione. Transibo exempla vulgaria, quae etiam si minora, tamen multa sunt, ad fastus te et annales perducam publicos. Vides omnes has imagines quae inplevere Caesarum atrium? Nulla non harum aliquo suorum incommodo insignis est; nemo non ex istis in ornamentum saeculorum refulgentibus viris aut desiderio suorum tortus est aut a suis cum maximo animi cruciatu desideratus est. Quid tibi referam Scipionem Africanum, cui mors fratris in exilio nuntiata est? Is frater, qui eripuit fratrem carceri, non potuit eripere fato; et quam impatiens iuris et aequi pietas Africani fuerit cunctis apparuit; eodem enim die Scipio Africanus, quo viatoris manibus fratrem abstulerat tribuno quoque plebis privatus intercessit. Tam magno tamen fratrem desideravit hic animo quam defenderat. Quid referam Aemilianum Scipionem, qui uno paene eodemque tempore
spectavit patris triumphum duorumque fratrum funera? Adulescentulus tamen ac propemodum puer tanto animo tulit illam familiae suae super ipsum Pauli triumphum concidentis subitam vastitatem quanto debuit ferre vir in hoc natus, ne urbi Romanae aut Scipio deesset aut Carthago superesset. 15. Quid referam duorum Lucullorum diremptam morte concordiam? Quid Pompeios? Quibus ne hoc quidem saeviens reliquit fortuna, ut una denique conciderent ruina. Vixit Sextus Pompeius primum sorori superstes, cuius morte optime cohaerentis Romanae pacis vincula resoluta sunt, idemque hic vixit superstes optimo fratri, quem fortuna in hoc evexerat, ne minus alte eum deiceret quam patrem deiecerat; et post hunc tamen casum Sextus Pompeius non tantum dolori sed etiam bello suffecit. Innumerabilia undique exempla separatorum morte fratrum succurrunt, immo contra vix ulla umquam horum paria conspecta sunt una senescentia. Sed contentus nostrae domus exemplis ero; nemo enim tam expers erit sensus ac sanitatis ut fortunam ulli queratur luctum intulisse quam sciet etiam Caesarum lacrimas concupisse. Divus Augustus amisit Octaviam sororem carissimam, et ne ei quidem rerum natura lugendi necessitatem abstulit cui caelum destinaverat. Immo vero idem, omni genere orbitatis vexatus, sororis filium successioni praeparatum suae perdidit; denique, ne singulos eius luctus enumerem, et generos ille amisit et liberos et nepotes, ac nemo magis ex omnibus mortalibus hominem esse se dum inter homines erat sensit. Tamen tot tantosque luctus cepit rerum omnium capacissimum eius pectus victorque divus Augustus non gentium tantummodo externarum sed etiam dolorum fuit. Gaius Caesar, divi Augusti avunculi mei nepos, circa primos iuventae suae annos Lucium fratrem carissimum sibi princeps iuventutis principem eiusdem iuventutis amisit in apparatu Parthici belli et graviore multo animi vulnere quam postea corporis ictus est; quod utrumque et piissime idem et fortissime tulit. Ti. Caesar patruus meus Drusum Germanicum patrem meum, minorem natu quam ipse erat fratrem, intima Germaniae recludentem et gentes ferocissimas Romano subicientem imperio in complexu et in osculis suis amisit; modum tamen lugendi non sibi tantum sed etiam aliis fecit ac totum exercitum non solum maestum sed etiam attonitum, corpus Drusi sui sibi vindicantem, ad morem Romani luctus redegit iudicavitque non militandi tantum disciplinam esse servandam sed etiam dolendi. Non potuisset ille lacrimas alienas compescere, nisi prius pressisset suas. 16. M. Antonius avus meus, nullo minor nisi eo a quo victus est, tunc cum rem publicam constitueret et triumvirali potestate praeditus nihil supra se videret, exceptis vero duobus collegis omnia infra se cerneret, fratrem interfectum audivit. Fortuna inpotens, quales ex humanis malis tibi ipsa ludos facis! eo ipso tempore quo M. Antonius civium suorum vitae sedebat mortisque arbiter, M. Antonii frater duci iubebatur ad supplicium. Tulit hoc tamen tam triste vulnus eadem magnitudine animi M. Antonius qua omnia alia adversa toleraverat, et hoc fuit eius lugere, viginti legionum sanguine fratri parentare. Sed ut omnia alia
exempla praeteream, ut in me quoque ipso alia taceam funera, bis me fraterno luctu adgressa fortuna est, bis intellexit laedi me posse, vinci non posse: amisi Germanicum fratrem, quem quomodo amaverim intellegit profecto quisquis cogitat quomodo suos fratres pii fratres ament; sic tamen adfectum meum rexi ut nec relinquerem quicquam quod exigi deberet a bono fratre, nec facerem quod reprehendi posset in principe». Haec ergo puta tibi parentem publicum referre exempla, eundem ostendere quam nihil sacrum intactumque sit fortunae, quae ex eis penatibus ausa est funera ducere ex quibus erat deos petitura. Nemo itaque miretur aliquid ab illa aut crudeliter fieri aut inique; potest enim haec adversus privatas domos ullam aequitatem nosse aut ullam modestiam cuius inplacabilis saevitia totiens ipsa funestavit pulvinaria? Faciamus licet illi convicium non nostro tantum ore sed etiam publico, non tamen mutabitur; adversus omnis se preces omnisque querimonias eriget. Hoc fuit in rebus humanis fortuna, hoc erit: nihil inausum sibi reliquit, nihil intactum relinquet; ibit violentior per omnia, sicut solita est semper, eas quoque domos ausa iniuriae causa intrare in quas per templa aditur, et atram laureatis foribus induet vestem. Hoc unum optineamus ab illa votis ac precibus publicis, si nondum illi genus humanum placuit consumere, si Romanum adhuc nomen propitia respicit: hunc principem lassis hominum rebus datum, sicut omnibus mortalibus, sibi esse sacratum velit; discat ab illo clementiam fiatque mitissimo omnium principum mitis. 17. Debes itaque eos intueri omnes quos paulo ante rettuli, aut adscitos caelo aut proximos, et ferre aequo animo fortunam ad te quoque porrigentem manus, quas ne ab eis quidem per quos iuramus abstinet; debes illorum imitari firmitatem in perferendis et evincendis doloribus, in quantum modo homini fas est per divina ire vestigia. Quamvis in aliis rebus dignitatum ac nobilitatum magna sint discrimina, virtus in medio posita est: neminem dedignatur qui modo dignum se illa iudicat. Optime certe illos imitaberis qui, cum indignari possent non esse ipsos exsortes huius mali, tamen in hoc uno se ceteris exaequari hominibus non iniuriam sed ius mortalitatis iudicaverunt tuleruntque nec nimis acerbe et aspere quod acciderat nec molliter et effeminate; nam et non sentire mala sua non est hominis et non ferre non est viri. Non possum tamen, cum omnes circumierim Caesares quibus fortuna fratres sororesque eripuit, hunc praeterire ex omni Caesarum numero excerpendum, quem rerum natura in exitium opprobriumque humani generis edidit, a quo imperium adustum atque eversum funditus principis mitissimi recreat clementia. C. Caesar amissa sorore Drusilla, is homo qui non magis dolere quam gaudere principaliter posset, conspectum conversationemque civium suorum profugit, exequiis sororis suae non interfuit, iusta sorori non praestitit, sed in Albano suo tesseris ac foro et †pervocatis† et huiusmodi aliis occupationibus acerbissimi funeris elevabat mala. Pro pudor imperii! principis Romani lugentis sororem alea solacium fuit! Idem ille Gaius furiosa inconstantia modo barbam capillumque
summittens modo Italiae ac Siciliae oras errabundus permetiens et numquam satis certus utrum lugeri vellet an coli sororem, eodem omni tempore quo templa illi constituebat ac pulvinaria eos qui parum maesti fuerant crudelissima adficiebat animadversione; eadem enim intemperie animi adversarum rerum ictus ferebat qua secundarum elatus eventu super humanum intumescebat modum. Procul istud exemplum ab omni Romano sit viro, luctum suum aut intempestivis avocare lusibus aut sordium ac squaloris foeditate inritare aut alienis malis oblectare minime humano solacio. 18. Tibi vero nihil ex consuetudine mutandum est tua, quoniam quidem ea instituisti amare studia quae et optime felicitatem extollunt et facillime minuunt calamitatem eademque et ornamenta maxima homini sunt et solacia. Nunc itaque te studiis tuis inmerge altius, nunc illa tibi velut munimenta animi circumda, ne ex ulla tui parte inveniat introitum dolor. Fratris quoque tui produc memoriam aliquo scriptorum monumento tuorum; hoc enim unum est in rebus humanis opus cui nulla tempestas noceat, quod nulla consumat vetustas. Cetera, quae per constructionem lapidum et marmoreas moles aut terrenos tumulos in magnam eductos altitudinem constant, non propagant longam diem, quippe et ipsa intereunt: inmortalis est ingeni memoria. Hanc tu fratri tuo largire, in hac eum conloca; melius illum duraturo semper consecrabis ingenio quam inrito dolore lugebis. Quod ad ipsam fortunam pertinet, etiam si nunc agi apud te causa eius non potest – omnia enim illa quae nobis dedit ob hoc ipsum quod aliquid eripuit invisa sunt – tunc tamen erit agenda cum primum aequiorem te illi iudicem dies fecerit; tunc enim poteris in gratiam cum illa redire. Nam multa providit quibus hanc emendaret iniuriam, multa etiamnunc dabit quibus redimat; denique ipsum quod abstulit ipsa dederat tibi. Noli ergo contra te ingenio uti tuo, noli adesse dolori tuo. Potest quidem eloquentia tua quae parva sunt adprobare pro magnis, rursus magna attenuare et ad minima deducere; sed alio ista vires servet suas, nunc tota se in solacium tuum conferat. Et tamen dispice ne hoc iam quoque ipsum sit supervacuum; aliquid enim a nobis natura exigit, plus vanitate contrahitur. Numquam autem ego a te ne ex toto maereas exigam. Et scio inveniri quosdam durae magis quam fortis prudentiae viros qui negent doliturum esse sapientem: hi non videntur mihi umquam in eiusmodi casum incidisse, alioqui excussisset illis fortuna superbam sapientiam et ad confessionem eos veri etiam invitos compulisset. Satis praestiterit ratio, si id unum ex dolore quod et superest et abundat exciderit: ut quidem nullum omnino esse eum patiatur nec sperandum ulli nec concupiscendum est. Hunc potius modum servet qui nec impietatem imitetur nec insaniam et nos in eo teneat habitu qui et piae mentis est nec motae: fluant lacrimae, sed eaedem et desinant, trahantur ex imo gemitus pectore, sed idem et finiantur; sic rege animum tuum ut et sapientibus te adprobare possis et fratribus. Effice ut frequenter fratris tui memoriam tibi velis occurrere, ut illum et sermonibus celebres et adsidua recordatione repraesentes tibi, quod ita demum consequi poteris, si tibi memoriam eius iucundam magis quam flebilem feceris;
naturale est enim ut semper animus ab eo refugiat ad quod cum tristitia revertitur. Cogita modestiam eius, cogita in rebus agendis sollertiam, in exequendis industriam, in promissis constantiam. Omnia dicta eius ac facta et aliis expone et tibimet ipse commemora. Qualis fuerit cogita qualisque sperari potuerit; quid enim de illo non tuto sponderi fratre posset? Haec, utcumque potui, longo iam situ obsoleto et hebetato animo composui. Quae si aut parum respondere ingenio tuo aut parum mederi dolori videbuntur, cogita quam non possit is alienae vacare consolationi quem sua mala occupatum tenent, et quam non facile latina ei homini verba succurrant quem barbarorum inconditus et barbaris quoque humanioribus gravis fremitus circumsonat.
Consolazione a Polibio
Premessa Polibio era il potente segretario e consigliere dell’imperatore Claudio, il liberto a libellis, incaricato di esaminare e giudicare le pratiche che giungevano da tutto il mondo. Secondo Svetonio era il liberto a studiis, l’archivista imperiale. Molto odiato dal popolo, che non ne sopportava lo strapotere, fu uno degli amanti di Messalina, che lo fece uccidere nel 47. Su questa consolatoria sono stati espressi dei dubbi, soprattutto perché contiene una smaccata adulazione dell’imperatore, a cui Seneca si rivolge indirettamente per ottenere il ritorno in patria. La morte di un fratello di Polibio avrebbe dunque offerto al filosofo il pretesto per chiedere la grazia. La supplica è molto scoperta e non fa onore a Seneca, tanto più dopo le sue dichiarazioni sulla sopportabilità dell’esilio e sulla sua condizione di uomo felice e sereno che vive nella contemplazione delle cose divine. Per questo motivo alcuni, fra cui Diderot, hanno negato l’autenticità di questa consolatoria. Anche qui ricorrono i temi dell’ineluttabilità del destino e dell’inutilità del dolore, nonché l’esortazione a sopportare coraggiosamente le avversità della vita. La supplica e le lodi all’imperatore sono introdotte in modo apparentemente spontaneo e naturale (molto può l’oratoria in certi casi). Prima di entrare nell’argomento che più gli preme, la grazia per il ritorno, Seneca, indicando a Polibio il rimedio più valido al suo dolore per la morte del fratello, gli dice: «Finché Cesare continuerà a governare il mondo, dimostrando quanto i benefìci concessi ai popoli valgano più delle armi a mantenere su di esso il comando, finché egli continuerà a presiedere ai destini dell’umanità, non ci sarà pericolo che tu ti accorga di aver perduto qualcosa: in lui solo troverai sufficiente difesa e sufficiente conforto. Risollevati, dunque, e ogni volta che gli occhi ti si riempiranno di lacrime, volgili a Cesare, ed essi si asciugheranno alla vista di quel sommo e fulgido dio». Poi, dopo un elenco delle benemerenze di Claudio, «balsamo a questa umanità già così lungamente ammalata e sofferente», Seneca arriva al punto e scrive: «La sua clemenza, che è la prima delle sue virtù, mi fa bene sperare. Egli, infatti, non mi ha abbattuto per non farmi più rialzare, anzi, non mi ha nemmeno abbattuto, mi ha sorretto quando, colpito dalla sorte, stavo cadendo e mentre precipitavo ha steso la sua mano divina abituata alla moderazione e dolcemente mi ha deposto a terra e, implorato il Senato in mio favore, mi concesse la vita. Ora giudichi lui, valuti la mia causa come ritiene opportuno: se la sua giustizia non la considera buona, sia la sua clemenza a renderla tale. Da parte mia farò di tutto affinché lui non debba arrossire di giungere sino a me». M. S. A.
1. [Le opere create dall’uomo]1 in confronto alla nostra vita sono durature, ma in rapporto alle leggi della natura, che distrugge tutte le cose riconducendole al nulla da cui le ha tratte, sono anch’esse caduche. Cos’hanno creato infatti di immortale le mani mortali? Le sette meraviglie e le opere più stupende che l’ambizione delle età successive ha saputo e saprà ancora innalzare le vedremo un giorno rase al suolo. È così: non c’è nulla di eterno, poche cose sono durevoli, ciascuna, in vario modo, è caduca e giunge a una sua particolare conclusione, ma tutto ciò che ha un principio è destinato a perire. C’è chi paventa anche la fine del mondo: un giorno – se così è lecito credere – questo universo, che abbraccia tutte le cose umane e divine, si dissolverà e sarà nuovamente sommerso nell’antico caos e nel buio primordiale. E noi piangiamo le morti di
singoli esseri, versiamo lacrime sulle ceneri di Cartagine, di Numanzia, di Corinto o di altre città crollate da un’altezza ancora maggiore, quando l’intero universo, che non ha dove cadere, un giorno rovinerà! Ci lamentiamo perché quel destino che oserà compiere un tale scempio non ha alcun riguardo per noi! Di fronte a questa legge di necessità implicita nella natura stessa, che riconduce tutte le cose a una medesima fine, chi sarà tanto superbo e arrogante da pretendere che lui solo, insieme ai suoi familiari, venga risparmiato e che da una catastrofe, che incombe sull’intero universo, si salvi una qualche dimora? Pensiamo, dunque – e ciò ci sia di grandissimo conforto – che a noi capiterà quel ch’è accaduto o accadrà a tutti quanti gli altri, sicché credo di poter dire che la natura ci ha resi tutti parimenti soggetti alla più dura delle sue leggi proprio perché questa uguaglianza ci consolasse della crudeltà del nostro destino. 2. Anche questo potrà esserti di non piccolo aiuto, il fatto che il tuo dolore non gioverà a nessuno, né a te, né alla persona che piangi, dunque a che serve prolungare una cosa sterile e vana? Se il nostro pianto potesse produrre qualcosa io non esiterei a versare per la tua sventura tutte le lacrime che mi restano dopo aver pianto la mia: potrei infatti trovarne ancora che scorrano attraverso questi occhi ormai esausti per i miei tanti lutti familiari, se ciò potesse in qualche modo giovarti. Su, non cessare di piangere, anzi, piangiamo insieme, e facciamo causa comune, con questo capo d’accusa: «Tu, per giudizio unanime, iniquissima sorte, che sino a poco fa sembravi aver favorito quest’uomo mantenendogli una tale venerazione che la sua felicità – cosa rara per un uomo – era sfuggita all’invidia, hai avuto l’ardire d’infliggergli, sotto il regno di Cesare!, il più grande dolore che potesse capitargli. Dopo averlo ben bene esaminato girandogli intorno, hai capito che questa era l’unica parte che potevi colpire. Quale altro malanno, infatti, avresti potuto assegnargli? Portargli via il suo denaro? Non ne è stato mai schiavo, e anche ora, per quanto gli è possibile, se ne tiene lontano e, pur potendo procurarsene con molta facilità, il maggior vantaggio che ne ricava nei suoi confronti è il disprezzo. Potevi forse togliergli gli amici? No: sapevi ch’era così benvoluto da poterne trovare facilmente altri con cui sostituire quelli perduti. Fra quanti ho visto acquistare potere e ricchezza nel palazzo imperiale solo costui era corteggiato più che per interesse per il puro piacere dell’amicizia. Potevi togliergli la buona reputazione? La sua è così solida che nemmeno tu avresti potuto intaccarla. La buona salute? Sapevi che il suo animo era talmente imbevuto di studi umanistici, non solo perché se n’era nutrito ma perché ne aveva una vocazione innata, da essere in grado di vincere ogni dolore fisico. La vita, forse? Lo avresti appena scalfito: la fama del suo ingegno gli ha già accordato l’immortalità, ed è lui stesso ad aver fatto in modo di sopravvivere nella sua parte migliore, affrancandosi dalla morte, con la composizione di splendide opere letterarie. Finché le lettere saranno in qualche modo onorate, fintantoché resterà il vigore della lingua latina o l’eleganza di quella greca, egli vivrà, insieme a quei sommi uomini di cui ha emulato l’ingegno, o – vista la sua
modestia – ai quali si è ispirato. Dunque tu hai escogitato la sola cosa che potesse nuocergli al massimo. Ma quanto più si è buoni, tanto più ci si abitua a sopportarti, perché tu non scegli le tue vittime ma colpisci alla cieca e sai farti temere anche quando elargisci dei benefìci. Non ti costava nulla risparmiare questa ingiuria a un uomo sul quale sembrava che tu avessi rivolto il tuo favore a ragion veduta, non a caso, com’è tuo costume!». 3. A queste lagnanze, se credi, possiamo aggiungerne un’altra, quella, cioè, di una vita stroncata nel periodo dell’adolescenza, al suo primo fiorire, e tuo fratello, già allora, si mostrava degno di te; anche se tu certamente non meritavi di soffrire un tale dolore nemmeno per un fratello indegno. Ora tutti unanimemente gli rendono testimonianza; lo rimpiangono in tuo onore e lo lodano per i suoi meriti. Tutto ciò ch’egli faceva o pensava trovava sempre la tua sincera approvazione, per quanto tu, a dire il vero, saresti stato così benevolo anche con un fratello meno buono; ma il tuo affetto per lui poté esprimersi in modo libero e spontaneo per una sorta di affinità elettiva che vi accomunava. Nessuno mai si sentì offeso da lui per una sua presunta superiorità, né lui, da parte sua, minacciò mai qualcuno approfittando dell’autorità del fratello: si era formato sull’esempio della tua discrezione e sapeva quanto tu fossi un vanto per i tuoi, ma anche un onere da parte loro, e questo peso egli assunse sopra di sé. O dura sorte, ingiusta di fronte a ogni virtù! Tuo fratello fu strappato alla vita prima di poter conoscere la sua felicità, e ciò m’indigna a tal punto che mi riesce difficile esprimere con parole appropriate un così grande dolore. A questo punto, però, se ciò può consolarci, lamentiamoci insieme: «Cosa pensavi di guadagnarci, o Sorte ingiusta e violenta? Tanto presto ti sei pentita della tua benevolenza? Che crudeltà è la tua? T’intrometti con prepotenza fra due fratelli e dimezzi con una rapina così sanguinosa una coppia affiatatissima? Hai voluto turbare e intaccare senza alcun motivo una famiglia piena di ottimi giovani dove nessun fratello tralignava. A nulla giova, dunque, l’integrità morale di chi osserva con scrupolo tutte le leggi, a nulla una vita vissuta frugalmente secondo il costume degli avi, il disinteresse mantenuto intatto anche al colmo del potere e della prospera fortuna, a nulla il retto e sincero amore delle lettere, una mente immune da ogni macchia? Polibio piange e, spinto dalla morte di un fratello a pensare a ciò che può accadere anche agli altri, teme pure per questi, che sono l’unico conforto al suo dolore! Quale indegno misfatto! Polibio piange e si dispera, pur essendo benvoluto da Cesare! Hai proprio colto questa occasione, insolente Fortuna, per dimostrare che contro di te non c’è difesa, nemmeno per chi gode dei favori di Cesare». 4. Possiamo lanciare al destino tutte le accuse che vogliamo, ma cambiarlo giammai: fermo e inflessibile resta, nella sua cruda realtà. Ingiurie, pianti, querele: niente e nessuno lo smuove, niente e nessuno egli risparmia, nessuna grazia concede. Asteniamoci dunque dalle lacrime, che non servono a nulla: un
dolore come questo è più facile che conduca noi tra i morti, piuttosto che i morti fra noi. Se invece di giovarci ci tormenta, dobbiamo desistere al più presto e liberare l’animo dagli sfoghi inutili e dall’amaro compiacimento del pianto. E chi se non la ragione può porre fine alle nostre lacrime? Non sarà certo il destino a farle cessare. Su, guarda gli uomini che ti stanno intorno, osserva, dovunque, incessante, quanta larga messe di pianto! C’è chi, costretto da una penosa povertà, è chiamato giorno dopo giorno a un faticoso lavoro, chi è sempre sotto il pungolo di un’ambizione che non si appaga mai, chi teme per le sue ricchezze che ha tanto desiderato e di cui perpetua il desiderio in uno stato d’ansia continuo; c’è chi è tormentato dalla solitudine, chi dal successo o dalla folla che sempre assedia l’ingresso della sua casa; chi si duole di aver figli e chi di averli perduti. I motivi, insomma, sono tanti che cesseremmo di piangere prima di elencarli tutti. Non vedi che genere di esistenza ci promette la natura, quando la nostra vita inizia con un pianto? È così che veniamo al mondo, e su quel primo pianto si accordano tutta la serie degli anni successivi. Così passiamo la vita. Dobbiamo dunque fare con moderazione ciò che ci tocca fare spesso: risparmiare le lacrime, dal momento che non possiamo sopprimerle di fronte alle tante sventure che incombono alle nostre spalle. Non c’è cosa che più meriti di essere risparmiata, visto che ne facciamo un uso così frequente. 5. Può esserti di grande aiuto anche il riflettere che la persona a cui meno è gradito il tuo dolore è proprio quella per la quale dimostri di soffrire, o perché non vuole che tu patisca per lei, o perché non ne sa nulla. E non è affatto ragionevole un’esternazione che al destinatario risulta o sgradita, quando gli giunga, direttamente o indirettamente, o del tutto inutile, quando non ne sia a conoscenza. Ti dirò con tutta franchezza che nel mondo intero non c’è una sola persona che si compiaccia delle tue lacrime. E allora? Vuoi attribuire a tuo fratello un sentimento che nessun altro prova verso di te, ovverosia la volontà di nuocerti facendoti soffrire e tenendoti per questo lontano dalle tue occupazioni, dallo studio e da Cesare stesso? È assurdo! Egli, infatti, non solo ti ha sempre amato come un fratello, ma ti ha anche venerato come un padre e onorato come un superiore. Vuole dunque essere per te un rimpianto, non un tormento. A che serve consumarsi in un dolore che, se i morti hanno ancora coscienza di noi, tuo fratello desidera che finisca? Se si trattasse di un fratello di cui non conoscessi bene i sentimenti, metterei in discussione tutto questo mio discorso e direi: «Se desidera che tu ti tormenti, piangendo senza fine, tuo fratello è indegno di tanto affetto; ma se non lo vuole, poni fine a un dolore che vi tormenta entrambi, poiché un fratello indegno non merita d’essere rimpianto così e un fratello buono non può volerlo». Ma quanto a questo tuo fratello, il cui affetto è ben conosciuto, dobbiamo essere certi che nulla gli è più penoso del sapere che tu soffri per la sua morte, o che comunque te ne lamenti, e che un pianto senza fine affligge e stanca i tuoi occhi che non meritano questa sofferenza. Tuttavia, poiché sei tanto sensibile agli affetti, non c’è cosa che possa distoglierti da queste tue lacrime,
anche se inutili, quanto il pensiero che devi essere di esempio ai tuoi fratelli, sopportando con coraggio questa ingiuria della sorte. Devi comportarti come i grandi condottieri, che nelle situazioni difficili simulano deliberatamente il buon umore nascondendo le loro preoccupazioni dietro una finta serenità, affinché l’animo dei soldati non si avvilisca nel veder vacillare quello del loro comandante. Assumi dunque un atteggiamento che dissimuli i tuoi sentimenti, anzi, se ne sei capace, liberati del tutto dal tuo dolore, o per lo meno nascondilo e cerca di tenertelo dentro, in modo che i tuoi fratelli, non vedendolo, facciano altrettanto, giudicando giusto il tuo agire e conformando l’animo al tuo aspetto esteriore. Tu per i tuoi fratelli devi essere conforto e consolatore insieme: se indulgi al tuo dolore non sei in grado di contrastare il loro. 6. C’è anche un’altra cosa che può trattenerti da uno sfogo eccessivo del tuo dolore, la consapevolezza che nessuna delle tue azioni può restare nascosta, visto che, per consenso unanime, rivesti una carica molto importante, da conservare in modo degno e rispettabile. Sei circondato da una gran folla di persone che fanno a gara per consolarti, ma che al tempo stesso scrutano il tuo animo per vedere quanta forza tu abbia contro il dolore, se sai solo sfruttare abilmente le occasioni propizie o se sei anche capace di sopportare virilmente le avversità; e ti osservano, se mai dai tuoi occhi trapeli un cenno, un sospetto. Chi può nascondere agli altri i propri sentimenti è certamente più libero, ma tu non hai questa libertà, neppure per i tuoi segreti privati, poiché il tuo successo pubblico ti ha messo pienamente in luce. Così tutti sapranno come hai reagito a questa ferita, se cioè, appena colpito, hai abbassato le armi o sei rimasto a piè fermo. Da tempo l’amicizia di Cesare ti ha innalzato a un gradino sociale più alto e i tuoi studi ti hanno reso famoso, perciò non ti si addice un atteggiamento mediocre o volgare, e nulla è così umiliante e tipicamente femminile quanto il lasciarsi consumare dal dolore. Pur colpito dal medesimo lutto, non puoi permetterti ciò che è concesso ai tuoi fratelli. Tante cose non si conciliano con la stima che tutti hanno della tua cultura e dei tuoi costumi: gli uomini esigono e si aspettano molto da te. Se volevi poter agire liberamente, secondo i tuoi desideri, non dovevi importi all’attenzione di tutti; ora devi mantenere quanto hai promesso. Il tuo animo è nelle mani di coloro che lodano le opere del tuo ingegno, che le trascrivono, che hanno bisogno della tua intelligenza, non già della tua fortuna, sicché non puoi fare alcuna cosa che contrasti col tuo ruolo di uomo colto e perfetto, diversamente molti potrebbero pentirsi di averti ammirato. E non solo non ti è concesso di piangere smodatamente, ma non puoi nemmeno protrarre il sonno sino al mattino avanzato, fuggire il traffico convulso degli affari ritirandoti nella tranquilla quiete della campagna, ristorare con un viaggio di piacere il tuo corpo affaticato dai continui impegni di lavoro, distrarti la mente con questo o quello spettacolo, o disporre la giornata a tuo piacimento. Sono tante le cose a cui non hai diritto e che possono invece permettersi le persone comuni, che hanno un luogo appartato in cui rincantucciarsi: una grande
fortuna è una grande schiavitù. Nulla puoi fare a tuo piacimento: devi ricevere migliaia di persone, esaminare altrettante richieste, sbrigare l’enorme cumulo di pratiche che arrivano da tutto il mondo per sottoporle, in ordine di precedenza, all’esame del sommo principe. In poche parole, piangere a te non è permesso: per prenderti a cuore le molte lacrime di coloro che ti chiedono udienza, che sono in bilico fra la vita e la morte e si affidano alla misericordia del più clemente fra gl’imperatori, devi asciugare le tue. 7. E ora ascolta quali rimedi possano più agevolmente giovarti. Quando vuoi azzerare tutte le tue preoccupazioni, pensa a Cesare, considera quanta devozione e quanto impegno gli devi in cambio della sua benevolenza e ti renderai conto che non puoi piegarti sotto il peso del tuo dolore più di colui che, per dirla col mito, regge il mondo sulle sue spalle.2 Del resto anche Cesare non può permettersi tutto, proprio perché tutto è in suo potere: deve cioè difendere con le sue veglie i nostri sonni, assicurare con la sua fatica la nostra tranquillità, col suo lavoro i nostri divertimenti, col suo impegno il nostro tempo libero. Da quando si è dedicato al mondo ha rinunciato a sé stesso e, come le stelle percorrono senza tregua le proprie orbite, così lui non può mai fermarsi o fare alcunché che lo riguardi. Entro certi limiti, anche tu sei soggetto a una analoga legge di necessità. Fintantoché Cesare è padrone del mondo non ti è concesso pensare ai tuoi interessi e ai tuoi bisogni privati, non puoi abbandonarti né al piacere, né al dolore, né ad altra cosa alcuna: tu devi a Cesare tutto te stesso. E poiché vai ripetendo che Cesare ti è più caro della tua vita stessa, non ti è lecito lamentarti della tua sorte, finché Cesare è vivo. Salvo lui, sono salvi tutti i tuoi cari, e tu nulla hai perduto. Perciò i tuoi occhi non solo devono essere asciutti, ma anche sprizzare di gioia. Ogni tua cosa è in lui, ed egli è tutto, per te. Quanto saresti in contrasto con la tua saggezza e con la tua bontà, e poco grato alla tua fortuna, se ti permettessi di emettere un solo lamento mentre Cesare è in vita! 8. Voglio indicarti anche un altro rimedio, non dico più efficace, ma più a portata di mano. Ogni volta che rientri in casa tua devi stare attento a non lasciarti prendere dalla tristezza: finché infatti sarai in presenza del tuo dio, ne sarai immune, perché Cesare impegnerà ogni tuo moto e ogni tuo pensiero, ma quando ti allontanerai da lui il dolore, approfittando di quella occasione, insidierà la tua solitudine e a poco a poco si insinuerà nel tuo animo inoperoso. Perciò non devi mai concedere un momento di tregua ai tuoi studi, e sarà soprattutto allora che le lettere, da te amate così lungamente e con tanta fedeltà, ti ricompenseranno, proclamandoti loro cultore e sacerdote; sarà allora che Omero e Virgilio – benemeriti dell’umanità come tu lo sei nei confronti di loro e di tutti quelli che hai voluto far conoscere a molti più popoli di quelli per i quali essi avevano scritto – si intratterranno a lungo con te: nulla dovrai temere nei momenti in cui ti troverai sotto la loro protezione. Descrivi allora, con quanta cura ti è possibile, le imprese del tuo Cesare, affinché siano tramandate per tutti i
secoli attraverso la voce di un suo familiare: egli stesso ti fornirà la materia e il modello per dar forma e struttura a quell’opera. Non oso spingermi al punto da consigliarti di comporre, con l’eleganza che ti è consueta, anche favolette e racconti alla maniera di Esopo, un genere in cui nessuno scrittore romano si è ancora cimentato:3 è difficile, infatti, che un animo così duramente colpito possa dedicarsi subito a queste frivolezze. Ma se saprai passare da opere più impegnative ad altre più leggere sarà questa la prova che hai riacquistato le tue forze e il dominio su te stesso. Le prime, infatti, per la serietà dei loro contenuti, distrarranno il tuo animo, benché ancora afflitto e riluttante, mentre le altre, i cui argomenti vanno affrontati con la fronte distesa, libera da preoccupazioni, bisogna che tu le lasci da parte finché non ti sarai ristabilito del tutto. Inizialmente, dunque, tieni la tua mente impegnata su temi più seri, dopodiché potrai rilassarla con argomenti più leggeri. 9. Potrà esserti di grande sollievo anche questa costante riflessione: «Per chi soffro, per me o per il morto? Se mi dolgo per me non posso menar vanto del mio affetto, perché il dolore vale solo se è nobile e distaccato, mentre se chi lo prova soddisfa in qualche modo un suo bisogno interiore non ha niente a che vedere con la compassione: è come ricevere un tornaconto dalla morte di un fratello, e ciò non è da galantuomini. Se invece mi dolgo per lui, due sono le ipotesi, dalle quali non si scappa: o i morti non hanno coscienza, e quindi mio fratello si è liberato da tutti gl’inconvenienti della vita ed è tornato laddove si trovava prima di nascere, sicché, essendo immune da ogni male, non teme, non desidera e non soffre nulla, e allora è una pazzia continuare a piangere per uno che non soffre; oppure con la morte la coscienza non si perde, e allora l’anima di mio fratello, come uscita da una lunga prigionia, è divenuta finalmente libera e padrona di sé e quindi gode dello spettacolo della natura, contempla dall’alto tutte le cose umane e penetra più da vicino quelle divine, di cui aveva invano ricercato a lungo una spiegazione. Perché, dunque, devo consumarmi nel rimpianto di uno che o è beato o è svanito nel nulla? Piangere chi è felice è invidia, piangere il nulla è follia». O forse ti rattristi perché gli mancano tutti quei grandi beni che lo circondavano? Ebbene, se così credi, rifletti che sono molto più numerosi i mali a cui è sfuggito. L’ira, per esempio, non lo tormenterà più, non lo affliggeranno le malattie, non lo assalirà il sospetto, non lo perseguiterà l’invidia vorace e sempre nemica dei successi altrui, non lo turberà il timore, non lo inquieterà la volubilità della fortuna, che trasferisce i suoi favori di qua e di là. A conti fatti, i guai da cui si è liberato sono più numerosi dei beni che ha perduto. D’accordo, non gioirà più delle ricchezze e del prestigio di cui godevate entrambi, non riceverà benefìci e non ne farà; ma tu lo reputi infelice perché ha perduto queste cose, o felice perché non le desidera più? Credimi, chi può fare a meno della fortuna è più contento di chi ce l’ha a portata di mano. Tutti questi beni che ci dànno un piacere illusorio, il denaro, l’autorità, il potere e tante altre cose di
fronte a cui la cieca cupidigia degli uomini rimane estasiata, costano fatica a mantenersi, suscitano invidia e finiscono con l’assillare proprio coloro che ne fanno mostra, più che un vantaggio sono un’ansia continua per i rischi che comportano, instabili e sfuggenti, non si godono mai con sicurezza, e anche se costituiscono una garanzia per il futuro la tutela di una così grande fortuna è fonte di ansie continue e continue preoccupazioni. Se vuoi credere a chi sa vedere più a fondo la verità, tutta la vita è un supplizio. Gettàti in questo mare profondo e tempestoso, agitato da continui marosi che ora ci sollevano ad altezze impreviste, ora ci buttano giù, causandoci più perdite che guadagni, siamo sballottati senza tregua e senza un approdo in cui sostare, sospesi e fluttuanti, sbattiamo gli uni contro gli altri, talvolta facciamo naufragio, ma ne abbiamo sempre timore. Per chi naviga in questo mare così burrascoso e aperto a tutte le intemperie non c’è altro porto che la morte. Non compiangere dunque tuo fratello: egli riposa, finalmente libero, finalmente eterno e sicuro. Dietro di sé lascia vivo Cesare con tutta la sua prole, lascia vivo te con gli altri tuoi fratelli: prima che la fortuna volgesse altrove i suoi favori e mentre ancora gli elargiva a piene mani i suoi doni, egli l’ha abbandonata. Ora gode del cielo libero e aperto. Dal luogo più umile e basso è volato in quello che accoglie nel suo felice seno le anime sciolte dalle catene: non importa quale sia quel luogo, egli vaga libero lassù e contempla con infinita gioia tutti i beni della natura. Sbagli dunque: tuo fratello non ha perso la vita, ne ha trovata una più pura. Siamo tutti in cammino verso quel luogo comune. Perché piangere la sua morte? Egli non ci ha lasciati: ci ha preceduti. Credimi, grande felicità è morire nel pieno della felicità. Nessuna cosa è sicura, neppure nello spazio di un giorno. Chi può indovinare, in una verità così oscura e intricata, se la morte di tuo fratello sia stata una cattiveria o una provvidenza? 10. Visto poi che valuti ogni cosa secondo giustizia, potrà giovarti anche questa riflessione, che con la perdita di un tale fratello non hai ricevuto un torto, al contrario, ti è stato fatto un grande favore poiché hai potuto godere a lungo del suo affetto. Ingiusto è colui che non lascia a chi vuol donare qualcosa la scelta del regalo, avido chi non considera un guadagno il dono ricevuto e una perdita la sua restituzione. È ingrato chi giudica un’offesa la fine di un piacere, stolto colui che gode solo dei beni del presente e non anche di quelli del passato, quando questi sono più sicuri degli altri perché ormai non c’è alcun timore di poterli perdere. Gioire solo dei beni che si hanno e che si vedono e non mettere nel conto anche quelli che si sono avuti è come limitarne il godimento. Il fatto è che tutti i piaceri sono di breve durata, scorrono e passano via così velocemente che quasi ci sembrano tolti prima ancora che ci vengano dati. Perciò dobbiamo rivolgere la nostra mente al passato, rievocare tutto ciò che una volta ci ha reso felici e fissarvi continuamente il nostro pensiero: i piaceri che si ricordano sono più duraturi e più fedeli di quelli reali che si vivono al presente. Poni dunque fra i tuoi beni più grandi l’aver avuto un ottimo fratello, e pensa non quanto avresti
potuto ancora goderne ma quanto ne hai goduto. La natura, come fa coi fratelli degli altri, non te lo ha dato in proprietà, te l’ha prestato, e quando lo ha ritenuto opportuno se l’è ripreso, in base alla sua legge, non al tuo desiderio. Uno che si dispiace di dover restituire il denaro ricevuto in prestito, per giunta senza interessi, secondo te non dev’essere giudicato ingiusto? La natura ha dato la vita a tuo fratello, come l’ha data a te; se a un certo punto, esercitando un suo diritto, ha chiesto il pagamento del debito a uno dei due, colpevole non è lei, di cui era noto il patto, ma l’insaziabile speranza dell’uomo, che dimentica spesso cosa sia la natura e non ricorda la propria condizione se non quando gli arriva l’avviso. Rallegrati, dunque, di aver avuto un fratello così buono e ritieniti fortunato se hai potuto goderne anche se per un tempo più breve di quanto desideravi. Cosa divina è l’averlo avuto, umana l’averlo perduto. Sarebbe il massimo dell’incoerenza affliggersi di aver goduto per poco tempo di un tale fratello e tuttavia non gioire di averlo avuto. 11. «Ma mi è stato tolto inaspettatamente», obietterai. Il fatto è che ci lasciamo ingannare dalle nostre illusioni, dimenticando che anche le persone a noi care sono mortali. E dove sta scritto che la natura può apportare delle modifiche alla sua legge quando questa è di per sé stessa ineluttabile? Ogni giorno ci passano davanti agli occhi funerali di persone note e sconosciute, ma noi pensiamo ad altro, e poi giudichiamo improvviso un fatto che nel corso di tutta la vita ci saremmo dovuti aspettare. Non c’entra, dunque, la crudeltà del destino, siamo noi che per una deformazione o difetto della nostra mente non ci accontentiamo mai di nulla e ci riteniamo offesi di dover lasciare ciò che solo temporaneamente c’era stato concesso. Quanto più giusto fu colui che all’annuncio della morte del figlio pronunciò queste parole, degne di un grande uomo: Quando lo generai ero ben certo che sarebbe morto.4 Non c’è da meravigliarsi che da un tale uomo sia nato uno che seppe morire da eroe. Quel padre non si mostrò impreparato all’annuncio della morte del figlio. Che novità è infatti la morte di un uomo quando tutta la vita altro non è che un andare verso la morte? Quando lo generai ero ben certo che sarebbe morto. Poi quel padre, con maggiore saggezza e coraggio, aggiunse: Ed è per questo che l’ho messo al mondo. Siamo nati per la morte. Chi nasce alla vita è destinato a morire. Godiamo dunque di ciò che c’è dato e restituiamolo quando ci verrà richiesto. Chi prima,
chi dopo, il destino ci coglierà tutti, perciò il nostro animo deve tenersi sempre pronto, non temere mai ciò che è inevitabile e aspettarsi in ogni momento anche ciò che è imprevedibile. Devo ricordarti i condottieri, i loro figli, i grandi personaggi, famosi per i molti consolati o per i molti trionfi, stroncati da un destino inesorabile? Interi regni con i loro re, intere nazioni con le loro popolazioni hanno subìto la sorte loro assegnata. Tutti gli uomini, anzi, tutte le cose tendono al loro ultimo giorno. Certo, la scadenza non è la stessa per tutti: la vita lascia alcuni nel mezzo del cammino, altri proprio all’inizio, altri ancora quando ormai sono stremati da una decrepita vecchiaia e desiderosi di andarsene, ma chi in un tempo, chi in un altro, tutti tendiamo alla medesima meta. Non so se sia più stolto chi ignora la legge della morte, o più impudente chi la rifiuta. Suvvia, riprendi in mano i celebri poemi dell’uno o dell’altro dei due autori che con tanta geniale fatica hai divulgato volgendoli in prosa e mutandone il ritmo ma conservandone intatta la bellezza (e infatti, pur trasferendoli in un’altra lingua, sei riuscito a riversare nella tua traduzione – e questa era la difficoltà maggiore – tutti i pregi dell’originale): in questi poemi non c’è un canto che non ti fornisca infiniti esempi di vicende umane, di eventi imprevisti, di lacrime versate per i più diversi motivi. Rileggi quei passi in cui hai saputo infondere tutto il tuo slancio poetico e subito ti vergognerai della tua debolezza e di non aver più creduto nella grandezza di una così alta espressione linguistica. Non costringere chi ammirerà senza riserve i tuoi scritti a domandarsi come un animo tanto debole abbia potuto concepire espressioni così grandiose e ben costruite. 12. Abbandona dunque questi pensieri che ti tormentano e volgiti a cose che possano consolarti: guarda quante ce ne sono, guarda i tuoi ottimi fratelli, guarda tua moglie e tuo figlio. Per l’incolumità di tutti costoro la sorte te ne ha tolto uno soltanto: ne hai molti, perciò, in cui poter trovare conforto. Riscattati da questa tua umiliante condizione, affinché a tutti non sembri che il dolore per uno solo valga più di tutte queste consolazioni. Sai bene che i tuoi cari sono stati anch’essi colpiti dalla medesima sventura, né possono offrirti alcun aiuto, anzi, devi riconoscere che sono loro ad averne bisogno, perché, disponendo di una cultura e di un’intelligenza inferiori alla tua, si aspettano che sia tu ad assumere maggiormente il peso di una disgrazia comune. Del resto il dividere con altri il proprio dolore è già un conforto, perché, essendo distribuito tra molti, te ne resta una piccola parte. Non cesserò mai di citarti l’esempio di Cesare. Finché egli continuerà a governare il mondo, dimostrando quanto i benefìci concessi ai popoli valgano più delle armi a mantenere su di esso il comando, finché egli continuerà a presiedere ai destini dell’umanità, non ci sarà pericolo che tu ti accorga di aver perduto qualcosa: in lui solo troverai sufficiente difesa e sufficiente conforto. Risollevati, dunque, e ogni volta che gli occhi ti si riempiranno di lacrime, volgili a Cesare, ed essi si asciugheranno alla vista di quel sommo e fulgido dio: il suo splendore li abbaglierà al punto che non
potranno vedere altro e continueranno a fissarlo. È a lui che devi pensare, giorno e notte, senza mai distrarti, è a lui che devi chiedere soccorso contro la malasorte. Tanto sono grandi la sua bontà e la sua benevolenza verso tutti i suoi ch’egli avrà già rimarginato con molti conforti – non ne ho il minimo dubbio – questa tua ferita, approntando ogni rimedio possibile contro il tuo dolore. Ma quand’anche non avesse fatto nulla di tutto ciò, non bastano a tuo massimo conforto la sola vista di Cesare, il solo pensiero di lui? Che gli dèi e le dee lo mantengano a lungo sulla terra! Possa egli uguagliare le gesta del divino Augusto e superarlo nel numero degli anni! Finché sarà tra i mortali senta nella sua casa la presenza costante della divinità, riconosca nel figlio, dopo tanta stima accordatagli, la capacità di reggere degnamente l’impero romano e lo abbia compagno nel governo, prima che successore! Venga tardi quel giorno, e lo vedano solo i nostri nipoti, quando la sua famiglia divina lo assumerà nel cielo! 13. Tieni le tue mani lontano da lui, o Fortuna, e mostra su di lui il tuo potere intervenendo solo a suo favore. Lascia ch’egli sia balsamo a questa umanità già così lungamente ammalata e sofferente, lascia che restauri e rimetta al suo posto tutto ciò che la follia del suo predecessore ha abbattuto! Possa sempre risplendere questa stella che ha brillato su un mondo precipitato nel baratro e sommerso nelle tenebre! Che egli possa pacificare la Germania e conquistare la Britannia, ripetere i trionfi del padre e ve ne aggiunga di nuovi! La sua clemenza, che è la prima delle sue virtù, mi fa bene sperare che potrò esserne spettatore anch’io. Egli, infatti, non mi ha abbattuto per non farmi più rialzare, anzi, non mi ha nemmeno abbattuto, mi ha sorretto quando, colpito dalla sorte, stavo cadendo e mentre precipitavo ha steso la sua mano divina abituata alla moderazione e dolcemente mi ha deposto a terra e, implorato il Senato in mio favore, mi ha concesso la vita. Ora giudichi lui, valuti la mia causa come ritiene opportuno: se la sua giustizia non la considera buona, sia la sua clemenza a renderla tale. In entrambi i casi, che la mia innocenza sia riconosciuta o stabilita da un decreto, per me sarà comunque un beneficio. Nel frattempo è di grande conforto nella mia sventura il vedere che la sua misericordia si diffonde in tutto il mondo: da questo stesso angolo in cui sono confinato ha dissotterrato e riportato alla luce parecchie persone che da anni giacevano sepolte nella loro rovina, perciò non temo che tralasci me solo. Egli sa bene in quale momento soccorrere ciascuno. Da parte mia farò di tutto affinché lui non debba arrossire di giungere sino a me. Sia benedetta la tua clemenza, o Cesare, che sotto il tuo principato permette agli esuli di vivere una vita più tranquilla di quella che poco tempo fa conducevano sotto Gaio i personaggi più ragguardevoli! Essi non hanno paura, non si aspettano di ora in ora un colpo di spada, non tremano ogni volta che vedono giungere una nave: grazie alla tua clemenza, come la sorte avversa pone dei limiti alla sua crudeltà, così c’è per loro la tranquillità del presente e la speranza di un futuro migliore. Io ti sono appunto testimone che i fulmini, quando vengono onorati anche da chi ne è stato colpito, sono quanto mai giusti e legittimi.
14. Dunque, se non m’inganno, questo principe, pubblico conforto dell’umanità, ha già rinfrancato il tuo animo e medicato la tua grave ferita con rimedi ancora più efficaci. Ti ha ridato coraggio in tutti i modi possibili, la sua tenacissima memoria ti ha messo davanti tutti gli esempi che potevano rasserenarti e la sua abituale eloquenza ti ha illustrato i precetti di tutti i saggi del mondo. Nessuno potrebbe svolgere meglio il compito di consolarti; pronunciate da lui, le parole hanno il peso di un oracolo, la sua autorità divina è capace di frantumare tutta la forza del tuo dolore. Immagina ch’egli ti parli così: «Non sei il solo a essere stato scelto dalla sorte per ricevere una simile offesa: in tutto il pianeta non c’è mai stata e non c’è famiglia che non abbia avuto motivo di piangere. Tralascerò gli esempi comuni che, per quanto meno importanti, sono anch’essi degni di nota: ti condurrò davanti al calendario della Storia.5 Vedi tutte queste statue che riempiono l’atrio dei Cesari? Ebbene, fra i personaggi che ciascuna di esse rappresenta non ce n’è uno che non sia noto per qualche grave disgrazia familiare; nessuno, fra questi uomini che rifulgono a ornamento dei secoli, che non abbia patito il tormento per la perdita dei suoi cari o che non sia stato egli stesso rimpianto dai suoi col più profondo dolore. Devo ricordarti Scipione Africano, il quale apprese in esilio la notizia che gli era morto il fratello?6 Lui, che lo aveva strappato al carcere, non poté strapparlo alla morte. Allora apparve chiaro a tutti quanto l’Africano, di fronte agli affetti più cari, disdegnasse persino le leggi e la giustizia. Infatti in quel medesimo giorno in cui aveva strappato dalle mani del messo il fratello, si oppose, da privato cittadino, anche al tribuno della plebe. Nondimeno egli pianse la morte del fratello con la stessa grandezza d’animo con cui lo aveva difeso. E Scipione Emiliano,7 che quasi contemporaneamente assistette al trionfo del padre e al funerale di due fratelli? Eppure, ancora giovinetto, anzi quasi bambino, sopportò quell’improvvisa tragedia della sua famiglia, che si abbatteva sul trionfo stesso di Paolo,8 col coraggio di un uomo ch’era venuto al mondo affinché Roma non fosse privata di uno Scipione e Cartagine non sopravvivesse a Roma. 15. E devo ricordarti l’amicizia dei due Luculli9 spezzata dalla morte? E i figli di Pompeo,10 a cui la sorte crudele non concesse nemmeno di cadere insieme, nel medesimo crollo? Sesto Pompeo dapprima sopravvisse alla sorella, la cui morte aveva rotto i vincoli della salda pace romana, poi sopravvisse anche all’ottimo fratello, che la Fortuna aveva innalzato tanto per farlo precipitare da un’altezza non inferiore a quella da cui aveva precipitato il padre. Eppure, anche dopo questa disgrazia, Sesto Pompeo seppe reggere non solo il peso del dolore, ma anche l’onere di una guerra. Sono innumerevoli gli esempi di fratelli che la morte ha separato, anzi, quasi mai si sono visti due fratelli invecchiare insieme. Mi limiterò a quelli della famiglia imperiale, di fronte ai quali credo che nessuno sarà così dissennato o privo di buon senso da rinfacciare alla sorte il lutto di qualcuno quando essa è avida persino delle lacrime dei Cesari. Il Divo Augusto
perse Ottavia, sua sorella carissima, il che dimostra come la natura non abbia sottratto alla legge del dolore neppure l’uomo che aveva destinato al cielo. Anzi, a dire il vero, egli fu afflitto da ogni genere di perdite: vide morire il figlio della sorella destinato a succedergli,11 poi, per non fare a uno a uno l’elenco di tutti i suoi lutti, perse generi, figli e nipoti, e nessuno fra tutti i mortali sperimentò più di lui cosa significhi essere un uomo, finché fu uomo fra gli uomini. E comunque il suo cuore, così grande da contenere e dominare ogni genere di eventi, riuscì a sopportare tutti quei lutti, vincitore non solo di tanti popoli stranieri, ma anche del dolore. Gaio Cesare,12 nipote del Divo Augusto, mio prozio materno, agli albori della sua giovinezza perse il carissimo fratello Lucio, primo anch’egli fra i giovani, nel momento in cui si apprestava alla guerra contro i Parti, e ne riportò nell’animo una ferita molto più profonda di quella che in seguito trafisse il suo corpo, ma seppe sopportarle entrambe con grande forza e serenità. Tiberio Cesare,13 mio zio paterno, vide morire fra le sue braccia e i suoi baci mio padre Druso Germanico,14 suo fratello minore, mentre stava per inoltrarsi nelle regioni più interne della Germania e assoggettare al dominio di Roma il più feroce di tutti i popoli. Tuttavia riuscì a dare un contegno non solo al proprio dolore ma anche a quello degli altri, riconducendo tutto l’esercito – che, addolorato e sbigottito, reclamava il corpo del suo Druso – al tradizionale costume del lutto romano, poiché pensava che bisogna mantenere la disciplina non solo sotto le armi ma anche nel dolore. E non avrebbe potuto frenare le lacrime degli altri se non avesse prima trattenuto le sue. 16. Mio nonno Marco Antonio,15 che non fu inferiore ad alcuno se non a colui che lo vinse, ebbe notizia della morte di suo fratello proprio mentre stava riorganizzando lo Stato e, insignito della potestà di triumviro, non aveva nessuno al di sopra di sé, anzi, a parte i due colleghi, tutti gli erano sottomessi. Tracotante Fortuna, come ti fai gioco delle sciagure umane! Nel tempo stesso in cui sedeva arbitro della vita e della morte dei suoi concittadini il fratello di Marco Antonio veniva ucciso!16 E tuttavia Marco Antonio sopportò questa ferita dolorosissima con la stessa grandezza d’animo con cui aveva sopportato tutte le altre disgrazie, e il suo pianto fu il sangue di venti legioni offerte in sacrificio alla morte del fratello.17 Ma non voglio citare tutti gli altri esempi e tacerò anche di quelli che riguardano me: la sorte mi ha colpito due volte con un lutto fraterno e due volte ha preso atto che io potevo essere ferito ma non vinto. Ho perso mio fratello Germanico, e chiunque può comprendere quanto io lo amassi se solo pensa all’affetto che intercorre fra i buoni fratelli. Eppure io seppi controllare il mio sentimento, tanto da non trascurare nessuno dei doveri che competono a un buon fratello e da non fare nulla che potesse risultare sconveniente in un principe». Immagina dunque che il nostro padre comune ti ricordi questi esempi, dimostrandoti che nulla è sacro e inviolabile per la fortuna quando essa si spinge
al punto da far uscire dei funerali da quella casa da cui avrebbe tratto degli dèi. Nessuno si meravigli se fa qualcosa che l’uomo ritiene ingiusto o crudele: potrebbe mai mostrare equità e misura verso le famiglie private quando con implacabile ferocia ha funestato tante volte i sacri letti imperiali? Anche se la coprissimo di ingiurie, e non solo singolarmente ma tutti quanti insieme, non per questo la Fortuna cambierà, anzi, ogni supplica e ogni lamento la renderanno ancora più spavalda. Tale essa sempre è stata e tale sempre sarà nelle vicende umane; nulla non c’è che lei non possa osare, né mai ci sarà nulla d’intoccabile per lei; entrerà dappertutto con smisurata violenza, com’è solita fare, oserà entrare, per colpirle, persino in quelle case alle quali si accede passando per i templi e ornerà di drappi funebri le porte fregiate di alloro. Cerchiamo dunque di ottenere da lei almeno questo, con pubblici voti e preghiere, se non ha ancora deciso di distruggere tutto il genere umano e guarda ancora con una qualche benevolenza al nome di Roma: che questo principe, donato alle incerte vicende degli uomini, le sia sacro quanto lo è a tutti i mortali! Impari da lui a essere clemente e sia mite col più mite di tutti i principi! 17. Segui dunque l’esempio di tutti i grandi personaggi che ti ho appena elencato, alcuni dei quali sono già saliti al cielo, altri vi saliranno, e sopporta con animo giusto e sereno la sorte che stende su te le sue mani e non le tiene lontane neppure da coloro sui quali giuriamo. Imita la loro forza s’animo nel sopportare e vincere il dolore, per quanto è lecito a un uomo seguire le orme degli dèi. Sebbene in altri campi la dignità e la nobiltà comportino grandi differenze fra gli uomini, la virtù è alla portata di tutti e non disdegna nessuno, purché in qualche modo ci si ritenga degni di lei. Sono certo che tu saprai imitare alla perfezione questi personaggi, i quali, pur avendo avuto motivo di risentirsi per non essere stati esenti da simili mali, considerarono non già un’ingiustizia ma una legge propria della condizione umana l’essere in questo uguali agli altri uomini, e perciò sopportarono ogni accidente senza abbandonarsi eccessivamente all’ira e al risentimento, né con fragilità e debolezza femminili. Se infatti è umano sentire i propri mali, non è da uomo il non saperli sopportare. Ora, però, dopo aver ricordato tutti i Cesari a cui la sventura ha tolto fratelli e sorelle, non posso tralasciare colui che dovrebbe essere cancellato dal novero dei Cesari, generato dalla natura a rovina e vergogna del genere umano, il quale incendiò e distrusse dalle fondamenta l’impero, che ora sta risorgendo per la clemenza del più mite tra i principi. Quando gli morì la sorella Drusilla, Gaio Cesare,18 quest’uomo incapace di sopportare il dolore e di gioire come la dignità di un principe richiede, si sottrasse alla vista dei suoi concittadini, troncando ogni rapporto con loro, non partecipò ai funerali della sorella e non le rese gli estremi onori, ma ritiratosi nella sua villa di Alba alleviò il dolore di questo gravissimo lutto giocando a dadi e a scacchi, o impegnato in altre simili facezie. Quale vergogna per l’impero! Furono i dadi la consolazione di un principe romano per la morte della sorella! E sempre questo Gaio, con la volubilità di un
pazzo, ora si lasciava crescere la barba e i capelli, ora scorrazzava senza meta lungo le coste dell’Italia e della Sicilia, e assillato continuamente dal dubbio se fosse meglio veder la sorella compianta o venerata, mentre le faceva innalzare templi e santuari, condannava alle pene più crudeli chi non si fosse dimostrato abbastanza addolorato. Mostrava infatti la stessa incoerenza nel reagire tanto agli eventi sfavorevoli quanto a quelli propizi, i quali ultimi lo eccitavano e lo insuperbivano in modo smisurato e disumano. Stia lontano da ogni romano l’esempio di quest’uomo, che distrasse il proprio dolore con divertimenti indecorosi, esasperandolo con un aspetto sordido e vergognoso, o alleviandolo coi mali altrui, la più disumana delle consolazioni. 18. Ma in fin dei conti tu non hai affatto bisogno di cambiare le tue abitudini, perché ti sei sempre dedicato amorevolmente a quegli studi che conducono a una giusta e opportuna felicità e facilmente alleviano il dolore: essi sono per l’uomo l’ornamento migliore e la più grande consolazione. Immergiti dunque col massimo ardore in questi tuoi studi, ergili a tua difesa come una corazza affinché il dolore non trovi accesso al tuo animo da nessuna parte. Dedica poi a tuo fratello qualche scritto che ne perpetui il ricordo, perché questa è fra le opere umane l’unica che nessuna tempesta danneggi e che il tempo non consumi. Tutte le altre, costruite con pietre o blocchi di marmo, o formate da altissimi cumuli di terra, non conservano a lungo il nostro ricordo, perché esse stesse rovinano: solo il ricordo destato dall’ingegno umano è immortale. Offri dunque questo ricordo a tuo fratello e fa che in esso egli continui a vivere: meglio eternarlo col tuo genio immortale che piangerlo con un dolore sterile e vano. Quanto al resto non è possibile per il momento prendere davanti a te le difese della sorte (quando, infatti, ci ha tolto l’unico bene ci diventano odiosi tutti gli altri che ci ha elargito), ma bisognerà pur affrontarlo questo argomento non appena il tempo avrà reso più imparziale il tuo giudizio: allora potrai anche riconciliarti con lei. Che d’altronde ti è stata provvida di molti beni con cui compensare questa sua offesa, e molti altri ancora te ne darà per sdebitarsi: dopotutto, anche ciò che ti ha tolto era un suo dono. Non usare dunque il tuo ingegno contro te stesso, non cedere al dolore. Sei così abile nel parlare da far sembrare grandi le cose piccole e rimpicciolire le grandi sino a renderle insignificanti: usa quindi questo tuo potere anche in altri casi, come in questo, volgendolo interamente a tua consolazione. Bada, però, di non esagerare, poiché la natura esige un limite per ogni cosa che facciamo, tutto ciò ch’è superfluo è frutto di vanità. Insomma, io non pretendo che tu ti sottragga al dolore, anche se ci sono uomini, dal temperamento rigido più che forte, secondo i quali l’uomo saggio non deve mai piangere. Io non so se costoro abbiano mai vissuto un’esperienza analoga alla tua, ma sono certo che in un simile caso la malasorte gli avrebbe strappato la maschera della loro saggezza presuntuosa, costringendoli a confessare la verità. La ragione ha il compito di eliminare dal dolore solo ciò ch’è superfluo e sovrabbondante, ma non si può né sperare né desiderare che lo annulli del tutto.
Essa piuttosto deve osservare una via di mezzo, fare in modo, cioè, che il dolore non abbia l’aspetto né del cinismo, né della follia, suggerendoci un contegno che sia indice di un animo commosso ma non sconvolto. Scorrano pure le lacrime, ma abbiano una fine: escano pure i gemiti dal profondo del cuore, ma sappiano anche tacere. Domina, insomma, il tuo animo, sì che ti apprezzino i saggi e i tuoi fratelli. Cerca anche di richiamare spesso alla tua mente l’immagine di tuo fratello, di celebrarlo nei tuoi discorsi, di mantenerlo vivo col tuo costante pensiero, e ciò potrai ottenerlo solo se il ricordo di lui ti sarà lieto anziché doloroso: l’animo, infatti, istintivamente rifugge da tutto ciò che gli provoca tristezza. Pensa quanto era modesto, con quale sollecitudine e con quale prontezza conduceva e concludeva gli affari, alla sua lealtà nel mantenere la parola data, ricorda a te stesso e racconta agli altri tutte le sue parole e le sue azioni, pensa a quello che è stato e che prometteva di essere: che cosa, infatti, non avrebbe potuto garantirti un simile fratello? Tutto questo l’ho scritto come ho potuto, con la mente intorpidita e indebolita dalla lunga inattività. Se gli argomenti trattati ti sembreranno poco degni del tuo ingegno e insufficienti ad alleviare il tuo dolore, pensa quanto sia difficile consolare gli altri per chi è afflitto dai propri mali, e come non sia facile trovare parole ed espressioni latine quando tutt’intorno risuona lo strepito del rozzo parlare di barbari, sgradito anche a loro stessi, se mai hanno un po’ di cultura.
1. L’inizio è mutilo, ma è molto probabile che siano i monumenti il soggetto della frase. 2. Si tratta di Atlante, condannato da Zeus a reggere il mondo sulle spalle per aver aiutato i Giganti contro il dio. 3. La favola era già entrata in Roma nel I secolo d.C. a opera di Fedro, autore di cinque libri in versi da lui chiamati Esopiche in onore del poeta greco Esopo (VI sec. a.C.). 4. Il verso è tratto da un dramma (Telamone) di Quinto Ennio (239-169 a.C.), il famoso autore degli Annali, poema epico in esametri sulla storia di Roma. 5. Si riferisce propriamente ai Fasti, i giorni in cui il pretore amministrava la giustizia e che in seguito costituirono il calendario romano. 6. È Cornelio Scipione Asiatico, fratello dell’Africano che lo difese in un processo per corruzione. 7. Scipione Emiliano (185-129 a.C.), distruttore di Cartagine, detto l’Africano Minore. 8. Paolo Emilio, che vinse a Pidna (168 a.C.) Perseo, ultimo re di Macedonia. 9. Sono Licinio Lucullo (106-57 a.C.), proconsole romano vincitore di Mitridate il Grande, re dei Parti, e Marco Licinio Lucullo, suo fratello minore. 10. Sesto e Gneo Pompeo. 11. Marcello, forse scelto da Augusto come suo successore, morì a diciannove anni. 12. Figlio di Agrippa e di Giulia, figlia di Augusto. 13. Tiberio Cesare è il futuro imperatore. 14. Druso Germanico, fratello di Tiberio, morì durante una spedizione in Germania nel 9 d.C. 15. Famoso triumviro sconfitto da Ottaviano ad Azio (31 a.C.). 16. È Caio Antonio: catturato da Bruto, fu giustiziato nel 42 a.C. 17. Sono le legioni di Bruto e Cassio, sconfitte da Ottaviano e Antonio a Filippi nel 42 a.C. 18. Caligola.
De brevitate vitae
1. Maior pars mortalium, Pauline, de naturae malignitate conqueritur, quod in exiguum aevi gignimur, quod haec tam velociter, tam rapide dati nobis temporis spatia decurrant, adeo ut exceptis admodum paucis ceteros in ipso vitae apparatu vita destituat. Nec huic publico, ut opinantur, malo turba tantum et imprudens vulgus ingemuit; clarorum quoque virorum hic affectus querellas evocavit. Inde illa maximi medicorum exclamatio est; «vitam brevem esse, longam artem». Inde Aristotelis cum rerum natura exigentis minime conveniens sapienti viro lis: «aetatis illam animalibus tantum indulsisse, ut quina aut dena saecula educerent, homini in tam multa ac magna genito tanto citeriorem terminum stare». Non exiguum temporis habemus, sed multum perdidimus. Satis longa vita et in maximarum rerum consummationem large data est, si tota bene collocaretur; sed ubi per luxum ac neglegentiam diffluit, ubi nulli bonae rei impenditur, ultima demum necessitate cogente, quam ire non intelleximus transisse sentimus. Ita est; non accipimus brevem vitam sed facimus, nec inopes eius sed prodigi sumus. Sicut amplae et regiae opes, ubi ad malum dominum pervenerunt, momento dissipantur, at quamvis modicae, si bono custodi traditae sunt, usu crescunt; ita aetas nostra bene disponenti multum patet. 2. Quid de rerum natura querimur? Illa se benigne gessit; vita, si uti scias, longa est. Alium insatiabilis tenet avaritia; alium in supervacuis laboribus operosa sedulitas; alius vino madet, alius inertia torpet; alium defetigat ex alienis iudiciis suspensa semper ambitio, alium mercandi praeceps cupiditas circa omnis terras, omnia maria spe lucri ducit; quosdam torquet cupido militiae numquam non aut alienis periculis intentos aut suis anxios; sunt quos ingratus superiorum cultus voluntaria servitute consumat; multos aut affectatio alienae formae aut suae cura detinuit; plerosque nihil certum sequentis vaga et inconstans et sibi displicens levitas per nova consilia iactavit; quibusdam nihil quo cursum derigant placet, sed marcentis oscitantisque fata deprendunt, adeo ut quod apud maximum poetarum more oraculi dictum est erum esse non dubitem: «Exigua pars est vitae qua vivimus». Ceterum quidem omne spatium non vita sed tempus est. Urgent et circumstant vitia undique nec resurgere aut in dispectum veri attollere oculos sinunt. Et immersos et in cupiditiam infixos premunt, numquam illis recurrere ad se licet. Si quando aliqua fortuito quies contigit, velut profundo mari, in quo post ventum quoque volutatio est fluctuantur nec unquam illis a cupiditatibus suis otium stat. De istis me putas dicere, quorum in confesso mala sunt? Aspice illos ad quorum felicitatem concurritur: bonis suis effocantur. Quam multis divitiae graves sunt! Quam multorum eloquentia et cotidiana ostentandi ingenii sollicitatio sanguinem educit! Quam multi continuis voluptatibus pallent! Quam multis nihil liberi reliquint cincumfusus clientium populus! Omnis denique
istos ab infimis usque ad summos pererra: hic advocat, hic adest, ille periclitatur, ille defendit, ille iudicat, nemo se sibi vindicat, alius in alium consumitur. Interroga de istis quorum nomina ediscuntur, his illos dinosci videbit notis: ille illus cultor est, hic illius; suus nemo est. Deinde dementissima quorundam indignatio est: queruntur de superiorum fastidio, quod ipsis adire volentibus non vacaverint! Audet quisquam de alterius superbia queri, qui sibi ipse numquam vacat? Ille tamen te, quisquis es, insolenti quidem vultu sed aliquando respexit, ille aures suas ad tua verba demisit, ille te ad latus suum recepit: tu non inspicere te umquam non audire dignatus es. Non est itaque quod ista officia cuiquam imputes, quoniam quidem, cum illa faceres, non esse cum alio volebas, sed tecum esse non poteras. 3. Omnia licet quae umquam ingenia fulserunt in hoc unum consentiant, numquam satis hanc humanarum mentium caliginem mirabuntur: praedia sua occupari a nullo patiuntur et, si exigua contentio est de modo finium, ad lapides et arma discurrunt; in vitam suam incedere alios sinunt, immo vero ipsi etiam possessores eius futuros inducunt; nemo invenitur qui pecuniam suam dividere velit, vitam unusquisque quam multis distribuit! Adstricti sunt in continendo patrimonio, simul ad iacturam temporis ventum est, profusissimi in eo cuius unius honesta avaritia est. Libet itaque ex seniorum turba comprendere aliquem: «Pervenisse et ad ultimum aetatis humanae videmus, centesimus tibi vel supra premitur annus: agedum ad computationem aetatem tuam revoca. Duc quantum ex isto tempore creditor, quantum amica, quantum rex, quantum cliens abstulerit, quantum lis uxoria, quantum servorum coercitio, quantum officiosa per urbem discursatio; adice morbos quos manu fecimus, adice quod et sine usu iacuit: videbis te pauciores annos habere quam numeras. Repete memoria tecum quando certus consilii fueris, quotus quisque dies ut destinaveras recesserit, quando tibi usus tui fuerit, quando in statu suo vultus, quando animus intrepidus, quid tibi in tam longo aevo facti operis sit, quam multi vitam tuam diripuerint te non sentiente quid perderes, quantum vanus dolor, stulta laetitia, avida cupiditas, blanda conversatio abstulerit, quam exiguum tibi de tuo relictum sit: intelleges te immaturum mori». Quid ergo est in causa? Tamquam semper victuri vivitis, numquam vobis fragilitas vestra succurrit, non observatis quantum iam temporis transierit; velut ex pleno et abundanti perditis, cum interim fortasse ille ipse qui alicui vel homini vel rei donatur dies ultimus sit. Omnia tamquam mortales timetis, omnia tamquam immortales concupiscitis. Audies plerosque dicentes: «A quinquagesimo anno in otium secedam, sexagesimus me annus ab officiis dimittet». Et quem tandem longioris vitae praedem accipis? Quis ista sicut disponis ire patietur? Non pudet te reliquias vitae tibi reservare et id solum tempus bonae menti destinare quod in nullam rem conferri possit? Quam serum est tunc vivere incipere cum desinendum est? Quae tam stulta mortalitatis oblivio in quinquagesimum et sexagesimum annum differre sana consilia et inde velle vitam inchoare quo pauci perduxerunt?
4. Potentissimis et in altum sublatis hominibus excidere voces videbis quibus otium optent, laudent, omnibus bonis suis praeferant. Cupiunt interim ex illo fastigio suo, si tuto liceat, descendere: nam ut nihil extra lacessat aut quatiat, in se ipsa fortuna ruit. Divus Augustus, cui dii plura quam ulli praestiterunt, non desiit quietem sibi precari et vacationem a re publica petere; omnis eius sermo ad hoc semper revolutus est, ut speraret otium: hoc labores suos, etiam si falso, dulci tamen oblectabat solacio, aliquando se victurum sibi. In quadam ad senatum missa epistula, cum requiem suam non vacuam fore dignitatis nec a priore gloria discrepantem pollicitus esset, haec verba inveni: «Sed ista fieri speciosius quam promitti possunt. Me tamen cupido temporis optatissimi mihi provexit, ut quoniam rerum laetitia moratur adhuc, praeciperem aliquid voluptatis ex verborum dulcedine». Tanta visa est res otium, ut illam, quia usu non poterat, cogitatione praesumeret. Qui omnia videbat ex se uno pendentia, qui hominibus gentibusque fortunam dabat, illum diem laetissimus cogitabat quo magnitudinem suam exueret. Expertus erat quantum illa bona per omnis terras fulgentia sudoris exprimerent, quantum occultarum sollicitudinum tegerent: cum civibus primum, deinde cum collegis, novissime cum affinibus coactus annis decernere mari terraque sanguinem fudit. Per Macedoniam, Siciliam, Aegyptum, Syriam Asiamque et omnis prope oras bello circumactus Romana caede lassos exercitus ad externa bella convertit. Dum Alpes pacat immixtosque mediae paci et imperio hostes perdomat, dum ultra Rhenum et Euphraten et Danuvium terminos movet, in ipsa urbe Murenae, Caepionis, Lepidi, Egnati, aliorum in eum mucrones acuebantur. Nondum horum effugerat insidias: filia et tot nobiles iuvenes adulterio velut sacramento adacti iam infractam aetatem territabant Iullusque et iterum timenda cum Antonio mulier. Haec ulcera cum ipsis membris absciderat: alia subnascebantur; velut grave multo sanguine corpus parte semper aliqua rumpebatur. Itaque otium optabat, in huius spe et cogitatione labores eius residebant, hoc votum erat eius qui voti compotes facere poterat. 5. M. Cicero inter Catilinas, Clodios iactatus Pompeiosque et Crassos, partim manifestos inimicos, partim dubios amicos, dum fluctuatur cum re publica et illam pessum euntem tenet, novissime abductus, nec secundis rebus quietus nec adversarum patiens, quotiens illum ipsum consulatum suum non sine causa sed sine fine laudatum detestatur! Quam flebiles voces exprimit in quadam ad Atticum epistula iam victo patre Pompeio, adhuc filio in Hispania facta arma refovente! «Quid agam», inquit, «hic, quaeris? Moror in Tusculano meo semiliber». Alia deinceps adicit, quibus et priorem aetatem complorat et de praesenti queritur et de futura desperat. Semiliberum se dixit Cicero: at me hercules numquam sapiens in tam humile nomen procedet, numquam semiliber erit, integrae semper libertatis et solidae, solutus et sui iuris et altior ceteris. Quid enim supra eum potest esse qui supra fortunam est?
6. Livius Drusus, vir acer et vehemens, cum leges novas et mala Gracchana movisset stipatus ingenti totius Italiae coetu, exitum rerum non pervidens, quas nec agere licebat nec iam liberum erat semel incohatas relinquere, exsecratus inquietam a primordiis vitam dicitur dixisse: uni sibi ne puero quidem umquam ferias contigisse. Ausus est enim et pupillus adhuc et praetextatus iudicibus reos commendare et gratiam suam foro interponere tam efficaciter quidem, ut quaedam iudicia constet ab illo rapta. Quo non erumperet tam immatura ambitio? Scires in malum ingens et privatum et publicum evasuram tam praecoquem audaciam. Sero itaque querebatur nullas sibi ferias contigisse a puero seditiosus et foro gravis. Disputatur an ipse sibi manus attulerit; subito enim vulnere per inguen accepto collapsus est, aliquo dubitante an mors eius voluntaria esset, nullo an tempestiva. Supervacuum est commemorare plures qui, cum aliis felicissimi viderentur, ipsi in se verum testimonium dixerunt perosi omnem actum annorum suorum; sed his querellis nec alios mutaverunt nec se ipsos: nam cum verba eruperunt, affectus ad consuetudinem relabuntur. Vestra me hercules vita, licet supra mille annos exeat, in artissimum contrahetur: ista vitia nullum non saeculum devorabunt; hoc vero spatium, quod quamvis natura currit ratio dilatat, cito vos effugiat necesse est; non enim apprenditis nec retinetis velocissimae omnium rei moram facitis, sed abire ut rem supervacuam ac reparabilem sinitis. 7. In primis autem et illos numero qui nulli rei nisi vino ac libidini vacant; nulli enim turpius occupati sunt. Ceteri, etiam si vana gloriae imagine teneantur, speciose tamen errant; licet avaros mihi, licet iracundos enumeres vel odia exercentes iniusta vel bella, omnes isti virilius peccant: in ventrem ac libidinem proiectorum inhonesta tabes est. Omnia istorum tempora excute, aspice quam diu computent, quam diu insidientur, quam diu timeant, quam diu colant, quam diu colantur, quantum vadimonia sua atque aliena occupent, quantum convivia, quae iam ipsa officia sunt: videbis quemadmodum illos respirare non sinant vel mala sua vel bona. Denique inter omnes convenit nullam rem bene exerceri posse ab homine occupato, non eloquentiam, non liberales disciplinas, quando districtus animus nihil altius recipit sed omnia velut inculcata respuit. Nihil minus est hominis occupati quam vivere: nullius rei difficilior scientia est. Professores aliarum artium vulgo multique sunt, quasdam vero ex his pueri admodum ita percepisse visi sunt, ut etiam praecipere possent: vivere tota vita discendum est et quod magis fortasse miraberis, tota vita discendum est mori. Tot maximi viri, relictis omnibus impedimentis, cum divitiis, officiis, voluptatibus renuntiassent, hoc unum in extremam usque aetatem egerunt ut vivere scirent; plures tamen ex his nondum se scire confessi vita abierunt, nedum ut isti sciant. Magni, mihi crede, et supra humanos errores eminentis viri est nihil ex suo tempore delibari sinere, et ideo eius vita longissima est, quia, quantumcumque patuit, totum ipsi vacavit. Nihil inde incultum otiosumque iacuit, nihil sub alio fuit, neque enim quicquam repperit dignum quod cum tempore suo permutaret custos eius parcissimus. Itaque satis illi fuit: iis vero necesse est defuisse ex quorum vita
multum populus tulit. Nec est quod putes hinc illos aliquando non intellegere damnum suum: plerosque certe audies ex iis quos magna felicitas gravat inter clientium greges aut causarum actiones aut ceteras honestas miserias exclamare interdum: «Vivere mihi non licet». Quidni non liceat? Omnes illi qui te sibi advocant tibi abducunt. Ille reus quot dies abstulit? Quot ille candidatus? Quot illa anus efferendis heredibus lassa? Quot ille ad irritandam avaritiam captantium simulatus aeger? Quot ille potentior amicus, qui vos non in amicitiam sed in apparatum habet? Dispunge, inquam, et recense vitae tuae dies: videbis paucos admodum et reiculos apud te resedisse. Assecutus ille quos optaverat fasces cupit ponere et subinde dicit: «Quando hic annus praeteribit?». Facit ille ludos, quorum sortem sibi obtingere magno aestimavit: «Quando», inquit, «istos effugiam?». Diripitur ibi toto foro patronus et magno concursu omnia ultra quam audiri potest complet: «Quando», inquit, «res proferentur?». Praecipitat quisque vitam suam et futuri desiderio laborat, praesentium taedio. At ille qui nullum non tempus in usus suos confert, qui omnes dies tamquam vitam ordinat, nec optat crastinum nec timet. Quid enim est quod iam ulla hora novae voluptatis possit afferre? Omnia nota, omnia ad satietatem percepta sunt. De cetero fors fortuna ut volet ordinet: vita iam in tuto est. Huic adici potest, detrahi nihil, et adici sic quemadmodum saturo iam ac pleno aliquid cibi: quod nec desiderat capit. Non est itaque quod quemquam propter canos aut rugas putes diu vixisse: non ille diu vixit, sed diu fuit. Quid enim, si illum multum putes navigasse quem saeva tempestas a portu exceptum huc et illuc tulit ac vicibus ventorum ex diverso furentium per eadem spatia in orbem egit? Non ille multum navigavit, sed multum iactatus est. 8. Mirari soleo cum video aliquos tempus petentes et eos qui rogantur facillimos; illud uterque spectat propter quod tempus petitum est, ipsum quidem neuter: quasi nihil petitur, quasi nihil datur. Re omnium pretiosissima luditur; fallit autem illos, quia res incorporalis est, quia sub oculos non venit ideoque vilissima aestimatur, immo paene nullum eius pretium est. Annua, congiaria homines carissime accipiunt et illis aut laborem aut operam aut diligentiam suam locant: nemo aestimat tempus; utuntur illo laxius quasi gratuito. At eosdem aegros vide, si mortis periculum propius admotum est, medicorum genua tangentes, si metuunt capitale supplicium, omnia sua, ut vivant, paratos impendere! Tanta in illis discordia affectuum est! Quodsi posset quemadmodum praeteritorum annorum cuiusque numerus proponi, sic futurorum, quomodo illi qui paucos viderent superesse trepidarent, quomodo illis parcerent! Atqui facile est quamvis exiguum dispensare quod certum est; id debet servari diligentius quod nescias quando deficiat. Nec est tamen quod putes illos ignorare quam cara res sit: dicere solent eis quos valdissime diligunt paratos se partem annorum suorum dare: dant nec intellegunt: dant autem ita ut sine illorum incremento sibi detrahant. Sed hoc ipsum an detrahant nesciunt; ideo tolerabilis est illis iactura detrimenti latentis. Nemo restituet annos, nemo iterum te tibi reddet. Ibit qua
coepit aetas nec cursum suum aut revocabit aut supprimet; nihil tumultuabitur, nihil admonebit velocitatis suae: tacita labetur. Non illa se regis imperio, non favore populi longius proferet: sicut missa est a primo die, curret, nusquam devertetur, nusquam remorabitur. Quid fiet? Tu occupatus es, vita festinat; mors interim aderit, cui velis nolis vacandum est. 9. Potestne quicquam stultius esse quam quorundam sensus, hominum eorum dico qui prudentiam iactant? Operosius occupati sunt. Ut melius possint vivere, impendio vitae vitam instruunt. Cogitationes suas in longum ordinant; maxima porro vitae iactura dilatio est: illa primum quemque extrahit diem, illa eripit praesentia dum ulteriora promittit. Maximum vivendi impedimentum est exspectatio, quae pendet ex crastino, perdit hodiernum. Quod in manu fortunae positum est disponis, quod in tua, dimittis. Quo spectas? Quo te extendis? Omnia quae ventura sunt in incerto iacent: protinus vive. Clamat ecce maximus vates et velut divino horrore instinctus salutare carmen canit: Optima quaeque dies miseris mortalibus aevi prima fugit. «Quid cunctaris?», inquit, «Quid cessas? Nisi occupas, fugit». Et cum occupaveris, tamen fugiet: itaque cum celeritate temporis utendi velocitate certandum est et velut ex torrenti rapido nec semper ituro cito hauriendum. Hoc quoque pulcherrime ad exprobrandam infinitam cogitationem quod non optimam quamque aetatem sed diem dicit. Quid securus et in tanta temporum fuga lentus menses tibi et annos in longam seriem, utcumque aviditati tuae visum est, exporrigis? De die tecum loquitur et de hoc ipso fugiente. Num dubium est ergo quin prima quaeque optima dies fugiat mortalibus miseris, id est occupatis? Quorum puerilis adhuc animos senectus opprimit, ad quam imparati inermesque perveniunt; nihil enim provisum est: subito in illam necopinantes inciderunt, accedere eam cotidie non sentiebant. Quemadmodum aut sermo aut lectio aut aliqua intentior cogitatio iter facientis decipit et pervenisse ante sciunt quam appropinquasse, sic hoc iter vitae assiduum et citatissimum quod vigilantes dormientesque eodem gradu facimus occupatis non apparet nisi in fine. 10. Quod proposui si in partes velim et argumenta diducere, multa mihi occurrent per quae probem brevissimam esse occupatorum vitam. Solebat dicere Fabianus, non ex his cathedrariis philosophis, sed ex veris et antiquis, «contra affectus impetu, non subtilitate pugnandum, nec minutis vulneribus sed incursu avertendam aciem». Non probabat cavillationes: «enim contundi debere, non vellicari». Tamen, ut illis error exprobretur suus, docendi non tantum deplorandi sunt. In tria tempora vita dividitur: quod fuit, quod est, quod futurum est. Ex his quod agimus breve est, quod acturi sumus dubium, quod egimus certum. Hoc est enim in quod fortuna ius perdidit, quod in nullius arbitrium reduci potest. Hoc
amittunt occupati; nec enim illis vacat praeterita respicere, et si vacet iniucunda est paenitendae rei recordatio. Inviti itaque ad tempora male exacta animum revocant nec audent ea retemptare quorum vitia, etiam quae aliquo praesentis voluptatis lenocinio surripiebantur, retractando patescunt. Nemo, nisi quoi omnia acta sunt sub censura sua, quae numquam fallitur, libenter se in praeteritum retorquet; ille qui multa ambitiose concupiit superbe contempsit, impotenter vicit, insidiose decepit, avare rapuit prodige effudit, necesse est memoriam suam timeat. Atqui haec est pars temporis nostri sacra ac dedicata, omnis humanos casus supergressa, extra regnum fortunae subducta, quam non inopia, non metus, non morborum incursus exagitet; haec nec turbari nec eripi potest; perpetua eius et intrepida possessio est. Singuli tantum dies, et hi per momenta, praesentes sunt; at praeteriti temporis omnes, cum iusseritis, aderunt, ad arbitrium tuum inspici se ac detineri patientur, quod facere occupatis non vacat. Securae et quietae mentis est in omnes vitae suae partes discurrere; occupatorum animi, velut sub iugo sint, flectere se ac respicere non possunt. Abit igitur vita eorum in profundum; et ut nihil prodest, licet quantumlibet ingeras, si non subest quod excipiat ac servet, sic nihil refert quantum temporis detur, si non est ubi subsidat: per quassos foratosque animos transmittitur. Praesens tempus brevissimum est, adeo quidem ut quibusdam nullum videatur; in cursu enim semper est, fluit et praecipitatur; ante desinit esse quam venit, nec magis moram patitur quam mundus aut sidera, quorum irrequieta semper agitatio numquam in eodem vestigio manet. Solum igitur ad occupatos praesens pertinet tempus, quod tam breve est ut arripi non possit, et id ipsum illis districtis in multa subducitur. 11. Denique vis scire quam non diu vivant? Vide quam cupiant diu vivere. Decrepiti senes paucorum annorum accessionem votis mendicant: minores natu se ipsos esse fingunt; mendacio sibi blandiuntur et tam libenter se fallunt quam si una fata decipiant. Iam vero cum illos aliqua imbecillitas mortalitatis admonuit, quemadmodum paventes moriuntur, non tamquam exeant de vita sed tamquam extrahantur. Stultos se fuisse ut non vixerint clamitant et, si modo evaserint ex illa valetudine, in otio victuros; tunc quam frustra paraverint quibus non fruerentur, quam in cassum omnis ceciderit labor cogitant. At quibus vita procul ab omni negotio agitur, quidni spatiosa sit? Nihil ex illa delegatur, nihil alio atque alio spargitur, nihil inde fortunae traditur, nihil neglegentia interit, nihil largitione detrahitur, nihil supervacuum est: tota, ut ita dicam, in reditu est. Quantulacumque itaque abunde sufficit, et ideo, quandoque ultimus dies venerit, non cunctabitur sapiens ire ad mortem certo gradu. 12. Quaeris fortasse quos occupatos vocem? Non est quod me solos putes dicere quos a basilica immissi demum canes eiciunt, quos aut in sua vides turba speciosius elidi aut in aliena contemptius, quos officia domibus suis evocant ut alienis foribus illidant, aut hasta praetoris infami lucro et quandoque suppuraturo exercet. Quorundam otium occupatum est: in villa aut in lecto suo, in media
solitudine, quamvis ab omnibus recesserint, sibi ipsi molesti sunt: quorum non otiosa vita dicenda est sed desidiosa occupatio. Illum tu otiosum vocas qui Corinthia, paucorum furore pretiosa, anxia subtilitate concinnat et maiorem dierum partem in aeruginosis lamellis consumit? Qui in ceromate (nam, pro facinus! ne Romanis quidem vitiis laboramus) spectator puerorum rixantium sedet? Qui iumentorum suorum greges in aetatum et colorum paria diducit? Qui athletas novissimos pascit? Quid? Illos otiosos vocas quibus apud tonsorem multae horae transmittuntur, dum decerpitur si quid proxima nocte succrevit, dum de singulis capillis in consilium itur, dum aut disiecta coma restituitur aut deficiens hinc atque illinc in frontem compellitur? Quomodo irascuntur, si tonsor paulo neglegentior fuit, tamquam virum tonderet! Quomodo excandescunt si quid ex iuba sua decisum est, si quid extra ordinem iacuit, nisi omnia in anulos suos reciderunt! Quis est istorum qui non malit rem publicam turbari quam comam suam? Qui non sollicitior sit de capitis sui decore quam de salute? Qui non comptior esse malit quam honestior? Hos tu otiosos vocas inter pectinem speculumque occupatos? Quid illi qui in componendis, audiendis, discendis canticis operati sunt, dum vocem, cuius rectum cursum natura et optimum et simplicissimum fecit, in flexus modulationis inertissimae torquent, quorum digiti aliquod intra se carmen metientes semper sonant, quorum, cum ad res serias, etiam saepe tristes adhibiti sunt, exauditur tacita modulatio? Non habent isti otium, sed iners negotium. Convivia me hercules horum non posuerim inter vacantia tempora, cum videam quam solliciti argentum ordinent, quam diligenter exoletorum suorum tunicas succingant, quam suspensi sint quomodo aper a coco exeat, qua celeritate signo dato glabri ad ministeria discurrant, quanta arte scindantur aves in frusta non enormia, quam curiose infelices pueruli ebriorum sputa detergeant: ex his elegantiae lautitiaeque fama captatur et usque eo in omnes vitae secessus mala sua illos sequuntur, ut nec bibant sine ambitione nec edant. Ne illos quidem inter otiosos numeraveris qui sella se et lectica huc et illuc ferunt et ad gestationum suarum, quasi deserere illas non liceat, horas occurrunt, quos quando lavari debeant, quando natare, quando cenare alius admonet: usque eo nimio delicati animi languore solvuntur, ut per se scire non possint an esuriant. Audio quendam ex delicatis (si modo deliciae vocandae sunt vitam et consuetudinem humanam dediscere), cum ex balneo inter manus elatus et in sella positus esset, dixisse interrogando: «Iam sedeo?». Hunc tu ignorantem an sedeat putas scire an vivat, an videat, an otiosus sit? Non facile dixerim utrum magis miserear, si hoc ignoravit an si ignorare se finxit. Multarum quidem rerum oblivionem sentiunt, sed multarum et imitantur; quaedam vitia illos quasi felicitatis argumenta delectant; nimis humilis et contempti hominis videtur scire quid facias: i nunc et mimos multa mentiri ad exprobrandam luxuriam puta. Plura me hercules praetereunt quam fingunt et tanta incredibilium vitiorum copia ingenioso in hoc unum saeculo processit, ut iam mimorum arguere possimus neglegentiam. Esse aliquem qui usque eo deliciis interierit ut an sedeat alteri credat! Non est ergo hic otiosus, aliud illi nomen imponas; aeger est, immo
mortuus est; ille otiosus est cui otii sui et sensus est. Hic vero semivivus, cui ad intellegendos corporis sui habitus indice opus est, quomodo potest hic ullius temporis dominus esse? 13. Persequi singulos longum est quorum aut latrunculi aut pila aut excoquendi in sole corporis cura consumpsere vitam. Non sunt otiosi quorum voluptates multum negotii habent. Nam de illis nemo dubitabit quin operose nihil agant, qui litterarum inutilium studiis detinentur, quae iam apud Romanos quoque magna manus est. Graecorum iste morbus fuit quaerere quem numerum Ulixes remigum habuisset, prior scripta esset Ilias an Odyssia, praeterea an eiusdem esset auctoris, alia deinceps huius notae, quae sive contineas nihil tacitam conscientiam iuvant, sive proferas non doctior videaris sed molestior. Ecce Romanos quoque invasit inane studium supervacua discendi; his diebus audivi quendam referentem quae primus quisque ex Romanis ducibus fecisset: primus navali proelio Duilius vicit, primus Curius Dentatus in triumpho duxit elephantos. Etiamnunc ista, etsi ad veram gloriam non tendunt, circa civilium tamen operum exempla versantur; non est profutura talis scientia. Est tamen quae nos speciosa rerum vanitate detineat. Hoc quoque quaerentibus remittamus quis Romanis primus persuaserit navem conscendere (Claudius is fuit, Caudex ob hoc ipsum appellatus quia plurium tabularum contextus caudex apud antiquos vocatur, unde publicae tabulae codices dicuntur etnaves nunc quoque ex antiqua consuetudine quae commeatus per Tiberim subvehunt codicariae vocantur); sane et hoc ad rem pertineat, quod Valerius Corvinus primus Messanam vicit et primus ex familia Valeriorum, urbis captae in se translato nomine, Messana appellatus est paulatimque vulgo permutante litteras Messala dictus: num et hoc cuiquam curare permittes quod primus L. Sulla in circo leones solutos dedit, cum alioquin alligati darentur, ad conficiendos eos missis a rege Boccho iaculatoribus? Et hoc sane remittatur: num et Pompeium primum in circo elephantorum duodeviginti pugnam edidisse commissis more proelii noxiis hominibus, ad ullam rem bonam pertinet? Princeps civitatis et inter antiquos principes (ut fama tradit) bonitatis eximiae memorabile putavit spectaculi genus novo more perdere homines. Depugnant? Parum est. Lancinatur? Parum est: ingenti mole animalium exterantur! Satius erat ista in oblivionem ire, ne quis postea potens disceret invideretque rei minime humanae. O quantum caliginis mentibus nostris obicit magna felicitas! Ille se supra rerum naturam esse tunc credidit, cum tot miserorum hominum catervas sub alio caelo natis beluis obiceret, cum bellum inter tam disparia animalia committeret, cum in conspectum populi Romani multum sanguinis funderet mox plus ipsum fundere coacturus; at idem postea Alexandrina perfidia deceptus ultimo mancipio transfodiendum se praebuit, tum demum intellecta inani iactatione cognominis sui. Sed, ut illo revertar unde decessi et in eadem materia ostendam supervacuam quorundam diligentiam, idem narrabat Metellum, victis in Sicilia Poenis triumphantem, unum omnium Romanorum ante currum centum et viginti captivos elephantos duxisse; Sullam ultimum Romanorum protulisse
pomerium quod numquam provinciali sed Italico agro adquisito proferre moris apud antiquos fuit. Hoc scire magis prodest quam Aventinum montem extra pomerium esse, ut ille affirmabat, propter alteram ex duabus causis, aut quod plebs eo secessisset aut quod Remo auspicante illo loco aves non addixissent, alia deinceps innumerabilia quae aut farta sunt mendaciis aut similia? Nam ut concedas omnia eos fide bona dicere, ut ad praestationem scribant, tamen cuius ista errores minuent? Cuius cupiditates prement? Quem fortiorem, quem iustiorem, quem liberaliorem facient? Dubitare se interim Fabianus noster aiebat an satius esset nullis studiis admoveri quam his implicari. 14. Soli omnium otiosi sunt qui sapientiae vacant, soli vivunt; nec enim suam tantum aetatem bene tuentur: omne aevum suo adiciunt; quicquid annorum ante illos actum est, illis adquisitum est. Nisi ingratissimi sumus, illi clarissimi sacrarum opinionum conditores nobis nati sunt, nobis vitam praeparaverunt. Ad res pulcherrimas ex tenebris ad lucem erutas alieno labore deducimur; nullo nobis saeculo interdictum est, in omnia admittimur et, si magnitudine animi egredi humanae imbecillitatis angustias libet, multum per quod spatiemur temporis est. Disputare cum Socrate licet, dubitare cum Carneade, cum Epicuro quiescere, hominis naturam cum Stoicis vincere, cum Cynicis excedere. Cum rerum natura in consortium omnis aevi patiatur incedere, quidni ab hoc exiguo et caduco temporis transitu in illa toto nos demus animo quae immensa, quae aeterna sunt, quae cum melioribus communia? Isti qui per officia discursant, qui se aliosque inquietant, cum bene insanierint, cum omnium limina cotidie perambulaverint nec ullas apertas fores praeterierint, cum per diversissimas domos meritoriam salutationem circumtulerint, quotum quemque ex tam immensa et variis cupiditatibus districta urbe poterunt videre? Quam multi erunt quorum illos aut somnus aut luxuria aut inhumanitas summoveat! Quam multi qui illos, cum diu torserint, simulata festinatione transcurrant! Quam multi per refertum clientibus atrium prodire vitabunt et per obscuros aedium aditus profugient, quasi non inhumanius sit decipere quam excludere! Quam multi hesterna crapula semisomnes et graves illis miseris suum somnum rumpentibus ut alienum exspectent, vix allevatis labris insusurratum miliens nomen oscitatione superbissima reddent! Hos in veris officiis morari putamus, licet dicant, qui Zenonem, qui pythagoran cotidie et Democritum ceterosque antistites bonarum artium, qui Aristotelen et Theophrastum volent habere quam familiarissimos. Nemo horum non vacabit, nemo non venientem ad se beatiorem, amantiorem sui dimittet, nemo quemquam vacuis a se manibus abire patietur; nocte conveniri, interdiu ab omnibus mortalibus possunt. 15. Horum te mori nemo coget, omnes docebunt; horum nemo annos tuos conterit, suos tibi contribuit; nullius ex his senno periculosus erit, nullius amicitia capitalis, nullius sumptuosa observatio. Feres ex illis quicquid voles; per illos non stabit quominus quantum plurimum cupieris haurias. Quae illum felicitas,
quam pulchra senectus manet, qui se in horum clientelam contulit! Habebit cum quibus de minimis maximisque rebus deliberet, quos de se cotidie consulat, a quibus audiat verum sine contumelia, laudetur sine adulatione, ad quorum se similitudinem effingat. Solemus dicere non fuisse in nostra potestate quos sortiremur parentes, forte nobis datos: nobis vero ad suum arbitrium nasci licet. Nobilissimorum ingeniorum familiae sunt: elige in quam adscisci velis; non in nomen tantum adoptaberis, sed in ipsa bona, quae non erunt sordide nec maligne custodienda: maiora fient quo illa pluribus diviseris. Hi tibi dabunt ad aeternitatem iter et te in illum locum ex quo nemo deicitur sublevabunt. Haec una ratio est extendendae mortalitatis, immo in immortalitatem vertendae. Honores, monumenta, quicquid aut decretis ambitio iussit aut operibus exstruxit cito subruitur, nihil non longa demolitur vetustas et movet; at iis quae consecravit sapientia nocere non potest; nulla abolebit aetas, nulla deminuet; sequens ac deinde semper ulterior aliquid ad venerationem conferet, quoniam quidem in vicino versatur invidia, simplicius longe posita miramur. Sapientis ergo multum patet vita; non idem illum qui ceteros terminus cludit; solus generis humani legibus solvitur omnia illi saecula ut deo serviunt. Transiit tempus aliquod? Hoc recordatione comprendit; instat? Hoc utitur; venturum est? Hoc praecipit. Longam illi vitam facit omnium temporum in unum collatio. 16. Illorum brevissima ac sollicitissima aetas est qui praeteritorum obliviscuntur, praesentia neglegunt, de futuro timent: cum ad extrema venerunt, sero intellegunt miseri tam diu se dum nihil agunt occupatos fuisse. Nec est quod hoc argumento probari putes longam illos agere vitam, quia interdum mortem invocant: vexat illos imprudentia incertis affectibus et incurrentibus in ipsa quae metuunt; mortem saepe ideo optant quia timent. Illud quoque argumentum non est quod putes diu viventium, quod saepe illis longus videtur dies, quod, dum veniat condictum tempus cenae tarde ire horas queruntur; nam si quando illos deseruerunt occupationes, in otio relicti aestuant nec quomodo id disponant ut extrahant sciunt. Itaque ad occupationem aliquam tendunt et, quod interiacet omne tempus grave est, tam me hercules quam cum dies muneris gladiatorii edictus est, aut cum alicuius alterius vel spectaculi vel voluptatis expectatur constitutum, transilire medios dies volunt. Omnis illis speratae rei longa dilatio est: at illud tempus quod amant breve est et praeceps breviusque multo suo vitio; aliunde enim alio transfugiunt et consistere in una cupiditate non possunt. Non sunt illis longi dies, sed invisi; at contra quam exiguae noctes videntur, quas in complexu scortorum aut vino exigunt! Inde etiam poetarum furor fabulis humanos errores alentium, quibus visus est Iuppiter voluptate concubitus delenitus duplicasse noctem; quid aliud est vitia nostra incendere quam auctores illis inscribere deos et dare morbo exemplo divinitatis excusatam licentiam? Possunt istis non brevissimae videri noctes quas tam care mercantur? Diem noctis exspectatione perdunt, noctem lucis metu.
17. Ipsae voluptates eorum trepidae et variis terroribus inquietae sunt subitque cum maxime exsultantis sollicita cogitatio: «Haec quam diu?». Ab hoc affectu reges suam flevere potentiam, nec illos magnitudo fortunae suae delectavit, sed venturus aliquando finis exterruit. Cum per magna camporum spatia porrigeret exercitum nec numerum eius sed mensuram comprenderet Persarum rex insolentissimus lacrimas profudit, quod intra centum annos nemo ex tanta iuventute superfuturus esset; at illis admoturus erat fatum ipse qui flebat perditurusque alios in mari alios in terra, alios proelio alios fuga, et intra exiguum tempus consumpturus illos quibus centesimum annum timebat. Quid quod gaudia quoque eorum trepida sunt? Non enim solidis causis innituntur, sed eadem qua oriuntur vanitate turbantur. Qualia autem putas esse tempora etiam ipsorum confessione misera, cum haec quoque quibus se at tollunt et super hominem efferunt parum sincera sint? Maxima quaeque bona sollicita sunt nec ulli fortunae minus bene quam optimae creditur; alia felicitate ad tuendam felicitatem opus est et pro ipsis quae successere votis vota facienda sunt. Omne enim quod fortuito obvenit instabile est: quod altius surrexerit, opportunius est in occasum. Neminem porro casura delectant; miserrimam ergo necesse est, non tantum brevissimam vitam esse eorum qui magno parant labore quod maiore possideant. Operose assequuntur quae volunt, anxii tenent quae assecuti sunt; nulla interim numquam amplius redituri temporis ratio est: novae occupationes veteribus substituuntur, spes spem excitat, ambitionem ambitio. Miseriarum non finis quaeritur, sed materia mutatur. Nostri nos honores torserunt? Plus temporis alieni auferunt; candidati laborare desiimus? Suffragatores incipimus; accusandi deposuimus molestiam? Iudicandi nanciscimur; iudex desiit esse? Quaesitor est; alienorum bonorum mercennaria procuratione consenuit? Suis opibus distinetur. Marium caliga dimisit? Consulatus exercet; Quintius dictaturam properat pervadere? Ab aratro revocabitur. Ibit in Poenos nondum tantae maturus rei Scipio; victor Hannibalis victor Antiochi, sui consulatus decus fraterni sponsor, ni per ipsum mora esset, cum Iove reponeretur: civiles servatorem agitabunt seditiones et post fastiditos a iuvene diis aequos honores iam senem contumacis exilii delectabit ambitio. Numquam derunt vel felices vel miserae sollicitudinis causae; per occupationes vita trudetur; otium numquam agetur, semper optabitur. 18. Excerpe itaque te vulgo, Pauline carissime, et in tranquilliorem portum non pro aetatis spatio iactatus tandem recede. Cogita quot fluctus subieris, quot tempestates partim privatas sustinueris, partim publicas in te converteris; satis iam per laboriosa et inquieta documenta exhibita virtus est; experire quid in otio faciat. Maior pars aetatis, certe melior rei publicae datast: aliquid temporis tui sume etiam tibi. Nec te ad segnem aut inertem quietem voco, non ut somno et caris turbae voluptatibus quicquid est in te indolis vividae mergas; non est istud adquiescere: invenies maiora omnibus adhuc strenue tractatis operibus, quae repositus et securus agites. Tu quidem orbis terrarum rationes administras tam abstinenter quam alienas, tam diligenter quam tuas, tam religiose quam publicas.
In officio amorem consequeris, in quo odium vitare difficile est; sed tamen, mihi crede, satius est vitae suae rationem quam frumenti publici nosse. Istum animi vigorem rerum maximarum capacissimum a ministerio honorifico quidem sed parum ad beatam vitam apto revoca, et cogita non id egisse te ab aetate prima omni cultu studiorum liberalium ut tibi multa milia frumenti bene committerentur; maius quiddam et altius de te promiseras. Non derunt et frugalitatis exactae homines et laboriosae operae; tanto aptiora portandis oneribus tarda iumenta sunt quam nobiles equi, quorum generosam pernicitatem quis umquam gravi sarcina pressit? Cogita praeterea quantum sollicitudinis sit ad tantam te molem obicere: cum ventre tibi humano negotium est; nec rationem patitur nec aequitate mitigatur nec ulla prece flectitur populus esuriens. Modo modo intrapaucos illos dies quibus C. Caesar periit (si quis inferis sensus est); hoc gravissime ferens quod decedebat populo Romano superstite; septem aut octo certe dierum cibaria superesse! Dum ille pontes navibus iungit et viribus imperi ludit, aderat ultimum malorum obsessis quoque, alimentorum egestas; exitio paene ac fame constitit et, quae famem sequitur, rerum omnium ruina furiosi et externi et infeliciter superbi regis imitatio. Quem tunc animum habuerunt illi quibus erat mandata frumenti publici cura, saxa, ferrum, ignes, Gaium excepturi? Summa dissimulatione tantum inter viscera latentis mali tegebant, cum ratione scilicet: quaedam enim ignorantibus aegris curanda sunt, causa multis moriendi fuit morbum suum nosse. 19. Recipe te ad haec tranquilliora, tutiora, maiora! Simile tu putas esse, utrum cures ut incorruptum et a fraude advehentium et a neglegentia frumentum transfundatur in horrea, ne concepto umore vitietur et concalescat, ut ad mensuram pondusque respondeat, an ad haec sacra et sublimia accedas sciturus quae materia sit dei, quae voluntas quae condicio, quae forma, quis animum tuum casus exspectet ubi nos a corporibus dimissos natura componat; quid sit quod huius mundi gravissima quaeque in medio sustineat, supra levia suspendat, in summum ignem ferat, sidera vicibus suis excitet; cetera deinceps ingentibus plena miraculis? Vis tu relicto solo mente ad ista respicere! Nunc, dum calet sanguis, vigentibus ad meliora eundum est. Exspectat te in hoc genere vitae multum bonarum artium, amor virtutum atque usus, cupiditatum oblivio, vivendi ac moriendi scientia, alta reum quies. 20. Omnium quidem occupatorum condicio misera est, eorum tamen miserrima, qui ne suis quidem laborant occupationibus, ad alienum dormiunt somnum, ad alienum ambulant gradum, amare et odisse, res omnium liberrimas, iubentur. Hi si volent scire quam brevis ipsorum vita sit, cogitent ex quota parte sua sit, Cum videris itaque praetextam saepe iam sumptam, cum celebre in foro nomen, ne invideris: ista vitae damno parantur. Ut unus ab illis numeretur annus, omnis annos suos conterent, Quosdam antequam in summum ambitionis eniterentur, inter prima luctantis aetas reliquit; quosdam, cum in consummationem dignitatis per mille indignitates erepsissent, misera subiit cogitatio laborasse
ipsos in titulum sepulcri; quorundam ultima senectus dum in novas spes ut iuventa disponitur, inter conatus magnos et improbos invalida defecit. Foedus ille quem in iudicio pro ignotissimis litigatoribus grandem natu et imperitae coronae assensiones captantem spiritus liquit; turpis ille qui vivendo lassus citius quam laborando inter ipsa officia collapsus est; turpis quem accipiendis immorientem rationibus diu tractus risit heres. Praeterire quod mihi occurrit exemplum non possum: Turannius fuit exactae diligentiae senex, qui post annum nonagesimum, cum vacationem procurationis ab C. Caesare ultro accepisset, componi se in lecto et velut exanimem a circumstante familia plangi iussit. Lugebat domus otium domini senis nec finivit ante tristitiam quam labor illi suus restitutus est. Adeone iuvat occupatum mori? Idem plerisque animus est; diutius cupiditas illis laboris quam facultas est; cum imbecillitate corporis pugnant, senectutem ipsam nullo alio nomine gravem iudicant quam quod illos seponit. Lex a quinquagesimo anno militem non legit, a sexagesimo senatorem non citat: difficilius homines a se otium impetrant quam a lege. Interim dum rapiuntur et rapiunt; dum alter alterius quietem rumpit, dum mutuo miseri sunt, vita est sine fructu, sine voluptate, sine ullo profectu animi; nemo in conspicuo mortem habet, nemo non procul spes intendit, quidam vero disponunt etiam illa quae ultra vitam sunt, magnas sepulcrorum et operum publicorum dedicationes et ad rogum munera et ambitiosas exsequias. At me hercules istorum funera, tamquam minimum vixerint, ad faces et cereos ducenda sunt.
Come vivere a lungo
Premessa Nel De brevitate vitae – dedicato a Paolino (forse il padre della sua seconda moglie, praefectus annonae, cioè sovrintendente agli approvvigionamenti) e composto secondo alcuni fra il 49 e il 50, dopo il ritorno dall’esilio, secondo altri verso il 62, dopo il ritiro dalla vita politica – Seneca nega che la vita sia breve, sostenendo che essa appare tale a chi non ne fa buon uso, ma che in effetti è satis longa, abbastanza lunga, anzi, large data, anche troppo abbondante, per coloro che sanno spenderla bene. E precisa che siamo noi che rendiamo breve la vita, impegnando in attività pubbliche o private e dedicando agli altri quel tempo che dovremmo invece dedicare a noi stessi. Torna il tema dell’ otium, della vita meditativa, la quale, mentre nel De otio costituisce un’alternativa a quella attiva, qui risulta essere l’unica ed esclusiva via per vivere una vita lunga e spesa bene. Il dialogo sembra un elogio dell’egoismo. «Tutti quelli che ti chiamano in loro aiuto ti allontanano da te», dice Seneca, e ci presenta il prossimo come una massa di ladri che «ci derubano del nostro tempo». Sembra che per Seneca qualunque attività svolta al servizio degli altri sia inutile, se definisce «miserie» (per quanto «decorose», VII, 6) persino i processi, cioè la professione di avvocato. Certo, la vita dev’essere spesa bene, perché il tempo è denaro, e Seneca, con l’aria più di un ragioniere che di un filosofo, fa il conto di tutti i pezzetti di tempo, sprecati, che diamo agli altri e sottraiamo a noi, concludendo che anche morendo centenari in realtà non viviamo che pochi anni e che riserviamo a noi stessi gli scarti, i rimasugli della nostra vita. In sostanza Seneca non fa che ripetere lo stesso concetto, che la vita non è breve e che bisogna spenderla a nostro esclusivo uso e consumo, e ciò allungando il discorso con digressioni lunghe e inutili, che allontanano dal tema e fanno perdere il filo. Ma gli faremmo un torto se non riconoscessimo che in questo dialogo non mancano delle belle pagine, quali quelle sugli affaccendati, che ci offrono il quadro come di un grande circo in cui si esibiscono nelle loro varie specialità gli acrobati della vita, dai più ai meno impegnati, dai più ai meno spericolati, tutti lì a mettere in mostra le loro capacità. E però su di loro non si stende un sorriso bonario, di comprensione, d’indulgenza e d’amore, e la satira, se c’è, è più vicina al disprezzo, è un sarcasmo pungente, che suona solo biasimo e condanna. Quanto allo stile, anche qui, forse più accentuati, gli stessi inconvenienti, che, a voler offrire una visione chiara, pulita e precisa del testo, inducono ad andare al di là di una semplice traduzione letterale. Valga un esempio per tutti: l’espressione nobis vero ad suum arbitrium nasci licet non può essere tradotta «a noi (virtuosi) è lecito nascere come vogliamo», o «gli uomini buoni hanno la facoltà di nascere per propria scelta»; il senso è che «chi segue la virtù può eleggere a suoi genitori chiunque voglia». Non inorridiscano dunque gli esperti se ci siamo permessi certe libertà, in questa come nelle altre traduzioni di Seneca. M. S. A.
1. La maggior parte degli uomini, o Paolino, rimprovera alla natura di essere stata avara con noi per averci dato una vita così breve e così veloce che, salvo pochissime eccezioni, ci abbandona proprio mentre ci accingiamo a sperimentarla. Questo fatto, che tutti considerano una disgrazia, provoca il risentimento e le lamentele non solo del volgo ignorante ma persino di uomini colti e famosi, che hanno la medesima sensazione della gente comune. Da qui quel celebre detto di Ippocrate1 il più grande dei medici: «La vita è breve, l’arte è lunga». Da qui l’accusa – sciocca per un sapiente – che Aristotele mosse alla natura, rimproverandole di essere stata tanto generosa con gli animali da
consentir loro un’esistenza lunga anche più di cinque o dieci generazioni delle nostre e di aver dato all’uomo, che pur ha destinato a imprese tanto grandi e numerose, un periodo assai più corto.2 Ma il tempo che ci è stato assegnato non è poco, di per sé, siamo noi che ne perdiamo molto. La vita è sufficientemente lunga, anzi più che abbondante anche per realizzare le più grandi e difficili imprese, purché si sappia spenderla bene dall’inizio alla fine. Ma quando la passiamo fra gli agi e l’indolenza o non la utilizziamo per niente di buono e vantaggioso, giunti alla resa dei conti, mentre prima non la sentivamo nemmeno scorrere, allora sì ci sembra che sia volata in un lampo. È proprio così: la nostra vita non è breve, siamo noi che la rendiamo tale; non è che lei sia tirchia, siamo noi che la dissipiamo. Come immense e regali ricchezze, se capitano in mano di un cattivo padrone, spariscono in un battibaleno, mentre capitali anche modesti, se affidati a un buon amministratore, aumentano, per gli utili che se ne sanno trarre, così la nostra vita riesce molto lunga a chi sa farla fruttare. 2. Perché dunque ci lamentiamo della natura? Lei si è comportata bene con noi, ci ha dato una vita lunga, se sappiamo spenderla bene. Senonché accade che uno non è mai sazio di niente, un altro si applica con frenetica operosità a lavori superflui, un altro ancora si sbronza dalla mattina alla sera, e c’è chi è intorpidito dall’inerzia, chi si macera per l’ambizione, sempre condizionata ai giudizi degli altri, chi smania per il commercio e va in giro per terre e per mari nella speranza di far quattrini; alcuni, spiriti bellicosi, sono sempre attenti ai pericoli del prossimo o preoccupati dei propri, altri si consumano in una volontaria schiavitù, adulando i loro superiori senza ricavarne la minima gratitudine, molti sono presi dalla bellezza altrui o si danno pensiero della propria; parecchi, poi, non avendo uno scopo preciso, incostanti e scontenti di sé stessi, passano da un proposito all’altro senza concludere niente, oppure vagano a caso, insoddisfatti di tutto, sì che la morte alla fine li coglie così spossati e pieni di sonno che mi sembra verissimo quanto, a mo’ d’un oracolo, dice il sommo poeta, che cioè «Noi viviamo veramente solo una piccola parte della nostra vita»:3 tutto il resto, infatti, non è un vivere ma un passare il tempo. I vizi incalzano e ci aggrediscono da ogni parte, né ci consentono di sollevarci e alzare gli occhi alla luce del vero. Essi opprimono a tal punto coloro che sono immersi e tesi nelle proprie passioni che non gli permettono di tornare in sé stessi, e se mai hanno un minuto di respiro, costoro continuano a ondeggiare, come fa il mare profondo, dove, anche quando il vento è cessato, le acque restano agitate. Non c’è tregua alle loro passioni. E non parlo di quelli i cui mali sono evidenti e sotto gli occhi di tutti, ma di coloro che richiamano gente intorno a sé perché ritenuti felici, mentre in realtà sono soffocati dai loro stessi beni. A quanti non sono di peso le ricchezze! A quanti ancora l’eloquenza e la continua preoccupazione di mettere in mostra il proprio ingegno non fanno sputar sangue! Alcuni diventano addirittura cadaverici per i continui piaceri e altri non hanno più un briciolo di libertà, attorniati come sono quotidianamente dalla folla
incalzante dei clienti. Ebbene, passali in rassegna tutti costoro, dai più umili ai più potenti; uno fa l’avvocato, un altro lo cerca, questo è accusato, quello lo difende e quell’altro lo giudica: nessuno è libero di badare a sé stesso ma ognuno si dà da fare e si consuma per un altro. Prendi quei personaggi dai nomi altisonanti, informati su di loro e vedrai che ciò che li distingue è il fatto che ciascuno di loro si dedica a un altro, ma nessuno di essi si appartiene, nessuno è padrone di sé stesso. È dunque irragionevole chi s’indigna e si duole perché il suo superiore non si cura di lui né trova il tempo di riceverlo quando chiede di parlargli: con quale coraggio si lamenta del disinteresse che gli dimostra il suo capo se lui non ha neppure un momentino da dedicare a sé stesso? Quello, almeno, sia pure con fare sprezzante, qualche occhiata gliela lancia, ascolta la sua voce, lascia persino che gli cammini al fianco, mentre lui non si degna e non si è mai degnato d’intrattenersi un poco con sé stesso, di guardarsi dentro, di ascoltarsi. Non possiamo dunque pretendere che gli altri si occupino di noi, dal momento che quando noi ci occupiamo degli altri lo facciamo unicamente perché non sappiamo o non vogliamo prenderci cura di noi stessi. 3. I più splendidi ingegni del passato, per quanto concordino tutti su questo argomento e lo diano per scontato, non finirebbero mai di stupirsene e di rilevare con meraviglia quanto sia ottusa e incoerente la mente degli uomini, i quali da un lato non permettono agli altri d’invadere le loro proprietà e se mai sorge la minima lite per questioni di confine come niente reagiscono a colpi di pietre o di spada, dall’altro gli consentono di entrare nella loro vita, anzi, di farne man bassa come se ne fossero i padroni, non sono disposti a dividere con nessuno il proprio denaro e poi distribuiscono la loro esistenza a centinaia di persone, tirchi coi propri beni materiali, prodighi del loro tempo, quando invece dovrebbero esserne avari. Prendi a caso uno dei più vecchi e digli: «Ora che sei giunto al limite estremo della vita umana, dato che hai cent’anni e forse più, torna un po’ indietro e calcola quanto di tutto questo tempo ti ha tolto un creditore, quanto l’amante, quanto il tuo capo, quanto i tuoi dipendenti4 e i litigi con tua moglie, le punizioni inflitte alla servitù, l’andare in giro per la città a render visite di cortesia, e ancora tutti quegli accidenti che ti sei procurato con le tue stesse mani, nonché il tempo che hai lasciato inutilizzato: tira le somme e guarda quanto sono pochi gli anni in cui sei vissuto per te, di fronte a quelli che hai. Cerca poi di ricordare quante volte sei stato fermo nei tuoi propositi, quanti giorni ti sono trascorsi come avevi stabilito, quanto tempo hai dedicato a te stesso e quante volte è rimasto impassibile il tuo volto e intrepido il tuo animo, che cos’hai in concreto realizzato in così lungo tempo, quante persone ti hanno derubato della tua vita senza che tu nemmeno ti accorgessi di ciò che perdevi, quanto tempo ti hanno sottratto un dolore vano, una gioia stupida, un desiderio insaziabile, una conversazione frivola, e vedrai quanto poco ti è rimasto del tuo: comprenderai allora che pur con una vita così lunga la tua morte è precoce». Ora, qual è la causa di tutto questo? È il fatto che noi viviamo come se
dovessimo vivere sempre, non riflettiamo mai che siamo esseri fragili, non consideriamo quanto tempo è passato ma lo consumiamo come se lo avessimo sempre tutto intero e persino in abbondanza, senza pensare che quel giorno che regaliamo a qualcuno o a qualche cosa potrebbe essere l’ultimo della nostra esistenza. Abbiamo paura di tutto in quanto esseri mortali ma nello stesso tempo vogliamo avere tutto come se fossimo immortali. «A cinquant’anni mi ritirerò dagli affari, a sessanta non muoverò più un dito!». Così dice la maggior parte. Ma chi ci garantisce di vivere più a lungo, o solo di arrivarci, a quell’età? Chi mai può assicurarci che le cose ci vadano secondo i nostri piani? Non è vergognoso che riserviamo a noi stessi solamente gli scarti, i rimasugli della nostra vita e ci volgiamo a nobili pensieri solo perché non possiamo più dedicarci ad alcuna attività pratica? Non è tardivo il pensare di poter cominciare a vivere proprio quando è giunta l’ora di togliere il disturbo? Quale grande sciocchezza dimenticarsi d’essere mortali e rinviare i saggi propositi a cinquanta o a sessant’anni, pretendendo d’iniziare la vita a un’età a cui solo pochissimi riescono ad arrivare! 4. Uomini potentissimi, che sono giunti alle più alte vette, vagheggiano una vita tranquilla e ritirata, preferendola persino a tutti i loro beni; se potessero farlo senza riceverne danno scenderebbero volentieri dal loro piedistallo, perché, anche se niente la minaccia o la scuote dal di fuori, la buona sorte a un certo punto crolla per il suo stesso peso. Il divino Augusto, ch’ebbe dalla fortuna più di qualunque altro mortale, non smise mai di desiderare la quiete di una vita dedicata interamente a sé stesso,5 di chiedere anzi l’esonero dagli affari politici e non c’era un suo discorso in cui non tornasse a battere sempre su questo chiodo: il pensiero, anche se illusorio, di potere un giorno vivere soltanto per sé stesso gli era già motivo di conforto e alleviava le sue fatiche. In una sua lettera al Senato, in cui assicurava che il suo ritiro non sarebbe stato privo di dignità né in contrasto con quella gloria che s’era ormai conquistato, ho trovato queste parole: «So benissimo che questo mio desiderio è più facile a concepirsi che a realizzarsi, e tuttavia l’attesa di quel momento tanto sognato si è fatta in me così viva che, se mi tarda la gioia, m’è già dolce il solo parlarne». La quiete di una vita privata gli sembrava una tale conquista che non potendo metterla in atto la pregustava col pensiero. Lui, che vedeva tutto dipendere solo dalla sua volontà, lui, che fissava i destini di singoli uomini e di popoli interi, si beava al pensiero che un giorno si sarebbe spogliato di tutta quella grandezza. Sapeva, per averlo sperimentato sulla sua pelle, quanto sudore e quanta fatica si nascondano dietro quei beni che splendono in ogni parte del mondo, quante segrete apprensioni: costretto a impugnare le armi prima contro i suoi concittadini, poi contro i colleghi e infine contro i parenti, sparse sangue per terra e per mare. Spinto attraverso la Macedonia, la Sicilia, l’Egitto, la Siria, l’Asia e quasi per il mondo intero, volse i suoi molti eserciti, stanchi di stragi fraterne, a guerre esterne e lontane. E mentre placava le Alpi e domava i nemici annidati nell’impero ormai
pacificato e spostava i confini dello Stato oltre il Reno, l’Eufrate e il Danubio, proprio a Roma si affilavano contro di lui i pugnali di Murena, di Cepione, di Lepido, di Egnazio e di altri. E non aveva ancora sventato le insidie di costoro che la figlia e molti giovani dell’aristocrazia, uniti nell’adulterio come da un vincolo sacro, riempivano di timori la sua già debole vecchiaia, e poi Iullo con la sua donna, una nuova coppia temibile come quella di Antonio e Cleopatra. 6 Non aveva esitato a troncarsi le membra per togliersi di dosso quelle piaghe incancrenite, ma altre se ne formavano, così come in un corpo gravato dal troppo sangue c’è sempre qualche punto in cui scoppia una nuova emorragia. Perciò voleva ritirarsi e unico sollievo alle sue pene era il pensiero di poterlo fare. Questo il desiderio di uno che poteva appagare tutti quelli degli altri. 5. E Cicerone? Sballottato fra Clodii, Crassi, Pompei e Catilina, quali aperti nemici, quali amici malsicuri, lui che in mezzo alla tempesta s’aggrappava al timone della repubblica perché questa non affondasse, e alla fine fu travolto insieme a lei, lui mai contento nella buona sorte e insofferente nelle avversità, quante volte maledisse, dopo averne tessuto le lodi (giustamente ma senza misura), quel suo famoso consolato! Senti quanta tristezza in una sua lettera indirizzata ad Attico quando, vinto Pompeo, il figlio di questi riaccendeva in Spagna la lotta: «Tu mi domandi», scrive, «che cosa faccio ora? Vivo attendendo gli eventi, qui, nella mia villa di Tuscolo, dimezzato della mia libertà». E altro dice ancora, da cui balza evidente che rimpiange il passato, si duole del presente, dispera del futuro.7 «Libero solo a metà»: così si definiva Cicerone! Ma, perdìo, come può un saggio degradarsi a tal punto da dichiarare dimezzata la sua libertà, quando egli è sempre interamente e saldamente libero, indipendente, padrone di sé e signore di tutti gli altri? Nulla infatti può esserci al di sopra di chi è al di sopra della sorte stessa. 6. E Livio Druso? Uomo duro e violento, dopo aver dato il via a nuove leggi8 e a nuovi disastri, che ricordavano il tempo dei Gracchi, attorniato da una folla immensa proveniente da ogni parte d’Italia, incapace di prevedere l’esito di una situazione che gli era sfuggita di mano e che una volta avviata non lo lasciava più libero di ritirarsi, maledisse quella sua vita sempre agitata, esclamando – così dicono – che neppure da bambino aveva avuto un giorno di riposo. Era infatti ancora sotto tutela e indossava la pretesta quando si prese a cuore la sorte di alcuni imputati al punto che osò raccomandarli ai giudici, sui quali esercitò una tale influenza da trarre dalla sua parte più di un verdetto. Un’ambizione così precoce sarebbe certo andata molto lontano ed era prevedibile che quella sua sfrontatezza di adolescente avrebbe provocato molti e seri guai non solo ai singoli cittadini ma all’intera collettività. Troppo tardi perciò si lamentava di non avere avuto neppure un giorno di vacanza fin da ragazzo, lui, istigatore di disordini e molesto alla giustizia. È dubbio se si sia ucciso, vibrando il colpo di propria mano, sappiamo solo che improvvisamente piombò a terra per una ferita
all’inguine, mentre qualcuno si domandava se la sua morte fosse volontaria, nessuno però se cadesse a proposito. Non serve ch’io riporti qui altri esempi di uomini che, felicissimi in apparenza, fecero aperta confessione di sé, maledicendo pubblicamente tutto ciò che avevano fatto nell’intero corso degli anni, e però tutte le loro lacrime di coccodrillo non valsero a modificarli, né a cambiare la condotta degli altri: solo a parole, infatti, riusciamo a liberarci dalle nostre passioni; dopo lo sfogo verbale ce le ritroviamo addosso come prima. Campassimo pure più di mille anni la nostra vita ci sembrerà sempre breve, se non sapremo spenderla bene: con simili difetti qualunque età si logora troppo presto. La natura fa scorrere rapidamente il tempo della nostra esistenza, ma la ragione può prolungarlo: è inevitabile che la vita scivoli via veloce a chi non cerca di acchiapparla, di trattenerla, o perlomeno di farla procedere più lentamente, ma la lascia passare così, lei, la più rapida di tutte le cose, come un bene superfluo o recuperabile. 7. Primi fra tutti vengono coloro che passano il tempo fra i piaceri del vino e della carne: non c’è infatti occupazione più degradante di questa. Quanto a quelli che sono accecati da vani sogni di gloria, essi sbagliano, sì, ma, almeno apparentemente, non mancano di una certa nobiltà d’animo; aggiungi a questi gli avari, gl’iracondi, i fomentatori di odi feroci e di guerre: ebbene tutti costoro, anche nel peccato, sono sempre uomini, ma quelli che si «abbassano ai piaceri del ventre e della carne, che cedono agl’istinti più brutali, non hanno alcuna giustificazione, la loro colpa è la più infame. E guarda come passano la giornata, conta il tempo che spendono nel fare calcoli, nel macchinare imbrogli, nel nutrire le loro paure, nel dare e nel ricevere onoranze e cortesie, nell’impegnarsi, ancora, nei processi, a garanzia degli altri o di sé stessi, e, infine, nei banchetti, che a quel punto diventano degli obblighi: vedrai come tutti questi impegni, buoni o cattivi che siano, non gli lascino un attimo di respiro. Tieni poi presente – e in ciò sono tutti d’accordo – che chi è troppo indaffarato non può svolgere bene nessuna attività e tanto meno alcune, come l’eloquenza e gli studi liberali, perché una mente impegnata in mille cose non può concepire nobili pensieri, o li respinge, come se le venissero ficcati dentro a forza. Per l’uomo sempre occupato niente conta così poco quanto la vita: perché non la conosce; e in verità l’arte del vivere è certamente la più difficile. Quanto alle altre, di maestri ce ne sono molti e dovunque, né mancano bambini, a quel che sembra, che riescono ad apprenderle e così bene da poterle persino insegnare. Per imparare a vivere, invece, ci vuole una vita intera, ma la cosa più sorprendente è che per tutta la vita bisogna imparare a morire. Tanti uomini illustri, dopo essersi sbarazzati di tutto ciò che poteva intralciarli, ricchezze, impegni, piaceri, dedicarono gli ultimi anni unicamente ad apprendere l’arte del vivere, e tuttavia molti di essi nel partirsi da questo mondo confessarono di non averla ancora imparata. Figurarsi dunque quelli che sono sempre affaccendati! Credi a me, è proprio di un animo grande, che sta al di sopra di ogni errore umano, non lasciarsi sottrarre nemmeno
la più piccola parte del tempo che gli appartiene, e perciò la sua vita alla fine gli risulta lunghissima, perché l’ha spesa interamente come un bene tutto suo, ne ha sfruttato ogni più piccolo spazio, non ha poltrito un solo momento, non è mai stato in balìa di altri, perché da buon risparmiatore non ha trovato nulla che meritasse d’essere scambiato col suo tempo, e questo, quindi, gli è bastato. Non basta invece a coloro che si lasciano portare via dalla gente molta parte della propria esistenza. Non credere però che essi qualche volta non si rendano conto di quello che perdono: ve ne sono molti, infatti, che sotto il peso di un’eccessiva fortuna, fra clienti che gli si accalcano intorno, nel bel mezzo di un processo o fra altre simili miserie, anche se decorose, non di rado se ne vengono fuori esclamando: «A me non è permesso vivere!». E chi te lo impedisce? Tutti quelli che ti chiamano in loro aiuto ti allontanano da te. Quanti giorni ti ha portato via quell’imputato? Quanti quel candidato? Quanti quella vecchietta, stanca di seppellire i suoi eredi? E quel tale che si fingeva ammalato per saggiare e stuzzicare l’ingordigia dei cacciatori di testamenti?9 E quell’amico ultrapotente che ti teneva impegnato accanto a sé, insieme ad altri bellimbusti, unicamente per pavoneggiarsi? Ebbene, fa’ l’elenco e poi tira le somme, vedrai quanti pochi giorni, e solo quelli di scarto, sono rimasti per te stesso. Uno, ottenuti i fasci che tanto desiderava, non vede l’ora di restituirli e va ripetendo: «Ma quando finisce quest’anno?», un altro organizza i giochi e considera una gran fortuna l’essere stato prescelto a quello scopo, e intanto si va chiedendo: «Quando potrò liberarmene?», un altro ancora, conteso da tutti per la sua fama di avvocato, raccoglie nei processi una tale folla di gente che quelli che stanno in fondo non riescono nemmeno a sentirlo, eppure dice: «Ma quando arrivano queste ferie?». Sprechiamo la nostra vita accelerandone la fine, e, disgustati del presente, ci angustiamo per il futuro. Ma chi dedica ogni istante del suo tempo ad arricchire sé stesso, chi organizza le sue giornate come se ciascuna di esse fosse una vita intera non ha bisogno di sperare nel domani, né tanto meno lo teme: quale nuovo piacere potrebbe infatti apportargli? Tutto gli è noto, tutto ha già gustato, sino alla sazietà, ormai si è messo al sicuro: del tempo che gli resta disponga, come vuole, la Fortuna, la quale non può più togliere nulla alla sua vita, può solo aggiungervi qualcosa, come un poco di cibo a chi ne è già pieno, e lui lo prende, ma senz’alcun desiderio. La lunghezza della vita non si misura quindi dai capelli bianchi o dalle rughe: non è un vivere questo, è solo un esistere a lungo. Così non si può dire che abbia navigato molto chi, appena uscito dal porto, incappato in una tempesta e spinto da venti contrari, non ha fatto altro che girare su sé stesso entro il medesimo spazio: questo non si chiama navigare, ma essere molto sballottato. 8. Mi meraviglio sempre quando vedo uno chiedere a un altro di concedergli un po’ del suo tempo e la facilità con cui questo viene accordato. Entrambi guardano solo allo scopo a cui quel tempo è destinato, non al tempo in sé stesso: lo si chiede e lo si dà come se fosse una cosuccia da niente, si scherza col bene
più prezioso che ci sia, di cui non ci si rende conto perché è immateriale, perché non lo si vede, e perciò lo si stima pochissimo, anzi non gli si dà nessun valore. Le pensioni, le donazioni, quelle sì che hanno un prezzo e si ricevono volentieri, e per ottenerle si spendono lavoro, fatica e ogni cura; al tempo invece non si riconosce alcun valore, nessuno ne fa il conto, tutti lo usano con troppa larghezza, quasi che fosse un bene da nulla. Quando però sono malate, o si trovano in pericolo di morte, quelle stesse persone che sino a poco prima non si curavano del tempo, vedi come s’attaccano alle ginocchia dei medici, scongiurandoli di guarirle, e se magari temono di poter essere giustiziate per qualche colpa commessa sono pronte a sacrificare tutti i loro beni pur di continuare a vivere. Tale è l’incoerenza dell’animo umano! Se si potesse conoscere il numero degli anni futuri, come avviene per quelli passati, quante persone tremerebbero vedendo che gliene restano pochi, e con quale parsimonia li spenderebbero! È facile gestire un bene, per quanto piccolo, quando è sicuro, ma con uno di cui non si conosce la durata si dovrebbe usare maggiore diligenza. Tu mi dirai che, sotto sotto, tutti, chi più chi meno, riconoscono il valore del tempo. Sì, ma in che modo? Quelli che dichiarano, per esempio, di essere disposti a dare la propria vita per le persone che amano, in realtà non sanno quel che dicono, non si rendono conto che morendo si privano di un bene senza che se ne giovino gli altri, anzi, non possono nemmeno sapere, una volta morti, che si sono tolti qualcosa, sicché accettano una perdita che in effetti non c’è. Nessuno può rifonderti i tuoi anni perduti, nessuno mai potrà restituirti nuovamente a te stesso. La vita di ognuno prosegue il suo cammino lungo la strada segnata e non s’arresta né ritorna indietro: non fa rumore, non dà segno alcuno della sua rapidità, scivola via in silenzio. Né potere di re né favore di popolo potranno prolungarla, rispetterà la sua andatura così com’è iniziata il primo giorno, senza deviazioni e senza ritardi di sorta. Cosa accadrà in avvenire nessuno può saperlo. Indugiamo su questo e su quello e la vita invece ha fretta, e un bel momento arriverà la morte, alla quale, volenti o non volenti, siamo votati tutti. 9. Non c’è poi cosa più sciocca che il programmarsi la vita:10 in questo modo si è ancora più affaccendati. E ce ne sono di persone che si comportano così: per poter vivere meglio passano il tempo a organizzarsi la vita, con gran dispendio della vita stessa, fanno progetti a lungo termine e non si rendono conto che il maggiore spreco di tempo sta proprio nel dilazionare le cose, nel rimandare al futuro la loro attuazione. Il rinvio, infatti, ci toglie un giorno dietro l’altro e mentre ci promette il futuro, perché lo abbiamo già programmato, ci porta via il presente. L’attesa è ciò che più c’impedisce di vivere, perché dipende dal domani e ci fa perdere l’oggi. Programmiamo con cura ciò che è nelle mani del destino e ci lasciamo sfuggire ciò che sta nelle nostre. A che guardi? Dove ti spingi? Il tuo futuro è incerto: vivi subito. Ascolta il canto di salvezza che, percorso da un fremito divino, intona il sommo poeta:
I più bei giorni della vita fuggono sempre per primi ai miseri mortali.11 «Perché indugi», egli dice, «perché ti arresti? Il tempo fugge, afferralo!» E poiché anche quando lo avrai afferrato non cesserà di fuggire, usalo in fretta, come se attingessi l’acqua da una corrente rapida e precaria: solo così puoi gareggiare con lui in velocità. Molto opportunamente il poeta, nel biasimare questa vana ed eterna programmazione, parla di «giorni più belli», non dell’età più bella. Ma come fai a sciorinare davanti a te, e con tanta sicurezza, una sfilza di mesi e di anni, lunga quanto la tua avidità, in un tempo che corre così veloce? E quando parla di giorni vuol dire uno per uno, e che ciascuno di essi se ne fugge veloce. Né c’è dubbio che per «miseri mortali» intende gli uomini affaccendati, ed è per loro che «ogni più lieto / giorno di nostra età primo s’invola». La vecchiaia sorprende i loro animi impreparati e inermi, perché sono rimasti infantili e nulla hanno previsto a questo riguardo, sicché v’incappano all’improvviso, senza che l’abbiano attesa, senza essersi accorti che giorno per giorno si avvicinava. Come durante un viaggio, se siamo immersi in una conversazione, in una lettura o in un pensiero più intenso degli altri, ci troviamo giunti alla meta prima ancora di accorgerci che stavamo avvicinandoci, così questa corsa della vita, rapida e ininterrotta, che non muta il suo ritmo, sia che dormiamo sia che stiamo svegli, se siamo sempre impegnati non l’avvertiamo se non quando è giunta alla fine. 10. Se volessi dividere per argomenti questa mia chiacchierata potrei addurre molti esempi per dimostrare quanto sia brevissima la vita di quelle persone che sono sempre affaccendate. Papirio Fabiano12 – che non era uno di quei filosofi che montano in cattedra come certi nostri di oggi, ma un pensatore vero e all’antica – diceva che «le passioni vanno prese di petto, non con i guanti» e che il loro fronte va sgominato non con piccole e sporadiche scaramucce ma con un attacco massiccio in piena regola: non andava insomma tanto per il sottile, per lui l’avversario doveva essere «annientato, non punzecchiato». Però, per far capire a uno che ha sbagliato non basta riprenderlo, bisogna anche educarlo. Tre sono i periodi della vita: passato, presente, futuro. Di essi il presente è breve, il futuro incerto, il passato certo. Su quest’ultimo la fortuna non può più esercitare alcun diritto: ciò che è stato non può tornare sotto il potere di chicchessia. Per gli eterni affaccendati il passato è davvero perduto, come se non esistesse, perché essi non hanno tempo di volgersi indietro a guardarlo, e anche ammesso che lo facciano gliene torna sgradito il ricordo, in quanto pieno di rimorsi. Non amano ripensare a quei momenti che hanno speso male, né osano rievocare fatti di cui allora non riuscivano a vedere la meschinità – nascosta com’era nelle pieghe di un piacere temporaneo – ma che ora, nel ricordo, appaiono nella loro effettiva realtà. Solo chi ha sempre sottoposto ogni suo atto al vaglio di una critica attenta e severa, che non fallisce mai, si volge
volentieri al proprio passato, ma chi è stato troppo ambizioso o altezzosamente sprezzante, chi ha vinto con la prepotenza o ha tramato perfidi inganni, chi ha rubato con avarizia o sperperato con prodigalità, è inevitabile che abbia paura dei propri ricordi. Eppure il passato è la parte sacra e inviolabile della nostra vita, che sta al di sopra degli eventi umani e fuori dal dominio della fortuna, imperturbabile, esente da povertà, timori e malattie; niente può portarcelo via, il suo possesso è stabile e continuo. Il presente è fatto di giorni singoli, e ciascuno di essi è suddiviso in tanti momenti, ma i giorni del passato, a un tuo cenno, accorrono tutti in una volta, e puoi trattenerli e contemplarli quanto tu voglia. È un privilegio, questo, che chi consuma il tempo in tutt’altre faccende affaccendato, disgraziatamente non ha. Solo chi possiede una mente libera e serena può passare in rassegna tutti i momenti della sua esistenza, quelli invece che l’hanno sempre impegnata non possono volgersi indietro, come le bestie al giogo. La loro vita, dunque, si perde in un abisso, e come a nulla serve versare acqua in un vaso senza fondo, così, per quanto tempo possa scorrere, esso diventa niente se non ha dove posarsi: passa attraverso animi sconnessi e pieni di buchi. Il presente è così breve che alcuni ne negano persino l’esistenza: è sempre in moto, fugge via, precipita, non ci ha ancora toccato che già non c’è più, è senza sosta, come il cielo e le stelle, il cui moto incessante non consente loro di fissarsi in un punto preciso nemmeno per un istante. Ebbene, agli eterni affaccendati appartiene solo il presente, un tempo così breve da non potersi afferrare, anzi, essi, distratti per via dei troppi impegni, non hanno nemmeno questo. 11. E vuoi sapere quanto vivono poco? Guarda come si affannano a voler prolungare la vita: già vecchi decrepiti vanno mendicando a forza di preghiere un supplemento di anni, fingono, anche di fronte a sé stessi, di essere più giovani, si lusingano con inganni e bugie, compiacendosi di questi stupidi sotterfugi, come convinti di poterla fare in barba al destino. Poi, quando qualche malanno li avverte che sono mortali, gli si dipinge nel volto un tale terrore che la morte in loro non sembra un semplice uscire dalla vita ma un esserne strappati a dura forza. Allora gridano che sono stati sciocchi a non vivere e giurano che se mai la scamperanno si daranno alla contemplazione, vedono, finalmente, quanto sia stato inutile darsi tanto da fare per delle cose di cui poi non avrebbero potuto godere, quanto vana sia stata ogni loro fatica. Perché, invece, non dovrebbe essere lunga una vita libera da ogni impegno? Nessuna parte di questa è delegata ad altri, niente viene disperso di qua e di là, nulla è lasciato al caso o perduto per negligenza, niente le viene tolto per largizioni o rimane inutilizzato: è, insomma, come se tutta la vita fosse una rendita continua, istante per istante. Dunque, per quanto breve, una simile esistenza è più che sufficiente, e l’uomo saggio, in qualunque momento lo colga il giorno supremo, andrà incontro alla morte sereno e con passo sicuro.
12. Quanto agli affaccendati non devi credere che io mi riferisca soltanto a quelle persone che per farle uscire dal tribunale bisogna ricorrere ai cani sguinzagliandoglieli addosso, o a quelli che si lasciano schiacciare a bella posta dalla folla dei propri clienti o, poco decorosamente, restano soffocati da quella dei clienti altrui, quelli che impegni esterni portano a battere alle porte degli altri, o che con le vendite all’asta13 indetta dal pretore ricavano guadagni disonorevoli che gli rimorderanno: molti sono indaffarati anche nel tempo libero; si trovino nella loro villa in campagna, a letto o in piena solitudine, benché lontani e appartati da tutti, sono sempre tormentati. Il loro non è un vivere ritirati ma un ozioso darsi da fare. Si può forse ritenere un meditativo chi passa il tempo a carezzare e a mettere in ordine con maniacale pignoleria dei bronzi di Corinto o consuma la maggior parte delle giornate a contemplare delle monetuzze di metallo arrugginite? O chi sta seduto in palestra ad ammirare (che vergogna, ci lasciamo contagiare anche dai vizi stranieri!) dei giovinetti che fanno la lotta? O chi suddivide in coppie le sue mandrie di giumenti secondo il colore e l’età, e chi alleva i nuovi atleti? Me li chiami meditativi quelli che passano ore e ore dal barbiere a farsi togliere quei pochi peli che gli sono cresciuti durante la notte, a discettare su ogni singolo capello, a farsi riordinare la chioma spettinata o riportare i capelli da ogni parte sopra la fronte perché sono quasi calvi? E come si arrabbiano se il barbiere, pensando di avere a che fare con un uomo, non è andato tanto per il sottile! Prorompono in escandescenze per un capello tagliato o fuori posto o se i riccioli non ricadono poi tutti ordinati. Preferirebbero vedere sottosopra lo Stato piuttosto che la loro capigliatura! Poco gl’importa se la testa è malata, basta che faccia bella figura: meglio essere ben pettinati che dignitosi e onesti. Sono dunque non occupati questi individui che stanno sempre davanti allo specchio e col pettine in mano? Che dire poi di quelli che passano il tempo a comporre, ascoltare o imparare canzonette, forzando in languidi e assurdi gorgheggi la loro voce a cui la natura ha dato un tono lineare, ottimo e semplicissimo, o accompagnando il ritmo del canto con lo schioccar delle dita? Persino quando sono impegnati in cose serie, magari spiacevoli e dolorose, li senti canticchiare sottovoce. Altro che ozio! Il loro è un negozio continuo, che non produce niente. Nemmeno i loro banchetti li metterei fra i momenti di svago, vedendo con quale sollecitudine dispongono in bell’ordine l’argenteria, aggiustano le gonnelle succinte ai loro adorati schiavetti, controllano se il cuoco ha cucinato a puntino il cinghiale, se i servi depilati14 svolgono celermente le loro mansioni, se i volatili vengono tagliati ad arte in pezzi regolari e se i poveri garzoni eseguono con cura il loro compito di asciugare gli sputi dei commensali ubriachi: da tutto ciò s’illudono di procacciarsi un’immagine di splendore e di eleganza, e questi difetti li accompagnano a tal punto che non riescono a fare senza ostentazione neppure le cose più intime e riservate, come il bere e il mangiare. Né sono meno impegnate di loro quelle persone che si fanno portare a spasso di qua e di là, vuoi sulla sedia vuoi nella lettiga, che aspettano con ansia i momenti dedicati alle loro passeggiate quotidiane, quasiché cascasse il mondo se
dovessero saltarne una, e hanno sempre a portata di mano un servo che le avverte di tutto ciò che devono fare, quando è l’ora del bagno, quando del nuoto, quando della cena: sono talmente rammollite da quella loro debolezza d’animo che da sole non riescono a capire nemmeno se hanno fame. Ho sentito di uno, immerso in tutte queste delizie (se si possono chiamare così il non saper vivere e l’ignoranza di quelle abitudini che sono proprie dell’uomo), che portato a braccia fuori dal bagno e piazzato sopra una sedia chiese dubbioso: «Sono già seduto?». Come può sapere se è vivo, se vede, se sta in pace o in guerra, uno che non sa nemmeno se è seduto? Mi chiedo se lo ignori veramente o faccia finta, ma in un caso o nell’altro, non so in quale di più, mi fa pietà. Queste persone, infatti, molte cose le dimenticano ma molte fingono di dimenticarle, e si compiacciono di questo difetto come se fosse una prova di spensieratezza e di felicità: ritengono cosa troppo meschina e da uomo comune sapere quel che si fa. Pensa pure che ci sia molta invenzione nelle critiche che i mimi rivolgono al lusso, ma perdio sono più i difetti che tralasciano che quelli che s’inventano! Tanta è l’abbondanza d’incredibili vizi nella nostra epoca, ingegnosa solo in questo campo, che possiamo accusare i mimi di negligenza: chi avrebbe mai potuto pensare che ci sono persone così sfinite dalla mollezza dei loro costumi da dover ricorrere ad altri per sapere se sono sedute o no? Dunque chi vive così non è meditativo, dagli un altro nome, chiamalo malato, anzi, morto, addirittura. Libero è colui che possiede anche il senso della sua libertà, ma questo semivivo, che ha bisogno di un consigliere per sapere se il suo corpo sta in piedi, seduto o coricato, come può essere padrone di un solo minuto della sua vita? 13. Non parlo poi di quelli – sarebbe infatti troppo lungo elencarli – che passano la loro vita giocando a scacchi, a palla o a rosolarsi il corpo sotto il sole: non si può dire che vivano una vita tranquilla se i loro piaceri costano tanta fatica. Quanto a quelli che si dedicano agli studi ma solo per ricavarne una vuota e sterile erudizione – ormai pure Roma ne è piena – non c’è dubbio che anche loro, pur non concludendo nulla, si danno tanto da fare. Una volta questa smania di notizie inutili era un vizio tipico dei Greci, che si fissavano di voler sapere il numero dei marinai di Ulisse, se fosse stata scritta prima l’Iliade o l’Odissea, se i due poemi appartenessero al medesimo autore, e altre simili notiziole che se le tieni chiuse dentro di te non giovano a nulla ma se le vai raccontando in giro ti fanno sembrare pedante, non “più colto”. E ora anche i Romani sono stati contagiati da questo stupido vizio del nozionismo. Proprio alcuni giorni fa ho sentito un tizio ch’elencava le imprese inedite di tutti i nostri condottieri: Duilio – diceva – è stato il primo a vincere in una battaglia navale,15 Curio Dentato il primo a far sfilare elefanti in un trionfo, e così via. E perlomeno queste notizie, anche se non ti fanno vedere la vera gloria dei personaggi, riguardano la nostra città, non daranno una cultura ma almeno avvincono per la loro speciosità. E ammetto pure che si possa indagare su chi per primo convinse i Romani a salire su una nave (fu Claudio,16 detto Caudice dal nome con cui gli antichi
designavano un insieme di assi connesse fra loro: perciò le tavole delle leggi sono dette «codici», e «codicarie» sono chiamate ancora oggi, secondo l’antica consuetudine, le navi che trasportano viveri lungo il Tevere); così pure può essere utile sapere che Valerio Corvino 17 fu il primo a vincere Messana e che, primo della famiglia dei Valeri, prese dalla città conquistata il soprannome di Messana, che col tempo divenne Messala per uno scambio di lettere, come spesso avviene nel parlare. E concediamo che possa interessare il fatto che Lucio Silla fu il primo a esibire nel circo dei leoni sciolti (mentre sino ad allora apparivano legati), e questo perché il re Bocco aveva inviato per ucciderli degli arcieri infallibili. Passi anche questo. Ma a cosa giova sapere, per esempio, che Pompeo offrì per primo nel circo un combattimento fra diciotto elefanti e un gruppo di condannati?18 Primo cittadino e uomo di particolare bontà fra i grandi personaggi del passato – come vuole la tradizione – ritenne degno di essere ricordato un genere di spettacolo in cui degli uomini venivano massacrati in un modo inconsueto: che combattessero era poco per lui, che fossero dilaniati non gli bastava, dovevano essere schiacciati, e perdipiù da una massa enorme di animali. Un fatto del genere sarebbe stato meglio dimenticarlo, anche per evitare che in seguito qualche potente venisse a conoscerlo e provasse invidia per un gesto così disumano. Vedi come la fortuna offusca le menti degli uomini, tanto più quando è eccessiva. Quell’uomo credette di poter scavalcare la natura dando in pasto a delle belve provenienti da altri paesi caterve di uomini sventurati, facendo combattere fra loro degli esseri così disuguali e scorrere tanto sangue al cospetto del popolo romano, a cui ben presto, con le sue guerre, ne avrebbe fatto spargere di più. Ma alla fine, ingannato dalla perfidia alessandrina, si lasciò ammazzare dal più ignobile dei servi e allora si rese conto di quanto fosse stato inutile quel suo pomposo soprannome.19 Ma per tornare al nostro argomento e dimostrare la vanità di questa diligente ricerca di notizie, dirò che quel tale, a cui poc’anzi ho accennato, raccontava ancora che Metello, dopo aver vinto in Sicilia i Cartaginesi, nel trionfo che ne riportò fece sfilare davanti al suo cocchio, unico fra tutti i Romani, centoventi elefanti da lui catturati, che Silla fu l’ultimo della nostra gente ad ampliare il pomerio,20 che per antica consuetudine era lecito allargare solo in seguito a conquiste territoriali fatte in Italia e non nelle province. È più utile sapere questo o la causa per cui l’Aventino si trova fuori dal pomerio (un fatto che, sempre secondo quel tizio, potrebbe essere dovuto a due motivi, o perché vi si è ritirata la plebe, o perché Remo in quel luogo non trasse auspici a lui favorevoli dal volo degli uccelli)? O altre innumerevoli notiziole che se non sono bugie ne hanno però l’aria? Ammettiamo pure che costoro le dicano in buona fede, facendosene garanti nei loro scritti, ma queste nozioni potranno mai servire a eliminare gli errori degli uomini, a frenarne le passioni, a renderli più forti, più giusti, più generosi? Fabiano, il mio maestro, si domandava se fosse meglio non studiare per niente piuttosto che impegolarsi in studi di questo genere.
14. Solo quelli che si dedicano al conseguimento della saggezza fanno buon uso del loro tempo e sono gli unici che vivono veramente perché non solo spendono bene la propria vita ma vi aggiungono pure l’eternità: infatti oltre agli anni vissuti in prima persona acquisiscono anche, come un patrimonio ereditario, tutto il tempo passato prima della loro nascita. Se non vogliamo peccare d’ingratitudine verso di loro, dobbiamo riconoscere che i grandi fondatori di nobili dottrine sono nati per noi, nel senso che ci hanno preparato la vita. È merito loro se possiamo pervenire alle più alte verità, emerse dalle tenebre alla luce. Se siamo saggi nessuna epoca ci è preclusa, possiamo accedere liberamente a tutte, ed è uno spazio di tempo incalcolabile, se il nostro animo, di per sé stesso infinito, riesce a liberarsi dalle strettoie della vita materiale che tenta d’infiacchirlo. Possiamo così discutere con Socrate, dubitare con Carneade,21 raggiungere con Epicuro la serenità, dominare con gli stoici la nostra umana natura e coi Cinici addirittura superarla. E se ciascuno di noi può farsi compartecipe della storia di tutti, non solo nel presente ma anche nel passato e nel futuro, perché non uscire, allora, da questo spazio di tempo angusto e passeggero e abbandonarci con tutto il nostro animo a pensieri eterni e infiniti, che sono propri degli spiriti eletti? Quelli che corrono affannosamente da un’occupazione all’altra, affliggendo sé stessi e il prossimo, dopo che si sono tanto scervellati, che hanno bussato a tutte le porte, portando i loro saluti interessati fin nelle case più lontane, alla fine che numero esiguo di persone avran potuto vedere (di fronte a un uomo saggio che abbraccia l’intera umanità), in questa città pur così grande, divisa da mille passioni! Per non dire che molti non li ricevono nemmeno, o perché stanno dormendo, o perché ineducati, o perché intenti a spassarsela nella loro sfrenata lussuria. E quanti, dopo averli fatti aspettare tenendoli in ansia, li piantano in asso, facendo finta di aver fretta, quanti, invece di uscire dall’ingresso principale affollato di clienti, se la svignano zitti zitti per la porta di servizio o per qualche passaggio segreto della casa, per evitare d’incontrarli, dimostrandosi così più sgarbati nell’illuderli che nell’allontanarli personalmente! Altri ancora, mezzo addormentati e appesantiti per i bagordi del giorno prima, dopo che quelli hanno interrotto il loro sonno per aspettarne il risveglio, gli rispondono villanamente con uno sbadiglio, mentre essi vanno mormorando continuamente il proprio nome con la bocca appena schiusa. Veramente impegnati saranno invece quelli che ogni giorno vorranno avere come compagni Zenone, Pitagora, Democrito e tutti gli altri maestri di virtù, oppure Aristotele e Teofrasto. Nessuno di questi potrà mai rispondere ad alcuno che non ha tempo di riceverlo, e chi si recherà da loro ne uscirà più felice e meglio disposto verso sé stesso e gli altri, non se ne andrà via a mani vuote: tutti, insomma, giorno e notte, possono incontrarli e conversare con loro. 15. Di questi nessuno ti farà morire e tutti t’insegneranno come si muore, nessuno ti porterà via una sola briciola del tuo tempo, ma tutti, anzi, vi aggiungeranno il proprio. A conversare con loro non corri alcun pericolo, né il
fatto di essergli amico può comportarti una condanna a morte; rendergli omaggio non costa nulla. Potrai prendere da loro tutto ciò che vorrai, né essi t’impediranno di attingere quanto più tu possa desiderare. Che felicità, che serena vecchiaia sono riservate a chi si affida a loro! Potrai avere sempre a portata di mano una persona con cui discutere di qualunque argomento, dai più banali ai più importanti, da consultare sulle tue faccende in ogni momento della giornata, da cui sentirti dire la verità senza offenderti minimamente, una persona le cui lodi siano prive di adulazione e che possa essere presa come modello. Abbiamo il vezzo di dire che i genitori non ce li siamo scelti noi, che è stato il caso a farci nascere da loro invece che da altri, ma chi segue la virtù può eleggere a suoi genitori chiunque voglia. I più nobili ingegni formano delle famiglie: scegli per te quella che vuoi, non ne prenderai soltanto il nome, ma anche tutti i beni, né avrai bisogno di custodirli, gelosamente o con avarizia: dividili con gli altri e ti cresceranno, tanto più quanti più ne distribuirai. Queste anime elette ti apriranno la strada all’immortalità, innalzandoti a un punto da cui nessuno precipita giù. Solo così la nostra vita mortale può essere prolungata, o meglio ancora eternarsi. Gli onori, le memorie, tutto ciò che è dettato dall’ambizione, si tratti di cariche pubbliche o di monumenti, è di breve durata, non c’è nulla che il tempo prima o poi non incenerisca o faccia crollare, ma ciò che la saggezza ha consacrato non può essere minimamente scalfito, nessuna epoca lo cancellerà, nessuna lo diminuirà, anzi, le età future lo faranno via via sempre più sacro: l’invidia, infatti, si volge alle cose vicine, mentre quelle lontane sono guardate con animo schietto e sincero. La vita del saggio, dunque, spazia per ogni dove, è senza tempo, non è limitata, come quella degli altri mortali; il saggio sfugge, lui solo, alle leggi del genere umano, e domina, simile a dio, tutte le epoche della storia, dentro di sé il passato perché lo ricorda, il presente perché lo vive, il futuro perché lo prevede: la facoltà di mettere insieme e collegare questi tre momenti gli rende lunga la vita. 16. Brevissima, invece, e assai tormentata è la vita di coloro che dimenticano il passato, trascurano il presente e temono il futuro: troppo tardi quei poveretti, solo quando ormai sono giunti al termine della loro esistenza, si rendono conto di aver passato il tempo occupati nel non far nulla. Né il fatto che ogni tanto invocano la morte può essere preso come prova di una vita lunga o sufficientemente vissuta: si dibattono infatti sconsideratamente fra sentimenti contrastanti, che li spingono proprio a desiderare ciò che in effetti temono, e per questo invocano la morte, perché ne hanno paura. Né tanto meno si può ritenere che essi vivano lungamente solo perché il tempo non gli passa mai, perché le giornate gli sembrano interminabili e aspettano con ansia che giunga l’ora di cena: il fatto è che, smessi i loro impegni, in quello spazio libero che gli rimane si agitano, non sapendo come organizzarsi per far passare il tempo. Ecco perché hanno sempre bisogno d’impegnarsi in qualcosa e ogni intervallo tra una faccenda e l’altra gli diventa una pena, come accade quando, fissata la data per
un combattimento di gladiatori o per qualche altro spettacolo o divertimento, si vorrebbe che i giorni che intercorrono se ne volassero via. Ciò che è lungo per loro non è il tempo, è il rinvio, il dover aspettare; il tempo che amano, invece, quello sì che è breve, precipitoso, e loro stessi lo rendono ancora più corto, perché passano da un desiderio all’altro, incapaci come sono di soffermarsi su un solo piacere. Perciò non è che le giornate siano lunghe, per loro, semplicemente gli risultano odiose, mentre brevi, anzi brevissime, gli sembrano le notti che passano in mezzo al vino e tra le braccia delle prostitute. Da qui proviene l’insensata immaginazione dei poeti, che con le loro favole alimentano gli errori degli uomini, quando raccontano che Giove, eccitato dal piacere che gli dava un suo notturno rapporto amoroso, raddoppiò la durata di quella notte.22 Non è forse un incrementare i nostri vizi questo farli risalire alla divinità e sfogarli e giustificarli sull’esempio di lei? Come possono quindi non sembrare brevissime le notti a quegli individui, quando le pagano così care? Perdono il giorno nell’attesa della notte e la notte nell’ansia e nel timore del giorno. 17. Anche i loro piaceri materiali, infatti, sono pieni di apprensione e turbati da mille paure, e proprio al culmine del godimento ecco che fa capolino questo angoscioso pensiero: «Quanto, quanto durerà?». Questa sensazione indusse molti re a compiangere la propria potenza e a ridimensionare la loro fortuna, nel terrore della fine che un giorno o l’altro sarebbe avvenuta. Serse, il più superbo re dei Persiani, mentre in una pianura sconfinata andava schierando i suoi soldati – che poteva valutare solo in base allo spazio che occupavano ma non numericamente – scoppiò in lacrime al pensiero che nel giro di cento anni non uno fra tutti quei giovani sarebbe rimasto vivo.23 Eppure proprio lui che ne piangeva la fine al tempo stesso l’affrettava, mandandoli incontro alla morte, per mare, sulla terraferma, in battaglia oppure in fuga, annientando in breve tempo quegli uomini di cui temeva una morte distribuita nell’arco di cento anni. E le loro gioie? Non sono anch’esse piene di trepidazioni? Non poggiano infatti su basi solide, ma sono instabili, ondeggiano, perché provengono da motivi futili, inconsistenti. E pensa un po’ come devono essere quei momenti che loro stessi confessano tristi se persino quelli che li riempiono di orgogliosa soddisfazione e li fanno sentire al di sopra di tutto il genere umano non brillano, in fondo, di autentica gioia. Anche il possesso dei beni più grandi non è privo di preoccupazioni, anzi, quanto maggiore è la fortuna tanto minore è la sua credibilità: per mantenere un successo ne occorre sempre un altro e soddisfatto un desiderio bisogna trovarne uno nuovo. I beni fortuiti sono infatti instabili e quanto più in alto si sale tanto più si rischia di cadere, e poiché l’idea di una caduta non rallegra nessuno è inevitabile che sia non solo brevissima ma infelicissima la vita di chi è costretto a una ulteriore e maggiore fatica per mantenere un bene che glien’è costata già tanta. Soddisfare un desiderio comporta sempre uno sforzo e ciò che si è ottenuto tiene sempre in apprensione, per il timore che si ha di perderlo, e intanto non si pensa che il tempo andato non
ritorna più, nuovi impegni subentrano a quelli passati e una dietro l’altra si succedono le speranze e le ambizioni. Non si cerca una fine alle proprie miserie, si va solo cambiandone il tipo, la sostanza. Le cariche che abbiamo raggiunto non ci preoccupano più? Ecco che dedichiamo il tempo a quelle degli altri: così da candidati ci trasformiamo in elettori, da accusatori in giudici, da giudici in investigatori, da amministratori dei beni altrui in curatori dei nostri nella vecchiaia. Mario ha lasciato la milizia?24 Ecco che aspira al consolato. Quinzio si affretta a dimettersi da dittatore? Ecco che già pensa all’aratro. E Scipione, dopo aver combattuto – non ancora maturo per una simile impresa – contro i Cartaginesi, dopo aver vinto Annibale e Antioco, lui, gloria del suo consolato e garante di quello del fratello e che se non si fosse opposto di persona sarebbe stato divinizzato, lui, salvatore della patria, coinvolto nelle guerre civili, che già in gioventù aveva rifiutato onori divini, scelse da vecchio un disdegnoso esilio. Sia nella buona che nella cattiva sorte si è sempre in ansia, le preoccupazioni incalzano la vita e il tempo libero da dedicare a sé stessi resta sempre una pura aspirazione. 18. Sfuggi dunque la folla, carissimo Paolino, e ritirati finalmente in un porto tranquillo, visto che già sei stato sballottato anche troppo, rispetto alla tua età. Pensa quanti marosi hai affrontato, quante tempeste, pubbliche e private, hai dovuto subire o ti sei accollato personalmente: hai già dato prove sufficienti della tua virtù, sostenendo dure e angosciose fatiche, ora sperimenta ciò che essa può fare in una vita ritirata. I tuoi anni migliori li hai dedicati allo Stato, ora pensa un po’ a te. Non ti esorto a un ozio pigro e inerte, a spegnere nel sonno e nei piaceri volgari il tuo vigore ancora valido e pronto: codesto non è riposarsi; ma dedicarsi a occupazioni più nobili di quelle del nostro vivere comune, alle quali si può attendere solo, e serenamente, nella quiete di una vita meditativa, questo è il vero riposo. Tu amministri i beni della comunità con lo stesso disinteresse con cui curi quelli dei singoli, con la stessa diligenza con cui governi i tuoi, con lo stesso scrupolo con cui badi a quelli dello Stato, riesci a farti amare in un incarico in cui è difficile evitare l’odio, ma nondimeno, credimi, è meglio tenere i conti della propria vita che quelli dei granai cittadini. Distogli questa tua energia, capace di nobilissime imprese, da un impegno che per quanto onorifico è poco adatto a rendere felice la vita, ricordati che quando ti dedicasti, ancora ragazzo, agli studi liberali non miravi certo a diventare lo zelante amministratore di molte migliaia di moggi di frumento, ambivi a cose ben più grandi ed elevate. Non mancheranno altri uomini come te, di provata onestà e altrettanto instancabili nel lavoro: sono più abili ai pesi le lente bestie da soma che non i cavalli di razza, di cui nessuno si è mai sognato di mortificare l’innata agilità con dei pesanti bagagli. Pensa poi a tutte le preoccupazioni che ti costa un così faticoso lavoro: hai a che fare con lo stomaco umano, e il popolo quand’è affamato non sente ragioni, non si placa con l’equità, né si lascia piegare dalle preghiere. Recentemente, nei pochi giorni in cui Caligola moriva, indignato di
doversene andare da questo mondo (come se poi quello sdegno potesse portarselo dietro nell’aldilà), il popolo romano, che per sua fortuna gli sopravviveva, aveva viveri per non più di una settimana. Mentre quello costruiva ponti di barche e scherzava con la potenza dell’impero, si prospettava l’ultima sciagura che possa toccare a degli assediati, la carestia. Quel suo voler imitare un re pazzo, straniero e rovinosamente superbo, per poco non ci costò morte, fame e, conseguenza di questa, la perdita di tutto. Pensa quale fosse allora l’animo di coloro che avevano in custodia gli approvvigionamenti, all’idea di dover subire assalti di pietre, di armi, incendi e l’ira di Caligola stesso! Con somma dissimulazione tenevano nascosto nel fondo delle proprie viscere un così grande male, e ciò non senza ragione: certe malattie, infatti, vanno curate senza che gli ammalati le conoscano, visto che molti di essi muoiono proprio per averle apprese. 19. Volgiti dunque a queste occupazioni più serene, più nobili, più sicure! Non credi che vi sia una bella differenza fra l’aver cura che il frumento sia stipato nei granai indenne dalle frodi o dalla negligenza dei trasportatori, che non fermenti e si guasti a causa dell’umidità, che corrisponda, nel peso e nella misura, alla quantità dovuta, e l’accostarsi invece a queste sacre e sublimi meditazioni, per indagare quale sia l’essenza di dio, il suo aspetto, il suo stato, la sua volontà, e quale sorte attenda la nostra anima, dove andrà dopo che si sarà staccata dal corpo, cos’è che attrae i gravi verso il centro della terra, tiene sospeso in aria ciò che è leggero, spinge il fuoco verso l’alto, muove le stelle nelle loro rotazioni, e tutti gli altri fenomeni che ci lasciano a bocca aperta? Volgi la mente da questa bassa aiuola a così eccelse meditazioni! Fallo adesso, finché il tuo sangue è caldo e sei ancora pieno di vigore, questo è il momento per guardare più in alto! In tale genere di vita ti attendono molte nobili attività, l’amore e la pratica delle virtù, l’oblio delle passioni, la scienza del vivere e del morire, nonché una quiete profonda, in cui tacciono tutte le cose. 20. Se triste è la condizione degli eterni affaccendati, ancora più misera è quella di coloro che non sono nemmeno impegnati in proprio ma dipendono in tutto dagli altri, regolano il loro sonno su quello altrui, camminano secondo il passo altrui e provano a comando amore e odio, che sono i più spontanei di tutti i sentimenti. Queste persone, se vogliono sapere quanto sia breve la loro vita, devono solo fare il conto di quel poco spazio di tempo che gli appartiene. Non invidiare dunque chi è molto conosciuto perché il suo nome viene ripetuto continuamente nel foro o perché indossa spesso la pretesta: simili onori si ottengono rubando tempo alla propria vita. Pensa che uno, per dare il suo nome a un solo anno, divenendo console, spende un’intera esistenza, che alcuni sono morti prima di giungere al colmo della loro ambizione, anzi, mentre si accingevano a compiere la scalata, che altri, dopo essere arrivati alle più alte cariche, magari con mezzi disonesti, sono presi dall’amaro sospetto di aver
lavorato tanto solo per avere un’iscrizione sulla propria tomba, che altri ancora, già vecchi e tuttavia animati da nuove speranze, come se fossero dei giovinetti, sono morti per sfinimento nei loro tentativi faticosi e sproporzionati all’età. Come non provare disgusto di fronte a uno che, già avanzato negli anni, esala l’ultimo respiro nel bel mezzo di un processo, difendendo per giunta dei litiganti da strapazzo e fra gli applausi di un pubblico zotico e ignorante? O di fronte a chi schiatta sul lavoro, stanco più per il suo modo frenetico di vivere che per la fatica in sé, o mentre magari sta facendosi dare il resoconto delle entrate e delle uscite, con grande gioia dell’erede che già da tempo lo aspetta al varco? Mi viene in mente Turannio, 25 un vecchio diligente e preciso che a novant’anni e passa, esonerato dai suoi incarichi da Caligola, e non dietro sua richiesta, si fece sistemare ben bene sul suo letto e comandò ai familiari e ai servi raccolti intorno a lui che lo piangessero come morto. La casa intera risuonava di quella lamentazione funebre, perché il padrone era stato dimesso dal suo lavoro, e smise il lutto solo quando Caligola lo reintegrò nell’incarico. Ma è proprio tanto piacevole morire in piena attività? Eppure i più la pensano così, smaniano di lavorare anche quando non ne hanno più la capacità, lottano contro la debolezza fisica e ritengono insopportabile la vecchiaia solo perché li mette in disparte. La legge non richiama alle armi i cittadini che abbiano più di cinquant’anni, non convoca alle sedute i senatori dopo i sessanta,26 ma gli uomini hanno maggiore difficoltà a mettersi in riposo da sé stessi che non per legge, e intanto, mentre vanno trascinando la loro vita, coinvolgendovi gli altri e rendendosi vicendevolmente pieni di affanni e d’infelicità, non raccolgono alcun frutto, alcuna soddisfazione, alcun bene che giovi al loro animo, non pensano alla morte, spingono al di là del possibile le proprie speranze, pretendono magari di predisporre cose che sono oltre la vita, come tombe gigantesche, opere pubbliche dedicate a loro, spettacoli funebri, esequie sontuose, quando invece meriterebbero solo funerali con torce e ceri, come chi muore bambino o comunque di morte precoce.
1. Ippocrate è il grande medico greco vissuto fra il V e il IV secolo a.C., sostenitore del principio secondo cui i rimedi contro le malattie sono nella stessa natura. 2. In realtà il rimprovero mosso alla natura di aver concesso agli animali una vita più lunga rispetto a quella degli uomini è di Teofrasto, a quanto almeno riferisce Cicerone in Tusc. III 69. 3. Anche l’espressione «viviamo veramente solo una brevissima parte della nostra vita», che qui sembra attribuita a Omero, maximum poetarum, è di altri. 4. Col termine rex è qui indicato il capo, il superiore, con quello di cliens il dipendente, l’inferiore. 5. Anche nel De clementia (I 9, 6) Seneca parla degl’impegni e delle preoccupazioni di Augusto. Delle congiure contro di lui vi sono cenni in Svetonio, Cassio Dione e Velleio Patercolo. 6. La coppia Iullo (figlio di Antonio) e Giulia (figlia di Augusto) richiama, con l’adulterio dei due, quella di Antonio e Cleopatra, funesta all’impero. Orazio dedicò a Iullo l’ode seconda del IV libro. 7. La lettera di Cicerone a cui accenna Seneca non ci è pervenuta.
8. Le leggi di Livio Druso si riferiscono alle distribuzioni di terra e frumento e all’estensione ai socii del diritto di cittadinanza romana (91 a.C.). Sulla sua morte non si hanno notizie certe. Cicerone (De nat. deor. III 23) dice che fu pugnalato da un certo Vario. 9. Dei cacciatori di testamenti parlano anche Orazio e Petronio. 10. Di coloro che programmano la propria vita Seneca parla anche nelle Lettere a Lucilio (24, 1). 11. L’intero passo (Virgilio, Georg. III 66 sgg.) è il seguente: Optima quaeque dies miseris mortalibus aevi / prima fugit; subeunt morbi tristisque senectus / et labor, et durae rapit inclementia mortis. Così lo rese il Leopardi nell’Ultimo canto di Saffo: «Ogni più lieto / giorno di nostra età primo s’invola. / Sottentra il morbo, e la vecchiezza, e l’ombra / della gelida morte». 12. Papirio Fabiano, retore e filosofo stoico, fu maestro di Seneca. 13. Sono le aste pubbliche in cui venivano messi in vendita il bottino di guerra o i beni confiscati ai proscritti: perciò il loro acquisto era ritenuto disonorevole. 14. Dei servi «depilati» Seneca parla anche nelle Lettere a Lucilio (47, 2). 15. Caio Duilio vinse la flotta cartaginese a Milazzo durante la prima guerra punica, nel 260 a.C., Curio Dentato vinse Pirro nel 275. 16. Claudio, detto Caudex, Caudice, è Appio Claudio, sotto il cui consolato, nel 264 a.C:, iniziarono le guerre puniche. È da notare come Seneca, mentre da un lato condanna l’erudizione, ne faccia poi sfoggio in una serie di notizie da lui stesso definite inutili. 17. Valerio Corvino fu console nel 263 a.C. 18. Della battaglia fra uomini ed elefanti parla anche Cicerone. 19. A Pompeo era stato attribuito il soprannome di Magno. 20. Il «pomerio» era lo spazio consacrato che si trovava al di qua e al di là delle mura. 21. «Carneade! Chi era costui?»: così il Manzoni nei Promessi Sposi (cap. VIII). Filosofo e grande oratore nativo di Cirene e vissuto fra il 214 e il 129 a.C., seguace dell’indirizzo scettico sosteneva l’impossibilità di poter pervenire a una verità certa e riusciva a dimostrare con eguale convinzione e capacità persuasiva due tesi completamente opposte. Era talmente preso dalla sua professione (soleva parlare nelle pubbliche piazze) che si dimenticava persino di mangiare. 22. Allude all’amore di Giove per Alcmena, di cui parla anche Plauto in Amph. 113 sgg. 23. L’episodio di Serse che compiange la futura morte dei suoi soldati è narrato anche da Erodoto (VII 45). 24. La caliga, calzatura dei soldati, indica qui il servizio militare. 25. È forse il Caio Turannio, prefetto dell’annona sotto Tiberio, di cui parla Tacito ( Ann. I 7 e XI 31). 26. In verità i militari andavano in pensione a 45 anni e, stando a Seneca il Vecchio ( Controv. I 8, 4), i senatori erano dispensati dal partecipare alle sedute a 65 anni.
De constantia sapientis
1. Tantum inter Stoicos, Serene, et ceteros sapientiam professos interesse quantum inter feminas et mares non immerito dixerim, cum utraque turba ad vitae societatem tantundem conferat, sed altera pars ad obsequendum, altera imperio nata sit. Ceteri sapientes molliter agunt et blande, ut fere domestici et familiares medici aegris corporibus non qua optimum et celerrimum est medentur, sed qua licet; Stoici, virilem ingressi viam, non ut amena ineuntibus videatur curae habent, sed ut quam primum nos eripiat et in illum editum verticem educat, qui adeo extra omnem teli iactum surrexit ut supra fortunam emineat. «At ardua per quae vocamur et confragosa sunt». Quid enim? Plano aditur excelsum? Sed ne tam abrupta quidem sunt quam quidam putant. Prima tantum pars saxa rupesque habet et invii speciem, sicut pleraque ex longinquo speculantibus abscisa et conexa videri solent, cum aciem longinquitas fallat, deinde propius adeuntibus eadem illa, quae in unum congesserat error oculorum, paulatim adaperiuntur, tum illis quae praecipitia ex intervallo apparebant redit lene fastigium. 2. Nuper, cum incidisset mentio M. Catonis, indigne ferebas, sicut es iniquitatis impatiens, quod Catonem aetas sua parum intellexisset, quod supra Pompeios et Caesares surgentem infra Vatinios posuisset, et tibi indignum videbatur quod illi dissuasuro legem toga in foro esset erepta quodque, a Rostris usque ad Arcum Fabianum per seditiosae factionis manus traditus, voces improbas et sputa et omnes alias insanae multitudinis contumelias pertulisset. Tum ego respondi habere te quod rei publicae nomine movereris, quam hinc P. Clodius, hinc Vatinius ac pessimus quisque venundabat et, caeca cupiditate correpti, non intellegebant se, dum vendunt, et venire; pro ipso quidem Catone securum te esse iussi: nullum enim sapientem nec iniuriam accipere nec contumeliam posse, Catonem autem certius exemplar sapientis viri nobis deos immortales dedisse quam Ulixen et Herculem prioribus saeculis. Hos enim Stoici nostri sapientes pronuntiaverunt, invictos laboribus et contemptores voluptatis et victores omnium terrorum. Cato non cum feris manus contulit, quas consectari venatoris agrestisque est, nec monstra igne ac ferro persecutus est, nec in ea tempora incidit quibus credi posset caelum umeris unius inniti, excussa iam antiqua credulitate et saeculo ad summam perducto sollertiam. Cum ambitu congressus, multiformi malo, et cum potentiae immensa cupiditate, quam totus orbis in tres divisus satiare non poterat, adversus vitia civitatis degenerantis et pessum sua mole sidentis stetit solus, et cadentem rem publicam, quantum modo una retrahi manu poterat, tenuit, donec abstractus comitem se diu sustentatae ruinae dedit simulque exstincta sunt quae nefas erat dividi: neque enim Cato post libertatem vixit, nec libertas post Catonem. Huic tu putas iniuriam fieri potuisse a populo, quod aut praeturam illi detraxit aut togam, quod sacrum illud caput
purgamentis oris aspersit? Tutus est sapiens, nec ulla affici aut iniuria aut contumelia potest. 3. Videor mihi intueri animum tuum incensum et effervescentem. Paras acclamare: «Haec sunt quae auctoritatem praeceptis vestris detrahant: magna promittitis etquae ne optari quidem, nedum credi possint; deinde, ingentia locuti, cum pauperem negastis esse sapientem, non negatis solere illi et servum et tectum et cibum deesse; cum sapientem negastis insanire, non negatis et alienari et parum sana verba emittere et quicquid vis morbi cogit audere; cum sapientem negastis servum esse, idem non itis infitias et veniturum et imperata facturum et domino suo servilia praestaturum ministeria. Ita, sublato alte supercilio, in eadem quae ceteri descenditis, mutatis rerum nominibus. Tale itaque aliquid et in hoc esse suspicor, quod prima specie pulchrum atque magnificum est, nec iniuriam nec contumeliam accepturum esse sapientem. Multum autem interest utrum sapientem extra indignationem an extra iniuriam ponas. Nam, si dicis illum aequo animo laturum, nullum habet privilegium: contigit illi res vulgaris et quae discitur ipsa iniuriarum assiduitate, patientia. Si negas accepturum iniuriam, id est neminem illi tentaturum facere, omnibus relictis negotiis, Stoicus fio». Ego vero sapientem non imaginario honore verbomm exornare constitui, sed eo loco ponere quo nulla permittatur iniuria. Quid ergo? Nemo erit qui lacessat, qui tentet? Nihil in rerum natura tam sacrum est quod sacrilegum non inveniat. Sed non ideo divina minus in sublimi sunt, si exsistunt qui magnitudinem multum ultra se positam non tacturi appetant. Invulnerabile est non quod feritur, sed quod non laeditur: ex hac tibi nota sapientem exhibebo. Numquid dubium est quin certius robur sit quod non vincitur quam quod non lacessitur, cum dubiae sint vires inexpertae, at merito certissima firmitas habeatur quae omnes incursus respuit? Sic tu sapientem melioris scito esse naturae si nulla illi iniuria nocet quam si nulla fit. Et illum fortem virum dicam quem bella non subigunt nec admota vis hostilis exterret, non cui pingue otium est inter desides populos. Hoc igitur dico, sapientem nulli esse iniuriae obnoxium. Itaque non refert quam multa in illum coiciantur tela, cum sit nulli penetrabilis. Quomodo quorundam lapidum inexpugnabilis ferro duritia est nec secari adamas aut caedi vel deteri potest, sed incurrentia ultro retundit, quemadmodum quaedam non possunt igne consumi, sed flamma circumfusa rigorem suum habitumque conservant, quemadmodum proiecti quidam in altum scopuli mare frangunt nec ipsi ulla saevitiae vestigia tot verberati saeculis ostentant, ita sapientis animus solidus est et id roboris collegit, ut tam tutus sit ab iniuria quam illa quae rettuli. 4. «Quid ergo? Non erit aliquis qui sapienti facere tentet iniuriam?». Tentabit, sed non perventuram ad eum: maiore enim intervallo a contactu inferiorum abductus est quam ut ulla vis noxia usque ad illum vires suas perferat. Etiam cum potentes et imperio editi et consensu servientium validi nocere intendent, Tam citra sapientiam omnes eorum impetus deficient quam quae nervo
tormentisve in altum exprimuntur, cum extra visum exsilierint, citra caelum tamen flectuntur. Quid? Tu putas tum, cum stolidus ille rex multitudine telorum diem obscuraret, ullam sagittam in solem incidisse, aut demissis in profundum catenis Neptunum potuisse contingi? Ut caelestia humanas manus effugiunt et ab iis qui tempIa dimunt ac simulacra conflant nihil divinitati nocetur, ita quicquid fit in sapientem proterve, petulanter, superbe, frustra tentatur. «At satius erat neminem esse qui facere vellet». Rem difficilem optas humano generi, innocentiam; et non fieri eorum interest qui facturi sunt, non eius qui pati, ne si fiat quidem, potest. Immo nescio an magis vires sapientia ostendat tranquillitate inter lacessentia, sicut maximum argumentum est imperatoris armis virisque pollentis tuta securitas in hostium terra. 5. Dividamus, si tibi videtur, Serene, iniuriam a contumelia. Prior illa natura gravior est, haec levior et tantum delicatis gravis, qua non laeduntur homines, sed offenduntur. Tanta est tamen animorum dissolutio et vanitas, ut quidam nihil acerbius putent. Sic invenies servum qui flagellis quam colaphis caedi malit et qui mortem ac verbera tolerabiliora credat quam contumeliosa verba. Ad tantas ineptias perventum est ut non dolore tantum, sed doloris opinione vexemur, more puerorum, quibus metum incutit umbra et personarum deformitas et depravata facies, lacrimas vero evocant nomina parum grata auribus et digitorum motus et alia quae impetu quodam erroris improvidi refugiunt. Iniuria propositum hoc habet, aliquem malo afficere. Malo autem sapientia non relinquit locum: unum enim illi malum est turpitudo, quae intrare eo ubi iam virtus honestumque est non potest. Ergo, si iniuria sine malo nulla est, malum nisi turpe nullum est, turpe autem ad honestis occupatum pervenire non potest, iniuria ad sapientem non pervenit. Nam, si iniuria alicuius mali patientia est, sapiens autem nullius mali est patiens, nulla ad sapientem iniuria pertinet. Omnis iniuria deminutio eius est in quem incurrit, nec potest quisquam iniuriam accipere sine aliquo detrimento vel dignitatis vel corporis vel rerum extra nos positarum. Sapiens autem nihil perdere potest: omnia in se reposuit, nihil fortunae credidit, bona sua in solido habet, contentus virtute, quae fortuitis non indiget ideoque nec augeri nec minui potest (nam et in summum perducta incrementi non habent locum, et nihil eripit fortuna nisi quod dedit; virtutem autem non dat, ideo nec detrahit: libera est, inviolabilis, immota, inconcussa, sic contra casus indurata ut ne inclinari quidem, nedum vinci possit; adversus apparatus terribilium rectos oculos tenet; nihil ex vultu mutat, sive illi dura sive secunda ostentantur). Itaque nihil perdet quod perire sensurus sit; unius enim in possessione virtutis est, ex qua depelli numquam potest. Ceteris precario utitur: quis autem iactura movetur alieni? Quod si iniuria nihil laedere potest ex iis quae propria sapientis sunt, quia, virtute salva, sua salva sunt, iniuria sapienti non potest fieri. Megaram Demetrius ceperat, cui cognomen Poliorcetes fuit. Ab hoc Stilpon philosophus interrogatus num aliquid perdidisset: «Nihil» inquit «omnia mea mecum sunt». Atqui et patrimonium eius in praedam cesserat, et filias rapuerat hostis, et patria in
alienam dicionem pervenerat, et ipsum rex circumfusus victoris exercitus armis ex superiore loco rogitabat. At ille victoriam illi excussit et se, urbe capta, non invictum tantum, sed indemnem esse testatus est. Habebat enim vera secum bona, in quae non est manus iniectio. At quae dissipata et direpta ferebantur non iudicabat sua, sed adventicia et nutum fortunae sequentia; ideo ut non propria dilexerat. Omnium enim extrinsecus affluentium lubrica et incerta possessio est. 6. Cogita nunc an huic fur aut calumniator aut vicinus impotens aut dives aliquis regnum orbae senectutis exercens facere iniuriam possit, cui bellum et hostis et ille egregiam artem quassandarum urbium professus eripere nihil potuit. Inter micantes ubique gladios et militarem in rapina tumultum, inter flammas et sanguinem stragemque impulsae civitatis, inter fragorem templorum super deos suos cadentium, uni homini pax fuit. Non est itaque quod audax iudices promissum, cuius tibi, si parum fidei habeo, sponsorem dabo. Vix enim credis tantum firmitatis in hominem aut tantam animi magnitudinem cadere. Sed, si prodit in medium qui dicat: «Non est quod dubites an attollere se homo natus supra humana possit, an dolores, damna, ulcerationes, vulnera, magnos motus rerum circa se frementium securus aspiciat, et dura placide ferat et secunda moderate, nec illis cedens nec his fretus unus idemque inter diversa sit, nec quicquam suum nisi seputet esse. En adsum hoc vobis probaturus, sub isto tot civitatum eversore munimenta incussu arietis labefieri et turrium altitudinem cuniculis ac latentibus fossis repente desidere et aequaturum editissimas arces aggerem crescere, at nulla machinamenta posse reperiri quae bene fundatum animum agitent. Erepsi modo e ruinis domus et, incendiis undique relucentibus, flammas per sanguinem fugi; filias meas quis casus habeat, an peior publico, nescio; solus et senior et hostilia circa me omnia videns, tamen integrum incolumemque esse censum meum profiteor: teneo, habeo quicquid mei habui. Non est quod me victum victoremque te credas: vicit fortuna tua fortunam meam. Caduca illa et dominum mutantia ubi sint nescio; quod ad res meas pertinet, mecum sunt, mecum erunt. Perdiderunt isti divites patrimonia, libidinosi amores suos et magno pudoris impendio dilecta scorta, ambitiosi curiam et forum et loca exercendis in publico vitiis destinata; feneratores perdiderunt tabellas, quibus avaritia falso laeta divitias imaginatur: ego quidem omnia integra illibataque habeo. Proinde istos interroga qui flent, qui lamentantur, strictis gladiis nuda pro pecunia corpora opponunt, qui hostem onerato sinu fugiunt». Ergo ita habe, Serene, perfectum illum virum, humanis divinisque virtutibus plenum, nihil perdere, Bona eius solidis et inexsuperabilibus munimentis praecincta sunt. Non Babylonios illis muros contuleris, quos Alexander intravit; non Carthaginis aut Numantiae moenia, una manu capta; non Capitolium arcemve, habent ista hostile vestigium. Illa, quae sapientem tuentur, et a flamma et ab incursu tuta sunt, nullum introitum praebent, excelsa, inexpugnabilia, diis aequa. 7. Non est quod dicas, ita ut soles, hunc sapientem nostrum nusquam inveniri.
Non fingimus istud humani ingenii vanum decus nec ingentem imaginem falsae rei concipimus, sed qualem conformamus exhibuimus, exhibebimus, raro forsitan magnisque aetatum intervallis unum (neque enim magna et excedentia solitum ac vulgarem modum crebro gignuntur); ceterum hic ipse M. Cato, a cuius mentione haec disputatio processit, vereor ne supra nostrum exemplar sit. Denique validius debet esse quod laedit eo quod laeditur. Non est autem fortior nequitia virtute: non potest ergo laedi sapiens. Iniuria in bonos nisi a malis non tentatur: bonis inter se pax est. Quod si laedi nisi infirmior non potest, malus autem bono infirmior est, nec iniuria bonis nisi a dispari verenda est, iniuria in sapientem virum non cadit. Illud enim iam non es admonendus, neminem bonum esse nisi sapientem. «Si iniuste» inquis «Socrates damnatus est, iniuriam accepit». Hoc loco intellegere nos oportet posse evenire ut faciat aliquis iniuriam mihi et ego non accipiam: tamquam si quis rem quam e villa mea subripuit in domo mea ponat, ille furtum fecerit, ego nihil perdiderim. Potest aliquis nocens fieri, quamvis non nocuerit. Si quis cum uxore sua tamquam cum aliena concumbat, adulter erit, quamvis illa adultera non sit. Aliquis mihi venenum dedit, sed vim suam remixtum cibo perdidit: venenum ille dando scelere se obligavit, etiam si non nocuit. Non minus latro est, cuius telum opposita veste elusum est. Omnia scelera etiam ante effectum operis, quantum culpae satis est, perfecta sunt. Quaedam eius condicionis sunt et hac vice copulantur, ut alterum sine altero esse possit, alterum sine altero non possit. Quod dico conabor facere manifestum. Possum pedes movere, ut non curram; currere non possum, ut pedes non moveam. Possum, quamvis in aqua sim, non natare; si nato, non possum in aqua non esse. Ex hac sorte et hoc est de quo agitur: si iniuriam accepi, necesse est factam esse; si est facta, non est necesse accepisse me. Multa enim incidere possunt quae summoveant iniuriam: ut intentatam manum deicere aliquis casus potest et emissa tela declinare, ita iniurias qualescumque potest aliqua res repellere et in medio intercipere, ut et factae sint nec acceptae. 8. Praeterea iustitia nihil iniustum pati potest, quia non coeunt contraria; iniuria autem non potest fieri nisi iniuste: ergo sapienti iniuria non potest fieri. Nec est quod mireris si nemo illi potest iniuriam facere: ne prodesse quidem quisquam potest. Et sapienti nihil deest quod accipere possit loco muneris et malus nihil potest dignum tribuere sapiente: habere enim prius debet quam dare; nihil autem habet quod ad se transferri sapiens gavisurus sit. Non potest ergo quisquam aut nocere sapienti aut prodesse, quoniam divina nec iuvari desiderant nec laedi possunt, sapiens autem vicinus proximusque diis consistit, excepta mortalitate similis deo. Ad illa nitens pergensque excelsa, ordinata, intrepida; aequali et concordi cursu fluentia, secura, benigna, bono publico nata, et sibi et aliis salutaria, nihil humile concupiscet, nihil flebit. Qui, rationi innixus, per humanos casus divino incedit animo, non habet ubi accipiat iniuriam: ab homine me tantum dicere putas? Ne a fortuna quidem, quae, quotiens cum virtute congressa est, numquam par recessit. Si maximum illud ultra quod nihil habent
iratae leges ac saevissimi domini quod minentur, in quo imperium suum fortuna consumit, aequo placidoque animo accipimus et scimus mortem malum non esse ob hoc ne iniuriam quidem, multo facilius alia tolerabimus, damna et dolores, ignominias, locorum commutationes, orbitates discidia, quae sapientem, etiam si universa circumveniant, non mergunt, nedum ut ad singulorum impulsus maereat. Et, si fortunae iniurias moderate fert, quanto magis hominum potentium, quos scit fortunae manus esse! 9. Omnia itaque sic patitur ut hiemis rigorem et intemperantiam caeli, ut fervores morbosque et cetera forte accidentia, nec de quoquam tam bene iudicat ut illum quicquam putet consilio fecisse, quod in uno sapiente est. Aliorum omnium non consilia, sed fraudes et insidiae et motus animorum inconditi sunt, quos casibus adnumerat. Omne autem fortuitum circa nos saevit: et iniuria. Illud quoque cogita, iniuriarum latissime patere materiam illis per quae periculum nobis quaesitum est, ut accusa tore submisso aut criminatione falsa aut irritatis in nos potentiorum odiis quaeque alia inter togatos latrocinia sunt. Est et illa iniuria frequens, si lucrum alicui excussum est aut praemium diu captatum, si magno labore affectata hereditas aversa est et quaestuosae domus gratia erepta. Haec effugit sapiens, qui nescit nec in spem nec in metum vivere. Adice nunc quod iniuriam nemo immota mente accipit, sed ad sensum eius perturbatur, caret autem perturbatione vir ereptus erroribus, moderator sui, altae quietis et placidae. Nam, si tangit illum iniuria, et movet et impellit; caret autem ira sapiens, quam excitat iniuriae species, nec aliter careret ira nisi et iniuria, quam scit sibi non posse fieri. Inde tam erectus laetusque est, inde continuo gaudio elatus. Adeo autem ad offensiones rerum hominumque non contrahitur, ut ipsa illi iniuria usui sit, per quam experimentum sui capit et virtutem tentat. Faveamus, obsecro vos, huic proposito aequisque et animis et auribus adsimus, dum sapiens iniuriae excipitur! Nec quicquam ideo petulantiae vestrae aut rapacissimis cupiditatibus aut caecae temeritati superbiaeque detrahitur: salvis vitiis vestris haec sapienti libertas quaeritur. Non ut vobis facere non liceat iniuriam agimus, sed ut ille omnes iniurias inultas dimittat patientiaque se ac magnitudine animi defendat. Sic in certaminibus sacris plerique vicerunt caedentium manus obstinata patientia fatigando: ex hoc puta genere sapientem, eorum qui exercitatione longa ac fideli robur perpetiendi lassandique. Omnem inimicam vim consecuti sunt. 10. Quoniam priorem partem percucurrimus, ad alteram transeamus, qua quibusdam propriis, plerisque vero communibus contumeliam refutabimus. Est minor iniuria, quam queri magis quam exsequi possumus, quam leges quoque nulla dignam vindicta putaverunt. Hunc affectum movet humilitas animi contrahentis se ob dictum factumve inhonorificum: «Ille me hodie non admisit, cum alios admitteret», et: «Sermonem meum aut superbe aversatus est aut palam risit», et: «Non in medio me lecto, sed in imo collocavit», et alia huius notae, quae quid vocem nisi querellas nausiantis animi? In quae fere delicati et felices
incidunt; non vacat enim haec notare cui peiora instant. Nimio otio ingenia natura infirma et muliebria et inopia verae iniuriae lascivientia his commoventur, quorum pars maior constat vitio interpretantis. Itaque nec prudentiae quicquam in se esse nec fiduciae ostendit qui contumelia afficitur. Non dubie enim contemptum se iudicat, et hic morsus non sine quadam humilitate animi evenit supprimentis se ac descendentis. Sapiens autem a nullo contemnitur: magnitudinem suam novit, nullique tantum de se licere renuntiat sibi, et omnes has quas non miserias animorum, sed molestias dixerim non vincit, sed ne sentit quidem. Alia sunt quae sapientem feriunt, etiam si non pervertunt, ut dolor corporis et debilitas aut amicorum liberorumque amissio et patriae bello flagrantis calamitas: haec non nego sentire sapientem, nec enim lapidis illi duritiam ferrive asserimus. Nulla virtus est, quae non sentias perpeti. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit, sed receptos evincit et sanat et comprimit; haec vero minora ne sentit quidem nec adversus ea solita illa virtute utitur dura tolerandi, sed aut non adnotat aut digna risu putat. 11. Praeterea, cum magnam partem contumeliarum superbi insolentesque faciant et male felicitatem ferentes, habet quo istum affectum inflatum respuat, pulcherrimam virtutem omnium, animi magnitudinem. Illa quicquid eiusmodi est transcurrit, ut vanas species somniorum visusque nocturnos nihil habentes solidi atque veri. Simul illud cogitat, omnes inferiores esse quam ut illis audacia sit tanto excelsiora despicere. Contumelia a contemptu dicta est, quia nemo nisi quem contempsit tali iniuria notat; nemo autem maiorem melioremque contemnit, etiam si facit aliquid quod contemnentes solent. Nam et pueri os parentium feriunt, et crines matris turbavit laceravitque infans et sputo aspersit, aut nudavit in conspectu suorum tegenda et verbis obscenioribus non pepercit, et nihil horum contumeliam dicimus. Quare? Quia qui facit contemnere non potest. Eadem causa est cur nos mancipiorum nostrorum urbanitas in dominos contumeliosa delectet, quorum audacia ita demum sibi in convivas ius facit, si coepit a domino, et, ut quisque contemptissimus et in ludibrium est, ita solutissimae linguae est. Pueros quidam in hoc mercantur procaces, et illorum impudentiam acuunt ac sub magistro habent, qui probra meditate effundant, nec has contumelias vocamus, sed argutias. Quanta autem dementia est iisdem modo delectari, modo offendi, et rem ab amico dictam maledictum vocare, a servulo ioculare convicium! 12. Quem animum nos adversus pueros habemus, hunc sapiens adversus omnes, quibus etiam post iuventam canosque puerilitas est. An quicquam isti profecerunt, quibus animi mala sunt auctique in maius errores, qui a pueris magnitudine tantum formaque corporum differunt, ceterum non minus vagi incertique, voluptatum sine dilectu appetentes, trepidi, et non ingenio, sed formidine quieti? Non ideo quicquam inter illos puerosque interesse quis dixerit, quod illis talorum nucumve et aeris minuti avaritia est, his auri argentique et urbium, quod illi inter ipsos magistratus gerunt et praetextam fascesque ac
tribunal imitantur, hi eadem in Campo Foroque et in Curia serio ludunt, illi in litoribus harenae congestu simulacra domuum excitant, hi, ut magnum aliquid agentes in lapidibus ac parietibus et tectis moliendis occupati, tutelae corporum inventa in periculum verterunt. Ergo par pueris longiusque progressis, sed in alia maioraque error est. Non immerito itaque horum contumelias sapiens ut iocos accipit, et aliquando illos tamquam pueros malo poenaque admonet, non quia accepit iniuriam, sed quia fecerunt et ut desinant facere. Sic enim et pecora verbere domantur, nec irascimur illis cum sessorem recusaverunt, sed compescimus, ut dolor contumaciam vincat. Ergo et illud solutum scies, quod nobis opponitur: quare, si non accepit iniuriam sapiens nec contumeliam, punit eos qui fecerunt? Non enim se ulciscitur, sed illos emendat. 13. Quid est autem quare hanc animi firmitatem non credas in virum sapientem cadere, cum tibi in aliis idem notare, sed non ex eadem causa liceat? Quis enim phrenetico medicus irascitur? Quis febricitantis et a frigida prohibiti maledicta in malam partem accipit? Hunc affectum adversus omnes habet sapiens, quem adversus aegros suos medicus, quorum nec obscena, si remedio egent, contrectare nec reliquias et effusa intueri dedignatur, nec per furorem saevientium excipere convicia. Scit sapiens omnes hos qui togati purpuratique incedunt valentes coloratos esse, quos non aliter videt quam aegros intemperantes. Itaque ne succenset quidem si quid in morbo petulantius ausi sunt adversus medentem et, quo animo honores eorum nihilo aestimat, eodem parum honorifice facta. Quemadmodum non placebit sibi si illum mendicus coluerit, nec contumeliam iudicabit si illi homo plebis ultimae salutanti mutuam salutationem non reddiderit, sic ne se suspiciet quidem si illum multi divites suspexerint (scit enim illos nihil a mendicis differre, immo miseriores esse: illi enim exiguo, hi multo egent), et rursus non tangetur si illum rex Medorum Attalusve Asiae salutantem silentio ac vultu arroganti transierit. Scit statum eius non magis habere quicquam invidendum quam eius cui in magna familia cura obtigit aegros insanosque compescere. Num moleste feram, si mihi non reddiderit nomen aliquis ex his qui ad Castoris negotiantur, nequam mancipia ementes vendentesque, quorum tabernae pessimorum servorum turba refertae sunt? Non, ut puto. Quid enim is boni habet, sub quo nemo nisi malus est? Ergo, ut huius humanitatem inhumanitatemque neglegit, ita et regis: «Habes sub te Parthos et Medos et Bactrianos, sed quos metu contines, sed propter quos remittere arcum tibi non contigit, sed hos deterrimos, sed venales, sed novum aucupantes dominium». Nullius ergo movebitur contumelia: omnes enim inter se differant, sapiens quidem pares illos ob aequalem stultitiam omnes putat. Nam, si semel se demiserit eo ut aut iniuria moveatur aut contumelia, non poterit umquam esse securus; securitas autem proprium bonum sapientis est. Nec committet ut iudicando contumeliam sibi factam honorem habeat ei qui fecit; necesse et enim, a quo quisque contemni moleste ferat, suspici gaudeat.
14. Tanta quosdam dementia tenet, ut sibi contumeliam fieri putent posse a muliere. Quid refert quam adeant, quot lecticarios habentem, quam oneratas aures, quam laxam sellam? Aeque imprudens animal est et, nisi scientia accessit ac multa eruditio, ferum, cupiditatum incontinens. Quidam se a cinerario impulsos moleste ferunt et contumeliam vocant ostiarii difficultatem, nomenclatoris superbiam, cubicularii supercilium. O quantus inter ista risus tollendus est, quanta voluptate implendus animus ex alienorum errorum tumultu contemplanti quietem suam! «Quid ergo? Sapiens non accedet adfores quas durus ianitor obsidet?». Ille vero, si res necessaria vocabit, experietur, et illum, quisquis erit, tamquam canem acrem obiecto cibo leniet, nec indignabitur aliquid impendere ut limen transeat, cogitans et in pontibus quibusdam pro transitu dari. Itaque illi quoque, quisquis erit, qui hoc salutationum publicum exerceat donabit: scit emere venalia. Ille pusilli animi est, qui sibi placet quod ostiario libere respondit, quod virgam eius fregit, quod ad dominum accessit et petiit corium. Facit se adversarium qui contendit, et, ut vincat, par fuit. «At sapiens colapho percussus quid faciet?». Quod Cato, cum illi os percussum esset: non excanduit, non vindicavit iniuriam, ne remisit quidem, sed factam negavit; maiore animo non agnovit quam ignovisset. Non diu in hoc haerebimus: quis enim nescit nihil ex his quae creduntur mala aut bona ita videri sapienti ut omnibus? Non respicit quid homines turpe iudicent aut miserum; non it qua populus, sed, ut sidera contrarium mundi iter intendunt, ita hic adversus opinionem omnium vadit. 15. Desinite itaque dicere: «Non accipiet ergo sapiens iniuriam, si caedetur, si oculus illi eruetur? Non accipiet contumeliam, si obscenorum vocibus improbis per forum agetur, si in convivio regis recumbere infra mensam vescique cum servis ignominiosa officia sortitis iubebitur, si quid aliud ferre cogetur eorum quae excogitari pudori ingenuo molesta possunt?». In quantumcumque ista vel numero vel magnitudine creverint, eiusdem naturae erunt: si non tangent illum parva, ne maiora quidem; si non tangent pauca, ne plura quidem. Sed ex imbecillitate vestra coniecturam capitis ingentis animi, et, cum cogitastis quantum putetis vos pati posse, sapientis patientiae paulo ulteriorem terminum ponitis. At illum in aliis mundi finibus sua virtus collocavit, nihil vobiscum commune habentem. Quaere et aspera et quaecumque toleratu gravia sunt audituque et visu refugienda: non obruetur eorum coetu et, qualis singulis, talis universis obsistet. Qui dicit illud tolerabile sapienti, illud intolerabile et animi magnitudinem intra certos fines tenet, male agit: vincit nos fortuna, nisi tota vincitur. Ne putes istam stoicam esse duritiam, Epicurus, quem vos patronum inertiae vestrae assumitis putatisque mollia ac desidiosa praecipere et ad voluptates ducentia: «Raro, inquit, sapienti fortuna intervenit». Quam paene emisit viri vocem! Vis tu fortius loqui et illam ex toto summovere! Domus haec sapientis angusta, sine cultu, sine strepitu, sine apparatu, nullis asservatur ianitoribus turbam venali fastidio digerentibus, sed per hoc limen vacuum et ab ostiariis liberum fortuna non transit: scit non esse illic sibi locum, ubi sui nihil est.
16. Quod si Epicurus quoque qui corpori plurimum indulsit, adversus iniurias exsurgit, quid apud nos incredibile videri potest aut supra humanae naturae mensuram? Ille ait iniurias tolerabiles esse sapienti, nos iniurias non esse. Nec enim est quod dicas hoc naturae repugnare: non negamus rem incommodam esse verberari et impelli et aliquo membro carere, sed omnia ista negamus iniurias esse; non sensum illis doloris detrahimus, sed nomen iniuriae, quod non potest recipi virtute salva. Uter verius dicat videbimus; ad contemptum quidem iniuriae uterque consentit. Quaeris quid inter duos intersit? Quod inter gladiatores fortissimos, quorum alter premit vulnus et stat in gradu, alter respiciens ad clamantem populum significat nihil esse et intercedi non patitur. Non est quod putes magnum quo dissidemus: illud quo de agitur, quod unum ad nos pertinet, utraque exempla hortantur, contemnere iniurias et quas iniuriarum umbras ac suspiciones dixerim, contumelias, ad quas despiciendas non sapiente opus est viro, sed tantum consipiente, qui sibi possit dicere: «Utrum merito mihi ista accidunt an immerito? Si merito, non est contumelia, iudicium est; si immerito, illi qui iniusta facit erubescendum est». Et quid est illud quod contumelia dicitur? In capitis mei levitatem iocatus est et in oculorum valetudinem et in crurum gracilitatem et in staturam: quae contumelia est, quod apparet audire? Coram uno aliquid dictum ridemus, coram pluribus indignamur, et eorum aliis libertatem non relinquimus, quae ipsi in nos dicere assuevimus; iocis temperatis delectamur, immodicis irascimur. 17. Chrysippus ait quendam indignatum quod illum aliquis vervecem marinum dixerat. In senatu flentem vidimus Fidum Cornelium, Nasonis Ovidii generum, cum illum Corbulo struthocamelum depilatum dixisset: adversus alia maledicta mores et vitam convulnerantia frontis illi firmitas adversus hoc tam absurdum lacrimae prociderunt. Tanta animorum imbecillitas est, ubi ratio discessit! Quid quod offendimur si quis sermonem nostrum imitatur, si quis incessum, si quis vitium aliquod corporis aut linguae exprimit? Quasi notiora illa fiant alio imitante quam nobis facientibus! Senectutem quidam inviti audiunt et canos et alia ad quae voto pervenitur. Paupertatis maledictum quosdam perussit, quam sibi obiecit quisquis abscondit. Itaque materia petulantibus et per contumeliam urbanis detrahitur, si ultro illam et prior occupes: nemo risum praebuit qui ex se cepit. Vatinium, hominem natum et ad risum et ad odium, scurram fuisse venustum ac dicacem memoriae proditum est: in pedes suos ipse plurima dicebat et in fauces concisas; sic inimicorum, quos plures habebat quam morbos, et in primis Ciceronis urbanitatem effugerat. Si hoc potuit ille duritia oris, qui assiduis conviciis pudere dedidicerat, cur is non possit qui studiis liberalibus et sapientiae cultu ad aliquem profectum pervenerit? Adice quod genus ultionis est eripere ei qui fecit factae contumeliae voluptatem. Solent dicere: «O miserum me! Puto, non intellexit». Adeo fructus contumeliae in sensu et indignatione patientis est. Deinde non deerit illi aliquando par: invenietur qui
te quoque vindicet. 18. C. Caesar, inter cetera vitia quibus abundabat contumeliosus, mira libidine ferebatur omnes aliqua nota feriendi, ipse materia risus benignissima: tanta illi palloris insaniam testantis foeditas erat, tanta oculorum sub fronte anili latentium torvilas, tanta capitis destituti et emendicaticiis capillis aspersi deformitas. Adice obsessam saetis cervicem, et exilitatem crurum, et enormitatem pedum. Immensum est si velim singula referre per quae in parentes avosque suos contumeliosus fuit, per quae in universos ordines; ea referam quae illum exitio dederunt. Asiaticum Valerium in primis amicis habebat, ferocem virum et vix aequo animo alienas contumelias laturum. Huic in convivio, id est in contione, voce clarissima qualis in concubitu esset uxor eius obiecit. Di boni! hoc virum audire! Et usque eo licentiam pervenisse ut, non dico consulari, non dico amico, sed tantum marito princeps et adulterium suum narret et fastidium! Chaereae contra, tribuno militum, sermo non pro manu erat, languidus sono et, ni facta nosses, suspectior. Huic Gaius signum petenti modo Veneris, modo Priapi dabat, aliter atque aliter exprobrans armato mollitiam; haec ipse perlucidus, crepidatus, auratus. Coegit itaque illum uti ferro, ne saepius signum peteret. Ille primus inter coniuratos manum sustulit, ille cervicem mediam uno ictu decidit. Plurimum deinde undique publicas ac privatas iniurias ulciscentium gladiorum ingestum est, sed primus vir fuit qui minime visus est. At idem Gaius omnia contumelias putabat, ut sunt ferendarum impatientes faciendarum cupidissimi. Iratus fuit Herennio Macro quod illum Gaium salutaverat, nec impune cessit primipilari quod Caligulam dixerat: hoc enim in castris natus et alumnus legionum vocari solebat, nullo nomine militibus familiarior umquam factus; sed iam Caligulam convicium et probrum iudicabat cothurnatus. Ergo hoc ipsum solacio erit, etiam si nostra facilitas ultionem omiserit, futurum aliquem qui poenas exigat a procace et superbo et iniurioso, quae vitia numquam in uno homine et in una contumelia consumuntur. 19. Respiciamus eorum exempla quorum laudamus patientiam, ut Socratis, qui comoediarum publicatos in se et spectatos sales in partem bonam accepit risitque non minus quam cum ab uxore Xanthippe immunda aqua perfunderetur. Antistheni mater barbara et Thraessa obiciebatur; respondit et deorum matrem Idaeam esse. Non est in rixam colluctationemque veniendum. Procul auferendi pedes sunt, et quicquid horum ab imprudentibus fiet (fieri autem nisi ab imprudentibus non potest) neglegendum, et honores iniuriaeque vulgi in promiscuo habendae, nec his dolendum nec illis gaudendum. Alioqui multa timore contumeliarum aut taedio necessaria omittemus publicisque et privatis officiis, aliquando etiam salutaribus, non occurremus, dum muliebris nos cura angit aliquid contra animum audiendi. Aliquando etiam, obirati potentibus, detegemus hunc affectum intemperanti libertate. Non est autem libertas nihil pati: fallimur; libertas est animum superponere iniuriis et eum facere se ex quo solo
sibi gaudenda veniant, exteriora diducere a se, ne inquieta agenda sit vita omnium risus, omnium linguas timenti. Quis enim est qui non possit contumeliam facere; si quisquam potest? Diverso autem remedio utetur sapiens affectatorque sapientiae. Imperfectis enim et adhuc ad publicum se iudicium dirigentibus hoc proponendum est, inter iniurias ipsos contumeliasque debere versari: omnia leviora accident exspectantibus. Quo quisque honestior genere, fama, patrimonio est, hoc se fortius gerat, memor in prima acie lectos ordines stare. Contumelias et verba probrosa et ignominias et cetera dehonestamenta velut clamorem hostium ferat et longinqua tela et saxa sine vulnere circa galeas crepitantia. Iniurias vero ut vulnera, alia armis, alia pectori infixa, non deiectus, ne motus quidem gradu, sustineat. Etiam si premeris et infesta vi urgeris, cedere tamen turpe est: assignatum a natura locum tuere. Quaeris quis hic sit locus? Viri. Sapienti aliud auxilium est, huic contrarium: vos enim rem geritis, illi parta victoria est. Ne repugnate vestro bono, et hanc spem, dum ad verum pervenitis, alite in animis, libentesque meliora excipite et opinione ac voto iuvate: esse aliquid invictum, esse aliquem in quem nihil fortuna possit, e re publica est generis humani.
La fermezza del saggio
Premessa Il De constantia sapientis affronta un aspetto particolare del saggio e cioè il suo atteggiamento di fronte alle offese. Composto fra il 55 e il 56 e dedicato ad Anneo Sereno, sovrintendente delle guardie imperiali (un epicureo che Seneca si propone di convertire allo stoicismo e a cui dedicherà anche il De otio e il De tranquillitate animi), il dialogo reca già indicato il contenuto nel sottotitolo, in cui è detto nec iniuriam nec contumeliam accipere sapientem, cioè che il saggio non può essere toccato da alcun tipo di offesa, un tema che, per ciò che riguarda l’impassibilità del saggio, ricorre anche nel De providentia e nella Consolatio ad Helviam matrem. Cosa sono l’iniuria e la contumelia? L’iniuria (da in-ius, o in-iustitia) è un’offesa «contro il diritto», o «contro la giustizia», la contumelia è anch’essa un’offesa, consistente, però, in parole o invettive rivolte ad altri direttamente, a voce o per iscritto, allo scopo di lederne l’onore: un vilipendio, dunque, un atto di disprezzo, come testimonia la derivazione del vocabolo da contemnere, che significa appunto «disprezzare». Seneca la considera meno grave dell’ingiuria, precisando, a dimostrazione di ciò, che «le leggi non la ritengono passibile di alcuna sanzione». Tradurre dunque contumelia col termine generico di «offesa» (come fanno alcuni) non è esatto. C’è chi rende iniuria con «offesa grave» e contumelia con «offesa lieve», ma è una distinzione inutile, tantopiù che i Romani generalmente – e non alcuni, come dice Seneca – ritenevano la contumelia più grave, appunto perché muoveva da un sentimento di disprezzo. Noi, tagliando la testa al toro, abbiamo reso iniuria e contumelia con i loro esatti corrispondenti «ingiuria» e «contumelia», ricorrendo a volte, anche per evitare ripetizioni, al termine generico di «offesa», ma solo riguardo all’iniuria. Per dare subito un’idea del suo modello di saggezza, Seneca dice che fra il saggio stoico e tutti quanti gli altri saggi c’è la stessa differenza che passa fra i maschi e le femmine, nel senso che gli uni sono nati per comandare, le altre per obbedire, e paragona i saggi non stoici ai medici di famiglia, che curano le malattie non come dovrebbero, ma come vogliono i malati. I saggi stoici, invece, virilem ingressi viam, non si preoccupano che la «cura» sia gradevole, ma mirano solo a liberarci al più presto dalla schiavitù dei nostri mali. Parlando poi del saggio in generale, Seneca dice che egli non può essere toccato da nessuna ingiuria o contumelia, perché, attraverso l’esercizio continuo della virtù che lo ha abituato a sopportare ogni sorta di offese, ha raggiunto l’imperturbabilità. Egli è simile a quei corpi che il fuoco non riesce a distruggere, o all’acciaio, contro cui si spuntano gli attrezzi che cercano di scalfirlo, o ancora a certi scogli che, per quanto flagellati per secoli dalle onde, non mostrano alcuna traccia della loro violenza. E cita gli esempi di Catone Uticense – che, preso a schiaffi, non reagì, né perdonò l’offesa, ma negò semplicemente che gli fosse stata fatta (dimostrando così, con l’ignorarla, maggiore magnanimità che perdonandola) – e del filosofo greco Stilpone, il quale, avendo perso ogni cosa nella distruzione della sua città, dichiarò che nulla aveva perduto, dal momento che i suoi veri beni – la virtù, la saggezza, l’imperturbabilità – erano sempre con lui. Di fronte alle offese, precisa Seneca, l’atteggiamento degli epicurei è sostanzialmente diverso da quello degli stoici, giacché i primi sostengono che per il saggio esse sono tollerabili, i secondi che non esistono neppure. Le offese, dice poi, le fanno gli sprovveduti e perciò non possono essere prese in considerazione, così come non si ritengono offensive le parole ingiuriose di un bambino. Bambini, infatti, sono considerati da Seneca tutti quelli che offendono. Quanto alla donna, egli si chiede (XIV), quale offesa può recare «un essere irriflessivo, selvatico e incapace di controllare le proprie passioni?». Eppure – osserva meravigliato – «alcuni arrivano a tal punto di stupidità da ritenere di poter essere offesi da una donna» (cioè da un essere inferiore, che, come ha detto all’inizio del dialogo, è nato per obbedire). Rimprovera poi coloro che offendono, ma aggiunge che proprio perché le offese ci sono la saggezza mostra la sua forza (se non ci fossero le tentazioni non ci sarebbe la virtù). Ci esorta infine a consolarci pensando che prima o poi qualcuno, punendo chi l’ha offeso, vendicherà anche noi, e, a conferma di ciò, cita l’esempio di Caligola, che a furia d’insultare la gente ebbe la morte che meritava. Anche in questo dialogo non sempre le argomentazioni di Seneca a sostegno del suo pensiero sono chiare e convincenti. La stessa immagine che egli ci dà del saggio non è del tutto coerente, ma il
dialogo è molto vivo, sia per gli esempi felici e appropriati ricavati dalla vita quotidiana, sia per il rapporto che Seneca riesce a instaurare con le persone di qualunque ceto e cultura, specialmente nella parte finale, in cui ci esorta a sopportare serenamente qualunque tipo di offesa, mostrandoci degni del nome di uomini. M. S. A.
1. Si può giustamente affermare, o Sereno, che fra gli stoici e quelli che come loro professano la saggezza c’è la stessa differenza che passa tra i maschi e le femmine, nel senso che entrambi i gruppi contribuiscono in uguale misura alla vita sociale, ma i maschi sono nati per comandare, le femmine per obbedire. Tutti gli altri saggi sono miti e indulgenti e si comportano perlopiù come quei medici di famiglia che curano le malattie non nel modo migliore e più rapido, ma come piace al malato; gli stoici, invece, che seguono una condotta davvero degna dell’uomo, non si preoccupano che essa appaia gradevole agli iniziati, a coloro, cioè, che hanno scelto di mettersi su quella strada, ma pensano solo a liberarsi al più presto dalle pastoie della vita, sollevandosi a una vetta così alta, al di là di qualunque gettata di dardo, da porsi al di sopra del loro stesso destino. Obietterai che quella indicata dagli stoici è una strada ripida e piena di precipizi. E con ciò? Forse che in alto si arriva facilmente, tenendosi rasoterra? Ma poi questo cammino non è neppure così ripido e dirupato come generalmente si crede. Solo il primo tratto è cosparso di sassi e di rupi, e perciò sembra impraticabile, così come, a colpo d’occhio, se si guardano da lontano, tutti i sentieri di una montagna appaiono perlopiù tortuosi e collegati fra loro in una massa uniforme, inquantoché la distanza inganna la vista, ma poi, via via che ci si avvicina, quello che l’occhio umano aveva per errore mescolato in un tutto unico e confuso, a poco a poco si fa chiaro e distinto e quelli che da lontano sembravano precipizi diventano lievi e facili pendii. 2. Qualche tempo fa, essendo il nostro discorso caduto su Catone,1 ti mostrasti sdegnato – tu che non tolleri le ingiustizie – per il fatto che quel grand’uomo fu capito poco dai suoi contemporanei, i quali lo giudicavano addirittura al di sotto di Vatinio, lui che era al di sopra di Cesare e di Pompeo, e ti sembrava vergognoso che nel Foro, poiché era contrario all’approvazione di una legge, gli fosse stata strappata di dosso la toga e che, trascinato dai Rostri sino all’Arco di Fabio da una banda di facinorosi, avesse dovuto sopportare gl’insulti, gli sputi e ogni altro genere di offese da parte della folla inferocita. Ebbene, allora io ti risposi che avevi ragione a sdegnarti per la sorte dello Stato – che Publio Clodio2 da un lato e Vatinio da un altro, insieme a tutti i peggiori, stavano vendendo all’asta, senza rendersi conto, accecati com’erano dalla loro avidità, che vendendo lo Stato vendevano anche sé stessi – ma per ciò che riguardava Catone ti dissi di stare tranquillo, giacché nessun uomo saggio può
subire alcuna ingiuria o contumelia, e Catone ci era stato dato dagli dèi immortali quale esempio di saggezza, ancora più sicuro di quello offerto da Ulisse e da Ercole alle nostre passate generazioni. Costoro furono definiti saggi dai nostri antichi stoici perché invincibili nelle fatiche, sprezzanti dei piaceri e vincitori di tutte le paure, Catone, invece, non combatte contro le belve – un compito, questo, riservato ai cacciatori e ai contadini – né assalì mostri col ferro o col fuoco, né gli toccò di vivere in un tempo in cui ancora si poteva credere che il mondo poggiasse sulle spalle di un gigante, giacché ormai le vecchie superstizioni erano crollate e la gente s’era fatta estremamente scaltra. Lottando contro l’ambizione, mostro dai mille volti, e contro la smisurata brama di potere – tale che nemmeno il mondo intero, diviso fra tre sole persone, Cesare, Crasso e Pompeo,3 poteva saziare – lui solo si levò contro i vizi di una città corrotta che stava per crollare sotto il suo stesso peso, ritardando così la caduta della repubblica, per quanto poteva farlo con la sua sola mano, sino a quando, travolto anche lui, volle partecipare a quella rovina che aveva cercato a lungo di evitare, e così perirono insieme due cose che non era possibile separare: né Catone, infatti, sopravvisse alla libertà, né la libertà sopravvisse a Catone. Credi dunque che il volgo abbia recato offesa a quest’uomo quando gli tolse la pretura, gli strappò di dosso la toga o coprì il suo sacro capo di sputi? Il saggio è imperturbabile di fronte a ogni male e non può essere raggiunto da alcuna ingiuria o contumelia. 3. A questo punto mi sembra di vederti fremere dentro e ribollire di sdegno. «Ecco», stai per sbottare, «sono questi i discorsi che tolgono credibilità ai vostri insegnamenti: promettete cose tanto grandi che non si possono né credere né desiderare, poi, dopo averne dette tante, dopo avere affermato che il saggio non può essere povero, siete costretti a riconoscere che spesso non ha uno schiavo, non ha un tetto, né cibo, addirittura; dopo avere proclamato che il saggio non può diventare pazzo, ammettete che può perdere il lume della ragione, dire parole insensate e comportarsi di conseguenza, non potendo sottrarsi agl’impulsi della sua malattia; così da un lato dite che il saggio non può essere schiavo, dall’altro confessate che può essere venduto o costretto a eseguire degli ordini e a compiere lavori servili per un padrone, sicché in sostanza, con tutta la vostra boria, finite col dire le stesse cose che dicono gli altri: cambiate i nomi, ma il contenuto resta tale e quale. E mi viene il sospetto che il vostro ragionamento non funzioni nemmeno per quel che riguarda l’idea, bella e magnifica a prima vista, secondo cui il saggio non può ricevere né ingiurie né contumelie. Perché un conto è ritenere il saggio immune da ogni risentimento (in quanto questo dipende da lui), un conto è ritenerlo esente da ogni ingiuria (in quanto questa dipende dagli altri). Se infatti dici che sopporta ogni cosa con animo sereno non gli dai alcun privilegio sugli altri, gli conferisci solo una virtù abbastanza comune, che si acquista proprio con la frequenza delle ingiurie ricevute, la sopportazione; se invece mi dimostri che non riceverà mai alcuna offesa, nel senso che nessuno
tenterà di fargliene, allora pianto baracca e burattini e mi faccio stoico». Ascoltami bene. Io non mi sono mai sognato d’incensare il saggio con delle lodi sperticate, attribuendogli delle doti immaginarie, ho solo voluto collocarlo in un posto in cui non possa giungergli alcuna offesa. In che senso?, mi domandi. Nel senso che non ci sarà mai nessuno che lo provochi, che lo aggredisca? In questo mondo non c’è niente di tanto sacro che non possa essere soggetto agli attacchi di un empio, ma non per questo le cose divine sono meno sublimi, per il fatto, cioè, ch’esiste qualcuno desideroso di colpirle; senza però riuscire a toccarle, giacché si trovano a una tale altezza che va ben oltre la portata delle nostre forze. In poche parole, è invulnerabile non chi non viene colpito, ma chi non si sente ferito: in questo è il privilegio del saggio, e te ne farò il ritratto partendo proprio da qui. C’è forse da dubitare se dia più affidamento una forza che non si lascia mai vincere o una che non viene mai attaccata? Nessuna certezza ci offrono quelle energie che non sono mai state messe alla prova, mentre è da considerarsi, e giustamente, saldissima quella fermezza che respinge tutti gli assalti. Allo stesso modo devi considerare più saggio chi non sente le ingiurie che non colui al quale non ne viene mai fatta alcuna. Così come è più forte chi non si lascia piegare dalle guerre o non si turba al sopraggiungere del nemico, che non chi vive in un piacevole ozio fra pacifiche popolazioni. È questo, dunque, ciò che intendo dire quando affermo che il saggio non è soggetto ad alcuna ingiuria. Perciò non importa quante e quali frecciate gli si lancino addosso: egli è impenetrabile a tutte. Come certe pietre per la loro durezza non vengono intaccate dal ferro,4 come l’acciaio non può essere tagliato o spezzato o consumato con l’uso, ma respinge gli attrezzi che lo aggrediscono, come certi corpi non sono distrutti dal fuoco ma anche avvolti dalle fiamme mantengono la loro forma e la loro consistenza, come certi scogli che, protesi verso il mare aperto, frangono le onde e, benché flagellati per tanti secoli, non mostrano alcuna traccia di quella violenza, così l’animo del saggio se ne sta saldo e sicuro e accoglie in sé una forza tale che lo pone al riparo da ogni ingiuria, come le cose che perlappunto ho citato. 4. «In conclusione, nessuno tenterà di fare ingiuria al saggio: è questo che vuoi dire?». Dico che l’ingiuria può anche essergli fatta, ma non lo tocca: egli è talmente lontano da ogni contatto con le cose volgari che nessuna forza maligna può praticamente raggiungerlo ed esercitare su di lui i suoi effetti nocivi. Siano pure i potenti ad attaccarlo – quelli che stanno in alto e comandano, forti del servilismo dei sudditi – tutti i loro assalti sono destinati a fallire di fronte alla sua saggezza prima ancora di sfiorare il bersaglio, come dei proiettili scagliati in alto da un arco o da una catapulta, che salgono, salgono sino a perdita d’occhio ma a un certo punto ricadono giù senz’avere raggiunto il cielo. Credi forse che quando quel pazzo del re Serse5 oscurò il giorno scagliando in aria una gran moltitudine di frecce ce ne sia stata fra tante almeno una che abbia colpito il sole? O che quando calò delle catene nel profondo del mare abbia potuto
acchiappare Nettuno? Come le cose divine sfuggono alla mano dell’uomo e quelli che distruggono templi e fondono statue degli dèi non nuocciono affatto alla divinità, così qualunque atto di malvagità, d’insolenza e di superbia compiuto contro il saggio è sforzo vano. Mi obietterai che sarebbe meglio se nessuno l’offendesse. D’accordo, ma tu pretendi dagli uomini una cosa difficile, l’incapacità di fare del male; e d’altronde questo problema, se astenersi o no dalle offese, riguarda solo coloro che sono in grado di poterle fare, ma non chi non può esserne toccato, chi non sente le ingiurie che gli vengono rivolte, ed è proprio in questo caso, se cioè le offese ci sono, che la saggezza mostra meglio la sua forza, restandosene tranquilla pur in mezzo agli assalti, così come un comandante, forte d’armi e di uomini, dà prova di un coraggio autentico, vero, in territorio nemico. 5. E adesso, Sereno, se sei d’accordo, vediamo che differenza passa fra l’ingiuria e la contumelia. La prima è per sua natura più grave, la seconda più leggera e risulta molesta solo alle persone permalose, non procura praticamente alcun danno, genera solo irritazione. Tuttavia la debolezza e la vanità dell’animo umano sono tali che alcuni considerano la contumelia come la cosa più terribile che vi sia, per cui può capitare che uno schiavo preferisca essere preso a frustate piuttosto che a pugni o ritenga la morte e le percosse più sopportabili delle parole offensive: siamo infatti arrivati all’assurdo che persino l’idea del dolore ci procura risentimento, come accade ai bambini, che si spaventano alla vista di un’ombra, di una maschera deforme o di un volto alterato, e che di fronte a una parola dal suono poco gradevole, a un movimento delle dita o a qualunque altro fatto che, per la loro inesperienza, istintivamente respingono, scoppiano subito a piangere. L’ingiuria mira a fare del male, ma questo non ha presa sul saggio: per lui l’unico male sarebbe l’infamia, ma anche questa non può entrare dove risiedono la virtù e l’onestà. Dunque, se non c’è ingiuria dove non c’è male, se non c’è male dove non c’è infamia, e l’infamia non può toccare chi è tutto preso dal bene, ne consegue che l’ingiuria non può raggiungere il saggio. Se essa infatti consiste nel patire qualcosa di male, e il saggio non può patire alcun male, è evidente che nessuna ingiuria potrà toccarlo. L’ingiuria reca danno a chi la riceve, il danno consiste in una qualche menomazione fisica o morale o nella perdita di beni esterni, ma il saggio non può perdere nulla in quanto ha tutto dentro di sé, non affida niente alla fortuna, ha i suoi beni al sicuro, pago della virtù, che non ha bisogno di cose fortuite e che perciò, essendo tutto per lui, non può né aumentare né diminuire: infatti ciò che ha raggiunto il massimo del suo sviluppo non può crescere ulteriormente, e d’altra parte la sorte può togliere solo quello che ha dato, ma non la virtù, che non è elargita da lei, in quanto è libera, inviolabile, immutabile, irremovibile, così fortificata di fronte alle disgrazie che non si lascia né piegare né vincere, osserva con occhio fermo, imperturbabile, senza battere ciglio, anche gli eventi più terribili che stanno per accadere e lo svolgersi di essi, siano pure i più spaventosi, le portino sventure o felicità. Il
saggio, quindi, non può perdere nulla di cui possa poi sentire la mancanza: il suo unico e vero bene, infatti, è la virtù, di cui, come ho già detto, non potrà mai essere privato; di tutto il resto si serve come di cosa precaria, accordatagli da altri a titolo di favore e perciò revocabile a discrezione di chi gliel’ha data, e chi mai si scompone per la perdita di un bene non suo? Ergo, se l’ingiuria non può danneggiarlo in niente di ciò che è esclusivamente suo – e se è salva la sua virtù sono salvi tutti i suoi beni – ne consegue che il saggio non può ricevere ingiuria. Il filosofo Stilpone, interrogato da Demetrio Poliorcete6 – che aveva conquistato Megara, la sua città – se mai avesse perso qualcosa: «Nulla», rispose, «tutti i miei beni sono con me». Eppure il nemico gli aveva depredato l’intero patrimonio, portato via le figlie, la sua patria era caduta sotto il dominio straniero, e ora il re vincitore, attorniato da tutto il suo esercito in armi, lo interrogava dall’alto del suo seggio. Ma lui gli tolse la soddisfazione di averlo vinto, gridandogli chiaro in faccia che nonostante la presa della città egli non solo rimaneva invitto ma ne usciva immune da qualsiasi danno, giacché aveva con sé i beni veri, autentici, su cui nessuno può mettere le mani: gli altri, che gli venivano saccheggiati e portati via, non li considerava suoi ma stranieri e soggetti al capriccio della sorte, per cui non li aveva mai amati come propri. Incerto, infatti, e sfuggevole è il possesso di tutto ciò che ci viene dal di fuori. 6. Se dunque né la guerra, né i nemici, né quel maestro famoso nell’arte egregia di distruggere le città poterono togliere nulla a quel grande saggio, pensa un po’ se potevano fargli ingiuria un ladro, un calunniatore, un vicino di casa arrogante o un riccone gonfio di autorità soltanto perché vecchio e senza figli. Fra le spade che balenavano da ogni parte e il tumulto dei soldati intenti al saccheggio, tra le fiamme, il sangue e le stragi di una città in rovina, tra il fragore dei templi che crollavano sui loro dèi, un solo uomo era in pace.7 Non hai motivo, quindi, di considerare avventata la mia promessa, a sostegno della quale non ti do solo la mia parola ma ti offro anche un garante, visto che ancora stenti a credere che in un uomo possano esserci tanta fermezza e tanta magnanimità. Ecco che lo stesso Stilpone ti si fa avanti e ti dice: «Non hai ragione di dubitare che un uomo possa innalzarsi al di sopra delle vicende umane e guardare imperterrito i dolori, le sventure, le piaghe, le ferite, i grandi cambiamenti che gli si agitano intorno; che possa accettare tranquillamente le avversità e con moderazione la buona sorte, non lasciandosi vincere da quelle né confidando troppo in questa, mantenendo insomma il medesimo atteggiamento pur nel variare delle situazioni e ritenendosi proprietario di niente altro che di sé stesso. Ecco, guarda: mentre a opera di questo distruttore di città ogni difesa materiale crolla sotto i colpi dell’ariete, le alte torri all’improvviso sprofondano nei cunicoli e nei fossi sotterranei e i bastioni innalzati per l’assedio raggiungono le difese più alte, non c’è macchina che possa atterrire un animo così saldo. Sono appena scampato alla rovina della mia casa e con gl’incendi che divampano da ogni parte ho evitato le fiamme attraversando laghi di sangue; ignoro la sorte delle mie figlie, forse
peggiore di quella toccata alla città; vecchio e solo, attorno a me non vedo che nemici, e tuttavia dichiaro apertamente che il mio patrimonio non ha subìto alcun danno: tutto quello che avevo m’è rimasto. Non puoi perciò considerarmi vinto, né, per quel che mi riguarda, ritenere vincitore quel re: non è lui, infatti, semmai, che mi ha sconfitto, è la sua sorte, di cui egli non è che uno strumento, che ha avuto ragione della mia. Non so dove siano quei beni caduchi, destinati a mutare padrone, ma i miei, quelli autentici, veri, sono con me, né mai potranno lasciarmi. I ricchi perdono interi patrimoni, i libertini gli amori lascivi, di cui si compiacciono con grave danno per la propria reputazione, gli ambiziosi il Foro, il Senato e gli altri posti riservati al pubblico esercizio delle umane debolezze, gli usurai perdono i registri, su cui la loro avarizia, che va beandosi a torto, sogna ricchezze a non finire; io, invece, conservo intatta e integra ogni cosa. Interroga questi vinti che piangono, che si lamentano di aver perduto qualcosa, che per salvare il denaro oppongono alle spade sguainate il corpo nudo, che fuggono davanti al nemico col grembo pieno di roba». Convinciti dunque, o Sereno, che chi è perfetto, ricco, cioè, di virtù umane e divine, non può perdere nulla. I suoi beni sono protetti da difese solide e inespugnabili. Niente sono al confronto di queste le mura di Babilonia, nelle quali Alessandro riuscì a penetrare,8 né quelle di Cartagine e di Numanzia, espugnate da un solo braccio, né la rocca del Campidoglio, che porta ancora i segni dell’assalto nemico. Le mura che difendono il saggio sono a prova d’incendi e d’incursioni, né offrono il minimo accesso; inattaccabili, eccelse, s’alzano sino agli dèi. 7. E ora, come al solito, non dirmi che questo saggio non lo si trova da nessuna parte. Noi stoici non c’inventiamo una gloria impossibile per l’uomo, non concepiamo l’immagine sublime di qualcosa che non esiste: questo saggio, quale noi lo rappresentiamo, si è già realizzato e si realizzerà ancora, raramente, forse, magari ne verrà fuori uno ogni tanto, a lunghi intervalli di tempo, perché gli uomini eccezionali, che superano il livello comune, non nascono spesso, ma verrà; e d’altra parte penso che Marco Catone stesso, dal cui ricordo ha preso inizio questa nostra discussione, sia andato addirittura al di là del modello che noi stoici proponiamo. Considera infine che ciò che ferisce deve necessariamente essere più forte di ciò che viene ferito, e poiché la malvagità non è più forte della virtù ne consegue che il saggio non può esserne ferito. È ovvio, infatti, che solo i cattivi possono tentare di nuocere ai buoni, giacché questi sono in pace, fra loro, e se può sentirsi ferito soltanto chi è più debole del feritore – e il malvagio è più debole del buono – è evidente che il saggio non può essere toccato dall’ingiuria. Quando dico saggio mi riferisco naturalmente a un uomo buono, giacché la bontà – non c’è bisogno ch’io te lo ricordi – è propria della saggezza. Mi obietterai: «Ma se Socrate, ch’era un uomo buono, ha scontato, e ingiustamente, una condanna, vuol dire che l’ingiuria l’ha subita». Non è così: il fatto che uno mi lanci un insulto non comporta necessariamente che io lo riceva. È come se un ladro rubasse un oggetto della mia villa di campagna e
andasse a riporlo nella mia casa di città: il furto è stato commesso, ma io non ho perduto niente. Quanto al ladro, egli rimane sempre un malfattore, anche se, praticamente, non ha recato alcun male. Se un marito, mentre fa l’amore con la sua donna, pensa a un’altra, si comporta da adultero, ma sua moglie non può certo dirsi infedele. Mettiamo che uno mi somministri del veleno mescolandolo nel cibo e che per questa ragione quello non faccia alcun effetto: bene, quel tizio, nel darmi il veleno, ha commesso un crimine, anche se all’atto pratico non m’ha ammazzato. Un delinquente non è meno assassino per il fatto che io ho impedito alla sua arma di uccidermi facendomi scudo con la veste. Tutti i delitti sussistono anche prima della loro esecuzione materiale, quando, naturalmente, vi sia un motivo sufficiente di colpa. Alcune cose, poi, sono di tale natura e collegate fra loro in modo che una può stare senza l’altra ma non viceversa. Cercherò di chiarirti il mio concetto. Io posso muovere i piedi senza per questo camminare, ma non posso camminare senza muovere i piedi. Così se sto in acqua posso non nuotare, ma se nuoto devo per forza essere in acqua. Lo stesso vale per ciò di cui stiamo parlando: se ho ricevuto un’ingiuria è segno ch’è stata commessa, ma, se mi è stata indirizzata, non necessariamente io devo averla raccolta. Per non dire che possono intervenire molti fattori esterni a impedire che l’ingiuria mi arrivi: come un fatto accidentale può bloccare la mano che tenta di colpirmi, o deviare una freccia già scagliata, così un evento qualsiasi può respingere o intercettare a metà strada l’offesa, di qualunque genere sia, con la conseguenza che essa risulta commessa ma non ricevuta. 8. D’altra parte la giustizia non può subire alcuna ingiustizia per la semplice ragione che i contrari non sono compatibili fra loro, non possono fondersi insieme, tanto è vero che l’ingiuria non può essere fatta se non ingiustamente: ergo, il saggio, che è un uomo giusto, è immune da ogni ingiuria. E se ti meravigli che nessuno possa nuocergli, pensa che, per la stessa ragione, non c’è alcuno che possa giovargli. A lui, infatti, non manca nulla, nulla, intendo, che possa essergli dato come un dono, o come un favore, e il malvagio cosa può offrire che sia degno del saggio? Innanzitutto dovrebbe avere qualcosa di utile da poter dare, e poi, quand’anche ce l’avesse e glielo desse, il saggio non potrebbe mai rallegrarsene. Insomma, come gli esseri divini non hanno bisogno di aiuto e non possono essere offesi, così nessuno può nuocere o giovare al saggio, il quale è molto vicino agli dèi, simile appunto a un dio, se si eccettua la sua condizione mortale. Nel tendere con tutte le sue forze a quelle sfere sublimi, ordinate, imperturbabili, dal moto regolare e armonico, serene, amorevoli, create per il bene di tutti, salutari per sé stesse e per gli altri, il saggio non potrà mai concepire niente di meschino né rimpiangere alcunché. Chi, sorretto dalla ragione, passa tra le vicende umane con l’animo di un dio non può ricevere offese, e non dico soltanto da parte dell’uomo: non ne riceverà nemmeno dalla sorte, la quale, ogni volta che ha ingaggiato battaglia con la virtù, non ne è mai uscita vittoriosa. Se noi accettiamo con animo calmo e sereno quello che è il
peggiore di tutti i guai, al di là del quale nulla possono più minacciarci delle leggi ingiuste e crudeli né i tiranni più spietati e contro cui diventa vano tutto il potere della fortuna, se siamo convinti che la morte, la morte, dico, non è un male e perciò neppure un’ingiuria, a maggior ragione potremo sopportare le altre avversità, le disgrazie, i dolori, le infamie, gli esilii, le perdite dei nostri cari, le separazioni, mali, questi, che quand’anche assalissero il saggio e lo stringessero in cerchio tutti insieme non riuscirebbero a sommergerlo, e tanto meno lo potrebbero singolarmente. E se egli sopporta con animo equilibrato le offese della fortuna, quanto più facilmente sopporterà quelle degli uomini potenti, i quali sono per lui nient’altro che strumenti della fortuna stessa. 9. Il saggio accetta tutto, come accetta i rigori dell’inverno, le intemperie, le febbri, le malattie e qualunque altro accidente che possa capitargli, ne giudica gli altri così ottimisticamente da crederli capaci di agire con giudizio, poiché questo è solo del saggio. Quelle di tutti gli altri non sono azioni assennate, sono inganni, insidie, sregolati moti dell’animo, che il saggio pone nel numero degli eventi fortuiti. Come l’ingiuria, appunto. Siamo accerchiati da una folla di cose occasionali, che infuriano da tutte le parti. Pensa quanti tipi e possibilità di offese possono venirci dagli altri, tali da mettere addirittura in pericolo la nostra vita, come prezzolare un delatore perché ci muova una falsa accusa, o scatenare contro di noi l’odio dei potenti, e tutte quelle altre ribalderie che sono in uso fra la cosiddetta gente civile. È ingiuria anche il privare uno di un giusto guadagno o di un successo a lungo sognato, soffiargli un’eredità ricercata con grande fatica o togliergli il favore di una famiglia ricca. Ma il saggio è esente da tutto ciò, inquantoché nella vita non ha né speranze né timori. Infatti, mentre chi riceve un’ingiuria l’avverte e si turba, il saggio, che è riuscito a sottrarsi alle lusinghe e agl’inganni della vita, che sa controllarsi e mantenersi in uno stato di placida e profonda serenità, è immune da ogni turbamento. Inoltre chi è ferito da un’ingiuria non solo ne resta scosso ma si arrabbia, cosa che non avviene al saggio, il quale non potrebbe essere immune dall’ira – che molte volte nasce alla sola idea di poter ricevere un’offesa – se non lo fosse anche dall’ingiuria, e ciò perché è consapevole che essa non può toccarlo. Per questo il suo animo è così elevato e sereno, per questo è sorretto da una letizia che non lo abbandona mai. Sino a tal punto egli non cede di fronte ai colpi degli eventi e degli uomini che l’ingiuria stessa finisce per essergli utile, nel senso che gli consente di mettere alla prova sé stesso e di sperimentare la sua virtù. Assecondiamo, vi prego, tale proposito, e prestiamo benevola attenzione all’uomo saggio, che riesce a sottrarsi all’ingiuria! Non per questo sarà tolto qualcosa alla vostra sfacciataggine, alle vostre brame insaziabili, alla cieca sconsideratezza e alla vostra superbia: noi stoici rivendichiamo per il saggio questa libertà senza toccare i vostri vizi. Il nostro intento non è quello d’impedire le offese, noi chiediamo soltanto che il saggio possa lasciarle passare tutte senza vendicarsene, che se ne difenda con la tolleranza e la magnanimità. È così che nelle gare sacre
molti ottengono la vittoria, stancando con una lunga e meditata pazienza le energie dell’avversario, e il saggio è della stessa tempra di coloro che con assiduo e coscienzioso esercizio hanno conseguito una forza tale da sostenere e fiaccare ogni violenza nemica. 10. Esaurita la prima parte del nostro discorso, relativa all’ingiuria, passiamo ora alla seconda, nella quale, con argomentazioni specifiche e generali insieme, dimostreremo l’inconsistenza della contumelia nei confronti del saggio. Cominciamo col dire che essa è meno grave dell’ingiuria e che, più che vendicarci di lei, possiamo lamentarcene, se, com’è vero, le leggi non la ritengono passibile di alcuna sanzione. È proprio di un animo mediocre risentirsi e chiudersi in sé stesso per una frase o per un’azione sgarbata. «Quel tizio oggi non mi ha ricevuto, ma altre persone le riceveva.» Oppure: «Mentre gli parlavo ostentava un superbo disprezzo o mi rideva in faccia pubblicamente». E ancora: «Invece di darmi un posto di riguardo, mi ha assegnato il peggiore». Come chiamare queste e altre simili frasi se non lamentele, proprie di un animo permaloso? Generalmente sono gli schizzinosi e quelli che vivono nell’agiatezza a imbattersi in situazioni del genere, che non capitano invece a chi ha cose ben più importanti a cui pensare. Quando non hanno niente da fare, le persone deboli per natura o effeminate e suscettibili, perché non hanno mai conosciuto le offese vere, si risentono e si turbano di fronte a simili bazzecole, che il più delle volte sono frutto di un’errata interpretazione. Perciò chi si sente colpito da una contumelia mostra di non avere né giudizio né consapevolezza di sé, dal momento che si ritiene suscettibile di disprezzo: la sua amarezza è lo specchio di un animo mediocre, che tende ad abbassarsi, a umiliarsi. Il saggio, invece, non si sente mai disprezzato, perché è consapevole della propria grandezza e non gli viene neppure in mente che qualcuno possa osare tanto contro di lui, perciò queste molestie dell’animo – non le chiamerei infatti sofferenze – non è che riesce a superarle, non le avverte proprio. Ben altre sono le cose che possono colpire il saggio, senza però abbatterlo, come il dolore fisico, l’invalidità, la perdita dei figli e degli amici, la rovina della patria incendiata dalla guerra: questi mali io non nego che il saggio li avverta – non vogliamo infatti attribuirgli la durezza e l’insensibilità del ferro o della pietra, né c’è virtù nel sopportare una cosa che non si sente. Allora? Allora li avverte, sì, ma nel medesimo istante li domina, ne guarisce, ne cancella le tracce. Le piccolezze, invece, non le sente nemmeno, né scomoda contro di esse la sua consueta virtù, avvezza a sostenere prove ben più dure: non le tiene insomma in alcun conto, o le considera degne di riso. 11. Inoltre, visto che generalmente le contumelie le fanno i presuntuosi, gl’insolenti e gli eterni insoddisfatti, per respingere questo contegno arrogante il saggio possiede la più bella delle virtù, la magnanimità, la quale passa sopra le offese come se fossero delle vane immagini di sogno, fantasmi notturni privi di
consistenza e di verità. Al tempo stesso egli ritiene che gli altri stiano troppo in basso per poter disprezzare degli esseri di gran lunga superiori a loro. La parola contumelia deriva da contemptus, che significa «disprezzo», e infatti non si reca una tale offesa se non a chi si disprezza, e un uomo non disprezza chi è più grande o migliore di lui, anche se a volte usa nei suoi confronti un atteggiamento che è tipico di chi disprezza. I bambini, per esempio, picchiano sul volto i genitori, i più piccoli spettinano la madre o le strappano i capelli, le sputano addosso o si scoprono davanti ai familiari quelle parti del corpo che dovrebbero restare coperte e non risparmiano parole oscene, eppure nessuno di questi atti li consideriamo un’offesa. E sai perché? Perché chi li compie non è capace di provare disprezzo. E come sorridiamo di fronte a tali gesti, così ci dilettiamo dell’arguzia dei nostri schiavi, un’arguzia che spesso, in realtà, diventa offensiva nei confronti dei padroni, anzi molti di loro sono così insolenti che dopo avere attaccato impunemente il padrone si sentono in diritto di punzecchiare anche gli ospiti e quanto più sono essi stessi disprezzati e derisi, tanto più hanno la lingua sciolta e si permettono certe libertà. C’è persino chi compra a tale scopo degli schiavetti procaci e li affida alle cure di un maestro che ne stimoli e ne perfezioni l’impertinenza in modo che sappiano lanciare insolenze ben studiate, e queste, tuttavia, noi non le chiamiamo contumelie, ma facezie. Che strana pazzia è la nostra: le medesime cose ora ci offendono, ora ci divertono, la stessa frase se è detta da un amico la chiamiamo maldicenza, se la dice invece uno schiavo è una battuta di spirito. 12. Ora, il saggio mostra verso tutti i suoi simili l’atteggiamento che noi abbiamo nei confronti dei bambini, perché l’uomo, anche quando non è più giovane e ha i capelli bianchi, resta sempre un po’ infantile: non si può dire infatti che abbia compiuto dei progressi se il suo animo è malato e i suoi errori, i suoi pregiudizi, invece di diminuire, sono andati crescendo. Gli adulti non differiscono dai fanciulli se non per la grandezza e l’aspetto fisico, ma in tutto il resto non sono meno volubili e incerti di loro, avidi di piaceri, di cui poi non sanno nemmeno godere, sempre pieni di trepidazione, e se se ne stanno buoni buoni è solo per paura, non per disposizione naturale. Non c’è dunque tanta differenza fra gli adulti e i bambini, perché questi sono attaccati ai dadi, alle noci, alle monetine, e quelli all’oro, all’argento, alle città, e se i bambini giocano a fare i magistrati e simulano la pretesta,9 i fasci e il tribunale, gli adulti fanno lo stesso, anche se sul serio, in Campo Marzio, nel Foro e nel Senato; gli uni, sulla spiaggia, costruiscono casette di sabbia, gli altri, convinti di fare chissà che cosa, tirano su pietre, muri e tetti, che poi, magari, invece di proteggerli finiscono per rovinargli addosso. Gli adulti, dunque, si comportano come i bambini, con la differenza che i loro errori sono diversi e più gravi. Per questo il saggio prende come scherzi le loro offese, e se a volte li ammonisce, li rimprovera, o magari li punisce, lo fa con l’atteggiamento che hanno gli adulti verso i bambini e non perché abbia raccolto l’ingiuria ma perché loro l’hanno
fatta e devono smettere di farne.10 È così che domiamo anche le bestie, le bastoniamo, se non si lasciano cavalcare, ma senza adirarci con loro: le percuotiamo affinché il dolore delle bastonate vinca il loro rifiuto. Eccoti dunque servito anche per l’obiezione che ci viene mossa, cioè per quale motivo, se non riceve né ingiurie né contumelie, il saggio punisce quelli che le fanno. Li punisce, ripeto, non per vendicarsi contro di loro, ma per correggerli. 13. D’altra parte perché non dovresti credere che al saggio si convenga questa fermezza d’animo, quando tu stesso la riscontri in altri, anche se dettata da un motivo diverso? Nessun medico si arrabbia con un pazzo, né si offende se un ammalato febbricitante lo insulta perché gli ha proibito l’acqua fredda. Ebbene, il saggio mostra verso tutti lo stesso atteggiamento che il medico ha nei confronti dei suoi pazienti, dei quali non disdegna di toccare le parti intime, se hanno bisogno di cure, di esaminare gli escrementi o altri rifiuti, né di subire gl’insulti quando li prende il delirio. Il saggio sa che tutti quelli che offendono, siano essi togati o porporati, benché all’aspetto sembrino sani, in realtà sono simili a dei malati che non sanno controllarsi, per cui, come il medico non se la prende se uno, sotto l’effetto della malattia, osa dirgli qualche frase sgradevole, così egli rimane indifferente di fronte alle loro villanie, allo stesso modo in cui non tiene in alcun conto gli elogi che essi gli fanno. Analogamente non si compiace se un mendicante lo riverisce, né si ritiene offeso se un plebeo non gli restituisce il saluto, e neppure monta in superbia se molti ricchi lo guardano con ammirazione, in quanto sa che costoro non differiscono affatto dai mendicanti, anzi sono più miserabili, perché a chi vive di elemosina basta poco, loro, invece, hanno bisogno di molto. Così pure non si offende se il re dei Medi, per dire, oppure Attalo d’Asia,11 non risponde al suo saluto e tira dritto in silenzio e con fare arrogante: egli sa che la loro condizione non è più invidiabile di quella di chi in una grande famiglia ha il compito di sorvegliare gl’infermi e i malati di mente. Credi che io me l’abbia a male se non ricambiano il mio saluto i trafficanti che bazzicano nel tempio di Castore o i commercianti che comprano e vendono schiavi di poco conto, le cui botteghe sono zeppe di servi della peggiore specie? Direi proprio di no. Cosa può avere infatti di buono uno che sotto di sé ha solo dei cattivi? Perciò il saggio, come si mostra indifferente di fronte alla cortesia o alla scortesia di simili persone, così fa anche con un re, al quale dice: «Hai sotto di te i Parti, i Medi e i Battriani,12 ma li domini con la paura e perciò non ti è consentito di allentare l’arco; e quelli sono pessimi, venali, sempre in cerca di un nuovo padrone». Il saggio, in conclusione, non si lascerà mai turbare dalle offese di chicchessia, giacché, sebbene diversi fra loro, gli uomini per lui sono tutti uguali, in quanto tutti parimenti stolti. Se infatti dovesse cedere anche una sola volta e turbarsi di fronte a un’ingiuria o a una contumelia, non potrebbe mai essere sicuro di sé, e la sicurezza, invece, è un bene proprio del saggio. E non commetterà mai l’errore di riconoscere apertamente di aver ricevuto un’offesa, per non dare importanza a colui che gliel’ha fatta: chi si duole di essere
disprezzato dimostra infatti che sarebbe lieto di essere apprezzato, e ciò non è del saggio. 14. C’è poi chi arriva a tal punto di stupidità da ritenersi offeso se una donna gli rivolge delle parole sgradevoli. Ebbene, può essere pure di alto rango, avere un gran numero di lettighieri, portare appesa agli orecchi tutta la sua oreficeria e stare seduta sopra un trono, la donna è un essere irriflessivo e, a meno che non abbia un’istruzione e una buona dose di cultura, selvatico e incapace di controllare le proprie passioni. Che offesa dunque può recare? Altri ancora si risentono se per caso vengono urtati dal barbiere e considerano contumelie il modo di fare poco urbano di un portinaio, la boria di un maestro di casa o di un semplice cameriere. Oh quanto invece ride di queste sciocchezze, quanto gioisce nell’animo colui che nel trambusto degli errori umani si mantiene sereno! «Ma allora», mi dirai, «il saggio non si accosterà mai a una porta sorvegliata da un custode sgarbato?». Se ha un serio motivo per farlo, sì, e cercherà di ammansire quell’uomo, chiunque egli sia, come si fa con un cane rabbioso gettandogli del cibo, né disdegnerà di dargli qualche moneta per poter varcare la soglia, considerando che anche per attraversare certi ponti bisogna pagare il pedaggio. Così darà pure la mancia a quel maestro di casa che si fa pagare una tassa per le visite al suo padrone: il saggio non si vergogna di comprare ciò che è in vendita. È un pusillanime chi si compiace di aver risposto per le rime a un custode scortese, di avergli spezzato la bacchetta e di essere andato egualmente dal suo padrone, chiedendogli di frustarlo. Chi litiga si mette sullo stesso piano dell’avversario, e vi resta anche se vince. «E se si piglia un ceffone, il saggio che cosa fa?». Quello che fece Catone quando fu schiaffeggiato: non andò in escandescenze, non si vendicò dell’ingiuria, e nemmeno la perdonò; negò semplicemente che gli fosse stata fatta. Ignorandola mostrò maggiore magnanimità che se l’avesse perdonata. Non c’è bisogno che ci soffermiamo a lungo su questo argomento: è noto, infatti, che il saggio la pensa in modo completamente diverso da quello degli altri su quel che è bene e su quel che è male. Non s’interessa di ciò che gli uomini considerano turpe o meschino, ma, come le stelle ruotano in senso contrario al moto del cielo, così egli procede nella direzione opposta a quella degli altri. 15. Smettetela dunque di chiedere: «Ma allora il saggio non riceverà ingiuria se verrà bastonato o se, mettiamo, gli si caverà un occhio? E se nel Foro sarà bersagliato dalle grida insolenti di persone spudorate, se al banchetto di un re sarà confinato all’ultimo posto e costretto a mangiare fra gli schiavi adibiti ai servizi più umili, o se dovrà subire qualunque altro di quegli atti molesti che si possono inventare contro un’anima candida e virtuosa, non riterrà che gli sia stata fatta una contumelia?». Simili affronti, per quanto possano essere gravi e numerosi, sono tutti della stessa natura: essi non toccano il saggio, siano leggeri o pesanti, siano pochi o parecchi. Voi vi costruite un’idea della magnanimità
sulla base della vostra debolezza e una volta che avete giudicato fin dove può arrivare la vostra capacità di sopportazione attribuite a quella del saggio un limite di poco più alto. Ma egli è stato posto dalla sua virtù in ben altri confini del mondo e non ha più niente in comune con voi. Mettetelo pure di fronte alle situazioni più difficili e intollerabili, quelle che non si vogliono nemmeno vedere o sentir nominare, egli non si lascerà abbattere da loro, che lo assalgano tutte insieme o singolarmente. Sbaglia chi pensa che il saggio alcune cose le sopporti e altre no, che la sua magnanimità giunga sino a determinati limiti: non si vince la sorte se non si riesce a vincerla in tutto. E non dirmi che questo è rigore stoico, perché Epicuro, che voi avete assunto ingiustamente a patrono della vostra inerzia, convinti che v’insegni le mollezze, la pigrizia e tutto ciò che conduce al piacere, ha detto: «Raramente la sorte s’intromette nella vita del saggio». Che grande massima è questa, quasi da vero uomo! Basta spingersi un po’ più avanti e cancellarla del tutto, la sorte. Guarda la casa del saggio, piccola, senza ricercatezze, senza rumori, senza pompa, non custodita da portinai che regolano l’entrata della gente con venale arroganza, e tuttavia da quella soglia aperta e priva di custodi la sorte non passa: sa che per lei non c’è posto dove non c’è nulla di suo. 16. Ora, se anche Epicuro, che pur fa molte concessioni al corpo, assume di fronte all’ingiuria un atteggiamento di superiorità, cosa può esserci per noi stoici di incredibile o che sembri andare al di là della natura umana? Egli afferma che le ingiurie sono tollerabili per il saggio, noi che non esistono affatto, per lui. E non dirmi che ciò è contrario alla natura: noi infatti non neghiamo che sia spiacevole essere bastonati, malmenati e persino privati di qualche parte del corpo, diciamo solo che queste non sono ingiurie; non sosteniamo che non fanno male, semplicemente non le chiamiamo ingiurie, perché l’ingiuria non è compatibile con la virtù. Vediamo quale delle due dottrine è più vicina al vero, premesso che stoici ed epicurei sono entrambi concordi nel detestare l’ingiuria. Se vuoi saperlo, fra loro c’è la stessa differenza che passa fra due gladiatori molto forti, l’uno dei quali si comprime la ferita restando fermo al suo posto, l’altro, rivolto alla folla urlante, fa segno che la sua è cosa da nulla e non accetta che s’intervenga. Non credere che fra noi il dissenso sia grande: entrambe le scuole concordano su questo punto, l’unico che ci riguardi, che cioè non si devono tenere in alcun conto le ingiurie, comprese quelle che si potrebbero chiamare ombre o sospetti di ingiurie, vale a dire le contumelie, per respingere le quali non c’è bisogno di essere saggi, basta avere un po’ di buon senso e dire a sé stessi: «Questi affronti che mi vengono fatti li merito o non li merito? Se li merito non sono un’offesa, sono un atto di giustizia, se non li merito non sono io che devo vergognarmi ma chi ha commesso questa ingiustizia». Ma poi, in definitiva, che cos’è la contumelia? Quando uno scherza sul mio cranio pelato, sulla mia vista corta, sulle mie gambe magre come due stecchini o sulla mia bassa statura, dove sta l’offesa? È una contumelia rimarcare a uno un suo difetto
evidente? Se uno ce lo dice a tu per tu ci ridiamo sopra, se di fronte a molti ci arrabbiamo, e neghiamo agli altri la libertà di ripeterci quelle cose che noi stessi siamo soliti dire sul nostro conto. Gli scherzi, se sono moderati ci divertono, se passano la misura ci fanno andare in bestia. 17. Crisippo narra di un tale che montò su tutte le furie perché uno lo aveva chiamato «montone marino». In Senato abbiamo visto piangere Fido Cornelio, genero di Ovidio Nasone,13 quando Corbulone lo chiamò «struzzo spennacchiato». Lui, ch’era rimasto imperterrito di fronte a ben altri insulti, che ferivano i suoi costumi e la sua vita stessa, scoppiò in lacrime per una cosa tanto assurda. Com’è debole l’animo umano quando viene a mancare la ragione! Ci offendiamo persino se uno imita il nostro modo di parlare o di camminare, se rifà un nostro difetto fisico o di pronuncia. Come se questi difetti fossero più evidenti quando vengono imitati da altri che non quando li mostriamo noi stessi. C’è poi chi non vuole sentir parlare di vecchiaia, di capelli bianchi o di altre cose proprie di quell’età a cui tutti si augurano di arrivare. Ad alcuni scotta sentirsi rinfacciare la propria povertà, quando è evidente che se uno cerca di nasconderla vuol dire che se ne fa un rimprovero. L’unico modo per togliere agl’insolenti e agli spiritosi la possibilità di offenderci è di prenderli in contropiede, canzonandoci da noi: chi ride per primo di sé stesso non viene preso in giro da nessuno. Vatinio, che sembrava nato per essere deriso e detestato, era – a quanto si racconta – un motteggiatore spiritoso e mordace: ne diceva tante anche su sé stesso, sui suoi piedi e sulle cicatrici che aveva alla gola, che con questo sistema riusciva a evitare le stilettate dei suoi nemici, che erano ancora più numerosi dei suoi difetti, e specialmente quelle di Cicerone. Se con la sua sfrontatezza quest’uomo – che a furia d’insultare aveva smesso di arrossire – è potuto giungere a tanto, perché non può arrivarvi chi con gli studi liberali e la pratica della saggezza ha già ottenuto qualche risultato? Aggiungi poi che non dare soddisfazione a chi ti ha insultato, riconoscendo l’offesa fatta, è già un modo di vendicarsi. In questo caso chi offende è solito dire: «Che sfortuna! Credo che non abbia capito». Ciò perché lo scopo della contumelia è proprio quello di attirare l’attenzione e suscitare lo sdegno di chi la riceve. Comunque sta’ tranquillo, un giorno o l’altro qualcuno gli renderà la pariglia, ai tuoi denigratori, vendicando anche te. 18. Caligola – che possedeva vizi in abbondanza – era pure insolente: provava un piacere matto nell’insultare la gente, proprio lui che col suo aspetto fisico offriva non poche occasioni di riso. Era infatti di un pallore così turpe che bastava solo quello a dimostrare ch’era pazzo, aveva occhi torvi nascosti sotto una fronte da vecchia, una testa deforme, pelata, con dei capelli sparsi qua e là che sembrava glieli avessero dati in elemosina. Aggiungi una nuca folta di peli, gambe magrissime e dei piedoni enormi. Ebbene, se io volessi riferire a una a una tutte le contumelie da lui rivolte ai genitori, ai nonni e a ogni categoria di
cittadini, non la finirei mai: ricorderò soltanto quelle che lo portarono alla morte. Tra i suoi amici più importanti c’era Valerio Asiatico, uomo violento e intollerante delle offese altrui. Caligola, durante un banchetto, che è come dire in una pubblica assemblea, parlando ad alta voce, sì che tutti potessero udirlo, gli rinfacciò il modo in cui sua moglie faceva l’amore. Per gli dèi, cosa doveva sentire un marito! L’imperatore che arriva a tal punto di sfacciataggine da raccontare, non dico a un ex console o a un amico, qual era per Caligola Valerio Asiatico, ma a un marito il suo rapporto amoroso con la moglie di lui, nonché il disgusto che ne ha provato! Cherea,14 invece, tribuno militare, parlava in un modo che non rispecchiava il suo valore: aveva infatti, nella voce, un’inflessione languida, che per chi non conoscesse le sue imprese guerresche poteva anche insospettire. Ebbene, quando andava a chiedere la parola d’ordine, Caligola gli dava a volte «Venere», a volte «Priapo», intendendo così rinfacciare a quell’uomo d’armi la sua effeminatezza, proprio lui che indossava vesti trasparenti, calzava i sandali e si copriva di monili d’oro. Per questo Cherea lo ammazzò, per non dover più chiedere parole d’ordine. Egli fu il primo fra i congiurati a levare il braccio contro Caligola, fu lui che gli staccò la testa, di netto. Dopo gli furono inferti da ogni parte numerosi colpi di spada, a vendetta d’ingiurie pubbliche e private, ma il primo a comportarsi da uomo in quell’occasione fu Cherea, lui che uomo non sembrava. Caligola vedeva insulti a ogni angolo, contro di sé, ed è naturale che i primi a voler offendere siano proprio quelli che non riescono a sopportare le offese. S’infuriò, per esempio, con Erennio Macro perché lo aveva salutato col nome di Gaio, e non la passò liscia neppure un centurione che lo aveva chiamato Caligola, quando questo appellativo era il più caro ai soldati, che solitamente lo chiamavano così inquantoché era nato in un accampamento ed era cresciuto fra i legionari. Ma lui, che ormai indossava i coturni, e non più le caligae, giudicava ingiurioso e offensivo quel nome. Perciò, anche se la nostra indulgenza ci farà rinunciare alla vendetta, potrà esserci di conforto pensare che alla fine ci sarà qualcuno che, in un modo o nell’altro, punirà la sfacciataggine, l’arroganza e l’insolenza di chi ci offende, vizi che non si consumano mai contro un solo uomo, né con una sola contumelia. 19. Guardiamo ora gli esempi di coloro di cui ammiriamo la pazienza, come Socrate, che accettò di buon animo e ridendovi sopra gli scherzi salaci a lui rivolti nelle commedie, rappresentate dinanzi a tutto il pubblico, mostrandosi non meno tollerante di quando la moglie Santippe gli rovesciò addosso un secchio d’acqua sporca. Antistene, a cui veniva sempre rinfacciato di avere una madre straniera, nativa della Tracia, rispondeva che lo era anche Cibele, la Madre degli dèi, perché del monte Ida.15 Mai litigare, dunque, o venire alle mani. Bisogna stare alla larga o far finta di niente, quali che siano le offese rivolteci dagli sprovveduti, che sono i soli a comportarsi così; tenere nello stesso conto sia le ingiurie che le lodi provenienti dal volgo, senza dolersi delle une e
rallegrarsi delle altre. Diversamente, per timore degli insulti o perché punti da essi, finiremo col non prendere più nessuna iniziativa, anche se necessaria, trascureremo i nostri doveri, pubblici e privati, a volte anche certe decisioni che potrebbero essere per noi d’importanza vitale, e ciò, ripeto, per la paura, tipicamente femminile, di poterci sentir dire qualcosa che ci disturbi. Talvolta, magari, se ci capita di prendercela con i potenti, manifestiamo pure il nostro risentimento senza peli sulla lingua, ma teniamo presente che la libertà non consiste nel non soffrire niente – sbagliamo se la pensiamo così – bensì nel metterci al di sopra delle offese e nel sentirci tali da godere solo di ciò che ci deriva da noi stessi, nel dare un taglio netto a tutte le cose che ci sono estranee, per non essere costretti a passare la vita nel timore che tutti ci deridano e ci sparlino addosso. C’è infatti qualcuno che possa non offenderci, quando tutti ne hanno la possibilità? Il rimedio del saggio, tuttavia, è diverso da quello di chi aspira alla saggezza. Quelli che sono sulla strada, che non hanno ancora raggiunto la perfezione e si regolano sul giudizio della gente, devono avere ben chiaro che gli toccherà vivere fra le ingiurie e le contumelie e che se sapranno prevederle, se avranno l’animo già disposto a riceverle, le sentiranno più leggere. E tanto più dovranno mostrarsi forti quanto più sono in vista per nascita, per buona reputazione e ricchezza: si ricordino che le truppe scelte stanno in prima fila. Le contumelie, le parole oltraggiose, le infamie e tutti gli altri simili affronti li sopportino come si sopportano le urla dei nemici, i dardi scagliati da troppo lontano, e perciò meno pericolosi, come i sassi che crepitano sull’elmo senza recare alcuna ferita. Le ingiurie, invece, le sopportino come i colpi che si abbattono sulle armi o sulla corazza, ma che non riescono a buttare a terra o a far recedere di un passo. Anche se si è incalzati e spinti da una forza avversa, è vergognoso battere in ritirata: bisogna difenderlo il posto che la natura ci ha assegnato. «Quale posto?», mi chiederai. Quello che è proprio dell’uomo. Quanto al saggio, come dicevo, il rimedio è diverso, opposto a quello che consiglio a voi, che vi trovate sulla strada della saggezza: voi, infatti, siete ancora in guerra, lui ha già ottenuto la vittoria. Non opponetevi al vostro bene e, mentre procedete lungo il cammino che conduce al vero, alimentate nei vostri animi questa speranza, accogliete di buon grado i retti insegnamenti e coltivateli con convinzione e con fede: che vi siano degli uomini invitti, che non si lasciano mai piegare dalla sorte, è cosa utile al vivere civile dell’intera umanità.
1. È Marco Porcio Catone, detto l’Uticense (95-46 a.C.), morto suicida per non sottostare alla dittatura di Cesare. Esaltato da tutti come uno dei più grandi esempi di libertà, oltre che di integrità morale, è citato da Seneca anche nel De providentia (II 9-12) e in altre opere. Vatinio, uomo dappoco e corrotto, rivestì le più alte cariche pubbliche (fu questore, tribuno della plebe, pretore e console). Cicerone scrisse contro di lui una celebre orazione, in cui, fra l’altro, lo definisce nimium vehemens feroxque natura… tamquam serpens e latibulis, oculis eminentibus, inflato collo, tumidis cervicibus (In Vat. , 2), e Catullo, a
dimostrare la bassezza dei tempi, dice (52, 3-4): per consulatum perierat Vatinius , e conclude: Quid est, Catulle, quid moraris emori? («Che aspetti dunque a morire, o Catullo?»). Degli episodi riguardanti gl’insulti mossi a Catone dalla folla non si trova notizia presso altri scrittori. 2. Publio Clodio Pulcro, un altro uomo corrotto e arruffapopolo: eletto tribuno, condannò Cicerone all’esilio. Fu ucciso nel 52 a.C. da Milone (che sarà difeso da Cicerone). 3. I tre uomini a cui Seneca si riferisce, «che nemmeno il possesso del mondo intero poteva saziare», sono Cesare, Pompeo e Crasso, che, costituito il primo triumvirato, nel 60 a.C., si spartirono i territori della repubblica. 4. Seneca non avrebbe potuto trovare un paragone più calzante («come certe pietre, come l’acciaio», ecc.) per mettere in risalto la fermezza e la resistenza del saggio di fronte alle offese, di qualunque natura esse siano. 5. Lo stolto re a cui qui si allude è Serse I, re dei Persiani (519-465 a.C.), che, dopo avere conquistato l’Egitto e assalito la Grecia varcando l’Ellesponto su un ponte di barche, fu sconfitto prima a Salamina (480) e poi a Platea (479). 6. Demetrio, re della Macedonia, soprannominato Poliorcete (che in greco significa «conquistatore di città») espugnò Megara nel 307 a.C. Stilpone di Megara fu il fondatore di una scuola filosofica (detta scuola megarica) precorritrice di quella stoica per quanto riguarda l’impassibilità. 7. Questo di Stilpone, l’unico uomo sereno e in pace in mezzo al fragore e alle devastazioni della guerra, è uno dei passi lirici non infrequenti in Seneca. 8. Alessandro Magno occupò Babilonia nel 331 a.C. Cartagine (Africa) e Numanzia (Spagna) furono espugnate e distrutte l’una nel 146, l’altra nel 133 a.C., da P. Cornelio Scipione l’Africano Minore. Quanto al Campidoglio, Seneca allude all’assalto portato alla rocca dai Galli nel 387 a.C. 9. La pretesta listata di porpora era la toga che indossavano i magistrati e i sacerdoti, i fasci simboleggiavano l’autorità dello Stato. Nel Campo Marzio, posto sulla riva del Tevere, i Romani si esercitavano alle armi. 10. Per Seneca la punizione doveva avere sempre una funzione educativa. 11. Attalo, re di Pergamo, era famoso per le sue strabilianti ricchezze. Lo ricorda, fra gli altri, Orazio, laddove dice che l’agricoltore nemmeno attalicis condicionibus (cioè neppure se gli si offrissero tutte le ricchezze di Attalo) oserebbe sfidare i pericoli del mare (Odi, I 1, 11-14). Qui Attalo è ricordato per la sua arroganza, anch’essa proverbiale. 12. I Parti, i Medi e i Battriani erano dei popoli fieri che abitavano ai confini orientali dell’Impero. 13. Ovidio Nasone (43 a.C.-17 d.C.) è il famoso poeta, autore, fra altre opere, delle Metamorfosi. 14. Cherea era comandante dei pretoriani e capeggiò la congiura contro Caligola, colpendolo per primo. Fu condannato a morte dall’imperatore Claudio. 15. Antistene fu un filosofo ateniese (IV-III a.C.). Discepolo di Socrate, fondò la scuola cinica. Il monte Ida, in Asia Minore, era sede del culto di Cibele, la Gran Madre degli dèi.
De vita beata
1. Vivere, Gallio frater, omnes beate volunt, sed ad pervidendum quid sit quod beatam vitam efficiat caligant; adeoque non est facile consequi beatam vitam, ut eo quisque ab ea longius recedat quo ad illam concitatius fertur, si via lapsus est; quae ubi in contrarium ducit, ipsa velocitas maioris intervalli causa fit. Proponendum est itaque primum quid sit quod appetamus; tunc circumspiciendum qua contendere illo celerrime possimus, intellecturi in ipso itinere, si modo rectum erit, quantum cotidie profligetur quantoque propius ab eo simus ad quod nos cupiditas naturalis impellit. Quamdiu quidem passim vagamur non ducem secuti sed fremitum et clamorem dissonum in diversa vocantium, conteretur vita inter errores brevis; etiam si dies noctesque bonae menti laboremus. Decernatur itaque et quo tendamus et qua, non sine perito aliquo cui explorata sint ea in quae procedimus, quoniam quidem non eadem hic quae in ceteris peregrinationibus condicio est: in illis com prensus aliquis limes et interrogati incolae non patiuntur errare, at hic tritissima quaeque via et celeberrima maxime decipit. Nihil ergo magis praestandum est quam ne pecorum ritu sequamur antecedentium gregem, pergentes non quo eundum est sed quo itur. Atqui nulla res nos maioribus malis implicat quam quod ad rumorem componimur, optima rati ea quae magno assensu recepta sunt, quodque exempla nobis multa sunt nec ad rationem sed ad similitudinem vivimus. Inde ista tanta coacervatio aliorum super alios ruentium. Quod in strage hominum magna evenit cum ipse se populus premit (nemo ita cadit ut non et alium in se attrahat, primique exitio sequentibus sunt), hoc in omni vita accidere videas licet: nemo sibi tantummodo errat, sed alieni erroris et causa et auctor est; nocet enim applicari antecedentibus et, dum unusquisque mavult credere quam iudicare, numquam de vita iudicatur, semper creditur, versatque nos et praecipitat traditus per manus error. Alienis perimus exemplis; sanabimur, separemur modo a coetu. Nunc vero stat contra rationem defensor mali sui populus. Itaque id evenit quod in comitiis, in quibus eos factos esse praetores idem qui fecere mirantur cum se mobilis favor circumegit: eadem probamus, eadem reprehendimus; hic exitus est omnis iudicii, in quo secundum plures datur. 2. Cum de beata vita agetur, non est quod mihi illud discessionum more respondeas: «Haec pars maior esse videtur»; ideo enim peior est. Non tam bene cum rebus humanis agitur ut meliora pluribus placeant: argumentum pessimi turba est. Quaeramus ergo quid optimum factu sit non quid usitatissimum, et quid nos in possessione felicitatis aeternae constituat non quid vulgo veritatis pessimo interpreti probatum sit. Vulgum autem tam chlamydatos quam coronatos voco; non enim colorem vestium quibus praetexta sunt corpora aspicio; oculis de homine non credo, habeo melius et certius lumen quo a falsis vera diiudicem;
animi bonum animus inveniat. Hic, si umquam respirare illi et recedere in se vacaverit, o quam sibi ipse verum tortus a se fatebitur ac dicet: «Quicquid feci adhuc infectum esse mallem, quicquid dixi cum recogito, mutis invideo, quicquid optavi inimicorum exsecrationem puto, quicquid timui, di boni! quanto levius fuit quam quod concupii! Cum multis inimicitias gessi et in gratiam ex odio (si modo ulla intra malos gratia est) redii: mihi ipsi nondum amicus sum. Omnem operam dedi ut me multitudini educerem et aliqua dote notabilem facerem: quid aliud quam telis me opposui et malevolentiae quod morderet ostendi? Vides istos qui eloquentiam laudant, qui opes sequuntur, qui gratiae adulantur, qui potentiam extollunt? Omnes aut sunt hostes aut, quod in aequo est, esse possunt: quam magnus mirantium tam magnus invidentium populus est. Quin potius quaero aliquod usu bonum quod sentiam, non quod ostendam? Ista quae spectantur, ad quae consistitur, quae alter alteri stupens monstrat, foris nitent, introrsus misera sunt». 3. Quaeramus aliquod non in speciem bonum sed solidum et aequale et a secretiore parte formosius; hoc eruamus. Nec longe positum est: invenietur, scire tantum opus est quo manum porrigas; nunc velut in tenebris vicina transimus, offensantes ea ipsa quae desideramus. Sed ne te per circumitus traham, aliorum quidem opiniones praeteribo (nam et enumerare illas longum est et coarguere): nostram accipe. Nostram autem cum dico, non alligo me a unum aliquem ex Stoicis proceribus: est et mihi censendi ius. Itaque aliquem sequar, aliquem iubebo sententiam dividere, fortasse et post omnes citatus nihil improbabo ex iis quae priores decreverint et dicam: «Hoc amplius censeo». Interim, quod inter omnis Stoicos convenit, rerum naturae assentior; ab illa non deerrare et ad illius legem exemplumque formari sapientia est. Beata est ergo vita conveniens naturae suae, quae non aliter contingere potest quam si primum sana mens est et in perpetua possessione sanitatis suae, deinde fortis ac vehemens, tunc pulcherrime patiens, apta temporibus, corporis sui pertinentiumque ad id curiosa non anxie, tum aliarum rerum quae vitam instruunt diligens sine admiratione cuiusquam, usura fortunae muneribus, non servitura. Intellegis, etiam si non adiciam, sequi perpetuam tranquillitatem, libertatem, depulsis iis quae aut irritant nos aut territant; nam voluptatibus et illiciis, quae parva ac fragilia sunt et ipsis fragantiis noxia, ingens gaudium subit inconsussum et aequale, tum pax et concordia animi et magnitudo cum mansuetudine; omnis enim ex infirmitate feritas est. 4. Potest aliter quoque definiri bonum nostrum, id est eadem sententia non eisdem comprendi verbis. Quemadmodum idem exercitus modo latius panditur modo in angustum coartatur et aut in cornua sinuata media parte curvatur aut recta fronte explicatur, vis illi, utcumque ordinatus est, eadem est et voluntas pro eisdem partibus standi: ita finitio summi boni alias diffundi potest et exporrigi alias colligi et in se cogi. Idem itaque erit si dixero: «Summum bonum est animus fortuita despiciens virtute laetus» aut «Invicta vis animi, perita rerum, placida in
actu cum humanitate multa et conversantium cura». Licet et ita finire ut beatum dicamus hominem eum cui nullum bonum malumque sit nisi bonus malusque animus, honesti cultorem, virtute contentum, quem nec extollant fortuita nec frangant, qui nullum maius bonum eo quod sibi ipse dare potest noverit, cui vera voluptas erit voluptatum contemptio. Licet, si evagari velis, idem in aliam atque aliam faciem salva et integra potestate transferre; quid enim prohibet nos beatam vitam dicere liberum animum et erectum et interritum ac stabilem, extra metum extra cupiditatem positum, cui unum bonum sit honestas unum malum turpitudo, cetera vilis turba rerum nec detrahens quicquam beatae vitae nec adiciens, sine auctu ac detrimento summi boni veniens ac recedens? Hoc ita fundatum necesse est, velit nolit, sequatur hilaritas continua et laetitia alta atque ex alto veniens, ut quae suis gaudeat nec maiora domesticis cupiat. Quidni ista bene penset cum minutis et frivolis et non perseverantibus corpusculi motibus? Quo die infra voluptatem fuerit, et infra dolorem erit; vides autem quam malam et noxiosam servitutem serviturus sit, quem voluptates doloresque, incertissima dominia impotentissimaque, alternis possidebunt: ergo exeundum ad libertatem est. Hanc non alia res tribuit quam fortunae negle gentia: tum illud orietur inaestimabile bonum, quies mentis in tuto collocatae et sublimitas expulsisque terroribus ex cognitione veri gaudium grande et immotum comitasque et diffusio animi, quibus delectabitur non ut bonis sed ut ex bono suo ortis. 5. Quoniam liberaliter agere coepi, potest beatus dici qui nec cupit nec timet beneficio rationis, quoniam et saxa timore et tristitia carent nec minus pecudes; non ideo tamen quisquam felicia dixerit quibus non est felicitatis intellectus. Eodem loco pone homines quos in numerum pecorum et inanimalium redegit hebes natura et ignoratio sui. Nihil interest inter hos et illa, quoniam illis nulla ratio est, his prava et malo suo atque in perversum sollers; beatus enim dici nemo potest extra veritatem proiectus. Beata ergo vita est in recto certoque iudicio stabilita et immutabilis. Tunc enim pura mens est et soluta omnibus malis, quae non tantum lacerationes sed etiam vellicationes effugerit, statura semper ubi constitit ac sedem suam etiam irata et infestante fortuna vindicatura. Nam quod ad voluptatem pertinet, licet circumfundatur undique et per omnes vias influat animumque blandimentis suis leniat aliaque ex aliis admoveat, quibus totos partesque nostri sollicitet: quis mortalium, cui ullum superest hominis vestigium, per diem noctemque titillari velit et deserto animo corpori operam dare? 6. – Sed animus quoque, inquit, voluptates habebit suas. – Habeat sane sedeatque luxuriae et voluptatum arbiter; impleat se eis omnibus quae oblectare sensus solent, deinde praeterita respiciat et exoletarum voluptatum memor exultet prioribus futurisque iam immineat ac spes suas ordinet et, dum corpus in praesenti sagina iacet, cogitationes ad futuram praemittat: hoc mihi videbitur miserior, quoniam mala pro bonis legere dementia est. Nec sine sanitate quisquam beatus est nec sanus, cui obfutura pro optimis appetuntur. Beatus ergo
est iudicii rectus; beatus est praesentibus qualiacumque sunt contentus amicusque rebus suis; beatus est is cui omnem habitum rerum suarum ratio commendat. 7. Vident et in illis qui summum bonum dixerunt, quam turpi illud loco posuerint. Itaque negant posse voluptatem a virtute diduci et aiunt nec honeste quemquam vivere ut non iucunde vivat nec iucunde ut non honeste quoque. Non video quomodo ista tam diversa in eandem copulam coinciantur. Quid est, oro vos, cur separari voluptas a virtute non possit? Videlicet quia omne bonis ex virtute principium est, ex huius radicibus etiam ea quae vos et amatis et expetitis oriuntur? Sed si ista indiscreta essent, non videremus quaedam iucunda sed inhonesta, quaedam vero honestissima sed aspera, per dolores exigenda. Adice nunc quod voluptas etiam ad vitam turpissimam venit at virtus malam vitam non admittit, et infelices quidam non sine voluptate immo ob ipsam voluptatem sunt, quod non eveniret si virtuti se voluptas immiscuisset, qua virtus saepe caret numquam indiget. Quid dissimilia immo diversa componitis? Altum quiddam est virtus, excelsum et regale, invictum infatigabile: voluptas humile servile, imbecillum caducum, cuius statio ac domicilium fornices et popinae sunt. Virtutem in templo convenies, in foro, in curia, pro muris stantem, pulverulentam, coloratam, callosas habentem manus, voluptatem latitantem seapius ac tenebras captantem circa balinea ac sudatoria ac loca aedilem metuentia, mollem, enervem, mero atque unguento madentem, pallidam aut fucatam et medicamentis pollinctam. Summum bonum immortale est, nescit exire nec satietatem habet nec paenitentiam: numquam enim recta mens vertitur nec sibi odio est nec quicquam mutavit a vita optima; at voluptas tunc cum maxime delectat exstinguitur; non multum loci habet, itaque cito implet et taedio est et post primum impetum marcet. Nec id umquam certum est cuius in motu natura est: ita ne potest quidem ulla eius esse substantia quod venit transitque celerrime, in ipso usu sui periturum; eo enim pervenit ubi desinat et dum incipit spectat ad finem. 8. Quid quod tam bonis quam malis voluptas inest nec minus turpes dedecus suum quam honestos egregia delectant? Ideoque praeceperunt veteres optimam sequi vitam, non iucundissimam, ut rectae ac bonae voluntatis non dux sed comes sit voluptas. Natura enim duce utendum est: hanc ratio observat, hanc consulit. Idem est ergo beate vivere et secundum naturam. Hoc quid sit iam aperiam: si corporis dotes et apta naturae conservabimus diligenter et impavide tamquam in diem data et fugacia, si non subierimus eorum servitutem nec nos aliena possederint, si corpori grata et adventicia eo nobis loco fuerint quo sunt in castris auxilia et armaturae leves (serviant ista, non imperent), ita demum utilia sunt menti. Incorruptus vir sit externis et insuperabilis miratorque tantum sui, fidens animo atque in utrumque paratus, artifex vitae; fiducia eius non sine scientia sit, scientia non sine constantia: maneant illi semel placita nec ulla in decretis eius litura sit. Intellegitur, etiam si non adiecero, compositum ordinatumque fore talem virum et in iis quae aget cum comitate magnificum.
Ratio quaerat sensibus irritata, et capiens inde principia (nec enim habet aliud unde conetur aut unde ad verum impetum capiat) in se revertatur. Nam mundus quoque cuncta complectens rectorque universi deus in exteriora quidem tendit, sed tamen introsum undique in se redit. Idem nostra mens faciat: cum secuta sensus suos per illos se ad externa porrexerit, et illorum et sui potens sit. Hoc modo una efficietur vis ac potestas concors sibi et ratio illa certa nascetur non dissidens nec haesitans in opinionibus comprensionibusque nec in persuasione, quae, cum se disposuit, et partibus suis consensit et ut ita dicam concinuit, summum bonum tetigit. Nihil enim pravi, nihil lubrici superest, nihil in quo arietet aut labet. Omnia faciet ex imperio suo nihilque inopinatum accidet, sed quicquid agetur in bonum exibit facile et parate et sine tergiversatione agentis; nam pigritia et haesitatio pugnam et inconstantiam ostendit. Quare audaciter licet profitearis summum bonum esse animi concordiam; virtutes enim ibi esse debebunt ubi consensus atque unitas erit, dissident vitia. 9. – Sed tu quoque, inquit, virtutem non ob aliud colis quam quia aliquam ex illa speras voluptatem. – Primum non si voluptatem praestatura virtus est, ideo propter hanc petitur: non enim hanc praestat sed et hanc, nec huic laborat sed labor eius quamvis aliud petat hoc quoque assequetur. Sicut in arvo quod segeti proscissum est aliqui flores internascuntur, non tamen huic herbulae quamvis delectet oculos tantum operis insumptum est (aliud fuit serenti propositum, hoc supervenit), sic et voluptas non est merces nec causa virtutis sed accessio, nec quia delectat placet, sed si placet, et delectat. Summum bonum in ipso iudicio est et habitu optimae mentis, quae cum cursum suum implevit et finibus se suis cinxit, consummatum est summum bonum nec quicquam amplius desiderat; nihil enim extra totum est, non magis quam ultra finem. Itaque erras, cum interrogas quid sit illud propter quod virtutem petam; quaeris enim aliquid supra summum. Interrogas quid petam ex virtute? Ipsam. Nihil enim habet melius, enim ipsa pretium sui. An hoc parum magnum est? Cum tibi dicam: «Summum bonum est infragilis animi rigor et providentia et sublimitas et sanitas et libertas et concordia et decor», aliquid etiam nunc exigis maius ad quod ista referantur? Quid mihi voluptatem nominas? Hominis bonum quaero, non ventris, qui pecudibus ac beluis laxior est. 10. – Dissimulas, inquit, quid a me dicatur; ego enim nego quemquam posse iucunde vivere nisi simul et honeste vivit, quod non potest mutis contingere animalibus nec bonum suum cibo metientibus. Clare, inquit, ac palam testor hanc vitam quam ego iucundam voco non nisi adiecta virtute contingere. – Atqui quis ignorat plenissimos esse voluptatibus vestris stultissimos quosque et nequitiam abundare iucundis animumque ipsum genera voluptatis prava et multa suggerere? In primis insolentiam et nimiam aestimationem sui tumoremque elatum super ceteros et amorem rerum suarum caecum et improvidum, delicias fluentis et ex minimis ac puerilibus causis exsultationem, iam dicacitatem ac superbiam
contumeliis gaudentem, desidiam dissolutionemque segnis animi indormientis sibi. Haec omnia virtus discutit et aurem pervellit et voluptates aestimat antequam admittat; nec si quas probavit magni pendit: caute utique enim admittit nec usu earum sed temperantia laeta est. Temperantia autem cum minuat, summi boni iniuria est. Tu voluptatem complecteris, ego compesco; tu voluptate frueris, ego utor; tu illam summum bonum putas, ego nec bonum; tu omnia voluptatis causa facis, ego nihil. 11. Cum dico me nihil voluptatis causa, de illo loquor sapiente, cui soli concedis voluptatem. Non voco autem sapientem, supra quem quicquam est, nedum voluptas: atqui ab hac occupatus quomodo resistet labori et periculo, egestati et tot humanam vitam circumstrepentibus minis? Quomodo conspectum mortis, quomodo dolores feret, quomodo mundi fragores et tantutm acerrimorum hostium, a tam molli adversario victus? – Quicquid voluptas suaserit faciet. – Age, non vides quam multa suasura sit? – Nihil, inquit, poterit turpiter suadere, quia adiuncta virtuti est. – Non vides iterum quale sit summum bonum cui custode opus est ut bonum sit? Virtus autem quomodo voluptatem reget quam sequitur, cum sequi parentis sit, regere imperatis? A tergo ponis quod imperat. Egregium autem habet virtus apud vos officium voluptates praegustare! Sed videbimus an apud quos tam contumeliose tractata virtus est adhuc virtus sit, quae habere nomen suum non potest, si loco cessit; interim, de quo agitur, multos ostendam voluptatibus obsessos, in quos fortuna omnia munera sua effudit, quos fatearis necesse est malos. Aspice Nomentanum et Apicium, terrarum ac maris, ut isti vocant, bona concoquentis et super mensam recognoscentis omnium gentium animalia, vide hos eosdem in suggestu rosae despectantis popinam suam, aures vocum sono, spectaculis oculos, saporibus palatum suum delectantes; mollibus lenibusque fomentis totum lacessitur eorum corpus et, ne nares interim cessent, odoribus variis inficitur locus ipse in quo luxuriae parentatur. Hosce esse in voluptatibus dices, nec tamen illis bene erit, quia non bono gaudent. 12. – Male, inquit, illis erit, quia multa interveniunt quae perturbent animum, et opiniones inter se contrariae mentem inquietabunt. – Quod ita esse concedo; sed nihilo minus illi ipsi stulti et inaequales et sub ictu paenitentiae positi magnas percipient voluptates, ut fatendum sit tam longe tum illos ab omni molestia abesse quam a bona mente et, quod plerisque contingit, hilarem insaniam insanire ac per risum furere. At contra sapientium remissae voluptates et modestae ac paene languidae sunt compressaeque et vix notabiles, ut quae neque accersitae veniant nec quamvis per se accesserint in honore sint neque ullo gaudio percipientium exceptae; miscent enim illas et interponunt vitae ut ludum iocumque inter seria. 13. Desinant ergo inconvenientia iungere et virtuti voluptatem implicare, per quod vitium pessimis quibusque adulantur. Ille effusus in voluptates, ructabundus semper atque ebrius, quia scit se cum voluptate vivere, credit et cum virtute;
audit enim voluptatem separari a virtute non posse, deinde vitiis suis sapientiam inscribit et abscondenda profitetur. Itaque non ab Epicuro impulsi luxuriantur, sed vitiis dediti luxuriam suam in philosophiae sinu abscondunt et eo concurrunt ubi audiant laudari voluptatem. Nec aestimant, voluptas illa Epicuri (ita enim me hercules sentio) quam sobria ac sicca sit, sed ad nomen ipsum advolant quaerentes libidinibus suis patrocinium aliquod ac velamentum. Itaque quod unum habebant in malis bonum perdunt, peccandi verecundia: laudant enim ea quibus erubescebant et vitio gloriantur, ideoque ne resurgere quidem †adulescentiae licet, cum honestus turpi desidiae titulus accessit. Hoc est cur ista voluptatis laudatio perniciosa sit, quia honesta praecepta intra latent, quod corrumpit apparet. In ea quidem ipse sententia sum (invitis hoc nostris popularibus dicam) sancta Epicurum et recta praecipere et, si propius accesseris, tristia; voluptas enim illa ad parvum et exile revocatur et quam nos virtuti legem dicimus eam ille dicit vouptati: iubet illam parere naturae; parum est autem luxuriae quod naturae satis est. Quid ergo est? Ille quisquis desidiosum otium et gulae ac libidinis vices felicitatem vocat bonum malae rei quaerit auctorem, et, dum illo venit blando nomine inductus, sequitur voluptatem non quam audit sed quam attulit, et vitia sua cum coepit putare similia praeceptis, indulget illis non timide nec obscure, luxuriatur etiam inde aperto capite. Itaque non quod dicunt plerique nostrorum, sectam Epicuri flagitiorum magistram esse, sed illud dico: male audit, infamis est, et immerito. Hoc scire qui potest nisi interius admissus? Frons eius ipsa dat locum fabulae et ad malam spem irritat. Hoc tale est quale vir fortis stolam indutus: constat tibi pudicitia, virilitas salva est, nulli corpus tuum turpi patientiae vacat, sed in manu tympanum est. Titulus itaque honestus eligatur et inscriptio ipsa excitans animum: quae stat, ad eam venerunt vitia. Quisquis ad virtutem accessit dedit generosae indolis specimen, qui voluptatem sequitur videtur enervis, fractus, degenerans viro, perventurus in turpia nisi aliquis distinxerit illi voluptates, ut sciat quae ex eis intra naturale desiderium desistant, quae praeceps ferantur infinitaeque sint et, quo magis implentur, eo magis inexplebiles. 14. Agedum, virtus antecedat, tutum erit omne vestigium. Et voluptas nocet nimia; in virtute non est verendum ne quid nimium sit, quia in ipsa est modus; non est bonum quod magnitudine laborat sua. Rationalem porro sortitis naturam quae melius res quam ratio proponitur? Et si placet ista iunctura, si hoc placet ad beatam vitam ire comitatu, virtus antecedat, comitetur voluptas et circa corpus ut umbra versetur: virtutem quidem, excelsissimum omnium, voluptati tradere ancillam nihil magnum animo capientis est. Prima virtus eat, haec ferat signa; habebimus nihilo minus voluptatem, sed domini eius et temperatores erimus; aliquid nos exorabit, nihil coget. At ei qui voluptati tradidere principia utroque caruere; virtutem enim amittunt, ceterum non ipsi voluptatem, sed ipsos voluptas habet; cuius aut inopia torquentur aut copia strangulantur, miseri si deseruntur ab illa, miseriores si obruuntur; sicut deprensi mari Syrtico modo in sicco
reliquuntur, modo torrente unda fluctuantur. Evenit autem hoc nimia intemperantia et amore caeco rei; nam mala pro bonis petenti periculosum est assequi. Ut feras cum labore periculoque venamur et captarum quoque illarum sollicita possessio est (saepe enim laniant dominos), ita habentes magnas voluptates in magnum evasere captaeque cepere; quae quo plures maioresque sunt, eo ille minor ac plurium servus est quem felicem vulgus appellat. Permanere libet in hac etiamnunc huius rei imagine. Quemadmodum qui bestiarum cubilia indagat et laqueo captare feras magno aestimat et latos canibus circumdare saltus ut illarum vestigia premat, potiora deserit multisque officiis renuntiat: ita qui sectatur voluptatem omnia postponit et primam libertatem neglegit ac pro ventre dependit, nec voluptates sibi emit, sed se voluptatibus vendit. 15. – Quid tamen, inquit, prohibet in unum virtutem voluptatemque confundi et ita effici summum bonum ut idem et honestum et iucundum sit? – Quia pars honesti non potest esse nisi honestum, nec summum bonum habebit sinceritatem suam si aliquid in se viderit dissimile meliori. Ne gaudium quidem quod ex virtute oritur, quamvis bonum sit, absoluti tamen boni pars est, non magis quam laetitia et tranquillitas, quamvis ex pulcherrimis causis nascantur; sunt enim ista bona, sed consequentia summum bonum, non consummantia. Qui vero virtutis voluptatisque societatem facit et ne ex aequo quidem, fragilitate alterius boni quicquid in altero vigoris est hebetat libertatemque illam, ita demum si nihil se pretiosius novit invictam, sub ingum mittit. Nam (quae maxima servitus est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur vita anxia, suspiciosa, trepida, casum pavens, temporum suspensa momentis. Non das virtuti fundamentum grave, immobile, sed iubes illam in loco volubili stare; quid autem tam volubile est quam fortuitorum exspectatio et corporis rerumque corpus afficientium varietas? Quomodo hic potest deo parere et quicquid evenit bono animo excipere nec de fato queri casuum suorum benignus interpres, si ad voluptatum dolorumque punctiunculas concutitur? Sed ne patriae quidem bonus tutor aut vindex est nec amicorum propugnator, si ad voluptates vergit. Illo ergo summum bonum escendat unde nulla vi detrahitur, quo neque dolori neque spei nec timori sit aditus nec ulli rei quae deterius summi boni ius faciat; escendere autem illo sola virtus potest. Illius gradu clivus iste frangendus est; illa fortier stabit et quicquid evenerit feret non patiens tantum sed etiam volens, omnemque temporum difficultatem sciet legem esse naturae et ut bonus miles feret vulnera, enumerabit cicatrices et transverberatus telis moriens amabit eum pro quo cadet imperatorem; habebit illud in animo vetus praeceptum: deum sequere. Quisquis
autem queritur et plorat et gemit imperata facere vi cogitur et invitus rapitur ad iussa nihilo minus. Quae autem dementia est potius trahi quam sequi! Tam me hercules quam stultitia et ignoratio condicionis est suae dolere, quod dest aliquid tibi aut incidit durius, aeque mirari aut indigne ferre ea quae tam bonis accidunt quam malis, morbos dico, funera, debilitates et cetera ex transverso in vitam humanam incurrentia. Qucquid ex universi constitutione patiendum est magno suscipiatur animo: ad hoc sacramentum adacti sumus, ferre mortalia nec perturbari iis quae vitare non est nostrae potestatis. In regno nati sumus: deo parere libertas est. 16. Ergo in virtute posita est vera felicitas. Quid haec tibi virtus saudebit? Ne quid aut bonum malum existimes quod nec virtute nec malitia continget. Deinde ut sis immobilis et contra malum et ex bono, ut qua fas est deum effingas. Quid tibi pro hac expeditione promittit? Ingentia et aequa divinis: nihil cogeris, nullo indigebis; liber eris, tutus, indemnis; nihil frustra temptabis, nihil prohibeberis; omnia tibi ex sententia cedent, nihil adversum accidet, nihil contra opinionem ac voluntatem. – Quid ergo? Virtus ad beate vivendum sufficit? – Perfecta illa et divina quidni sufficiat, immo superfluat? Quid enim deesse potest extra desiderium omnium posito? Quid extrinsecus opus est ei qui omnia sua in se collegit? Sed ei qui ad virtutem tendit, etiam si multum processit, opus est aliqua fortunae indulgentia adhuc inter humana luctanti, dum nodum illum exsolvit et omne vinculum mortale. Quid ergo interest? Quod arte alligati sunt alii, adstricti, [alii] districti quoque; hic qui ad superiora progressus est et se altius extulit laxam catenam trahit nondum liber, iam tamen pro libero. 17. Si quis itaque ex istis, qui philosophiam collatrant, quod solent dixerit: «Quare ergo tu fortius loqueris quam vivis? Quare et superiori verba summittis et pecuniam necessarium tibi instrumentum existimas et damno moveris et lacrimas audita coniugis aut amici morte demittis et respicis famam et malignis sermonibus tangeris? Quare cultius rus tibi est quam naturalis usus desiderat? Cur non ad praescriptum tuum cenas? Cur tibi nitidior suppellex est? Cur apud te vinum aetate tua vetustius bibitur? Cur aviarium disponitur? Cur arbores nihil praeter umbram daturae conseruntur? Quare uxor tua locupletis domus censum auribus gerit? Quare paedagogium pretiosa veste succingitur? Quare ars est apud te ministrare nec temere et ut libet collocatur argentum sed perite servitur et est aliquis scindendi obsonii magister?». Adice si vis: «Cur trans mare possides? Cur plura quam nosti? Turpiter aut tam neglegens es ut non noveris pauculos servos, aut tam luxuriosus ut plures habeas quam quorum notitiae memoria sufficiat!». Adiuvabo postmodo convicia et plura mihi quam putas obiciam, nunc hoc respondeo tibi: «Non sum sapiens et, ut malivolentiam tuam pascam, nec ero. Exige itaque a me, non ut optimus par sim, sed ut malis melior: hoc mihi satis est, cotidie aliquid ex vitiis meis demere et errores meos obiurgare. Non perveni ad sanitatem, ne perveniam quidem; delenimenta magis quam remedia podagrae
meae compono, contentus si rarius accedit et si minus verminatur; vestris quidem pedibus comparatus, debilis, cursor sum». Haec non pro me loquor (enim ego in alto vitiorum omnium sum), sed pro illo cui aliquid acti est. 18. – Aliter, inquis, loqueris, aliter vivis. – Hoc, malignissima capita et optimo cuique inimicissima, Platoni obiectum est, obiectum Epicuro, obiectum Zenoni; omnes enim isti dicebant non quemadmodum ipsi viverent, sed quemanmodum esset ipsis vivendum. De virtute, non de me loquor, et cum vitiis convicium facio, in primis meis facio: cum potuero vivam quomodo oportet. Nec malignitas me ista multo veneno tincta deterrebit ab optimis; ne virus quidem istud, quo alios spargitis, quo vos necatis, me impediet quo minus perseverem laudare vitam non quam ago sed quam agendam scio, quo minus virtutem adorem et ex intervallo ingenti reptabundus sequar. Exspectabo scilicet ut quicquam malivolentiae inviolatum sit, cui sacer nec Rutilius fuit nec Cato? Curet aliquis an istis nimis dives videatur, quibus Demetrius Cynicus parum pauper est? Virum acerrimum et contra omnia naturae desideria pugnantem, hoc pauperiorem quam ceteros Cynicos quod, cum sibi interdixerint habere, interdixit et poscere, negant satis egere! Vides enim: non virtutis scientiam sed egestatis professus est. 19. Diodorum, epicureum philosophum, qui intra paucos dies finem vitae suae manu sua imposuit, negant ex decreto Epicuri fecisse quod sibi gulam praesecuit. Alii dementiam videri volunt factum hoc eius, alii temeritatem; ille interim beatus ac plenus bona conscientia reddidit sibi testimonium vita excedens laudavitque aetatis in portu et ad ancoram actae quietem et dixit, quod vos inviti audistis quasi vobis quoque faciendum sit: Vixi et quem dederat cursum fortuna peregi. De alterius vita, de alterius morte disputatis et ad nomen magnorum ob aliquam eximiam laudem virorum, sicut ad accursum ignotorum hominum minuti canes, latratis; expedit enim vobis neminem videri bonum, quasi aliena virtus exprobratio delictorum vestrum omnium sit. Invidi splendida cum sordidus vestris confertis nec intellegitis quanto id vestro detrimento audeatis. Nam si illi qui virtutem sequuntur avari libidinosi ambitiosique sunt, quid vos estis quibus ipsum nomen virtutis odio est? Negatis quemquam praestare quae loquitur nec ad exemplar orationis suae vivere; quid mirum, cum loquantur fortia, ingentia, omnis humanas tempestates evadentia? Cum refigere se crucibus conentur, in quas unusquisque vestrum clavos suos ipse adigit, ad supplicium tamen acti stipitibus singulis pendent; hi, qui in se ipsi animum advertunt, quot cupiditatibus tot crucibus distrahuntur. At hi maledici et in alienam contumeliam venusti sunt. Crederem illis hoc vacare, nisi quidam ex patibulo suos spectatores conspuerent. 20. – Non praestant philosophi quae loquuntur. – Multum tamen praestant
quod loquuntur, quod honesta mente concipiunt: nam quidem si et paria dictis agerent, quid esset illis beatius? Interim non est quod contemnas bona verba et bonis cogitationibus plena praecordia. Studiorum salutarium etiam citra effectum laudanda tractatio est. Quid mirum, si non escendunt in altum ardua aggressi? Sed si vir es, suspice, etiam si decidunt, magna conantis. Generosa res est respicientem non ad suas sed ad naturare suae vires conari, alta temptare et mente maiora concipere quam quae etiam ingenti animo adornatis effici possunt. Qui sibi hoc proposuit: «Ego mortem eodem vultu quo cum audiam videbo. Ego laboribus, quanticumque illi erunt, parebo animo fulciens corpus. Ego divitias et praesentis et absentis aeque contemnam, nec si aliubi iacebunt tristior, nec si circa me fulgebunt animosior. Ego fortunam nec venientem sentiam nec recedentem. Ego terras omnis tamquam meas videbo, meas tamquam omnium. Ego sic vivam, quasi sciam aliis esse me natum et naturae rerum hoc nomine gratias agam: quo enim melius genere negotium meum agere potuit? Unum me donavit omnibus, uni mihi omnis. Quicquid habebo nec sordide custodiam nec prodige spargam. Nihil magis possidere me credam quam bene donata. Non numero nec pondere beneficia nec ulla nisi accipientis aestimatione perpendam; numquam id mihi multum erit quod dignus accipiet. Nihil opinionis causa, omnia conscientiae faciam; populo spectante fieri credam quicquid me conscio faciam. Edendi mihi erit bibendique finis desideria naturae restinguere, non implere alvum et exinanire. Ego amicis iucundus, inimicis mitis et facilis, exorabor antequam roger et honestis precibus occurram. Patriam meam esse mundum sciam et praesides deos, hos supra me circaque me stare factorum dictorumque censores. Quandoque aut natura spiritum repetet aut ratio dimittet, testatus exibo bonam me coscientiam amasse, bona studia, nullius per me libertatem deminutam, minime meam», – qui haec facere proponet, volet, temptabit, ad deos iter faciet, ne ille, etiam si non tenuerit, magnis tamen excidit ausis. Vos quidem, quod virtutem cultoremque eius odistis, nihil novi facitis. Nam et solem lumina aegra formidant et aver santur diem splendidum nocturna animalia, quae ad primum eius ortum stupent et latibula sua passim petunt, abduntur in aliquas rimas timida lucis. Gemite et infelicem linguam bonorum exercete convicio. Hiate, commordete: citius multo frangetis dentes quam imprimetis. 21. – Quare ille philosophiae studiosus est et tam dives vitam agit? Quare opes contemnendas dicit et habet? Vitam contemnendam putat et tamen vivit? Valetudinem contemmendam et tamen illam diligentissime tuetur atque optimam mavult? Et exsilium vanum nomen putat et ait: «Quid enim est mali mutare regiones?» et tamen si licet senescit in patria? Et inter longius tempus et brevius nihil interesse iudicat, tamen, si nihil prohibet, extendit aetatem et in multa
senectute placidus viret? Ait ista debere contemni, non ne habeat sed ne sollicitus habeat, non abigit illa a se, sed abeuntia securus prosequitur. Divitias quidem ubi tutius fortuna deponet quam ibi unde sine querela reddentis receptura est? M. Cato, cum laudaret Curium et Coruncanium et illud saeculum in quo censorium crimen erat paucae argenti lamellae, possidebat ipse quadragies sestertium, minus sine dubio quam Crassus, plus quam Censorius Cato. Maiore spatio, si comparentur, proavom vicerat quam a Crasso vinceretur, et si maiores illi obvenissent opes non sprevisset. Nec enim se sapiens indignum ullis muneribus fortuitis putat: non amat divitias sed mavult; non in animum illas sed in domum recipit, nec respuit possessas sed continet et maiorem virtuti suae materiam sumministrari vult. 22. Quid autem dubii est quin haec maior materia sapienti viro sit animum explicandi suum in divitiis quam in paupertate, cum in hac unum genus virtutis sit non inclinari nec deprimi, in divitiis et temperantia et liberalitas et diligentia et dispositio et magnificentia campum habeat patentem? Non contemnet se sapiens etiam si fuerit minimae staturae, esse tamen se procerum volet. Et exilis corpore aut amisso oculo valebit, malet tamen sibi esse corporis robur et hoc ita ut sciat esse aliud in se valentius. Malam valetudinem tolerabit, bonam optabit. Quaedam enim, etiam si in summam rei parva sunt et subduci sine ruina principalis boni possunt, adiciunt tamen aliquid ad perpetuam laetitiam et ex virtute nascentem: sic illum afficiunt divitiae et exhilarant, ut navigantem secundus et ferens ventus, ut dies bonus et in bruma ac frigore apricus locus. Quis porro sapientium (nostrorum dico quibus unum est bonum virtus) negat etiam haec quae indifferentia vocamus habere aliquid in se pretii et alia aliis esse potiora? Quibusdam ex iis tribuitur aliquid honoris, quibusdam multum. Ne erres itaque, inter potiora divitiae sunt. – Quid ergo, inquis, me derides, cum eundem apud te locum habeant quem apud me? – Vis scire quam non eundem habeant locum? Mihi divitiae si effluxerint, nihil auferent nisi semet ipsas, tu stupebis et videberis tibi sine te relictus, si illae a te recesserint; apud me divitiae aliquem locum habent, apud te summum; ad postremum divitiae meae sunt, tu divitiarum es. 23. Desine ergo philosophis pecunia interdicere: nemo sapientiam paupertate damnavit. Habebit philosophus amplas opes, sed nulli detractas nec alieno sanguine cruentas, sine cuiusquam iniuria partas, sine sordidis quaestibus, quarum tam honestus sit exitus quam introitus, quibus memo ingemescat nisi malignus. In quantum vis exaggera illas: honestae sunt in quibus, cum multa sint quae sua quisque dici velit, nihil est quod quisquam suum possit dicere. Ille vero fortunae benignitatem a se non summovebit et patrimonio per honesta quaesito nec gloriabitur nec erubescet. Habebit tamen etiam quo glorietur, si aperta domo et admissa in res suas civitate poterit dicere: «Quod quisque agnoverit, tollat». O magnum virum, optime divitem, si post hanc vocem tantundem habuerit! Ita dico:
si tuto et securus scrutationem populo praebuerit, si nihil quisquam apud illum invenerit quo manus iniciat, audacter et propalam erit dives. Sapiens nullum denarium intra limen suum admittet male intrantem; idem magnas opes, munus fortunae fructumque virtutis, non repudiabit nec excludet. Quid enim est quare illis bono loco invideat? Veniant, hospitentur. Nec iactabit illas nec abscondet (alterum infruniti animi est, alterum timidi et pusilli, velut magnum bonum intra sinum continentis) nec, ut dixi, eiciet illas e domo. Quid enim dicet? Utrumne «inutiles estis» an «ego uti divitiis nescio»? Quemadmodum etiam pedibus suis poterit iter conficere, escendere tamen vehiculum malet, sic, pauper, si poterit esse dives, volet. Habebit itaque opes sed tamquam leves et avolaturas, nec ulli alii eas nec sibi graves esse patietur. Donabit; quid erexistis aures? Quid expeditis sinum?… donabit aut bonis aut eis quos facere poterit bonos, donabit cum summo consilio dignissimos eligens, ut qui meminerit tam expensorum quam acceptorum rationem esse reddendam, donabit ex recta et probabili causa, nam inter turpes iacturas malum munus est, habebit sinum facilem, non perforatum, ex quo multa exeant et nihil excidat. 24. Errat si quis existimat facilem rem esse donare: plurimum ista res habet difficultatis, si modo consilio tribuitur, non casu et impetu spargitur. Hunc promereor, illi reddo; huic succurro, huius misereor; illum instruo dignum quem non deducat paupertas nec occupatum teneat; quibusdam non dabo quamvis desit quia etiam si dedero erit defuturum: quibusdam offeram, quibusdam etiam inculcabo. Non possum in hac esse re neglegens; numquam magis nomina facio quam cum dono. Quid tu, inquis, recepturus donas? – Immo non perditurus: eo loco sit donatio unde repeti non debeat, reddi possit. Beneficium collocetur, quemadmodum thesaurus alte obrutus, quem non eruas nisi fuerit necesse. Quid? Domus ipsa divitis vivi quantam habet bene faciendi materiam! Quis enim liberalitatem tantum ad togatos vocat? Hominibus prodesse natura me iubet servi liberine sint, hi, ingenui an libertini, iustae libertatis an inter amicos datae, quid refert? Ubicumque homo est ibi beneficii locus est. Potest itaque pecunia etiam intra limen suum diffundi et liberalitatem exercere, quae non quia liberis debetur sed quia a libero animo proficiscitur ita nominata est. Haec apud sapientem nec umquam in turpes indignosque impingitur nec umquam ita defetigata errat ut non, quotiens dignum invenerit, quasi ex pleno fluat. Non est ergo quod perperam exaudiatis quae honeste, fortiter, animose a studiosis sapientiae dicuntur. Et hoc primum attendite: aliud est studiosus sapientiae, aliud iam adeptus sapientiam. Ille tibi dicet: «Optime loquor, sed adhuc inter mala volutor plurima. Non est quod me ad formulam meam exigas: cum maxime facio me et formo et ad exemplar ingens attollo; si processero quantumcumque proposui, exige ut dictis facta respondeant». Assecutus vero humani boni summam aliter tecum aget et dicet: «Primum non est quod tibi permittas de melioribus ferre sententiam; mihi iam, quod argumentum est recti, contingit malis displicere. Sed ut tibi rationem reddam qua nulli mortalium invideo, audi quid promittam et quanti quaeque
aestimem. Divitias nego bonum esse: nam si essent, bonos facerent; nunc, quoniam quod apud malos deprenditur dici bonum non potest, hoc illis nomen nego. Ceterum et habendas esse et utiles et magna commoda vitae afferentis fateor. 25. «Quid ergo est? Quare illas non in bonis numerem, et quid praestem in illis aliud quam vos, quoniam inter utrosque convenit habendas, audite. Pone in opulentissima me domo, aurum argentumque in promiscuo usu sit: non suspiciam me ob ista, quae etiam si apud me extra me tamen sunt. In Sublicium pontem me trasfer et inter egentes abige: non ideo tamen me despiciam, quod in illorum numero consedero qui manum ad stipem porrigunt. Quid enim ad rem an frustum panis desit, cui non deest mori posse? Quid ergo est? Domum illam splendidam malo quam pontem. Pone in instrumentis splendentibus et delicato apparatu: nihilo me feliciorem credam, quod mihi molle erit adminiculum, quod purpura convivis meis substernatur. Muta stragula mea: nihilo miserius ero, si lassa cervix mea in maniculo faeni adquiescet, si super Circense tomentum per sarturas veteris lintei effluens incubabo. Quid ergo est? Malo quid mihi animi sit ostendere praetextatus et †causatus quam nudis scapulis aut† sententis. Omnes mihi ex voto dies cedant, novae gratulationes prioribus subtexantur: non ob hoc mihi placebo. Muta in contrarium hanc indulgentiam temporis, hinc illinc percutiatur animus damno, luctu, incursionibus variis, nulla hora sine aliqua querela sit: non ideo me dicam inter miserrima miserum, non ideo aliquem exsecrabor diem; provisum est enim a me ne quis mihi ater dies esset. Quid ergo est? Malo gaudia temperare quam dolores compescere». Hoc tibi ille Socrates dicet: «Fac me victorem universarum gentium, delicatus illi Liberi currus triumphantem usque ad Thebas a solis ortu vehat, iura reges petant a me: hominem esse maxime cogitabo, cum deus undique consalutabor. Huic tam sublimi fastigio coniunge protinus praecipitem mutationem; in alienum imponar fericulum exornaturus victoris superbi ac feri pompam: non humilior sub alieno curru agar quam in meo steteram. Quid ergo est? Vincere tamen quam capi malo. Totum fortunae regnum despiciam, sed ex illo, si dabitur electio, meliora suman. Quicquid ad me venerit bonum fiet, sed malo faciliora ac iucundiora veniant et minus vexatura tractantem. Non est enim quod existimes ullam esse sine labore virtutem, sed quaedam virtutes stimulis, quaedam frenis egent. Quemadmodum corpus in proclivi retineri debet, adversus ardua impelli, ita quaedam virtutes in proclivi sunt, quaedam clivum subent. An dubium sit quin escendat, nitatur, obluctetur patientia, fortitudo, perseverantia et quaecumque alia duris opposita virtus est et fortunam subigit. Quid ergo? Non aeque manifestum est per devexum ire liberalitatem, temperantiam, mansuetudinem? In his continemus animum ne prolabatur, in illis exhortamur incitamusque acerrime. Ergo paupertati adhibebimus illas quae pugnare sciunt fortiores, divitiis illas diligentiores quae suspensum gradum ponunt et pondus suum sustinent. Cum hoc ita divisum sit, malo has in usu mihi esse quae exercendae tranquillius sunt quam eas quarum
experimentum sanguis et sudor est. Ergo non ego aliter», inquit sapiens, «vivo quam loquor, sed vos aliter auditis, sonus tantummodo verborum ad aures vestras pervenit: quid significet non quaeritis». 26. – Quid ergo inter me stultum et te sapientem interest, si uterque habere volumus? – Plurimum: divitiae enim apud sapientem virum in servitute sunt, apud stultum in imperio; sapiens divitiis nihil permittit, vobis divitiae omnia; vos, tamquam aliquis vobis aeternam possessionem earum promiserit, assuescitis illis et cohaeretis, sapiens tunc maxime paupertatem meditatur cum in mediis divitiis constitit. Numquam imperator ita paci credit ut non se praeparet bello quod etiam si non geritur indictum est: vos domus formosa, tamquam nec ardere nec ruere possit, insolentes, vos opes, tamquam periculum omne transcenderint maioresque sint vobis quam quibus consumendis satis virium habeat fortuna, obstupefaciunt. Otiosi divitiis luditis nec providetis illarum periculum, sicut barbari plerumque inclusi et ignari machinarum segnes laborem obsidentium spectant, nec quo illa pertineant quae ex longinquo struuntur intellegunt. Idem vobis evenit: marcetis in vestris rebus nec cogitatis quot casus undique immineant iam iamque pretiosa spolia laturi. Sapientis quisquis abstulerit divitias, omnia illi sua relinquet; vivit enim praesentibus laetus, futuri securus. «Nihil magis», inquit ille Socrates aut aliquis alius, ius cui idem adversus humana atque eadem potestas est, «persuasi mihi quam ne ad opiniones vestras actum vitae mae flecterem. Solita conferte undique verba: non conviciari vos putabo sed vagire velut infantes miserrimos». Haec dicet ille cui sapientia contigit, quem animus vitiorum immunis increpare alios non quia odit sed in remedium iubet. Adiciet his illa: «Existimatio me vestra non meo nomine sed vestro movet, quia clamitantis odisse et lacessere virtutem bonae spei eiuratio est. Nullam mihi iniuriam facitis, sed ne dis quidem hi qui aras evertunt. Sed malum propositum apparet malumque consilium etiam ibi ubi nocere non potuit. Sic vestras halucinationes fero quemadmodum Iuppiter optimus maximus ineptias poetarum, quorum alius illi alas imposuit, alius cornua, alius adulterum illum induxit et abnoctantem, alius saevum in deos, alius iniquum in homines, alius raptorem ingenuorum et cognatorum quidem, alius parricidam et regni alieni paternique expugnatorem: quibus nihil aliud actum est quam ut pudor hominbus peccandi demeretur, si tales deos credidissent. Sed quamquam ista me nihil laedant, vestra tamen vos moneo causa: suspicite virtutem, credite iis qui illam diu secuti magnum quiddam ipsos et quod in dies maius appareat sequi clamant, et ipsam ut deos ac professores eius ut antistites colite, et quotiens mentio sacrarum litterarum intervenerit favete linguis. Hoc verbum non, ut plerique existimant, a favore trahitur, sed imperat silentium, ut rite peragi possit sacrum nulla voce mala obstrepente: quod multo magis necessarium est imperari vobis, ut quotiens aliquid ex illo proferetur oraculo intenti et compressa voce audiatis. Cum sistrum aliquis concutiens ex imperio mentitur, cum aliquis secandi lacertos suos artifex brachia atque umeros suspensa manu cruentat, cum aliqua genibus per viam repens ululat laurumque linteatus senex et medio lucernam die
praeferens conclamat iratum aliquem deorum, concurritis et auditis ac divinum esse eum, invicem mutuum alentes stuporem, affirmatis». 27. Ecce Socrates ex illo carcere quem intrando purgavit omnique honestiorem curia reddidit proclamat: «Quis iste furor, quae ista inimica dis hominibusque natura est infamare virtutes et malignis sermonibus sancta violare? Si potestis, bonos laudate, si minus, transite; quod si vobis exercere taetram istam licentiam placet, alter in alterum incursitate: nam cum in caelum insanitis, non dico sacrilegium facitis sed operam perditis. Praebui ego aliquando Aristophani materiam iocorum, tota illa comicorum poetarum manus in me venenatos sales suos effudit: illustrata est virtus mea per ea ipsa per quae petebatur; produci enim illi et temptari expedit, nee ulli magis intellegunt quanta sit quam qui vires eius lacessendo senserunt: duritia silicis nullis magis quam ferientibus nota est. Praebeo me non aliter quam rupes aliqua in vadoso mari destituta, quam fluctus non desinunt undecumque moti sunt verberare, nec ideo aut loco eam movent aut per tot aetates crebro incursu suo consummunt; assilite, facite impetum: ferendo vos vincam. In ea quae firma et inexsuperabilia sunt quicquid incurrit malo suo vim suam exercet: proinde quaerite aliquam mollem cedentemque materiam in qua tela vestra figantur. Vobis autem vacat aliena scrutari mala et sententias ferre de quoquam: “Quare hic philosophus laxius habitat? Quare hic lautius cenat”. Papulas observatis alienas, obsiti plurimis ulceribus. Hoc tale est quale si quis pulcherrimorum corporum naevos aut verrucas derideat, quem fera scabies depascitur. Obicite Platoni quod petierit pecuniam, Aristoteli quod acceperit, Democrito quod neglexerit, Epicuro quod consumpserit; mihi ipsi Alcibiadem et Phaedrum obiectate, evasuri maxime felices cum primum vobis imitari vitia nostra contigerit! Quin potius mala vestra circumspicitis quae vos ab omni parte confodiunt, alia grassantia extrinsecus, alia in visceribus ipsis ardentia? Non eo loco res humanae sunt, etiam si statum vestrum parum nostis, ut vobis tantum otii supersit ut in probra meliorum agitare linguam vacet. 28. Hoc vos non intellegitis et alienum fortunae vestrae vultum geritis, sicut plurimi quibus in circo aut theatro desidentibus iam funesta domus est nec annuntiatum malum. At ego ex alto prospiciens video, quae tempestates aut immineant vobis paulo tardius rupturae nimbum suum aut iam vicinae vos ac vestra rapturae propius accesserint. Quid porro? Nonne nunc quoque, etiam si parum sentitis, turbo quidam animos vestros rotat et involvit, figientes petentesque eadem et nunc in sublime allevatos nunc in infima allisos?»…
La felicità
Premessa Il dialogo è dedicato al fratello Annèo Novato, qui chiamato Gallione dal nome di Giunio Gallione, un retore amico di famiglia che lo aveva adottato (è quel Novato che in qualità di proconsole di Acaia ebbe modo di ascoltare san Paolo in un processo celebrato in seguito a una controversia sorta nel 52 nella comunità cristiana di Corinto. Seneca gli aveva già dedicato il De ira). Il tema è quello della felicità, la quale, secondo l’Autore, risiede non nel piacere, che è meschino, servile, debole e caduco, ma nella virtù, che è invece eccelsa, invincibile e duratura. Seguace della dottrina stoica, Seneca combatte l’epicureismo, precisando, però («questo», dice, «è il mio parere», XIII, 2) che il piacere di cui parla Epicuro è «sobrio e secco» e che il volgo lo interpreta male perché corre dietro soltanto alla parola e perché cerca un pretesto e una giustificazione per abbandonarsi ai godimenti volgari. La virtù è dunque il presupposto della vita beata. Ma bisogna avere una mente sana e seguire la ragione, conformandosi alla natura, che nel caso dell’uomo è appunto quella razionale. Anche le bestie, che seguono l’istinto, possono essere, a loro modo, felici, ma non hanno il senso della felicità. Come non l’hanno gl’idioti, quos in numerum pecorum et inanimalium redegit hebes natura et ignoratio sui, e, possiamo aggiungere, i fanciulli. Non basta, quindi, essere felici, bisogna avere anche felicitatis intellectus, cioè la piena consapevolezza di quella condizione, e il saggio è veramente felice, perché a differenza dell’ignorante, che pure può godere di una sua felicità, lo è con cognizione di causa. Questa felicità (non la felicità pura e semplice, ma la vera felicitas, che Seneca distingue dalla felicitas) è difficile a raggiungersi, sia perché non sappiamo esattamente quid sit quod beatam vitam efficiat, sia perché ignoriamo la strada che conduce a lei, e quanto più affannosamente ci sforziamo di conseguirla tanto più ce ne allontaniamo. Veramente più che di felicità si dovrebbe parlare di sommo bene, giacché quella del saggio è una condizione che sta al di sopra della felicità stessa, e difatti Seneca in molti punti la chiama summum bonum. Il sommo bene: è questa in realtà la vera meta del saggio, che per essere tale, nella maniera più autentica e piena, deve annullare in sé persino quella gioia che può venirgli dalla condizione stessa e dalla stessa coscienza della felicità. Il sommo bene è qualcosa di diverso da ciò di cui parlano generalmente i filosofi, Seneca compreso: è uno stato così sublime e profondo che non si può nemmeno esprimere a parole, si può solo sperimentare. Chi riemerge da un’estasi mistica o da una meditazione yoga profonda non è in grado di descrivere ciò che ha provato, può solo dire, con Dante: «Qual è colui che somnïando vede, / che dopo il sogno la passione impressa / rimane, e l’altro alla mente non riede; / cotal son io, ché tutta quanta cessa / mia visïone, ed ancor mi distilla / nel core il dolce che nacque da essa». Il sommo bene, insomma, è la pura contemplazione (non la vita contemplativa, di cui Seneca parla nel De otio), uno stato di cui la sola cosa che si può dire è che non se ne può dire nulla; non ha sensazioni, non ha pensieri, non ha sentimenti, non ha attribuiti, ma perché li possiede e li racchiude tutti, «quasi conflati insieme». È la coscienza cosmica, è l’essere in intima comunione col tutto, il vibrare all’unisono con lui, di una vibrazione sottilissima, impercettibile, che non appartiene ai sensi, che sta al di là di essi, come fuori dal corpo che l’ha imprigionata rendendola grossolana e contaminandone l’originaria purezza. Un attimo, che racchiude l’eterno e l’infinito: se durasse di più ci ucciderebbe. Questo è il sommo bene, e a darcelo non sarà né la saggezza di Seneca né la sapienza (vana) di Qohèlet, e tanto meno tutta la logica di questo mondo (che è stoltezza davanti a Dio, come dice san Paolo). Del resto Seneca – che sembra annaspare non solo nella sua ricerca della felicità ma anche nello sforzo di darcene l’esatta spiegazione (con una serie di definizioni che se non sono approssimative restano pur sempre incomplete) – ci offre la chiave per una vera interpretazione di questo sommo bene nelle ultime parole del XV capitolo, che sono come il “sugo” di tutto il dialogo (e bene avrebbe fatto a chiuderlo lì, invece di abbassarsi poi a una polemica personale che avvilisce un così alto discorso). In regno nati sumus: deo parere libertas est (un’espressione che richiama la massima Summum arbitrium est adhaerere D e o di sant’Agostino, anch’egli autore di un De beata vita). E però non si tratta di obbedienza, perché, volenti o non volenti, coscienti o non coscienti, in ogni caso già facciamo sempre la volontà di Dio, si tratta propriamente d’identificazione, di un annullamento, in Dio, della nostra individualità. In regno nati sumus: «il nostro è un mondo di schiavitù», ma non nel senso che siamo schiavi delle
passioni, del piacere, del denaro o di una dittatura, bensì nel senso che siamo schiavi della vita stessa e che nel mondo non c’è un solo briciolo di libertà: noi “crediamo” di essere liberi, perché così ci dice la coscienza, ma la coscienza che abbiamo di essere liberi non prova che lo siamo davvero. Questa è la conclusione a cui perviene il saggio, il quale vede i fatti del mondo come la storia di Dio (espressione di un gioco dialettico) proiettata sopra uno schermo, e perciò non si turba, che la scena sia lieta o dolorosa; una storia in cui il tutto si compone in un’ineffabile armonia. Non si turba, il saggio, perché sa e sente che ogni atto, ogni pensiero, ogni respiro umano gli appartiene, giacché dovunque palpita e si diffonde Dio. La vera felicità, la vera saggezza, la vera virtù, il sommo bene, insomma, nascono non dal distacco o dalla negazione delle cose sensibili, ma al contrario da una compenetrazione, da un’identificazione in esse così totale e profonda che pur essendovi dentro, e proprio per esservi dentro, in quello spirito, si è, nello stesso tempo, anche al di fuori del mondo. Il vero saggio non rifiuta niente, poiché sa che tutto è comunque espressione di Dio: il punto sta nel modo di vedere e di sentire le cose, abbracciandole e componendole nella divina armonia, superando il presente, superando le barriere del tempo e dello spazio. M. S. A.
1. Gallione,1 fratello mio, tutti aspiriamo alla felicità, ma, quanto a conoscerne la via, brancoliamo come nelle tenebre. È infatti così difficile raggiungerla che più ci affanniamo a cercarla, più ce ne allontaniamo, se prendiamo una strada sbagliata; e se questa, poi, conduce addirittura in una direzione contraria, la velocità con cui procediamo rende sempre più distante la nostra meta. Perciò dobbiamo avere innanzitutto ben chiaro quel che vogliamo, dopodiché cercheremo la via per arrivarci, e lungo il viaggio stesso, se sarà quello giusto, dovremo misurare giorno per giorno la strada che ci lasciamo indietro e quanto si fa più vicino quel traguardo a cui il nostro impulso naturale ci porta. È certo che, sino a quando vagheremo a caso, non seguendo una guida ma ascoltando lo strepito delle voci discordi che ci spingono in direzioni diverse, la nostra vita, già breve di per sé, si consumerà in questo andare errabondo, anche se c’impegniamo giorno e notte, animati dalle migliori intenzioni. Fissiamo dunque bene la meta e scrutiamo attentamente il modo per poterla raggiungere, con l’aiuto di un esperto che abbia già intrapreso ed esplorato il cammino che stiamo per affrontare, perché questo non ha nulla a che vedere con tutti gli altri, in cui sentieri precisi e le indicazioni forniteci dagli abitanti dei luoghi che attraversiamo c’impediscono di sbagliare: qui sono proprio le strade più battute e più frequentate a trarci in errore. Non c’è dunque nulla di peggio che seguire, come fanno le pecore, il gregge di coloro che ci precedono, perché essi ci portano non dove dobbiamo arrivare, ma dove vanno tutti. Questa è la prima cosa da evitare. Niente c’invischia di più in mali peggiori che l’adeguarci al costume del volgo, ritenendo ottimo ciò che approva la maggioranza, e il copiare l’esempio dei molti, vivendo non secondo ragione ma secondo la corrente. Da qui questo enorme affollarsi di persone che rovinano le une sulle altre. Come in una grande massa di uomini, in cui ciascuno, spingendo, cade e fa cadere (nessuno infatti cade senza tirarsi addosso almeno un altro, e i
primi nuocciono a quelli che gli vanno dietro), così avviene in tutti i campi della vita: nessuno sbaglia a suo esclusivo uso e consumo, ma ciascuno di noi è artefice e responsabile anche degli errori degli altri. È pericoloso appoggiarsi a quelli che ci camminano davanti, ma noi, come preferiamo affidarci alle opinioni altrui piuttosto che giudicare con la nostra testa, così anche intorno alla vita non formuliamo mai dei giudizi personali, sicché l’errore, passando di mano in mano, c’incalza, ci travolge e ci butta giù, con nostra grande rovina. Sono gli esempi degli altri che ci guastano: solo se sapremo tenerci lontani dalla moltitudine potremo salvarci. Il volgo, invece, a dispetto della ragione, s’irrigidisce in una ostinata difesa dei propri errori, per cui accade come nei comizi, nei quali, appena il favore popolare, volubile com’è, ha mutato direzione, quelle stesse persone che li hanno votati si meravigliano che siano stati eletti “quei” pretori: così noi indifferentemente, approviamo o rigettiamo le medesime cose; questo è il risultato di ogni giudizio, quando lo regoliamo sull’opinione degli altri. 2. Ma di fronte alla felicità non possiamo comportarci come nelle votazioni, accodandoci alla maggioranza, perché questa proprio per il fatto di essere la maggioranza è peggiore. I nostri rapporti con le vicende umane non sono infatti così buoni da poterci indurre a ritenere che il meglio stia dalla parte dei più, perché la folla testimonia esattamente il contrario, che cioè il peggio, per l’appunto, sta lì. Sforziamoci dunque di vedere e di seguire non i comportamenti più comuni ma cosa sia meglio fare, non ciò che è approvato dal volgo, pessimo interprete della verità, ma ciò che possa condurci alla conquista e al possesso di una durevole felicità. Per volgo intendo sia chi indossa il mantello2 sia chi porta la corona: io non bado all’apparenza delle vesti che coprono i corpi, non giudico un uomo con gli occhi, dei quali non mi fido, c’è in me una luce migliore e più sicura con cui distinguo il vero dal falso: è l’anima che deve trovare quel bene che solum è suo. Se mai avrà un momento di respiro per ritrarsi un poco in sé stessa, oh come, allora, torcendosi con grande strazio di sé, confesserà la verità e sarà indotta a esclamare: «Vorrei non avere mai fatto tutto quello che ho fatto sinora, e quando penso a ciò che ho detto provo invidia per i muti, e ogni mio desiderio lo considero una maledizione dei miei nemici. Buon dio, quanto mi sarebbe stato più sopportabile ciò che temevo, di fronte a ciò che ho tanto desiderato! Sono stata nemica di molti, e dopo l’odio che ho provato mi sono riappacificata con loro (se mai può esservi tregua fra malvagi), ma non sono ancora amica di me stessa. Mi sono adoperata in tutti i modi per tirarmi fuori dalla folla e farmi notare per qualche mia qualità, e che altro ho ottenuto se non espormi alle frecciate e ai morsi dei maligni? Li vedi questi che lodano l’eloquenza, inseguono la ricchezza, accarezzano i favori ed esaltano il potere? Tutti costoro o sono nemici o possono diventarlo, che è poi la stessa cosa. Tanto folta è la schiera degli adulatori quanto lo è quella degl’invidiosi. Perché non cercare un bene da potersi intimamente sentire, piuttosto che uno da mettere in vetrina? Tutte queste cose che ci stanno intorno, che ci avvincono e che ci
mostriamo a dito gli uni agli altri con ammirato stupore, brillano esternamente, ma dentro non sono che miserie». 3. Cerchiamo dunque un bene non apparente ma vero, che sia costante e bello nella sua intima essenza: è questo che dobbiamo sprigionare e portare alla luce. Non è lontano, lo troveremo, ci basta solo sapere dove tendere la mano. E invece continuiamo a brancolare nel buio, senz’accorgerci di ciò che pur ci sta vicino e inciampando proprio in quello che desideriamo. Ma per non trascinarti in un tortuoso giro di parole, tralascerò le opinioni degli altri (che sarebbe troppo lungo elencare e discutere) e ti esporrò la nostra: dico “nostra” non perché io mi senta legato ad alcuno dei grandi stoici, giacché anch’io ho diritto a un mio parere personale, ma perché di loro uno lo seguirò, un altro lo inviterò a puntualizzare il suo pensiero, e alla fine, magari, interpellato, non respingerò nessuna delle idee di coloro che hanno parlato prima di me, e dirò: «In più io la penso così». Intanto, come tutti gli stoici, io seguo la natura: è segno di saggezza non allontanarsene ma conformarsi alle sue leggi e al suo esempio. Felice è dunque quella vita che si accorda con la sua propria natura, il che è possibile solo se la mente, in primo luogo, è sana, ma sana sempre, in ogni momento, poi se è forte ed energica, decisamente paziente, capace di affrontare qualsiasi situazione, interessata al corpo e a quanto lo riguarda ma senza ansie e preoccupazioni, amante di tutto ciò che adorna la vita ma con distacco,3 disposta a servirsi dei doni della fortuna ma senza farsene schiava. Comprendi bene – anche se non aggiungo altro – che una volta eliminate tutte le cause di irritazione e di paura, ne conseguono una calma interiore e una libertà ininterrotte: infatti ai piaceri e agli allettamenti, che sono fragili e di breve durata, e che ci nuocciono col loro solo profumo, subentra una gioia incommensurabile, salda e costante; e poi la pace e l’armonia dell’anima, l’elevatezza e la bontà: la cattiveria è sempre frutto di una malattia. 4. Della felicità si possono dare anche altre definizioni, giacché uno stesso concetto può essere espresso con parole diverse. Come un esercito che si schieri ora in larghe file, ora in uno spazio ristretto, oppure a semicerchio o frontalmente, ma comunque si disponga non cambiano la sua forza e la sua volontà di combattere per la medesima causa, così la definizione della felicità può essere ora ampia e particolareggiata, ora breve e concisa. Sicché possiamo dire, per esempio, che essa «consiste nel disprezzare i doni della fortuna e nel compiacersi della virtù», o che «è una forza invincibile dell’animo, esperta della vita, serena nell’agire, piena di umanità e di premure per gli altri», senza con ciò mutarne il concetto o la sostanza. E possiamo ancora dire che felice è colui per il quale non esistono il bene e il male ma soltanto uomini buoni e uomini cattivi, che segue solo ciò che è onesto e si compiace unicamente della virtù, che non si accende né si avvilisce nelle alterne vicende della sorte, che non conosce bene maggiore di quello che può procurarsi da solo, e per il quale il vero piacere è il
disprezzo del piacere stesso. Se vogliamo allargare il discorso, possiamo usare altre forme, sempre nuove e diverse, ma la sostanza non cambierà. Nessuno, per esempio, c’impedisce di dire che la felicità è un dono proprio di un animo libero, elevato, intrepido e costante, lontano da timori e desideri, per il quale l’unico bene è l’onestà e l’unico male la disonestà, e tutto il resto non è altro che uno spregevole insieme di cose che non tolgono e non aggiungono nulla alla felicità, la quale né diminuisce né si accresce col loro andare e venire. Un simile presupposto comporterà necessariamente, anche se noi non lo volessimo, una serenità ininterrotta, una gioia che sgorga dal profondo, intensa e duratura, perché gode di un bene che è suo e non desidera se non ciò che strettamente le appartiene. Per quale motivo non dovremmo credere che un tale stato possa compensare perfettamente i moti meschini, futili e passeggeri del nostro misero corpo? Quando uno è schiavo del piacere lo è anche del dolore, e non c’è schiavitù più dannosa e più triste che nel soggiacere ora all’uno ora all’altro di questi due tirannici e capricciosi padroni. Bisogna quindi liberarsene, e l’unica via sta nell’indifferenza di fronte alle mutevoli vicende della sorte: allora nascerà quell’inestimabile bene, la serenità di una mente sicura e decisa, l’elevatezza morale, e, una volta eliminato ogni timore, la gioia immensa e senza fine, proveniente dalla conoscenza del vero, l’affabilità e l’espansività; e tutti questi beni ci diletteranno non in quanto tali ma in quanto doti o qualità proprie dell’animo. 5. Visto che tessendo mi si è allargata la tela, aggiungerò che si può dire felice anche chi, servendosi della ragione, si è liberato dai desideri e dai timori. Certo, pure i sassi e gli animali sono privi di tristezze e di paure, ma non per questo possiamo chiamarli felici, perché non hanno il senso della felicità.4 Lo stesso si può dire di quegli uomini che per innata ottusità mentale e ignoranza di sé annoveriamo fra i bruti e gli esseri inanimati: non c’è infatti alcuna differenza fra le due categorie, perché negli uni manca la ragione, negli altri c’è, ma è depravata, indirizzata unicamente a loro danno e perversione. Non si può definire felice chi si trova fuori dalla verità. La felicità, insomma, si fonda sulla capacità di formulare un giudizio retto, sicuro e immutabile. Soltanto allora, infatti, la mente è pura e libera da ogni male, perché è riuscita a sottrarsi non solo alle lacerazioni ma anche alle minime scalfitture, e resterà sempre nella condizione che si è conquistata, anche se dovesse piombarle addosso tutta la rabbia dell’avversa fortuna. Quanto al piacere – ci avvolga pure da tutti i lati e si diffonda per ogni vena, ci titilli l’animo con le sue continue e insistenti lusinghe per turbarci, completamente o in parte – quale uomo, a cui sia rimasto almeno un briciolo di umanità, vorrà lasciarsi solleticare giorno e notte e abbandonare l’animo, per dedicarsi unicamente al corpo?5 6. Ma anche l’anima – si obietterà – ha la sua parte nei piaceri. E se li prenda, si segga pure a giudice del lusso e di ogni genere di godimenti, si
riempia sino alla sazietà di ciò che suole dilettare i sensi, poi si volga al passato e nel ricordo dei piaceri già consumati s’inebri di quel che ha provato e si protenda verso ciò che proverà, programmi le sue attese, e mentre il corpo se ne sta disteso, appesantito dal lauto pasto dell’oggi, spinga avanti il pensiero ai godimenti del domani; ebbene, tutto questo mi sembrerà ancora più meschino, poiché scegliere il male al posto del bene è pura e semplice follia. Nessuno può essere felice se non è sano di mente, e non è sano di mente colui che invece del meglio cerca ciò che gli nuocerà. In definitiva, è felice colui che giudica rettamente, è felice chi si accontenta della sua condizione, quale che essa sia, e gode di quello che ha, è felice colui che imposta e regola su basi razionali la condotta di tutta la sua vita. 7. Anche quelli che fanno consistere la felicità nei godimenti sopra accennati riconoscono di collocarla in un posto quanto mai vergognoso, per cui cercano di conciliare le cose, dicendo che il piacere va a braccetto con la virtù e che non si può vivere una vita onesta che non sia contemporaneamente amabile, e viceversa.6 Io non vedo come si possano accoppiare delle cose tanto diverse fra loro. Ditemi, per favore, per quale motivo non si può separare il piacere dalla virtù? Se è in questa che si trova l’origine di tutti i beni, com’è possibile che da quelle stesse radici provengano anche i piaceri, quei piaceri che voi, spinti dal desiderio, cercate con tanta insistenza? Se la virtù e il piacere non fossero distinti, come faremmo a vedere che alcune cose sono piacevoli ma non oneste, altre invece onestissime ma dure e conseguibili solo attraverso la sofferenza? Per non dire che il piacere può accompagnarsi anche alla più ignobile condotta, mentre la virtù non ammette una vita disonesta, e che alcuni sono infelici non perché senza piaceri ma proprio per via dei piaceri, il che non accadrebbe se il piacere fosse mescolato alla virtù, la quale, quando quello non c’è, non ne sente per questo alcun bisogno. Perché, dunque, volete mettere insieme cose diverse o addirittura contrarie fra loro? La virtù è un che di alto e profondo, un che di eccelso e regale, d’invincibile e d’instancabile, il piacere invece è meschino, servile, debole, caduco, staziona e alloggia nei bordelli e nelle osterie.7 La virtù la incontrerai nell’interno di un tempio, nel foro, in senato, a guardia delle mura, ricoperta di polvere, accaldata o con i calli alle mani, il piacere lo vedrai perlopiù nascosto o in cerca del buio, presso i bagni e le terme, o nei luoghi che temono la polizia, lo vedrai fiacco, snervato, imbevuto di vino e di unguenti, pallido o imbellettato, imbalsamato come un cadavere. Il sommo bene è immortale, non sfugge, non dà sazietà né rimorsi, giacché una mente retta non muta, non odia sé stessa e non cede di un passo da quella sua condizione, che è la migliore; il piacere, invece, finisce nel momento stesso in cui giunge al suo culmine, ha uno spazio ristretto e perciò ben presto ci sazia e ci dà nausea, e già nel suo primo slancio s’infiacchisce. Non c’è nulla di stabile e di certo in ciò che per sua natura è soggetto a movimento, né può avere alcuna consistenza ciò che viene e se ne va in un baleno, destinato a perire nel medesimo istante in cui si
consuma; tende infatti colà dov’è condannato a morire, e nel suo stesso principio ha già presente la fine. 8. Quanto poi al fatto che il piacere si trova sia nei buoni che nei cattivi e che gli scellerati godono della propria infamia non meno di quanto gli onesti si compiacciono del loro retto operare, dirò che – come gli antichi ci hanno insegnato – dobbiamo seguire la vita migliore, non la più dilettevole, e che il piacere non dev’essere guida ma soltanto compagno del buono e del giusto volere. Il nostro maestro è la natura, è lei che la ragione guarda e consulta. Perciò vivere felici e vivere secondo natura sono la medesima cosa, e dirò subito perché: se conserveremo le qualità fisiche e le inclinazioni naturali con cura e con serenità, nella consapevolezza che sono beni passeggeri destinati a perire, se non ne subiremo la schiavitù e non ci lasceremo possedere dal mondo esterno, se le occasionali soddisfazioni del nostro corpo conteranno per noi come le truppe ausiliarie e i soldati armati alla leggera (che hanno il compito di servire, non di comandare), solo così tutto questo potrà essere utile alla nostra mente. Non dobbiamo lasciarci corrompere né dominare dal mondo che ci circonda, dobbiamo fare assegnazione solo su noi stessi, affidarci alle nostre personali capacità, risoluti sia nella fortuna che nella malasorte; dobbiamo, insomma, essere noi gli artefici della nostra vita e della nostra condotta. E però quella fede deve accompagnarsi alla scienza, a un sapere saldo e costante, sì che quando abbiamo preso delle decisioni queste rimangano stabili e certe, senza riserve o cancellature di sorta. Va da sé – né c’è bisogno ch’io mi dilunghi in questo discorso – che se ci atterremo a tali princìpi saremo equilibrati e ordinati, generosi e affabili in ogni nostra azione. La ragione parta pure dai sensi nel fare le sue ricerche (i sensi, infatti, hanno il compito di stimolarla, né da altro essa può muovere nel suo slancio verso la verità), ma, una volta preso l’avvio, rientri subito in sé, come del resto fanno l’universo intero, che tutto abbraccia, e dio stesso che lo governa, i quali, pur tendendo verso l’esterno, tornano poi, da ogni parte, nella loro intima essenza. Questo deve fare la nostra mente. Dopo che dietro la spinta dei sensi e per loro mezzo si sia volta alle cose che la circondano, si mantenga padrona di queste e di sé stessa. Ne nasceranno una forza sola e un potere concorde, e quella razionalità sicura che non conosce contrasti o tentennamenti nelle sue opinioni, nelle sue conoscenze e nelle sue convinzioni. Quando la mente si sia così organizzata, ordinata e armonizzata, diciamo, in tutte le sue parti, il nostro animo avrà già raggiunto la felicità, perché in sé non avrà più nulla di riprovevole, nulla d’incerto, nulla in cui possa urtare o scivolare; agirà sempre di sua libera iniziativa e niente potrà accadergli che da lui non sia già stato previsto e calcolato, ma tutto ciò che farà avrà giusto e felice compimento, perché l’agire gli riuscirà facile, pronto e senza alcuna esitazione: la pigrizia, infatti, e l’indecisione rivelano l’esistenza di contrasti e di incoerenze, che un simile animo non ha. Perciò possiamo dichiarare apertamente che la felicità è l’armonia interiore, giacché le virtù si trovano nell’accordo e
nell’unità: dove questi mancano non ci sono che vizi. 9. Ma anche tu – mi dirai – coltivi la virtù unicamente perché speri di ricavarne un piacere. Ebbene, tanto per cominciare, il fatto che la virtù procuri un piacere non significa che la si cerchi per questo: il piacere è solo un’aggiunta, non la meta del nostro sforzo: lo conseguiremo, ma mirando a un altro fine, che è appunto la virtù. Come in un campo di grano spuntano qua e là dei fiorellini – ma non a questa erbetta, benché gradita agli occhi, mirava tanta fatica (altro era lo scopo del seminatore, i fiori sono un di più) – allo stesso modo il piacere non è né il premio né la causa della virtù, ma un elemento accessorio: il virtuoso non ne gode perché gli procura diletto, ma, dal momento che gli procura diletto, se ne compiace. La felicità, ancora, sta nella convinzione stessa di essere felici e nell’atteggiamento di una mente perfetta, che, giunta al termine del suo viaggio e postasi intorno i suoi limiti, ha pienamente realizzato il suo massimo bene e non chiede più altro, perché oltre al tutto non c’è nulla, non c’è nulla al di là della fine. Commetti dunque un errore quando mi chiedi per quale motivo io aspiri alla virtù, perché ti riferisci a qualcosa che dovrebbe stare al di sopra del massimo a cui si possa aspirare. Vuoi sapere che chiedo alla virtù? La virtù, nient’altro che la virtù. Essa infatti non può dare nulla di meglio, perché ha in sé stessa il suo premio. Ti sembra poco? Se ti dico che «la felicità è fermezza inflessibile dell’anima, preveggenza, sublimità, ragionevolezza, libertà, bellezza e armonia», chiedi ancora qualcosa di più grande a cui ascrivere tutti questi beni? Perché mi tiri in ballo il piacere? Io cerco il bene dell’uomo, non già quello del ventre,8 che – se la metti su questo piano – nelle bestie è ancora più capiente. 10. Mi obietterai che io traviso il senso delle tue parole, giacché tu pure sostieni che nessuno può essere felice se non è insieme onesto, e questo – dici – non potrà mai capitare alle bestie o a coloro che fanno consistere la propria felicità nel mangiare. E dichiari apertamente e pubblicamente che la felicità di cui parli tu non può sussistere se non è unita alla virtù. D’accordo. E chi non sa che sono i più sciocchi a rimpinzarsi di questi vostri piaceri, che la malvagità trabocca di godimenti e che persino l’animo, spesso, suggerisce molti e depravati tipi di piaceri? In primo luogo l’arroganza, l’eccessiva stima di sé stessi, la superbia,9 che ci gonfia e ci fa sentire al di sopra di tutti gli altri, l’amore cieco e smodato dei propri averi, i godimenti sfrenati e l’esultanza per i più piccoli e puerili motivi, e ancora la mordacità e l’insolenza che si compiace di offendere, l’accidia e la dissoluzione di un animo fiacco che dorme su sé stesso. La virtù fa piazza pulita di tutto questo, tira le orecchie, valuta i piaceri prima di accoglierli e quei pochi che approva non li tiene in gran conto: li accetta, ma con cautela, e non gode perché ne fruisce, ma per l’uso moderato che ne fa. Il fatto che la temperanza sia una diminuzione non intacca la felicità. Tu apri le braccia al piacere, io lo tengo a freno, tu del piacere godi, io me ne servo, tu lo consideri il più grande dei beni, io non lo stimo neppure un bene, tu fai tutto
per il piacere, io, per lui, non faccio niente di niente. 11. Con ciò mi riferisco a quel tipo di saggio che tu consideri unico depositario del piacere. Ma per me non è saggio chi si trova sotto il potere di qualcosa, e tanto meno del piacere, perché se ne è dominato come può resistere alle fatiche, ai pericoli, alla povertà e a tutte le minacce che si affollano e strepitano intorno alla vita umana? Come potrà sopportare costui la vista della morte, i dolori, la furia fragorosa degli elementi, la nutrita schiera di feroci nemici, se si lascia vincere da un avversario così debole? Tu mi dirai: «Farà tutte le cose che il piacere gli suggerirà». Bravo! E non vedi quante sono? «Ma non potrà consigliargli niente di disonesto», ribatterai, «perché è unito alla virtù». E io, a mia volta, ti rimbeccherò: «Ma che razza di felicità è quella che, per essere tale, ha bisogno di un custode? E la virtù come potrà governare un piacere a cui va dietro, quando il seguire è proprio di chi ubbidisce, il guidare, invece, di chi comanda? Tu, così, m’inverti le cose!». Voi attribuite alla virtù un nobile compito davvero: quello di assaggiatrice dei piaceri! Vedremo dopo se possa esserci fin qui un briciolo di virtù in coloro che l’offendono in questo modo: non si può infatti parlare di virtù quando si è lontani anche solo di un passo da quella condizione in cui essa propriamente consiste. Per ora, attenendoci all’argomento di cui abbiamo preso a trattare, ti mostrerò che ci sono molte persone assediate dai piaceri, alle quali la sorte ha profuso tutti i suoi doni, ma che tu riconoscerai, necessariamente, infelici. Guarda Nomentano10 e Apicio, per esempio, che si cucinano i beni (così essi li chiamano) della terra e del mare, che sanno riconoscere, solo al vederli imbanditi sulla tavola, gli animali di ogni paese; guardali, mentre già si gustano con gli occhi il ghiotto cibo dall’alto del loro trono tappezzato di rose, riempiendosi l’udito di carezzevoli suoni, la vista di spettacoli, il palato dei più diversi sapori; il loro corpo è tutto acceso ed eccitato da morbide e lascive seduzioni, e affinché le narici, nel frattempo, non restino inoperose, il luogo stesso in cui si consuma il sacro rito della lussuria è impregnato dei più diversi profumi. Ebbene, potrai dire che costoro sono immersi nei piaceri, ma non che sono felici: essi infatti non godono di un bene. 12. Obietterai che non sono infelici per questo, ma perché insorgono molti fattori a turbare il loro animo, e opinioni diverse e contrastanti gli rendono inquieta la mente. Ammetto che sia così, ma nondimeno, stolti e incostanti, e sempre sotto i colpi del rimorso, provano grandi piaceri, per cui si deve riconoscere che sono tanto lontani dalla sofferenza quanto dalla buona razionalità, e, come accade alla maggior parte di loro, dominati da un’allegra follia che sfogano mediante un riso sfrenato. I piaceri del saggio, al contrario, sono modesti e pacati, quasi languidi, trattenuti e percettibili appena, inquantoché non sono stati invitati ed essendosi presentati di loro spontanea iniziativa non vengono accolti con tutti gli onori, né con gioia ed entusiasmo, da parte di colui
che li riceve: il saggio, infatti, li mescola e li frappone alla vita, come il gioco e lo scherzo s’intercalano fra le severe occupazioni. 13. Finiamola dunque di mettere insieme cose inconciliabili fra loro, mescolando il piacere con la virtù: è un vezzo, questo, volto a giustificare e a elogiare i vizi peggiori. L’uomo che si abbandona alle gozzoviglie, che rutta continuamente ed è sempre ubriaco, visto che ne gode, s’illude che il piacere conviva con la virtù, anche perché sente dire così, per cui chiama sapienza i propri vizi e ostenta sfacciatamente ciò che invece dovrebbe nascondere. Quindi non è Epicuro che spinge questi individui alla lussuria, sono loro che, essendo dediti al vizio, celano la propria libidine nel grembo della filosofia, rifugiandosi in quella dottrina in cui si fa l’elogio del piacere. E però non si preoccupano di vedere quanto sia sobrio e sereno il piacere di Epicuro (questa, almeno, è la mia interpretazione), ma corrono diritti alla parola, in cui credono di trovare una giustificazione e una maschera alle loro sfrenate passioni. E così perdono l’unico bene che gli restava, in mezzo a tutti quei mali, la vergogna del peccato: lodano infatti ciò di cui prima arrossivano e si vantano dei propri vizi. Per questo i giovani non hanno più la possibilità di riemergere da quel fango, quando a un così turpe e pigro godimento si è conferito un attestato di onorabilità. Sono evidenti a questo punto i rischi che si annidano in un elogio avventato e superficiale del piacere, perché i precetti nobili e profondi contenuti in tale dottrina rimangono nascosti, mentre affiorano solo i sozzi germi della corruzione. Io sono fermamente convinto (e lo dico anche a dispetto dei miei colleghi della scuola stoica) che i precetti di Epicuro sono retti e santi, e se li guardiamo attentamente persino severi: il piacere infatti, per lui, si riduce a ben piccola e magra cosa ed è soggetto a quella stessa legge che noi stoici applichiamo alla virtù: esso deve, cioè, obbedire alla natura. Senonché ciò che basta alla natura non è sufficiente per il piacere. E allora? Chi chiama felicità l’ozio assoluto e l’alterno appagamento della gola e dei sensi cerca un buon avvocato per un’azione malvagia e, spinto su quella strada da una parola ingannevole, segue non il piacere di cui si parla in quella dottrina ma quello che ha scelto lui e che si porta appresso, e scambiati i suoi vizi per precetti filosofici vi si abbandona con indulgenza, sfacciatamente e senza più nascondersi nemmeno, anzi, finisce col praticare la lussuria addirittura in pubblico. Io perciò non sostengo, come la maggior parte dei miei colleghi stoici, che la scuola di Epicuro è maestra d’infamie, dico che è diffamata, che ha una cattiva reputazione, e ingiustamente. Chi può sapere, del resto, come stanno esattamente le cose, se non ha ben studiato e approfondito questa dottrina? La sua facciata può dare adito a maldicenze e far nascere cattivi propositi. Come se tu, uomo forte e vigoroso, ti presentassi in pubblico ricoperto di un abito femminile: tu ben conosci la tua onorabilità, la tua virilità è fuori discussione, il tuo corpo non indulge ad alcun atto di libidine, però… hai in mano il tamburello!11 Si scelga dunque per questa dottrina una definizione decorosa e un’insegna che già di per sé stessa sia di
adeguato incitamento all’animo: quella attuale non fa che favorire i vizi. Chi si mette sulla via della virtù dà prova di un’indole nobile, chi invece va dietro al piacere è uno privo di nervi, un debosciato, un deviato, pronto a precipitare nei vizi più abominevoli, a meno che non abbia qualcuno che gli mostri la differenza fra i vari piaceri, sì ch’egli possa comprendere quali di essi rientrano nei limiti del desiderio naturale e quali invece corrono all’impazzata e senza fine, tanto più insaziabili quanto più si cerca di appagarli. 14. Sia dunque la virtù la nostra guida: seguendo lei ogni passo sarà sicuro. Il piacere, inoltre, quando è eccessivo nuoce, nella virtù non c’è da temere che vi sia nulla di troppo, perché è intrinseca in lei la moderazione. Tutto ciò che risente del proprio peso non è un bene. A chi ha avuto in sorte una natura razionale si può forse proporre qualcosa di meglio della ragione? Ora, se questa unione ci piace, se ci è gradito avviarci lungo il sentiero della felicità in tale compagnia, la virtù faccia da battistrada e il piacere l’accompagni, limitandosi a corteggiarla, come l’ombra che procede accanto al corpo ma senza confondersi con lui. Asservire al piacere la virtù, che è il più nobile dei beni, è proprio di chi non sa concepire nulla di grande. La virtù vada dunque per prima e sia lei a portare le insegne; il piacere lo avremo egualmente ma come suoi padroni e moderatori; ci pregherà di fare qualche strappo, qualche eccezione, alla nostra temperanza, ma non potrà mai piegarci a sé. Invece quelli che hanno dato la prerogativa del comando al piacere restano privi dell’uno e dell’altra, giacché perdono la virtù e, quanto al piacere, non loro godono di lui ma lui gode di loro; e se è scarso si tormentano, se è eccessivo ne sono soffocati, infelici se li abbandona, più infelici se li travolge: come i naviganti in balìa delle Sirti, che ora restano bloccati in una secca, ora vengono sballottati dai ribollenti flutti. Questi sono i risultati di un’intemperanza smodata e di un amore cieco per l’oggetto dei nostri desideri. È rischioso, infatti, giungere in porto quando si va dietro al male quasiché fosse un bene. Come andiamo a caccia di bestie feroci tra fatiche e pericoli e una volta che le abbiamo catturate e le teniamo con noi stiamo sempre all’erta, visto che spesso sbranano i proprietari, allo stesso modo chi si procaccia grandi piaceri incorre in gravi disgrazie, e quelli, che prima stavano al guinzaglio, diventano i suoi padroni; e quanto più essi sono forti e numerosi, tanto più piccolo e schiavo di più padroni si fa colui, che il volgo chiama felice. E, proseguendo con questa immagine, come il cacciatore, che dopo averne scovato i nascondigli, prende col laccio le selvagge fiere e circonda di cani i grandi balzi,12 e per seguirne le tracce tralascia cose di maggiore importanza e rinuncia a molti dei suoi impegni, così chi corre dietro al piacere dimentica tutto il resto e in primo luogo trascura la propria libertà, mettendola al servizio del ventre; si
vende, insomma, ai piaceri, invece di comprarli. 15. Ma cosa impedisce – si dirà – che virtù e piacere si fondano insieme, dando luogo a una felicità che sia contemporaneamente onesta e piena di godimenti? Il fatto che l’onestà è costituita esclusivamente da tanti pezzetti di onestà, e che la felicità non sarebbe più autentica se dovesse accogliere in sé qualcosa che differisce da quella che è la migliore, cioè l’onestà. Nemmeno la gioia che nasce dal possesso della virtù, per quanto buona in sé stessa, fa parte del bene assoluto, e così pure l’allegria e la tranquillità, anche se provengono dalle più nobili cause: sono infatti dei beni conseguenti, dei compagni, che non rappresentano il completamento della felicità. Chi invece mette insieme virtù e piacere – e neppure in eguale misura – con la fragilità di un bene spegne tutto il vigore che c’è nell’altro e finisce col mandare sotto il giogo la libertà, che si mantiene intatta solo se non le si presentino altri beni spacciati come più preziosi. Si comincia, così, ad avere bisogno della fortuna (e questa è la peggiore delle schiavitù), con la conseguenza che si vive una vita piena di ansie, di sospetti, di trepidazioni, timorosa di ogni evento, come attaccata a un filo. In tal modo non si dà alla virtù un fondamento solido e stabile, ma la si colloca sopra una base malferma; e che c’è di più instabile e insicuro dell’affidarsi al caso, o delle continue variazioni del nostro corpo fisico e di tutto ciò che lo riguarda? Come può obbedire a dio e accogliere con animo sereno qualunque avvenimento, senza lagnarsi della sorte, perché sa interpretare sempre benevolmente i propri casi, un uomo che si scuote ai più piccoli stimoli del piacere e del dolore? Non può nemmeno difendere o liberare la patria, o sostenere gli amici,13 se pensa solo al piacere. La felicità salga sopra una cima, da cui nessuna forza possa tirarla giù, a cui non abbiano accesso né dolori, né speranze, né timori, né alcun’altra cosa che possa intaccare la sua prerogativa: soltanto la virtù può arrivare a quell’altezza, giacché solo il suo passo vince l’ardua salita. E piazzatasi lì, saldamente, sopporterà qualsiasi evento non solo con pazienza, ma di buon grado, ben sapendo che le avversità della vita fanno parte della legge di natura; reggerà alle ferite come un valoroso soldato che conti le sue cicatrici e trafitto dai dardi, anche in punto di morte resta fedele al suo capo, per il quale è caduto; e avrà sempre nel cuore l’antica massima stoica: «Conformati a dio».14 Chi si lamenta, piange e si dispera, è costretto a servire come un forzato, a obbedire contro il proprio volere. Ma non è follia farsi trascinare a forza, invece di seguire con remissività? Così pure è stoltezza e ignoranza della nostra umana condizione dolersi perché qualcosa ci manca o ci riesce sgradito, meravigliarsi e sdegnarsi di dover sopportare ciò che capita tanto ai buoni quanto ai cattivi, come le malattie, i lutti e tutte le altre disgrazie della vita. Accettiamo quindi con animo forte tutto ciò che c’impone la legge stessa dell’universo: a questo impegno siamo chiamati, come da un giuramento: ad accettare il nostro stato mortale e a non lasciarci turbare da ciò che non ci è dato di evitare. Il nostro è un mondo di schiavitù: il solo modo per uscirne è
l’ubbidire a dio: è questa l’unica possibile libertà. 16. La vera felicità, dunque, risiede nella virtù, la quale ci consiglia di giudicare come bene solo ciò che deriva da lei e come male ciò che proviene invece dal suo contrario, la malvagità. Poi, di essere imperturbabili, sia di fronte al male che di fronte al bene, in modo da riprodurre in noi, per quanto è possibile, dio. Quale premio per questa impresa la virtù ci promette privilegi immensi, simili a quelli divini: nessuna costrizione, nessun bisogno, libertà totale, assoluta, sicurezza, inviolabilità; non tenteremo nulla che non sia realizzabile, niente ci sarà impedito, né potrà accaderci alcunché che non sia conforme al nostro pensiero, niente di avverso, niente d’imprevisto o contro la nostra volontà. «Cosa?», mi dirai. «La virtù basta per vivere felici?». E come potrebbe non bastare, quand’è perfetta e divina? Anzi, è più che sufficiente. Che può mancare, infatti, a chi si trova fuori da ogni desiderio? Non può venirgli nulla dall’esterno, quando ha già tutto dentro di sé. «Ma chi procede verso la virtù», replicherai, «anche se ha fatto molta strada, dev’essere un po’ aiutato dalla fortuna, fintantoché si dibatte tra le vicende umane, sino a che non sciolga quel nodo e non infranga ogni legame mortale. Che differenza c’è, allora, fra costui e gli altri?». Che questi sono legati solidamente, strettamente, e anche con molti nodi, a quello, invece, che si è avviato verso una dimensione superiore, spingendosi più in alto, la catena s’è allentata: egli non è ancora libero, ma è come se lo fosse. 17. A questo punto qualcuno di quelli che abbaiano contro la filosofia verrà, come al solito, a dirmi: «Ma tu, perché parli da persona virtuosa, quando la tua vita non lo è? Perché abbassi la voce di fronte ai superiori, consideri il denaro una necessità, ti turbi se qualcosa ti va storto, piangi per la morte di tua moglie o di un amico, ti preoccupi del tuo buon nome e ti senti toccato dalle parole maligne? E perché il tuo podere produce più di quanto non richiedano i tuoi bisogni naturali? Perché i tuoi pasti non sono conformi ai tuoi insegnamenti, hai dei mobili raffinati e bevi vino più vecchio di te? Perché hai piazzato in casa un’uccelliera, piantato alberi che non danno altro che ombra, tua moglie porta appesa alle orecchie tutta l’oreficeria della tua ricca casa e i tuoi schiavetti indossano vesti preziose? Perché da te servire a tavola è un’arte, sulla mensa l’argenteria non viene disposta a caso o a piacere ma sistemata con estrema perizia, e hai persino uno scalco, preposto al taglio delle vivande?». E andando avanti di questo passo: «Perché hai delle proprietà pure al di là del mare, e così numerose che non sai nemmeno quante sono? È un’indecenza! O sei trascurato a tal punto da non conoscere neppure quei pochi schiavi che hai, o, vivendo in un lusso sfrenato, ne possiedi più di quanti la tua memoria sia capace di contenerne».15 Ebbene, io stesso, fra poco, rincarerò la dose delle accuse mossemi da quei signori, rimproverandomi più difetti di quanti essi non pensino; per ora mi limiterò a rispondere: «Non sono saggio; e, per dare ancora più esca
alla vostra malignità, aggiungo che non lo sarò mai. Non pretendete, dunque, che io sia uguale ai migliori, chiedetemi solo di essere migliore dei cattivi: è già un passo avanti se riesco a togliere ogni giorno qualcosa ai miei difetti e a biasimare i miei errori. Non sono guarito, e non guarirò: per la mia gotta più che dei toccasana preparo dei calmanti, accontentandomi di ridurre il numero degli attacchi e l’intensità del dolore, ma di fronte a voi, se misuro i miei deboli piedi con i vostri, io sono un corridore». E dico questo non per me, giacché io sono in un oceano di vizi, ma per chi ha già fatto qualcosa sulla via della virtù. 18. «Comunque», mi si replicherà, «resta il fatto che tu parli in un modo e vivi in un altro». Ebbene, questo rimprovero, o teste maligne e inimicissime delle più degne persone, è stato rivolto anche a Platone, a Epicuro e a Zenone: ma essi descrivevano non già il modo in cui vivevano bensì i precetti secondo i quali avrebbero dovuto e voluto vivere. Io non parlo di me, ma della virtù, e se grido contro i vizi mi riferisco soprattutto ai miei: quando sarò riuscito a liberarmene, vivrò come si conviene ai miei insegnamenti, dai quali non potrà allontanarmi tutta la velenosa malignità che mi gettate addosso; e neppure quella che spargete sugli altri, e con la quale uccidete voi stessi, m’impedirà di continuare a tessere l’elogio di una vita, che non è quella ch’io conduco, lo so, ma che ritengo che si debba vivere; non m’impedirà di amare la virtù e di seguirla anche strisciando e a grande distanza. Dovrei forse sperare che risparmi qualcosa questa malevolenza che non ha rispettato nemmeno la sacralità di Rutilio16 e di Catone? O preoccuparmi di sembrare troppo ricco a della gentucola per la quale persino il cinico Demetrio non è abbastanza povero? Quest’uomo rigidissimo, perennemente in lotta contro tutti i bisogni naturali, ancora più indigente degli altri cinici, perché mentre costoro si negano il possesso di qualsiasi bene materiale, egli s’è imposto anche il divieto di chiedere. E poi dicono che non è abbastanza povero! Eppure è chiaro: egli non ha professato la teoria della virtù, ma ha praticato la povertà. 19. E Diodoro?17 Il filosofo epicureo che pochi giorni fa ha troncato, di sua mano, il filo della propria esistenza? Dicono, alcuni, che non ha agito secondo i precetti del maestro, perché si è tagliato la gola; altri vogliono vedere nel suo suicidio un segno di pazzia, altri ancora un atto di temerarietà; ma lui, intanto, felice e pieno di una coscienza vigorosa e pura, ha dato una testimonianza, e non soltanto a sé stesso, nello staccarsi da questo mondo; ha lodato la calma e la serenità di una vita vissuta come in un porto e all’ancora, dicendo cose che voi avete ascoltato a denti stretti, quasiché vi avesse invitato a fare altrettanto: Sono vissuto: il ciclo che la sorte m’ha dato è compiuto. Voi disputate sulla vita dell’uno e sulla morte dell’altro e abbaiate di fronte al nome di uomini divenuti insigni per qualche lodevole merito, come fanno i
cagnolini all’avvicinarsi di persone sconosciute. La verità è che a voi fa comodo che nessuno risulti virtuoso, perché la virtù degli altri suona come un rimprovero alle vostre malefatte. Invidiosi quali siete, confrontate lo splendore morale di quelle vite con la vostra sozza materialità, e non vedete il danno che fate a voi stessi con una simile presunzione, perché se gli uomini virtuosi sono degli avari, dei dissoluti e degli ambiziosi, cosa sarete voi, che avete in odio persino il nome di virtù? Proclamate che nessuno, di quelli che voi accusate, mette in pratica ciò che dice, né vive secondo il modello che va predicando: ma c’è già da meravigliarsi che vi siano al mondo delle persone così coraggiose, che parlano di cose tanto straordinarie, tali da sottrarsi a tutte le tempeste della vita. Anche se non riescono a staccarsi dalle loro croci, quelle croci in cui ciascuno conficca di propria mano i suoi chiodi, perlomeno, una volta giunti alla morte, pendono ognuno da un solo palo, mentre voi, che badate soltanto a voi stessi, siete lacerati da tante croci quante sono le vostre passioni. Siete dei maldicenti, bravi solo a offendere gli altri. Gente come voi potrei anche crederla priva di questo vezzo, se non ce ne fossero alcuni che persino mentre pendono dalla forca lanciano sputi sugli spettatori. 20. I filosofi, dunque, predicano bene e razzolano male: così cianciate voi. E invece fanno già molto, proprio perché certe cose perlomeno le dicono, e concepiscono pensieri di virtù e di onestà; se poi agissero in piena conformità dei loro insegnamenti quale uomo potrebbe essere più felice di loro? Intanto, non c’è motivo di disprezzare le buone parole e gli animi ricchi di pensieri virtuosi, e poi il coltivare salutari inclinazioni è di per sé lodevole, indipendentemente dai risultati che si possono conseguire. Forse che ci meravigliamo se non giunge sino alla vetta chi s’è incamminato lungo una dura salita? Se siamo uomini non possiamo non ammirare coloro che han posto mano a degne imprese, anche se poi cadono senza toccare la meta. È di un animo nobile tentare, guardando non alle sue forze personali ma ai poteri della propria natura, mirare in alto e concepire azioni superiori anche a quelle che possono compiere delle persone eccezionalmente dotate. Ci sono uomini che si sono proposti questi obiettivi: «Guarderò la morte con lo stesso volto con cui ne sento parlare. Mi assoggetterò a qualunque fatica, sostenendo il corpo con l’animo. Disprezzerò le ricchezze, ch’io le possieda o no, né mi dorrò per il fatto che le abbiano altri o monterò in superbia se mai mi splendessero intorno. Non darò peso alla fortuna, sia che m’assista, sia che m’abbandoni. Guarderò tutte le terre del mondo come se fossero mie e le mie come se appartenessero all’intera umanità. Vivrò con la convinzione di essere nato per gli altri, ricambiando così la natura per avermi generato: quale dono più grande, infatti, avrebbe potuto farmi? Ha donato me solo a tutti gli altri, e tutti gli altri a me solo. Non sarò né un tirchio né uno spendaccione, farò conto di non possedere niente di più di quanto avrò opportunamente donato, e i beni che dispenserò non li giudicherò dal numero o dal peso ma in base alla mia stima per chi li riceverà; non riterrò mai troppo
grande il dono che farò a una persona degna. In ogni mia azione non seguirò l’opinione degli altri ma soltanto la mia coscienza, e anche se ne sarò consapevole io solo mi comporterò come se agissi al cospetto del mondo. Nel mangiare e nel bere perseguirò l’unico scopo di soddisfare i miei bisogni naturali, non quello di riempirmi e di svuotarmi lo stomaco; sarò amabile con gli amici, mite e indulgente con i nemici, e quando qualcuno starà per chiedermi qualcosa di onesto lo preverrò, per non metterlo nelle condizioni di dovermi pregare. Conoscerò come mia patria il mondo, gli dèi come mia guida, sempre al di sopra e intorno a me, censori d’ogni mio gesto e d’ogni mia parola, e quando la natura vorrà riprendersi il mio soffio vitale, anche armando la mano alla ragione, me ne andrò via di qui, testimoniando di avere sempre amato la retta coscienza e i nobili propositi, di non avere mai diminuito la libertà di alcuno, e tanto meno la mia». Chi si prefiggerà tutto questo, e si sforzerà di metterlo in atto con viva determinazione, salirà verso il regno degli dèi, e, quand’anche fallisse la meta, si potrà dire di lui: è tuttavia caduto nell’osare una nobile impresa.18 Ma voi, col pretesto che odiate la virtù e coloro che la coltivano, non fate niente d’insolito, niente che si levi al di sopra dell’ordinario, simili agli occhi malati che temono la luce del sole o agli animali notturni che aborrono lo splendore del giorno e al primo chiarore dell’alba, abbagliati e storditi, corrono disordinatamente verso le loro tane o s’infilano in qualche fessura, tanto sono spaventati dalla luce. Ringhiate pure, esercitate la vostra sterile lingua nel calunniare le persone dabbene, spalancate la bocca, mordete: vi spezzerete i denti, senza poterle nemmeno scalfire. 21. «Come mai quel tale», così dirà ancora qualcuno, «si professa filosofo e vive da riccone? Perché proclama che si deve disprezzare il denaro e gli altri beni materiali, e tuttavia non se ne disfa? Persino la vita detesta, ma intanto non s’è ancora ammazzato. E perché va gridando ai quattro venti che non bisogna curarsi della salute e poi invece le mostra ogni riguardo e la vuole persino eccellente? Definisce l’esilio un vuoto nome, sostiene che non è una disgrazia cambiare nazione, ma fa di tutto per invecchiare nel suo paesello. E mentre dichiara, da un lato, che non gl’importa un fico se campa un solo giorno oppure un secolo, dall’altro, se non gli piglia un colpo, si allunga l’esistenza più che può, mantenendosi arzillo e beato magari sino a cent’anni». Ora, è vero che il filosofo dice che tutte queste cose si debbono disprezzare, ma non nel senso che siano da rifiutarsi a priori, bensì nel senso che, pur possedendole, non bisogna lasciarsi influenzare da loro; egli, insomma, non le respinge, ma, sia che vengano, sia che se ne vadano, le guarda con distacco. D’altronde è proprio qui che la fortuna può mettere più al sicuro i propri doni, presso uno da cui sa che potrà riprenderseli senza riceverne querele e maledizioni. Marco Catone, al
tempo in cui tesseva le lodi di Curio e di Coruncanio,19 e di quando avere poche lamine d’argento era un crimine punito dai censori,20 possedeva personalmente una ricchezza di quattro milioni di sesterzi, inferiore senz’altro a quella di Crasso, ma superiore a quella di Catone il Censore.21 Per fare un paragone, aveva distanziato il suo bisnonno più di quanto Crasso non distanziasse lui, e se gli fossero piovute ancora altre ricchezze non le avrebbe rifiutate. Il saggio, infatti, non si reputa indegno dei doni della fortuna e quanto alle ricchezze accetta di averle ma non le ama, esse non entrano nel suo animo, gli stanno solo intorno: le tiene, sì, ma per dominarle, e perché possano fornire una più ricca materia e un più vasto campo alla sua virtù. 22. È chiaro, infatti, che il saggio ha maggiori e più valide possibilità di sperimentare il suo animo nella ricchezza che non nella povertà, giacché in questa si esercita un solo tipo di virtù, la sopportazione, mentre nella ricchezza possono esplicarsi, in una sfera più ampia, anche altre qualità, come la temperanza, la liberalità, l’accortezza, la capacità d’imporsi delle regole, la magnificenza. Il saggio non si duole né si disprezza se è di bassa statura, ma al tempo stesso ritiene preferibile, anche per sé, essere alti; così, se è magro o privo di un occhio non dà importanza alla cosa, e tuttavia vorrebbe un corpo robusto, sempre però tenendo presente ch’esistono doti molto più importanti. Allo stesso modo accetterà una cattiva salute, ma non per questo dovrà negarsi il desiderio di stare in perfetta forma. Certe cose, infatti, anche se in rapporto all’insieme hanno scarso valore e possono venire a mancare senza che il bene principale vada in rovina, sono sempre un quid in più, rispetto a quella gioia duratura che nasce dalla virtù: i beni materiali rasserenano il saggio e gli procurano la stessa sensazione che un venticello leggero e propizio arreca al marinaio durante la navigazione, o quella che possono darci una bella giornata o un luogo soleggiato nel freddo e rigido inverno. E poi nessuno dei saggi (parlo dei nostri, che stimano quale unico bene la virtù) nega che anche le cose che chiamiamo “indifferenti” abbiano in sé dei pregi, in una loro scala di valori, in base alla quale da alcune si ricava poco onore, da altre, invece, molto. Perciò non sbaglierai se porrai le ricchezze fra le cose da preferire. «E perché allora mi deridi», obietterai, «visto che tu le tieni nella stessa considerazione in cui le tengo io?». Non è la stessa, e te lo dimostro subito: a me, se se ne andranno, non porteranno via niente, tu, invece, se ti lasceranno, resterai sbalordito, quasiché fossi stato privato di te stesso. Le ricchezze per me occupano solo un posto, nella vita, uno qualunque, per te quello più alto; io le possiedo, tu ne sei posseduto. 23. Smettila, dunque, di negare ai filosofi il diritto di possedere denaro: nessuno ha condannato la saggezza alla povertà, anche il filosofo può avere grandi ricchezze, quando queste non siano state rubate, non grondino di sangue altrui e il loro acquisto non abbia fatto torto ad alcuno, non provengano da ignobili speculazioni e le uscite siano tanto oneste quanto lo sono state le entrate,
sì che nessuno, tranne gl’invidiosi, abbia motivo di criticare. Ammassane perciò quante ne vuoi: sono pulite. Sono pulite perché, per quante ognuno voglia averne per sé, non c’è fra esse un solo granello che possa dirsi suo. E perché poi il filosofo dovrebbe allontanare da sé la benevolenza della fortuna? Né egli si farà vanto o arrossirà di un patrimonio acquisito onestamente; avrà un solo motivo per gloriarsene, se, spalancata la sua casa e chiamata a raccolta tutta la città davanti alle sue ricchezze, potrà dire senza timore: «Se qualcuno vi riconosce qualcosa di suo, lo prenda pure». O uomo degno e giustamente ricco chi, dopo tale invito, manterrà intatti i suoi averi! Intendo dire: se il saggio potrà sottoporsi a un simile esame da parte di tutto il popolo con la coscienza tranquilla e sicura, se nessuno troverà presso di lui un solo spillo su cui mettere le mani, allora egli sarà ricco, orgogliosamente e davanti agli occhi di tutti. Il saggio non farà mai passare dalla sua soglia un solo soldo di provenienza sospetta, ma al tempo stesso non rifiuterà né scaccerà ricchezze anche cospicue, se sono dono della fortuna o frutto della virtù. E per quale motivo dovrebbe negare loro un posto onorevole? Ben vengano, e siano accolte in qualità di ospiti. Il saggio non se ne vanterà né le nasconderà (nel primo caso si comporterebbe come uno sciocco, nel secondo come un timido e un pusillanime, che si tiene stretti al seno i suoi averi quasi che fossero un gran bene), e neppure, ripeto, le caccerà di casa. Potrebbe forse dir loro: «Voi siete inutili», o: «Io non so servirmi delle ricchezze»? Come, pur potendo andare a piedi, preferisce viaggiare sopra un carro, così, se da povero potrà diventare ricco, non si tirerà indietro; ma si terrà le sue ricchezze quali beni leggeri e pronti sempre a volarsene via, né lascerà che esse costituiscano un peso, per sé stesso o per gli altri. Donerà (ma non drizzate le orecchie e non aprite la vostra borsa), donerà ai buoni, o a quelli che potranno diventarlo, scegliendo i più degni con la massima oculatezza e ricordandosi che si deve rendere conto sia delle entrate che delle uscite; donerà per motivi onesti e plausibili, perché un dono sbagliato è un inutile spreco, e avrà la borsa pronta e disponibile, ma non bucata, dalla quale esca molto, e niente scivoli via. 24. Donare22 non è facile, e chi pensa che lo sia sbaglia di grosso: quel gesto, infatti, presenta molte difficoltà, almeno quando lo si compia non a casaccio o impulsivamente, bensì a proposito e col dovuto discernimento. A uno doneremo per farcelo amico, a un altro per restituirgli un favore, a un altro ancora per soccorrerlo; a questo per compassione, a quello perché merita di non perdersi tra i morsi della fame; ad alcuni invece non daremo nulla, anche se si trovano in ristrettezze, per il semplice fatto che se li aiutassimo non muoverebbero un dito per tirarsene fuori da sé; a certuni ci limiteremo a offrire, ad altri, addirittura, imporremo di accettare. Non si può agire con disinvoltura in questa faccenda, perché quello di donare è il nostro migliore investimento. «Tu, allora, doni per ricevere?», mi obietterà qualcuno. No, dono per non perdere. Il beneficio vada a persone meritevoli e sicure, a cui poi non debba essere
rinfacciato, ma da cui possa essere ricambiato; sia depositato come un tesoro seppellito a grande profondità, che non viene dissotterrato se non in caso di necessità. Ma poi, anche la casa di un uomo ricco quante possibilità offre, essa stessa, di fare del bene! Perché, infatti, essere liberali soltanto con persone di ceto elevato? La natura ci comanda di giovare agli uomini, siano essi liberi o schiavi, nobili o affrancati, né importa se la loro libertà sia riconosciuta dalla legge o ottenuta per ragioni di amicizia: dovunque c’è un uomo, lì c’è l’occasione per fare del bene. Non occorre uscire di casa per elargire denaro: anche dentro le mura domestiche si può esercitare la liberalità, la quale è chiamata così non perché sia indirizzata a individui liberi ma perché libero è l’animo di colui che la pratica. E quella del saggio non si volge mai verso gl’immeritevoli o i malvagi, né mai si sente tanto stanca da non tornare a profondere, come se avesse ancora la borsa piena, ogni volta che incontra una persona degna. Non fraintendete, quindi, ciò che dicono i filosofi, le loro sono parole oneste, forti e appassionate. E soprattutto vi sia ben chiaro questo: altro è aspirare alla saggezza, altro il possederla. Nel primo caso diremo: «Io parlo bene, ma mi dibatto ancora in mezzo a molti difetti: non giudicatemi, dunque, in base alla regola che mi sono imposto, perché mi trovo solo sulla strada, verso quel nobilissimo modello a cui tendo con tutte le mie forze. Se sarò andato avanti in questo processo tanto quanto mi sono proposto, allora sì potrete pretendere che i fatti corrispondano alle mie parole». Se invece avremo raggiunto il culmine di questo nostro bene, ci comporteremo diversamente, e diremo: «Innanzitutto non permettetevi di giudicare chi è migliore di voi: il fatto che io dispiaccia ai disonesti è già una prova della mia onestà. Se poi volete che vi dia una spiegazione, che non nego mai a nessuno, ascoltate bene ciò che sto per dirvi e quanto stimo le cose. Io non sostengo che le ricchezze siano un bene, per il semplice motivo che se lo fossero renderebbero buoni gli uomini, e perché mi rifiuto di definire bene ciò che si trova anche in mano di persone cattive. Dico però che il possesso delle ricchezze è legittimo, perché esse sono utili e apportano alla vita grandi vantaggi». 25. «Visto, dunque, che siamo tutti d’accordo sul fatto che le ricchezze si debbano possedere, sentite perché io non le considero un bene e perché nei loro confronti mi comporto diversamente da voi. Mettetemi in una casa straricca, dove anche gli oggetti d’uso comune siano d’oro e d’argento: non monterò in superbia per codesta roba, che, pur essendo in casa mia, mi è tuttavia estranea. Da lì portatemi sul ponte Sublicio23 e gettatemi in mezzo agli straccioni: non per questo mi farò schifo, per il fatto, cioè, di starmene seduto fra coloro che stendono la mano per l’elemosina. Che importa, infatti, di fronte alla morte, poiché tutti dobbiamo morire, se mi manca un pezzo di pane? Ciò però non m’impedisce di preferire a un ponte una ricca casa. Mettetemi in mezzo a mobili lussuosi e fra gli agi più raffinati: non mi riterrò più felice perché ho un cuscino morbido o faccio distendere i miei convitati su tessuti di porpora. Cambiate ora
il mio letto: non sarò certo più misero perché il corpo stanco riposa su un mucchio di fieno o su un pagliericcio da circo che perde l’imbottitura dai rattoppi della vecchia tela. Nondimeno preferisco esprimere i miei sentimenti e i miei pensieri con indosso la toga pretesta piuttosto che con le spalle scoperte. Così, se i giorni passassero secondo i miei desideri, apportandomi sempre nuove soddisfazioni e riconoscimenti, non per questo mi compiacerò di me stesso. Rovesciate adesso la situazione e da un tempo così benevolo trasportatemi in un altro, in cui il mio animo sia circondato e tormentato da lutti e da ogni genere di avversità, e non vi sia un momento di tregua ai miei lamenti: ebbene, anche nella più nera miseria non mi dirò infelice, non maledirò nessuno dei miei giorni, perché ho già preso le mie precauzioni, ho già disposto il mio animo in modo che non vi siano giornate nere per me. Con ciò preferisco moderare le mie gioie piuttosto che dover placare i miei dolori». Il grande Socrate dirà: «Immaginate ch’io abbia sottomesso il mondo intero, che il raffinato carro di Libero mi trasporti in trionfo da Oriente sino a Tebe e che ogni re ricorra al mio giudizio: ebbene, soprattutto allora continuerei a ritenermi un uomo, quando da ogni parte mi salutassero come un dio. Ribaltate ora le cose e da una tale altezza precipitatemi nel più profondo abisso: mettetemi sopra una lettiga, come un prigioniero, per abbellire il trionfo di un vincitore superbo e fiero: non mi sentirò più umile dietro un carro altrui di quanto non lo fossi quando stavo sul mio. Con ciò preferisco vincere piuttosto che essere catturato. Disprezzerò l’intero regno della fortuna, ma da lì, se mi sarà dato di scegliere, prenderò il meglio. Qualunque cosa mi toccherà sarà benvenuta per me, ma preferisco trovarmi in situazioni favorevoli e più liete, o che meno possano molestarmi nell’affrontarle. Non ci sono virtù che non comportino uno sforzo, ma alcune hanno bisogno di sprone, altre di freno. Come il corpo se va lungo un pendio dev’essere trattenuto e lungo un’erta, invece, sollecitato, così è delle virtù, alcune vanno in discesa, altre in salita. Chi potrebbe infatti dubitare che salgano, si sforzino e lottino, la pazienza, la fortezza, la perseveranza e tutte le altre virtù che si oppongono alle avversità e dominano la fortuna? E d’altra parte non è altrettanto evidente che la liberalità, la moderazione e la bontà procedono come in discesa? In queste freniamo l’animo affinché non scivoli, in quelle l’esortiamo e l’incitiamo energicamente. Quindi, per la povertà ci serviremo di quelle virtù che essendo più forti sanno combattere, per la ricchezza di quelle più accorte, che camminano a passi brevi, sorreggendo il loro carico. Stando così le cose, preferisco avere quelle virtù che si possono praticare con maggiore tranquillità, che non quelle il cui esercizio costa sudore e sangue. In definitiva – conclude il saggio – non è ch’io viva diversamente da come parlo, è che voi fraintendete quello che dico, perché alle vostre orecchie arriva solo il suono delle parole, ma quanto al loro significato non vi date neppure la pena di cercarlo». 26. «Ma allora», mi obietterete, «che differenza c’è fra uno stolto e un sapiente, se sia l’uno che l’altro aspirano al possesso di beni materiali?». Una
differenza enorme: il sapiente, infatti, tiene le ricchezze presso di sé come sue schiave, lo stolto, invece, come sue padrone;24 al saggio esse non danno praticamente nulla, mentre a voi permettono tutto; voi vi ci attaccate e vi ci abituate come se qualcuno ve ne avesse assicurato il possesso in eterno, il saggio soprattutto allora pensa alla povertà, quando si trova in mezzo alla ricchezza. Nessun generale confida tanto nella pace da non prepararsi alla guerra, quando questa, se non ancora in atto, è tuttavia nell’aria; voi, invece, vi fate arroganti perché avete una bella casa, come se questa non potesse mai prendere fuoco o crollare, e restate abbagliati di fronte alle ricchezze come se queste fossero esenti da ogni pericolo e al di sopra della stessa fortuna, quasi che questa non avesse forze bastanti a distruggerle. E giocate con loro, oziosamente, incuranti dei rischi, come certi barbari quando, assediati dai nemici, ignari delle macchine da guerra, stanno lì a contemplare, senza muovere un dito, gli sforzi degli assedianti, non comprendendo a che servano quelle apparecchiature che vedono innalzarsi da lontano. Così capita a voi: marcite in mezzo ai vostri averi e non pensate agli accidenti numerosi e improvvisi che vi sovrastano, pronti a rubarvi quel prezioso bottino. Il saggio, invece, potrà perdere tutte le ricchezze, ma i beni suoi gli rimarranno:25 egli sa vivere, infatti, solo di ciò che possiede al momento, con animo lieto e senza alcuna preoccupazione del suo futuro. «Non c’è in me volontà più decisa», direbbe il grande Socrate (e con lui chiunque abbia un tale privilegio e un tale potere di fronte alle cose umane), «che quella di non piegare alle vostre opinioni alcun atto della mia vita. Assediatemi pure da ogni parte con le solite punzecchiature: per me non sono che vagiti di poveri neonati». Così parla l’uomo saggio, il cui animo è privo di vizi e si sente spinto a rimproverare gli altri non per odio ma perché vuole correggerli. E aggiunge: «I vostri apprezzamenti mi toccano non per me ma per voi stessi, perché l’astio e gl’insulti che lanciate alla virtù vi tolgono ogni possibilità di conseguire qualcosa di buono. Voi non mi fate alcuna offesa, così come non ledono gli dèi coloro che ne abbattono gli altari. E però, anche se non possono nuocere, il cattivo proposito e il disegno perverso sono comunque visibili. E io sopporto i vostri vaneggiamenti come Giove Ottimo Massimo le fantasie dei poeti, che ora lo raffigurano con le ali,26 ora lo descrivono come un adultero che passa le notti fuori di casa, ora lo dicono crudele verso gli dèi, ingiusto con gli uomini, sequestratore di poveri mortali e magari di parenti, o addirittura parricida e usurpatore del regno paterno; fantasie che, col far credere un simile comportamento da parte degli dèi, hanno spento negli uomini il senso del peccato. Ora, per quanto i vostri deliri non mi tocchino minimamente, nel vostro interesse vi dico: abbiate rispetto per la virtù, credete a chi, dopo averla seguita a lungo, proclama di andar dietro a qualcosa di grande e che di giorno in giorno cresce sempre di più; veneratela, come si venerano gli dèi, unitamente a coloro che la professano quali suoi sacerdoti, e ogni volta che sentite nominare i testi sacri favete linguis.27 Con questa espressione non s’intende – come credono i più – domandare un favore, ma solo imporre il silenzio, affinché la cerimonia
sacra possa compiersi secondo il rituale e senza che alcuna voce profana la disturbi; questo vale soprattutto per voi, perché ascoltiate attenti e a bocca chiusa tutto ciò che l’oracolo in quell’occasione proclamerà. Quando uno sconosciuto va gridando menzogne dietro comando, agitando un sistro, quando un imbroglione, esperto nel ferirsi le membra, s’insanguina con mano accorta e leggera le braccia e le spalle, quando una donna, strisciando sulle ginocchia lungo la via, urla come un’ossessa, oppure un vecchio, coperto di lino e coronato di alloro, e con in mano una lucerna in pieno giorno, grida che qualche dio è adirato con noi, allora, sì, voi correte a frotte ad ascoltare, e, passando di stupore in stupore, giurate che quella tale persona è ispirata dagli dèi». 27. Guardate ora Socrate, che da quella sua prigione, purificata dalla sua presenza e resa più onorevole di qualsiasi senato, proclama: «Quale pazzia, quale impulso, ostile agli uomini e agli dèi, vi spinge a calunniare la virtù e a profanare le cose sacre con discorsi malevoli? Se ne siete capaci, lodate i buoni, altrimenti smettetela. Se poi vi piace esercitare codesta vostra vergognosa licenza, azzuffatevi fra di voi. Quando scagliate contro il cielo le vostre folli bestemmie, più che commettere un sacrilegio, perdete il vostro tempo. Una volta fui oggetto di scherno da parte di Aristofane, 28 e tutta quella banda di poeti comici mi rovesciò addosso i suoi lazzi velenosi; ma la mia virtù ha ricevuto più luce proprio in grazia di quelle frecciate che pretendevano di colpirla, giacché l’essere messa alla prova davanti agli occhi di tutti lungi dal danneggiarla le ha giovato, e nessuno ne ha compreso la grandezza più di quelli che, attaccandola, ne hanno sentito la forza: chi, infatti, conosce la durezza della selce meglio dei tagliapietre che la lavorano? Io sono come una roccia piantata in una secca, che i marosi flagellano incessantemente da tutte le parti senza però riuscire a smuoverla o a intaccarla coi loro assalti continui nel lungo corso dei secoli. Saltatemi pure addosso, gettate su di me tutta la vostra furia: vi vincerò sopportandovi. Tutto ciò che si scaglia contro ostacoli saldi e inespugnabili fa uso della forza a proprio danno: cercate dunque un bersaglio facile e malleabile per configgervi le vostre frecce. Vi piace ficcare il naso nei difetti altrui e sputar sentenze su tutti: “Perché questo filosofo ha una casa tanto grande? Perché quest’altro offre pranzi così sontuosi?”. Osservate i foruncoli degli altri, mentre voi siete tutta una piaga. È come se uno, divorato da una terribile scabbia, deridesse i nei o le verruche che si trovano su uno splendido corpo. Rinfacciate a Platone di aver cercato denaro, ad Aristotele di averlo accettato, a Democrito di averlo trascurato, a Epicuro di averlo sperperato;29 a me rinfacciate pure il comportamento di Alcibiade e di Fedro. 30 Ma il colmo della vostra felicità sarebbe l’imitare, se mai fosse possibile, i miei vizi. Perché, piuttosto, non badate ai vostri mali, che vi affollano da tutte le parti, quali infierendo dall’esterno, quali bruciandovi dentro, fin nel profondo? La condizione umana – anche se a voi risulta poco chiaro il vostro stato – non è così durevole da lasciarvi tempo sufficiente per agitare la lingua, insolentendo i buoni.
28. Ma tutto questo voi non lo capite, e mostrate un atteggiamento che contrasta con la vostra reale situazione, simili a quella gente che se la spassa nel circo o nel teatro e non sa che frattanto in casa sua è accaduta una disgrazia. Ma io, che guardo le cose dall’alto, vedo quali tempeste vi sovrastano, pronte a vomitare su di voi il loro cumulo oscuro, o, fattesi ancora più vicine, stanno ormai per travolgervi con tutti i vostri averi. Ma che dico? Già in questo momento, per poco che lo sentiate, un turbine fa girare le vostre anime, che cercano di scappare e tuttavia continuano a desiderare quegli stessi vani piaceri, e ora le solleva verso il cielo, ora le scaraventa nell’abisso»…
1. Gallione è Annèo Novato, il fratello maggiore di Seneca, così chiamato dal nome del retore Giunio Gallione, da cui venne adottato. Stazio lo definisce l’uomo più pacifico e più paziente del mondo. Fu proconsole d’Acaia dal 51 al 53 (come si legge in un’iscrizione di Delfi). Sotto di lui, a Corinto, i Giudei si sollevarono contro San Paolo e lo trascinarono in tribunale. Gallione lo difese, dicendo: «Se avesse commesso qualche ingiustizia o qualche grave misfatto, o Giudei, potrei anche ascoltarvi, ma trattandosi di questioni di parole, di nome e della vostra Legge, pensateci voi: io non voglio essere giudice di tali cose». Fu fatto assassinare da Nerone nel 65. 2. La clamide potrebbe qui essere riferita ai semplici soldati, la corona ai trionfatori. 3. La mancanza di ammirazione di cui parla Seneca è la athaumastia della filosofia stoica. Oltre a Democrito e a Eraclito, ne fa cenno Orazio in Epist. I 6, 1: Nihil admirari prope res est una, Numici, / solaque quae possit facere et servare beatum: «Non stupirsi di niente è forse il solo mezzo, Numicio, a renderci felici». 4. Anche nel De ira (I 3, 6) Seneca esprime lo stesso concetto: Muta animalia humanis affectibus carent; habent autem similes illis quosdam impulsus: gli animali, privi della parola, difettano anche dei sentimenti, che sono propri degli esseri umani, ma hanno certi istinti che gli somigliano. 5. Il tipo di piacere che qui Seneca combatte, più che di Epicuro, è quello di Aristippo, filosofo di Cirene, per il quale il piacere e l’assenza di bisogni dovevano accompagnarsi a una grande serenità di spirito. Di lui sappiamo che fu della cerchia di Socrate, assimilato ai sofisti perché dava lezioni dietro ricompensa. Ne parla Platone, nel Teeteto e nel Filebo, sottolineandone l’arguzia e la raffinatezza, nonché Senofonte, nei Memorabili, e Orazio, in Sat. I 3, 100 e in Epist. I 1, 18; 17, 14, 17, 23: «Aristippo, pur aspirando al meglio si adattava» (è un po’ quello che Seneca dice del saggio). 6. È quanto dice Cicerone di Epicuro: Clamat Epicurus… non posse iucunde vivi nisi sapienter honeste iusteque vivatur, nec sapienter honeste iuste nisi iucunde (De finibus, I 18). 7. Cicerone chiama il piacere invidiosum, infame, suspectum anche solo nel nome (De finibus, III 4). 8. Per gli epicurei il ventre era la sede o il punto di diramazione di tutti i piaceri. 9. Arroganza e superbia erano i vizi attribuiti agli epicurei. 10. Nomentano è forse lo stesso personaggio di cui parla Orazio in Sat. I 1, 102, e I 8, 11. Apicio fu un famoso esperto d’arte culinaria, noto per la sua ghiottoneria, vissuto sotto Tiberio. Lo stesso Seneca narra che si uccise perché, avendo dissipato in gozzoviglie il suo patrimonio, pur rimanendogliene ancora gran parte, fu preso dal timore di morire di fame. Scrisse un trattato, De re coquinaria, ricettario in 10 libri, una specie di «Artusi». Celebre la “salsa A”, di cui si ignorano gl’ingredienti. 11. Il tamburello era il simbolo dei Galli, sacerdoti di Cibele: perlopiù evirati, indossavano abiti femminili. 12. La citazione è di Virgilio, qui riprodotta non esattamente. 13. Per la dedizione del saggio verso gli amici si veda Orazio, Carm. IV 9, 51 sgg.: non ille pro caris amicis/aut patria timidus perire. 14. È un’antica massima stoica.
15. Delle ricchezze di Seneca parlano anche Tacito (Ann. XIII 42) e Dione Cassio (LXI 10). 16. Rutilio Rufo, condannato all’esilio, richiamato in patria da Silla, rifiutò sdegnosamente di ritornarvi. Demetrio è un filosofo cinico, citato spesso da Seneca. 17. Diodoro era un filosofo epicureo di cui non abbiamo notizie. «Sono vissuto…»: sono le parole pronunciate da Didone in punto di morte (En., IV, 653); il verso è citato anche nel De beneficiis (V 17) e nelle Epistulae ad Lucilium (VII 9). 18. Gli stoici ammettevano il suicidio. La citazione è di Ovidio (Metam. II 328). 19. Curio Dentato e Tiberio Coruncanio, l’uno vincitore dei Sanniti, dei Sabini e di Pirro, l’altro il primo pontefice di origine plebea, erano due esempi di frugalità e di virtù patrie. 20. La notizia secondo cui era una colpa possedere poche lamine d’argento si trova anche in Ovidio (Metam. I 85: et levis argenti crimen erat). 21. Di Catone il Censore (243-149 a.C.) sono note l’integrità morale e la lotta contro l’introduzione in Roma dei molli costumi dei Greci. Era il bisnonno di Catone l’Uticense. 22. Il tema delle donazioni è trattato diffusamente nel De beneficiis. Anche Tacito parla della generosità di Seneca, e Giovenale ne sottolinea la delicatezza: Nemo petit modicis quae mittebantur amicis a Seneca: «Nessuno dovette mai chiedere a Seneca ciò ch’egli donava agli amici di modeste condizioni», nel senso che donava senza darne notizia agli altri (come accenna anche nel De beneficiis). 23. Il ponte Sublicio, il più antico di Roma, era pieno di mendicanti, come apprendiamo anche da Giovenale che nella satira quinta (vv. 6 sgg.) ce li presenta seduti sopra una stuoia lungo il parapetto del ponte, nell’atto di stendere la mano ai passanti. 24.Imperat aut servit collecta pecunia cuique: così Orazio in Epist. I 10, 47. 25. Allusione, forse, a Stilpone di Megara, a cui Seneca, nel De constantia sapientis, V 6 attribuisce le famose parole: Omnia mea mecum porto: «Tutto quello che ho lo porto con me». 26. Allusione ai miti di Leda e di Europa, amate e possedute da Zeus sotto le spoglie di un cigno e di un toro, nonché a quello di Ganimede, che il dio rapì nelle vesti di un’aquila. 27. L’espressione favete linguis si trova anche in Orazio, Carm. III 1, 2. 28. Si riferisce alle Nuvole di Aristofane (450-385), il più grande commediografo dell’antichità, in cui Socrate viene preso in giro. Anche Eupoli derise il filosofo. 29. Le notizie sull’atteggiamento di Platone, Aristotele, Democrito ed Epicuro di fronte al denaro, si trovano in Diogene Laerzio. Quanto a Democrito ne parla Seneca stesso nel De providentia, VI 2. 30. Allude all’amore fra giovinetti, da cui, stando a Dione, non sarebbe stato immune nemmeno Seneca, che anche in questo, anzi, avrebbe fatto da maestro a Nerone.
De tranquillitate animi
1. SERENUS Inquirenti mihi in me quaedam vitia apparebant, Seneca, in aperto posita, quae manu prehenderem, quaedam obscuria et in recessu, quaedam non continua, sed ex intervallis redeuntia, quae vel molestissima dixerim, ut hostes vagos et ex occasionibus assilientes, per quos neutrum licet, nec tamquam in bello pratum esse nec tamquam in pace securum. Illum tamen habitum in me maxime deprehendo (quare enim non verum ut medico fatear?), nec bona fide liberatum me iis quae timebam et odeam, nec rursus obnoxium. In statu ut non pessimo, ita maxime querulo et moroso positus sum: nec aegroto nec valeo. Non est quod dicas omnium virtutum tenera esse principia, tempore illis duramentum et robur accedere. Non ignoro etiam quae in speciem, laborant, dignitatem dico et eloquentiae famam et quicquid ad alienum suffragium venit, mora convalescere: et quae veras vires parant et quae ad placendum fuco quodam subornantur exspectant annos donec paulatim colorem diuturnitas ducat. Sed ego vereor ne consuetudo, quae rebus affert costantiam, hoc vitium mihi altius figat: tam malorum quam bonorum longa conversatio amorem induit. Haec animi inter utrumque dubii, nec ad recta fortiter nec ad prava vergentis, infirmitas qualis sit, non tam semel tibi possum quam per partes ostendere. Dicam quae accidant mihi; tu morbo nomen invenies. Tenet me summus amor parsimoniae, fateor: placet non in ambitionem cubile compositum, non ex arcula prolata vestis, non ponderibus ac mille tormentis splendere cogentibus expressa, sed domestica et vilis, nec servata nec sumenda sollicite; placet cibus quem nec parent familiae nec spectent, non ante multos imperatus dies nec multorum manibus ministratus, sed parabilis facilisque, nihil habens arcessiti pretiosive, ubilibet non defuturus, nec patrimonio nec corpori gravis, non rediturus qua intraverit; placet minister incultus et rudis vernula, argentum grave rustici patris sine ullo nomine artificis, et mensa non varietate macularum conspicua nec per multas dominorum elegantium successiones civitati nota, sed in usum posita, quae nullius convivae oculos nec voluptate moretur nec accendat invidia. Cum bene ista placuerunt, praestringit animum apparatus alicuius paedagogii, diligentius quam in tralatu vestita et auro culta mancipia et agmen servorum nitentium, iam domus etiam qua calcatur pretiosa et, divitiis per omnes angulos dissipatis, tecta ipsa fulgentia, et assectator comesque patrimoniorum pereuntium populus. Quid perlucentes ad imum aquas et circumfluentes ipsa convivia, quid epulas loquar scaena sua dignas? Circumfudit me ex longo frugalitatis situ venientem multo splendore luxuria et undique circumsonuit: paulum titubat acies, facilius adversus illam animum quam oculos attollo; recedo itaque non peior, sed tristior, nec inter illa frivola mea tam altus incedo, tacitusque morsus subit et dubitatio numquid illa meliora sint. Nihil horum me mutat nihil tamen non concutit. Placet vim praeceptorum sequi et in mediam ire rem publicam; placet honores fascesque non
scilicet purpura aut virgis abductum capessere, sed ut amicis propinquisque et omnibus civibus, omnibus deinde mortalibus paratior utiliorque sim: promptus, imperitus, sequor Zenona, Cleanthen, Chrysippum, quorum tamen nemo ad rem publicam accessit, et nemo non misit. Ubi aliquid animum insolitum arietari percussit, ubi aliquid occurrit aut indignum, ut in omni vita humana multa sunt, aut parum ex facili fluens, aut multum temporis res non magno aestimandae poposcerunt, ad otium convertor, et, quemadmodum pecoribus, fatigatis quoque, velocior domum gradus est. Placet intra parietes rursus vitam coercere: nemo ullum auferat diem, nihil dignum tanto impendio redditurus; sibi ipse animus haerat, se colat, nihil alieni agat, nihil quod ad iudicem spectet; ametur expers publicae privataeque curae tranquillitas. Sed, ubi lectio fortior erexit animum et aculeos subdiderunt exempla nobilia, prosilire libet in forum, commodare alteri vocem, alteri operam, etiam si nihil profuturam, tamen conaturam prodessem alicuius coercere in foro superbiam male secundis rebus elati. In studiis puto mehercules melius esse res ipsas intueri et harum causa loqui, ceterum verba rebus permittere, ut qua duxerint, hac inelaborata sequatur oratio. Quid opus est saeculis duratura componere? Vis tu non id agere ne te posteri taceant! Morti natus es: minus molestiarum habet funus tacitum. Itaque occupandi temporis causa in usum tuum, non in praeconium, aliquid simplici stilo scribe: minore labore opus est studentibus in diem. Rursus, ubi se animus cogitationum magnitudine levavit, ambitiosus in verba est altiusque ut spirare, ita eloqui gestit, et ad dignitatem rerut exit oratio. Oblitus tum legis pressiorisque iudicii, sublimius feror et ore iam non meo. Ne singula diutius persequar, in omnibus rebus haec me sequitur bonae mentis infimitas, cui ne paulatim defluam vereor, aut, quod est sollicitius, ne semper casuro similis pendeam et plus fortasse sit quam quod ipse pervideo. Familiariter enim domestica aspicimus, et semper iudicio favor officit. Puto multos potuisse ad sapientiam pervenire, nisi putassent se pervenisse, nisi quaedam in se dissimulassent, quaedam opertis oculis transiluissent. Non est enim quod magis aliena iudices adulatione nos perire quam nostra. Quis sibi verum dicere ausus est? Quis non, inter laudantium blandientiumque positus greges, plurimum tamen sibi ipse assentatus est? Rogo itaque, si quod habes remedium quo hanc fluctuationem meam sistas, dignum me putes qui tibi tranquillitatem debeam. Non esse periculosos hos motus animi nec quicquam tumultuosi afferentes scio; ut vera tibi similitudine id de quo queror exprimam, non tempestate vexor, sed nausea: detrahe ergo quicquid hoc est mali, et succurre in conspectu terrarum laboranti. 2. SENECA Quaero mehercules iamdudum, Serene, ipse tacitus cui talem affectum animi similem putem, nec ulli propius admoverim exemplo quam eorum qui, ex longa et gravi valetudine expliciti, motiunculis levibusque interim offensis pestringuntur et, cum reliquias effugerunt, suspicionibus tamen inquietantur medicisque iam sani manum porrigunt et omnem calorem corporis sui calumniantur. Horum, Serene, non parum sanum est corpus, sed sanitati parum
assuevit, sicut est quidam tremor etiam tranquilli maris motusque, cum ex tempestate requievit. Opus est itaque non illis durioribus, quae iam transcucurrimus, ut alicubi obstes tibi, alicubi irascaris, alicubi instes gravis, sed illo quod ultimum venit, ut fidem tibi habeas et recta ire te via credas, nihil avocatus transversis multorum vestigiis passim discurrentium, quorundam circa illam errantium viam. Quod desideras autem magnum et summum est deoque vicinum, non concuti. Hanc stabilem animi sedem Graeci euthymian vocant, de qua Democriti volumen egregium est, ego tranquillitatem voco: nec enim imitari et transferre verba ad illorum, formam necesse est; res ipsa de qua agitur aliquo signanda nomine est, quod appellationis graecae vim debet habere, non faciem. Ergo quaerimus quomodo animus semper aequali secundoque cursu eat propitiusque sibi sit et sua laetus aspiciat et hoc gaudium non interrumpat, sed placido statu maneat, nec attollens se umquam nec deprimens. Id tranquillitas erit. Quomodo ad hanc perveniri possit in universum quaeramus; sumes tu ex publico remedio quantum voles. Totum interim vitium in medium protrahendum est, ex quo agnoscet quisque partem suam. Simul tu intelleges quanto minus negotii habeas cum fastidio tui quam ii quos, ad professionem speciosam alligatos et sub ingenti titulo laborantes, in sua simulatione pudor magis quam voluntas tenet. Omnes in eadem causa sunt, et hi qui levitate vexantur ac taedio assiduaque mutatione propositi, quibus semper magis placet quod reliquerunt, et illi qui marcent et oscitantur. Adice eos qui non aliter quam quibus difficilis somnus est versant se et hoc atque illo modo componunt, donec quietem lassitudine inveniant: statum vitae suae reformando subinde, in eo novissime manent, in quo illos non mutandi odium, sed senectus ad novandum pigra deprehendit. Adice et illos, qui non constantiae vitio parum leves sunt, sed inertiae, et vivunt non quomodo volunt, sed quomodo coeperunt. Innumerabiles deinceps proprietates sunt, sed unus effectus vitii, sibi displicere. Hoc oritur ab intemperie animi et cupiditatibus timidis ut parum prosperis, ubi aut non audent quantum concupiscunt aut non consequuntur, et in spem toti prominent. Semper instabiles mobilesque sunt, quod necesse est accidere pendentibus. Ad vota sua omni via tendunt et inhonesta se ac difficilia docent coguntque, et, ubi sine praemio labor est, torquet illos irritum dedecus, nec dolent prava, sed frustra voluisse. Tunc illos et poenitentia coepti tenet et incipiendi timor, subrepitque illa animi iactatio non invenientis exitum, quia nec imperare capiditatibus suis nec obsequi possunt, et conctatio vitae parum se explicantis et inter destituta vota torpentis animi situs. Quae omnia graviora sunt ubi odio infelicitatis operosae ad otium pefugerunt ac secreta studia, quae pati non potest animus ad civilia erectus agendique cupidus et natura inquies, parum scilicet in se solaciorum habens. Ideo, detractis oblectationibus quas ipsae occupationes discurrentibus praebent, domum, solitudinem, parietes non fert; invitus aspicit se sibi relictum. Hinc illud est taedium et displicentia sui et nusquam residentis animi volutatio et otii sui tristis atque aegra patientia, utique ubi causas fateri pudet et tormenta introrsus egit verecundia, in angusto inclusae cupiditates sine exitu se ipsae strangulant;
inde maeror marcorque et mille fluctus mentis incertae, quam spes inchoatae suspensam habent, deploratae tristem; inde ille affectus otium suum detestantium querentiumque nihil ipsos habere quod agant, et alienis incrementis inimicissima invidia (alit enim livorem infelix inertia et omnes destrui cupiunt, quia se non potuere provehere); ex hac deinde aversatione alienorum processuum et suorum desperatione obirascens fortunae animus et de saeculo querens et in angulos se retrahens et poenae incubans suae, dum illum taedet sui pigetque. Natura enim humanus animus agilis est et pronus ad motus. Grata omnis illi excitandi se abstrahendique materia est, gratior pessimis quibusque ingeniis, quae occupationibus libenter deteruntur: ut ulcera quaedam nocituras manus appetunt et tactu gaudent et foedam corporum scabiem delectat quicquid exasperat, non aliter dixerim his mentibus, in quas cupiditates velut mala ulcera eruperunt, voluptati esse laborem vexationemque. Sunt enim quaedam quae corpus quoque nostrum cum quodam dolore delectent, ut versare se et mutare nondum fessum latus et alio atque alio positu ventilari: qualis ille homericus Achilles est, modo pronus, modo supinus, in varios habitus se ipse componens, quod proprium aegri est, nihil diu pati et mutationibus ut remediis uti. Inde peregrinationes suscipiuntur vagae et litora pererrantur et modo mari se, modo terra experitur semper praesentibus infesta levitas: «Nunc Campaniam petamus». Iam delicata fastidio sunt: «Inculta videantur, Bruttios et Lucaniae saltus persequamur». Aliquid tamen inter deserta amoeni requiritur, in quo luxuriosi oculi longo locorum horrentium squalore releventur: «Tarentum petatur laudatusque portus et hiberna caeli mitioris et regio vel antiquae satis opulenta turbae; Iam flectamus cursum ad Urbem: nimis diu a plausu et fragore aures vacaverunt, iuvat iam et humano sanguine frui». Aliud ex alio iter suscipitur et spectacula spectaculis mutantur. Ut ait Lucretius: Hoc se quisque modo semper fugit. Sed quid prodest, si non effugit? Sequitur se ipse et urget gravissimus comes. Itaque scire debemus non locorum vitium esse quo laboramus, sed nostrum: infirmi sumus ad omne tolerandum, nec laboris patientes nec voluptatis nec nostri nec ullius rei diutius. Hoc quosdam egit ad mortem: quod proposita saepe mutando in eadem revolvebantur et non reliquerant novitati locum, fastidio esse illis coepit vita et ipse mundus, et subiit illud tabidarum deliciarum: «Quousque eadem?». 3. Adversus hoc taedium quo auxilio putem utendum quaeris. Optimum erat, ut ait Athenodorus, actione rerum et rei publicae tractatione et officiis civilibus se detinere. Nam, ut quidam sole atque exercitatione et cura corporis diem educunt athletisque longe utilissimum est lacertos suos roburque, cui se uni dicaverunt, maiore temporis parte nutrire, ita nobis, animum ad rerum civilium certamen parantibus, in opere esse nostro longe pulcherrimum est: nam, cum
utilem se efficere civibus mortalibusque propositum habeat, simul et exercetur et proficit qui in mediis se officiis posuit, communia privataque pro facultate administrans. «Sed, quia in hac, inquit, tam insana hominum ambitione, tot calumniatoribus in deterius recta torquentibus, parum tuta simplicitas est et plus futurum semper est quod obstet quam quod succedat, a foro quidem et publico recedendum est. Sed habet ubi se etiam in privato laxe explicet magnus animus, nec, ut leonum animaliumque impetus caveis coercetur, sic hominum quorum maximae in seducto actiones sunt. Ita tamen delituerit, ut, ubicumque otium suum absconderit, prodesse velit singulis universisque ingenio, voce, consilio. Nec enim is solus rei publicae prodest, qui candidatos extrahit et tuetur reos et de pace belloque censet; sed qui iuventutem exhortatur, qui in tanta bonorum praeceptorum inopia virtutem insinuat animis, qui ad pecuniam luxuriamque cursu ruentes prensat ac retrahit et, si nihil aliud, certe moratur, in privato publicum negotium agit. An ille plus praestat, qui inter peregrinos et cives aut urbanus praetor adeuntibus assessoris verba pronuntiat, quam qui quid sit iustitia, quid pietas, quid patientia, quid fortitudo, quid mortis contemptus, quid deorum intellectus, quam gratuitum bonum sit bona conscientia? Ergo, si tempus in studia conferas quod subduxeris officiis, non deserueris nec munus detractaveris: neque enim ille solus militat qui in acie stat et cornu dextrum laevumque defendit, sed et qui portas tuetur et statione minus periculosa, non notios tamen fungitur vigiliasque servat et armamentario praeest; quae ministeria, quamvis incruenta sint, in numerum stipendiorum veniunt. Si te ad studia revocaveris, omne vitae fastidium effugeris, nec noctem fieri optabis taedio lucis, nec tibi gravis eris nec aliis supervacuus; multos in amicitiam attrahes affluetque ad te optimus quisque. Numquam enim, quamvis obscura, virtus latet, sed mittit sui signa: quisquis dignus fuerit vestigiis illam colliget. Nam, si omnem conversationem tollimus et generi humano renuntiamus vivimusque in nos tantum conversi, sequetur hanc solitudinem omni studio carentem inopia rerum agendarum: incipiemus aedificia alia ponere, alia subvertere, et mare summovere et aquas contra difficultatem locorum educere, et male dispensare tempus quod nobis natura consumendum dedit. Alii parce illo utimur, alii prodige; alii sic impendimus ut possimus rationem reddere, alii ut nullas habeamus reliquias, qua re nihil turpius est. Saepe grandis natu senes nullum aliud habet argumentum quo se probet diu vixisse, praeter aetatem». 4. Mihi, carissime Serene, nimis videtur summisisse temporibus se Athenodorus, nimis cito refugisse. Nec ego negaverim aliquando cedendum, sed sensim relato gradu et salvis signis, salva militari dignitate: sanctiores tutioresque sunt hostibus suis qui in fidem cum armis veniunt. Hoc puto virtuti faciendum studiosoque virtutis: si praevalebit fortuna et praecidet agendi facultatem, non statim aversus inermisque fugiat, latebras quaerens, quasi ullus locus sit quo non possit fortuna persequi, sed parcius se inferat officiis et cum dilectu inveniat aliquid in quo utilis civitati sit. Militare non licet: honores petat.
Privato vivendum est: sit orator. Silentium indictum est: tacita advocatione cives invet. Periculosum etiam ingressu forum est: in domibus, in spectaculis, in conviviis bonum contubernalem, fidelem amicum, temperantem convivam agat. Officia civis amisit: hominis exerceat. Ideo magno animo nos non unius urbis moenibus clusimus, sed in totius orbis commercium emisimus patriamque nobis mundum professi sumus, ut liceret latiorem virtuti campum dare. Praeclusum tibi tribunal est et rostris prohiberis aut comitiis: respice post te quantum latissimarum regionum pateat, quantum populorum. Numquam ita tibi magna pars obstruetur, ut non maior relinquatur. Sed vide ne totum istud tuum vitium sit. Non vis enim nisi consul aut prytanis aut ceryx aut sufes administrare rem publicam. Quid si militare nolis nisi imperator aut tribunus? Etiam si alii primam frontem tenebunt, te sors inter triarios posuerit, inde voce, adhortatione, exemplo, animo milita: praecisis quoque manibus, ille in proelio invenit quod partibus conferat, qui stat tamen et clamore invat. Tale quiddam facias: si a prima te rei publicae parte fortuna summoverit, stes tamen et clamore iuves, et, si quis fauces oppresserit, stes tamen et silentio iuves. Numquam inutilis est opera civis boni: auditus est visusque. Vultu, nutu, obstinatione tacita incessuque, ipso prodest. Ut salutaria quaedam citra gustum tactumque odore proficiunt, ita virtus utilitatem etiam ex longinquo et latens fundit: sive spatiatur et se utitur suo iure, sive precarios habet excessus cogiturque vela contrahere, sive otiosa mutaque est et anguste circumsaepta, sive adaperta, in quocumque habitu est, proficit. Quid tu parum utile putas exemplum bene quiescentis? Longe itaque optimum est miscere otium rebus, quotiens actuosa vita impedimentis fortuitis aut civitatis condicione prohibebitur; numquam enim usque eo interclusa sunt omnia, ut nulli actioni locus honestae sit. 5. Numquid potes invenire urbem miseriorem quam Atheniensium fuit, cum illam triginta tyranni divellerent? Mille trecentos cives, optimum quemque, occiderant, nec finem ideo faciebant, sed irritabat se ipsa saevitia. In qua civitate erat Areos pagos, religiosissimum iudicium, in qua senatus populusque senatui similis, coibat cotidie carnificum triste collegium et infelix curia tyrannis augusta. Poteratne illa civitas conquiescere, in qua tot tyranni erant quot satellites essent? Ne spes quidem ulla recipiendae libertatis animis poterat offerri, nec ulli remedio locus apparebat contra tantam vim malorum: und enim miserae civitati tot Harmodios? Socrates tamen in medio erat, et lugentes patres consolabatur, et desperantes de re publica exhortabatur, et divitibus opes suas metuentibus exprobrabat seram periculosae avaritiae paenitentiam, et imitari volentibus magnum circumferebat exemplar, cum inter triginta dominos liber incederet. Hunc tamen Athenae ipsae in carcere occiderunt, et qui tuto insultaverat agmini tyrannorum, eius libertatem libertas non tulit: ut scias et in afflicta re publica esse occasionem sapienti viro ad se proferendum, et in florenti ac beata saevitiam, invidiam, mille alia inermia vitia regnare. Utcumque ergo se res publica dabit, utcumque fortuna permittet, ita aut explicabimus nos aut contrahemus, utique
movebimus nec alligati metu torpebimus. Immo ille vir fuerit, qui, periculis undique imminentibus, armis circa et catenis frementibus, non alliserit virtutem nec absconderit: non est enim servare se obruere. Ut opinor, Curius Dentatus aiebat malle esse se mortuum quam vivere: ultimum malorum est e vivorum numero exire antequam moriaris. Sed faciendum erit, si in rei publicae tempus minus tractabile incideris, ut plus otio ac litteris vindices, nec aliter quam in periculosa navigatione subinde portum petas, nec expectes donec res te dimittant, sed ab illis te ipse diiungas. 6. Inspicere autem debebimus primum nosmet ipsos, deinde ea quae aggrediemur negotia, deinde eos quorum causa aut cum quibus. Ante omnia necesse est se ipsum aestimare, quia fere plus nobis videmur posse quam possumus: alius eloquentiae fiducia prolabitur, alius patrimonio suo plus imperavit quam ferre posset, alius infirmum corpus laborioso pressit officio. Quorundam parum idonea est verecundia rebus civilibus, quae firmam frontem desiderant; quorundam contumacia non facit ad aulam; quidam non habent iram in potestate, et illos ad temeraria verba quaelibet indignatio effert; quidam urbanitatem nesciunt continere nec periculosis abstinent salibus: omnibus his utilior negotio quies est. Ferox impatiensque natura irritamenta nociturae libertatis evitet. Considerandum est utrum natura tua agendis rebus an otioso studio contemplationique aptior sit, et eo inclinandum quo te vis ingenii feret: Isocrates Ephorum iniecta manu a foro subduxit, utiliorem componendis monumentis historiarum ratus. Male enim respondent coacta ingenia; reluctante natura, irritus labor est. Aestimanda sunt deinde ipsa quae aggredimur, et vires nostrae cum rebus quas tentaturi sumus comparandae. Debet enim semper plus esse virium in actore quam in opere: necesse est opprimant onera quae ferente maiora sunt. Quaedam praeterea non tam magna sunt quam fecunda multumque negotiorum ferunt: et haec refugienda sunt, ex quibus nova occupatio multiplexque nascetur. Nec accedendum eo unde liber regressus non sit: iis admovenda manus est, quorum finem aut facere aut certe sperare possis; relinquenda, quae latius actu procedunt nec ubi proposueris desinunt. Hominum utique dilectus habendus est, an digni sint quibus partem vitae nostrae impendamus, an ad illos temporis nostri iactura perveniat: quidam enim ultro officia nobis nostra imputant. Athenodorus ait ne ad cenam quidem se iturum ad eum qui sibi nihil pro hoc debiturus sit. Puto, intellegis multo minus ad eos iturum qui cum amicorum officiis paria mensa faciunt, qui fericula pro congiariis numerant, quasi in alienum honorem intemperantes sint. Deme illis testes spectatoresque, non delectabit popina secreta… 7. Nihil tamen aeque oblectaverit animum quam amicitia fidelis et dulcis. Quantum bonum est, ubi praeparata sunt pectora in quae tuto secretum omne descendat, quorum conscientiam minus quam tuam timeas, quorum sermo sollicitudinem leniat, sententia consilium expediat, hilaritas tristitiam dissipet,
conspectus ipse delectet! Quos scilicet vacuos, quantum fieri poterit, a cupiditatibus eligemus: serpunt enim vitia et in proximum quemque transiliunt et contactu nocent. Itaque, ut in pestilentia curandum est ne correptis iam corporibus et morbo flagrantibus assideamus, quia pericula trahemus afflatuque ipso laborabimus, ita in amicorum legendis ingeniis dabimus operam ut quam minime inquinatos assumamus: initium morbi est aegris sana miscere. Nec hoc praeceperim tibi, ut neminem nisi sapientem sequaris aut attrahas: ubi enim istum invenies, quem tot saeculis quaerimus? Pro optimo est minime malus. Vix tibi esset facultas dilectus felicioris, si inter Platonas et Xenophontas et illum Socratici fetus proventum bonos quaereres, aut si tibi potestas Catonianae fieret aetatis, quae plerosque dignos tulit qui Catonis saeculo nascerentur (sicut multos peiores quam umquam alias maximorumque molitores scelerum; utraque enim turba opus erat, ut Cato posset intellegi: habere debuit et bonos, quibus se approbaret, et malos, in quibus vim suam experiretur). Nunc vero, in tanta bonorum egestate, minus fastidiosa fiat electio. Praecipue tamen vitentur tristes et omnia deplorantes, quibus nulla non causa in querellas placet. Constet illi licet fides et benevolentia, tranquillitati tamen inimicus est comes perturbatus et omnia gemens. 8. Transeamus ad patrimonia, maximam humanarum aerumnarum materiam. Nam, si omnia alia quibus angimur compares, mortes, aegrotationes, metus, desideria, dolorum laborumque patientiam, cum iis quae nobis mala pecunia nostra exhibet, haec pars multum praegravabit. Itaque cogitandum est quanto levior dolor sit non habere quam perdere, et intellegemus paupertati eo minorem tormentorum quo minorem damnorum esse materiam. Erras enim si putas animosius detrimenta divites ferre: maximis minimisque corporibus par est dolor vulneris. Bion eleganter ait non minus molestum esse calvis quam comatis pilos velli. Idem scias licet de pauperibus locupletibusque, par illis esse tormentum: utrique enim pecuniam sua obhaesit nec sine sensu revelli potest. Tolerabilius autem est, ut dixi, faciliusque non adquirere quam amittere, ideoque laetiores videbis quos numquam fortuna respexit quam quos deseruit. Vidit hoc Diogenes, vir ingentis animi, et effecit ne quid sibi eripi posset. Tu istud paupertatem, inopiam, egestatem voca, quod voles ignominiosum securitati nomen impone: putabo hunc non esse felicem, si quem mihi alium inveneris cui nihil pereat. Aut ego fallor, aut regnum est inter avaros, circumscriptores, latrones, plagiarios unum esse cui noceri non possit. Si quis de felicitate Diogenis dubitat, potest idem dubitare et de deorum immortalium statu, an parum beate degant quod illis nec praedia nec horti sint nec alieno colono rura pretiosa nec grande in foro faenus. Non te pudet quisquis divitiis astupes? Respice agedum mundum: nudos videbis deosm omnio dantes nihil habentes. Hunc tu pauperem putas an diis immortalibus similem, qui se fortuitis amnibus exuit? Feliciorem tu Demetrium Pompeianum vocas quem non puduit locupletiorem esse Pompeio? Numerus illi cotidie servorum velut imperatori exercitus referebatur cui iamdudum divitiae
esse debuerant duo vicarii et cella laxior. At Diogeni servus unicus fugit nec eum reducere, cum monstraretur, tanti putavit: «Turpe est, inquit, Manen sine Diogene posse vivere, Diogenen sine Mane non posse». Videtur mihi dixisse: «Age tuum negotium, Fortuna, nihil apud Diogenen iam tui est: fugit mihi servus, immo liber abii». Familia petit vestiarium victumque; tot ventres avidissimorum animalium tuendi sunt, emenda vestis et custodiendae rapacissimae manus et flentius detestantiumque ministeriis utendum. Quanto ille felicior, qui nihil ulli debet nisi sibi! cui facillime negat. Sed, quoniam non est nobis tantum roboris, angustanda certe sunt patrimonia, ut minus ad iniuras fortunae simus expositi. Habiliora sunt corpora in bello quae in arma sua contrahi possunt quam quae superfunduntur et undique magnitudo sua vulneribus obicit; optimus pecuniae modus est, qui nec in paupertatem cadit nec procul a paupertate discedit. 9. Placebit autem haec nobis mensura si prius parsimonia placuerit, sine qua nec ullae opes sufficiunt nec ullae non satis patent, praesertim cum in vicino remedium sit et possit paupertas in divitias se, advocata frugalitate, convertere. Assuescamus a nobis removere pompam et usus rerum, non ornamenta metiri. Cibus famen domet, potio sitim, libido qua necesse est fluat. Discamus membris nostris inniti, cultum victumque non ad nova exempla componere, sed ut maiorum mores suadent. Discamus continentiam augere, luxuriam coercere, gloriam temperare, iracundiam lenire, paupertatem aequis oculis aspiciere, frugalitatem colere, etiam si multos pudebit rei eius, desideriis naturalibus parvo parata remedia adhibere, spes effrenatas et animum in futura imminentem velut sub vinculis habere id agere, ut divitias a nobis potius quam a fortuna petamus. Non potest umquam tanta varietas et iniquitas casuum ita depelli, ut non multum procellarum irruat magna armamenta pandentibus. Cogendae in artum res sunt, ut tela in vanum cadant, ideoque exsilia interim calamitatesque in remedium cessere et levioribus incommodis graviora sanata sunt. Ubi parum audit praecepta animus nec curari mollius potest, quidni consulatur, si et paupertas et ignominia et rerum eversio adhibetur? Malo malum opponitur. Assuescamus ergo cenare posse sine populo et servis paucioribus servire et vestes parare in quod inventae sunt et habitare contractius. Non in cursu tantum circique certamine, sed in his spatiis vitae interius flectendum est. Studiorum quoque, quae liberalissima impensa est, tamdiu rationem habet quamdiu modum. Quo innumerabiles libros et bibliothecas, quarum dominus vix tota vita indices perlegit? Onerat discentem turba, non instruit, multoque satius est paucis te auctoribus tradere quam errare per multos. Quadraginta milia librorum Alexandriae arserunt. Pulcherrimum regiae opulentiae monumentum alius laudaverit, sicut et Livius, qui elegantiae regum curaeque egregium id opus ait fuisse. Non fuit elegantia illud aut cura, sed studiosa luxuria, immo ne studiosa quidem, quoniam non in studium, sed in spectaculum comparaverant, sicut plerisque ignaris etiam puerilium litterarum libri non studiorum istrumenta, sed cenationum ornamenta sunt. Paretur itaque librorum quantum satis sit, nihil in apparatum. – Honestius, inquis, huc se
impensae quam in Corinthia pictasque tabulas effuderint. – Vitiosum est ubique quod nimium est. Quid habes cur ignoscas homini armaria ecitro atque ebore captanti, corpora conquirenti aut ignotorum auctorum aut improbatorum et inter tot milia librorum oscitanti, cui voluminum suorum frontes maxime placent titulique? Apud desidiosissimos ergo videbis quicquid orationum historiamque est, tecto tenus exstructa loculamenta: iam enim, inter balnearia et thermas, bibliotheca quoque ut necessarium domus ornamentum expolitur. Ignoscerem plane, si studiorum nimia cupidine erraretur; nunc ista conquisita, cum imaginibus suis discripta, sacrorum opera ingeniorum in speciem et cultum parietum comparantur. 10. At in aliquod genus vitae difficile incidisti et tibi ignoranti vel publica fortuna vel privata laqueum impegit, quem nec solvere possis nec rumpere. Cogita compeditos primo aegre ferre onera et impedimenta crurum; deinde, ubi non indignari illa, sed pati proposuerunt, necessitas fortiter ferre docet, consuetudo facile. Invenies in quolibet genere vitae oblectamenta et remissiones et voluptates, si volueris mala putare levia potius quam invidiosa facere. Nullo melius nomine de nobis natura meruit, quae, cum sciret quibus aerumnis nasceremur, calamitatum mollimentum consuetudinem invenit, cito in familiaritatem gravissima adducens. Nemo duraret, si rerum adversarum eandem vim assiduitas haberet quam primus ictus. Omnes cum fortuna copulati sumus: aliorum aurea catena est ac laxa, aliorum arta et sordida, sed quid refert? Eadem custodia universos circumdedit alligatique sunt etiam qui alligaverunt, nisi forte tu leviorem in sinistra catenam putas. Alium honores, alium ope vinciunt; quosdam nobilitas, quosdam humilitas premit; quibusdam aliena supra caput imperia sunt, quibusdam sua; quosdam exsilia uno loco tenent, quosdam sacerdotia. Omnis vita servitium est. Assuescendum et itaque condicioni suae et quam minumum de illa querendum et quicquid habet circa se commodi apprehendendum: nihil tam acerbum est, in quo non aequus animus solacium inveniat. Exiguae saepe areae in multos usus discribentis arte patuerunt, et quamvis angustum pedem dispositio fecit habitabilem. Adhibe rationem difficultatibus: possunt et dura molliri et angusta laxari et gravia scite ferentes minus premere. Non sunt praeterea cupiditates in longiquum mittendae, sed in vicinum illis egredi permittamus, quoniam includi ex toto non patiuntur. Relictis iis quae aut non possunt fieri aut difficulter possunt prope posita speique nostrae alludentia sequamur, sed sciamus omnia aeque levia esse, extrinsecus diversas facies habentia, introrsus pariter vana. Nec invideamus altius stantibus: quae excelsa videbantur praerupta sunt. Illi rursus quos sors iniqua in ancipiti posuit tutiores erunt superbiam detrahendo rebus per se superbis et fortunam suam quam maxime poterunt in planum deferendo. Multi quidem sunt quibus necessario haerendum sit in fastigio suo, ex quo non possunt nisi cadendo descendere; sec hoc ipsum testentur maximum onus suum esse, quod aliis graves esse cogantur, nec sublevatos se, sed suffixos. Iustitia, mansuetudine,
humanitate, larga et benigna manu praeparent multa ad secundos casus praesidia, quorum spe securius pendeant. Nihil tamen aeque nos ab his animi fluctibus vindicaverit quam semper aliquem incrementus terminum figere, nec fortunae arbitrium desinendi dare, sed ipsos multo quidem citra consistere. Sic et aliquae cupiditates animum acuent et finitae non in immensum incertumque producent. 11. Ad imperfectos et mediocres et male sanos hic meus sermo pertinet, non ad sapientem. Huic non timide nec pedetentim ambulandum est: tanta enim fiducia sui est, ut obviam fortunae ire non dubitet nec umquam loco illi cessurus sit. Nec habet ubi illam timeat, quia non mancipia tantum possessionesque et dignitatem, sed corpus quoque suum et oculus et manum et quicquid cariorem vitam facit seque ipsum inter precaria numerat, vivitque ut commodatus sibi et reposcentibus sine tristitia redditurus. Nec ideo vilis est sibi, quia scit se suum non esse; sed omnia tam diligenter faciet, tam circumspecte, quam religious homo sanctusque solet tueri fidei commissa. Quandoque autem reddere iubebitur, non queretur cum fortuna, sed dicet: «Gratias ago pro eo quod possedi habuique». Magna quidem res tuas mercede colui, sed, quia ita imperas, do, cedo gratus libensque. Si quid habere me tui volueris etiamnunc, servabo; si aliud placet, ego vero factum signatumque argentum, domum familiamque meam reddo, restituo». Appellaverit natura, quae prior nobis credidit, et huic dicemus: «Recipe animum meliorem quam dedisti; non tergiversor nec refugio. Paratum habes a volente quod non sentienti dedisti: aufer». Reverti unde veneris quid grave est? Male vivet quisquis nesciet bene mori. Huic itaque primum rei pretium detrahendum est et spiritus inter vilia numerandus. Gladiatores, ut ait Cicero, invisos habemus, si omni modo vitam impetrare cupiunt; favemus, si contemptum eius prae se ferunt. Idem evenire nobis scias: saepe enim causa moriendi est timide mori. Fortuna illa, quae ludos sibi facit: «Quo, inquit, te reservem, malum et trepidum animal? Eo magis convulneraberis et confodieris, quia nescis praebere iugulum. At tu et vives diutius et morieris expeditius, qui ferrum non subducta cervice nec manibus oppositis, sed animose recipis». Qui mortem timebit, nihil umquam pro homine vivo faciet; at qui sciet hoc sibi cum conciperetur statim condictum vivet ad formulam et simul illud quoque eodem animi robore preastabit, ne quid ex iis quae eveniunt subitum sit. Quicquid enim fieri potest quasi futurum sit prospiciendo malorum omnium impetus molliet, qui ad praeparatos expectantesque nihil afferunt novi, securis et beata tantum spectantibus graves veniunt. Morbus est, captivitas, ruina, ignis: nihil horum repentium est. Sciebam in quam tumultuosum me contubernium natura cluisset. Totiens in vicina mea conclamatum est; totiens praeter limen immaturas exsequias fax cereusque praecessit; saepe a latere ruentis aedificii fragor sonuit; multos ex iis quos forum, curia, sermo mecum contraxerat, nox abstulit et iunctas sodalium manus †copuatas† interscidit: mirer ad me aliquando pericula accessisse, quae circa me semper erraverint? Magna pars hominum est quae navigatura de tempestate non cogitat. Numquam, me in re bona mali pudebit auctoris: Publilius, tragicis
comicisque vehementior ingeniis quotiens mimicas ineptias et verba ad summam caveam spectantia reliquit, inter multa alia cothurno, non tantum sipario fortiora et hoc ait: Cuivis potest accidere quod cuiquam potest. Hoc si quis in medullas demiserit et omnia aliena mala, quorum ingens cotidie copia est, sic aspexerit tamquam liberum illis et ad se iter sit, multo ante se armabit quam petatur. Sero animus ad periculorum patientiam post pericula, instruitur. «Non putavi hoc futurum» et: «Umquam tu hoc eventurum credidisses?». Quare autem non? Quae sunt divitiae quas non egestas et fames et mendicitas a tergo sequatur? Quae dignitas, cuius non praetextam et augurale et lora patricia sordes comitentur et exprobratio notae et mille maculae et extrema contemptio? Quod regnum est, cui non parata sit ruina et proculcatio et dominus et carnifex? Nec magnis ista intervallis divisa, sed horae momentum interest inter solium et aliena genua. Scito ergo omnem condicionem versabilem esse et quicquid in ullum incurrit posse in te quoque incurrere. Locuples es: numquid divitior Pompeio? Cui cum Gaius, vetus cognatus, hopes novus, aperuisset Caesaris domum ut suam cluderet, defuit panis, aqua. Cum tot flumina possideret in suo orientia, in suo cadentia, mendicavit stillicidia; fame ac siti periit in palatio cognati, dum illi heres publicum funus esurienti locat. Honoribus summis functus es: numquid aut tam magnis aut tam insperatis aut tam universis quam Seianus? Quo die illum senatus deduxerat, populus in frusta divisit. In quem quicquid congeri poterat dii hominesque contulerant, ex eo nihil superfuit quod carnifex traheret. Rex es: non ad Croesum te mittam, qui rogum suum et accendi vivus et exstingui vidit, factus non regno tantum, etiam morti suae superstes; non ad Iugurtham, quem populus romanus intra annum quam timuerat spectavit: Ptolemaeum Africae regem, Armeniae Mithridaten inter Gaianas custodias vidimus; alter in exsilium missus est, alter ut meliore fide mitteretur optabat. In tanta rerum sursum ac deorsum euntum versatione, si non quicquid fieri potest pro futuro habes, das in te vires rebus adversis, quas infregit quisquis prior vidit. 12. Proximum ab his erit ne aut in supervacuis aut ex supervacuo laboremus, id est ne quae aut non possumus consequi concupiscamus aut adepti vanitatem cupiditatum nostrarum sero post multum sudorem intellegamus, id est indignus. Fere enim ex his tristitia sequitur, si aut non successit aut successus pudet. Circumcidenda concursatio, qualis est magnae parti hominum domos et theatra et fora pererrantium: alienis se negotiis offerunt, semper aliquid agentibus similes. Horum si aliquem exeuntem e domo interrogaveris: «Quo tu? Quid cogitas?» respondebit tibi: «Non mehercules scio, sed aliquos videbo, aliquid agam». Sine proposito vagantur, quaerentes negotia, nec quae destinaverunt agunt, sed in quae incucurrerunt. Inconsultus illis vanusque cursus est, qualis formicis per arbusta repentibus, quae in summum cacumen et inde in imum inanes aguntur. His
plerique similem vitam agunt, quorum non immerito quis inquietam inertiam dixerit. Quorundam quasi ad incendium currentium misereberis: usque eo impellunt obvios et se alioque praecipitant, cum interim cucurrerunt aut salutaturi aliquem non resalutaturum aut funus ignoti hominis prosecuturi, aut ad iudicium saepe litigantis aut ad sponsalia saepe nubentis, et lecticam assectati quibusdam locis etiam tulerunt. Dein, domum cum supervacua redeuntes lassitudine, iurant nescire se ipsos quare exierint, ubi fuerint postero die erraturi per eadem illa vestigia. Omnis itaque labor aliquo referatur, aliquo respiciat. Non industria inquietos, ut insanos falsae rerum imagines agitant: nam ne illi quidem sine aliqua spe moventur; proritat illos alicuius rei species, cuius vanitatem capta mens non coarguit. Eodem modo unumquemque ex his qui ad augendam turbam exeunt inanes et leves causae per urbem circumducunt, nihilque habentem in quod laboret lux orta expellit, et cum, multorum frustra liminibus illisus, nomenclatores persalutavit, a multis exclusus, neminem ex omnibus difficilius domi quam se convenit. Ex hoc malo dependet illud taeterrimum vitium auscultatio et publicorum secretorumque inquisitio, et multarum rerum scientia quae nec tuto narrantur nec tuto audiuntur. 13. Hoc secutum puto Democritum ita cepisse: «Qui tranquille volet vivere nec privatim agat multa nec publice», ad supervacua scilicet referentem: nam, si necessaria sunt, et privatim et publice non tantum multa, sed innumerabilia agenda sunt, ubi vero nullum officium solemne nos citat, inhibendae actiones. Nam qui multa agit saepe fortunae potestatem sui facit: quam tutissimum est raro experiri, ceterum semper de illa cogitare et nihil sibi de fide eius promittere: «Navigabo, nisi si quid inciderit» et: «Praetor fiam, nisi si quid obstiterit» et: «Negotiatio mihi respondebit, nisi si quid intervenerit». Hoc est quare sapienti nihil contra opinionem dicamus accidere: non illum casibus hominum excerpimus, sed erroribus, nec illi omnia ut voluit cedunt, sed ut cogitavit. Imprimis autem cogitavit aliquid posse propositis suis resistere. Necesse est autem levius ad animum pervenire destitutae cupiditatis dolorem, cui successum non utique promiseris. 14. Faciles etiam nos facere debemus, ne nimis destinatis rebus indulgeamus, transeamusque in ea in quae nos casus deduxerit, nec mutationem aut consilii aut status pertimescamus, dummodo nos levitas, inimicissimum quieti vitium, non excipiat. Nam et pertinacia necesse est anxia et misera sit, cui fortuna saepe aliquid extorquet, et levitas multo gravior, nusquam se continens. Utrumque infestum est tranquillitati, et nihil mutare posse et nihil pati. Utique animus ab omnibus externis in se revocandus est: sibi confidat, se gaudeat, sua suspiciat, recedat quantum potest ab alienis, et sibi applicet; damna non sentiat, etiam adversa benigne interpretetur. Nuntiato naufragio, Zenon noster, cum omnia sua audiret submersa: «Iubet, inquit, me fortuna expeditius philosophari». Minabatur Theodoro philosopho tyrannus mortem, et quidem insepultam: «Habes, inquit, cur
tibi placeas, hemina sanguinis in tua potestate est; nam quod ad sepulturam pertinet, o te ineptum, si putas mea interesse supra terram an infra putrescam». Canus Iulius, vir in primis magnus, cuius admirationi ne hoc quidem obstat quod nostro saeculo natus est, cum Gaio diu altercatus, postquam abeunti Phalaris ille dixit. «Ne forte inepta spe tibi blandiaris, duci te iussi». «Gratias, inquit, ago, optime princeps». Quid senserit dubito; multa enim mihi occurrunt. Contumeliosus esse voluit et ostendere quanta crudelitas esset, in qua mors beneficium erat? An exprobravit illi cotidianam dementiam? Agebant enim gratias et quorum liberi occisi et quorum bona ablata erant. An tamquam libertatem libenter accepit? Quicquid est, magno animo respondit. Dicet aliquis: potuit post hoc iubere illum Gaius vivere. Non timuit hoc Canus: nota erat Gaii in talibus imperiis fides. Credisne illum decem medios usque ad supplicium dies sine ulla sollicitudine exegisse? Verisimile non est quae vir ille dixerit, quae fecerit, quam in tranquillo fuerit. Ludebat latrunculis. Cum centurio, agmen periturorum trahens, illum quoque excitari iuberet, vocatus numeravit calculos et sodali suo: «Vide, inquit, ne post mortem meam mentiaris te vicisse». Tum, annuens centurioni: «Testis, inquit, eris uno me antecedere». Lusisse tu Canum illa tabula putas? Illusit. Tristes erant amici, talem amissuri virum: «Quid maesti, inquit, estis? Vos quaeritis an immortales animae sint; ego iam sciam». Nec desiit veritatem in ipso fine scrutari et ex morte sua quaestionem habere. Prosequebatur illum philosophus suus, nec iam procul erat tumulus in quo Caesari deo nostro fiebat cotidianum sacrum. Is: «Quid, inquit, Cane, nunc cogitas? Aut quae tibi mens est?». «Observare, inquit Canus, proposui illo velocissimo momento an sensurus sit animus exire se». Promisitque, si quid explorasset, circumiturum amicos et indicaturum quis esset animarum status. Ecce in media tempestate tranquillitas, ecce animus aeternitate dignus, qui fatum suum in argumentum veri vocat, qui, in ultimo illo gradu positum exeuntem animam percontatur, nec usque ad mortem tantum, sed aliquid etiam ex ipsa morte discit: nemo diutius philosophatus est. Non raptim relinquetur magnus vir et cum cura dicendus: dabimus te in omnem memoriam, clarissimum, caput, Gaianae cladis magna portio! 15. Sed nihil prodest privatae tristitiae causas abiecisse: occupat enim nonnumquam odium generis humain, et occurrit tot scelerum felicium turba. Cum cogitaveris quam sit rara simplicitas et quam ignota innocentia et vix umquam, nisi cum expedit, fides, et libidinis lucra damnaque pariter invisa, et ambitio usque eo iam se suis non continens terminis ut per turpitudinem splendeat, agitur animus in noctem et, velut eversis virtutibus, quas nec sperare licet nec habere prodest, tenebrae oboriuntur. In hoc itaque flectendi sumus, ut omnia vulgi vitia non invisa nobis, sed riducula videantur, et Democritum potius imitemur quam Heraclitum: hic enim, quotiens in publicum processerat, flebat, ille ribedat; huic omnia quae agimus miseriae, illi ineptiae videbantur. Elevanda ergo omnia et facili animo ferenda: humanius est deridere vitam quam deplorare. Adice quod
de humano quoque genere melius meretur qui ridet illud quam qui luget: ille et spei bonae aliquid relinquit, hic autem stulte deflet quae corrigi posse desperat; et universa contemplanti maioris animi est qui risum non tenet quam qui lacrimas, quando levissimum affectum animi movet et nihil magnum, nihil severum, ne miserum quidem ex tanto paratu putat. Singula propter quae laeti ac tristes sumus sibi quisque proponat, et sciet verum esse quod Bion dixit, omnia hominum negotia simillima initiis esse nec vitam illorum magis sanctam aut severam esse quam conceptum. Sed satius est publicos mores et humana vitia placide accipere, nec in risum nec in lacrimas excidentem; nam alienis malis torqueri aeterna miseria est, alienis delectari malis voluptas inhumana. Sicut est illa inutilis humanitas, flere, quia aliquis filium efferat, et frontem suam fingere, in suis quoque malis ita gerere se oportet, ut dolori tantum des quantum natura poscit, non quantum consuetudo. Plerique enim lacrimas fundunt ut ostendant, et totiens siccos oculos habent quotiens spectator defuit, turpe indicante non flere cum omnes faciant: adeo penitus hoc se malum fixit, ex aliena opinione pendere, ut in simulationem etiam res simplicissima, dolor, veniat. 16. Sequetur pars quae solet non immerito contristare et in sollictudinem adducere. Ubi bonorum exitus mali sunt, ubi Socrates cogitur in carcere mori, Rutilius in exsilio vivere, Pompeius et Cicero clientibus suis praebere cervicem, Cato ille, virtutum viva imago, incumbens gladio, simul de se ac de re publica palam facere, necesse est torqueri tam iniqua praemia fortunam persolvere. Et quid sibi quisque tunc speret, cum videat pessima optimos pati? Qui ergo est? Vide quomodo quisque illorum tulerit et, si fortes fuerunt, ipsorum illos animo desidera, si muliebriter et ignave perierunt, nihil periit. Aut digni sunt quorum virtus tibi placeat, aut indigni quorum desideretur ignavia. Qui enim est turpius quam si maximi viri timidos fortiter moriendo faciunt? Laudemus totiens dignum laudibus et dicamus: «Tanto fortior! tanto felicior! Omnes effigisti casus, livorem, morbum; existi ex custodia; non tu dignus mala fortuna diis visus es, sed indignus in quem iam aliquid fortuna posset». Subducentibus vero se et in ipsa morte ad vitam respectantibus manus iniciendae sunt. Neminem flebo laetum, neminem flentem: ille lacrimas meas ipse abstersit, hic suis lacrimis effecit ne ullis dignus sit. Ego Herculem fleam quod vivus uritur, aut Regulum quod tot clavis configitur, aut Catonem quod vulnera iterat sua? Omnes isti levi temporis impensa invenerunt quomodo aeterni fierent, et ad immortalitatem moriendo venerunt. 17. Est et illa sollicitudinum non mediocris materia, si te anxie componas nec ullis simpliciter ostendas, qualis multorum vita est, ficta, ostentationi parata: torquet enim assidua observatio sui et deprehendi aliter ac solet metuit. Nec umquam cura solvimur, ubi totiens nos aestimari putamus quotiens aspici. Nam et multa incidunt quae invitos denudent et, ut bene cedat tanta sui diligentia, non tamen iucunda vita aut secura est semper sub persona viventium. At illa quantum
habet voluptatis sincera et per se inornata simplicitas, nihil obtendens moribus suis! Subit tamen et haec vita contemptus periculum, si omnia omnibus patent: sunt enim qui fastidiant quicquid propius adierunt. Sed nec virtuti periculum est ne admota oculis revilescat, et satius est simplicitate contemni quam perpetua simulatione torqueri. Modum tamen rei adhibeamus: multum interest, simpliciter vivas an neglegenter. Multum et in se recedendum est: conversatio enim dissimilium bene composita disturbat et renovat affectus et quicquid imbecillum in animo nec percuratum est exulcerat. Miscenda tamen ista et alternada sunt, solitudo et frequentia. Illa nobis faciet hominum desiderium, haec nostri, et erit altera alterius remedium: odium turbae sanabit solitudo, taedium solitudinis turba. Nec in eadem intentione aequaliter retinenda mens est, sed ad iocos devocanda. Cum puerulis Socrates ludere non erubescebat, et Cato vino laxabat animum curis publicis fatigatum, et Scipio triumphale illud ac militare corpus movebat ad numeros, non molliter se infringens, ut nunc mos est etiam incessu ipso ultra muliebrem mollitiam fluentibus, sed ut antiqui illi viri solebant interlusum ac festa tempora virilem in modum tripudiare, non facturi detrimentum etiam si ab hostibus suis spectarentur. Danda est animis remissio: meliores acrioresque requieti surgent. Ut fertilibus agris non est imperandum (cito enim illos exhauriet numquam intermissa fecunditas), ita animorum impetus assiduus labor franget; vires recipient pulum resoluti et remissi. Nascitur ex assiduitate laborum animorum hebetatio quaedam et languor. Nec ad hoc tanta hominum cupiditas tenderet, nisi naturalem quandam voluptatem haberet lusus iocusque. Quorum frequens usus omne animis pondus omnemque vim eripiet: nam et somnus refectioni necessarius est, hunc tamen si per diem noctemque continues, mors erit. Multum interest, remittas aliquid an solvas. Legum conditores festos instituerunt dies ut ad hilaritatem homines publice cogerentur, tanquam necessarium laboribus interponentes temperamentum, et magni iudicii viri quidam sibi menstruas certis diebus ferias dabant quidam nullum non diem inter otium et curas dividebant. Qualem Pollionem Asinium oratorem magnum meminimus, quem nulla res ultra decumam detinuit: ne epistulas quidem post eam horam legebat, ne quid novae curae nasceretur, sed totius diei lassitudinem duabus illis horis ponebat. Quidam medio die interiunxerunt et in postmeridianas horas aliquid levioris operae distulerunt. Maiores quoque nostri novam relationem post horam decumam in senatu fieri vetabant. Miles vigilias dividit, et nox immunis est ab expeditione redeuntium. Indulgendum est animo dandumque subinde otium, quod alimenti ac virium loco sit. Et in ambulationibus apertis vagandum, ut caelo libero et multo spiritu augeat attollatque se animus; aliquando vectatio iterque et mutata regio vigorem dabunt, convictusque et liberalior potio. Nonnumquam et usque ad ebrietatem veniendum, non ut mergat nos, sed ut deprimat: eluit enim curas et ab imo animum movet et, ut morbis quibusdam, ita tristitiae medetur, Liberque non ob licentiam linguae dictus est inventor vini, sed quia liberat servitio curarum animum et asserit vegetatque et audaciorem in omnes conatus facit. Sed, ut libertatis, ita vini salubris moderatio est. Solonem
Arcesilanque indulsisse vino credunt; Catoni ebrietas obiecta est: facilius efficient crimen honestum quam turpem Catonem. Sed nec saepe faciendum est, ne animus malam consuetudinem ducat, et aliquando tamen in exsultationem libertatemque extrahendus tristique sobrietas removenda paulisper. Nam, sive graeco poetae credimus, «aliquando et insanire iucundum est»; sive Platoni, «frustra poeticas fores campos sui pepulit», sive Aristoteli, «nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit». Non potest grande aliquid et solita contempsit instinctuque sacro surrexit excelsior, tunc demum aliquid cecinit grandius ore mortali. Non potest sublime quicquam et in arduo positum contingere, quamdiu apud se est: desciscat oportet a solito et efferatur et mordeat frenos et rectorem rapiat suum, eoque ferat quo per se timuisset escendere. Habes, Serene carissime, quae possint tranquillitatem tueri, quae restituere, quae subrepentibus vitiis resistant. Illud tamen scito, nihil horum satis esse validum rem imbecillam servantibus, nisi intenta et assidua cura circumit animum labentem.
La serenità
Premessa Il De tranquillitate animi, dedicato anch’esso a Sereno, svolge il tema dell’inquietudine, del taedium vitae, del vuoto interiore, un argomento affine a quello del De otio e comune alla tradizione letteraria platonico-stoica. Sulla serenità c’è anche uno scritto di Plutarco (contenuto nelle Opere morali, Ethikà), che attinge alle medesime fonti di Seneca. Si deve a Democrito l’introduzione del termine atarassìa (dal greco a- priv. e tarasso, turbo), che è appunto la serenità o imperturbabilità e che costituisce l’ideale del saggio. Ma mentre per Democrito l’atarassia è una delle condizioni della felicità e per gli epicurei un godimento quieto e raffinato di tutti i piaceri, sia fisici che spirituali, per gli stoici, e quindi per Seneca, è il totale annullamento delle passioni. In effetti la vera serenità (l’aggettivo è sempre d’obbligo, perché, anche qui, c’è serenità e serenità) nasce non dall’annullamento (impossibile, del resto, a livello profondo), bensì dall’equilibrio costante di tutte le passioni armonicamente composte, che è, come dice Seneca, l’euthymìa dei Greci, de qua Democriti volumen egregium est. Base della serenità – come della felicità e della saggezza – è la conoscenza: chi non ne ha l’intellectus, cioè la piena cognizione, è simile a quegli uomini quos in numerum pecorum et inanimalium redegit hebes natura et ignoratio sui (De vita beata, V 2). Prima di prendere in esame le varie passioni, Seneca descrive, facendo parlare direttamente l’interessato, lo stato d’animo dell’amico, uno stato ambiguo, d’instabilità e di ondeggiamento: Sereno non è sano, ma non è nemmeno malato, non libero dalle paure, ma nemmeno in loro balìa, non si volge con decisione né al bene né al male, si trova in bilico, teme di cadere da un momento all’altro, ma, con quella lucidità tipica dei nevrotici, che si controllano e si studiano minuziosamente, sa che non cadrà mai, che la sua instabilità non è pericolosa e non può portarlo ad alcun reale disastro: Non tempestate vexor, sed nausea: «Ciò che mi turba non è la tempesta, ma il mal di mare». Sono gli eterni mali dell’uomo: dall’odi et amo (di Catullo) all’«essere o non essere» (di Amleto), dall’ aut-aut (di Kierkegaard) all’inettitudine (di Svevo), dalla nausea (di Sartre) all’uomo in bilico (di Saul Bellow), dalla noia (di Moravia) al male di vivere (di Montale), dal male oscuro (di Berto), all’irrealtà (di Ottiero Ottieri). Scontenti di tutto, dice Seneca, passiamo da un desiderio all’altro, da una posizione all’altra, come il malato «che non può trovar posa in su le piume», cambiamo luoghi, portandoci dalla giungla della civiltà alla solitudine del deserto e viceversa, ma il male non ci abbandona: non sono infatti i luoghi e le cose, che fuggiamo, siamo noi stessi, e la fuga è senza risultato, giacché dovunque andiamo ci portiamo sempre appresso il nostro io, inseparabile e inesorabile compagno. Dietro Sereno si cela in fondo Seneca stesso, che non sfugge a questo amletico ondeggiare fra due poli, in bilico fra la vita attiva e quella meditativa, fra un’esigenza razionalistica e una mistica, fra l’umanitarismo e l’aristocraticismo, fra la negazione razionale e l’affermazione passionale della sopravvivenza dell’individuo dopo la morte, fra il pessimismo e la dichiarazione che il saggio sta al di sopra del pessimismo e dell’ottimismo. Seneca prende quindi in esame tutte le passioni, con una sorprendente penetrazione psicologica, riconosce che sono, come i dolori, una legge della natura umana, e dichiara che il saggio non odia e non disprezza gli uomini che ne sono dominati: più che piangere sopra i loro mali, egli ne ride. Ma nello stesso tempo li comprende e li ama, perché gli uomini sono infelici. Passando ai rimedi contro l’instabilità, l’inquietudine, l’insoddisfazione e soprattutto contro la noia, Seneca fornisce una serie di consigli, che spesso non si capisce bene se rientrino nel discorso sulla serenità o tendano solo a risolvere situazioni particolari e contingenti, come quando, ad esempio, suggerisce l’alternanza fra la vita attiva e quella meditativa, perché così – dice – si mantiene vivo il desiderio dell’una e dell’altra, inquantoché la solitudine porta a desiderare la folla, la folla a desiderare la solitudine. Ma è, come al solito, un compromesso: quell’alternanza (che non elimina l’ondeggiamento) rimette tutto in discussione. Il fatto è che Seneca, più che un filosofo, è un esploratore, com’egli stesso si definisce («io passo nell’accampamento del nemico non come transfuga ma come esploratore»), va in cerca di anime, da guarire, da consolare, e ognuna ha i suoi malanni, i suoi problemi. Seneca stesso – non soltanto Sereno, non soltanto Lucilio, Polibio e gli altri destinatari dei suoi consigli e delle sue medicine – non è ancora guarito, e forse – così almeno egli dice – non guarirà mai, non è un saggio e forse – così
almeno dichiara – non lo sarà mai, anzi, in questo stesso dialogo (VII 2) dice, non senza un fondo di pessimismo, che il vero saggio non esiste (tot saeculis quaerimus, «lo stiamo cercando da tanti secoli»). Nemmeno Socrate, dunque? E allora, o la serenità – come la saggezza, la felicità e la libertà – è una bella favola, o l’unico modo per realizzarla è l’isolamento totale dal mondo, non il tenere il piede in due staffe, l’alternanza fra vita attiva e contemplativa, ma la vita contemplativa e basta, come quella degli eremiti. M. S. A.
1. SERENO1 Esplorando, o Seneca, l’animo mio, vi ho trovato molti difetti, alcuni talmente evidenti da potersi, per così dire, toccare con mano, altri invece rintanati come in un nascondiglio, altri ancora saltuari, riemergenti a tratti, a intervalli, e che sono forse i più molesti di tutti, simili a nemici sparpagliati qua e là che ti assalgono all’improvviso, quando gliene viene l’estro – come certe tribù nomadi – per cui tu vivi sempre in uno stato ambiguo, che non è di guerra ma nemmeno di pace, e io mi sono scoperto appunto in un’analoga condizione (te lo confesso come un paziente che si confida al proprio medico), quella, cioè, di non essere né completamente libero dai miei rancori e dalle mie paure, né di trovarmi in loro balìa, sicché, pur riconoscendo che la mia situazione non è delle peggiori, avverto un senso di malessere quanto mai sgradevole, che mi rende lunatico e lagnoso: insomma, non sono malato, ma non sto neppure bene. Non dirmi che le virtù sono tutte fragili all’inizio e che acquistano vigore e stabilità solo col tempo, lo so da me che anche quelle prerogative a cui generalmente si aspira per fare bella figura, come il potere politico, la fama di avvocato e il favore popolare, non si conseguono da un giorno all’altro, che sia le doti autentiche sia quelle che portano a piacere solo perché si vestono di orpelli devono attendere anni prima che il tempo, a poco a poco, dia loro smalto e colore, ma io temo che con l’abitudine – la quale porta le cose a fossilizzarsi in una persistente stabilità – questo mio difetto possa mettere radici, giacché la continua dimestichezza con i nostri mali alla lunga ce li fa gustare e amare come se fossero dei beni. Io non so di che genere sia questo strano malessere dell’animo, oscillante fra due estremi, la salvezza e la perdizione, non sono in grado di spiegartelo nell’insieme, posso dirtene solo i particolari, per cui io ti esporrò i sintomi e tu poi mi dirai la malattia. Voglio parlarti a cuore aperto: io amo la vita semplice, mi accontento di un letto modesto, di un vestito che non debba essere riposto con cura nell’armadio e pressato e torchiato mille volte perché faccia bella figura, mi basta un abito modesto, da poco prezzo, da potersi indossare e conservare senza alcuna preoccupazione; mi piace un cibo cucinato alla buona, a cui non metta mano l’intera servitù, che poi magari debba starmi a guardare mentre lo consumo, un cibo che non richieda di essere ordinato molti giorni prima né di essere servito da un esercito di camerieri, ma che sia semplice, di facile preparazione, reperibile dovunque, che non abbia niente di ricercato o di eccezionale, un cibo che non gravi troppo sul bilancio familiare e
non mi stia poi sullo stomaco, costringendomi magari a farlo uscire da dove è entrato. Amo essere servito senza tante cerimonie da un domestico semplice e naturale, mi piace l’argenteria non lavorata e anonima di mio padre, ch’era un uomo alla buona, una tavola non impreziosita da mille chiazze multicolori o che sia sulla bocca di tutti per essere passata da un amatore all’altro, che serva insomma solo allo scopo a cui è destinata e non faccia scoppiare gli occhi ai convitati, o per l’invidia o per l’ammirazione. Ebbene, dopo che ho apprezzato tutte queste cose semplici e modeste, ecco che resto affascinato da una sfarzosa schiera di paggetti o di servi ornati d’oro e vestiti con tanta cura più che se dovessero andare a una sfilata, da un drappello di splendidi valletti, da una casa con pavimenti pregiati, piena di ricche suppellettili disseminate in tutti gli angoli, da soffitti meravigliosi e dalla folla di gente che sempre segue e s’accompagna in mezzo a tutto quel diluviante sperpero di denaro. Che dire poi dei ruscelletti fatti scorrere intorno ai commensali, dalle acque così trasparenti che se ne vede il fondo,2 e degli stessi banchetti, degni di un simile scenario? Abituato per lungo tempo a una vita semplice e frugale, resto abbagliato dallo splendore di quel lusso che mi avvolge da tutte le parti sino a stordirmi: la vista quasi mi si offusca di fronte a un tale spettacolo, sicché più che guardarlo – tanto forte è l’impatto – lo rifletto nella mia mente. Quando alla fine me ne vado, se non mi sento svilito nell’animo, certamente sono più triste, e non mi muovo più con quell’antico orgoglio in mezzo ai miei mobili dozzinali e alle mie carabattole senza valore. Il cuore mi si stringe in un tormento segreto e mi s’insinua il dubbio se non sia meglio vivere nel lusso che nella sobrietà: non già ch’io mi senta diverso di fronte a tanto sfarzo, resto sempre quello di prima, però ne sono turbato. Ritengo giusto seguire l’autorevole voce dei miei maestri, darmi alla politica per conseguire alte cariche onorifiche, non perché mi attirino i fasci, le verghe o le vesti di porpora, ma per poter essere utile agli amici, ai parenti, alla comunità, anzi agli uomini tutti: anche se sono ancora un novellino, seguo con entusiasmo Zenone, Cleante, Crisippo, i quali, pur non essendosi impegnati in prima persona nella vita politica, vi hanno avviato però gli altri. Quando poi, non abituato a scontrarmi con le cose e con le persone, ricevo qualche spintone, quando – come sovente accade nella vita – mi capita un fatto sconveniente o che contrasta col mio temperamento, che mi va storto o che non scorre liscio come vorrei, o quando impegni di scarsa importanza mi portano via troppo tempo, allora pianto tutto e corro a ritirarmi nella mia quiete privata, affrettando il passo come gli animali che tornano stanchi all’ovile. E nuovamente mi compiaccio, come di cosa migliore, di consumare la vita fra le pareti domestiche, sì che nessuno mi rubi anche una sola giornata, perché nulla potrebbe ripagarmi se mai dovessi perderla per altre occupazioni. La mente, allora, si attacca solo a sé stessa, non bada ad altro, niente di estraneo la distrae, sospende ogni giudizio, serena, imperturbabile, lontana sia dalle cure pubbliche che da quelle private. Ma appena una bella lettura mi titilla l’animo e piena com’è di nobilissimi esempi mi sprona a imitarli, allora ecco, di nuovo, mi vien voglia di lanciarmi nel foro,
di giovare agli altri con la parola o con l’azione, e anche se non dovessi riuscirvi già solo l’averlo tentato mi soddisferebbe, mi viene voglia di rintuzzare al cospetto di tutti la tracotanza di coloro che il successo ha reso ancora più insolenti. Quanto allo scrivere sono convinto che in un’opera si debba guardare principalmente al contenuto, ch’è la molla di ogni discorso, subordinando le parole all’argomento, in modo che questo possa svilupparsi senza sforzo e pervenire là dove si vuole arrivare. A che pro preoccuparsi di comporre opere immortali? Darsi tanto da fare perché i posteri parlino di te? Grandi o piccini, siamo tutti destinati a morire: meglio allora andarsene in punta di piedi, silenziosi, inosservati, che con un funerale rumoroso, pieno di tante inutili e fastidiose parole. Scrivere dunque, sì, ma in una forma semplice, per passatempo, senza battere la grancassa ma solo a nostro uso e consumo: ci si affatica di meno lavorando così, alla giornata. Questo mi dico, ma poi, quando la mente torna a innalzarsi a grandi e nobili concetti, allora ecco che mi riprende il gusto della parola forbita e non mi basta più solo pensare, voglio anche esprimermi in un modo più elevato, adeguato alla dignità del contenuto, sicché, dimentico di quelle norme e di quella semplicità che prima m’ero imposto, mi lascio trascinare dall’enfasi, parlando con un linguaggio che non è più mio. Per farla breve, e per non tediarti con un elenco particolareggiato dei miei mali, in tutte le cose mi accompagna questa debolezza di buoni propositi, sì che temo di allontanarmene sempre di più, o, peggio ancora, ho il terrore di non riuscire a decidermi né per un verso né per l’altro, ma di restarmene in bilico, come uno che sia sempre lì lì per cadere e tuttavia non cade, e che il mio male sia ancora più grave di quanto penso. Siamo infatti indulgenti e faziosi con tutto ciò che ci riguarda, il che rende i nostri giudizi poco obbiettivi. Sono convinto che molti potrebbero pervenire davvero alla saggezza se non avessero la presunzione di esservi già arrivati, se non coprissero certi difetti e sorvolassero su altri a occhi chiusi. L’autoincensamento ci danneggia assai più dell’adulazione degli altri. Chi, posto in mezzo a un gregge di belanti adulatori, non è andato anche oltre nelle lodi di sé stesso? Perciò ti prego, se conosci qualche rimedio capace di fermare questo mio continuo ondeggiare dell’animo, ti sarò debitore della mia serenità. So bene che questo malessere non è pericoloso e che non può portarmi alcun disastro reale, e affinché tu possa fartene un’idea chiara, con un paragone appropriato ti dirò che non è la tempesta che mi disturba, è il mal di mare: tirami dunque fuori da questa burrasca, perché, seppure in vista della terra, sono sempre in difficoltà. 2. SENECA È da un pezzo, Sereno, che mi chiedo, meditando fra me e me, a cosa mai potrei paragonare questo tuo stato d’animo, e l’esempio più calzante che mi viene in mente è quello di un convalescente che, uscito da una lunga e grave malattia, è ancora preso da piccoli accessi di febbre e da leggeri malesseri e anche quando questi non ci sono più e si è completamente ristabilito rimane inquieto e pieno di sospetti, consulta ancora il medico, si fa tastare il polso e
accusa come malattia ogni minimo arrossamento del corpo. Ora, Sereno mio, chi si trova in questa situazione è già guarito, praticamente, ma deve ancora riabituarsi alla buona salute, è come il mare, quando, passata la tempesta, è increspato da lievi fremiti e tremolanti ondeggiamenti. Basta, dunque, con quelle cure energiche a cui sinora hai fatto ricorso, non devi più metterti il bastone fra le ruote, accusarti, dandoti addosso con insistenza e con severità, ormai ti serve solo un rimedio, l’ultimo, cioè la fiducia in te stesso, la convinzione di essere sulla strada giusta e la volontà di non lasciarti deviare dalle orme ingannevoli che vanno di qua e di là disordinatamente o da quelle smarrite nei pressi della strada. Ciò che tu desideri conseguire è uno stato meraviglioso e sublime, che ci avvicina a dio, l’imperturbabilità, quell’equilibrio costante dell’animo che i Greci chiamano euthymìa e su cui Democrito ha scritto un bellissimo libro. Io lo chiamo tranquillità: non occorre, infatti, usare vocaboli greci o tradurli con altri che ne ricalchino pedissequamente la forma, non è l’aspetto della parola che bisogna riprodurre ma il suo significato. Vediamo dunque come l’animo possa procedere costantemente in questo stato di sereno e utile equilibrio che lo renda ben disposto verso sé stesso e tutto ciò che lo riguarda, e come possa mantenersi sempre così, senza abbattersi mai ma anche senza eccitarsi. Sarà questa la tranquillità. Prima dirò, a grandi linee, come ci si arrivi e poi tu dal rimedio generale che io proporrò prenderai quello specifico che ti serve. È bene infatti esaminare il male in tutta la sua portata sì che ciascuno possa ricavarne l’aspetto particolare che lo riguarda. Così vedrai anche quanto sia minore la tua sofferenza, per la nausea che hai di te, rispetto a quella di chi, essendo legato a una scuola filosofica di grande rinomanza e gravato dal peso di un nome illustre, è portato a fingere di non avere alcun male e ciò più per vergogna che per convinzione. Sia gli animi annoiati e volubili, che passano continuamente da un proposito all’altro e rimpiangono sempre ciò che hanno lasciato, sia quelli che poltriscono e sbadigliano, si trovano nella stessa dolorosa situazione. A questi aggiungi quelli che a furia di mutare la loro condizione di vita alla fine, sopraggiunti dalla vecchiaia – ch’è sempre pigra di fronte alle novità – non hanno più neppure il conforto della noia, che li portava, appunto, a cambiare continuamente il loro stato, come fanno coloro che non riuscendo a dormire si girano e si rigirano passando da una posizione all’altra, fintantoché non crollano, vinti più che dal sonno dalla stanchezza. Aggiungi ancora quelli che sono poco volubili non perché in loro ci sia una certa dose di costanza ma solo per indolenza, per cui, pur volendo vivere diversamente, continuano a mantenersi in quello stato semplicemente perché così si sono trovati a vivere all’inizio. Come vedi, le varietà del male sono innumerevoli, ma tutte portano allo stesso risultato: l’insoddisfazione. La quale nasce dall’incostanza o instabilità dell’animo, da desideri imprecisi o che hanno scarsa fortuna, per cui o non si ha il coraggio di osare o non si riesce a realizzare ciò che si vuole, col risultato che ci s’immerge tutti nella speranza. Questa condizione è appunto quella di coloro che stanno sempre in bilico e sono perciò continuamente instabili e oscillanti,
cercano di realizzare i loro desideri ricorrendo magari a mezzi illeciti e persuadendosi e costringendosi anche ad azioni disoneste e difficili, poi, quando vedono che il loro sforzo non viene ricompensato, si vergognano per lo scorno subìto e si dolgono non già per aver voluto cose disoneste ma per averle volute inutilmente. Li prende allora come un rimorso per quello che hanno fatto, l’idea di ricominciare li spaventa e li afferra l’angoscia tipica di chi non trova una via d’uscita, incapaci come sono sia di comandare che di obbedire alle proprie passioni; non si sentono più sicuri perché vedono che non riescono a realizzarsi e in mezzo a tante delusioni restano come paralizzati. La situazione si fa ancora più drammatica allorché, disgustati dalla vita pubblica, in quanto priva di soddisfazioni e di risultati positivi, ci si rifugia nel privato e nella meditazione, giacché uno spirito nato per l’impegno sociale e portato all’azione, irrequieto per natura e perciò incapace di trovare conforto nel raccoglimento interiore, non è in grado di sopportare la solitudine che comporta un tale genere di vita, chiusa e ristretta negli angusti limiti delle pareti domestiche, e non avendo più quelle distrazioni che pur ci sono in ogni attività si sente abbandonato a sé stesso contro il proprio volere. Da qui la noia, lo scontento, quell’irrequieto e ininterrotto volgersi di qua e di là senza trovare un appiglio a cui aggrapparsi, la deprimente insofferenza per quello stato d’inattività, tanto più se il pudore c’impedisce di riconoscerne e confessarne le cause, col risultato che quel tormento resta chiuso dentro noi stessi e le passioni, non trovando uno sfogo, una via d’uscita, finiscono col soffocarsi a vicenda. Da qui, ancora, la malinconia, la depressione e i mille ondeggiamenti di un animo incerto, ora ansioso e impaziente per una speranza intravista, ora abbattuto per una delusione. Si finisce così col detestare quello stato d’inerzia, ci si lamenta di non aver nulla da fare e al tempo stesso si prova un’acutissima invidia per i successi degli altri (perché l’inoperosità priva di soddisfazioni alimenta il livore e chi non ha saputo farsi strada desidera la sconfitta di tutti); poi, demoralizzati per i propri insuccessi e invidiosi dei successi altrui, si tira in ballo il destino avverso, ci si lagna dei tempi e ci si ritira in un angolo a covare la propria angoscia, vergognosi e pieni di rimorsi. Questo perché l’animo umano è per natura portato all’azione, al movimento, e mal sopporta l’inattività, va in cerca di stimoli, di distrazioni che possano gratificarlo, tanto più quando è incline a una vita convulsa e si compiace di logorarsi nel lavoro: come, avendo delle piaghe in qualche parte del corpo, siamo presi dal desiderio di mettervi sopra le mani e toccandole ne godiamo, pur provandone dolore, o come alla scabbia schifosa è un sollievo l’essere sfruculiata, così per quelle indoli in cui le passioni sono scoppiate come delle ulcere maligne, il tormento e l’angoscia diventano un piacere. Certe cose, infatti, gratificano il nostro corpo pur se arrecano un certo dolore, come il girarsi ripetutamente sul letto e mutare il fianco, anche se questo non s’è ancora stancato di stare in quella posizione: così fa l’Achille omerico,3 che ora si mette bocconi, ora si stende supino, e ora assume un’altra posa. È infatti proprio degli ammalati non riuscire a sopportare una cosa più di tanto e prendere come un rimedio il
cambiamento. Ed è per questo che alcuni intraprendono lunghi viaggi, senza una meta precisa, girano di costa in costa, sperimentando la loro volubilità ora per terra ora per mare, avversando sempre ciò che gli sta davanti: «Ora», dicono, «vado in Campania», ma subito, annoiati dalla civiltà: «È meglio andare in luoghi disabitati, a vedere i valichi selvaggi della Lucania o del Bruzio». Senonché, come arrivano lì, in quelle zone brulle e deserte, sono ripresi dalla nostalgia di qualche bel paesaggio che possa risollevare i loro occhi da quell’orrido squallore, e allora: «Si va a Taranto, via, c’è un porto famoso, il clima è mite anche d’inverno, il territorio è così ricco che basterebbe a mantenere tutta la popolazione di una volta». E poi: «Adesso è meglio tornare a Roma, troppo a lungo le mie orecchie sono rimaste lontane dalle grida e dagli applausi del circo, ora ho voglia di veder scorrere sangue umano». Così si fanno viaggi su viaggi, passando da uno spettacolo all’altro. Come dice Lucrezio: Sempre, in questo modo, ciascuno fugge sé stesso. Ma a che ci serve viaggiare, se non riusciamo a evitare noi stessi? Compagno inseparabile, il nostro io c’incalza, dovunque andiamo, inesorabilmente. Non ci rendiamo conto che non è una questione geografica, il nostro male non dipende dai luoghi ma da noi stessi, è dentro, nel profondo, è l’incapacità di sopportare qualsiasi cosa, l’insofferenza del lavoro, delle fatiche e persino dei piaceri, di noi stessi: niente, insomma, ci aggrada più di tanto. C’è chi si uccide, per questo, in quanto a furia di cambiare si torna sempre al medesimo punto, non c’è più spazio alle novità, e allora si comincia a odiare il mondo e la vita stessa, giungendo nella condizione di colui che immerso totalmente nei piaceri finisce con l’esclamare: «Sempre le stesse cose! Sino a quando?». 3. Tu, dunque, mi domandi quale rimedio posso consigliarti contro una simile noia. La cosa migliore, dice Atenodoro, 4 sarebbe l’impegno pubblico e sociale. Come infatti ci sono quelli che, amanti del proprio corpo, passano la giornata tenendosi in esercizio sotto il sole, come ci sono gli atleti, che dedicano la maggior parte del tempo unicamente al rafforzamento dei muscoli – la sola cosa che sappiano fare – così esistono anche quelli che, come noi, preparano lo spirito alle competizioni della vita pubblica e ritengono questo esercizio di gran lunga il più utile e il migliore, perché se si vuole giovare agli altri, siano i propri concittadini o l’intera umanità, bisogna mantenersi in forma per poter sfruttare in questo impegno tutte le proprie energie, sia che ci si volga – secondo le attitudini personali – all’interesse dei singoli o della collettività. «Senonché», aggiunge Atenodoro, «visto che gli uomini sono così follemente ambiziosi, che l’onestà non trova una difesa sufficiente in mezzo a tanti calunniatori che con la loro malevolenza macchiano anche le azioni più pulite, e che gli ostacoli sono sempre più numerosi dei successi, è meglio che tali persone stiano alla larga dalle pubbliche attività. Del resto un animo nobile può realizzarsi benissimo anche
nella vita privata, perché gli uomini – a differenza degli animali, come i leoni, per esempio, che messi in gabbia perdono il loro slancio naturale – le imprese migliori le compiono proprio nel chiuso delle pareti domestiche. E però, per quanto appartato, il ritiro non sia tale da impedirci di giovare al prossimo, singolarmente o collettivamente, col pensiero o con la parola, dando consigli e suggerimenti. Concorre infatti al bene dello Stato non solo chi vota i candidati alle pubbliche cariche, cura i processi o discute di guerra e di pace, ma anche chi educa i giovani, istillando nei loro animi – in tanta penuria di buoni maestri – l’amore per la virtù, chi con la sua parola afferra e ritrae dal baratro quanti corrono a precipizio dietro al denaro e al lusso sfrenato, o perlomeno ne ritarda la caduta: anche questi, benché in privato, svolgono un’attività pubblica e sociale. Forse colui che arbitra tra forestieri e cittadini, o il pretore urbano che legge ai convenuti la formula di rito suggerita dall’assistente,5 è più importante di chi insegna cosa siano la giustizia, la pietà, la sopportazione, la forza d’animo, il disprezzo della morte, la conoscenza di dio e quanto costi poco un bene così grande come la buona coscienza? Perciò chi dedica allo studio il tempo che gli altri spendono nell’attività pubblica non diserta la società né viene meno al suo compito, come non viene meno al suo dovere di soldato quel militare che invece di combattere, nell’ala destra o nell’ala sinistra, sorveglia le porte dell’accampamento o monta di guardia, un servizio, questo, meno pericoloso ma sempre utile, oppure sta di sentinella o piantona i depositi delle armi: anche se non comportano pericoli mortali, tutte queste mansioni, anch’esse necessarie, rientrano nei doveri della vita militare. Ora, se tu ti dedicherai agli studi eviterai le noie del vivere quotidiano, non attenderai che venga la notte perché il giorno t’infastidisce, non sarai più di peso a te stesso e inutile agli altri, ti farai molti amici e la tua casa diverrà la meta delle più degne persone, perché la virtù, anche se appartata, non resta mai così nascosta che gli uomini non riescano a captarne i segnali, e chi ne sarà degno potrà seguirne le tracce. Ma se tronchiamo ogni contatto con gli altri, se c’isoliamo dal mondo e ci chiudiamo completamente in noi stessi, in una siffatta solitudine non avremo mai nulla da fare: ci metteremo allora a fabbricare di qua e a demolire di là, a costruire ville sugli arenili, costringendo il mare a ritirarsi, devieremo i corsi d’acqua6 per ovviare alle asperità del terreno, finiremo insomma con l’usare male il tempo che la natura ci ha messo a disposizione e che alcuni adoperano con parsimonia, altri con eccessiva prodigalità, altri ancora come se dovessero renderne conto, altri infine in un modo tale che non ne resta alcuna traccia, e questo è il peggio che si possa fare. Perciò capita spesso che a un vecchio, a prova della sua lunga esistenza, non resti altro argomento che l’età». 4. Così, carissimo Sereno, diceva Atenodoro. Credo però che egli si sia lasciato influenzare troppo dalle circostanze e abbia rinunciato alla vita attiva prima del tempo. Non dico che una buona volta non si debba cedere il campo, ma bisogna ritirarsi gradatamente, passo dopo passo, salvando le insegne e l’onore:
è più rispettato, infatti, e più sicuro, chi si arrende al nemico con le armi in pugno. E così deve fare l’uomo virtuoso, o che aspira a diventare tale: se la malasorte dovesse prevalere e togliergli ogni possibilità di agire, non volga subito le spalle, gettando le armi, per correre alla ricerca di un nascondiglio – anche perché non c’è rifugio, non c’è luogo appartato in cui la sorte avversa non possa raggiungerci – ma continui a svolgere il suo lavoro dedicandogli minor tempo e intanto si scelga, con giudizio, un’altra attività che gli consenta di giovare ugualmente alla società, anche se in modo diverso. Non può più continuare a fare il soldato? Si cerchi delle cariche civili. È costretto a vivere da privato? Si dia all’avvocatura. È stato ridotto al silenzio? Assista i suoi concittadini con la sua sola presenza, accompagnandoli come garante ai processi.7 Se poi trova rischioso anche l’accesso al foro, si rechi nelle case private, agli spettacoli, ai banchetti, e faccia da compagno agli altri, mostrandosi piacevole conversatore, amico fedele e sobrio commensale. Gli sono preclusi i doveri di cittadino? Eserciti quelli di uomo. È per questa ragione che noi stoici – tale è la nostra grandezza d’animo – non ci chiudiamo dentro le mura di una città ma ci sentiamo e siamo in rapporto con l’intera umanità, eleggiamo a nostra patria il mondo per poter dare un campo più vasto alla virtù. Non puoi accedere al tribunale, ai palchi rostrati degli oratori, alle piazze dove si svolgono le adunanze popolari? Volgiti indietro, e guarda quanti spazi, quante regioni immense, quanti popoli s’aprono all’animo tuo. Per quanto vasto possa essere il campo che ti vien tolto, te ne resterà sempre uno più grande. Bada però che il difetto non stia tutto dalla tua parte, cioè che tu voglia sì partecipare alla vita dello Stato ma solo come console o pritano, come cerice o suffeta,8 e militare nell’esercito soltanto da generale o da tribuno. In tal caso ti dirò che anche se in prima fila ci saranno altri, e la sorte ti avrà posto fra i triari,9 pure da lì potrai prestare il tuo servizio di soldato, sostenendo i compagni con la parola, con l’esortazione, con l’esempio del tuo coraggio: in una battaglia anche chi ha le mani mozzate trova il modo di giovare alla causa, restando in piedi e incitando gli altri con la forza della sua voce. Tu fa’ qualcosa del genere: se la sorte ti nega i primi posti nell’amministrazione dello Stato, resta nel tuo e giova con la parola, e se ti tappano la bocca non demordere: hai sempre l’arma del silenzio. Un buon cittadino non è mai inutile, egli è ascoltato e ammirato, può giovare agli altri con lo sguardo, con un gesto, persino col suo silenzio ostinato e col suo modo di camminare. Come certe sostanze producono effetti salutari soltanto con l’odore, senza che si debba toccarle o ingerirle, così la virtù esercita i suoi benefici influssi anche nascostamente e da lontano. Essa è utile sempre, sotto qualunque aspetto, sia che si muova libera e a sua completa discrezione, sia che abbia solo effimere sortite, o sia costretta ad ammainare le vele, sia che rimanga inerte e silenziosa o imprigionata in uno spazio angusto, sia che si mostri in tutto il suo vigore. Perché dovremmo considerare poco utile l’esempio di chi sa fare buon uso di una vita tranquilla e ritirata? L’ optimum sarebbe poter alternare l’attività privata con quella pubblica, quando questa ci venga negata da ostacoli
casuali o da una particolare situazione politica. In ogni caso non potranno mai esserci precluse tutte le strade, almeno al punto da non lasciarci spazio per un’azione virtuosa. 5. Guarda Atene, ad esempio, quando era dilaniata dai morsi dei trenta tiranni.10 Non c’era allora città più infelice di quella: mille e trecento cittadini mandati a morte, ed erano i migliori. Né l’ingordigia di quei mostri si fermava, anzi la loro crudeltà si faceva sempre più spietata. In quella città, che vantava il più scrupoloso dei tribunali, l’Areopago, che aveva un popolo e un senato degni l’uno dell’altro, si dava convegno ogni giorno una truce accozzaglia di carnefici, nonché un senato, che doveva essere sacro e inviolabile, immiserito e reso sterile dalla presenza di quei tiranni. Poteva forse essere tranquilla quella città, in cui tanti erano i despoti quanti i complici dei loro delitti? Non c’era la più pallida speranza di poter riacquistare la libertà, nessun rimedio s’intravedeva di fronte a tanta rovina. Dove trovare altrettanti Armodii 11 per l’infelice città? Eppure Socrate era lì, in mezzo ai suoi concittadini, consolava il pianto dei senatori, infondeva speranza ai disperati, rinfacciava ai ricchi, timorosi di perdere i loro averi, di pentirsi troppo tardi della loro funesta cupidigia, e a chi volesse imitarlo offriva un esempio insuperabile, procedendo da uomo libero in mezzo a ben trenta tiranni. Eppure fu proprio Atene a imprigionarlo e a ucciderlo: la libertà politica non tollerò la libertà morale di quell’uomo che aveva sfidato in campo aperto un esercito di tiranni. Vedi dunque se anche nella più nera schiavitù non vi sia posto per la saggezza, e come in una città fiorente e felice possano regnare spesso la crudeltà, l’invidia e mille altri vizi che non hanno bisogno di armi per farsi strada. Perciò, a seconda della fortuna o della situazione politica, noi ci esporremo o ci ritireremo, ma in ogni caso dovremo agire e non starcene incatenati e intorpiditi dalla paura. Insomma, si comporterà da uomo chi, trovandosi in mezzo a pericoli che incombono da tutte le parti e circondato da armi e catene, non getterà allo sbaraglio la sua virtù, ma nemmeno l’occulterà: non ci si salva seppellendosi vivi. Curio Dentato,12 se ben ricordo, diceva che preferiva essere morto piuttosto che vivere come un morto, e in realtà la peggiore disgrazia che possa capitare è quella di uscire dal numero dei vivi prima ancora di morire. In conclusione, se ti accadrà di vivere in tempi poco propizi all’attività politica dovrai dare più spazio alla tua vita privata e agli studi letterari, e, come chi si trovi in una navigazione piena di pericoli, cercare subito un porto, liberandoti tu dagli eventi e dagl’impegni pubblici, invece di aspettare che siano loro a congedarti. 6. Devi fare, però, un preventivo esame di te stesso, dopodiché passerai ad analizzare le attività che desideri intraprendere e le persone per le quali e con le quali lavorerai. Per prima cosa, ripeto, bisogna valutare le proprie capacità, perché generalmente siamo portati a ritenere di averne più di quante in effetti ne possediamo: alcuni crollano perché hanno confidato troppo nelle proprie doti
oratorie, altri perché hanno speso più di quanto le loro finanze gli consentivano, altri ancora perché, già deboli o affaticati nel fisico, hanno tirato troppo la corda; certi, poi, sono alquanto timidi o modesti, il che mal si concilia con l’attività pubblica, che vuole invece fermezza e decisione, altri hanno uno spiccato spirito d’indipendenza, che fa a pugni con l’arrendevolezza che richiede, ad esempio, la vita di corte; c’è poi chi non riesce a dominare l’ira e al minimo risentimento butta fuori delle parole avventate, e chi, mordace, non ha il senso della misura e si lascia andare a battute pericolose: tutti costoro è meglio che se ne stiano a casa. Tieni poi presente che un temperamento ribelle o che si lascia facilmente trasportare dalle sue passioni deve frenare gli stimoli di una libertà che può essergli dannosa. Devi poi vedere se il tuo carattere, pur nell’ambito del privato, è portato alle attività pratiche o agli studi e alla meditazione, sì che tu possa volgerti dove ti porta la tua vocazione: Isocrate strappò di sua mano Eforo13 dal tribunale, ritenendolo più utile e più bravo come storico che come avvocato. Chi va contro le proprie inclinazioni fa una cattiva riuscita: quando un’indole è riluttante, per quanto s’impegni, la sua è una fatica sprecata. Dobbiamo poi valutare attentamente quel che intendiamo fare e commisurare le nostre forze con l’attività che vogliamo intraprendere, e a questo proposito va tenuto presente che chi fa dev’essere sempre al di sopra di ciò che fa, perché se il peso supera le forze del portatore inevitabilmente lo schiaccia. Considera ancora che in certi casi i risultati non corrispondono all’importanza del lavoro svolto, il quale richiede, magari, tutta una serie di piccoli impegni particolari. Anche queste attività sono da evitare inquantoché da una sola ne nascerà sempre un’altra, a cui prima non si pensava. Né bisogna invischiarsi in occupazioni da cui non ci si possa liberamente ritirare; è bene invece accedere a quelle di cui si possa stabilire un termine o perlomeno sperarlo, e tralasciare quelle che nel loro svolgersi richiedono spazi sempre maggiori e si protraggono oltre il previsto. Quanto, infine, alla scelta delle persone, per le quali o con le quali lavorare, bisogna vedere se meritano che spendiamo per loro una parte della nostra vita e se se ne rendono conto, visto che alcuni considerano il nostro servizio come un loro diritto. Atenodoro dice che non andrebbe a pranzo da uno che per questo non si sentisse suo debitore. E men che meno da chi pensasse di disobbligarsi in quel modo dei favori degli amici, contando addirittura le portate come se fossero dei doni, quasi che si adattasse a quel lauto banchetto solo per fare onore agli altri. Prova a togliere a costui spettatori e testimoni e vedrai se avrà più gusto a gozzovigliare da solo…14 7. Tuttavia non c’è nulla che possa rasserenarti l’animo quanto un amico fidato. È un gran conforto poter disporre di una persona dal cuore così pieno di affetto da potervi riversare tranquillamente ogni segreto, dalla coscienza così aperta da metterti a tuo agio più di quanto tu non ti senta con la tua, la cui voce lenisca le tue ansie, il cui consiglio aiuti le tue decisioni e il cui buonumore disperda la tua tristezza, una persona, insomma, la cui sola presenza ti rallegri e
ti rassicuri. S’intende che gli amici, per quanto almeno sarà possibile, dovranno essere liberi da passioni, perché i vizi sono come le serpi, strisciano e s’insinuano di nascosto negli animi più vicini, nuocendo loro anche col solo contatto. Perciò, come in un’epidemia bisogna stare attenti a non sedersi accanto a persone il cui corpo sia già contagiato e divorato dal male, perché anche il loro solo respiro può essere pericoloso e farci ammalare, così nello scegliere gli amici dovremo volgerci a quelli che sono il meno possibile corrotti: mescolare i sani con i malati è già principio di malattia. Con ciò non ti dico di avvicinare e frequentare soltanto uomini saggi, perché dove potresti trovarne uno, se lo stiamo cercando da tante generazioni? Se non è possibile il meglio accontentiamoci del meno peggio. A stento potresti avere una scelta più facile se cercassi i virtuosi fra uomini come Platone e Senofonte15 e fra gli eredi di Socrate, o se ti fosse messa a disposizione l’epoca di Catone, che pur vantava molti uomini degni di lui (ma che produsse anche molti bastardi quanti mai nessun altro tempo ne generò, autori di atrocissimi delitti, che pur erano necessari per far capire il valore di Catone, il quale aveva bisogno sia dei buoni, che lo apprezzassero, sia dei malvagi, su cui sperimentare la sua forza). Ma oggi, in cui gli onesti sono così rari come le mosche bianche, nello scegliere gli amici non possiamo essere tanto esigenti. Evitiamo però in particolare i malinconici e quelli a cui non va mai bene niente, che hanno sempre un pretesto per lamentarsi: un amico turbato e scontento, per quanto sia fedele e affettuoso, è sempre nemico della tranquillità. 8. Passiamo ora a parlare delle ricchezze, che sono la fonte principale delle umane tribolazioni. Se provi infatti a fare un confronto fra tutti gli altri mali che ci affliggono – lutti, paure, malattie, rimpianti, dolori, fatiche da sopportare – e quelli che ci arreca il denaro, la bilancia penderà dalla parte di questi ultimi, e non di poco. Bisogna dunque convincersi che procura minor dolore il non aver ricchezze che il dovervi poi rinunciare e che una vita modesta è tanto meno esposta alle sofferenze quanto più scarse sono le perdite. Chi è ricco non per questo è più vaccinato contro le disgrazie o le subisce con maggiore spirito di sopportazione: una ferita fa egualmente male in un corpo ben piazzato e in uno magro come un chiodo. Allo stesso modo – come dice molto argutamente Bione 16 – il dolore per un capello strappato non varia se uno è calvo o ha una folta capigliatura. Così è dei ricchi e dei poveri: proveranno entrambi lo stesso tormento nel perdere il denaro, perché quando questo gli si è attaccato non si può portarglielo via senza che essi ne sentano dolore. Perciò, ripeto, il non acquistare è molto più accettabile e facile che il perdere, e chi non è mai stato baciato dalla fortuna è più fortunato di uno a cui la buona sorte, dopo averlo toccato, ha voltato le spalle. Quel furbacchione di Diogene17 l’aveva capito e s’era premunito, mettendosi in uno stato tale che non si potesse portargli via nulla. Chiamala pure povertà, indigenza, miseria, affibbia il nome più ignominioso che vuoi a questa condizione così intaccabile e serena, io riconoscerò che quell’uomo non era felice se tu sarai capace di trovarmene un
altro che non subisca perdita alcuna. O io m’inganno, o in un mondo di avari, d’imbroglioni, di ladri e di falsari un uomo che sia l’unico a cui non possa recarsi il minimo danno è degno di essere un re. Se non era felice Diogene, allora non lo è nemmeno dio, perché non ha poderi né giardini né campagne incrementate dal lavoro di coloni forestieri, né redditi di capitali investiti nei mercati. Vergognatevi, voi che cadete in estasi davanti alle ricchezze! Guardate il cielo: vedrete un dio nudo e disadorno, un dio che dà tutto e non possiede nulla. Allora? Lo ritenete ancora povero, Diogene, o non vi sembra simile a dio quest’uomo che si è spogliato di cose contingenti, che sono legate al capriccio della fortuna? Considerate più felice Demetrio Pompeiano,18 che non ebbe vergogna di essere più ricco di Pompeo? Si faceva dire ogni giorno il numero dei suoi servi, come a un generale si riferisce quello dei soldati, quando sarebbe stato anche fin troppo ricco con due aiutanti e una stanzetta appena un po’ più grande del normale. Quanto diverso Diogene, che, fuggitogli l’unico schiavo e benché gl’indicassero il luogo in cui s’era nascosto, non volle riprenderlo, anzi esclamò: «Sarebbe una vergogna che Diogene non potesse vivere senza Mane, quando Mane può vivere senza Diogene!». Come a dire: «Giri pure Fortuna la sua ruota come le piace, in me non c’è più nulla di quanto m’aveva dato: mi ha fatto scappare lo schiavo? No, me ne sono liberato». La servitù vuole cibo e vestiti, bisogna riempire lo stomaco di tanti voracissimi animali, comprargli gli abiti, sorvegliare quelle loro manacce rapaci, servirsi di gentucola che sa soltanto piangere e imprecare. Quanto più felice chi è debitore solo di sé stesso, di uno, cioè, a cui non costa nulla dire di no! Ma se non abbiamo tanta forza da disfarci dei nostri beni, riduciamoli, almeno, e diminuiremo così gli assalti della fortuna. In guerra sono meno esposti alle ferite e più svelti a scansarle i magri che non i grassi, perché possono coprirsi più facilmente dietro le proprie armi. La misura migliore per il denaro è quella che non scende al livello della povertà ma nemmeno se ne allontana. 9. Ma questa misura potremo accettarla solo se prima avremo gustato la parsimonia, senza la quale le nostre sostanze o sono insufficienti o non sono sufficienti abbastanza; ed è, la parsimonia, un rimedio piuttosto facile, a portata di mano, mentre la stessa povertà, quando l’intacchi la frugalità, può diventare ricchezza. Abituiamoci a tenere lontano il lusso, a giudicare le cose non dalla loro esteriorità ma dall’uso a cui sono destinate: il cibo sazi la fame, le bevande la sete, il sesso si sfoghi quel tanto che richiedono le esigenze naturali; impariamo a servirci delle nostre gambe, a conformare la nostra condotta di vita e la nostra alimentazione non alla moda corrente ma ai costumi dei nostri padri; impariamo a rafforzare la temperanza, a contenere il benessere, a moderare l’ambizione, a frenare la collera, a guardare di buon occhio la povertà, a coltivare la frugalità, anche se molti se ne vergognano, a usare per i nostri bisogni naturali dei rimedi che costano poco, a tenere come in catene le speranze esagerate e l’animo sempre proteso verso il futuro, a ricercare insomma la
ricchezza in noi stessi invece di chiederla alla fortuna. Le burrasche della vita sono così varie e numerose che quante più navi mettiamo in mare tanto più ne siamo assaliti: se vogliamo che gli strali della sorte cadano a vuoto dobbiamo ridurre in breve spazio noi e le nostre cose: è così che talvolta anche l’esilio può rivelarsi un bene e con piccoli disagi si sanano mali più gravi. Quando uno è sordo a ogni insegnamento e non si lascia prendere con le buone non gli sono utili, forse, rimedi come la povertà, il disonore e i rovesci di fortuna? Un male scaccia l’altro. Abituiamoci dunque a mangiare senza tanta gente intorno, a dipendere dal minor numero possibile di servitori, a procurarci dei vestiti il cui scopo non sia altro che quello per cui sono stati inventati e ad abitare in più piccolo spazio: come nelle corse e nelle gare del circo, così anche nei percorsi della vita le curve vanno prese molto strette. Pure le spese per gli studi, che sono le più nobili, devono essere oculate, non andare al di là delle nostre reali possibilità di lettura, perché non ha senso ammassare libri su libri e costruire intere biblioteche quando poi in tutta la vita si finisce col leggere a malapena i titoli delle opere. Una quantità di libri eccessiva è solo di peso, non istruisce, è meglio dedicarsi a pochi autori piuttosto che perdersi fra molti. La biblioteca di Alessandria d’Egitto, in cui andarono bruciati ben quarantamila volumi,19 potrà anche essere esaltata quale splendida testimonianza della munificenza regale – come fanno molti, compreso Livio,20 che la definisce un capolavoro di eleganza e di premura verso i sudditi da parte dei re – ma in realtà non fu né un fatto di buon gusto né una prova di sollecitudine alcuna, fu solamente un lusso letterario, anzi neppure, perché quella biblioteca venne allestita solo a fini spettacolari: così fanno molte persone, che non conoscono nemmeno l’abbiccì e tengono in casa i libri non quali strumenti di studio ma come ornamento nelle loro sale da pranzo.21 Compriamo dunque soltanto i libri che ci servono e non per metterli in mostra. Tu mi dirai che è meglio spendere in libri piuttosto che in quadri o in bronzi di Corinto,22 ma non è questo il punto: in ogni cosa il troppo è sempre un difetto. Si può scusare un uomo che va acquistando librerie di cedro o di avorio, vi mette dentro le opere complete di autori sconosciuti o di scarso valore, e poi sbadiglia in mezzo a tutte quelle migliaia di volumi e si compiace solo dei frontespizi e dei titoli? È proprio nelle case delle persone oziose, prive di ogni interesse culturale, che si possono trovare tutte le opere degli storici e degli oratori sistemate in scaffali che arrivano magari sino al soffitto, perché oggi una casa non è fine, non è alla moda, se oltre al bagno e alla stanza termale non ha anche una bella biblioteca. Ci passerei sopra se a questo lusso si accompagnasse uno sviscerato amore per lo studio, ma il fatto è che tutti questi libri, opere perlopiù di grandi ingegni, raccolti e bene allineati con accanto i ritratti dei loro autori, molto spesso sono comprati solo per figura, per abbellire le pareti. 10. Adesso immagina di essere piombato inaspettatamente in una situazione difficile, che per una malaugurata circostanza, pubblica o privata, ti trovi col nodo alla gola e tu non sia capace né di scioglierlo né di spezzarlo. Ebbene,
pensa a quelli che hanno una catena al piede: in un primo tempo non riescono a trascinare i pesi che gl’impediscono il movimento delle gambe, ma poi, quando hanno capito che è inutile ribellarsi e che conviene accettare, fanno di necessità virtù, sopportano con coraggio e l’abitudine gli rende meno gravosa quella schiavitù. Non c’è vita per quanto disgraziata in cui non si possano trovare soddisfazioni, tranquillità e piaceri, a condizione che si riesca a dar poco peso ai propri mali, invece di renderseli odiosi. Il merito più grande della natura sta nell’averci dato l’abitudine, con la quale possiamo trovare sollievo ai nostri affanni: lei sa infatti a quante tribolazioni andiamo incontro nascendo e perciò ci ha reso familiari anche gli eventi più penosi. Nessuno potrebbe resistere a un dolore che mantenesse sempre la stessa intensità iniziale. Non si sfugge alla sorte: c’è chi è legato a lei con una catena d’oro e allentata, chi invece – e in questo solo sta la differenza – con una stretta e di vile metallo, ma tutti siamo incatenati, compresi quelli che incatenano,23 che se sono legati soltanto al braccio sinistro non per questo sono meno prigionieri degli altri. Alcuni sono legati alla carriera, altri al denaro, altri ancora al fatto di essere nobili o, viceversa, di oscuri natali, taluni sono in potere di altri, altri, invece, di sé stessi, e c’è chi è costretto a vivere sempre nello stesso posto, come gli esuli e i sacerdoti. La vita è tutta una schiavitù. Bisogna quindi abituarsi alla propria condizione, lamentarsene il meno possibile e approfittare di tutti quei vantaggi che ci offre: nessuna sorte infatti è così dura da negare un po’ di conforto, almeno a chi riesca a raggiungere un certo equilibrio interiore. Spesso spazi ristretti, se ben progettati, possono essere utilizzati in molti modi, e anche un locale angusto, quando sia ben sistemato, può diventare abitabile. Bisogna spremersi la testa di fronte alle difficoltà, far lavorare la ragione, così le amarezze possono essere addolcite, le ristrettezze allargarsi e i pesi essere meno gravosi, se si portano opportunamente. Non bisogna poi spingere i desideri oltre il limite a cui possono razionalmente arrivare, tuttavia è bene consentire loro delle sortite, poiché non sopporterebbero una reclusione totale. Messo da parte ciò che non possiamo realizzare o la cui attuazione ci costerebbe troppa fatica, poniamo mano a imprese che siano alla nostra portata, che arridano facilmente alle nostre speranze, tenendo però presente che tutte le attività sono fuggevoli, diverse solo all’aspetto, dentro ugualmente vuote. E non invidiamo chi sta più in alto di noi: le cose che sembrano eccelse sono poste sull’orlo del precipizio. Quelli poi che un destino sfavorevole ha collocato in una posizione piena di rischi staranno sicuri se la spoglieranno della sua naturale superbia, facendo scendere la propria fortuna a un livello modesto. Ci sono infine molti che devono mantenersi necessariamente all’altezza a cui sono arrivati, giacché l’allontanarsene anche solo di un passo comporterebbe un crollo totale,24 ma riconoscano, almeno, e lo dicano a chiare lettere che quel gravare sugli altri gli pesa più che mai e che non stanno comodamente seduti su quella vetta bensì sospesi ad essa. Siano giusti con gli altri, miti, cortesi e largamente generosi:
potranno così procurarsi molte pezze di appoggio per propiziarsi gli eventi, e con questa speranza si sentiranno più sicuri in quella loro precaria condizione. Niente però potrà affrancarci meglio da questo continuo fluttuare dell’animo quanto il proporci sempre un limite nel nostro andare avanti, non rimettendo la conclusione all’arbitrio della fortuna, ma fermandoci noi, di nostra iniziativa, e molto prima di quella fine stessa voluta dalla sorte. Così, se il nostro animo sarà sollecitato da certe aspirazioni, queste, una volta che siano delimitate, non potranno spingerlo lungo un cammino incerto e senza meta. 11. È chiaro che tutto quello che ho detto riguarda le persone imperfette, mediocri e poco assennate, non il saggio, il quale non procede timidamente, passo per passo, perché ha tanta fiducia in sé stesso da andare incontro alla sorte con sicurezza e senza doverle mai cedere. E non la teme, inquantoché considera ogni cosa come un bene precario, non soltanto i suoi averi, la sua posizione, la servitù, ma anche il suo corpo, gli occhi, le mani, tutto ciò che gli rende cara la vita, e persino il suo essere uomo: vive, insomma, la sua esistenza come un prestito fatto a sé stesso, pronto a restituirla senza rimpianto quando ne sarà richiesto. Non per questo, però – per il fatto, cioè, di non ritenersi padrone di sé stesso – si tiene in poco conto, ma al contrario fa tutto con diligenza e precisione, come una persona onesta e scrupolosa conserva ciò che le è stato dato in custodia. E quando gliene sarà chiesta la restituzione non si lagnerà con la sorte, ma dirà: «Ti ringrazio per quanto ho avuto e goduto, ho curato i tuoi beni e li ho fatti fruttare, ma poiché ora così mi comandi te li restituisco di buon grado e riconoscente. Se vuoi che mi trattenga qualcosa lo custodirò, se no, prenditi pure l’argenteria, il denaro, la mia casa e la mia servitù». E se a chiamarci sarà la natura, che è la nostra prima creditrice, le diremo: «Eccoti l’anima mia, migliore di come me l’hai data, non tergiverso, non mi tiro indietro, ti restituisco immediatamente e in piena coscienza ciò che mi hai prestato quando non ero ancora cosciente: pòrtatelo via». Perché dovremmo dispiacerci di tornare colà da dove siamo venuti? Si vive male al pensiero di non poter morire serenamente. Per prima cosa, dunque, bisogna non dare importanza alla vita, o annoverarla fra le cose di poco conto. Come osserva Cicerone, disprezziamo e vogliamo morti quei gladiatori che chiedono salva la pelle a ogni costo, ammiriamo invece e risparmiamo quelli che mostrano di non curarla.25 Lo stesso accade a noi: spesso ci causa la morte il solo averne paura. La fortuna, che appronta e regge il gioco della vita a suo esclusivo uso e consumo, dice: «Perché dovrei risparmiare te, essere vile e meschino? Proprio per questo ti ferirò e ti trafiggerò, perché non sai offrire la gola. Tu, invece, che sei pronto a ricevere il colpo con coraggio, senza tirare indietro il collo o proteggerlo con le mani, vivrai più a lungo e avrai una fine veloce». Chi ha paura della morte è come se fosse già morto, chi invece è cosciente che fin dall’atto del concepimento è destinato a morire, vivrà conforme a questa legge e nel medesimo tempo, con la stessa forza d’animo, otterrà che qualunque cosa gli accada non lo trovi mai impreparato. Pensando infatti in
anticipo tutto quanto il possibile come se dovesse realmente accadere, mitigherà l’assalto di qualunque avversità, giacché per lui, che è preparato e se li aspetta, i mali non sono una novità, mentre risultano molto gravosi a chi si crede al sicuro e si attende solo cose buone. «Malattie, prigionie, incendi, crolli, rovine, niente di ciò può giungermi inatteso», così pensa chi è preparato a tutto. «Sapevo benissimo in quale tumultuosa coabitazione la natura mi aveva rinchiuso: quante volte nei pressi della mia casa ho udito grida di dolore, quante volte davanti alla mia soglia ho visto passare portatori di fiaccole e di ceri che accompagnavano il feretro di gente morta prematuramente; spesso proprio accanto a me ho sentito il fragore di un edificio che crollava e molti di quelli con cui durante il giorno m’ero trattenuto a parlare, nel foro o nel senato, nella notte sono spariti; quante strette di mani non ha diviso la morte! Perché dunque dovrei meravigliarmi se quei pericoli che mi stanno sempre intorno dovessero abbattersi anche su di me?». Generalmente chi si mette in mare non pensa a una burrasca. Ebbene, a questo proposito, non mi vergogno di citare una frase di un cattivo autore, poiché la giudico buona e opportuna: Publilio Siro,26 uno degl’ingegni più vigorosi fra i poeti tragici e comici – quando sa mettere da parte gli scherzi tipici dei mimi e quel frasario destinato alla plebe del loggione – fra le tante cose, di tono superiore non solo alla commedia ma anche alla tragedia, dice: Quello che accade a uno può capitare a tutti. Se assorbiremo nel profondo delle nostre viscere questa verità e guarderemo a tutte le disgrazie altrui – e ce ne sono tante ogni giorno! – come se avessero via libera anche presso di noi, ci armeremo molto prima di essere assaliti. È difficile abituarsi a un pericolo dopo che questo ci è piombato addosso, è tardi, ormai, per poterlo sopportare. «Non pensavo», diciamo, «che sarebbe accaduto». Oppure: «Ma chi poteva credere che potesse accadere?». E perché mai non dovremmo crederlo? Non c’è ricchezza che non sia insidiata dalla povertà, dalla fame, dall’indigenza più nera. Non c’è una carica pubblica il cui abito, le cui insegne e le cui nobili decorazioni non si accompagnino ad accuse infamanti, a vergognose note di censura, a mille macchie e al discredito estremo. Non c’è regno che non sia soggetto a un crollo, a un rovesciamento, a un tiranno, un carnefice. E spesso il cambiamento non si verifica gradualmente, nell’arco di un secolo o di decenni: in un fiat si passa dal trono ad abbracciare le ginocchia altrui. Non c’è condizione umana che non possa rovesciarsi, e quel che accade a uno può capitare anche a te. Sei ricco? Anche più di Pompeo? 27 Eppure a questi, quando Caligola, suo vecchio parente, gli aprì le porte della reggia, accogliendolo come suo ospite, dopo avergli fatto vendere la casa, vennero a mancare persino il pane e l’acqua. Con tanti fiumi che possedeva, che nascevano e scorrevano nel suo territorio, si ridusse a mendicare una goccia d’acqua; morì di fame e di sete nel palazzo regale del suo congiunto, che, erede dei suoi beni, gli faceva preparare, dopo averlo affamato, un funerale a spese dello Stato. Hai
ricoperto le più alte cariche? Così grandi, così inattese e illimitate come quelle di Seiano?28 Ebbene, questi il giorno stesso in cui il senato lo licenziò fu fatto a brani dal popolo e di lui, sul quale gli uomini e dio avevano fatto affluire tutto ciò ch’è possibile accumulare, non restò un solo brandello che uno dei suoi carnefici potesse ancora strappare. Sei re? Non ti parlo di Creso,29 che mandato sul rogo lo vide accendersi e spegnersi, superstite del proprio regno e della propria morte, né di Giugurta, che, nel giro di un anno da che lo aveva temuto, il popolo romano vide in catene come prigioniero: nelle carceri di Caligola abbiamo visto un re d’Africa, Tolomeo, e uno d’Armenia, Mitridate, questi mandato in esilio, quello ucciso slealmente, quando sperava d’essere esiliato. In mezzo a tanto turbinio di eventi, se non ti aspetti che tutto il possibile possa davvero accadere, ti rendi ancora più ostili le avversità, se invece le prevedi puoi mandarle in frantumi. 12. Un’altra cosa da evitare è il dedicarsi ad attività sterili o l’affaticarsi inutilmente, voglio dire che bisogna guardarsi dal desiderare ciò che non ci è possibile ottenere o che, una volta conseguito, ci faccia capire, troppo tardi, ahimè, l’inutilità di tanti sforzi e di tanto sudore. Facciamo dunque in modo che la nostra fatica riesca utile e redditizia e il risultato proporzionato allo sforzo, perché se poi viene meno il successo o se ciò che abbiamo ottenuto ci diventa motivo di vergogna ci prenderà lo scontento, l’insoddisfazione. Evitiamo anche di correre di qua e di là, come fanno i più, che sono sempre in movimento, dalla casa al teatro, alla piazza, al mercato e via correndo, che s’impicciano quotidianamente degli affari degli altri, con l’aria di chi è sempre affaccendato. Se quando escono di casa gli chiedi: «Dove vai? Cos’hai da fare?», «Non lo so», ti rispondono, «ma qualcosa farò, incontrerò qualcuno». E così vanno in giro, senza meta e senza scopo, in cerca d’incombenze occasionali, affidandosi al caso non a impegni precisi, prestabiliti. Fanno, insomma, come le formiche quando vanno su e giù, disordinatamente, lungo i tronchi degli alberi, e ogni volta che scendono non trasportano niente. Ce ne sono di quelli, poveretti, che corrono a precipizio, come se andassero a spegnere un incendio, si scontrano con i passanti, li fanno cadere e cadono essi stessi, mentre si lanciano a salutare uno, che poi magari non se li fila nemmeno, che fanno a gomitate per andare a mettersi in coda dietro il funerale di un tizio che non hanno conosciuto manco di vista, che s’intrufolano nel tribunale per assistere al processo di un eterno attaccabrighe o nel mezzo dell’ennesimo matrimonio di una pluridivorziata,30 finché, messisi dietro la lettiga, dànno pure una mano a trasportarla. Tornati a casa, stanchi, estenuati per quel niente che hanno fatto, giurano di non sapere nemmeno loro il motivo per cui sono usciti e dove sono stati, ma l’indomani, puntualmente, sono di nuovo in pista. Ogni fatica, dunque, abbia un fine, una meta. Quelli che vagano a caso, senza un lavoro preciso e prefissato, sono come i pazzi agitati da false visioni, e però neppure i pazzi si muovono a vuoto, anche loro vanno dietro a qualcosa, pur se, malati di mente come sono, non riescono a vederne
l’inconsistenza. Così appunto fanno quelli che escono solo per ingrossare la folla, che vanno in giro per la città spinti da vani o stupidi motivi, che, non avendo niente da fare, appena sorge il sole sono già per la strada, bussano a destra e a sinistra e molte volte, non trovando il padrone di casa o messi alla porta dalla servitù, lasciano i loro saluti all’inserviente addetto a tale scopo,31 e si arrabbiano, magari, perché il padrone non si è fatto trovare, quando loro sono sempre assenti da casa. Da questa sorta di malattia deriva il pessimo vizio di spiare i segreti degli altri, vuoi privati che pubblici, e spesso si viene a conoscenza di fatti che, non che raccontarli, è già un rischio il solo averli ascoltati.32 13. Così la pensava Democrito, che nella sua opera sulla serenità esordisce appunto dicendo che «chi vuol vivere in pace non deve avere troppe occupazioni, né private né pubbliche».33 Naturalmente si riferisce a quelle superflue, perché gl’impegni della vita che non si possono evitare, più che molti, sono innumerevoli, ma quando non c’è nessun «tu devi», nessun imperativo categorico che ce lo imponga, le nostre attività vanno limitate. A fare più cose di quante non bisogni si è maggiormente esposti ai capricci della sorte e noi invece dobbiamo provocarla il meno possibile, pensando a lei, certamente, ma senza darle troppo spago e troppa fiducia. «Farò un bel viaggio in mare. Salvo imprevisti». Oppure: «Diventerò pretore. Se niente me lo impedirà». O ancora: «Quest’affare mi andrà bene. A meno che qualcuno non mi metta il bastone fra le ruote». Così dobbiamo dire. Per questo al saggio non può accadere nulla che già non abbia previsto: non che i malanni non lo tocchino, ma lui non fa gli errori che facciamo noi; non che tutto gli vada bene come voleva, gli va, semplicemente, com’era incluso nelle sue previsioni. Egli, insomma, le pensa tutte, mette nel conto fin dall’inizio tutti gli accidenti che possono ostacolare i suoi piani, sicché la sua delusione di fronte a un fiasco è meno dolorosa e più sopportabile di quella di chi invece s’era prefisso un successo a tutti i costi. 14. Dobbiamo poi essere flessibili, non troppo ostinati nei nostri propositi, seguire anche le circostanze, senza con ciò temere o vergognarci di cambiare idea o stato. Sempreché non assumiamo la volubilità a nostra regola di vita, il che fa a pugni con la quiete e la tranquillità. Se infatti l’incaponirci in un progetto comporta inevitabilmente ansia e tormento, inquantoché la sorte ci toglie sempre qualcosa, la volubilità è ancora più dolorosa, perché non ci consente di soffermarci su nulla, non ci dà tregua. Comunque entrambe le cose, il non voler cambiare e il non contentarsi di niente, sono nemiche della serenità. Dobbiamo allora ripiegare in noi stessi, chiuderci al mondo esterno: il nostro animo gioisca solo di sé, confidi solo in sé, non badi ad altro che a sé, apprezzi unicamente ciò ch’è suo, insensibile a qualsiasi perdita, benevolo verso le avversità. Zenone, alla notizia che un naufragio gli aveva colato a picco ogni suo avere: «Meglio così», rispose: «La sorte ha voluto rendermi più libero, perché mi dedichi
interamente alla filosofia». Il filosofo Teodoro,34 minacciato di morte – e, peggio ancora, insepolto – dal tiranno, esclamò: «Hai di che compiacerti per quest’oncia di sangue che mi togli! Quanto alla sepoltura, per me non fa nessuna differenza marcire sotto terra o alla luce del sole». Giulio Cano,35 uomo tra i più eccellenti (non meno degno di ammirazione per il fatto d’essere nato in questa nostra epoca), ebbe un violento alterco con Caligola e mentre se ne andava, avendogli quel Falaride gridato: «Non sperare di farla franca, perché ho già dato l’ordine di ucciderti!», «Grazie, ottimo principe», rispose. Cosa volesse dire esattamente nessuno può saperlo, si possono solo fare delle ipotesi. Forse voleva offenderlo e mostrargli quant’era grande la sua crudeltà, di fronte alla quale la morte diventava un favore. O forse gli rinfacciava la sua quotidiana pazzia, visto che lo ringraziavano anche quelli a cui sgozzava i figli o confiscava i beni. O accettò la morte come una liberazione? In ogni modo non avrebbe potuto dare una risposta più nobile. Qualcuno obietterà che rispose così perché Caligola di fronte a una tale prova di coraggio avrebbe potuto graziarlo. No, Cano non aveva affatto paura e sapeva benissimo che Caligola non recedeva da simili ordini. Ebbene, lo crederesti che passò i dieci giorni che lo separavano dalla morte senza il minimo turbamento? Il suo comportamento, le sue parole, i suoi gesti, la sua serenità superano ogni immaginazione. Stava giocando a dama,36 quando arrivò il centurione che conduceva gli altri condannati, e, avendolo quello chiamato, prima contò le pedine, poi, rivolto al suo compagno: «Bada», gli disse, «dopo la mia morte non andare a raccontare che stavi vincendo tu». Quindi, facendo un cenno al centurione: «Tu mi sei testimone che lo vinco di un punto». Io non credo che Cano stesse giocando davvero: era solo un pretesto per farsi beffe del suo assassino. «Perché siete così tristi?», disse agli amici che non riuscivano a capacitarsi di dover perdere un uomo simile. «Voi starete ancora a domandarvi se l’anima è immortale, io lo saprò fra poco». Non cessò di cercare la verità persino in punto di morte, che anzi fece argomento di discussione. Lo accompagnava il suo filosofo personale, ed era già vicino al tumulo su cui si compiva ogni giorno un sacrificio a Cesare, nostra divinità, quando, avendogli quello chiesto: «Che cosa pensi, Cano? Qual è il tuo stato d’animo?», «Voglio vedere», rispose, «se in quel rapidissimo istante in cui volerà via dal corpo, la mia anima ne avrà coscienza», e promise che se avesse appurato qualcosa avrebbe fatto il giro degli amici per rivelare loro qual è lo stato delle anime. Ecco, questa è la vera serenità, in mezzo alle tempeste, ecco un mortale degno dell’eterno, che chiama il suo stesso morire a testimone della verità, che, giunto a quell’ultimo passo, interroga l’anima fuggitiva, e impara oltre la morte. Chi è stato più filosofo di lui? Quest’uomo insuperabile non può essere dimenticato, di lui si deve parlare con venerazione, e noi lo consacriamo al ricordo dei secoli avvenire, gloriosissimo eroe, che, da solo, incarna una gran parte delle stragi di Gaio. 15. Ma non serve a nulla l’aver rimosso tutti i motivi di tristezza personale,
quando alla vista di tanti delitti che restano impuniti ci prende l’odio per l’intero genere umano. Nel constatare quanto sia rara la semplicità e sconosciuta del tutto l’innocenza, come quel poco di lealtà che ancora esiste sia subordinato ai vantaggi che ne possono derivare, che i guadagni e i danni provocati dalla libidine vanno di pari passo nella ripugnanza che suscitano e che l’ambizione ha superato i limiti al punto da gloriarsi della sua bassezza, l’animo si confonde e, come se fossero state sovvertite tutte le virtù, che ormai non solo non formano più oggetto di desiderio ma addirittura non è nemmeno utile possedere, va brancolando in una fitta tenebra. In questo generale sfacelo non ci resta che adattarci, nel senso, voglio dire, che dobbiamo considerare tutti questi vizi non odiosi ma ridicoli, farne oggetto di scherno, e comportarci come Democrito, più che come Eraclito:37 questi, infatti, quando si trovava fra la gente piangeva, quello, invece, rideva; l’uno considerava disgrazie tutte le azioni umane, l’altro delle sciocchezze. Bisogna dunque non dare peso alle cose e prenderle a cuor leggero. Il vero uomo se ne ride della vita, non se ne lamenta, e così è anche più utile all’umanità, perché lascia un po’ di spazio alla speranza, mentre chi piange si comporta da stolto, inquantoché dispera che le cose si possano modificare, anzi, dirò che in generale è più magnanimo chi non riesce a trattenere il riso di chi non frena le lacrime, inquanto il primo riduce le sue emozioni a un livello superficiale e nel grande scenario della vita non vede nulla di tanto importante che meriti di essere preso in seria considerazione, e neppure niente di meschino. Se esaminiamo una per una le ragioni che ci rendono lieti o tristi, non possiamo non riconoscere la verità di quanto affermava Bione, che cioè tutte le attività umane valgono per la loro spinta iniziale e che la vita non è più sacra e importante in un essere fatto che in un embrione. Secondo me, però, è meglio accettare serenamente i costumi e i vizi degli uomini senza riderci o piangervi sopra, perché l’affliggerci per i mali altrui è un’angoscia continua e, d’altronde, farsene beffa è un piacere disumano. Com’è inutile pietà mettersi a piangere perché a uno è morto il figlio e fare la faccia di circostanza, così anche nelle nostre disgrazie bisogna concedere al dolore quanto richiede la natura e non la consuetudine. I più, infatti, versano lacrime solo per ostentazione, quando si trovano in presenza di altri, ma non appena gli spettatori se ne sono andati i loro occhi tornano asciutti: visto che piangono tutti, essi ritengono un dovere fare altrettanto e proverebbero vergogna se non si unissero al coro. Questo dipendere dall’opinione altrui è un vizio così radicato che persino il dolore, il sentimento più spontaneo e sincero, diventa una finzione. 16. C’è poi un’altra constatazione, che non a torto ci angoscia e ci addolora. Quando vediamo che i buoni fanno una brutta fine, che Socrate è costretto a morire in carcere, Rutilio a vivere in esilio, Pompeo e Cicerone a lasciarsi trucidare da uomini a cui hanno fatto del bene, e il grande Catone, immagine vivente di tutte le virtù, a gettarsi sulla propria spada, per denunciare pubblicamente il fallimento suo e dello Stato, non possiamo non sentirci
sconvolti, tanto grande ci appare l’ingiustizia con cui la sorte ripaga gli uomini giusti.38 Se i migliori fanno una simile fine, che di tutte è la peggiore, cosa dobbiamo sperare di noi? Questo ci domandiamo. Ma guardiamo anche come tali uomini affrontarono il proprio destino, e poiché sono stati forti e coraggiosi il nostro rimpianto sia degno di loro: quando uno muore da vigliacco o come una femminuccia il mondo non perde nulla. O uno è degno di essere ammirato per la sua virtù, o non lo è perché codardo, e allora non merita rimpianto. Non c’è vergogna maggiore che il lasciarsi intimidire dalla morte coraggiosa di così grandi eroi. Lodiamo altrettante volte chi ha più di un motivo di lode, e diciamo: «O tanto forte e tanto fortunato! Tu sei sfuggito a tutte le sventure, le malattie, l’invidia, ti sei liberato da questo carcere, dio non solo non ha voluto che ti sfiorasse la malasorte, ma che la sorte stessa avesse su di te qualche potere». Diamo invece addosso a coloro che cercano di sottrarsi al destino e persino in punto di morte pensano ancora alla vita. Io, quanto a me, non piangerò nessuno, né chi sia lieto né chi si sprema gli occhi dal dolore, il primo perché ha già prosciugato le mie lacrime, il secondo perché con le sue si è reso indegno delle mie. Dovrei piangere Ercole perché brucia vivo, Regolo perché è trafitto da tanti chiodi, o Catone che s’infligge ferite su ferite? Costoro con poca spesa di tempo, rinunciando a una piccola parte della loro vita, hanno trovato il modo, con la morte, di conquistarsi l’immortalità. 17. Un’altra fonte non trascurabile di preoccupazione è l’assumere sempre, di fronte agli altri, atteggiamenti non conformi alla propria natura, in poche parole, la mancanza di spontaneità. In questo modo la vita diventa una finzione e un tale comportamento è purtroppo molto diffuso: più che a essere, insomma, si tende ad apparire. Ne consegue un continuo e ossessivo controllo di sé stessi, perché si ha il timore di essere colti dagli altri in un atteggiamento diverso da quello che si suole assumere, e questa preoccupazione diventa una schiavitù da cui non si riesce a liberarsi, dovendo stare sempre all’erta, nella convinzione e nel timore di dover subire un esame ogni volta che si è osservati. È vero che ci sono dei casi in cui gli altri ci sorprendono, nostro malgrado, completamente nudi e disarmati, ma anche ammesso che questo autocontrollo ci riesca sempre e ci torni utile, non si può negare che il vivere con un’eterna maschera sul viso non solo non è facile ma non è nemmeno piacevole. Quanto è adorabile, invece, quella semplicità schietta e disadorna, che non nasconde il suo naturale e consueto modo di essere! Non dico che chi si comporta così non corra il rischio di essere criticato e magari disprezzato, tanto più quando si apre a tutti – c’è gente, infatti, che considera quasi un insulto un così facile accesso all’animo altrui – ma la virtù, pur se guardata da mille occhi, non perde comunque valore, e poi è meglio una spontaneità disprezzata che una simulazione continuamente sotto torchio. Attenzione, però: come in ogni cosa, anche qui ci vuole misura: un conto è la semplicità, un conto la sciatteria. Bisogna poi ritirarsi spesso in sé stessi, perché il contatto con persone diverse da noi e dissimili anche fra loro turba il
nostro equilibrio, riaccende le passioni, esulcera quanto ancora vacilla nell’animo o non è del tutto guarito. Bisogna perciò accoppiare e alternare le due cose, la solitudine e la compagnia: la prima ci farà sentire il desiderio del prossimo, la seconda di noi stessi, e l’una sarà un rimedio per l’altra, la solitudine guarirà l’avversione per la folla, la folla, a sua volta, la noia della solitudine. Non bisogna poi tenere la mente impegnata troppo a lungo e in uno stesso pensiero, occorre distrarla con svaghi e divertimenti: Socrate, per esempio, non si vergognava di giocare coi bambini,39 Catone addolciva col vino l’animo amareggiato dalle preoccupazioni politiche, e Scipione40 non si faceva scrupolo di affidare alla danza quel suo corpo vigoroso di guerriero e di trionfatore, senza però abbandonarsi a quelle movenze sdolcinate, tipiche di molti giovani nostrani che anche nel camminare vanno ancheggiando più di quanto non facciano le donne, ma mantenendo quel contegno virile che pur nel gioco e nella danza, durante i giorni festivi, mostravano i nostri uomini di un tempo, che anche di fronte ai loro nemici non avrebbero perso un solo briciolo di dignità. Bisogna dare all’animo un po’ di tregua: dal riposo riemergerà migliorato e più forte. Come un campo già fertile non va forzato affinché produca di più – perché una produzione ininterrotta finisce con l’esaurirlo – così una tensione continua toglie lo slancio alla mente, che può riprendere il suo pieno vigore solo se di quando in quando si rilassa o si distrae: una fatica assidua, senza soste, rende il cervello languido e ottuso. Del resto, il fatto che gli uomini amano lo svago e il divertimento prova che anche questi rientrano nelle esigenze naturali. Tieni però presente che l’abusarne finisce col toglierci forza e serietà: anche il sonno è necessario per rimetterci in sesto, ma se lo si protrae pure di giorno, incessantemente, non è più un sonno, è la morte. C’è una bella differenza fra interrompere e abolire. Per questo i legislatori istituirono i giorni festivi, costringendo gli uomini a svagarsi tutti insieme, affinché le fatiche fossero intercalate da pause necessarie, e alcuni, ancora più giudiziosi, si prendevano ogni mese delle vacanze fisse, altri dividevano la giornata fra attività e riposo. Così, ricordo, faceva Asinio Pollione, il grande oratore, che alle quattro del pomeriggio piantava tutto e scaricava, in due ore, la stanchezza della giornata: non leggeva neppure la corrispondenza, per evitare che potesse saltar fuori un motivo per qualche nuova faccenda o preoccupazione. Alcuni facevano un’interruzione a mezzogiorno, rinviando al pomeriggio i lavori più leggeri. I nostri antenati stabilirono anche che in senato non si accettassero nuove mozioni dopo le quattro pomeridiane. Nella vita militare ci sono i turni di guardia e quelli che rientrano da una missione sono esentati dal servizio notturno. Anche lo spirito ha bisogno di un po’ di riposo, che lo alimenti, lo risollevi e lo rinvigorisca, e a questo scopo saranno utili, per esempio, delle passeggiate all’aria aperta, che consentano di respirare a pieni polmoni, una gita in vettura, un viaggio, un mutamento di luogo, un bel pranzo con gli amici, un bicchiere di vino in più, magari anche l’ubriachezza, ma per tirarci su non già per annegare la nostra coscienza: l’ebbrezza, infatti, elimina gli affanni, ci smuove l’animo nel
profondo, e come cura certe malattie è anche una medicina per le nostre tristezze. L’inventore del vino fu chiamato Libero non perché col bere la lingua si faccia più sciolta e sciorini parole in libertà, ma perché il vino libera l’animo dalla schiavitù degli affanni, dei pensieri, lo rassicura, lo fortifica e lo rende più ardito a ogni impresa. Ma come la libertà, così anche il bere esige una misura. Dicono che Solone e Arcesilao avessero un debole per il vino e a Catone rimproveravano l’abitudine di ubriacarsi,41 il che può rendere onorevole il vizio, ma non disonorare quel grande uomo. Non bisogna però ubriacarsi spesso, per evitare di cadere nell’assuefazione; in ogni caso certe volte fa bene dare pieno sfogo all’esaltante libertà dell’animo, mettendo da parte per un poco l’austera sobrietà. Affidiamoci a quanto diceva il famoso poeta greco, secondo cui «talvolta è dolce anche far pazzie»,42 oppure a Platone, per il quale «non è poeta chi è sempre presente a sé stesso»,43 o, ancora, ad Aristotele, che sentenziava non esserci grande ingegno senza un pizzico di follia. Solo nell’eccitazione la mente può pronunciare parole nobili e inusitate, inquantoché nel disprezzo delle cose ovvie e volgari, spinta da una divina ispirazione, si solleva più in alto e allora canta in un modo che va al di là dell’umano. Finché rimane troppo attaccata a sé stessa non può toccare alcunché di sublime o inaccessibile, deve staccarsi dalla sua abituale condizione, uscire, mordere i freni e trascinare con sé il suo cocchiere, fin dove questi, senza tale stimolo, non avrebbe il coraggio di salire. Ecco, carissimo Sereno, queste sono le medicine per mantenere la tranquillità, per recuperarla e per scacciare i virus che possono inquinarla. Sappi, però, che nessuna di esse è di per sé sufficiente a guarire un animo fragile e pieno di tentennamenti, se questo, da parte sua, non si munisce di attente e assidue cure.
1. Di Annèo Sereno, prefetto delle guardie di Nerone, parla anche Tacito ( Ann. XII 13). La descrizione ch’egli fa qui dei propri mali deriva dalla consuetudine stoica ed epicurea (che Seneca aveva appreso dal filosofo Sestio) di praticare l’esame di coscienza. 2. Anche nelle Lettere a Lucilio (90, 15) Seneca accenna all’uso di fare scorrere ruscelletti d’acqua nelle sale dei banchetti. 3. Allude alla disperazione di Achille per la morte di Patroclo (Iliade, XVIII 10 sgg.). 4. Si tratta quasi certamente di Atenodoro di Tarso, discepolo di Posidonio e maestro nonché amico di Augusto, lodato da Cassio Dione e da Plutarco. 5. L’assessore era il funzionario che assisteva il pretore. 6. Quella del mare costretto a retrocedere a causa delle costruzioni, e delle deviazioni dei corsi d’acqua contra difficultatem locorum è un’immagine che si trova anche in Orazio (Arte poetica 64-68), il quale allude in particolare alle opere progettate da Cesare e da Augusto, e che però sembra condividere con Seneca il senso dell’inutilità di tali lavori. 7. Era consuetudine accompagnare uno a un processo, a garanzia e testimonianza del proprio sostegno con la sola presenza. 8.Pritano era il sommo magistrato di alcune città, come Rodi e Corinto; suffeta il primo magistrato di Cartagine; cerice era forse l’araldo dell’Areopago, il sommo tribunale di Atene.
9. I triari costituivano le truppe di riserva e occupavano l’ultima delle tre file in cui solitamente era schierato l’esercito. 10. I trenta tiranni sono i membri del collegio eletto ad Atene dopo la pace che seguì alla guerra del Peloponneso affinché elaborasse la nuova costituzione da dare alla città. I più famosi furono: Crizia, discepolo di Socrate, Teramene ed Eratostene. Il loro governo fu abbattuto dopo otto mesi, nel 403, a opera di 70 democratici, cresciuti poi di numero, guidati da Trasibulo e da Anito, e sostituito da un comitato di Dieci. Fu il periodo del più completo asservimento di Atene e Sparta. 11. Armodio e Aristogitone sono i tirannicidi che liberarono Atene dai Pisistratidi, uccidendo, nel 514 a.C., il tiranno Ipparco, figlio di Pisistrato. 12. Curio Dentato è il famoso console romano vincitore dei Sanniti, dei Sabini, dei Lucani e di Pirro. L’immagine di chi vive come un morto si trova anche in Lucrezio ( De rerum nat. III 1046): mortui cui vita est prope iam vivo atque videnti. 13. Eforo, che riversò anche nella storiografia il suo stile di retore, appreso proprio da Isocrate, scrisse 29 libri di Storie (Istorìai), andati perduti, che muovevano dall’invasione dorica nel Peloponneso (XI sec. a.C.) e arrivavano sino al 356. Un trentesimo libro (dal 356 al 340) fu aggiunto dal figlio Demofilo. Ci restano circa 250 frammenti. 14. Alla fine il testo è lacunoso. 15. Senofonte è lo scrittore e storico greco (565-470 a.C.) autore dell’Anabasi. 16. Bione è il filosofo cinico del III sec. a.C., noto per la sua mordacità. È ricordato anche da Orazio (Epist. II 2, 60). 17. Diogene è il famoso filosofo cinico, anch’egli del III secolo, che si ridusse a vivere in una botte. 18. Demetrio Pompeiano era un ricco e potente liberto di Pompeo. 19. Allude alla biblioteca di Alessandria nel cui incendio, avvenuto nel 47 a.C. quando Cesare prese la città, bruciarono parecchie migliaia di volumi (la cifra riportata da Seneca è inesatta), dei circa cinquecentomila che racchiudeva. 20. Livio è il grande storico romano (59 a.C.-17 d.C.) autore della storia di Roma Ab urbe condita. 21. Seneca rimprovera chi acquistava librerie in legno di cedro, preziosissimo e riservato ai mobili di lusso, quando egli stesso possedeva ben cinquecento tripodi di quel legno e con i piedi di avorio. 22. Corinto era nota per i suoi vasi di bronzo. 23. L’espressione «sono legati anche quelli che legano» richiama l’immagine del guardiano legato al condannato, come avviene oggi con le manette. 24. Anche la posizione di Seneca alla corte di Nerone era di quelli che non possono scendere da certe altezze se non cadendo, cioè con loro totale rovina. Seneca sembra qui voler quasi giustificare il suo restare nell’alta carica, pur se sospeso e non saldamente attaccato. 25. L’opera di Cicerone a cui Seneca si richiama per l’immagine dei gladiatori è il Pro Milone. 26. Publilio Siro era un mimografo noto per i suoi detti sentenziosi. 27. Del Pompeo a cui Seneca accenna si sa soltanto ch’era un parente di Caligola. Non ne abbiamo altra notizia. 28. Seiano, ricordato più volte da Seneca, era prefetto del pretorio sotto Tiberio. Fu ucciso dal popolo inferocito. 29. Creso, re di Lidia, fu graziato da Ciro mentre era già sul rogo. Erodoto (I 86) ci dà una lunga descrizione del fatto. 30. Il divorzio era ormai in Roma molto frequente. 31. Il nomenclator era lo schiavo che prendeva nota dei visitatori. 32. Quanto al rischio derivante dall’ascoltare e dal riferire i fatti altrui, si veda anche Plutarco (De curiositate 4, 517). 33. È l’inizio del libro di Democrito, citato nel II cap., Perì euthymìas, Sulla serenità. 34. Sull’episodio del filosofo Teodoro di Cirene si hanno anche altre fonti. Il tiranno è Lisimaco. 35. Su Giulio Cano non si hanno altre notizie. Falaride è il nome di un tiranno. 36. Quello dei latrunculi (pedine, ma anche «ladroni» e «soldati mercenari») era un gioco ai soldati o alla guerra, simile alla dama e agli scacchi. 37. Dell’atteggiamento di Eraclito e di Democrito di fronte alla gente Seneca parla anche nel De ira, II 10 5: «Eraclito, animo mite ma troppo debole, quando vedeva gente che viveva e moriva male, piangeva, e compiangeva quelli che gli si facevano incontro lieti e felici. Democrito, invece, ogni volta che andava fra la gente, scoppiava a ridere. In una situazione del genere», conclude Seneca, «in cui tutto è da piangere o da ridere, può esserci posto per l’ira?». 38. Quelli di Socrate, Catone e Regolo sono esempi ricorrenti. Quanto a Pompeo e Cicerone è ben nota la loro morte.
39. Quanto all’abitudine di Socrate di giocare coi bambini, Valerio Massimo racconta che un giorno Alcibiade sorprese il filosofo a cavallo di un bastone. 40. Scipione è l’Africano Maggiore, che vinse Annibale a Zama. 41. Della consuetudine di Catone di ubriacarsi parla anche Plutarco (Cato, VI). 42. Anche Orazio (Odi IV 12, 28) dice che dulce est desipere in loco, che ricorda il semel in anno licet insanire. 43. La frase di Platone è tolta dal Fedro (22, 245a), a cui si riferisce anche l’immagine dell’auriga (11).
De otio
1. * * * nobis magno consensu vitia commendant. Licet nihil aliud quod sit salutare tentemus, proderit tamen per se ipsum secedere: meliores erimus singuli. Quid quod secedere ad optimos viros et aliquod exemplum eligere, ad quod vitam derigamus, licet? Quod sine otio non fit: tunc potest obtineri quod semel placuit, ubi nemo intervenit qui iudicium adhuc imbecillum, populo adiutore, detorqueat; tunc potest vita aequali et uno tenore procedere quam propositis diversissimis scindimus. Nam inter cetera mala illud pessimum est, quod vitia ipsa mutamus. Sic ne hoc quidem nobis contingit, permanere in malo iam familiari: aliud ex alio placet, vexatque nos hoc quoque, quod iudicia nostra non tantum prava, sed etiam levia sunt. Fluctuamur aliudque ex alio comprehendimus; petita relinquimus, relicta repetimus: alternae inter cupiditatem nostram et paenitentiam vices sunt. Pendemus enim toti ex alienis iudiciis, et id optimum nobis videtur quod petitores laudatoresque multos habet, non id quod laudandum petendumque est, nec viam bonam ac malam per se aestimamus, sed turba vestigiorum, in quibus nulla sunt redeuntium. Dices mihi: «Quid agis, Seneca? Deseris partes! Certe Stoici vestri dicunt: – Usque ad ultimum vitae finem in actu erimus, non desinemus communi bono operam dare, adiuvare singulos, opem ferre etiam inimicis, eniti manu. Nos sumus qui nullis annis vacationem damus et, quod ait ille vir disertissimus, canitiem galea premimus; nos sumus apud quos usque eo nihil ante mortem otiosum est ut, si res patitur, non sit ipsa mors otiosa. – Quid nobis Epicuri praecepta in ipsis Zenonis principiis loqueris? Quin tu bene gnaviter, si partium piget, transfugis potius quam prodis?». Hoc tibi in praesentia respondebo: «Num quid vis amplius quam ut me similem ducibus meis praestem? Quid ergo est? Non quo miserint me illi, sed quo duxerint ibo». 2. Nunc probabo tibi non desciscere me a praeceptis Stoicorum, nam ne ipsi quidem a suis desciverunt (et tamen excusatissimus essem etiam si non praecepta illorum sequerer, sed exempla). Hoc quod dico in duas dividam partes: primum, ut possit aliquis vel a prima aetate contemplationi veritatis totum se tradere, rationem vivendi quaerere atque exercere secreto; deinde, ut possit hoc aliquis emeritis iam stipendiis, profligatae aetatis, iure optimo facere et ad alios occupationes referre, virginum Vestalium more, quae, annis inter officia divisis, discunt facere sacra et, cum didicerunt, docent. 3. Hoc Stoicis quoque placere ostendam, non quia mihi legem dixerim nihil
contra dictum Zenonis Chrysippive committere, sed quia res ipsa patitur me ire in illorum sententiam: quam si quis semper unius sequitur, non in curia, sed in factione est. Utinam quidem iam tenerentur omnia et in aperto confessa veritas esset nihilque ex decretis mutaremus! Nunc veritatem cum iis ipsis qui docent quaerimus. Duae maxime et in hac re dissident sectae Epicureorum et Stoicorum, sed utraque ad otium diversa via mittit. Epicurus ait: «Non accedet ad rem publicam sapiens, nisi si quid intervenerit». Zenon ait: «Accedet ad rem publicam, nisi si quid impedierit». Alter otium ex proposito petit, alter ex causa. Causa autem illa late patet: si res publica corruptior est quam ut adiuvari possit, si obscurata est malis, non nitetur sapiens in supervacuum nec se nihil profuturus impendet; si parum habebit auctoritatis aut virium nec illum erit admissura res publica, si valetudo illum impediet, quomodo navem quassam non deduceret in mare, quomodo nomen in militiam non daret debilis, sic ad iter quod inhabile sciet non accedet. Potest ergo et ille cui omnia adhuc in integro sunt, antequam ullas experiatur tempestates, in tuto subsistere et protinus commendare se bonis artibus et illibatum otium exigere, virtutum cultor, quae exerceri etiam quietissimis possunt. Hoc nempe ab homine exigitur, ut prosit hominibus: si fieri potest, multis; si minus, paucis; si minus, proximis; si minus, sibi. Nam, cum se utilem ceteris efficit, commune agit negotium: quomodo qui se deteriorem facit non sibi tantummodo nocet, sed etiam omnibus iis quibus, melior factus, prodesse potuisset, sic quisquis bene de se meretur hoc ipso aliis prodest, quod illis profuturum parat. 4. Duas res publicas animo complectamur: alteram magnam et vere publicam, qua dii atque homines continentur, in qua non ad hunc angulum respicimus aut ad illum, sed terminos civitatis nostrae cum sole metimur; alteram, cui nos scripsit condicio nascendi (haec aut Atheniensium erit aut Carthaginiensium aut alterius alicuius urbis), quae non ad omnes pertineat homines, sed ad certos. Quidam eodem tempore utrique rei publicae dant operam, maiori minorique; quidam tantum minori, quidam tantum maiori. Huic maiori rei publicae et in otio deservire possumus, immo vero nescio an in otio melius, ut quaeramus quid sit virtus, una pluresne sint, natura an ars bonos viros faciat; unum sit hoc quod maria terrasque et mari ac terris inserta complectitur, an multa eiusmodi corpora deus sparserit; continua sit omnis et plena materia ex qua cuncta gignuntur, an diducta et solidis inane permixtum; quae sit dei sedes, opus suum spectet an tractet, utrumne extrinsecus illi circumfusus sit an toti inditus; immortalis sit mundus an inter caduca et ad tempus nata numerandus. Haec qui contemplatur quid deo praestat? Ne tanta eius opera sine teste sit. Solemus dicere summum bonum esse secundum naturam vivere: natura nos ad utrumque genuit, et contemplationi rerum et actioni. 5. Nunc id probemus quod prius diximus. Quid porro? Hoc non erit probatum, si se unusquisque consuluerit quantam cupidinem habeat ignota
noscendi, quam ad omnes fabulas excitetur? Navigant quidam et labores peregrinationis longissimae una mercede perpetiuntur cognoscendi aliquid abditum remotumque. Haec res ad spectacula populos contrahit, haec cogit praeclusa rimari, secretiora exquirere, antiquitates evolvere, mores barbararum audire gentium. Curiosum nobis natura ingenium dedit et, artis sibi ac pulchritudinis suae conscia, spectatores nos tantis rerum spectaculis genuit, perditura fructum sui si tam magna, tam clara, tam subtiliter ducta, tam nitida et non uno genere formosa solitudini ostenderet. Ut scias illam spectari voluisse, non tantum aspici, vide quem nobis locum dederit: in media nos sui parte constituit et circumspectum omnium nobis dedit; nec erexit tantummodo hominem, sed etiam habilem contemplationem factura, ut ab ortu sidera in occasum labentia prosequi posset et vultum circumferre cum toto, sublime fecit illi caput et collo flexili imposuit. Deinde, sena per diem, sena per noctem signa perducens, nullam non partem sui explicuit, ut per haec quae obtulerat oculis eius cupiditatem faceret etiam ceterorum. Nec enim omnia nec tanta visimus quanta sunt, sed acies nostra aperit sibi investigandi viam et fundamenta vero iacit, ut inquisitio transeat ex apertis in obscura et aliquid ipso mundo inveniat antiquius: unde ista sidera exierint; quis fuerit universi status antequam singula in partes discederent; quae ratio mersa et confusa diduxerit; quis loca rebus assignaverit; suapte natura gravia descenderint, evolaverint levia, an praeter nisum pondusque corporum altior aliqua vis legem singulis dixerit; an illud verum sit, quo maxime probatur homines divini esse spiritus, partem ac veluti scintillas quasdam astrorum in terram desiluisse atque alieno loco haesisse. Cogitatio nostra caeli munimenta perrumpit nec contenta est id quod ostenditur scire: «Illud, inquit, scrutor quod ultra mundum iacet, utrumne profunda vastitas sit an et hoc ipsum terminis suis cludatur; qualis sit habitus exclusis, informia et confusa sint, an, in omnem partem tantundem loci obtinentia, et illa in aliquem cultum discripta sint; huic cohaereant mundo, an longe ab hoc secesserint et hic in vacuo volutetur; individua sint per quae struitur omne quod natum futurumque est, an continua eorum materia sit et per totum mutabilis; utrum contraria inter se elementa sint, an non pugnent, sed per diversa conspirent». Ad haec quaerenda natus aestima quam non multum acceperit temporis, etiam si illud totum sibi vindicat: cui licet nihil facilitate eripi, nihil neglegentia patiatur excidere, licet horas suas avarissime servet et usque in ultimum aetatis humanae terminum procedat nec quicquam illi ex eo quod natura constituit fortuna concutiat, tamen homo ad immortalium cognitionem nimis mortalis est. Ergo secundum naturam vivo si totum me illi dedi, si illius admirator cultorque sum. Natura autem utrumque facere me voluit, et agere et contemplationi vacare: utrumque facio, quoniam ne contemplatio quidem sine actione est. 6. Sed refert, inquis, an ad illam voluptatis causa accesseris, nihil aliud ex illa petens quam assiduam contemplationem sine exitu: est enim dulcis et habet illecebras suas. – Adversus hoc tibi respondeo: aeque refert quo animo civilem
agas vitam, an semper inquietus sis nec tibi umquam sumas ullum tempus quo ab humanis ad divina respicias. Quomodo res appetere sine ullo virtutum amore et sine cultu ingenii ac nudas edere operas minime probabile est (misceri enim ista inter se et conseri debent), sic imperfectum ac languidum bonum est in otium sine actu proiecta virtus, numquam id quod didicit ostendens. Quis negat illam debere profectus suos in opere tentare, nec tantum quid faciendum sit cogitare, sed etiam aliquando manum exercere et ea quae meditata sunt ad verum perducere? – Quid si per ipsum sapientem non est mora, si non actor deest, sed agenda desunt? Ecquid illi secum esse permittes? – Quo animo ad otium sapiens secedit? Ut sciat se tum quoque ea acturum per quae posteris prosit. Nos certe sumus qui dicimus et Zenonem et Chrysippum maiora egisse quam si duxissent exercitus, gessissent honores, leges tulissent: quas non uni civitati, sed toti humano generi tulerunt. Quid est ergo quare tale otium non conveniat viro bono, per quod futura saecula ordinet nec apud paucos contionetur, sed apud omnes omnium gentium homines quique sunt quique erunt? Ad summam, quaero an ex praeceptis suis vixerint Cleanthes et Chrysippus et Zenon. Non dubie respondebis sic illos vixisse quemadmodum dixerant esse vivendum. Atqui nemo illorum rem publicam administravit. – Non fuit, inquis, illis aut ea fortuna aut ea dignitas quae admitti ad publicarum rerum tractationem solet. – Sed iidem nihilo minus non segnem egere vitam: invenerunt quemadmodum plus quies illorum hominibus prodesset quas aliorum discursus et sudor. Ergo nihilo minus hi multum egisse visi sunt, quamvis nihil publice agerent. 7. Praeterea tria genera sunt vitae, inter quae quod sit optimum quaeri solet: unum voluptati vacat, alterum contemplationi, tertium actioni. Primum, deposita contentione depositoque odio quod implacabile diversa sequentibus indiximus, videamus an haec omnia ad idem sub alio atque alio titulo perveniant. Nec ille qui voluptatem probat sine contemplatione est, nec ille qui contemplationi inseruit sine voluptate est, nec ille cuius vita actionibus destinata est sine contemplatione est. – Plurimum, inquis, discriminis est, utrum aliqua res propositum sit an propositi alterius accessio sit. – Sane grande discrimen; tamen alterum sine altero non est: nec ille sine actione contemplatur, nec hic sine contemplatione agit, nec ille tertius, de quo male existimare consensimus, voluptatem inertem probat, sed eam quam ratione efficit firmam sibi. Ita et haec ipsa voluptaria secta in actu est. Quidni in actu sit, cum ipse dicat Epicurus aliquando se recessurum a voluptate, dolorem etiam appetiturum, si aut voluptati imminebit paenitentia aut dolor minor pro graviore sumetur? Quo pertinet haec dicere? Ut appareat contemplationem placere omnibus: alii petunt illam; nobis haec statio, non portus est. 8. Adice nunc quod e lege Chrysippi vivere otioso licet: non dico ut otium patiatur, sed ut eligat. Negant nostri sapientem ad quamlibet rem publicam accessurum: quid autem interest quomodo sapiens ad otium veniat, utrum quia res
publica illi deest an quia ipse rei publicae, si omnibus defutura res publica est? Semper autem deerit fastidiose quaerentibus. Interrogo ad quam rem publicam sapiens sit accessurus. Ad Atheniensium, in qua Socrates damnatur, Aristoteles ne damnetur fugit, in qua opprimit invidia virtutes? Negabis mihi accessurum ad hanc rem publicam sapientem. Ad Carthaginiensium ergo rem publicam sapiens accedet, in qua assidua seditio et optimo cuique infesta libertas est, summa aequi ac boni vilitas, adversus hostes inhumana crudelitas, etiam adversus suos hostilis? Et hanc fugiet. Si percensere singulas voluero, nullam inveniam quae sapientem aut quam sapiens pati possit. Quod si non invenitur illa res publica quam nobis fingimus, incipit omnibus esse otium necessarium, quia quod unum praeferri poterat otio nusquam est. Si quis dicit optimum esse navigare, deinde negat navigandum in eo mari in quo naufragia fieri soleant et frequenter subitae tempestates sint quae rectorem in contrarium rapiant, puto, hic me vetat navem solvere, cum laudet navigationem.
L’ozio o della contemplazione
Premessa L’otium, presso i Romani, racchiudeva molti significati, indicando il semplice ozio, il riposo dagli affari, la quiete, il tempo libero, la calma, la pace, ma anche un genere di attività diversa da quella abituale, che costituiva invece il negotium (= nec otium, non ozio). Rientrava dunque nell’otium anche lo studio, che potremmo definire una disoccupazione studiosa, la scolè dei Greci, da cui “scuola”. Il dialogo è dedicato a Sereno, un epicureo che Seneca si propone di convertire allo stoicismo, ma l’intento dell’autore non è solo quello di recare un aiuto all’amico, pieno di dubbi e di angosciose incertezze, bensì anche e specialmente quello di fornire giustificazioni logiche e morali al suo ritiro dalla politica (avvenuto nel 62, anno in cui l’opera fu scritta) soprattutto di fronte agli stoici, che sostenevano l’impegno attivo del saggio per tutta la vita, nisi si quid impedierit. Vicino per molti aspetti al precedente, il De vita beata (tanto che, essendo mutilo del principio e della fine, si ritenne che facesse parte di quello), il De otio nasce dunque da una situazione contingente e ciò lo condiziona, gli toglie il carattere di una speculazione pura, svincolata dagli eventi, che sarebbe più valida e accettabile. L’obiettività del dialogo è quindi già viziata in partenza e le affermazioni che vi sono contenute possono, in molti casi, essere messe in discussione. Le argomentazioni a cui Seneca fa ricorso, per giustificare il suo cambiamento di vita, sono infatti piuttosto arzigogolate, forzate e contraddittorie, né esauriscono il problema. Anche qui Seneca cerca di conciliare le cose, piegando la filosofia, il ragionamento, alla sua situazione personale: essendosi prima dedicato alla vita attiva non può sconfessarla, tantopiù che quella scelta l’ha fatta sempre da saggio, secondo i dettami dello stoicismo. E allora dice che «tutti possono dedicarsi alla vita contemplativa, perché anche questa ha una componente di attività», e, conseguentemente, che pure la vita attiva ha una componente di contemplazione, e che ce l’ha persino una vita dedita ai piaceri. Che genere di contemplazione è dunque quella di Seneca? Il riflettere, o il meditare, su tutte le cose, visibili e invisibili, «per capire perché» siamo stati collocati nel centro dell’universo, ci sia stata data una posizione eretta, una testa piazzata nella parte più alta del corpo sopra un collo snodabile per poter seguire il rotante corso degli astri, per capire, o cercar di capire, in che consistesse l’universo prima di dividersi e sparpagliarsi nelle sue varie parti, da dove siano venute fuori le stelle, chi abbia assegnato alle cose i loro specifici posti, e così via. Ma in questa descrizione più che contemplazione si avverte l’ansia di una ricerca, scientifica o filosofica, vicina a quella delle Naturales quaestiones (che Seneca compose o finì di comporre nello stesso periodo del suo ritiro dalla vita attiva). Non si tratta dunque della contemplazione in sé, bensì di una vita condotta lontano dall’attività pubblica, e più precisamente politica, ma non dal mondo sensibile, non dalle comodità che può offrire anche una casa modesta; non l’isolamento, non la vita dell’eremita. Per Seneca non si tratta di scegliere la vita contemplativa, quella attiva o quella del piacere (e perché non anche quella del dolore?), non si tratta di vedere il piacere distinto dalla virtù, il bene dal male e così via, ma di osservare o contemplare il tutto armonicamente composto, così come si trova nella mente di Dio. Questa è la vera contemplazione, in questo stanno la vera saggezza, la felicità, la serenità, la libertà, che è quanto dire il sommo bene. M. S. A.
1. * * * tutti sono d’accordo nel ritenere1 che vivendo in società è difficile essere immuni dai vizi, e allora, se non abbiamo altro mezzo per salvarci da essi, isoliamoci: già questo solo fatto ci renderà migliori. D’altronde chi c’impedisce, pur vivendo appartati, di avvicinare uomini virtuosi e ricavarne un esempio su
cui modellare la nostra esistenza? E ciò non è possibile se non in una vita tranquilla, lontana dalle pubbliche faccende: solo così potremo mantenere fermi i nostri propositi, non avendo accanto nessuno che, sollecitato dalla grande massa che gli sta intorno, possa distoglierci dalla nostra decisione, ancora instabile, all’inizio, e perciò facile a sgretolarsi. Allora sì la nostra vita potrà procedere uniforme e costante, perché non turbata dalle idee più diverse e contrastanti. Per giunta, come se già non bastassero i numerosi mali che ci affliggono, passiamo da un vizio all’altro, e questo è il guaio peggiore: restassimo almeno attaccati a un vizio solo, quello che ci è più familiare e che abbiamo ormai sperimentato! Così a questo inconveniente si aggiunge pure il tormento che ci rode nel constatare come le nostre scelte, oltre che cattive, siano anche incostanti. Siamo sballottati di qua e di là come dai flutti o dal vento, e ora ci attacchiamo a una cosa, ora a un’altra, lasciamo ciò che avevamo cercato e ricerchiamo ciò che avevamo lasciato, in un altalenante avvicendarsi di desideri e pentimenti. Questo perché dipendiamo sempre dalle opinioni degli altri, ci sembra migliore ciò che ha un gran numero di aspiranti e di elogiatori e non ciò che va lodato e ricercato per il suo intrinseco valore, così come una strada la giudichiamo buona o cattiva non di per sé stessa ma dalla quantità delle impronte e dal fatto che fra di queste non ce ne sia nessuna che torni indietro. Qualcuno mi dirà: «Ma Seneca, che fai? Tradisci la tua scuola? I tuoi compagni stoici, infatti, dicono chiaramente che bisogna partecipare alla vita attiva sino all’ultimo fiato, adoperarsi per il bene comune, aiutare gli uomini, singolarmente, soccorrendo persino i propri nemici, operare, insomma, in modo concreto, sforzandosi in prima persona. “Noi siamo quelli”, così essi dichiarano, “che non conosciamo congedi o aspettative, e come dice quel facondissimo poeta, anche vecchi e canuti combattiamo.2 Noi siamo quelli che non hanno un solo attimo di tregua finché non giunga la morte, al punto che – se mai fosse possibile – la morte stessa per noi non sarebbe un riposo”. E allora? Perché innesti i precetti di Epicuro sui princìpi basilari di Zenone?3 Se non ti va più a genio la tua scuola, perché non ti premuri di lasciarla, invece di comportarti come un traditore?». Gli rispondo così, per il momento: «Io seguo i miei maestri: cosa vuoi che faccia di più? Cammino sulle loro orme, non mi spingo oltre, dove essi non sono ancora arrivati». 2. Ora ti dimostrerò che io non mi allontano dagl’insegnamenti della scuola stoica, come non se ne sono allontanati neppure i suoi discepoli; ma anche se seguissi gli esempi di questi, invece che i precetti dei maestri, sarei più che scusato. E te lo proverò dicendoti due sole cose, prima di tutto che ci si può dedicare interamente alla contemplazione del vero fin dalla fanciullezza, cercando una propria norma di vita e praticandola nell’isolamento, in secondo
luogo che si può fare altrettanto e a buon diritto anche dopo essersi concretamente impegnati nella sfera sociale e quando ormai la vita volge al suo tramonto, passando ad altri il testimone, cioè la cura delle cose pratiche, come fanno, ad esempio, le Vestali, 4 che si dividono i compiti secondo l’età, per cui prima imparano a compiere i sacri riti e poi, finito il tirocinio, si dedicano all’insegnamento. 3. Ciò, del resto, è conforme alla dottrina stoica, e te lo dimostrerò, non perché qualche scrupolo mi vieti di andar contro i precetti di Zenone o di Crisippo,5 ma perché è proprio l’argomento stesso che mi trova d’accordo con loro due: quando si segue il parere di uno solo non si è più in un senato, fra gente libera, indipendente, ma in una fazione, in una corrente di partito. Magari sapessimo già tutto e la verità fosse così palese e incontestabile da mantenerci sempre nella stessa opinione! Noi ricerchiamo il vero insieme ai nostri maestri, che non ne sono i depositari unici e infallibili. Quanto alla vita meditativa, la scuola stoica e l’epicurea la pensano in modo diametralmente opposto e tuttavia, seppure per strade diverse, conducono entrambe a quel fine. Epicuro dice: «Il saggio non partecipi alla vita pubblica, se non costretto da qualche accidente». Zenone, invece: «Il saggio partecipi alla vita pubblica, se non vi sia qualcosa che glielo impedisca». L’uno sostiene l’isolamento come principio, l’altro come evenienza. E questa evenienza può essere di varia natura: se lo Stato, ad esempio, è talmente corrotto da non esservi aiuto capace di sanarlo minimamente, o se è accecato da troppi mali: in questo caso è inutile che il saggio sacrifichi le proprie forze, quando sa che il suo impegno non porterà alcun giovamento alla cosa pubblica; così pure se non avrà prestigio o vigore sufficiente, se la politica stessa, per qualche sua ragione, lo respingerà, o se non glielo consentirà la sua salute, anche allora il sapiente avrà un motivo plausibile per tenersi lontano dalla vita attiva; allo stesso modo che non si mette in mare una nave sconquassata o non ci si arruola nell’esercito se non si è abili alla vita militare, così il saggio non si avvierà lungo una strada che già in partenza ritiene impraticabile, per uno come lui. Ma anche chi abbia ancora intatte le sue forze potrà starsene al sicuro, prima di affrontare le tempeste della vita pubblica, e lontano da essa dedicarsi a più nobili occupazioni, in piena tranquillità, praticando le virtù, le quali possono essere coltivate e sperimentate anche nella quiete più assoluta e nel più totale isolamento. Questo si esige soprattutto dall’uomo, che sia di aiuto agli uomini: se è possibile, a molti, se non è possibile, a pochi, se no, a quelli che gli sono vicini, o, in ultima analisi, a sé stesso. Se infatti è vero che giovando al prossimo si compie un’opera d’interesse generale, è anche vero che – come chi si guasta nuoce a sé stesso e a quelli che avrebbe potuto aiutare se fosse rimasto onesto – pure chi agisce bene a suo esclusivo vantaggio giova alla società, perché si fa strumento di utilità per gli altri.
4. Immaginiamoci due tipi di Stato, uno immenso e veramente tale, nel senso che abbracci dèi e popoli diversi, e in cui lo sguardo nostro non si fermi su questo o quell’angolino ma ne misuri i confini seguendo il corso del sole, l’altro, assai più piccolo e specifico, in cui siamo nati per sorte (intendo dire Atene, Cartagine, o qualunque altra città), che non sia comune a tutti gli uomini ma solo a una parte determinata di essi. Ebbene, c’è chi si adopera per entrambi gli Stati,6 per quello più grande e per quello più piccolo, chi solo per uno dei due. Il più grande possiamo servirlo anche conducendo una vita ritirata, dedita alla meditazione, anzi, non so come si potrebbe farlo meglio che in questo caso, a condizione, però, che ci si dedichi allo studio della virtù, indagando se ve ne sia una sola oppure tante, se quel che rende virtuosi sia l’indole naturale o l’educazione, se ciò che abbraccia mari e terre coi loro rispettivi contenuti sia in sostanza un solo elemento, o se invece dio abbia disseminato nello spazio tanti elementi di tal fatta, se la materia da cui nascono tutte le cose sia una massa ininterrotta e compatta o discontinua, con degli spazi vuoti che si frammettono al pieno; e, ancora, dove risieda dio, se Egli muova la sua creazione e se ne prenda cura o si limiti a contemplarla, se ne sia fuori e l’abbracci, diffuso intorno ad essa, o la compenetri tutta, se il mondo, infine, sia eterno o si debba piuttosto annoverarlo fra le cose caduche e temporanee. Chi guarda a tutto questo rende un servizio a dio: testimonia infatti l’opera sua. Noi diciamo che il sommo bene è vivere secondo natura, e la nostra natura ha due facce, una rivolta alla contemplazione e l’altra, invece, all’azione.7 5. Quanto alla prima, la contemplazione, la prova della sua validità sta già nel fatto stesso che in ciascuno di noi è insito il desiderio di conoscere l’ignoto e vivo l’interesse per ciò che di lui si racconta. C’è chi si mette in mare e sopporta i fastidi di un lunghissimo viaggio per il solo e unico premio che può derivargli dallo scoprire cose sconosciute e lontane: è questo che attira le folle agli spettacoli, che c’induce a spiare attraverso le fessure ciò ch’è precluso al nostro sguardo, a esplorare i più profondi segreti, a consultare i libri antichi o ad apprendere i costumi di popoli stranieri. Questa curiosità ce l’ha data la natura, la quale, conscia della propria arte e del suo fascino, ci ha creati quali testimoni di un così stupendo spettacolo. Quale scopo, quale utilità avrebbe avuto la sua opera se cose tanto grandi e meravigliose, così accuratamente rifinite, così eleganti e splendide di mille e più bellezze le avesse sciorinate davanti a un deserto? Ma non ci ha fatti soltanto testimoni e spettatori passivi delle sue bellezze esteriori, essa vuole essere anche esaminata, scrutata, e a conferma di ciò basta considerare il luogo che ci ha assegnato: ci ha posti proprio nel suo centro,8 dandoci così la facoltà di vedere tutto ciò che ci circonda; e non solo ha dato all’uomo una posizione eretta, ma gli ha messo il capo in alto e sopra un collo snodabile, affinché possa osservarla più facilmente, seguire il rotante corso degli astri, dal loro sorgere al loro tramonto, e accompagnare il suo sguardo al movimento dell’intero universo. Poi, col far procedere le
costellazioni, sei di giorno e sei di notte, gli ha spiegato davanti ogni parte di sé, in modo che, per mezzo delle cose visibili che cadono sotto i suoi occhi, nasca in lui il desiderio di conoscere anche il resto. Noi, infatti, vediamo solo una parte delle cose, e molte, perdipiù, neppure nella loro grandezza reale, ma il nostro sguardo, acuto com’è, si apre la strada alla ricerca, avviandosi verso la verità, per cui la nostra indagine si sposta dalle cose visibili a quelle invisibili, sino a tentare la scoperta di una realtà ancora più antica del mondo stesso, e cioè da dove siano venute fuori le stelle, in che consistesse l’universo prima di dividersi e sparpagliarsi nelle sue varie e singole parti, in base a quale criterio gli elementi sommersi e confusi si siano separati, chi abbia assegnato alle cose i loro specifici posti, se i corpi pesanti vanno verso il basso e quelli leggeri verso l’alto per un principio insito in loro stessi, o se tale comportamento è invece determinato da una qualche forza superiore, al di là dell’impulso e del peso di ciascuno di essi, se sia vero che nell’uomo c’è uno spirito divino, e ciò in virtù del fatto che sulla terra sarebbero cadute dal cielo delle schegge, come scintille di stelle, posatesi qui, in una sede non propria. Il pensiero infrange le barriere del cielo, né si accontenta di conoscere ciò che si mostra allo sguardo. «Voglio andare», egli dice, «anche al di là dell’universo, per vedere se lo spazio è infinito o limitato anch’esso e imprigionato entro precisi confini, e quale sia l’aspetto di ciò che m’è precluso, se sia una massa informe e confusa o se, occupando in ogni direzione un’eguale quantità di spazio, anche tale materia sia disposta con un qualche ordine, collegata a questo mondo, o separata, ed esso ruota nel vuoto; se tutto ciò che è e che sarà sia costituito da elementi singoli e indivisibili o se la sostanza di questi sia omogenea e muti solo in virtù della sua totalità, e, ancora, se gli elementi siano fra loro discordi oppure no, se, pur nella loro differenziazione, tendano, per vie diverse, a un unico fine». Pensa, poi, quanto poco tempo abbia chi è nato per queste ricerche, sempre ammesso che riesca ad adoperarlo tutto. E quand’anche non se ne lasciasse sottrarre nemmeno un briciolo dalla negligenza o dalla faciloneria e si tenesse avidamente stretto, a tale scopo, ogni minuto della sua giornata e campasse cent’anni o anche più, senza che il caso gli porti via nulla di quanto gli ha concesso la natura, ebbene, l’uomo è sempre troppo mortale per poter pervenire alla conoscenza di cose immortali. Vive dunque secondo natura chi si dedica completamente a lei, per contemplarla e venerarla. Ma la stessa natura vuole anche che ci si dedichi all’azione, sicché possiamo fare entrambe le cose,9 e così faccio io, tantopiù che pure la contemplazione è, in definitiva, un’azione. 6. Ma occorre sapere – mi chiederà qualcuno – se ci si dedica alla vita meditativa solo per ricavarne un godimento, cioè per la contemplazione pura e semplice, ininterrotta e senza alcuno scopo o risultato, visto che di per sé è già uno stato piacevole e allettante. Rispondo che anche nella vita attiva bisogna vedere con quale disposizione vi si partecipa, se cioè ci volgiamo a lei solo per essere sempre in movimento, sì che non ci resti un briciolo di tempo per
sollevare il nostro sguardo mortale alla visione di cose divine. L’azione per l’azione non è accettabile. Il giusto agire richiede anche l’esercizio della mente e l’amore per la virtù, che devono mescolarsi e intrecciarsi con lui; allo stesso modo una virtù passiva, che si chiude in sé stessa, pigramente, senza mai tirar fuori e mostrare agli altri il frutto delle sue esperienze e delle sue scoperte, è un bene sterile e incompleto. È chiaro, invece, che anche sotto il profilo personale, la virtù deve sperimentare concretamente e progressivamente i risultati raggiunti, confrontandosi con la realtà sensibile: non si limiti a pensare come si debba o non si debba agire, ma passi anche all’azione, quando serva, mettendo mano a qualche lodevole impresa e portando così a effetto ciò che ha meditato. «E se ci fosse qualche impedimento, imputabile non al saggio – che da parte sua sarebbe pronto ad agire – bensì al fatto che mancano proprio le cose da fare? In questo caso gli permetterai di chiudersi in sé stesso?». Ma perché pensi che il saggio si isoli dal mondo, dedicandosi alla vita meditativa? Perché è convinto che anche così potrà giovare ai posteri. Perciò diciamo con convinzione che Zenone e Crisippo hanno compiuto imprese maggiori che se avessero guidato eserciti, ricoperto cariche pubbliche o promulgato leggi, perché anzi le leggi le hanno fatte e non per una sola città ma per tutto il genere umano. Perché dunque si dovrebbe negare a un uomo virtuoso di dedicarsi alla vita meditativa, se per mezzo di essa potrà farsi legislatore e guida alle generazioni future e parlare non a pochi ma a tutti gli uomini di tutte le nazioni, quelli che sono e quelli che saranno? Insomma, io ti domando se Cleante,10 Crisippo e Zenone siano vissuti secondo i propri insegnamenti. Risponderai certamente di sì. Eppure nessuno di loro rivestì cariche pubbliche. Mi obietterai che mancarono loro le occasioni favorevoli o quei titoli necessari che di solito si richiedono per l’attività politica. Ma non per questo trascorsero la vita nell’inerzia, anzi, trovarono il modo di rendere la loro tranquillità più utile agli uomini di quanto non sia l’attività affannosa e sudata degli altri. Hanno quindi agito, e molto, pur non essendosi mai impegnati concretamente nella vita pubblica. 7. In realtà sono tre i generi di vita fra cui si discute quale sia il migliore: il primo si prefigge il piacere, il secondo la contemplazione, il terzo l’azione. Per prima cosa – messe da parte la polemica e l’implacabile avversione che mostriamo sempre nei confronti di chi segue una dottrina diversa dalla nostra – vediamo se questi tre generi, anche se sotto aspetti diversi, giungano alla stessa conclusione. Tanto per cominciare, il piacere non esclude la contemplazione, come la contemplazione non esclude il piacere, e l’azione, a sua volta, comprende pure la contemplazione. «Però i fini sono diversi», mi obietterai. D’accordo, ed è anche notevole la loro differenza, però il fine e l’elemento accessorio che caratterizza i tre generi di vita sono strettamente legati fra loro: il contemplativo non può contemplare senza essere contemporaneamente attivo, l’attivo, a sua volta, non può agire senza contemplare l’oggetto del suo agire, e il gaudente, che tutti concordemente giudichiamo male, non cerca un piacere inerte,
cerca un piacere attivo e duraturo, che solo per via della razionalità può rendere tale, fissandolo dentro di sé in una continua contemplazione. Vista così, anche la scuola del piacere rientra nella vita attiva. E come potrebbe non rientrarvi, quando lo stesso Epicuro sostiene di essere pronto a rinunciare al piacere, e a cercare anzi il dolore, se il piacere fosse soltanto minacciato dal rimorso, o a scegliere il minore fra due mali? Dove voglio arrivare con questo discorso? A dimostrare, chiaramente, che la contemplazione piace a tutti, con la differenza che altri vi aspirano come a una meta finale senza ritorno, per noi invece è solo uno scalo, non un porto definitivo.11 8. Andando avanti dirò che secondo i princìpi di Crisippo la vita contemplativa è più che legittima, quando però derivi da una nostra libera scelta e non dall’adesione passiva a uno stato d’inattività. Gli stoici dicono che il saggio non parteciperà alla vita dello Stato quale che esso sia: se questo avvenga perché lo Stato manca al saggio o perché il saggio manca allo Stato cosa importa, quando lo Stato, prima o poi, viene a mancare a tutti? E mancherà sempre, a chi pretende troppo da lui. Ora io mi chiedo a quale tipo di Stato potrebbe accedere il saggio: a quello ateniese, che mandò a morte Socrate e costrinse Aristotele a scappare per non fare la stessa fine? 12 Uno Stato in cui l’invidia strozza ogni virtù? È evidente che il saggio non darà mai la sua opera a un regime siffatto. E allora? Si accosterà a quello cartaginese, dove la guerra civile non ha un minuto di tregua, dove la libertà è rovinosa ai migliori e onestà e giustizia sono tenute a vile, dove contro i nemici si consuma una crudeltà disumana e i cittadini stessi sono guardati di traverso, come persone pericolose? Anche da questo tipo di Stato il saggio si guarderà. E se li passassi in rassegna uno per uno non ne troverei nessuno capace di sopportare il saggio, o viceversa. E allora? Se quello Stato ideale, che pur ci raffiguriamo nella nostra mente, non si trova da nessuna parte, ecco che la vita contemplativa s’impone a tutti come una necessità, essa è la nostra àncora di salvezza, dal momento, ripeto, che non esiste al mondo l’unica cosa che avrebbe potuto esserle anteposta. Se uno mi dice che navigare è bellissimo, ma poi aggiunge che i mari sono cosparsi di naufràgi e infestati da frequenti burrasche che portano fuori rotta in direzione addirittura opposta, è evidente che costui, pur lodando la navigazione, in effetti mi vieta di salpare.
1.Commendant è reso da alcuni con «esaltano» o «tessono l’elogio», quando, anche se l’inizio è mutilo e manca il soggetto, il significato sembra essere piuttosto quello di un incoraggiamento o un suggerimento, e nemmeno volontario, come a dire: «Quelli che vivono in società (o semplicemente la vita di società) col loro esempio c’invitano, inconsapevolmente, ai vizi». 2. Il verso a cui Seneca accenna è preso da Virgilio (Eneide, IX 12) e si riferisce alle parole del rutulo Numano (cui Remulo cognomen erat), che aveva sposato la sorella minore di Turno.
3. Zenone (336-264 a.C.) è il fondatore della scuola stoica. 4. Le Vestali erano sacerdotesse di Vesta, forse anteriori alla fondazione di Roma e comunque organizzate in un collegio da Numa. Inizialmente in numero di 4, furono portate a 6 e a 7. Scelte dal sommo pontefice tra fanciulle dai 6 ai 10 anni, quali custodi del fuoco sacro nel tempio della dea, al Foro, restavano in carica per trent’anni, di cui dieci erano dedicati alla loro formazione, dieci all’esercizio del ministero e dieci all’insegnamento. 5. Crisippo (281-204 a.C.) è l’ordinatore delle dottrine stoiche. 6. Per duas res publicas s’intendono qui due diversi tipi di Stato, inquantoché res publica (lett. «la cosa pubblica») significa anche «forma di governo». 7.In duas partes virtus dividitur, in contemplationem veri et actionem: così ancora Seneca in Epist. ad Luc. 94, 95. 8. Il centro in cui la natura ci ha posto è qui, ovviamente quello dell’universo, secondo l’antica concezione (aristotelico-tolemaica) che poneva appunto la terra al centro di esso. Oltre agli stoici, anche Cicerone (De nat. deor. II 18) attribuiva al mondo una forma sferica. 9. Anche nel De tranquillitate animi Seneca dice che si può mescolare la vita attiva con quella contemplativa (longe optimum est miscere otium rebus). 10. Cleante (304-233 a. C.) tenne la scuola stoica dopo Zenone. Scrisse un Inno a Zeus. 11. La frase «la contemplazione è uno scalo, non un porto» richiama l’immagine di chi si tuffa nel mare dell’assoluto, ma per riemergere, dopo, e tornare nel mondo del relativo, non fosse altro che per testimoniare quell’esperienza. 12. Com’è noto, Socrate, accusato falsamente di empietà e di corrompere i giovani, fu condannato a morte e si suicidò avvelenandosi con la cicuta. Aristotele, accusato anch’egli di empietà, dovette fuggire da Atene e si rifugiò a Calcide, nell’Eubea, dove morì un anno dopo, nel 322.
De providentia
1. Quaesisti a me, Lucili, quid ita, si providentia mundus regeretur, multa bonis viris mala acciderent. Hoc commodius in contextu operis redderetur, cum praeesse universis providentiam probaremus et interesse nobis deum; sed, quoniam a toto particulam revelli placet et unam contradictionem, manente lite integra, solvere, faciam rem non difficilem: causam deorum agam. Supervacuum est in praesentia ostendere non sine aliquo custode tantum opus stare, nec hunc siderum coetum discursumque fortuiti impetus esse, et quae casus incitat saepe turbari et cito arietare, hanc inoffensam velocitatem procedere aeternae legis imperio, tantum rerum terra marique gestantem, tantum clarissimorum luminum et ex disposito relucentium; non esse materiae errantis hunc ordinem, nec quae temere coierunt tanta arte pendere ut terrarum gravissimum pondus sedeat immotum et circa se properantis caeli fugam spectet, ut infusa vallibus maria molliant terras nec ullum incrementum fluminum sentiant, ut ex minimis seminibus nascantur ingentia. Ne illa quidem quae videntur confusa et incerta, pluvias dico nubesque et elisorum fulminum iactus et incendia ruptis montium verticibus effusa, tremores labantis soli aliaque quae tumultuosa pars rerum circa terras movet, sine ratione, quamvis subita sint, accidunt, sed suas et illa causas habent, non minus quam quae alienis locis conspecta miraculo sunt, ut in mediis fluctibus calentes aquae et nova insularum in vasto exsilientium mari spatia. Iam vero, si quis observaverit nudari litora, pelago in se recedente, eademque intra exiguum tempus operiri, credet caeca quadam volutatione modo contrahi undas et introrsum agi, modo erumpere et magno cursu repetere sedem suam, cum interim illae portionibus crescunt et ad horam ac diem subeunt, ampliores minoresque prout illas lunare sidus elicuit, ad cuius arbitrium Oceanus exundat? Suo ista tempori reserventur, eo quidem magis quod tu non dubitas de providentia, sed quereris. In gratiam te reducam cum diis, adversus optimos optimis. Neque enim rerum natura patitur ut umquam bona bonis noceant. Inter bonos viros ac deos amicitia est, conciliante virtute: amicitiam dico? immo etiam necessitudo et similitudo, quoniam quidem bonus tempore tantum a deo differt, discipulus eius aemulatorque et vera progenies, quam parens ille magnificus, virtutum non lenis etactor, sicut severi patres durius educat. Itaque, cum videris bonos viros acceptosque diis laborare, sudare, per arduum escendere, malos autem lascivire et voluptatibus fluere, cogita filiorum nos modestia delectari, vernularum licentia, illos disciplina tristiori contineri, horum ali audaciam ldem tibi de deo liqueat: bonum virum in deliciis non habet; experitur, indurat, sibi illum parat. 2. Quare multa bonis viris adversa eveniunt? Nihil accidere bono viro mali potest: non miscentur contraria. Quemadmodum tot amnes, tantum supeme deiectorum imbrium, tanta medicatorum vis fontium non mutant saporem maris,
ne remittunt quidem, ita adversarum impetus rerum viri fortis non vertit animum: manet in statu et quicquid evenit in suum colorem trahit; est enim omnibus externis potentior. Nec hoc dico: non sentit illa, sed vincit et, alioqui quietus placidusque, contra incurrentia attollitur. Omnia adversa exercitationes putat. Quis autem, vir modo et erectus ad honesta, non est laboris appetens iusti et ad officia cum periculo promptus? Cui non industrio otium poena est? Athletas videmus, quibus virium cura est, cum fortissimis quibusque confligere et exigere ab iis per quos certamini praeparantur ut totis contra ipsos viribus utantur: caedi se vexarique patiuntur et, si non inveniunt singulos pares, pluribus simul obiciuntur. Marcet sine adversario virtus; tunc apparet quanta sit quantumque polleat, cum quid possit patientia ostendit. Scias licet idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac difficilia non reformident nec de fato querantur, quicquid accidit boni consulant, in bonum vertant. Non quid, sed quemadmodum feras interest. Non vides quanto aliter patres, aliter matres indulgeant? Illi excitari iubent liberos ad studia obeunda mature, feriatis quoque diebus non patiuntur esse otiosos, et sudorem illis et interdum lacrimas excutiunt; at matres fovere in sinu, continere in umbra volunt, numquam contristari, numquam flere, numquam laborare. Patrium deus habet adversus bonos viros animum, et illos fortiter amat et: «Operibus, inquit, doloribus, damnis exagitentur, ut verum colligant robur». Languent per inertiam saginata nec labore tantum, sed motu et ipso sui onere deficiunt. Non fert ullum ictum illaesa felicitas; at cui assidua fuit cum incommodis suis rixa callum per iniurias duxit, nec ulli malo cedit, sed, etiam si cecidit, de genu pugnat. Miraris tu si deus ille bonorum amantissimus, qui illos quam optimos esse atque excellentissimos vult, fortunam illis cum qua exerceantur assignat? Ego vero non miror si aliquando impetum capit spectandi magnos viros colluctantes cum aliqua calamitate. Nobis interdum voluptati est si adulescens constantis animi irruentem feram venabulo excepit, si leonis incursum interritus pertulit, tantoque hoc spectaculum et gratius quanto id honestior fecit. Non sunt ista quae possint deorum in se vultum convertere, puerilia et humanae oblectamenta levitatis. Ecce spectaculum dignum ad quod respiciat intentus operi suo deus, ecce par deo dignum: vir fortis cum fortuna mala compositus, utique si et provocavit. Non video, inquam, quid habeat in terris Iuppiter pulchrius, si convertere animum velit, quam ut spectet Catonem, iam partibus non semel fractis, stantem nihilo minus inter ruinas publicas rectum: «Licet, inquit, omnia in unius dicionem concesserint, custodiantur legionibus terrae, classibus maria, Caesarianus portas miles obsideat, Cato qua exeat habet; una manu latam libertati viam faciet. Ferrum istud, etiam civili bello purum et innoxium, bonas tandem ac nobiles edet operas: libertatem, quam patriae non potuit, Catoni dabit. Aggredere, anime, diu meditatum opus, eripe te rebus humanis! Iam Petreius et Iuba concucurrerunt iacentque alter alterius manu caesi: fortis et egregia fati conventio, sed quae non deceat magnitudinem nostram. Tam turpe est Catoni mortem ab ullo petere quam vitam». Liquet mihi cum magno spectasse gaudio deos, dum ille vir, acerrimus sui vindex alienae saluti consulit et instruit
discedentium fugam, dum studia etiam nocte ultima tractat, dum gladium sacro pectore infigit, dum viscera spargit et illam sanctissimam animam indignamque quae ferro contaminaretur manu educit. Inde crediderim fuisse parum certum et efficax vulnus: non fuit diis immortalibus satis spectare Catonem semel; retenta ac revocata virtus est, ut in difficiliore parte se ostenderet: non enim tam magno animo mors initur quam repetitur. Quidni libenter spectarent alumnum suum tam claro ac o exitu evadentem? Mors illos consecrat, quorum etitum et quitiment laudant. 3. Sed, iam procedente oratione, ostendam quam non sint quae Videntur mala. Nunc illud dico, ista quae tu vocas aspera, quae adversa et abominanda, primum pro ipsis esse quibus accidunt, deinde pro universis, quorum maior diis cura quam singulorum est, post hoc volentibus accidere, ac dignos malo esse si nolint. His adiciam fato ista subiecta eadem lege bonis evenire, qua sunt boni. Persuadebo deinde tibi ne umquam boni viri miserearis: potest enim miser dici, non potest esse. Difficillimum ex omnibus quae proposui videtur quod primum dixi, pro ipsis esse quibus eveniunt ista quae horremus ac tremimus. «Pro ipsis est, inquis, in exsilium proici, in egestatem deduci, liberos, coniugem ecferre, ignominia affici, debilitari?». Si miraris haec pro aliquo esse, miraberis quosdam ferro et igne curari, nec minus fame ac siti. Sed, si cogitaveris tecum remedii causa quibusdam et radi ossa et legi et extrahi venas et quaedam amputari membra quae sine totius pernicie corporis haerere non poterant, hoc quoque patieris probari tibi, quaedam incommoda pro iis esse quibus accidunt, tam mehercules quam quaedam quae laudantur atque appetuntur contra eos esse quos delectaverunt, simillima cruditatibus ebrietatibusque et ceteris quae necant per voluptatem. Inter multa magnifica Demetrii nostri et haec vox est, a qua recens sum (sonat adhuc et vibrat in auribus meis): «Nihil, inquit, mihi videtur infelicius eo cui nihil umquam evenit adversi». Non licuit enim illi se experiri. Ut ex voto illi fluxerint omnia, ut ante votum, male tamen de illo dii iudicaverunt: indignus visus est a quo vinceretur aliquando fortuna, quae ignavissimum quemque refugit, quasi dicat: «Quid ego istum mihi adversarium assumam? Statim arma submittet. Non opus est in illum tota potentia mea; levi comminatione pelletur: non potest sustinere vultum meum. Alius circumspiciatur cum quo conferre possimus manum. Pudet congredi cum homine vinci parato». Ignominiam iudicat gladiator cum inferiore componi, et scit eum sine gloria vinci qui sine periculo vincitur. Idem facit fortuna: fortissimos sibi pares quaerit. Quosdam fastidio transit; contumacissimum quemque et rectissimum aggreditur, adversus quem vim suam intendat: ignem experitur in Mucio, paupertatem in Fabricio, exsilium in Rutilio, tormenta in Regulo, venenum in Socrate, mortem in Catone. Magnum exemplum nisi mala fortuna non invenit. Infelix est Mucius, quod dextra ignes hostium premit et ipse a se exigit erroris sui poenas? quod regem, quem armata manu non potuit, exusta fugat? Quid ergo? felicior esset, si in sinu amicae foveret manum? Infelix est Fabricius, quod rus suum, quantum a re publica
vacavit, fodit? quod bellum tam cum Pyrrho quam cum divitiis gerit? quod ad focum cenat illos ipsas radices et herbas quas in repurgando agro triumphalis senex vulsit? Quid ergo? felicior esset, si in ventrem suum longinqui litoris pisces et peregrina aucupia congereret, si conchyliis Superi atque Inferi maris pigritiam stomachi nausiantis erigeret, si ingenti pomorum strue cingeret primae formae feras, captas multa caede venantium? Infelix est Rutilius, quod qui illum damnaverunt causam dicent omnibus saeculis? quod aequiore animo passus est se patriae eripi quam sibi exsilium? quod Sullae dictatori solus aliquid negavit et, revocatus, tantum non retro cessit et longius fugit? «Viderint, inquit, isti quos Romae deprehendit felicitas tua! Videant largum in foro sanguinem et supra Servilianum lacum (id enim proscriptionis Sullanae spoliarium est) senatorum capita et passim vagantes per urbem percussorum greges et multa milia civium romanorum uno loco post fidem, immo per ipsam fidem trucidata. Videant ista qui exsulare non possunt». Quid ergo? felix est L. Sulla, quod illi descendenti ad forum gladio summovetur, quod capita sibi consularium virorum patitur ostendi et pretium caedis per quaestorem ac tabulas publicas numerat? Et haec omnia facit ille, ille qui legem Corneliam tulit. Veniamus ad Regulum: quid illi fortuna nocuit, quod illum documentum fidei, documentum patientiae fecit? Figunt cutem clavi et, quocumque fatigatum corpus reclinavit, vulneri incumbit; in perpetuam vigiliam suspensa sunt lumina; quanto plus tormenti, tanto plus erit gloriae. Vis scire quam non paeniteat hoc pretio aestimasse virtutem? Refice illum et mitte in senatum: eandem sententiam dicet. Feliciorem ergo tu Maecenatem putas, cui, amoribus anxio et morosae uxoris cotidiana repudia deflenti, somnus per symphoniarum cantum ex longinquo lene resonantium quaeritur? Mero se licet sopiat et aquarum fragoribus avocet et mille voluptatibus mentem anxiam fallat: tam vigilabit in pluma quam ille in cruce. Sed illi solacium est pro honesto dura tolerare, et ad causam a patientia respicit; hunc, voluptatibus marcidum et felicitate nimia laborantem, magis iis quae patitur vexat causa patiendi. Non usque eo in possessionem generis humani vitia venerunt, ut dubium sit an, electione fati data, plures nasci Reguli quam Maecenates velint; aut, si quis fuerit qui audeat dicere Maecenatem se quam Regulum nasci maluisse, idem iste, taceat licet, nasci se Terentiam maluit. Male tractatum Socratem iudicas, quod illam potionem publice mixtam non aliter quam medicamentum immortalitatis obduxit et de morte disputavit usque ad ipsam? Male cum illo actum est, quod gelatus est sanguis ac, paulatim frigore inducto, venarum vigor constitit? Quanto magis huic invidendum est quam illis quibus gemma ministratur, quibus exoletus omnia pati doctus, exsectae virilitatis aut dubiae, suspensam auro nivem diluit! Hi quicquid biberunt vomitu remetientur, tristes et bilem suam regustantes; at ille venenum laetus et libens hauriet. Quod ad Catonem pertinet, satis dictum est, summamque illi felicitatem contigisse consensu hominum fatebitur, quem sibi rerum natura delegit cum quo metuenda collideret: «Inimicitiae potentium graves sunt? Opponatur simul Pompeio, Caesari, Crasso. Grave est a deterioribus honore anteiri? Vatinio postferatur. Grave est civilibus bellis interesse? Toto terrarum
orbe pro causa bona tam infeliciter quam pertinaciter militet. Grave est manus sibi afferre? Faciat. Quid per haec consequar? Ut omnes sciant non esse haec mala, quibus ego dignum Catonem putavi». 4. Prosperae res et in plebem ac vilia ingenia deveniunt; at calamitates terroresque mortalium sub iugum mittere proprium magni viri est. Semper vero esse felicem et sine morsu animi transire vitam ignorare est rerum naturae alteram partem. Magnus vir es? Sed unde scio, si tibi fortuna non dat facultatem exhibendae virtutis? Descendisti ad Olympia, sed nemo praeter te: coronam habes; victoriam non habes. Non gratulor tamquam viro forti, sed tamquam consulatum praeturamve adepto: honore auctus es. Idem dicere et bono viro possum, si illi nullam occasionem difficilior casus dedit in qua vim animi sui ostenderet: «Miserum te iudico, quod numquam fuisti miser. Transisti sine adversario vitam; nemo sciet quid potueris, ne tu quidem ipse». Opus est enim ad notitiam sui experimento: quid quisque posset nisi tentando non didicit. Itaque quidam ipsi ultro se cessantibus malis obtulerunt et virtuti iturae in obscurum occasionem per quam enitesceret quaesierunt. Gaudent, inquam, magni viri aliquando rebus adversis, non aliter quam fortes milites bello. Triumphum ego murmillonem sub Tib. Caesare de raritate munerum audivi querentem: «Quam bella, inquit, aetas perit!». Avida est periculi virtus et quo tendat, non quid passura sit cogitat, quoniam etiam quod passura est gloriae pars est. Militares viri gloriantur vulneribus, laeti fluentem e lorica suum sanguinem ostentant; idem licet fecerint qui integri revertuntur ex acie, magis spectatur qui saucius redit. Ipsis, inquam, deus consulit, quos esse quam honestissimos cupit, quotiens illis materiam praebet aliquid animose fortiterque faciendi, ad quam rem opus est aliqua rerum difficultate: gubernatorem in tempestate, in acie militem intellegas. Unde possum scire quantum adversus paupertatem tibi animi sit, si divitiis diffluis? Unde possum scire quantum adversus ignominiam et infamiam odiumque populare constantiae habeas, si inter plausus senescis, si te inexpugnabilis et inclinatione quadam mentium pronus favor sequitur? Unde scio quam aequo animo laturus sis orbitatem, si quoscumque sustulisti vides? Audivi te, cum alios consolareris; tunc conspexissem, si te ipse consolatus esses, si te ipse dolere vetuisses. Nolite, obsecro vos, expavescere ista, quae dii immortales velut stimulos admovent animis: calamitas virtutis occasio est. Illos merito quis dixerit miseros, qui nimia felicitate torpescunt, quos velut in mari lento tranquillitas iners detinet. Quicquid illis inciderit, novum veniet: magis urgent saeva inexpertos; grave est teneris cervicibus iugum; ad suspicionem vulneris tiro pallescit, audacter veteranus cruorem suum spectat, qui scit se saepe vicisse post sanguinem. Hos itaque deus quos probat, quos amat, indurat, recognoscit, exercet; eos autem quibus indulgere videtur, quibus parcere, molles venturis malis servat. Erratis enim, si quem iudicatis exceptum: veniet ad illum diu felicem sua portio; quisquis videtur dimissus esse, dilatus est. Quare deus optimum quemque aut mala valetudine aut luctu aut aliis incommodis afficit? Quia in castris quoque
periculosa fortissimis imperantur: dux lectissimos mittit, qui nocturnis hostes aggrediantur insidiis aut explorent iter aut praesidium loco deiciant. Nemo eorum qui exeunt dicit: «Male de me imperator meruit», sed: «Bene iudicavit». Item dicant quicumque iubentur pati timidis ignavisque flebilia: «Digni visi sumus deo in quibus experiretur quantum humana natura posset pati». Fugite delicias, fugite enervatam felicitatem qua animi permadescunt, nisi aliquid intervenit quod humanae sortis admoneat velut perpetua ebrietate sopiti. Quem specularia semper ab afflatu vindicaverunt, cuius pedes inter fomenta subinde mutata tepuerunt, cuius cenationes subditus et parietibus circumfusus calor temperavit, hunc levis aura non sine periculo stringet. Cum omnia quae excesserunt modum noceant, periculosissima felicitatis intemperantia est: movet cerebrum, in vanas mentem imagines evocat, multum inter falsum ac verum mediae caliginis fundit. Quidni satius sit perpetuam infelicitatem advocata virtute sustinere quam infinitis atque immodicis bonis rumpi? Lenior ieiunio mors est; cruditate dissiliunt. Hanc itaque rationem dii sequuntur in bonis viris, quam in discipulis suis praeceptores, qui plus laboris ab iis exigunt in quibus certior spes est. Numquid tu invisos esse Lacedaemoniis liberos suos credis, quorum experiuntur indolem publice verberibus admotis? Ipsi illos patres adhortantur ut ictus flagellorum fortiter perferant, et laceros ac semianimes rogant perseverent vulnera praebere vulneribus. Quid mirum si dure generosos spiritus deus tentat? Numquam virtutis molle documentum est. Verberat nos et lacerat fortuna? Patiamur: non est saevitia; certamen est, quod quo saepius adierimus, fortiores erimus. Solidissima corporis pars est quam frequens usus agitavit. Praebendi fortunae sumus, ut contra illam ab ipsa duremur: paulatim nos sibi pares faciet, contemptum periculorum assiduitas periclitandi dabit. Sic sunt nauticis corpora ferendo mari dura, agricolis manus tritae. Ad contemnendam patientiam malorum animus patientia pervenit; quae quid in nobis efficere possit scies, si aspexeris quantum nationibus nudis et inopia fortioribus labor praestet. Omnes considera gentes in quibus romana pax desinit, Germanos dico et quicquid circa Histrum vagarum gentium occursat: perpetua illos hiems, triste caelum premit, maligne solum sterile sustentat; imbrem culmo aut fronde defendunt, super durata glacie stagna persultant, in alimentum feras captant. Miseri tibi videntur? Nihil miserum est quod in naturam consuetudo perduxit; paulatim enim voluptati sunt quae necessitate coeperunt. Nulla illis domicilia nullaeque sedes sunt nisi quas lassitudo in diem posuit, vilis, et hic quaerendus manu, victus, horrenda iniquitas caeli, intecta corpora: hoc quod tibi calamitas videtur tot gentium vita est. Quid miraris bonos viros ut confirmentur concuti? Non est arbor solido nec fortis nisi in quam frequens ventus incursat: ipsa enim vexatione constringitur et radices certius figit; fragiles sunt quae in aprica valle creverunt. Pro ipsis ergo bonis viris est, ut esse interriti possint, multum inter formidolosa versari et aequo animo ferre quae non sunt mala nisi male sustinenti. 5. Adice nunc quod pro omnibus est optimum quemque, ut ita dicam, militare
et edere operas. Hoc est propositum deo, quod sapienti viro, ostendere haec quae vulgus appetit, quae reformidat, nec bona esse nec mala. Apparebit autem bona esse si illa non nisi bonis viris tribuerit, et mala esse si tantum malis irrogaverit. Detestabilis erit caecitas, si nemo oculos perdiderit nisi cui eruendi sunt: itaque careant luce Appius et Metellus. Non sunt divitiae bonum: itaque habeat illas et Elius leno, ut homines pecuniam, cum in templis consecraverint, videant et in fornice. Nullo modo magis potest deus concupita traducere quam si illa ad turpissimos defert, ab optimis abigit. «At iniquum est virum bonum debilitari aut configi aut alligari, malos integris corporibus solutos ac delicatos incedere». Quid porro? non est iniquum fortes viros arma sumere et in castris pernoctare et pro vallo obligatis stare vulneribus, interim in urbe securos esse percisos et professos impudicitiam? Quid porro? non est iniquum nobilissimas virgines ad sacra facienda noctibus excitari, altissimo somno inquinatas frui? Labor optimos citat. Senatus per totum diem saepe consulitur, cum illo tempore vilissimus quisque aut in Campo otium suum oblectet aut in popina lateat aut tempus in aliquo circulo terat. Idem in hac magna re publica fit: boni viri laborant, impendunt, impenduntur, et volentes quidem. Non trahuntur a fortuna, sequuntur illam, et aequant gradus. Si scissent, antecessissent. Hanc quoque animosam Demetrii fortissimi viri vocem audisse me memini: «Hoc unum, inquit, de vobis, Di immortales, queri possum, quod non ante mihi notam voluntatem vestram fecistis: prior enim ad ista venissem, ad quae nunc vocatus adsum. Vultis liberos sumere? Vobis illos sustuli. Vultis aliquam partem corporis? Sumite. Non magnam rem promitto: cito totum relinquam. Vultis spiritum? Quidni nullam moram faciam quo minus recipiatis quod dedistis? A volente feretis quicquid petieritis. Quid ergo est? maluissem offerre quam tradere. Quid opus fuit auferre? Accipere potuistis. Sed ne nunc quidem auferetis, quia nihil eripitur nisi retinenti». Nihil cogor, nihil patior invitus, nec servio deo, sed assentior, eo quidem magis quod scio omnia certa et in aeternum dicta lege decurrere. Fata nos ducunt et quantum cuique temporis restat prima nascentium hora disposuit. Causa pendet ex causa; privata ac publica longus ordo rerum trahit. Ideo fortiter omne patiendum est, quia non, ut putamus, incidunt cuncta, sed veniunt. Olim constitutum est quid gaudeas, quid fleas, et, quamvis magna videatur varietate singulorum vita distingui, summa in unum venit: accipimus peritura perituri. Quid itaque indignamur? quid querimur? Ad hoc parti sumus. Utatur ut vult suis natura corporibus; nos, laeti ad omnia et fortes, cogitemus nihil perire de nostro. Quid est boni viri? Praebere se fato. Grande solacium est cum universo rapi: quicquid est quod nos sic vivere, sic mori iussit, eadem necessitate et deos alligat; irrevocabilis humana pariter ac divina cursus vehit. Ille ipse omnium conditor et rector scripsit quidem fata, sed sequitur; semper paret, semel iussit. «Quare tamen deus tam iniquus in distributione fati fuit, ut bonis viris paupertatem et vulnera et acerba funera ascriberet?». Non potest artifex mutare materiam. Hoc pactum est: quaedam separari a quibusdam non possunt, cohaerent, individua sunt. Languida ingenia et in somnum itura aut in vigiliam somno simillimam
inertibus nectuntur elementis; ut efficiatur vir cum cura dicendus, fortiore texto opus est. Non erit illi planum iter: sursum oportet ac deorsum eat, fluctuetur ac navigium in turbido regat; contra fortunam illi tenendus et cursus. Multa accident dura, aspera, sed quae molliat et complanet ipse. Ignis aurum probat, miseria fortes viros. Vide quam alte escendere debeat virtus: scies illi non per secura vadendum. Ardua prima via est et quam vix mane recentes Enituntur equi. Medio est altissima caelo, Unde mare et terras ipsi mihi saepe videre Sit timor et pavida trepidet formidine pectus. Ultima prona via est et eget moderamine certo; Tunc etiam quae me subiectis excipit undis, Ne ferar in praeceps, Tethys solet ima vereri. Haec cum audisset ille generosus adulescens: «Placet, inquit, via. Escendo: est tanti per ista ire casuro». Non desinit acrem animum metu territare: Utque viam teneas nulloque errore traharis, Per tamen adversi gradieris cornua Tauri Haemoniosque arcus violentique ora Leonis. Post haec ait: «Iunge datos Currus! His quibus deterreri me putas incitor. Libet illic stare, ubi ipse Sol trepidat». Humilis et inertis est tuta sectari: per alta virtus it. 6. «Quare tamen bonis viris patitur aliquid mali deus fieri?». Ille vero non patitur: omnia mala ab illis removit, scelera et flagitia et cogitationes improbas et avida consilia et libidinem caecam et alieno imminentem avaritiam. Ipsos tuetur ac vindicat; numquid hoc quoque aliquis a deo exigit, ut bonorum virorum etiam sarcinas servet? Remittunt ipsi hanc deo curam: externa contemnunt. Democritus divitias proiecit, onus illas bonae mentis existimans. Quid ergo miraris si id deus bono viro accidere patitur, quod vir bonus aliquando vult sibi accidere? Filios amittunt viri boni: quidni, cum aliquando et occidant? In exsilium mittuntur: quidni, cum aliquando ipsi patriam non repetituri relinquant? Occiduntur: quidni, cum aliquando ipsi sibi manus afferant? Quare quaedam dura patiuntur? Ut alios pati doceant: nati sunt in exemplar. Puta itaque deum dicere: «Quid habetis quod de me queri possitis, vos, quibus recta placuerunt? Aliis bona falsa circumdedi et animos inanes velut longo fallacique somnio lusi: auro illos et argento et ebore adornavi, intus boni nihil est. Isti quos pro felicibus aspicis, si non qua occurrunt, sed qua latent videris, miseri sunt, sordidi, turpes, ad similitudinem parietum suorum extrinsecus culti. Non est ista solida et sincera
felicitas: crusta est, et quidem tenuis. Itaque, dum illis licet stare et ad arbitrium suum ostendi, nitent et imponunt; cum aliquid incidit quod disturbet ac detegat, tunc apparet quantum latae ac verae foeditatis alienus splendor absconderit. Vobis dedi bona certa, mansura, quanto magis versaverit aliquis et undique inspexerit meliora maioraque: permisi vobis metuenda contemnere, cupiditates fastidire. Non fulgetis extrinsecus: bona vestra introrsus obversa sunt: sic mundus exteriora contempsit, spectaculo sui laetus. Intus omne posui bonum; non egere felicitate felicitas vestra est. “At multa incidunt tristia, horrenda, dura toleratu”. Quia non poteram vos istis subducere, animos vestros adversus omnia armavi. Ferte fortiter. Hoc est quo deum antecedatis: ille extra patientiam malorum est, vos supra patientiam. Contemnite paupertatem: nemo tam pauper vivit quam natus est. Contemnite dolorem: aut solvetur aut solvet. Contemnite mortem: quae vos aut finit aut transfert. Contemnite fortunam: nullum illi telum quo feriret animum dedi. Ante omnia cavi ne quis vos teneret invitos: patet exitus. Si pugnare non vultis, licet fungere. Ideo ex omnibus rebus quas esse vobis necessarias volui nihil feci facilius quam mori. Prono animam loco posui: trahitur. Attendite modo, et videbitis quam brevis ad libertatem et quam expedita ducat via. Non tam longas in exitu vobis quam intrantibus moras posui; alioqui magnum in vos regnum fortuna tenuisset, si homo tam tarde moreretur quam nascitur. Omne tempus, omnis vos locus doceat quam facile sit renuntiare naturae et munus illi suum impingere. Inter ipsa altaria et sollemnes sacrificantium ritus, dum optatur vita, mortem condiscite: corpora opima taurorum exiguo concidunt vulnere et magnarum virium animalia humanae manus ictus impellit. Tenui ferro commissura cervicis abrumpitur, et, cum articulus ille qui caput collumque committit incisus est, tanta illa moles corruit. Non in alto latet spiritus, nec utique ferro eruendus est; non sunt vulnere penitus impresso scrutanda praecordia: in proximo mors est. Non certum ad hos ictus destinavi locum: quacumque vis, pervium est. Ipsum illud quod vocatur mori, quo anima discedit a corpore, brevius est quam ut sentiri tanta velocitas possit. Sive fauces nodus elisit, sive spiramentum aqua praeclusit, sive in caput lapsos subiacentis soli duritia comminuit, sive haustus ignis cursum animae remeantis interscidit, quicquid est, properat. Ecquid erubescitis? Quod tam cito fit, timetis diu!».
La provvidenza
Premessa Il De providentia di Seneca – composto secondo alcuni all’inizio dell’esilio, secondo altri fra il 64 e il 65 – tocca il problema del bene e del male, in riferimento alla domanda posta da Lucilio, il dedicatario, Quare multa bonis adversa eveniunt, cioè per quale ragione ai buoni capitino molte disgrazie. Seneca risponde che all’uomo buono non può accadere alcunché che possa dirsi propriamente un male, poiché i contrari non sono mescolabili fra loro, dopodiché passa a dimostrare come quelli che gli uomini comuni chiamano mali non siano tali per i buoni, ma costituiscano solo un mezzo con cui Dio sperimenta la loro virtù e nello stesso tempo una prova della sua benevolenza verso di loro (è il concetto della «provvida sventura».) Il male è dunque una necessità ed è legato all’equilibrio stesso della vita, del mondo e della storia, come il dolore, il brutto tempo, le malattie e tutto ciò che ai nostri occhi è negativo, e che però è indispensabile per farci comprendere e apprezzare il positivo, in questo gioco dialettico in cui consiste la vita umana con tutto il suo progredire. Del resto è proprio in questo contrasto che risiede la suprema bellezza della creazione, l’essenza stessa dell’Arte, la quale è gioia e sofferenza insieme, come l’amore di una madre nell’atto appunto del generare. Naturalmente riconoscere il male necessario non significa che non si debba combatterlo, ma il combatterlo rientra anch’esso nel disegno provvidenziale, ai fini di quell’equilibrio a cui appunto abbiamo accennato. Seneca, tuttavia, non spinge la sua provvidenza più in là di tanto, come del resto tutti coloro che hanno la stessa visione del mondo, per non negare all’uomo la libertà e la responsabilità. La provvidenza, nel senso di un intervento divino extra ordinem, non esiste. Analogamente al fato, con cui in sostanza s’identifica, essa ha due aspetti, uno statico e uno dinamico (essere e divenire, o manifestarsi), ma nel secondo non ha niente che già non sia nel primo. Come una pellicola in proiezione non fa che rivelare progressivamente quanto ha già stampato, chiuso e arrotolato dentro di sé, così la provvidenza. Dio, nella sua onniscienza, ha già fissato per ciascuno ciò che, nel tempo, gli sarà dato. Il fatto che l’uomo glielo chieda rientra nella dialettica del gioco, e Dio può anche compiacersene, come Cacciaguida che, pur conoscendo la domanda che Dante intende fargli, vuole sentirgliela formulare («…la voce tua sicura, balda e lieta, / suoni la volontà, suoni ’l disìo / a che la mia risposta è già decreta!» Par. XV 64-69). La provvidenza può essere paragonata a una sorta di tela cosmica costituita da fili invisibili che collegano tutte le cose e tutte le vite in una rete di comunicazioni subliminali, in una interdipendenza delle più diverse nature, per cui possiamo dire che nel mondo ogni fatto, anche il più insignificante, accade con la partecipazione dell’intero universo e che «chi strappa un fiore disturba una stella». M. S. A.
1. Tu mi chiedi, Lucilio, 1 perché, se dio si prende cura del mondo, accadano ai buoni tante disgrazie. L’argomento esigerebbe una trattazione più ampia, poiché si dovrebbe prima discutere e dimostrare se è vero che l’universo è retto da una legge provvidenziale e che dio si cura effettivamente di noi, ma poiché tu mi domandi di affrontare una sola parte del problema, per risolvere il tuo quesito, senza approfondire l’intera questione, farò una cosa semplicissima: assumerò, cioè, la difesa di dio. Innanzitutto è superfluo dimostrare, almeno per il momento, come un’opera di così vasta portata qual è l’universo possa sussistere senza che alcuno la sorvegli e come il regolare e costante corso delle
stelle, nel loro duplice moto di avvicinamento e di allontanamento, non sia dovuto a un impulso casuale – cosa impossibile inquanto tutto ciò che si muove disordinatamente si scompiglia e dà di cozzo, mentre queste rotazioni procedono senza intoppi, sotto la spinta ordinata di una legge eterna, portando sulla terra e nel mare un’enorme quantità di esseri animati e inanimati e sparpagliando nel cielo un gran numero di chiarissime stelle rilucenti secondo un ordine che le colloca ciascuna in un posto preciso e determinato. Né serve dimostrare come tutto quest’ordine non possa attribuirsi a una materia cieca, che vaghi a caso, e come degli elementi aggregatisi fortuitamente possano restare sospesi nel vuoto, con tale e tanta arte da far sì che l’enorme mole della terra se ne rimanga immobile a contemplare il cielo che le gira intorno nel solerte e veloce moto degli astri, e consentire che i mari s’insinuino nelle valli, rendendo le terre permeabili affinché i fiumi poi nel riversarvisi non abbiano a straripare, e come infine da piccoli semi possano nascere organismi viventi tanto grandi. E anche quei fenomeni che sembrano oscuri e irregolari, cioè le piogge, le nubi, lo sprigionarsi e l’abbattersi dei fulmini, le lave incandescenti che traboccano dai crateri dei vulcani, le scosse della terra, che vacilla sotto i nostri piedi e tutti quegli altri rivolgimenti che si verificano nell’atmosfera che circonda la terra, per quanto imprevedibili, non accadono senza una ragione, ma hanno anch’essi le loro cause, non meno di quei fenomeni che sembrano miracoli inquanto accadono in luoghi diversi da quelli in cui, secondo noi, dovrebbero verificarsi, come le sorgenti d’acqua calda nel bel mezzo del mare o l’emergere improvviso di nuove e vaste isole nell’immensità dell’oceano. Se poi osserviamo le spiagge prosciugarsi e ribagnarsi nel moto alterno delle onde che cadenzando si ritraggono e rifluiscono in breve spazio di tempo, possiamo mai pensare che questo flusso e riflusso, che ora cede e ora riconquista la propria sede, sia dovuto al caso? Al contrario, le onde crescono e si riversano sulla spiaggia con un ritmo periodico, in giorni e ore stabiliti, alzandosi e abbassandosi secondo l’attrazione esercitata dalla luna, che determina appunto il rigonfiarsi e lo straripamento della massa marina. Ma rimandiamo ad altro tempo la discussione su tutti questi fenomeni, tanto più per il fatto che tu non metti in dubbio la provvidenza, ma te ne lamenti: io voglio riconciliarti con dio e dimostrarti che non è ingiusto coi buoni. Del resto è legge di natura che un bene non possa nuocere a un altro bene. Tra gli uomini virtuosi e la divinità c’è uno stretto legame di amicizia, costituito dalla virtù, anzi un legame più che di amicizia di parentela e di somiglianza inquantoché l’uomo buono differisce da dio solo per via del tempo, voglio dire perché non è eterno come lui, che, da quel padre meraviglioso che è, ma anche esigente in fatto di virtù, lo educa quale suo figlio vero, e discepolo ed emulo, più duramente di quanto non educhi gli altri, come del resto fanno tutti i padri severi. Perciò quando vedi gli uomini buoni – che come ho detto sono cari a dio – affannarsi, sudare e arrampicarsi lungo difficili pendii, mentre i malvagi se la spassano e nuotano nei piaceri lascivi della carne, pensa quanto ci diletti vedere i nostri figli costumati di fronte a quelli, sfacciati,
della servitù, e come mentre i nostri li teniamo a freno con una dura disciplina alimentiamo così la sfrontatezza degli altri. La stessa idea devi farti di dio: Egli non tiene l’uomo buono in mezzo ai piaceri, ma lo mette alla prova, lo irrobustisce, e in questo modo lo fa degno di sé. 2. «Ma se vuole farli degni di sé, per quale ragione dio manda ai buoni tante disgrazie?» Innanzitutto ti ripeto che a un uomo buono non può capitare nulla che possa dirsi propriamente un male: i contrari, infatti, non si mescolano fra loro. Come la quantità dei fiumi, delle piogge che cadono dal cielo e delle sorgenti curative non altera la salsedine del mare, né tanto meno l’elimina, così l’assalto delle avversità non intacca l’animo dell’uomo forte: questi rimane saldo nel suo stato e nelle sue convinzioni, piegando gli eventi a sé, non sé agli eventi, perché ha un potere superiore a tutto ciò che lo circonda. Non dico che sia insensibile alle avversità, dico che le vince, e anche se abitualmente è tranquillo e pacifico, quando quelle gli si buttano addosso sa ergervisi contro e rintuzzarle. Per lui le avversità non hanno altra funzione e altro scopo che di esercitare la sua virtù. E quale uomo, degno di questo nome, che sia dedito all’onestà, non aspira a essere messo giustamente alla prova, o non è pronto a fare il suo dovere anche sapendo di rischiare? Così l’ozio è una sofferenza per chi sia nato all’azione. Guarda gli atleti, che, attenti come sono alle proprie forze, si battono con avversari più gagliardi di loro, anzi, durante l’esercitazione, chiedono e pretendono dagli allenatori che li preparano alla gara di scaricargli contro tutte le loro energie, e incassano colpi su colpi, e se non trovano uno che sia almeno pari a loro, si battono contemporaneamente con più di un avversario. La virtù si rammollisce se non ha chi la contrasti, e solo quando dimostra quale peso può reggere rivela la sua grandezza e la sua forza. Convinciti dunque che l’uomo buono deve comportarsi nel medesimo modo: non temere durezze e difficoltà, non lagnarsi se il destino gli è avverso, accogliere come un bene, o trasformarlo in tale, qualunque male gli accada; e non importa quale ma come egli riesce a sopportarlo. Guarda la differenza fra l’amore di un padre e quello di una madre: il padre esige che i figli s’alzino di buon’ora per dedicarsi alle loro occupazioni, non vuole che riposino neppure nei giorni festivi, gli fa versare lacrime e sudore; la madre, invece, vorrebbe coccolarseli in seno, fargli scudo, a difesa d’ogni tristezza, d’ogni pianto e fatica. Ebbene, dio verso i buoni ha l’animo di un padre, li ama, ma senza debolezze o cedimenti, e dice: «Le fatiche, i dolori e le sventure li tengano sempre vigili, così acquisteranno una forza autentica, vera». Le bestie che ingrassano nell’inoperosità s’indeboliscono e non solo non sono capaci di compiere alcuno sforzo ma non riescono nemmeno a muoversi e a sostenere il loro stesso peso. Una felicità che non conosca assalti al minimo colpo vacilla, chi invece è costretto a lottare incessantemente contro le avversità della vita finisce col farci il callo e non cade davanti ad alcun male, e anche se cade continua a combattere in ginocchio. Ora ti meravigli che un dio così amorevole verso i buoni, che desidera ottimi e superiori agli altri, assegni loro
un destino che li tenga sempre addestrati? Io, per me, non mi meraviglio affatto se talvolta gli viene il ghiribizzo di vedere degli uomini virtuosi alle prese con qualche disgrazia. Anche a noi piace spesso guardare un giovane deciso e valoroso attendere a piè fermo, col giavellotto in pugno, la belva che s’avventa contro di lui, il balzo del leone, senz’alcuna paura, e lo spettacolo ci è tanto più gradito quanto più coraggioso è colui da cui ci viene offerto. Ma non a simili imprese si volge l’occhio di dio: questi sono giochetti puerili, passatempi dell’umana leggerezza. Ecco invece uno spettacolo degno di essere guardato da un dio intento alla sua opera, ecco l’uguale, pari alla divinità: un uomo forte in lotta contro la sorte avversa, e meglio ancora se quella lotta l’ha provocata lui. Non so davvero quale spettacolo più bello potrebbe vedere dio sulla terra, quando volesse volgervi lo sguardo, di quello di Catone, che a dispetto delle tante sconfitte subite dai suoi se ne sta dritto in mezzo alla generale rovina. Sembra che dica: «Pur se ogni cosa è caduta sotto il dominio di Cesare e ormai le sue legioni presidiano la terra e le sue flotte il mare e i suoi soldati battono alle porte, Catone ha come uscirne: con una sola mano saprà aprirsi la strada verso la libertà! Codesta spada, rimasta pura e innocente anche nella guerra civile, compirà finalmente una buona e nobile impresa: darà a Catone quella libertà che egli non poté dare alla patria. Esegui, animo mio, quel gesto già meditato da tempo, ritirati dalle vicende umane! Giuba e Petreio2 si sono già scontrati e son caduti l’uno per mano dell’altro: un patto di morte nobile e coraggioso, ma che non si addice alla grandezza di Catone: per lui sarebbe una vergogna chiedere ad altri la morte, come pure la vita». Sono certo che dio avrà guardato con somma gioia la scena di quest’uomo così deciso in quel suo gesto liberatore, dopo aver atteso alla salvezza degli altri organizzandone la fuga, un uomo che dedicò allo studio anche l’ultima notte, e che alla fine s’immerse la spada nel petto immacolato aprendosi le viscere con le sue stesse mani, per liberare così la sua santissima anima che il contatto del ferro avrebbe indegnamente contaminato.3 dio non si accontentò di vederlo morire d’una morte istantanea – e perciò la ferita prodotta dalla spada fu imprecisa e poco efficace – ma volle prolungare il suo coraggio perché quel gesto si ripetesse più volte, in una prova sempre più dura: il vero eroismo, infatti, non sta tanto nell’affrontare la morte quanto nel provocarla ripetutamente. E perché dio non avrebbe dovuto compiacersi di guardare un figlio suo che se ne usciva dalla scena del mondo con una fine così esemplare e memorabile? Una simile morte consacra l’uomo all’immortalità, ed è lodata anche da coloro che ne hanno paura. 3. Ma, proseguendo nel mio discorso, ti dimostrerò come e perché quelli che noi chiamiamo mali siano tali solo all’aspetto. Per ora ti dico questo, che quegli eventi che tu definisci difficili, avversi e detestabili, sono utili in primo luogo a quelle stesse persone che li subiscono e poi anche all’umanità, alla quale dio guarda più nell’insieme che non nei suoi singoli componenti; inoltre, che essi capitano a coloro che sono disposti ad accettarli, che se non fossero accettati,
allora sì sarebbero veramente dei mali e come tali sarebbero meritati. A chiarimento di questa mia affermazione aggiungerò che tali eventi, regolati dal destino, toccano ai buoni proprio perché sono buoni. Poi ti convincerò a non compiangere mai un uomo buono, giacché egli è compassionevole solo all’apparenza, a chi lo guardi superficialmente, ma in realtà non lo è. Di tutti i punti della questione il più difficile a comprendersi mi sembra il primo, il fatto, cioè, che degli avvenimenti spaventosi e tremendi possano giovare a chi li riceve. «È forse un bene», mi dirai, «essere cacciati in esilio, ridursi in povertà, veder morti i propri figli, la moglie, essere tacciati d’infamia, cadere ammalati?». Ascolta: se ti meravigli che simili accidenti possano giovare a qualcuno, devi anche stupirti del fatto che in certi casi i malati vengano curati col fuoco e col ferro, oppure con la fame e con la sete. Se poi pensi che ad alcuni, per guarirli, vengono raschiate o asportate ossa, sfilate vene e tolte delle membra, che restando attaccate al corpo lo ucciderebbero, devi convenire che anche certe disgrazie sono di vantaggio a chi le subisce, così come certi piaceri, che pur sono lodati e desiderati, finiscono per nuocere a chi li ha goduti, simili alle indigestioni, alle ubriacature e ad altre cose del genere che uccidono proprio attraverso il piacere. Fra i detti memorabili del mio amico Demetrio4 c’è anche questo, fresco fresco, che ancora mi suona e mi fischia negli orecchi: «Non c’è niente di più infelice che una felicità senza disgrazie». Chi infatti non ha mai messo alla prova la sua felicità non è propriamente felice. dio non si fa un buon concetto di un uomo a cui tutto fili liscio, secondo i suoi desideri o addirittura anticipandoli; non può ritenerlo degno se non ha affrontato e vinto almeno una volta le avversità della sorte, la quale fugge i vigliacchi, quasi dicesse: «Perché dovrei scegliermi costui come rivale? Non c’è gusto: deporrebbe subito le armi. Non potrei sperimentare contro di lui tutte le mie forze, quando una mia semplice minaccia lo abbatterebbe. Non reggerebbe neppure il mio sguardo. È meglio che mi cerchi qualcun altro con cui attaccar battaglia. Mi vergogno di battermi con chi rinuncia alla lotta e si dichiara vinto in partenza». Il gladiatore considera disonorevole l’essere messo di fronte a un avversario meno forte di lui, perché sa che non c’è gloria in una vittoria senza rischi. Così fa pure la sorte: cerca rivali degni di lei. Certi uomini li guarda con disprezzo e passa oltre, assale solo i più decisi e ostinati contro cui poter dirigere tutta la sua forza: usa il fuoco con Muzio,5 la povertà con Fabrizio,6 l’esilio con Rutilio,7 la tortura con Regolo,8 il veleno con Socrate, il suicidio con Catone. I grandi esempi sono possibili solo nella sventura. È forse infelice Muzio perché impone la destra sul fuoco nemico punendola egli stesso per lo sbaglio commesso? Quella mano che armata non seppe uccidere il re e che ora, bruciata, riesce a metterlo in fuga? Sarebbe stato più lieto se quella mano l’avesse riscaldata nel seno dell’amante? È forse infelice Fabrizio quando vanga il suo campicello, in quel tanto di libertà che gli rimane dagli affari di Stato? O perché muove guerra contro Pirro e al tempo stesso contro le ricchezze? O perché, seduto accanto al fuoco, si ciba di quelle stesse erbe e radici che di sua mano ha raccolto nel pulire il suo orto, lui,
vecchio e glorioso trionfatore? Sarebbe forse stato più felice se si fosse rimpinzato di pesci provenienti dai lidi più lontani o di uccelli forestieri, se avesse stuzzicato il suo stomaco pigro e riluttante con le ostriche dell’Adriatico e del Tirreno, o guarnito con montagne di frutta la pregevole selvaggina catturata con tanta strage dai cacciatori? È infelice Rutilio, quando i giudici che gli hanno inflitto quella condanna dovranno risponderne alla Storia per tutti i secoli futuri? Lui, che ha sofferto di essere strappato alla patria con più serenità che se fosse scampato all’esilio? lnfelice per aver lui solo risposto no al dittatore, quando, pur richiamato da Silla, non soltanto non ritornò ma fuggì ancora più lontano? «Se la sbrighino», gli disse, «quei disgraziati che in Roma sono rimasti abbindolati dalla tua felicità, quella felicità di cui usurpasti il nome, facendoti chiamare, per la tua èra, Felice. Guardino i fiumi di sangue nel foro, le teste mozze dei senatori sulla fontana di Servilio, covo di assassini delle tue proscrizioni, le squadracce dei tuoi sicari sparpagliati per la città e le tante migliaia di romani trucidati in massa, dopo il pegno d’incolumità che gli era stato dato, anzi proprio per questo. Se lo guardi un tale spettacolo chi non ha il privilegio dell’esilio!». Ed è forse felice lo stesso Silla,9 quando, recandosi al foro, deve aprirsi la strada a colpi di spada, o quando gli si mostrano le teste dei consolari e fa segnare dal questore sui registri dello Stato le taglie da pagare per quelle stragi? Ed è lui che fa tutto questo, proprio lui che ha emanato la legge Cornelia10 contro i sicari e gli avvelenatori! Veniamo a Regolo, ora: quale danno gli fece mai la sorte, quando lo assunse a modello di lealtà e di coraggio? I chiodi gli si conficcano nelle carni, dovunque si appoggi, il suo corpo straziato riceve ferite su ferite, i suoi occhi sono sospesi in una veglia senza fine; ma quanto più nero è lo strazio tanto più luminosa risplende la sua gloria. Vuoi sapere se si è pentito di aver pagato a questo prezzo la sua lealtà? Risuscitalo e rimandalo in Senato: sarà sempre dello stesso parere. E ancora: credi tu più felice Mecenate,11 quando, eccitato dalle sue voglie amorose e mortificato dai quotidiani rifiuti di una moglie lunatica e capricciosa, cerca di conciliarsi il sonno al dolce suono di melodie lontane? Si stordisca pure col vino, si distragga allo scroscio fragoroso delle acque, inganni pure con mille piaceri il suo animo esulcerato: resterà sveglio sul suo letto di piume come Regolo sulla sua croce. Ma Regolo almeno ha il conforto di aver patito tale strazio in nome della sua lealtà, quando da quella sofferenza volge lo sguardo alla causa, nobilissima, che l’ha generata; Mecenate, invece, snervato dai piaceri e schiavo della troppa felicità, è tormentato più dalla causa della sua pena che dalla pena stessa. I vizi non sono ancora così padroni del mondo da far dubitare che se potessimo scegliere il nostro destino vi sarebbero più Regoli che Mecenati, o addirittura che se uno ardisse confessare di preferire a Regolo Mecenate, in realtà vorrebbe essere Terenzia. Pensi che Socrate sia stato trattato male da dio, quando bevve, come se fosse un filtro per l’immortalità, il veleno fornitogli dallo Stato e disputò sulla morte sino a che questa non lo ghermì? Che male gliene venne quando il sangue gli si gelò e, diffondendosi il freddo a poco a poco, la vita gli
si spense nelle vene? Quanto più invidiabile è lui di fronte a chi beve nettari prelibati dentro coppe ingemmate, mentre magari un giovane lascivo, rotto a ogni libidine, evirato o di sesso ambiguo, gli versa neve disciolta da un calice dorato! Uomini siffatti vomiteranno tutto ciò che han bevuto, sentendone il più totale disgusto nel rigurgito della loro bile, mentre Socrate bevve lieto e tranquillo il suo veleno. Quanto a Catone se n’è già detto abbastanza, e tutti saranno concordi nel riconoscere che gli è toccato il massimo della felicità, visto che la natura lo ha scelto quale oggetto delle sue più terribili prove: «È pericoloso avere nemici potenti? Mettiamolo allora di fronte a Pompeo, a Cesare e a Crasso contemporaneamente. È umiliante essere scavalcati dai peggiori nelle cariche pubbliche? Posponiamolo a Vatinio. 12 È duro trovarsi in mezzo a una guerra civile? Combatta allora in tutto il mondo per una buona causa e con tanto insuccesso quanta è la sua ostinazione. È duro darsi la morte? Lo faccia. A che pro tutto questo? Perché gli uomini sappiano che non sono mali codesti, se ho giudicato Catone degno di simili prove». 4. Considera ora questo: la buona fortuna può capitare anche a un plebeo o a una persona spregevole, ma è solo dell’uomo grande vincere le disgrazie e le paure. Inoltre l’essere sempre felici, il passare indenni la vita significa ignorarne l’altra metà. Come fai a sapere che sei un grand’uomo, se la sorte non t’offre l’occasione di dimostrare il tuo valore? Se scendi nell’arena dei giochi olimpici e ci sei solo tu a misurarti puoi prenderti la corona ma non la vittoria, e io non posso congratularmi con te come si fa con un uomo forte, posso solo stringerti la mano, come a uno che ha conseguito la pretura o il consolato: un’onorificenza, niente di più. Lo stesso potrei dire a un uomo buono se nessuna difficoltà di un certo rilievo gli ha mai dato modo di dimostrare la sua forza d’animo. «Ti giudico infelice perché non sei mai stato infelice», così gli direi. «Hai passato la vita intera senza mai misurarti con qualcuno o qualcosa che ti contrastasse. Nessuno potrà mai sapere quanto vali in realtà, nemmeno tu stesso». Per conoscersi, infatti, bisogna dar prova di sé, le proprie forze non si apprendono se non sperimentandole. Per questo alcuni, invece di aspettarle, visto che quelle tardano a venire, vanno incontro alle disgrazie volontariamente e cercano loro l’occasione per mettere in luce una virtù che diversamente resterebbe nell’ombra. Gli uomini forti talvolta si rallegrano delle avversità come della guerra i soldati valorosi. Al tempo dell’imperatore Tiberio il gladiatore 13 Trionfo – come io stesso ho potuto sentire – si lamentava della scarsezza di quelle competizioni: «Un’età sprecata!», diceva. La virtù è avida di pericoli e guarda dritto alla meta, non a quel che deve patire, perché sa che anche le sofferenze fanno parte della gloria. I soldati valorosi sono fieri delle loro ferite e mostrano con gioioso orgoglio il sangue che cola dalla corazza: anche se chi esce illeso da una battaglia ha compiuto le stesse imprese, la nostra ammirazione è maggiore per chi ne torna ferito. dio, ripeto, si prende cura di quegli uomini che vuole perfetti, offrendo loro l’occasione di agire con coraggio e con
fermezza, ma ciò comporta delle difficoltà: un buon timoniere lo si vede nella tempesta, come un buon soldato nella battaglia. Se nuoti nella ricchezza non posso sapere di quanta forza d’animo tu disponga per affrontare la povertà. Allo stesso modo come posso conoscere la tua fermezza di fronte all’infamia, al disonore e all’odio popolare, se invecchi fra gli applausi, se ti accompagna sempre un consenso generale che non conosce crolli e oscillazioni perché dovuto a un moto di simpatia spontanea verso di te? Come posso sapere con quale animo sei in grado di sopportare la perdita di uno dei tuoi figli, se quelli che hai generato li hai tutti vivi e presenti davanti a te? So, per averti sentito, che sei bravo a consolare gli altri, ma saresti capace di fare altrettanto con te, anzi, di non soffrire per niente? In nome di dio, non abbiate timore di tutti questi mali, che sono solo degli stimoli per provare l’animo umano! La sventura non è che un pretesto per mettere a nudo la virtù. Si possono dire infelici, e giustamente, quelli che impigriscono in un’eccessiva felicità, a cui un’inerzia stagnante impedisce persino di muoversi, come non ci si muove su un mare liscio e tranquillo non intaccato dal vento. Sono infelici perché non solamente i mali ma qualunque cosa gli accada li troverà impreparati: le disgrazie infatti fanno più male a chi non le ha mai provate. Il giogo, insomma, pesa sui colli delicati, la recluta si sbianca al solo pensiero di una ferita, il veterano, invece, guarda impassibile il proprio sangue in quanto sa che a questo deve le sue vittorie. Perciò dio mette alla prova, irrobustisce e tiene in esercizio quelli che ama e apprezza, mentre lascia indifesi di fronte alle disgrazie proprio quelli che sembra prediligere e risparmiare. Ma poi nessuno è completamente immune dai mali: anche chi è stato a lungo felice avrà la sua parte d’infelicità, sarà solo una proroga, non un’esclusione. «Perché, allora», mi dirai, «tante malattie, tanti lutti, tanti guai capitano proprio ai migliori?». Per la stessa ragione per cui in guerra le imprese più rischiose sono assegnate ai più forti. Come un generale sceglie i soldati più abili per le sortite notturne contro il nemico, per esplorare la strada o togliere di mezzo un avamposto – e nessuno di quelli pensa di essere malvisto dal comandante ma al contrario ciascuno è convinto di essere nelle sue grazie – così fa dio, e così devono dire coloro ch’Egli chiama alla sventura, di fronte alla quale si arrendono soltanto i timidi e i vigliacchi: «dio ci ha prescelti per mostrare al mondo quanto sia forte la natura umana». Così parlano costoro. Fuggite, o uomini, i piaceri, fuggite la molle prosperità che svigorisce l’animo, stordito come in un’eterna ebbrezza, se non s’imbatte in qualcosa che lo risvegli, che lo faccia riflettere sulla fragilità del nostro destino mortale! Chi tiene sempre chiusi i vetri delle finestre perché non passi un filo d’aria, chi si ripara i piedi dal freddo con pannicelli o scaldini rinnovati continuamente e pranza in sale riscaldate da tubature che passano sulle pareti e sotto il pavimento, è fatale che si ammali al minimo soffio di vento. Come ogni eccesso nuoce, così anche una smodata felicità è dannosissima: fa infatti girare la testa, evoca nella mente fantasie strane, frammette una diffusa nebbia tra il falso e il vero. Meglio sopportare un’infelicità senza fine sostenuti dalla virtù, piuttosto che schiattare
tra infiniti e sfrenati piaceri. Meglio morire di fame che non d’indigestione. Dio si comporta con i buoni come un maestro con i suoi scolari: pretende di più da coloro sui quali conta di più. Non è certo per odio che gli Spartani fanno frustare pubblicamente i loro figliuoli, ma per temprarne il carattere. E i padri stessi, del resto, li esortano a sopportare le nerbate con forza e con coraggio, e anche quando i loro corpi sono già pieni di piaghe e come privi di vita li persuadono a nuovi colpi e a nuove ferite. Che c’è di strano, dunque, se dio tenta con dure prove gli animi generosi? Non è facile dar segno della propria virtù. Sopportiamo le piaghe della sorte, quando essa ci assale e ci flagella, non per masochismo, ma perché si tratta di una battaglia, e saremo tanto più forti quanto più spesso la sosterremo. La parte più robusta del nostro corpo è quella sottoposta a stimoli maggiori e più frequenti. Dobbiamo esporci agli assalti della cattiva sorte per uscire rafforzati dalle sue stesse percosse: sarà lei a poco a poco a farci uguali a sé e la continua familiarità col rischio ce ne darà anche il disprezzo. È così che il fisico dei marinai s’incallisce alla rigida vita del mare e le mani dei contadini s’induriscono al lavoro. Non c’è disprezzo del male se prima non lo si sopporta, e se si vuole avere un’idea di quanta pazienza sia capace l’uomo si guardi quanto renda la fatica a quei popoli che sono privi di ogni cosa e fatti duri dal bisogno. Osserva tutte quelle genti a cui si è spinta la pace romana, intendo dire i Germani e quanti altri s’incontrano errabondi nella regione dell’Istro: un inverno continuo, interminabile, un cielo grigio li opprime, una terra infeconda li nutre a malapena; si riparano dalla pioggia in capanne di paglia e di rami, camminano su acque stagnanti indurite dal gelo e vanno a caccia di belve, loro unico cibo. Ti sembrano infelici? No, non c’è infelicità in ciò che l’abitudine ha trasformato in una condizione di vita naturale, tanto che quel che s’è cominciato a fare per necessità a poco a poco diventa persino piacevole. Quei nomadi non hanno altra casa, altra dimora che quella occasionale in cui li porta di giorno in giorno, per riposarsi, il loro spostarsi continuo e senza meta. Perdipiù vanno a corpo nudo, in un clima così rigidamente ostile, mangiano poco e quel poco devono procurarselo con le proprie mani. Ebbene, questa che a te sembra una disgrazia, per tanti popoli è la vita. Non ti stupire, dunque, se gli uomini buoni sono così tartassati, in ciò sta appunto la loro forza. Un albero non diventa solido e robusto se non è continuamente investito dal vento e sono queste raffiche che ne fanno il fusto compatto e ne rinsaldano le radici, che si abbarbicano con maggior forza al terreno; fragili sono invece quegli alberi che crescono in una valle tranquilla, esposta solo ai raggi del sole. Perciò, nel loro stesso interesse, affinché nulla possa atterrirli, è necessario che i buoni attraversino spesso esperienze dolorose, sopportando con animo sereno ciò che non è di per sé stesso un male ma che diventa tale solo per chi non è disposto a sopportarlo. 5. Va poi considerato un altro fatto: è nell’interesse di tutti che i migliori siano, per così dire, sempre sotto le armi. Il fine di dio, che poi è anche quello
dell’uomo saggio, è di dimostrare che tutto ciò che si desidera o si teme non è né buono né cattivo, di per sé. Dovrebbe essere un bene ciò che dio concede solo ai buoni e un male ciò che assegna solamente ai cattivi, ma noi detesteremmo la cecità se perdessero gli occhi soltanto quelli che lo meritano, quindi è necessario che perdano la vista anche un Appio e un Metello. 14 Le ricchezze non sono un bene e perciò le possiede pure un magnaccia come Elio, così gli uomini che hanno consacrato il denaro nei templi possono vederlo anche nel postribolo. Dio non avrebbe potuto inventare un espediente migliore per togliere valore alle cose desiderate dagli uomini che dandole ai peggiori e negandole ai migliori. «Ma non è giusto», mi dirai, «che un uomo buono perda una gamba, sia storpiato, trafitto o incatenato, e i cattivi invece se ne vadano in giro col corpo integro e sano, tutti sciolti e schizzinosi». Ah no? E allora è giusto che uomini forti prendano le armi, passino le notti negli accampamenti e montino di vedetta con le ferite ancora fasciate, mentre in città i pervertiti se ne stanno al sicuro esercitando il loro sporco mestiere? È giusto che delle nobili vergini si alzino di notte per compiere riti sacri15 mentre le prostitute se la dormono saporitamente? La fatica chiama i migliori. Il Senato passa spesso in sedute l’intera giornata e intanto gli sfaccendati nel Campo Marzio si trastullano col loro dolce far niente, si chiudono in una bettola o consumano il tempo in qualche circolo. Lo stesso accade in questo grande Stato che è l’umana società, dove sono i buoni a faticare, a impegnarsi, a lasciarsi impegnare, e lo fanno anche volentieri. Non subiscono la sorte passivamente ma le vanno dietro e si mettono al passo con lei; la precederebbero pure, se conoscessero la strada. Mi ricordo di avere udito da quel fortissimo uomo di Demetrio anche queste ardite parole: «Dio immortale, di una sola cosa ti rimprovero, di non avermi fatto conoscere in anticipo la tua volontà: mi sarei infatti mosso io per primo a quella prova a cui tu ora mi chiami. Vuoi prenderti i miei figli? Li ho generati per te. Vuoi qualche pezzo del mio corpo? Prendilo: non posso darti molto ma presto te lo restituirò tutto intero. Lo vuoi subito? Sia: perché dovrei indugiare a rimettere nelle tue mani ciò che tu m’hai prestato? Sono pronto a restituirti, e di buon grado, tutto ciò che vorrai chiedermi. Questo solo mi dispiace, che avrei preferito offrirti tutte queste cose come beni miei personali, che non si trattasse, cioè, di una restituzione. Con me non avevi bisogno di riprendertele, quando io te le donavo spontaneamente. Ma anche così, dopotutto, non me le porti via, perché si porta via una cosa solo a chi vuole tenersela». Io non mi sento né sono costretto ad alcunché da niente e da nessuno, nulla patisco o faccio contro la mia volontà in quanto il mio volere è il volere di dio, con cui concordo pienamente e di cui quindi non sono schiavo, perché so che tutto si svolge secondo una legge ben precisa e progettata per l’eternità. È il destino che ci guida e tutta la nostra vita è stata già stabilita, sin dal momento della nascita: tutte le cause, tutte le situazioni, umane e non umane, sono interdipendenti, concatenate, l’una legata all’altra, in una lunga serie che determina i fatti, sia pubblici che privati. Bisogna dunque accettare tutto con coraggio, giacché, contrariamente a quel che noi crediamo, le cose non capitano
a caso ma vengono tutte da una causa. Fin dal tempo dei tempi è stabilito di che uno goda o pianga e benché le vite dei singoli individui siano all’apparenza così diverse fra loro, la conclusione, nell’insieme, è una sola: tutto è mortale, noi come le cose che ci sono date. Perché dunque indignarsi? Perché lamentarsi? Siamo nati alla morte: la natura disponga dunque a suo piacimento di queste vite materiali che appartengono a lei, ma ciò ch’è nostro – l’anima, voglio dire – non morirà, ed è questa convinzione che deve renderci forti e sereni di fronte a tutto. L’uomo buono s’affida al destino: è un grande conforto, e anche un risarcimento, sentirsi trascinati con l’intero universo, suoi compartecipi in tutto. Consoliamoci, pensando come a quella legge di necessità, quale che essa sia, che ha stabilito per noi questa vita e questa morte, sia soggetto dio stesso: un corso irrevocabile trascina con sé, parimenti, le cose umane e le cose divine. Dio, padre e reggitore di tutto il creato e di tutti i destini, non può non seguire le leggi ch’egli stesso ha fissato: una volta che le ha ordinate deve rispettarle sino alla fine. «Ma dio», tu mi chiedi, «nel distribuire agli uomini le varie sorti, ha assegnato ai buoni povertà, ferite e morti premature: non è ingiustizia questa?» Ti rispondo subito. Il punto fondamentale è questo: l’artefice non può cambiare la materia, che per essere tale è soggetta a delle leggi precise, in virtù delle quali certe cose non si possono separare da altre, ma formano insieme a esse come un tutt’uno, organico e indivisibile. Così, per esempio, nell’uomo i caratteri deboli, portati al sonno, o a una veglia molto simile ad esso, sono costituiti, necessariamente, da elementi inerti; per un uomo forte, invece, e degno di rispetto, ci vuole un tessuto più solido, giacche per lui è previsto un cammino difficile, dovrà salire, scendere, essere sballottato dalle onde, reggere la nave nella burrasca, mantenere dritta la rotta contro la sorte avversa, dovrà affrontare molti ostacoli, molti pericoli, ch’egli stesso però riuscirà a rimuovere e ad appianare, proprio perché tale è la sua costituzione. Come il fuoco prova l’oro, così la sventura gli uomini forti. Ascolta sino a che punto il valore dell’uomo sia destinato a salire e vedrai perché il suo cammino non può andare per vie sicure e tranquille. Ardua è la strada all’inizio e tale che al primo mattino, anche se freschi, già stanchi sono i cavalli. La cima splende nel cielo più alto tanto ch’io stesso, se appena guardo la terra e il mare, son preso da un vile terrore. L’ultimo tratto discende, ma vuole una guida sicura: Teti, anche lei, nel profondo del mare che sempre m’accoglie palpita allora per me, temendo ch’io possa cadere.16 Quando quel valoroso giovinetto udì queste parole: «Salgo», esclamò: «mi piace questo cammino; vale la pena di farlo anche a costo di cadere». Lui non cessò di atterrire quell’animo ardimentoso: «Quando tu voglia tenere, senza sbagliare, la strada,
tieni diritto il corso contro le corna del Toro, sino all’arco di Emonio, alle fauci del truce Leone». A queste parole: «Aggioga il carro», fece il giovinetto. «Ciò che dici per spaventarmi mi eccita ancora di più. Voglio salire là, dove lo stesso Sole si sgomenta.» Lasciamo ai pigri e ai vili le vie piane e sicure: i valorosi salgono alle vette. 6. Ora, quanto alla domanda perché mai dio permette che ai buoni accada qualcosa di male, concluderò dicendo che in realtà non lo permette, che Egli, anzi, dal male li tiene lontani: essi infatti non compiono delitti, non commettono infamie, non hanno pensieri malvagi, ambizioni smodate, la lussuria che accieca, l’avidità sempre bramosa dei beni altrui. Dio si prende cura dei buoni e li difende, ma si può mai pretendere che ne sorvegli pure i bagagli? Essi stessi del resto, lo dispensano dal far questo, quando non danno alcuna importanza a quei bagagli, voglio dire, alle cose sensibili e materiali. Democrito17 non si sbarazzò forse delle ricchezze, ritenendole un peso alla virtù? Perché dunque ti meravigli se dio lascia che accada a un uomo buono ciò ch’egli stesso vuole che gli accada? Gli uomini buoni perdono i propri figli. Ma se sono essi stessi che li uccidono, a volte? Sono cacciati in esilio. Ma se spesso sono loro a lasciare la patria per non farvi più ritorno? Vengono uccisi. E che? Non si tolgono forse essi stessi la vita, certe volte? Ma perché devono sopportare delle prove così dure? Per insegnare a sopportarle agli altri: sono nati per essere di esempio. Immagina che dio dica: «Cos’avete da rimproverarmi, voi che avete scelto la retta via? Gli altri li ho circondati di beni falsi, avvolgendo e illudendo le loro povere menti come in un lungo e ingannevole sogno, li ho rivestiti d’oro e d’argento, ma dentro non hanno niente che valga. Guardateli nell’intimo, non nel loro aspetto esteriore, quelli che chiamate felici, e vedrete quanto siano meschini, squallidi e turpi. Come le belle pareti delle loro case: così sono fuori, ma dentro!… La loro non è una vera felicità, è soltanto una crosta, e perdipiù sottile. Per questo, finché riescono a tenersi in piedi e a mostrarsi come gli piace, abbagliano e infinocchiano gli altri, ma appena barcollano o si scoprono per qualche improvviso accidente, allora si vede quanta reale ed estesa sporcizia si nascondeva sotto quello splendore artificiale. A voi buoni ho dato dei beni sicuri, durevoli, che quanto più si girano e si rigirano per guardarli da tutte le parti tanto più risultano splendidi e grandi; a voi ho concesso di non tenere in alcun conto le cose che agli altri fanno paura, di disprezzare le passioni. La luce vostra è di dentro, è lì che sono i vostri beni. Così l’universo non ha cura e non gioisce del suo aspetto esteriore, ma della sua intima essenza. Ogni mio bene io l’ho riposto in voi. La vostra felicità sta nel non aver bisogno di felicità. “Ma sono tanti i mali che ci colpiscono, dolorosi, terribili e duri a sopportarsi”. E io, dal momento che non potevo privarvi di essi, vi ho dato le armi per combatterli. Sopportateli dunque con coraggio: in questo potete superare dio stesso, perché
lui è al di fuori di ogni sopportazione, voi ne siete al di sopra. Disprezzate la povertà: non si è mai così poveri come quando si nasce. Disprezzate il dolore: o riuscirete a liberarvene o sarà lui a liberare voi. Disprezzate la morte: non è che una fine o un passaggio, per voi. Disprezzate la sorte: non le ho dato alcuna arma che possa colpire voi. Ma soprattutto ho disposto che nessuno al mondo possa costringervi ad alcunché contro il vostro volere. Per voi sempre aperta è l’uscita verso la libertà: se ritenete di non dover combattere, servitevene. Per questo fra tutte le prove necessarie a cui ho voluto sottoporvi non ne ho fatta nessuna più facile della morte. Ho posto la vostra anima come in un pendìo, sì che, volendo, invece di salire essa possa discendere e andarsene via. Vi basta poco per capire quanto sia breve e spedita la strada che conduce alla libertà: non ho messo all’uscita della vita tante remore quante ne ho poste invece all’ingresso, giacché troppo grande sarebbe su di voi il potere della sorte se per morire occorresse tanto tempo quanto quello che ci vuole per nascere. Ogni momento, ogni luogo v’insegni quanto sia facile ricusare la natura, sbattendole in faccia il suo dono. Proprio là dove s’implora la vita, fra gli altari e i solenni riti sacrificali, imparate a conoscere la morte. Vedete come basti una piccola ferita per far piombare a terra un grosso toro e come un uomo con un solo colpo di mano riesca ad abbattere animali di grande forza, come una lama sottilissima sia sufficiente a spezzare la giuntura del collo e una volta recisa l’articolazione che lo connette alla testa l’intera mole del corpo precipiti giù. Non è nel profondo che si cela la vita, non c’è bisogno di alcun pugnale per estirparla, non serve esplorarne i precordi con una lunga ferita per ritrovarne il nodo: la morte è a portata di mano, non ho designato un punto fisso e preciso ai colpi che possono provocarla, qualunque strada le è aperta. Ed è così rapido l’istante in cui la morte si realizza, quando l’anima si stacca dal corpo, ch’è impossibile coglierne la velocità. Che un cappio vi strozzi la gola, che vi soffochi l’acqua, vi si fracassi la testa sopra la dura terra o il fumo di un incendio vi blocchi il ritmo del respiro, in qualunque modo la morte si affretta verso di voi. Ed è vergogna temere per tutto il corso della vita ciò che si compie in un istante».
1. Gaio Lucilio Iuniore era procuratore della Sicilia. Seneca gli dedica anche le Questioni naturali e le Epistole. 2. Marco Petreio, legato di Pompeo in Spagna dal 54 al 49 a.C., e Giuba, re della Numidia, si scontrarono in duello: Giuba, dopo aver uciso Petreio, si fece dare la morte da uno schiavo. 3. Catone, prima di suicidarsi, in Utica, fece imbarcare e fuggire i senatori. Della sua morte parla anche Plutarco, il quale narra che, infertosi il primo colpo, non mortale, rifiutò il soccorso del medico e si lacerò le viscere con le sue stesse mani. 4. Demetrio era un filosofo cinico, amico di Seneca. 5. Muzio Scevola si bruciò la mano destra su un braciere per punirsi di aver fallito l’uccisione di Porsenna. 6. Caio Fabrizio, inviato come ambasciatore al re Pirro, ne sdegnò le ricche offerte.
7. Rutilio, esiliato, prima a Mitilene poi a Smirne, richiamato in patria da Scilla, rifiutò di tornarvi. 8. Attilio Regolo, fatto prigioniero dai Cartaginesi e inviato a Roma per trattare la pace, dissuase il Senato dal farlo e riconsegnatosi al nemico fu da questo torturato e ucciso. 9. Silla si era dato il soprannome di Felice. 10. Allude alla Lex Cornelia de sicariis et veneficiis, emanata da Silla nell’81 a.C. 11. Mecenate, consigliere di Augusto e protettore dei letterati, non era ben visto da Seneca. Terenzia, a cui si accenna più avanti, era la moglie. 12. Publio Vatinio, tribuno nel 59 e pretore nel 54 a.C., fu accusato di brogli elettorali. 13. I “mirmilloni” erano gladiatori, così chiamati dal mormyr, un pesce, di cui portavano l’immagine sull’elmo. 14. Appio Claudio Cieco è il famoso censore. A lui si deve la costruzione della via Appia da Roma a Capua. Cecilio Metello è il pontefice massimo che perse la vista nell’incendio del tempio di Vesta. 15. Le Vestali erano sacerdotesse di Vesta, dea della casa e del focolare, che avevano fatto voto di castità. 16. Il passo citato è di Ovidio (Metamorfosi II, 63-69) e riporta il dialogo fra il Sole e suo figlio Fetonte. Il Toro e il Leone sono le costellazioni, l’arco di Emonio è il Sagittario. 17. Democrito, di Abdera, è il filosofo greco del IV secolo a.C. a cui si deve la teoria che vuole la materia costituita da atomi, dal cui moto hanno origine tutte le cose.
Lettere a Lucilio e altre opere
Lettere a Lucilio, Apocolocintosi, La clemenza, I benefìci, Questioni naturali, Sul matrimonio Cura e versione di Mario Scaffidi Abbate
Epistulae morales
Liber primus 1. Ita fac, mi Lucili: vindica te tibi, et tempus quod adhuc aut auferebatur aut subripiebatur aut excidebat collige et serva. Persuade tibi hoc sic esse ut scribo: quaedam tempora eripiuntur nobis, quaedam subducuntur, quaedam effluunt. Turpissima tamen est iactura quae per neglegentiam fit. Et si volueris adtendere, magna pars vitae elabitur male agentibus, maxima nihil agentibus, tota vita aliud agentibus. Quem mihi dabis qui aliquod pretium tempori ponat, qui diem aestimet, qui intellegat se cotidie mori? In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus: magna pars eius iam praeterit; quidquid aetatis retro est mors tenet. Fac ergo, mi Lucili, quod facere te scribis, omnes horas conplectere; sic fiet ut minus ex crastino pendeas, si hodierno manum inieceris. Dum differtur vita transcurrit. Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est; in huius rei unius fugacis ac lubricae possessionem natura nos misit, ex qua expellit quicumque vult. Et tanta stultitia mortalium est ut quae minima et vilissima sunt, certe reparabilia, inputari sibi cum inpetravere patiantur, nemo se iudicet quicquam debere qui tempus accepit, cum interim hoc unum est quod ne gratus quidem potest reddere. Interrogabis fortasse quid ego faciam qui tibi ista praecipio. Fatebor ingenue: quod apud luxuriosum sed diligentem evenit, ratio mihi constat inpensae. Non possum dicere nihil perdere, sed quid perdam et quare et quemadmodum dicam; causas paupertatis meae reddam. Sed evenit mihi quod plerisque non suo vitio ad inopiam redactis: omnes ignoscunt, nemo succurrit. Quid ergo est? Non puto pauperem cui quantulumcumque superest sat est; tu tamen malo serves tua, et bono tempore incipies. Nam ut visum est maioribus nostris, «sera parsimonia in fundo est»; non enim tantum minimum in imo sed pessimum remanet. Vale. 2. Ex iis quae mihi scribis et ex iis quae audio bonam spem de te concipio: non discurris nec locorum mutationibus inquietaris. Aegri animi ista iactatio est: primum argumentum compositae mentis existimo posse consistere et secum morari. Illud autem vide, ne ista lectio auctorum multorum et omnis generis voluminum habeat aliquid vagum et instabile. Certis ingeniis inmorari et innutriri oportet, si velis aliquid trahere quod in animo fideliter sedeat. Nusquam est qui ubique est. Vitam in peregrinatione exigentibus hoc evenit, ut multa hospitia habeant, nullas amicitias; idem accidat necesse est iis qui nullius se ingenio familiariter applicant sed omnia cursim et properantes transmittunt. Non prodest cibus nec corpori accedit qui statim sumptus emittitur; nihil aeque sanitatem inpedit quam remediorum crebra mutatio; non venit vulnus ad cicatricem in quo
medicamenta temptantur; non convalescit planta quae saepe transfertur; nihil tam utile est ut in transitu prosit. Distringit librorum multitudo; itaque cum legere non possis quantum habueris, satis est habere quantum legas. «Sed modo» inquis «hunc librum evolvere volo, modo illum». Fastidientis stomachi est multa degustare; quae ubi varia sunt et diversa, inquinant non alunt. Probatos itaque semper lege, et si quando ad alios deverti libuerit, ad priores redi. Aliquid cotidie adversus paupertatem, aliquid adversus mortem auxili compara, nec minus adversus ceteras pestes; et cum multa percurreris, unum excerpe quod illo die concoquas. Hoc ipse quoque facio; ex pluribus quae legi aliquid adprehendo. Hodiernum hoc est quod apud Epicurum nanctus sum (soleo enim et in aliena castra transire, non tamquam transfuga, sed tamquam explorator): «honesta» inquit «res est laeta paupertas». Illa vero non est paupertas, si laeta est; non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est. Quid enim refert quantum illi in arca, quantum in horreis iaceat, quantum pascat aut feneret, si alieno imminet, si non adquisita sed adquirenda conputat? Quis sit divitiarum modus quaeris? Primus habere quod necesse est, proximus quod sat est. Vale. 3. Epistulas ad me perferendas tradidisti, ut scribis, amico tuo; deinde admones me ne omnia cum eo ad te pertinentia communicem, quia non soleas ne ipse quidem id facere: ita eadem epistula illum et dixisti amicum et negasti. Itaque si proprio illo verbo quasi publico usus es et sic illum amicum vocasti quomodo omnes candidatos «bonos viros» dicimus, quomodo obvios, si nomen non succurrit, «dominos» salutamus, hac abierit. Sed si aliquem amicum existimas cui non tantundem credis quantum tibi, vehementer erras et non satis nosti vim verae amicitiae. Tu vero omnia cum amico delibera, sed de ipso prius: post amicitiam credendum est, ante amicitiam iudicandum. Isti vero praepostero officia permiscent qui, contra praecepta Theophrasti, cum amaverunt iudicant, et non amant cum iudicaverunt. Diu cogita an tibi in amicitiam aliquis recipiendus sit. Cum placuerit fieri, toto illum pectore admitte; tam audaciter cum illo loquere quam tecum. Tu quidem ita vive ut nihil tibi committas nisi quod committere etiam inimico tuo possis; sed quia interveniunt quaedam quae consuetudo fecit arcana, cum amico omnes curas, omnes cogitationes tuas misce. Fidelem si putaveris, facies; nam quidam fallere docuerunt dum timent falli, et illi ius peccandi suspicando fecerunt. Quid est quare ego ulla verba coram amico meo retraham? Quid est quare me coram illo non putem solum? Quidam quae tantum amicis committenda sunt obviis narrant, et in quaslibet aures quidquid illos urit exonerant; quidam rursus etiam carissimorum conscientiam reformidant et, si possent, ne sibi quidem credituri interius premunt omne secretum. Neutrum faciendum est; utrumque enim vitium est, et omnibus credere et nulli, sed alterum honestius dixerim vitium, alterum tutius. Sic utrosque reprehendas, et eos qui semper inquieti sunt, et eos qui semper quiescunt. Nam illa tumultu gaudens non est industria sed exagitatae mentis concursatio, et haec non est quies quae motum omnem molestiam iudicat, sed dissolutio et languor. Itaque hoc quod apud
Pomponium legi animo mandabitur: «quidam adeo in latebras refugerunt ut putent in turbido esse quidquid in luce est». Inter se ista miscenda sunt: et quiescenti agendum et agenti quiescendum est. Cum rerum natura delibera: illa dicet tibi et diem fecisse se et noctem. Vale. 4. Persevera ut coepisti et quantum potes propera, quo diutius frui emendato animo et composito possis. Frueris quidem etiam dum emendas, etiam dum componis: alia tamen illa voluptas est quae percipitur ex contemplatione mentis ab omni labe purae et splendidae. Tenes utique memoria quantum senseris gaudium cum praetexta posita sumpsisti virilem togam et in forum deductus es: maius expecta cum puerilem animum deposueris et te in viros philosophia transscripserit. Adhuc enim non pueritia sed, quod est gravius, puerilitas remanet; et hoc quidem peior est, quod auctoritatem habemus senum, vitia puerorum, nec puerorum tantum sed infantum: illi levia, hi falsa formidant, nos utraque. Profice modo: intelleges quaedam ideo minus timenda quia multum metus adferunt. Nullum malum magnum quod extremum est. Mors ad te venit: timenda erat si tecum esse posset: necesse est aut non perveniat aut transeat. «Difficile est» inquis «animum perducere ad contemptionem animae». Non vides quam ex frivolis causis contemnatur? Alius ante amicae fores laqueo pependit, alius se praecipitavit e tecto ne dominum stomachantem diutius audiret, alius ne reduceretur e fuga ferrum adegit in viscera: non putas virtutem hoc effecturam quod efficit nimia formido? Nulli potest secura vita contingere qui de producenda nimis cogitat, qui inter magna bona multos consules numerat. Hoc cotidie meditare, ut possis aequo animo vitam relinquere, quam multi sic conplectuntur et tenent quomodo qui aqua torrente rapiuntur spinas et aspera. Plerique inter mortis metum et vitae tormenta miseri fluctuantur et vivere nolunt, mori nesciunt. Fac itaque tibi iucundam vitam omnem pro illa sollicitudinem deponendo. Nullum bonum adiuvat habentem nisi ad cuius amissionem praeparatus est animus; nullius autem rei facilior amissio est quam quae desiderari amissa non potest. Ergo adversus haec quae incidere possunt etiam potentissimis adhortare te et indura. De Pompei capite pupillus et spado tulere sententiam, de Crasso crudelis et insolens Parthus; Gaius Caesar iussit Lepidum Dextro tribuno praebere cervicem, ipse Chaereae praestitit; neminem eo fortuna provexit ut non tantum illi minaretur quantum permiserat. Noli huic tranquillitati confidere: momento mare evertitur; eodem die ubi luserunt navigia sorbentur. Cogita posse et latronem et hostem admovere iugulo tuo gladium; ut potestas maior absit, nemo non servus habet in te vitae necisque arbitrium. Ita dico: quisquis vitam suam contempsit tuae dominus est. Recognosce exempla eorum qui domesticis insidiis perierunt, aut aperta vi aut dolo: intelleges non pauciores servorum ira cecidisse quam regum. Quid ad te itaque quam potens sit quem times, cum id propter quod times nemo non possit? At si forte in manus hostium incideris, victor te duci iubebit – eo nempe quo duceris. Quid te ipse decipis et hoc nunc primum quod olim patiebaris intellegis? Ita dico: ex quo natus es,
duceris. Haec et eiusmodi versanda in animo sunt si volumus ultimam illam horam placidi expectare cuius metus omnes alias inquietas facit. Sed ut finem epistulae inponam, accipe quod mihi hodierno die placuit – et hoc quoque ex alienis hortulis sumptum est: «magnae divitiae sunt lege naturae composita paupertas». Lex autem illa naturae scis quos nobis terminos statuat? Non esurire, non sitire, non algere. Ut famem sitimque depellas non est necesse superbis adsidere liminibus nec supercilium grave et contumeliosam etiam humanitatem pati, non est necesse maria temptare nec sequi castra: parabile est quod natura desiderat et adpositum. Ad supervacua sudatur; illa sunt quae togam conterunt, quae nos senescere sub tentorio cogunt, quae in aliena litora inpingunt: ad manum est quod sat est. Cui cum paupertate bene convenit dives est. Vale. 5. Quod pertinaciter studes et omnibus omissis hoc unum agis, ut te meliorem cotidie facias, et probo et gaudeo, nec tantum hortor ut perseveres sed etiam rogo. Illud autem te admoneo, ne eorum more qui non proficere sed conspici cupiunt facias aliqua quae in habitu tuo aut genere vitae notabilia sint; asperum cultum et intonsum caput et neglegentiorem barbam et indictum argento odium et cubile humi positum et quidquid aliud ambitionem perversa via sequitur evita. Satis ipsum nomen philosophiae, etiam si modeste tractetur, invidiosum est: quid si nos hominum consuetudini coeperimus excerpere? Intus omnia dissimilia sint, frons populo nostra conveniat. Non splendeat toga, ne sordeat quidem; non habeamus argentum in quod solidi auri caelatura descenderit, sed non putemus frugalitatis indicium auro argentoque caruisse. Id agamus ut meliorem vitam sequamur quam vulgus, non ut contrariam: alioquin quos emendari volumus fugamus a nobis et avertimus; illud quoque efficimus, ut nihil imitari velint nostri, dum timent ne imitanda sint omnia. Hoc primum philosophia promittit, sensum communem, humanitatem et congregationem; a qua professione dissimilitudo nos separabit. Videamus ne ista per quae admirationem parare volumus ridicula et odiosa sint. Nempe propositum nostrum est secundum naturam vivere: hoc contra naturam est, torquere corpus suum et faciles odisse munditias et squalorem adpetere et cibis non tantum vilibus uti sed taetris et horridis. Quemadmodum desiderare delicatas res luxuriaest, ita usitatas et non magno parabiles fugere dementiae. Frugalitatem exigit philosophia, non poenam; potest autem esse non incompta frugalitas. Hic mihi modus placet: temperetur vita inter bonos mores et publicos; suspiciant omnes vitam nostram sed agnoscant. «Quid ergo? Eadem faciemus quae ceteri? Nihil inter nos et illos intererit?» Plurimum: dissimiles esse nos vulgo sciat qui inspexerit propius; qui domum intraverit nos potius miretur quam supellectilem nostram. Magnus ille est qui fictilibus sic utitur quemadmodum argento, nec ille minor est qui sic argento utitur quemadmodum fictilibus; infirmi animi est pati non posse divitias. Sed ut huius quoque diei lucellum tecum communicem, apud Hecatonem nostrum inveni cupiditatum finem etiam ad timoris remedia proficere. «Desines» inquit «timere, si sperare desieris». Dices, «quomodo ista tam diversa pariter
sunt?» Ita est, mi Lucili: cum videantur dissidere, coniuncta sunt. Quemadmodum eadem catena et custodiam et militem copulat, sic ista quae tam dissimilia sunt pariter incedunt: spem metus sequitur. Nec miror ista sic ire: utrumque pendentis animi est, utrumque futuri expectatione solliciti. Maxima autem utriusque causa est quod non ad praesentia aptamur sed cogitationes in longinqua praemittimus; itaque providentia, maximum bonum condicionis humanae, in malum versa est. Ferae pericula quae vident fugiunt, cum effugere, securae sunt: nos et venturo torquemur et praeterito. Multa bona nostra nobis nocent; timoris enim tormentum memoria reducit, providentia anticipat; nemo tantum praesentibus miser est. Vale. 6. Intellego, Lucili, non emendari me tantum sed transfigurari; nec hoc promitto iam aut spero, nihil in me superesse quod mutandum sit. Quidni multa habeam quae debeant colligi, quae extenuari, quae attolli? Et hoc ipsum argumentum est in melius translati animi, quod vitia sua quae adhuc ignorabat videt; quibusdam aegris gratulatio fit cum ipsi aegros se esse senserunt. Cuperem itaque tecum communicare tam subitam mutationem mei; tunc amicitiae nostrae certiorem fiduciam habere coepissem, illius verae quam non spes, non timor, non utilitatis suae cura divellit, illius cum qua homines moriuntur, pro qua moriuntur. Multos tibi dabo qui non amico sed amicitia caruerint: hoc non potest accidere cum animos in societatem honesta cupiendi par voluntas trahit. Quidni non possit? Sciunt enim ipsos omnia habere communia, et quidem magis adversa. Concipere animo non potes quantum momenti adferre mihi singulos dies videam. «Mitte» inquis «et nobis ista quae tam efficacia expertus es». Ego vero omnia in te cupio transfundere, et in hoc aliquid gaudeo discere, ut doceam; nec me ulla res delectabit, licet sit eximia et salutaris, quam mihi uni sciturus sum. Si cum hac exceptione detur sapientia, ut illam inclusam teneam nec enuntiem, reiciam: nullius boni sine socio iucunda possessio est. Mittam itaque ipsos tibi libros, et ne multum operae inpendas dum passim profutura sectaris, inponam notas, ut ad ipsa protinus quae probo et miror accedas. Plus tamen tibi et viva vox et convictus quam oratio proderit; in rem praesentem venias oportet, primum quia homines amplius oculis quam auribus credunt, deinde quia longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla. Zenonem Cleanthes non expressisset, si tantummodo audisset: vitae eius interfuit, secreta perspexit, observavit illum, an ex formula sua viveret. Platon et Aristoteles et omnis in diversum itura sapientium turba plus ex moribus quam ex verbis Socratis traxit; Metrodorum et Hermarchum et Polyaenum magnos viros non schola Epicuri sed contubernium fecit. Nec in hoc te accerso tantum, ut proficias, sed ut prosis; plurimum enim alter alteri conferemus. Interim quoniam diurnam tibi mercedulam debeo, quid me hodie apud Hecatonem delectaverit dicam. «Quaeris» inquit «quid profecerim? Amicus esse mihi coepi». Multum profecit: numquam erit solus. Scito esse hunc amicum omnibus. Vale.
7. Quid tibi vitandum praecipue existimes quaeris? Turbam. Nondum illi tuto committeris. Ego certe confitebor inbecillitatem meam: numquam mores quos extuli refero; aliquid ex eo quod composui turbatur, aliquid ex iis quae fugavi redit. Quod aegris evenit quos longa inbecillitas usque eo adfecit ut nusquam sine offensa proferantur, hoc accidit nobis quorum animi ex longo morbo reficiuntur. Inimica est multorum conversatio: nemo non aliquod nobis vitium aut commendat aut inprimit aut nescientibus adlinit. Utique quo maior est populus cui miscemur, hoc periculi plus est. Nihil vero tam damnosum bonis moribus quam in aliquo spectaculo desidere; tunc enim per voluptatem facilius vitia subrepunt. Quid me existimas dicere? Avarior redeo, ambitiosior, luxuriosior? Immo vero crudelior et inhumanior, quia inter homines fui. Casu in meridianum spectaculum incidi, lusus expectans et sales et aliquid laxamenti quo hominum oculi ab humano cruore adquiescant. Contra est: quidquid ante pugnatum est misericordia fuit; nunc omissis nugis mera homicidia sunt. Nihil habent quo tegantur; ad ictum totis corporibus expositi numquam frustra manum mittunt. Hoc plerique ordinariis paribus et postulaticiis praeferunt. Quidni praeferant? Non galea, non scuto repellitur ferrum. Quo munimenta? Quo artes? Omnia ista mortis morae sunt. Mane leonibus et ursis homines, meridie spectatoribus suis obiciuntur. Interfectores interfecturis iubent obici et victorem in aliam detinent caedem; exitus pugnantium mors est. Ferro et igne res geritur. Haec fiunt dum vacat harena. «Sed latrocinium fecit aliquis, occidit hominem». Quid ergo? Quia occidit, ille meruit ut hoc pateretur: tu quid meruisti miser ut hoc spectes? «Occide, verbera, ure! Quare tam timide incurrit in ferrum? Quare parum audacter occidit? Quare parum libenter moritur? Plagis agatur in vulnera, mutuos ictus nudis et obviis pectoribus excipiant». Intermissum est spectaculum: «interim iugulentur homines, ne nihil agatur». Age, ne hoc quidem intellegitis, mala exempla in eos redundare qui faciunt? Agite dis immortalibus gratias quod eum docetis esse crudelem qui non potest discere. Subducendus populo est tener animus et parum tenax recti: facile transitur ad plures. Socrati et Catoni et Laelio excutere morem suum dissimilis multitudo potuisset: adeo nemo nostrum, qui cum maxime concinnamus ingenium, ferre impetum vitiorum tam magno comitatu venientium potest. Unum exemplum luxuriae aut avaritiae multum mali facit: convictor delicatus paulatim enervat et mollit, vicinus dives cupiditatem inritat, malignus comes quamvis candido et simplici rubiginem suam adfricuit: quid tu accidere his moribus credis in quos publice factus est impetus? Necesse est aut imiteris aut oderis. Utrumque autem devitandum est: neve similis malis fias, quia multi sunt, neve inimicus multis, quia dissimiles sunt. Recede in te ipse quantum potes; cum his versare qui te meliorem facturi sunt, illos admitte quos tu potes facere meliores. Mutuo ista fiunt, et homines dum docent discunt. Non est quod te gloria publicandi ingenii producat in medium, ut recitare istis velis aut disputare; quod facere te vellem, si haberes isti populo idoneam mercem: nemo est qui intellegere te possit. Aliquis fortasse, unus aut alter incidet, et hic ipse formandus tibi erit instituendusque ad
intellectum tui. «Cui ergo ista didici?» Non est quod timeas ne operam perdideris, si tibi didicisti. Sed ne soli mihi hodie didicerim, communicabo tecum quae occurrunt mihi egregie dicta circa eundem fere sensum tria, ex quibus unum haec epistula in debitum solvet, duo in antecessum accipe. Democritus ait, «unus mihi pro populo est, et populus pro uno». Bene et ille, quisquis fuit (ambigitur enim de auctore), cum quaereretur ab illo quo tanta diligentia artis spectaret ad paucissimos perventurae, «satis sunt» inquit «mihi pauci, satis est unus, satis est nullus». Egregie hoc tertium Epicurus, cum uni ex consortibus studiorum suorum scriberet: «haec» inquit «ego non multis, sed tibi; satis enim magnum alter alteri theatrum sumus». Ista, mi Lucili, condenda in animum sunt, ut contemnas voluptatem ex plurium adsensione venientem. Multi te laudant: ecquid habes cur placeas tibi, si is es quem intellegant multi? Introrsus bona tua spectent. Vale. 8. «Tu me» inquis «vitare turbam iubes, secedere et conscientia esse contentum? Ubi illa praecepta vestra quae imperant in actu mori?» Quid? Ego tibi videor inertiam suadere? In hoc me recondidi et fores clusi, ut prodesse pluribus possem. Nullus mihi per otium dies exit; partem noctium studiis vindico; non vaco somno sed succumbo, et oculos vigilia fatigatos cadentesque in opere detineo. Secessi non tantum ab hominibus sed a rebus, et in primis a meis rebus: posterorum negotium ago. Illis aliqua quae possint prodesse conscribo; salutares admonitiones, velut medicamentorum utilium compositiones, litteris mando, esse illas efficaces in meis ulceribus expertus, quae etiam si persanata non sunt, serpere desierunt. Rectum iter, quod sero cognovi et lassus errando, aliis monstro. Clamo: «vitate quaecumque vulgo placent, quae casus adtribuit; ad omne fortuitum bonum suspiciosi pavidique subsistite: et fera et piscis spe aliqua oblectante decipitur. Munera ista fortunae putatis? Insidiae sunt. Quisquis vestrum tutam agere vitam volet, quantum plurimum potest ista viscata beneficia devitet in quibus hoc quoque miserrimi fallimur: habere nos putamus, haeremus. In praecipitia cursus iste deducit; huius eminentis vitae exitus cadere est. Deinde ne resistere quidem licet, cum coepit transversos agere felicitas, aut saltim rectis aut semel ruere: non vertit fortuna sed cernulat et allidit. Hanc ergo sanam ac salubrem formam vitae tenete, ut corpori tantum indulgeatis quantum bonae valetudini satis est. Durius tractandum est ne animo male pareat: cibus famem sedet, potio sitim extinguat, vestis arceat frigus, domus munimentum sit adversus infesta temporis. Hanc utrum caespes erexerit an varius lapis gentis alienae, nihil interest: scitote tam bene hominem culmo quam auro tegi. Contemnite omnia quae supervacuus labor velut ornamentum ac decus ponit; cogitate nihil praeter animum esse mirabile, cui magno nihil magnum est». Si haec mecum, si haec cum posteris loquor, non videor tibi plus prodesse quam cum ad vadimonium advocatus descenderem aut tabulis testamenti anulum inprimerem aut in senatu candidato vocem et manum commodarem? Mihi crede, qui nihil agere videntur maiora agunt: humana divinaque simul tractant.
Sed iam finis faciendus est et aliquid, ut institui, pro hac epistula dependendum. Id non de meo fiet: adhuc Epicurum compilamus, cuius hanc vocem hodierno die legi: «philosophiae servias oportet, ut tibi contingat vera libertas». Non differtur in diem qui se illi subiecit et tradidit: statim circumagitur; hoc enim ipsum philosophiae servire libertas est. Potest fieri ut me interroges quare ab Epicuro tam multa bene dicta referam potius quam nostrorum: quid est tamen quare tu istas Epicuri voces putes esse, non publicas? Quam multi poetae dicunt quae philosophis aut dicta sunt aut dicenda! Non attingam tragicos nec togatas nostras (habent enim hae quoque aliquid severitatis et sunt inter comoedias ac tragoedias mediae): quantum disertissimorum versuum inter mimos iacet! quam multa Publilii non excalceatis sed coturnatis dicenda sunt! Unum versum eius, qui ad philosophiam pertinet et ad hanc partem quae modo fuit in manibus, referam, quo negat fortuita in nostro habenda: alienum est omne quidquid optando evenit. Hunc sensum a te dici non paulo melius et adstrictius memini: non est tuum fortuna quod fecit tuum. Illud etiamnunc melius dictum a te non praeteribo: dari bonum quod potuit auferri potest. Hoc non inputo in solutum: de tuo tibi. Vale. 9. An merito reprehendat in quadam epistula Epicurus eos qui dicunt sapientem se ipso esse contentum et propter hoc amico non indigere, desideras scire. Hoc obicitur Stilboni ab Epicuro et iis quibus summum bonum visum est animus inpatiens. In ambiguitatem incidendum est, si exprimere ajpavqeian uno verbo cito voluerimus et inpatientiam dicere; poterit enim contrarium ei quod significare volumus intellegi. Nos eum volumus dicere qui respuat omnis mali sensum: accipietur is qui nullum ferre possit malum. Vide ergo num satius sit aut invulnerabilem animum dicere aut animum extra omnem patientiam positum. Hoc inter nos et illos interest: noster sapiens vincit quidem incommodum omne sed sentit, illorum ne sentit quidem. Illud nobis et illis commune est, sapientem se ipso esse contentum. Sed tamen et amicum habere vult et vicinum et contubernalem, quamvis sibi ipse sufficiat. Vide quam sit se contentus: aliquando sui parte contentus est. Si illi manum aut morbus aut hostis exciderit, si quis oculum vel oculos casus excusserit, reliquiae illi suae satisfacient et erit inminuto corpore et amputato tam laetus quam integro fuit; sed si quae sibi desunt non desiderat, non deesse mavult. Ita sapiens se contentus est, non ut velit esse sine amico sed ut possit; et hoc quod dico «possit» tale est: amissum aequo
animo fert. Sine amico quidem numquam erit: in sua potestate habet quam cito reparet. Quomodo si perdiderit Phidias statuam protinus alteram faciet, sic hic faciendarum amicitiarum artifex substituet alium in locum amissi. Quaeris quomodo amicum cito facturus sit? Dicam, si illud mihi tecum convenerit, ut statim tibi solvam quod debeo et quantum ad hanc epistulam paria faciamus. Hecaton ait, «ego tibi monstrabo amatorium sine medicamento, sine herba, sine ullius veneficae carmine: si vis amari, ama». Habet autem non tantum usus amicitiae veteris et certae magnam voluptatem sed etiam initium et comparatio novae. Quod interest inter metentem agricolam et serentem, hoc inter eum qui amicum paravit et qui parat. Attalus philosophus dicere solebat iucundius esse amicum facere quam habere, «quomodo artifici iucundius pingere est quam pinxisse». Illa in opere suo occupata sollicitudo ingens oblectamentum habet in ipsa occupatione: non aeque delectatur qui ab opere perfecto removit manum. Iam fructu artis suae fruitur: ipsa fruebatur arte cum pingeret. Fructuosior est adulescentia liberorum, sed infantia dulcior. Nunc ad propositum revertamur. Sapiens etiam si contentus est se, tamen habere amicum vult, si nihil aliud, ut exerceat amicitiam, ne tam magna virtus iaceat, non ad hoc quod dicebat Epicurus in hac ipsa epistula, «ut habeat qui sibi aegro adsideat, succurrat in vincula coniecto vel inopi», sed ut habeat aliquem cui ipse aegro adsideat, quem ipse circumventum hostili custodia liberet. Qui se spectat et propter hoc ad amicitiam venit male cogitat. Quemadmodum coepit, sic desinet: paravit amicum adversum vincla laturum opem; cum primum crepuerit catena, discedet. Hae sunt amicitiae quas temporarias populus appellat; qui utilitatis causa adsumptus est tamdiu placebit quamdiu utilis fuerit. Hac re florentes amicorum turba circumsedet, circa eversos solitudo est, et inde amici fugiunt ubi probantur; hac re ista tot nefaria exempla sunt aliorum metu relinquentium, aliorum metu prodentium. Necesse est initia inter se et exitus congruant: qui amicus esse coepit quia expedit et desinet quia expedit; placebit aliquod pretium contra amicitiam, si ullum in illa placet praeter ipsam. «In quid amicum paras?». Ut habeam pro quo mori possim, ut habeam quem in exilium sequar, cuius me morti et opponam et inpendam: ista quam tu describis negotiatio est, non amicitia, quae ad commodum accedit, quae quid consecutura sit spectat. Non dubie habet aliquid simile amicitiae adfectus amantium; possis dicere illam esse insanam amicitiam. Numquid ergo quisquam amat lucri causa? Numquid ambitionis aut gloriae? Ipse per se amor, omnium aliarum rerum neglegens, animos in cupiditatem formae non sine spe mutuae caritatis accendit. Quid ergo? Ex honestiore causa coit turpis adfectus? «Non agitur» inquis «nunc de hoc, an amicitia propter se ipsam adpetenda sit». Immo vero nihil magis probandum est; nam si propter se ipsam expetenda est, potest ad illam accedere qui se ipso contentus est. «Quomodo ergo ad illam accedit?». Quomodo ad rem pulcherrimam, non lucro captus nec varietate fortunae perterritus; detrahit amicitiae maiestatem suam qui illam parat ad bonos casus. «Se contentus est sapiens». Hoc, mi Lucili, plerique perperam interpretantur:
sapientem undique submovent et intra cutem suam cogunt. Distinguendum autem est quid et quatenus vox ista promittat: se contentus est sapiens ad beate vivendum, non ad vivendum; ad hoc enim multis illi rebus opus est, ad illud tantum animo sano et erecto et despiciente fortunam. Volo tibi Chrysippi quoque distinctionem indicare. Ait sapientem nulla re egere, et tamen multis illi rebus opus esse: «contra stulto nulla re opus est (nulla enim re uti scit) sed omnibus eget». Sapienti et manibus et oculis et multis ad cotidianum usum necessariis opus est, eget nulla re; egere enim necessitatis est, nihil necesse sapienti est. Ergo quamvis se ipso contentus sit, amicis illi opus est; hos cupit habere quam plurimos, non ut beate vivat; vivet enim etiam sine amicis beate. Summum bonum extrinsecus instrumenta non quaerit; domi colitur, ex se totum est; incipit fortunae esse subiectum si quam partem sui foris quaerit. «Qualis tamen futura est vita sapientis, si sine amicis relinquatur in custodiam coniectus vel in aliqua gente aliena destitutus vel in navigatione longa retentus aut in desertum litus eiectus?». Qualis est Iovis, cum resoluto mundo et dis in unum confusis paulisper cessante natura adquiescit sibi cogitationibus suis traditus. Tale quiddam sapiens facit: in se reconditur, secum est. Quamdiu quidem illi licet suo arbitrio res suas ordinare, se contentus est et ducit uxorem; se contentus est et liberos tollit; se contentus est et tamen non viveret si foret sine homine victurus. Ad amicitiam fert illum nulla utilitas sua, sed naturalis inritatio; nam ut aliarum nobis rerum innata dulcedo est, sic amicitiae. Quomodo solitudinis odium est et adpetitio societatis, quomodo hominem homini natura conciliat, sic inest huic quoque rei stimulus qui nos amicitiarum adpetentes faciat. Nihilominus cum sit amicorum amantissimus, cum illos sibi comparet, saepe praeferat, omne intra se bonum terminabit et dicet quod Stilbon ille dixit, Stilbon quem Epicuri epistula insequitur. Hic enim capta patria, amissis liberis, amissa uxore, cum ex incendio publico solus et tamen beatus exiret, interroganti Demetrio, cui cognomen ab exitio urbium Poliorcetes fuit, num quid perdidisset, «omnia» inquit «bona mea mecum sunt». Ecce vir fortis ac strenuus! ipsam hostis sui victoriam vicit. «Nihil» inquit «perdidi»: dubitare illum coegit an vicisset. «Omnia mea mecum sunt»: iustitia, virtus, prudentia, hoc ipsum, nihil bonum putare quod eripi possit. Miramur animalia quaedam quae per medios ignes sine noxa corporum transeunt: quanto hic mirabilior vir qui per ferrum et ruinas et ignes inlaesus et indemnis evasit! Vides quanto facilius sit totam gentem quam unum virum vincere? Haec vox illi communis est cum Stoico: aeque et hic intacta bona per concrematas urbes fert; se enim ipse contentus est; hoc felicitatem suam fine designat. Ne existimes nos solos generosa verba iactare, et ipse Stilbonis obiurgator Epicurus similem illi vocem emisit, quam tu boni consule, etiam si hunc diem iam expunxi. «Si cui» inquit «sua non videntur amplissima, licet totius mundi dominus sit, tamen miser est». Vel si hoc modo tibi melius enuntiari videtur (id enim agendum est ut non verbis serviamus sed sensibus), «miser est qui se non beatissimum iudicat, licet imperet mundo». Ut scias autem hos sensus esse communes, natura scilicet dictante, apud poetam comicum invenies:
non est beatus, esse se qui non putat. Quid enim refert qualis status tuus sit, si tibi videtur malus? «Quid ergo?» inquis «si beatum se dixerit ille turpiter dives et ille multorum dominus sed plurium servus, beatus sua sententia fiet?» Non quid dicat sed quid sentiat refert, nec quid uno die sentiat, sed quid adsidue. Non est autem quod verearis ne ad indignum res tanta perveniat: nisi sapienti sua non placent; omnis stultitia laborat fastidio sui. Vale.
10. Sic est, non muto sententiam: fuge multitudinem, fuge paucitatem, fuge etiam unum. Non habeo cum quo te communicatum velim. Et vide quod iudicium meum habeas: audeo te tibi credere. Crates, ut aiunt, huius ipsius Stilbonis auditor, cuius mentionem priore epistula feci, cum vidisset adulescentulum secreto ambulantem, interrogavit quid illic solus faceret. «Mecum» inquit «loquor». Cui Crates «cave» inquit «rogo et diligenter adtende: cum homine malo loqueris». Lugentem timentemque custodire solemus, ne solitudine male utatur. Nemo est ex inprudentibus qui relinqui sibi debeat; tunc mala consilia agitant, tunc aut aliis aut ipsis futura pericula struunt, tunc cupiditates inprobas ordinant; tunc quidquid aut metu aut pudore celabat animus exponit, tunc audaciam acuit, libidinem inritat, iracundiam instigat. Denique quod unum solitudo habet commodum, nihil ulli committere, non timere indicem, perit stulto: ipse se prodit. Vide itaque quid de te sperem, immo quid spondeam mihi (spes enim incerti boni nomen est): non invenio cum quo te malim esse quam tecum. Repeto memoria quam magno animo quaedam verba proieceris, quanti roboris plena: gratulatus sum protinus mihi et dixi, «non a summis labris ista venerunt, habent hae voces fundamentum; iste homo non est unus e populo, ad salutem spectat». Sic loquere, sic vive; vide ne te ulla res deprimat. Votorum tuorum veterum licet deis gratiam facias, alia de integro suscipe: roga bonam mentem, bonam valetudinem animi, deinde tunc corporis. Quidni tu ista vota saepe facias? Audacter deum roga: nihil illum de alieno rogaturus es. Sed ut more meo cum aliquo munusculo epistulam mittam, verum est quod apud Athenodorum inveni: «tunc scito esse te omnibus cupiditatibus solutum, cum eo perveneris ut nihil deum roges nisi quod rogare possis palam». Nunc enim quanta dementia est hominum! turpissima vota dis insusurrant; si quis admoverit aurem, conticiscent, et quod scire hominem nolunt deo narrant. Vide ergo ne hoc praecipi salubriter possit: sic vive cum hominibus tamquam deus videat, sic loquere cum deo tamquam homines audiant. Vale. 11. Locutus est mecum amicus tuus bonae indolis, in quo quantum esset animi, quantum ingenii, quantum iam etiam profectus, sermo primus ostendit. Dedit
nobis gustum, ad quem respondebit; non enim ex praeparato locutus est, sed subito deprehensus. Ubi se colligebat, verecundiam, bonum in adulescente signum, vix potuit excutere; adeo illi ex alto suffusus est rubor. Hic illum, quantum suspicor, etiam cum se confirmaverit et omnibus vitiis exuerit, sapientem quoque sequetur. Nulla enim sapientia naturalia corporis aut animi vitia ponuntur: quidquid infixum et ingenitum est lenitur arte, non vincitur. Quibusdam etiam constantissimis in conspectu populi sudor erumpit non aliter quam fatigatis et aestuantibus solet, quibusdam tremunt genua dicturis, quorundam dentes colliduntur, lingua titubat, labra concurrunt: haec nec disciplina nec usus umquam excutit, sed natura vim suam exercet et illo vitio sui etiam robustissimos admonet. Inter haec esse et ruborem scio, qui gravissimis quoque viris subitus adfunditur. Magis quidem in iuvenibus apparet, quibus et plus caloris est et tenera frons; nihilominus et veteranos et senes tangit. Quidam numquam magis quam cum erubuerint timendi sunt, quasi omnem verecundiam effuderint; Sulla tunc erat violentissimus cum faciem eius sanguis invaserat. Nihil erat mollius ore Pompei; numquam non coram pluribus rubuit, utique in contionibus. Fabianum, cum in senatum testis esset inductus, erubuisse memini, et hic illum mire pudor decuit. Non accidit hoc ab infirmitate mentis sed a novitate rei, quae inexercitatos, etiam si non concutit, movet naturali in hoc facilitate corporis pronos; nam ut quidam boni sanguinis sunt, ita quidam incitati et mobilis et cito in os prodeuntis. Haec, ut dixi, nulla sapientia abigit: alioquin haberet rerum naturam sub imperio, si omnia eraderet vitia. Quaecumque adtribuit condicio nascendi et corporis temperatura, cum multum se diuque animus composuerit, haerebunt; nihil horum vetari potest, non magis quam accersi. Artifices scaenici, qui imitantur adfectus, qui metum et trepidationem exprimunt, qui tristitiam repraesentant, hoc indicio imitantur verecundiam. Deiciunt enim vultum, verba summittunt, figunt in terram oculos et deprimunt: ruborem sibi exprimere non possunt; nec prohibetur hic nec adducitur. Nihil adversus haec sapientia promittit, nihil proficit: sui iuris sunt, iniussa veniunt, iniussa discedunt. Iam clausulam epistula poscit. Accipe, et quidem utilem ac salutarem, quam te adfigere animo volo: «aliquis vir bonus nobis diligendus est ac semper ante oculos habendus, ut sic tamquam illo spectante vivamus et omnia tamquam illo vidente faciamus». Hoc, mi Lucili, Epicurus praecepit; custodem nobis et paedagogum dedit, nec inmerito: magna pars peccatorum tollitur, si peccaturis testis adsistit. Aliquem habeat animus quem vereatur, cuius auctoritate etiam secretum suum sanctius faciat. O felicem illum qui non praesens tantum sed etiam cogitatus emendat! O felicem qui sic aliquem vereri potest ut ad memoriam quoque eius se componat atque ordinet! Qui sic aliquem vereri potest cito erit verendus. Elige itaque Catonem; si hic tibi videtur nimis rigidus, elige remissioris animi virum Laelium. Elige eum cuius tibi placuit et vita et oratio et ipse animum ante se ferens vultus; illum tibi semper ostende vel custodem vel exemplum. Opus est, inquam, aliquo ad quem mores nostri se ipsi exigant: nisi ad regulam prava non corriges. Vale.
12. Quocumque me verti, argumenta senectutis meae video. Veneram in suburbanum meum et querebar de inpensis aedificii dilabentis. Ait vilicus mihi non esse neglegentiae suae vitium, omnia se facere, sed villam veterem esse. Haec villa inter manus meas crevit: quid mihi futurum est, si tam putria sunt aetatis meae saxa? Iratus illi proximam occasionem stomachandi arripio. «Apparet» inquam «has platanos neglegi: nullas habent frondes. Quam nodosi sunt et retorridi rami, quam tristes et squalidi trunci! Hoc non accideret si quis has circumfoderet, si inrigaret». Iurat per genium meum se omnia facere, in nulla re cessare curam suam, sed illas vetulas esse. Quod intra nos sit, ego illas posueram, ego illarum primum videram folium. Conversus ad ianuam «quis est iste?» inquam «iste decrepitus et merito ad ostium admotus? Foras enim spectat. Unde istunc nanctus es? Quid te delectavit alienum mortuum tollere?» At ille «non cognoscis me?» inquit: «ego sum Felicio, cui solebas sigillaria adferre; ego sum Philositi vilici filius, deliciolum tuum». «Perfecte» inquam «iste delirat: pupulus, etiam delicium meum factus est? Prorsus potest fieri: dentes illi cum maxime cadunt». Debeo hoc suburbano meo, quod mihi senectus mea quocumque adverteram apparuit. Conplectamur illam et amemus; plena est voluptatis, si illa scias uti. Gratissima sunt poma cum fugiunt; pueritiae maximus in exitu decor est; deditos vino potio extrema delectat, illa quae mergit, quae ebrietati summam manum inponit; quod in se iucundissimum omnis voluptas habet in finem sui differt. Iucundissima est aetas devexa iam, non tamen praeceps, et illam quoque in extrema tegula stantem iudico habere suas voluptates; aut hoc ipsum succedit in locum voluptatium, nullis egere. Quam dulce est cupiditates fatigasse ac reliquisse! «Molestum est» inquis «mortem ante oculos habere». Primum ista tam seni ante oculos debet esse quam iuveni (non enim citamur ex censu); deinde nemo tam senex est ut inprobe unum diem speret. Unus autem dies gradus vitae est. Tota aetas partibus constat et orbes habet circumductos maiores minoribus: est aliquis qui omnis conplectatur et cingat (hic pertinet a natali ad diem extremum); est alter qui annos adulescentiae excludit; est qui totam pueritiam ambitu suo adstringit; est deinde per se annus in se omnia continens tempora, quorum multiplicatione vita componitur; mensis artiore praecingitur circulo; angustissimum habet dies gyrum, sed et hic ab initio ad exitum venit, ab ortu ad occasum. Ideo Heraclitus, cui cognomen fecit orationis obscuritas, «unus» inquit «dies par omni est». Hoc alius aliter excepit. Dixit enim parem esse horis, nec mentitur; nam si dies est tempus viginti et quattuor horarum, necesse est omnes inter se dies pares esse, quia nox habet quod dies perdidit. Alius ait parem esse unum diem omnibus similitudine; nihil enim habet longissimi temporis spatium quod non et in uno die invenias, lucem et noctem, et in alternas mundi vices plura facit ista, non alia alias contractior, alias productior. Itaque sic ordinandus est dies omnis tamquam cogat agmen et consummet atque expleat vitam. Pacuvius, qui Syriam usu suam fecit, cum vino et illis funebribus epulis sibi parentaverat,
sic in cubiculum ferebatur a cena ut inter plausus exoletorum hoc ad symphoniam caneretur: bebivwtai, bebivwtai. Nullo non se die extulit. Hoc quod ille ex mala conscientia faciebat nos ex bona faciamus, et in somnum ituri laeti hilaresque dicamus, vixi et quem dederat cursum fortuna peregi. Crastinum si adiecerit deus, laeti recipiamus. Ille beatissimus est et securus sui possessor qui crastinum sine sollicitudine expectat; quisquis dixit «vixi» cotidie ad lucrum surgit. Sed iam debeo epistulam includere. «Sic» inquis «sine ullo ad me peculio veniet?» Noli timere: aliquid secum fert. Quare aliquid dixi? Multum. Quid enim hac voce praeclarius quam illi trado ad te perferendam? «Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est». Quidni nulla sit? Patent undique ad libertatem viae multae, breves faciles. Agamus deo gratias quod nemo in vita teneri potest: calcare ipsas necessitates licet. «Epicurus» inquis «dixit: quid tibi cum alieno?» Quod verum est meum est; perseverabo Epicurum tibi ingerere, ut isti qui in verba iurant nec quid dicatur aestimant, sed a quo, sciant quae optima sunt esse communia. Vale.
Liber secundus 13. Multum tibi esse animi scio; nam etiam antequam instrueres te praeceptis salutaribus et dura vincentibus, satis adversus fortunam placebas tibi, et multo magis postquam cum illa manum conseruisti viresque expertus es tuas, quae numquam certam dare fiduciam sui possunt nisi cum multae difficultates hinc et illinc apparuerunt, aliquando vero et propius accesserunt. Sic verus ille animus et in alienum non venturus arbitrium probatur; haec eius obrussa est. Non potest athleta magnos spiritus ad certamen adferre qui numquam suggillatus est: ille qui sanguinem suum vidit, cuius dentes crepuere sub pugno, ille qui subplantatus adversarium toto tulit corpore nec proiecit animum proiectus, qui quotiens cecidit contumacior resurrexit, cum magna spe descendit ad pugnam. Ergo, ut similitudinem istam prosequar, saepe iam fortuna supra te fuit, nec tamen tradidisti te, sed subsiluisti et acrior constitisti; multum enim adicit sibi virtus lacessita. Tamen, si tibi videtur, accipe a me auxilia quibus munire te possis. Plura sunt, Lucili, quae nos terrent quam quae premunt, et saepius opinione quam re laboramus. Non loquor tecum Stoica lingua, sed hac summissiore; nos enim dicimus omnia ista quae gemitus mugitusque exprimunt levia esse et contemnenda. Omittamus haec magna verba, sed, di boni, vera: illud tibi praecipio, ne sis miser ante tempus, cum illa quae velut inminentia expavisti fortasse nunquam ventura sint, certe non venerint. Quaedam ergo nos magis torquent quam debent, quaedam ante torquent quam debent, quaedam torquent cum omnino non debeant; aut augemus dolorem aut praecipimus aut fingimus. Primum illud, quia res in controversia est et litem contestatam habemus, in praesentia differatur. Quod ego leve dixero tu gravissimum esse contendes; scio alios inter flagella ridere, alios gemere sub colapho. Postea videbimus utrum ista suis viribus valeant an inbecillitate nostra. Illud praesta mihi, ut, quotiens circumsteterint qui tibi te miserum esse persuadeant, non quid audias sed quid sentias cogites, et cum patientia tua deliberes ac te ipse interroges, qui tua optime nosti, «Quid est quare isti me conplorent? Quid est quod trepident, quod contagium quoque mei timeant, quasi transilire calamitas possit? Est aliquid istic mali, an res ista magis infamis est quam mala?». Ipse te interroga, «numquid sine causa crucior et maereo et quod non est malum facio?» «Quomodo» inquis «intellegam, vana sint an vera quibus angor?». Accipe huius rei regulam: aut praesentibus torquemur aut futuris aut utrisque. De praesentibus facile iudicium est: si corpus tuum liberum et sanum est, nec ullus ex iniuria dolor est, videbimus quid futurum sit: hodie nihil negotii habet. «At enim futurum est». Primum dispice an certa argumenta sint venturi mali; plerumque enim suspicionibus laboramus, et inludit nobis illa quae conficere bellum solet fama, multo autem magis singulos conficit. Ita est, mi Lucili: cito accedimus opinioni; non coarguimus illa quae nos in metum adducunt nec excutimus, sed trepidamus et sic vertimus terga quemadmodum illi quos pulvis motus fuga pecorum exuit castris aut quos aliqua
fabula sine auctore sparsa conterruit. Nescio quomodo magis vana perturbant; vera enim modum suum habent: quidquid ex incerto venit coniecturae et paventis animi licentiae traditur. Nulli itaque tam perniciosi, tam inrevocabiles quam lymphatici metus sunt; ceteri enim sine ratione, hi sine mente sunt. Inquiramus itaque in rem diligenter. Verisimile est aliquid futurum mali: non statim verum est. Quam multa non expectata venerunt! quam multa expectata nusquam conparuerunt! Etiam si futurum est, quid iuvat dolori suo occurrere? Satis cito dolebis cum venerit: interim tibi meliora promitte. Quid facies lucri? Tempus. Multa intervenient quibus vicinum periculum vel prope admotum aut subsistat aut desinat aut in alienum caput transeat: incendium ad fugam patuit; quosdam molliter ruina deposuit; aliquando gladius ab ipsa cervice revocatus est; aliquis carnifici suo superstes fuit. Habet etiam mala fortuna levitatem. Fortasse erit, fortasse non erit: interim non est; meliora propone. Nonnumquam, nullis apparentibus signis quae mali aliquid praenuntient, animus sibi falsas imagines fingit: aut verbum aliquod dubiae significationis detorquet in peius aut maiorem sibi offensam proponit alicuius quam est, et cogitat non quam iratus ille sit, sed quantum liceat irato. Nulla autem causa vitae est, nullus miseriarum modus, si timetur quantum potest. Hic prudentia prosit, hic robore animi evidentem quoque metum respue; si minus, vitio vitium repelle, spe metum tempera. Nihil tam certum est ex his quae timentur ut non certius sit et formidata subsidere et sperata decipere. Ergo spem ac metum examina, et quotiens incerta erunt omnia, tibi fave: crede quod mavis. Si plures habebit sententias metus, nihilominus in hanc partem potius inclina et perturbare te desine ac subinde hoc in animo volve, maiorem partem mortalium, cum illi nec sit quicquam mali nec pro certo futurum sit, aestuare ac discurrere. Nemo enim resistit sibi, cum coepit inpelli, nec timorem suum redigit ad verum; nemo dicit «vanus auctor est, vanus: aut finxit aut credidit». Damus nos aurae ferendos; expavescimus dubia pro certis; non servamus modum rerum, statim in timorem venit scrupulus. Pudet me †ibi† sic tecum loqui et tam lenibus te remediis focilare. Alius dicat «fortasse non veniet»: tu dic «quid porro, si veniet? Videbimus uter vincat; fortasse pro me venit, et mors ista vitam honestabit». Cicuta magnum Socratem fecit. Catoni gladium adsertorem libertatis extorque: magnam partem detraxeris gloriae. Nimium diu te cohortor, cum tibi admonitione magis quam exhortatione opus sit. Non in diversum te a natura tua ducimus: natus es ad ista quae dicimus; eo magis bonum tuum auge et exorna. Sed iam finem epistulae faciam, si illi signum suum inpressero, id est aliquam magnificam vocem perferendam ad te mandavero. «Inter cetera mala hoc quoque habet stultitia: semper incipit vivere». Considera quid vox ista significet, Lucili virorum optime, et intelleges quam foeda sit hominum levitas cotidie nova vitae fundamenta ponentium, novas spes etiam in exitu inchoantium. Circumspice tecum singulos: occurrent tibi senes qui se cum maxime ad ambitionem, ad peregrinationes, ad negotiandum parent. Quid est autem turpius quam senex vivere incipiens? Non adicerem auctorem huic voci, nisi esset secretior nec inter
vulgata Epicuri dicta, quae mihi et laudare et adoptare permisi. Vale. 14. Fateor insitam esse nobis corporis nostri caritatem; fateor nos huius gerere tutelam. Non nego indulgendum illi, serviendum nego; multis enim serviet qui corpori servit, qui pro illo nimium timet, qui ad illud omnia refert. Sic gerere nos debemus, non tamquam propter corpus vivere debeamus, sed tamquam non possimus sine corpore; huius nos nimius amor timoribus inquietat, sollicitudinibus onerat, contumeliis obicit; honestum ei vile est cui corpus nimis carum est. Agatur eius diligentissime cura, ita tamen ut, cum exiget ratio, cum dignitas, cum fides, mittendum in ignes sit. Nihilominus quantum possumus evitemus incommoda quoque, non tantum pericula, et in tutum nos reducamus, excogitantes subinde quibus possint timenda depelli. Quorum tria, nisi fallor, genera sunt: timetur inopia, timentur morbi, timentur quae per vim potentioris eveniunt. Ex his omnibus nihil nos magis concutit quam quod ex aliena potentia inpendet; magno enim strepitu et tumultu venit. Naturalia mala quae rettuli, inopia atque morbus, silentio subeunt nec oculis nec auribus quicquam terroris incutiunt: ingens alterius mali pompa est; ferrum circa se et ignes habet et catenas et turbam ferarum quam in viscera inmittat humana. Cogita hoc loco carcerem et cruces et eculeos et uncum et adactum per medium hominem qui per os emergeret stipitem et distracta in diversum actis curribus membra, illam tunicam alimentis ignium et inlitam et textam, et quidquid aliud praeter haec commenta saevitia est. Non est itaque mirum, si maximus huius rei timor est cuius et varietas magna et apparatus terribilis est. Nam quemadmodum plus agit tortor quo plura instrumenta doloris exposuit (specie enim vincuntur qui patientiae restitissent), ita ex iis quae animos nostros subigunt et domant plus proficiunt quae habent quod ostendant. Illae pestes non minus graves sunt – famem dico et sitim et praecordiorum suppurationes et febrem viscera ipsa torrentem – sed latent, nihil habent quod intentent, quod praeferant: haec ut magna bella aspectu paratuque vicerunt. Demus itaque operam, abstineamus offensis. Interdum populus est quem timere debeamus; interdum, si ea civitatis disciplina est ut plurima per senatum transigantur, gratiosi in eo viri; interdum singuli quibus potestas populi et in populum data est. Hos omnes amicos habere operosum est, satis est inimicos non habere. Itaque sapiens numquam potentium iras provocabit, immo declinabit, non aliter quam in navigando procellam. Cum peteres Siciliam, traiecisti fretum. Temerarius gubernator contempsit austri minas (ille est enim qui Siculum pelagus exasperet et in vertices cogat); non sinistrum petit litus sed id a quo propior Charybdis maria convolvit. At ille cautior peritos locorum rogat quis aestus sit, quae signa dent nubes; longe ab illa regione verticibus infami cursum tenet. Idem facit sapiens: nocituram potentiam vitat, hoc primum cavens, ne vitare videatur; pars enim securitatis et in hoc est, non ex professo eam petere, quia quae quis fugit damnat. Circumspiciendum ergo nobis est quomodo a vulgo tuti esse possimus. Primum nihil idem concupiscamus: rixa est inter competitores. Deinde
nihil habeamus quod cum magno emolumento insidiantis eripi possit; quam minimum sit in corpore tuo spoliorum. Nemo ad humanum sanguinem propter ipsum venit, aut admodum pauci; plures conputant quam oderunt. Nudum latro transmittit; etiam in obsessa via pauperi pax est. Tria deinde ex praecepto veteri praestanda sunt ut vitentur: odium, invidia, contemptus. Quomodo hoc fiat sapientia sola monstrabit; difficile enim temperamentum est, verendumque ne in contemptum nos invidiae timor transferat, ne dum calcare nolumus videamur posse calcari. Multis timendi attulit causas timeri posse. Undique nos reducamus: non minus contemni quam suspici nocet. Ad philosophiam ergo confugiendum est; hae litterae, non dico apud bonos sed apud mediocriter malos infularum loco sunt. Nam forensis eloquentia et quaecumque alia populum movet adversarios habet: haec quieta et sui negotii contemni non potest, cui ab omnibus artibus etiam apud pessimos honor est. Numquam in tantum convalescet nequitia, numquam sic contra virtutes coniurabitur, ut non philosophiae nomen venerabile et sacrum maneat. Ceterum philosophia ipsa tranquille modesteque tractanda est. «Quid ergo?» inquis «videtur tibi M. Cato modeste philosophari, qui bellum civile sententia reprimit? Qui furentium principum armis medius intervenit? Qui aliis Pompeium offendentibus, aliis Caesarem, simul lacessit duos?». Potest aliquis disputare an illo tempore capessenda fuerit sapienti res publica. Quid tibi vis, Marce Cato? Iam non agitur de libertate: olim pessum data est. Quaeritur utrum Caesar an Pompeius possideat rem publicam: quid tibi cum ista contentione? Nullae partes tuae sunt. Dominus eligitur: quid tua, uter vincat? Potest melior vincere, non potest non peior esse qui vicerit. Ultimas partes attigi Catonis; sed ne priores quidem anni fuerunt qui sapientem in illam rapinam rei publicae admitterent. Quid aliud quam vociferatus est Cato et misit inritas voces, cum modo per populi levatus manus et obrutus sputis exportandus extra forum traheretur, modo e senatu in carcerem duceretur? Sed postea videbimus an sapienti opera rei publicae danda sit: interim ad hos te Stoicos voco qui a re publica exclusi secesserunt ad colendam vitam et humano generi iura condenda sine ulla potentioris offensa. Non conturbabit sapiens publicos mores nec populum in se vitae novitate convertet. «Quid ergo? Utique erit tutus qui hoc propositum sequetur?». Promittere tibi hoc non magis possum quam in homine temperanti bonam valetudinem, et tamen facit temperantia bonam valetudinem. Perit aliqua navis in portu: sed quid tu accidere in medio mari credis? Quanto huic periculum paratius foret multa agenti molientique, cui ne otium quidem tutum est? Pereunt aliquando innocentes (quis negat?), nocentes tamen saepius. Ars ei constat qui per ornamenta percussus est. Denique consilium rerum omnium sapiens, non exitum spectat; initia in potestate nostra sunt, de eventu fortuna iudicat, cui de me sententiam non do. «At aliquid vexationis adferet, aliquid adversi». Non damnat latro cum occidit. Nunc ad cotidianam stipem manum porrigis. Aurea te stipe implebo, et quia facta est auri mentio, accipe quemadmodum usus fructusque eius tibi esse gratior possit. «Is maxime divitiis fruitur qui minime divitiis indiget». «Ede» inquis
«auctorem». Ut scias quam benigni simus, propositum est aliena laudare: Epicuri est aut Metrodori aut alicuius ex illa officina. Et quid interest quis dixerit? Omnibus dixit. Qui eget divitiis timet pro illis; nemo autem sollicito bono fruitur. Adicere illis aliquid studet; dum de incremento cogitat, oblitus est usus. Rationes accipit, forum conterit, kalendarium versat: fit ex domino procurator. Vale. 15. Mos antiquis fuit, usque ad meam servatus aetatem, primis epistulae verbis adicere «si vales bene est, ego valeo». Recte nos dicimus «si philosopharis, bene est». Valere enim hoc demum est. Sine hoc aeger est animus; corpus quoque, etiam si magnas habet vires, non aliter quam furiosi aut frenetici validum est. Ergo hanc praecipue valetudinem cura, deinde et illam secundam; quae non magno tibi constabit, si volueris bene valere. Stulta est enim, mi Lucili, et minime conveniens litterato viro occupatio exercendi lacertos et dilatandi cervicem ac latera firmandi; cum tibi feliciter sagina cesserit et tori creverint, nec vires umquam opimi bovis nec pondus aequabis. Adice nunc quod maiore corporis sarcina animus eliditur et minus agilis est. Itaque quantum potes circumscribe corpus tuum et animo locum laxa. Multa sequuntur incommoda huic deditos curae: primum exercitationes, quarum labor spiritum exhaurit et inhabilem intentioni ac studiis acrioribus reddit; deinde copia ciborum subtilitas inpeditur. Accedunt pessimae notae mancipia in magisterium recepta, homines inter oleum et vinum occupati, quibus ad votum dies actus est si bene desudaverunt, si in locum eius quod effluxit multum potionis altius in ieiuno iturae regesserunt. Bibere et sudare vita cardiaci est. Sunt exercitationes et faciles et breves, quae corpus et sine mora lassent et tempori parcant, cuius praecipua ratio habenda est: cursus et cum aliquo pondere manus motae et saltus vel ille qui corpus in altum levat vel ille qui in longum mittit vel ille, ut ita dicam, saliaris aut, ut contumeliosius dicam, fullonius: quoslibet ex his elige †usum rude facile†. Quidquid facies, cito redi a corpore ad animum; illum noctibus ac diebus exerce. Labore modico alitur ille; hanc exercitationem non frigus, non aestus inpediet, ne senectus quidem. Id bonum cura quod vetustate fit melius. Neque ego te iubeo semper inminere libro aut pugillaribus: dandum est aliquod intervallum animo, ita tamen ut non resolvatur, sed remittatur. Gestatio et corpus concutit et studio non officit: possis legere, possis dictare, possis loqui, possis audire, quorum nihil ne ambulatio quidem vetat fieri. Nec tu intentionem vocis contempseris, quam veto te per gradus et certos modos extollere, deinde deprimere. Quid si velis deinde quemadmodum ambules discere? Admitte istos quos nova artificia docuit fames: erit qui gradus tuos temperet et buccas edentis observet et in tantum procedat in quantum audaciam eius patientia et credulitate produxeris. Quid ergo? A clamore protinus et a summa contentione vox tua incipiet? Usque eo naturale est paulatim incitari ut litigantes quoque a sermone incipiant, ad vociferationem transeant; nemo statim Quiritium fidem implorat. Ergo utcumque tibi impetus animi suaserit, modo vehementius fac vitiis convicium, modo lentius, prout vox te quoque
hortabitur †in id latus†; modesta, cum recipies illam revocarisque, descendat, non decidat; †mediatorisui habeat et hoc† indocto et rustico more desaeviat. Non enim id agimus ut exerceatur vox, sed ut exerceat. Detraxi tibi non pusillum negotii: una mercedula et †unum graecum† ad haec beneficia accedet. Ecce insigne praeceptum: «stulta vita ingrata est, trepida; tota in futurum fertur». «Quis hoc» inquis «dicit?» idem qui supra. Quam tu nunc vitam dici existimas stultam? Babae et Isionis? Non ita est: nostra dicitur, quos caeca cupiditas in nocitura, certe numquam satiatura praecipitat, quibus si quid satis esse posset, fuisset, qui non cogitamus quam iucundum sit nihil poscere, quam magnificum sit plenum esse nec ex fortuna pendere. Subinde itaque, Lucili, quam multa sis consecutus recordare; cum aspexeris quot te antecedant, cogita quot sequantur. Si vis gratus esse adversus deos et adversus vitam tuam, cogita quam multos antecesseris. Quid tibi cum ceteris? Te ipse antecessisti. Finem constitue quem transire ne possis quidem si velis; discedant aliquando ista insidiosa bona et sperantibus meliora quam adsecutis. Si quid in illis esset solidi, aliquando et implerent: nunc haurientium sitim concitant. Mittantur speciosi apparatus; et quod futuri temporis incerta sors volvit, quare potius a fortuna inpetrem ut det, quam a me ne petam? Quare autem petam? Oblitus fragilitatis humanae congeram? In quid laborem? Ecce hic dies ultimus est; ut non sit, prope ab ultimo est. Vale. 16. Liquere hoc tibi, Lucili, scio, neminem posse beate vivere, ne tolerabiliter quidem, sine sapientiae studio, et beatam vitam perfecta sapientia effici, ceterum tolerabilem etiam inchoata. Sed hoc quod liquet firmandum et altius cotidiana meditatione figendum est: plus operis est in eo ut proposita custodias quam ut honesta proponas. Perseverandum est et adsiduo studio robur addendum, donec bona mens sit quod bona voluntas est. Itaque non opus est tibi apud me pluribus verbis aut adfirmatione tam longa: intellego multum te profecisse. Quae scribis unde veniant scio; non sunt ficta nec colorata. Dicam tamen quid sentiam: iam de te spem habeo, nondum fiduciam. Tu quoque idem facias volo: non est quod tibi cito et facile credas. Excute te et varie scrutare et observa; illud ante omnia vide, utrum in philosophia an in ipsa vita profeceris. Non est philosophia populare artificium nec ostentationi paratum; non in verbis sed in rebus est. Nec in hoc adhibetur, ut cum aliqua oblectatione consumatur dies, ut dematur otio nausia: animum format et fabricat, vitam disponit, actiones regit, agenda et omittenda demonstrat, sedet ad gubernaculum et per ancipitia fluctuantium derigit cursum. Sine hac nemo intrepide potest vivere, nemo secure; innumerabilia accidunt singulis horis quae consilium exigant, quod ab hac petendum est. Dicet aliquis, «quid mihi prodest philosophia, si fatum est? Quid prodest, si deus rector est? Quid prodest, si casus imperat? Nam et mutari certa non possunt et nihil praeparari potest adversus incerta, sed aut consilium meum occupavit deus decrevitque quid facerem, aut consilio meo nihil fortuna permittit». Quidquid est ex his, Lucili, vel si omnia haec sunt,
philosophandum est; sive nos inexorabili lege fata constringunt, sive arbiter deus universi cuncta disposuit, sive casus res humanas sine ordine inpellit et iactat, philosophia nos tueri debet. Haec adhortabitur ut deo libenter pareamus, ut fortunae contumaciter; haec docebit ut deum sequaris, feras casum. Sed non est nunc in hanc disputationem transeundum, quid sit iuris nostri si providentia in imperio est, aut si fatorum series inligatos trahit, aut si repentina ac subita dominantur: illo nunc revertor, ut te moneam et exhorter ne patiaris impetum animi tui delabi et refrigescere. Contine illum et constitue, ut habitus animi fiat quod est impetus. Iam ab initio, si te bene novi, circumspicies quid haec epistula munusculi adtulerit: excute illam, et invenies. Non est quod mireris animum meum: adhuc de alieno liberalis sum. Quare autem alienum dixi? Quidquid bene dictum est ab ullo meum est. Istuc quoque ab Epicuro dictum est: «si ad naturam vives, numquam eris pauper; si ad opiniones, numquam eris dives». Exiguum natura desiderat, opinio immensum. Congeratur in te quidquid multi locupletes possederant; ultra privatum pecuniae modum fortuna te provehat, auro tegat, purpura vestiat, eo deliciarum opumque perducat ut terram marmoribus abscondas; non tantum habere tibi liceat sed calcare divitias; accedant statuae et picturae et quidquid ars ulla luxuriae elaboravit: maiora cupere ab his disces. Naturalia desideria finita sunt: ex falsa opinione nascentia ubi desinant non habent; nullus enim terminus falso est. Via eunti aliquid extremum est: error immensus est. Retrahe ergo te a vanis, et cum voles scire quod petes, utrum naturalem habeat an caecam cupiditatem, considera num possit alicubi consistere: si longe progresso semper aliquid longius restat, scito id naturale non esse. Vale. 17. Proice omnia ista, si sapis, immo ut sapias, et ad bonam mentem magno cursu ac totis viribus tende; si quid est quo teneris, aut expedi aut incide. «Moratur» inquis «me res familiaris; sic illam disponere volo ut sufficere nihil agenti possit, ne aut paupertas mihi oneri sit aut ego alicui». Cum hoc dicis, non videris vim ac potentiam eius de quo cogitas boni nosse; et summam quidem rei pervides, quantum philosophia prosit, partes autem nondum satis subtiliter dispicis, necdum scis quantum ubique nos adiuvet, quemadmodum et in maximis, ut Ciceronis utar verbo, «opituletur» et in minima descendat. Mihi crede, advoca illam in consilium: suadebit tibi ne ad calculos sedeas. Nempe hoc quaeris et hoc ista dilatione vis consequi, ne tibi paupertas timenda sit: quid si adpetenda est? Multis ad philosophandum obstitere divitiae: paupertas expedita est, secura est. Cum classicum cecinit, scit non se peti; cum aqua conclamata est, quomodo exeat, non quid efferat, quaerit; si navigandum est, non strepunt portus nec unius comitatu inquieta sunt litora; non circumstat illam turba servorum, ad quos pascendos transmarinarum regionum est optanda fertilitas. Facile est pascere paucos ventres et bene institutos et nihil aliud desiderantes quam impleri: parvo fames constat, magno fastidium. Paupertas contenta est desideriis instantibus satis
facere: quid est ergo quare hanc recuses contubernalem cuius mores sanus dives imitatur? Si vis vacare animo, aut pauper sis oportet aut pauperi similis. Non potest studium salutare fieri sine frugalitatis cura; frugalitas autem paupertas voluntaria est. Tolle itaque istas excusationes: «nondum habeo quantum sat est; si ad illam summam pervenero, tunc me totum philosophiae dabo». Atqui nihil prius quam hoc parandum est quod tu differs et post cetera paras; ab hoc incipiendum est. «Parare» inquis «unde vivam volo». Simul et parare te disce: si quid te vetat bene vivere, bene mori non vetat. Non est quod nos paupertas a philosophia revocet, ne egestas quidem. Toleranda est enim ad hoc properantibus vel fames; quam toleravere quidam in obsidionibus, et quod aliud erat illius patientiae praemium quam in arbitrium non cadere victoris? Quanto hoc maius est quod promittitur: perpetua libertas, nullius nec hominis nec dei timor. Ecquid vel esurienti ad ista veniendum est? Perpessi sunt exercitus inopiam omnium rerum, vixerunt herbarum radicibus et dictu foedis tulerunt famem; haec omnia passi sunt pro regno, quo magis mireris, alieno: dubitabit aliquis ferre paupertatem ut animum furoribus liberet? Non est ergo prius adquirendum: licet ad philosophiam etiam sine viatico pervenire. Ita est? Cum omnia habueris, tunc habere et sapientiam voles? Haec erit ultimum vitae instrumentum et, ut ita dicam, additamentum? Tu vero, sive aliquid habes, iam philosophare (unde enim scis an iam nimis habeas?), sive nihil, hoc prius quaere quam quicquam. «At necessaria deerunt». Primum deesse non poterunt, quia natura minimum petit, naturae autem se sapiens accommodat. Sed si necessitates ultimae inciderint, iamdudum exibit e vita et molestus sibi esse desinet. Si vero exiguum erit et angustum quo possit vita produci, id boni consulet nec ultra necessaria sollicitus aut anxius ventri et scapulis suum reddet et occupationes divitum concursationesque ad divitias euntium securus laetusque ridebit ac dicet, «quid in longum ipse te differs? Expectabisne fenoris quaestum aut ex merce conpendium aut tabulas beati senis, cum fieri possis statim dives? Repraesentat opes sapientia, quas cuicumque fecit supervacuas dedit». Haec ad alios pertinent: tu locupletibus propior es. Saeculum muta, nimis habes; idem est autem omni saeculo quod sat est. Poteram hoc loco epistulam claudere, nisi te male instituissem. Reges Parthos non potest quisquam salutare sine munere; tibi valedicere non licet gratis. Quid istic? Ab Epicuro mutuum sumam: «multis parasse divitias non finis miseriarum fuit sed mutatio». Nec hoc miror; non est enim in rebus vitium sed in ipso animo. Illud quod paupertatem nobis gravem fecerat et divitias graves fecit. Quemadmodum nihil refert utrum aegrum in ligneo lecto an in aureo conloces (quocumque illum transtuleris, morbum secum suum transferet), sic nihil refert utrum aeger animus in divitiis an in paupertate ponatur: malum illum suum sequitur. Vale. 18. December est mensis: cum maxime civitas sudat. Ius luxuriae publice datum est; ingenti apparatu sonant omnia, tamquam quicquam inter Saturnalia intersit et dies rerum agendarum; adeo nihil interest ut non videatur mihi errasse
qui dixit olim mensem Decembrem fuisse, nunc annum. Si te hic haberem, libenter tecum conferrem quid existimares esse faciendum, utrum nihil ex cotidiana consuetudine movendum an, ne dissidere videremur cum publicis moribus, et hilarius cenandum et exuendam togam. Nam quod fieri nisi in tumultu et tristi tempore civitatis non solebat, voluptatis causa ac festorum dierum vestem mutavimus. Si te bene novi, arbitri partibus functus nec per omnia nos similes esse pilleatae turbae voluisses nec per omnia dissimiles; nisi forte his maxime diebus animo imperandum est, ut tunc voluptatibus solus abstineat cum in illas omnis turba procubuit; certissimum enim argumentum firmitatis suae capit, si ad blanda et in luxuriam trahentia nec it nec abducitur. Hoc multo fortius est, ebrio ac vomitante populo siccum ac sobrium esse, illud temperantius, non excerpere se nec insignire nec misceri omnibus et eadem sed non eodem modo facere; licet enim sine luxuria agere festum diem. Ceterum adeo mihi placet temptare animi tui firmitatem ut ex praecepto magnorum virorum tibi quoque praecipiam: interponas aliquot dies quibus contentus minimo ac vilissimo cibo, dura atque horrida veste, dicas tibi «hoc est quod timebatur?». In ipsa securitate animus ad difficilia se praeparet et contra iniurias fortunae inter beneficia firmetur. Miles in media pace decurrit, sine ullo hoste vallum iacit, et supervacuo labore lassatur ut sufficere necessario possit; quem in ipsa re trepidare nolueris, ante rem exerceas. Hoc secuti sunt qui omnibus mensibus paupertatem imitati prope ad inopiam accesserunt, ne umquam expavescerent quod saepe didicissent. Non est nunc quod existimes me dicere Timoneas cenas et pauperum cellas et quidquid aliud est per quod luxuria divitiarum taedio ludit: grabattus ille verus sit et sagum et panis durus ac sordidus. Hoc triduo et quatriduo fer, interdum pluribus diebus, ut non lusus sit sed experimentum: tunc, mihi crede, Lucili, exultabis dipondio satur et intelleges ad securitatem non opus esse fortuna; hoc enim quod necessitati sat est dabit et irata. Non est tamen quare tu multum tibi facere videaris (facies enim quod multa milia servorum, multa milia pauperum faciunt): illo nomine te suspice, quod facies non coactus, quod tam facile erit tibi illud pati semper quam aliquando experiri. Exerceamur ad palum, et ne inparatos fortuna deprehendat, fiat nobis paupertas familiaris; securius divites erimus si scierimus quam non sit grave pauperes esse. Certos habebat dies ille magister voluptatis Epicurus quibus maligne famem extingueret, visurus an aliquid deesset ex plena et consummata voluptate, vel quantum deesset, et an dignum quod quis magno labore pensaret. Hoc certe in iis epistulis ait quas scripsit Charino magistratu ad Polyaenum; et quidem gloriatur non toto asse se pasci, Metrodorum, qui nondum tantum profecerit, toto. In hoc tu victu saturitatem putas esse? Et voluptas est; voluptas autem non illa levis et fugax et subinde reficienda, sed stabilis et certa. Non enim iucunda res est aqua et polenta aut frustum hordeacii panis, sed summa voluptas est posse capere etiam ex his voluptatem et ad id se deduxisse quod eripere nulla fortunae iniquitas possit. Liberaliora alimenta sunt carceris, sepositos ad capitale supplicium non tam anguste qui occisurus est pascit: quanta est animi magnitudo ad id sua sponte descendere
quod ne ad extrema quidem decretis timendum sit! hoc est praeoccupare tela fortunae. Incipe ergo, mi Lucili, sequi horum consuetudinem et aliquos dies destina quibus secedas a tuis rebus minimoque te facias familiarem; incipe cum paupertate habere commercium; aude, hospes, contemnere opes et te quoque dignum finge deo. Nemo alius est deo dignus quam qui opes contempsit; quarum possessionem tibi non interdico, sed efficere volo ut illas intrepide possideas; quod uno consequeris modo, si te etiam sine illis beate victurum persuaseris tibi, si illas tamquam exituras semper aspexeris. Sed iam incipiamus epistulam complicare. «Prius» inquis «redde quod debes». Delegabo te ad Epicurum, ab illo fiet numeratio: «inmodica ira gignit insaniam». Hoc quam verum sit necesse est scias, cum habueris et servum et inimicum. In omnes personas hic exardescit adfectus; tam ex amore nascitur quam ex odio, non minus inter seria quam inter lusus et iocos; nec interest ex quam magna causa nascatur sed in qualem perveniat animum. Sic ignis non refert quam magnus sed quo incidat; nam etiam maximum solida non receperunt, rursus arida et corripi facilia scintillam quoque fovent usque in incendium. Ita est, mi Lucili: ingentis irae exitus furor est, et ideo ira vitanda est non moderationis causa sed sanitatis. Vale. 19. Exulto quotiens epistulas tuas accipio; implent enim me bona spe, et iam non promittunt de te sed spondent. Ita fac, oro atque obsecro – quid enim habeo melius quod amicum rogem quam quod pro ipso rogaturus sum? Si potes, subduc te istis occupationibus; si minus, eripe. Satis multum temporis sparsimus: incipiamus vasa in senectute colligere. Numquid invidiosum est? In freto viximus, moriamur in portu. Neque ego suaserim tibi nomen ex otio petere, quod nec iactare debes nec abscondere; numquam enim usque eo te abigam generis humani furore damnato ut latebram tibi aliquam parari et oblivionem velim: id age ut otium tuum non emineat sed appareat. Deinde videbunt de isto quibus integra sunt et prima consilia an velint vitam per obscurum transmittere: tibi liberum non est. In medium te protulit ingenii vigor, scriptorum elegantia, clarae et nobiles amicitiae; iam notitia te invasit; ut in extrema mergaris ac penitus recondaris, tamen priora monstrabunt. Tenebras habere non potes; sequetur quocumque fugeris multum pristinae lucis: quietem potes vindicare sine ullius odio, sine desiderio aut morsu animi tui. Quid enim relinques quod invitus relictum a te possis cogitare? Clientes? Quorum nemo te ipsum sequitur, sed aliquid ex te; amicitia olim petebatur, nunc praeda; mutabunt testamenta destituti senes, migrabit ad aliud limen salutator. Non potest parvo res magna constare: aestima utrum te relinquere an aliquid ex tuis malis. Utinam quidem tibi
senescere contigisset intra natalium tuorum modum, nec te in altum fortuna misisset! Tulit te longe a conspectu vitae salubris rapida felicitas, provincia et procuratio et quidquid ab istis promittitur; maiora deinde officia te excipient et ex aliis alia: quis exitus erit? Quid expectas donec desinas habere quod cupias? Numquam erit tempus. Qualem dicimus seriem esse causarum ex quibus nectitur fatum, talem esse * * * cupiditatum: altera ex fine alterius nascitur. In eam demissus es vitam quae numquam tibi terminum miseriarum ac servitutis ipsa factura sit: subduc cervicem iugo tritam; semel illam incidi quam semper premi satius est. Si te ad privata rettuleris, minora erunt omnia, sed adfatim implebunt: at nunc plurima et undique ingesta non satiant. Utrum autem mavis ex inopia saturitatem an in copia famem? Et avida felicitas est et alienae aviditati exposita; quamdiu tibi satis nihil fuerit, ipse aliis non eris. «Quomodo» inquis «exibo?». Utcumque. Cogita quam multa temere pro pecunia, quam multa laboriose pro honore temptaveris: aliquid et pro otio audendum est, aut in ista sollicitudine procurationum et deinde urbanorum officiorum senescendum, in tumultu ac semper novis fluctibus quos effugere nulla modestia, nulla vitae quiete contingit. Quid enim ad rem pertinet an tu quiescere velis? Fortuna tua non vult. Quid si illi etiam nunc permiseris crescere? Quantum ad successus accesserit accedet ad metus. Volo tibi hoc loco referre dictum Maecenatis vera in ipso eculeo elocuti: «ipsa enim altitudo attonat summa». Si quaeris in quo libro dixerit, in eo qui Prometheus inscribitur. Hoc voluit dicere, attonita habet summa. Est ergo tanti ulla potentia ut sit tibi tam ebrius sermo? Ingeniosus ille vir fuit, magnum exemplum Romanae eloquentiae daturus nisi illum enervasset felicitas, immo castrasset. Hic te exitus manet nisi iam contrahes vela, nisi, quod ille sero voluit, terram leges. Poteram tecum hac Maecenatis sententia parem facere rationem, sed movebis mihi controversiam, si novi te, nec voles quod debeo nisi in aspero et probo accipere. Ut se res habet, ab Epicuro versura facienda est. «Ante» inquit «circumspiciendum est cum quibus edas et bibas quam quid edas et bibas; nam sine amico visceratio leonis ac lupi vita est». Hoc non continget tibi nisi secesseris: alioquin habebis convivas quos ex turba salutantium nomenclator digesserit; errat autem qui amicum in atrio quaerit, in convivio probat. Nullum habet maius malum occupatus homo et bonis suis obsessus quam quod amicos sibi putat quibus ipse non est, quod beneficia sua efficacia iudicat ad conciliandos animos, cum quidam quo plus debent magis oderint: leve aes alienum debitorem facit, grave inimicum. «Quid ergo? Beneficia non parant amicitias?» Parant, si accepturos licuit eligere, si conlocata, non sparsa sunt. Itaque dum incipis esse mentis tuae, interim hoc consilio sapientium utere, ut magis ad rem existimes pertinere quis quam quid acceperit. Vale. 20. Si vales et te dignum putas qui aliquando fias tuus, gaudeo; mea enim gloria erit, si te istinc ubi sine spe exeundi fluctuaris extraxero. Illud autem te, mi Lucili, rogo atque hortor, ut philosophiam in praecordia ima demittas et
experimentum profectus tui capias non oratione nec scripto, sed animi firmitate, cupiditatum deminutione: verba rebus proba. Aliud propositum est declamantibus et adsensionem coronae captantibus, aliud his qui iuvenum et otiosorum aures disputatione varia aut volubili detinent: facere docet philosophia, non dicere, et hoc exigit, ut ad legem suam quisque vivat, ne orationi vita dissentiat vel ipsa inter se vita; ut unus sit omnium actionum color. Maximum hoc est et officium sapientiae et indicium, ut verbis opera concordent, ut ipse ubique par sibi idemque sit. «Quis hoc praestabit?». Pauci, aliqui tamen. Est enim difficile; nec hoc dico, sapientem uno semper iturum gradu, sed una via. Observa te itaque, numquid vestis tua domusque dissentiant, numquid in te liberalis sis, in tuos sordidus, numquid cenes frugaliter, aedifices luxuriose; unam semel ad quam vivas regulam prende et ad hanc omnem vitam tuam exaequa. Quidam se domi contrahunt, dilatant foris et extendunt: vitium est haec diversitas et signum vacillantis animi ac nondum habentis tenorem suum. Etiamnunc dicam unde sit ista inconstantia et dissimilitudo rerum consiliorumque: nemo proponit sibi quid velit, nec si proposuit perseverat in eo, sed transilit; nec tantum mutat sed redit et in ea quae deseruit ac damnavit revolvitur. Itaque ut relinquam definitiones sapientiae veteres et totum conplectar humanae vitae modum, hoc possum contentus esse: quid est sapientia? Semper idem velle atque idem nolle. Licet illam exceptiunculam non adicias, ut rectum sit quod velis; non potest enim cuiquam idem semper placere nisi rectum. Nesciunt ergo homines quid velint nisi illo momento quo volunt; in totum nulli velle aut nolle decretum est; variatur cotidie iudicium et in contrarium vertitur ac plerisque agitur vita per lusum. Preme ergo quod coepisti, et fortasse perduceris aut ad summum aut eo quod summum nondum esse solus intellegas. «Quid fiet» inquis «huic turbae familiarium sine re familiari?». Turba ista cum a te pasci desierit, ipsa se pascet, aut quod tu beneficio tuo non potes scire, paupertatis scies: illa veros certosque amicos retinebit, discedet quisquis non te sed aliud sequebatur. Non est autem vel ob hoc unum amanda paupertas, quod a quibus ameris ostendet? O quando ille veniet dies quo nemo in honorem tuum mentiatur! Huc ergo cogitationes tuae tendant, hoc cura, hoc opta, omnia alia vota deo remissurus, ut contentus sis temet ipso et ex te nascentibus bonis. Quae potest esse felicitas propior? Redige te ad parva ex quibus cadere non possis, idque ut libentius facias, ad hoc pertinebit tributum huius epistulae, quod statim conferam. Invideas licet, etiam nunc libenter pro me dependet Epicurus. «Magnificentior, mihi crede, sermo tuus in grabatto videbitur et in panno; non enim dicentur tantum illa sed probabuntur». Ego certe aliter audio quae dicit Demetrius noster, cum illum vidi nudum, quanto minus quam stramentis incubantem: non praeceptor veri sed testis est. «Quid ergo? Non licet divitias in sinu positas contemnere?» Quidni liceat? Et ille ingentis animi est qui illas circumfusas sibi, multum diuque miratus quod ad se venerint, ridet suasque audit magis esse quam sentit. Multum est non corrumpi divitiarum contubernio; magnus ille qui in divitis pauper est. «Nescio» inquis «quomodo paupertatem iste laturus
sit, si in illam inciderit». Nec ego, Epicure, an †gulus† iste pauper contempturus sit divitias, si in illas inciderit; itaque in utroque mens aestimanda est inspiciendumque an ille paupertati indulgeat, an hic divitiis non indulgeat. Alioquin leve argumentum est bonae voluntatis grabattus aut pannus, nisi apparuit aliquem illa non necessitate pati sed malle. Ceterum magnae indolis est ad ista non properare tamquam meliora, sed praeparari tamquam ad facilia. Et sunt, Lucili, facilia; cum vero multum ante meditatus accesseris, iucunda quoque; inest enim illis, sine qua nihil est iucundum, securitas. Necessarium ergo iudico id quod tibi scripsi magnos viros saepe fecisse, aliquos dies interponere quibus nos imaginaria paupertate exerceamus ad veram; quod eo magis faciendum est quod deliciis permaduimus et omnia dura ac difficilia iudicamus. Potius excitandus e somno et vellicandus est animus admonendusque naturam nobis minimum constituisse. Nemo nascitur dives; quisquis exit in lucem iussus est lacte et panno esse contentus: ab his initiis nos regna non capiunt. Vale. 21. Cum istis tibi esse negotium iudicas de quibus scripseras? Maximum negotium tecum habes, tu tibi molestus es. Quid velis nescis, melius probas honesta quam sequeris, vides ubi sit posita felicitas sed ad illam pervenire non audes. Quid sit autem quod te inpediat, quia parum ipse dispicis, dicam: magna esse haec existimas quae relicturus es, et cum proposuisti tibi illam securitatem ad quam transiturus es, retinet te huius vitae a qua recessurus es fulgor tamquam in sordida et obscura casurum. Erras, Lucili: ex hac vita ad illam ascenditur. Quod interest inter splendorem et lucem, cum haec certam originem habeat ac suam, ille niteat alieno, hoc inter hanc vitam et illam: haec fulgore extrinsecus veniente percussa est, crassam illi statim umbram faciet quisquis obstiterit: illa suo lumine inlustris est. Studia te tua clarum et nobilem efficient. Exemplum Epicuri referam. Cum Idomeneo scriberet et illum a vita speciosa ad fidelem stabilemque gloriam revocaret, regiae tunc potentiae ministrum et magna tractantem, «si gloria» inquit «tangeris, notiorem te epistulae meae facient quam omnia ista quae colis et propter quae coleris». Numquid ergo mentitus est? Quis Idomenea nosset nisi Epicurus illum litteris suis incidisset? Omnes illos megistanas et satrapas et regem ipsum ex quo Idomenei titulus petebatur oblivio alta suppressit. Nomen Attici perire Ciceronis epistulae non sinunt. Nihil illi profuisset gener Agrippa et Tiberius progener et Drusus Caesar pronepos; inter tam magna nomina taceretur nisi sibi Cicero illum adplicuisset. Profunda super nos altitudo temporis veniet, pauca ingenia caput exerent et in idem quandoque silentium abitura oblivioni resistent ac se diu vindicabunt. Quod Epicurus amico suo potuit promittere, hoc tibi promitto, Lucili: habebo apud posteros gratiam, possum mecum duratura nomina educere. Vergilius noster duobus memoriam aeternam promisit et praestat: fortunati ambo! si quid mea carmina possunt, nulla dies umquam memori vos eximet aevo,
dum domus Aeneae Capitoli immobile saxum accolet imperiumque pater Romanus habebit. Quoscumque in medium fortuna protulit, quicumque membra ac partes alienae potentiae fuerant, horum gratia viguit, domus frequentata est, dum ipsi steterunt: post ipsos cito memoria defecit. Ingeniorum crescit dignatio nec ipsis tantum honor habetur, sed quidquid illorum memoriae adhaesit excipitur. Ne gratis Idomeneus in epistulam meam venerit, ipse eam de suo redimet. Ad hunc Epicurus illam nobilem sententiam scripsit qua hortatur ut Pythoclea locupletem non publica nec ancipiti via faciat. «Si vis» inquit «Pythoclea divitem facere, non pecuniae adiciendum sed cupiditati detrahendum est». Et apertior ista sententia est quam ut interpretanda sit, et disertior quam ut adiuvanda. Hoc unum te admoneo, ne istud tantum existimes de divitis dictum: quocumque transtuleris, idem poterit. Si vis Pythoclea honestum facere, non honoribus adiciendum est sed cupiditatibus detrahendum; si vis Pythoclea esse in perpetua voluptate, non voluptatibus adiciendum est sed cupiditatibus detrahendum; si vis Pythoclea senem facere et implere vitam, non annis adiciendum est sed cupiditatibus detrahendum. Has voces non est quod Epicuri esse iudices: publicae sunt. Quod fieri in senatu solet faciendum ego in philosophia quoque existimo: cum censuit aliquis quod ex parte mihi placeat, iubeo illum dividere sententiam et sequor quod probo. Eo libentius Epicuri egregia dicta commemoro, ut istis qui ad illum confugiunt spe mala inducti, qui velamentum ipsos vitiorum suorum habituros existimant, probent quocumque ierint honeste esse vivendum. Cum adieris eius hortulos †et inscriptum hortulis† HOSPES, HIC BENE MANEBIS, HIC SVMMVM BONVM VOLVPTAS EST, paratus erit istius domicilii custos hospitalis, humanus, et te polenta excipiet et aquam quoque large ministrabit et dicet, «ecquid bene acceptus es?» «Non inritant» inquit «hi hortuli famem sed extinguunt, nec maiorem ipsis potionibus sitim faciunt, sed naturali et gratuito remedio sedant; in hac voluptate consenui». De his tecum desideriis loquor quae consolationem non recipiunt, quibus dandum est aliquid ut desinant. Nam de illis extraordinariis quae licet differre, licet castigare et opprimere, hoc unum commonefaciam: ista voluptas naturalis est, non necessaria. Huic nihil debes; si quid inpendis, voluntarium est. Venter praecepta non audit: poscit, appellat. Non est tamen molestus creditor: parvo dimittitur, si modo das illi quod debes, non quod potes. Vale.
Liber tertius 22. Iam intellegis educendum esse te ex istis occupationibus speciosis et malis, sed quomodo id consequi possis quaeris. Quaedam non nisi a praesente monstrantur; non potest medicus per epistulas cibi aut balinei tempus eligere: vena tangenda est. Vetus proverbium est gladiatorem in harena capere consilium: aliquid adversarii vultus, aliquid manus mota, aliquid ipsa inclinatio corporis intuentem monet. Quid fieri soleat, quid oporteat, in universum et mandari potest et scribi; tale consilium non tantum absentibus, etiam posteris datur: illud alterum, quando fieri debeat aut quemadmodum, ex longinquo nemo suadebit, cum rebus ipsis deliberandum est. Non tantum praesentis sed vigilantis est occasionem observare properantem; itaque hanc circumspice, hanc si videris prende, et toto impetu, totis viribus, id age ut te istis officiis exuas. Et quidem quam sententiam feram adtende: censeo aut ex ista vita tibi aut e vita exeundum. Sed idem illud existimo, leni eundum via, ut quod male inplicuisti solvas potius quam abrumpas, dummodo, si alia solvendi ratio non erit, vel abrumpas. Nemo tam timidus est ut malit semper pendere quam semel cadere. Interim, quod primum est, inpedire te noli; contentus esto negotiis in quae descendisti, vel, quod videri mavis, incidisti. Non est quod ad ulteriora nitaris, aut perdes excusationem et apparebit te non incidisse. Ista enim quae dici solent falsa sunt: «non potui aliter. Quid si nollem? Necesse erat». Nulli necesse est felicitatem cursu sequi: est aliquid, etiam si non repugnare, subsistere nec instare fortunae ferenti. Numquid offenderis si in consilium non venio tantum sed advoco, et quidem prudentiores quam ipse sum, ad quos soleo deferre si quid delibero? Epicuri epistulam ad hanc rem pertinentem lege, Idomeneo quae inscribitur, quem rogat ut quantum potest fugiat et properet, antequam aliqua vis maior interveniat et auferat libertatem recedendi. Idem tamen subicit nihil esse temptandum nisi cum apte poterit tempestiveque temptari; sed cum illud tempus captatum diu venerit, exiliendum ait. Dormitare de fuga cogitantem vetat et sperat salutarem etiam ex difficillimis exitum, si nec properemus ante tempus nec cessemus in tempore. Puto, nunc et Stoicam sententiam quaeris. Non est quod quisquam illos apud te temeritatis infamet: cautiores quam fortiores sunt. Expectas forsitan ut tibi haec dicant: «turpe est cedere oneri; luctare cum officio quod semel recepisti. Non est vir fortis ac strenuus qui laborem fugit, nisi crescit illi animus ipsa rerum difficultate». Dicentur tibi ista, si operae pretium habebit perseverantia, si nihil indignum bono viro faciendum patiendumve erit; alioqui sordido se et contumelioso labore non conteret nec in negotiis erit negotii causa. Ne illud quidem quod existimas facturum eum faciet, ut ambitiosis rebus inplicitus semper aestus earum ferat; sed cum viderit gravia in quibus volutatur, incerta, ancipitia, referet pedem, non vertet terga, sed sensim recedet in tutum. Facile est autem, mi Lucili, occupationes evadere, si occupationum pretia contempseris; illa sunt quae nos morantur et detinent. «Quid ergo? Tam magnas spes relinquam? Ab ipsa
messe discedam? Nudum erit latus, incomitata lectica, atrium vacuum?». Ab his ergo inviti homines recedunt et mercedem miseriarum amant, ipsas execrantur. Sic de ambitione quomodo de amica queruntur, id est, si verum adfectum eorum inspicias, non oderunt sed litigant. Excute istos qui quae cupiere deplorant et de earum rerum loquuntur fuga quibus carere non possunt: videbis voluntariam esse illis in eo moram quod aegre ferre ipsos et misere loquuntur. Ita est, Lucili: paucos servitus, plures servitutem tenent. Sed si deponere illam in animo est et libertas bona fide placuit, in hoc autem unum advocationem petis, ut sine perpetua sollicitudine id tibi facere contingat, quidni tota te cohors Stoicorum probatura sit? Omnes Zenones et Chrysippi moderata, honesta, tua suadebunt. Sed si propter hoc tergiversaris, ut circumaspicias quantum feras tecum et quam magna pecunia instruas otium, numquam exitum invenies: nemo cum sarcinis enatat. Emerge ad meliorem vitam propitiis diis, sed non sic quomodo istis propitii sunt quibus bono ac benigno vultu mala magnifica tribuerunt, ob hoc unum excusati, quod ista quae urunt, quae excruciant, optantibus data sunt. Iam inprimebam epistulae signum: resolvenda est, ut cum sollemni ad te munusculo veniat et aliquam magnificam vocem ferat secum; et occurrit mihi ecce nescio utrum verior an eloquentior. «Cuius?» inquis. Epicuri; adhuc enim alienas †sarcinas adoro†: «nemo non ita exit e vita tamquam modo intraverit». Quemcumque vis occupa, adulescentem, senem, medium: invenies aeque timidum mortis, aeque inscium vitae. Nemo quicquam habet facti; in futurum enim nostra distulimus. Nihil me magis in ista voce delectat quam quod exprobratur senibus infantia. «Nemo» inquit «aliter quam quomodo natus est exit e vita». Falsum est: peiores morimur quam nascimur. Nostrum istud, non naturae vitium est. Illa nobiscum queri debet et dicere, «quid hoc est? Sine cupiditatibus vos genui, sine timoribus, sine superstitione, sine perfidia ceterisque pestibus: quales intrastis exite». Percepit sapientiam, si quis tam securus moritur quam nascitur; nunc vero trepidamus cum periculum accessit, non animus nobis, non color constat, lacrimae nihil profuturae cadunt. Quid est turpius quam in ipso limine securitatis esse sollicitum? Causa autem haec est, quod inanes omnium bonorum sumus, vitae iactura laboramus. Non enim apud nos pars eius ulla subsedit: transmissa est et effluxit. Nemo quam bene vivat sed quam diu curat, cum omnibus possit contingere ut bene vivant, ut diu nulli. Vale. 23. Putas me tibi scripturum quam humane nobiscum hiemps egerit, quae et remissa fuit et brevis, quam malignum ver sit, quam praeposterum frigus, et alias ineptias verba quaerentium? Ego vero aliquid quod et mihi et tibi prodesse possit scribam. Quid autem id erit nisi ut te exhorter ad bonam mentem? Huius fundamentum quod sit quaeris? Ne gaudeas vanis. Fundamentum hoc esse dixi: culmen est. Ad summa pervenit qui scit quo gaudeat, qui felicitatem suam in aliena potestate non posuit; sollicitus est et incertus sui quem spes aliqua proritat, licet ad manum sit, licet non ex difficili petatur, licet numquam illum sperata deceperint. Hoc ante omnia fac, mi Lucili: disce gaudere. Existimas nunc me
detrahere tibi multas voluptates qui fortuita summoveo, qui spes, dulcissima oblectamenta, devitandas existimo? Immo contra nolo tibi umquam deesse laetitiam. Volo illam tibi domi nasci: nascitur si modo intra te ipsum fit. Ceterae hilaritates non implent pectus; frontem remittunt, leves sunt, nisi forte tu iudicas eum gaudere qui ridet: animus esse debet alacer et fidens et supra omnia erectus. Mihi crede, verum gaudium res severa est. An tu existimas quemquam soluto vultu et, ut isti delicati loquuntur, hilariculo mortem contemnere, paupertati domum aperire, voluptates tenere sub freno, meditari dolorum patientiam? Haec qui apud se versat in magno gaudio est, sed parum blando. In huius gaudii possessione esse te volo: numquam deficiet, cum semel unde petatur inveneris. Levium metallorum fructus in summo est: illa opulentissima sunt quorum in alto latet vena adsidue plenius responsura fodienti. Haec quibus delectatur vulgus tenuem habent ac perfusoriam voluptatem, et quodcumque invecticium gaudium est fundamento caret: hoc de quo loquor, ad quod te conor perducere, solidum est et quod plus pateat introrsus. Fac, oro te, Lucili carissime, quod unum potest praestare felicem: dissice et conculca ista quae extrinsecus splendent, quae tibi promittuntur ab alio vel ex alio; ad verum bonum specta et de tuo gaude. Quid est autem hoc «de tuo»? Te ipso et tui optima parte. Corpusculum quoque, etiam si nihil fieri sine illo potest, magis necessariam rem crede quam magnam; vanas suggerit voluptates, breves, paenitendas ac, nisi magna moderatione temperentur, in contrarium abituras. Ita dico: in praecipiti voluptas stat, ad dolorem vergit nisi modum tenuit; modum autem tenere in eo difficile est quod bonum esse credideris: veri boni aviditas tuta est. Quod sit istud interrogas, aut unde subeat? Dicam: ex bona conscientia, ex honestis consiliis, ex rectis actionibus, ex contemptu fortuitorum, ex placido vitae et continuo tenore unam prementis viam. Nam illi qui ex aliis propositis in alia transiliunt aut ne transiliunt quidem sed casu quodam transmittuntur, quomodo habere quicquam certum mansurumve possunt suspensi et vagi? Pauci sunt qui consilio se suaque disponant: ceteri, eorum more quae fluminibus innatant, non eunt sed feruntur; ex quibus alia lenior unda detinuit ac mollius vexit, alia vehementior rapuit, alia proxima ripae cursu languescente deposuit, alia torrens impetus in mare eiecit. Ideo constituendum est quid velimus et in eo perseverandum. Hic est locus solvendi aeris alieni. Possum enim tibi vocem Epicuri tui reddere et hanc epistulam liberare: «molestum est semper vitam inchoare»; aut si hoc modo magis sensus potest exprimi, «male vivunt qui semper vivere incipiunt». «Quare?» inquis; desiderat enim explanationem ista vox. Quia semper illis inperfecta vita est; non potest autem stare paratus ad mortem qui modo incipit vivere. Id agendum est ut satis vixerimus: nemo hoc praestat qui orditur cum maxime vitam. Non est quod existimes paucos esse hos: propemodum omnes sunt. Quidam vero tunc incipiunt cum desinendum est. Si hoc iudicas mirum, adiciam quod magis admireris: quidam ante vivere desierunt quam inciperent. Vale.
24. Sollicitum esse te scribis de iudici eventu quod tibi furor inimici denuntiat; existimas me suasurum ut meliora tibi ipse proponas et adquiescas spei blandae. Quid enim necesse est mala accersere, satis cito patienda cum venerint praesumere, ac praesens tempus futuri metu perdere? Est sine dubio stultum, quia quandoque sis futurus miser, esse iam miserum. Sed ego alia te ad securitatem via ducam: si vis omnem sollicitudinem exuere, quidquid vereris ne eveniat eventurum utique propone, et quodcumque est illud malum, tecum ipse metire ac timorem tuum taxa: intelleges profecto aut non magnum aut non longum esse quod metuis. Nec diu exempla quibus confirmeris colligenda sunt: omnis illa aetas tulit. In quamcumque partem rerum vel civilium vel externarum memoriam miseris, occurrent tibi ingenia aut profectus aut impetus magni. Numquid accidere tibi, si damnaris, potest durius quam ut mittaris in exilium, ut ducaris in carcerem? Numquid ultra quicquam ulli timendum est quam ut uratur, quam ut pereat? Singula ista constitue et contemptores eorum cita, qui non quaerendi sed eligendi sunt. Damnationem suam Rutilius sic tulit tamquam nihil illi molestum aliud esset quam quod male iudicaretur. Exilium Metellus fortiter tulit, Rutilius etiam libenter; alter ut rediret rei publicae praestitit, alter reditum suum Sullae negavit, cui nihil tunc negabatur. In carcere Socrates disputavit et exire, cum essent qui promitterent fugam, noluit remansitque, ut duarum rerum gravissimarum hominibus metum demeret, mortis et carceris. Mucius ignibus manum inposuit. Acerbum est uri: quanto acerbius si id te faciente patiaris! Vides hominem non eruditum nec ullis praeceptis contra mortem aut dolorem subornatum, militari tantum robore instructum, poenas a se inriti conatus exigentem; spectator destillantis in hostili foculo dexterae stetit nec ante removit nudis ossibus fluentem manum quam ignis illi ab hoste subductus est. Facere aliquid in illis castris felicius potuit, nihil fortius. Vide quanto acrior sit ad occupanda pericula virtus quam crudelitas ad inroganda: facilius Porsina Mucio ignovit quod voluerat occidere quam sibi Mucius quod non occiderat. «Decantatae» inquis «in omnibus scholis fabulae istae sunt; iam mihi, cum ad contemnendam mortem ventum fuerit, Catonem narrabis». Quidni ego narrem ultima illa nocte Platonis librum legentem posito ad caput gladio? Duo haec in rebus extremis instrumenta prospexerat, alterum ut vellet mori, alterum ut posset. Compositis ergo rebus, utcumque componi fractae atque ultimae poterant, id agendum existimavit ne cui Catonem aut occidere liceret aut servare contingeret; et stricto gladio quem usque in illum diem ab omni caede purum servaverat, «nihil» inquit «egisti, fortuna, omnibus conatibus meis obstando. Non pro mea adhuc sed pro patriae libertate pugnavi, nec agebam tanta pertinacia ut liber, sed ut inter liberos, viverem: nunc quoniam deploratae sunt res generis humani, Cato deducatur in tutum». Inpressit deinde mortiferum corpori vulnus; quo obligato a medicis cum minus sanguinis haberet, minus virium, animi idem, iam non tantum Caesari sed sibi iratus nudas in vulnus manus egit et generosum illum contemptoremque omnis potentiae spiritum non emisit sed eiecit. Non in hoc exempla nunc congero ut ingenium exerceam, sed ut te adversus id
quod maxime terribile videtur exhorter; facilius autem exhortabor, si ostendero non fortes tantum viros hoc momentum efflandae animae contempsisse sed quosdam ad alia ignavos in hac re aequasse animum fortissimorum, sicut illum Cn. Pompei socerum Scipionem, qui contrario in Africam vento relatus cum teneri navem suam vidisset ab hostibus, ferro se transverberavit et quaerentibus ubi imperator esset, «imperator» inquit «se bene habet». Vox haec illum parem maioribus fecit et fatalem Scipionibus in Africa gloriam non est interrumpi passa. Multum fuit Carthaginem vincere, sed amplius mortem. «Imperator» inquit «se bene habet»: an aliter debebat imperator, et quidem Catonis, mori? Non revoco te ad historias nec ex omnibus saeculis contemptores mortis, qui sunt plurimi, colligo; respice ad haec nostra tempora, de quorum languore ac delicis querimur: omnis ordinis homines suggerent, omnis fortunae, omnis aetatis, qui mala sua morte praeciderint. Mihi crede, Lucili, adeo mors timenda non est ut beneficio eius nihil timendum sit. Securus itaque inimici minas audi; et quamvis conscientia tibi tua fiduciam faciat, tamen, quia multa extra causam valent, et quod aequissimum est spera et ad id te quod est iniquissimum compara. Illud autem ante omnia memento, demere rebus tumultum ac videre quid in quaque re sit: scies nihil esse in istis terribile nisi ipsum timorem. Quod vides accidere pueris, hoc nobis quoque maiusculis pueris evenit: illi quos amant, quibus adsueverunt, cum quibus ludunt, si personatos vident, expavescunt: non hominibus tantum sed rebus persona demenda est et reddenda facies sua. Quid mihi gladios et ignes ostendis et turbam carnificum circa te frementem? Tolle istam pompam sub qua lates et stultos territas: mors es, quam nuper servus meus, quam ancilla contempsit. Quid tu rursus mihi flagella et eculeos magno apparatu explicas? Quid singulis articulis singula machinamenta quibus extorqueantur aptata et mille alia instrumenta excarnificandi particulatim hominis? Pone ista quae nos obstupefaciunt; iube conticiscere gemitus et exclamationes et vocum inter lacerationem elisarum acerbitatem: nempe dolor es, quem podagricus ille contemnit, quem stomachicus ille in ipsis delicis perfert, quem in puerperio puella perpetitur. Levis es si ferre possum; brevis es si ferre non possum. Haec in animo voluta, quae saepe audisti, saepe dixisti; sed an vere audieris, an vere dixeris, effectu proba; hoc enim turpissimum est quod nobis obici solet, verba nos philosophiae, non opera tractare. Quid? Tu nunc primum tibi mortem inminere scisti, nunc exilium, nunc dolorem? In haec natus es; quidquid fieri potest quasi futurum cogitemus. Quod facere te moneo scio certe fecisse: nunc admoneo ut animum tuum non mergas in istam sollicitudinem; hebetabitur enim et minus habebit vigoris cum exsurgendum erit. Abduc illum a privata causa ad publicam; dic mortale tibi et fragile corpusculum esse, cui non ex iniuria tantum aut ex potentioribus viribus denuntiabitur dolor: ipsae voluptates in tormenta vertuntur, epulae cruditatem adferunt, ebrietates nervorum torporem tremoremque, libidines pedum, manuum, articulorum omnium depravationes. Pauper fiam: inter plures ero. Exul fiam: ibi me natum putabo quo mittar. Alligabor: quid enim? Nunc solutus sum? Ad hoc me natura grave corporis mei
pondus adstrinxit. Moriar: hoc dicis, desinam aegrotare posse, desinam alligari posse, desinam mori posse. Non sum tam ineptus ut Epicuream cantilenam hoc loco persequar et dicam vanos esse inferorum metus, nec Ixionem rota volvi nec saxum umeris Sisyphi trudi in adversum nec ullius viscera et renasci posse cotidie et carpi: nemo tam puer est ut Cerberum timeat et tenebras et larvalem habitum nudis ossibus cohaerentium. Mors nos aut consumit aut exuit; emissis meliora restant onere detracto, consumptis nihil restat, bona pariter malaque summota sunt. Permitte mihi hoc loco referre versum tuum, si prius admonuero ut te iudices non aliis scripsisse ista sed etiam tibi. Turpe est aliud loqui, aliud sentire: quanto turpius aliud scribere, aliud sentire! Memini te illum locum aliquando tractasse, non repente nos in mortem incidere sed minutatim procedere. Cotidie morimur; cotidie enim demitur aliqua pars vitae, et tunc quoque cum crescimus vita decrescit. Infantiam amisimus, deinde pueritiam, deinde adulescentiam. Usque ad hesternum quidquid transit temporis perit; hunc ipsum quem agimus diem cum morte dividimus. Quemadmodum clepsydram non extremum stilicidium exhaurit sed quidquid ante defluxit, sic ultima hora qua esse desinimus non sola mortem facit sed sola consummat; tunc ad illam pervenimus, sed diu venimus. Haec cum descripsisses quo soles ore, semper quidem magnus, numquam tamen acrior quam ubi veritati commodas verba, dixisti, mors non una venit, sed quae rapit ultima mors est. Malo te legas quam epistulam meam; apparebit enim tibi hanc quam timemus mortem extremam esse, non solam. Video quo spectes: quaeris quid huic epistulae infulserim, quod dictum alicuius animosum, quod praeceptum utile. Ex hac ipsa materia quae in manibus fuit mittetur aliquid. Obiurgat Epicurus non minus eos qui mortem concupiscunt quam eos qui timent, et ait: «ridiculum est currere ad mortem taedio vitae, cum genere vitae ut currendum ad mortem esset effeceris». Item alio loco dicit: «quid tam ridiculum quam adpetere mortem, cum vitam inquietam tibi feceris metu mortis?». His adicias et illud eiusdem notae licet, tantam hominum inprudentiam esse, immo dementiam, ut quidam timore mortis cogantur ad mortem. Quidquid horum tractaveris, confirmabis animum vel ad mortis vel ad vitae patientiam; in utrumque enim monendi ac firmandi sumus, et ne nimis amemus vitam et ne nimis oderimus. Etiam cum ratio suadet finire se, non temere nec cum procursu capiendus est impetus. Vir fortis ac sapiens non fugere debet e vita sed exire; et ante omnia ille quoque vitetur adfectus qui multos occupavit, libido moriendi. Est enim, mi Lucili, ut ad alia, sic etiam ad moriendum inconsulta animi inclinatio, quae saepe generosos atque acerrimae indolis viros corripit, saepe ignavos iacentesque: illi contemnunt vitam, hi gravantur. Quosdam subit eadem faciendi videndique satietas et vitae non odium sed fastidium, in quod prolabimur ipsa inpellente philosophia, dum dicimus «quousque eadem? Nempe expergiscar
dormiam, edam esuriam, algebo aestuabo. Nullius rei finis est, sed in orbem nexa sunt omnia, fugiunt ac sequuntur; diem nox premit, dies noctem, aestas in autumnum desinit, autumno hiemps instat, quae vere conpescitur; omnia sic transeunt ut revertantur. Nihil novi facio, nihil novi video: fit aliquando et huius rei nausia». Multi sunt qui non acerbum iudicent vivere sed supervacuum. Vale. 25. Quod ad duos amicos nostros pertinet, diversa via eundum est; alterius enim vitia emendanda, alterius frangenda sunt. Utar libertate tota: non amo illum nisi offendo. «Quid ergo?» inquis «quadragenarium pupillum cogitas sub tutela tua continere? Respice aetatem eius iam duram et intractabilem: non potest reformari; tenera finguntur». An profecturus sim nescio: malo successum mihi quam fidem deesse. Nec desperaveris etiam diutinos aegros posse sanari, si contra intemperantiam steteris, si multa invitos et facere coegeris et pati. Ne de altero quidem satis fiduciae habeo, excepto eo quod adhuc peccare erubescit; nutriendus est hic pudor, qui quamdiu in animo eius duraverit, aliquis erit bonae spei locus. Cum hoc veterano parcius agendum puto, ne in desperationem sui veniat; nec ullum tempus adgrediendi fuit melius quam hoc, dum interquiescit, dum emendato similis est. Aliis haec intermissio eius inposuit, mihi verba non dat: expecto cum magno fenore vitia reditura, quae nunc scio cessare, non deesse. Inpendam huic rei dies et utrum possit aliquid agi an non possit experiar. Tu nobis te, ut facis, fortem praesta et sarcinas contrahe; nihil ex his quae habemus necessarium est. Ad legem naturae revertamur; divitiae paratae sunt. Aut gratuitum est quo egemus, aut vile: panem et aquam natura desiderat. Nemo ad haec pauper est, intra quae quisquis desiderium suum clusit cum ipso Iove de felicitate contendat, ut ait Epicurus, cuius aliquam vocem huic epistulae involvam. «Sic fac» inquit «omnia tamquam spectet Epicurus». Prodest sine dubio custodem sibi inposuisse et habere quem respicias, quem interesse cogitationibus tuis iudices. Hoc quidem longe magnificentius est, sic vivere tamquam sub alicuius boni viri ac semper praesentis oculis, sed ego etiam hoc contentus sum, ut sic facias quaecumque facies tamquam spectet aliquis: omnia nobis mala solitudo persuadet. Cum iam profeceris tantum ut sit tibi etiam tui reverentia, licebit dimittas paedagogum: interim aliquorum te auctoritate custodi – aut Cato ille sit aut Scipio aut Laelius aut alius cuius interventu perditi quoque homines vitia supprimerent, dum te efficis eum cum quo peccare non audeas. Cum hoc effeceris et aliqua coeperit apud te tui esse dignatio, incipiam tibi permittere quod idem suadet Epicurus: «tunc praecipue in te ipse secede cum esse cogeris in turba». Dissimilem te fieri multis oportet, dum tibi tutum sit ad te recedere. Circumspice singulos: nemo est cui non satius sit cum quolibet esse quam secum. «Tunc praecipue in te ipse secede cum esse cogeris in turba» – si bonus vir es, si quietus, si temperans. Alioquin in turbam tibi a te recedendum est: istic malo viro propius es. Vale. 26. Modo dicebam tibi in conspectu esse me senectutis: iam vereor ne
senectutem post me reliquerim. Aliud iam his annis, certe huic corpori, vocabulum convenit, quoniam quidem senectus lassae aetatis, non fractae nomen est: inter decrepitos me numera et extrema tangentis. Gratias tamen mihi apud te ago: non sentio in animo aetatis iniuriam, cum sentiam in corpore. Tantum vitia et vitiorum ministeria senuerunt: viget animus et gaudet non multum sibi esse cum corpore; magnam partem oneris sui posuit. Exultat et mihi facit controversiam de senectute: hunc ait esse florem suum. Credamus illi: bono suo utatur. Ire in cogitationem iubet et dispicere quid ex hac tranquillitate ac modestia morum sapientiae debeam, quid aetati, et diligenter excutere quae non possim facere, quae nolim, proinde habiturus atque si nolim quidquid non posse me gaudeo: quae enim querela est, quod incommodum, si quidquid debebat desinere defecit? «Incommodum summum est» inquis «minui et deperire et, ut proprie dicam, liquescere. Non enim subito inpulsi ac prostrati sumus: carpimur, singuli dies aliquid subtrahunt viribus». Ecquis exitus est melior quam in finem suum natura solvente dilabi? Non quia aliquid mali ictus est et e vita repentinus excessus, sed quia lenis haec est via, subduci. Ego certe, velut adpropinquet experimentum et ille laturus sententiam de omnibus annis meis dies venerit, ita me observo et adloquor: «nihil est» inquam «adhuc quod aut rebus aut verbis exhibuimus; levia sunt ista et fallacia pignora animi multisque involuta lenociniis: quid profecerim morti crediturus sum. Non timide itaque componor ad illum diem quo remotis strophis ac fucis de me iudicaturus sum, utrum loquar fortia an sentiam, numquid simulatio fuerit et mimus quidquid contra fortunam iactavi verborum contumacium. Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur. Remove studia tota vita tractata: mors de te pronuntiatura est. Ita dico: disputationes et litterata colloquia et ex praeceptis sapientium verba collecta et eruditus sermo non ostendunt verum robur animi; est enim oratio etiam timidissimis audax. Quid egeris tunc apparebit cum animam ages. Accipio condicionem, non reformido iudicium». Haec mecum loquor, sed tecum quoque me locutum puta. Iuvenior es: quid refert? Non dinumerantur anni. Incertum est quo loco te mors expectet; itaque tu illam omni loco expecta. Desinere iam volebam et manus spectabat ad clausulam, sed conficienda sunt aera et huic epistulae viaticum dandum est. Puta me non dicere unde sumpturus sim mutuum: scis cuius arca utar. Expecta me pusillum, et de domo fiet numeratio; interim commodabit Epicurus, qui ait «meditare mortem», vel si commodius sic transire ad nos hic potest sensus: «egregia res est mortem condiscere». Supervacuum forsitan putas id discere quod semel utendum est. Hoc est ipsum quare meditari debeamus: semper discendum est quod an sciamus experiri non possumus. «Meditare mortem»: qui hoc dicit meditari libertatem iubet. Qui mori didicit servire dedidicit; supra omnem potentiam est, certe extra omnem. Quid ad illum carcer et custodia et claustra? Liberum ostium habet. Una est catena quae nos alligatos tenet, amor vitae, qui ut non est abiciendus, ita minuendus est, ut si quando res exiget, nihil nos detineat nec inpediat quominus parati simus quod quandoque faciendum est statim facere. Vale.
27. «Tu me» inquis «mones? Iam enim te ipse monuisti, iam correxisti? Ideo aliorum emendationi vacas?» Non sum tam inprobus ut curationes aeger obeam, sed, tamquam in eodem valetudinario iaceam, de communi tecum malo conloquor et remedia communico. Sic itaque me audi tamquam mecum loquar; in secretum te meum admitto et te adhibito mecum exigo. Clamo mihi ipse, «numera annos tuos, et pudebit eadem velle quae volueras puer, eadem parare. Hoc denique tibi circa mortis diem praesta: moriantur ante te vitia. Dimitte istas voluptates turbidas, magno luendas: non venturae tantum sed praeteritae nocent. Quemadmodum scelera etiam si non sunt deprehensa cum fierent, sollicitudo non cum ipsis abit, ita inprobarum voluptatum etiam post ipsas paenitentia est. Non sunt solidae, non sunt fideles; etiam si non nocent, fugiunt. Aliquod potius bonum mansurum circumspice; nullum autem est nisi quod animus ex se sibi invenit. Sola virtus praestat gaudium perpetuum, securum; etiam si quid obstat, nubium modo intervenit, quae infra feruntur nec umquam diem vincunt». Quando ad hoc gaudium pervenire continget? Non quidem cessatur adhuc, sed festinetur. Multum restat operis, in quod ipse necesse est vigiliam, ipse laborem tuum inpendas, si effici cupis; delegationem res ista non recipit. Aliud litterarum genus adiutorium admittit. Calvisius Sabinus memoria nostra fuit dives; et patrimonium habebat libertini et ingenium; numquam vidi hominem beatum indecentius. Huic memoria tam mala erat ut illi nomen modo Ulixis excideret, modo Achillis, modo Priami, quos tam bene noverat quam paedagogos nostros novimus. Nemo vetulus nomenclator, qui nomina non reddit sed inponit, tam perperam tribus quam ille Troianos et Achivos persalutabat. Nihilominus eruditus volebat videri. Hanc itaque compendiariam excogitavit: magna summa emit servos, unum qui Homerum teneret, alterum qui Hesiodum; novem praeterea lyricis singulos adsignavit. Magno emisse illum non est quod mireris: non invenerat, faciendos locavit. Postquam haec familia illi comparata est, coepit convivas suos inquietare. Habebat ad pedes hos, a quibus subinde cum peteret versus quos referret, saepe in medio verbo excidebat. Suasit illi Satellius Quadratus, stultorum divitum adrosor et, quod sequitur, adrisor, et, quod duobus his adiunctum est, derisor, ut grammaticos haberet analectas. Cum dixisset Sabinus centenis millibus sibi constare singulos servos, «minoris» inquit «totidem scrinia emisses». Ille tamen in ea opinione erat ut putaret se scire quod quisquam in domo sua sciret. Idem Satellius illum hortari coepit ut luctaretur, hominem aegrum, pallidum, gracilem. Cum Sabinus respondisset, «et quomodo possum? Vix vivo», «noli, obsecro te» inquit «istuc dicere: non vides quam multos servos valentissimos habeas?». Bona mens nec commodatur nec emitur; et puto, si venalis esset, non haberet emptorem: at mala cotidie emitur. Sed accipe iam quod debeo et vale. «Divitiae sunt ad legem naturae composita paupertas». Hoc saepe dicit Epicurus aliter atque aliter, sed numquam nimis dicitur quod numquam satis discitur; quibusdam remedia monstranda, quibusdam inculcanda sunt. Vale.
28. Hoc tibi soli putas accidisse et admiraris quasi rem novam quod peregrinatione tam longa et tot locorum varietatibus non discussisti tristitiam gravitatemque mentis? Animum debes mutare, non caelum. Licet vastum traieceris mare, licet, ut ait Vergilius noster, terraeque urbesque recedant, sequentur te quocumque perveneris vitia. Hoc idem querenti cuidam Socrates ait, «quid miraris nihil tibi peregrinationes prodesse, cum te circumferas? Premit te eadem causa quae expulit». Quid terrarum iuvare novitas potest? Quid cognitio urbium aut locorum? In inritum cedit ista iactatio. Quaeris quare te fuga ista non adiuvet? Tecum fugis. Onus animi deponendum est: non ante tibi ullus placebit locus. Talem nunc esse habitum tuum cogita qualem Vergilius noster vatis inducit iam concitatae et instigatae multumque habentis in se spiritus non sui: bacchatur vates, magnum si pectore possit excussisse deum. Vadis huc illuc ut excutias insidens pondus quod ipsa iactatione incommodius fit, sicut in navi onera inmota minus urgent, inaequaliter convoluta citius eam partem in quam incubuere demergunt. Quidquid facis, contra te facis et motu ipso noces tibi; aegrum enim concutis. At cum istuc exemeris malum, omnis mutatio loci iucunda fiet; in ultimas expellaris terras licebit, in quolibet barbariae angulo conloceris, hospitalis tibi illa qualiscumque sedes erit. Magis quis veneris quam quo interest, et ideo nulli loco addicere debemus animum. Cum hac persuasione vivendum est: «non sum uni angulo natus, patria mea totus hic mundus est». Quod si liqueret tibi, non admirareris nil adiuvari te regionum varietatibus in quas subinde priorum taedio migras; prima enim quaeque placuisset si omnem tuam crederes. Nunc non peregrinaris sed erras et ageris ac locum ex loco mutas, cum illud quod quaeris, bene vivere, omni loco positum sit. Num quid tam turbidum fieri potest quam forum? Ibi quoque licet quiete vivere, si necesse sit. Sed si liceat disponere se, conspectum quoque et viciniam fori procul fugiam; nam ut loca gravia etiam firmissimam valetudinem temptant, ita bonae quoque menti necdum adhuc perfectae et convalescenti sunt aliqua parum salubria. Dissentio ab his qui in fluctus medios eunt et tumultuosam probantes vitam cotidie cum difficultatibus rerum magno animo conluctantur. Sapiens feret ista, non eliget, et malet in pace esse quam in pugna; non multum prodest vitia sua proiecisse, si cum alienis rixandum est. «Triginta» inquit «tyranni Socraten circumsteterunt nec potuerunt animum eius infringere». Quid interest quot domini sint? Servitus una est; hanc qui contempsit in quantalibet turba dominantium liber est. Tempus est desinere, sed si prius portorium solvero. «Initium est salutis notitia peccati». Egregie mihi hoc dixisse videtur Epicurus; nam qui peccare se
nescit corrigi non vult; deprehendas te oportet antequam emendes. Quidam vitiis gloriantur: tu existimas aliquid de remedio cogitare qui mala sua virtutum loco numerant? Ideo quantum potes te ipse coargue, inquire in te; accusatoris primum partibus fungere, deinde iudicis, novissime deprecatoris; aliquando te offende. Vale. 29. De Marcellino nostro quaeris et vis scire quid agat. Raro ad nos venit, non ulla alia ex causa quam quod audire verum timet, a quo periculo iam abest; nulli enim nisi audituro dicendum est. Ideo de Diogene nec minus de aliis Cynicis qui libertate promiscua usi sunt et obvios quosque monuerunt dubitari solet an hoc facere debuerint. Quid enim, si quis surdos obiurget aut natura morbove mutos? «Quare» inquis «verbis parcam? Gratuita sunt. Non possum scire an ei profuturus sim quem admoneo: illud scio, alicui me profuturum, si multos admonuero. Spargenda manus est: non potest fieri ut non aliquando succedat multa temptanti». Hoc, mi Lucili, non existimo magno viro faciendum: diluitur eius auctoritas nec habet apud eos satis ponderis quos posset minus obsolefacta corrigere. Sagittarius non aliquando ferire debet, sed aliquando deerrare; non est ars quae ad effectum casu venit. Sapientia ars est: certum petat, eligat profecturos, ab iis quos desperavit recedat, non tamen cito relinquat et in ipsa desperatione extrema remedia temptet. Marcellinum nostrum ego nondum despero; etiamnunc servari potest, sed si cito illi manus porrigitur. Est quidem periculum ne porrigentem trahat; magna in illo ingeni vis est, sed iam tendentis in pravum. Nihilominus adibo hoc periculum et audebo illi mala sua ostendere. Faciet quod solet: advocabit illas facetias quae risum evocare lugentibus possunt, et in se primum, deinde in nos iocabitur; omnia quae dicturus sum occupabit. Scrutabitur scholas nostras et obiciet philosophis congiaria, amicas, gulam; ostendet mihi alium in adulterio, alium in popina, alium in aula; ostendet mihi lepidum philosophum Aristonem, qui in gestatione disserebat – hoc enim ad edendas operas tempus exceperat. De cuius secta cum quaereretur, Scaurus ait «utique Peripateticus non est». De eodem cum consuleretur Iulius Graecinus, vir egregius, quid sentiret, «non possum» inquit «tibi dicere; nescio enim quid de gradu faciat», tamquam de essedario interrogaretur. Hos mihi circulatores qui philosophiam honestius neglexissent quam vendunt in faciem ingeret. Constitui tamen contumelias perpeti: moveat ille mihi risum, ego fortasse illi lacrimas movebo, aut si ridere perseverabit, gaudebo tamquam in malis quod illi genus insaniae hilare contigerit. Sed non est ista hilaritas longa: observa, videbis eosdem intra exiguum tempus acerrime ridere et acerrime rabere. Propositum est adgredi illum et ostendere quanto pluris fuerit cum multis minoris videretur. Vitia eius etiam si non excidero, inhibebo; non desinent, sed intermittent; fortasse autem et desinent, si intermittendi consuetudinem fecerint. Non est hoc ipsum fastidiendum, quoniam quidem graviter adfectis sanitatis loco est bona remissio. Dum me illi paro, tu interim, qui potes, qui intellegis unde quo evaseris et ex
eo suspicaris quousque sis evasurus, compone mores tuos, attolle animum, adversus formidata consiste; numerare eos noli qui tibi metum faciunt. Nonne videatur stultus, si quis multitudinem eo loco timeat per quem transitus singulis est? Aeque ad tuam mortem multis aditus non est, licet illam multi minentur. Sic istuc natura disposuit: spiritum tibi tam unus eripiet quam unus dedit. Si pudorem haberes, ultimam mihi pensionem remisisses; sed ne ego quidem me sordide geram in finem aeris alieni et tibi quod debeo inpingam. «Numquam volui populo placere; nam quae ego scio non probat populus, quae probat populus ego nescio». «Quis hoc?» inquis, tamquam nescias cui imperem. Epicurus; sed idem hoc omnes tibi ex omni domo conclamabunt, Peripatetici, Academici, Stoici, Cynici. Quis enim placere populo potest cui placet virtus? Malis artibus popularis favor quaeritur. Similem te illis facias oportet: non probabunt nisi agnoverint. Multo autem ad rem magis pertinet qualis tibi videaris quam aliis; conciliari nisi turpi ratione amor turpium non potest. Quid ergo illa laudata et omnibus praeferenda artibus rebusque philosophia praestabit? Scilicet ut malis tibi placere quam populo, ut aestimes iudicia, non numeres, ut sine metu deorum hominumque vivas, ut aut vincas mala aut finias. Ceterum, si te videro celebrem secundis vocibus vulgi, si intrante te clamor et plausus, pantomimica ornamenta, obstrepuerint, si tota civitate te feminae puerique laudaverint, quidni ego tui miserear, cum sciam quae via ad istum favorem ferat? Vale.
Liber quartus 30. Bassum Aufidium, virum optimum, vidi quassum, aetati obluctantem. Sed iam plus illum degravat quam quod possit attolli; magno senectus et universo pondere incubuit. Scis illum semper infirmi corporis et exsucti fuisse; diu illud continuit et, ut verius dicam, concinnavit: subito defecit. Quemadmodum in nave quae sentinam trahit uni rimae aut alteri obsistitur, ubi plurimis locis laxari coepit et cedere, succurri non potest navigio dehiscenti, ita in senili corpore aliquatenus inbecillitas sustineri et fulciri potest. Ubi tamquam in putri aedificio omnis iunctura diducitur, et dum alia excipitur, alia discinditur, circumspiciendum est quomodo exeas. Bassus tamen noster alacer animo est: hoc philosophia praestat, in conspectu mortis hilarem esse et in quocumque corporis habitu fortem laetumque nec deficientem quamvis deficiatur. Magnus gubernator et scisso navigat velo et, si exarmavit, tamen reliquias navigii aptat ad cursum. Hoc facit Bassus noster et eo animo vultuque finem suum spectat quo alienum spectare nimis securi putares. Magna res est, Lucili, haec et diu discenda, cum adventat hora illa inevitabilis, aequo animo abire. Alia genera mortis spei mixta sunt: desinit morbus, incendium extinguitur, ruina quos videbatur oppressura deposuit; mare quos hauserat eadem vi qua sorbebat eiecit incolumes; gladium miles ab ipsa perituri cervice revocavit: nil habet quod speret quem senectus ducit ad mortem; huic uni intercedi non potest. Nullo genere homines mollius moriuntur sed nec diutius. Bassus noster videbatur mihi prosequi se et componere et vivere tamquam superstes sibi et sapienter ferre desiderium sui. Nam de morte multa loquitur et id agit sedulo ut nobis persuadeat, si quid incommodi aut metus in hoc negotio est, morientis vitium esse, non mortis; non magis in ipsa quicquam esse molestiae quam post ipsam. Tam demens autem est qui timet quod non est passurus quam qui timet quod non est sensurus. An quisquam hoc futurum credit, ut per quam nihil sentiatur, ea sentiatur? «Ergo» inquit «mors adeo extra omne malum est ut sit extra omnem malorum metum». Haec ego scio et saepe dicta et saepe dicenda, sed neque cum legerem aeque mihi profuerunt neque cum audirem iis dicentibus qui negabant timenda a quorum metu aberant: hic vero plurimum apud me auctoritatis habuit, cum loqueretur de morte vicina. Dicam enim quid sentiam: puto fortiorem esse eum qui in ipsa morte est quam qui circa mortem. Mors enim admota etiam inperitis animum dedit non vitandi inevitabilia; sic gladiator tota pugna timidissimus iugulum adversario praestat et errantem gladium sibi adtemperat. At illa quae in propinquo est utique ventura desiderat lentam animi firmitatem, quae est rarior nec potest nisi a sapiente praestari. Libentissime itaque illum audiebam quasi ferentem de morte sententiam et qualis esset eius natura velut propius inspectae indicantem. Plus, ut puto, fidei haberet apud te, plus ponderis, si quis revixisset et in morte nihil mali esse narraret expertus: accessus mortis quam perturbationem adferat optime tibi hi dicent qui secundum illam steterunt, qui venientem et viderunt et receperunt. Inter hos Bassum licet numeres, qui nos
decipi noluit. Is ait tam stultum esse qui mortem timeat quam qui senectutem; nam quemadmodum senectus adulescentiam sequitur, ita mors senectutem. Vivere noluit qui mori non vult; vita enim cum exceptione mortis data est; ad hanc itur. Quam ideo timere dementis est quia certa expectantur, dubia metuuntur. Mors necessitatem habet aequam et invictam: quis queri potest in ea condicione se esse in qua nemo non est? Prima autem pars est aequitatis aequalitas. Sed nunc supervacuum est naturae causam agere, quae non aliam voluit legem nostram esse quam suam: quidquid composuit resolvit, et quidquid resolvit componit iterum. Iam vero si cui contigit ut illum senectus leviter emitteret, non repente avulsum vitae sed minutatim subductum, o ne ille agere gratias diis omnibus debet quod satiatus ad requiem homini necessariam, lasso gratam perductus est. Vides quosdam optantes mortem, et quidem magis quam rogari solet vita. Nescio utros existimem maiorem nobis animum dare, qui deposcunt mortem an qui hilares eam quietique opperiuntur, quoniam illud ex rabie interdum ac repentina indignatione fit, haec ex iudicio certo tranquillitas est. Venit aliquis ad mortem iratus: mortem venientem nemo hilaris excepit nisi qui se ad illam diu composuerat. Fateor ergo ad hominem mihi carum ex pluribus me causis frequentius venisse, ut scirem an illum totiens eundem invenirem, numquid cum corporis viribus minueretur animi vigor; qui sic crescebat illi quomodo manifestior notari solet agitatorum laetitia cum septimo spatio palmae adpropinquant. Dicebat quidem ille Epicuri praeceptis obsequens, primum sperare se nullum dolorem esse in illo extremo anhelitu; si tamen esset, habere aliquantum in ipsa brevitate solacii; nullum enim dolorem longum esse qui magnus est. Ceterum succursurum sibi etiam in ipsa distractione animae corporisque, si cum cruciatu id fieret, post illum dolorem se dolere non posse. Non dubitare autem se quin senilis anima in primis labris esset nec magna vi distraheretur a corpore. «Ignis qui alentem materiam occupavit aqua et interdum ruina extinguendus est: ille qui alimentis deficitur sua sponte subsidit». Libenter haec, mi Lucili, audio non tamquam nova, sed tamquam in rem praesentem perductus. Quid ergo? Non multos spectavi abrumpentes vitam? Ego vero vidi, sed plus momenti apud me habent qui ad mortem veniunt sine odio vitae et admittunt illam, non adtrahunt. Illud quidem aiebat tormentum nostra nos sentire opera, quod tunc trepidamus cum prope a nobis esse credimus mortem: a quo enim non prope est, parata omnibus locis omnibusque momentis? «Sed consideremus» inquit «tunc cum aliqua causa moriendi videtur accedere, quanto aliae propiores sint quae non timentur». Hostis alicui mortem minabatur, hanc cruditas occupavit. Si distinguere voluerimus causas metus nostri, inveniemus alias esse, alias videri. Non mortem timemus sed cogitationem mortis; ab ipsa enim semper tantundem absumus. Ita si timenda mors est, semper timenda est: quod enim morti tempus exemptum est? Sed vereri debeo ne tam longas epistulas peius quam mortem oderis. Itaque finem faciam: tu tamen mortem ut numquam timeas semper cogita. Vale. 31. Agnosco Lucilium meum: incipit quem promiserat exhibere. Sequere
illum impetum animi quo ad optima quaeque calcatis popularibus bonis ibas: non desidero maiorem melioremque te fieri quam moliebaris. Fundamenta tua multum loci occupaverunt: tantum effice quantum conatus es, et illa quae tecum in animo tulisti tracta. Ad summam sapiens eris, si cluseris aures, quibus ceram parum est obdere: firmiore spissamento opus est quam in sociis usum Ulixem ferunt. Illa vox quae timebatur erat blanda, non tamen publica: at haec quae timenda est non ex uno scopulo sed ex omni terrarum parte circumsonat. Praetervehere itaque non unum locum insidiosa voluptate suspectum, sed omnes urbes. Surdum te amantissimis tuis praesta: bono animo mala precantur. Et si esse vis felix, deos ora ne quid tibi ex his quae optantur eveniat. Non sunt ista bona quae in te isti volunt congeri: unum bonum est, quod beatae vitae causa et firmamentum est, sibi fidere. Hoc autem contingere non potest, nisi contemptus est labor et in eorum numero habitus quae neque bona sunt neque mala; fieri enim non potest ut una ulla res modo mala sit, modo bona, modo levis et perferenda, modo expavescenda. Labor bonum non est: quid ergo est bonum? Laboris contemptio. Itaque in vanum operosos culpaverim: rursus ad honesta nitentes, quanto magis incubuerint minusque sibi vinci ac strigare permiserint, admirabor et clamabo, «tanto melior, surge et inspira et clivum istum uno si potes spiritu exsupera». Generosos animos labor nutrit. Non est ergo quod ex illo voto vetere parentum tuorum eligas quid contingere tibi velis, quid optes; et in totum iam per maxima acto viro turpe est etiamnunc deos fatigare. Quid votis opus est? Fac te ipse felicem; facies autem, si intellexeris bona esse quibus admixta virtus est, turpia quibus malitia coniuncta est. Quemadmodum sine mixtura lucis nihil splendidum est, nihil atrum nisi quod tenebras habet aut aliquid in se traxit obscuri, quemadmodum sine adiutorio ignis nihil calidum est, nihil sine aëre frigidum, ita honesta et turpia virtutis ac malitiae societas efficit. Quid ergo est bonum? Rerum scientia. Quid malum est? Rerum imperitia. Ille prudens atque artifex pro tempore quaeque repellet aut eliget; sed nec quae repellit timet nec miratur quae eligit, si modo magnus illi et invictus animus est. Summitti te ac deprimi veto. Laborem si non recuses, parum est: posce. «Quid ergo?» inquis «labor frivolus et supervacuus et quem humiles causae evocaverunt non est malus?». Non magis quam ille qui pulchris rebus inpenditur, quoniam animi est ipsa tolerantia quae se ad dura et aspera hortatur ac dicit, «quid cessas? Non est viri timere sudorem». Huc et illud accedat, ut perfecta virtus sit, aequalitas ac tenor vitae per omnia consonans sibi, quod non potest esse nisi rerum scientia contingit et ars per quam humana ac divina noscantur. Hoc est summum bonum; quod si occupas, incipis deorum socius esse, non supplex. «Quomodo» inquis «isto pervenitur?». Non per Poeninum Graiumve montem nec per deserta Candaviae; nec Syrtes tibi nec Scylla aut Charybdis adeundae sunt, quae tamen omnia transisti procuratiunculae pretio: tutum iter est, iucundum est, ad quod natura te instruxit. Dedit tibi illa quae si non deserueris, par deo surges. Parem autem te deo pecunia non faciet: deus nihil habet. Praetexta non faciet: deus nudus est. Fama non faciet nec ostentatio tui et in populos nominis dimissa notitia: nemo novit deum, multi de
illo male existimant, et inpune. Non turba servorum lecticam tuam per itinera urbana ac peregrina portantium: deus ille maximus potentissimusque ipse vehit omnia. Ne forma quidem et vires beatum te facere possunt: nihil horum patitur vetustatem. Quaerendum est quod non fiat in dies peius, cui non possit obstari. Quid hoc est? Animus, sed hic rectus, bonus, magnus. Quid aliud voces hunc quam deum in corpore humano hospitantem? Hic animus tam in equitem Romanum quam in libertinum, quam in servum potest cadere. Quid est enim eques Romanus aut libertinus aut servus? Nomina ex ambitione aut iniuria nata. Subsilire in caelum ex angulo licet: exsurge modo et te quoque dignum finge deo. Finges autem non auro vel argento: non potest ex hac materia imago deo exprimi similis; cogita illos, cum propitii essent, fictiles fuisse. Vale. 32. Inquiro de te et ab omnibus sciscitor qui ex ista regione veniunt quid agas, ubi et cum quibus moreris. Verba dare non potes: tecum sum. Sic vive tamquam quid facias auditurus sim, immo tamquam visurus. Quaeris quid me maxime ex iis quae de te audio delectet? Quod nihil audio, quod plerique ex iis quos interrogo nesciunt quid agas. Hoc est salutare, non conversari dissimilibus et diversa cupientibus. Habeo quidem fiduciam non posse te detorqueri mansurumque in proposito, etiam si sollicitantium turba circumeat. Quid ergo est? Non timeo ne mutent te, timeo ne inpediant. Multum autem nocet etiam qui moratur, utique in tanta brevitate vitae, quam breviorem inconstantia facimus, aliud eius subinde atque aliud facientes initium; diducimus illam in particulas ac lancinamus. Propera ergo, Lucili carissime, et cogita quantum additurus celeritati fueris, si a tergo hostis instaret, si equitem adventare suspicareris ac fugientium premere vestigia. Fit hoc, premeris: adcelera et evade, perduc te in tutum et subinde considera quam pulchra res sit consummare vitam ante mortem, deinde expectare securum reliquam temporis sui partem, nihil sibi, in possessione beatae vitae positum, quae beatior non fit si longior. O quando illud videbis tempus quo scies tempus ad te non pertinere, quo tranquillus placidusque eris et crastini neglegens et in summa tui satietate! Vis scire quid sit quod faciat homines avidos futuri? Nemo sibi contigit. Optaverunt itaque tibi alia parentes tui; sed ego contra omnium tibi eorum contemptum opto quorum illi copiam. Vota illorum multos compilant ut te locupletent; quidquid ad te transferunt alicui detrahendum est. Opto tibi tui facultatem, ut vagis cogitationibus agitata mens tandem resistat et certa sit, ut placeat sibi et intellectis veris bonis, quae simul intellecta sunt possidentur, aetatis adiectione non egeat. Ille demum necessitates supergressus est et exauctoratus ac liber qui vivit vita peracta. Vale. 33. Desideras his quoque epistulis sicut prioribus adscribi aliquas voces
nostrorum procerum. Non fuerunt circa flosculos occupati: totus contextus illorum virilis est. Inaequalitatem scias esse ubi quae eminent notabilia sunt: non est admirationi una arbor ubi in eandem altitudinem tota silva surrexit. Eiusmodi vocibus referta sunt carmina, refertae historiae. Itaque nolo illas Epicuri existimes esse: publicae sunt et maxime nostrae, sed in illo magis adnotantur quia rarae interim interveniunt, quia inexpectatae, quia mirum est fortiter aliquid dici ab homine mollitiam professo. Ita enim plerique iudicant: apud me Epicurus est et fortis, licet manuleatus sit; fortitudo et industria et ad bellum prompta mens tam in Persas quam in alte cinctos cadit. Non est ergo quod exigas excerpta et repetita: continuum est apud nostros quidquid apud alios excerpitur. Non habemus itaque ista ocliferia nec emptorem decipimus nihil inventurum cum intraverit praeter illa quae in fronte suspensa sunt: ipsis permittimus unde velint sumere exemplar. Iam puta nos velle singulares sententias ex turba separare: cui illas adsignabimus? Zenoni an Cleanthi an Chrysippo an Panaetio an Posidonio? Non sumus sub rege: sibi quisque se vindicat. Apud istos quidquid Hermarchus dixit, quidquid Metrodorus, ad unum refertur; omnia quae quisquam in illo contubernio locutus est unius ductu et auspiciis dicta sunt. Non possumus, inquam, licet temptemus, educere aliquid ex tanta rerum aequalium multitudine: pauperis est numerare pecus. Quocumque miseris oculum, id tibi occurret quod eminere posset nisi inter paria legeretur. Quare depone istam spem posse te summatim degustare ingenia maximorum virorum: tota tibi inspicienda sunt, tota tractanda. Continuando res geritur et per lineamenta sua ingenii opus nectitur ex quo nihil subduci sine ruina potest. Nec recuso quominus singula membra, dummodo in ipso homine, consideres: non est formonsa cuius crus laudatur aut brachium, sed illa cuius universa facies admirationem partibus singulis abstulit. Si tamen exegeris, non tam mendice tecum agam, sed plena manu fiet; ingens eorum turba est passim iacentium; sumenda erunt, non colligenda. Non enim excidunt sed fluunt; perpetua et inter se contexta sunt. Nec dubito quin multum conferant rudibus adhuc et extrinsecus auscultantibus; facilius enim singula insidunt circumscripta et carminis modo inclusa. Ideo pueris et sententias ediscendas damus et has quas Graeci chrias vocant, quia conplecti illas puerilis animus potest, qui plus adhuc non capit. Certi profectus viro captare flosculos turpe est et fulcire se notissimis ac paucissimis vocibus et memoria stare: sibi iam innitatur. Dicat ista, non teneat; turpe est enim seni aut prospicienti senectutem ex commentario sapere. «Hoc Zenon dixit»: tu quid? «Hoc Cleanthes»: tu quid? Quousque sub alio moveris? Impera et dic quod memoriae tradatur, aliquid et de tuo profer. Omnes itaque istos, numquam auctores, semper interpretes, sub aliena umbra latentes, nihil existimo habere generosi, numquam ausos aliquando facere quod diu didicerant. Memoriam in alienis exercuerunt; aliud autem est meminisse, aliud scire. Meminisse est rem commissam memoriae custodire; at contra scire est et
sua facere quaeque nec ad exemplar pendere et totiens respicere ad magistrum. «Hoc dixit Zenon, hoc Cleanthes». Aliquid inter te intersit et librum. Quousque disces? Iam et praecipe. Quid est quare audiam quod legere possum? «Multum» inquit «viva vox facit». Non quidem haec quae alienis verbis commodatur et actuari vice fungitur. Adice nunc quod isti qui numquam tutelae suae fiunt primum in ea re sequuntur priores in qua nemo non a priore descivit; deinde in ea re sequuntur quae adhuc quaeritur. Numquam autem invenietur, si contenti fuerimus inventis. Praeterea qui alium sequitur nihil invenit, immo nec quaerit. Quid ergo? Non ibo per priorum vestigia? Ego vero utar via vetere, sed si propiorem planioremque invenero, hanc muniam. Qui ante nos ista moverunt non domini nostri sed duces sunt. Patet omnibus veritas; nondum est occupata; multum ex illa etiam futuris relictum est. Vale. 34. Cresco et exulto et discussa senectute recalesco quotiens ex iis quae agis ac scribis intellego quantum te ipse – nam turbam olim reliqueras – superieceris. Si agricolam arbor ad fructum perducta delectat, si pastor ex fetu gregis sui capit voluptatem, si alumnum suum nemo aliter intuetur quam ut adulescentiam illius suam iudicet, quid evenire credis iis qui ingenia educaverunt et quae tenera formaverunt adulta subito vident? Adsero te mihi; meum opus es. Ego cum vidissem indolem tuam, inieci manum, exhortatus sum, addidi stimulos nec lente ire passus sum sed subinde incitavi; et nunc idem facio, sed iam currentem hortor et invicem hortantem. «Quid illud?» inquis «adhuc volo». In hoc plurimum est, non sic quomodo principia totius operis dimidium occupare dicuntur. Ista res animo constat; itaque pars magna bonitatis est velle fieri bonum. Scis quem bonum dicam? Perfectum, absolutum, quem malum facere nulla vis, nulla necessitas possit. Hunc te prospicio, si perseveraveris et incubueris et id egeris ut omnia facta dictaque tua inter se congruant ac respondeant sibi et una forma percussa sint. Non est huius animus in recto cuius acta discordant. Vale. 35. Cum te tam valde rogo ut studeas, meum negotium ago: habere amicum volo, quod contingere mihi, nisi pergis ut coepisti excolere te, non potest. Nunc enim amas me, amicus non es. «Quid ergo? Haec inter se diversa sunt?» immo dissimilia. Qui amicus est amat; qui amat non utique amicus est; itaque amicitia semper prodest, amor aliquando etiam nocet. Si nihil aliud, ob hoc profice, ut amare discas. Festina ergo dum mihi proficis, ne istuc alteri didiceris. Ego quidem percipio iam fructum, cum mihi fingo uno nos animo futuros et quidquid aetati meae vigoris abscessit, id ad me ex tua, quamquam non multum abest, rediturum; sed tamen re quoque ipsa esse laetus volo. Venit ad nos ex iis quos amamus etiam absentibus gaudium, sed id leve et evanidum: conspectus et praesentia et conversatio habet aliquid vivae voluptatis, utique si non tantum quem velis sed qualem velis videas. Adfer itaque te mihi, ingens munus, et quo magis instes, cogita te mortalem esse, me senem. Propera ad me, sed ad te prius. Profice et ante omnia hoc cura, ut constes tibi. Quotiens experiri voles an aliquid
actum sit, observa an eadem hodie velis quae heri: mutatio voluntatis indicat animum natare, aliubi atque aliubi apparere, prout tulit ventus. Non vagatur quod fixum atque fundatum est: istud sapienti perfecto contingit, aliquatenus et proficienti provectoque. Quid ergo interest? Hic commovetur quidem, non tamen transit, sed suo loco nutat; ille ne commovetur quidem. Vale. 36. Amicum tuum hortare ut istos magno animo contemnat qui illum obiurgant quod umbram et otium petierit, quod dignitatem suam destituerit et, cum plus consequi posset, praetulerit quietem omnibus; quam utiliter suum negotium gesserit cotidie illis ostentet. Hi quibus invidetur non desinent transire: alii elidentur, alii cadent. Res est inquieta felicitas; ipsa se exagitat. Movet cerebrum non uno genere: alios in aliud inritat, hos in inpotentiam, illos in luxuriam; hos inflat, illos mollit et totos resolvit. «At bene aliquis illam fert». Sic, quomodo vinum. Itaque non est quod tibi isti persuadeant eum esse felicem qui a multis obsidetur: sic ad illum quemadmodum ad lacum concurritur, quem exhauriunt et turbant. «Nugatorium et inertem vocant». Scis quosdam perverse loqui et significare contraria. Felicem vocabant: quid ergo? Erat? Ne illud quidem curo, quod quibusdam nimis horridi animi videtur et tetrici. Ariston aiebat malle se adulescentem tristem quam hilarem et amabilem turbae; vinum enim bonum fieri quod recens durum et asperum visum est; non pati aetatem quod in dolio placuit. Sine eum tristem appellent et inimicum processibus suis: bene se dabit in vetustate ipsa tristitia, perseveret modo colere virtutem, perbibere liberalia studia, non illa quibus perfundi satis est, sed haec quibus tingendus est animus. Hoc est discendi tempus. «Quid ergo? Aliquod est quo non sit discendum?». Minime; sed quemadmodum omnibus annis studere honestum est, ita non omnibus institui. Turpis et ridicula res est elementarius senex: iuveni parandum, seni utendum est. Facies ergo rem utilissimam tibi, si illum quam optimum feceris; haec aiunt beneficia esse expetenda tribuendaque, non dubie primae sortis, quae tam dare prodest quam accipere. Denique nihil illi iam liberi est, spopondit; minus autem turpe est creditori quam spei bonae decoquere. Ad illud aes alienum solvendum opus est negotianti navigatione prospera, agrum colenti ubertate eius quam colit terrae, caeli favore: ille quod debet sola potest voluntate persolvi. In mores fortuna ius non habet. Hos disponat ut quam tranquillissimus ille animus ad perfectum veniat, qui nec ablatum sibi quicquam sentit nec adiectum, sed in eodem habitu est quomodocumque res cedunt; cui sive adgeruntur vulgaria bona, supra res suas eminet, sive aliquid ex istis vel omnia casus excussit, minor non fit. Si in Parthia natus esset, arcum infans statim tenderet; si in Germania, protinus puer tenerum hastile vibraret; si avorum nostrorum temporibus fuisset, equitare et hostem comminus percutere didicisset. Haec singulis disciplina gentis suae suadet atque imperat. Quid ergo huic meditandum est? Quod adversus omnia tela, quod adversus omne hostium genus bene facit, mortem contemnere, quae quin habeat aliquid in se terribile, ut et animos nostros quos in amorem sui natura formavit offendat, nemo dubitat; nec enim opus esset in id comparari et acui in
quod instinctu quodam voluntario iremus, sicut feruntur omnes ad conservationem sui. Nemo discit ut si necesse fuerit aequo animo in rosa iaceat, sed in hoc duratur, ut tormentis non summittat fidem, ut si necesse fuerit stans etiam aliquando saucius pro vallo pervigilet et ne pilo quidem incumbat, quia solet obrepere interim somnus in aliquod adminiculum reclinatis. Mors nullum habet incommodum; esse enim debet aliquid cuius sit incommodum. Quod si tanta cupiditas te longioris aevi tenet, cogita nihil eorum quae ab oculis abeunt et in rerum naturam, ex qua prodierunt ac mox processura sunt, reconduntur consumi: desinunt ista, non pereunt, et mors, quam pertimescimus ac recusamus, intermittit vitam, non eripit; veniet iterum qui nos in lucem reponat dies, quem multi recusarent nisi oblitos reduceret. Sed postea diligentius docebo omnia quae videntur perire mutari. Aequo animo debet rediturus exire. Observa orbem rerum in se remeantium: videbis nihil in hoc mundo extingui sed vicibus descendere ac surgere. Aestas abit, sed alter illam annus adducet; hiemps cecidit, referent illam sui menses; solem nox obruit, sed ipsam statim dies abiget. Stellarum iste discursus quidquid praeterit repetit; pars caeli levatur adsidue, pars mergitur. Denique finem faciam, si hoc unum adiecero, nec infantes pueros nec mente lapsos timere mortem et esse turpissimum si eam securitatem nobis ratio non praestat ad quam stultitia perducit. Vale. 37. Quod maximum vinculum est ad bonam mentem, promisisti virum bonum, sacramento rogatus es. Deridebit te, si quis tibi dixerit mollem esse militiam et facilem. Nolo te decipi. Eadem honestissimi huius et illius turpissimi auctoramenti verba sunt: «uri, vinciri ferroque necari». Ab illis qui manus harenae locant et edunt ac bibunt quae per sanguinem reddant cavetur ut ista vel inviti patiantur: a te ut volens libensque patiaris. Illis licet arma summittere, misericordiam populi temptare: tu neque summittes nec vitam rogabis; recto tibi invictoque moriendum est. Quid porro prodest paucos dies aut annos lucrificare? Sine missione nascimur. «Quomodo ergo» inquis «me expediam?» Effugere non potes necessitates, potes vincere. Fit via vi; et hanc tibi viam dabit philosophia. Ad hanc te confer si vis salvus esse, si securus, si beatus, denique si vis esse, quod est maximum, liber; hoc contingere aliter non potest. Humilis res est stultitia, abiecta, sordida, servilis, multis adfectibus et saevissimis subiecta. Hos tam graves dominos, interdum alternis imperantes, interdum pariter, dimittit a te sapientia, quae sola libertas est. Una ad hanc fert via, et quidem recta; non aberrabis; vade certo gradu. Si vis omnia tibi subicere, te subice rationi; multos reges, si ratio te rexerit. Ab illa disces quid et quemadmodum adgredi debeas; non incides rebus. Neminem mihi dabis qui sciat quomodo quod vult coeperit velle: non consilio adductus illo sed impetu inpactus est. Non minus saepe fortuna in nos incurrit quam nos in illam. Turpe est non ire
sed ferri, et subito in medio turbine rerum stupentem quaerere, «huc ego quemadmodum veni?» Vale. 38. Merito exigis ut hoc inter nos epistularum commercium frequentemus. Plurimum proficit sermo, quia minutatim inrepit animo: disputationes praeparatae et effusae audiente populo plus habent strepitus, minus familiaritatis. Philosophia bonum consilium est: consilium nemo clare dat. Aliquando utendum est et illis, ut ita dicam, contionibus, ubi qui dubitat inpellendus est; ubi vero non hoc agendum est, ut velit discere, sed ut discat, ad haec submissiora verba veniendum est. Facilius intrant et haerent; nec enim multis opus est sed efficacibus. Seminis modo spargenda sunt, quod quamvis sit exiguum, cum occupavit idoneum locum, vires suas explicat et ex minimo in maximos auctus diffunditur. Idem facit ratio: non late patet, si aspicias; in opere crescit. Pauca sunt quae dicuntur, sed si illa animus bene excepit, convalescunt et exsurgunt. Eadem est, inquam, praeceptorum condicio quae seminum: multum efficiunt, et angusta sunt. Tantum, ut dixi, idonea mens rapiat illa et in se trahat; multa invicem et ipsa generabit et plus reddet quam acceperit. Vale. 39. Commentarios quos desideras, diligenter ordinatos et in angustum coactos, ego vero componam; sed vide ne plus profutura sit ratio ordinaria quam haec quae nunc vulgo breviarium dicitur, olim cum latine loqueremur summarium vocabatur. Illa res discenti magis necessaria est, haec scienti; illa enim docet, haec admonet. Sed utriusque rei tibi copiam faciam. Tu a me non est quod illum aut illum exigas: qui notorem dat ignotus est. Scribam ergo quod vis, sed meo more; interim multos habes quorum scripta nescio an satis ordinentur. Sume in manus indicem philosophorum: haec ipsa res expergisci te coget, si videris quam multi tibi laboraverint. Concupisces et ipse ex illis unus esse; habet enim hoc optimum in se generosus animus, quod concitatur ad honesta. Neminem excelsi ingenii virum humilia delectant et sordida: magnarum rerum species ad se vocat et extollit. Quemadmodum flamma surgit in rectum, iacere ac deprimi non potest, non magis quam quiescere, ita noster animus in motu est, eo mobilior et actuosior quo vehementior fuerit. Sed felix qui ad meliora hunc impetum dedit: ponet se extra ius dicionemque fortunae; secunda temperabit, adversa comminuet et aliis admiranda despiciet. Magni animi est magna contemnere ac mediocria malle quam nimia; illa enim utilia vitaliaque sunt, at haec eo quod superfluunt nocent. Sic segetem nimia sternit ubertas, sic rami onere franguntur, sic ad maturitatem non pervenit nimia fecunditas. Idem animis quoque evenit quos immoderata felicitas rumpit, qua non tantum in aliorum iniuriam sed etiam in suam utuntur. Qui hostis in quemquam tam contumeliosus fuit quam in quosdam voluptates suae sunt? Quorum inpotentiae atque insanae libidini ob hoc unum possis ignoscere, quod quae fecere patiuntur. Nec inmerito hic illos furor vexat; necesse est enim in immensum exeat cupiditas quae naturalem modum transilit. Ille enim habet suum finem, inania et ex libidine orta sine termino sunt. Necessaria metitur
utilitas: supervacua quo redigis? Voluptatibus itaque se mergunt quibus in consuetudinem adductis carere non possunt, et ob hoc miserrimi sunt, quod eo pervenerunt ut illis quae supervacua fuerant facta sint necessaria. Serviunt itaque voluptatibus, non fruuntur, et mala sua, quod malorum ultimum est, et amant; tunc autem est consummata infelicitas, ubi turpia non solum delectant sed etiam placent, et desinit esse remedio locus ubi quae fuerant vitia mores sunt. Vale. 40. Quod frequenter mihi scribis gratias ago; nam quo uno modo potes te mihi ostendis. Numquam epistulam tuam accipio ut non protinus una simus. Si imagines nobis amicorum absentium iucundae sunt, quae memoriam renovant et desiderium falso atque inani solacio levant, quanto iucundiores sunt litterae, quae vera amici absentis vestigia, veras notas adferunt? Nam quod in conspectu dulcissimum est, id amici manus epistulae inpressa praestat, agnoscere. Audisse te scribis Serapionem philosophum, cum istuc adplicuisset: «solet magno cursu verba convellere, quae non effundit †ima† sed premit et urguet; plura enim veniunt quam quibus vox una sufficiat». Hoc non probo in philosopho, cuius pronuntiatio quoque, sicut vita, debet esse composita; nihil autem ordinatum est quod praecipitatur et properat. Itaque oratio illa apud Homerum concitata et sine intermissione in morem nivis superveniens oratori data est, lenis et melle dulcior seni profluit. Sic itaque habe: istam vim dicendi rapidam atque abundantem aptiorem esse circulanti quam agenti rem magnam ac seriam docentique. Aeque stillare illum nolo quam currere; nec extendat aures nec obruat. Nam illa quoque inopia et exilitas minus intentum auditorem habet taedio interruptae tarditatis; facilius tamen insidit quod expectatur quam quod praetervolat. Denique tradere homines discipulis praecepta dicuntur: non traditur quod fugit. Adice nunc quod quae veritati operam dat oratio incomposita esse debet et simplex: haec popularis nihil habet veri. Movere vult turbam et inconsultas aures impetu rapere, tractandam se non praebet, aufertur: quomodo autem regere potest quae regi non potest? Quid quod haec oratio quae sanandis mentibus adhibetur descendere in nos debet? Remedia non prosunt nisi inmorantur. Multum praeterea habet inanitatis et vani, plus sonat quam valet. Lenienda sunt quae me exterrent, conpescenda quae inritant, discutienda quae fallunt, inhibenda luxuria, corripienda avaritia: quid horum raptim potest fieri? Quis medicus aegros in transitu curat? Quid quod ne voluptatem quidem ullam habet talis verborum sine dilectu ruentium strepitus? Sed ut pleraque quae fieri posse non crederes cognovisse satis est, ita istos qui verba exercuerunt abunde est semel audisse. Quid enim quis discere, quid imitari velit? Quid de eorum animo iudicet quorum oratio perturbata et inmissa est nec potest reprimi? Quemadmodum per proclive currentium non ubi visum est gradus sistitur, sed incitato corporis ponderi servit ac longius quam voluit effertur, sic ista dicendi celeritas nec in sua potestate est nec satis decora philosophiae, quae ponere debet verba, non proicere, et pedetemptim procedere. «Quid ergo? Non aliquando et insurget?». Quidni? Sed salva dignitate morum, quam violenta ista et
nimia vis exuit. Habeat vires magnas, moderatas tamen; perennis sit unda, non torrens. Vix oratori permiserim talem dicendi velocitatem inrevocabilem ac sine lege vadentem: quemadmodum enim iudex subsequi poterit aliquando etiam inperitus et rudis? Tum quoque, cum illum aut ostentatio abstulerit aut adfectus inpotens sui, tantum festinet atque ingerat quantum aures pati possunt. Recte ergo facies si non audieris istos qui quantum dicant, non quemadmodum quaerunt, et ipse malueris, si necesse est, †vel P. Vinicium dicere qui itaque†. Cum quaereretur quomodo P. Vinicius diceret, Asellius ait «tractim». Nam Geminus Varius ait, «quomodo istum disertum dicatis nescio: tria verba non potest iungere». Quidni malis tu sic dicere quomodo Vinicius? Aliquis tam insulsus intervenerit quam qui illi singula verba vellenti, tamquam dictaret, non diceret, ait «dic, †numquam dicas†?» Nam Q. Hateri cursum, suis temporibus oratoris celeberrimi, longe abesse ab homine sano volo: numquam dubitavit, numquam intermisit; semel incipiebat, semel desinebat. Quaedam tamen et nationibus puto magis aut minus convenire. In Graecis hanc licentiam tuleris: nos etiam cum scribimus interpungere adsuevimus. Cicero quoque noster, a quo Romana eloquentia exiluit, gradarius fuit. Romanus sermo magis se circumspicit et aestimat praebetque aestimandum. Fabianus, vir egregius et vita et scientia et, quod post ista est, eloquentia quoque, disputabat expedite magis quam concitate, ut posses dicere facilitatem esse illam, non celeritatem. Hanc ego in viro sapiente recipio, non exigo; ut oratio eius sine inpedimento exeat, proferatur tamen malo quam profluat. Eo autem magis te deterreo ab isto morbo quod non potest tibi ista res contingere aliter quam si te pudere desierit: perfrices frontem oportet et te ipse non audias; multa enim inobservatus ille cursus feret quae reprendere velis. Non potest, inquam, tibi contingere res ista salva verecundia. Praeterea exercitatione opus est cotidiana et a rebus studium transferendum est ad verba. Haec autem etiam si aderunt et poterunt sine ullo tuo labore decurrere, tamen temperanda sunt; nam quemadmodum sapienti viro incessus modestior convenit, ita oratio pressa, non audax. Summa ergo summarum haec erit: tardilocum esse te iubeo. Vale. 41. Facis rem optimam et tibi salutarem si, ut scribis, perseveras ire ad bonam mentem, quam stultum est optare cum possis a te inpetrare. Non sunt ad caelum elevandae manus nec exorandus aedituus ut nos ad aurem simulacri, quasi magis exaudiri possimus, admittat: prope est a te deus, tecum est, intus est. Ita dico, Lucili: sacer intra nos spiritus sedet, malorum bonorumque nostrorum observator et custos; hic prout a nobis tractatus est, ita nos ipse tractat. Bonus vero vir sine deo nemo est: an potest aliquis supra fortunam nisi ab illo adiutus exsurgere? Ille dat consilia magnifica et erecta. In unoquoque virorum bonorum (quis deus incertum est) habitat deus. Si tibi occurrerit vetustis arboribus et solitam altitudinem egressis frequens
lucus et conspectum caeli densitate ramorum aliorum alios protegentium summovens, illa proceritas silvae et secretum loci et admiratio umbrae in aperto tam densae atque continuae fidem tibi numinis faciet. Si quis specus saxis penitus exesis montem suspenderit, non manu factus, sed naturalibus causis in tantam laxitatem excavatus, animum tuum quadam religionis suspicione percutiet. Magnorum fluminum capita veneramur; subita ex abdito vasti amnis eruptio aras habet; coluntur aquarum calentium fontes, et stagna quaedam vel opacitas vel immensa altitudo sacravit. Si hominem videris interritum periculis, intactum cupiditatibus, inter adversa felicem, in mediis tempestatibus placidum, ex superiore loco homines videntem, ex aequo deos, non subibit te veneratio eius? Non dices, «ista res maior est altiorque quam ut credi similis huic in quo est corpusculo possit»? Vis isto divina descendit; animum excellentem, moderatum, omnia tamquam minora transeuntem, quidquid timemus optamusque ridentem, caelestis potentia agitat. Non potest res tanta sine adminiculo numinis stare; itaque maiore sui parte illic est unde descendit. Quemadmodum radii solis contingunt quidem terram sed ibi sunt unde mittuntur, sic animus magnus ac sacer et in hoc demissus, ut propius divina nossemus, conversatur quidem nobiscum sed haeret origini suae; illinc pendet, illuc spectat ac nititur, nostris tamquam melior interest. Quis est ergo hic animus? Qui nullo bono nisi suo nitet. Quid enim est stultius quam in homine aliena laudare? Quid eo dementius qui ea miratur quae ad alium transferri protinus possunt? Non faciunt meliorem equum aurei freni. Aliter leo aurata iuba mittitur, dum contractatur et ad patientiam recipiendi ornamenti cogitur fatigatus, aliter incultus, integri spiritus: hic scilicet impetu acer, qualem illum natura esse voluit, speciosus ex horrido, cuius hic decor est, non sine timore aspici, praefertur illi languido et bratteato. Nemo gloriari nisi suo debet. Vitem laudamus si fructu palmites onerat, si ipsa pondere eorum quae tulit adminicula deducit: num quis huic illam praeferret vitem cui aureae uvae, aurea folia dependent? Propria virtus est in vite fertilitas; in homine quoque id laudandum est quod ipsius est. Familiam formonsam habet et domum pulchram, multum serit, multum fenerat: nihil horum in ipso est sed circa ipsum. Lauda in illo quod nec eripi potest nec dari, quod proprium hominis est. Quaeris quid sit? Animus et ratio in animo perfecta. Rationale enim animal est homo; consummatur itaque bonum eius, si id inplevit cui nascitur. Quid est autem quod ab illo ratio haec exigat? Rem facillimam, secundum naturam suam vivere. Sed hanc difficilem facit communis insania: in vitia alter alterum trudimus. Quomodo autem revocari ad salutem possunt quos nemo retinet, populus inpellit? Vale.
Liber quintus 42. Iam tibi iste persuasit virum se bonum esse? Atqui vir bonus tam cito nec fieri potest nec intellegi. Scis quem nunc virum bonum dicam? Hunc secundae notae; nam ille alter fortasse tamquam phoenix semel anno quingentesimo nascitur. Nec est mirum ex intervallo magna generari: mediocria et in turbam nascentia saepe fortuna producit, eximia vero ipsa raritate commendat. Sed iste multum adhuc abest ab eo quod profitetur; et si sciret quid esset vir bonus, nondum esse se crederet, fortasse etiam fieri posse desperaret. «At male existimat de malis». Hoc etiam mali faciunt, nec ulla maior poena nequitiaest quam quod sibi ac suis displicet. «At odit eos qui subita et magna potentia inpotenter utuntur». Idem faciet cum idem potuerit. Multorum quia inbecilla sunt latent vitia, non minus ausura cum illis vires suae placuerint quam illa quae iam felicitas aperuit. Instrumenta illis explicandae nequitiae desunt. Sic tuto serpens etiam pestifera tractatur dum riget frigore: non desunt tunc illi venena sed torpent. Multorum crudelitas et ambitio et luxuria, ut paria pessimis audeat, fortunae favore deficitur. Eadem velle cognosces: da posse quantum volunt. Meministi, cum quendam adfirmares esse in tua potestate, dixisse me volaticum esse ac levem et te non pedem eius tenere sed pinnam? Mentitus sum: pluma tenebatur, quam remisit et fugit. Scis quos postea tibi exhibuerit ludos, quam multa in caput suum casura temptaverit. Non videbat se per aliorum pericula in suum ruere; non cogitabat quam onerosa essent quae petebat, etiam si supervacua non essent. Hoc itaque in his quae adfectamus, ad quae labore magno contendimus, inspicere debemus, aut nihil in illis commodi esse aut plus incommodi: quaedam supervacua sunt, quaedam tanti non sunt. Sed hoc non pervidemus et gratuita nobis videntur quae carissime constant. Ex eo licet stupor noster appareat, quod ea sola putamus emi pro quibus pecuniam solvimus, ea gratuita vocamus pro quibus nos ipsos inpendimus. Quae emere nollemus si domus nobis nostra pro illis esset danda, si amoenum aliquod fructuosumve praedium, ad ea paratissimi sumus pervenire cum sollicitudine, cum periculo, cum iactura pudoris et libertatis et temporis; adeo nihil est cuique se vilius. Idem itaque in omnibus consiliis rebusque faciamus quod solemus facere quotiens ad institorem alicuius mercis accessimus: videamus hoc quod concupiscimus quanti deferatur. Saepe maximum pretium est pro quo nullum datur. Multa possum tibi ostendere quae adquisita acceptaque libertatem nobis extorserint; nostri essemus, si ista nostra non essent. Haec ergo tecum ipse versa, non solum ubi de incremento agetur, sed etiam ubi de iactura. «Hoc periturum est». Nempe adventicium fuit; tam facile sine isto vives quam vixisti. Si diu illud habuisti, perdis postquam satiatus es; si non diu, perdis antequam adsuescas. «Pecuniam minorem habebis». Nempe et molestiam. «Gratiam minorem». Nempe et invidiam. Circumspice ista quae nos agunt in insaniam, quae cum plurimis lacrimis amittimus: scies non damnum in iis molestum esse, sed opinionem damni. Nemo illa perisse sentit sed cogitat. Qui se habet nihil perdidit: sed quoto cuique habere se contigit? Vale.
43. Quomodo hoc ad me pervenerit quaeris, quis mihi id te cogitare narraverit quod tu nulli narraveras? Is qui scit plurimum, rumor. «Quid ergo?» inquis «tantus sum ut possim excitare rumorem?» Non est quod te ad hunc locum respiciens metiaris: ad istum respice in quo moraris. Quidquid inter vicina eminet magnum est illic ubi eminet; nam magnitudo non habet modum certum: comparatio illam aut tollit aut deprimit. Navis quae in flumine magna est in mari parvula est; gubernaculum quod alteri navi magnum alteri exiguum est. Tu nunc in provincia, licet contemnas ipse te, magnus es. Quid agas, quemadmodum cenes, quemadmodum dormias, quaeritur, scitur: eo tibi diligentius vivendum est. Tunc autem felicem esse te iudica cum poteris in publico vivere, cum te parietes tui tegent, non abscondent, quos plerumque circumdatos nobis iudicamus non ut tutius vivamus, sed ut peccemus occultius. Rem dicam ex qua mores aestimes nostros: vix quemquam invenies qui possit aperto ostio vivere. Ianitores conscientia nostra, non superbia opposuit: sic vivimus ut deprendi sit subito aspici. Quid autem prodest recondere se et oculos hominum auresque vitare? Bona conscientia turbam advocat, mala etiam in solitudine anxia atque sollicita est. Si honesta sunt quae facis, omnes sciant; si turpia, quid refert neminem scire cum tu scias? O te miserum si contemnis hunc testem! Vale. 44. Iterum tu mihi te pusillum facis et dicis malignius tecum egisse naturam prius, deinde fortunam, cum possis eximere te vulgo et ad felicitatem hominum maximam emergere. Si quid est aliud in philosophia boni, hoc est, quod stemma non inspicit; omnes, si ad originem primam revocantur, a dis sunt. Eques Romanus es, et ad hunc ordinem tua te perduxit industria; at mehercules multis quattuordecim clausa sunt, non omnes curia admittit, castra quoque quos ad laborem et periculum recipiant fastidiose legunt: bona mens omnibus patet, omnes ad hoc sumus nobiles. Nec reicit quemquam philosophia nec eligit: omnibus lucet. Patricius Socrates non fuit; Cleanthes aquam traxit et rigando horto locavit manus; Platonem non accepit nobilem philosophia sed fecit: quid est quare desperes his te posse fieri parem? Omnes hi maiores tui sunt, si te illis geris dignum; geres autem, si hoc protinus tibi ipse persuaseris, a nullo te nobilitate superari. Omnibus nobis totidem ante nos sunt; nullius non origo ultra memoriam iacet. Platon ait neminem regem non ex servis esse oriundum, neminem non servum ex regibus. Omnia ista longa varietas miscuit et sursum deorsum fortuna versavit. Quis est generosus? Ad virtutem bene a natura compositus. Hoc unum intuendum est: alioquin si ad vetera revocas, nemo non inde est ante quod nihil est. A primo mundi ortu usque in hoc tempus perduxit nos ex splendidis sordidisque alternata series. Non facit nobilem atrium plenum fumosis imaginibus; nemo in nostram gloriam vixit nec quod ante nos fuit nostrum est: animus facit nobilem, cui ex quacumque condicione supra fortunam licet surgere. Puta itaque te non equitem Romanum esse sed libertinum: potes hoc consequi, ut solus sis liber inter ingenuos. «Quomodo?» inquis. Si mala bonaque
non populo auctore distinxeris. Intuendum est non unde veniant, sed quo eant. Si quid est quod vitam beatam potest facere, id bonum est suo iure; depravari enim in malum non potest. Quid est ergo in quo erratur, cum omnes beatam vitam optent? Quod instrumenta eius pro ipsa habent et illam dum petunt fugiunt. Nam cum summa vitae beatae sit solida securitas et eius inconcussa fiducia, sollicitudinis colligunt causas et per insidiosum iter vitae non tantum ferunt sarcinas sed trahunt; ita longius ab effectu eius quod petunt semper abscedunt et quo plus operae inpenderunt, hoc se magis inpediunt et feruntur retro. Quod evenit in labyrintho properantibus: ipsa illos velocitas inplicat. Vale. 45. Librorum istic inopiam esse quereris. Non refert quam multos sed quam bonos habeas: lectio certa prodest, varia delectat. Qui quo destinavit pervenire vult unam sequatur viam, non per multas vagetur: non ire istuc sed errare est. «Vellem» inquis «non magis consilium mihi quam libros dares». Ego vero quoscumque habeo mittere paratus sum et totum horreum excutere; me quoque isto, si possem, transferrem, et nisi mature te finem officii sperarem inpetraturum, hanc senilem expeditionem indixissem mihi nec me Charybdis et Scylla et fabulosum istud fretum deterrere potuissent. Tranassem ista, non solum traiecissem, dummodo te conplecti possem et praesens aestimare quantum animo crevisses. Ceterum quod libros meos tibi mitti desideras, non magis ideo me disertum puto quam formonsum putarem si imaginem meam peteres. Indulgentiae scio istud esse, non iudici; et si modo iudici est, indulgentia tibi inposuit. Sed qualescumque sunt, tu illos sic lege tamquam verum quaeram adhuc, non sciam, et contumaciter quaeram. Non enim me cuiquam emancipavi, nullius nomen fero; multum magnorum virorum iudicio credo, aliquid et meo vindico. Nam illi quoque non inventa sed quaerenda nobis reliquerunt, et invenissent forsitan necessaria nisi et supervacua quaesissent. Multum illis temporis verborum cavillatio eripuit, captiosae disputationes quae acumen inritum exercent. Nectimus nodos et ambiguam significationem verbis inligamus ac deinde dissolvimus: tantum nobis vacat? Iam vivere, iam mori scimus? Tota illo mente pergendum est ubi provideri debet ne res nos, non verba decipiant. Quid mihi vocum similitudines distinguis, quibus nemo umquam nisi dum disputat captus est? Res fallunt: illas discerne. Pro bonis mala amplectimur; optamus contra id quod optavimus; pugnant vota nostra cum votis, consilia cum consilis. Adulatio quam similis est amicitiae! Non imitatur tantum illam sed vincit et praeterit; apertis ac propitiis auribus recipitur et in praecordia ima descendit, eo ipso gratiosa quo laedit: doce quemadmodum hanc similitudinem possim dinoscere. Venit ad me pro amico blandus inimicus; vitia nobis sub virtutum nomine obrepunt: temeritas sub titulo fortitudinis latet, moderatio vocatur ignavia, pro cauto timidus accipitur. In his magno periculo erramus: his certas notas inprime. Ceterum qui interrogatur an cornua habeat non est tam stultus ut frontem suam temptet, nec rursus tam ineptus aut hebes ut nesciat nisi tu illi subtilissima
collectione persuaseris. Sic ista sine noxa decipiunt quomodo praestigiatorum acetabula et calculi, in quibus me fallacia ipsa delectat. Effice ut quomodo fiat intellegam: perdidi lusum. Idem de istis captionibus dico (quo enim nomine potius sophismata appellem?): nec ignoranti nocent nec scientem iuvant. Si utique vis verborum ambiguitates diducere, hoc nos doce, beatum non eum esse quem vulgus appellat, ad quem pecunia magna confluxit, sed illum cui bonum omne in animo est, erectum et excelsum et mirabilia calcantem, qui neminem videt cum quo se commutatum velit, qui hominem ea sola parte aestimat qua homo est, qui natura magistra utitur, ad illius leges componitur, sic vivit quomodo illa praescripsit; cui bona sua nulla vis excutit, qui mala in bonum vertit, certus iudicii, inconcussus, intrepidus; quem aliqua vis movet, nulla perturbat; quem fortuna, cum quod habuit telum nocentissimum vi maxima intorsit, pungit, non vulnerat, et hoc raro; nam cetera eius tela, quibus genus humanum debellatur, grandinis more dissultant, quae incussa tectis sine ullo habitatoris incommodo crepitat ac solvitur. Quid me detines in eo quem tu ipse pseudomenon appellas, de quo tantum librorum compositum est? Ecce tota mihi vita mentitur: hanc coargue, hanc ad verum, si acutus es, redige. Necessaria iudicat quorum magna pars supervacua est; etiam quae non est supervacua nihil in se momenti habet in hoc, ut possit fortunatum beatumque praestare. Non enim statim bonum est, si quid necessarium est: aut proicimus bonum, si hoc nomen pani et polentae damus et ceteris sine quibus vita non ducitur. Quod bonum est utique necessarium est: quod necessarium est non utique bonum est, quoniam quidem necessaria sunt quaedam eademque vilissima. Nemo usque eo dignitatem boni ignorat ut illud ad haec in diem utilia demittat. Quid ergo? Non eo potius curam transferes, ut ostendas omnibus magno temporis inpendio quaeri supervacua et multos transisse vitam dum vitae instrumenta conquirunt? Recognosce singulos, considera universos: nullius non vita spectat in crastinum. Quid in hoc sit mali quaeris? Infinitum. Non enim vivunt sed victuri sunt: omnia differunt. Etiamsi adtenderemus, tamen nos vita praecurreret; nunc vero cunctantes quasi aliena transcurrit et ultimo die finitur, omni perit. Sed ne epistulae modum excedam, quae non debet sinistram manum legentis inplere, in alium diem hanc litem cum dialecticis differam nimium subtilibus et hoc solum curantibus, non et hoc. Vale. 46. Librum tuum quem mihi promiseras accepi et tamquam lecturus ex commodo adaperui ac tantum degustare volui; deinde blanditus est ipse ut procederem longius. Qui quam disertus fuerit ex hoc intellegas licet: levis mihi visus est, cum esset nec mei nec tui corporis, sed qui primo aspectu aut Titi Livii aut Epicuri posset videri. Tanta autem dulcedine me tenuit et traxit ut illum sine ulla dilatione perlegerim. Sol me invitabat, fames admonebat, nubes minabantur; tamen exhausi totum. Non tantum delectatus sed gavisus sum. Quid ingenii iste habuit, quid animi! Dicerem «quid impetus!», si interquievisset, si ex intervallo surrexisset; nunc non fuit impetus sed tenor. Compositio virilis et sancta;
nihilominus interveniebat dulce illud et loco lene. Grandis, erectus es: hoc te volo tenere, sic ire. Fecit aliquid et materia; ideo eligenda est fertilis, quae capiat ingenium, quae incitet. De libro plura scribam cum illum retractavero; nunc parum mihi sedet iudicium, tamquam audierim illa, non legerim. Sine me et inquirere. Non est quod verearis: verum audies. O te hominem felicem, quod nihil habes propter quod quisquam tibi tam longe mentiatur! nisi quod iam etiam ubi causa sublata est mentimur consuetudinis causa. Vale. 47. Libenter ex iis qui a te veniunt cognovi familiariter te cum servis tuis vivere: hoc prudentiam tuam, hoc eruditionem decet. «Servi sunt». Immo homines. «Servi sunt». Immo contubernales. «Servi sunt». Immo humiles amici. «Servi sunt». Immo conservi, si cogitaveris tantundem in utrosque licere fortunae. Itaque rideo istos qui turpe existimant cum servo suo cenare: quare, nisi quia superbissima consuetudo cenanti domino stantium servorum turbam circumdedit? Est ille plus quam capit, et ingenti aviditate onerat distentum ventrem ac desuetum iam ventris officio, ut maiore opera omnia egerat quam ingessit. At infelicibus servis movere labra ne in hoc quidem, ut loquantur, licet; virga murmur omne conpescitur, et ne fortuita quidem verberibus excepta sunt, tussis, sternumenta, singultus; magno malo ulla voce interpellatum silentium luitur; nocte tota ieiuni mutique perstant. Sic fit ut isti de domino loquantur quibus coram domino loqui non licet. At illi quibus non tantum coram dominis sed cum ipsis erat sermo, quorum os non consuebatur, parati erant pro domino porrigere cervicem, periculum inminens in caput suum avertere; in conviviis loquebantur, sed in tormentis tacebant. Deinde eiusdem adrogantiae proverbium iactatur, totidem hostes esse quot servos: non habemus illos hostes sed facimus. Alia interim crudelia, inhumana praetereo, quod ne tamquam hominibus quidem sed tamquam iumentis abutimur. Cum ad cenandum discubuimus, alius sputa deterget, alius reliquias temulentorum toro subditus colligit. Alius pretiosas aves scindit; per pectus et clunes certis ductibus circumferens eruditam manum frusta excutit, infelix, qui huic uni rei vivit, ut altilia decenter secet, nisi quod miserior est qui hoc voluptatis causa docet quam qui necessitatis discit. Alius vini minister in muliebrem modum ornatus cum aetate luctatur: non potest effugere pueritiam, retrahitur, iamque militari habitu glaber retritis pilis aut penitus evulsis tota nocte pervigilat, quam inter ebrietatem domini ac libidinem dividit et in cubiculo vir, in convivio puer est. Alius, cui convivarum censura permissa est, perstat infelix et expectat quos adulatio et intemperantia aut gulae aut linguae revocet in crastinum. Adice obsonatores quibus dominici palati notitia subtilis est, qui sciunt cuius illum rei sapor excitet, cuius delectet aspectus, cuius novitate nauseabundus erigi possit, quid iam ipsa satietate fastidiat, quid illo die esuriat. Cum his cenare non sustinet et maiestatis suae deminutionem putat ad eandem mensam cum servo suo accedere. Di melius! quot ex istis dominos habet! Stare ante limen Callisti dominum suum vidi et eum qui illi inpegerat titulum, qui inter
reicula manicipia produxerat, aliis intrantibus excludi. Rettulit illi gratiam servus ille in primam decuriam coniectus, in qua vocem praeco experitur: et ipse illum invicem apologavit, et ipse non iudicavit domo sua dignum. Dominus Callistum vendidit: sed domino quam multa Callistus! Vis tu cogitare istum quem servum tuum vocas ex isdem seminibus ortum eodem frui caelo, aeque spirare, aeque vivere, aeque mori! tam tu illum videre ingenuum potes quam ille te servum. Variana clade multos splendidissime natos, senatorium per militiam auspicantes gradum, fortuna depressit: alium ex illis pastorem, alium custodem casae fecit. Contemne nunc eius fortunae hominem in quam transire dum contemnis potes. Nolo in ingentem me locum inmittere et de usu servorum disputare, in quos superbissimi, crudelissimi, contumeliosissimi sumus. Haec tamen praecepti mei summa est: sic cum inferiore vivas quemadmodum tecum superiorem velis vivere. Quotiens in mentem venerit quantum tibi in servum tuum liceat, veniat in mentem tantundem in te domino tuo licere. «At ego» inquis «nullum habeo dominum». Bona aetas est: forsitan habebis. Nescis qua aetate Hecuba servire coeperit, qua Croesus, qua Darei mater, qua Platon, qua Diogenes? Vive cum servo clementer, comiter quoque, et in sermonem illum admitte et in consilium et in convictum. Hoc loco adclamabit mihi tota manus delicatorum «nihil hac re humilius, nihil turpius». Hos ego eosdem deprehendam alienorum servorum osculantes manum. Ne illud quidem videtis, quam omnem invidiam maiores nostri dominis, omnem contumeliam servis detraxerint? Dominum patrem familiae appellaverunt, servos, quod etiam in mimis adhuc durat, familiares; instituerunt diem festum, non quo solo cum servis domini vescerentur, sed quo utique; honores illis in domo gerere, ius dicere permiserunt et domum pusillam rem publicam esse iudicaverunt. «Quid ergo? Omnes servos admovebo mensae meae?». Non magis quam omnes liberos. Erras si existimas me quosdam quasi sordidioris operae reiecturum, ut puta illum mulionem et illum bubulcum. Non ministeriis illos aestimabo sed moribus: sibi quisque dat mores, ministeria casus adsignat. Quidam cenent tecum quia digni sunt, quidam ut sint; si quid enim in illis ex sordida conversatione servile est, honestiorum convictus excutiet. Non est, mi Lucili, quod amicum tantum in foro et in curia quaeras: si diligenter adtenderis, et domi invenies. Saepe bona materia cessat sine artifice: tempta et experire. Quemadmodum stultus est qui equum empturus non ipsum inspicit sed stratum eius ac frenos, sic stultissimus est qui hominem aut ex veste aut ex condicione, quae vestis modo nobis circumdata est, aestimat. «Servus est». Sed fortasse liber animo. «Servus est». Hoc illi nocebit? Ostende quis non sit: alius libidini servit, alius avaritiae, alius ambitioni, omnes spei, omnes timori. Dabo consularem aniculae servientem, dabo ancillulae divitem, ostendam nobilissimos iuvenes mancipia pantomimorum: nulla servitus turpior est quam voluntaria. Quare non est quod fastidiosi isti te deterreant quominus servis tuis hilarem te praestes et non superbe superiorem: colant potius te quam timeant.
Dicet aliquis nunc me vocare ad pilleum servos et dominos de fastigio suo deicere, quod dixi, «colant potius dominum quam timeant». «Ita» inquit «prorsus? Colant tamquam clientes, tamquam salutatores?» Hoc qui dixerit obliviscetur id dominis parum non esse quod deo sat est. Qui colitur, et amatur: non potest amor cum timore misceri. Rectissime ergo facere te iudico quod timeri a servis tuis non vis, quod verborum castigatione uteris: verberibus muta admonentur. Non quidquid nos offendit et laedit; sed ad rabiem cogunt pervenire deliciae, ut quidquid non ex voluntate respondit iram evocet. Regum nobis induimus animos; nam illi quoque obliti et suarum virium et inbecillitatis alienae sic excandescunt, sic saeviunt, quasi iniuriam acceperint, a cuius rei periculo illos fortunae suae magnitudo tutissimos praestat. Nec hoc ignorant, sed occasionem nocendi captant querendo; acceperunt iniuriam ut facerent. Diutius te morari nolo; non est enim tibi exhortatione opus. Hoc habent inter cetera boni mores: placent sibi, permanent. Levis est malitia, saepe mutatur, non in melius sed in aliud. Vale. 48. Ad epistulam quam mihi ex itinere misisti, tam longam quam ipsum iter fuit, postea rescribam; seducere me debeo et quid suadeam circumspicere. Nam tu quoque, qui consulis, diu an consuleres cogitasti: quanto magis hoc mihi faciendum est, cum longiore mora opus sit ut solvas quaestionem quam ut proponas? Utique cum aliud tibi expediat, aliud mihi. Iterum ego tamquam Epicureus loquor? Mihi vero idem expedit quod tibi: aut non sum amicus, nisi quidquid agitur ad te pertinens meum est. Consortium rerum omnium inter nos facit amicitia; nec secundi quicquam singulis est nec adversi; in commune vivitur. Nec potest quisquam beate degere qui se tantum intuetur, qui omnia ad utilitates suas convertit: alteri vivas oportet, si vis tibi vivere. Haec societas diligenter et sancte observata, quae nos homines hominibus miscet et iudicat aliquod esse commune ius generis humani, plurimum ad illam quoque de qua loquebar interiorem societatem amicitiae colendam proficit; omnia enim cum amico communia habebit qui multa cum homine. Hoc, Lucili virorum optime, mihi ab istis subtilibus praecipi malo, quid amico praestare debeam, quid homini, quam quot modis «amicus» dicatur, et «homo» quam multa significet. In diversum ecce sapientia et stultitia discedunt! cui accedo? In utram ire partem iubes? Illi homo pro amico est, huic amicus non est pro homine; ille amicum sibi parat, hic se amico: tu mihi verba distorques et syllabas digeris. Scilicet nisi interrogationes vaferrimas struxero et conclusione falsa a vero nascens mendacium adstrinxero, non potero a fugiendis petenda secernere. Pudet me: in re tam seria senes ludimus. «Mus syllaba est; mus autem caseum rodit; syllaba ergo caseum rodit». Puta nunc me istuc non posse solvere: quod mihi ex ista inscientia periculum inminet? Quod incommodum? Sine dubio verendum est ne quando in muscipulo syllabas capiam, aut ne quando, si neglegentior fuero, caseum liber comedat. Nisi forte illa acutior est collectio: «mus syllaba est; syllaba autem caseum non rodit; mus
ergo caseum non rodit». O pueriles ineptias! in hoc supercilia subduximus? In hoc barbam demisimus? Hoc est quod tristes docemus et pallidi? Vis scire quid philosophia promittat generi humano? Consilium. Alium mors vocat, alium paupertas urit, alium divitiae vel alienae torquent vel suae; ille malam fortunam horret, hic se felicitati suae subducere cupit; hunc homines male habent, illum dii. Quid mihi lusoria ista componis? Non est iocandi locus: ad miseros advocatus es. Opem laturum te naufragis, captis, aegris, egentibus, intentae securi subiectum praestantibus caput pollicitus es: quo diverteris? Quid agis? Hic cum quo ludis timet: succurre, quidquid †laqueti respondentium poenis†. Omnes undique ad te manus tendunt, perditae vitae perituraeque auxilium aliquod implorant, in te spes opesque sunt; rogant ut ex tanta illos volutatione extrahas, ut disiectis et errantibus clarum veritatis lumen ostendas. Dic quid natura necessarium fecerit, quid supervacuum, quam faciles leges posuerit, quam iucunda sit vita, quam expedita illas sequentibus, quam acerba et inplicita eorum qui opinioni plus quam naturae crediderunt * * * si prius docueris quam partem eorum levatura sint. Quid istorum cupiditates demit? Quid temperat? Utinam tantum non prodessent! nocent. Hoc tibi cum voles manifestissimum faciam, comminui et debilitari generosam indolem in istas argutias coniectam. Pudet dicere contra fortunam militaturis quae porrigant tela, quemadmodum illos subornent. Hac ad summum bonum itur? Per istud philosophiae «sive nive» et turpes infamesque etiam ad album sedentibus exceptiones? Quid enim aliud agitis, cum eum quem interrogatis scientes in fraudem inducitis, quam ut formula cecidisse videatur? Sed quemadmodum illos praetor, sic hos philosophia in integrum restituit. Quid disceditis ab ingentibus promissis et grandia locuti, effecturos vos ut non magis auri fulgor quam gladii praestringat oculos meos, ut ingenti constantia et quod omnes optant et quod omnes timent calcem, ad grammaticorum elementa descenditis? Quid dicitis? sic itur ad astra? Hoc enim est quod mihi philosophia promittit, ut parem deo faciat; ad hoc invitatus sum, ad hoc veni: fidem praesta. Quantum potes ergo, mi Lucili, reduc te ab istis exceptionibus et praescriptionibus philosophorum: aperta decent et simplicia bonitatem. Etiam si multum superesset aetatis, parce dispensandum erat ut sufficeret necessariis: nunc quae dementia est supervacua discere in tanta temporis egestate! Vale. 49. Est quidem, mi Lucili, supinus et neglegens qui in amici memoriam ab aliqua regione admonitus reducitur; tamen repositum in animo nostro desiderium loca interdum familiaria evocant, nec extinctam memoriam reddunt sed quiescentem inritant, sicut dolorem lugentium, etiam si mitigatus est tempore, aut servulus familiaris amisso aut vestis aut domus renovat. Ecce Campania et maxime Neapolis ac Pompeiorum tuorum conspectus incredibile est quam recens
desiderium tui fecerint: totus mihi in oculis es. Cum maxime a te discedo; video lacrimas conbibentem et adfectibus tuis inter ipsam coercitionem exeuntibus non satis resistentem. Modo amisisse te videor; quid enim non «modo» est, si recorderis? Modo apud Sotionem philosophum puer sedi, modo causas agere coepi, modo desii velle agere, modo desii posse. Infinita est velocitas temporis, quae magis apparet respicientibus. Nam ad praesentia intentos fallit; adeo praecipitis fugae transitus lenis est. Causam huius rei quaeris? Quidquid temporis transit eodem loco est; pariter aspicitur, una iacet; omnia in idem profundum cadunt. Et alioqui non possunt longa intervalla esse in ea re quae tota brevis est. Punctum est quod vivimus et adhuc puncto minus; sed et hoc minimum specie quadam longioris spatii natura derisit: aliud ex hoc infantiam fecit, aliud pueritiam, aliud adulescentiam, aliud inclinationem quandam ab adulescentia ad senectutem, aliud ipsam senectutem. In quam angusto quodam quot gradus posuit! Modo te prosecutus sum; et tamen hoc «modo» aetatis nostrae bona portio est, cuius brevitatem aliquando defecturam cogitemus. Non solebat mihi tam velox tempus videri: nunc incredibilis cursus apparet, sive quia admoveri lineas sentio, sive quia adtendere coepi et conputare damnum meum. Eo magis itaque indignor aliquos ex hoc tempore quod sufficere ne ad necessaria quidem potest, etiam si custoditum diligentissime fuerit, in supervacua maiorem partem erogare. Negat Cicero, si duplicetur sibi aetas, habiturum se tempus quo legat lyricos: eodem loco pono dialecticos: tristius inepti sunt. Illi ex professo lasciviunt, hi agere ipsos aliquid existimant. Nec ego nego prospicienda ista, sed prospicienda tantum et a limine salutanda, in hoc unum, ne verba nobis dentur et aliquid esse in illis magni ac secreti boni iudicemus. Quid te torques et maceras in ea quaestione quam subtilius est contempsisse quam solvere? Securi est et ex commodo migrantis minuta conquirere: cum hostis instat a tergo et movere se iussus est miles, necessitas excutit quidquid pax otiosa collegerat. Non vacat mihi verba dubie cadentia consectari et vafritiam in illis meam experiri. Aspice qui coeant populi, quae moenia clusis ferrum acuant portis. Magno mihi animo strepitus iste belli circumsonantis exaudiendus est. Demens omnibus merito viderer, si cum saxa in munimentum murorum senes feminaeque congererent, cum iuventus intra portas armata signum eruptionis expectaret aut posceret, cum hostilia in portis tela vibrarent et ipsum solum suffossionibus et cuniculis tremeret, sederem otiosus et eiusmodi quaestiunculas ponens: «quod non perdidisti habes; cornua autem non perdidisti; cornua ergo habes» aliaque ad exemplum huius acutae delirationis concinnata. Atqui aeque licet tibi demens videar si istis inpendero operam: et nunc obsideor. Tunc tamen periculum mihi obsesso externum inmineret, murus me ab hoste secerneret: nunc
mortifera mecum sunt. Non vaco ad istas ineptias; ingens negotium in manibus est. Quid agam? Mors me sequitur, fugit vita. Adversus haec me doce aliquid; effice ut ego mortem non fugiam, vita me non effugiat. Exhortare adversus difficilia, adversus inevitabilia; angustias temporis mei laxa. Doce non esse positum bonum vitae in spatio eius sed in usu, posse fieri, immo saepissime fieri, ut qui diu vixit parum vixerit. Dic mihi dormituro «potes non expergisci»; dic experrecto «potes non dormire amplius». Dic exeunti «potes non reverti»; dic redeunti «potes non exire». Erras si in navigatione tantum existimas minimum esse quo a morte vita diducitur: in omni loco aeque tenue intervallum est. Non ubique se mors tam prope ostendit: ubique tam prope est. Has tenebras discute, et facilius ea trades ad quae praeparatus sum. Dociles natura nos edidit, et rationem dedit inperfectam, sed quae perfici posset. De iustitia mihi, de pietate disputa, de frugalitate, de pudicitia utraque, et illa cui alieni corporis abstinentia est, et hac cui sui cura. Si me nolueris per devia ducere, facilius ad id quo tendo perveniam; nam, ut ait ille tragicus, «veritatis simplex oratio est», ideoque illam inplicari non oportet; nec enim quicquam minus convenit quam subdola ista calliditas animis magna conantibus. Vale. 50. Epistulam tuam accepi post multos menses quam miseras; supervacuum itaque putavi ab eo qui adferebat quid ageres quaerere. Valde enim bonae memoriae est, si meminit; et tamen spero te sic iam vivere ut, ubicumque eris, sciam quid agas. Quid enim aliud agis quam ut meliorem te ipse cotidie facias, ut aliquid ex erroribus ponas, ut intellegas tua vitia esse quae putas rerum? Quaedam enim locis et temporibus adscribimus; at illa, quocumque transierimus, secutura sunt. Harpasten, uxoris meae fatuam, scis hereditarium onus in domo mea remansisse. Ipse enim aversissimus ab istis prodigiis sum; si quando fatuo delectari volo, non est mihi longe quaerendus: me rideo. Haec fatua subito desiit videre. Incredibilem rem tibi narro, sed veram: nescit esse se caecam; subinde paedagogum suum rogat ut migret, ait domum tenebricosam esse. Hoc quod in illa ridemus omnibus nobis accidere liqueat tibi: nemo se avarum esse intellegit, nemo cupidum. Caeci tamen ducem quaerunt, nos sine duce erramus et dicimus, «non ego ambitiosus sum, sed nemo aliter Romae potest vivere; non ego sumptuosus sum, sed urbs ipsa magnas inpensas exigit; non est meum vitium quod iracundus sum, quod nondum constitui certum genus vitae: adulescentia haec facit». Quid nos decipimus? Non est extrinsecus malum nostrum: intra nos est, in visceribus ipsis sedet, et ideo difficulter ad sanitatem pervenimus quia nos aegrotare nescimus. Si curari coeperimus, quando tot morborum tantas vires discutiemus? Nunc vero ne quaerimus quidem medicum, qui minus negotii haberet si adhiberetur ad recens vitium; sequerentur teneri et rudes animi recta monstrantem. Nemo difficulter ad naturam reducitur nisi qui ab illa defecit: erubescimus discere bonam mentem. At mehercules, si turpe est magistrum huius rei quaerere, illud desperandum est, posse nobis casu tantum bonum influere:
laborandum est et, ut verum dicam, ne labor quidem magnus est, si modo, ut dixi, ante animum nostrum formare incipimus et recorrigere quam indurescat pravitas eius. Sed nec indurata despero: nihil est quod non expugnet pertinax opera et intenta ac diligens cura. Robora in rectum quamvis flexa revocabis; curvatas trabes calor explicat et aliter natae in id finguntur quod usus noster exigit: quanto facilius animus accipit formam, flexibilis et omni umore obsequentior! Quid enim est aliud animus quam quodam modo se habens spiritus? Vides autem tanto spiritum esse faciliorem omni alia materia quanto tenuior est. Illud, mi Lucili, non est quod te inpediat quominus de nobis bene speres, quod malitia nos iam tenet, quod diu in possessione nostri est: ad neminem ante bona mens venit quam mala; omnes praeoccupati sumus; virtutes discere vitia dediscere est. Sed eo maiore animo ad emendationem nostri debemus accedere quod semel traditi nobis boni perpetua possessio est; non dediscitur virtus. Contraria enim male in alieno haerent, ideo depelli et exturbari possunt; fideliter sedent quae in locum suum veniunt. Virtus secundum naturam est, vitia inimica et infesta sunt. Sed quemadmodum virtutes receptae exire non possunt facilisque earum tutela est, ita initium ad illas eundi arduum, quia hoc proprium inbecillae mentis atque aegrae est, formidare inexperta; itaque cogenda est ut incipiat. Deinde non est acerba medicina; protinus enim delectat, dum sanat. Aliorum remediorum post sanitatem voluptas est, philosophia pariter et salutaris et dulcis est. Vale. 51. Quomodo quisque potest, mi Lucili: tu istic habes Aetnam, †et illuc† nobilissimum Siciliae montem (quem quare dixerit Messala unicum, sive Valgius – apud utrumque enim legi – non reperio, cum plurima loca evomant ignem, non tantum edita, quod crebrius evenit, videlicet quia ignis in altissimum effertur, sed etiam iacentia), nos, utcumque possumus, contenti sumus Bais; quas postero die quam attigeram reliqui, locum ob hoc devitandum, cum habeat quasdam naturales dotes, quia illum sibi celebrandum luxuria desumpsit. «Quid ergo? Ulli loco indicendum est odium?». Minime; sed quemadmodum aliqua vestis sapienti ac probo viro magis convenit quam aliqua, nec ullum colorem ille odit sed aliquem parum putat aptum esse frugalitatem professo, sic regio quoque est quam sapiens vir aut ad sapientiam tendens declinet tamquam alienam bonis moribus. Itaque de secessu cogitans numquam Canopum eliget, quamvis neminem Canopus esse frugi vetet, ne Baias quidem: deversorium vitiorum esse coeperunt. Illic sibi plurimum luxuria permittit, illic, tamquam aliqua licentia debeatur loco, magis solvitur. Non tantum corpori sed etiam moribus salubrem locum eligere debemus; quemadmodum inter tortores habitare nolim, sic ne inter popinas quidem. Videre ebrios per litora errantes et comessationes navigantium et symphoniarum cantibus strepentes lacus et alia quae velut soluta legibus luxuria non tantum peccat sed publicat, quid necesse est? Id agere debemus ut inritamenta vitiorum quam longissime profugiamus; indurandus est animus et a blandimentis voluptatum procul abstrahendus. Una Hannibalem hiberna solverunt et indomitum illum nivibus atque Alpibus virum enervaverunt fomenta Campaniae: armis vicit, vitiis
victus est. Nobis quoque militandum est, et quidem genere militiae quo numquam quies, numquam otium datur: debellandae sunt in primis voluptates, quae, ut vides, saeva quoque ad se ingenia rapuerunt. Si quis sibi proposuerit quantum operis adgressus sit, sciet nihil delicate, nihil molliter esse faciendum. Quid mihi cum istis calentibus stagnis? Quid cum sudatoriis, in quae siccus vapor corpora exhausurus includitur? Omnis sudor per laborem exeat. Si faceremus quod fecit Hannibal, ut interrupto cursu rerum omissoque bello fovendis corporibus operam daremus, nemo non intempestivam desidiam, victori quoque, nedum vincenti, periculosam, merito reprehenderet: minus nobis quam illis Punica signa sequentibus licet, plus periculi restat cedentibus, plus operis etiam perseverantibus. Fortuna mecum bellum gerit: non sum imperata facturus; iugum non recipio, immo, quod maiore virtute faciendum est, excutio. Non est emolliendus animus: si voluptati cessero, cedendum est dolori, cedendum est labori, cedendum est paupertati; idem sibi in me iuris esse volet et ambitio et ira; inter tot adfectus distrahar, immo discerpar. Libertas proposita est; ad hoc praemium laboratur. Quae sit libertas quaeris? Nulli rei servire, nulli necessitati, nullis casibus, fortunam in aequum deducere. Quo die illam intellexero plus posse, nil poterit: ego illam feram, cum in manu mors sit? His cogitationibus intentum loca seria sanctaque eligere oportet; effeminat animos amoenitas nimia, nec dubie aliquid ad corrumpendum vigorem potest regio. Quamlibet viam iumenta patiuntur quorum durata in aspero ungula est: in molli palustrique pascuo saginata cito subteruntur. Et fortior miles ex confragoso venit: segnis est urbanus et verna. Nullum laborem recusant manus quae ad arma ab aratro transferuntur: in primo deficit pulvere ille unctus et nitidus. Severior loci disciplina firmat ingenium aptumque magnis conatibus reddit. Literni honestius Scipio quam Bais exulabat: ruina eiusmodi non est tam molliter conlocanda. Illi quoque ad quos primos fortuna populi Romani publicas opes transtulit, C. Marius et Cn. Pompeius et Caesar, exstruxerunt quidem villas in regione Baiana, sed illas inposuerunt summis iugis montium: videbatur hoc magis militare, ex edito speculari late longeque subiecta. Aspice quam positionem elegerint, quibus aedificia excitaverint locis et qualia: scies non villas esse sed castra. Habitaturum tu putas umquam fuisse illic M. Catonem, ut praenavigantes adulteras dinumeraret et tot genera cumbarum variis coloribus picta et fluvitantem toto lacu rosam, ut audiret canentium nocturna convicia? Nonne ille manere intra vallum maluisset, quod in unam noctem manu sua ipse duxisset? Quidni mallet, quisquis vir est, somnum suum classico quam symphonia rumpi? Sed satis diu cum Bais litigavimus, numquam satis cum vitiis, quae, oro te, Lucili, persequere sine modo, sine fine; nam illis quoque nec finis est nec modus. Proice quaecumque cor tuum laniant, quae si aliter extrahi nequirent, cor ipsum cum illis revellendum erat. Voluptates praecipue exturba et invisissimas habe: latronum more, quos filhvta" Aegyptii vocant, in hoc nos amplectuntur, ut strangulent. Vale.
52. Quid est hoc, Lucili, quod nos alio tendentes alio trahit et eo unde recedere cupimus inpellit? Quid conluctatur cum animo nostro nec permittit nobis quicquam semel velle? Fluctuamur inter varia consilia; nihil libere volumus, nihil absolute, nihil semper. «Stultitia» inquis «est cui nihil constat, nihil diu placet». Sed quomodo nos aut quando ab illa revellemus? Nemo per se satis valet ut emergat; oportet manum aliquis porrigat, aliquis educat. Quosdam ait Epicurus ad veritatem sine ullius adiutorio exisse, fecisse sibi ipsos viam; hos maxime laudat quibus ex se impetus fuit, qui se ipsi protulerunt: quosdam indigere ope aliena, non ituros si nemo praecesserit, sed bene secuturos. Ex his Metrodorum ait esse; egregium hoc quoque, sed secundae sortis ingenium. Nos ex illa prima nota non sumus; bene nobiscum agitur, si in secundam recipimur. Ne hunc quidem contempseris hominem qui alieno beneficio esse salvus potest; et hoc multum est, velle servari. Praeter haec adhuc invenies genus aliud hominum ne ipsum quidem fastidiendum eorum qui cogi ad rectum conpellique possunt, quibus non duce tantum opus sit sed adiutore et, ut ita dicam, coactore; hic tertius color est. Si quaeris huius quoque exemplar, Hermarchum ait Epicurus talem fuisse. Itaque alteri magis gratulatur, alterum magis suspicit; quamvis enim ad eundem finem uterque pervenerit, tamen maior est laus idem effecisse in difficiliore materia. Puta enim duo aedificia excitata esse, ambo paria, aeque excelsa atque magnifica. Alter puram aream accepit, illic protinus opus crevit; alterum fundamenta lassarunt in mollem et fluvidam humum missa multumque laboris exhaustum est dum pervenitur ad solidum: intuentibus quidquid fecit alter alterius magna pars et difficilior latet. Quaedam ingenia facilia, expedita, quaedam manu, quod aiunt, facienda sunt et in fundamentis suis occupata. Itaque illum ego feliciorem dixerim qui nihil negotii secum habuit, hunc quidem melius de se meruisse qui malignitatem naturae suae vicit et ad sapientiam se non perduxit sed extraxit. Hoc durum ac laboriosum ingenium nobis datum scias licet; imus per obstantia. Itaque pugnemus, aliquorum invocemus auxilium. «Quem» inquis «invocabo? Hunc aut illum?». Tu vero etiam ad priores revertere, qui vacant; adiuvare nos possunt non tantum qui sunt, sed qui fuerunt. Ex his autem qui sunt eligamus non eos qui verba magna celeritate praecipitant et communes locos volvunt et in privato circulantur, sed eos qui vita docent, qui cum dixerunt quid faciendum sit probant faciendo, qui docent quid vitandum sit nec umquam in eo quod fugiendum dixerunt deprehenduntur; eum elige adiutorem quem magis admireris cum videris quam cum audieris. Nec ideo te prohibuerim hos quoque audire quibus admittere populum ac disserere consuetudo est, si modo hoc proposito in turbam prodeunt, ut meliores fiant faciantque meliores, si non ambitionis hoc causa exercent. Quid enim turpius philosophia captante clamores? Numquid aeger laudat medicum secantem? Tacete, favete et praebete vos curationi; etiam si exclamaveritis, non aliter audiam quam si ad tactum vitiorum vestrorum ingemescatis. Testari vultis adtendere vos moverique rerum magnitudine? Sane liceat: ut quidem iudicetis et feratis de meliore suffragium,
quidni non permittam? Apud Pythagoram discipulis quinque annis tacendum erat: numquid ergo existimas statim illis et loqui et laudare licuisse? Quanta autem dementia eius est quem clamores inperitorum hilarem ex auditorio dimittunt! Quid laetaris quod ab hominibus his laudatus es quos non potes ipse laudare? Disserebat populo Fabianus, sed audiebatur modeste; erumpebat interdum magnus clamor laudantium, sed quem rerum magnitudo evocaverat, non sonus inoffense ac molliter orationis elapsae. Intersit aliquid inter clamorem theatri et scholae: est aliqua et laudandi elegantia. Omnia rerum omnium, si observentur, indicia sunt, et argumentum morum ex minimis quoque licet capere: inpudicum et incessus ostendit et manus mota et unum interdum responsum et relatus ad caput digitus et flexus oculorum; inprobum risus, insanum vultus habitusque demonstrat. Illa enim in apertum per notas exeunt: qualis quisque sit scies, si quemadmodum laudet, quemadmodum laudetur aspexeris. Hinc atque illinc philosopho manus auditor intentat et super ipsum caput mirantium turba consistit: non laudatur ille nunc, si intellegis, sed conclamatur. Relinquantur istae voces illis artibus quae propositum habent populo placere: philosophia adoretur. Permittendum erit aliquando iuvenibus sequi impetum animi, tunc autem cum hoc ex impetu facient, cum silentium sibi imperare non poterunt; talis laudatio aliquid exhortationis adfert ipsis audientibus et animos adulescentium exstimulat. At ad rem commoveantur, non ad verba composita; alioquin nocet illis eloquentia, si non rerum cupiditatem facit sed sui. Differam hoc in praesentia; desiderat enim propriam et longam exsecutionem, quemadmodum populo disserendum, quid sibi apud populum permittendum sit, quid populo apud se. Damnum quidem fecisse philosophiam non erit dubium postquam prostituta est; sed potest in penetralibus suis ostendi, si modo non institorem sed antistitem nancta est. Vale.
Liber sextus 53. Quid non potest mihi persuaderi, cui persuasum est ut navigarem? Solvi mari languido; erat sine dubio caelum grave sordidis nubibus, quae fere aut in aquam aut in ventum resolvuntur, sed putavi tam pauca milia a Parthenope tua usque Puteolos subripi posse, quamvis dubio et inpendente caelo. Itaque quo celerius evaderem, protinus per altum ad Nesida derexi praecisurus omnes sinus. Cum iam eo processissem ut mea nihil interesset utrum irem an redirem, primum aequalitas illa quae me corruperat periit; nondum erat tempestas, sed iam inclinatio maris ac subinde crebrior fluctus. Coepi gubernatorem rogare ut me in aliquo litore exponeret: aiebat ille aspera esse et inportuosa nec quicquam se aeque in tempestate timere quam terram. Peius autem vexabar quam ut mihi periculum succurreret; nausia enim me segnis haec et sine exitu torquebat, quae bilem movet nec effundit. Institi itaque gubernatori et illum, vellet nollet, coegi, peteret litus. Cuius ut viciniam attigimus, non expecto ut quicquam ex praeceptis Vergilii fiat, obvertunt pelago proras aut ancora de prora iacitur: memor artificii mei vetus frigidae cultor mitto me in mare, quomodo psychrolutam decet, gausapatus. Quae putas me passum dum per aspera erepo, dum viam quaero, dum facio? Intellexi non inmerito nautis terram timeri. Incredibilia sunt quae tulerim, cum me ferre non possem: illud scito, Ulixem non fuisse tam irato mari natum ut ubique naufragia faceret: nausiator erat. Et ego quocumque navigare debuero vicensimo anno perveniam. Ut primum stomachum, quem scis non cum mari nausiam effugere, collegi, ut corpus unctione recreavi, hoc coepi mecum cogitare, quanta nos vitiorum nostrorum sequeretur oblivio, etiam corporalium, quae subinde admonent sui, nedum illorum quae eo magis latent quo maiora sunt. Levis aliquem motiuncula decipit; sed cum crevit et vera febris exarsit, etiam duro et perpessicio confessionem exprimit. Pedes dolent, articuli punctiunculas sentiunt: adhuc dissimulamus et aut talum extorsisse dicimus nos aut in exercitatione aliqua laborasse. Dubio et incipiente morbo quaeritur nomen, qui ubi ut talaria coepit intendere et utrosque distortos pedes fecit, necesse est podagram fateri. Contra evenit in his morbis quibus adficiuntur animi: quo quis peius se habet, minus sentit. Non est quod mireris, Lucili carissime; nam qui leviter dormit, et species secundum quietem capit et aliquando dormire se dormiens cogitat: gravis sopor etiam somnia extinguit animumque altius mergit quam ut in ullo intellectu sui sit. Quare vitia sua nemo confitetur? Quia etiamnunc in illis est: somnium
narrare vigilantis est, et vitia sua confiteri sanitatis indicium est. Expergiscamur ergo, ut errores nostros coarguere possimus. Sola autem nos philosophia excitabit, sola somnum excutiet gravem: illi te totum dedica. Dignus illa es, illa digna te est: ite in complexum alter alterius. Omnibus aliis rebus te nega, fortiter, aperte; non est quod precario philosopheris. Si aeger esses, curam intermisisses rei familiaris et forensia tibi negotia excidissent nec quemquam tanti putares cui advocatus in remissione descenderes; toto animo id ageres ut quam primum morbo liberareris. Quid ergo? Non et nunc idem facies? Omnia inpedimenta dimitte et vaca bonae menti: nemo ad illam pervenit occupatus. Exercet philosophia regnum suum; dat tempus, non accipit; non est res subsiciva; ordinaria est, domina est, adest et iubet. Alexander cuidam civitati partem agrorum et dimidium rerum omnium promittenti «eo» inquit «proposito in Asiam veni, ut non id acciperem quod dedissetis, sed ut id haberetis quod reliquissem». Idem philosophia rebus omnibus: «non sum hoc tempus acceptura quod vobis superfuerit, sed id vos habebitis quod ipsa reiecero». Totam huc converte mentem, huic adside, hanc cole: ingens intervallum inter te et ceteros fiet; omnes mortales multo antecedes, non multo te dii antecedent. Quaeris quid inter te et illos interfuturum sit? Diutius erunt. At mehercules magni artificis est clusisse totum in exiguo; tantum sapienti sua quantum deo omnis aetas patet. Est aliquid quo sapiens antecedat deum: ille naturae beneficio non timet, suo sapiens. Ecce res magna, habere inbecillitatem hominis, securitatem dei. Incredibilis philosophiae vis est ad omnem fortuitam vim retundendam. Nullum telum in corpore eius sedet; munita est, solida; quaedam defetigat et velut levia tela laxo sinu eludit, quaedam discutit et in eum usque qui miserat respuit. Vale. 54. Longum mihi commeatum dederat mala valetudo; repente me invasit. «Quo genere?» inquis. Prorsus merito interrogas: adeo nullum mihi ignotum est. Uni tamen morbo quasi adsignatus sum, quem quare Graeco nomine appellem nescio; satis enim apte dici suspirium potest. Brevis autem valde et procellae similis est impetus; intra horam fere desinit: quis enim diu exspirat? Omnia corporis aut incommoda aut pericula per me transierunt: nullum mihi videtur molestius. Quidni? Aliud enim quidquid est aegrotare est, hoc animam egerere. Itaque medici hanc «meditationem mortis» vocant; facit enim aliquando spiritus ille quod saepe conatus est. Hilarem me putas haec tibi scribere quia effugi? Tam ridicule facio, si hoc fine quasi bona valetudine delector, quam ille, quisquis vicisse se putat cum vadimonium distulit. Ego vero et in ipsa suffocatione non desii cogitationibus laetis ac fortibus adquiescere. «Quid hoc est?» inquam «tam saepe mors experitur me? Faciat: ego illam diu expertus sum». «Quando?» inquis. Antequam nascerer. Mors est non esse. Id quale sit iam scio: hoc erit post me quod ante me fuit. Si quid in hac re tormenti est, necesse est et fuisse, antequam prodiremus in lucem; atqui nullam sensimus tunc vexationem. Rogo, non stultissimum dicas si quis existimet lucernae peius esse cum extincta est quam antequam accenditur? Nos quoque et
extinguimur et accendimur: medio illo tempore aliquid patimur, utrimque vero alta securitas est. In hoc enim, mi Lucili, nisi fallor, erramus, quod mortem iudicamus sequi, cum illa et praecesserit et secutura sit. Quidquid ante nos fuit mors est; quid enim refert non incipias an desinas, cum utriusque rei hic sit effectus, non esse? His et eiusmodi exhortationibus (tacitis scilicet, nam verbis locus non erat) adloqui me non desii; deinde paulatim suspirium illud, quod esse iam anhelitus coeperat, intervalla maiora fecit et retardatum est. At remansit, nec adhuc, quamvis desierit, ex natura fluit spiritus; sentio haesitationem quandam eius et moram. Quomodo volet, dummodo non ex animo suspirem. Hoc tibi de me recipe: non trepidabo ad extrema, iam praeparatus sum, nihil cogito de die toto. Illum tu lauda et imitare quem non piget mori, cum iuvet vivere: quae est enim virtus, cum eiciaris, exire? Tamen est et hic virtus: eicior quidem, sed tamquam exeam. Et ideo numquam eicitur sapiens quia eici est inde expelli unde invitus recedas: nihil invitus facit sapiens; necessitatem effugit, quia vult quod coactura est. Vale. 55. A gestatione cum maxime venio, non minus fatigatus quam si tantum ambulassem quantum sedi; labor est enim et diu ferri, ac nescio an eo maior quia contra naturam est, quae pedes dedit ut per nos ambularemus, oculos ut per nos videremus. Debilitatem nobis indixere deliciae, et quod diu noluimus posse desimus. Mihi tamen necessarium erat concutere corpus, ut, sive bilis insederat faucibus, discuteretur, sive ipse ex aliqua causa spiritus densior erat, extenuaret illum iactatio, quam profuisse mihi sensi. Ideo diutius vehi perseveravi invitante ipso litore, quod inter Cumas et Servili Vatiae villam curvatur et hinc mari, illinc lacu velut angustum iter cluditur. Erat autem a recenti tempestate spissum; fluctus enim illud, ut scis, frequens et concitatus exaequat, longior tranquillitas solvit, cum harenis, quae umore alligantur, sucus abscessit. Ex consuetudine tamen mea circumspicere coepi an aliquid illic invenirem quod mihi posset bono esse, et derexi oculos in villam quae aliquando Vatiae fuit. In hac ille praetorius dives, nulla alia re quam otio notus, consenuit, et ob hoc unum felix habebatur. Nam quotiens aliquos amicitiae Asinii Galli, quotiens Seiani odium, deinde amor merserat (aeque enim offendisse illum quam amasse periculosum fuit), exclamabant homines, «o Vatia, solus scis vivere». At ille latere sciebat, non vivere; multum autem interest utrum vita tua otiosa sit an ignava. Numquam aliter hanc villam Vatia vivo praeteribam quam ut dicerem, «Vatia hic situs est». Sed adeo, mi Lucili, philosophia sacrum quiddam est et venerabile ut etiam si quid illi simile est mendacio placeat. Otiosum enim hominem seductum existimat vulgus et securum et se contentum, sibi viventem, quorum nihil ulli contingere nisi sapienti potest. Ille solus scit sibi vivere; ille enim, quod est primum, scit vivere. Nam qui res et homines fugit, quem cupiditatum suarum infelicitas relegavit, qui alios feliciores videre non potuit, qui velut timidum atque iners animal metu oblituit, ille sibi non vivit, sed, quod
est turpissimum, ventri, somno, libidini; non continuo sibi vivit qui nemini. Adeo tamen magna res est constantia et in proposito suo perseverantia ut habeat auctoritatem inertia quoque pertinax. De ipsa villa nihil tibi possum certi scribere; frontem enim eius tantum novi et exposita, quae ostendit etiam transeuntibus. Speluncae sunt duae magni operis, cuivis laxo atrio pares, manu factae, quarum altera solem non recipit, altera usque in occidentem tenet. Platanona medius rivus et a mari et ab Acherusio lacu receptus euripi modo dividit, alendis piscibus, etiam si adsidue exhauriatur, sufficiens. Sed illi, cum mare patet, parcitur: cum tempestas piscatoribus dedit ferias, manus ad parata porrigitur. Hoc tamen est commodissimum in villa, quod Baias trans parietem habet: incommodis illarum caret, voluptatibus fruitur. Has laudes eius ipse novi: esse illam totius anni credo; occurrit enim Favonio et illum adeo excipit ut Bais neget. Non stulte videtur elegisse hunc locum Vatia in quem otium suum pigrum iam et senile conferret. Sed non multum ad tranquillitatem locus confert: animus est qui sibi commendet omnia. Vidi ego in villa hilari et amoena maestos, vidi in media solitudine occupatis similes. Quare non est quod existimes ideo parum bene compositum esse te quod in Campania non es. Quare autem non es? Huc usque cogitationes tuas mitte. Conversari cum amicis absentibus licet, et quidem quotiens velis, quamdiu velis. Magis hac voluptate, quae maxima est, fruimur dum absumus; praesentia enim nos delicatos facit, et quia aliquando una loquimur, ambulamus, consedimus, cum diducti sumus nihil de iis quos modo vidimus cogitamus. Et ideo aequo animo ferre debemus absentiam, quia nemo non multum etiam praesentibus abest. Pone hic primum noctes separatas, deinde occupationes utrique diversas, deinde studia secreta, suburbanas profectiones: videbis non multum esse quod nobis peregrinatio eripiat. Amicus animo possidendus est; hic autem numquam abest; quemcumque vult cotidie videt. Itaque mecum stude, mecum cena, mecum ambula: in angusto vivebamus, si quicquam esset cogitationibus clusum. Video te, mi Lucili; cum maxime audio; adeo tecum sum ut dubitem an incipiam non epistulas sed codicellos tibi scribere. Vale. 56. Peream si est tam necessarium quam videtur silentium in studia seposito. Ecce undique me varius clamor circumsonat: supra ipsum balneum habito. Propone nunc tibi omnia genera vocum quae in odium possunt aures adducere: cum fortiores exercentur et manus plumbo graves iactant, cum aut laborant aut laborantem imitantur, gemitus audio, quotiens retentum spiritum remiserunt, sibilos et acerbissimas respirationes; cum in aliquem inertem et hac plebeia unctione contentum incidi, audio crepitum inlisae manus umeris, quae prout plana pervenit aut concava, ita sonum mutat. Si vero pilicrepus supervenit et numerare coepit pilas, actum est. Adice nunc scordalum et furem deprensum et illum cui vox sua in balineo placet, adice nunc eos qui in piscinam cum ingenti inpulsae aquae sono saliunt. Praeter istos quorum, si nihil aliud, rectae voces sunt,
alipilum cogita tenuem et stridulam vocem quo sit notabilior subinde exprimentem nec umquam tacentem nisi dum vellit alas et alium pro se clamare cogit; iam biberari varias exclamationes et botularium et crustularium et omnes popinarum institores mercem sua quadam et insignita modulatione vendentis. «O te» inquis «ferreum aut surdum, cui mens inter tot clamores tam varios, tam dissonos constat, cum Chrysippum nostrum adsidua salutatio perducat ad mortem». At mehercules ego istum fremitum non magis curo quam fluctum aut deiectum aquae, quamvis audiam cuidam genti hanc unam fuisse causam urbem suam transferendi, quod fragorem Nili cadentis ferre non potuit. Magis mihi videtur vox avocare quam crepitus; illa enim animum adducit, hic tantum aures implet ac verberat. In his quae me sine avocatione circumstrepunt essedas transcurrentes pono et fabrum inquilinum et serrarium vicinum, aut hunc qui ad Metam Sudantem tubulas experitur et tibias, nec cantat sed exclamat: etiamnunc molestior est mihi sonus qui intermittitur subinde quam qui continuatur. Sed iam me sic ad omnia ista duravi ut audire vel pausarium possim voce acerbissima remigibus modos dantem. Animum enim cogo sibi intentum esse nec avocari ad externa; omnia licet foris resonent, dum intus nihil tumultus sit, dum inter se non rixentur cupiditas et timor, dum avaritia luxuriaque non dissideant nec altera alteram vexet. Nam quid prodest totius regionis silentium, si adfectus fremunt? Omnia noctis erant placida composta quiete. Falsum est: nulla placida est quies nisi quam ratio composuit; nox exhibet molestiam, non tollit, et sollicitudines mutat. Nam dormientium quoque insomnia tam turbulenta sunt quam dies: illa tranquillitas vera est in quam bona mens explicatur. Aspice illum cui somnus laxae domus silentio quaeritur, cuius aures ne quis agitet sonus, omnis servorum turba conticuit et suspensum accedentium propius vestigium ponitur: huc nempe versatur atque illuc, somnum inter aegritudines levem captans; quae non audit audisse se queritur. Quid in causa putas esse? Animus illi obstrepit. Hic placandus est, huius conpescenda seditio est, quem non est quod existimes placidum, si iacet corpus: interdum quies inquieta est; et ideo ad rerum actus excitandi ac tractatione bonarum artium occupandi sumus, quotiens nos male habet inertia sui inpatiens. Magni imperatores, cum male parere militem vident, aliquo labore conpescunt et expeditionibus detinent: numquam vacat lascivire districtis, nihilque tam certum est quam otii vitia negotio discuti. Saepe videmur taedio rerum civilium et infelicis atque ingratae stationis paenitentia secessisse; tamen in illa latebra in quam nos timor ac lassitudo coniecit interdum recrudescit ambitio. Non enim excisa desit, sed fatigata aut etiam obirata rebus parum sibi cedentibus. Idem de luxuria dico, quae videtur aliquando cessisse, deinde frugalitatem professos sollicitat atque in media parsimonia voluptates non damnatas sed relictas petit, et quidem eo vehementius quo occultius. Omnia enim vitia in aperto leniora sunt; morbi quoque tunc ad sanitatem inclinant cum ex abdito erumpunt ac vim sui
proferunt. Et avaritiam itaque et ambitionem et cetera mala mentis humanae tunc perniciosissima scias esse cum simulata sanitate subsidunt. Otiosi videmur, et non sumus. Nam si bona fide sumus, si receptui cecinimus, si speciosa contempsimus, ut paulo ante dicebam, nulla res nos avocabit, nullus hominum aviumque concentus interrumpet cogitationes bonas, solidasque iam et certas. Leve illud ingenium est nec sese adhuc reduxit introsus quod ad vocem et accidentia erigitur; habet intus aliquid sollicitudinis et habet aliquid concepti pavoris quod illum curiosum facit, ut ait Vergilius noster: et me, quem dudum non ulla iniecta movebant tela neque adverso glomerati ex agmine Grai, nunc omnes terrent aurae, sonus excitat omnis suspensum et pariter comitique onerique timentem. Prior ille sapiens est, quem non tela vibrantia, non arietata inter se arma agminis densi, non urbis inpulsae fragor territat: hic alter inperitus est, rebus suis timet ad omnem crepitum expavescens, quem una quaelibet vox pro fremitu accepta deiecit, quem motus levissimi exanimant; timidum illum sarcinae faciunt. Quemcumque ex istis felicibus elegeris, multa trahentibus, multa portantibus, videbis illum «comitique onerique timentem». Tunc ergo te scito esse compositum cum ad te nullus clamor pertinebit, cum te nulla vox tibi excutiet, non si blandietur, non si minabitur, non si inani sono vana circumstrepet. «Quid ergo? Non aliquando commodius est et carere convicio?». Fateor; itaque ego ex hoc loco migrabo. Experiri et exercere me volui: quid necesse est diutius torqueri, cum tam facile remedium Ulixes sociis etiam adversus Sirenas invenerit? Vale. 57. Cum a Bais deberem Neapolim repetere, facile credidi tempestatem esse, ne iterum navem experirer; et tantum luti tota via fuit ut possim videri nihilominus navigasse. Totum athletarum fatum mihi illo die perpetiendum fuit: a ceromate nos haphe excepit in crypta Neapolitana. Nihil illo carcere longius, nihil illis facibus obscurius, quae nobis praestant non ut per tenebras videamus, sed ut ipsas. Ceterum etiam si locus haberet lucem, pulvis auferret, in aperto quoque res gravis et molesta: quid illic, ubi in se volutatur et, cum sine ullo spiramento sit inclusus, in ipsos a quibus excitatus est recidit? Duo incommoda inter se contraria simul pertulimus: eadem via, eodem die et luto et pulvere laboravimus. Aliquid tamen mihi illa obscuritas quod cogitarem dedit: sensi quendam ictum animi et sine metu mutationem quam insolitae rei novitas simul ac foeditas fecerat. Non de me nunc tecum loquor, qui multum ab homine tolerabili, nedum a perfecto absum, sed de illo in quem fortuna ius perdidit: huius quoque ferietur animus, mutabitur color. Quaedam enim, mi Lucili, nulla effugere virtus potest; admonet illam natura mortalitatis suae. Itaque et vultum adducet ad tristia et inhorrescet ad subita et caligabit, si vastam altitudinem in crepidine eius constitutus despexerit: non est hoc timor, sed naturalis adfectio inexpugnabilis
rationi. Itaque fortes quidam et paratissimi fundere suum sanguinem alienum videre non possunt; quidam ad vulneris novi, quidam ad veteris et purulenti tractationem inspectionemque succidunt ac linquuntur animo; alii gladium facilius recipiunt quam vident. Sensi ergo, ut dicebam, quandam non quidem perturbationem, sed mutationem: rursus ad primum conspectum redditae lucis alacritas rediit incogitata et iniussa. Illud deinde mecum loqui coepi, quam inepte quaedam magis aut minus timeremus, cum omnium idem finis esset. Quid enim interest utrum supra aliquem vigilarium ruat an mons? Nihil invenies. Erunt tamen qui hanc ruinam magis timeant, quamvis utraque mortifera aeque sit; adeo non effectus, sed efficientia timor spectat. Nunc me putas de Stoicis dicere, qui existimant animam hominis magno pondere extriti permanere non posse et statim spargi, quia non fuerit illi exitus liber? Ego vero non facio: qui hoc dicunt videntur mihi errare. Quemadmodum flamma non potest opprimi (nam circa id diffugit quo urgetur), quemadmodum aer verbere atque ictu non laeditur, ne scinditur quidem, sed circa id cui cessit refunditur, sic animus, qui ex tenuissimo constat, deprehendi non potest nec intra corpus effligi, sed beneficio subtilitatis suae per ipsa quibus premitur erumpit. Quomodo fulmini, etiam cum latissime percussit ac fulsit, per exiguum foramen est reditus, sic animo, qui adhuc tenuior est igne, per omne corpus fuga est. Itaque de illo quaerendum est, an possit inmortalis esse. Hoc quidem certum habe: si superstes est corpori, opteri illum nullo genere posse, quoniam nulla inmortalitas cum exceptione est, nec quicquam noxium aeterno est. Vale. 58. Quanta verborum nobis paupertas, immo egestas sit, numquam magis quam hodierno die intellexi. Mille res inciderunt, cum forte de Platone loqueremur, quae nomina desiderarent nec haberent, quaedam vero quae cum habuissent fastidio nostro perdidissent. Quis autem ferat in egestate fastidium? Hunc quem Graeci «oestron» vocant, pecora peragentem et totis saltibus dissipantem, «asilum» nostri vocabant. Hoc Vergilio licet credas: est lucum Silari iuxta ilicibusque virentem plurimus Alburnum volitans, cui nomen asilo Romanum est, oestrum Grai vertere vocantes, asper, acerba sonans, quo tota exterrita silvis diffugiunt armenta. Puto intellegi istud verbum interisse. Ne te longe differam, quaedam simplicia in usu erant, sicut «cernere ferro inter se» dicebant. Idem Vergilius hoc probabit tibi: ingentis, genitos diversis partibus orbis, inter se coiisse viros et cernere ferro.
Quod nunc «decernere» dicimus: simplicis illius verbi usus amissus est. Dicebant antiqui «si iusso», id est «iussero». Hoc nolo mihi credas, sed eidem Vergilio: cetera, qua iusso, mecum manus inferat arma. Non id ago nunc hac diligentia ut ostendam quantum tempus apud grammaticum perdiderim, sed ut ex hoc intellegas quantum apud Ennium et Accium verborum situs occupaverit, cum apud hunc quoque, qui cotidie excutitur, aliqua nobis subducta sint. «Quid sibi» inquis «ista praeparatio vult? Quo spectat?». Non celabo te: cupio, si fieri potest, propitiis auribus tuis «essentiam» dicere; si minus, dicam et iratis. Ciceronem auctorem huius verbi habeo, puto locupletem; si recentiorem quaeris, Fabianum, disertum et elegantem, orationis etiam ad nostrum fastidium nitidae. Quid enim fiet, mi Lucili? Quomodo dicetur oujsiva, res necessaria, natura continens fundamentum omnium? Rogo itaque permittas mihi hoc verbo uti. Nihilominus dabo operam ut ius a te datum parcissime exerceam; fortasse contentus ero mihi licere. Quid proderit facilitas tua, cum ecce id nullo modo Latine exprimere possim propter quod linguae nostrae convicium feci? Magis damnabis angustias Romanas, si scieris unam syllabam esse quam mutare non possum. Quae sit haec quaeris? to; o[n. Duri tibi videor ingenii: in medio positum, posse sic transferri ut dicam «quod est». Sed multum interesse video: cogor verbum pro vocabulo ponere; sed si ita necesse est, ponam «quod est». Sex modis hoc a Platone dici amicus noster, homo eruditissimus, hodierno die dicebat. Omnes tibi exponam, si ante indicavero esse aliquid genus, esse et speciem. Nunc autem primum illud genus quaerimus ex quo ceterae species suspensae sunt, a quo nascitur omnis divisio, quo universa conprensa sunt. Invenietur autem si coeperimus singula retro legere; sic enim perducemur ad primum. Homo species est, ut Aristoteles ait; equus species est; canis species est. Ergo commune aliquod quaerendum est his omnibus vinculum, quod illa conplectatur et sub se habeat. Hoc quid est? Animal. Ergo genus esse coepit horum omnium quae modo rettuli – hominis, equi, canis – animal. Sed quaedam animum habent nec sunt animalia; placet enim satis et arbustis animam inesse; itaque et vivere illa et mori dicimus. Ergo animantia superiorem tenebunt locum, quia et animalia in hac forma sunt et sata. Sed quaedam anima carent, ut saxa; itaque erit aliquid animantibus antiquius, corpus scilicet. Hoc sic dividam ut dicam corpora omnia aut animantia esse aut inanima. Etiamnunc est aliquid superius quam corpus; dicimus enim quaedam corporalia esse, quaedam incorporalia. Quid ergo erit ex quo haec deducantur? Illud cui nomen modo parum proprium inposuimus, «quod est». Sic enim in species secabitur ut dicamus: «quod est» aut corporale est aut incorporale. Hoc ergo est genus primum et antiquissimum et, ut ita dicam, generale; cetera genera quidem sunt, sed specialia. Tamquam homo genus est; habet enim in se nationum species,
Graecos, Romanos, Parthos; colorum, albos, nigros, flavos; habet singulos, Catonem, Ciceronem, Lucretium. Ita qua multa continet, in genus cadit; qua sub alio est, in speciem. Illud genus «quod est» generale supra se nihil habet; initium rerum est; omnia sub illo sunt. Stoici volunt superponere huic etiamnunc aliud genus magis principale; de quo statim dicam, si prius illud genus de quo locutus sum merito primum poni docuero, cum sit rerum omnium capax. «Quod est» in has species divido, ut sint corporalia aut incorporalia; nihil tertium est. Corpus quomodo divido? Ut dicam: aut animantia sunt aut inanima. Rursus animantia quemadmodum divido? Ut dicam: quaedam animum habent, quaedam tantum animam, aut sic: quaedam impetum habent, incedunt, transeunt, quaedam solo adfixa radicibus aluntur, crescunt. Rursus animalia in quas species seco? Aut mortalia sunt aut inmortalia. Primum genus Stoicis quibusdam videtur «quid»; quare videatur subiciam. «In rerum» inquiunt «natura quaedam sunt, quaedam non sunt, et haec autem quae non sunt rerum natura conplectitur, quae animo succurrunt, tamquam Centauri, Gigantes et quidquid aliud falsa cogitatione formatum habere aliquam imaginem coepit, quamvis non habeat substantiam». Nunc ad id quod tibi promisi revertor, quomodo quaecumque sunt in sex modos Plato partiatur. Primum illud «quod est» nec visu nec tactu nec ullo sensu conprenditur: cogitabile est. Quod generaliter est, tamquam homo generalis, sub oculos non venit; sed specialis venit, ut Cicero et Cato. Animal non videtur: cogitatur. Videtur autem species eius, equus et canis. Secundum ex his quae sunt ponit Plato quod eminet et exsuperat omnia; hoc ait per excellentiam esse. Poeta communiter dicitur (omnibus enim versus facientibus hoc nomen est) sed iam apud Graecos in unius notam cessit: Homerum intellegas, cum audieris poetam. Quid ergo hoc est? Deus scilicet, maior ac potentior cunctis. Tertium genus est eorum quae proprie sunt; innumerabilia haec sunt, sed extra nostrum posita conspectum. Quae sint interrogas? Propria Platonis supellex est: «ideas» vocat, ex quibus omnia quaecumque videmus fiunt et ad quas cuncta formantur. Hae inmortales, inmutabiles, inviolabiles sunt. Quid sit idea, id est quid Platoni esse videatur, audi: «idea est eorum quae natura fiunt exemplar aeternum». Adiciam definitioni interpretationem, quo tibi res apertior fiat. Volo imaginem tuam facere. Exemplar picturae te habeo, ex quo capit aliquem habitum mens nostra quem operi suo inponat; ita illa quae me docet et instruit facies, a qua petitur imitatio, idea est. Talia ergo exemplaria infinita habet rerum natura, hominum, piscium, arborum, ad quae quodcumque fieri ab illa debet exprimitur. Quartum locum habebit idos. Quid sit hoc idos adtendas oportet, et Platoni inputes, non mihi, hanc rerum difficultatem; nulla est autem sine difficultate subtilitas. Paulo ante pictoris imagine utebar. Ille cum reddere Vergilium coloribus vellet, ipsum intuebatur. Idea erat Vergilii facies, futuri operis exemplar; ex hac quod artifex trahit et operi suo inposuit idos est. Quid intersit quaeris? Alterum exemplar est, alterum forma ab exemplari sumpta et operi inposita; alteram artifex imitatur, alteram facit. Habet aliquam faciem statua: haec est idos. Habet aliquam faciem exemplar ipsum quod intuens opifex statuam figuravit: haec idea est. Etiamnunc
si aliam desideras distinctionem, idos in opere est, idea extra opus, nec tantum extra opus est, sed ante opus. Quintum genus est eorum quae communiter sunt; haec incipiunt ad nos pertinere; hic sunt omnia, homines, pecora, res. Sextum genus est eorum quae quasi sunt, tamquam inane, tamquam tempus. Quaecumque videmus aut tangimus Plato in illis non numerat quae esse proprie putat; fluunt enim et in adsidua deminutione atque adiectione sunt. Nemo nostrum idem est in senectute qui fuit iuvenis; nemo nostrum est idem mane qui fuit pridie. Corpora nostra rapiuntur fluminum more. Quidquid vides currit cum tempore; nihil ex iis quae videmus manet; ego ipse, dum loquor mutari ista, mutatus sum. Hoc est quod ait Heraclitus: «in idem flumen bis descendimus et non descendimus». Manet enim idem fluminis nomen, aqua transmissa est. Hoc in amne manifestius est quam in homine; sed nos quoque non minus velox cursus praetervehit, et ideo admiror dementiam nostram, quod tantopere amamus rem fugacissimam, corpus, timemusque ne quando moriamur, cum omne momentum mors prioris habitus sit: vis tu non timere ne semel fiat quod cotidie fit! De homine dixi, fluvida materia et caduca et omnibus obnoxia causis: mundus quoque, aeterna res et invicta, mutatur nec idem manet. Quamvis enim omnia in se habeat quae habuit, aliter habet quam habuit: ordinem mutat. «Quid ista» inquis «mihi subtilitas proderit?». Si me interrogas, nihil; sed quemadmodum ille caelator oculos diu intentos ac fatigatos remittit atque avocat et, ut dici solet, pascit, sic nos animum aliquando debemus relaxare et quibusdam oblectamentis reficere. Sed ipsa oblectamenta opera sint; ex his quoque, si observaveris, sumes quod possit fieri salutare. Hoc ego, Lucili, facere soleo: ex omni notione, etiam si a philosophia longissime aversa est, eruere aliquid conor et utile efficere. Quid istis quae modo tractavimus remotius a reformatione morum? Quomodo meliorem me facere ideae Platonicae possunt? Quid ex istis traham quod cupiditates meas conprimat? Vel hoc ipsum, quod omnia ista quae sensibus serviunt, quae nos accendunt et inritant, negat Plato ex iis esse quae vere sint. Ergo ista imaginaria sunt et ad tempus aliquam faciem ferunt, nihil horum stabile nec solidum est; et nos tamen cupimus tamquam aut semper futura aut semper habituri. Inbecilli fluvidique inter vana constitimus: ad illa mittamus animum quae aeterna sunt. Miremur in sublimi volitantes rerum omnium formas deumque inter illa versantem et hoc providentem, quemadmodum quae inmortalia facere non potuit, quia materia prohibebat, defendat a morte ac ratione vitium corporis vincat. Manent enim cuncta, non quia aeterna sunt, sed quia defenduntur cura regentis: inmortalia tutore non egerent. Haec conservat artifex fragilitatem materiae vi sua vincens. Contemnamus omnia quae adeo pretiosa non sunt ut an sint omnino dubium sit. Illud simul cogitemus, si mundum ipsum, non minus mortalem quam nos sumus, providentia periculis eximit, posse aliquatenus nostra quoque providentia longiorem prorogari huic corpusculo moram, si voluptates, quibus pars maior perit, potuerimus regere et coercere. Plato ipse ad senectutem se diligentia protulit. Erat quidem corpus validum ac forte sortitus et illi nomen latitudo pectoris fecerat, sed navigationes ac pericula multum detraxerant viribus;
parsimonia tamen et eorum quae aviditatem evocant modus et diligens sui tutela perduxit illum ad senectutem multis prohibentibus causis. Nam hoc scis, puto, Platoni diligentiae suae beneficio contigisse quod natali suo decessit et annum unum atque octogensimum implevit sine ulla deductione. Ideo magi, qui forte Athenis erant, immolaverunt defuncto, amplioris fuisse sortis quam humanae rati, quia consummasset perfectissimum numerum, quem novem novies multiplicata componunt. Non dubito quin paratus sis et paucos dies ex ista summa et sacrificium remittere. Potest frugalitas producere senectutem, quam ut non puto concupiscendam, ita ne recusandam quidem; iucundum est secum esse quam diutissime, cum quis se dignum quo frueretur effecit. Itaque de isto feremus sententiam, an oporteat fastidire senectutis extrema et finem non opperiri sed manu facere. Prope est a timente qui fatum segnis expectat, sicut ille ultra modum deditus vino est qui amphoram exsiccat et faecem quoque exsorbet. De hoc tamen quaeremus, pars summa vitae utrum faex sit an liquidissimum ac purissimum quiddam, si modo mens sine iniuria est et integri sensus animum iuvant nec defectum et praemortuum corpus est; plurimum enim refert, vitam aliquis extendat an mortem. At si inutile ministeriis corpus est, quidni oporteat educere animum laborantem? Et fortasse paulo ante quam debet faciendum est, ne cum fieri debebit facere non possis; et cum maius periculum sit male vivendi quam cito moriendi, stultus est qui non exigua temporis mercede magnae rei aleam redimit. Paucos longissima senectus ad mortem sine iniuria pertulit, multis iners vita sine usu sui iacuit: quanto deinde crudelius iudicas aliquid ex vita perdidisse quam ius finiendae? Noli me invitus audire, tamquam ad te iam pertineat ista sententia, et quid dicam aestima: non relinquam senectutem, si me totum mihi reservabit, totum autem ab illa parte meliore; at si coeperit concutere mentem, si partes eius convellere, si mihi non vitam reliquerit sed animam, prosiliam ex aedificio putri ac ruenti. Morbum morte non fugiam, dumtaxat sanabilem nec officientem animo. Non adferam mihi manus propter dolorem: sic mori vinci est. Hunc tamen si sciero perpetuo mihi esse patiendum, exibo, non propter ipsum, sed quia inpedimento mihi futurus est ad omne propter quod vivitur; inbecillus est et ignavus qui propter dolorem moritur, stultus qui doloris causa vivit. Sed in longum exeo; est praeterea materia quae ducere diem possit: et quomodo finem inponere vitae poterit qui epistulae non potest? Vale ergo: quod libentius quam mortes meras lecturus es. Vale. 59. Magnam ex epistula tua percepi voluptatem; permitte enim mihi uti verbis publicis nec illa ad significationem Stoicam revoca. Vitium esse voluptatem credimus. Sit sane; ponere tamen illam solemus ad demonstrandam animi hilarem adfectionem. Scio, inquam, et voluptatem, si ad nostrum album verba derigimus, rem infamem esse et gaudium nisi sapienti non contingere; est enim animi elatio suis bonis verisque fidentis. Vulgo tamen sic loquimur ut dicamus magnum gaudium nos ex illius consulatu aut nuptiis aut ex partu uxoris percepisse, quae adeo non sunt gaudia ut saepe initia futurae tristitiae sint; gaudio autem iunctum
est non desinere nec in contrarium verti. Itaque cum dicit Vergilius noster et mala mentis gaudia, diserte quidem dicit, sed parum proprie; nullum enim malum gaudium est. Voluptatibus hoc nomen inposuit et quod voluit expressit; significavit enim homines malo suo laetos. Tamen ego non inmerito dixeram cepisse me magnam ex epistula tua voluptatem; quamvis enim ex honesta causa inperitus homo gaudeat, tamen adfectum eius inpotentem et in diversum statim inclinaturum voluptatem voco, opinione falsi boni motam, inmoderatam et inmodicam. Sed ut ad propositum revertar, audi quid me in epistula tua delectaverit: habes verba in potestate, non effert te oratio nec longius quam destinasti trahit. Multi sunt qui ad id quod non proposuerant scribere alicuius verbi placentis decore vocentur, quod tibi non evenit: pressa sunt omnia et rei aptata; loqueris quantum vis et plus significas quam loqueris. Hoc maioris rei indicium est: apparet animum quoque nihil habere supervacui, nihil tumidi. Invenio tamen translationes verborum ut non temerarias ita quae periculum sui fecerint; invenio imagines, quibus si quis nos uti vetat et poetis illas solis iudicat esse concessas, neminem mihi videtur ex antiquis legisse, apud quos nondum captabatur plausibilis oratio: illi, qui simpliciter et demonstrandae rei causa eloquebantur, parabolis referti sunt, quas existimo necessarias, non ex eadem causa qua poetis, sed ut inbecillitatis nostrae adminicula sint, ut et dicentem et audientem in rem praesentem adducant. Sextium ecce cum maxime lego, virum acrem, Graecis verbis, Romanis moribus philosophantem. Movit me imago ab illo posita: ire quadrato agmine exercitum, ubi hostis ab omni parte suspectus est, pugnae paratum. «Idem» inquit «sapiens facere debet: omnis virtutes suas undique expandat, ut ubicumque infesti aliquid orietur, illic parata praesidia sint et ad nutum regentis sine tumultu respondeant». Quod in exercitibus iis quos imperatores magni ordinant fieri videmus, ut imperium ducis simul omnes copiae sentiant, sic dispositae ut signum ab uno datum peditem simul equitemque percurrat, hoc aliquanto magis necessarium esse nobis ait. Illi enim saepe hostem timuere sine causa, tutissimumque illis iter quod suspectissimum fuit: nihil stultitia pacatum habet; tam superne illi metus est quam infra; utrumque trepidat latus; sequuntur pericula et occurrunt; ad omnia pavet, inparata est et ipsis terretur auxiliis. Sapiens autem, ad omnem incursum munitus, intentus, non si paupertas, non si luctus, non si ignominia, non si dolor impetum faciat, pedem referet: interritus et contra illa ibit et inter illa. Nos multa alligant, multa debilitant. Diu in istis vitiis iacuimus, elui difficile est; non enim inquinati sumus sed infecti. Ne ab alia imagine ad aliam transeamus, hoc quaeram quod saepe mecum dispicio, quid ita nos stultitia tam pertinaciter teneat? Primo quia non fortiter illam repellimus nec toto ad salutem impetu nitimur, deinde quia illa quae a sapientibus viris reperta sunt non satis credimus nec apertis pectoribus haurimus leviterque tam magnae rei insistimus.
Quemadmodum autem potest aliquis quantum satis sit adversus vitia discere, qui quantum a vitiis vacat discit? Nemo nostrum in altum descendit; summa tantum decerpsimus et exiguum temporis inpendisse philosophiae satis abundeque occupatis fuit. Illud praecipue inpedit, quod cito nobis placemus; si invenimus qui nos bonos viros dicat, qui prudentes, qui sanctos, adgnoscimus. Non sumus modica laudatione contenti: quidquid in nos adulatio sine pudore congessit tamquam debitum prendimus. Optimos nos esse, sapientissimos adfirmantibus adsentimur, cum sciamus illos saepe multa mentiri; adeoque indulgemus nobis ut laudari velimus in id cui contraria cum maxime facimus. Mitissimum ille se in ipsis suppliciis audit, in rapinis liberalissimum et in ebrietatibus ac libidinibus temperantissimum; sequitur itaque ut ideo mutari nolimus quia nos optimos esse credidimus. Alexander cum iam in India vagaretur et gentes ne finitimis quidem satis notas bello vastaret, in obsidione cuiusdam urbis, dum circumit muros et inbecillissima moenium quaerit, sagitta ictus diu persedere et incepta agere perseveravit. Deinde cum represso sanguine sicci vulneris dolor cresceret et crus suspensum equo paulatim obtorpuisset, coactus absistere «omnes» inquit «iurant esse me Iovis filium, sed vulnus hoc hominem esse me clamat». Idem nos faciamus. Pro sua quemque portione adulatio infatuat: dicamus, «vos quidem dicitis me prudentem esse, ego autem video quam multa inutilia concupiscam, nocitura optem. Ne hoc quidem intellego quod animalibus satietas monstrat, quis cibo debeat esse, quis potioni modus; quantum capiam adhuc nescio». Iam docebo quemadmodum intellegas te non esse sapientem. Sapiens ille plenus est gaudio, hilaris et placidus, inconcussus; cum dis ex pari vivit. Nunc ipse te consule: si numquam maestus es, si nulla spes animum tuum futuri expectatione sollicitat, si per dies noctesque par et aequalis animi tenor erecti et placentis sibi est, pervenisti ad humani boni summam; sed si appetis voluptates et undique et omnes, scito tantum tibi ex sapientia quantum ex gaudio deesse. Ad hoc cupis pervenire, sed erras, qui inter divitias illuc venturum esse te speras, inter honores, id est gaudium inter sollicitudines quaeris: ista, quae sic petis tamquam datura laetitiam ac voluptatem, causae dolorum sunt. Omnes, inquam, illo tendunt ad gaudium, sed unde stabile magnumque consequantur ignorant: ille ex conviviis et luxuria, ille ex ambitione et circumfusa clientium turba, ille ex amica, alius ex studiorum liberalium vana ostentatione et nihil sanantibus litteris – omnes istos oblectamenta fallacia et brevia decipiunt, sicut ebrietas, quae unius horae hilarem insaniam longi temporis taedio pensat, sicut plausus et adclamationis secundae favor, qui magna sollicitudine et partus est et expiandus. Hoc ergo cogita, hunc esse sapientiae effectum, gaudii aequalitatem. Talis est sapientis animus qualis mundus super lunam: semper illic serenum est. Habes ergo et quare velis sapiens esse, si numquam sine gaudio est. Gaudium hoc non nascitur nisi ex virtutum conscientia: non potest gaudere nisi fortis, nisi iustus, nisi temperans. «Quid ergo» inquis, «stulti ac mali non gaudent?». Non magis quam praedam nancti leones: cum fatigaverunt se vino ac libidinibus, cum illos nox inter vitia defecit, cum voluptates angusto corpori ultra quam capiebat
ingestae suppurare coeperunt, tunc exclamant miseri Vergilianum illum versum: namque ut supremam falsa inter gaudia noctem egerimus nosti. Omnem luxuriosi noctem inter falsa gaudia et quidem tamquam supremam agunt: illud gaudium quod deos deorumque aemulos sequitur non interrumpitur, non desinit; desineret, si sumptum esset aliunde. Quia non est alieni muneris, ne arbitrii quidem alieni est: quod non dedit fortuna non eripit. Vale. 60. Queror, litigo, irascor. Etiamnunc optas quod tibi optavit nutrix tua aut paedagogus aut mater? Nondum intellegis quantum mali optaverint? O quam inimica nobis sunt vota nostrorum! eo quidem inimiciora quo cessere felicius. Iam non admiror si omnia nos a prima pueritia mala sequuntur: inter execrationes parentum crevimus. Exaudiant di quandoque nostram pro nobis vocem gratuitam. Quousque poscemus aliquid deos? Ita nondum ipsi alere nos possumus? Quamdiu sationibus implebimus magnarum urbium campos? Quamdiu nobis populus metet? Quamdiu unius mensae instrumentum multa navigia et quidem non ex uno mari subvehent? Taurus paucissimorum iugerum pascuo impletur; una silva elephantis pluribus sufficit: homo et terra et mari pascitur. Quid ergo? Tam insatiabilem nobis natura alvum dedit, cum tam modica corpora dedisset, ut vastissimorum edacissimorumque animalium aviditatem vinceremus? Minime; quantulum est enim quod naturae datur! Parvo illa dimittitur: non fames nobis ventris nostri magno constat sed ambitio. Hos itaque, ut ait Sallustius, «ventri oboedientes» animalium loco numeremus, non hominum, quosdam vero ne animalium quidem, sed mortuorum. Vivit is qui multis usui est, vivit is qui se utitur; qui vero latitant et torpent sic in domo sunt quomodo in conditivo. Horum licet in limine ipso nomen marmori inscribas: mortem suam antecesserunt. Vale. 61. Desinamus quod voluimus velle. Ego certe id ago ne senex eadem velim quae puer volui. In hoc unum eunt dies, in hoc noctes, hoc opus meum est, haec cogitatio, inponere veteribus malis finem. Id ago ut mihi instar totius vitae dies sit; nec mehercules tamquam ultimum rapio, sed sic illum aspicio tamquam esse vel ultimus possit. Hoc animo tibi hanc epistulam scribo, tamquam me cum maxime scribentem mors evocatura sit; paratus exire sum, et ideo fruar vita quia quam diu futurum hoc sit non nimis pendeo. Ante senectutem curavi ut bene viverem, in senectute ut bene moriar; bene autem mori est libenter mori. Da operam ne quid umquam invitus facias: quidquid necesse futurum est repugnanti, id volenti necessitas non est. Ita dico: qui imperia libens excipit partem acerbissimam servitutis effugit, facere quod nolit; non qui iussus aliquid facit miser est, sed qui invitus facit. Itaque sic animum componamus ut quidquid res exiget, id velimus, et in primis ut finem nostri sine tristitia cogitemus. Ante ad mortem quam ad vitam praeparandi sumus. Satis instructa vita est, sed nos in
instrumenta eius avidi sumus; deesse aliquid nobis videtur et semper videbitur: ut satis vixerimus, nec anni nec dies faciunt sed animus. Vixi, Lucili carissime, quantum satis erat; mortem plenus expecto. Vale. 62. Mentiuntur qui sibi obstare ad studia liberalia turbam negotiorum videri volunt: simulant occupationes et augent et ipsi se occupant. Vaco, Lucili, vaco, et ubicumque sum, ibi meus sum. Rebus enim me non trado sed commodo, nec consector perdendi temporis causas; et quocumque constiti loco, ibi cogitationes meas tracto et aliquid in animo salutare converso. Cum me amicis dedi, non tamen mihi abduco nec cum illis moror quibus me tempus aliquod congregavit aut causa ex officio nata civili, sed cum optimo quoque sum; ad illos, in quocumque loco, in quocumque saeculo fuerunt, animum meum mitto. Demetrium, virorum optimum, mecum circumfero et relictis conchyliatis cum illo seminudo loquor, illum admiror. Quidni admirer? Vidi nihil ei deesse. Contemnere aliquis omnia potest, omnia habere nemo potest: brevissima ad divitias per contemptum divitiarum via est. Demetrius autem noster sic vivit, non tamquam contempserit omnia, sed tamquam aliis habenda permiserit. Vale.
Liber septimus 63. Moleste fero decessisse Flaccum, amicum tuum, plus tamen aequo dolere te nolo. Illud, ut non doleas, vix audebo exigere; et esse melius scio. Sed cui ista firmitas animi continget nisi iam multum supra fortunam elato? Illum quoque ista res vellicabit, sed tantum vellicabit. Nobis autem ignosci potest prolapsis ad lacrimas, si non nimiae decucurrerunt, si ipsi illas repressimus. Nec sicci sint oculi amisso amico nec fluant; lacrimandum est, non plorandum. Duram tibi legem videor ponere, cum poetarum Graecorum maximus ius flendi dederit in unum dumtaxat diem, cum dixerit etiam Niobam de cibo cogitasse? Quaeris unde sint lamentationes, unde inmodici fletus? Per lacrimas argumenta desiderii quaerimus et dolorem non sequimur sed ostendimus; nemo tristis sibi est. O infelicem stultitiam! est aliqua et doloris ambitio. «Quid ergo?» inquis «obliviscar amici?». Brevem illi apud te memoriam promittis, si cum dolore mansura est: iam istam frontem ad risum quaelibet fortuita res transferet. Non differo in longius tempus quo desiderium omne mulcetur, quo etiam acerrimi luctus residunt: cum primum te observare desieris, imago ista tristitiae discedet. Nunc ipse custodis dolorem tuum; sed custodienti quoque elabitur, eoque citius quo est acrior desinit. Id agamus ut iucunda nobis amissorum fiat recordatio. Nemo libenter ad id redit quod non sine tormento cogitaturus est, sicut illud fieri necesse est, ut cum aliquo nobis morsu amissorum quos amavimus nomen occurrat; sed hic quoque morsus habet suam voluptatem. Nam, ut dicere solebat Attalus noster, «sic amicorum defunctorum memoria iucunda est quomodo poma quaedam sunt suaviter aspera, quomodo in vino nimis veteri ipsa nos amaritudo delectat; cum vero intervenit spatium, omne quod angebat extinguitur et pura ad nos voluptas venit». Si illi credimus, «amicos incolumes cogitare melle ac placenta frui est: eorum qui fuerunt retractatio non sine acerbitate quadam iuvat. Quis autem negaverit haec acria quoque et habentia austeritatis aliquid stomachum excitare?». Ego non idem sentio: mihi amicorum defunctorum cogitatio dulcis ac blanda est; habui enim illos tamquam amissurus, amisi tamquam habeam. Fac ergo, mi Lucili, quod aequitatem tuam decet, desine beneficium fortunae male interpretari: abstulit, sed dedit. Ideo amicis avide fruamur quia quamdiu contingere hoc possit incertum est. Cogitemus quam saepe illos reliquerimus in aliquam peregrinationem longinquam exituri, quam saepe eodem morantes loco non viderimus: intellegemus plus nos temporis in vivis perdidisse. Feras autem hos qui neglegentissime amicos habent, miserrime lugent, nec amant quemquam nisi perdiderunt? Ideoque tunc effusius maerent quia verentur ne dubium sit an amaverint; sera indicia adfectus sui quaerunt. Si habemus alios amicos, male de iis et meremur et existimamus, qui parum valent in unius elati solacium; si non habemus, maiorem iniuriam ipsi nobis fecimus quam a fortuna accepimus: illa unum abstulit, nos quemcumque non fecimus. Deinde ne unum quidem nimis amavit qui plus quam unum amare non potuit. Si quis despoliatus amissa unica
tunica conplorare se malit quam circumspicere quomodo frigus effugiat et aliquid inveniat quo tegat scapulas, nonne tibi videatur stultissimus? Quem amabas extulisti: quaere quem ames. Satius est amicum reparare quam flere. Scio pertritum iam hoc esse quod adiecturus sum, non ideo tamen praetermittam quia ab omnibus dictum est: finem dolendi etiam qui consilio non fecerat tempore invenit. Turpissimum autem est in homine prudente remedium maeroris lassitudo maerendi: malo relinquas dolorem quam ab illo relinquaris; et quam primum id facere desiste quod, etiam si voles, diu facere non poteris. Annum feminis ad lugendum constituere maiores, non ut tam diu lugerent, sed ne diutius: viris nullum legitimum tempus est, quia nullum honestum. Quam tamen mihi ex illis mulierculis dabis vix retractis a rogo, vix a cadavere revulsis, cui lacrimae in totum mensem duraverint? Nulla res citius in odium venit quam dolor, qui recens consolatorem invenit et aliquos ad se adducit, inveteratus vero deridetur, nec inmerito; aut enim simulatus aut stultus est. Haec tibi scribo, is qui Annaeum Serenum carissimum mihi tam inmodice flevi ut, quod minime velim, inter exempla sim eorum quos dolor vicit. Hodie tamen factum meum damno et intellego maximam mihi causam sic lugendi fuisse quod numquam cogitaveram mori eum ante me posse. Hoc unum mihi occurrebat, minorem esse et multo minorem – tamquam ordinem fata servarent! Itaque adsidue cogitemus tam de nostra quam omnium quos diligimus mortalitate. Tunc ego debui dicere, «minor est Serenus meus: quid ad rem pertinet? Post me mori debet, sed ante me potest». Quia non feci, inparatum subito fortuna percussit. Nunc cogito omnia et mortalia esse et incerta lege mortalia; hodie fieri potest quidquid umquam potest. Cogitemus ergo, Lucili carissime, cito nos eo perventuros quo illum pervenisse maeremus; et fortasse, si modo vera sapientium fama est recipitque nos locus aliquis, quem putamus perisse praemissus est. Vale. 64. Fuisti here nobiscum. Potes queri, si here tantum; ideo adieci «nobiscum»; mecum enim semper es. Intervenerant quidam amici propter quos maior fumus fieret, non hic qui erumpere ex lautorum culinis et terrere vigiles solet, sed hic modicus qui hospites venisse significet. Varius nobis fuit sermo, ut in convivio, nullam rem usque ad exitum adducens sed aliunde alio transiliens. Lectus est deinde liber Quinti Sextii patris, magni, si quid mihi credis, viri, et licet neget Stoici. Quantus in illo, di boni, vigor est, quantum animi! Hoc non in omnibus philosophis invenies: quorundam scripta clarum habentium nomen exanguia sunt. Instituunt, disputant, cavillantur, non faciunt animum quia non habent: cum legeris Sextium, dices, «vivit, viget, liber est, supra hominem est, dimittit me plenum ingentis fiduciae». In qua positione mentis sim cum hunc lego fatebor tibi: libet omnis casus provocare, libet exclamare, «quid cessas, fortuna? Congredere: paratum vides». Illius animum induo qui quaerit ubi se experiatur, ubi virtutem suam ostendat, spumantemque dari pecora inter inertia votis
optat aprum aut fulvum descendere monte leonem. Libet aliquid habere quod vincam, cuius patientia exercear. Nam hoc quoque egregium Sextius habet, quod et ostendet tibi beatae vitae magnitudinem et desperationem eius non faciet: scies esse illam in excelso, sed volenti penetrabilem. Hoc idem virtus tibi ipsa praestabit, ut illam admireris et tamen speres. Mihi certe multum auferre temporis solet contemplatio ipsa sapientiae; non aliter illam intueor obstupefactus quam ipsum interim mundum, quem saepe tamquam spectator novus video. Veneror itaque inventa sapientiae inventoresque; adire tamquam multorum hereditatem iuvat. Mihi ista adquisita, mihi laborata sunt. Sed agamus bonum patrem familiae, faciamus ampliora quae accepimus; maior ista hereditas a me ad posteros transeat. Multum adhuc restat operis multumque restabit, nec ulli nato post mille saecula praecludetur occasio aliquid adhuc adiciendi. Sed etiam si omnia a veteribus inventa sunt, hoc semper novum erit, usus et inventorum ab aliis scientia ac dispositio. Puta relicta nobis medicamenta quibus sanarentur oculi: non opus est mihi alia quaerere, sed haec tamen morbis et temporibus aptanda sunt. Hoc asperitas oculorum conlevatur; hoc palpebrarum crassitudo tenuatur; hoc vis subita et umor avertitur; hoc acuetur visus: teras ista oportet et eligas tempus, adhibeas singulis modum. Animi remedia inventa sunt ab antiquis; quomodo autem admoveantur aut quando nostri operis est quaerere. Multum egerunt qui ante nos fuerunt, sed non peregerunt. Suspiciendi tamen sunt et ritu deorum colendi. Quidni ego magnorum virorum et imagines habeam incitamenta animi et natales celebrem? Quidni ego illos honoris causa semper appellem? Quam venerationem praeceptoribus meis debeo, eandem illis praeceptoribus generis humani, a quibus tanti boni initia fluxerunt. Si consulem videro aut praetorem, omnia quibus honor haberi honori solet faciam: equo desiliam, caput adaperiam, semita cedam. Quid ergo? Marcum Catonem utrumque et Laelium Sapientem et Socraten cum Platone et Zenonem Cleanthenque in animum meum sine dignatione summa recipiam? Ego vero illos veneror et tantis nominibus semper adsurgo. Vale. 65. Hesternum diem divisi cum mala valetudine: antemeridianum illa sibi vindicavit, postmeridiano mihi cessit. Itaque lectione primum temptavi animum; deinde, cum hanc recepisset, plus illi imperare ausus sum, immo permittere: aliquid scripsi et quidem intentius quam soleo, dum cum materia difficili contendo et vinci nolo, donec intervenerunt amici qui mihi vim adferrent et tamquam aegrum intemperantem coercerent. In locum stili sermo successit, ex quo eam partem ad te perferam quae in lite est. Te arbitrum addiximus. Plus negotii habes quam existimas: triplex causa est. Dicunt, ut scis, Stoici nostri duo esse in rerum natura ex quibus omnia fiant, causam et materiam. Materia iacet iners, res ad omnia parata, cessatura si nemo moveat; causa autem, id est ratio, materiam format et quocumque vult versat, ex illa varia opera producit. Esse ergo debet unde fiat aliquid, deinde a quo fiat:
hoc causa est, illud materia. Omnis ars naturae imitatio est; itaque quod de universo dicebam ad haec transfer quae ab homine facienda sunt. Statua et materiam habuit quae pateretur artificem, et artificem qui materiae daret faciem; ergo in statua materia aes fuit, causa opifex. Eadem condicio rerum omnium est: ex eo constant quod fit, et ex eo quod facit. Stoicis placet unam causam esse, id quod facit. Aristoteles putat causam tribus modis dici: «prima» inquit «causa est ipsa materia, sine qua nihil potest effici; secunda opifex; tertia est forma, quae unicuique operi inponitur tamquam statuae». Nam hanc Aristoteles «idos» vocat. «Quarta quoque» inquit «his accedit, propositum totius operis». Quid sit hoc aperiam. Aes prima statuae causa est; numquam enim facta esset, nisi fuisset id ex quo funderetur ducereturve. Secunda causa artifex est; non potuisset enim aes illud in habitum statuae figurari, nisi accessissent peritae manus. Tertia causa est forma; neque enim statua ista «doryphoros» aut «diadumenos» vocaretur, nisi haec illi esset inpressa facies. Quarta causa est faciendi propositum; nam nisi hoc fuisset, facta non esset. Quid est propositum? Quod invitavit artificem, quod ille secutus fecit: vel pecunia est haec, si venditurus fabricavit, vel gloria, si laboravit in nomen, vel religio, si donum templo paravit. Ergo et haec causa est propter quam fit: an non putas inter causas facti operis esse numerandum quo remoto factum non esset? His quintam Plato adicit exemplar, quam ipse «idean» vocat; hoc est enim ad quod respiciens artifex id quod destinabat effecit. Nihil autem ad rem pertinet utrum foris habeat exemplar ad quod referat oculos an intus, quod ibi ipse concepit et posuit. Haec exemplaria rerum omnium deus intra se habet numerosque universorum quae agenda sunt et modos mente conplexus est; plenus his figuris est quas Plato «ideas» appellat, inmortales, inmutabiles, infatigabiles. Itaque homines quidem pereunt, ipsa autem humanitas, ad quam homo effingitur, permanet, et hominibus laborantibus, intereuntibus, illa nihil patitur. Quinque ergo causae sunt, ut Plato dicit: id ex quo, id a quo, id in quo, id ad quod, id propter quod; novissime id quod ex his est. Tamquam in statua (quia de hac loqui coepimus) id ex quo aes est, id a quo artifex est, id in quo forma est quae aptatur illi, id ad quod exemplar est quod imitatur is qui facit, id propter quod facientis propositum est, id quod ex istis est ipsa statua est. Haec omnia mundus quoque, ut ait Plato, habet: facientem, hic deus est; ex quo fit, haec materia est; formam, haec est habitus et ordo mundi quem videmus; exemplar, scilicet ad quod deus hanc magnitudinem operis pulcherrimi fecit; propositum, propter quod fecit. Quaeris quod sit propositum deo? Bonitas. Ita certe Plato ait: «quae deo faciendi mundum fuit causa? Bonus est; bono nulla cuiusquam boni invidia est; fecit itaque quam optimum potuit». Fer ergo iudex sententiam et pronuntia quis tibi videatur verisimillimum dicere, non quis verissimum dicat; id enim tam supra nos est quam ipsa veritas. Haec quae ab Aristotele et Platone ponitur turba causarum aut nimium multa aut nimium pauca conprendit. Nam si quocumque remoto quid effici non potest,
id causam iudicant esse faciendi, pauca dixerunt. Ponant inter causas tempus: nihil sine tempore potest fieri. Ponant locum: si non fuerit ubi fiat aliquid, ne fiet quidem. Ponant motum: nihil sine hoc nec fit nec perit; nulla sine motu ars, nulla mutatio est. Sed nos nunc primam et generalem quaerimus causam. Haec simplex esse debet; nam et materia simplex est. Quaerimus quid sit causa? Ratio scilicet faciens, id est deus; ista enim quaecumque rettulistis non sunt multae et singulae causae, sed ex una pendent, ex ea quae facit. Formam dicis causam esse? Hanc inponit artifex operi: pars causae est, non causa. Exemplar quoque non est causa, sed instrumentum causae necessarium. Sic necessarium est exemplar artifici quomodo scalprum, quomodo lima: sine his procedere ars non potest, non tamen hae partes artis aut causae sunt. «Propositum» inquit «artificis, propter quod ad faciendum aliquid accedit, causa est». Ut sit causa, non est efficiens causa, sed superveniens. Hae autem innumerabiles sunt: nos de causa generali quaerimus. Illud vero non pro solita ipsis subtilitate dixerunt, totum mundum et consummatum opus causam esse; multum enim interest inter opus et causam operis. Aut fer sententiam aut, quod facilius in eiusmodi rebus est, nega tibi liquere et nos reverti iube. «Quid te» inquis «delectat tempus inter ista conterere, quae tibi nullum adfectum eripiunt, nullam cupiditatem abigunt?» Ego quidem †peiora† illa ago ac tracto quibus pacatur animus, et me prius scrutor, deinde hunc mundum. Ne nunc quidem tempus, ut existimas, perdo; ista enim omnia, si non concidantur nec in hanc subtilitatem inutilem distrahantur, attollunt et levant animum, qui gravi sarcina pressus explicari cupit et reverti ad illa quorum fuit. Nam corpus hoc animi pondus ac poena est; premente illo urguetur, in vinclis est, nisi accessit philosophia et illum respirare rerum naturae spectaculo iussit et a terrenis ad divina dimisit. Haec libertas eius est, haec evagatio; subducit interim se custodiae in qua tenetur et caelo reficitur. Quemadmodum artifices alicuius rei subtilioris quae intentione oculos defetigat, si malignum habent et precarium lumen, in publicum prodeunt et in aliqua regione ad populi otium dedicata oculos libera luce delectant, sic animus in hoc tristi et obscuro domicilio clusus, quotiens potest, apertum petit et in rerum naturae contemplatione requiescit. Sapiens adsectatorque sapientiae adhaeret quidem in corpore suo, sed optima sui parte abest et cogitationes suas ad sublimia intendit. Velut sacramento rogatus hoc quod vivit stipendium putat; et ita formatus est ut illi nec amor vitae nec odium sit, patiturque mortalia quamvis sciat ampliora superesse. Interdicis mihi inspectione rerum naturae, a toto abductum redigis in partem? Ego non quaeram quae sint initia universorum? Quis rerum formator? Quis omnia in uno mersa et materia inerti convoluta discreverit? Non quaeram quis sit istius artifex mundi? Qua ratione tanta magnitudo in legem et ordinem venerit? Quis sparsa collegerit, confusa distinxerit, in una deformitate iacentibus faciem diviserit? Unde lux tanta fundatur? Ignis sit, an aliquid igne lucidius? Ego ista non quaeram? Ego nesciam unde descenderim? Semel haec mihi videnda sint, an saepe nascendum? Quo hinc iturus sim? Quae sedes expectet animam solutam legibus servitutis humanae?
Vetas me caelo interesse, id est iubes me vivere capite demisso? Maior sum et ad maiora genitus quam ut mancipium sim mei corporis, quod equidem non aliter aspicio quam vinclum aliquod libertati meae circumdatum; hoc itaque oppono fortunae, in quo resistat, nec per illud ad me ullum transire vulnus sino. Quidquid in me potest iniuriam pati hoc est: in hoc obnoxio domicilio animus liber habitat. Numquam me caro ista conpellet ad metum, numquam ad indignam bono simulationem; numquam in honorem huius corpusculi mentiar. Cum visum erit, distraham cum illo societatem; et nunc tamen, dum haeremus, non erimus aequis partibus socii: animus ad se omne ius ducet. Contemptus corporis sui certa libertas est. Ut ad propositum revertar, huic libertati multum conferet et illa de qua modo loquebamur inspectio; nempe universa ex materia et ex deo constant. Deus ista temperat quae circumfusa rectorem sequuntur et ducem. Potentius autem est ac pretiosius quod facit, quod est deus, quam materia patiens dei. Quem in hoc mundo locum deus obtinet, hunc in homine animus; quod est illic materia, id in nobis corpus est. Serviant ergo deteriora melioribus; fortes simus adversus fortuita; non contremescamus iniurias, non vulnera, non vincula, non egestatem. Mors quid est? Aut finis aut transitus. Nec desinere timeo (idem est enim quod non coepisse), nec transire, quia nusquam tam anguste ero. Vale. 66. Claranum condiscipulum meum vidi post multos annos: non, puto, expectas ut adiciam senem, sed mehercules viridem animo ac vigentem et cum corpusculo suo conluctantem. Inique enim se natura gessit et talem animum male conlocavit; aut fortasse voluit hoc ipsum nobis ostendere, posse ingenium fortissimum ac beatissimum sub qualibet cute latere. Vicit tamen omnia inpedimenta et ad cetera contemnenda a contemptu sui venit. Errare mihi visus est qui dixit gratior et pulchro veniens e corpore virtus. Non enim ullo honestamento eget: ipsa magnum sui decus est et corpus suum consecrat. Aliter certe Claranum nostrum coepi intueri: formosus mihi videtur et tam rectus corpore quam est animo. Potest ex casa vir magnus exire, potest et ex deformi humilique corpusculo formosus animus ac magnus. Quosdam itaque mihi videtur in hoc tales natura generare, ut adprobet virtutem omni loco nasci. Si posset per se nudos edere animos, fecisset; nunc quod amplius est facit: quosdam enim edit corporibus inpeditos, sed nihilominus perrumpentis obstantia. Claranus mihi videtur in exemplar editus, ut scire possemus non deformitate corporis foedari animum, sed pulchritudine animi corpus ornari. Quamvis autem paucissimos una fecerimus dies, tamen multi nobis sermones fuerunt, quos subinde egeram et ad te permittam. Hoc primo die quaesitum est, quomodo possint paria bona esse, si triplex eorum condicio est. Quaedam, ut nostris videtur, prima bona sunt, tamquam gaudium, pax, salus patriae; quaedam
secunda, in materia infelici expressa, tamquam tormentorum patientia et in morbo gravi temperantia. Illa bona derecto optabimus nobis, haec, si necesse erit. Sunt adhuc tertia, tamquam modestus incessus et compositus ac probus vultus et conveniens prudenti viro gestus. Quomodo ista inter se paria esse possunt, cum alia optanda sint, alia aversanda? Si volumus ista distinguere, ad primum bonum revertamur et consideremus id quale sit. Animus intuens vera, peritus fugiendorum ac petendorum, non ex opinione sed ex natura pretia rebus inponens, toti se inserens mundo et in omnis eius actus contemplationem suam mittens, cogitationibus actionibusque intentus ex aequo, magnus ac vehemens, asperis blandisque pariter invictus, neutri se fortunae summittens, supra omnia quae contingunt acciduntque eminens, pulcherrimus, ordinatissimus cum decore tum viribus, sanus ac siccus, inperturbatus intrepidus, quem nulla vis frangat, quem nec attollant fortuita nec deprimant – talis animus virtus est. Haec eius est facies, si sub unum veniat aspectum et semel tota se ostendat. Ceterum multae eius species sunt, quae pro vitae varietate et pro actionibus explicantur: nec minor fit aut maior ipsa. Decrescere enim summum bonum non potest nec virtuti ire retro licet; sed in alias atque alias qualitates convertitur, ad rerum quas actura est habitum figurata. Quidquid attigit in similitudinem sui adducit et tinguit; actiones, amicitias, interdum domos totas quas intravit disposuitque condecorat; quidquid tractavit, id amabile, conspicuum, mirabile facit. Itaque vis eius et magnitudo ultra non potest surgere, quando incrementum maximo non est: nihil invenies rectius recto, non magis quam verius vero, quam temperato temperatius. Omnis in modo est virtus; modo certa mensura est; constantia non habet quo procedat, non magis quam fiducia aut veritas aut fides. Quid accedere perfecto potest? Nihil, aut perfectum non erat cui accessit; ergo ne virtuti quidem, cui si quid adici potest, defuit. Honestum quoque nullam accessionem recipit; honestum est enim propter ista quae rettuli. Quid porro? Decorum et iustum et legitimum non eiusdem esse formae putas, certis terminis conprehensum? Crescere posse inperfectae rei signum est. Bonum omne in easdem cadit leges: iuncta est privata et publica utilitas, tam mehercules quam inseparabile est laudandum petendumque. Ergo virtutes inter se pares sunt et opera virtutis et omnes homines quibus illae contigere. Satorum vero animaliumque virtutes, cum mortales sint, fragiles quoque caducaeque sunt et incertae; exiliunt residuntque et ideo non eodem pretio aestimantur. Una inducitur humanis virtutibus regula; una enim est ratio recta simplexque. Nihil est divino divinius, caelesti caelestius. Mortalia minuuntur cadunt, deteruntur crescunt, exhauriuntur implentur; itaque illis in tam incerta sorte inaequalitas est: divinorum una natura est. Ratio autem nihil aliud est quam in corpus humanum pars divini spiritus mersa; si ratio divina est, nullum autem bonum sine ratione est, bonum omne divinum est. Nullum porro inter divina discrimen est; ergo nec inter bona. Paria itaque sunt et gaudium et fortis atque obstinata tormentorum perpessio; in utroque enim eadem est animi magnitudo, in altero remissa et laxa, in altero pugnax et intenta. Quid? Tu non putas parem esse
virtutem eius qui fortiter hostium moenia expugnat, et eius qui obsidionem patientissime sustinet? Magnus Scipio, qui Numantiam cludit et conprimit cogitque invictas manus in exitium ipsas suum verti, magnus ille obsessorum animus, qui scit non esse clusum cui mors aperta est, et in complexu libertatis expirat. Aeque reliqua quoque inter se paria sunt, tranquillitas, simplicitas, liberalitas, constantia, aequanimitas, tolerantia; omnibus enim istis una virtus subest, quae animum rectum et indeclinabilem praestat. «Quid ergo? Nihil interest inter gaudium et dolorum inflexibilem patientiam?». Nihil, quantum ad ipsas virtutes: plurimum inter illa in quibus virtus utraque ostenditur; in altero enim naturalis est animi remissio ac laxitas, in altero contra naturam dolor. Itaque media sunt haec quae plurimum intervalli recipiunt: virtus in utroque par est. Virtutem materia non mutat: nec peiorem facit dura ac difficilis nec meliorem hilaris et laeta; necessest ergo par sit. In utraque enim quod fit aeque recte fit, aeque prudenter, aeque honeste; ergo aequalia sunt bona, ultra quae nec hic potest se melius in hoc gaudio gerere nec ille melius in illis cruciatibus; duo autem quibus nihil fieri melius potest paria sunt. Nam si quae extra virtutem posita sunt aut minuere illam aut augere possunt, desinit unum bonum esse quod honestum. Si hoc concesseris, omne honestum perit. Quare? Dicam: quia nihil honestum est quod ab invito, quod a coacto fit; omne honestum voluntarium est. Admisce illi pigritiam, querelam, tergiversationem, metum: quod habet in se optimum perdidit, sibi placere. Non potest honestum esse quod non est liberum; nam quod timet servit. Honestum omne securum est, tranquillum est: si recusat aliquid, si conplorat, si malum iudicat, perturbationem recepit et in magna discordia volutatur; hinc enim species recti vocat, illinc suspicio mali retrahit. Itaque qui honeste aliquid facturus est, quidquid opponitur, id etiam si incommodum putat, malum non putet, velit, libens faciat. Omne honestum iniussum incoactumque est, sincerum et nulli malo mixtum. Scio quid mihi responderi hoc loco possit: «hoc nobis persuadere conaris, nihil interesse utrum aliquis in gaudio sit an in eculeo iaceat ac tortorem suum lasset?». Poteram respondere: Epicurus quoque ait sapientem, si in Phalaridis tauro peruratur, exclamaturum, «dulce est et ad me nihil pertinet». Quid miraris si ego paria bona dico alterius in convivio iacentis, alterius inter tormenta fortissime stantis, cum quod incredibilius est dicat Epicurus, dulce esse torreri? Sed hoc respondeo, plurimum interesse inter gaudium et dolorem; si quaeratur electio, alterum petam, alterum vitabo: illud secundum naturam est, hoc contra. Quamdiu sic aestimantur, magno inter se dissident spatio: cum ad virtutem ventum est, utraque par est, et quae per laeta procedit et quae per tristia. Nullum habet momentum vexatio et dolor et quidquid aliud incommodi est; virtute enim obruitur. Quemadmodum minuta lumina claritas solis obscurat, sic dolores, molestias, iniurias virtus magnitudine sua elidit atque opprimit; et quocumque adfulsit, ibi quidquid sine illa apparet extinguitur, nec magis ullam portionem habent incommoda, cum in virtutem inciderunt, quam in mari nimbus. Hoc ut scias ita esse, ad omne pulchrum vir bonus sine ulla cunctatione procurret: stet
illic licet carnifex, stet tortor atque ignis, perseverabit nec quid passurus sed quid facturus sit aspiciet, et se honestae rei tamquam bono viro credet; utilem illam sibi iudicabit, tutam, prosperam. Eundem locum habebit apud illum honesta res, sed tristis atque aspera, quem vir bonus pauper aut exul aut exilis ac pallidus. Agedum pone ex alia parte virum bonum divitiis abundantem, ex altera nihil habentem, sed in se omnia: uterque aeque vir bonus erit, etiam si fortuna dispari utetur. Idem, ut dixi, in rebus iudicium est quod in hominibus: aeque laudabilis virtus est in corpore valido ac libero posita quam in morbido ac vincto. Ergo tuam quoque virtutem non magis laudabis si corpus illi tuum integrum fortuna praestiterit quam si ex aliqua parte mutilatum: alioqui hoc erit ex servorum habitu dominum aestimare. Omnia enim ista in quae dominium casus exercet serva sunt, pecunia et corpus et honores, inbecilla, fluida, mortalia, possessionis incertae: illa rursus libera et invicta opera virtutis, quae non ideo magis adpetenda sunt si benignius a fortuna tractantur, nec minus si aliqua iniquitate rerum premuntur. Quod amicitia in hominibus est, hoc in rebus adpetitio. Non, puto, magis amares virum bonum locupletem quam pauperem, nec robustum et lacertosum quam gracilem et languidi corporis; ergo ne rem quidem magis adpetes aut amabis hilarem ac pacatam quam distractam et operosam. Aut si hoc est, magis diliges ex duobus aeque bonis viris nitidum et unctum quam pulverulentum et horrentem; deinde hoc usque pervenies ut magis diligas integrum omnibus membris et inlaesum quam debilem aut luscum; paulatim fastidium tuum illo usque procedet ut ex duobus aeque iustis ac prudentibus comatum et crispulum malis. Ubi par in utroque virtus est, non comparet aliarum rerum inaequalitas; omnia enim alia non partes sed accessiones sunt. Num quis tam iniquam censuram inter suos agit ut sanum filium quam aegrum magis diligat, procerumve et excelsum quam brevem aut modicum? Fetus suos non distinguunt ferae et se in alimentum pariter omnium sternunt; aves ex aequo partiuntur cibos. Ulixes ad Ithacae suae saxa sic properat quemadmodum Agamemnon ad Mycenarum nobiles muros; nemo enim patriam quia magna est amat, sed quia sua. Quorsus haec pertinent? Ut scias virtutem omnia opera velut fetus suos isdem oculis intueri, aeque indulgere omnibus, et quidem inpensius laborantibus, quoniam quidem etiam parentium amor magis in ea quorum miseretur inclinat. Virtus quoque opera sua quae videt adfici et premi non magis amat, sed parentium bonorum more magis conplectitur ac fovet. Quare non est ullum bonum altero maius? Quia non est quicquam apto aptius, quia plano nihil est planius. Non potes dicere hoc magis par esse alicui quam illud; ergo nec honesto honestius quicquam est. Quod si par omnium virtutum natura est, tria genera bonorum in aequo sunt. Ita dico: in aequo est moderate gaudere et moderate dolere. Laetitia illa non vincit hanc animi firmitatem sub tortore gemitus devorantem: illa bona optabilia, haec mirabilia sunt, utraque nihilominus paria, quia quidquid incommodi est vi tanto maioris boni tegitur. Quisquis haec inparia iudicat ab ipsis virtutibus avertit oculos et exteriora circumspicit. Bona vera idem pendent, idem patent: illa falsa multum habent vani;
itaque speciosa et magna contra visentibus, cum ad pondus revocata sunt, fallunt. Ita est, mi Lucili: quidquid vera ratio commendat solidum et aeternum est, firmat animum attollitque semper futurum in excelso: illa quae temere laudantur et vulgi sententia bona sunt inflant inanibus laetos; rursus ea quae timentur tamquam mala iniciunt formidinem mentibus et illas non aliter quam animalia specie periculi agitant. Utraque ergo res sine causa animum et diffundit et mordet: nec illa gaudio nec haec metu digna est. Sola ratio inmutabilis et iudicii tenax est; non enim servit sed imperat sensibus. Ratio rationi par est, sicut rectum recto; ergo et virtus virtuti; nihil enim aliud est virtus quam recta ratio. Omnes virtutes rationes sunt; rationes sunt, si rectae sunt; si rectae sunt, et pares sunt. Qualis ratio est, tales et actiones sunt; ergo omnes pares sunt; nam cum similes rationi sint, similes et inter se sunt. Pares autem actiones inter se esse dico qua honestae rectaeque sunt; ceterum magna habebunt discrimina variante materia, quae modo latior est, modo angustior, modo inlustris, modo ignobilis, modo ad multos pertinens, modo ad paucos. In omnibus tamen istis id quod optimum est par est: honestae sunt. Tamquam viri boni omnes pares sunt qua boni sunt, sed habent differentias aetatis: alius senior est, alius iunior; habent corporis: alius formosus, alius deformis est; habent fortunae: ille dives, hic pauper est, ille gratiosus, potens, urbibus notus et populis, hic ignotus plerisque et obscurus. Sed per illud quo boni sunt pares sunt. De bonis ac malis sensus non iudicat; quid utile sit, quid inutile, ignorat. Non potest ferre sententiam nisi in rem praesentem perductus est; nec futuri providus est nec praeteriti memor; quid sit consequens nescit. Ex hoc autem rerum ordo seriesque contexitur et unitas vitae per rectum iturae. Ratio ergo arbitra est bonorum ac malorum; aliena et externa pro vilibus habet, et ea quae neque bona sunt neque mala accessiones minimas ac levissimas iudicat; omne enim illi bonum in animo est. Ceterum bona quaedam prima existimat, ad quae ex proposito venit, tamquam victoriam, bonos liberos, salutem patriae; quaedam secunda, quae non apparent nisi in rebus adversis, tamquam aequo animo pati morbum, ignem, exilium; quaedam media, quae nihilo magis secundum naturam sunt quam contra naturam, tamquam prudenter ambulare, composite sedere. Non enim minus secundum naturam est sedere quam stare aut ambulare. Duo illa bona superiora diversa sunt: prima enim secundum naturam sunt, gaudere liberorum pietate, patriae incolumitate; secunda contra naturam sunt, fortiter obstare tormentis et sitim perpeti morbo urente praecordia. «Quid ergo? Aliquid contra naturam bonum est?». Minime; sed id aliquando contra naturam est in quo bonum illud existit. Vulnerari enim et subiecto igne tabescere et adversa valetudine adfligi contra naturam est, sed inter ista servare animum infatigabilem secundum naturam est. Et ut quod volo exprimam breviter, materia boni aliquando contra naturam est, bonum numquam, quoniam bonum sine ratione nullum est, sequitur autem ratio naturam. «Quid est ergo ratio?». Naturae imitatio. «Quod est summum hominis bonum?». Ex naturae voluntate se gerere. «Non est» inquit «dubium quin felicior pax sit numquam lacessita quam multo
reparata sanguine. Non est dubium» inquit «quin felicior res sit inconcussa valetudo quam ex gravibus morbis et extrema minitantibus in tutum vi quadam et patientia educta. Eodem modo non erit dubium quin maius bonum sit gaudium quam obnixus animus ad perpetiendos cruciatus vulnerum aut ignium». Minime; illa enim quae fortuita sunt plurimum discriminis recipiunt; aestimantur enim utilitate sumentium. Bonorum unum propositum est consentire naturae; hoc in omnibus par est. Cum alicuius in senatu sententiam sequimur, non potest dici: ille magis adsentitur quam ille. Ab omnibus in eandem sententiam itur. Idem de virtutibus dico: omnes naturae adsentiuntur. Idem de bonis dico: omnia naturae adsentiuntur. Alter adulescens decessit, alter senex, aliquis protinus infans, cui nihil amplius contigit quam prospicere vitam: omnes hi aeque fuere mortales, etiam si mors aliorum longius vitam passa est procedere, aliorum in medio flore praecidit, aliorum interrupit ipsa principia. Alius inter cenandum solutus est; alterius continuata mors somno est; aliquem concubitus extinxit. His oppone ferro transfossos aut exanimatos serpentium morsu aut fractos ruina aut per longam nervorum contractionem extortos minutatim. Aliquorum melior dici, aliquorum peior potest exitus: mors quidem omnium par est. Per quae veniunt diversa sunt; in quod desinunt unum est. Mors nulla maior aut minor est; habet enim eundem in omnibus modum, finisse vitam. Idem tibi de bonis dico: hoc bonum inter meras voluptates, hoc est inter tristia et acerba; illud fortunae indulgentiam rexit, hoc violentiam domuit: utrumque aeque bonum est, quamvis illud plana et molli via ierit, hoc aspera. Idem enim finis omnium est: bona sunt, laudanda sunt, virtutem rationemque comitantur; virtus aequat inter se quidquid agnoscit. Nec est quare hoc inter nostra placita mireris: apud Epicurum duo bona sunt, ex quibus summum illud beatumque componitur, ut corpus sine dolore sit, animus sine perturbatione. Haec bona non crescunt si plena sunt: quo enim crescet quod plenum est? Dolore corpus caret: quid ad hanc accedere indolentiam potest? Animus constat sibi et placidus est: quid accedere ad hanc tranquillitatem potest? Quemadmodum serenitas caeli non recipit maiorem adhuc claritatem in sincerissimum nitorem repurgata, sic hominis corpus animumque curantis et bonum suum ex utroque nectentis perfectus est status, et summam voti sui invenit si nec aestus animo est nec dolor corpori. Si qua extra blandimenta contingunt, non augent summum bonum, sed, ut ita dicam, condiunt et oblectant; absolutum enim illud humanae naturae bonum corporis et animi pace contentum est. Dabo apud Epicurum tibi etiamnunc simillimam huic nostrae divisionem bonorum. Alia enim sunt apud illum quae malit contingere sibi, ut corporis quietem ab omni incommodo liberam et animi remissionem bonorum suorum contemplatione gaudentis; alia sunt quae, quamvis nolit accidere, nihilominus laudat et conprobat, tamquam illam quam paulo ante dicebam malae valetudinis et dolorum gravissimorum perpessionem, in qua Epicurus fuit illo summo ac fortunatissimo die suo. Ait enim se vesicae et exulcerati ventris tormenta tolerare ulteriorem doloris accessionem non recipientia, esse nihilominus sibi illum beatum diem. Beatum autem diem agere nisi qui est in summo bono non potest.
Ergo et apud Epicurum sunt haec bona, quae malles non experiri, sed, quia ita res tulit, et amplexanda et laudanda et exaequanda summis sunt. Non potest dici hoc non esse par maximis bonum quod beatae vitae clausulam inposuit, cui Epicurus extrema voce gratias egit. Permitte mihi, Lucili virorum optime, aliquid audacius dicere: si ulla bona maiora esse aliis possent, haec ego quae tristia videntur mollibus illis et delicatis praetulissem, haec maiora dixissem. Maius est enim difficilia perfringere quam laeta moderari. Eadem ratione fit, scio, ut aliquis felicitatem bene et ut calamitatem fortiter ferat. Aeque esse fortis potest qui pro vallo securus excubuit nullis hostibus castra temptantibus et qui succisis poplitibus in genua se excepit nec arma dimisit: «macte virtute esto» sanguinulentis et ex acie redeuntibus dicitur. Itaque haec magis laudaverim bona exercitata et fortia et cum fortuna rixata. Ego dubitem quin magis laudem truncam illam et retorridam manum Mucii quam cuiuslibet fortissimi salvam? Stetit hostium flammarumque contemptor et manum suam in hostili foculo destillantem perspectavit, donec Porsina cuius poenae favebat gloriae invidit et ignem invito eripi iussit. Hoc bonum quidni inter prima numerem tantoque maius putem quam illa secura et intemptata fortunae quanto rarius est hostem amissa manu vicisse quam armata? «Quid ergo?» inquis «hoc bonum tibi optabis?». Quidni? Hoc enim nisi qui potest et optare, non potest facere. An potius optem ut malaxandos articulos exoletis meis porrigam? Ut muliercula aut aliquis in mulierculam ex viro versus digitulos meos ducat? Quidni ego feliciorem putem Mucium, quod sic tractavit ignem quasi illam manum tractatori praestitisset? In integrum restituit quidquid erraverat: confecit bellum inermis ac mancus et illa manu trunca reges duos vicit. Vale. 67. Ut a communibus initium faciam, ver aperire se coepit, sed iam inclinatum in aestatem, quo tempore calere debebat, intepuit nec adhuc illi fides est; saepe enim in hiemem revolvitur. Vis scire quam dubium adhuc sit? Nondum me committo frigidae verae, adhuc rigorem eius infringo. «Hoc est» inquis «nec calidum nec frigidum pati». Ita est, mi Lucili: iam aetas mea contenta est suo frigore; vix media regelatur aestate. Itaque maior pars in vestimentis degitur. Ago gratias senectuti quod me lectulo adfixit: quidni gratias illi hoc nomine agam? Quidquid debebam nolle, non possum. Cum libellis mihi plurimus sermo est. Si quando intervenerunt epistulae tuae, tecum esse mihi videor et sic adficior animo tamquam tibi non rescribam sed respondeam. Itaque et de hoc quod quaeris, quasi conloquar tecum, quale sit una scrutabimur. Quaeris an omne bonum optabile sit. «Si bonum est» inquis «fortiter torqueri et magno animo uri et patienter aegrotare, sequitur ut ista optabilia sint; nihil autem video ex istis voto dignum. Neminem certe adhuc scio eo nomine votum solvisse quod flagellis caesus esset aut podagra distortus aut eculeo longior factus». Distingue, mi Lucili, ista, et intelleges esse in iis aliquid optandum. Tormenta abesse a me velim; sed si sustinenda fuerint, ut me in illis fortiter, honeste, animose geram optabo. Quidni ego malim non incidere bellum? Sed si
inciderit, ut vulnera, ut famem et omnia quae bellorum necessitas adfert generose feram optabo. Non sum tam demens ut aegrotare cupiam; sed si aegrotandum fuerit, ut nihil intemperanter, nihil effeminate faciam optabo. Ita non incommoda optabilia sunt, sed virtus qua perferuntur incommoda. Quidam ex nostris existimant omnium istorum fortem tolerantiam non esse optabilem, sed ne abominandam quidem, quia voto purum bonum peti debet et tranquillum et extra molestiam positum. Ego dissentio. Quare? Primum quia fieri non potest ut aliqua res bona quidem sit sed optabilis non sit; deinde si virtus optabilis est, nullum autem sine virtute bonum, et omne bonum optabile est; deinde etiam si tormentorum fortis patientia optabilis est. Etiamnunc interrogo: nempe fortitudo optabilis est? Atqui pericula contemnit et provocat; pulcherrima pars eius maximeque mirabilis illa est, non cedere ignibus, obviam ire vulneribus, interdum tela ne vitare quidem sed pectore excipere. Si fortitudo optabilis est, et tormenta patienter ferre optabile est; hoc enim fortitudinis pars est. Sed separa ista, ut dixi: nihil erit quod tibi faciat errorem. Non enim pati tormenta optabile est, sed pati fortiter: illud opto «fortiter», quod est virtus. «Quis tamen umquam hoc sibi optavit?» Quaedam vota aperta et professa sunt, cum particulatim fiunt; quaedam latent, cum uno voto multa conprensa sunt. Tamquam opto mihi vitam honestam; vita autem honesta actionibus variis constat: in hac est Reguli arca, Catonis scissum manu sua vulnus, Rutili exilium, calix venenatus qui Socraten transtulit e carcere in caelum. Ita cum optavi mihi vitam honestam, et haec optavi sine quibus interdum honesta non potest esse. O terque quaterque beati, quis ante ora patrum Troiae sub moenibus altis contigit oppetere! Quid interest, optes hoc alicui an optabile fuisse fatearis? Decius se pro re publica devovit et in medios hostes concitato equo mortem petens inruit. Alter post hunc, paternae virtutis aemulus, conceptis sollemnibus ac iam familiaribus verbis in aciem confertissimam incucurrit, de hoc sollicitus tantum, ut litaret, optabilem rem putans bonam mortem. Dubitas ergo an optimum sit memorabilem mori et in aliquo opere virtutis? Cum aliquis tormenta fortiter patitur, omnibus virtutibus utitur. Fortasse una in promptu sit et maxime appareat, patientia; ceterum illic est fortitudo, cuius patientia et perpessio et tolerantia rami sunt; illic est prudentia, sine qua nullum initur consilium, quae suadet quod effugere non possis quam fortissime ferre; illic est constantia, quae deici loco non potest et propositum nulla vi extorquente dimittit; illic est individuus ille comitatus virtutum. Quidquid honeste fit una virtus facit, sed ex consilii sententia; quod autem ab omnibus virtutibus conprobatur, etiam si ab una fieri videtur, optabile est. Quid? Tu existimas ea tantum optabilia esse quae per voluptatem et otium veniunt, quae excipiuntur foribus ornatis? Sunt quaedam tristis vultus bona; sunt
quaedam vota quae non gratulantium coetu, sed adorantium venerantiumque celebrantur. Ita tu non putas Regulum optasse ut ad Poenos perveniret? Indue magni viri animum et ab opinionibus vulgi secede paulisper; cape, quantam debes, virtutis pulcherrimae ac magnificentissimae speciem, quae nobis non ture nec sertis, sed sudore et sanguine colenda est. Aspice M. Catonem sacro illi pectori purissimas manus admoventem et vulnera parum alte demissa laxantem. Utrum tandem illi dicturus es «vellem quae velles» et «moleste fero» an «feliciter quod agis»? Hoc loco mihi Demetrius noster occurrit, qui vitam securam et sine ullis fortunae incursionibus mare mortuum vocat. Nihil habere ad quod exciteris, ad quod te concites, cuius denuntiatione et incursu firmitatem animi tui temptes, sed in otio inconcusso iacere non est tranquillitas: malacia est. Attalus Stoicus dicere solebat, «malo me fortuna in castris suis quam in delicis habeat. Torqueor, sed fortiter: bene est. Occidor, sed fortiter: bene est». Audi Epicurum, dicet et «dulce est». Ego tam honestae rei ac severae numquam molle nomen inponam. Uror, sed invictus: quidni hoc optabile sit? – non quod urit me ignis, sed quod non vincit. Nihil est virtute praestantius, nihil pulchrius; et bonum est et optabile quidquid ex huius geritur imperio. Vale. 68. Consilio tuo accedo: absconde te in otio, sed et ipsum otium absconde. Hoc te facturum Stoicorum etiam si non praecepto, at exemplo licet scias; sed ex praecepto quoque facies: et tibi et cui voles adprobabis. Nec ad omnem rem publicam mittimus nec semper nec sine ullo fine; praeterea, cum sapienti rem publicam ipso dignam dedimus, id est mundum, non est extra rem publicam etiam si recesserit, immo fortasse relicto uno angulo in maiora atque ampliora transit et caelo inpositus intellegit, cum sellam aut tribunal ascenderet, quam humili loco sederit. Depone hoc apud te, numquam plus agere sapientem quam cum in conspectum eius divina atque humana venerunt. Nunc ad illud revertor quod suadere tibi coeperam, ut otium tuum ignotum sit. Non est quod inscribas tibi philosophiam ac quietem: aliud proposito tuo nomen inpone, valetudinem et inbecillitatem vocato et desidiam. Gloriari otio iners ambitio est. Animalia quaedam, ne inveniri possint, vestigia sua circa ipsum cubile confundunt: idem tibi faciendum est, alioqui non deerunt qui persequantur. Multi aperta transeunt, condita et abstrusa rimantur; furem signata sollicitant. Vile videtur quidquid patet; aperta effractarius praeterit. Hos mores habet populus, hos inperitissimus quisque: in secreta inrumpere cupit. Optimum itaque est non iactare otium suum; iactandi autem genus est nimis latere et a conspectu hominum secedere. Ille Tarentum se abdidit, ille Neapoli inclusus est, ille multis annis non transit domus suae limen: convocat turbam quisquis otio suo aliquam fabulam inposuit. Cum secesseris, non est hoc agendum, ut de te homines loquantur, sed ut ipse tecum loquaris. Quid autem loqueris? Quod homines de aliis libentissime faciunt, de te apud te male existima: adsuesces et dicere verum et audire. Id autem maxime tracta quod in te esse infirmissimum senties. Nota habet sui quisque corporis vitia. Itaque alius vomitu levat stomachum, alius frequenti cibo
fulcit, alius interposito ieiunio corpus exhaurit et purgat; ii quorum pedes dolor repetit aut vino aut balineo abstinent: in cetera neglegentes huic a quo saepe infestantur occurrunt. Sic in animo nostro sunt quaedam quasi causariae partes quibus adhibenda curatio est. Quid in otio facio? Ulcus meum curo. Si ostenderem tibi pedem turgidum, lividam manum, aut contracti cruris aridos nervos, permitteres mihi uno loco iacere et fovere morbum meum: maius malum est hoc, quod non possum tibi ostendere: in pectore ipso collectio et vomica est. Nolo nolo laudes, nolo dicas, «o magnum virum! contempsit omnia et damnatis humanae vitae furoribus fugit». Nihil damnavi nisi me. Non est quod proficiendi causa venire ad me velis. Erras, qui hinc aliquid auxili speras: non medicus sed aeger hic habitat. Malo illa, cum discesseris, dicas: «ego istum beatum hominem putabam et eruditum, erexeram aures: destitutus sum, nihil vidi, nihil audivi quod concupiscerem, ad quod reverterer». Si hoc sentis, si hoc loqueris, aliquid profectum est: malo ignoscas otio meo quam invideas. «Otium» inquis «Seneca, commendas mihi? Ad Epicureas voces delaberis?». Otium tibi commendo, in quo maiora agas et pulchriora quam quae reliquisti: pulsare superbas potentiorum fores, digerere in litteram senes orbos, plurimum in foro posse invidiosa potentia ac brevis est et, si verum aestimes, sordida. Ille me gratia forensi longe antecedet, ille stipendiis militaribus et quaesita per hoc dignitate, ille clientium turba. Par esse non possum, plus habent gratiae: est tanti ab omnibus vinci, dum a me fortuna vincatur. Utinam quidem hoc propositum sequi olim fuisset animus tibi! utinam de vita beata non in conspectu mortis ageremus! Sed nunc quoque non moramur; multa enim quae supervacua esse et inimica credituri fuimus rationi, nunc experientiae credimus. Quod facere solent qui serius exierunt et volunt tempus celeritate reparare, calcar addamus. Haec aetas optime facit ad haec studia: iam despumavit, iam vitia primo fervore adulescentiae indomita lassavit; non multum superest ut extinguat. «Et quando» inquis «tibi proderit istud quod in exitu discis, aut in quam rem?». In hanc, ut exeam melior. Non est tamen quod existimes ullam aetatem aptiorem esse ad bonam mentem quam quae se multis experimentis, longa ac frequenti rerum paenitentia domuit, quae ad salutaria mitigatis adfectibus venit. Hoc est huius boni tempus: quisquis senex ad sapientiam pervenit, annis pervenit. Vale. 69. Mutare te loca et aliunde alio transilire nolo, primum quia tam frequens migratio instabilis animi est: coalescere otio non potest nisi desit circumspicere et errare. Ut animum possis continere, primum corporis tui fugam siste. Deinde plurimum remedia continuata proficiunt: interrumpenda non est quies et vitae prioris oblivio; sine dediscere oculos tuos, sine aures adsuescere sanioribus verbis. Quotiens processeris, in ipso transitu aliqua quae renovent cupiditates tuas tibi occurrent. Quemadmodum ei qui amorem exuere conatur evitanda est omnis admonitio dilecti corporis (nihil enim facilius quam amor recrudescit), ita qui deponere vult desideria rerum omnium quarum cupiditate flagravit et oculos et aures ab iis quae reliquit avertat. Cito rebellat adfectus. Quocumque se
verterit, pretium aliquod praesens occupationis suae aspiciet. Nullum sine auctoramento malum est: avaritia pecuniam promittit, luxuria multas ac varias voluptates, ambitio purpuram et plausum et ex hoc potentiam et quidquid potest potentia. Mercede te vitia sollicitant: hic tibi gratis vivendum est. Vix effici toto saeculo potest ut vitia tam longa licentia tumida subigantur et iugum accipiant, nedum si tam breve tempus intervallis discindimus; unam quamlibet rem vix ad perfectum perducit adsidua vigilia et intentio. Si me quidem velis audire, hoc meditare et exerce, ut mortem et excipias et, si ita res suadebit, accersas: interest nihil, illa ad nos veniat an ad illam nos. Illud inperitissimi cuiusque verbum falsum esse tibi ipse persuade: «bella res est mori sua morte». Nemo moritur nisi sua morte. Illud praeterea tecum licet cogites: nemo nisi suo die moritur. Nihil perdis ex tuo tempore; nam quod relinquis alienum est. Vale.
Liber octavus 70. Post longum intervallum Pompeios tuos vidi. In conspectum adulescentiae meae reductus sum; quidquid illic iuvenis feceram videbar mihi facere adhuc posse et paulo ante fecisse. Praenavigavimus, Lucili, vitam et quemadmodum in mari, ut ait Vergilius noster, terraeque urbesque recedunt, sic in hoc cursu rapidissimi temporis primum pueritiam abscondimus, deinde adulescentiam, deinde quidquid est illud inter iuvenem et senem medium, in utriusque confinio positum, deinde ipsius senectutis optimos annos; novissime incipit ostendi publicus finis generis humani. Scopulum esse illum putamus dementissimi: portus est, aliquando petendus, numquam recusandus, in quem si quis intra primos annos delatus est, non magis queri debet quam qui cito navigavit. Alium enim, ut scis, venti segnes ludunt ac detinent et tranquillitatis lentissimae taedio lassant, alium pertinax flatus celerrime perfert. Idem evenire nobis puta: alios vita velocissime adduxit quo veniendum erat etiam cunctantibus, alios maceravit et coxit. Quae, ut scis, non semper retinenda est; non enim vivere bonum est, sed bene vivere. Itaque sapiens vivet quantum debet, non quantum potest. Videbit ubi victurus sit, cum quibus, quomodo, quid acturus. Cogitat semper qualis vita, non quanta sit. Si multa occurrunt molesta et tranquillitatem turbantia, emittit se; nec hoc tantum in necessitate ultima facit, sed cum primum illi coepit suspecta esse fortuna, diligenter circumspicit numquid illic desinendum sit. Nihil existimat sua referre, faciat finem an accipiat, tardius fiat an citius: non tamquam de magno detrimento timet; nemo multum ex stilicidio potest perdere. Citius mori aut tardius ad rem non pertinet, bene mori aut male ad rem pertinet; bene autem mori est effugere male vivendi periculum. Itaque effeminatissimam vocem illius Rhodii existimo, qui cum in caveam coniectus esset a tyranno et tamquam ferum aliquod animal aleretur, suadenti cuidam ut abstineret cibo, «omnia» inquit «homini, dum vivit, speranda sunt». Ut sit hoc verum, non omni pretio vita emenda est. Quaedam licet magna, licet certa sint, tamen ad illa turpi infirmitatis confessione non veniam: ego cogitem in eo qui vivit omnia posse fortunam, potius quam cogitem in eo qui scit mori nil posse fortunam? Aliquando tamen, etiam si certa mors instabit et destinatum sibi supplicium sciet, non commodabit poenae suae manum: sibi commodaret. Stultitia est timore mortis mori: venit qui occidat, expecta. Quid occupas? Quare suscipis alienae crudelitatis procurationem? Utrum invides carnifici tuo an parcis? Socrates potuit abstinentia finire vitam et inedia potius quam veneno mori; triginta tamen dies in carcere et in expectatione mortis exegit, non hoc animo tamquam omnia fieri possent, tamquam multas spes tam longum tempus reciperet, sed ut praeberet se legibus, ut fruendum amicis extremum Socraten daret. Quid erat stultius quam
mortem contemnere, venenum timere? Scribonia, gravis femina, amita Drusi Libonis fuit, adulescentis tam stolidi quam nobilis, maiora sperantis quam illo saeculo quisquam sperare poterat aut ipse ullo. Cum aeger a senatu in lectica relatus esset non sane frequentibus exsequis (omnes enim necessarii deseruerant impie iam non reum sed funus), habere coepit consilium utrum conscisceret mortem an expectaret. Cui Scribonia «quid te» inquit «delectat alienum negotium agere?». Non persuasit illi: manus sibi attulit, nec sine causa. Nam post diem tertium aut quartum inimici moriturus arbitrio si vivit, alienum negotium agit. Non possis itaque de re in universum pronuntiare, cum mortem vis externa denuntiat, occupanda sit an expectanda; multa enim sunt quae in utramque partem trahere possunt. Si altera mors cum tormento, altera simplex et facilis est, quidni huic inicienda sit manus? Quemadmodum navem eligam navigaturus et domum habitaturus, sic mortem exiturus e vita. Praeterea quemadmodum non utique melior est longior vita, sic peior est utique mors longior. In nulla re magis quam in morte morem animo gerere debemus. Exeat qua impetum cepit: sive ferrum appetit sive laqueum sive aliquam potionem venas occupantem, pergat et vincula servitutis abrumpat. Vitam et aliis adprobare quisque debet, mortem sibi: optima est quae placet. Stulte haec cogitantur: «aliquis dicet me parum fortiter fecisse, aliquis nimis temere, aliquis fuisse aliquod genus mortis animosius». Vis tu cogitare id in manibus esse consilium ad quod fama non pertinet! Hoc unum intuere, ut te fortunae quam celerrime eripias; alioquin aderunt qui de facto tuo male existiment. Invenies etiam professos sapientiam qui vim adferendam vitae suae negent et nefas iudicent ipsum interemptorem sui fieri: expectandum esse exitum quem natura decrevit. Hoc qui dicit non videt se libertatis viam cludere: nihil melius aeterna lex fecit quam quod unum introitum nobis ad vitam dedit, exitus multos. Ego expectem vel morbi crudelitatem vel hominis, cum possim per media exire tormenta et adversa discutere? Hoc est unum cur de vita non possimus queri: neminem tenet. Bono loco res humanae sunt, quod nemo nisi vitio suo miser est. Placet? Vive: non placet? Licet eo reverti unde venisti. Ut dolorem capitis levares, sanguinem saepe misisti; ad extenuandum corpus vena percutitur. Non opus est vasto vulnere dividere praecordia: scalpello aperitur ad illam magnam libertatem via et puncto securitas constat. Quid ergo est quod nos facit pigros inertesque? Nemo nostrum cogitat quandoque sibi ex hoc domicilio exeundum; sic veteres inquilinos indulgentia loci et consuetudo etiam inter iniurias detinet. Vis adversus hoc corpus liber esse? Tamquam migraturus habita. Propone tibi quandoque hoc contubernio carendum: fortior eris ad necessitatem exeundi. Sed quemadmodum suus finis veniet in mentem omnia sine fine concupiscentibus? Nullius rei meditatio tam necessaria est; alia enim fortasse exercentur in supervacuum. Adversus paupertatem praeparatus est animus: permansere divitiae. Ad contemptum nos doloris armavimus: numquam a nobis exegit huius virtutis experimentum integri ac sani felicitas corporis. Ut fortiter amissorum desideria pateremur praecepimus nobis: omnis quos amabamus superstites
fortuna servavit. Huius unius rei usum qui exigat dies veniet. Non est quod existimes magnis tantum viris hoc robur fuisse quo servitutis humanae claustra perrumperent; non est quod iudices hoc fieri nisi a Catone non posse, qui quam ferro non emiserat animam manu extraxit: vilissimae sortis homines ingenti impetu in tutum evaserunt, cumque e commodo mori non licuisset nec ad arbitrium suum instrumenta mortis eligere, obvia quaeque rapuerunt et quae natura non erant noxia vi sua tela fecerunt. Nuper in ludo bestiariorum unus e Germanis, cum ad matutina spectacula pararetur, secessit ad exonerandum corpus – nullum aliud illi dabatur sine custode secretum; ibi lignum id quod ad emundanda obscena adhaerente spongia positum est totum in gulam farsit et interclusis faucibus spiritum elisit. Hoc fuit morti contumeliam facere. Ita prorsus, parum munde et parum decenter: quid est stultius quam fastidiose mori? O virum fortem, o dignum cui fati daretur electio! Quam fortiter ille gladio usus esset, quam animose in profundam se altitudinem maris aut abscisae rupis inmisisset! Undique destitutus invenit quemadmodum et mortem sibi deberet et telum, ut scias ad moriendum nihil aliud in mora esse quam velle. Existimetur de facto hominis acerrimi ut cuique visum erit, dum hoc constet, praeferendam esse spurcissimam mortem servituti mundissimae. Quoniam coepi sordidis exemplis uti, perseverabo; plus enim a se quisque exiget, si viderit hanc rem etiam a contemptissimis posse contemni. Catones Scipionesque et alios quos audire cum admiratione consuevimus supra imitationem positos putamus: iam ego istam virtutem habere tam multa exempla in ludo bestiario quam in ducibus belli civilis ostendam. Cum adveheretur nuper inter custodias quidam ad matutinum spectaculum missus, tamquam somno premente nutaret, caput usque eo demisit donec radiis insereret, et tamdiu se in sedili suo tenuit donec cervicem circumactu rotae frangeret; eodem vehiculo quo ad poenam ferebatur effugit. Nihil obstat erumpere et exire cupienti: in aperto nos natura custodit. Cui permittit necessitas sua, circumspiciat exitum mollem; cui ad manum plura sunt per quae sese adserat, is dilectum agat et qua potissimum liberetur consideret: cui difficilis occasio est, is proximam quamque pro optima arripiat, sit licet inaudita, sit nova. Non deerit ad mortem ingenium cui non defuerit animus. Vides quemadmodum extrema quoque mancipia, ubi illis stimulos adegit dolor, excitentur et intentissimas custodias fallant? Ille vir magnus est qui mortem sibi non tantum imperavit sed invenit. Ex eodem tibi munere plura exempla promisi. Secundo naumachiae spectaculo unus e barbaris lanceam quam in adversarios acceperat totam iugulo suo mersit. «Quare, quare» inquit «non omne tormentum, omne ludibrium iamdudum effugio? Quare ego mortem armatus expecto?». Tanto hoc speciosius spectaculum fuit quanto honestius mori discunt homines quam occidere. Quid ergo? Quod animi perditi quoque noxiosi habent non habebunt illi quos adversus hos casus instruxit longa meditatio et magistra rerum omnium ratio? Illa nos docet fati varios esse accessus, finem eundem, nihil autem interesse unde incipiat quod venit. Eadem illa ratio monet ut si licet moriaris quemadmodum placet, si minus
quemadmodum potes, et quidquid obvenerit ad vim adferendam tibi invadas. Iniuriosum est rapto vivere, at contra pulcherrimum mori rapto. Vale. 71. Subinde me de rebus singulis consulis, oblitus vasto nos mari dividi. Cum magna pars consilii sit in tempore, necesse est evenire ut de quibusdam rebus tunc ad te perferatur sententia mea cum iam contraria potior est. Consilia enim rebus aptantur; res nostrae feruntur, immo volvuntur; ergo consilium nasci sub diem debet. Et hoc quoque nimis tardum est: sub manu, quod aiunt, nascatur. Quemadmodum autem inveniatur ostendam. Quotiens quid fugiendum sit aut quid petendum voles scire, ad summum bonum, propositum totius vitae tuae, respice. Illi enim consentire debet quidquid agimus: non disponet singula, nisi cui iam vitae suae summa proposita est. Nemo, quamvis paratos habeat colores, similitudinem reddet, nisi iam constat quid velit pingere. Ideo peccamus quia de partibus vitae omnes deliberamus, de tota nemo deliberat. Scire debet quid petat ille qui sagittam vult mittere, et tunc derigere ac moderari manu telum: errant consilia nostra, quia non habent quo derigantur; ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est. Necesse est multum in vita nostra casus possit, quia vivimus casu. Quibusdam autem evenit ut quaedam scire se nesciant; quemadmodum quaerimus saepe eos cum quibus stamus, ita plerumque finem summi boni ignoramus adpositum. Nec multis verbis nec circumitu longo quod sit summum bonum colliges: digito, ut ita dicam, demonstrandum est nec in multa spargendum. Quid enim ad rem pertinet in particulas illud diducere? Cum possis dicere «summum bonum est quod honestum est» et, quod magis admireris, «unum bonum est quod honestum est, cetera falsa et adulterina bona sunt». Hoc si persuaseris tibi et virtutem adamaveris (amare enim parum est), quidquid illa contigerit, id tibi, qualecumque aliis videbitur, faustum felixque erit. Et torqueri, si modo iacueris ipso torquente securior, et aegrotare, si non male dixeris fortunae, si non cesseris morbo, omnia denique quae ceteris videntur mala et mansuescent et in bonum abibunt, si super illa eminueris. Hoc liqueat, nihil esse bonum nisi honestum: et omnia incommoda suo iure bona vocabuntur quae modo virtus honestaverit. Multis videmur maiora promittere quam recipit humana condicio, non inmerito; ad corpus enim respiciunt. Revertantur ad animum: iam hominem deo metientur. Erige te, Lucili virorum optime, et relinque istum ludum litterarium philosophorum qui rem magnificentissimam ad syllabas vocant, qui animum minuta docendo demittunt et conterunt: fies similis illis qui invenerunt ista, non qui docent et id agunt ut philosophia potius difficilis quam magna videatur. Socrates, qui totam philosophiam revocavit ad mores et hanc summam dixit esse sapientiam, bona malaque distinguere, «sequere» inquit «illos, si quid apud te habeo auctoritatis, ut sis beatus, et te alicui stultum videri sine. Quisquis volet tibi contumeliam faciat et iniuriam, tu tamen nihil patieris, si modo tecum erit virtus. Si vis» inquit «beatus esse, si fide bona vir bonus, sine contemnat te aliquis». Hoc nemo praestabit nisi qui omnia prior ipse contempserit, nisi qui
omnia bona exaequaverit, quia nec bonum sine honesto est et honestum in omnibus par est. «Quid ergo? Nihil interest inter praeturam Catonis et repulsam? Nihil interest utrum Pharsalica acie Cato vincatur an vincat? Hoc eius bonum, quo victis partibus non potest vinci, par erat illi bono quo victor rediret in patriam et componeret pacem?». Quidni par sit? Eadem enim virtute et mala fortuna vincitur et ordinatur bona; virtus autem non potest maior aut minor fieri: unius staturae est. «Sed Cn. Pompeius amittet exercitum, sed illud pulcherrimum rei publicae praetextum, optimates, et prima acies Pompeianarum partium, senatus ferens arma, uno proelio profligabuntur et tam magni ruina imperii in totum dissiliet orbem: aliqua pars eius in Aegypto, aliqua in Africa, aliqua in Hispania cadet. Ne hoc quidem miserae rei publicae continget, semel ruere». Omnia licet fiant: Iubam in regno suo non locorum notitia adiuvet, non popularium pro rege suo virtus obstinatissima, Uticensium quoque fides malis fracta deficiat et Scipionem in Africa nominis sui fortuna destituat: olim provisum est ne quid Cato detrimenti caperet. «Victus est tamen». Et hoc numera inter repulsas Catonis: tam magno animo feret aliquid sibi ad victoriam quam ad praeturam obstitisse. Quo die repulsus est lusit, qua nocte periturus fuit legit; eodem loco habuit praetura et vita excidere; omnia quae acciderent ferenda esse persuaserat sibi. Quidni ille mutationem rei publicae forti et aequo pateretur animo? Quid enim mutationis periculo exceptum? Non terra, non caelum, non totus hic rerum omnium contextus, quamvis deo agente ducatur; non semper tenebit hunc ordinem, sed illum ex hoc cursu aliquis dies deiciet. Certis eunt cuncta temporibus: nasci debent, crescere, extingui. Quaecumque supra nos vides currere et haec quibus innixi atque inpositi sumus veluti solidissimis carpentur ac desinent; nulli non senectus sua est. Inaequalibus ista spatiis eodem natura dimittit: quidquid est non erit, nec peribit sed resolvetur. Nobis solvi perire est; proxima enim intuemur, ad ulteriora non prospicit mens hebes et quae se corpori addixerit; alioqui fortius finem sui suorumque pateretur, si speraret, ut omnia illa, sic vitam mortemque per vices ire et composita dissolvi, dissoluta componi, in hoc opere aeternam artem cuncta temperantis dei verti. Itaque ut M. Cato, cum aevum animo percucurrerit, dicet, «omne humanum genus, quodque est quodque erit, morte damnatum est; omnes quae usquam rerum potiuntur urbes quaeque alienorum imperiorum magna sunt decora, ubi fuerint aliquando quaeretur et vario exitii genere tollentur: alias destruent bella, alias desidia paxque ad inertiam versa consumet et magnis opibus exitiosa res, luxus. Omnes hos fertiles campos repentini maris inundatio abscondet aut in subitam cavernam considentis soli lapsus abducet. Quid est ergo quare indigner aut doleam, si exiguo momento publica fata praecedo?». Magnus animus deo pareat et quidquid lex universi iubet sine cunctatione patiatur: aut in meliorem emittitur vitam lucidius tranquilliusque inter divina mansurus aut certe sine ullo futurus incommodo, si naturae remiscebitur et revertetur in totum. Non est ergo M. Catonis maius bonum honesta vita quam mors honesta, quoniam non intenditur virtus. Idem esse dicebat
Socrates veritatem et virtutem. Quomodo illa non crescit, sic ne virtus quidem: habet numeros suos, plena est. Non est itaque quod mireris paria esse bona, et quae ex proposito sumenda sunt et quae si ita res tulit. Nam si hanc inaequalitatem receperis ut fortiter torqueri in minoribus bonis numeres, numerabis etiam in malis, et infelicem Socraten dices in carcere, infelicem Catonem vulnera sua animosius quam fecerat retractantem, calamitosissimum omnium Regulum fidei poenas etiam hostibus servatae pendentem. Atqui nemo hoc dicere, ne ex mollissimis quidem, ausus est; negant enim illum esse beatum, sed tamen negant miserum. Academici veteres beatum quidem esse etiam inter hos cruciatus fatentur, sed non ad perfectum nec ad plenum, quod nullo modo potest recipi: nisi beatus est, in summo bono non est. Quod summum bonum est supra se gradum non habet, si modo illi virtus inest, si illam adversa non minuunt, si manet etiam comminuto corpore incolumis: manet autem. Virtutem enim intellego animosam et excelsam, quam incitat quidquid infestat. Hunc animum, quem saepe induunt generosae indolis iuvenes quos alicuius honestae rei pulchritudo percussit, ut omnia fortuita contemnant, profecto sapientia infundet et tradet; persuadebit unum bonum esse quod honestum, hoc nec remitti nec intendi posse, non magis quam regulam qua rectum probari solet flectes. Quidquid ex illa mutaveris iniuria est recti. Idem ergo de virtute dicemus: et haec recta est, flexuram non recipit; †rigidari quidem amplius intendi potest†. Haec de omnibus rebus iudicat, de hac nulla. Si rectior ipsa non potest fieri, ne quae ab illa quidem fiunt alia aliis rectiora sunt; huic enim necesse est respondeant; ita paria sunt. «Quid ergo?» inquis «iacere in convivio et torqueri paria sunt?». Hoc mirum videtur tibi? Illud licet magis admireris: iacere in convivio malum est, iacere in eculeo bonum est, si illud turpiter, hoc honeste fit. Bona ista aut mala non efficit materia sed virtus; haec ubicumque apparuit, omnia eiusdem mensurae ac pretii sunt. In oculos nunc mihi manus intentat ille qui omnium animum aestimat ex suo, quod dicam paria bona esse honeste iudicantis et honeste periclitantis, quod dicam paria bona esse eius qui triumphat et eius qui ante currum vehitur invictus animo. Non putant enim fieri quidquid facere non possunt; ex infirmitate sua ferunt de virtute sententiam. Quid miraris si uri, vulnerari, occidi, alligari iuvat, aliquando etiam libet? Luxurioso frugalitas poena est, pigro supplicii loco labor est, delicatus miseretur industrii, desidioso studere torqueri est: eodem modo haec ad quae omnes inbecilli sumus dura atque intoleranda credimus, obliti quam multis tormentum sit vino carere aut prima luce excitari. Non ista difficilia sunt natura, sed nos fluvidi et enerves. Magno animo de rebus magnis iudicandum est; alioqui videbitur illarum vitium esse quod nostrum est. Sic quaedam rectissima, cum in aquam demissa sunt, speciem curvi praefractique visentibus reddunt. Non tantum quid videas, sed quemadmodum, refert: animus noster ad vera perspicienda caligat. Da mihi adulescentem incorruptum et ingenio vegetum: dicet fortunatiorem sibi videri qui omnia rerum adversarum onera rigida cervice sustollat, qui supra fortunam extet. Non est mirum in tranquillitate non concuti:
illud mirare, ibi extolli aliquem ubi omnes deprimuntur, ibi stare ubi omnes iacent. Quid est in tormentis, quid est in aliis quae adversa appellamus mali? Hoc, ut opinor, succidere mentem et incurvari et subcumbere. Quorum nihil sapienti viro potest evenire: stat rectus sub quolibet pondere. Nulla illum res minorem facit; nihil illi eorum quae ferenda sunt displicet. Nam quidquid cadere in hominem potest in se cecidisse non queritur. Vires suas novit; scit se esse oneri ferendo. Non educo sapientem ex hominum numero nec dolores ab illo sicut ab aliqua rupe nullum sensum admittente summoveo. Memini ex duabus illum partibus esse compositum: altera est inrationalis, haec mordetur, uritur, dolet; altera rationalis, haec inconcussas opiniones habet, intrepida est et indomita. In hac positum est summum illud hominis bonum. Antequam impleatur, incerta mentis volutatio est; cum vero perfectum est, inmota illi stabilitas est. Itaque inchoatus et ad summa procedens cultorque virtutis, etiam si adpropinquat perfecto bono sed ei nondum summam manum inposuit, ibit interim cessim et remittet aliquid ex intentione mentis; nondum enim incerta trangressus est, etiamnunc versatur in lubrico. Beatus vero et virtutis exactae tunc se maxime amat cum fortissime expertus est, et metuenda ceteris, si alicuius honesti officii pretia sunt, non tantum fert sed amplexatur multoque audire mavult «tanto melior» quam «tanto felicior». Venio nunc illo quo me vocat expectatio tua. Ne extra rerum naturam vagari virtus nostra videatur, et tremet sapiens et dolebit et expallescet; hi enim omnes corporis sensus sunt. Ubi ergo calamitas, ubi illud malum verum est? Illic scilicet, si ista animum detrahunt, si ad confessionem servitutis adducunt, si illi paenitentiam sui faciunt. Sapiens quidem vincit virtute fortunam, at multi professi sapientiam levissimis nonnumquam minis exterriti sunt. Hoc loco nostrum vitium est, qui idem a sapiente exigimus et a proficiente. Suadeo adhuc mihi ista quae laudo, nondum persuadeo; etiam si persuasissem, nondum tam parata haberem aut tam exercitata ut ad omnes casus procurrerent. Quemadmodum lana quosdam colores semel ducit, quosdam nisi saepius macerata et recocta non perbibit, sic alias disciplinas ingenia, cum accepere, protinus praestant: haec, nisi alte descendit et diu sedit et animum non coloravit sed infecit, nihil ex iis quae promiserat praestat. Cito hoc potest tradi et paucissimis verbis: unum bonum esse virtutem, nullum certe sine virtute, et ipsam virtutem in parte nostri meliore, id est rationali, positam. Quid erit haec virtus? Iudicium verum et inmotum; ab hoc enim impetus venient mentis, ab hoc omnis species quae impetum movet redigetur ad liquidum. Huic iudicio consentaneum erit omnia quae virtute contacta sunt et bona iudicare et inter se paria. Corporum autem bona corporibus quidem bona sunt, sed in totum non sunt bona; his pretium quidem erit aliquod, ceterum dignitas non erit; magnis inter se intervallis distabunt: alia minora, alia maiora erunt. Et in ipsis sapientiam sectantibus magna discrimina esse fateamur necesse est: alius iam in tantum profecit ut contra fortunam audeat attollere oculos, sed non pertinaciter (cadunt enim nimio splendore praestricti), alius in tantum ut possit cum illa conferre vultum, nisi iam pervenit ad summum et fiduciae plenus
est. Inperfecta necesse est labent et modo prodeant, modo sublabantur aut succidant. Sublabentur autem, nisi ire et niti perseveraverint; si quicquam ex studio et fideli intentione laxaverint, retro eundum est. Nemo profectum ibi invenit ubi reliquerat. Instemus itaque et perseveremus; plus quam profligavimus restat, sed magna pars est profectus velle proficere. Huius rei conscius mihi sum: volo et mente tota volo. Te quoque instinctum esse et magno ad pulcherrima properare impetu video. Properemus: ita demum vita beneficium erit; alioquin mora est, et quidem turpis inter foeda versantibus. Id agamus ut nostrum omne tempus sit; non erit autem, nisi prius nos nostri esse coeperimus. Quando continget contemnere utramque fortunam, quando continget omnibus oppressis adfectibus et sub arbitrium suum adductis hanc vocem emittere «vici»? Quem vicerim quaeris? Non Persas nec extrema Medorum nec si quid ultra Dahas bellicosum iacet, sed avaritiam, sed ambitionem, sed metum mortis, qui victores gentium vicit. Vale. 72. Quod quaeris a me liquebat mihi (sic rem edidiceram) per se; sed diu non retemptavi memoriam meam, itaque non facile me sequitur. Quod evenit libris situ cohaerentibus, hoc evenisse mihi sentio: explicandus est animus et quaecumque apud illum deposita sunt subinde excuti debent, ut parata sint quotiens usus exegerit. Ergo hoc in praesentia differamus; multum enim operae, multum diligentiae poscit. Cum primum longiorem eodem loco speravero moram, tunc istud in manus sumam. Quaedam enim sunt quae possis et in cisio scribere, quaedam lectum et otium et secretum desiderant. Nihilominus his quoque occupatis diebus agatur aliquid et quidem totis. Numquam enim non succedent occupationes novae: serimus illas, itaque ex una exeunt plures. Deinde ipsi nobis dilationem damus: «cum hoc peregero, toto animo incumbam» et «si hanc rem molestam composuero, studio me dabo». Non cum vacaveris philosophandum est, sed ut philosopheris vacandum est; omnia alia neglegenda ut huic adsideamus, cui nullum tempus satis magnum est, etiam si a pueritia usque ad longissimos humani aevi terminos vita producitur. Non multum refert utrum omittas philosophiam an intermittas; non enim ubi interrupta est manet, sed eorum more quae intenta dissiliunt usque ad initia sua recurrit, quod a continuatione discessit. Resistendum est occupationibus, nec explicandae sed summovendae sunt. Tempus quidem nullum est parum idoneum studio salutari; atqui multi inter illa non student propter quae studendum est. «Incidet aliquid quod inpediat». Non quidem eum cuius animus in omni negotio laetus atque alacer est: inperfectis adhuc interscinditur laetitia, sapientis vero contexitur gaudium, nulla causa rumpitur, nulla fortuna; semper et ubique tranquillus est. Non enim ex alieno pendet nec favorem fortunae aut hominis expectat. Domestica illi felicitas est; exiret ex animo si intraret: ibi nascitur. Aliquando extrinsecus quo admoneatur mortalitatis intervenit, sed id leve et quod summam cutem stringat. Aliquo, inquam, incommodo adflatur; maximum autem illud bonum fixum est. Ita dico, extrinsecus aliqua sunt incommoda, velut in corpore interdum robusto solidoque
eruptiones quaedam pustularum et ulcuscula, nullum in alto malum est. Hoc, inquam, interest inter consummatae sapientiae virum et alium procedentis quod inter sanum et ex morbo gravi ac diutino emergentem, cui sanitatis loco est levior accessio: hic nisi adtendit, subinde gravatur et in eadem revolvitur, sapiens recidere non potest, ne incidere quidem amplius. Corpori enim ad tempus bona valetudo est, quam medicus, etiam si reddidit, non praestat – saepe ad eundem qui advocaverat excitatur: animus semel in totum sanatur. Dicam quomodo intellegas sanum: si se ipse contentus est, si confidit sibi, si scit omnia vota mortalium, omnia beneficia quae dantur petunturque, nullum in beata vita habere momentum. Nam cui aliquid accedere potest, id inperfectum est; cui aliquid abscedere potest, id inperpetuum est: cuius perpetua futura laetitia est, is suo gaudeat. Omnia autem quibus vulgus inhiat ultro citroque fluunt: nihil dat fortuna mancipio. Sed haec quoque fortuita tunc delectant cum illa ratio temperavit ac miscuit: haec est quae etiam externa commendet, quorum avidis usus ingratus est. Solebat Attalus hac imagine uti: «vidisti aliquando canem missa a domino frusta panis aut carnis aperto ore captantem? Quidquid excepit protinus integrum devorat et semper ad spem venturi hiat. Idem evenit nobis: quidquid expectantibus fortuna proiecit, id sine ulla voluptate demittimus statim, ad rapinam alterius erecti et attoniti». Hoc sapienti non evenit: plenus est; etiam si quid obvenit, secure excipit ac reponit; laetitia fruitur maxima, continua, sua. Habet aliquis bonam voluntatem, habet profectum, sed cui multum desit a summo: hic deprimitur alternis et extollitur ac modo in caelum adlevatur, modo defertur ad terram. Inperitis ac rudibus nullus praecipitationis finis est; in Epicureum illud chaos decidunt, inane sine termino. Est adhuc genus tertium eorum qui sapientiae adludunt, quam non quidem contigerunt, in conspectu tamen et, ut ita dicam, sub ictu habent: hi non concutiuntur, ne defluunt quidem; nondum in sicco, iam in portu sunt. Ergo cum tam magna sint inter summos imosque discrimina, cum medios quoque sequatur fluctus suus, sequatur ingens periculum ad deteriora redeundi, non debemus occupationibus indulgere. Excludendae sunt: si semel intraverint, in locum suum alias substituent. Principiis illarum obstemus: melius non incipient quam desinent. Vale. 73. Errare mihi videntur qui existimant philosophiae fideliter deditos contumaces esse ac refractarios, contemptores magistratuum aut regum eorumve per quos publica administrantur. Ex contrario enim nulli adversus illos gratiores sunt, nec inmerito; nullis enim plus praestant quam quibus frui tranquillo otio licet. Itaque ii quibus multum ad propositum bene vivendi confert securitas publica necesse est auctorem huius boni ut parentem colant, multo quidem magis quam illi inquieti et in medio positi, qui multa principibus debent sed multa et inputant, quibus numquam tam plene occurrere ulla liberalitas potest ut cupiditates illorum, quae crescunt dum implentur, exsatiet. Quisquis autem de accipiendo cogitat oblitus accepti est, nec ullum habet malum cupiditas maius quam quod ingrata est. Adice nunc quod nemo eorum qui in re publica versantur
quot vincat, sed a quibus vincatur, aspicit; et illis non tam iucundum est multos post se videre quam grave aliquem ante se. Habet hoc vitium omnis ambitio: non respicit. Nec ambitio tantum instabilis est, verum cupiditas omnis, quia incipit semper a fine. At ille vir sincerus ac purus, qui reliquit et curiam et forum et omnem administrationem rei publicae ut ad ampliora secederet, diligit eos per quos hoc ei facere tuto licet solusque illis gratuitum testimonium reddit et magnam rem nescientibus debet. Quemadmodum praeceptores suos veneratur ac suspicit quorum beneficio illis inviis exit, sic et hos sub quorum tutela positus exercet artes bonas. «Verum alios quoque rex viribus suis protegit». Quis negat? Sed quemadmodum Neptuno plus debere se iudicat ex iis qui eadem tranquillitate usi sunt qui plura et pretiosiora illo mari vexit, animosius a mercatore quam a vectore solvitur votum, et ex ipsis mercatoribus effusius gratus est qui odores ac purpuras et auro pensanda portabat quam qui vilissima quaeque et saburrae loco futura congesserat, sic huius pacis beneficium ad omnis pertinentis altius ad eos pervenit qui illa bene utuntur. Multi enim sunt ex his togatis quibus pax operosior bello est: an idem existimas pro pace debere eos qui illam ebrietati aut libidini inpendunt aut aliis vitiis quae vel bello rumpenda sunt? Nisi forte tam iniquum putas esse sapientem ut nihil viritim se debere pro communibus bonis iudicet. Soli lunaeque plurimum debeo, et non uni mihi oriuntur; anno temperantique annum deo privatim obligatus sum, quamvis nihil in meum honorem * * * discripta sint. Stulta avaritia mortalium possessionem proprietatemque discernit nec quicquam suum credit esse quod publicum est; at ille sapiens nihil magis suum iudicat quam cuius illi cum humano genere consortium est. Nec enim essent ista communia, nisi pars illorum pertineret ad singulos; socium efficit etiam quod ex minima portione commune est. Adice nunc quod magna et vera bona non sic dividuntur ut exiguum in singulos cadat: ad unumquemque tota perveniunt. Ex congiario tantum ferunt homines quantum in capita promissum est; epulum et visceratio et quidquid aliud manu capitur discedit in partes: at haec individua bona, pax et libertas, ea tam omnium tota quam singulorum sunt. Cogitat itaque per quem sibi horum usus fructusque contingat, per quem non ad arma illum nec ad servandas vigilias nec ad tuenda moenia et multiplex belli tributum publica necessitas vocet, agitque gubernatori suo gratias. Hoc docet philosophia praecipue, bene debere beneficia, bene solvere; interdum autem solutio est ipsa confessio. Confitebitur ergo multum se debere ei cuius administratione ac providentia contingit illi pingue otium et arbitrium sui temporis et inperturbata publicis occupationibus quies. O Meliboee, deus nobis haec otia fecit; namque erit ille mihi semper deus. Si illa quoque otia multum auctori suo debent quorum munus hoc maximum est,
ille meas errare boves, ut cernis, et ipsum ludere quae vellem calamo permisit agresti, quanti aestimamus hoc otium quod inter deos agitur, quod deos facit? Ita dico, Lucili, et te in caelum compendiario voco. Solebat Sextius dicere Iovem plus non posse quam bonum virum. Plura Iuppiter habet quae praestet hominibus, sed inter duos bonos non est melior qui locupletior, non magis quam inter duos quibus par scientia regendi gubernaculum est meliorem dixeris cui maius speciosiusque navigium est. Iuppiter quo antecedit virum bonum? Diutius bonus est: sapiens nihilo se minoris aestimat quod virtutes eius spatio breviore cluduntur. Quemadmodum ex duobus sapientibus qui senior decessit non est beatior eo cuius intra pauciores annos terminata virtus est, sic deus non vincit sapientem felicitate, etiam si vincit aetate; non est virtus maior quae longior. Iuppiter omnia habet, sed nempe aliis tradidit habenda: ad ipsum hic unus usus pertinet, quod utendi omnibus causa est: sapiens tam aequo animo omnia apud alios videt contemnitque quam Iuppiter et hoc se magis suspicit quod Iuppiter uti illis non potest, sapiens non vult. Credamus itaque Sextio monstranti pulcherrimum iter et clamanti «hac itur ad astra, hac secundum frugalitatem, hac secundum temperantiam, hac secundum fortitudinem». Non sunt dii fastidiosi, non invidi: admittunt et ascendentibus manum porrigunt. Miraris hominem ad deos ire? Deus ad homines venit, immo quod est propius, in homines venit: nulla sine deo mens bona est. Semina in corporibus humanis divina dispersa sunt, quae si bonus cultor excipit, similia origini prodeunt et paria iis ex quibus orta sunt surgunt: si malus, non aliter quam humus sterilis ac palustris necat ac deinde creat purgamenta pro frugibus. Vale. 74. Epistula tua delectavit me et marcentem excitavit; memoriam quoque meam, quae iam mihi segnis ac lenta est, evocavit. Quidni tu, mi Lucili, maximum putes instrumentum vitae beatae hanc persuasionem unum bonum esse quod honestum est? Nam qui alia bona iudicat in fortunae venit potestatem, alieni arbitrii fit: qui omne bonum honesto circumscripsit intra se felix est. Hic amissis liberis maestus, hic sollicitus aegris, hic turpibus et aliqua sparsis infamia tristis; illum videbis alienae uxoris amore cruciari, illum suae; non deerit quem repulsa distorqueat; erunt quos ipse honor vexet. Illa vero maxima ex omni mortalium populo turba miserorum quam expectatio mortis exagitat undique inpendens; nihil enim est unde non subeat. Itaque, ut in hostili regione versantibus, huc et illuc circumspiciendum est et ad omnem strepitum circumagenda cervix; nisi hic timor e pectore eiectus est, palpitantibus praecordiis vivitur. Occurrent acti in exilium et evoluti bonis; occurrent, quod genus egestatis gravissimum est, in divitis
inopes; occurrent naufragi similiave naufragis passi, quos aut popularis ira aut invidia, perniciosum optimis telum, inopinantis securosque disiecit procellae more quae in ipsa sereni fiducia solet emergere, aut fulminis subiti ad cuius ictum etiam vicina tremuerunt. Nam ut illic quisquis ab igne propior stetit percusso similis obstipuit, sic in his per aliquam vim accidentibus unum calamitas opprimit, ceteros metus, paremque passis tristitiam facit pati posse. Omnium animos mala aliena ac repentina sollicitant. Quemadmodum aves etiam inanis fundae sonus territat, ita nos non ad ictum tantum exagitamur sed ad crepitum. Non potest ergo quisquam beatus esse qui huic se opinioni credidit. Non enim beatum est nisi quod intrepidum; inter suspecta male vivitur. Quisquis se multum fortuitis dedit ingentem sibi materiam perturbationis et inexplicabilem fecit: una haec via est ad tuta vadenti, externa despicere et honesto esse contentum. Nam qui aliquid virtute melius putat aut ullum praeter illam bonum, ad haec quae a fortuna sparguntur sinum expandit et sollicitus missilia eius expectat. Hanc enim imaginem animo tuo propone, ludos facere fortunam et in hunc mortalium coetum honores, divitias, gratiam excutere, quorum alia inter diripientium manus scissa sunt, alia infida societate divisa, alia magno detrimento eorum in quos devenerant prensa. Ex quibus quaedam aliud agentibus inciderunt, quaedam, quia nimis captabantur, amissa et dum avide rapiuntur expulsa sunt: nulli vero, etiam cui rapina feliciter cessit, gaudium rapti duravit in posterum. Itaque prudentissimus quisque, cum primum induci videt munuscula, a theatro fugit et scit magno parva constare. Nemo manum conserit cum recedente, nemo exeuntem ferit: circa praemium rixa est. Idem in his evenit quae fortuna desuper iactat: aestuamus miseri, distringimur, multas habere cupimus manus, modo in hanc partem, modo in illam respicimus; nimis tarde nobis mitti videntur quae cupiditates nostras inritant, ad paucos perventura, expectata omnibus; ire obviam cadentibus cupimus; gaudemus si quid invasimus invadendique aliquos spes vana delusit; vilem praedam magno aliquo incommodo luimus aut †de† fallimur. Secedamus itaque ab istis ludis et demus raptoribus locum; illi spectent bona ista pendentia et ipsi magis pendeant. Quicumque beatus esse constituet, unum esse bonum putet quod honestum est; nam si ullum aliud existimat, primum male de providentia iudicat, quia multa incommoda iustis viris accidunt, et quia quidquid nobis dedit breve est et exiguum si compares mundi totius aevo. Ex hac deploratione nascitur ut ingrati divinorum interpretes simus: querimur quod non semper, quod et pauca nobis et incerta et abitura contingant. Inde est quod nec vivere nec mori volumus: vitae nos odium tenet, timor mortis. Natat omne consilium nec implere nos ulla felicitas potest. Causa autem est quod non pervenimus ad illud bonum immensum et insuperabile ubi necesse est resistat voluntas nostra quia ultra summum non est locus. Quaeris quare virtus nullo egeat? Praesentibus gaudet, non concupiscit absentia; nihil non illi magnum est quod satis. Ab hoc discede iudicio: non pietas constabit, non fides; multa enim utramque praestare cupienti patienda sunt ex iis quae mala vocantur, multa inpendenda ex iis quibus indulgemus tamquam bonis.
Perit fortitudo, quae periculum facere debet sui; perit magnanimitas, quae non potest eminere nisi omnia velut minuta contempsit quae pro maximis vulgus optat; perit gratia et relatio gratiae si timemus laborem, si quicquam pretiosius fide novimus, si non optima spectamus. Sed ut illa praeteream, aut ista bona non sunt quae vocantur aut homo felicior deo est, quoniam quidem quae cara nobis sunt non habet in usu deus; nec enim libido ad illum nec epularum lautitia nec opes nec quicquam ex his hominem inescantibus et vili voluptate ducentibus pertinet. Ergo aut credibile est bona deo deesse aut hoc ipsum argumentum est bona non esse, quod deo desunt. Adice quod multa quae bona videri volunt animalibus quam homini pleniora contingunt. Illa cibo avidius utuntur, venere non aeque fatigantur; virium illis maior est et aequabilior firmitas: sequitur ut multo feliciora sint homine. Nam sine nequitia, sine fraudibus degunt; fruuntur voluptatibus, quas et magis capiunt et ex facili, sine ullo pudoris aut paenitentiae metu. Considera tu itaque an id bonum vocandum sit quo deus ab homine, homo ab animalibus vincitur. Summum bonum in animo contineamus: obsolescit si ab optima nostri parte ad pessimam transit et transfertur ad sensus, qui agiliores sunt animalibus mutis. Non est summa felicitatis nostrae in carne ponenda: bona illa sunt vera quae ratio dat, solida ac sempiterna, quae cadere non possunt, ne decrescere quidem ac minui. Cetera opinione bona sunt et nomen quidem habent commune cum veris, proprietas in illis boni non est; itaque commoda vocentur et, ut nostra lingua loquar, producta. Ceterum sciamus mancipia nostra esse, non partes, et sint apud nos, sed ita ut meminerimus extra nos esse; etiam si apud nos sint, inter subiecta et humilia numerentur propter quae nemo se attollere debeat. Quid enim stultius quam aliquem eo sibi placere quod ipse non fecit? Omnia ista nobis accedant, non haereant, ut si abducentur, sine ulla nostri laceratione discedant. Utamur illis, non gloriemur, et utamur parce tamquam depositis apud nos et abituris. Quisquis illa sine ratione possedit non diu tenuit; ipsa enim se felicitas, nisi temperatur, premit. Si fugacissimis bonis credidit, cito deseritur, et, ut deseratur, adfligitur. Paucis deponere felicitatem molliter licuit: ceteri cum iis inter quae eminuere labuntur, et illos degravant ipsa quae extulerant. Ideo adhibebitur prudentia, quae modum illis ac parsimoniam inponat, quoniam quidem licentia opes suas praecipitat atque urget, nec umquam inmodica durarunt nisi illa moderatrix ratio conpescuit. Hoc multarum tibi urbium ostendet eventus, quarum in ipso flore luxuriosa imperia ceciderunt, et quidquid virtute partum erat intemperantia corruit. Adversus hos casus muniendi sumus. Nullus autem contra fortunam inexpugnabilis murus est: intus instruamur; si illa pars tuta est, pulsari homo potest, capi non potest. Quod sit hoc instrumentum scire desideras? Nihil indignetur sibi accidere sciatque illa ipsa quibus laedi videtur ad conservationem universi pertinere et ex iis esse quae cursum mundi officiumque consummant; placeat homini quidquid deo placuit; ob hoc ipsum se suaque miretur, quod non potest vinci, quod mala ipsa sub se tenet, quod ratione, qua valentius nihil est, casum doloremque et iniuriam subigit. Ama rationem! huius te amor contra
durissima armabit. Feras catulorum amor in venabula inpingit feritasque et inconsultus impetus praestat indomitas; iuvenilia nonnumquam ingenia cupido gloriae in contemptum tam ferri quam ignium misit; species quosdam atque umbra virtutis in mortem voluntariam trudit: quanto his omnibus fortior ratio est, quanto constantior, tanto vehementius per metus ipsos et pericula exibit. «Nihil agitis» inquit «quod negatis ullum esse aliud honesto bonum: non faciet vos haec munitio tutos a fortuna et inmunes. Dicitis enim inter bona esse liberos pios et bene moratam patriam et parentes bonos. Horum pericula non potestis spectare securi: perturbabit vos obsidio patriae, liberorum mors, parentum servitus». Quid adversus hos pro nobis responderi soleat ponam; deinde tunc adiciam quid praeterea respondendum putem. Alia condicio est in iis quae ablata in locum suum aliquid incommodi substituunt: tamquam bona valetudo vitiata in malam transfert; acies oculorum extincta caecitate nos adficit; non tantum velocitas perit poplitibus incisis, sed debilitas pro illa subit. Hoc non est periculum in iis quae paulo ante rettulimus. Quare? Si amicum bonum amisi, non est mihi pro illo perfidia patienda, nec si bonos liberos extuli, in illorum locum impietas succedit. Deinde non amicorum illic aut liberorum interitus sed corporum est. Bonum autem uno modo perit, si in malum transit; quod natura non patitur, quia omnis virtus et opus omne virtutis incorruptum manet. Deinde etiam si amici perierunt, etiam si probati respondentesque voto patris liberi, est quod illorum expleat locum. Quid sit quaeris? Quod illos quoque bonos fecerat, virtus. Haec nihil vacare patitur loci, totum animum tenet, desiderium omnium tollit, sola satis est; omnium enim bonorum vis et origo in ipsa est. Quid refert an aqua decurrens intercipiatur atque abeat, si fons ex quo fluxerat salvus est? Non dices vitam iustiorem salvis liberis quam amissis nec ordinatiorem nec prudentiorem nec honestiorem; ergo ne meliorem quidem. Non facit adiectio amicorum sapientiorem, non facit stultiorem detractio; ergo nec beatiorem aut miseriorem. Quamdiu virtus salva fuerit, non senties quidquid abscesserit. «Quid ergo? Non est beatior et amicorum et liberorum turba succinctus?». Quidni non sit? Summum enim bonum nec infringitur nec augetur; in suo modo permanet, utcumque fortuna se gessit. Sive illi senectus longa contigit sive citra senectutem finitus est, eadem mensura summi boni est, quamvis aetatis diversa sit. Utrum maiorem an minorem circulum scribas ad spatium eius pertinet, non ad formam: licet alter diu manserit, alterum statim obduxeris et in eum in quo scriptus est pulverem solveris, in eadem uterque forma fuit. Quod rectum est nec magnitudine aestimatur nec numero nec tempore; non magis produci quam contrahi potest. Honestam vitam ex centum annorum numero in quantum voles corripe et in unum diem coge: aeque honesta est. Modo latius virtus funditur, regna urbes provincias temperat, fert leges, colit amicitias, inter propinquos liberosque dispensat officia, modo arto fine circumdatur paupertatis exilii orbitatis; non tamen minor est si ex altiore fastigio in humile subducitur, in privatum ex regio, ex publico et spatioso iure in angustias domus vel anguli coit.
Aeque magna est, etiam si in se recessit undique exclusa; nihilominus enim magni spiritus est et erecti, exactae prudentiae, indeclinabilis iustitiae. Ergo aeque beata est; beatum enim illud uno loco positum est, in ipsa mente, stabile, grande, tranquillum, quod sine scientia divinorum humanorumque non potest effici. Sequitur illud quod me responsurum esse dicebam. Non adfligitur sapiens liberorum amissione, non amicorum; eodem enim animo fert illorum mortem quo suam expectat; non magis hanc timet quam illam dolet. Virtus enim convenientia constat: omnia opera eius cum ipsa concordant et congruunt. Haec concordia perit si animus, quem excelsum esse oportet, luctu aut desiderio summittitur. Inhonesta est omnis trepidatio et sollicitudo, in ullo actu pigritia; honestum enim securum et expeditum est, interritum est, in procinctu stat. «Quid ergo? Non aliquid perturbationi simile patietur? Non et color eius mutabitur et vultus agitabitur et artus refrigescent? Et quidquid aliud non ex imperio animi, sed inconsulto quodam naturae impetu geritur?». Fateor; sed manebit illi persuasio eadem, nihil illorum malum esse nec dignum ad quod mens sana deficiat. Omnia quae facienda erunt audaciter faciet et prompte. Hoc enim stultitiae proprium quis dixerit, ignave et contumaciter facere quae faciat, et alio corpus inpellere, alio animum, distrahique inter diversissimos motus. Nam propter illa ipsa quibus extollit se miraturque contempta est, et ne illa quidem quibus gloriatur libenter facit. Si vero aliquod timetur malum, eo proinde, dum expectat, quasi venisset urguetur, et quidquid ne patiatur timet iam metu patitur. Quemadmodum in corporibus infirmis languorem signa praecurrunt – quaedam enim segnitia enervis est et sine labore ullo lassitudo et oscitatio et horror membra percurrens – sic infirmus animus multo ante quam opprimatur malis quatitur; praesumit illa et ante tempus cadit. Quid autem dementius quam angi futuris nec se tormento reservare, sed arcessere sibi miserias et admovere? Quas optimum est differre, si discutere non possis. Vis scire futuro neminem debere torqueri? Quicumque audierit post quinquagesimum annum sibi patienda supplicia, non perturbatur nisi si medium spatium transiluerit et se in illam saeculo post futuram sollicitudinem inmiserit: eodem modo fit ut animos libenter aegros et captantes causas doloris vetera atque obliterata contristent. Et quae praeterierunt et quae futura sunt absunt: neutra sentimus. Non est autem nisi ex eo quod sentias dolor. Vale.
Liber nonus 75. Minus tibi accuratas a me epistulas mitti quereris. Quis enim accurate loquitur nisi qui vult putide loqui? Qualis sermo meus esset si una desideremus aut ambularemus, inlaboratus et facilis, tales esse epistulas meas volo, quae nihil habent accersitum nec fictum. Si fieri posset, quid sentiam ostendere quam loqui mallem. Etiam si disputarem, nec supploderem pedem nec manum iactarem nec attollerem vocem, sed ista oratoribus reliquissem, contentus sensus meos ad te pertulisse, quos nec exornassem nec abiecissem. Hoc unum plane tibi adprobare vellem, omnia me illa sentire quae dicerem, nec tantum sentire sed amare. Aliter homines amicam, aliter liberos osculantur; tamen in hoc quoque amplexu tam sancto et moderato satis apparet adfectus. Non mehercules ieiuna esse et arida volo quae de rebus tam magnis dicentur (neque enim philosophia ingenio renuntiat), multum tamen operae inpendi verbis non oportet. Haec sit propositi nostri summa: quod sentimus loquamur, quod loquimur sentiamus; concordet sermo cum vita. Ille promissum suum implevit qui et cum videas illum et cum audias idem est. Videbimus qualis sit, quantus sit: unus est. Non delectent verba nostra sed prosint. Si tamen contingere eloquentia non sollicito potest, si aut parata est aut parvo constat, adsit et res pulcherrimas prosequatur: sit talis ut res potius quam se ostendat. Aliae artes ad ingenium totae pertinent, hic animi negotium agitur. Non quaerit aeger medicum eloquentem, sed si ita competit ut idem ille qui sanare potest compte de iis quae facienda sunt disserat, boni consulet. Non tamen erit quare gratuletur sibi quod inciderit in medicum etiam disertum; hoc enim tale est quale si peritus gubernator etiam formosus est. Quid aures meas scabis? Quid oblectas? Aliud agitur: urendus, secandus, abstinendus sum. Ad haec adhibitus es; curare debes morbum veterem, gravem, publicum; tantum negotii habes quantum in pestilentia medicus. Circa verba occupatus es? Iamdudum gaude si sufficis rebus. Quando tam multa disces? Quando quae didiceris adfiges tibi ita ut excidere non possint? Quando illa experieris? Non enim, ut cetera, memoriae tradidisse satis est: in opere temptanda sunt; non est beatus qui scit illa, sed qui facit. «Quid ergo? Infra illum nulli gradus sunt? Statim a sapientia praeceps est?» Non, ut existimo; nam qui proficit in numero quidem stultorum est, magno tamen intervallo ab illis diducitur. Inter ipsos quoque proficientes sunt magna discrimina: in tres classes, ut quibusdam placet, dividuntur. Primi sunt qui sapientiam nondum habent sed iam in vicinia eius constiterunt; tamen etiam quod prope est extra est. Qui sint hi quaeris? Qui omnes iam adfectus ac vitia posuerunt, quae erant conplectenda didicerunt, sed illis adhuc inexperta fiducia est. Bonum suum nondum in usu habent, iam tamen in illa quae fugerunt decidere non possunt; iam ibi sunt unde non est retro lapsus, sed hoc illis de se nondum liquet: quod in quadam epistula scripsisse me memini, «scire se nesciunt». Iam contigit illis bono suo frui, nondum confidere. Quidam hoc proficientium genus de quo locutus sum ita conplectuntur ut illos dicant iam
effugisse morbos animi, adfectus nondum, et adhuc in lubrico stare, quia nemo sit extra periculum malitiae nisi qui totam eam excussit; nemo autem illam excussit nisi qui pro illa sapientiam adsumpsit. Quid inter morbos animi intersit et adfectus saepe iam dixi. Nunc quoque te admonebo: morbi sunt inveterata vitia et dura, ut avaritia, ut ambitio; nimio artius haec animum inplicuerunt et perpetua eius mala esse coeperunt. Ut breviter finiam, morbus est iudicium in pravo pertinax, tamquam valde expetenda sint quae leviter expetenda sunt; vel, si mavis, ita finiamus: nimis inminere leviter petendis vel ex toto non petendis, aut in magno pretio habere in aliquo habenda vel in nullo. Adfectus sunt motus animi inprobabiles, subiti et concitati, qui frequentes neglectique fecere morbum, sicut destillatio una nec adhuc in morem adducta tussim facit, adsidua et vetus pthisin. Itaque qui plurimum profecere extra morbos sunt, adfectus adhuc sentiunt perfecto proximi. Secundum genus est eorum qui et maxima animi mala et adfectus deposuerunt, sed ita ut non sit illis securitatis suae certa possessio; possunt enim in eadem relabi. Tertium illud genus extra multa et magna vitia est, sed non extra omnia. Effugit avaritiam sed iram adhuc sentit; iam non sollicitatur libidine, etiamnunc ambitione; iam non concupiscit, sed adhuc timet, et in ipso metu ad quaedam satis firmus est, quibusdam cedit: mortem contemnit, dolorem reformidat. De hoc loco aliquid cogitemus: bene nobiscum agetur, si in hunc admittimur numerum. Magna felicitate naturae magnaque et adsidua intentione studii secundus occupatur gradus; sed ne hic quidem contemnendus est color tertius. Cogita quantum circa te videas malorum; aspice quam nullum sit nefas sine exemplo, quantum cotidie nequitia proficiat, quantum publice privatimque peccetur: intelleges satis nos consequi, si inter pessimos non sumus. «Ego vero» inquis «spero me posse et amplioris ordinis fieri». Optaverim hoc nobis magis quam promiserim: praeoccupati sumus, ad virtutem contendimus inter vitia districti. Pudet dicere: honesta colimus quantum vacat. At quam grande praemium expectat, si occupationes nostras et mala tenacissima abrumpimus! Non cupiditas nos, non timor pellet; inagitati terroribus, incorrupti voluptatibus, nec mortem horrebimus nec deos; sciemus mortem malum non esse, deos malo non esse. Tam inbecillum est quod nocet quam cui nocetur: optima vi noxia carent. Expectant nos, si ex hac aliquando faece in illud evadimus sublime et excelsum, tranquillitas animi et expulsis erroribus absoluta libertas. Quaeris quae sit ista? Non homines timere, non deos; nec turpia velle nec nimia; in se ipsum habere maximam potestatem: inaestimabile bonum est suum fieri. Vale. 76. Inimicitias mihi denuntias si quicquam ex iis quae cotidie facio ignoraveris. Vide quam simpliciter tecum vivam: hoc quoque tibi committam. Philosophum audio et quidem quintum iam diem habeo ex quo in scholam eo et ab octava disputantem audio. «Bona» inquis «aetate». Quidni bona? Quid autem stultius est quam quia diu non didiceris non discere? «Quid ergo? Idem faciam
quod trossuli et iuvenes?». Bene mecum agitur si hoc unum senectutem meam dedecet: omnis aetatis homines haec schola admittit. «In hoc senescamus, ut iuvenes sequamur?». In theatrum senex ibo et in circum deferar et nullum par sine me depugnabit: ad philosophum ire erubescam? Tamdiu discendum est quamdiu nescias; si proverbio credimus, quamdiu vivas. Nec ulli hoc rei magis convenit quam huic: tamdiu discendum est quemadmodum vivas quamdiu vivas. Ego tamen illic aliquid et doceo. Quaeris quid doceam? Etiam seni esse discendum. Pudet autem me generis humani quotiens scholam intravi. Praeter ipsum theatrum Neapolitanorum, ut scis, transeundum est Metronactis petenti domum. Illud quidem fartum est, et ingenti studio quis sit pythaules bonus iudicatur; habet tubicen quoque Graecus et praeco concursum: at in illo loco in quo vir bonus quaeritur, in quo vir bonus discitur, paucissimi sedent, et hi plerisque videntur nihil boni negotii habere quod agant; inepti et inertes vocantur. Mihi contingat iste derisus: aequo animo audienda sunt inperitorum convicia et ad honesta vadenti contemnendus est ipse contemptus. Perge, Lucili, et propera, ne tibi accidat quod mihi, ut senex discas; immo ideo magis propera quoniam id nunc adgressus es quod perdiscere vix senex possis. «Quantum» inquis «proficiam?» Quantum temptaveris. Quid expectas? Nulli sapere casu obtigit. Pecunia veniet ultro, honor offeretur, gratia ac dignitas fortasse ingerentur tibi: virtus in te non incidet. Ne levi quidem opera aut parvo labore cognoscitur; sed est tanti laborare omnia bona semel occupaturo. Unum est enim bonum quod honestum: in illis nihil invenies veri, nihil certi, quaecumque famae placent. Quare autem unum sit bonum quod honestum dicam, quoniam parum me exsecutum priore epistula iudicas magisque hanc rem tibi laudatam quam probatam putas, et in artum quae dicta sunt contraham. Omnia suo bono constant. Vitem fertilitas commendat et sapor vini, velocitas cervum; quam fortia dorso iumenta sint quaeris, quorum hic unus est usus, sarcinam ferre; in cane sagacitas prima est, si investigare debet feras, cursus, si consequi, audacia, si mordere et invadere: id in quoque optimum esse debet cui nascitur, quo censetur. In homine quid est optimum? Ratio: hac antecedit animalia, deos sequitur. Ratio ergo perfecta proprium bonum est, cetera illi cum animalibus satisque communia sunt. Valet: et leones. Formonsus est: et pavones. Velox est: et equi. Non dico, in his omnibus vincitur; non quaero quid in se maximum habeat, sed quid suum. Corpus habet: et arbores. Habet impetum ac motum voluntarium: et bestiae et vermes. Habet vocem: sed quanto clariorem canes, acutiorem aquilae, graviorem tauri, dulciorem mobilioremque luscinii? Quid est in homine proprium? Ratio: haec recta et consummata felicitatem hominis implevit. Ergo si omnis res, cum bonum suum perfecit, laudabilis est et ad finem naturae suae pervenit, homini autem suum bonum ratio est, si hanc perfecit laudabilis est et finem naturae suae tetigit. Haec ratio perfecta virtus vocatur eademque honestum est. Id itaque unum bonum est in homine quod unum hominis est; nunc enim non quaerimus quid sit bonum, sed quid sit hominis bonum. Si nullum aliud est hominis quam ratio, haec erit unum eius bonum, sed
pensandum cum omnibus. Si sit aliquis malus, puto inprobabitur; si bonus, puto probabitur. Id ergo in homine primum solumque est quo et probatur et inprobatur. Non dubitas an hoc sit bonum; dubitas an solum bonum sit. Si quis omnia alia habeat, valetudinem, divitias, imagines multas, frequens atrium, sed malus ex confesso sit, inprobabis illum; item si quis nihil quidem eorum quae rettuli habeat, deficiatur pecunia, clientium turba, nobilitate et avorum proavorumque serie, sed ex confesso bonus sit, probabis illum. Ergo hoc unum est bonum hominis, quod qui habet, etiam si aliis destituitur, laudandus est, quod qui non habet in omnium aliorum copia damnatur ac reicitur. Quae condicio rerum, eadem hominum est: navis bona dicitur non quae pretiosis coloribus picta est nec cui argenteum aut aureum rostrum est nec cuius tutela ebore caelata est nec quae fiscis atque opibus regiis pressa est, sed stabilis et firma et iuncturis aquam excludentibus spissa, ad ferendum incursum maris solida, gubernaculo parens, velox et non sentiens ventum; gladium bonum dices non cui auratus est balteus nec cuius vagina gemmis distinguitur, sed cui et ad secandum subtilis acies est et mucro munimentum omne rupturus; regula non quam formosa, sed quam recta sit quaeritur: eo quidque laudatur cui comparatur, quod illi proprium est. Ergo in homine quoque nihil ad rem pertinet quantum aret, quantum feneret, a quam multis salutetur, quam pretioso incumbat lecto, quam perlucido poculo bibat, sed quam bonus sit. Bonus autem est si ratio eius explicita et recta est et ad naturae suae voluntatem accommodata. Haec vocatur virtus, hoc est honestum et unicum hominis bonum. Nam cum sola ratio perficiat hominem, sola ratio perfecte beatum facit; hoc autem unum bonum est quo uno beatus efficitur. Dicimus et illa bona esse quae a virtute profecta contractaque sunt, id est opera eius omnia; sed ideo unum ipsa bonum est quia nullum sine illa est. Si omne in animo bonum est, quidquid illum confirmat, extollit, amplificat, bonum est; validiorem autem animum et excelsiorem et ampliorem facit virtus. Nam cetera quae cupiditates nostras inritant deprimunt quoque animum et labefaciunt et cum videntur attollere inflant ac multa vanitate deludunt. Ergo id unum bonum est quo melior animus efficitur. Omnes actiones totius vitae honesti ac turpis respectu temperantur; ad haec faciendi et non faciendi ratio derigitur. Quid sit hoc dicam: vir bonus quod honeste se facturum putaverit faciet etiam si laboriosum erit, faciet etiam si damnosum erit, faciet etiam si periculosum erit; rursus quod turpe erit non faciet, etiam si pecuniam adferet, etiam si voluptatem, etiam si potentiam; ab honesto nulla re deterrebitur, ad turpia nulla invitabitur. Ergo si honestum utique secuturus est, turpe utique vitaturus, et in omni actu vitae spectaturus haec duo, nec aliud bonum quam honestum nec aliud malum quam turpe, si una indepravata virtus est et sola permanet tenoris sui, unum est bonum virtus, cui iam accidere ne sit bonum non potest. Mutationis periculum effugit: stultitia ad sapientiam erepit, sapientia in stultitiam non revolvitur. Dixi, si forte meministi, et concupita vulgo et formidata inconsulto impetu plerosque calcasse: inventus est qui divitias proiceret, inventus est qui flammis manum inponeret, cuius risum non interrumperet tortor, qui in funere liberorum
lacrimam non mitteret, qui morti non trepidus occurreret; amor enim, ira, cupiditas pericula depoposcerunt. Quod potest brevis obstinatio animi, aliquo stimulo excitata, quanto magis virtus, quae non ex impetu nec subito sed aequaliter valet, cui perpetuum robur est? Sequitur ut quae ab inconsultis saepe contemnuntur, a sapientibus semper, ea nec bona sint nec mala. Unum ergo bonum ipsa virtus est, quae inter hanc fortunam et illam superba incedit cum magno utriusque contemptu. Si hanc opinionem receperis, aliquid bonum esse praeter honestum, nulla non virtus laborabit; nulla enim obtineri poterit si quicquam extra se respexerit. Quod si est, rationi repugnat, ex qua virtutes sunt, et veritati, quae sine ratione non est; quaecumque autem opinio veritati repugnat falsa est. Virum bonum concedas necesse est summae pietatis erga deos esse. Itaque quidquid illi accidit aequo animo sustinebit; sciet enim id accidisse lege divina qua universa procedunt. Quod si est, unum illi bonum erit quod honestum; in hoc enim positum est et parere diis nec excandescere ad subita nec deplorare sortem suam, sed patienter excipere fatum et facere imperata. Si ullum aliud est bonum quam honestum, sequetur nos aviditas vitae, aviditas rerum vitam instruentium, quod est intolerabile, infinitum, vagum. Solum ergo bonum est honestum, cui modus est. Diximus futuram hominum feliciorem vitam quam deorum, si ea bona sunt quorum nullus diis usus est, tamquam pecunia, honores. Adice nunc quod, si modo solutae corporibus animae manent, felicior illis status restat quam est dum versantur in corpore. Atqui si ista bona sunt quibus per corpora utimur, emissis erit peius, quod contra fidem est, feliciores esse liberis et in universum datis clusas et obsessas. Illud quoque dixeram, si bona sunt ea quae tam homini contingunt quam mutis animalibus, et muta animalia beatam vitam actura; quod fieri nullo modo potest. Omnia pro honesto patienda sunt; quod non erat faciendum si esset ullum aliud bonum quam honestum. Haec quamvis latius exsecutus essem priore epistula, constrinxi et breviter percucurri. Numquam autem vera tibi opinio talis videbitur, nisi animum adleves et te ipse interroges, si res exegerit ut pro patria moriaris et salutem omnium civium tua redimas, an porrecturus sis cervicem non tantum patienter sed etiam libenter. Si hoc facturus es, nullum aliud bonum est; omnia enim relinquis ut hoc habeas. Vide quanta vis honesti sit: pro re publica morieris, etiam si statim facturus hoc eris cum scieris tibi esse faciendum. Interdum ex re pulcherrima magnum gaudium etiam exiguo tempore ac brevi capitur, et quamvis fructus operis peracti nullus ad defunctum exemptumque rebus humanis pertineat, ipsa tamen contemplatio futuri operis iuvat, et vir fortis ac iustus, cum mortis suae pretia ante se posuit, libertatem patriae, salutem omnium pro quibus dependit animam, in summa voluptate est et periculo suo fruitur. Sed ille quoque cui etiam hoc gaudium eripitur quod tractatio operis maximi et ultimi praestat, nihil cunctatus desiliet in mortem, facere recte pieque contentus. Oppone etiamnunc illi multa quae dehortentur, dic, «factum tuum matura sequetur oblivio et parum grata existimatio civium». Respondebit tibi, «ista omnia extra opus meum sunt,
ego ipsum contemplor; hoc esse honestum scio; itaque quocumque ducit ac vocat venio». Hoc ergo unum bonum est, quod non tantum perfectus animus sed generosus quoque et indolis bonae sentit: cetera levia sunt, mutabilia. Itaque sollicite possidentur; etiam si favente fortuna in unum congesta sunt, dominis suis incubant gravia et illos semper premunt, aliquando et inludunt. Nemo ex istis quos purpuratos vides felix est, non magis quam ex illis quibus sceptrum et chlamydem in scaena fabulae adsignant: cum praesente populo lati incesserunt et coturnati, simul exierunt, excalceantur et ad staturam suam redeunt. Nemo istorum quos divitiae honoresque in altiore fastigio ponunt magnus est. Quare ergo magnus videtur? Cum basi illum sua metiris. Non est magnus pumilio licet in monte constiterit; colossus magnitudinem suam servabit etiam si steterit in puteo. Hoc laboramus errore, sic nobis inponitur, quod neminem aestimamus eo quod est, sed adicimus illi et ea quibus adornatus est. Atqui cum voles veram hominis aestimationem inire et scire qualis sit, nudum inspice; ponat patrimonium, ponat honores et alia fortunae mendacia, corpus ipsum exuat: animum intuere, qualis quantusque sit, alieno an suo magnus. Si rectis oculis gladios micantes videt et si scit sua nihil interesse utrum anima per os an per iugulum exeat, beatum voca; si cum illi denuntiata sunt corporis tormenta et quae casu veniunt et quae potentioris iniuria, si vincula et exilia et vanas humanarum formidines mentium securus audit et dicit: «non ulla laborum, o virgo, nova mi facies inopinave surgit; omnia praecepi atque animo mecum ipse peregi. Tu hodie ista denuntias: ego semper denuntiavi mihi et hominem paravi ad humana». Praecogitati mali mollis ictus venit. At stultis et fortunae credentibus omnis videtur nova rerum et inopinata facies; magna autem pars est apud inperitos mali novitas. Hoc ut scias, ea quae putaverant aspera fortius, cum adsuevere, patiuntur. Ideo sapiens adsuescit futuris malis, et quae alii diu patiendo levia faciunt hic levia facit diu cogitando. Audimus aliquando voces inperitorum dicentium «sciebam hoc mihi restare»: sapiens scit sibi omnia restare; quidquid factum est, dicit «sciebam». Vale. 77. Subito nobis hodie Alexandrinae naves apparuerunt, quae praemitti solent et nuntiare secuturae classis adventum: tabellarias vocant. Gratus illarum Campaniae aspectus est: omnis in pilis Puteolorum turba consistit et ex ipso genere velorum Alexandrinas quamvis in magna turba navium intellegit; solis enim licet siparum intendere, quod in alto omnes habent naves. Nulla enim res aeque adiuvat cursum quam summa pars veli; illinc maxime navis urgetur. Itaque quotiens ventus increbruit maiorque est quam expedit, antemna summittitur: minus habet virium flatus ex humili. Cum intravere Capreas et promunturium ex quo
alta procelloso speculatur vertice Pallas, ceterae velo iubentur esse contentae: siparum Alexandrinarum insigne est. In hoc omnium discursu properantium ad litus magnam ex pigritia mea sensi voluptatem, quod epistulas meorum accepturus non properavi scire quis illic esset rerum mearum status, quid adferrent: olim iam nec perit quicquam mihi nec adquiritur. Hoc, etiam si senex non essem, fuerat sentiendum, nunc vero multo magis: quantulumcumque haberem, tamen plus iam mihi superesset viatici quam viae, praesertim cum eam viam simus ingressi quam peragere non est necesse. Iter inperfectum erit si in media parte aut citra petitum locum steteris: vita non est inperfecta si honesta est; ubicumque desines, si bene desines, tota est. Saepe autem et fortiter desinendum est et non ex maximis causis; nam nec eae maximae sunt quae nos tenent. Tullius Marcellinus, quem optime noveras, adulescens quietus et cito senex, morbo et non insanabili correptus sed longo et molesto et multa imperante, coepit deliberare de morte. Convocavit complures amicos. Unusquisque aut, quia timidus erat, id illi suadebat quod sibi suasisset, aut, quia adulator et blandus, id consilium dabat quod deliberanti gratius fore suspicabatur. Amicus noster Stoicus, homo egregius et, ut verbis illum quibus laudari dignus est laudem, vir fortis ac strenuus, videtur mihi optime illum cohortatus. Sic enim coepit: «noli, mi Marcelline, torqueri tamquam de re magna deliberes. Non est res magna vivere: omnes servi tui vivunt, omnia animalia: magnum est honeste mori, prudenter, fortiter. Cogita quamdiu iam idem facias: cibus, somnus, libido – per hunc circulum curritur; mori velle non tantum prudens aut fortis aut miser, etiam fastidiosus potest». Non opus erat suasore illi sed adiutore: servi parere nolebant. Primum detraxit illis metum et indicavit tunc familiam periculum adire cum incertum esset an mors domini voluntaria fuisset; alioqui tam mali exempli esse occidere dominum quam prohibere. Deinde ipsum Marcellinum admonuit non esse inhumanum, quemadmodum cena peracta reliquiae circumstantibus dividantur, sic peracta vita aliquid porrigi iis qui totius vitae ministri fuissent. Erat Marcellinus facilis animi et liberalis etiam cum de suo fieret; minutas itaque summulas distribuit flentibus servis et illos ultro consolatus est. Non fuit illi opus ferro, non sanguine: triduo abstinuit et in ipso cubiculo poni tabernaculum iussit. Solium deinde inlatum est, in quo diu iacuit et calda subinde suffusa paulatim defecit, ut aiebat, non sine quadam voluptate, quam adferre solet lenis dissolutio non inexperta nobis, quos aliquando liquit animus. In fabellam excessi non ingratam tibi; exitum enim amici tui cognosces non difficilem nec miserum. Quamvis enim mortem sibi consciverit, tamen mollissime excessit et vita elapsus est. Sed ne inutilis quidem haec fabella fuerit; saepe enim talia exempla necessitas exigit. Saepe debemus mori nec volumus, morimur nec volumus. Nemo tam inperitus est ut nesciat quandoque moriendum; tamen cum prope accessit, tergiversatur, tremit, plorat. Nonne tibi videtur
stultissimus omnium qui flevit quod ante annos mille non vixerat? Aeque stultus est qui flet quod post annos mille non vivet. Haec paria sunt: non eris nec fuisti; utrumque tempus alienum est. In hoc punctum coniectus es, quod ut extendas, quousque extendes? Quid fles? Quid optas? Perdis operam. Desine fata deum flecti sperare precando. Rata et fixa sunt et magna atque aeterna necessitate ducuntur: eo ibis quo omnia eunt. Quid tibi novi est? Ad hanc legem natus es; hoc patri tuo accidit, hoc matri, hoc maioribus, hoc omnibus ante te, hoc omnibus post te. Series invicta et nulla mutabilis ope inligavit ac trahit cuncta. Quantus te populus moriturorum sequetur, quantus comitabitur! Fortior, ut opinor, esses, si multa milia tibi commorerentur; atqui multa milia et hominum et animalium hoc ipso momento quo tu mori dubitas animam variis generibus emittunt. Tu autem non putabas te aliquando ad id perventurum ad quod semper ibas? Nullum sine exitu iter est. Exempla nunc magnorum virorum me tibi iudicas relaturum? Puerorum referam. Lacon ille memoriae traditur, inpubis adhuc, qui captus clamabat «non serviam» sua illa Dorica lingua, et verbis fidem inposuit: ut primum iussus est fungi servili et contumelioso ministerio (adferre enim vas obscenum iubebatur), inlisum parieti caput rupit. Tam prope libertas est: et servit aliquis? Ita non sic perire filium tuum malles quam per inertiam senem fieri? Quid ergo est cur perturberis, si mori fortiter etiam puerile est? Puta nolle te sequi: duceris. Fac tui iuris quod alieni est. Non sumes pueri spiritum, ut dicas «non servio»? Infelix, servis hominibus, servis rebus, servis vitae; nam vita, si moriendi virtus abest, servitus est. Ecquid habes propter quod expectes? Voluptates ipsas quae te morantur ac retinent consumpsisti: nulla tibi nova est, nulla non iam odiosa ipsa satietate. Quis sit vini, quis mulsi sapor scis: nihil interest centum per vesicam tuam an mille amphorae transeant: saccus es. Quid sapiat ostreum, quid mullus optime nosti: nihil tibi luxuria tua in futuros annos intactum reservavit. Atqui haec sunt a quibus invitus divelleris. Quid est aliud quod tibi eripi doleas? Amicos? Scis enim amicus esse? Patriam? Tanti enim illam putas ut tardius cenes? Solem? Quem, si posses, extingueres: quid enim umquam fecisti luce dignum? Confitere non curiae te, non fori, non ipsius rerum naturae desiderio tardiorem ad moriendum fieri: invitus relinquis macellum, in quo nihil reliquisti. Mortem times: at quomodo illam media boletatione contemnis! Vivere vis: scis enim? Mori times: quid porro? Ista vita non mors est? C. Caesar, cum illum transeuntem per Latinam viam unus ex custodiarum agmine demissa usque in pectus vetere barba rogaret mortem, «nunc enim» inquit «vivis?» Hoc istis respondendum est quibus succursura mors est: «mori times: nunc enim vivis?» «Sed ego» inquit «vivere volo, qui multa honeste facio; invitus relinquo officia vitae, quibus fideliter et industrie fungor». Quid? Tu nescis unum esse ex vitae officiis et mori? Nullum officium relinquis; non enim certus numerus quem debeas explere finitur. Nulla vita est non brevis; nam si ad naturam rerum
respexeris, etiam Nestoris et Sattiae brevis est, quae inscribi monumento suo iussit annis se nonaginta novem vixisse. Vides aliquem gloriari senectute longa: quis illam ferre potuisset si contigisset centesimum implere? Quomodo fabula, sic vita: non quam diu, sed quam bene acta sit, refert. Nihil ad rem pertinet quo loco desinas. Quocumque voles desine: tantum bonam clausulam inpone. Vale. 78. Vexari te destillationibus crebris ac febriculis, quae longas destillationes et in consuetudinem adductas sequuntur, eo molestius mihi est quia expertus sum hoc genus valetudinis, quod inter initia contempsi – poterat adhuc adulescentia iniurias ferre et se adversus morbos contumaciter gerere – deinde succubui et eo perductus sum ut ipse destillarem, ad summam maciem deductus. Saepe impetum cepi abrumpendae vitae: patris me indulgentissimi senectus retinuit. Cogitavi enim non quam fortiter ego mori possem, sed quam ille fortiter desiderare non posset. Itaque imperavi mihi ut viverem; aliquando enim et vivere fortiter facere est. Quae mihi tunc fuerint solacio dicam, si prius hoc dixero, haec ipsa quibus adquiescebam medicinae vim habuisse; in remedium cedunt honesta solacia, et quidquid animum erexit etiam corpori prodest. Studia mihi nostra saluti fuerunt; philosophiae acceptum fero quod surrexi, quod convalui; illi vitam debeo et nihil illi minus debeo. Multum autem mihi contulerunt ad bonam valetudinem et amici, quorum adhortationibus, vigiliis, sermonibus adlevabar. Nihil aeque, Lucili, virorum optime, aegrum reficit atque adiuvat quam amicorum adfectus, nihil aeque expectationem mortis ac metum subripit: non iudicabam me, cum illos superstites relinquerem, mori. Putabam, inquam, me victurum non cum illis, sed per illos; non effundere mihi spiritum videbar, sed tradere. Haec mihi dederunt voluntatem adiuvandi me et patiendi omne tormentum; alioqui miserrimum est, cum animum moriendi proieceris, non habere vivendi. Ad haec ergo remedia te confer. Medicus tibi quantum ambules, quantum exercearis monstrabit; ne indulgeas otio, ad quod vergit iners valetudo; ut legas clarius et spiritum, cuius iter ac receptaculum laborat, exerceas; ut naviges et viscera molli iactatione concutias; quibus cibis utaris, vinum quando virium causa advoces, quando intermittas ne inritet et exasperet tussim. Ego tibi illud praecipio quod non tantum huius morbi sed totius vitae remedium est: contemne mortem. Nihil triste est cum huius metum effugimus. Tria haec in omni morbo gravia sunt: metus mortis, dolor corporis, intermissio voluptatum. De morte satis dictum est: hoc unum dicam, non morbi hunc esse sed naturae metum. Multorum mortem distulit morbus et saluti illis fuit videri perire. Morieris, non quia aegrotas, sed quia vivis. Ista te res et sanatum manet; cum convalueris, non mortem sed valetudinem effugeris. Ad illud nunc proprium incommodum revertamur: magnos cruciatus habet morbus, sed hos tolerabiles intervalla faciunt. Nam summi doloris intentio invenit finem; nemo potest valde dolere et diu; sic nos amantissima nostri natura disposuit ut dolorem aut tolerabilem aut brevem faceret. Maximi dolores
consistunt in macerrimis corporis partibus: nervi articulique et quidquid aliud exile est acerrime saevit cum in arto vitia concepit. Sed cito hae partes obstupescunt et ipso dolore sensum doloris amittunt, sive quia spiritus naturali prohibitus cursu et mutatus in peius vim suam qua viget admonetque nos perdit, sive quia corruptus umor, cum desiit habere quo confluat, ipse se elidit et iis quae nimis implevit excutit sensum. Sic podagra et cheragra et omnis vertebrarum dolor nervorumque interquiescit cum illa quae torquebat hebetavit; omnium istorum prima verminatio vexat, impetus mora extinguitur et finis dolendi est optorpuisse. Dentium, oculorum, aurium dolor ob hoc ipsum acutissimus est quod inter angusta corporis nascitur, non minus, mehercule, quam capitis ipsius; sed si incitatior est, in alienationem soporemque convertitur. Hoc itaque solacium vasti doloris est, quod necesse est desinas illum sentire si nimis senseris. Illud autem est quod inperitos in vexatione corporis male habet: non adsueverunt animo esse contenti; multum illis cum corpore fuit. Ideo vir magnus ac prudens animum diducit a corpore et multum cum meliore ac divina parte versatur, cum hac querula et fragili quantum necesse est. «Sed molestum est» inquit «carere adsuetis voluptatibus, abstinere cibo, sitire, esurire». Haec prima abstinentia gravia sunt, deinde cupiditas relanguescit ipsis per quae cupimus fatigatis ac deficientibus; inde morosus est stomachus, inde quibus fuit aviditas cibi odium est. Desideria ipsa moriuntur; non est autem acerbum carere eo quod cupere desieris. Adice quod nullus non intermittitur dolor aut certe remittitur. Adice quod licet cavere venturum et obsistere inminenti remediis; nullus enim non signa praemittit, utique qui ex solito revertitur. Tolerabilis est morbi patientia, si contempseris id quod extremum minatur. Noli mala tua facere tibi ipse graviora et te querelis onerare: levis est dolor si nihil illi opinio adiecerit. Contra si exhortari te coeperis ac dicere «nihil est aut certe exiguum est; duremus; iam desinet», levem illum, dum putas, facies. Omnia ex opinione suspensa sunt; non ambitio tantum ad illam respicit et luxuria et avaritia: ad opinionem dolemus. Tam miser est quisque quam credidit. Detrahendas praeteritorum dolorum conquestiones puto et illa verba: «nulli umquam fuit peius. Quos cruciatus, quanta mala pertuli! Nemo me surrecturum putavit. Quotiens deploratus sum a meis, quotiens a medicis relictus! In eculeum inpositi non sic distrahuntur». Etiam si sunt vera ista, transierunt: quid iuvat praeteritos dolores retractare et miserum esse quia fueris? Quid quod nemo non multum malis suis adicit et sibi ipse mentitur? Deinde quod acerbum fuit ferre, tulisse iucundum est: naturale est mali sui fine gaudere. Circumcidenda ergo duo sunt, et futuri timor et veteris incommodi memoria: hoc ad me iam non pertinet, illud nondum. In ipsis positus difficultatibus dicat, forsan et haec olim meminisse iuvabit. Toto contra ille pugnet animo; vincetur si cesserit, vincet si se contra dolorem suum intenderit: nunc hoc plerique faciunt, adtrahunt in se ruinam cui
obstandum est. Istud quod premit, quod inpendet, quod urguet, si subducere te coeperis, sequetur et gravius incumbet; si contra steteris et obniti volueris, repelletur. Athletae quantum plagarum ore, quantum toto corpore excipiunt! ferunt tamen omne tormentum gloriae cupiditate nec tantum quia pugnant ista patiuntur, sed ut pugnent: exercitatio ipsa tormentum est. Nos quoque evincamus omnia, quorum praemium non corona nec palma est nec tubicen praedicationi nominis nostri silentium faciens, sed virtus et firmitas animi et pax in ceterum parta, si semel in aliquo certamine debellata fortuna est. «Dolorem gravem sentio». Quid ergo? Non sentis si illum muliebriter tuleris? Quemadmodum perniciosior est hostis fugientibus, sic omne fortuitum incommodum magis instat cedenti et averso. «Sed grave est». Quid? Nos ad hoc fortes sumus, ut levia portemus? Utrum vis longum esse morbum an concitatum et brevem? Si longus est, habet intercapedinem, dat refectioni locum, multum temporis donat, necesse est, ut exsurgat, et desinat: brevis morbus ac praeceps alterutrum faciet, aut extinguetur aut extinguet. Quid autem interest, non sit an non sim? In utroque finis dolendi est. Illud quoque proderit, ad alias cogitationes avertere animum et a dolore discedere. Cogita quid honeste, quid fortiter feceris; bonas partes tecum ipse tracta; memoriam in ea quae maxime miratus es sparge; tunc tibi fortissimus quisque et victor doloris occurrat: ille qui dum varices exsecandas praeberet legere librum perseveravit, ille qui non desiit ridere cum hoc ipsum irati tortores omnia instrumenta crudelitatis suae experirentur. Non vincetur dolor ratione, qui victus est risu? Quidquid vis nunc licet dicas, destillationes et vim continuae tussis egerentem viscerum partes et febrem praecordia ipsa torrentem et sitim et artus in diversum articulis exeuntibus tortos: plus est flamma et eculeus et lamina et vulneribus ipsis intumescentibus quod illa renovaret et altius urgueret inpressum. Inter haec tamen aliquis non gemuit. Parum est: non rogavit. Parum est: non respondit. Parum est: risit et quidem ex animo. Vis tu post hoc dolorem deridere? «Sed nihil» inquit «agere sinit morbus, qui me omnibus abduxit officiis». Corpus tuum valetudo tenet, non et animum. Itaque cursoris moratur pedes, sutoris aut fabri manus inpedit: si animus tibi esse in usu solet, suadebis docebis, audies disces, quaeres recordaberis. Quid porro? Nihil agere te credis si temperans aeger sis? Ostendes morbum posse superari vel certe sustineri. Est, mihi crede, virtuti etiam in lectulo locus. Non tantum arma et acies dant argumenta alacris animi indomitique terroribus: et in vestimentis vir fortis apparet. Habes quod agas: bene luctare cum morbo. Si nihil te coegerit, si nihil exoraverit, insigne prodis exemplum. O quam magna erat gloriae materia, si spectaremur aegri! ipse te specta, ipse te lauda. Praeterea duo genera sunt voluptatum. Corporales morbus inhibet, non tamen tollit; immo, si verum aestimes, incitat. Magis iuvat bibere sitientem, gratior est esurienti cibus; quidquid ex abstinentia contingit avidius excipitur. Illas vero animi voluptates, quae maiores certioresque sunt, nemo medicus aegro negat. Has quisquis sequitur et bene intellegit omnia sensuum blandimenta contemnit. «O
infelicem aegrum!». Quare? Quia non vino nivem diluit? Quia non rigorem potionis suae, quam capaci scypho miscuit, renovat fracta insuper glacie? Quia non ostrea illi Lucrina in ipsa mensa aperiuntur? Quia non circa cenationem eius tumultus cocorum est ipsos cum opsoniis focos transferentium? Hoc enim iam luxuria commenta est: ne quis intepescat cibus, ne quid palato iam calloso parum ferveat, cenam culina prosequitur. «O infelicem aegrum!». Edet quantum concoquat; non iacebit in conspectu aper ut vilis caro a mensa relegatus, nec in repositorio eius pectora avium (totas enim videre fastidium est) congesta ponentur. Quid tibi mali factum est? Cenabis tamquam aeger, immo aliquando tamquam sanus. Sed omnia ista facile perferemus, sorbitionem, aquam calidam, et quidquid aliud intolerabile videtur delicatis et luxu fluentibus magisque animo quam corpore morbidis: tantum mortem desinamus horrere. Desinemus autem, si fines bonorum ac malorum cognoverimus; ita demum nec vita taedio erit nec mors timori. Vitam enim occupare satietas sui non potest tot res varias, magnas, divinas percensentem: in odium illam sui adducere solet iners otium. Rerum naturam peragranti numquam in fastidium veritas veniet: falsa satiabunt. Rursus si mors accedit et vocat, licet inmatura sit, licet mediam praecidat aetatem, perceptus longissimae fructus est. Cognita est illi ex magna parte natura; scit tempore honesta non crescere: iis necesse est videri omnem vitam brevem qui illam voluptatibus vanis et ideo infinitis metiuntur. His te cogitationibus recrea et interim epistulis nostris vaca. Veniet aliquando tempus quod nos iterum iungat ac misceat; quantulumlibet sit illud, longum faciet scientia utendi. Nam, ut Posidonius ait, «unus dies hominum eruditorum plus patet quam inperitis longissima aetas». Interim hoc tene, hoc morde: adversis non succumbere, laetis non credere, omnem fortunae licentiam in oculis habere, tamquam quidquid potest facere factura sit. Quidquid expectatum est diu, levius accedit. Vale. 79. Expecto epistulas tuas quibus mihi indices circuitus Siciliae totius quid tibi novi ostenderit, et omnia de ipsa Charybdi certiora. Nam Scyllam saxum esse et quidem non terribile navigantibus optime scio: Charybdis an respondeat fabulis perscribi mihi desidero et, si forte observaveris (dignum est autem quod observes), fac nos certiores utrum uno tantum vento agatur in vertices an omnis tempestas aeque mare illud contorqueat, et an verum sit quidquid illo freti turbine abreptum est per multa milia trahi conditum et circa Tauromenitanum litus emergere. Si haec mihi perscripseris, tunc tibi audebo mandare ut in honorem meum Aetnam quoque ascendas, quam consumi et sensim subsidere ex hoc colligunt quidam, quod aliquanto longius navigantibus solebat ostendi. Potest hoc accidere non quia montis altitudo descendit, sed quia ignis evanuit et minus vehemens ac largus effertur, ob eandem causam fumo quoque per diem segniore. Neutrum autem incredibile est, nec montem qui devoretur cotidie minui, nec manere eundem, quia non ipsum ignis exest sed in aliqua inferna valle conceptus
exaestuat et aliis pascitur, in ipso monte non alimentum habet sed viam. In Lycia regio notissima est (Hephaestion incolae vocant), foratum pluribus locis solum, quod sine ullo nascentium damno ignis innoxius circumit. Laeta itaque regio est et herbida, nihil flammis adurentibus sed tantum vi remissa ac languida refulgentibus. Sed reservemus ista, tunc quaesituri cum tu mihi scripseris quantum ab ipso ore montis nives absint, quas ne aestas quidem solvit; adeo tutae sunt ab igne vicino. Non est autem quod istam curam inputes mihi; morbo enim tuo daturus eras, etiam si nemo mandaret. Quid tibi do ne Aetnam describas in tuo carmine, ne hunc sollemnem omnibus poetis locum adtingas? Quem quominus Ovidius tractaret, nihil obstitit quod iam Vergilius impleverat; ne Severum quidem Cornelium uterque deterruit. Omnibus praeterea feliciter hic locus se dedit, et qui praecesserant non praeripuisse mihi videntur quae dici poterant, sed aperuisse. Multum interest utrum ad consumptam materiam an ad subactam accedas: crescit in dies, et inventuris inventa non obstant. Praeterea condicio optima est ultimi: parata verba invenit, quae aliter instructa novam faciem habent. Nec illis manus inicit tamquam alienis; sunt enim publica. Aut ego te non novi aut Aetna tibi salivam movet; iam cupis grande aliquid et par prioribus scribere. Plus enim sperare modestia tibi tua non permittit, quae tanta in te est ut videaris mihi retracturus ingenii tui vires, si vincendi periculum sit: tanta tibi priorum reverentia est. Inter cetera hoc habet boni sapientia: nemo ab altero potest vinci nisi dum ascenditur. Cum ad summum perveneris, paria sunt; non est incremento locus, statur. Numquid sol magnitudini suae adicit? Numquid ultra quam solet luna procedit? Maria non crescunt; mundus eundem habitum ac modum servat. Extollere se quae iustam magnitudinem implevere non possunt: quicumque fuerint sapientes, pares erunt et aequales. Habebit unusquisque ex iis proprias dotes: alius erit affabilior, alius expeditior, alius promptior in eloquendo, alius facundior: illud de quo agitur, quod beatum facit, aequalest in omnibus. An Aetna tua possit sublabi et in se ruere, an hoc excelsum cacumen et conspicuum per vasti maris spatia detrahat adsidua vis ignium, nescio: virtutem non flamma, non ruina inferius adducet; haec una maiestas deprimi nescit. Nec proferri ultra nec referri potest; sic huius, ut caelestium, stata magnitudo est. Ad hanc nos conemur educere. Iam multum operis effecti est; immo, si verum fateri volo, non multum. Nec enim bonitas est pessimis esse meliorem: quis oculis glorietur qui suspicetur diem? Cui sol per caliginem splendet, licet contentus interim sit effugisse tenebras, adhuc non fruitur bono lucis. Tunc animus noster habebit quod gratuletur sibi cum emissus his tenebris in quibus volutatur non tenui visu clara prospexerit, sed totum diem admiserit et redditus caelo suo fuerit, cum receperit locum quem occupavit sorte nascendi. Sursum illum vocant initia sua; erit autem illic etiam antequam hac custodia exsolvatur, cum vitia disiecerit purusque ac levis in cogitationes divinas emicuerit. Hoc nos agere, Lucili carissime, in hoc ire impetu toto, licet pauci sciant, licet nemo, iuvat. Gloria umbra virtutis est: etiam invitam comitabitur. Sed
quemadmodum aliquando umbra antecedit, aliquando sequitur vel a tergo est, ita gloria aliquando ante nos est visendamque se praebet, aliquando in averso est maiorque quo serior, ubi invidia secessit. Quamdiu videbatur furere Democritus! Vix recepit Socraten fama. Quamdiu Catonem civitas ignoravit! respuit nec intellexit nisi cum perdidit. Rutili innocentia ac virtus lateret, nisi accepisset iniuriam: dum violatur, effulsit. Numquid non sorti suae gratias egit et exilium suum complexus est? De his loquor quos inlustravit fortuna dum vexat: quam multorum profectus in notitiam evasere post ipsos! quam multos fama non excepit sed eruit! Vides Epicurum quantopere non tantum eruditiores sed haec quoque inperitorum turba miretur: hic ignotus ipsis Athenis fuit, circa quas delituerat. Multis itaque iam annis Metrodoro suo superstes in quadam epistula, cum amicitiam suam et Metrodori grata commemoratione cecinisset, hoc novissime adiecit, nihil sibi et Metrodoro inter bona tanta nocuisse quod ipsos illa nobilis Graecia non ignotos solum habuisset sed paene inauditos. Numquid ergo non postea quam esse desierat inventus est? Numquid non opinio eius enituit? Hoc Metrodorus quoque in quadam epistula confitetur, se et Epicurum non satis enotuisse; sed post se et Epicurum magnum paratumque nomen habituros qui voluissent per eadem ire vestigia. Nulla virtus latet, et latuisse non ipsius est damnum: veniet qui conditam et saeculi sui malignitate conpressam dies publicet. Paucis natus est qui populum aetatis suae cogitat. Multa annorum milia, multa populorum supervenient: ad illa respice. Etiam si omnibus tecum viventibus silentium livor indixerit, venient qui sine offensa, sine gratia iudicent. Si quod est pretium virtutis ex fama, nec hoc interit. Ad nos quidem nihil pertinebit posterorum sermo; tamen etiam non sentientes colet ac frequentabit. Nulli non virtus et vivo et mortuo rettulit gratiam, si modo illam bona secutus est fide, si se non exornavit et pinxit, sed idem fuit sive ex denuntiato videbatur sive inparatus ac subito. Nihil simulatio proficit; paucis inponit leviter extrinsecus inducta facies: veritas in omnem partem sui eadem est. Quae decipiunt nihil habent solidi. Tenue est mendacium: perlucet si diligenter inspexeris. Vale. 80. Hodierno die non tantum meo beneficio mihi vaco sed spectaculi, quod omnes molestos ad sphaeromachian avocavit. Nemo inrumpet, nemo cogitationem meam inpediet, quae hac ipsa fiducia procedit audacius. Non crepabit subinde ostium, non adlevabitur velum: licebit tuto vadere, quod magis necessarium est per se eunti et suam sequenti viam. Non ergo sequor priores? Facio, sed permitto mihi et invenire aliquid et mutare et relinquere; non servio illis, sed assentior. Magnum tamen verbum dixi, qui mihi silentium promittebam et sine interpellatore secretum: ecce ingens clamor ex stadio perfertur et me non excutit mihi, sed in huius ipsius rei contemplationem transfert. Cogito mecum quam multi corpora exerceant, ingenia quam pauci; quantus ad spectaculum non fidele et lusorium fiat concursus, quanta sit circa artes bonas solitudo; quam inbecilli animo sint quorum lacertos umerosque miramur. Illud maxime revolvo mecum: si
corpus perduci exercitatione ad hanc patientiam potest qua et pugnos pariter et calces non unius hominis ferat, qua solem ardentissimum in ferventissimo pulvere sustinens aliquis et sanguine suo madens diem ducat, quanto facilius animus conroborari possit ut fortunae ictus invictus excipiat, ut proiectus, ut conculcatus exsurgat. Corpus enim multis eget rebus ut valeat: animus ex se crescit, se ipse alit, se exercet. Illis multo cibo, multa potione opus est, multo oleo, longa denique opera: tibi continget virtus sine apparatu, sine inpensa. Quidquid facere te potest bonum tecum est. Quid tibi opus est ut sis bonus? Velle. Quid autem melius potes velle quam eripere te huic servituti quae omnes premit, quam mancipia quoque condicionis extremae et in his sordibus nata omni modo exuere conantur? Peculium suum, quod comparaverunt ventre fraudato, pro capite numerant: tu non concupisces quanticumque ad libertatem pervenire, qui te in illa putas natum? Quid ad arcam tuam respicis? Emi non potest. Itaque in tabellas vanum coicitur nomen libertatis, quam nec qui emerunt habent nec qui vendiderunt: tibi des oportet istud bonum, a te petas. Libera te primum metu mortis (illa nobis iugum inponit), deinde metu paupertatis. Si vis scire quam nihil in illa mali sit, compara inter se pauperum et divitum vultus: saepius pauper et fidelius ridet; nulla sollicitudo in alto est; etiam si qua incidit cura, velut nubes levis transit: horum qui felices vocantur hilaritas ficta est aut gravis et suppurata tristitia, eo quidem gravior quia interdum non licet palam esse miseros, sed inter aerumnas cor ipsum exedentes necesse est agere felicem. Saepius hoc exemplo mihi utendum est, nec enim ullo efficacius exprimitur hic humanae vitae mimus, qui nobis partes quas male agamus adsignat. Ille qui in scaena latus incedit et haec resupinus dicit, en impero Argis; regna mihi liquit Pelops, qua ponto ab Helles atque ab Ionio mari urguetur Isthmos, servus est, quinque modios accipit et quinque denarios. Ille qui superbus atque inpotens et fiducia virium tumidus ait, quod nisi quieris, Menelae, hac dextra occides, diurnum accipit, in centunculo dormit. Idem de istis licet omnibus dicas quos supra capita hominum supraque turbam delicatos lectica suspendit: omnium istorum personata felicitas est. Contemnes illos si despoliaveris. Equum empturus solvi iubes stratum, detrahis vestimenta venalibus ne qua vitia corporis lateant: hominem involutum aestimas? Mangones quidquid est quod displiceat, id aliquo lenocinio abscondunt, itaque ementibus ornamenta ipsa suspecta sunt: sive crus alligatum sive brachium aspiceres, nudari iuberes et ipsum tibi corpus ostendi. Vides illum Scythiae Sarmatiaeve regem insigni capitis decorum? Si vis illum aestimare totumque scire qualis sit, fasciam solve: multum mali sub illa
latet. Quid de aliis loquor? Si perpendere te voles, sepone pecuniam, domum, dignitatem, intus te ipse considera: nunc qualis sis aliis credis. Vale.
Liber decimus 81. Quereris incidisse te in hominem ingratum: si hoc nunc primum, age aut fortunae aut diligentiae tuae gratias. Sed nihil facere hoc loco diligentia potest nisi te malignum; nam si hoc periculum vitare volueris, non dabis beneficia; ita ne apud alium pereant, apud te peribunt. Non respondeant potius quam non dentur: et post malam segetem serendum est. Saepe quidquid perierat adsidua infelicis soli sterilitate unius anni restituit ubertas. Est tanti, ut gratum invenias, experiri et ingratos. Nemo habet tam certam in beneficiis manum ut non saepe fallatur: aberrent, ut aliquando haereant. Post naufragium maria temptantur; feneratorem non fugat a foro coctor. Cito inerti otio vita torpebit, si relinquendum est quidquid offendit. Te vero benigniorem haec ipsa res faciat; nam cuius rei eventus incertus est, id ut aliquando procedat saepe temptandum est. Sed de isto satis multa in iis libris locuti sumus qui de beneficiis inscribuntur: illud magis quaerendum videtur, quod non satis, ut existimo, explicatum est, an is qui profuit nobis, si postea nocuit, paria fecerit et nos debito solverit. Adice, si vis, et illud: multo plus postea nocuit quam ante profuerat. Si rectam illam rigidi iudicis sententiam quaeris, alterum ab altero absolvet et dicet, «quamvis iniuriae praeponderent, tamen beneficiis donetur quod ex iniuria superest». Plus nocuit, sed prius profuit; itaque habeatur et temporis ratio. Iam illa manifestiora sunt quam ut admoneri debeas quaerendum esse quam libenter profuerit, quam invitus nocuerit, quoniam animo et beneficia et iniuriae constant. «Nolui beneficium dare; victus sum aut verecundia aut instantis pertinacia aut spe». Eo animo quidque debetur quo datur, nec quantum sit sed a quali profectum voluntate perpenditur. Nunc coniectura tollatur: et illud beneficium fuit et hoc, quod modum beneficii prioris excessit, iniuria est. Vir bonus utrosque calculos sic ponit ut se ipse circumscribat: beneficio adicit, iniuriae demit. Alter ille remissior iudex, quem esse me malo, iniuriae oblivisci iubebit, officii meminisse. «Hoc certe» inquis «iustitiae convenit, suum cuique reddere, beneficio gratiam, iniuriae talionem aut certe malam gratiam». Verum erit istud cum alius iniuriam fecerit, alius beneficium dederit; nam si idem est, beneficio vis iniuriae extinguitur. Nam cui, etiam si merita non antecessissent, oportebat ignosci, post beneficia laedenti plus quam venia debetur. Non pono utrique par pretium: pluris aestimo beneficium quam iniuriam. Non omnes esse grati sciunt: debere beneficium potest etiam inprudens et rudis et unus e turba, utique dum prope est ab accepto, ignorat autem quantum pro eo debeat. Uni sapienti notum est quanti res quaeque taxanda sit. Nam ille de quo loquebar modo stultus, etiam si bonae voluntatis est, aut minus quam debet aut alio quam debet tempore aut quo non debet loco reddit; id quod referendum est effundit atque abicit. Mira in quibusdam rebus verborum proprietas est, et consuetudo sermonis antiqui quaedam efficacissimis et officia docentibus notis signat. Sic certe solemus loqui: «ille illi gratiam rettulit». Referre est ultro quod debeas adferre. Non dicimus «gratiam reddidit»; reddunt enim et qui reposcuntur et qui inviti et qui
ubilibet et qui per alium. Non dicimus «reposuit beneficium» aut «solvit»: nullum nobis placuit quod aeri alieno convenit verbum. Referre est ad eum a quo acceperis rem ferre. Haec vox significat voluntariam relationem: qui rettulit, ipse se appellavit. Sapiens omnia examinabit secum, quantum acceperit, a quo, quare, quando, ubi, quemadmodum. Itaque negamus quemquam scire gratiam referre nisi sapientem, non magis quam beneficium dare quisquam scit nisi sapiens – hic scilicet qui magis dato gaudet quam alius accepto. Hoc aliquis inter illa numerat quae videmur inopinata omnibus dicere (paravdoxa Graeci vocant) et ait, «nemo ergo scit praeter sapientem referre gratiam? Ergo nec quod debet creditori suo reponere quisquam scit alius nec, cum emit aliquam rem, pretium venditori persolvere?» Ne nobis fiat invidia, scito idem dicere Epicurum. Metrodorus certe ait solum sapientem referre gratiam scire. Deinde idem admiratur cum dicimus, «solus sapiens scit amare, solus sapiens amicus est». Atqui et amoris et amicitiae pars est referre gratiam, immo hoc magis vulgare est et in plures cadit quam vera amicitia. Deinde idem admiratur quod dicimus fidem nisi in sapiente non esse, tamquam non ipse idem dicat. An tibi videtur fidem habere qui referre gratiam nescit? Desinant itaque infamare nos tamquam incredibilia iactantes et sciant apud sapientem esse ipsa honesta, apud vulgum simulacra rerum honestarum et effigies. Nemo referre gratiam scit nisi sapiens. Stultus quoque, utcumque scit et quemadmodum potest, referat; scientia illi potius quam voluntas desit: velle non discitur. Sapiens omnia inter se comparabit; maius enim aut minus fit, quamvis idem sit, tempore, loco, causa. Saepe enim hoc non potuere divitiae in domum infusae quod opportune dati mille denarii. Multum enim interest donaveris an succurreris, servaverit illum tua liberalitas an instruxerit; saepe quod datur exiguum est, quod sequitur ex eo magnum. Quantum autem existimas interesse utrum aliquis quod daret a se sumpserit an beneficium acceperit ut daret? Sed ne in eadem quae satis scrutati sumus revolvamur, in hac comparatione beneficii et iniuriae vir bonus iudicabit quidem quod erit aequissimum, sed beneficio favebit; in hanc erit partem proclivior. Plurimum autem momenti persona solet adferre in rebus eiusmodi: «dedisti mihi beneficium in servo, iniuriam fecisti in patre; servasti mihi filium, sed patrem abstulisti». Alia deinceps per quae procedit omnis conlatio prosequetur, et si pusillum erit quod intersit, dissimulabit; etiam si multum fuerit, sed si id donari salva pietate ac fide poterit, remittet, id est si ad ipsum tota pertinebit iniuria. Summa rei haec est: facilis erit in commutando; patietur plus inputari sibi; invitus beneficium per compensationem iniuriae solvet; in hanc partem inclinabit, huc verget, ut cupiat debere gratiam, cupiat referre. Errat enim si quis beneficium accipit libentius quam reddit: quanto hilarior est qui solvit quam qui mutuatur, tanto debet laetior esse qui se maximo aere alieno accepti benefici exonerat quam qui cum maxime obligatur. Nam in hoc quoque falluntur ingrati, quod creditori quidem praeter sortem extra ordinem numerant, beneficiorum autem usum esse gratuitum putant: et illa crescunt mora tantoque plus solvendum est quanto tardius. Ingratus est qui
beneficium reddit sine usura; itaque huius quoque rei habebitur ratio, cum conferentur accepta et expensa. Omnia facienda sunt ut quam gratissimi simus. Nostrum enim hoc bonum est, quemadmodum iustitia non est (ut vulgo creditur) ad alios pertinens: magna pars eius in se redit. Nemo non, cum alteri prodest, sibi profuit, non eo nomine dico, quod volet adiuvare adiutus, protegere defensus, quod bonum exemplum circuitu ad facientem revertitur (sicut mala exempla recidunt in auctores nec ulla miseratio contingit iis qui patiuntur iniurias quas posse fieri faciendo docuerunt), sed quod virtutum omnium pretium in ipsis est. Non enim exercentur ad praemium: recte facti fecisse merces est. Gratus sum non ut alius mihi libentius praestet priori inritatus exemplo, sed ut rem iucundissimam ac pulcherrimam faciam; gratus sum non quia expedit, sed quia iuvat. Hoc ut scias ita esse, si gratum esse non licebit nisi ut videar ingratus, si reddere beneficium non aliter quam per speciem iniuriae potero, aequissimo animo ad honestum consilium per mediam infamiam tendam. Nemo mihi videtur pluris aestimare virtutem, nemo illi magis esse devotus quam qui boni viri famam perdidit ne conscientiam perderet. Itaque, ut dixi, maiore tuo quam alterius bono gratus es; illi enim vulgaris et cotidiana res contigit, recipere quod dederat, tibi magna et ex beatissimo animi statu profecta, gratum fuisse. Nam si malitia miseros facit, virtus beatos, gratum autem esse virtus est, rem usitatam reddidisti, inaestimabilem consecutus es, conscientiam grati, quae nisi in animum divinum fortunatumque non pervenit. Contrarium autem huic adfectum summa infelicitas urget: nemo sibi gratus est qui alteri non fuit. Hoc me putas dicere, qui ingratus est miser erit? Non differo illum: statim miser est. Itaque ingrati esse vitemus non aliena causa sed nostra. Minimum ex nequitia levissimumque ad alios redundat: quod pessimum ex illa est et, ut ita dicam, spississimum, domi remanet et premit habentem, quemadmodum Attalus noster dicere solebat, «malitia ipsa maximam partem veneni sui bibit». Illud venenum quod serpentes in alienam perniciem proferunt, sine sua continent, non est huic simile: hoc habentibus pessimum est. Torquet se ingratus et macerat; odit quae accepit, quia redditurus est, et extenuat, iniurias vero dilatat atque auget. Quid autem eo miserius cui beneficia excidunt, haerent iniuriae? At contra sapientia exornat omne beneficium ac sibi ipsa commendat et se adsidua eius commemoratione delectat. Malis una voluptas est et haec brevis, dum accipiunt beneficia, ex quibus sapienti longum gaudium manet ac perenne. Non enim illum accipere sed accepisse delectat, quod inmortale est et adsiduum. Illa contemnit quibus laesus est, nec obliviscitur per neglegentiam sed volens. Non vertit omnia in peius nec quaerit cui inputet casum, et peccata hominum ad fortunam potius refert. Non calumniatur verba nec vultus; quidquid accidit benigne interpretando levat. Non offensae potius quam offici meminit; quantum potest in priore ac meliore se memoria detinet, nec mutat animum adversus bene meritos nisi multum male facta praecedunt et manifestum etiam coniventi discrimen est; tunc quoque in hoc dumtaxat, ut talis sit post maiorem iniuriam qualis ante beneficium. Nam cum beneficio par est iniuria, aliquid in animo
benivolentiae remanet. Quemadmodum reus sententiis paribus absolvitur et semper quidquid dubium est humanitas inclinat in melius, sic animus sapientis, ubi paria maleficiis merita sunt, desinit quidem debere, sed non desinit velle debere, et hoc facit quod qui post tabulas novas solvunt. Nemo autem esse gratus potest nisi contempsit ista propter quae vulgus insanit: si referre vis gratiam, et in exilium eundum est et effundendus sanguis et suscipienda egestas et ipsa innocentia saepe maculanda indignisque obicienda rumoribus. Non parvo sibi constat homo gratus. Nihil carius aestimamus quam beneficium quamdiu petimus, nihil vilius cum accepimus. Quaeris quid sit quod oblivionem nobis acceptorum faciat? Cupiditas accipiendorum; cogitamus non quid inpetratum sed quid petendum sit. Abstrahunt a recto divitiae, honores, potentia et cetera quae opinione nostra cara sunt, pretio suo vilia. Nescimus aestimare res, de quibus non cum fama sed cum rerum natura deliberandum est; nihil habent ista magnificum quo mentes in se nostras trahant praeter hoc, quod mirari illa consuevimus. Non enim quia concupiscenda sunt laudantur, sed concupiscuntur quia laudata sunt, et cum singulorum error publicum fecerit, singulorum errorem facit publicus. Sed quemadmodum illa credidimus, sic et hoc eidem populo credamus, nihil esse grato animo honestius; omnes hoc urbes, omnes etiam ex barbaris regionibus gentes conclamabunt; in hoc bonis malisque conveniet. Erunt qui voluptates laudent, erunt qui labores malint; erunt qui dolorem maximum malum dicant, erunt qui ne malum quidem appellent; divitias aliquis ad summum bonum admittet, alius illas dicet malo vitae humanae repertas, nihil esse eo locupletius cui quod donet fortuna non invenit: in tanta iudiciorum diversitate referendam bene merentibus gratiam omnes tibi uno, quod aiunt, ore adfirmabunt. In hoc tam discors turba consentiet, cum interim iniurias pro beneficiis reddimus, et prima causa est cur quis ingratus sit si satis gratus esse non potuit. Eo perductus est furor ut periculosissima res sit beneficia in aliquem magna conferre; nam quia putat turpe non reddere, non vult esse cui reddat. Tibi habe quod accepisti; non repeto, non exigo: profuisse tutum sit. Nullum est odium perniciosius quam e beneficii violati pudore. Vale. 82. Desii iam de te esse sollicitus. «Quem» inquis «deorum sponsorem accepisti?». Eum scilicet qui neminem fallit, animum recti ac boni amatorem. In tuto pars tui melior est. Potest fortuna tibi iniuriam facere: quod ad rem magis pertinet, non timeo ne tu facias tibi. I qua ire coepisti et in isto te vitae habitu compone placide, non molliter. Male mihi esse malo quam molliter – «male» nunc sic excipe quemadmodum a populo solet dici: dure, aspere, laboriose. Audire solemus sic quorundam vitam laudari quibus invidetur: «molliter vivit»; hoc dicunt, «mollis est». Paulatim enim effeminatur animus atque in similitudinem otii sui et pigritiae in qua iacet solvitur. Quid ergo? Viro non vel obrigescere satius est? * * * deinde idem delicati timent, cui vitam suam fecere similem. Multum interest inter otium et conditivum. «Quid ergo?» inquis «non satius est vel sic iacere quam in istis officiorum verticibus volutari?». Utraque
res detestabilis est, et contractio et torpor. Puto, aeque qui in odoribus iacet mortuus est quam qui rapitur unco; otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura. Quid deinde prodest secessisse? Tamquam non trans maria nos sollicitudinum causae persequantur. Quae latebra est in quam non intret metus mortis? Quae tam emunita et in altum subducta vitae quies quam non dolor territet? Quacumque te abdideris, mala humana circumstrepent. Multa extra sunt quae circumeunt nos quo aut fallant aut urgeant, multa intus quae in media solitudine exaestuant. Philosophia circumdanda est, inexpugnabilis murus, quem fortuna multis machinis lacessitum non transit. In insuperabili loco stat animus qui externa deseruit et arce se sua vindicat; infra illum omne telum cadit. Non habet, ut putamus, fortuna longas manus: neminem occupat nisi haerentem sibi. Itaque quantum possumus ab illa resiliamus; quod sola praestabit sui naturaeque cognitio. Sciat quo iturus sit, unde ortus, quod illi bonum, quod malum sit, quid petat, quid evitet, quae sit illa ratio quae adpetenda ac fugienda discernat, qua cupiditatum mansuescit insania, timorum saexitia conpescitur. Haec quidam putant ipsos etiam sine philosophia repressisse; sed cum securos aliquis casus expertus est, exprimitur sera confessio; magna verba excidunt cum tortor poposcit manum, cum mors propius accessit. Possis illi dicere, «facile provocabas mala absentia: ecce dolor, quem tolerabilem esse dicebas, ecce mors, quam contra multa animose locutus es; sonant flagella, gladius micat; nunc animis opus, Aenea, nunc pectore firmo». Faciet autem illud firmum adsidua meditatio, si non verba exercueris sed animum, si contra mortem te praeparaveris, adversus quam non exhortabitur nec attollet qui cavillationibus tibi persuadere temptaverit mortem malum non esse. Libet enim, Lucili, virorum optime, ridere ineptias Graecas, quas nondum, quamvis mirer, excussi. Zenon noster hac conlectione utitur: «nullum malum gloriosum est; mors autem gloriosa est; mors ergo non est malum». Profecisti! liberatus sum metu; post hoc non dubitabo porrigere cervicem. Non vis severius loqui nec morituro risum movere? Non mehercules facile tibi dixerim utrum ineptior fuerit qui se hac interrogatione iudicavit mortis metum extinguere, an qui hoc, tamquam ad rem pertineret, conatus est solvere. Nam et ipse interrogationem contrariam opposuit ex eo natam quod mortem inter indifferentia ponimus, quae ajdiavfora Graeci vocant. «Nihil» inquit «indifferens gloriosum est; mors autem gloriosum est; ergo mors non est indifferens». Haec interrogatio vides ubi obrepat: mors non est gloriosa, sed fortiter mori gloriosum est. Et cum dicis «indifferens nihil gloriosum est», concedo tibi ita ut dicam nihil gloriosum esse nisi circa indifferentia; tamquam indifferentia esse dico (id est nec bona nec mala) morbum, dolorem, paupertatem, exilium, mortem. Nihil horum per se gloriosum est, nihil tamen sine his. Laudatur enim non paupertas, sed ille quem paupertas non summittit nec incurvat; laudatur non exilium, sed ille qui fortiore vultu in exilium iit quam
misisset; laudatur non dolor, sed ille quem nihil coegit dolor; nemo mortem laudat, sed eum cuius mors ante abstulit animum quam conturbavit. Omnia ista per se non sunt honesta nec gloriosa, sed quidquid ex illis virtus adiit tractavitque honestum et gloriosum facit: illa in medio posita sunt. Interest utrum malitia illis an virtus manum admoverit; mors enim illa quae in Catone gloriosa est in Bruto statim turpis est et erubescenda. Hic est enim Brutus qui, cum periturus mortis moras quaereret, ad exonerandum ventrem secessit et evocatus ad mortem iussusque praebere cervicem, «praebebo», inquit «ita vivam». Quae dementia est fugere cum retro ire non possis! «Praebebo», inquit «ita vivam». Paene adiecit «vel sub Antonio». O hominem dignum qui vitae dederetur! Sed, ut coeperam dicere, vides ipsam mortem nec malum esse nec bonum: Cato illa honestissime usus est, turpissime Brutus. Omnis res quod non habuit decus virtute addita sumit. Cubiculum lucidum dicimus, hoc idem obscurissimum est nocte; dies illi lucem infundit, nox eripit: sic istis quae a nobis indifferentia ac media dicuntur, divitiis, viribus, formae, honoribus, regno, et contra morti, exilio, malae valetudini, doloribus quaeque alia aut minus aut magis pertimuimus, aut malitia aut virtus dat boni vel mali nomen. Massa per se nec calida nec frigida est: in fornacem coniecta concaluit, in aquam demissa refrixit. Mors honesta est per illud quod honestum est, id est virtus et animus externa contemnens. Est et horum, Lucili, quae appellamus media grande discrimen. Non enim sic mors indifferens est quomodo utrum capillos pares an inpares habeas: mors inter illa est quae mala quidem non sunt, tamen habent mali speciem: sui amor est et permanendi conservandique se insita voluntas atque aspernatio dissolutionis, * * * quia videtur multa nobis bona eripere et nos ex hac cui adsuevimus rerum copia educere. Illa quoque res morti nos alienat, quod haec iam novimus, illa ad quae transituri sumus nescimus qualia sint, et horremus ignota. Naturalis praeterea tenebrarum metus est, in quas adductura mors creditur. Itaque etiam si indifferens mors est, non tamen ea est quae facile neglegi possit: magna exercitatione durandus est animus ut conspectum eius accessumque patiatur. Mors contemni debet magis quam solet; multa enim de illa credidimus; multorum ingeniis certatum est ad augendam eius infamiam; descriptus est carcer infernus et perpetua nocte oppressa regio, in qua ingens ianitor Orci ossa super recubans antro semesa cruento aeternum latrans exsangues terreat umbras. Etiam cum persuaseris istas fabulas esse nec quicquam defunctis superesse quod timeant, subit alius metus: aeque enim timent ne apud inferos sint quam ne nusquam. His adversantibus quae nobis offundit longa persuasio, fortiter pati mortem quidni gloriosum sit et inter maxima opera mentis humanae? Quae numquam ad virtutem exsurget si mortem malum esse crediderit: exsurget si
putabit indifferens esse. Non recipit rerum natura ut aliquis magno animo accedat ad id quod malum iudicat: pigre veniet et cunctanter. Non est autem gloriosum quod ab invito et tergiversante fit; nihil facit virtus quia necesse est. Adice nunc quod nihil honeste fit nisi cui totus animus incubuit atque adfuit, cui nulla parte sui repugnavit. Ubi autem ad malum acceditur aut peiorum metu, aut spe bonorum ad quae pervenire tanti sit devorata unius mali patientia, dissident inter se iudicia facientis: hinc est quod iubeat proposita perficere, illinc quod retrahat et ab re suspecta ac periculosa fugiat; igitur in diversa distrahitur. Si hoc est, perit gloria; virtus enim concordi animo decreta peragit, non timet quod facit. Tu ne cede malis, sed contra audentior ito quam tua te fortuna sinet. Non ibis audentior si mala illa esse credideris. Eximendum hoc e pectore est; alioqui haesitabit impetum moratura suspicio; trudetur in id quod invadendum est. Nostri quidem videri volunt Zenonis interrogationem veram esse, fallacem autem alteram et falsam quae illi opponitur. Ego non redigo ista ad legem dialecticam et ad illos artificii veternosissimi nodos: totum genus istuc exturbandum iudico quo circumscribi se qui interrogatur existimat et ad confessionem perductus aliud respondet, aliud putat. Pro veritate simplicius agendum est, contra metum fortius. Haec ipsa quae involvuntur ab illis solvere malim et expandere, ut persuadeam, non ut inponam. In aciem educturus exercitum pro coniugibus ac liberis mortem obiturum quomodo exhortabitur? Do tibi Fabios totum rei publicae bellum in unam transferentes domum. Laconas tibi ostendo in ipsis Thermopylarum angustiis positos: nec victoriam sperant nec reditum; ille locus illis sepulchrum futurus est. Quemadmodum exhortaris ut totius gentis ruinam obiectis corporibus excipiant et vita potius quam loco cedant? Dices «quod malum est gloriosum non est; mors gloriosa est; mors ergo non malum»? O efficacem contionem! Quis post hanc dubitet se infestis ingerere mucronibus et stans mori? At ille Leonidas quam fortiter illos adlocutus est! «Sic», inquit «conmilitones, prandete tamquam apud inferos cenaturi». Non in ore crevit cibus, non haesit in faucibus, non elapsus est manibus: alacres et ad prandium illi promiserunt et ad cenam. Quid? Dux ille Romanus, qui ad occupandum locum milites missos, cum per ingentem hostium exercitum ituri essent, sic adlocutus est: «ire, conmilitones, illo necesse est unde redire non est necesse». Vides quam simplex et imperiosa virtus sit: quem mortalium circumscriptiones vestrae fortiorem facere, quem erectiorem possunt? Frangunt animum, qui numquam minus contrahendus est et in minuta ac spinosa cogendus quam cum ad aliquid grande conponitur. Non trecentis, sed omnibus mortalibus mortis timor detrahi debet. Quomodo illos doces malum non esse? Quomodo opiniones totius aevi, quibus protinus infantia inbuitur, evincis? Quod auxilium invenis inbecillitati humanae? Quid dicis quo inflammati in media pericula inruant? Qua oratione hunc timendi consensum, quibus ingenii viribus obnixam
contra te persuasionem humani generis avertis? Verba mihi captiosa componis et interrogatiunculas nectis? Magnis telis magna portenta feriuntur. Serpentem illam in Africa saevam et Romanis legionibus bello ipso terribiliorem frustra sagittis fundisque petierunt: ne Pythio quidem vulnerabilis erat. Cum ingens magnitudo pro vastitate corporis solida ferrum et quidquid humanae torserant manus reiceret, molaribus demum fracta saxis est. Et adversus mortem tu tam minuta iacularis? Subula leonem excipis? Acuta sunt ista quae dicis: nihil est acutius arista; quaedam inutilia et inefficacia ipsa subtilitas reddit. Vale. 83. Singulos dies tibi meos et quidem totos indicari iubes: bene de me iudicas si nihil esse in illis putas quod abscondam. Sic certe vivendum est tamquam in conspectu vivamus, sic cogitandum tamquam aliquis in pectus intimum introspicere possit: et potest. Quid enim prodest ab homine aliquid esse secretum? Nihil deo clusum est; interest animis nostris et cogitationibus medius intervenit – sic «intervenit» dico tamquam aliquando discedat. Faciam ergo quod iubes, et quid agam et quo ordine libenter tibi scribam. Observabo me protinus et, quod est utilissimum, diem meum recognoscam. Hoc nos pessimos facit, quod nemo vitam suam respicit; quid facturi simus cogitamus, et id raro, quid fecerimus non cogitamus; atqui consilium futuri ex praeterito venit. Hodiernus dies solidus est, nemo ex illo quicquam mihi eripuit; totus inter stratum lectionemque divisus est; minimum exercitationi corporis datum, et hoc nomine ago gratias senectuti: non magno mihi constat. Cum me movi, lassus sum; hic autem est exercitationis etiam fortissimis finis. Progymnastas meos quaeris? Unus mihi sufficit Pharius, puer, ut scis, amabilis, sed mutabitur: iam aliquem teneriorem quaero. Hic quidem ait nos eandem crisin habere, quia utrique dentes cadunt. Sed iam vix illum adsequor currentem et intra paucissimos dies non potero: vide quid exercitatio cotidiana proficiat. Cito magnum intervallum fit inter duos in diversum euntes: eodem tempore ille ascendit, ego descendo, nec ignoras quanto ex his velocius alterum fiat. Mentitus sum; iam enim aetas nostra non descendit sed cadit. Quomodo tamen hodiernum certamen nobis cesserit quaeris? Quod raro cursoribus evenit, hieran fecimus. Ab hac fatigatione magis quam exercitatione in frigidam descendi: hoc apud me vocatur parum calda. Ille tantus psychrolutes, qui kalendis Ianuariis euripum salutabam, qui anno novo quemadmodum legere, scribere, dicere aliquid, sic auspicabar in Virginem desilire, primum ad Tiberim transtuli castra, deinde ad hoc solium quod, cum fortissimus sum et omnia bona fide fiunt, sol temperat: non multum mihi ad balneum superest. Panis deinde siccus et sine mensa prandium, post quod non sunt lavandae manus. Dormio minimum. Consuetudinem meam nosti: brevissimo somno utor et quasi interiungo; satis est mihi vigilare desisse; aliquando dormisse me scio, aliquando suspicor. Ecce circensium obstrepit clamor; subita aliqua et universa voce feriuntur aures meae, nec cogitationem meam excutiunt, ne interrumpunt quidem. Fremitum patientissime fero; multae voces et in unum confusae pro fluctu mihi sunt aut vento silvam verberante et ceteris sine intellectu
sonantibus. Quid ergo est nunc cui animum adiecerim? Dicam. Superest ex hesterno mihi cogitatio quid sibi voluerint prudentissimi viri qui rerum maximarum probationes levissimas et perplexas fecerint, quae ut sint verae, tamen mendacio similes sunt. Vult nos ab ebrietate deterrere Zenon, vir maximus, huius sectae fortissimae ac sanctissimae conditor. Audi ergo quemadmodum colligat virum bonum non futurum ebrium: «ebrio secretum sermonem nemo committit, viro autem bono committit; ergo vir bonus ebrius non erit». Quemadmodum opposita interrogatione simili derideatur adtende (satis enim est unam ponere ex multis): «dormienti nemo secretum sermonem committit, viro autem bono committit; vir bonus ergo non dormit». Quo uno modo potest Posidonius Zenonis nostri causam agit, sed ne sic quidem, ut existimo, agi potest. Ait enim «ebrium» duobus modis dici, altero cum aliquis vino gravis est et inpos sui, altero si solet ebrius fieri et huic obnoxius vitio est; hunc a Zenone dici qui soleat fieri ebrius, non qui sit; huic autem neminem commissurum arcana quae per vinum eloqui possit. Quod est falsum; prima enim illa interrogatio conplectitur eum qui est ebrius, non eum qui futurus est. Plurimum enim interesse concedes et inter ebrium et ebriosum: potest et qui ebrius est tunc primum esse nec habere hoc vitium, et qui ebriosus est saepe extra ebrietatem esse; itaque id intellego quod significari verbo isto solet, praesertim cum ab homine diligentiam professo ponatur et verba examinante. Adice nunc quod, si hoc intellexit Zenon et nos intellegere noluit, ambiguitate verbi quaesiit locum fraudi, quod faciendum non est ubi veritas quaeritur. Sed sane hoc senserit: quod sequitur falsum est, ei qui soleat ebrius fieri non committi sermonem secretum. Cogita enim quam multis militibus non semper sobriis et imperator et tribunus et centurio tacenda mandaverint. De illa C. Caesaris caede, illius dico qui superato Pompeio rem publicam tenuit, tam creditum est Tillio Cimbro quam C. Cassio. Cassius tota vita aquam bibit, Tillius Cimber et nimius erat in vino et scordalus. In hanc rem iocatus est ipse: «ego» inquit «quemquam feram, qui vinum ferre non possum?». Sibi quisque nunc nominet eos quibus scit et vinum male credi et sermonem bene; unum tamen exemplum quod occurrit mihi referam, ne intercidat. Instruenda est enim vita exemplis inlustribus, nec semper confugiamus ad vetera. L. Piso, urbis custos, ebrius ex quo semel factus est fuit. Maiorem noctis partem in convivio exigebat; usque in horam sextam fere dormiebat: hoc eius erat matutinum. Officium tamen suum, quo tutela urbis continebatur, diligentissime administravit. Huic et divus Augustus dedit secreta mandata, cum illum praeponeret Thraciae, quam perdomuit, et Tiberius proficiscens in Campaniam, cum multa in urbe et suspecta relinqueret et invisa. Puto, quia bene illi cesserat Pisonis ebrietas, postea Cossum fecit urbis praefectum, virum gravem, moderatum, sed mersum vino et madentem, adeo ut ex senatu aliquando, in quem e convivio venerat, oppressus inexcitabili somno tolleretur. Huic tamen Tiberius multa sua manu scripsit quae committenda ne ministris quidem suis iudicabat: nullum Cosso aut privatum secretum aut publicum elapsum est.
Itaque declamationes istas de medio removeamus: «Non est animus in sua potestate ebrietate devinctus: quemadmodum musto dolia ipsa rumpuntur et omne quod in imo iacet in summam partem vis caloris eiectat, sic vino exaestuante quidquid in imo iacet abditum effertur et prodit in medium. Onerati mero quemadmodum non continent cibum vino redundante, ita ne secretum quidem; quod suum alienumque est pariter effundunt». Sed quamvis hoc soleat accidere, ita et illud solet, ut cum iis quos sciamus libentius bibere de rebus necessariis deliberemus; falsum ergo est hoc quod patrocinii loco ponitur, ei qui soleat ebrius fieri non dari tacitum. Quanto satius est aperte accusare ebrietatem et vitia eius exponere, quae etiam tolerabilis homo vitaverit, nedum perfectus ac sapiens, cui satis est sitim extinguere, qui, etiam si quando hortata est hilaritas aliena causa producta longius, tamen citra ebrietatem resistit. Nam de illo videbimus, an sapientis animus nimio vino turbetur et faciat ebriis solita: interim, si hoc colligere vis, virum bonum non debere ebrium fieri, cur syllogismis agis? Dic quam turpe sit plus sibi ingerere quam capiat et stomachi sui non nosse mensuram, quam multa ebrii faciant quibus sobrii erubescant, nihil aliud esse ebrietatem quam voluntariam insaniam. Extende in plures dies illum ebrii habitum: numquid de furore dubitabis? Nunc quoque non est minor sed brevior. Refer Alexandri Macedonis exemplum, qui Clitum carissimum sibi ac fidelissimum inter epulas transfodit et intellecto facinore mori voluit, certe debuit. Omne vitium ebrietas et incendit et detegit, obstantem malis conatibus verecundiam removet; plures enim pudore peccandi quam bona voluntate prohibitis abstinent. Ubi possedit animum nimia vis vini, quidquid mali latebat emergit. Non facit ebrietas vitia sed protrahit: tunc libidinosus ne cubiculum quidem expectat, sed cupiditatibus suis quantum petierunt sine dilatione permittit; tunc inpudicus morbum profitetur ac publicat; tunc petulans non linguam, non manum continet. Crescit insolenti superbia, crudelitas saevo, malignitas livido; omne vitium laxatur et prodit. Adice illam ignorationem sui, dubia et parum explanata verba, incertos oculos, gradum errantem, vertiginem capitis, tecta ipsa mobilia velut aliquo turbine circumagente totam domum, stomachi tormenta cum effervescit merum ac viscera ipsa distendit. Tunc tamen utcumque tolerabile est, dum illi vis sua est: quid cum somno vitiatur et quae ebrietas fuit cruditas facta est? Cogita quas clades ediderit publica ebrietas: haec acerrimas gentes bellicosasque hostibus tradidit, haec multorum annorum pertinaci bello defensa moenia patefecit, haec contumacissimos et iugum recusantes in alienum egit arbitrium, haec invictos acie mero domuit. Alexandrum, cuius modo feci mentionem, tot itinera, tot proelia, tot hiemes per quas victa temporum locorumque difficultate transierat, tot flumina ex ignoto cadentia, tot maria tutum dimiserunt: intemperantia bibendi et ille Herculaneus ac fatalis scyphus condidit. Quae gloria est capere multum? Cum penes te palma fuerit et propinationes tuas strati somno ac vomitantes recusaverint, cum superstes toti convivio fueris, cum omnes viceris virtute magnifica et nemo vini tam capax fuerit, vinceris a dolio. M. Antonium, magnum
virum et ingeni nobilis, quae alia res perdidit et in externos mores ac vitia non Romana traiecit quam ebrietas nec minor vino Cleopatrae amor? Haec illum res hostem rei publicae, haec hostibus suis inparem reddidit; haec crudelem fecit, cum capita principum civitatis cenanti referrentur, cum inter apparatissimas epulas luxusque regales ora ac manus proscriptorum recognosceret, cum vino gravis sitiret tamen sanguinem. Intolerabile erat quod ebrius fiebat cum haec faceret: quanto intolerabilius quod haec in ipsa ebrietate faciebat! Fere vinolentiam crudelitas sequitur; vitiatur enim exasperaturque sanitas mentis. Quemadmodum morosos difficilesque faciunt diutini morbi et ad minimam rabidos offensionem, ita ebrietates continuae efferant animos; nam cum saepe apud se non sint, consuetudo insaniae durat et vitia vino concepta etiam sine illo valent. Dic ergo quare sapiens non debeat ebrius fieri; deformitatem rei et inportunitatem ostende rebus, non verbis. Quod facillimum est, proba istas quae voluptates vocantur, ubi transcenderunt modum, poenas esse. Nam si illud argumentaberis, sapientem multo vino non inebriari et retinere rectum tenorem etiam si temulentus sit, licet colligas nec veneno poto moriturum nec sopore sumpto dormiturum nec elleboro accepto quidquid in visceribus haerebit eiecturum deiecturumque. Sed si temptantur pedes, lingua non constat, quid est quare illum existimes in parte sobrium esse, in parte ebrium? Vale.
Liber undecimus 84. Itinera ista quae segnitiam mihi excutiunt et valetudini meae prodesse iudico et studiis. Quare valetudinem adiuvent vides: cum pigrum me et neglegentem corporis litterarum amor faciat, aliena opera exerceor. Studio quare prosint indicabo: a lectionibus non recessi. Sunt autem, ut existimo, necessariae, primum ne sim me uno contentus, deinde ut, cum ab aliis quaesita cognovero, tum et de inventis iudicem et cogitem de inveniendis. Alit lectio ingenium et studio fatigatum, non sine studio tamen, reficit. Nec scribere tantum nec tantum legere debemus: altera res contristabit vires et exhauriet (de stilo dico), altera solvet ac diluet. Invicem hoc et illo commeandum est et alterum altero temperandum, ut quidquid lectione collectum est stilus redigat in corpus. Apes, ut aiunt, debemus imitari, quae vagantur et flores ad mel faciendum idoneos carpunt, deinde quidquid attulere disponunt ac per favos digerunt et, ut Vergilius noster ait, liquentia mella stipant et dulci distendunt nectare cellas. De illis non satis constat utrum sucum ex floribus ducant qui protinus mel sit, an quae collegerunt in hunc saporem mixtura quadam et proprietate spiritus sui mutent. Quibusdam enim placet non faciendi mellis scientiam esse illis sed colligendi. Aiunt inveniri apud Indos mel in arundinum foliis, quod aut ros illius caeli aut ipsius arundinis umor dulcis et pinguior gignat; in nostris quoque herbis vim eandem sed minus manifestam et notabilem poni, quam persequatur et contrahat animal huic rei genitum. Quidam existimant conditura et dispositione in hanc qualitatem verti quae ex tenerrimis virentium florentiumque decerpserint, non sine quodam, ut ita dicam, fermento, quo in unum diversa coalescunt. Sed ne ad aliud quam de quo agitur abducar, nos quoque has apes debemus imitari et quaecumque ex diversa lectione congessimus separare (melius enim distincta servantur), deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere, ut etiam si apparuerit unde sumptum sit, aliud tamen esse quam unde sumptum est appareat. Quod in corpore nostro videmus sine ulla opera nostra facere naturam (alimenta quae accepimus, quamdiu in sua qualitate perdurant et solida innatant stomacho, onera sunt; at cum ex eo quod erant mutata sunt, tunc demum in vires et in sanguinem transeunt), idem in his quibus aluntur ingenia praestemus, ut quaecumque hausimus non patiamur integra esse, ne aliena sint. Concoquamus illa; alioqui in memoriam ibunt, non in ingenium. Adsentiamur illis fideliter et nostra faciamus, ut unum quiddam fiat ex multis, sicut unus numerus fit ex singulis cum minores summas et dissidentes conputatio una conprendit. Hoc faciat animus noster: omnia quibus est adiutus abscondat, ipsum tantum ostendat quod effecit. Etiam si cuius in te comparebit similitudo quem admiratio tibi altius fixerit, similem esse te volo quomodo filium, non quomodo imaginem: imago res mortua est. «Quid ergo? Non
intellegetur cuius imiteris orationem? Cuius argumentationem? Cuius sententias?». Puto aliquando ne intellegi quidem posse, si magni vir ingenii omnibus quae ex quo voluit exemplari traxit formam suam inpressit, ut in unitatem illa conpetant. Non vides quam multorum vocibus chorus constet? Unus tamen ex omnibus redditur. Aliqua illic acuta est, aliqua gravis, aliqua media; accedunt viris feminae, interponuntur tibiae: singulorum illic latent voces, omnium apparent. De choro dico quem veteres philosophi noverant: in commissionibus nostris plus cantorum est quam in theatris olim spectatorum fuit. Cum omnes vias ordo canentium implevit et cavea aeneatoribus cincta est et ex pulpito omne tibiarum genus organorumque consonuit, fit concentus ex dissonis. Talem animum esse nostrum volo: multae in illo artes, multa praecepta sint, multarum aetatum exempla, sed in unum conspirata. «Quomodo» inquis «hoc effici poterit?». Adsidua intentione: si nihil egerimus nisi ratione suadente, nihil vitaverimus nisi ratione suadente. Hanc si audire volueris, dicet tibi: relinque ista iamdudum ad quae discurritur; relinque divitias, aut periculum possidentium aut onus; relinque corporis atque animi voluptates, molliunt et enervant; relinque ambitum, tumida res est, vana, ventosa, nullum habet terminum, tam sollicita est ne quem ante se videat quam ne secum, laborat invidia et quidem duplici. Vides autem quam miser sit si is cui invidetur et invidet. Intueris illas potentium domos, illa tumultuosa rixa salutantium limina? Multum habent contumeliarum ut intres, plus cum intraveris. Praeteri istos gradus divitum et magno adgestu suspensa vestibula: non in praerupto tantum istic stabis sed in lubrico. Huc potius te ad sapientiam derige, tranquillissimasque res eius et simul amplissimas pete. Quaecumque videntur eminere in rebus humanis, quamvis pusilla sint et comparatione humillimorum exstent, per difficiles tamen et arduos tramites adeuntur. Confragosa in fastigium dignitatis via est; at si conscendere hunc verticem libet, cui se fortuna summisit, omnia quidem sub te quae pro excelsissimis habentur aspicies, sed tamen venies ad summa per planum. Vale. 85. Peperceram tibi et quidquid nodosi adhuc supererat praeterieram, contentus quasi gustum tibi dare eorum quae a nostris dicuntur ut probetur virtus ad explendam beatam vitam sola satis efficax. Iubes me quidquid est interrogationum aut nostrarum aut ad traductionem nostram excogitatarum conprendere: quod si facere voluero, non erit epistula sed liber. Illud totiens testor, hoc me argumentorum genere non delectari; pudet in aciem descendere pro dis hominibusque susceptam subula armatum. «Qui prudens est et temperans est; qui temperans est, et constans; qui constans est inperturbatus est; qui inperturbatus est sine tristitia est; qui sine tristitia est beatus est; ergo prudens beatus est, et prudentia ad beatam vitam satis est». Huic collectioni hoc modo Peripatetici quidam respondent, ut inperturbatum et constantem et sine tristitia sic interpretentur tamquam inperturbatus dicatur qui
raro perturbatur et modice, non qui numquam. Item sine tristitia eum dici aiunt qui non est obnoxius tristitiae nec frequens nimiusve in hoc vitio; illud enim humanam naturam negare, alicuius animum inmunem esse tristitia; sapientem non vinci maerore, ceterum tangi; et cetera in hunc modum sectae suae respondentia. Non his tollunt adfectus sed temperant. Quantulum autem sapienti damus, si inbecillissimis fortior est et maestissimis laetior et effrenatissimis moderatior et humillimis maior! Quid si miretur velocitatem suam Ladas ad claudos debilesque respiciens? Illa vel intactae segetis per summa volaret gramina nec cursu teneras laesisset aristas, vel mare per medium fluctu suspensa tumenti ferret iter, celeres nec tingueret aequore plantas. Haec est pernicitas per se aestimata, non quae tardissimorum conlatione laudatur. Quid si sanum voces leviter febricitantem? Non est bona valetudo mediocritas morbi. «Sic» inquit «sapiens inperturbatus dicitur quomodo apyrina dicuntur non quibus nulla inest duritia granorum sed quibus minor». Falsum est. Non enim deminutionem malorum in bono viro intellego sed vacationem; nulla debent esse, non parva; nam si ulla sunt, crescent et interim inpedient. Quomodo oculos maior et perfecta suffusio excaecat, sic modica turbat. Si das aliquos adfectus sapienti, inpar illis erit ratio et velut torrente quodam auferetur, praesertim cum illi non unum adfectum des cum quo conluctetur sed omnis. Plus potest quamvis mediocrium turba quam posset unius magni violentia. Habet pecuniae cupiditatem, sed modicam; habet ambitionem, sed non concitatam; habet iracundiam, sed placabilem; habet inconstantiam, sed minus vagam ac mobilem; habet libidinem, sed non insanam. Melius cum illo ageretur qui unum vitium integrum haberet quam cum eo qui leviora quidem, sed omnia. Deinde nihil interest quam magnus sit adfectus: quantuscumque est, parere nescit, consilium non accipit. Quemadmodum rationi nullum animal optemperat, non ferum, non domesticum et mite (natura enim illorum est surda suadenti), sic non sequuntur, non audiunt adfectus, quantulicumque sunt. Tigres leonesque numquam feritatem exuunt, aliquando summittunt, et cum minime expectaveris exasperatur torvitas mitigata. Numquam bona fide vitia mansuescunt. Deinde, si ratio proficit, ne incipient quidem adfectus; si invita ratione coeperint, invita perseverabunt. Facilius est enim initia illorum prohibere quam impetum regere. Falsa est itaque ista mediocritas et inutilis, eodem loco habenda quo si quis diceret modice insaniendum, modice aegrotandum. Sola virtus habet, non recipiunt animi mala temperamentum; facilius sustuleris illa quam rexeris. Numquid dubium est quin vitia mentis humanae inveterata et dura, quae morbos vocamus, inmoderata sint, ut avaritia, ut crudelitas, ut inpotentia? Ergo inmoderati sunt et adfectus; ab his enim ad illa transitur. Deinde, si das aliquid iuris tristitiae, timori, cupiditati, ceteris motibus pravis, non erunt in nostra
potestate. Quare? Quia extra nos sunt quibus inritantur; itaque crescent prout magnas habuerint minoresve causas quibus concitentur. Maior erit timor, si plus quo exterreatur aut propius aspexerit, acrior cupiditas quo illam amplioris rei spes evocaverit. Si in nostra potestate non est an sint adfectus, ne illud quidem est, quanti sint: si ipsis permisisti incipere, cum causis suis crescent tantique erunt quanti fient. Adice nunc quod ista, quamvis exigua sint, in maius excedunt; numquam perniciosa servant modum; quamvis levia initia morborum serpunt et aegra corpora minima interdum mergit accessio. Illud vero cuius dementiae est, credere quarum rerum extra nostrum arbitrium posita principia sunt, earum nostri esse arbitri terminos! Quomodo ad id finiendum satis valeo ad quod prohibendum parum valui, cum facilius sit excludere quam admissa conprimere? Quidam ita distinxerunt ut dicerent, «temperans ac prudens positione quidem mentis et habitu tranquillus est, eventu non est. Nam, quantum ad habitum mentis suae, non perturbatur nec contristatur nec timet, sed multae extrinsecus causae incidunt quae illi perturbationem adferant». Tale est quod volunt dicere: iracundum quidem illum non esse, irasci tamen aliquando; et timidum quidem non esse, timere tamen aliquando, id est vitio timoris carere, adfectu non carere. Quod si recipitur, usu frequenti timor transibit in vitium, et ira in animum admissa habitum illum ira carentis animi retexet. Praeterea si non contemnit venientes extrinsecus causas et aliquid timet, cum fortiter eundum erit adversus tela, ignes, pro patria, legibus, libertate, cunctanter exibit et animo recedente. Non cadit autem in sapientem haec diversitas mentis. Illud praeterea iudico observandum, ne duo quae separatim probanda sunt misceamus; per se enim colligitur unum bonum esse quod honestum, per se rursus ad vitam beatam satis esse virtutem. Si unum bonum est quod honestum, omnes concedunt ad beate vivendum sufficere virtutem; e contrario non remittetur, si beatum sola virtus facit, unum bonum esse quod honestum est. Xenocrates et Speusippus putant beatum vel sola virtute fieri posse, non tamen unum bonum esse quod honestum est. Epicurus quoque iudicat, cum virtutem habeat, beatum esse, sed ipsam virtutem non satis esse ad beatam vitam, quia beatum efficiat voluptas quae ex virtute est, non ipsa virtus. Inepta distinctio: idem enim negat umquam virtutem esse sine voluptate. Ita si ei iuncta semper est atque inseparabilis, et sola satis est; habet enim secum voluptatem, sine qua non est etiam cum sola est. Illud autem absurdum est, quod dicitur beatum quidem futurum vel sola virtute, non futurum autem perfecte beatum; quod quemadmodum fieri possit non reperio. Beata enim vita bonum in se perfectum habet, inexsuperabile; quod si est, perfecte beata est. Si deorum vita nihil habet maius aut melius, beata autem vita divina est, nihil habet in quod amplius possit attolli. Praeterea, si beata vita nullius est indigens, omnis beata vita perfecta est eademque est et beata et beatissima. Numquid dubitas quin beata vita summum bonum sit? Ergo si summum bonum habet, summe beata est. Quemadmodum summum bonum adiectionem non recipit (quid enim supra summum erit?), ita ne beata quidem vita, quae sine summo bono non est. Quod si aliquem «magis» beatum induxeris,
induces et «multo magis»; innumerabilia discrimina summi boni facies, cum summum bonum intellegam quod supra se gradum non habet. Si est aliquis minus beatus quam alius, sequitur ut hic alterius vitam beatioris magis concupiscat quam suam; beatus autem nihil suae praefert. Utrumlibet ex his incredibile est, aut aliquid beato restare quod esse quam quod est malit, aut id illum non malle quod illo melius est. Utique enim quo prudentior est, hoc magis se ad id quod est optimum extendet et id omni modo consequi cupiet. Quomodo autem beatus est qui cupere etiamnunc potest, immo qui debet? Dicam quid sit ex quo veniat hic error: nesciunt beatam vitam unam esse. In optimo illam statu ponit qualitas sua, non magnitudo; itaque in aequo est longa et brevis, diffusa et angustior, in multa loca multasque partes distributa et in unum coacta. Qui illam numero aestimat et mensura et partibus, id illi quod habet eximium eripit. Quid autem est in beata vita eximium? Quod plena est. Finis, ut puto, edendi bibendique satietas est. Hic plus edit, ille minus: quid refert? Uterque iam satur est. Hic plus bibit, ille minus: quid refert? Uterque non sitit. Hic pluribus annis vixit, hic paucioribus: nihil interest si tam illum multi anni beatum fecerunt quam hunc pauci. Ille quem tu minus beatum vocas non est beatus: non potest hoc nomen inminui. «Qui fortis est sine timore est; qui sine timore est sine tristitia est; qui sine tristitia est beatus est». Nostrorum haec interrogatio est. Adversus hanc sic respondere conantur: falsam nos rem et controversiosam pro confessa vindicare, eum qui fortis est sine timore esse. «Quid ergo?» inquit «fortis inminentia mala non timebit? Istuc dementis alienatique, non fortis est. Ille vero» inquit «moderatissime timet, sed in totum extra metum non est». Qui hoc dicunt rursus in idem revolvuntur, ut illis virtutum loco sint minora vitia; nam qui timet quidem, sed rarius et minus, non caret malitia, sed leviore vexatur. «At enim dementem puto qui mala inminentia non extimescit». Verum est quod dicis, si mala sunt; sed si scit mala illa non esse et unam tantum turpitudinem malum iudicat, debebit secure pericula aspicere et aliis timenda contemnere. Aut si stulti et amentis est mala non timere, quo quis prudentior est, hoc timebit magis. «Ut vobis» inquit «videtur, praebebit se periculis fortis». Minime: non timebit illa sed vitabit; cautio illum decet, timor non decet. «Quid ergo?» inquit «mortem, vincula, ignes, alia tela fortunae non timebit?». Non; scit enim illa non esse mala sed videri; omnia ista humanae vitae formidines putat. Describe captivitatem, verbera, catenas, egestatem et membrorum lacerationes vel per morbum vel per iniuriam et quidquid aliud adtuleris: inter lymphatos metus numerat. Ista timidis timenda sunt. An id existimas malum ad quod aliquando nobis nostra sponte veniendum est? Quaeris quid sit malum? Cedere iis quae mala vocantur et illis libertatem suam dedere, pro qua cuncta patienda sunt: perit libertas nisi illa contemnimus quae nobis iugum inponunt. Non dubitarent quid conveniret forti viro si scirent quid esset fortitudo. Non est enim inconsulta temeritas nec periculorum amor nec formidabilium adpetitio: scientia est distinguendi quid sit malum et quid non sit. Diligentissima in tutela sui fortitudo est et eadem patientissima eorum quibus
falsa species malorum est. «Quid ergo? Si ferrum intentatur cervicibus viri fortis, si pars subinde alia atque alia suffoditur, si viscera sua in sinu suo vidit, si ex intervallo, quo magis tormenta sentiat, repetitur et per adsiccata vulnera recens demittitur sanguis, non timet? Istum tu dices nec dolere?». Iste vero dolet (sensum enim hominis nulla exuit virtus), sed non timet: invictus ex alto dolores suos spectat. Quaeris quis tunc animus illi sit? Qui aegrum amicum adhortantibus. «Quod malum est nocet; quod nocet deteriorem facit; dolor et paupertas deteriorem non faciunt; ergo mala non sunt». «Falsum est» inquit «quod proponitis; non enim, si quid nocet, etiam deteriorem facit. Tempestas et procella nocet gubernatori, non tamen illum deteriorem facit». Quidam e Stoicis ita adversus hoc respondent: deteriorem fieri gubernatorem tempestate ac procella, quia non possit id quod proposuit efficere nec tenere cursum suum; deteriorem illum in arte sua non fieri, in opere fieri. Quibus Peripateticus «ergo» inquit «et sapientem deteriorem faciet paupertas, dolor, et quidquid aliud tale fuerit; virtutem enim illi non eripiet, sed opera eius inpediet». Hoc recte diceretur nisi dissimilis esset gubernatoris condicio et sapientis. Huic enim propositum est in vita agenda non utique quod temptat efficere, sed omnia recte facere: gubernatori propositum est utique navem in portum perducere. Artes ministrae sunt, praestare debent quod promittunt, sapientia domina rectrixque est; artes serviunt vitae, sapientia imperat. Ego aliter respondendum iudico: nec artem gubernatoris deteriorem ulla tempestate fieri nec ipsam administrationem artis. Gubernator tibi non felicitatem promisit sed utilem operam et navis regendae scientiam; haec eo magis apparet quo illi magis aliqua fortuita vis obstitit. Qui hoc potuit dicere, «Neptune, numquam hanc navem nisi rectam», arti satis fecit: tempestas non opus gubernatoris inpedit sed successum. «Quid ergo?» inquit «non nocet gubernatori ea res quae illum tenere portum vetat, quae conatus eius inritos efficit, quae aut refert illum aut detinet et exarmat?». Non tamquam gubernatori, sed tamquam naviganti nocet: alioqui gubernator ille non est. Gubernatoris artem adeo non inpedit ut ostendat; tranquillo enim, ut aiunt, quilibet gubernator est. Navigio ista obsunt, non rectori eius, qua rector est. Duas personas habet gubernator, alteram communem cum omnibus qui eandem conscenderunt navem: ipse quoque vector est; alteram propriam: gubernator est. Tempestas tamquam vectori nocet, non tamquam gubernatori. Deinde gubernatoris ars alienum bonum est: ad eos quos vehit pertinet, quomodo medici ad eos quos curat: sapientis commune bonum est: est et eorum cum quibus vivit et proprium ipsius. Itaque gubernatori fortasse noceatur cuius ministerium aliis promissum tempestate inpeditur: sapienti non nocetur a paupertate, non a dolore, non ab aliis tempestatibus vitae. Non enim prohibentur opera eius omnia, sed tantum ad alios pertinentia: ipse semper in actu est, in effectu tunc maximus cum illi fortuna se opposuit; tunc enim ipsius sapientiae negotium agit, quam diximus et alienum bonum esse et suum. Praeterea ne aliis quidem tunc prodesse prohibetur cum illum aliquae necessitates premunt. Propter paupertatem prohibetur docere quemadmodum
tractanda res publica sit, at illud docet, quemadmodum sit tractanda paupertas. Per totam vitam opus eius extenditur. Ita nulla fortuna, nulla res actus sapientis excludit; id enim ipsum agit quo alia agere prohibetur. Ad utrosque casus aptatus est: bonorum rector est, malorum victor. Sic, inquam, se exercuit ut virtutem tam in secundis quam in adversis exhiberet nec materiam eius sed ipsam intueretur; itaque nec paupertas illum nec dolor nec quidquid aliud inperitos avertit et praecipites agit prohibet. Tu illum premi putas malis? Utitur. Non ex ebore tantum Phidias sciebat facere simulacra; faciebat ex aere. Si marmor illi, si adhuc viliorem materiam obtulisses, fecisset quale ex illa fieri optimum posset. Sic sapiens virtutem, si licebit, in divitiis explicabit, si minus, in paupertate; si poterit, in patria, si minus, in exilio; si poterit, imperator, si minus, miles; si poterit, integer, si minus, debilis. Quamcumque fortunam acceperit, aliquid ex illa memorabile efficiet. Certi sunt domitores ferarum qui saevissima animalia et ad occursum expavescenda hominem pati subigunt nec asperitatem excussisse contenti usque in contubernium mitigant: leonis faucibus magister manum insertat, osculatur tigrim suus custos, elephantum minimus Aethiops iubet subsidere in genua et ambulare per funem. Sic sapiens artifex est domandi mala: dolor, egestas, ignominia, carcer, exilium ubique horrenda, cum ad hunc pervenere, mansueta sunt. Vale. 86. In ipsa Scipionis Africani villa iacens haec tibi scribo, adoratis manibus eius et ara, quam sepulchrum esse tanti viri suspicor. Animum quidem eius in caelum ex quo erat redisse persuadeo mihi, non quia magnos exercitus duxit (hos enim et Cambyses furiosus ac furore feliciter usus habuit), sed ob egregiam moderationem pietatemque, quam magis in illo admirabilem iudico cum reliquit patriam quam cum defendit. Aut Scipio Romae esse debebat aut Roma in libertate. «Nihil» inquit «volo derogare legibus, nihil institutis; aequum inter omnes cives ius sit. Utere sine me beneficio meo, patria. Causa tibi libertatis fui, ero et argumentum: exeo, si plus quam tibi expedit crevi». Quidni ego admirer hanc magnitudinem animi, qua in exilium voluntarium secessit et civitatem exoneravit? Eo perducta res erat ut aut libertas Scipioni aut Scipio libertati faceret iniuriam. Neutrum fas erat; itaque locum dedit legibus et se Liternum recepit tam suum exilium rei publicae inputaturus quam Hannibalis. Vidi villam extructam lapide quadrato, murum circumdatum silvae, turres quoque in propugnaculum villae utrimque subrectas, cisternam aedificiis ac viridibus subditam quae sufficere in usum vel exercitus posset, balneolum angustum, tenebricosum ex consuetudine antiqua: non videbatur maioribus nostris caldum nisi obscurum. Magna ergo me voluptas subiit contemplantem mores Scipionis ac nostros: in hoc angulo ille «Carthaginis horror», cui Roma debet quod tantum semel capta est, abluebat corpus laboribus rusticis fessum. Exercebat enim opere se terramque (ut mos fuit priscis) ipse subigebat. Sub hoc ille tecto tam sordido stetit, hoc illum pavimentum tam vile sustinuit: at nunc quis est qui sic lavari sustineat? Pauper sibi videtur ac sordidus nisi parietes magnis
et pretiosis orbibus refulserunt, nisi Alexandrina marmora Numidicis crustis distincta sunt, nisi illis undique operosa et in picturae modum variata circumlitio praetexitur, nisi vitro absconditur camera, nisi Thasius lapis, quondam rarum in aliquo spectaculum templo, piscinas nostras circumdedit, in quas multa sudatione corpora exsaniata demittimus, nisi aquam argentea epitonia fuderunt. Et adhuc plebeias fistulas loquor: quid cum ad balnea libertinorum pervenero? Quantum statuarum, quantum columnarum est nihil sustinentium sed in ornamentum positarum impensae causa! quantum aquarum per gradus cum fragore labentium! Eo deliciarum pervenimus ut nisi gemmas calcare nolimus. In hoc balneo Scipionis minimae sunt rimae magis quam fenestrae muro lapideo exsectae, ut sine iniuria munimenti lumen admitterent; at nunc blattaria vocant balnea, si qua non ita aptata sunt ut totius diei solem fenestris amplissimis recipiant, nisi et lavantur simul et colorantur, nisi ex solio agros ac maria prospiciunt. Itaque quae concursum et admirationem habuerant cum dedicarentur, ea in antiquorum numerum reiciuntur cum aliquid novi luxuria commenta est quo ipsa se obrueret. At olim et pauca erant balnea nec ullo cultu exornata: cur enim exornaretur res quadrantaria et in usum, non in oblectamentum reperta? Non suffundebatur aqua nec recens semper velut ex calido fonte currebat, nec referre credebant in quam perlucida sordes deponerent. Sed, di boni, quam iuvat illa balinea intrare obscura et gregali tectorio inducta, quae scires Catonem tibi aedilem aut Fabium Maximum aut ex Corneliis aliquem manu sua temperasse! Nam hoc quoque nobilissimi aediles fungebantur officio intrandi ea loca quae populum receptabant exigendique munditias et utilem ac salubrem temperaturam, non hanc quae nuper inventa est similis incendio, adeo quidem ut convictum in aliquo scelere servum vivum lavari oporteat. Nihil mihi videtur iam interesse, ardeat balineum an caleat. Quantae nunc aliqui rusticitatis damnant Scipionem quod non in caldarium suum latis specularibus diem admiserat, quod non in multa luce decoquebatur et expectabat ut in balneo concoqueret! O hominem calamitosum! nesciit vivere. Non saccata aqua lavabatur sed saepe turbida et, cum plueret vehementius, paene lutulenta. Nec multum eius intererat an sic lavaretur; veniebat enim ut sudorem illic ablueret, non ut unguentum. Quas nunc quorundam voces futuras credis? «Non invideo Scipioni: vere in exilio vixit qui sic lavabatur». Immo, si scias, non cotidie lavabatur; nam, ut aiunt qui priscos mores urbis tradiderunt, brachia et crura cotidie abluebant, quae scilicet sordes opere collegerant, ceterum toti nundinis lavabantur. Hoc loco dicet aliquis: «liquet mihi inmundissimos fuisse». Quid putas illos oluisse? Militiam, laborem, virum. Postquam munda balnea inventa sunt, spurciores sunt. Descripturus infamem et nimiis notabilem deliciis Horatius Flaccus quid ait? Pastillos Buccillus olet. Dares nunc Buccillum: proinde esset ac si hircum oleret, Gargonii loco esset, quem idem Horatius Buccillo opposuit. Parum est sumere unguentum nisi bis die
terque renovatur, ne evanescat in corpore. Quid quod hoc odore tamquam suo gloriantur? Haec si tibi nimium tristia videbuntur, villae inputabis, in qua didici ab Aegialo, diligentissimo patre familiae (is enim nunc huius agri possessor est) quamvis vetus arbustum posse transferri. Hoc nobis senibus discere necessarium est, quorum nemo non olivetum alteri ponit, †quod vidi illud arborum trimum et quadrimum fastidiendi fructus aut deponere.† Te quoque proteget illa quae tarda venit seris factura nepotibus umbram, ut ait Vergilius noster, qui non quid verissime sed quid decentissime diceretur aspexit, nec agricolas docere voluit sed legentes delectare. Nam, ut alia omnia transeam, hoc quod mihi hodie necesse fuit deprehendere, adscribam: vere fabis satio est; tunc te quoque, Medica, putres accipiunt sulci, et milio venit annua cura. An uno tempore ista ponenda sint et an utriusque verna sit satio, hinc aestimes licet: Iunius mensis est quo tibi scribo, iam proclivis in Iulium: eodem die vidi fabam metentes, milium serentes. Ad olivetum revertar, quod vidi duobus modis positum: magnarum arborum truncos circumcisis ramis et ad unum redactis pedem cum rapo suo transtulit, amputatis radicibus, relicto tantum capite ipso ex quo illae pependerant. Hoc fimo tinctum in scrobem demisit, deinde terram non adgessit tantum, sed calcavit et pressit. Negat quicquam esse hac, ut ait, pisatione efficacius. Videlicet frigus excludit et ventum; minus praeterea movetur et ob hoc nascentes radices prodire patitur ac solum adprendere, quas necesse est cereas adhuc et precario haerentes levis quoque revellat agitatio. Rapum autem arboris antequam obruat radit; ex omni enim materia quae nudata est, ut ait, radices exeunt novae. Non plures autem super terram eminere debet truncus quam tres aut quattuor pedes; statim enim ab imo vestietur nec magna pars eius quemadmodum in olivetis veteribus arida et retorrida erit. Alter ponendi modus hic fuit: ramos fortes nec corticis duri, quales esse novellarum arborum solent, eodem genere deposuit. Hi paulo tardius surgunt, sed cum tamquam a planta processerint, nihil habent in se abhorridum aut triste. Illud etiamnunc vidi, vitem ex arbusto suo annosam transferri; huius capillamenta quoque, si fieri potest, colligenda sunt, deinde liberalius sternenda vitis, ut etiam ex corpore radicescat. Et vidi non tantum mense Februario positas sed etiam Martio exacto; tenent et conplexae sunt non suas ulmos. Omnes autem istas arbores quae, ut ita dicam, grandiscapiae sunt, ait aqua adiuvandas cisternina; quae si prodest, habemus pluviam in nostra potestate. Plura te docere non cogito, ne quemadmodum Aegialus me sibi adversarium paravit, sic ego parem te mihi. Vale.
87. Naufragium antequam navem ascenderem feci: quomodo acciderit non adicio, ne et hoc putes inter Stoica paradoxa ponendum, quorum nullum esse falsum nec tam mirabile quam prima facie videtur, cum volueris, adprobabo, immo etiam si nolueris. Interim hoc me iter docuit quam multa haberemus supervacua et quam facile iudicio possemus deponere quae, si quando necessitas abstulit, non sentimus ablata. Cum paucissimis servis, quos unum capere vehiculum potuit, sine ullis rebus nisi quae corpore nostro continebantur, ego et Maximus meus biduum iam beatissimum agimus. Culcita in terra iacet, ego in culcita; ex duabus paenulis altera stragulum, altera opertorium facta est. De prandio nihil detrahi potuit; paratum fuit †non magis hora†, nusquam sine caricis, numquam sine pugillaribus; illae, si panem habeo, pro pulmentario sunt, si non habeo, pro pane. Cotidie mihi annum novum faciunt, quem ego faustum et felicem reddo bonis cogitationibus et animi magnitudine, qui numquam maior est quam ubi aliena seposuit et fecit sibi pacem nihil timendo, fecit sibi divitias nihil concupiscendo. Vehiculum in quod inpositus sum rusticum est; mulae vivere se ambulando testantur; mulio excalceatus, non propter aestatem. Vix a me obtineo ut hoc vehiculum velim videri meum: durat adhuc perversa recti verecundia, et quotiens in aliquem comitatum lautiorem incidimus invitus erubesco, quod argumentum est ista quae probo, quae laudo, nondum habere certam sedem et immobilem. Qui sordido vehiculo erubescit pretioso gloriabitur. Parum adhuc profeci: nondum audeo frugalitatem palam ferre; etiamnunc curo opiniones viatorum. Contra totius generis humani opiniones mittenda vox erat: «Insanitis, erratis, stupetis ad supervacua, neminem aestimatis suo. Cum ad patrimonium ventum est, diligentissimi conputatores sic rationem ponitis singulorum quibus aut pecuniam credituri estis aut beneficia (nam haec quoque iam expensa fertis): late possidet, sed multum debet; habet domum formosam, sed alienis nummis paratam; familiam nemo cito speciosiorem producet, sed nominibus non respondet; si creditoribus solverit, nihil illi supererit. Idem in reliquis quoque facere debebitis et excutere quantum proprii quisque habeat». Divitem illum putas quia aurea supellex etiam in via sequitur, quia in omnibus provinciis arat, quia magnus kalendari liber volvitur, quia tantum suburbani agri possidet quantum invidiose in desertis Apuliae possideret: cum omnia dixeris, pauper est. Quare? Quia debet. «Quantum?» inquis. Omnia; nisi forte iudicas interesse utrum aliquis ab homine an a fortuna mutuum sumpserit. Quid ad rem pertinent mulae saginatae unius omnes coloris? Quid ista vehicula caelata? Instratos ostro alipedes pictisque tapetis: aurea pectoribus demissa monilia pendent, tecti auro fulvum mandunt sub dentibus aurum. Ista nec dominum meliorem possunt facere nec mulam. M. Cato Censorius, quem tam e re publica fuit nasci quam Scipionem (alter enim cum hostibus nostris
bellum, alter cum moribus gessit), cantherio vehebatur et hippoperis quidem inpositis, ut secum utilia portaret. O quam cuperem illi nunc occurrere aliquem ex his trossulis, in via divitibus, cursores et Numidas et multum ante se pulveris agentem! Hic sine dubio cultior comitatiorque quam M. Cato videretur, hic qui inter illos apparatus delicatos cum maxime dubitat utrum se ad gladium locet an ad cultrum. O quantum erat saeculi decus, imperatorem, triumphalem, censorium, quod super omnia haec est, Catonem, uno caballo esse contentum et ne toto quidem; partem enim sarcinae ab utroque latere dependentes occupabant. Ita non omnibus obesis mannis et asturconibus et tolutariis praeferres unicum illum equum ab ipso Catone defrictum? Video non futurum finem in ista materia ullum nisi quem ipse mihi fecero. Hic itaque conticiscam, quantum ad ista quae sine dubio talia divinavit futura qualia nunc sunt qui primus appellavit «inpedimenta». Nunc volo paucissimas adhuc interrogationes nostrorum tibi reddere ad virtutem pertinentes, quam satisfacere vitae beatae contendimus. «Quod bonum est bonos facit (nam et in arte musica quod bonum est facit musicum); fortuita bonum non faciunt; ergo non sunt bona». Adversus hoc sic respondent Peripatetici ut quod primum proponimus falsum esse dicant. «Ab eo» inquiunt «quod est bonum non utique fiunt boni. In musica est aliquid bonum tamquam tibia aut chorda aut organum aliquod aptatum ad usus canendi; nihil tamen horum facit musicum». His respondebimus, «non intellegitis quomodo posuerimus quod bonum est in musica. Non enim id dicimus quod instruit musicum, sed quod facit: tu ad supellectilem artis, non ad artem venis. Si quid autem in ipsa arte musica bonum est, id utique musicum faciet». Etiamnunc facere istuc planius volo. Bonum in arte musica duobus modis dicitur, alterum quo effectus musici adiuvatur, alterum quo ars: ad effectum pertinent instrumenta, tibiae et organa et chordae, ad artem ipsam non pertinent. Est enim artifex etiam sine istis: uti forsitan non potest arte. Hoc non est aeque duplex in homine; idem enim est bonum et hominis et vitae. «Quod contemptissimo cuique contingere ac turpissimo potest bonum non est; opes autem et lenoni et lanistae contingunt; ergo non sunt bona». «Falsum est» inquiunt «quod proponitis; nam et in grammatice et in arte medendi aut gubernandi videmus bona humillimis quibusque contingere». Sed istae artes non sunt magnitudinem animi professae, non consurgunt in altum nec fortuita fastidiunt: virtus extollit hominem et super cara mortalibus conlocat; nec ea quae bona nec ea quae mala vocantur aut cupit nimis aut expavescit. Chelidon, unus ex Cleopatrae mollibus, patrimonium grande possedit. Nuper Natalis, tam inprobae linguae quam inpurae, in cuius ore feminae purgabantur, et multorum heres fuit et multos habuit heredes. Quid ergo? Utrum illum pecunia inpurum effecit an ipse pecuniam inspurcavit? Quae sic in quosdam homines quomodo denarius in cloacam cadit. Virtus super ista consistit; suo aere censetur; nihil ex istis quolibet incurrentibus bonum iudicat. Medicina et gubernatio non interdicit sibi ac suis admiratione talium rerum; qui non est vir bonus potest nihilominus
medicus esse, potest gubernator, potest grammaticus tam mehercules quam cocus. Cui contingit habere rem non quamlibet, hunc non quemlibet dixeris; qualia quisque habet, talis est. Fiscus tanti est quantum habet; immo in accessionem eius venit quod habet. Quis pleno sacculo ullum pretium ponit nisi quod pecuniae in eo conditae numerus effecit? Idem evenit magnorum dominis patrimoniorum: accessiones illorum et appendices sunt. Quare ergo sapiens magnus est? Quia magnum animum habet. Verum est ergo quod contemptissimo cuique contingit bonum non esse. Itaque indolentiam numquam bonum dicam: habet illam cicada, habet pulex. Ne quietem quidem et molestia vacare bonum dicam: quid est otiosius verme? Quaeris quae res sapientem faciat? Quae deum. Des oportet illi divinum aliquid, caeleste, magnificum: non in omnes bonum cadit nec quemlibet possessorem patitur. Vide et quid quaeque ferat regio et quid quaeque recuset: hic segetes, illic veniunt felicius uvae, arborei fetus alibi atque iniussa virescunt gramina. Nonne vides, croceos ut Tmolus odores, India mittit ebur, molles sua tura Sabaei, at Chalybes nudi ferrum? Ista in regiones discripta sunt, ut necessarium mortalibus esset inter ipsos commercium, si invicem alius aliquid ab alio peteret. Summum illud bonum habet et ipsum suam sedem; non nascitur ubi ebur, nec ubi ferrum. Quis sit summi boni locus quaeris? Animus. Hic nisi purus ac sanctus est, deum non capit. «Bonum ex malo non fit; divitiae fiunt autem ex avaritia; divitiae ergo non sunt bonum». «Non est» inquit «verum, bonum ex malo non nasci; ex sacrilegio enim et furto pecunia nascitur. Itaque malum quidem est sacrilegium et furtum, sed ideo quia plura mala facit quam bona; dat enim lucrum, sed cum metu, sollicitudine, tormentis et animi et corporis». Quisquis hoc dicit, necesse est recipiat sacrilegium, sicut malum sit quia multa mala facit, ita bonum quoque ex aliqua parte esse, quia aliquid boni facit: quo quid fieri portentuosius potest? Quamquam sacrilegium, furtum, adulterium inter bona haberi prorsus persuasimus. Quam multi furto non erubescunt, quam multi adulterio gloriantur! nam sacrilegia minuta puniuntur, magna in triumphis feruntur. Adice nunc quod sacrilegium, si omnino ex aliqua parte bonum est, etiam honestum erit et recte factum vocabitur, †nostra enim actio est† quod nullius mortalium cogitatio recipit. Ergo bona nasci ex malo non possunt. Nam si, ut dicitis, ob hoc unum sacrilegium malum est, quia multum mali adfert, si remiseris illi supplicia, si securitatem spoponderis, ex toto bonum erit. Atqui maximum scelerum supplicium in ipsis est. Erras, inquam, si illa ad carnificem aut carcerem differs: statim puniuntur cum facta sunt, immo dum fiunt. Non nascitur itaque ex malo bonum, non magis quam ficus ex olea: ad semen nata respondent, bona
degenerare non possunt. Quemadmodum ex turpi honestum non nascitur, ita ne ex malo quidem bonum; nam idem est honestum et bonum. Quidam ex nostris adversus hoc sic respondent: «putemus pecuniam bonum esse undecumque sumptam; non tamen ideo ex sacrilegio pecunia est, etiam si ex sacrilegio sumitur. Hoc sic intellege. In eadem urna et aurum est et vipera: si aurum ex urna sustuleris, non ideo sustuleris quia illic et vipera est; non ideo, inquam, mihi urna aurum dat quia viperam habet, sed aurum dat, cum et viperam habeat. Eodem modo ex sacrilegio lucrum fit, non quia turpe et sceleratum est sacrilegium, sed quia et lucrum habet. Quemadmodum in illa urna vipera malum est, non aurum quod cum vipera iacet, sic in sacrilegio malum est scelus, non lucrum». A quibus dissentio; dissimillima enim utriusque rei condicio est. Illic aurum possum sine vipera tollere, hic lucrum sine sacrilegio facere non possum; lucrum istud non est adpositum sceleri sed inmixtum. «Quod dum consequi volumus in multa mala incidimus, id bonum non est; dum divitias autem consequi volumus, in multa mala incidimus; ergo divitiae bonum non sunt». «Duas» inquit «significationes habet propositio vestra: unam, dum divitias consequi volumus, in multa nos mala incidere. In multa autem mala incidimus et dum virtutem consequi volumus: aliquis dum navigat studii causa, naufragium fecit, aliquis captus est. Altera significatio talis est: per quod in mala incidimus bonum non est. Huic propositioni non erit consequens per divitias nos aut per voluptates in mala incidere; aut si per divitias in multa mala incidimus, non tantum bonum non sunt divitiae sed malum sunt; vos autem illas dicitis tantum bonum non esse. Praeterea» inquit «conceditis divitias habere aliquid usus: inter commoda illas numeratis. Atqui eadem ratione ne commodum quidem erunt; per illas enim multa nobis incommoda eveniunt». His quidam hoc respondent: «erratis, qui incommoda divitis inputatis. Illae neminem laedunt: aut sua nocet cuique stultitia aut aliena nequitia, sic quemadmodum gladius neminem occidit: occidentis telum est. Non ideo divitiae tibi nocent si propter divitias tibi nocetur». Posidonius, ut ego existimo, melius, qui ait divitias esse causam malorum, non quia ipsae faciunt aliquid, sed quia facturos inritant. Alia est enim causa efficiens, quae protinus necessest noceat, alia praecedens. Hanc praecedentem causam divitiae habent: inflant animos, superbiam pariunt, invidiam contrahunt, et usque eo mentem alienant ut fama pecuniae nos etiam nocitura delectet. Bona autem omnia carere culpa decet; pura sunt, non corrumpunt animos, non sollicitant; extollunt quidem et dilatant, sed sine tumore. Quae bona sunt fiduciam faciunt, divitiae audaciam; quae bona sunt magnitudinem animi dant, divitiae insolentiam. Nihil autem aliud est insolentia quam species magnitudinis falsa. «Isto modo» inquit «etiam malum sunt divitiae, non tantum bonum non sunt». Essent malum si ipsae nocerent, si, ut dixi, haberent efficientem causam: nunc praecedentem habent et quidem non inritantem tantum animos sed adtrahentem; speciem enim boni offundunt veri similem ac plerisque credibilem. Habet virtus quoque praecedentem causam ad invidiam; multis enim propter
sapientiam, multis propter iustitiam invidetur. Sed nec ex se hanc causam habet nec veri similem; contra enim veri similior illa species hominum animis obicitur a virtute, quae illos in amorem et admirationem vocet. Posidonius sic interrogandum ait: «quae neque magnitudinem animo dant nec fiduciam nec securitatem non sunt bona; divitiae autem et bona valetudo et similia his nihil horum faciunt; ergo non sunt bona». Hanc interrogationem magis etiamnunc hoc modo intendit: «quae neque magnitudinem animo dant nec fiduciam nec securitatem, contra autem insolentiam, tumorem, arrogantiam creant, mala sunt; a fortuitis autem in haec inpellimur; ergo non sunt bona». «Hac» inquit «ratione ne commoda quidem ista erunt». Alia est commodorum condicio, alia bonorum: commodum est quod plus usus habet quam molestiae; bonum sincerum esse debet et ab omni parte innoxium. Non est id bonum quod plus prodest, sed quod tantum prodest. Praeterea commodum et ad animalia pertinet et ad inperfectos homines et ad stultos. Itaque potest ei esse incommodum mixtum, sed commodum dicitur a maiore sui parte aestimatum: bonum ad unum sapientem pertinet; inviolatum esse oportet. Bonum animum habe: unus tibi nodus, sed Herculaneus restat: «ex malis bonum non fit; ex multis paupertatibus divitiae fiunt; ergo divitiae bonum non sunt». Hanc interrogationem nostri non agnoscunt, Peripatetici et fingunt illam et solvunt. Ait autem Posidonius hoc sophisma, per omnes dialecticorum scholas iactatum, sic ab Antipatro refelli: «paupertas non per possessionem dicitur, sed per detractionem» (vel, ut antiqui dixerunt, orbationem; Graeci kata; stevrhsin dicunt); «non quod habeat dicit, sed quod non habeat. Itaque ex multis inanibus nihil impleri potest: divitias multae res faciunt, non multae inopiae. Aliter» inquit «quam debes paupertatem intellegis. Paupertas enim est non quae pauca possidet, sed quae multa non possidet; ita non ab eo dicitur quod habet, sed ab eo quod ei deest». Facilius quod volo exprimerem, si Latinum verbum esset quo ajnuparxiva significaretur. Hanc paupertati Antipater adsignat: ego non video quid aliud sit paupertas quam parvi possessio. De isto videbimus, si quando valde vacabit, quae sit divitiarum, quae paupertatis substantia; sed tunc quoque considerabimus numquid satius sit paupertatem permulcere, divitiis demere supercilium quam litigare de verbis, quasi iam de rebus iudicatum sit. Putemus nos ad contionem vocatos: lex de abolendis divitis fertur. His interrogationibus suasuri aut dissuasuri sumus? His effecturi ut populus Romanus paupertatem, fundamentum et causam imperii sui, requirat ac laudet, divitias autem suas timeat, ut cogitet has se apud victos repperisse, hinc ambitum et largitiones et tumultus in urbem sanctissimam temperatissimam inrupisse, nimis luxuriose ostentari gentium spolia, quod unus populus eripuerit omnibus facilius ab omnibus uni eripi posse? Haec satius est suadere, et expugnare adfectus, non circumscribere. Si possumus, fortius loquamur; si minus, apertius. Vale.
88. De liberalibus studiis quid sentiam scire desideras: nullum suspicio, nullum in bonis numero quod ad aes exit. Meritoria artificia sunt, hactenus utilia si praeparant ingenium, non detinent. Tamdiu enim istis inmorandum est quamdiu nihil animus agere maius potest; rudimenta sunt nostra, non opera. Quare liberalia studia dicta sint vides: quia homine libero digna sunt. Ceterum unum studium vere liberale est quod liberum facit, hoc est sapientiae, sublime, forte, magnanimum: cetera pusilla et puerilia sunt. An tu quicquam in istis esse credis boni quorum professores turpissimos omnium ac flagitiosissimos cernis? Non discere debemus ista, sed didicisse. Quidam illud de liberalibus studiis quaerendum iudicaverunt, an virum bonum facerent: ne promittunt quidem nec huius rei scientiam adfectant. Grammatice circa curam sermonis versatur et, si latius evagari vult, circa historias, iam ut longissime fines suos proferat, circa carmina. Quid horum ad virtutem viam sternit? Syllabarum enarratio et verborum diligentia et fabularum memoria et versuum lex ac modificatio – quid ex his metum demit, cupiditatem eximit, libidinem frenat? Ad geometriam transeamus et ad musicen: nihil apud illas invenies quod vetet timere, vetet cupere. Quae quisquis ignorat, alia frustra scit. * * * utrum doceant isti virtutem an non: si non docent, ne tradunt quidem; si docent, philosophi sunt. Vis scire quam non ad docendam virtutem consederint? Aspice quam dissimilia inter se omnium studia sint: atqui similitudo esset idem docentium. Nisi forte tibi Homerum philosophum fuisse persuadent, cum his ipsis quibus colligunt negent; nam modo Stoicum illum faciunt, virtutem solam probantem et voluptates refugientem et ab honesto ne inmortalitatis quidem pretio recedentem, modo Epicureum, laudantem statum quietae civitatis et inter convivia cantusque vitam exigentis, modo Peripateticum, tria bonorum genera inducentem, modo Academicum, omnia incerta dicentem. Apparet nihil horum esse in illo, quia omnia sunt; ista enim inter se dissident. Demus illis Homerum philosophum fuisse: nempe sapiens factus est antequam carmina ulla cognosceret; ergo illa discamus quae Homerum fecere sapientem. Hoc quidem me quaerere, uter maior aetate fuerit, Homerus an Hesiodus, non magis ad rem pertinet quam scire, cum minor Hecuba fuerit quam Helena, quare tam male tulerit aetatem. Quid, inquam, annos Patrocli et Achillis inquirere ad rem existimas pertinere? Quaeris Ulixes ubi erraverit potius quam efficias ne nos semper erremus? Non vacat audire utrum inter Italiam et Siciliam iactatus sit an extra notum nobis orbem (neque enim potuit in tam angusto error esse tam longus): tempestates nos animi cotidie iactant et nequitia in omnia Ulixis mala inpellit. Non deest forma quae sollicitet oculos, non hostis; hinc monstra effera et humano cruore gaudentia, hinc insidiosa blandimenta aurium, hinc naufragia et tot varietates malorum. Hoc me doce, quomodo patriam amem, quomodo uxorem, quomodo patrem, quomodo ad haec tam honesta vel naufragus navigem. Quid inquiris an Penelopa inpudica fuerit, an verba saeculo suo dederit? An Ulixem illum esse quem videbat, antequam sciret, suspicata sit? Doce me quid sit pudicitia et
quantum in ea bonum, in corpore an in animo posita sit. Ad musicum transeo. Doces me quomodo inter se acutae ac graves consonent, quomodo nervorum disparem reddentium sonum fiat concordia: fac potius quomodo animus secum meus consonet nec consilia mea discrepent. Monstras mihi qui sint modi flebiles: monstra potius quomodo inter adversa non emittam flebilem vocem. Metiri me geometres docet latifundia potius quam doceat quomodo metiar quantum homini satis sit; numerare docet me et avaritiae commodat digitos potius quam doceat nihil ad rem pertinere istas conputationes, non esse feliciorem cuius patrimonium tabularios lassat, immo quam supervacua possideat qui infelicissimus futurus est si quantum habeat per se conputare cogetur. Quid mihi prodest scire agellum in partes dividere, si nescio cum fratre dividere? Quid prodest colligere subtiliter pedes iugeri et conprendere etiam si quid decempedam effugit, si tristem me facit vicinus inpotens et aliquid ex meo abradens? Docet quomodo nihil perdam ex finibus meis: at ego discere volo quomodo totos hilaris amittam. «Paterno agro et avito» inquit «expellor». Quid? Ante avum tuum quis istum agrum tenuit? Cuius, non dico hominis, sed populi fuerit potes expedire? Non dominus isto, sed colonus intrasti. Cuius colonus es? Si bene tecum agitur, heredis. Negant iurisconsulti quicquam usu capi publicum: hoc quod tenes, quod tuum dicis, publicum est et quidem generis humani. O egregiam artem! scis rotunda metiri, in quadratum redigis quamcumque acceperis formam, intervalla siderum dicis, nihil est quod in mensuram tuam non cadat: si artifex es, metire hominis animum, dic quam magnus sit, dic quam pusillus sit. Scis quae recta sit linea: quid tibi prodest, si quid in vita rectum sit ignoras? Venio nunc ad illum qui caelestium notitia gloriatur: frigida Saturni sese quo stella receptet, quos ignis caeli Cyllenius erret in orbes. Hoc scire quid proderit? Ut sollicitus sim cum Saturnus et Mars ex contrario stabunt aut cum Mercurius vespertinum faciet occasum vidente Saturno, potius quam hoc discam, ubicumque sunt ista, propitia esse nec posse mutari? Agit illa continuus ordo fatorum et inevitabilis cursus; per statas vices remeant et effectus rerum omnium aut movent aut notant. Sed sive quidquid evenit faciunt, quid inmutabilis rei notitia proficiet? Sive significant, quid refert providere quod effugere non possis? Scias ista, nescias: fient. Si vero solem ad rapidum stellasque sequentes ordine respicies, numquam te crastina fallet hora, nec insidiis noctis capiere serenae. Satis abundeque provisum est ut ab insidiis tutus essem. «Numquid me crastina non fallit hora? Fallit enim quod nescienti evenit». Ego quid futurum sit
nescio: quid fieri possit scio. Ex hoc nihil deprecabor, totum expecto: si quid remittitur, boni consulo. Fallit me hora si parcit, sed ne sic quidem fallit. Nam quemadmodum scio omnia accidere posse, sic scio et non utique casura; itaque secunda expecto, malis paratus sum. In illo feras me necesse est non per praescriptum euntem; non enim adducor ut in numerum liberalium artium pictores recipiam, non magis quam statuarios aut marmorarios aut ceteros luxuriae ministros. Aeque luctatores et totam oleo ac luto constantem scientiam expello ex his studiis liberalibus; aut et unguentarios recipiam et cocos et ceteros voluptatibus nostris ingenia accommodantes sua. Quid enim, oro te, liberale habent isti ieiuni vomitores, quorum corpora in sagina, animi in macie et veterno sunt? An liberale studium istuc esse iuventuti nostrae credimus, quam maiores nostri rectam exercuerunt hastilia iacere, sudem torquere, equum agitare, arma tractare? Nihil liberos suos docebant quod discendum esset iacentibus. Sed nec hae nec illae docent aluntve virtutem; quid enim prodest equum regere et cursum eius freno temperare, adfectibus effrenatissimis abstrahi? Quid prodest multos vincere luctatione vel caestu, ab iracundia vinci? «Quid ergo? Nihil nobis liberalia conferunt studia?». Ad alia multum, ad virtutem nihil; nam et hae viles ex professo artes quae manu constant ad instrumenta vitae plurimum conferunt, tamen ad virtutem non pertinent. «Quare ergo liberalibus studiis filios erudimus?». Non quia virtutem dare possunt, sed quia animum ad accipiendam virtutem praeparant. Quemadmodum prima illa, ut antiqui vocabant, litteratura, per quam pueris elementa traduntur, non docet liberales artes sed mox percipiendis locum parat, sic liberales artes non perducunt animum ad virtutem sed expediunt. Quattuor ait esse artium Posidonius genera: sunt vulgares et sordidae, sunt ludicrae, sunt pueriles, sunt liberales. Vulgares opificum, quae manu constant et ad instruendam vitam occupatae sunt, in quibus nulla decoris, nulla honesti simulatio est. Ludicrae sunt quae ad voluptatem oculorum atque aurium tendunt; his adnumeres licet machinatores qui pegmata per se surgentia excogitant et tabulata tacite in sublime crescentia et alias ex inopinato varietates, aut dehiscentibus quae cohaerebant aut his quae distabant sua sponte coeuntibus aut his quae eminebant paulatim in se residentibus. His inperitorum feriuntur oculi, omnia subita quia causas non novere mirantium. Pueriles sunt et aliquid habentes liberalibus simile hae artes quas ejgkuklivou" Graeci, nostri autem liberales vocant. Solae autem liberales sunt, immo, ut dicam verius, liberae, quibus curae virtus est. «Quemadmodum» inquit «est aliqua pars philosophiae naturalis, est aliqua moralis, est aliqua rationalis, sic et haec quoque liberalium artium turba locum sibi in philosophia vindicat. Cum ventum est ad naturales quaestiones, geometriae testimonio statur; ergo eius quam adiuvat pars est». Multa adiuvant nos nec ideo partes nostri sunt; immo si partes essent, non adiuvarent. Cibus adiutorium corporis nec tamen pars est. Aliquod nobis praestat geometria
ministerium: sic philosophiae necessaria est quomodo ipsi faber, sed nec hic geometriae pars est nec illa philosophiae. Praeterea utraque fines suos habet; sapiens enim causas naturalium et quaerit et novit, quorum numeros mensurasque geometres persequitur et supputat. Qua ratione constent caelestia, quae illis sit vis quaeve natura sapiens scit: cursus et recursus et quasdam obversationes per quas descendunt et adlevantur ac speciem interdum stantium praebent, cum caelestibus stare non liceat, colligit mathematicus. Quae causa in speculo imagines exprimat sciet sapiens: illud tibi geometres potest dicere, quantum abesse debeat corpus ab imagine et qualis forma speculi quales imagines reddat. Magnum esse solem philosophus probabit, quantus sit mathematicus, qui usu quodam et exercitatione procedit. Sed ut procedat, inpetranda illi quaedam principia sunt; non est autem ars sui iuris cui precarium fundamentum est. Philosophia nil ab alio petit, totum opus a solo excitat: mathematice, ut ita dicam, superficiaria est, in alieno aedificat; accipit prima, quorum beneficio ad ulteriora perveniat. Si per se iret ad verum, si totius mundi naturam posset conprendere, dicerem multum conlaturam mentibus nostris, quae tractatu caelestium crescunt trahuntque aliquid ex alto. Una re consummatur animus, scientia bonorum ac malorum inmutabili; nihil autem ulla ars alia de bonis ac malis quaerit. Singulas lubet circumire virtutes. Fortitudo contemptrix timendorum est; terribilia et sub iugum libertatem nostram mittentia despicit, provocat, frangit: numquid ergo hanc liberalia studia corroborant? Fides sanctissimum humani pectoris bonum est, nulla necessitate ad fallendum cogitur, nullo corrumpitur praemio: «ure», inquit «caede, occide: non prodam, sed quo magis secreta quaeret dolor, hoc illa altius condam». Numquid liberalia studia hos animos facere possunt? Temperantia voluptatibus imperat, alias odit atque abigit, alias dispensat et ad sanum modum redigit nec umquam ad illas propter ipsas venit; scit optimum esse modum cupitorum non quantum velis, sed quantum debeas sumere. Humanitas vetat superbum esse adversus socios, vetat amarum; verbis, rebus, adfectibus comem se facilemque omnibus praestat; nullum alienum malum putat, bonum autem suum ideo maxime quod alicui bono futurum est amat. Numquid liberalia studia hos mores praecipiunt? Non magis quam simplicitatem, quam modestiam ac moderationem, non magis quam frugalitatem ac parsimoniam, non magis quam clementiam, quae alieno sanguini tamquam suo parcit et scit homini non esse homine prodige utendum. «Cum dicatis» inquit «sine liberalibus studiis ad virtutem non perveniri, quemadmodum negatis illa nihil conferre virtuti?». Quia nec sine cibo ad virtutem pervenitur, cibus tamen ad virtutem non pertinet; ligna navi nihil conferunt, quamvis non fiat navis nisi ex lignis: non est, inquam, cur aliquid putes eius adiutorio fieri sine quo non potest fieri. Potest quidem etiam illud dici, sine liberalibus studiis veniri ad sapientiam posse; quamvis enim virtus discenda sit, tamen non per haec discitur. Quid est autem quare existimem non futurum sapientem eum qui litteras nescit, cum sapientia non sit in litteris? Res tradit, non verba, et nescio an certior memoria sit
quae nullum extra se subsidium habet. Magna et spatiosa res est sapientia; vacuo illi loco opus est; de divinis humanisque discendum est, de praeteritis de futuris, de caducis de aeternis, de tempore. De quo uno vide quam multa quaerantur: primum an per se sit aliquid; deinde an aliquid ante tempus sit sine tempore; cum mundo coeperit an etiam ante mundum quia fuerit aliquid, fuerit et tempus. Innumerabiles quaestiones sunt de animo tantum: unde sit, qualis sit, quando esse incipiat, quamdiu sit, aliunde alio transeat et domicilia mutet in alias animalium formas aliasque coniectus, an non amplius quam semel serviat et emissus vagetur in toto; utrum corpus sit an non sit; quid sit facturus cum per nos aliquid facere desierit, quomodo libertate sua usurus cum ex hac effugerit cavea; an obliviscatur priorum et illinc nosse se incipiat unde corpori abductus in sublime secessit. Quamcumque partem rerum humanarum divinarumque conprenderis, ingenti copia quaerendorum ac discendorum fatigaberis. Haec tam multa, tam magna ut habere possint liberum hospitium, supervacua ex animo tollenda sunt. Non dabit se in has angustias virtus; laxum spatium res magna desiderat. Expellantur omnia, totum pectus illi vacet. «At enim delectat artium notitia multarum». Tantum itaque ex illis retineamus quantum necessarium est. An tu existimas reprendendum qui supervacua usibus comparat et pretiosarum rerum pompam in domo explicat, non putas eum qui occupatus est in supervacua litterarum supellectile? Plus scire velle quam sit satis intemperantiae genus est. Quid quod ista liberalium artium consectatio molestos, verbosos, intempestivos, sibi placentes facit et ideo non discentes necessaria quia supervacua didicerunt? Quattuor milia librorum Didymus grammaticus scripsit: misererer si tam multa supervacua legisset. In his libris de patria Homeri quaeritur, in his de Aeneae matre vera, in his libidinosior Anacreon an ebriosior vixerit, in his an Sappho publica fuerit, et alia quae erant dediscenda si scires. I nunc et longam esse vitam nega! Sed ad nostros quoque cum perveneris, ostendam multa securibus recidenda. Magno inpendio temporum, magna alienarum aurium molestia laudatio haec constat: «o hominem litteratum!». Simus hoc titulo rusticiore contenti: «o virum bonum!». Itane est? Annales evolvam omnium gentium et quis primus carmina scripserit quaeram? Quantum temporis inter Orphea intersit et Homerum, cum fastos non habeam, conputabo? Et Aristarchi notas quibus aliena carmina conpunxit recognoscam, et aetatem in syllabis conteram? Itane in geometriae pulvere haerebo? Adeo mihi praeceptum illud salutare excidit: «tempori parce»? Haec sciam? Et quid ignorem? Apion grammaticus, qui sub C. Caesare tota circulatus est Graecia et in nomen Homeri ab omnibus civitatibus adoptatus, aiebat Homerum utraque materia consummata, et Odyssia et Iliade, principium adiecisse operi suo quo bellum Troianum conplexus est. Huius rei argumentum adferebat quod duas litteras in primo versu posuisset ex industria librorum suorum numerum continentes. Talia sciat oportet qui multa vult scire. Non vis cogitare quantum temporis tibi auferat mala valetudo, quantum occupatio publica, quantum occupatio privata, quantum occupatio cotidiana,
quantum somnus? Metire aetatem tuam: tam multa non capit. De liberalibus studiis loquor: philosophi quantum habent supervacui, quantum ab usu recedentis! Ipsi quoque ad syllabarum distinctiones et coniunctionum ac praepositionum proprietates descenderunt et invidere grammaticis, invidere geometris; quidquid in illorum artibus supervacuum erat transtulere in suam. Sic effectum est ut diligentius loqui scirent quam vivere. Audi quantum mali faciat nimia subtilitas et quam infesta veritati sit. Protagoras ait de omni re in utramque partem disputari posse ex aequo et de hac ipsa, an omnis res in utramque partem disputabilis sit. Nausiphanes ait ex his quae videntur esse nihil magis esse quam non esse. Parmenides ait ex his quae videntur nihil esse †universo†. Zenon Eleates omnia negotia de negotio deiecit: ait nihil esse. Circa eadem fere Pyrrhonei versantur et Megarici et Eretrici et Academici, qui novam induxerunt scientiam, nihil scire. Haec omnia in illum supervacuum studiorum liberalium gregem coice; illi mihi non profuturam scientiam tradunt, hi spem omnis scientiae eripiunt. Satius est supervacua scire quam nihil. Illi non praeferunt lumen per quod acies derigatur ad verum, hi oculos mihi effodiunt. Si Protagorae credo, nihil in rerum natura est nisi dubium; si Nausiphani, hoc unum certum est, nihil esse certi; si Parmenidi, nihil est praeter unum; si Zenoni, ne unum quidem. Quid ergo nos sumus? Quid ista quae nos circumstant, alunt, sustinent? Tota rerum natura umbra est aut inanis aut fallax. Non facile dixerim utris magis irascar, illis qui nos nihil scire voluerunt, an illis qui ne hoc quidem nobis reliquerunt, nihil scire. Vale.
Liber quartus decimus 89. Rem utilem desideras et ad sapientiam properanti necessariam, dividi philosophiam et ingens corpus eius in membra disponi; facilius enim per partes in cognitionem totius adducimur. Utinam quidem quemadmodum universa mundi facies in conspectum venit, ita philosophia tota nobis posset occurrere, simillimum mundo spectaculum! Profecto enim omnes mortales in admirationem sui raperet, relictis iis quae nunc magna magnorum ignorantia credimus. Sed quia contingere hoc non potest, est sic nobis aspicienda quemadmodum mundi secreta cernuntur. Sapientis quidem animus totam molem eius amplectitur nec minus illam velociter obit quam caelum acies nostra; nobis autem, quibus perrumpenda caligo est et quorum visus in proximo deficit, singula quaeque ostendi facilius possunt, universi nondum capacibus. Faciam ergo quod exigis et philosophiam in partes, non in frusta dividam. Dividi enim illam, non concidi, utile est; nam conprehendere quemadmodum maxima ita minima difficile est. Discribitur in tribus populus, in centurias exercitus; quidquid in maius crevit facilius agnoscitur si discessit in partes, quas, ut dixi, innumerabiles esse et parvulas non oportet. Idem enim vitii habet nimia quod nulla divisio: simile confuso est quidquid usque in pulverem sectum est. Primum itaque, si videtur tibi, dicam inter sapientiam et philosophiam quid intersit. Sapientia perfectum bonum est mentis humanae; philosophia sapientiae amor est et adfectatio: haec eo tendit quo illa pervenit. Philosophia unde dicta sit apparet; ipso enim nomine fatetur quid amet. Sapientiam quidam ita finierunt ut dicerent divinorum et humanorum scientiam; quidam ita: sapientia est nosse divina et humana et horum causas. Supervacua mihi haec videtur adiectio, quia causae divinorum humanorumque pars divinorum sunt. Philosophiam quoque fuerunt qui aliter atque aliter finirent: alii studium illam virtutis esse dixerunt, alii studium corrigendae mentis; a quibusdam dicta est adpetitio rectae rationis. Illud quasi constitit, aliquid inter philosophiam et sapientiam interesse; neque enim fieri potest ut idem sit quod adfectatur et quod adfectat. Quomodo multum inter avaritiam et pecuniam interest, cum illa cupiat, haec concupiscatur, sic inter philosophiam et sapientiam. Haec enim illius effectus ac praemium est; illa venit, ad hanc itur. Sapientia est quam Graeci sofivan vocant. Hoc verbo Romani quoque utebantur, sicut philosophia nunc quoque utuntur; quod et togatae tibi antiquae probabunt et inscriptus Dossenni monumento titulus: hospes resiste et sophian Dossenni lege. Quidam ex nostris, quamvis philosophia studium virtutis esset et haec peteretur, illa peteret, tamen non putaverunt illas distrahi posse; nam nec philosophia sine virtute est nec sine philosophia virtus. Philosophia studium virtutis est, sed per ipsam virtutem; nec virtus autem esse sine studio sui potest nec virtutis studium sine ipsa. Non enim quemadmodum in iis qui aliquid ex
distanti loco ferire conantur alibi est qui petit, alibi quod petitur; nec quemadmodum itinera quae ad urbes perducunt extra urbes sunt, sic viae ad virtutem extra ipsam: ad virtutem venitur per ipsam, cohaerent inter se philosophia virtusque. Philosophiae tres partes esse dixerunt et maximi et plurimi auctores: moralem, naturalem, rationalem. Prima componit animum; secunda rerum naturam scrutatur; tertia proprietates verborum exigit et structuram et argumentationes, ne pro vero falsa subrepant. Ceterum inventi sunt et qui in pauciora philosophiam et qui in plura diducerent. Quidam ex Peripateticis quartam partem adiecerunt civilem, quia propriam quandam exercitationem desideret et circa aliam materiam occupata sit; quidam adiecerunt his partem quam oijkonomikh;n vocant, administrandae familiaris rei scientiam; quidam et de generibus vitae locum separaverunt. Nihil autem horum non in illa parte morali reperietur. Epicurei duas partes philosophiae putaverunt esse, naturalem atque moralem: rationalem removerunt. Deinde cum ipsis rebus cogerentur ambigua secernere, falsa sub specie veri latentia coarguere, ipsi quoque locum quem «de iudicio et regula» appellant – alio nomine rationalem – induxerunt, sed eum accessionem esse naturalis partis existimant. Cyrenaici naturalia cum rationalibus sustulerunt et contenti fuerunt moralibus, sed hi quoque quae removent aliter inducunt; in quinque enim partes moralia dividunt, ut una sit de fugiendis et petendis, altera de adfectibus, tertia de actionibus, quarta de causis, quinta de argumentis. Causae rerum ex naturali parte sunt, argumenta ex rationali. Ariston Chius non tantum supervacuas esse dixit naturalem et rationalem sed etiam contrarias; moralem quoque, quam solam reliquerat, circumcidit. Nam eum locum qui monitiones continet sustulit et paedagogi esse dixit, non philosophi, tamquam quidquam aliud sit sapiens quam generis humani paedagogus. Ergo cum tripertita sit philosophia, moralem eius partem primum incipiamus disponere. Quam in tria rursus dividi placuit, ut prima esset inspectio suum cuique distribuens et aestimans quanto quidque dignum sit, maxime utilis – quid enim est tam necessarium quam pretia rebus inponere? – secunda de impetu, de actionibus tertia. Primum enim est ut quanti quidque sit iudices, secundum ut impetum ad illa capias ordinatum temperatumque, tertium ut inter impetum tuum actionemque conveniat, ut in omnibus istis tibi ipse consentias. Quidquid ex tribus defuit turbat et cetera. Quid enim prodest inter se aestimata habere omnia, si sis in impetu nimius? Quid prodest impetus repressisse et habere cupiditates in sua potestate, si in ipsa rerum actione tempora ignores nec scias quando quidque et ubi et quemadmodum agi debeat? Aliud est enim dignitates et pretia rerum nosse, aliud articulos, aliud impetus refrenare et ad agenda ire, non ruere. Tunc ergo vita concors sibi est ubi actio non destituit impetum, impetus ex dignitate rei cuiusque concipitur, proinde remissus aut acrior prout illa digna est peti. Naturalis pars philosophiae in duo scinditur, corporalia et incorporalia; utraque dividuntur in suos, ut ita dicam, gradus. Corporum locus in hos primum, in ea quae faciunt et quae ex his gignuntur – gignuntur autem elementa. Ipse de
elementis locus, ut quidam putant, simplex est, ut quidam, in materiam et causam omnia moventem et elementa dividitur. Superest ut rationalem partem philosophiae dividam. Omnis oratio aut continua est aut inter respondentem et interrogantem discissa; hanc dialektikhvn, illam rJhtorikh;n placuit vocari. ÔRhtorikh; verba curat et sensus et ordinem; dialektikh; in duas partes dividitur, in verba et significationes, id est in res quae dicuntur et vocabula quibus dicuntur. Ingens deinde sequitur utriusque divisio. Itaque hoc loco finem faciam et summa sequar fastigia rerum; alioqui, si voluero facere partium partes, quaestionum liber fiet. Haec, Lucili virorum optime, quominus legas non deterreo, dummodo quidquid legeris ad mores statim referas. Illos conpesce, marcentia in te excita, soluta constringe, contumacia doma, cupiditates tuas publicasque quantum potes vexa; et istis dicentibus «quousque eadem?» responde: «Ego debebam dicere «quousque eadem peccabitis? Remedia ante vultis quam vitia desinere? Ego vero eo magis dicam, et quia recusatis perseverabo; tunc incipit medicina proficere ubi in corpore alienato dolorem tactus expressit. Dicam etiam invitis profutura. Aliquando aliqua ad vos non blanda vox veniat, et quia verum singuli audire non vultis, publice audite. Quousque fines possessionum propagabitis? Ager uni domino qui populum cepit angustus est? Quousque arationes vestras porrigetis, ne provinciarum quidem spatio contenti circumscribere praediorum modum? Inlustrium fluminum per privatum decursus est et amnes magni magnarumque gentium termini usque ad ostium a fonte vestri sunt. Hoc quoque parum est nisi latifundiis vestris maria cinxistis, nisi trans Hadriam et Ionium Aegaeumque vester vilicus regnat, nisi insulae, ducum domicilia magnorum, inter vilissima rerum numerantur. Quam vultis late possidete, sit fundus quod aliquando imperium vocabatur, facite vestrum quidquid potestis, dum plus sit alieni. Nunc vobiscum loquor quorum aeque spatiose luxuria quam illorum avaritia diffunditur. Vobis dico: quousque nullus erit lacus cui non villarum vestrarum fastigia inmineant? Nullum flumen cuius non ripas aedificia vestra praetexant? Ubicumque scatebunt aquarum calentium venae, ibi nova deversoria luxuriae excitabuntur. Ubicumque in aliquem sinum litus curvabitur, vos protinus fundamenta iacietis, nec contenti solo nisi quod manu feceritis, mare agetis introrsus. Omnibus licet locis tecta vestra resplendeant, aliubi inposita montibus in vastum terrarum marisque prospectum, aliubi ex plano in altitudinem montium educta, cum multa aedificaveritis, cum ingentia, tamen et singula corpora estis et parvola. Quid prosunt multa cubicula? In uno iacetis. Non est vestrum ubicumque non estis. Ad vos deinde transeo quorum profunda et insatiabilis gula hinc maria scrutatur, hinc terras, alia hamis, alia laqueis, alia retium variis generibus cum
magno labore persequitur: nullis animalibus nisi ex fastidio pax est. Quantulum ex istis epulis per tot comparatis manus fesso voluptatibus ore libatis? Quantulum ex ista fera periculose capta dominus crudus ac nauseans gustat? Quantulum ex tot conchyliis tam longe advectis per istum stomachum inexplebilem labitur? Infelices, ecquid intellegitis maiorem vos famem habere quam ventrem?». Haec aliis dic, ut dum dicis audias ipse, scribe, ut dum scribis legas, omnia ad mores et ad sedandam rabiem adfectuum referens. Stude, non ut plus aliquid scias, sed ut melius. Vale. 90. Quis dubitare, mi Lucili, potest quin deorum inmortalium munus sit quod vivimus, philosophiae quod bene vivimus? Itaque tanto plus huic nos debere quam dis quanto maius beneficium est bona vita quam vita pro certo haberetur, nisi ipsam philosophiam di tribuissent; cuius scientiam nulli dederunt, facultatem omnibus. Nam si hanc quoque bonum vulgare fecissent et prudentes nasceremur, sapientia quod in se optimum habet perdidisset, inter fortuita non esse. Nunc enim hoc in illa pretiosum atque magnificum est, quod non obvenit, quod illam sibi quisque debet, quod non ab alio petitur. Quid haberes quod in philosophia suspiceres si beneficiaria res esset? Huius opus unum est de divinis humanisque verum invenire; ab hac numquam recedit religio, pietas, iustitia et omnis alius comitatus virtutum consertarum et inter se cohaerentium. Haec docuit colere divina, humana diligere, et penes deos imperium esse, inter homines consortium. Quod aliquamdiu inviolatum mansit, antequam societatem avaritia distraxit et paupertatis causa etiam iis quos fecit locupletissimos fuit; desierunt enim omnia possidere, dum volunt propria. Sed primi mortalium quique ex his geniti naturam incorrupti sequebantur eundem habebant et ducem et legem, commissi melioris arbitrio; naturaest enim potioribus deteriora summittere. Mutis quidem gregibus aut maxima corpora praesunt aut vehementissima: non praecedit armenta degener taurus, sed qui magnitudine ac toris ceteros mares vicit; elephantorum gregem excelsissimus ducit: inter homines pro maximo est optimum. Animo itaque rector eligebatur, ideoque summa felicitas erat gentium in quibus non poterat potentior esse nisi melior; tuto enim quantum vult potest qui se nisi quod debet non putat posse. Illo ergo saeculo quod aureum perhibent penes sapientes fuisse regnum Posidonius iudicat. Hi continebant manus et infirmiorem a validioribus tuebantur, suadebant dissuadebantque et utilia atque inutilia monstrabant; horum prudentia ne quid deesset suis providebat, fortitudo pericula arcebat, beneficentia augebat ornabatque subiectos. Officium erat imperare, non regnum. Nemo quantum posset adversus eos experiebatur per quos coeperat posse, nec erat cuiquam aut animus in iniuriam aut causa, cum bene imperanti bene pareretur, nihilque rex maius minari male parentibus posset quam ut abiret e regno. Sed postquam subrepentibus vitiis in tyrannidem regna conversa sunt, opus esse legibus coepit, quas et ipsas inter initia tulere sapientes. Solon, qui Athenas aequo iure fundavit, inter septem fuit sapientia notos; Lycurgum si eadem aetas tulisset, sacro illi
numero accessisset octavus. Zaleuci leges Charondaeque laudantur; hi non in foro nec in consultorum atrio, sed in Pythagorae tacito illo sanctoque secessu didicerunt iura quae florenti tunc Siciliae et per Italiam Graeciae ponerent. Hactenus Posidonio adsentior: artes quidem a philosophia inventas quibus in cotidiano vita utitur non concesserim, nec illi fabricae adseram gloriam. «Illa» inquit «sparsos et aut casis tectos aut aliqua rupe suffossa aut exesae arboris trunco docuit tecta moliri». Ego vero philosophiam iudico non magis excogitasse has machinationes tectorum supra tecta surgentium et urbium urbes prementium quam vivaria piscium in hoc clausa ut tempestatum periculum non adiret gula et quamvis acerrime pelago saeviente haberet luxuria portus suos in quibus distinctos piscium greges saginaret. Quid ais? Philosophia homines docuit habere clavem et seram? Quid aliud erat avaritiae signum dare? Philosophia haec cum tanto habitantium periculo inminentia tecta suspendit? Parum enim erat fortuitis tegi et sine arte et sine difficultate naturale invenire sibi aliquod receptaculum. Mihi crede, felix illud saeculum ante architectos fuit, ante tectores. Ista nata sunt iam nascente luxuria, in quadratum tigna decidere et serra per designata currente certa manu trabem scindere; nam primi cuneis scindebant fissile lignum. Non enim tecta cenationi epulum recepturae parabantur, nec in hunc usum pinus aut abies deferebatur longo vehiculorum ordine vicis intrementibus, ut ex illa lacunaria auro gravia penderent. Furcae utrimque suspensae fulciebant casam; spissatis ramalibus ac fronde congesta et in proclive disposita decursus imbribus quamvis magnis erat. Sub his tectis habitavere securi: culmus liberos texit, sub marmore atque auro servitus habitat. In illo quoque dissentio a Posidonio, quod ferramenta fabrilia excogitata a sapientibus viris iudicat; isto enim modo dicat licet sapientes fuisse per quos tunc laqueis captare feras et fallere visco inventum et magnos canibus circumdare saltus. Omnia enim ista sagacitas hominum, non sapientia invenit. In hoc quoque dissentio, sapientes fuisse qui ferri metalla et aeris invenerint, cum incendio silvarum adusta tellus in summo venas iacentis liquefacta fudisset: ista tales inveniunt quales colunt. Ne illa quidem tam subtilis mihi quaestio videtur quam Posidonio, utrum malleus in usu esse prius an forcipes coeperint. Utraque invenit aliquis excitati ingenii, acuti, non magni nec elati, et quidquid aliud corpore incurvato et animo humum spectante quaerendum est. Sapiens facilis victu fuit. Quidni? Cum hoc quoque saeculo esse quam expeditissimus cupiat. Quomodo, oro te, convenit ut et Diogenen mireris et Daedalum? Uter ex his sapiens tibi videtur? Qui serram commentus est, an ille qui, cum vidisset puerum cava manu bibentem aquam, fregit protinus exemptum e perula calicem cum hac obiurgatione
sui: «quamdiu homo stultus supervacuas sarcinas habui!», qui se conplicuit in dolio et in eo cubitavit? Hodie utrum tandem sapientiorem putas qui invenit quemadmodum in immensam altitudinem crocum latentibus fistulis exprimat, qui euripos subito aquarum impetu implet aut siccat et versatilia cenationum laquearia ita coagmentat ut subinde alia facies atque alia succedat et totiens tecta quotiens fericula mutentur, an eum qui et aliis et sibi hoc monstrat, quam nihil nobis natura durum ac difficile imperaverit, posse nos habitare sine marmorario ac fabro, posse nos vestitos esse sine commercio sericorum, posse nos habere usibus nostris necessaria si contenti fuerimus iis quae terra posuit in summo? Quem si audire humanum genus voluerit, tam supervacuum sciet sibi cocum esse quam militem. Illi sapientes fuerunt aut certe sapientibus similes quibus expedita erat tutela corporis. Simplici cura constant necessaria: in delicias laboratur. Non desiderabis artifices: sequere naturam. Illa noluit esse districtos; ad quaecumque nos cogebat instruxit. «Frigus intolerabilest corpori nudo». Quid ergo? Non pelles ferarum et aliorum animalium a frigore satis abundeque defendere queunt? Non corticibus arborum pleraeque gentes tegunt corpora? Non avium plumae in usum vestis conseruntur? Non hodieque magna Scytharum pars tergis vulpium induitur ac murum, quae tactu mollia et inpenetrabilia ventis sunt? Quid ergo? Non quilibet virgeam cratem texuerunt manu et vili obliverunt luto, deinde stipula aliisque silvestribus operuere fastigium et pluviis per devexa labentibus hiemem transiere securi? «Opus est tamen calorem solis aestivi umbra crassiore propellere». Quid ergo? Non vetustas multa abdidit loca quae vel iniuria temporis vel alio quolibet casu excavata in specum recesserunt? Quid ergo? Non in defosso latent Syrticae gentes quibusque propter nimios solis ardores nullum tegimentum satis repellendis caloribus solidum est nisi ipsa arens humus? Non fuit tam iniqua natura ut, cum omnibus aliis animalibus facilem actum vitae daret, homo solus non posset sine tot artibus vivere; nihil durum ab illa nobis imperatum est, nihil aegre quaerendum, ut possit vita produci. Ad parata nati sumus: nos omnia nobis difficilia facilium fastidio fecimus. Tecta tegimentaque et fomenta corporum et cibi et quae nunc ingens negotium facta sunt obvia erant et gratuita et opera levi parabilia; modus enim omnium prout necessitas erat: nos ista pretiosa, nos mira, nos magnis multisque conquirenda artibus fecimus. Sufficit ad id natura quod poscit. A natura luxuria descivit, quae cotidie se ipsa incitat et tot saeculis crescit et ingenio adiuvat vitia. Primo supervacua coepit concupiscere, inde contraria, novissime animum corpori addixit et illius deservire libidini iussit. Omnes istae artes quibus aut circitatur civitas aut strepit corpori negotium gerunt, cui omnia olim tamquam servo praestabantur, nunc tamquam domino parantur. Itaque hinc textorum, hinc fabrorum officinae sunt, hinc odores coquentium, hinc molles corporis motus docentium mollesque cantus et infractos. Recessit enim ille naturalis modus desideria ope necessaria finiens; iam rusticitatis et miseriae est velle quantum sat est. Incredibilest, mi Lucili, quam facile etiam magnos viros dulcedo orationis
abducat a vero. Ecce Posidonius, ut mea fert opinio, ex iis qui plurimum philosophiae contulerunt, dum vult describere primum quemadmodum alia torqueantur fila, alia ex molli solutoque ducantur, deinde quemadmodum tela suspensis ponderibus rectum stamen extendat, quemadmodum subtemen insertum, quod duritiam utrimque conprimentis tramae remolliat, spatha coire cogatur et iungi, textrini quoque artem a sapientibus dixit inventam, oblitus postea repertum hoc subtilius genus in quo tela iugo vincta est, stamen secernit harundo, inseritur medium radiis subtemen acutis, quod lato paviunt insecti pectine dentes. Quid si contigisset illi videre has nostri temporis telas, in quibus vestis nihil celatura conficitur, in qua non dico nullum corpori auxilium, sed nullum pudori est? Transit deinde ad agricolas nec minus facunde describit proscissum aratro solum et iteratum quo solutior terra facilius pateat radicibus, tunc sparsa semina et collectas manu herbas ne quid fortuitum et agreste succrescat quod necet segetem. Hoc quoque opus ait esse sapientium, tamquam non nunc quoque plurima cultores agrorum nova inveniant per quae fertilitas augeatur. Deinde non est contentus his artibus, sed in pistrinum sapientem summittit; narrat enim quemadmodum rerum naturam imitatus panem coeperit facere. «Receptas» inquit «in os fruges concurrens inter se duritia dentium frangit, et quidquid excidit ad eosdem dentes lingua refertur; tunc umore miscetur ut facilius per fauces lubricas transeat; cum pervenit in ventrem, aequali eius fervore concoquitur; tunc demum corpori accedit. Hoc aliquis secutus exemplar lapidem asperum aspero inposuit ad similitudinem dentium, quorum pars immobilis motum alterius expectat; deinde utriusque adtritu grana franguntur et saepius regeruntur donec ad minutiam frequenter trita redigantur; tum farinam aqua sparsit et adsidua tractatione perdomuit finxitque panem, quem primo cinis calidus et fervens testa percoxit, deinde furni paulatim reperti et alia genera quorum fervor serviret arbitrio». Non multum afuit quin sutrinum quoque inventum a sapientibus diceret. Omnia ista ratio quidem, sed non recta ratio commenta est. Hominis enim, non sapientis inventa sunt, tam mehercules quam navigia quibus amnes quibusque maria transimus, aptatis ad excipiendum ventorum impetum velis et additis a tergo gubernaculis quae huc atque illuc cursum navigii torqueant. Exemplum a piscibus tractum est, qui cauda reguntur et levi eius in utrumque momento velocitatem suam flectunt. «Omnia» inquit «haec sapiens quidem invenit, sed minora quam ut ipse tractaret sordidioribus ministris dedit». Immo non aliis excogitata ista sunt quam quibus hodieque curantur. Quaedam nostra demum prodisse memoria scimus, ut speculariorum usum perlucente testa clarum transmittentium lumen, ut suspensuras balneorum et inpressos parietibus tubos per quos circumfunderetur calor qui ima simul ac summa foveret aequaliter. Quid loquar marmora quibus templa, quibus domus fulgent? Quid lapideas moles in
rotundum ac leve formatas quibus porticus et capacia populorum tecta suscipimus? Quid verborum notas quibus quamvis citata excipitur oratio et celeritatem linguae manus sequitur? Vilissimorum mancipiorum ista commenta sunt: sapientia altius sedet nec manus edocet: animorum magistra est. Vis scire quid illa eruerit, quid effecerit? Non decoros corporis motus nec varios per tubam ac tibiam cantus, quibus exceptus spiritus aut in exitu aut in transitu formatur in vocem. Non arma nec muros nec bello utilia molitur: paci favet et genus humanum ad concordiam vocat. Non est, inquam, instrumentorum ad usus necessarios opifex. Quid illi tam parvola adsignas? Artificem vides vitae. Alias quidem artes sub dominio habet; nam cui vita, illi vitae quoque ornantia serviunt: ceterum ad beatum statum tendit, illo ducit, illo vias aperit. Quae sint mala, quae videantur ostendit; vanitatem exuit mentibus, dat magnitudinem solidam, inflatam vero et ex inani speciosam reprimit, nec ignorari sinit inter magna quid intersit et tumida; totius naturae notitiam ac sui tradit. Quid sint di qualesque declarat, quid inferi, quid lares et genii, quid in secundam numinum formam animae perpetitae, ubi consistant, quid agant, quid possint, quid velint. Haec eius initiamenta sunt, per quae non municipale sacrum sed ingens deorum omnium templum, mundus ipse, reseratur, cuius vera simulacra verasque facies cernendas mentibus protulit; nam ad spectacula tam magna hebes visus est. Ad initia deinde rerum redit aeternamque rationem toti inditam et vim omnium seminum singula proprie figurantem. Tum de animo coepit inquirere, unde esset, ubi, quamdiu, in quot membra divisus. Deinde a corporibus se ad incorporalia transtulit veritatemque et argumenta eius excussit; post haec quemadmodum discernerentur vitae aut vocis ambigua; in utraque enim falsa veris inmixta sunt. Non abduxit, inquam, se (ut Posidonio videtur) ab istis artibus sapiens, sed ad illas omnino non venit. Nihil enim dignum inventu iudicasset quod non erat dignum perpetuo usu iudicaturus; ponenda non sumeret. «Anacharsis» inquit «invenit rotam figuli, cuius circuitu vasa formantur». Deinde quia apud Homerum invenitur figuli rota, maluit videri versus falsos esse quam fabulam. Ego nec Anacharsim auctorem huius rei fuisse contendo et, si fuit, sapiens quidem hoc invenit, sed non tamquam sapiens, sicut multa sapientes faciunt qua homines sunt, non qua sapientes. Puta velocissimum esse sapientem: cursu omnis anteibit qua velox est, non qua sapiens. Cuperem Posidonio aliquem vitrearium ostendere, qui spiritu vitrum in habitus plurimos format qui vix diligenti manu effingerentur. Haec inventa sunt postquam sapientem invenire desimus. «Democritus» inquit «invenisse dicitur fornicem, ut lapidum curvatura paulatim inclinatorum medio saxo alligaretur». Hoc dicam falsum esse; necesse est enim ante Democritum et pontes et portas fuisse, quarum fere summa curvantur. Excidit porro vobis eundem Democritum invenisse quemadmodum ebur molliretur, quemadmodum decoctus calculus in zmaragdum converteretur, qua hodieque coctura inventi lapides in hoc utiles colorantur. Ista sapiens licet invenerit, non qua sapiens erat invenit; multa enim facit quae ab inprudentissimis aut aeque fieri videmus aut peritius atque exercitatius.
Quid sapiens investigaverit, quid in lucem protraxerit quaeris? Primum verum naturamque, quam non ut cetera animalia oculis secutus est, tardis ad divina; deinde vitae legem, quam ad universa derexit, nec nosse tantum sed sequi deos docuit et accidentia non aliter excipere quam imperata. Vetuit parere opinionibus falsis et quanti quidque esset vera aestimatione perpendit; damnavit mixtas paenitentia voluptates et bona semper placitura laudavit et palam fecit felicissimum esse cui felicitate non opus est, potentissimum esse qui se habet in potestate. Non de ea philosophia loquor quae civem extra patriam posuit, extra mundum deos, quae virtutem donavit voluptati, sed de illa quae nullum bonum putat nisi quod honestum est, quae nec hominis nec fortunae muneribus deleniri potest, cuius hoc pretium est, non posse pretio capi. Hanc philosophiam fuisse illo rudi saeculo quo adhuc artificia deerant et ipso usu discebantur utilia non credo. †Sicut aut† fortunata tempora, cum in medio iacerent beneficia naturae promiscue utenda, antequam avaritia atque luxuria dissociavere mortales et ad rapinam ex consortio docuere discurrere: non erant illi sapientes viri, etiam si faciebant facienda sapientibus. Statum quidem generis humani non alium quisquam suspexerit magis, nec si cui permittat deus terrena formare et dare gentibus mores, aliud probaverit quam quod apud illos fuisse memoratur apud quos nulli subigebant arva coloni; ne signare quidem aut partiri limite campum fas erat: in medium quaerebant, ipsaque tellus omnia liberius nullo poscente ferebat. Quid hominum illo genere felicius? In commune rerum natura fruebantur; sufficiebat illa ut parens in tutelam omnium; haec erat publicarum opum secura possessio. Quidni ego illud locupletissimum mortalium genus dixerim in quo pauperem invenire non posses? Inrupit in res optime positas avaritia et, dum seducere aliquid cupit atque in suum vertere, omnia fecit aliena et in angustum se ex inmenso redegit. Avaritia paupertatem intulit et multa concupiscendo omnia amisit. Licet itaque nunc conetur reparare quod perdidit, licet agros agris adiciat vicinum vel pretio pellens vel iniuria, licet in provinciarum spatium rura dilatet et possessionem vocet per sua longam peregrinationem: nulla nos finium propagatio eo reducet unde discessimus. Cum omnia fecerimus, multum habebimus: universum habebamus. Terra ipsa fertilior erat inlaborata et in usus populorum non diripientium larga. Quidquid natura protulerat, id non minus invenisse quam inventum monstrare alteri voluptas erat; nec ulli aut superesse poterat aut deesse: inter concordes dividebatur. Nondum valentior inposuerat infirmiori manum, nondum avarus abscondendo quod sibi iaceret alium necessariis quoque excluserat: par erat alterius ac sui cura. Arma cessabant incruentaeque humano sanguine manus odium omne in feras verterant. Illi quos aliquod nemus densum a sole protexerat, qui adversus saevitiam hiemis aut
imbris vili receptaculo tuti sub fronde vivebant, placidas transigebant sine suspirio noctes. Sollicitudo nos in nostra purpura versat et acerrimis excitat stimulis: at quam mollem somnum illis dura tellus dabat! Non inpendebant caelata laquearia, sed in aperto iacentis sidera superlabebantur et, insigne spectaculum noctium, mundus in praeceps agebatur, silentio tantum opus ducens. Tam interdiu illis quam nocte patebant prospectus huius pulcherrimae domus; libebat intueri signa ex media caeli parte vergentia, rursus ex occulto alia surgentia. Quidni iuvaret vagari inter tam late sparsa miracula? At vos ad omnem tectorum pavetis sonum et inter picturas vestras, si quid increpuit, fugitis attoniti. Non habebant domos instar urbium: spiritus ac liber inter aperta perflatus et levis umbra rupis aut arboris et perlucidi fontes rivique non opere nec fistula nec ullo coacto itinere obsolefacti sed sponte currentes et prata sine arte formosa, inter haec agreste domicilium rustica politum manu – haec erat secundum naturam domus, in qua libebat habitare nec ipsam nec pro ipsa timentem: nunc magna pars nostri metus tecta sunt. Sed quamvis egregia illis vita fuerit et carens fraude, non fuere sapientes, quando hoc iam in opere maximo nomen est. Non tamen negaverim fuisse alti spiritus viros et, ut ita dicam, a dis recentes; neque enim dubium est quin meliora mundus nondum effetus ediderit. Quemadmodum autem omnibus indoles fortior fuit et ad labores paratior, ita non erant ingenia omnibus consummata. Non enim dat natura virtutem: ars est bonum fieri. Illi quidem non aurum nec argentum nec perlucidos lapides in ima terrarum faece quaerebant parcebantque adhuc etiam mutis animalibus: tantum aberat ut homo hominem non iratus, non timens, tantum spectaturus occideret. Nondum vestis illis erat picta, nondum texebatur aurum, adhuc nec eruebatur. Quid ergo est? Ignorantia rerum innocentes erant; multum autem interest utrum peccare aliquis nolit an nesciat. Deerat illis iustitia, deerat prudentia, deerat temperantia ac fortitudo. Omnibus his virtutibus habebat similia quaedam rudis vita: virtus non contingit animo nisi instituto et edocto et ad summum adsidua exercitatione perducto. Ad hoc quidem, sed sine hoc nascimur, et in optimis quoque, antequam erudias, virtutis materia, non virtus est. Vale. 91. Liberalis noster nunc tristis est nuntiato incendio quo Lugdunensis colonia exusta est; movere hic casus quemlibet posset, nedum hominem patriae suae amantissimum. Quae res effecit ut firmitatem animi sui quaerat, quam videlicet ad ea quae timeri posse putabat exercuit. Hoc vero tam inopinatum malum et paene inauditum non miror si sine metu fuit, cum esset sine exemplo; multas enim civitates incendium vexavit, nullam abstulit. Nam etiam ubi hostili manu in tecta ignis inmissus est, multis locis deficit, et quamvis subinde excitetur, raro tamen sic cuncta depascitur ut nihil ferro relinquat. Terrarum quoque vix umquam tam gravis et perniciosus fuit motus ut tota oppida everteret. Numquam denique tam infestum ulli exarsit incendium ut nihil alteri superesset incendio. Tot pulcherrima opera, quae singula inlustrare urbes singulas possent, una nox stravit, et in tanta pace quantum ne bello quidem timeri potest accidit. Quis hoc
credat? Ubique armis quiescentibus, cum toto orbe terrarum diffusa securitas sit, Lugudunum, quod ostendebatur in Gallia, quaeritur. Omnibus fortuna quos publice adflixit quod passuri erant timere permisit; nulla res magna non aliquod habuit ruinae suae spatium: in hac una nox interfuit inter urbem maximam et nullam. Denique diutius illam tibi perisse quam perit narro. Haec omnia Liberalis nostri adfectum inclinant, adversus sua firmum et erectum. Nec sine causa concussus est: inexpectata plus adgravant; novitas adicit calamitatibus pondus, nec quisquam mortalium non magis quod etiam miratus est doluit. Ideo nihil nobis inprovisum esse debet; in omnia praemittendus animus cogitandumque non quidquid solet sed quidquid potest fieri. Quid enim est quod non fortuna, cum voluit, ex florentissimo detrahat? Quod non eo magis adgrediatur et quatiat quo speciosius fulget? Quid illi arduum quidve difficile est? Non una via semper, ne trita quidem incurrit: modo nostras in nos manus advocat, modo suis contenta viribus invenit pericula sine auctore. Nullum tempus exceptum est: in ipsis voluptatibus causae doloris oriuntur. Bellum in media pace consurgit et auxilia securitatis in metum transeunt: ex amico fit inimicus, hostis ex socio. In subitas tempestates hibernisque maiores agitur aestiva tranquillitas. Sine hoste patimur hostilia, et cladis causas, si alia deficiunt, nimia sibi felicitas invenit. Invadit temperantissimos morbus, validissimos pthisis, innocentissimos poena, secretissimos tumultus; eligit aliquid novi casus per quod velut oblitis vires suas ingerat. Quidquid longa series multis laboribus, multa deum indulgentia struxit, id unus dies spargit ac dissipat. Longam moram dedit malis properantibus qui diem dixit: hora momentumque temporis evertendis imperis sufficit. Esset aliquod inbecillitatis nostrae solacium rerumque nostrarum si tam tarde perirent cuncta quam fiunt: nunc incrementa lente exeunt, festinatur in damnum. Nihil privatim, nihil publice stabile est; tam hominum quam urbium fata volvuntur. Inter placidissima terror existit nihilque extra tumultuantibus causis mala unde minime expectabantur erumpunt. Quae domesticis bellis steterant regna, quae externis, inpellente nullo ruunt: quota quaeque felicitatem civitas pertulit! Cogitanda ergo sunt omnia et animus adversus ea quae possunt evenire firmandus. Exilia, tormenta, bella, naufragia meditare. Potest te patriae, potest patriam tibi casus eripere, potest te in solitudines abigere, potest hoc ipsum in quo turba suffocatur fieri solitudo. Tota ante oculos sortis humanae condicio ponatur, nec quantum frequenter evenit sed quantum plurimum potest evenire praesumamus animo, si nolumus opprimi nec illis inusitatis velut novis obstupefieri; in plenum cogitanda fortuna est. Quotiens Asiae, quotiens Achaiae urbes uno tremore ceciderunt! Quot oppida in Syria, quot in Macedonia devorata sunt! Cypron quotiens vastavit haec clades! Quotiens in se Paphus corruit! Frequenter nobis nuntiati sunt totarum urbium interitus, et nos inter quos ista frequenter nuntiantur, quota pars omnium sumus! Consurgamus itaque adversus fortuita et quidquid inciderit sciamus non esse tam magnum quam rumore iactetur. Civitas arsit opulenta ornamentumque provinciarum quibus et inserta erat et excepta, uni tamen inposita et huic non latissimo monti: omnium istarum
civitatium quas nunc magnificas ac nobiles audis vestigia quoque tempus eradet. Non vides quemadmodum in Achaia clarissimarum urbium iam fundamenta consumpta sint nec quicquam extet ex quo appareat illas saltem fuisse? Non tantum manu facta labuntur, nec tantum humana arte atque industria posita vertit dies: iuga montium diffluunt, totae desedere regiones, operta sunt fluctibus quae procul a conspectu maris stabant; vasta vis ignium colles per quos relucebat erosit et quondam altissimos vertices, solacia navigantium ac speculas, ad humile deduxit. Ipsius naturae opera vexantur et ideo aequo animo ferre debemus urbium excidia. Casurae stant; omnis hic exitus manet, sive ventorum interna vis flatusque per clusa violenti pondus sub quo tenentur excusserint, sive torrentium impetus in abdito vastior obstantia effregerit, sive flammarum violentia conpaginem soli ruperit, sive vetustas, a qua nihil tutum est, expugnaverit minutatim, sive gravitas caeli egesserit populos et situs deserta corruperit. Enumerare omnes fatorum vias longum est. Hoc unum scio: omnia mortalium opera mortalitate damnata sunt, inter peritura vivimus. Haec ergo atque eiusmodi solacia admoveo Liberali nostro incredibili quodam patriae suae amore flagranti, quae fortasse consumpta est ut in melius excitaretur. Saepe maiori fortunae locum fecit iniuria: multa ceciderunt ut altius surgerent. Timagenes, felicitati urbis inimicus, aiebat Romae sibi incendia ob hoc unum dolori esse, quod sciret meliora surrectura quam arsissent. In hac quoque urbe veri simile est certaturos omnes ut maiora celsioraque quam amisere restituant. Sint utinam diuturna et melioribus auspiciis in aevum longius condita! Nam huic coloniae ab origine sua centensimus annus est, aetas ne homini quidem extrema. A Planco deducta in hanc frequentiam loci opportunitate convaluit: quot tamen gravissimos casus intra spatium humanae pertulit senectutis! Itaque formetur animus ad intellectum patientiamque sortis suae et sciat nihil inausum esse fortunae, adversus imperia illam idem habere iuris quod adversus imperantis, adversus urbes idem posse quod adversus homines. Nihil horum indignandum est: in eum intravimus mundum in quo his legibus vivitur. Placet: pare. Non placet: quacumque vis exi. Indignare si quid in te iniqui proprie constitutum est; sed si haec summos imosque necessitas alligat, in gratiam cum fato revertere, a quo omnia resolvuntur. Non est quod nos tumulis metiaris et his monumentis quae viam disparia praetexunt: aequat omnis cinis. Inpares nascimur, pares morimur. Idem de urbibus quod de urbium incolis dico: tam Ardea capta quam Roma est. Conditor ille iuris humani non natalibus nos nec nominum claritate distinxit, nisi dum sumus: ubi vero ad finem mortalium ventum est, «discede» inquit «ambitio: omnium quae terram premunt siremps lex esto». Ad omnia patienda pares sumus; nemo altero fragilior est, nemo in crastinum sui certior. Alexander Macedonum rex discere geometriam coeperat, infelix, sciturus quam pusilla terra esset, ex qua minimum occupaverat. Ita dico: «infelix» ob hoc quod intellegere debebat falsum se gerere cognomen: quis enim esse magnus in pusillo potest? Erant illa quae tradebantur subtilia et diligenti intentione
discenda, non quae perciperet vesanus homo et trans oceanum cogitationes suas mittens. «Facilia» inquit «me doce». Cui praeceptor «ista» inquit «omnibus eadem sunt, aeque difficilia». Hoc puta rerum naturam dicere: «ista de quibus quereris omnibus eadem sunt; nulli dare faciliora possum, sed quisquis volet sibi ipse illa reddet faciliora». Quomodo? Aequanimitate. Et doleas oportet et sitias et esurias et senescas (si tibi longior contigerit inter homines mora) et aegrotes et perdas aliquid et pereas. Non est tamen quod istis qui te circumstrepunt credas: nihil horum malum est, nihil intolerabile aut durum. Ex consensu istis metus est. Sic mortem times quomodo famam: quid autem stultius homine verba metuente? Eleganter Demetrius noster solet dicere eodem loco sibi esse voces inperitorum quo ventre redditos crepitus. «Quid enim» inquit «mea, susum isti an deosum sonent?». Quanta dementia est vereri ne infameris ab infamibus! Quemadmodum famam extimuisti sine causa, sic et illa quae numquam timeres nisi fama iussisset. Num quid detrimenti faceret vir bonus iniquis rumoribus sparsus? Ne morti quidem hoc apud nos noceat: et haec malam opinionem habet. Nemo eorum qui illam accusat expertus est: interim temeritas est damnare quod nescias. At illud scis, quam multis utilis sit, quam multos liberet tormentis, egestate, querellis, supplicis, taedio. Non sumus in ullius potestate, cum mors in nostra potestate sit. Vale. 92. Puto, inter me teque conveniet externa corpori adquiri, corpus in honorem animi coli, in animo esse partes ministras, per quas movemur alimurque, propter ipsum principale nobis datas. In hoc principali est aliquid inrationale, est et rationale; illud huic servit, hoc unum est quod alio non refertur sed omnia ad se refert. Nam illa quoque divina ratio omnibus praeposita est, ipsa sub nullo est; et haec autem nostra eadem est, quae ex illa est. Si de hoc inter nos convenit, sequitur ut de illo quoque conveniat, in hoc uno positam esse beatam vitam, ut in nobis ratio perfecta sit. Haec enim sola non summittit animum, stat contra fortunam; in quolibet rerum habitu †servitus† servat. Id autem unum bonum est quod numquam defringitur. Is est, inquam, beatus quem nulla res minorem facit; tenet summa, et ne ulli quidem nisi sibi innixus; nam qui aliquo auxilio sustinetur potest cadere. Si aliter est, incipient multum in nobis valere non nostra. Quis autem vult constare fortuna aut quis se prudens ob aliena miratur? Quid est beata vita? Securitas et perpetua tranquillitas. Hanc dabit animi magnitudo, dabit constantia bene iudicati tenax. Ad haec quomodo pervenitur? Si veritas tota perspecta est; si servatus est in rebus agendis ordo, modus, decor, innoxia voluntas ac benigna, intenta rationi nec umquam ab illa recedens, amabilis simul mirabilisque. Denique ut breviter tibi formulam scribam, talis animus esse sapientis viri debet qualis deum deceat. Quid potest desiderare is cui omnia honesta contingunt? Nam si possunt aliquid non honesta conferre ad optimum statum, in his erit beata vita sine quibus non est. Et quid turpius stultiusve quam bonum rationalis animi ex inrationalibus nectere? Quidam tamen augeri summum bonum iudicant, quia parum plenum sit
fortuitis repugnantibus. Antipater quoque inter magnos sectae huius auctores aliquid se tribuere dicit externis, sed exiguum admodum. Vides autem quale sit die non esse contentum nisi aliquis igniculus adluxerit: quod potest in hac claritate solis habere scintilla momentum? Si non es sola honestate contentus, necesse est aut quietem adici velis, quam Graeci ajoclhsivan vocant, aut voluptatem. Horum alterum utcumque recipi potest; vacat enim animus molestia liber ad inspectum universi, nihilque illum avocat a contemplatione naturae. Alterum illud, voluptas, bonum pecoris est: adicimus rationali inrationale, honesto inhonestum, magno vitam facit titillatio corporis? Quid ergo dubitatis dicere bene esse homini, si palato bene est? Et hunc tu, non dico inter viros numeras, sed inter homines, cuius summum bonum saporibus et coloribus et sonis constat? Excedat ex hoc animalium numero pulcherrimo ac dis secundo; mutis adgregetur animal pabulo laetum. Inrationalis pars animi duas habet partes, alteram animosam, ambitiosam, inpotentem, positam in adfectionibus, alteram humilem, languidam, voluptatibus deditam: illam effrenatam, meliorem tamen, certe fortiorem ac digniorem viro, reliquerunt, hanc necessariam beatae vitae putaverunt, enervem et abiectam. Huic rationem servire iusserunt, et fecerunt animalis generosissimi summum bonum demissum et ignobile, praeterea mixtum portentosumque et ex diversis ac male congruentibus membris. Nam ut ait Vergilius noster in Scylla, prima hominis facies et pulchro pectore virgo pube tenus, postrema inmani corpore pistrix delphinum caudas utero commissa luporum. Huic tamen Scyllae fera animalia adiuncta sunt, horrenda, velocia: at isti sapientiam ex quibus composuere portentis? Prima pars hominis est ipsa virtus; huic committitur inutilis caro et fluida, receptandis tantum cibis habilis, ut ait Posidonius. Virtus illa divina in lubricum desinit et superioribus eius partibus venerandis atque caelestibus animal iners ac marcidum adtexitur. Illa utcumque altera quies nihil quidem ipsa praestabat animo, sed inpedimenta removebat: voluptas ultro dissolvit et omne robur emollit. Quae invenietur tam discors inter se iunctura corporum? Fortissimae rei inertissima adstruitur, severissimae parum seria, sanctissimae intemperans usque ad incesta. «Quid ergo?» inquit «si virtutem nihil inpeditura sit bona valetudo et quies et dolorum vacatio, non petes illas?». Quidni petam? Non quia bona sunt, sed quia secundum naturam sunt, et quia bono a me iudicio sumentur. Quid erit tunc in illis bonum? Hoc unum, bene eligi. Nam cum vestem qualem decet sumo, cum ambulo ut oportet, cum ceno quemadmodum debeo, non cena aut ambulatio aut vestis bona sunt, sed meum in iis propositum servantis in quaque re rationi convenientem modum. Etiamnunc adiciam: mundae vestis electio adpetenda est homini; natura enim homo mundum et elegans animal est. Itaque non est bonum per se munda vestis sed mundae vestis electio, quia non in re bonum est sed in
electione quali; actiones nostrae honestae sunt, non ipsa quae aguntur. Quod de veste dixi, idem me dicere de corpore existima. Nam hoc quoque natura ut quandam vestem animo circumdedit; velamentum eius est. Quis autem umquam vestimenta aestimavit arcula? Nec bonum nec malum vagina gladium facit. Ergo de corpore quoque idem tibi respondeo: sumpturum quidem me, si detur electio, et sanitatem et vires, bonum autem futurum iudicium de illis meum, non ipsa. «Est quidem» inquit «sapiens beatus; summum tamen illud bonum non consequitur nisi illi et naturalia instrumenta respondeant. Ita miser quidem esse qui virtutem habet non potest, beatissimus autem non est qui naturalibus bonis destituitur, ut valetudine, ut membrorum integritate». Quod incredibilius videtur, id concedis, aliquem in maximis et continuis doloribus non esse miserum, esse etiam beatum: quod levius est negas, beatissimum esse. Atqui si potest virtus efficere ne miser aliquis sit, facilius efficiet ut beatissimus sit; minus enim intervalli a beato ad beatissimum restat quam a misero ad beatum. An quae res tantum valet ut ereptum calamitatibus inter beatos locet non potest adicere quod superest, ut beatissimum faciat? In summo deficit clivo? Commoda sunt in vita et incommoda, utraque extra nos. Si non est miser vir bonus quamvis omnibus prematur incommodis, quomodo non est beatissimus si aliquibus commodis deficitur? Nam quemadmodum incommodorum onere usque ad miserum non deprimitur, sic commodorum inopia non deducitur a beatissimo, sed tam sine commodis beatissimus est quam non est sub incommodis miser; aut potest illi eripi bonum suum, si potest minui. Paulo ante dicebam igniculum nihil conferre lumini solis; claritate enim eius quidquid sine illo luceret absconditur. «Sed quaedam» inquit «soli quoque opstant». At sol integer est etiam inter opposita, et quamvis aliquid interiacet quod nos prohibeat eius aspectu, in opere est, cursu suo fertur; quotiens inter nubila eluxit, non est sereno minor, ne tardior quidem, quoniam multum interest utrum aliquid obstet tantum an inpediat. Eodem modo virtuti opposita nihil detrahunt: non est minor, sed minus fulget. Nobis forsitan non aeque apparet ac nitet, sibi eadem est et more solis obscuri in occulto vim suam exercet. Hoc itaque adversus virtutem possunt calamitates et damna et iniuriae quod adversus solem potest nebula. Invenitur qui dicat sapientem corpore parum prospero usum nec miserum esse nec beatum. Hic quoque fallitur; exaequat enim fortuita virtutibus et tantundem tribuit honestis quantum honestate carentibus. Quid autem foedius, quid indignius quam comparari veneranda contemptis? Veneranda enim sunt iustitia, pietas, fides, fortitudo, prudentia: e contrario vilia sunt quae saepe contingunt pleniora vilissimis, crus solidum et lacertus et dentes et horum sanitas firmitasque. Deinde si sapiens cui corpus molestum est nec miser habebitur nec beatus, sed in medio relinquetur, vita quoque eius nec adpetenda erit nec fugienda. Quid autem tam absurdum quam sapientis vitam adpetendam non esse? Aut quid tam extra fidem quam esse aliquam vitam nec adpetendam nec fugiendam? Deinde si damna corporis miserum non faciunt, beatum esse patiuntur; nam quibus potentia non est in peiorem transferendi statum, ne interpellandi quidem optimum.
«Frigidum» inquit «aliquid et calidum novimus, inter utrumque tepidum est; sic aliquis beatus est, aliquis miser, aliquis nec beatus nec miser». Volo hanc contra nos positam imaginem excutere. Si tepido illi plus frigidi ingessero, fiet frigidum; si plus calidi adfudero, fiet novissime calidum. At huic nec misero nec beato quantumcumque ad miserias adiecero, miser non erit, quemadmodum dicitis; ergo imago ista dissimilis est. Deinde trado tibi hominem nec miserum nec beatum. Huic adicio caecitatem: non fit miser; adicio debilitatem: non fit miser; adicio dolores continuos et graves: miser non fit. Quem tam multa mala in miseram vitam non transferunt ne ex beata quidem educunt. Si non potest, ut dicitis, sapiens ex beato in miserum decidere, non potest in non beatum. Quare enim qui labi coepit alicubi subsistat? Quae res illum non patitur ad imum devolvi retinet in summo. Quidni non possit beata vita rescindi? Ne remitti quidem potest, et ideo virtus ad illam per se ipsa satis est. «Quid ergo?» inquit «sapiens non est beatior qui diutius vixit, quem nullus avocavit dolor, quam ille qui cum mala fortuna semper luctatus est?». Responde mihi: numquid et melior est et honestior? Si haec non sunt, ne beatior quidem est. Rectius vivat oportet ut beatius vivat: si rectius non potest, ne beatius quidem. Non intenditur virtus, ergo ne beata quidem vita, quae ex virtute est. Virtus enim tantum bonum est ut istas accessiones minutas non sentiat, brevitatem aevi et dolorem et corporum varias offensiones; nam voluptas non est digna ad quam respiciat. Quid est in virtute praecipuum? Futuro non indigere nec dies suos conputare. In quantulo libet tempore bona aeterna consummat. Incredibilia nobis haec videntur et supra humanam naturam excurrentia; maiestatem enim eius ex nostra inbecillitate metimur et vitiis nostris nomen virtutis inponimus. Quid porro? Non aeque incredibile videtur aliquem in summis cruciatibus positum dicere «beatus sum»? Atqui haec vox in ipsa officina voluptatis audita est. «Beatissimum» inquit «hunc et ultimum diem ago» Epicurus, cum illum hinc urinae difficultas torqueret, hinc insanabilis exulcerati dolor ventris. Quare ergo incredibilia ista sint apud eos qui virtutem colunt, cum apud eos quoque reperiantur apud quos voluptas imperavit? Hi quoque degeneres et humillimae mentis aiunt in summis doloribus, in summis calamitatibus sapientem nec miserum futurum nec beatum. Atqui hoc quoque incredibile est, immo incredibilius; non video enim quomodo non in imum agatur e fastigio suo deiecta virtus. Aut beatum praestare debet aut, si ab hoc depulsa est, non prohibebit fieri miserum. Stans non potest mitti: aut vincatur oportet aut vincat. «Dis» inquit «inmortalibus solis et virtus et beata vita contigit, nobis umbra quaedam illorum bonorum et similitudo; accedimus ad illa, non pervenimus». Ratio vero dis hominibusque communis est: haec in illis consummata est, in nobis consummabilis. Sed ad desperationem nos vitia nostra perducunt. Nam ille alter secundus est ut aliquis parum constans ad custodienda optima, cuius iudicium labat etiamnunc et incertum est. Desideret oculorum atque aurium sensum, bonam valetudinem et non foedum aspectum corporis et habitu manente suo aetatis praeterea longius spatium. Per haec potest non paenitenda agi vita, at inperfecto
viro huic malitiae vis quaedam inest, quia animum habet mobilem ad prava, illa †aitarens malitia et ea agitata† abest. Non est adhuc bonus, sed in bonum fingitur; cuicumque autem deest aliquid ad bonum, malus est. Sed si cui virtus animusque in corpore praesens, hic deos aequat, illo tendit originis suae memor. Nemo inprobe eo conatur ascendere unde descenderat. Quid est autem cur non existimes in eo divini aliquid existere qui dei pars est? Totum hoc quo continemur et unum est et deus; et socii sumus eius et membra. Capax est noster animus, perfertur illo si vitia non deprimant. Quemadmodum corporum nostrorum habitus erigitur et spectat in caelum, ita animus, cui in quantum vult licet porrigi, in hoc a natura rerum formatus est, ut paria dis vellet; et si utatur suis viribus ac se in spatium suum extendat, non aliena via ad summa nititur. Magnus erat labor ire in caelum: redit. Cum hoc iter nactus est, vadit audaciter contemptor omnium nec ad pecuniam respicit aurumque et argentum, illis in quibus iacuere tenebris dignissima, non ab hoc aestimat splendore quo inperitorum verberant oculos, sed a vetere caeno ex quo illa secrevit cupiditas nostra et effodit. Scit, inquam, aliubi positas esse divitias quam quo congeruntur; animum impleri debere, non arcam. Hunc inponere dominio rerum omnium licet, hunc in possessionem rerum naturae inducere, ut sua orientis occidentisque terminis finiat, deorumque ritu cuncta possideat, cum opibus suis divites superne despiciat, quorum nemo tam suo laetus est quam tristis alieno. Cum se in hanc sublimitatem tulit, corporis quoque ut oneris necessarii non amator sed procurator est, nec se illi cui inpositus est subicit. Nemo liber est qui corpori servit; nam ut alios dominos quos nimia pro illo sollicitudo invenit transeas, ipsius morosum imperium delicatumque est. Ab hoc modo aequo animo exit, modo magno prosilit, nec quis deinde relicti eius futurus sit exitus quaerit; sed ut ex barba capilloque tonsa neglegimus, ita ille divinus animus egressurus hominem, quo receptaculum suum conferatur, ignis illud †excludat† an terra contegat an ferae distrahant, non magis ad se iudicat pertinere quam secundas ad editum infantem. Utrum proiectum aves differant an consumatur canibus data praeda marinis, quid ad illum qui nullus est? Sed tunc quoque cum inter homines est, non timet ullas post mortem minas eorum quibus usque ad mortem timeri parum est. «Non conterret» inquit «me nec uncus nec proiecti ad contumeliam cadaveris laceratio foeda visuris. Neminem de supremo officio rogo, nulli reliquias meas commendo. Ne quis insepultus esset rerum natura prospexit: quem saevitia proiecerit dies condet». Diserte Maecenas ait, nec tumulum curo: sepelit natura relictos.
Alte cinctum putes dixisse; habuit enim ingenium et grande et virile, nisi illud secunda discinxissent. Vale.
Liber quintus decimus 93. In epistula qua de morte Metronactis philosophi querebaris, tamquam et potuisset diutius vivere et debuisset, aequitatem tuam desideravi, quae tibi in omni persona, in omni negotio superest, in una re deest, in qua omnibus: multos inveni aequos adversus homines, adversus deos neminem. Obiurgamus cotidie fatum: «quare ille in medio cursu raptus est? Quare ille non rapitur? Quare senectutem et sibi et aliis gravem extendit?». Utrum, obsecro te, aequius iudicas, te naturae an tibi parere naturam? Quid autem interest quam cito exeas unde utique exeundum est? Non ut diu vivamus curandum est, sed ut satis; nam ut diu vivas fato opus est, ut satis, animo. Longa est vita si plena est; impletur autem cum animus sibi bonum suum reddidit et ad se potestatem sui transtulit. Quid illum octoginta anni iuvant per inertiam exacti? Non vixit iste sed in vita moratus est, nec sero mortuus est, sed diu. «Octoginta annis vixit». Interest mortem eius ex quo die numeres. «At ille obiit viridis». Sed officia boni civis, boni amici, boni filii executus est; in nulla parte cessavit; licet aetas eius inperfecta sit, vita perfecta est. «Octoginta annis vixit». Immo octoginta annis fuit, nisi forte sic vixisse eum dicis quomodo dicuntur arbores vivere. Obsecro te, Lucili, hoc agamus ut quemadmodum pretiosa rerum sic vita nostra non multum pateat sed multum pendeat; actu illam metiamur, non tempore. Vis scire quid inter hunc intersit vegetum contemptoremque fortunae functum omnibus vitae humanae stipendiis atque in summum bonum eius evectum et illum cui multi anni transmissi sunt? Alter post mortem quoque est, alter ante mortem perit. Laudemus itaque et in numero felicium reponamus eum cui quantulumcumque temporis contigit bene conlocatum est. Vidit enim veram lucem; non fuit unus e multis; et vixit et viguit. Aliquando sereno usus est, aliquando, ut solet, validi sideris fulgor per nubila emicuit. Quid quaeris quamdiu vixerit? Vivit: ad posteros usque transiluit et se in memoriam dedit. Nec ideo mihi plures annos accedere recusaverim; nihil tamen mihi ad beatam vitam defuisse dicam si spatium eius inciditur; non enim ad eum diem me aptavi quem ultimum mihi spes avida promiserat, sed nullum non tamquam ultimum aspexi. Quid me interrogas quando natus sim, an inter iuniores adhuc censear? Habeo meum. Quemadmodum in minore corporis habitu potest homo esse perfectus, sic et in minore temporis modo potest vita esse perfecta. Aetas inter externa est. Quamdiu sim alienum est: quamdiu ero, vere ut sim, meum est. Hoc a me exige, ne velut per tenebras aevum ignobile emetiar, ut agam vitam, non ut praetervehar. Quaeris quod sit amplissimum vitae spatium? Usque ad sapientiam vivere; qui ad illam pervenit attigit non longissimum finem, sed maximum. Ille vero glorietur audacter et dis agat gratias interque eos sibi, et rerum naturae inputet quod fuit. Merito enim inputabit: meliorem illi vitam reddidit quam accepit. Exemplar boni viri posuit, qualis quantusque esset ostendit; si quid adiecisset, fuisset simile praeterito. Et tamen quousque vivimus? Omnium rerum cognitione fruiti sumus: scimus a quibus principiis natura se attollat, quemadmodum ordinet mundum, per quas annum vices revocet,
quemadmodum omnia quae usquam erunt cluserit et se ipsam finem sui fecerit; scimus sidera impetu suo vadere, praeter terram nihil stare, cetera continua velocitate decurrere; scimus quemadmodum solem luna praetereat, quare tardior velociorem post se relinquat, quomodo lumen accipiat aut perdat, quae causa inducat noctem, quae reducat diem: illuc eundum est ubi ista propius aspicias. «Nec hac spe» inquit sapiens ille «fortius exeo, quod patere mihi ad deos meos iter iudico. Merui quidem admitti et iam inter illos fui animumque illo meum misi et ad me illi suum miserant. Sed tolli me de medio puta et post mortem nihil ex homine restare: aeque magnum animum habeo, etiam si nusquam transiturus excedo». Non tam multis vixit annis quam potuit. Et paucorum versuum liber est et quidem laudandus atque utilis: annales Tanusii scis quam ponderosi sint et quid vocentur. Hoc est vita quorundam longa, et quod Tanusii sequitur annales. Numquid feliciorem iudicas eum qui summo die muneris quam eum qui medio occiditur? Numquid aliquem tam stulte cupidum esse vitae putas ut iugulari in spoliario quam in harena malit? Non maiore spatio alter alterum praecedimus. Mors per omnis it; qui occidit consequitur occisum. Minimum est de quo sollicitissime agitur. Quid autem ad rem pertinet quam diu vites quod evitare non possis? Vale. 94. Eam partem philosophiae quae dat propria cuique personae praecepta nec in universum componit hominem sed marito suadet quomodo se gerat adversus uxorem, patri quomodo educet liberos, domino quomodo servos regat, quidam solam receperunt, ceteras quasi extra utilitatem nostram vagantis reliquerunt, tamquam quis posset de parte suadere nisi qui summam prius totius vitae conplexus esset. Ariston Stoicus e contrario hanc partem levem existimat et quae non descendat in pectus usque, anilia habentem praecepta; plurimum ait proficere ipsa decreta philosophiae constitutionemque summi boni; «quam qui bene intellexit ac didicit quid in quaque re faciendum sit sibi ipse praecipit». Quemadmodum qui iaculari discit destinatum locum captat et manum format ad derigenda quae mittit, cum hanc vim ex disciplina et exercitatione percepit, quocumque vult illa utitur (didicit enim non hoc aut illud ferire sed quodcumque voluerit), sic qui se ad totam vitam instruxit non desiderat particulatim admoneri, doctus in totum, non enim quomodo cum uxore aut cum filio viveret sed quomodo bene viveret: in hoc est et quomodo cum uxore ac liberis vivat. Cleanthes utilem quidem iudicat et hanc partem, sed inbecillam nisi ab universo fluit, nisi decreta ipsa philosophiae et capita cognovit. In duas ergo quaestiones locus iste dividitur: utrum utilis an inutilis sit, et an solus virum bonum possit efficere, id est utrum supervacuus sit an omnis faciat supervacuos. Qui hanc partem videri volunt supervacuam hoc aiunt: si quid oculis oppositum moratur aciem, removendum est; illo quidem obiecto operam perdit qui praecipit «sic ambulabis, illo manum porriges». Eodem modo ubi aliqua res occaecat animum et ad officiorum dispiciendum ordinem inpedit, nihil agit qui praecipit «sic vives cum patre, sic cum uxore». Nihil enim proficient praecepta
quamdiu menti error offusus est: si ille discutitur, apparebit quid cuique debeatur officio. Alioqui doces illum quid sano faciendum sit, non efficis sanum. Pauperi ut agat divitem monstras: hoc quomodo manente paupertate fieri potest? Ostendis esurienti quid tamquam satur faciat: fixam potius medullis famem detrahe. Idem tibi de omnibus vitiis dico: ipsa removenda sunt, non praecipiendum quod fieri illis manentibus non potest. Nisi opiniones falsas quibus laboramus expuleris, nec avarus quomodo pecunia utendum sit exaudiet nec timidus quomodo periculosa contemnat. Efficias oportet ut sciat pecuniam nec bonum nec malum esse; ostendas illi miserrimos divites; efficias ut quidquid publice expavimus sciat non esse tam timendum quam fama circumfert, nec diu dolere quemquam nec mori saepe: in morte, quam pati lex est, magnum esse solacium quod ad neminem redit; in dolore pro remedio futuram obstinationem animi, qui levius sibi facit quidquid contumaciter passus est; optimam doloris esse naturam, quod non potest nec qui extenditur magnus esse nec qui est magnus extendi; omnia fortiter excipienda quae nobis mundi necessitas imperat. His decretis cum illum in conspectum suae condicionis adduxeris et cognoverit beatam esse vitam non quae secundum voluptatem est sed secundum naturam, cum virtutem unicum bonum hominis adamaverit, turpitudinem solum malum fugerit, reliqua omnia – divitias, honores, bonam valetudinem, vires, imperia – scierit esse mediam partem nec bonis adnumerandam nec malis, monitorem non desiderabit ad singula qui dicat «sic incede, sic cena; hoc viro, hoc feminae, hoc marito, hoc caelibi convenit». Ista enim qui diligentissime monent ipsi facere non possunt; haec paedagogus puero, haec avia nepoti praecipit, et irascendum non esse magister iracundissimus disputat. Si ludum litterarium intraveris, scies ista quae ingenti supercilio philosophi iactant in puerili esse praescripto. Utrum deinde manifesta an dubia praecipies? Non desiderant manifesta monitorem, praecipienti dubia non creditur; supervacuum est ergo praecipere. Id adeo sic disce: si id mones quod obscurum est et ambiguum, probationibus adiuvandum erit; si probaturus es, illa per quae probas plus valent satisque per se sunt. «Sic amico utere, sic cive, sic socio». «Quare?». «Quia iustum est». Omnia ista mihi de iustitia locus tradit: illic invenio aequitatem per se expetendam, nec metu nos ad illam cogi nec mercede conduci, non esse iustum cui quidquam in hac virtute placet praeter ipsam. Hoc cum persuasi mihi et perbibi, quid ista praecepta proficiunt quae eruditum docent? Praecepta dare scienti supervacuum est, nescienti parum; audire enim debet non tantum quid sibi praecipiatur sed etiam quare. Utrum, inquam, veras opiniones habenti de bonis malisque sunt necessaria an non habenti? Qui non habet nihil a te adiuvabitur, aures eius contraria monitionibus tuis fama possedit; qui habet exactum iudicium de fugiendis petendisque scit quid sibi faciendum sit etiam te tacente. Tota ergo pars ista philosophiae summoveri potest. Duo sunt propter quae delinquimus: aut inest animo pravis opinionibus malitia contracta aut, etiam si non est falsis occupatus, ad falsa proclivis est et cito specie quo non oportet trahente corrumpitur. Itaque debemus aut percurare
mentem aegram et vitiis liberare aut vacantem quidem sed ad peiora pronam praeoccupare. Utrumque decreta philosophiae faciunt; ergo tale praecipiendi genus nil agit. Praeterea si praecepta singulis damus, inconprehensibile opus est; alia enim dare debemus feneranti, alia colenti agrum, alia negotianti, alia regum amicitias sequenti, alia pares, alia inferiores amaturo. In matrimonio praecipies quomodo vivat cum uxore aliquis quam virginem duxit, quomodo cum ea quae alicuius ante matrimonium experta est, quemadmodum cum locuplete, quemadmodum cum indotata. An non putas aliquid esse discriminis inter sterilem et fecundam, inter provectiorem et puellam, inter matrem et novercam? Omnis species conplecti non possumus: atqui singulae propria exigunt, leges autem philosophiae breves sunt et omnia alligant. Adice nunc quod sapientiae praecepta finita debent esse et certa; si qua finiri non possunt, extra sapientiam sunt; sapientia rerum terminos novit. Ergo ista praeceptiva pars summovenda est, quia quod paucis promittit praestare omnibus non potest; sapientia autem omnis tenet. Inter insaniam publicam et hanc quae medicis traditur nihil interest nisi quod haec morbo laborat, illa opinionibus falsis; altera causas furoris traxit ex valetudine, altera animi mala valetudo est. Si quis furioso praecepta det quomodo loqui debeat, quomodo procedere, quomodo in publico se gerere, quomodo in privato, erit ipso quem monebit insanior: bilis nigra curanda est et ipsa furoris causa removenda. Idem in hoc alio animi furore faciendum est: ipse discuti debet; alioqui abibunt in vanum monentium verba. Haec ab Aristone dicuntur; cui respondebimus ad singula. Primum adversus illud quod ait, si quid obstat oculo et inpedit visum, debere removeri, fateor huic non opus esse praeceptis ad videndum, sed remedio quo purgetur acies et officientem sibi moram effugiat; natura enim videmus, cui usum sui reddit qui removit obstantia; quid autem cuique debeatur officio natura non docet. Deinde cuius curata suffusio est, is non protinus cum visum recepit aliis quoque potest reddere: malitia liberatus et liberat. Non opus est exhortatione, ne consilio quidem, ut colorum proprietates oculus intellegat; a nigro album etiam nullo monente distinguet. Multis contra praeceptis eget animus ut videat quid agendum sit in vita. Quamquam oculis quoque aegros medicus non tantum curat sed etiam monet. «Non est» inquit «quod protinus inbecillam aciem committas inprobo lumini; a tenebris primum ad umbrosa procede, deinde plus aude et paulatim claram lucem pati adsuesce. Non est quod post cibum studeas, non est quod plenis oculis ac tumentibus imperes; adflatum et vim frigoris in os occurrentis evita» – alia eiusmodi, quae non minus quam medicamenta proficiunt. Adicit remediis medicina consilium. «Error» inquit «est causa peccandi: hunc nobis praecepta non detrahunt nec expugnant opiniones de bonis ac malis falsas». Concedo per se efficacia praecepta non esse ad evertendam pravam animi persuasionem; sed non ideo non aliis quidem adiecta proficiunt. Primum memoriam renovant; deinde quae in universo confusius videbantur in partes divisa diligentius considerantur. Aut isto modo licet et consolationes dicas supervacuas et exhortationes: atqui non sunt
supervacuae; ergo ne monitiones quidem. «Stultum est» inquit «praecipere aegro quid facere tamquam sanus debeat, cum restituenda sanitas sit, sine qua inrita sunt praecepta». Quid quod habent aegri quaedam sanique communia de quibus admonendi sunt? Tamquam ne avide cibos adpetant, ut lassitudinem vitent. Habent quaedam praecepta communia pauper et dives. «Sana» inquit «avaritiam, et nihil habebis quod admoneas aut pauperem aut divitem, si cupiditas utriusque consedit». Quid quod aliud est non concupiscere pecuniam, aliud uti pecunia scire? Cuius avari modum ignorant, etiam non avari usum. «Tolle» inquit «errores: supervacua praecepta sunt». Falsum est. Puta enim avaritiam relaxatam, puta adstrictam esse luxuriam, temeritati frenos iniectos, ignaviae subditum calcar: etiam remotis vitiis, quid et quemadmodum debeamus facere discendum est. «Nihil» inquit «efficient monitiones admotae gravibus vitiis». Ne medicina quidem morbos insanabiles vincit, tamen adhibetur aliis in remedium, aliis in levamentum. Ne ipsa quidem universae philosophiae vis, licet totas in hoc vires suas advocet, duram iam et veterem animis extrahet pestem; sed non ideo nihil sanat quia non omnia. «Quid prodest» inquit «aperta monstrare?». Plurimum; interdum enim scimus nec adtendimus. Non docet admonitio sed advertit, sed excitat, sed memoriam continet nec patitur elabi. Pleraque ante oculos posita transimus: admonere genus adhortandi est. Saepe animus etiam aperta dissimulat; ingerenda est itaque illi notitia rerum notissimarum. Illa hoc loco in Vatinium Calvi repetenda sententia est: «factum esse ambitum scitis, et hoc vos scire omnes sciunt». Scis amicitias sancte colendas esse, sed non facis. Scis inprobum esse qui ab uxore pudicitiam exigit, ipse alienarum corruptor uxorum; scis ut illi nil cum adultero, sic tibi nil esse debere cum paelice, et non facis. Itaque subinde ad memoriam reducendus es; non enim reposita illa esse oportet sed in promptu. Quaecumque salutaria sunt saepe agitari debent, saepe versari, ut non tantum nota sint nobis sed etiam parata. Adice nunc quod aperta quoque apertiora fieri solent. «Si dubia sunt» inquit «quae praecipis, probationes adicere debebis; ergo illae, non praecepta proficient». Quid quod etiam sine probationibus ipsa monentis auctoritas prodest? Sic quomodo iurisconsultorum valent responsa, etiam si ratio non redditur. Praeterea ipsa quae praecipiuntur per se multum habent ponderis, utique si aut carmini intexta sunt aut prosa oratione in sententiam coartata, sicut illa Catoniana: «emas non quod opus est, sed quod necesse est; quod non opus est asse carum est», qualia sunt illa aut reddita oraculo aut similia: «tempori parce», «te nosce». Numquid rationem exiges cum tibi aliquis hos dixerit versus? Iniuriarum remedium est oblivio. Audentis fortuna iuvat, piger ipse sibi opstat. Advocatum ista non quaerunt: adfectus ipsos tangunt et natura vim suam exercente proficiunt. Omnium honestarum rerum semina animi gerunt, quae admonitione excitantur non aliter quam scintilla flatu levi adiuta ignem suum
explicat; erigitur virtus cum tacta est et inpulsa. Praeterea quaedam sunt quidem in animo, sed parum prompta, quae incipiunt in expedito esse cum dicta sunt; quaedam diversis locis iacent sparsa, quae contrahere inexercitata mens non potest. Itaque in unum conferenda sunt et iungenda, ut plus valeant animumque magis adlevent. Aut si praecepta nihil adiuvant, omnis institutio tollenda est; ipsa natura contenti esse debemus. Hoc qui dicunt non vident alium esse ingenii mobilis et erecti, alium tardi et hebetis, utique alium alio ingeniosiorem. Ingenii vis praeceptis alitur et crescit novasque persuasiones adicit innatis et depravata corrigit. «Si quis» inquit «non habet recta decreta, quid illum admonitiones iuvabunt vitiosis obligatum?». Hoc scilicet, ut illis liberetur; non enim extincta in illo indoles naturalis est sed obscurata et oppressa. Sic quoque temptat resurgere et contra prava nititur, nacta vero praesidium et adiuta praeceptis evalescit, si tamen illam diutina pestis non infecit nec enecuit; hanc enim ne disciplina quidem philosophiae toto impetu suo conisa restituet. Quid enim interest inter decreta philosophiae et praecepta nisi quod illa generalia praecepta sunt, haec specialia? Utraque res praecipit, sed altera in totum, particulatim altera. «Si quis» inquit «recta habet et honesta decreta, hic ex supervacuo monetur». Minime; nam hic quoque doctus quidem est facere quae debet, sed haec non satis perspicit. Non enim tantum adfectibus inpedimur quominus probanda faciamus sed inperitia inveniendi quid quaeque res exigat. Habemus interdum compositum animum, sed residem et inexercitatum ad inveniendam officiorum viam, quam admonitio demonstrat. «Expelle» inquit «falsas opiniones de bonis et malis, in locum autem earum veras repone, et nihil habebit admonitio quod agat». Ordinatur sine dubio ista ratione animus, sed non ista tantum; nam quamvis argumentis collectum sit quae bona malaque sint, nihilominus habent praecepta partes suas. Et prudentia et iustitia officiis constat: officia praeceptis disponuntur. Praeterea ipsum de malis bonisque iudicium confirmatur officiorum exsecutione, ad quam praecepta perducunt. Utraque enim inter se consentiunt: nec illa possunt praecedere ut non haec sequantur, et haec ordinem sequuntur suum; unde apparet illa praecedere. «Infinita» inquit «praecepta sunt». Falsum est; nam de maximis ac necessariis rebus non sunt infinita; tenues autem differentias habent quas exigunt tempora, loca, personae, sed his quoque dantur praecepta generalia. «Nemo», inquit, «praeceptis curat insaniam; ergo ne malitiam quidem». Dissimile est; nam si insaniam sustuleris, sanitas reddita est; si falsas opiniones exclusimus, non statim sequitur dispectus rerum agendarum; ut sequatur, tamen admonitio conroborabit rectam de bonis malisque sententiam. Illud quoque falsum est, nihil apud insanos proficere praecepta. Nam quemadmodum sola non prosunt, sic curationem adiuvant; et denuntiatio et castigatio insanos coercuit – de illis nunc insanis loquor quibus mens mota est, non erepta. «Leges» inquit «ut faciamus quod oportet non efficiunt, et quid aliud sunt quam minis mixta praecepta?». Primum omnium ob hoc illae non persuadent quia
minantur, at haec non cogunt sed exorant; deinde leges a scelere deterrent, praecepta in officium adhortantur. His adice quod leges quoque proficiunt ad bonos mores, utique si non tantum imperant sed docent. In hac re dissentio a Posidonio, qui »improbo» inquit «quod Platonis legibus adiecta principia sunt. Legem enim brevem esse oportet, quo facilius ab inperitis teneatur. Velut emissa divinitus vox sit: iubeat, non disputet. Nihil videtur mihi frigidius, nihil ineptius quam lex cum prologo. Mone, dic quid me velis fecisse: non disco sed pareo». Proficiunt vero; itaque malis moribus uti videbis civitates usas malis legibus. «At non apud omnis proficiunt». Ne philosophia quidem; nec ideo inutilis et formandis animis inefficax est. Quid autem? Philosophia non vitae lex est? Sed putemus non proficere leges: non ideo sequitur ut ne monitiones quidem proficiant. Aut sic et consolationes nega proficere dissuasionesque et adhortationes et obiurgationes et laudationes. Omnia ista monitionum genera sunt; per ista ad perfectum animi statum pervenitur. Nulla res magis animis honesta induit dubiosque et in pravum inclinabiles revocat ad rectum quam bonorum virorum conversatio; paulatim enim descendit in pectora et vim praeceptorum obtinet frequenter aspici, frequenter audiri. Occursus mehercules ipse sapientium iuvat, et est aliquid quod ex magno viro vel tacente proficias. Nec tibi facile dixerim quemadmodum prosit, sicut illud intellegam profuisse. «Minuta quaedam» ut ait Phaedon «animalia cum mordent non sentiuntur, adeo tenuis illis et fallens in periculum vis est; tumor indicat morsum et in ipso tumore nullum vulnus apparet». Idem tibi in conversatione virorum sapientium eveniet: non deprehendes quemadmodum aut quando tibi prosit, profuisse deprendes. «Quorsus» inquis «hoc pertinet?». Aeque praecepta bona, si saepe tecum sint, profutura quam bona exempla. Pythagoras ait alium animum fieri intrantibus templum deorumque simulacra ex vicino cernentibus et alicuius oraculi opperientibus vocem. Quis autem negabit feriri quibusdam praeceptis efficaciter etiam inperitissimos? Velut his brevissimis vocibus, sed multum habentibus ponderis: Nil nimis. Avarus animus nullo satiatur lucro. Ab alio expectes alteri quod feceris. Haec cum ictu quodam audimus, nec ulli licet dubitare aut interrogare «quare?»; adeo etiam sine ratione ipsa veritas lucet. Si reverentia frenat animos ac vitia conpescit, cur non et admonitio idem possit? Si inponit pudorem castigatio, cur admonitio non faciat, etiam si nudis praeceptis utitur? Illa vero efficacior est et altius penetrat quae adiuvat ratione quod praecipit, quae adicit quare quidque faciendum sit et quis facientem oboedientemque praeceptis fructus expectet. Si imperio proficitur, et admonitione; atqui proficitur imperio; ergo et admonitione. In duas partes virtus dividitur, in contemplationem veri et actionem:
contemplationem institutio tradit, actionem admonitio. Virtutem et exercet et ostendit recta actio. Acturo autem si prodest qui suadet, et qui monet proderit. Ergo si recta actio virtuti necessaria est, rectas autem actiones admonitio demonstrat, et admonitio necessaria est. Duae res plurimum roboris animo dant, fides veri et fiducia: utramque admonitio facit. Nam et creditur illi et, cum creditum est, magnos animus spiritus concipit ac fiducia impletur; ergo admonitio non est supervacua. M. Agrippa, vir ingentis animi, qui solus ex iis quos civilia bella claros potentesque fecerunt felix in publicum fuit, dicere solebat multum se huic debere sententiae: «nam concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur». Hac se aiebat et fratrem et amicum optimum factum. Si eiusmodi sententiae familiariter in animum receptae formant eum, cur non haec pars philosophiae quae talibus sententiis constat idem possit? Pars virtutis disciplina constat, pars exercitatione; et discas oportet et quod didicisti agendo confirmes. Quod si est, non tantum scita sapientiae prosunt sed etiam praecepta, quae adfectus nostros velut edicto coercent et ablegant. «Philosophia» inquit «dividitur in haec, scientiam et habitum animi; nam qui didicit et facienda ac vitanda percepit nondum sapiens est nisi in ea quae didicit animus eius transfiguratus est. Tertia ista pars praecipiendi ex utroque est, et ex decretis et ex habitu; itaque supervacua est ad implendam virtutem, cui duo illa sufficiunt». Isto ergo modo et consolatio supervacua est (nam haec quoque ex utroque est) et adhortatio et suasio et ipsa argumentatio; nam et haec ab habitu animi compositi validique proficiscitur. Sed quamvis ista ex optimo habitu animi veniant, optimus animi habitus ex his est; et facit illa et ex illis ipse fit. Deinde istud quod dicis iam perfecti viri est ac summam consecuti felicitatis humanae. Ad haec autem tarde pervenitur; interim etiam inperfecto sed proficienti demonstranda est in rebus agendis via. Hanc forsitan etiam sine admonitione dabit sibi ipsa sapientia, quae iam eo perduxit animum ut moveri nequeat nisi in rectum. Inbecillioribus quidem ingeniis necessarium est aliquem praeire: «hoc vitabis, hoc facies». Praeterea si expectat tempus quo per se sciat quid optimum factu sit, interim errabit et errando inpedietur quominus ad illud perveniat quo possit se esse contentus; regi ergo debet dum incipit posse se regere. Pueri ad praescriptum discunt; digiti illorum tenentur et aliena manu per litterarum simulacra ducuntur, deinde imitari iubentur proposita et ad illa reformare chirographum: sic animus noster, dum eruditur ad praescriptum, iuvatur. Haec sunt per quae probatur hanc philosophiae partem supervacuam non esse. Quaeritur deinde an ad faciendum sapientem sola sufficiat. Huic quaestioni suum diem dabimus: interim omissis argumentis nonne apparet opus esse nobis aliquo advocato qui contra populi praecepta praecipiat? Nulla ad aures nostras vox inpune perfertur: nocent qui optant, nocent qui execrantur. Nam et horum inprecatio falsos nobis metus inserit et illorum amor male docet bene optando; mittit enim nos ad longinqua bona et incerta et errantia, cum possimus felicitatem domo promere. Non licet, inquam, ire recta via; trahunt in pravum parentes, trahunt servi. Nemo errat uni sibi, sed dementiam spargit in proximos accipitque
invicem. Et ideo in singulis vitia populorum sunt quia illa populus dedit. Dum facit quisque peiorem, factus est; didicit deteriora, dein docuit, effectaque est ingens illa nequitia congesto in unum quod cuique pessimum scitur. Sit ergo aliquis custos et aurem subinde pervellat abigatque rumores et reclamet populis laudantibus. Erras enim si existimas nobiscum vitia nasci: supervenerunt, ingesta sunt. Itaque monitionibus crebris opiniones quae nos circumsonant repellantur. Nulli nos vitio natura conciliat: illa integros ac liberos genuit. Nihil quo avaritiam nostram inritaret posuit in aperto: pedibus aurum argentumque subiecit calcandumque ac premendum dedit quidquid est propter quod calcamur ac premimur. Illa vultus nostros erexit ad caelum et quidquid magnificum mirumque fecerat videri a suspicientibus voluit: ortus occasusque et properantis mundi volubilem cursum, interdiu terrena aperientem, nocte caelestia, tardos siderum incessus si compares toti, citatissimos autem si cogites quanta spatia numquam intermissa velocitate circumeant, defectus solis ac lunae invicem obstantium, alia deinceps digna miratu, sive per ordinem subeunt sive subitis causis mota prosiliunt, ut nocturnos ignium tractus et sine ullo ictu sonituque fulgores caeli patescentis columnasque ac trabes et varia simulacra flammarum. Haec supra nos natura disposuit, aurum quidem et argentum et propter ista numquam pacem agens ferrum, quasi male nobis committerentur, abscondit. Nos in lucem propter quae pugnaremus extulimus, nos et causas periculorum nostrorum et instrumenta disiecto terrarum pondere eruimus, nos fortunae mala nostra tradidimus nec erubescimus summa apud nos haberi quae fuerant ima terrarum. Vis scire quam falsus oculos tuos deceperit fulgor? Nihil est istis quamdiu mersa et involuta caeno suo iacent foedius, nihil obscurius, quidni? Quae per longissimorum cuniculorum tenebras extrahuntur; nihil est illis dum fiunt et a faece sua separantur informius. Denique ipsos opifices intuere per quorum manus sterile terrae genus et infernum perpurgatur: videbis quanta fuligine oblinantur. Atqui ista magis inquinant animos quam corpora, et in possessore eorum quam in artifice plus sordium est. Necessarium itaque admoneri est, habere aliquem advocatum bonae mentis et in tanto fremitu tumultuque falsorum unam denique audire vocem. Quae erit illa vox? Ea scilicet quae tibi tantis clamoribus ambitionis exsurdato salubria insusurret verba, quae dicat: non est quod invideas istis quos magnos felicesque populus vocat, non est quod tibi compositae mentis habitum et sanitatem plausus excutiat, non est quod tibi tranquillitatis tuae fastidium faciat ille sub illis fascibus purpura cultus, non est quod feliciorem eum iudices cui summovetur quam te quem lictor semita deicit. Si vis exercere tibi utile, nulli autem grave imperium, summove vitia. Multi inveniuntur qui ignem inferant urbibus, qui inexpugnabilia saeculis et per aliquot aetates tuta prosternant, qui aequum arcibus aggerem attollant et muros in miram altitudinem eductos arietibus ac machinis quassent. Multi sunt qui ante se agant agmina et tergis hostium graves instent et ad mare magnum perfusi caede gentium veniant, sed hi quoque, ut vincerent hostem, cupiditate victi sunt. Nemo illis venientibus restitit, sed nec ipsi ambitioni crudelitatique
restiterant; tunc cum agere alios visi sunt, agebantur. Agebat infelicem Alexandrum furor aliena vastandi et ad ignota mittebat. An tu putas sanum qui a Graeciae primum cladibus, in qua eruditus est, incipit? Qui quod cuique optimum est eripit, Lacedaemona servire iubet, Athenas tacere? Non contentus tot civitatium strage, quas aut vicerat Philippus aut emerat, alias alio loco proicit et toto orbe arma circumfert; nec subsistit usquam lassa crudelitas inmanium ferarum modo quae plus quam exigit fames mordent. Iam in unum regnum multa regna coniecit, iam Graeci Persaeque eundem timent, iam etiam a Dareo liberae nationes iugum accipiunt; it tamen ultra oceanum solemque, indignatur ab Herculis Liberique vestigiis victoriam flectere, ipsi naturae vim parat. Non ille ire vult, sed non potest stare, non aliter quam in praeceps deiecta pondera, quibus eundi finis est iacuisse. Ne Gnaeo quidem Pompeio externa bella ac domestica virtus aut ratio suadebat, sed insanus amor magnitudinis falsae. Modo in Hispaniam et Sertoriana arma, modo ad colligandos piratas ac maria pacanda vadebat: hae praetexebantur causae ad continuandam potentiam. Quid illum in Africam, quid in septentrionem, quid in Mithridaten et Armeniam et omnis Asiae angulos traxit? Infinita scilicet cupido crescendi, cum sibi uni parum magnus videretur. Quid C. Caesarem in sua fata pariter ac publica inmisit? Gloria et ambitio et nullus supra ceteros eminendi modus. Unum ante se ferre non potuit, cum res publica supra se duos ferret. Quid, tu C. Marium semel consulem (unum enim consulatum accepit, ceteros rapuit), cum Teutonos Cimbrosque concideret, cum Iugurtham per Africae deserta sequeretur, tot pericula putas adpetisse virtutis instinctu? Marius exercitus, Marium ambitio ducebat. Isti cum omnia concuterent, concutiebantur turbinum more, qui rapta convolvunt sed ipsi ante volvuntur et ob hoc maiore impetu incurrunt quia nullum illis sui regimen est, ideoque, cum multis fuerunt malo, pestiferam illam vim qua plerisque nocuerunt ipsi quoque sentiunt. Non est quod credas quemquam fieri aliena infelicitate felicem. Omnia ista exempla quae oculis atque auribus nostris ingeruntur retexenda sunt, et plenum malis sermonibus pectus exhauriendum; inducenda in occupatum locum virtus, quae mendacia et contra verum placentia exstirpet, quae nos a populo cui nimis credimus separet ac sinceris opinionibus reddat. Hoc est enim sapientia, in naturam converti et eo restitui unde publicus error expulerit. Magna pars sanitatis est hortatores insaniae reliquisse et ex isto coitu invicem noxio procul abisse. Hoc ut esse verum scias, aspice quanto aliter unusquisque populo vivat, aliter sibi. Non est per se magistra innocentiae solitudo nec frugalitatem docent rura, sed ubi testis ac spectator abscessit, vitia subsidunt, quorum monstrari et conspici fructus est. Quis eam quam nulli ostenderet induit purpuram? Quis posuit secretam in auro dapem? Quis sub alicuius arboris rusticae proiectus umbra luxuriae suae pompam solus explicuit? Nemo oculis suis lautus est, ne paucorum quidem aut familiarium, sed apparatum vitiorum suorum pro modo turbae spectantis expandit. Ita est: inritamentum est omnium in quae insanimus admirator et conscius. Ne concupiscamus efficies si ne
ostendamus effeceris. Ambitio et luxuria et inpotentia scaenam desiderant: sanabis ista si absconderis. Itaque si in medio urbium fremitu conlocati sumus, stet ad latus monitor et contra laudatores ingentium patrimoniorum laudet parvo divitem et usu opes metientem. Contra illos qui gratiam ac potentiam attollunt otium ipse suspiciat traditum litteris et animum ab externis ad sua reversum. Ostendat ex constitutione vulgi beatos in illo invidioso fastigio suo trementis et attonitos longeque aliam de se opinionem habentis quam ab aliis habetur; nam quae aliis excelsa videntur ipsis praerupta sunt. Itaque exanimantur et trepidant quotiens despexerunt in illud magnitudinis suae praeceps; cogitant enim varios casus et in sublimi maxime lubricos. Tunc adpetita formidant et quae illos graves aliis reddit gravior ipsis felicitas incubat. Tunc laudant otium lene et sui iuris, odio est fulgor et fuga a rebus adhuc stantibus quaeritur. Tunc demum videas philosophantis metu et aegrae fortunae sana consilia. Nam quasi ista inter se contraria sint, bona fortuna et mens bona, ita melius in malis sapimus: secunda rectum auferunt. Vale. 95. Petis a me ut id quod in diem suum dixeram debere differri repraesentem et scribam tibi an haec pars philosophiae quam Graeci paraeneticen vocant, nos praeceptivam dicimus, satis sit ad consummandam sapientiam. Scio te in bonam partem accepturum si negavero. Eo magis promitto et verbum publicum perire non patior: «postea noli rogare quod inpetrare nolueris». Interdum enim enixe petimus id quod recusaremus si quis offerret. Haec sive levitas est sive vernilitas punienda est promittendi facilitate. Multa videri volumus velle sed nolumus. Recitator historiam ingentem attulit minutissime scriptam, artissime plictam, et magna parte perlecta «desinam» inquit «si vultis»: adclamatur «recita, recita» ab iis qui illum ommutescere illic cupiunt. Saepe aliud volumus, aliud optamus, et verum ne dis quidem dicimus, sed dii aut non exaudiunt aut miserentur. Ego me omissa misericordia vindicabo et tibi ingentem epistulam inpingam, quam tu si invitus leges, dicito «ego mihi hoc contraxi», teque inter illos numera quos uxor magno ducta ambitu torquet, inter illos quos divitiae per summum adquisitae sudorem male habent, inter illos quos honores nulla non arte atque opera petiti discruciant, et ceteros malorum suorum compotes. Sed ut omisso principio rem ipsam adgrediar, «beata» inquiunt «vita constat ex actionibus rectis; ad actiones rectas praecepta perducunt; ergo ad beatam vitam praecepta sufficiunt». Non semper ad actiones rectas praecepta perducunt, sed cum obsequens ingenium est; aliquando frustra admoventur, si animum opiniones obsident pravae. Deinde etiam si recte faciunt, nesciunt facere se recte. Non potest enim quisquam nisi ab initio formatus et tota ratione compositus omnis exsequi numeros ut sciat quando oporteat et in quantum et cum quo et quemadmodum et quare. Non potest toto animo ad honesta conari, ne constanter quidem aut libenter, sed respiciet, sed haesitabit. «Si honesta» inquit «actio ex praeceptis venit, ad beatam vitam praecepta abunde sunt: atqui est illud, ergo et hoc». His respondebimus actiones honestas et
praeceptis fieri, non tantum praeceptis. «Si aliae» inquit «artes contentae sunt praeceptis, contenta erit et sapientia; nam et haec ars vitae est. Atqui gubernatorem facit ille qui praecipit “sic move gubernaculum, sic vela summitte, sic secundo vento utere, sic adverso resiste, sic dubium communemque tibi vindica”. Alios quoque artifices praecepta conformant; ergo in hoc idem poterunt artifice vivendi». Omnes istae artes circa instrumenta vitae occupatae sunt, non circa totam vitam; itaque multa illas inhibent extrinsecus et inpediunt, spes, cupiditas, timor. At haec quae artem vitae professa est nulla re quominus se exerceat vetari potest; discutit enim inpedimenta et iactat obstantia. Vis scire quam dissimilis sit aliarum artium condicio et huius? In illis excusatius est voluntate peccare quam casu, in hac maxima culpa est sponte delinquere. Quod dico tale est. Grammaticus non erubescet soloecismo si sciens fecit, erubescet si nesciens; medicus si deficere aegrum non intellegit, quantum ad artem magis peccat quam si se intellegere dissimulat: at in hac arte vivendi turpior volentium culpa est. Adice nunc quod artes quoque pleraeque – immo ex omnibus liberalissimae – habent decreta sua, non tantum praecepta, sicut medicina; itaque alia est Hippocratis secta, alia Asclepiadis, alia Themisonis. Praeterea nulla ars contemplativa sine decretis suis est, quae Graeci vocant dogmata, nobis vel decreta licet appellare vel scita vel placita; quae et in geometria et in astronomia invenies. Philosophia autem et contemplativa est et activa: spectat simul agitque. Erras enim si tibi illam putas tantum terrestres operas promittere: altius spirat. «Totum» inquit «mundum scrutor nec me intra contubernium mortale contineo, suadere vobis aut dissuadere contenta: magna me vocant supraque vos posita. Nam tibi de summa caeli ratione deumque disserere incipiam et rerum primordia pandam, unde omnis natura creet res, auctet alatque, quoque eadem rursus natura perempta resolvat, ut ait Lucretius». Sequitur ergo ut, cum contemplativa sit, habeat decreta sua. Quid quod facienda quoque nemo rite obibit nisi is cui ratio erit tradita qua in quaque re omnis officiorum numeros exsequi possit? Quos non servabit qui in rem praecepta acceperit, non in omne. Inbecilla sunt per se et, ut ita dicam, sine radice quae partibus dantur. Decreta sunt quae muniant, quae securitatem nostram tranquillitatemque tueantur, quae totam vitam totamque rerum naturam simul contineant. Hoc interest inter decreta philosophiae et praecepta quod inter elementa et membra: haec ex illis dependent, illa et horum causae sunt et omnium. «Antiqua» inquit «sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri: postquam docti prodierunt, boni desunt; simplex enim illa et aperta virtus in obscuram et sollertem scientiam versa est docemurque disputare, non vivere». Fuit sine dubio, ut dicitis, vetus illa
sapientia cum maxime nascens rudis non minus quam ceterae artes quarum in processu subtilitas crevit. Sed ne opus quidem adhuc erat remediis diligentibus. Nondum in tantum nequitia surrexerat nec tam late se sparserat: poterant vitiis simplicibus obstare remedia simplicia. Nunc necesse est tanto operosiora esse munimenta quanto vehementiora sunt quibus petimur. Medicina quondam paucarum fuit scientia herbarum quibus sisteretur fluens sanguis, vulnera coirent; paulatim deinde in hanc pervenit tam multiplicem varietatem. Nec est mirum tunc illam minus negotii habuisse firmis adhuc solidisque corporibus et facili cibo nec per artem voluptatemque corrupto: qui postquam coepit non ad tollendam sed ad inritandam famem quaeri et inventae sunt mille conditurae quibus aviditas excitaretur, quae desiderantibus alimenta erant onera sunt plenis. Inde pallor et nervorum vino madentium tremor et miserabilior ex cruditatibus quam ex fame macies; inde incerti labantium pedes et semper qualis in ipsa ebrietate titubatio; inde in totam cutem umor admissus distentusque venter dum male adsuescit plus capere quam poterat; inde suffusio luridae bilis et decolor vultus tabesque †in se† putrescentium et retorridi digiti articulis obrigescentibus nervorumque sine sensu iacentium torpor aut palpitatio sine intermissione vibrantium. Quid capitis vertigines dicam? Quid oculorum auriumque tormenta et cerebri exaestuantis verminationes et omnia per quae exoneramur internis ulceribus adfecta? Innumerabilia praeterea febrium genera, aliarum impetu saevientium, aliarum tenui peste repentium, aliarum cum horrore et multa membrorum quassatione venientium? Quid alios referam innumerabiles morbos, supplicia luxuriae? Immunes erant ab istis malis qui nondum se delicis solverant, qui sibi imperabant, sibi ministrabant. Corpora opere ac vero labore durabant, aut cursu defatigati aut venatu aut tellure versanda; excipiebat illos cibus qui nisi esurientibus placere non posset. Itaque nihil opus erat tam magna medicorum supellectile nec tot ferramentis atque puxidibus. Simplex erat ex causa simplici valetudo: multos morbos multa fericula fecerunt. Vide quantum rerum per unam gulam transiturarum permisceat luxuria, terrarum marisque vastatrix. Necesse est itaque inter se tam diversa dissideant et hausta male digerantur aliis alio nitentibus. Nec mirum quod inconstans variusque ex discordi cibo morbus est et illa ex contrariis naturae partibus in eundem conpulsa ventrem redundant. Inde tam novo aegrotamus genere quam vivimus. Maximus ille medicorum et huius scientiae conditor feminis nec capillos defluere dixit nec pedes laborare: atqui et capillis destituuntur et pedibus aegrae sunt. Non mutata feminarum natura sed victa est; nam cum virorum licentiam aequaverint, corporum quoque virilium incommoda aequarunt. Non minus pervigilant, non minus potant, et oleo et mero viros provocant; aeque invitis ingesta visceribus per os reddunt et vinum omne vomitu remetiuntur; aeque nivem rodunt, solacium stomachi aestuantis. Libidine vero ne maribus quidem cedunt: pati natae (di illas deaeque male perdant!) adeo perversum commentae genus inpudicitiae viros ineunt. Quid ergo mirandum est maximum medicorum ac naturae peritissimum in mendacio prendi, cum tot feminae podagricae calvaeque
sint? Beneficium sexus sui vitiis perdiderunt et, quia feminam exuerant, damnatae sunt morbis virilibus. Antiqui medici nesciebant dare cibum saepius et vino fulcire venas cadentis, nesciebant sanguinem mittere et diutinam aegrotationem balneo sudoribusque laxare, nesciebant crurum vinculo brachiorumque latentem vim et in medio sedentem ad extrema revocare. Non erat necesse circumspicere multa auxiliorum genera, cum essent periculorum paucissima. Nunc vero quam longe processerunt mala valetudinis! Has usuras voluptatium pendimus ultra modum fasque concupitarum. Innumerabiles esse morbos non miraberis: cocos numera. Cessat omne studium et liberalia professi sine ulla frequentia desertis angulis praesident; in rhetorum ac philosophorum scholis solitudo est: at quam celebres culinae sunt, quanta circa nepotum focos se iuventus premit! Transeo puerorum infelicium greges quos post transacta convivia aliae cubiculi contumeliae expectant; transeo agmina exoletorum per nationes coloresque discripta ut eadem omnibus levitas sit, eadem primae mensura lanuginis, eadem species capillorum, ne quis cui rectior est coma crispulis misceatur; transeo pistorum turbam, transeo ministratorum per quos signo dato ad inferendam cenam discurritur. Di boni, quantum hominum unus venter exercet! Quid? Tu illos boletos, voluptarium venenum, nihil occulti operis iudicas facere, etiam si praesentanei non fuerunt? Quid? Tu illam aestivam nivem non putas callum iocineribus obducere? Quid? Illa ostrea, inertissimam carnem caeno saginatam, nihil existimas limosae gravitatis inferre? Quid? Illud sociorum garum, pretiosam malorum piscium saniem, non credis urere salsa tabe praecordia? Quid? Illa purulenta et quae tantum non ex ipso igne in os transferuntur iudicas sine noxa in ipsis visceribus extingui? Quam foedi itaque pestilentesque ructus sunt, quantum fastidium sui exhalantibus crapulam veterem! scias putrescere sumpta, non concoqui. Memini fuisse quondam in sermone nobilem patinam in quam quidquid apud lautos solet diem ducere properans in damnum suum popina congesserat: veneriae spondylique et ostrea eatenus circumcisa qua eduntur intervenientibus distinguebantur †echini totam destructique† sine ullis ossibus mulli constraverant. Piget esse iam singula: coguntur in unum sapores. In cena fit quod fieri debebat in ventre: expecto iam ut manducata ponantur. Quantulo autem hoc minus est, testas excerpere atque ossa et dentium opera cocum fungi? «Gravest luxuriari per singula: omnia semel et in eundem saporem versa ponantur. Quare ego ad unam rem manum porrigam? Plura veniant simul, multorum ferculorum ornamenta coeant et cohaereant. Sciant protinus hi qui iactationem ex istis peti et gloriam aiebant non ostendi ista sed conscientiae dari. Pariter sint quae disponi solent, uno iure perfusa; nihil intersit; ostrea, echini, spondyli, mulli perturbati concoctique ponantur». Non esset confusior vomentium cibus. Quomodo ista perplexa sunt, sic ex istis non singulares morbi nascuntur sed inexplicabiles, diversi, multiformes, adversus quos et medicina armare se coepit multis generibus, multis observationibus. Idem tibi de philosophia dico. Fuit aliquando simplicior inter minora
peccantis et levi quoque cura remediabiles: adversus tantam morum eversionem omnia conanda sunt. Et utinam sic denique lues ista vincatur! Non privatim solum sed publice furimus. Homicidia conpescimus et singulas caedes: quid bella et occisarum gentium gloriosum scelus? Non avaritia, non crudelitas modum novit. Et ista quamdiu furtim et a singulis fiunt minus noxia minusque monstrosa sunt: ex senatus consultis plebisque scitis saeva exercentur et publice iubentur vetata privatim. Quae clam commissa capite luerent, tum quia paludati fecere laudamus. Non pudet homines, mitissimum genus, gaudere sanguine alterno et bella gerere gerendaque liberis tradere, cum inter se etiam mutis ac feris pax sit. Adversus tam potentem explicitumque late furorem operosior philosophia facta est et tantum sibi virium sumpsit quantum iis adversus quae parabatur accesserat. Expeditum erat obiurgare indulgentis mero et petentis delicatiorem cibum, non erat animus ad frugalitatem magna vi reducendus a qua paullum discesserat: nunc manibus rapidis opus est, nunc arte magistra. Voluptas ex omni quaeritur. Nullum intra se manet vitium: in avaritiam luxuria praeceps est. Honesti oblivio invasit; nihil turpest cuius placet pretium. Homo, sacra res homini, iam per lusum ac iocum occiditur et quem erudiri ad inferenda accipiendaque vulnera nefas erat, is iam nudus inermisque producitur satisque spectaculi ex homine mors est. In hac ergo morum perversitate desideratur solito vehementius aliquid quod mala inveterata discutiat: decretis agendum est ut revellatur penitus falsorum recepta persuasio. His si adiunxerimus praecepta, consolationes, adhortationes, poterunt valere: per se inefficaces sunt. Si volumus habere obligatos et malis quibus iam tenentur avellere, discant quid malum, quid bonum sit, sciant omnia praeter virtutem mutare nomen, modo mala fieri, modo bona. Quemadmodum primum militiae vinculum est religio et signorum amor et deserendi nefas, tunc deinde facile cetera exiguntur mandanturque iusiurandum adactis, ita in iis quos velis ad beatam vitam perducere prima fundamenta iacienda sunt et insinuanda virtus. Huius quadam superstitione teneantur, hanc ament; cum hac vivere velint, sine hac nolint. «Quid ergo? Non quidam sine institutione subtili evaserunt probi magnosque profectus adsecuti sunt dum nudis tantum praeceptis obsequuntur?» Fateor, sed felix illis ingenium fuit et salutaria in transitu rapuit. Nam ut dii immortales nullam didicere virtutem cum omni editi et pars naturae eorum est bonos esse, ita quidam ex hominibus egregiam sortiti indolem in ea quae tradi solent perveniunt sine longo magisterio et honesta conplexi sunt cum primum audiere; unde ista tam rapacia virtutis ingenia vel ex se fertilia. At illis aut hebetibus et obtusis aut mala consuetudine obsessis diu robigo animorum effricanda est. Ceterum, ut illos in bonum pronos citius educit ad summa, et hos inbecilliores adiuvabit malisque opinionibus extrahet qui illis philosophiae placita tradiderit; quae quam sint necessaria sic licet videas. Quaedam insident nobis quae nos ad alia pigros, ad alia temerarios faciunt; nec haec audacia reprimi potest nec illa inertia suscitari
nisi causae eorum eximuntur, falsa admiratio et falsa formido. Haec nos quamdiu possident, dicas licet «hoc patri praestare debes, hoc liberis, hoc amicis, hoc hospitibus»: temptantem avaritia retinebit. Sciet pro patria pugnandum esse, dissuadebit timor; sciet pro amicis desudandum esse ad extremum usque sudorem, sed deliciae vetabunt; sciet in uxore gravissimum esse genus iniuriae paelicem, sed illum libido in contraria inpinget. Nihil ergo proderit dare praecepta nisi prius amoveris obstatura praeceptis, non magis quam proderit arma in conspectu posuisse propiusque admovisse nisi usurae manus expediuntur. Ut ad praecepta quae damus possit animus ire, solvendus est. Putemus aliquem facere quod oportet: non faciet adsidue, non faciet aequaliter; nesciet enim quare faciat. Aliqua vel casu vel exercitatione exibunt recta, sed non erit in manu regula ad quam exigantur, cui credat recta esse quae fecit. Non promittet se talem in perpetuum qui bonus casu est. Deinde praestabunt tibi fortasse praecepta ut quod oportet faciat, non praestabunt ut quemadmodum oportet; si hoc non praestant, ad virtutem non perducunt. Faciet quod oportet monitus, concedo; sed id parum est, quoniam quidem non in facto laus est sed in eo quemadmodum fiat. Quid est cena sumptuosa flagitiosius et equestrem censum consumente? Quid tam dignum censoria nota, si quis, ut isti ganeones loquuntur, sibi hoc et genio suo praestet? Et deciens tamen sestertio aditiales cenae frugalissimis viris constiterunt. Eadem res, si gulae datur, turpis est, si honori, reprensionem effugit; non enim luxuria sed inpensa sollemnis est. Mullum ingentis formae – quare autem non pondus adicio et aliquorum gulam inrito? Quattuor pondo et selibram fuisse aiebant – Tiberius Caesar missum sibi cum in macellum deferri et venire iussisset, «amici», inquit «omnia me fallunt nisi istum mullum aut Apicius emerit aut P. Octavius». Ultra spem illi coniectura processit: liciti sunt, vicit Octavius et ingentem consecutus est inter suos gloriam, cum quinque sestertiis emisset piscem quem Caesar vendiderat, ne Apicius quidem emerat. Numerare tantum Octavio fuit turpe, non illi qui emerat ut Tiberio mitteret, quamquam illum quoque reprenderim: admiratus est rem qua putavit Caesarem dignum. Amico aliquis aegro adsidet: probamus. At hoc hereditatis causa facit: vultur est, cadaver expectat. Eadem aut turpia sunt aut honesta: refert quare aut quemadmodum fiant. Omnia autem honeste fient si honesto nos addixerimus idque unum in rebus humanis bonum iudicarimus quaeque ex eo sunt; cetera in diem bona sunt. Ergo infigi debet persuasio ad totam pertinens vitam: hoc est quod decretum voco. Qualis haec persuasio fuerit, talia erunt quae agentur, quae cogitabuntur; qualia autem haec fuerint, talis vita erit. In particulas suasisse totum ordinanti parum est. M. Brutus in eo libro quem peri; kaqhvkonto" inscripsit dat multa praecepta et parentibus et liberis et fratribus: haec nemo faciet quemadmodum debet nisi habuerit quo referat. Proponamus oportet finem summi boni ad quem nitamur, ad quem omne factum nostrum dictumque respiciat; veluti navigantibus ad aliquod sidus derigendus est cursus. Vita sine proposito vaga est; quod si utique proponendum est, incipiunt necessaria esse decreta. Illud, ut puto, concedes, nihil esse turpius dubio et incerto ac timide pedem referente. Hoc in
omnibus rebus accidet nobis nisi eximuntur quae reprendunt animos et detinent et ire conarique totos vetant. Quomodo sint dii colendi solet praecipi. Accendere aliquem lucernas sabbatis prohibeamus, quoniam nec lumine dii egent et ne homines quidem delectantur fuligine. Vetemus salutationibus matutinis fungi et foribus adsidere templorum: humana ambitio istis officiis capitur, deum colit qui novit. Vetemus lintea et strigiles Iovi ferre et speculum tenere Iunoni: non quaerit ministros deus. Quidni? Ipse humano generi ministrat, ubique et omnibus praesto est. Audiat licet quem modum servare in sacrificiis debeat, quam procul resilire a molestis superstitionibus, numquam satis profectum erit nisi qualem debet deum mente conceperit, omnia habentem, omnia tribuentem, beneficum gratis. Quae causa est dis bene faciendi? Natura. Errat si quis illos putat nocere nolle: non possunt. Nec accipere iniuriam queunt nec facere; laedere etenim laedique coniunctum est. Summa illa ac pulcherrima omnium natura quos periculo exemit ne periculosos quidem fecit. Primus est deorum cultus deos credere; deinde reddere illis maiestatem suam, reddere bonitatem sine qua nulla maiestas est; scire illos esse qui praesident mundo, qui universa vi sua temperant, qui humani generis tutelam gerunt interdum incuriosi singulorum. Hi nec dant malum nec habent; ceterum castigant quosdam et coercent et inrogant poenas et aliquando specie boni puniunt. Vis deos propitiare? Bonus esto. Satis illos coluit quisquis imitatus est. Ecce altera quaestio, quomodo hominibus sit utendum. Quid agimus? Quae damus praecepta? Ut parcamus sanguini humano? Quantulum est ei non nocere cui debeas prodesse! Magna scilicet laus est si homo mansuetus homini est. Praecipiemus ut naufrago manum porrigat, erranti viam monstret, cum esuriente panem suum dividat? Quare omnia quae praestanda ac vitanda sunt dicam? Cum possim breviter hanc illi formulam humani offici tradere: omne hoc quod vides, quo divina atque humana conclusa sunt, unum est; membra sumus corporis magni. Natura nos cognatos edidit, cum ex isdem et in eadem gigneret; haec nobis amorem indidit mutuum et sociabiles fecit. Illa aequum iustumque composuit; ex illius constitutione miserius est nocere quam laedi; ex illius imperio paratae sint iuvandis manus. Ille versus et in pectore et in ore sit: homo sum, humani nihil a me alienum puto. Habeamus in commune: in commune nati sumus. Societas nostra lapidum fornicationi simillima est, quae, casura nisi in vicem obstarent, hoc ipso sustinetur. Post deos hominesque dispiciamus quomodo rebus sit utendum. In supervacuum praecepta iactabimus nisi illud praecesserit, qualem de quacumque re habere debeamus opinionem, de paupertate, de divitiis, de gloria, de ignominia, de patria, de exilio. Aestimemus singula fama remota et quaeramus quid sint, non quid vocentur. Ad virtutes transeamus. Praecipiet aliquis ut prudentiam magni aestimemus,
ut fortitudinem conplectamur, iustitiam, si fieri potest, propius etiam quam ceteras nobis adplicemus; sed nil aget si ignoramus quid sit virtus, una sit an plures, separatae an innexae, an qui unam habet et ceteras habeat, quo inter se differant. Non est necesse fabro de fabrica quaerere quod eius initium, quis usus sit, non magis quam pantomimo de arte saltandi: omnes istae artes se sciunt, nihil deest; non enim ad totam pertinent vitam. Virtus et aliorum scientia est et sui; discendum de ipsa est ut ipsa discatur. Actio recta non erit nisi recta fuerit voluntas; ab hac enim est actio. Rursus voluntas non erit recta nisi habitus animi rectus fuerit; ab hoc enim est voluntas. Habitus porro animi non erit in optimo nisi totius vitae leges perceperit et quid de quoque iudicandum sit exegerit, nisi res ad verum redegerit. Non contingit tranquillitas nisi inmutabile certumque iudicium adeptis: ceteri decidunt subinde et reponuntur et inter missa adpetitaque alternis fluctuantur. Causa his quae iactationis est? Quod nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama. Si vis eadem semper velle, vera oportet velis. Ad verum sine decretis non pervenitur: continent vitam. Bona et mala, honesta et turpia, iusta et iniusta, pia et impia, virtutes ususque virtutum, rerum commodarum possessio, existimatio ac dignitas, valetudo, vires, forma, sagacitas sensuum – haec omnia aestimatorem desiderant. Scire liceat quanti quidque in censum deferendum sit. Falleris enim et pluris quaedam quam sunt putas, adeoque falleris ut quae maxima inter nos habentur – divitiae, gratia, potentia – sestertio nummo aestimanda sint. Hoc nescies nisi constitutionem ipsam qua ista inter se aestimantur inspexeris. Quemadmodum folia per se virere non possunt, ramum desiderant cui inhaereant, ex quo trahant sucum, sic ista praecepta, si sola sunt, marcent; infigi volunt sectae. Praeterea non intellegunt hi qui decreta tollunt eo ipso confirmari illa quo tolluntur. Quid enim dicunt? Praeceptis vitam satis explicari, supervacua esse decreta sapientiae. Atqui hoc ipsum quod dicunt decretum est tam mehercules quam si nunc ego dicerem recedendum a praeceptis velut supervacuis, utendum esse decretis, in haec sola studium conferendum; hoc ipso quo negarem curanda esse praecepta praeciperem. Quaedam admonitionem in philosophia desiderant, quaedam probationem et quidem multam, quia involuta sunt vixque summa diligentia ac summa subtilitate aperiuntur. Si probationes necessariae sunt, necessaria sunt et decreta quae veritatem argumentis colligunt. Quaedam aperta sunt, quaedam obscura: aperta quae sensu conprehenduntur, quae memoria; obscura quae extra haec sunt. Ratio autem non impletur manifestis: maior eius pars pulchriorque in occultis est. Occulta probationem exigunt, probatio non sine decretis est; necessaria ergo decreta sunt. Quae res communem sensum facit, eadem perfectum, certa rerum persuasio; sine qua si omnia in animo natant, necessaria sunt decreta quae dant animis inflexibile iudicium. Denique cum monemus aliquem ut amicum eodem habeat loco quo se, ut ex inimico cogitet fieri posse amicum, in illo amorem incitet, in hoc odium moderetur, adicimus «iustum est, honestum». Iustum autem honestumque decretorum nostrorum continet ratio; ergo haec necessaria est, sine qua nec illa sunt. Sed utrumque
iungamus; namque et sine radice inutiles rami sunt et ipsae radices iis quae genuere adiuvantur. Quantum utilitatis manus habeant nescire nulli licet, aperte iuvant: cor illud, quo manus vivunt, ex quo impetum sumunt, quo moventur, latet. Idem dicere de praeceptis possum: aperta sunt, decreta vero sapientiae in abdito. Sicut sanctiora sacrorum tantum initiati sciunt, ita in philosophia arcana illa admissis receptisque in sacra ostenduntur; at praecepta et alia eiusmodi profanis quoque nota sunt. Posidonius non tantum praeceptionem (nihil enim nos hoc verbo uti prohibet) sed etiam suasionem et consolationem et exhortationem necessariam iudicat; his adicit causarum inquisitionem, aetiologian quam quare nos dicere non audeamus, cum grammatici, custodes Latini sermonis, suo iure ita appellent, non video. Ait utilem futuram et descriptionem cuiusque virtutis; hanc Posidonius «ethologian» vocat, quidam «characterismon» appellant, signa cuiusque virtutis ac vitii et notas reddentem, quibus inter se similia discriminentur. Haec res eandem vim habet quam praecipere; nam qui praecipit dicit «illa facies si voles temperans esse», qui describit ait «temperans est qui illa facit, qui illis abstinet». Quaeris quid intersit? Alter praecepta virtutis dat, alter exemplar. Descriptiones has et, ut publicanorum utar verbo, iconismos ex usu esse confiteor: proponamus laudanda, invenietur imitator. Putas utile dari tibi argumenta per quae intellegas nobilem equum, ne fallaris empturus, ne operam perdas in ignavo? Quanto hoc utilius est excellentis animi notas nosse, quas ex alio in se transferre permittitur. Continuo pecoris generosi pullus in arvis altius ingreditur et mollia crura reponit; primus et ire viam et fluvios temptare minantis audet et ignoto sese committere ponti, nec vanos horret strepitus. Illi ardua cervix argutumque caput, brevis alvus obesaque terga, luxuriatque toris animosum pectus … … Tum, si qua sonum procul arma dederunt, stare loco nescit, micat auribus et tremit artus, conlectumque premens volvit sub naribus ignem. Dum aliud agit, Vergilius noster descripsit virum fortem: ego certe non aliam imaginem magno viro dederim. Si mihi M. Cato exprimendus sit inter fragores bellorum civilium inpavidus et primus incessens admotos iam exercitus Alpibus civilique se bello ferens obvium, non alium illi adsignaverim vultum, non alium habitum. Altius certe nemo ingredi potuit quam qui simul contra Caesarem Pompeiumque se sustulit et aliis Caesareanas opes, aliis Pompeianas foventibus utrumque provocavit ostenditque aliquas esse et rei publicae partes. Nam parum est in Catone dicere «nec vanos horret strepitus». Quidni? Cum veros vicinosque non horreat, cum contra decem legiones et Gallica auxilia et mixta barbarica
arma civilibus vocem liberam mittat et rem publicam hortetur ne pro libertate decidat, sed omnia experiatur, honestius in servitutem casura quam itura. Quantum in illo vigoris ac spiritus, quantum in publica trepidatione fiduciaest! Scit se unum esse de cuius statu non agatur; non enim quaeri an liber Cato, sed an inter liberos sit: inde periculorum gladiorumque contemptus. Libet admirantem invictam constantiam viri inter publicas ruinas non labantis dicere «luxuriatque toris animosum pectus». Proderit non tantum quales esse soleant boni viri dicere formamque eorum et liniamenta deducere sed quales fuerint narrare et exponere, Catonis illud ultimum ac fortissimum vulnus per quod libertas emisit animam, Laeli sapientiam et cum suo Scipione concordiam, alterius Catonis domi forisque egregia facta, Tuberonis ligneos lectos, cum in publicum sterneret, haedinasque pro stragulis pelles et ante ipsius Iovis cellam adposita conviviis vasa fictilia. Quid aliud paupertatem in Capitolio consecrare? Ut nullum aliud factum eius habeam quo illum Catonibus inseram, hoc parum credimus? Censura fuit illa, non cena. O quam ignorant homines cupidi gloriae quid illa sit aut quemadmodum petenda! Illo die populus Romanus multorum supellectilem spectavit, unius miratus est. Omnium illorum aurum argentumque fractum est et milliens conflatum, at omnibus saeculis Tuberonis fictilia durabunt. Vale.
Liber sextus decimus 96. Tamen tu indignaris aliquid aut quereris et non intellegis nihil esse in istis mali nisi hoc unum quod indignaris et quereris? Si me interrogas, nihil puto viro miserum nisi aliquid esse in rerum natura quod putet miserum. Non feram me quo die aliquid ferre non potero. Male valeo: pars fati est. Familia decubuit, fenus offendit, domus crepuit, damna, vulnera, labores, metus incucurrerunt: solet fieri. Hoc parum est: debuit fieri. Decernuntur ista, non accidunt. Si quid credis mihi, intimos adfectus meos tibi cum maxime detego: in omnibus quae adversa videntur et dura sic formatus sum: non pareo deo sed adsentior; ex animo illum, non quia necesse est, sequor. Nihil umquam mihi incidet quod tristis excipiam, quod malo vultu; nullum tributum invitus conferam. Omnia autem ad quae gemimus, quae expavescimus, tributa vitae sunt: horum, mi Lucili, nec speraveris immunitatem nec petieris. Vesicae te dolor inquietavit, epistulae venerunt parum dulces, detrimenta continua – propius accedam, de capite timuisti. Quid, tu nesciebas haec te optare cum optares senectutem? Omnia ista in longa vita sunt, quomodo in longa via et pulvis et lutum et pluvia. «Sed volebam vivere, carere tamen incommodis omnibus». Tam effeminata vox virum dedecet. Videris quemadmodum hoc votum meum excipias; ego illud magno animo, non tantum bono facio: neque di neque deae faciant ut te fortuna in delicis habeat. Ipse te interroga, si quis potestatem tibi deus faciat, utrum velis vivere in macello an in castris. Atqui vivere, Lucili, militare est. Itaque hi qui iactantur et per operosa atque ardua sursum ac deorsum eunt et expeditiones periculosissimas obeunt fortes viri sunt primoresque castrorum; isti quos putida quies aliis laborantibus molliter habet turturillae sunt, tuti contumeliae causa. Vale. 97. Erras, mi Lucili, si existimas nostri saeculi esse vitium luxuriam et neglegentiam boni moris et alia quae obiecit suis quisque temporibus: hominum sunt ista, non temporum. Nulla aetas vacavit a culpa; et si aestimare licentiam cuiusque saeculi incipias, pudet dicere, numquam apertius quam coram Catone peccatum est. Credat aliquis pecuniam esse versatam in eo iudicio in quo reus erat P. Clodius ob id adulterium quod cum Caesaris uxore in operto commiserat, violatis religionibus eius sacrificii quod «pro populo» fieri dicitur, sic summotis extra consaeptum omnibus viris ut picturae quoque masculorum animalium contegantur? Atqui dati iudicibus nummi sunt et, quod hac etiamnunc pactione turpius est, stupra insuper matronarum et adulescentulorum nobilium stilari loco exacta sunt. Minus crimine quam absolutione peccatum est: adulterii reus adulteria divisit nec ante fuit de salute securus quam similes sui iudices suos reddidit. Haec in eo iudicio facta sunt in quo, si nihil aliud, Cato testimonium dixerat. Ipsa ponam verba Ciceronis, quia res fidem excedit. «Accersivit ad se, promisit, intercessit, dedit. Iam vero (o di boni, rem perditam!) etiam noctes certarum mulierum atque adulescentulorum nobilium introductiones nonnullis iudicibus pro mercedis cumulo fuerunt». Non vacat de pretio queri, plus in
accessionibus fuit. «Vis severi illius uxorem? Dabo illam. Vis divitis huius? Tibi praestabo concubitum. Adulterium nisi feceris, damna. Illa formonsa quam desideras veniet. Illius tibi noctem promitto nec differo; intra comperendinationem fides promissi mei extabit». Plus est distribuere adulteria quam facere; hoc vero matribus familiae denuntiare est. Hi iudices Clodiani a senatu petierant praesidium, quod non erat nisi damnaturis necessarium, et inpetraverant; itaque eleganter illis Catulus absoluto reo «quid vos» inquit «praesidium a nobis petebatis? An ne nummi vobis eriperentur?». Inter hos tamen iocos inpune tulit ante iudicium adulter, in iudicio leno, qui damnationem peius effugit quam meruit. Quicquam fuisse corruptius illis moribus credis quibus libido non sacris inhiberi, non iudicis poterat, quibus in ea ipsa quaestione quae extra ordinem senatusconsulto exercebatur plus quam quaerebatur admissum est? Quaerebatur an post adulterium aliquis posset tutus esse: apparuit sine adulterio tutum esse non posse. Hoc inter Pompeium et Caesarem, inter Ciceronem Catonemque commissum est, Catonem inquam illum quo sedente populus negatur permisisse sibi postulare Florales iocos nudandarum meretricum, si credis spectasse tunc severius homines quam iudicasse. Et fient et facta sunt ista, et licentia urbium aliquando disciplina metuque, numquam sponte considet. Non est itaque quod credas nos plurimum libidini permisisse, legibus minimum; longe enim frugalior haec iuventus est quam illa, cum reus adulterium apud iudices negaret, iudices apud reum confiterentur, cum stuprum committeretur rei iudicandae causa, cum Clodius, isdem vitiis gratiosus quibus nocens, conciliaturas exerceret in ipsa causae dictione. Credat hoc quisquam? Qui damnabatur uno adulterio absolutus est multis. Omne tempus Clodios, non omne Catones feret. Ad deteriora faciles sumus, quia nec dux potest nec comes deesse, et res ipsa etiam sine duce, sine comite procedit. Non pronum est tantum ad vitia sed praeceps, et, quod plerosque inemendabiles facit, omnium aliarum artium peccata artificibus pudori sunt offenduntque deerrantem, vitae peccata delectant. Non gaudet navigio gubernator everso, non gaudet aegro medicus elato, non gaudet orator si patroni culpa reus cecidit, at contra omnibus crimen suum voluptati est: laetatur ille adulterio in quod inritatus est ipsa difficultate; laetatur ille circumscriptione furtoque, nec ante illi culpa quam culpae fortuna displicuit. Id prava consuetudine evenit. Alioquin, ut scias subesse animis etiam in pessima abductis boni sensum nec ignorari turpe sed neglegi, omnes peccata dissimulant et, quamvis feliciter cesserint, fructu illorum utuntur, ipsa subducunt. At bona conscientia prodire vult et conspici: ipsas nequitia tenebras timet. Eleganter itaque ab Epicuro dictum puto: «potest nocenti contingere ut lateat, latendi fides non potest», aut si hoc modo melius hunc explicari posse iudicas sensum: «ideo non prodest latere peccantibus quia latendi etiam si felicitatem habent, fiduciam non habent». Ita est, tuta scelera esse possunt, secura esse non possunt. Hoc ego repugnare sectae nostrae si sic expediatur non iudico. Quare? Quia prima illa et maxima
peccantium est poena peccasse, nec ullum scelus, licet illud fortuna exornet muneribus suis, licet tueatur ac vindicet, inpunitum est, quoniam sceleris in scelere supplicium est. Sed nihilominus et hae illam secundae poenae premunt ac sequuntur, timere semper et expavescere et securitati diffidere. Quare ego hoc supplicio nequitiam liberem? Quare non semper illam in suspenso relinquam? Illic dissentiamus cum Epicuro ubi dicit nihil iustum esse natura et crimina vitanda esse quia vitari metus non posse: hic consentiamus, mala facinora conscientia flagellari et plurimum illi tormentorum esse eo quod perpetua illam sollicitudo urget ac verberat, quod sponsoribus securitatis suae non potest credere. Hoc enim ipsum argumentum est, Epicure, natura nos a scelere abhorrere, quod nulli non etiam inter tuta timor est. Multos fortuna liberat poena, metu neminem. Quare nisi quia infixa nobis eius rei aversatio est quam natura damnavit? Ideo numquam fides latendi fit etiam latentibus quia coarguit illos conscientia et ipsos sibi ostendit. Proprium autem est nocentium trepidare. Male de nobis actum erat, quod multa scelera legem et vindicem effugiunt et scripta supplicia, nisi illa naturalia et gravia de praesentibus solverent et in locum patientiae timor cederet. Vale. 98. Numquam credideris felicem quemquam ex felicitate suspensum. Fragilibus innititur qui adventicio laetus est: exibit gaudium quod intravit. At illud ex se ortum fidele firmumque est et crescit et ad extremum usque prosequitur: cetera quorum admiratio est vulgo in diem bona sunt. «Quid ergo? Non usui ac voluptati esse possunt?». Quis negat? Sed ita si illa ex nobis pendent, non ex illis nos. Omnia quae fortuna intuetur ita fructifera ac iucunda fiunt si qui habet illa se quoque habet nec in rerum suarum potestate est. Errant enim, Lucili, qui aut boni aliquid nobis aut mali iudicant tribuere fortunam: materiam dat bonorum ac malorum et initia rerum apud nos in malum bonumve exiturarum. Valentior enim omni fortuna animus est et in utramque partem ipse res suas ducit beataeque ac miserae vitae sibi causa est. Malus omnia in malum vertit, etiam quae cum specie optimi venerant: rectus atque integer corrigit prava fortunae et dura atque aspera ferendi scientia mollit, idemque et secunda grate excipit modesteque et adversa constanter ac fortiter. Qui licet prudens sit, licet exacto faciat cuncta iudicio, licet nihil supra vires suas temptet, non continget illi bonum illud integrum et extra minas positum nisi certus adversus incerta est. Sive alios observare volueris (liberius enim inter aliena iudicium est) sive te ipsum favore seposito, et senties hoc et confiteberis, nihil ex his optabilibus et caris utile esse nisi te contra levitatem casus rerumque casum sequentium instruxeris, nisi illud frequenter et sine querella inter singula damna dixeris: dis aliter visum est. Immo mehercules, ut carmen fortius ac iustius petam quo animum tuum magis fulcias, hoc dicito quotiens aliquid aliter quam cogitabas evenerit: «di melius».
Sic composito nihil accidet. Sic autem componetur si quid humanarum rerum varietas possit cogitaverit antequam senserit, si et liberos et coniugem et patrimonium sic habuerit tamquam non utique semper habiturus et tamquam non futurus ob hoc miserior si habere desierit. Calamitosus est animus futuri anxius et ante miserias miser, qui sollicitus est ut ea quibus delectatur ad extremum usque permaneant; nullo enim tempore conquiescet et expectatione venturi praesentia, quibus frui poterat, amittet. In aequo est autem amissae rei dolor et timor amittendae. Nec ideo praecipio tibi neglegentiam. Tu vero metuenda declina; quidquid consilio prospici potest prospice; quodcumque laesurum est multo ante quam accidat speculare et averte. In hoc ipsum tibi plurimum conferet fiducia et ad tolerandum omne obfirmata mens. Potest fortunam cavere qui potest ferre; certe in tranquillo non tumultuatur. Nihil est nec miserius nec stultius quam praetimere: quae ista dementia est malum suum antecedere? Denique, ut breviter includam quod sentio et istos satagios ac sibi molestos describam tibi, tam intemperantes in ipsis miseriis sunt quam ante illas. Plus dolet quam necesse est qui ante dolet quam necesse est; eadem enim infirmitate dolorem non aestimat qua non expectat; eadem intemperantia fingit sibi perpetuam felicitatem suam, fingit crescere debere quaecumque contigerunt, non tantum durare, et oblitus huius petauri quo humana iactantur sibi uni fortuitorum constantiam spondet. Egregie itaque videtur mihi Metrodorus dixisse in ea epistula qua sororem amisso optimae indolis filio adloquitur: «mortale est omne mortalium bonum». De his loquitur bonis ad quae concurritur; nam illud verum bonum non moritur, certum est sempiternumque, sapientia et virtus; hoc unum contingit inmortale mortalibus. Ceterum tam inprobi sunt tamque obliti quo eant, quo illos singuli dies trudant, ut mirentur aliquid ipsos amittere, amissuri uno die omnia. Quidquid est cui dominus inscriberis apud te est, tuum non est; nihil firmum infirmo, nihil fragili aeternum et invictum est. Tam necesse est perire quam perdere et hoc ipsum, si intellegimus, solacium est. Aequo animo perde: pereundum est. Quid ergo adversus has amissiones auxili invenimus? Hoc, ut memoria teneamus amissa nec cum ipsis fructum excidere patiamur quem ex illis percepimus. Habere eripitur, habuisse numquam. Peringratus est qui, cum amisit, pro accepto nihil debet. Rem nobis eripit casus, usum fructumque apud nos relinquit, quem nos iniquitate desiderii perdidimus. Dic tibi «ex istis quae terribilia videntur nihil est invictum». Singula vicere iam multi, ignem Mucius, crucem Regulus, venenum Socrates, exilium Rutilius, mortem ferro adactam Cato: et nos vincamus aliquid. Rursus ista quae ut speciosa et felicia trahunt vulgum a multis et saepe contempta sunt. Fabricius divitias imperator reiecit, censor notavit; Tubero paupertatem et se dignam et Capitolio iudicavit, cum fictilibus in publica cena usus ostendit debere iis hominem esse contentum quibus di etiamnunc uterentur. Honores reppulit pater Sextius, qui ita natus ut rem publicam deberet capessere, latum clavum divo Iulio dante non recepit; intellegebat enim quod dari posset et eripi posse. Nos quoque aliquid et ipsi
faciamus animose; simus inter exempla. Quare defecimus? Quare desperamus? Quidquid fieri potuit potest, nos modo purgemus animum sequamurque naturam, a qua aberranti cupiendum timendumque est et fortuitis serviendum. Licet reverti in viam, licet in integrum restitui: restituamur, ut possimus dolores quocumque modo corpus invaserint perferre et fortunae dicere «cum viro tibi negotium est: quaere quem vincas». * * * His sermonibus et his similibus lenitur illa vis ulceris, quam opto mehercules mitigari et aut sanari aut stare et cum ipso senescere. Sed securus de illo sum: de nostro damno agitur, quibus senex egregius eripitur. Nam ipse vitae plenus est, cui adici nihil desiderat sua causa sed eorum quibus utilis est. Liberaliter facit quod vivit. Alius iam hos cruciatus finisset: hic tam turpe putat mortem fugere quam ad mortem confugere. «Quid ergo? Non si suadebit res exibit?». Quidni exeat, si nemo iam uti eo poterit, si nihil aliud quam dolori operam dabit? Hoc est, mi Lucili, philosophiam in opere discere et ad verum exerceri, videre quid homo prudens animi habeat contra mortem, contra dolorem, cum illa accedat, hic premat; quid faciendum sit a faciente discendum est. Adhuc argumentis actum est an posset aliqui dolori resistere, an mors magnos quoque animos admota summittere. Quid opus est verbis? In rem praesentem eamus: nec mors illum contra dolorem facit fortiorem nec dolor contra mortem. Contra utrumque sibi fidit nec spe mortis patienter dolet nec taedio doloris libenter moritur: hunc fert, illam expectat. Vale. 99. Epistulam quam scripsi Marullo cum filium parvulum amisisset et diceretur molliter ferre misi tibi, in qua non sum solitum morem secutus nec putavi leniter illum debere tractari, cum obiurgatione esset quam solacio dignior. Adflicto enim et magnum vulnus male ferenti paulisper cedendum est; exsatiet se aut certe primum impetum effundat: hi qui sibi lugere sumpserunt protinus castigentur et discant quasdam etiam lacrimarum ineptias esse. Solacia expectas? Convicia accipe. Tam molliter tu fers mortem filii? Quid faceres si amicum perdidisses? Decessit filius incertae spei, parvulus; pusillum temporis perit. Causas doloris conquirimus et de fortuna etiam inique queri volumus, quasi non sit iustas querendi causas praebitura: at mehercules satis mihi iam videbaris animi habere etiam adversus solida mala, nedum ad istas umbras malorum quibus ingemescunt homines moris causa. Quod damnorum omnium maximum est, si amicum perdidisses, danda opera erat ut magis gauderes quod habueras quam maereres quod amiseras. Sed plerique non conputant quanta perceperint, quantum gavisi sint. Hoc habet inter reliqua mali dolor iste: non supervacuus tantum sed ingratus est. Ergo quod habuisti talem amicum, perit opera? Tot annis, tanta coniunctione vitae, tam familiari studiorum societate nil actum est? Cum amico effers amicitiam? Et quid doles amisisse, si habuisse non prodest? Mihi crede, magna pars ex iis quos amavimus, licet ipsos casus abstulerit, apud nos manet; nostrum est quod praeterit tempus nec quicquam est loco tutiore quam quod fuit. Ingrati adversus percepta spe futuri sumus, quasi non
quod futurum est, si modo successerit nobis, cito in praeterita transiturum sit. Anguste fructus rerum determinat qui tantum praesentibus laetus est: et futura et praeterita delectant, haec expectatione, illa memoria, sed alterum pendet et non fieri potest, alterum non potest non fuisse. Quis ergo furor est certissimo excidere? Adquiescamus iis quae iam hausimus, si modo non perforato animo hauriebamus et transmittente quidquid acceperat. Innumerabilia sunt exempla eorum qui liberos iuvenes sine lacrimis extulerint, qui in senatum aut in aliquod publicum officium a rogo redierint et statim aliud egerint. Nec inmerito; nam primum supervacuum est dolere si nihil dolendo proficias; deinde iniquum est queri de eo quod uni accidit, omnibus restat; deinde desiderii stulta conquestio est, ubi minimum interest inter amissum et desiderantem. Eo itaque aequiore animo esse debemus quod quos amisimus sequimur. Respice celeritatem rapidissimi temporis, cogita brevitatem huius spatii per quod citatissimi currimus, observa hunc comitatum generis humani eodem tendentis, minimis intervallis distinctum etiam ubi maxima videntur: quem putas perisse praemissus est. Quid autem dementius quam, cum idem tibi iter emetiendum sit, flere eum qui antecessit? Flet aliquis factum quod non ignoravit futurum? Aut si mortem in homine non cogitavit, sibi inposuit. Flet aliquis factum quod aiebat non posse non fieri? Quisquis aliquem queritur mortuum esse, queritur hominem fuisse. Omnis eadem condicio devinxit: cui nasci contigit mori restat. Intervallis distinguimur, exitu aequamur. Hoc quod inter primum diem et ultimum iacet varium incertumque est: si molestias aestimes, etiam puero longum, si velocitatem, etiam seni angustum. Nihil non lubricum et fallax et omni tempestate mobilius; iactantur cuncta et in contrarium transeunt iubente fortuna, et in tanta volutatione rerum humanarum nihil cuiquam nisi mors certum est; tamen de eo queruntur omnes in quo uno nemo decipitur. «Sed puer decessit». Nondum dico melius agi cum eo qui cito vita defungitur: ad eum transeamus qui consenuit: quantulo vincit infantem! Propone temporis profundi vastitatem et universum conplectere, deinde hoc quod aetatem vocamus humanam compara immenso: videbis quam exiguum sit quod optamus, quod extendimus. Ex hoc quantum lacrimae, quantum sollicitudines occupant? Quantum mors antequam veniat optata, quantum valetudo, quantum timor? Quantum tenent aut rudes aut inutiles anni? Dimidium ex hoc edormitur. Adice labores, luctus, pericula, et intelleges etiam in longissima vita minimum esse quod vivitur. Sed quis tibi concedit non melius se habere eum cui cito reverti licet, cui ante lassitudinem peractum est iter? Vita nec bonum nec malum est: boni ac mali locus est. Ita nihil ille perdidit nisi aleam in damnum certiorem. Potuit evadere modestus et prudens, potuit sub cura tua in meliora formari, sed, quod iustius timetur, potuit fieri pluribus similis. Aspice illos iuvenes quos ex nobilissimis domibus in harenam luxuria proiecit; aspice illos qui suam alienamque libidinem exercent mutuo inpudici, quorum nullus sine ebrietate, nullus sine aliquo insigni flagitio dies exit: plus timeri quam sperari potuisse manifestum erit. Non debes itaque causas doloris accersere nec levia incommoda indignando cumulare. Non
hortor ut nitaris et surgas; non tam male de te iudico ut tibi adversus hoc totam putem virtutem advocandam. Non est dolor iste sed morsus: tu illum dolorem facis. Sine dubio multum philosophia profecit, si puerum nutrici adhuc quam patri notiorem animo forti desideras. Quid? Nunc ego duritiam suadeo et in funere ipso rigere vultum volo et animum ne contrahi quidem patior? Minime. Inhumanitas est ista, non virtus, funera suorum isdem oculis quibus ipsos videre nec commoveri ad primam familiarium divulsionem. Puta autem me vetare: quaedam sunt sui iuris; excidunt etiam retinentibus lacrimae et animum profusae levant. Quid ergo est? Permittamus illis cadere, non imperemus; fluat quantum adfectus eiecerit, non quantum poscet imitatio. Nihil vero maerori adiciamus nec illum ad alienum augeamus exemplum. Plus ostentatio doloris exigit quam dolor: quotus quisque sibi tristis est? Clarius cum audiuntur gemunt, et taciti quietique dum secretum est, cum aliquos videre, in fletus novos excitantur; tunc capiti suo manus ingerunt (quod potuerant facere nullo prohibente liberius), tunc mortem comprecantur sibi, tunc lectulo devolvuntur: sine spectatore cessat dolor. Sequitur nos, ut in aliis rebus, ita in hac quoque hoc vitium, ad plurium exempla componi nec quid oporteat sed quid soleat aspicere. A natura discedimus, populo nos damus nullius rei bono auctori et in hac re sicut in his omnibus inconstantissimo. Videt aliquem fortem in luctu suo, impium vocat et efferatum; videt aliquem conlabentem et corpori adfusum, effeminatum ait et enervem. Omnia itaque ad rationem revocanda sunt. Stultius vero nihil est quam famam captare tristitiae et lacrimas adprobare, quas iudico sapienti viro alias permissas cadere, alias vi sua latas. Dicam quid intersit. Cum primus nos nuntius acerbi funeris perculit, cum tenemus corpus e complexu nostro in ignem transiturum, lacrimas naturalis necessitas exprimit et spiritus ictu doloris inpulsus quemadmodum totum corpus quatit, ita oculos, quibus adiacentem umorem perpremit et expellit. Hae lacrimae per elisionem cadunt nolentibus nobis: aliae sunt quibus exitum damus cum memoria eorum quos amisimus retractatur, et inest quiddam dulce tristitiae cum occurrunt sermones eorum iucundi, conversatio hilaris, officiosa pietas; tunc oculi velut in gaudio relaxantur. His indulgemus, illis vincimur. Non est itaque quod lacrimas propter circumstantem adsidentemque aut contineas aut exprimas: nec cessant nec fluunt umquam tam turpiter quam finguntur: eant sua sponte. Ire autem possunt placidis atque compositis; saepe salva sapientis auctoritate fluxerunt tanto temperamento ut illis nec humanitas nec dignitas deesset. Licet, inquam, naturae obsequi gravitate servata. Vidi ego in funere suorum verendos, in quorum ore amor eminebat remota omni lugentium scaena; nihil erat nisi quod veris dabatur adfectibus. Est aliquis et dolendi decor; hic sapienti servandus est et quemadmodum in ceteris rebus, ita etiam in lacrimis aliquid sat est: inprudentium ut gaudia sic dolores exundavere. Aequo animo excipe necessaria. Quid incredibile, quid novum evenit? Quam multis cum maxime funus locatur, quam multis vitalia emuntur, quam multi post luctum tuum lugent! Quotiens cogitaveris puerum fuisse, cogita et hominem, cui
nihil certi promittitur, quem fortuna non utique perducit ad senectutem: unde visum est dimittit. Ceterum frequenter de illo loquere et memoriam eius quantum potes celebra; quae ad te saepius revertetur si erit sine acerbitate ventura; nemo enim libenter tristi conversatur, nedum tristitiae. Si quos sermones eius, si quos quamvis parvoli iocos cum voluptate audieras, saepius repete; potuisse illum implere spes tuas, quas paterna mente conceperas, audacter adfirma. Oblivisci quidem suorum ac memoriam cum corporibus efferre et effusissime flere, meminisse parcissime, inhumani animi est. Sic aves, sic ferae suos diligunt, quarum concitatus est amor et paene rabidus, sed cum amissis totus extinguitur. Hoc prudentem virum non decet: meminisse perseveret, lugere desinat. Illud nullo modo probo quod ait Metrodorus, esse aliquam cognatam tristitiae voluptatem, hanc esse captandam in eiusmodi tempore. Ipsa Metrodori verba subscripsi. Mhtrodwvrou ejpistolw'n pro;" th;n ajdelfhvn. “Estin gavr ti" hJdonh; luvph/ suggenhv", h}n crh; qhreuvein kata; tou'ton to;n kairovn. De quibus non dubito quid sis sensurus; quid enim est turpius quam captare in ipso luctu voluptatem, immo per luctum, et inter lacrimas quoque quod iuvet quaerere? Hi sunt qui nobis obiciunt nimium rigorem et infamant praecepta nostra duritiae, quod dicamus dolorem aut admittendum in animum non esse aut cito expellendum. Utrum tandem est aut incredibilius aut inhumanius, non sentire amisso amico dolorem an voluptatem in ipso dolore aucupari? Nos quod praecipimus honestum est: cum aliquid lacrimarum adfectus effuderit et, ut ita dicam, despumaverit, non esse tradendum animum dolori. Quid, tu dicis miscendam ipsi dolori voluptatem? Sic consolamur crustulo pueros, sic infantium fletum infuso lacte conpescimus. Ne illo quidem tempore quo filius ardet aut amicus expirat cessare pateris voluptatem, sed ipsum vis titillare maerorem? Utrum honestius dolor ab animo summovetur an voluptas ad dolorem quoque admittitur? «Admittitur» dico? Captatur, et quidem ex ipso. «Est aliqua» inquit «voluptas cognata tristitiae». Istuc nobis licet dicere, vobis quidem non licet. Unum bonum nostis, voluptatem, unum malum, dolorem: quae potest inter bonum et malum esse cognatio? Sed puta esse: nunc potissimum eruitur? Et ipsum dolorem scrutamur, an aliquid habeat iucundum circa se et voluptarium? Quaedam remedia aliis partibus corporis salutaria velut foeda et indecora adhiberi aliis nequeunt, et quod aliubi prodesset sine damno verecundiae, id fit inhonestum loco vulneris: non te pudet luctum voluptate sanare? Severius ista plaga curanda est. Illud potius admone, nullum mali sensum ad eum qui perit pervenire; nam si pervenit, non perit. Nulla, inquam, res eum laedit qui nullus est: vivit si laeditur. Utrum putas illi male esse quod nullus est an quod est adhuc aliquis? Atqui nec ex eo potest ei tormentum esse quod non est (quis enim nullius sensus est?) nec ex eo quod est; effugit enim maximum mortis incommodum, non esse. Illud quoque dicamus ei qui deflet ac desiderat in aetate prima raptum: omnes, quantum ad brevitatem aevi, si universo compares, et iuvenes et senes, in aequo sumus. Minus enim ad nos ex aetate omni venit quam quod minimum esse quis dixerit, quoniam quidem minimum aliqua pars est: hoc quod vivimus
proximum nihilo est; et tamen, o dementiam nostram, late disponitur. Haec tibi scripsi, non tamquam expectaturus esses remedium a me tam serum (liquet enim mihi te locutum tecum quidquid lecturus es) sed ut castigarem exiguam illam moram qua a te recessisti, et in reliquum adhortarer contra fortunam tolleres animos et omnia eius tela non tamquam possent venire sed tamquam utique essent ventura prospiceres. Vale. 100. Fabiani Papiri libros qui inscribuntur civilium legisse te cupidissime scribis, et non respondisse expectationi tuae; deinde oblitus de philosopho agi compositionem eius accusas. Puta esse quod dicis et effundi verba, non figi. Primum habet ista res suam gratiam et est decor proprius orationis leniter lapsae; multum enim interesse existimo utrum exciderit an fluxerit. Adice nunc quod in hoc quoque quod dicturus sum ingens differentia est: Fabianus mihi non effundere videtur orationem sed fundere; adeo larga est et sine perturbatione, non sine cursu tamen veniens. Illud plane fatetur et praefert, non esse tractatam nec diu tortam. Sed ita, ut vis, esse credamus: mores ille, non verba composuit et animis scripsit ista, non auribus. Praeterea ipso dicente non vacasset tibi partes intueri, adeo te summa rapuisset; et fere quae impetu placent minus praestant ad manum relata; sed illud quoque multum est, primo aspectu oculos occupasse, etiam si contemplatio diligens inventura est quod arguat. Si me interrogas, maior ille est qui iudicium abstulit quam qui meruit; et scio hunc tutiorem esse, scio audacius sibi de futuro promittere. Oratio sollicita philosophum non decet: ubi tandem erit fortis et constans, ubi periculum sui faciet qui timet verbis? Fabianus non erat neglegens in oratione sed securus. Itaque nihil invenies sordidum: electa verba sunt, non captata, nec huius saeculi more contra naturam suam posita et inversa, splendida tamen quamvis sumantur e medio. Sensus honestos et magnificos habes, non coactos in sententiam sed latius dictos. Videbimus quid parum recisum sit, quid parum structum, quid non huius recentis politurae: cum circumspexeris omnia, nullas videbis angustias inanis. Desit sane varietas marmorum et concisura aquarum cubiculis interfluentium et pauperis cella et quidquid aliud luxuria non contenta decore simplici miscet: quod dici solet, domus recta est. Adice nunc quod de compositione non constat: quidam illam volunt esse ex horrido comptam, quidam usque eo aspera gaudent ut etiam quae mollius casus explicuit ex industria dissipent et clausulas abrumpant ne ad expectatum respondeant. Lege Ciceronem: compositio eius una est, pedem curvat lenta et sine infamia mollis. At contra Pollionis Asinii salebrosa et exiliens et ubi minime expectes relictura. Denique omnia apud Ciceronem desinunt, apud Pollionem cadunt, exceptis paucissimis quae ad certum modum et ad unum exemplar adstricta sunt. Humilia praeterea tibi videri dicis omnia et parum erecta: quo vitio carere eum iudico. Non sunt enim illa humilia sed placida et ad animi tenorem quietum compositumque formata, nec depressa sed plana. Deest illis oratorius vigor
stimulique quos quaeris et subiti ictus sententiarum; sed totum corpus, videris quam sit comptum, honestum est. Non habet oratio eius sed dabit dignitatem. Adfer quem Fabiano possis praeponere. Dic Ciceronem, cuius libri ad philosophiam pertinentes paene totidem sunt quot Fabiani: cedam, sed non statim pusillum est si quid maximo minus est. Dic Asinium Pollionem: cedam, et respondeamus: in re tanta eminere est post duos esse. Nomina adhuc T. Livium; scripsit enim et dialogos, quos non magis philosophiae adnumerare possis quam historiae, et ex professo philosophiam continentis libros: huic quoque dabo locum. Vide tamen quam multos antecedat qui a tribus vincitur et tribus eloquentissimis. Sed non praestat omnia: non est fortis oratio eius, quamvis elata sit; non est violenta nec torrens, quamvis effusa sit; non est perspicua sed pura. «Desideres» inquis «contra vitia aliquid aspere dici, contra pericula animose, contra fortunam superbe, contra ambitionem contumeliose. Volo luxuriam obiurgari, libidinem traduci, inpotentiam frangi. Sit aliquid oratorie acre, tragice grande, comice exile». Vis illum adsidere pusillae rei, verbis: ille rerum se magnitudini addixit, eloquentiam velut umbram non hoc agens trahit. Non erunt sine dubio singula circumspecta nec in se collecta nec omne verbum excitabit ac punget, fateor; exibunt multa nec ferient et interdum otiosa praeterlabetur oratio, sed multum erit in omnibus lucis, sed ingens sine taedio spatium. Denique illud praestabit, ut liqueat tibi illum sensisse quae scripsit. Intelleges hoc actum ut tu scires quid illi placeret, non ut ille placeret tibi. Ad profectum omnia tendunt, ad bonam mentem: non quaeritur plausus. Talia esse scripta eius non dubito, etiam si magis reminiscor quam teneo haeretque mihi color eorum non ex recenti conversatione familiariter sed summatim, ut solet ex vetere notitia; cum audirem certe illum, talia mihi videbantur, non solida sed plena, quae adulescentem indolis bonae attollerent et ad imitationem sui evocarent sine desperatione vincendi, quae mihi adhortatio videtur efficacissima. Deterret enim qui imitandi cupiditatem fecit, spem abstulit. Ceterum verbis abundabat, sine commendatione partium singularum in universum magnificus. Vale.
Liber septimus decimus 101. Omnis dies, omnis hora quam nihil simus ostendit et aliquo argumento recenti admonet fragilitatis oblitos; tum aeterna meditatos respicere cogit ad mortem. Quid sibi istud principium velit quaeris? Senecionem Cornelium, equitem Romanum splendidum et officiosum, noveras: ex tenui principio se ipse promoverat et iam illi declivis erat cursus ad cetera; facilius enim crescit dignitas quam incipit. Pecunia quoque circa paupertatem plurimum morae habet; dum ex illa erepat haeret. Iam Senecio divitis inminebat, ad quas illum duae res ducebant efficacissimae, et quaerendi et custodiendi scientia, quarum vel altera locupletem facere potuisset. Hic homo summae frugalitatis, non minus patrimonii quam corporis diligens, cum me ex consuetudine mane vidisset, cum per totum diem amico graviter adfecto et sine spe iacenti usque in noctem adsedisset, cum hilaris cenasset, genere valetudinis praecipiti arreptus, angina, vix conpressum artatis faucibus spiritum traxit in lucem. Intra paucissimas ergo horas quam omnibus erat sani ac valentis officiis functus decessit. Ille qui et mari et terra pecuniam agitabat, qui ad publica quoque nullum relinquens inexpertum genus quaestus accesserat, in ipso actu bene cedentium rerum, in ipso procurrentis pecuniae impetu raptus est. Insere nunc, Meliboee, piros, pone ordine vites. Quam stultum est aetatem disponere ne crastini quidem dominum! o quanta dementia est spes longas inchoantium: emam, aedificabo, credam, exigam, honores geram, tum deinde lassam et plenam senectutem in otium referam. Omnia, mihi crede, etiam felicibus dubia sunt; nihil sibi quisquam de futuro debet promittere; id quoque quod tenetur per manus exit et ipsam quam premimus horam casus incidit. Volvitur tempus rata quidem lege, sed per obscurum: quid autem ad me an naturae certum sit quod mihi incertum est? Navigationes longas et pererratis litoribus alienis seros in patriam reditus proponimus, militiam et castrensium laborum tarda manipretia, procurationes officiorumque per officia processus, cum interim ad latus mors est, quae quoniam numquam cogitatur nisi aliena, subinde nobis ingeruntur mortalitatis exempla non diutius quam dum miramur haesura. Quid autem stultius quam mirari id ullo die factum quod omni potest fieri? Stat quidem terminus nobis ubi illum inexorabilis fatorum necessitas fixit, sed nemo scit nostrum quam prope versetur a termino; sic itaque formemus animum tamquam ad extrema ventum sit. Nihil differamus; cotidie cum vita paria faciamus. Maximum vitae vitium est quod inperfecta semper est, quod aliquid ex illa differtur. Qui cotidie vitae suae summam manum inposuit non indiget tempore; ex hac autem indigentia timor nascitur et cupiditas futuri exedens animum. Nihil est miserius dubitatione venientium quorsus evadant; quantum sit illud quod restat aut quale sollicita mens inexplicabili formidine agitatur. Quo modo effugiemus hanc volutationem? Uno: si vita nostra non prominebit, si in se
colligitur; ille enim ex futuro suspenditur cui inritum est praesens. Ubi vero quidquid mihi debui redditum est, ubi stabilita mens scit nihil interesse inter diem et saeculum, quidquid deinceps dierum rerumque venturum est ex alto prospicit et cum multo risu seriem temporum cogitat. Quid enim varietas mobilitasque casuum perturbabit, si certus sis adversus incerta? Ideo propera, Lucili mi, vivere, et singulos dies singulas vitas puta. Qui hoc modo se aptavit, cui vita sua cotidie fuit tota, securus est: in spem viventibus proximum quodque tempus elabitur, subitque aviditas et miserrimus ac miserrima omnia efficiens metus mortis. Inde illud Maecenatis turpissimum votum quo et debilitatem non recusat et deformitatem et novissime acutam crucem, dummodo inter haec mala spiritus prorogetur: debilem facito manu, debilem pede coxo, tuber adstrue gibberum, lubricos quate dentes: vita dum superest, benest; hanc mihi, vel acuta si sedeam cruce, sustine. Quod miserrimum erat si incidisset optatur, et tamquam vita petitur supplici mora. Contemptissimum putarem si vivere vellet usque ad crucem: «tu vero» inquit «me debilites licet, dum spiritus in corpore fracto et inutili maneat; depraves licet, dum monstroso et distorto temporis aliquid accedat; suffigas licet et acutam sessuro crucem subdas»: est tanti vulnus suum premere et patibulo pendere districtum, dum differat id quod est in malis optimum, supplici finem? Est tanti habere animam ut agam? Quid huic optes nisi deos faciles? Quid sibi vult ista carminis effeminati turpitudo? Quid timoris dementissimi pactio? Quid tam foeda vitae mendicatio? Huic putes umquam recitasse Vergilium: usque adeone mori miserum est? Optat ultima malorum et quae pati gravissimum est extendi ac sustineri cupit: qua mercede? Scilicet vitae longioris. Quod autem vivere est diu mori? Invenitur aliquis qui velit inter supplicia tabescere et perire membratim et totiens per stilicidia emittere animam quam semel exhalare? Invenitur qui velit adactus ad illud infelix lignum, iam debilis, iam pravus et in foedum scapularum ac pectoris tuber elisus, cui multae moriendi causae etiam citra crucem fuerant, trahere animam tot tormenta tracturam? Nega nunc magnum beneficium esse naturae quod necesse est mori. Multi peiora adhuc pacisci parati sunt: etiam amicum prodere, ut diutius vivant, et liberos ad stuprum manu sua tradere, ut contingat lucem videre tot consciam scelerum. Excutienda vitae cupido est discendumque nihil interesse quando patiaris quod quandoque
patiendum est; quam bene vivas referre, non quam diu; saepe autem in hoc esse bene, ne diu. Vale. 102. Quomodo molestus est iucundum somnium videnti qui excitat (aufert enim voluptatem etiam si falsam, effectum tamen verae habentem) sic epistula tua mihi fecit iniuriam; revocavit enim me cogitationi aptae traditum et iturum, si licuisset, ulterius. Iuvabat de aeternitate animarum quaerere, immo mehercules credere; praebebam enim me facilem opinionibus magnorum virorum rem gratissimam promittentium magis quam probantium. Dabam me spei tantae, iam eram fastidio mihi, iam reliquias aetatis infractae contemnebam in immensum illud tempus et in possessionem omnis aevi transiturus, cum subito experrectus sum epistula tua accepta et tam bellum somnium perdidi. Quod repetam, si te dimisero, et redimam. Negas me epistula prima totam quaestionem explicuisse in qua probare conabar id quod nostris placet, claritatem quae post mortem contingit bonum esse. Id enim me non solvisse quod opponitur nobis: «nullum» inquiunt «bonum ex distantibus; hoc autem ex distantibus constat». Quod interrogas, mi Lucili, eiusdem quaestionis est loci alterius, et ideo non id tantum sed alia quoque eodem pertinentia distuleram; quaedam enim, ut scis, moralibus rationalia inmixta sunt. Itaque illam partem rectam et ad mores pertinentem tractavi, numquid stultum sit ac supervacuum ultra extremum diem curas transmittere, an cadant bona nostra nobiscum nihilque sit eius qui nullus est, an ex eo quod, cum erit, sensuri non sumus, antequam sit aliquis fructus percipi aut peti possit. Haec omnia ad mores spectant; itaque suo loco posita sunt. At quae a dialecticis contra hanc opinionem dicuntur segreganda fuerunt et ideo seposita sunt. Nunc, quia omnia exigis, omnia quae dicunt persequar, deinde singulis occurram. Nisi aliquid praedixero, intellegi non poterunt quae refellentur. Quid est quod praedicere velim? Quaedam continua corpora esse, ut hominem; quaedam esse composita, ut navem, domum, omnia denique quorum diversae partes iunctura in unum coactae sunt; quaedam ex distantibus, quorum adhuc membra separata sunt, tamquam exercitus, populus, senatus. Illi enim per quos ista corpora efficiuntur iure aut officio cohaerent, natura diducti et singuli sunt. Quid est quod etiamnunc praedicere velim? Nullum bonum putamus esse quod ex distantibus constat; uno enim spiritu unum bonum contineri ac regi debet, unum esse unius boni principale. Hoc si quando desideraveris per se probatur: interim ponendum fuit, quia in nos nostra tela mittuntur. «Dicitis» inquit «nullum bonum ex distantibus esse; claritas autem ista bonorum virorum secunda opinio est. Nam quomodo fama non est unius sermo nec infamia unius mala existimatio, sic nec claritas uni bono placuisse; consentire in hoc plures insignes et spectabiles viri debent, ut claritas sit. Haec autem ex iudiciis plurium efficitur, id est distantium; ergo non est bonum. «Claritas» inquit «laus est a bonis bono reddita; laus oratio, vox est aliquid significans; vox est autem, licet virorum sit ‹bonorum, non bonum. Nec enim
quidquid vir bonus facit bonum est; nam et plaudit et sibilat, sed nec plausum quisquam nec sibilum, licet omnia eius admiretur et laudet, bonum dicit, non magis quam sternumentum aut tussim. Ergo claritas bonum non est. «Ad summam dicite nobis utrum laudantis an laudati bonum sit: si laudati bonum esse dicitis, tam ridiculam rem facitis quam si adfirmetis meum esse quod alius bene valeat. Sed laudare dignos honesta actio est; ita laudantis bonum est cuius actio est, non nostrum qui laudamur: atqui hoc quaerebatur». Respondebo nunc singulis cursim. Primum an sit aliquod ex distantibus bonum etiamnunc quaeritur et pars utraque sententias habet. Deinde claritas desiderat multa suffragia? Potest et unius boni viri iudicio esse contenta: nos bonus bonos iudicat. «Quid ergo?» inquit «et fama erit unius hominis existimatio et infamia unius malignus sermo? Gloriam quoque» inquit «latius fusam intellego; consensum enim multorum exigit». Diversa horum condicio est et illius. Quare? Quia si de me bene vir bonus sentit, eodem loco sum quo si omnes boni idem sentirent; omnes enim, si me cognoverint, idem sentient. Par illis idemque iudicium est, aeque vero inficiscitur. Dissidere non possunt; ita pro eo est ac si omnes idem sentiant, quia aliud sentire non possunt. Ad gloriam aut famam non est satis unius opinio. Illic idem potest una sententia quod omnium, quia omnium, si perrogetur, una erit: hic diversa dissimilium iudicia sunt. Difficiles adsensus, dubia omnia invenies, levia, suspecta. Putas tu posse unam omnium esse sententiam? Non est unius una sententia. Illic placet verum, veritatis una vis, una facies est: apud hos falsa sunt quibus adsentiuntur. Numquam autem falsis constantia est; variantur et dissident. «Sed laus» inquit «nihil aliud quam vox est, vox autem bonum non est». Cum dicunt claritatem esse laudem bonorum a bonis redditam, non ad vocem referunt sed ad sententiam. Licet enim vir bonus taceat sed aliquem iudicet dignum laude esse, laudatus est. Praeterea aliud est laus, aliud laudatio, haec et vocem exigit; itaque nemo dicit laudem funebrem sed laudationem, cuius officium oratione constat. Cum dicimus aliquem laude dignum, non verba illi benigna hominum sed iudicia promittimus. Ergo laus etiam taciti est bene sentientis ac bonum virum apud se laudantis. Deinde, ut dixi, ad animum refertur laus, non ad verba, quae conceptam laudem egerunt et in notitiam plurium emittunt. Laudat qui laudandum esse iudicat. Cum tragicus ille apud nos ait magnificum esse «laudari a laudato viro», laude digno ait. Et cum aeque antiquus poeta ait «laus alit artis», non laudationem dicit, quae corrumpit artes; nihil enim aeque et eloquentiam et omne aliud studium auribus deditum vitiavit quam popularis adsensio. Fama vocem utique desiderat, claritas potest etiam citra vocem contingere contenta iudicio; plena est non tantum inter tacentis sed etiam inter reclamantis. Quid intersit inter claritatem et gloriam dicam: gloria multorum iudicis constat, claritas bonorum. «Cuius» inquit «bonum est claritas, id est laus bono a bonis reddita? Utrum laudati an laudantis?». Utriusque. Meum, qui laudor; quia natura me amantem omnium genuit, et bene fecisse gaudeo et gratos me invenisse virtutum interpretes laetor. Hoc plurium bonum est quod grati sunt, sed et meum; ita enim animo
compositus sum ut aliorum bonum meum iudicem, utique eorum quibus ipse sum boni causa. Est istud laudantium bonum; virtute enim geritur; omnis autem virtutis actio bonum est. Hoc contingere illis non potuisset nisi ego talis essem. Itaque utriusque bonum est merito laudari, tam mehercules quam bene iudicasse iudicantis bonum est et eius secundum quem iudicatum est. Numquid dubitas quin iustitia et habentis bonum sit et autem sit eius cui debitum solvit? Merentem laudare iustitia est; ergo utriusque bonum est. Cavillatoribus istis abunde responderimus. Sed non debet hoc nobis esse propositum, arguta disserere et philosophiam in has angustias ex sua maiestate detrahere: quanto satius est ire aperta via et recta quam sibi ipsum flexus disponere quos cum magna molestia debeas relegere? Neque enim quicquam aliud istae disputationes sunt quam inter se perite captantium lusus. Dic potius quam naturale sit in immensum mentem suam extendere. Magna et generosa res est humanus animus; nullos sibi poni nisi communes et cum deo terminos patitur. Primum humilem non accipit patriam, Ephesum aut Alexandriam aut si quod est etiamnunc frequentius accolis laetiusve tectis solum: patria est illi quodcumque suprema et universa circuitu suo cingit, hoc omne convexum intra quod iacent maria cum terris, intra quod aer humanis divina secernens etiam coniungit, in quo disposita tot numina in actus suos excubant. Deinde artam aetatem sibi dari non sinit: «omnes» inquit «anni mei sunt; nullum saeculum magnis ingeniis clusum est, nullum non cogitationi pervium tempus. Cum venerit dies ille qui mixtum hoc divini humanique secernat, corpus hic ubi inveni relinquam, ipse me diis reddam. Nec nunc sine illis sum, sed gravi terrenoque detineor». Per has mortalis aevi moras illi meliori vitae longiorique proluditur. Quemadmodum decem mensibus tenet nos maternus uterus et praeparat non sibi sed illi loco in quem videmur emitti iam idonei spiritum trahere et in aperto durare, sic per hoc spatium quod ab infantia patet in senectutem in alium maturescimus partum. Alia origo nos expectat, alius rerum status. Nondum caelum nisi ex intervallo pati possumus. Proinde intrepidus horam illam decretoriam prospice: non est animo suprema, sed corpori. Quidquid circa te iacet rerum tamquam hospitalis loci sarcinas specta: transeundum est. Excutit redeuntem natura sicut intrantem. Non licet plus efferre quam intuleris, immo etiam ex eo quod ad vitam adtulisti pars magna ponenda est: detrahetur tibi haec circumiecta, novissimum velamentum tui, cutis; detrahetur caro et suffusus sanguis discurrensque per totum; detrahentur ossa nervique, firmamenta fluidorum ac labentium. Dies iste quem tamquam extremum reformidas aeterni natalis est. Depone onus: quid cunctaris, tamquam non prius quoque relicto in quo latebas corpore exieris? Haeres, reluctaris: tum quoque magno nisu matris expulsus es. Gemis, ploras: et hoc ipsum flere nascentis est, sed tunc debebat ignosci: rudis et inperitus omnium veneras. Ex maternorum viscerum calido mollique fomento emissum adflavit aura liberior, deinde offendit durae manus tactus, tenerque adhuc et nullius rei gnarus obstipuisti inter ignota: nunc tibi non est novum separari ab eo cuius ante pars fueris; aequo animo membra iam supervacua dimitte et istuc corpus inhabitatum diu pone. Scindetur,
obruetur, abolebitur: quid contristaris? Ita solet fieri: pereunt semper velamenta nascentium. Quid ista sic diligis quasi tua? Istis opertus es: veniet qui te revellat dies et ex contubernio foedi atque olidi ventris educat. Huic nunc quoque tu quantum potes subduc te voluptatique nisi quae * * * necessariisque cohaerebit alienus iam hinc altius aliquid sublimiusque meditare: aliquando naturae tibi arcana retegentur, discutietur ista caligo et lux undique clara percutiet. Imaginare tecum quantus ille sit fulgor tot sideribus inter se lumen miscentibus. Nulla serenum umbra turbabit; aequaliter splendebit omne caeli latus: dies et nox aëris infimi vices sunt. Tunc in tenebris vixisse te dices cum totam lucem et totus aspexeris, quam nunc per angustissimas oculorum vias obscure intueris, et tamen admiraris illam iam procul: quid tibi videbitur divina lux cum illam suo loco videris? Haec cogitatio nihil sordidum animo subsidere sinit, nihil humile, nihil crudele. Deos rerum omnium esse testes ait; illis nos adprobari, illis in futurum parari iubet et aeternitatem proponere. Quam qui mente concepit nullos horret exercitus, non terretur tuba, nullis ad timorem minis agitur. Quidni non timeat qui mori sperat? Is quoque qui animum tamdiu iudicat manere quamdiu retinetur corporis vinculo, solutum statim spargi, id agit ut etiam post mortem utilis esse possit. Quamvis enim ipse ereptus sit oculis, tamen multa viri virtus animo multusque recursat gentis honos. Cogita quantum nobis exempla bona prosint: scies magnorum virorum non minus praesentiam esse utilem quam memoriam. Vale. 103. Quid ista circumspicis quae tibi possunt fortasse evenire sed possunt et non evenire? Incendium dico, ruinam, alia quae nobis incidunt, non insidiantur: illa potius vide, illa vita quae nos observant, quae captant. Rari sunt casus, etiamsi graves, naufragium facere, vehiculo everti: ab homine homini cotidianum periculum. Adversus hoc te expedi, hoc intentis oculis intuere; nullum est malum frequentius, nullum pertinacius, nullum blandius. Tempestas minatur antequam surgat, crepant aedificia antequam corruant, praenuntiat fumus incendium: subita est ex homine pernicies, et eo diligentius tegitur quo propius accedit. Erras si istorum tibi qui occurrunt vultibus credis: hominum effigies habent, animos ferarum, nisi quod illarum perniciosus est primus incursus: quos transiere non quaerunt. Numquam enim illas ad nocendum nisi necessitas incitat; aut fame aut timore coguntur ad pugnam: homini perdere hominem libet. Tu tamen ita cogita quod ex homine periculum sit ut cogites quod sit hominis officium; alterum intuere ne laedaris, alterum ne laedas. Commodis omnium laeteris, movearis incommodis, et memineris quae praestare debeas, quae cavere. Sic vivendo quid consequaris? Non te ne noceant, sed ne fallant. Quantum potes autem in philosophiam recede: illa te sinu suo proteget, in huius sacrario eris aut tutus aut tutior. Non arietant inter se nisi in eadem ambulantes via. Ipsam autem
philosophiam non debebis iactare; multis fuit periculi causa insolenter tractata et contumaciter: tibi vitia detrahat, non aliis exprobret. Non abhorreat a publicis moribus nec hoc agat ut quidquid non facit damnare videatur. Licet sapere sine pompa, sine invidia. Vale. 104. In Nomentanum meum fugi – quid putas? Urbem? Immo febrem et quidem subrepentem; iam manum mihi iniecerat. Medicus initia esse dicebat motis venis et incertis et naturalem turbantibus modum. Protinus itaque parari vehiculum iussi; Paulina mea retinente exire perseveravi. Illud mihi in ore erat domini mei Gallionis, qui cum in Achaia febrem habere coepisset, protinus navem escendit clamitans non corporis esse sed loci morbum. Hoc ego Paulinae meae dixi, quae mihi valetudinem meam commendat. Nam cum sciam spiritum illius in meo verti, incipio, ut illi consulam, mihi consulere. Et cum me fortiorem senectus ad multa reddiderit, hoc beneficium aetatis amitto; venit enim mihi in mentem in hoc sene et adulescentem esse cui parcitur. Itaque quoniam ego ab illa non inpetro ut me fortius amet, a me inpetrat illa ut me diligentius amem. Indulgendum est enim honestis adfectibus; et interdum, etiam si premunt causae, spiritus in honorem suorum vel cum tormento revocandus et in ipso ore retinendus est, cum bono viro vivendum sit non quamdiu iuvat sed quamdiu oportet: ille qui non uxorem, non amicum tanti putat ut diutius in vita commoretur, qui perseverabit mori, delicatus est. Hoc quoque imperet sibi animus, ubi utilitas suorum exigit, nec tantum si vult mori, sed si coepit, intermittat et se suis commodet. Ingentis animi est aliena causa ad vitam reverti, quod magni viri saepe fecerunt; sed hoc quoque summae humanitatis existimo, senectutem suam, cuius maximus fructus est securior sui tutela et vitae usus animosior, attentius curare, si scias alicui id tuorum esse dulce, utile, optabile. Habet praeterea in se non mediocre ista res gaudium et mercedem; quid enim iucundius quam uxori tam carum esse ut propter hoc tibi carior fias? Potest itaque Paulina mea non tantum suum mihi timorem inputare sed etiam meum. Quaeris ergo quomodo mihi consilium profectionis cesserit? Ut primum gravitatem urbis excessi et illum odorem culinarum fumantium quae motae quidquid pestiferi vaporis sorbuerunt cum pulvere effundunt, protinus mutatam valetudinem sensi. Quantum deinde adiectum putas viribus postquam vineas attigi? In pascuum emissus cibum meum invasi. Repetivi ergo iam me; non permansit marcor ille corporis dubii et male cogitantis. Incipio toto animo studere. Non multum ad hoc locus confert nisi se sibi praestat animus, qui secretum in occupationibus mediis si volet habebit: at ille qui regiones eligit et otium captat ubique quo distringatur inveniet. Nam Socraten querenti cuidam quod nihil sibi peregrinationes profuissent respondisse ferunt, «non inmerito hoc tibi evenit; tecum enim peregrinabaris». O quam bene cum quibusdam ageretur, si a se aberrarent! Nunc premunt se ipsi, sollicitant, corrumpunt, territant. Quid prodest mare traicere et urbes mutare? Si vis ista quibus urgueris effugere, non aliubi sis oportet sed alius. Puta venisse te Athenas, puta Rhodon; elige arbitrio
tuo civitatem: quid ad rem pertinet quos illa mores habeat? Tuos adferes. Divitias iudicabis bonum: torquebit te paupertas, quod est miserrimum, falsa. Quamvis enim multum possideas, tamen, quia aliquis plus habet, tanto tibi videris defici quanto vinceris. Honores iudicabis bonum: male te habebit ille consul factus, ille etiam refectus; invidebis quotiens aliquem in fastis saepius legeris. Tantus erit ambitionis furor ut nemo tibi post te videatur si aliquis ante te fuerit. Maximum malum iudicabis mortem, cum in illa nihil sit mali nisi quod ante ipsam est, timeri. Exterrebunt te non tantum pericula sed suspiciones; vanis semper agitaberis. Quid enim proderit evasisse tot urbes Argolicas mediosque fugam tenuisse per hostis? Ipsa pax timores sumministrabit; ne tutis quidem habebitur fides consternata semel mente, quae ubi consuetudinem pavoris inprovidi fecit, etiam ad tutelam salutis suae inhabilis est. Non enim vitat sed fugit; magis autem periculis patemus aversi. Gravissimum iudicabis malum aliquem ex his quos amabis amittere, cum interim hoc tam ineptum erit quam flere quod arboribus amoenis et domum tuam ornantibus decidant folia. Quidquid te delectat aeque vide †ut videres†: dum virent, utere. Alium alio die casus excutiet, sed quemadmodum frondium iactura facilis est quia renascuntur, sic istorum quos amas quosque oblectamenta vitae putas esse damnum, quia reparantur etiam si non renascuntur. «Sed non erunt idem». Ne tu quidem idem eris. Omnis dies, omnis hora te mutat; sed in aliis rapina facilius apparet, hic latet, quia non ex aperto fit. Alii auferuntur, at ipsi nobis furto subducimur. Horum nihil cogitabis nec remedia vulneribus oppones, sed ipse tibi seres sollicitudinum causas alia sperando, alia desperando? Si sapis, alterum alteri misce: nec speraveris sine desperatione nec desperaveris sine spe. Quid per se peregrinatio prodesse cuiquam potuit? Non voluptates illa temperavit, non cupiditates refrenavit, non iras repressit, non indomitos amoris impetus fregit, nulla denique animo mala eduxit. Non iudicium dedit, non discussit errorem, sed ut puerum ignota mirantem ad breve tempus rerum aliqua novitate detinuit. Ceterum inconstantiam mentis, quae maxime aegra est, lacessit, mobiliorem levioremque reddit ipsa iactatio. Itaque quae petierant cupidissime loca cupidius deserunt et avium modo transvolant citiusque quam venerant abeunt. Peregrinatio notitiam dabit gentium, novas tibi montium formas ostendet, invisitata spatia camporum et inriguas perennibus aquis valles; alicuius fluminis singularem ponet sub observatione naturam, sive ut Nilus aestivo incremento tumet, sive ut Tigris eripitur ex oculis et acto per occulta cursu integrae magnitudinis redditur, sive ut Maeander, poetarum omnium exercitatio et ludus, implicatur crebris anfractibus et saepe in vicinum alveo suo admotus, antequam sibi influat, flectitur: ceterum neque meliorem faciet neque saniorem. Inter studia versandum est et inter auctores sapientiae ut quaesita discamus, nondum inventa
quaeramus; sic eximendus animus ex miserrima servitute in libertatem adseritur. Quamdiu quidem nescieris quid fugiendum, quid petendum, quid necessarium, quid supervacuum, quid iustum, quid iniustum, quid honestum, quid inhonestum sit, non erit hoc peregrinari sed errare. Nullam tibi opem feret iste discursus; peregrinaris enim cum adfectibus tuis et mala te tua sequuntur. Utinam quidem sequerentur! Longius abessent: nunc fers illa, non ducis. Itaque ubique te premunt et paribus incommodis urunt. Medicina aegro, non regio quaerenda est. Fregit aliquis crus aut extorsit articulum: non vehiculum navemque conscendit, sed advocat medicum ut fracta pars iungatur, ut luxata in locum reponatur. Quid ergo? Animum tot locis fractum et extortum credis locorum mutatione posse sanari? Maius est istud malum quam ut gestatione curetur. Peregrinatio non facit medicum, non oratorem; nulla ars loco discitur: quid ergo? Sapientia, ars omnium maxima, in itinere colligitur? Nullum est, mihi crede, iter quod te extra cupiditates, extra iras, extra metus sistat; aut si quod esset, agmine facto gens illuc humana pergeret. Tamdiu ista urguebunt mala macerabuntque per terras ac maria vagum quamdiu malorum gestaveris causas. Fugam tibi non prodesse miraris? Tecum sunt quae fugis. Te igitur emenda, onera tibi detrahe et desideria intra salutarem modum contine; omnem ex animo erade nequitiam. Si vis peregrinationes habere iucundas, comitem tuum sana. Haerebit tibi avaritia quamdiu avaro sordidoque convixeris; haerebit tumor quamdiu superbo conversaberis; numquam saevitiam in tortoris contubernio pones; incendent libidines tuas adulterorum sodalicia. Si velis vitiis exui, longe a vitiorum exemplis recedendum est. Avarus, corruptor, saevus, fraudulentus, multum nocituri si prope a te fuissent, intra te sunt. Ad meliores transi: cum Catonibus vive, cum Laelio, cum Tuberone. Quod si convivere etiam Graecis iuvat, cum Socrate, cum Zenone versare: alter te docebit mori si necesse erit, alter antequam necesse erit. Vive cum Chrysippo, cum Posidonio: hi tibi tradent humanorum divinorumque notitiam, hi iubebunt in opere esse nec tantum scite loqui et in oblectationem audientium verba iactare, sed animum indurare et adversus minas erigere. Unus est enim huius vitae fluctuantis et turbidae portus eventura contemnere, stare fidenter ac paratum tela fortunae adverso pectore excipere, non latitantem nec tergiversantem. Magnanimos nos natura produxit, et ut quibusdam animalibus ferum dedit, quibusdam subdolum, quibusdam pavidum, ita nobis gloriosum et excelsum spiritum quaerentem ubi honestissime, non ubi tutissime vivat, simillimum mundo, quem quantum mortalium passibus licet sequitur aemulaturque; profert se, laudari et aspici credit. Dominus omnium est, supra omnia est; itaque nulli se rei summittat, nihil illi videatur grave, nihil quod virum incurvet. Terribiles visu formae, Letumque Labosque: minime quidem, si quis rectis oculis intueri illa possit et tenebras perrumpere; multa per noctem habita terrori dies vertit ad risum.
Terribiles visu formae, Letumque Labosque: egregie Vergilius noster non re dixit terribiles esse sed visu, id est videri, non esse. Quid, inquam, in istis est tam formidabile quam fama vulgavit? Quid est, obsecro te, Lucili, cur timeat laborem vir, mortem homo? Totiens mihi occurrunt isti qui non putant fieri posse quidquid facere non possunt, et aiunt nos loqui maiora quam quae humana natura sustineat. At quanto ego de illis melius existimo! ipsi quoque haec possunt facere, sed nolunt. Denique quem umquam ista destituere temptantem? Cui non faciliora apparuere in actu? Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt. Si tamen exemplum desideratis, accipite Socraten, perpessicium senem, per omnia aspera iactatum, invictum tamen et paupertate, quam graviorem illi domestica onera faciebant, et laboribus, quos militares quoque pertulit. Quibus ille domi exercitus, sive uxorem eius moribus feram, lingua petulantem, sive liberos indociles et matri quam patri similiores †sivere† aut in bello fuit aut in tyrannide aut in libertate bellis ac tyrannis saeviore. Viginti et septem annis pugnatum est; post finita arma triginta tyrannis noxae dedita est civitas, ex quibus plerique inimici erant. Novissime damnatio est sub gravissimis nominibus impleta: obiecta est et religionum violatio et iuventutis corruptela, quam inmittere in deos, in patres, in rem publicam dictus est. Post haec carcer et venenum. Haec usque eo animum Socratis non moverant ut ne vultum quidem moverint. O illam mirabilem laudem et singularem! usque ad extremum nec hilariorem quisquam nec tristiorem Socraten vidit; aequalis fuit in tanta inaequalitate fortunae. Vis alterum exemplum? Accipe hunc M. Catonem recentiorem, cum quo et infestius fortuna egit et pertinacius. Cui cum omnibus locis obstitisset, novissime et in morte, ostendit tamen virum fortem posse invita fortuna vivere, invita mori. Tota illi aetas aut in armis est exacta civilibus aut †intacta† concipiente iam civile bellum; et hunc licet dicas non minus quam Socraten †inseruisse dixisse† nisi forte Cn. Pompeium et Caesarem et Crassum putas libertatis socios fuisse. Nemo mutatum Catonem totiens mutata re publica vidit; eundem se in omni statu praestitit, in praetura, in repulsa, in accusatione, in provincia, in contione, in exercitu, in morte. Denique in illa rei publicae trepidatione, cum illinc Caesar esset decem legionibus pugnacissimis subnixus, totis exterarum gentium praesidiis, hinc Cn. Pompeius, satis unus adversus omnia, cum alii ad Caesarem inclinarent, alii ad Pompeium, solus Cato fecit aliquas et rei publicae partes. Si animo conplecti volueris illius imaginem temporis, videbis illinc plebem et omnem erectum ad res novas vulgum, hinc optumates et equestrem ordinem, quidquid erat in civitate sancti et electi, duos in medio relictos, rem publicam et Catonem. Miraberis, inquam, cum animadverteris Atriden Priamumque et saevom ambobus Achillen;
utrumque enim inprobat, utrumque exarmat. Hanc fert de utroque sententiam: ait se, si Caesar vicerit, moriturum, si Pompeius, exulaturum. Quid habebat quod timeret qui ipse sibi et victo et victori constituerat quae constituta esse ab hostibus iratissimis poterant? Perit itaque ex decreto suo. Vides posse homines laborem pati: per medias Africae solitudines pedes duxit exercitum. Vides posse tolerari sitim: in collibus arentibus sine ullis inpedimentis victi exercitus reliquias trahens inopiam umoris loricatus tulit et, quotiens aquae fuerat occasio, novissimus bibit. Vides honorem et notam posse contemni: eodem quo repulsus est die in comitio pila lusit. Vides posse non timeri potentiam superiorum: et Pompeium et Caesarem, quorum nemo alterum offendere audebat nisi ut alterum demereretur, simul provocavit. Vides tam mortem posse contemni quam exilium: et exilium sibi indixit et mortem et interim bellum. Possumus itaque adversus ista tantum habere animi, libeat modo subducere iugo collum. In primis autem respuendae voluptates: enervant et effeminant et multum petunt, multum autem a fortuna petendum est. Deinde spernendae opes: auctoramenta sunt servitutum. Aurum et argentum et quidquid aliud felices domos onerat relinquatur: non potest gratis constare libertas. Hanc si magno aestimas, omnia parvo aestimanda sunt. Vale. 105. Quae observanda tibi sint ut tutior vivas dicam. Tu tamen sic audias censeo ista praecepta quomodo si tibi praeciperem qua ratione bonam valetudinem in Ardeatino tuereris. Considera quae sint quae hominem in perniciem hominis instigent: invenies spem, invidiam, odium, metum, contemptum. Ex omnibus istis adeo levissimum est contemptus ut multi in illo remedii causa delituerint. Quem quis contemnit, calcat sine dubio sed transit; nemo homini contempto pertinaciter, nemo diligenter nocet; etiam in acie iacens praeteritur, cum stante pugnatur. Spem inproborum vitabis si nihil habueris quod cupiditatem alienam et inprobam inritet, si nihil insigne possederis; concupiscuntur enim etiam †pars innotarum sunt sic raro†. Invidiam effugies si te non ingesseris oculis, si bona tua non iactaveris, si scieris in sinu gaudere. Odium aut est ex offensa (hoc vitabis neminem lacessendo) aut gratuitum, a quo te sensus communis tuebitur. Fuit hoc multis periculosum: quidam odium habuerunt nec inimicum. Illud, ne timearis, praestabit tibi et fortunae mediocritas et ingeni lenitas: eum esse te homines sciant quem offendere sine periculo possint; reconciliatio tua et facilis sit et certa. Timeri autem tam domi molestum est quam foris, tam a servis quam a liberis: nulli non ad nocendum satis virium est. Adice nunc quod qui timetur timet: nemo potuit terribilis esse secure. Contemptus superest, cuius modum in sua potestate habet qui illum sibi adiunxit, qui contemnitur quia voluit, non quia debuit. Huius incommodum et artes bonae discutiunt et amicitiae eorum qui apud aliquem potentem potentes sunt, quibus adplicari expediet, non inplicari, ne pluris remedium quam periculum constet. Nihil tamen aeque proderit quam quiescere et minimum cum aliis loqui, plurimum secum. Est quaedam dulcedo sermonis quae inrepit et eblanditur et non
aliter quam ebrietas aut amor secreta producit. Nemo quod audierit tacebit, nemo quantum audierit loquetur; qui rem non tacuerit non tacebit auctorem. Habet unusquisque aliquem cui tantum credat quantum ipsi creditum est; ut garrulitatem suam custodiat et contentus sit unius auribus, populum faciet; sic quod modo secretum erat rumor est. Securitatis magna portio est nihil inique facere: confusam vitam et perturbatam inpotentes agunt; tantum metuunt quantum nocent, nec ullo tempore vacant. Trepidant enim cum fecerunt, haerent; conscientia aliud agere non patitur ac subinde respondere ad se cogit. Dat poenas quisquis expectat; quisquis autem meruit expectat. Tutum aliqua res in mala conscientia praestat, nulla securum; putat enim se, etiam si non deprenditur, posse deprendi, et inter somnos movetur et, quotiens alicuius scelus loquitur, de suo cogitat; non satis illi oblitteratum videtur, non satis tectum. Nocens habuit aliquando latendi fortunam, numquam fiduciam. Vale. 106. Tardius rescribo ad epistulas tuas, non quia districtus occupationibus sum. Hanc excusationem cave audias: vaco, et omnes vacant qui volunt. Neminem res sequuntur: ipsi illas amplexantur et argumentum esse felicitatis occupationem putant. Quid ergo fuit quare non protinus rescriberem? Id de quo quaerebas veniebat in contextum operis mei; scis enim me moralem philosophiam velle conplecti et omnes ad eam pertinentis quaestiones explicare. Itaque dubitavi utrum differrem te donec suus isti rei veniret locus, an ius tibi extra ordinem dicerem: humanius visum est tam longe venientem non detinere. Itaque et hoc ex illa serie rerum cohaerentium excerpam et, si qua erunt eiusmodi, non quaerenti tibi ultro mittam. Quae sint haec interrogas? Quae scire magis iuvat quam prodest, sicut hoc de quo quaeris: bonum an corpus sit? Bonum facit; prodest enim; quod facit corpus est. Bonum agitat animum et quodam modo format et continet, quae propria sunt corporis. Quae corporis bona sunt corpora sunt; ergo et quae animi sunt; nam et hoc corpus est. Bonum hominis necesse est corpus sit, cum ipse sit corporalis. Mentior, nisi et quae alunt illum et quae valetudinem eius vel custodiunt vel restituunt corpora sunt; ergo et bonum eius corpus est. Non puto te dubitaturum an adfectus corpora sint (ut aliud quoque de quo non quaeris infulciam), tamquam ira, amor, tristitia, nisi dubitas an vultum nobis mutent, an frontem adstringant, an faciem diffundant, an ruborem evocent, an fugent sanguinem. Quid ergo? Tam manifestas notas corporis credis inprimi nisi a corpore? Si adfectus corpora sunt, et morbi animorum, ut avaritia, crudelitas, indurata vitia et in statum inemendabilem adducta; ergo et malitia et species eius omnes, malignitas, invidia, superbia; ergo et bona, primum quia contraria istis sunt, deinde quia eadem tibi indicia praestabunt. An non vides quantum oculis det vigorem fortitudo? Quantam intentionem prudentia? Quantam modestiam et quietem reverentia? Quantam serenitatem laetitia? Quantum rigorem severitas? Quantam remissionem lenitas? Corpora ergo sunt quae colorem habitumque corporum
mutant, quae in illis regnum suum exercent. Omnes autem quas rettuli virtutes bona sunt, et quidquid ex illis est. Numquid est dubium an id quo quid tangi potest corpus sit? Tangere enim et tangi nisi corpus nulla potest res, ut ait Lucretius. Omnia autem ista quae dixi non mutarent corpus nisi tangerent; ergo corpora sunt. Etiam nunc cui tanta vis est ut inpellat et cogat et retineat et inhibeat corpus est. Quid ergo? Non timor retinet? Non audacia inpellit? Non fortitudo inmittit et impetum dat? Non moderatio refrenat ac revocat? Non gaudium extollit? Non tristitia deducit? Denique quidquid facimus aut malitiae aut virtutis gerimus imperio: quod imperat corpori corpus est, quod vim corpori adfert, corpus. Bonum corporis corporale est, bonum hominis et corporis bonum est; itaque corporale est. Quoniam, ut voluisti, morem gessi tibi, nunc ipse dicam mihi quod dicturum esse te video: latrunculis ludimus. In supervacuis subtilitas teritur: non faciunt bonos ista sed doctos. Apertior res est sapere, immo simplicior: paucis satis est ad mentem bonam uti litteris, sed nos ut cetera in supervacuum diffundimus, ita philosophiam ipsam. Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: non vitae sed scholae discimus. Vale. 107. Ubi illa prudentia tua? Ubi in dispiciendis rebus subtilitas? Ubi magnitudo? Tam pusilla te res tangit? Servi occupationes tuas occasionem fugae putaverunt. Si amici deciperent (habeant enim sane nomen quod illis noster error inposuit, et vocentur quo turpius non sint) * * * omnibus rebus tuis desunt illi qui et operam tuam conterebant et te aliis molestum esse credebant. Nihil horum insolitum, nihil inexpectatum est; offendi rebus istis tam ridiculum est quam queri quod spargaris in balneo aut vexeris in publico aut inquineris in luto. Eadem vitae condicio est quae balnei, turbae, itineris: quaedam in te mittentur, quaedam incident. Non est delicata res vivere. Longam viam ingressus es: et labaris oportet et arietes et cadas et lasseris et exclames «o mors!», id est mentiaris. Alio loco comitem relinques, alio efferes, alio timebis: per eiusmodi offensas emetiendum est confragosum hoc iter. Mori vult? Praeparetur animus contra omnia; sciat se venisse ubi tonat fulmen; sciat se venisse ubi Luctus et ultrices posuere cubilia Curae pallentesque habitant Morbi tristisque Senectus. In hoc contubernio vita degenda est. Effugere ista non potes, comtemnere potes; contemnes autem si saepe cogitaveris et futura praesumpseris. Nemo non fortius ad id cui se diu composuerat accessit et duris quoque, si praemeditata erant, obstitit: at contra inparatus etiam levissima expavit. Id agendum est ne quid nobis inopinatum sit; et quia omnia novitate graviora sunt, hoc cogitatio adsidua
praestabit, ut nulli sis malo tiro. «Servi me reliquerunt». Alium compilaverunt, alium accusaverunt, alium occiderunt, alium prodiderunt, alium mulcaverunt, alium veneno, alium criminatione petierunt: quidquid dixeris multis accidit deinceps quae multa et varia sunt in nos deriguntur. Quaedam in nos fixa sunt, quaedam vibrant et cum maxime veniunt, quaedam in alios perventura nos stringunt. Nihil miremur eorum ad quae nati sumus, quae ideo nulli querenda quia paria sunt omnibus. Ita dico, paria sunt; nam etiam quod effugit aliquis pati potuit. Aequum autem ius est non quo omnes usi sunt sed quod omnibus latum est. Imperetur aequitas animo et sine querella mortalitatis tributa pendamus. Hiems frigora adducit: algendum est. Aestas calores refert: aestuandum est. Intemperies caeli valetudinem temptat: aegrotandum est. Et fera nobis aliquo loco occurret et homo perniciosior feris omnibus. Aliud aqua, aliud ignis eripiet. Hanc rerum condicionem mutare non possumus: illud possumus, magnum sumere animum et viro bono dignum, quo fortiter fortuita patiamur et naturae consentiamus. Natura autem hoc quod vides regnum mutationibus temperat: nubilo serena succedunt; turbantur maria cum quieverunt; flant in vicem venti; noctem dies sequitur; pars caeli consurgit, pars mergitur: contrariis rerum aeternitas constat. Ad hanc legem animus noster aptandus est; hanc sequatur, huic pareat; et quaecumque fiunt debuisse fieri putet nec velit obiurgare naturam. Optimum est pati quod emendare non possis, et deum quo auctore cuncta proveniunt sine murmuratione comitari: malus miles est qui imperatorem gemens sequitur. Quare inpigri atque alacres excipiamus imperia nec deseramus hunc operis pulcherrimi cursum, cui quidquid patiemur intextum est; et sic adloquamur Iovem, cuius gubernaculo moles ista derigitur, quemadmodum Cleanthes noster versibus disertissimis adloquitur, quos mihi in nostrum sermonem mutare permittitur Ciceronis, disertissimi viri, exemplo. Si placuerint, boni consules; si displicuerint, scies me in hoc secutum Ciceronis exemplum. Duc, o parens celsique dominator poli, quocumque placuit: nulla parendi mora est; adsum inpiger. Fac nolle, comitabor gemens malusque patiar facere quod licuit bono. Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. Sic vivamus, sic loquamur; paratos nos inveniat atque inpigros fatum. Hic est magnus animus qui se ei tradidit: at contra ille pusillus et degener qui obluctatur et de ordine mundi male existimat et emendare mavult deos quam se Vale. 108. Id de quo quaeris ex iis est quae scire tantum eo, ut scias, pertinet. Sed nihilominus, quia pertinet, properas nec vis expectare libros quos cum maxime ordino continentis totam moralem philosophiae partem. Statim expediam; illud tamen prius scribam, quemadmodum tibi ista cupiditas discendi, qua flagrare te
video, digerenda sit, ne ipsa se inpediat. Nec passim carpenda sunt nec avide invadenda universa: per partes pervenietur ad totum. Aptari onus viribus debet nec plus occupari quam cui sufficere possimus. Non quantum vis sed quantum capis hauriendum est. Bonum tantum habe animum: capies quantum voles. Quo plus recipit animus, hoc se magis laxat. Haec nobis praecipere Attalum memini, cum scholam eius obsideremus et primi veniremus et novissimi exiremus, ambulantem quoque illum ad aliquas disputationes evocaremus, non tantum paratum discentibus sed obvium. «Idem» inquit «et docenti et discenti debet esse propositum, ut ille prodesse velit, hic proficere». Qui ad philosophum venit cotidie aliquid secum boni ferat: aut sanior domum redeat aut sanabilior. Redibit autem: ea philosophiae vis est ut non studentis sed etiam conversantis iuvet. Qui in solem venit, licet non in hoc venerit, colorabitur; qui in unguentaria taberna resederunt et paullo diutius commorati sunt odorem secum loci ferunt; et qui ad philosophum fuerunt traxerint aliquid necesse est quod prodesset etiam neglegentibus. Attende quid dicam: neglegentibus, non repugnantibus. «Quid ergo? Non novimus quosdam qui multis apud philosophum annis persederint et ne colorem quidem duxerint?». Quidni noverim? Pertinacissimos quidem et adsiduos, quos ego non discipulos philosophorum sed inquilinos voco. Quidam veniunt ut audiant, non ut discant, sicut in theatrum voluptatis causa ad delectandas aures oratione vel voce vel fabulis ducimur. Magnam hanc auditorum partem videbis cui philosophi schola deversorium otii sit. Non id agunt ut aliqua illo vitia deponant, ut aliquam legem vitae accipiant qua mores suos exigant, sed ut oblectamento aurium perfruantur. Aliqui tamen et cum pugillaribus veniunt, non ut res excipiant, sed ut verba, quae tam sine profectu alieno dicant quam sine suo audiunt. Quidam ad magnificas voces excitantur et transeunt in adfectum dicentium alacres vultu et animo, nec aliter concitantur quam solent Phrygii tibicinis sono semiviri et ex imperio furentes. Rapit illos instigatque rerum pulchritudo, non verborum inanium sonitus. Si quid acriter contra mortem dictum est, si quid contra fortunam contumaciter, iuvat protinus quae audias facere. Adficiuntur illis et sunt quales iubentur, si illa animo forma permaneat, si non impetum insignem protinus populus, honesti dissuasor, excipiat: pauci illam quam conceperant mentem domum perferre potuerunt. Facile est auditorem concitare ad cupidinem recti; omnibus enim natura fundamenta dedit semenque virtutum. Omnes ad omnia ista nati sumus: cum inritator accessit, tunc illa animi bona veluti sopita excitantur. Non vides quemadmodum theatra consonent quotiens aliqua dicta sunt quae publice adgnoscimus et consensu vera esse testamur? Desunt inopiae multa, avaritiae omnia. In nullum avarus bonus est, in se pessimus. Ad hos versus ille sordidissimus plaudit et vitiis suis fieri convicium gaudet:
quanto magis hoc iudicas evenire cum a philosopho ista dicuntur, cum salutaribus praeceptis versus inseruntur, efficacius eadem illa demissuri in animum inperitorum? Nam ut dicebat Cleanthes, «quemadmodum spiritus noster clariorem sonum reddit cum illum tuba per longi canalis angustias tractum patentiore novissime exitu effudit, sic sensus nostros clariores carminis arta necessitas efficit». Eadem neglegentius audiuntur minusque percutiunt quamdiu soluta oratione dicuntur: ubi accessere numeri et egregium sensum adstrinxere certi pedes, eadem illa sententia velut lacerto excussiore torquetur. De contemptu pecuniae multa dicuntur et longissimis orationibus hoc praecipitur, ut homines in animo, non in patrimonio putent esse divitias, eum esse locupletem qui paupertati suae aptatus est et parvo se divitem fecit; magis tamen feriuntur animi cum carmina eiusmodi dicta sunt: Is minimo eget mortalis qui minimum cupit. Quod vult habet qui velle quod satis est potest. Cum haec atque eiusmodi audimus, ad confessionem veritatis adducimur; illi enim quibus nihil satis est admirantur, adclamant, odium pecuniae indicunt. Hunc illorum adfectum cum videris, urge, hoc preme, hoc onera, relictis ambiguitatibus et syllogismis et cavillationibus et ceteris acuminis inriti ludicris. Dic in avaritiam, dic in luxuriam; cum profecisse te videris et animos audientium adfeceris, insta vehementius: veri simile non est quantum proficiat talis oratio remedio intenta et tota in bonum audientium versa. Facillime enim tenera conciliantur ingenia ad honesti rectique amorem, et adhuc docilibus leviterque corruptis inicit manum veritas si advocatum idoneum nacta est. Ego certe cum Attalum audirem in vitia, in errores, in mala vitae perorantem, saepe miseritus sum generis humani et illum sublimem altioremque humano fastigio credidi. Ipse regem se esse dicebat, sed plus quam regnare mihi videbatur cui liceret censuram agere regnantium. Cum vero commendare paupertatem coeperat et ostendere quam quidquid usum excederet pondus esset supervacuum et grave ferenti, saepe exire e schola pauperi libuit. Cum coeperat voluptates nostras traducere, laudare castum corpus, sobriam mensam, puram mentem non tantum ab inlicitis voluptatibus sed etiam supervacuis, libebat circumscribere gulam ac ventrem. Inde mihi quaedam permansere, Lucili; magno enim in omnia impetu veneram, deinde ad civitatis vitam reductus ex bene coeptis pauca servavi. Inde ostreis boletisque in omnem vitam renuntiatum est; nec enim cibi sed oblectamenta sunt ad edendum saturos cogentia (quod gratissimum est edacibus et se ultra quam capiunt farcientibus), facile descensura, facile reditura. Inde in omnem vitam unguento abstinemus, quoniam optimus odor in corpore est nullus. Inde vino carens stomachus. Inde in omnem vitam balneum fugimus; decoquere corpus atque exinanire sudoribus inutile simul delicatumque credidimus. Cetera proiecta redierunt, ita tamen ut quorum abstinentiam interrupi modum servem et quidem abstinentiae proximiorem, nescio an difficiliorem, quoniam quaedam absciduntur
facilius animo quam temperantur. Quoniam coepi tibi exponere quanto maiore impetu ad philosophiam iuvenis accesserim quam senex pergam, non pudebit fateri quem mihi amorem Pythagoras iniecerit. Sotion dicebat quare ille animalibus abstinuisset, quare postea Sextius. Dissimilis utrique causa erat, sed utrique magnifica. Hic homini satis alimentorum citra sanguinem esse credebat et crudelitatis consuetudinem fieri ubi in voluptatem esset adducta laceratio. Adiciebat contrahendam materiam esse luxuriae; colligebat bonae valetudini contraria esse alimenta varia et nostris aliena corporibus. At Pythagoras omnium inter omnia cognationem esse dicebat et animorum commercium in alias atque alias formas transeuntium. Nulla, si illi credas, anima interit, ne cessat quidem nisi tempore exiguo, dum in aliud corpus transfunditur. Videbimus per quas temporum vices et quando pererratis pluribus domiciliis in hominem revertatur: interim sceleris hominibus ac parricidii metum fecit, cum possent in parentis animam inscii incurrere et ferro morsuve violare, si in quo corpore cognatus aliqui spiritus hospitaretur. Haec cum exposuisset Sotion et implesset argumentis suis, «non credis» inquit «animas in alia corpora atque alia discribi et migrationem esse quod dicimus mortem? Non credis in his pecudibus ferisve aut aqua mersis illum quondam hominis animum morari? Non credis nihil perire in hoc mundo, sed mutare regionem? Nec tantum caelestia per certos circuitus verti, sed animalia quoque per vices ire et animos per orbem agi? Magni ista crediderunt viri. Itaque iudicium quidem tuum sustine, ceterum omnia tibi in integro serva. Si vera sunt ista, abstinuisse animalibus innocentia est; si falsa, frugalitas est. Quod istic credulitatis tuae damnum est? Alimenta tibi leonum et vulturum eripio». His ego instinctus abstinere animalibus coepi, et anno peracto non tantum facilis erat mihi consuetudo sed dulcis. Agitatiorem mihi animum esse credebam nec tibi hodie adfirmaverim an fuerit. Quaeris quomodo desierim? In primum Tiberii Caesaris principatum iuventae tempus inciderat: alienigena tum sacra movebantur et inter argumenta superstitionis ponebatur quorundam animalium abstinentia. Patre itaque meo rogante, qui non calumniam timebat sed philosophiam oderat, ad pristinam consuetudinem redii; nec difficulter mihi ut inciperem melius cenare persuasit. Laudare solebat Attalus culcitam quae resisteret corpori: tali utor etiam senex, in qua vestigium apparere non possit. Haec rettuli ut probarem tibi quam vehementes haberent tirunculi impetus primos ad optima quaeque, si quis exhortaretur illos, si quis inpelleret. Sed aliquid praecipientium vitio peccatur, qui nos docent disputare, non vivere, aliquid discentium, qui propositum adferunt ad praeceptores suos non animum excolendi sed ingenium. Itaque quae philosophia fuit facta philologia est. Multum autem ad rem pertinet quo proposito ad quamquam rem accedas. Qui grammaticus futurus Vergilium scrutatur non hoc animo legit illud egregium fugit inreparabile tempus:
«vigilandum est; nisi properamus relinquemur; agit nos agiturque velox dies; inscii rapimur; omnia in futurum disponimus et inter praecipitia lenti sumus»: sed ut observet, quotiens Vergilius de celeritate temporum dicit, hoc uti verbo illum «fugit». Optima quaeque dies miseris mortalibus aevi prima fugit; subeunt morbi tristisque senectus et labor, et durae rapit inclementia mortis. Ille qui ad philosophiam spectat haec eadem quo debet adducit. «Numquam Vergilius» inquit «dies dicit ire, sed fugere, quod currendi genus concitatissimum est, et optimos quosque primos rapi: quid ergo cessamus nos ipsi concitare, ut velocitatem rapidissimae rei possimus aequare? Meliora praetervolant, deteriora succedunt». Quemadmodum ex amphora primum quod est sincerissimum effluit, gravissimum quodque turbidumque subsidit, sic in aetate nostra quod est optimum in primo est. Id exhauriri aliis potius patimur, ut nobis faecem reservemus? Inhaereat istud animo et tamquam missum oraculo placeat: optima quaeque dies miseris mortalibus aevi prima fugit. Quare optima? Quia quod restat incertum est. Quare optima? Quia iuvenes possumus discere, possumus facilem animum et adhuc tractabilem ad meliora convertere; quia hoc tempus idoneum est laboribus, idoneum agitandis per studia ingeniis et exercendis per opera corporibus: quod superest segnius et languidius est et propius a fine. Itaque toto hoc agamus animo et omissis ad quae devertimur in rem unam laboremus, ne hanc temporis pernicissimi celeritatem, quam retinere non possumus, relicti demum intellegamus. Primus quisque tamquam optimus dies placeat et redigatur in nostrum. Quod fugit occupandum est. Haec non cogitat ille qui grammatici oculis carmen istud legit, ideo optimum quemque primum esse diem quia subeunt morbi, quia senectus premit et adhuc adulescentiam cogitantibus supra caput est, sed ait Vergilium semper una ponere morbos et senectutem – non mehercules inmerito; senectus enim insanabilis morbus est. «Praeterea» inquit «hoc senectuti cognomen inposuit, «tristem» illam vocat: subeunt morbi tristisque senectus. Alio loco dicit pallentesque habitant Morbi tristisque Senectus». Non est quod mireris ex eadem materia suis quemque studiis apta colligere: in eodem prato bos herbam quaerit, canis leporem, ciconia lacertam.
Cum Ciceronis librum de re publica prendit hinc philologus aliquis, hinc grammaticus, hinc philosophiae deditus, alius alio curam suam mittit. Philosophus admiratur contra iustitiam dici tam multa potuisse. Cum ad hanc eandem lectionem philologus accessit, hoc subnotat: duos Romanos reges esse quorum alter patrem non habet, alter matrem. Nam de Servi matre dubitatur; Anci pater nullus, Numae nepos dicitur. Praeterea notat eum quem nos dictatorem dicimus et in historiis ita nominari legimus apud antiquos «magistrum populi» vocatum. Hodieque id extat in auguralibus libris, et testimonium est quod qui ab illo nominatur «magister equitum» est. Aeque notat Romulum perisse solis defectione; provocationem ad populum etiam a regibus fuisse; id ita in pontificalibus libris †et aliqui qui† putant et Fenestella. Eosdem libros cum grammaticus explicuit, primum «reapse» dici a Cicerone, id est «re ipsa», in commentarium refert, nec minus «sepse», id est «se ipse». Deinde transit ad ea quae consuetudo saeculi mutavit, tamquam ait Cicero «quoniam sumus ab ipsa calce eius interpellatione revocati». Hanc quam nunc in circo «cretam» vocamus «calcem» antiqui dicebant. Deinde Ennianos colligit versus et in primis illos de Africano scriptos: cui nemo civis neque hostis quibit pro factis reddere opis pretium. Ex eo se ait intellegere opem apud antiquos non tantum auxilium significasse sed operam. Ait enim Ennius neminem potuisse Scipioni neque civem neque hostem reddere operae pretium. Felicem deinde se putat quod invenerit unde visum sit Vergilio dicere quem super ingens porta tonat caeli. Ennium hoc ait Homero subripuisse, Ennio Vergilium; esse enim apud Ciceronem in his ipsis de re publica hoc epigramma Enni: si fas endo plagas caelestum ascendere cuiquam est, mi soli caeli maxima porta patet. Sed ne et ipse, dum aliud ago, in philologum aut grammaticum delabar, illud admoneo, auditionem philosophorum lectionemque ad propositum beatae vitae trahendam, non ut verba prisca aut ficta captemus et translationes inprobas figurasque dicendi, sed ut profutura praecepta et magnificas voces et animosas quae mox in rem transferantur. Sic ista ediscamus ut quae fuerint verba sint opera. Nullos autem peius mereri de omnibus mortalibus iudico quam qui philosophiam velut aliquod artificium venale didicerunt, qui aliter vivunt quam vivendum esse praecipiunt. Exempla enim se ipsos inutilis disciplinae
circumferunt, nulli non vitio quod insequuntur obnoxii. Non magis mihi potest quisquam talis prodesse praeceptor quam gubernator in tempestate nauseabundus. Tenendum rapiente fluctu gubernaculum, luctandum cum ipso mari, eripienda sunt vento vela: quid me potest adiuvare rector navigii attonitus et vomitans? Quanto maiore putas vitam tempestate iactari quam ullam ratem? Non est loquendum sed gubernandum. Omnia quae dicunt, quae turba audiente iactant, aliena sunt: dixit illa Platon, dixit Zenon, dixit Chrysippus et Posidonius et ingens agmen nominum tot ac talium. Quomodo probare possint sua esse monstrabo: faciant quae dixerint. Quoniam quae volueram ad te perferre iam dixi, nunc desiderio tuo satis faciam et in alteram epistulam integrum quod exegeras transferam, ne ad rem spinosam et auribus erectis curiosisque audiendam lassus accedas. Vale. 109. An sapiens sapienti prosit scire desideras. Dicimus plenum omni bono esse sapientem et summa adeptum: quomodo prodesse aliqui possit summum habenti bonum quaeritur. Prosunt inter se boni. Exercent enim virtutes et sapientiam in suo statu continent; desiderat uterque aliquem cum quo conferat, cum quo quaerat. Peritos luctandi usus exercet; musicum qui paria didicit movet. Opus est et sapienti agitatione virtutum; ita quemadmodum ipse se movet, sic movetur ab alio sapiente. Quid sapiens sapienti proderit? Impetum illi dabit, occasiones actionum honestarum commonstrabit. Praeter haec aliquas cogitationes suas exprimet; docebit quae invenerit. Semper enim etiam sapienti restabit quod inveniat et quo animus eius excurrat. Malus malo nocet facitque peiorem, iram eius incitando, tristitiae adsentiendo, voluptates laudando; et tunc maxime laborant mali ubi plurimum vitia miscuere et in unum conlata nequitia est. Ergo ex contrario bonus bono proderit. «Quomodo?» inquis. Gaudium illi adferet, fiduciam confirmabit; ex conspectu mutuae tranquillitatis crescet utriusque laetitia. Praeterea quarumdam illi rerum scientiam tradet; non enim omnia sapiens scit; etiam si sciret, breviores vias rerum aliqui excogitare posset et has indicare per quas facilius totum opus circumfertur. Proderit sapienti sapiens, non scilicet tantum suis viribus sed ipsius quem adiuvabit. Potest quidem ille etiam relictus sibi explicare partes suas: utetur propria velocitate, sed nihilominus adiuvat etiam currentem hortator. «Non prodest sapienti sapiens sed sibi ipse. Hoc ut scias, detrahe illi vim propriam et ille nihil aget». Isto modo dicas licet non esse in melle dulcedinem; nam ipse ille qui esse debeat nisi ita aptatus lingua palatoque est ad eiusmodi gustum ut illum talis sapor capiat, offendetur; sunt enim quidam quibus morbi vitio mel amarum videatur. Oportet utrumque valere ut et ille prodesse possit et hic profuturo idonea materia sit. «Ut in summum» inquit «perducto calorem calefieri supervacuum est, et in summum perducto bonum supervacuum est si qui prosit. Numquid instructus omnibus rebus agricola ab alio instrui quaerit? Numquid armatus miles quantum in aciem exituro satis est ulla amplius arma desiderat? Ergo nec sapiens; satis
enim vitae instructus, satis armatus est». Ad haec respondeo: et qui in summum perductus est calorem opus est calore adiecto ut summum teneat. «Sed ipse se» inquit «calor continet». Primum multum interest inter ista quae comparas. Calor enim unus est, prodesse varium est. Deinde calor non adiuvatur adiectione caloris ut caleat: sapiens non potest in habitu mentis suae stare nisi amicos aliquos similes sui admisit cum quibus virtutes suas communicet. Adice nunc quod omnibus inter se virtutibus amicitia est; itaque prodest qui virtutes alicuius paris sui amat amandasque invicem praestat. Similia delectant, utique ubi honesta sunt et probare ac probari sciunt. Etiamnunc sapientis animum perite movere nemo alius potest quam sapiens, sicut hominem movere rationaliter non potest nisi homo. Quomodo ergo ad rationem movendam ratione opus est, sic ut moveatur ratio perfecta opus est ratione perfecta. Prodesse dicuntur et qui media nobis largiuntur, pecuniam, gratiam, incolumitatem, alia in usus vitae cara aut necessaria; in his dicetur etiam stultus prodesse sapienti. Prodesse autem est animum secundum naturam movere virtute sua. Ut eius qui movebitur, hoc non sine ipsius quoque qui proderit bono fiet; necessest enim alienam virtutem exercendo exerceat et suam. Sed ut removeas ista quae aut summa bona sunt aut summorum efficientia, nihilominus prodesse inter se sapientes possunt. Invenire enim sapientem sapienti per se res expetenda est, quia natura bonum omne carum est bono et sic quisque conciliatur bono quemadmodum sibi. Necesse est ex hac quaestione argumenti causa in alteram transeam. Quaeritur enim an deliberaturus sit sapiens, an in consilium aliquem advocaturus. Quod facere illi necessarium est cum ad haec civilia et domestica venitur et, ut ita dicam, mortalia; in his sic illi opus est alieno consilio quomodo medico, quomodo gubernatori, quomodo advocato et litis ordinatori. Proderit ergo sapiens aliquando sapienti; suadebit enim. Sed in illis quoque magnis ac divinis, ut diximus, communiter honesta tractando et animos cogitationesque miscendo utilis erit. Praeterea secundum naturam est et amicos conplecti et amicorum auctu ut suo proprioque laetari; nam nisi hoc fecerimus, ne virtus quidem nobis permanebit, quae exercendo sensu valet. Virtus autem suadet praesentia bene conlocare, in futurum consulere, deliberare et intendere animum: facilius intendet explicabitque qui aliquem sibi adsumpserit. Quaeret itaque aut perfectum virum aut proficientem vicinumque perfecto. Proderit autem ille perfectus, si consilium communi prudentia iuverit. Aiunt homines plus in alieno negotio videre †initio†. Hoc illis evenit quos amor sui excaecat quibusque dispectum utilitatis timor in periculis excutit: incipiet sapere securior et extra metum positus. Sed nihilominus quaedam sunt quae etiam sapientes in alio quam in se diligentius vident. Praeterea illud dulcissimum et honestissimum «idem velle atque idem nolle» sapiens sapienti praestabit; egregium opus pari iugo ducet. Persolvi quod exegeras, quamquam in ordine rerum erat quas moralis philosophiae voluminibus conplectimur. Cogita quod soleo frequenter tibi dicere, in istis nos nihil aliud quam acumen exercere. Totiens enim illo revertor: quid ista me res iuvat? Fortiorem fac me, iustiorem, temperantiorem. Nondum exerceri
vacat: adhuc medico mihi opus est. Quid me poscis scientiam inutilem? Magna promisisti: exhibe fidem. Dicebas intrepidum fore etiam si circa me gladii micarent, etiam si mucro tangeret iugulum; dicebas securum fore etiam si circa me flagrarent incendia, etiam si subitus turbo toto navem meam mari raperet: hanc mihi praesta curam, ut voluptatem, ut gloriam contemnam. Postea docebis inplicta solvere, ambigua distinguere, obscura perspicere: nunc doce quod necesse est. Vale.
Liber undevicensimus 110. Ex Nomentano meo te saluto et iubeo habere mentem bonam, hoc est propitios deos omnis, quos habet placatos et faventes quisquis sibi se propitiavit. Sepone in praesentia quae quibusdam placent, unicuique nostrum paedagogum dari deum, non quidem ordinarium, sed hunc inferioris notae ex eorum numero quos Ovidius ait «de plebe deos». Ita tamen hoc seponas volo ut memineris maiores nostros qui crediderunt Stoicos fuisse; singulis enim et Genium et Iunonem dederunt. Postea videbimus an tantum dis vacet ut privatorum negotia procurent: interim illud scito, sive adsignati sumus sive neglecti et fortunae dati, nulli te posse inprecari quicquam gravius quam si inprecatus fueris ut se habeat iratum. Sed non est quare cuiquam quem poena putaveris dignum optes ut infestos deos habeat: habet, inquam, etiam si videtur eorum favore produci. Adhibe diligentiam tuam et intuere quid sint res nostrae, non quid vocentur, et scies plura mala contingere nobis quam accidere. Quotiens enim felicitatis et causa et initium fuit quod calamitas vocabatur! quotiens magna gratulatione excepta res gradum sibi struxit in praeceps et aliquem iam eminentem adlevavit etiamnunc, tamquam adhuc ibi staret unde tuto cadunt! Sed ipsum illud cadere non habet in se mali quicquam si exitum spectes, ultra quem natura neminem deiecit. Prope est rerum omnium terminus, prope est, inquam, et illud unde felix eicitur et illud unde infelix emittitur: nos utraque extendimus et longa spe ac metu facimus. Sed, si sapis, omnia humana condicione metire; simul et quod gaudes et quod times contrahe. Est autem tanti nihil diu gaudere ne quid diu timeas. Sed quare istuc malum adstringo? Non est quod quicquam timendum putes: vana sunt ista quae nos movent, quae attonitos habent. Nemo nostrum quid veri esset excussit, sed metum alter alteri tradidit; nemo ausus est ad id quo perturbabatur accedere et naturam ac bonum timoris sui nosse. Itaque res falsa et inanis habet adhuc fidem quia non coarguitur. Tanti putemus oculos intendere: iam apparebit quam brevia, quam incerta, quam tuta timeantur. Talis est animorum nostrorum confusio qualis Lucretio visa est: nam veluti pueri trepidant atque omnia caecis in tenebris metuunt, ita nos in luce timemus. Quid ergo? Non omni puero stultiores sumus qui in luce timemus? Sed falsum est, Lucreti, non timemus in luce: omnia nobis fecimus tenebras. Nihil videmus, nec quid noceat nec quid expediat; tota vita incursitamus nec ob hoc resistimus aut circumspectius pedem ponimus. Vides autem quam sit furiosa res in tenebris impetus. At mehercules id agimus ut longius revocandi simus, et cum ignoremus quo feramur, velociter tamen illo quo intendimus perseveramus. Sed lucescere, si velimus, potest. Uno autem modo potest, si quis hanc humanorum divinorumque notitiam acceperit, si illa se non perfuderit sed infecerit, si eadem, quamvis sciat, retractaverit et ad se saepe rettulerit, si quaesierit quae sint bona, quae mala,
quibus hoc falso sit nomen adscriptum, si quaesierit de honestis et turpibus, de providentia. Nec intra haec humani ingenii sagacitas sistitur: prospicere et ultra mundum libet, quo feratur, unde surrexerit, in quem exitum tanta rerum velocitas properet. Ab hac divina contemplatione abductum animum in sordida et humilia pertraximus, ut avaritiae serviret, ut relicto mundo terminisque eius et dominis cuncta versantibus terram rimaretur et quaereret quid ex illa mali effoderet, non contentus oblatis. Quidquid nobis bono futurum erat deus et parens noster in proximo posuit; non expectavit inquisitionem nostram et ultro dedit: nocitura altissime pressit. Nihil nisi de nobis queri possumus: ea quibus periremus nolente rerum natura et abscondente protulimus. Addiximus animum voluptati, cui indulgere initium omnium malorum est, tradidimus ambitioni et famae, ceteris aeque vanis et inanibus. Quid ergo nunc te hortor ut facias? Nihil novi – nec enim novis malis remedia quaeruntur – sed hoc primum, ut tecum ipse dispicias quid sit necessarium, quid supervacuum. Necessaria tibi ubique occurrent: supervacua et semper et toto animo quaerenda sunt. Non est autem quod te nimis laudes si contempseris aureos lectos et gemmeam supellectilem; quae est enim virtus supervacua contemnere? Tunc te admirare cum contempseris necessaria. Non magnam rem facis quod vivere sine regio apparatu potes, quod non desideras milliarios apros nec linguas phoenicopterorum et alia portenta luxuriae iam tota animalia fastidientis et certa membra ex singulis eligentis: tunc te admirabor si contempseris etiam sordidum panem, si tibi persuaseris herbam, ubi necesse est, non pecori tantum sed homini nasci, si scieris cacumina arborum explementum esse ventris in quem sic pretiosa congerimus tamquam recepta servantem. Sine fastidio implendus est; quid enim ad rem pertinet quid accipiat, perditurus quidquid acceperit? Delectant te disposita quae terra marique capiuntur, alia eo gratiora si recentia perferuntur ad mensam, alia si diu pasta et coacta pinguescere fluunt ac vix saginam continent suam; delectat te nitor horum arte quaesitus. At mehercules ista sollicite scrutata varieque condita, cum subierint ventrem, una atque eadem foeditas occupabit. Vis ciborum voluptatem contemnere? Exitum specta. Attalum memini cum magna admiratione omnium haec dicere: «Diu» inquit «mihi inposuere divitiae. Stupebam ubi aliquid ex illis alio atque alio loco fulserat; existimabam similia esse quae laterent his quae ostenderentur. Sed in quodam apparatu vidi totas opes urbis, caelata et auro et argento et iis quae pretium auri argentique vicerunt, exquisitos colores et vestes ultra non tantum nostrum sed ultra finem hostium advectas; hinc puerorum perspicuos cultu atque forma greges, hinc feminarum, et alia quae res suas recognoscens summi imperii fortuna protulerat». «Quid hoc est» inquam «aliud inritare cupiditates hominum per se incitatas? Quid sibi vult ista pecuniae pompa? Ad discendam avaritiam convenimus?». At mehercules minus cupiditatis istinc effero quam adtuleram. Contempsi divitias, non quia supervacuae sed quia pusillae sunt. Vidistine quam intra paucas horas ille ordo quamvis lentus dispositusque transierit? Hoc totam vitam nostram occupabit quod totum diem occupare non potuit? Accessit illud
quoque: tam supervacuae mihi visae sunt habentibus quam fuerunt spectantibus. Hoc itaque ipse mihi dico quotiens tale aliquid praestrinxerit oculos meos, quotiens occurrit domus splendida, cohors culta servorum, lectica formonsis inposita calonibus: «quid miraris? Quid stupes? Pompa est. Ostenduntur istae res, non possidentur, et dum placent transeunt». Ad veras potius te converte divitias; disce parvo esse contentus et illam vocem magnus atque animosus exclama: habemus aquam, habemus polentam; Iovi ipsi controversiam de felicitate faciamus. Faciamus, oro te, etiam si ista defuerint; turpe est beatam vitam in auro et argento reponere, aeque turpe in aqua et polenta. «Quid ergo faciam si ista non fuerint?». Quaeris quod sit remedium inopiae? Famem fames finit: alioquin quid interest magna sint an exigua quae servire te cogant? Quid refert quantulum sit quod tibi possit negare fortuna? Haec ipsa aqua et polenta in alienum arbitrium cadit; liber est autem non in quem parum licet fortunae, sed in quem nihil. Ita est: nihil desideres oportet si vis Iovem provocare nihil desiderantem». Haec nobis Attalus dixit, natura omnibus dixit; quae si voles frequenter cogitare, id ages ut sis felix, non ut videaris, et ut tibi videaris, non aliis. Vale. 111. Quid vocentur Latine sophismata quaesisti a me. Multi temptaverunt illis nomen inponere, nullum haesit; videlicet, quia res ipsa non recipiebatur a nobis nec in usu erat, nomini quoque repugnatum est. Aptissimum tamen videtur mihi quo Cicero usus est: «cavillationes» vocat. Quibus quisquis se tradidit quaestiunculas quidem vafras nectit, ceterum ad vitam nihil proficit: neque fortior fit neque temperantior neque elatior. At ille qui philosophiam in remedium suum exercuit ingens fit animo, plenus fiduciae, inexsuperabilis et maior adeunti. Quod in magnis evenit montibus, quorum proceritas minus apparet longe intuentibus: cum accesseris, tunc manifestum fit quam in arduo summa sint. Talis est, mi Lucili, verus et rebus, non artificiis philosophus. In edito stat, admirabilis, celsus, magnitudinis verae; non exsurgit in plantas nec summis ambulat digitis eorum more qui mendacio staturam adiuvant longioresque quam sunt videri volunt; contentus est magnitudine sua. Quidni contentus sit eo usque crevisse quo manus fortuna non porrigit? Ergo et supra humana est et par sibi in omni statu rerum, sive secundo cursu vita procedit, sive fluctuatur et it per adversa ac difficilia: hanc constantiam cavillationes istae de quibus paulo ante loquebar praestare non possunt. Ludit istis animus, non proficit, et philosophiam a fastigio suo deducit in planum. Nec te prohibuerim aliquando ista agere, sed tunc cum voles nihil agere. Hoc tamen habent in se pessimum: dulcedinem quandam sui faciunt et animum specie subtilitatis inductum tenent ac morantur, cum tanta rerum moles vocet, cum vix tota vita sufficiat ut hoc unum discas, vitam contemnere. «Quid regere?» inquis. Secundum opus est; nam nemo illam bene rexit nisi qui contempserat. Vale. 112. Cupio mehercules amicum tuum formari ut desideras et institui, sed
valde durus capitur; immo, quod est molestius, valde mollis capitur et consuetudine mala ac diutina fractus. Volo tibi ex nostro artificio exemplum referre. Non quaelibet insitionem vitis patitur: si vetus et exesa est, si infirma gracilisque, aut non recipiet surculum aut non alet nec adplicabit sibi nec in qualitatem eius naturamque transibit. Itaque solemus supra terram praecidere ut, si non respondit, temptari possit secunda fortuna et iterum repetita infra terram inseratur. Hic de quo scribis et mandas non habet vires: indulsit vitiis. Simul et emarcuit et induruit; non potest recipere rationem, non potest nutrire. «At cupit ipse». Noli credere. Non dico illum mentiri tibi: putat se cupere. Stomachum illi fecit luxuria: cito cum illa redibit in gratiam. «Sed dicit se offendi vita sua». Non negaverim; quis enim non offenditur? Homines vitia sua et amant simul et oderunt. Tunc itaque de illo feremus sententiam cum fidem nobis fecerit invisam iam sibi esse luxuriam: nunc illis male convenit. Vale. 113. Desideras tibi scribi a me quid sentiam de hac quaestione iactata apud nostros, an iustitia, fortitudo, prudentia ceteraeque virtutes animalia sint. Hac subtilitate effecimus, Lucili carissime, ut exercere ingenium inter inrita videremur et disputationibus nihil profuturis otium terere. Faciam quod desideras et quid nostris videatur exponam; sed me in alia esse sententia profiteor: puto quaedam esse quae deceant phaecasiatum palliatumque. Quae sint ergo quae antiquos moverint vel quae sint quae antiqui moverint dicam. Animum constat animal esse, cum ipse efficiat ut simus animalia, cum ab illo animalia nomen hoc traxerint; virtus autem nihil aliud est quam animus quodam modo se habens; ergo animal est. Deinde virtus agit aliquid; agi autem nihil sine impetu potest; si impetum habet, qui nulli est nisi animali, animal est. «Si animal est» inquit «virtus, habet ipsa virtutem». Quidni habeat se ipsam? Quomodo sapiens omnia per virtutem gerit, sic virtus per se. «Ergo» inquit «et omnes artes animalia sunt et omnia quae cogitamus quaeque mente conplectimur. Sequitur ut multa millia animalium habitent in his angustiis pectoris, et singuli multa simus animalia aut multa habeamus animalia». Quaeris quid adversus istud respondeatur? Unaquaeque ex istis res animal erit: multa animalia non erunt. Quare? Dicam, si mihi accommodaveris subtilitatem et intentionem tuam. Singula animalia singulas habere debent substantias; ista omnia unum animum habent; itaque singula esse possunt, multa esse non possunt. Ego et animal sum et homo, non tamen duos esse nos dices. Quare? Quia separati debent esse. Ita dico: alter ab altero debet esse diductus ut duo sint. Quidquid in uno multiplex est sub unam naturam cadit; itaque unum est. Et animus meus animal est et ego animal sum, duo tamen non sumus. Quare? Quia animus mei pars est. Tunc aliquid per se numerabitur cum per se stabit; ubi vero alterius membrum erit, non poterit videri aliud. Quare? Dicam: quia quod aliud est suum oportet esse et proprium et totum et intra se absolutum. Ego in alia esse me sententia professus sum; non enim tantum virtutes animalia erunt, si hoc recipitur, sed opposita quoque illis vitia et adfectus,
tamquam ira, timor, luctus, suspicio. Ultra res ista procedet: omnes sententiae, omnes cogitationes animalia erunt. Quod nullo modo recipiendum est; non enim quidquid ab homine fit homo est. «Iustitia quid est?» inquit. Animus quodam modo se habens. «Itaque si animus animal est, et iustitia». Minime; haec enim habitus animi est et quaedam vis. Idem animus in varias figuras convertitur et non totiens animal aliud est quotiens aliud facit; nec illud quod fit ab animo animal est. Si iustitia animal est, si fortitudo, si ceterae virtutes, utrum desinunt esse animalia subinde aut rursus incipiunt, an semper sunt? Desinere virtutes non possunt. Ergo multa animalia, immo innumerabilia, in hoc animo versantur. «Non sunt» inquit «multa, quia ex uno religata sunt et partes unius ac membra sunt». Talem ergo faciem animi nobis proponimus qualis est hydrae multa habentis capita, quorum unumquodque per se pugnat, per se nocet. Atqui nullum ex illis capitibus animal est, sed animalis caput: ceterum ipsa unum animal est. Nemo in Chimaera leonem animal esse dixit aut draconem: hae partes erant eius; partes autem non sunt animalia. Quid est quo colligas iustitiam animal esse? «Agit» inquit «aliquid et prodest; quod autem agit et prodest impetum habet; quod autem impetum habet animal est». Verum est si suum impetum habet; suum autem non habet sed animi. Omne animal donec moriatur id est quod coepit: homo donec moriatur homo est, equus equus, canis canis; transire in aliud non potest. Iustitia, id est animus quodam modo se habens, animal est. Credamus: deinde animal est fortitudo, id est animus quodam modo se habens. Quis animus? Ille qui modo iustitia erat? Tenetur in priore animali, in aliud animal transire ei non licet; in eo illi in quo primum esse coepit perseverandum est. Praeterea unus animus duorum esse animalium non potest, multo minus plurium. Si iustitia, fortitudo, temperantia ceteraeque virtutes animalia sunt, quomodo unum animum habebunt? Singulos habeant oportet, aut non sunt animalia. Non potest unum corpus plurium animalium esse. Hoc et ipsi fatentur. Iustitiae quod est corpus? «Animus». Quid? Fortitudinis quod est corpus? «Idem animus». Atqui unum corpus esse duorum animalium non potest. «Sed idem animus» inquit «iustitiae habitum induit et fortitudinis et temperantiae». Hoc fieri posset si quo tempore iustitia esset fortitudo non esset, quo tempore fortitudo esset temperantia non esset; nunc vero omnes virtutes simul sunt. Ita quomodo singulae erunt animalia, cum unus animus sit, qui plus quam unum animal non potest facere? Denique nullum animal pars est alterius animalis; iustitia autem pars est animi; non est ergo animal. Videor mihi in re confessa perdere operam; magis enim indignandum de isto quam disputandum est. Nullum animal alteri par est. Circumspice omnium corpora: nulli non et color proprius est et figura sua et magnitudo. Inter cetera propter quae mirabile divini artificis ingenium est hoc quoque existimo esse, quod in tanta copia rerum numquam in idem incidit; etiam quae similia videntur, cum contuleris, diversa sunt. Tot fecit genera foliorum: nullum non sua proprietate signatum; tot animalia: nullius magnitudo cum altero convenit, utique aliquid interest. Exegit a se ut quae alia erant et dissimilia essent et inparia. Virtutes omnes, ut dicitis, pares sunt; ergo non sunt animalia. Nullum non animal
per se agit; virtus autem per se nihil agit, sed cum homine. Omnia animalia aut rationalia sunt, ut homines, ut dii, aut inrationalia, ut ferae, ut pecora; virtutes utique rationales sunt; atqui nec homines sunt nec dii; ergo non sunt animalia. Omne rationale animal nihil agit nisi primum specie alicuius rei inritatum est, deinde impetum cepit, deinde adsensio confirmavit hunc impetum. Quid sit adsensio dicam. Oportet me ambulare: tunc demum ambulo cum hoc mihi dixi et adprobavi hanc opinionem meam; oportet me sedere: tunc demum sedeo. Haec adsensio in virtute non est. Puta enim prudentiam esse: quomodo adsentietur «oportet me ambulare»? Hoc natura non recipit. Prudentia enim ei cuius est prospicit, non sibi; nam nec ambulare potest nec sedere. Ergo adsensionem non habet; quod adsensionem non habet rationale animal non est. Virtus si animal est, rationale est; rationale autem non est; ergo nec animal. Si virtus animal est, virtus autem bonum omnest, omne bonum animal est. Hoc nostri fatentur. Patrem servare bonum est, et sententiam prudenter in senatu dicere bonum est, et iuste decernere bonum est; ergo et patrem servare animal est et prudenter sententiam dicere animal est. Eo usque res †exegit† ut risum tenere non possis: prudenter tacere bonum est, * * * cenare bonum est; ita et tacere et cenare animal est. Ego mehercules titillare non desinam et ludos mihi ex istis subtilibus ineptiis facere. Iustitia et fortitudo, si animalia sunt, certe terrestria sunt; omne animal terrestre alget, esurit, sitit; ergo iustitia alget, fortitudo esurit, clementia sitit. Quid porro? Non interrogabo illos quam figuram habeant ista animalia? Hominis an equi an ferae? Si rotundam illis qualem deo dederint, quaeram an et avaritia et luxuria et dementia aeque rotundae sint; sunt enim et ipsae animalia. Si has quoque conrotundaverint, etiamnunc interrogabo an prudens ambulatio animal sit. Necesse est confiteantur, deinde dicant ambulationem animal esse et quidem rotundum. Ne putes autem primum me ex nostris non ex praescripto loqui sed meae sententiae esse, inter Cleanthen et discipulum eius Chrysippum non convenit quid sit ambulatio. Cleanthes ait spiritum esse a principali usque in pedes permissum, Chrysippus ipsum principale. Quid est ergo cur non ipsius Chrysippi exemplo sibi quisque se vindicet et ista tot animalia quot mundus ipse non potest capere derideat? «Non sunt» inquit «virtutes multa animalia, et tamen animalia sunt. Nam quemadmodum aliquis et poeta est et orator, et tamen unus, sic virtutes istae animalia sunt sed multa non sunt. Idem est animus et animus et iustus et prudens et fortis, ad singulas virtutes quodam modo se habens». Sublata convenit nobis. Nam et ego interim fateor animum animal esse, postea visurus quam de ista re sententiam feram: actiones eius animalia esse nego. Alioqui et omnia verba erunt animalia et omnes versus. Nam si prudens sermo bonum est, bonum autem omne animal est, sermo animal est. Prudens versus bonum est, bonum autem omne animal est; versus ergo animal est. Ita arma virumque cano
animal est, quod non possunt rotundum dicere cum sex pedes habeat. «Textorium» inquis «totum mehercules istud quod cum maxime agitur». Dissilio risu cum mihi propono soloecismum animal esse et barbarismum et syllogismum et aptas illis facies tamquam pictor adsigno. Haec disputamus attractis superciliis, fronte rugosa? Non possum hoc loco dicere illud Caelianum: «o tristes ineptias!» Ridiculae sunt. Quin itaque potius aliquid utile nobis ac salutare tractamus et quaerimus quomodo ad virtutes pervenire possimus, quae nos ad illas via adducat? Doce me non an fortitudo animal sit, sed nullum animal felix esse sine fortitudine, nisi contra fortuita convaluit et omnis casus antequam exciperet meditando praedomuit. Quid est fortitudo? Munimentum humanae imbecillitatis inexpugnabile, quod qui circumdedit sibi securus in hac vitae obsidione perdurat; utitur enim suis viribus, suis telis. Hoc loco tibi Posidonii nostri referre sententiam volo: «non est quod umquam fortunae armis putes esse te tutum: tuis pugna. Contra ipsam fortuna non armat; itaque contra hostes instructi, contra ipsam inermes sunt». Alexander Persas quidem et Hyrcanos et Indos et quidquid gentium usque in oceanum extendit oriens vastabat fugabatque, sed ipse modo occiso amico, modo amisso, iacebat in tenebris, alias scelus, alias desiderium suum maerens, victor tot regum atque populorum irae tristitiaeque succumbens; id enim egerat ut omnia potius haberet in potestate quam adfectus. O quam magnis homines tenentur erroribus qui ius dominandi trans maria cupiunt permittere felicissimosque se iudicant si multas milite provincias obtinent et novas veteribus adiungunt, ignari quod sit illud ingens parque dis regnum: imperare sibi maximum imperium est. Doceat me quam sacra res sit iustitia alienum bonum spectans, nihil ex se petens nisi usum sui. Nihil sit illi cum ambitione famaque: sibi placeat. Hoc ante omnia sibi quisque persuadeat: me iustum esse gratis oportet. Parum est. Adhuc illud persuadeat sibi: me in hanc pulcherrimam virtutem ultro etiam inpendere iuvet; tota cogitatio a privatis commodis quam longissime aversa sit. Non est quod spectes quod sit iustae rei praemium: maius in iusto est. Illud adhuc tibi adfige quod paulo ante dicebam, nihil ad rem pertinere quam multi aequitatem tuam noverint. Qui virtutem suam publicari vult non virtuti laborat sed gloriae. Non vis esse iustus sine gloria? At mehercules saepe iustus esse debebis cum infamia, et tunc, si sapis, mala opinio bene parta delectet. Vale. 114. Quare quibusdam temporibus provenerit corrupti generis oratio quaeris et quomodo in quaedam vitia inclinatio ingeniorum facta sit, ut aliquando inflata explicatio vigeret, aliquando infracta et in morem cantici ducta; quare alias sensus audaces et fidem egressi placuerint, alias abruptae sententiae et suspiciosae, in quibus plus intellegendum esset quam audiendum; quare aliqua aetas fuerit quae translationis iure uteretur inverecunde. Hoc quod audire vulgo soles, quod apud Graecos in proverbium cessit: talis hominibus fuit oratio qualis
vita. Quemadmodum autem uniuscuiusque actio †dicendi† similis est, sic genus dicendi aliquando imitatur publicos mores, si disciplina civitatis laboravit et se in delicias dedit. Argumentum est luxuriae publicae orationis lascivia, si modo non in uno aut in altero fuit, sed adprobata est et recepta. Non potest alius esse ingenio, alius animo color. Si ille sanus est, si compositus, gravis, temperans, ingenium quoque siccum ac sobrium est: illo vitiato hoc quoque adflatur. Non vides, si animus elanguit, trahi membra et pigre moveri pedes? Si ille effeminatus est, in ipso incessu apparere mollitiam? Si ille acer est et ferox, concitari gradum? Si furit aut, quod furori simile est, irascitur, turbatum esse corporis motum nec ire sed ferri? Quanto hoc magis accidere ingenio putas, quod totum animo permixtum est, ab illo fingitur, illi paret, inde legem petit? Quomodo Maecenas vixerit notius est quam ut narrari nunc debeat quomodo ambulaverit, quam delicatus fuerit, quam cupierit videri, quam vitia sua latere noluerit. Quid ergo? Non oratio eius aeque soluta est quam ipse discinctus? Non tam insignita illius verba sunt quam cultus, quam comitatus, quam domus, quam uxor? Magni vir ingenii fuerat si illud egisset via rectiore, si non vitasset intellegi, si non etiam in oratione difflueret. Videbis itaque eloquentiam ebrii hominis involutam et errantem et licentiae plenam. Quid turpius «amne silvisque ripa comantibus»? Vide ut «alveum lyntribus arent versoque vado remittant hortos». Quid? Si quis «feminae cinno crispat et labris columbatur incipitque suspirans, ut cervice lassa fanantur nemoris tyranni». «Inremediabilis factio rimantur epulis lagonaque temptant domos et spe mortem exigunt». «Genium festo vix suo testem». «Tenuisve cerei fila et crepacem molam». «Focum mater aut uxor investiunt». Non statim cum haec legeris hoc tibi occurret, hunc esse qui solutis tunicis in urbe semper incesserit (nam etiam cum absentis Caesaris partibus fungeretur, signum a discincto petebatur); hunc esse qui in tribunali, in rostris, in omni publico coetu sic apparuerit ut pallio velaretur caput exclusis utrimque auribus, non aliter quam in mimo fugitivi divitis solent; hunc esse cui tunc maxime civilibus bellis strepentibus et sollicita urbe et armata comitatus hic fuerit in publico, spadones duo, magis tamen viri quam ipse; hunc esse qui uxorem milliens duxit, cum unam habuerit? Haec verba tam inprobe structa, tam neglegenter abiecta, tam contra consuetudinem omnium posita ostendunt mores quoque non minus novos et pravos et singulares fuisse. Maxima laus illi tribuitur mansuetudinis: pepercit gladio, sanguine abstinuit, nec ulla alia re quid posset quam licentia ostendit. Hanc ipsam laudem suam corrupit istis orationis portentosissimae delicis; apparet enim mollem fuisse, non mitem. Hoc istae ambages compositionis, hoc verba transversa, hoc sensus miri, magni quidem saepe sed enervati dum exeunt, cuivis manifestum facient: motum illi felicitate nimia caput. Quod vitium hominis esse interdum, interdum temporis solet. Ubi luxuriam late felicitas fudit, cultus primum corporum esse diligentior incipit; deinde supellectili laboratur; deinde in ipsas domos inpenditur cura ut in laxitatem ruris excurrant, ut parietes advectis trans maria marmoribus fulgeant, ut tecta varientur auro, ut lacunaribus pavimentorum respondeat nitor; deinde ad
cenas lautitia transfertur et illic commendatio ex novitate et soliti ordinis commutatione captatur, ut ea quae includere solent cenam prima ponantur, ut quae advenientibus dabantur exeuntibus dentur. Cum adsuevit animus fastidire quae ex more sunt et illi pro sordidis solita sunt, etiam in oratione quod novum est quaerit et modo antiqua verba atque exoleta revocat ac profert, modo fingit †et ignota ac† deflectit, modo, id quod nuper increbruit, pro cultu habetur audax translatio ac frequens. Sunt qui sensus praecidant et hoc gratiam sperent, si sententia pependerit et audienti suspicionem sui fecerit; sunt qui illos detineant et porrigant; sunt qui non usque ad vitium accedant (necesse est enim hoc facere aliquid grande temptanti) sed qui ipsum vitium ament. Itaque ubicumque videris orationem corruptam placere, ibi mores quoque a recto descivisse non erit dubium. Quomodo conviviorum luxuria, quomodo vestium aegrae civitatis indicia sunt, sic orationis licentia, si modo frequens est, ostendit animos quoque a quibus verba exeunt procidisse. Mirari quidem non debes corrupta excipi non tantum a corona sordidiore sed ab hac quoque turba cultiore; togis enim inter se isti, non iudicis distant. Hoc magis mirari potes, quod non tantum vitiosa sed vitia laudentur. Nam illud semper factum est: nullum sine venia placuit ingenium. Da mihi quemcumque vis magni nominis virum: dicam quid illi aetas sua ignoverit, quid in illo sciens dissimulaverit. Multos tibi dabo quibus vitia non nocuerint, quosdam quibus profuerint. Dabo, inquam, maximae famae et inter admiranda propositos, quos si quis corrigit, delet; sic enim vitia virtutibus inmixta sunt ut illas secum tractura sint. Adice nunc quod oratio certam regulam non habet: consuetudo illam civitatis, quae numquam in eodem diu stetit, versat. Multi ex alieno saeculo petunt verba, duodecim tabulas loquuntur; Gracchus illis et Crassus et Curio nimis culti et recentes sunt, ad Appium usque et Coruncanium redeunt. Quidam contra, dum nihil nisi tritum et usitatum volunt, in sordes incidunt. Utrumque diverso genere corruptum est, tam mehercules quam nolle nisi splendidis uti ac sonantibus et poeticis, necessaria atque in usu posita vitare. Tam hunc dicam peccare quam illum: alter se plus iusto colit, alter plus iusto neglegit; ille et crura, hic ne alas quidem vellit. Ad compositionem transeamus. Quot genera tibi in hac dabo quibus peccetur? Quidam praefractam et asperam probant; disturbant de industria si quid placidius effluxit; nolunt sine salebra esse iuncturam; virilem putant et fortem quae aurem inaequalitate percutiat. Quorundam non est compositio, modulatio est; adeo blanditur et molliter labitur. Quid de illa loquar in qua verba differuntur et diu expectata vix ad clausulas redeunt? Quid illa in exitu lenta, qualis Ciceronis est, devexa et molliter detinens nec aliter quam solet ad morem suum pedemque respondens? Non tantum * * * in genere sententiarum vitium est, si aut pusillae sunt et pueriles aut inprobae et plus ausae quam pudore salvo licet, si floridae sunt et nimis dulces, si in vanum exeunt et sine effectu nihil amplius quam sonant. Haec vitia unus aliquis inducit, sub quo tunc eloquentia est, ceteri imitantur et
alter alteri tradunt. Sic Sallustio vigente anputatae sententiae et verba ante expectatum cadentia et obscura brevitas fuere pro cultu. L. Arruntius, vir rarae frugalitatis, qui historias belli Punici scripsit, fuit Sallustianus et in illud genus nitens. Est apud Sallustium «exercitum argento fecit», id est, pecunia paravit. Hoc Arruntius amare coepit; posuit illud omnibus paginis. Dicit quodam loco «fugam nostris fecere», alio loco «Hiero rex Syracusanorum bellum fecit», et alio loco «quae audita Panhormitanos dedere Romanis fecere». Gustum tibi dare volui: totus his contexitur liber. Quae apud Sallustium rara fuerunt apud hunc crebra sunt et paene continua, nec sine causa; ille enim in haec incidebat, at hic illa quaerebat. Vides autem quid sequatur ubi alicui vitium pro exemplo est. Dixit Sallustius «aquis hiemantibus». Arruntius in primo libro belli Punici ait «repente hiemavit tempestas», et alio loco cum dicere vellet frigidum annum fuisse ait «totus hiemavit annus», et alio loco «inde sexaginta onerarias leves praeter militem et necessarios nautarum hiemante aquilone misit». Non desinit omnibus locis hoc verbum infulcire. Quodam loco dicit Sallustius «dum inter arma civilia aequi bonique famas petit». Arruntius non temperavit quominus primo statim libro poneret ingentes esse «famas» de Regulo. Haec ergo et eiusmodi vitia, quae alicui inpressit imitatio, non sunt indicia luxuriae nec animi corrupti; propria enim esse debent et ex ipso nata ex quibus tu aestimes alicuius adfectus: iracundi hominis iracunda oratio est, commoti nimis incitata, delicati tenera et fluxa. Quod vides istos sequi qui aut vellunt barbam aut intervellunt, qui labra pressius tondent et adradunt servata et summissa cetera parte, qui lacernas coloris inprobi sumunt, qui perlucentem togam, qui nolunt facere quicquam quod hominum oculis transire liceat: inritant illos et in se avertunt, volunt vel reprehendi dum conspici. Talis est oratio Maecenatis omniumque aliorum qui non casu errant sed scientes volentesque. Hoc a magno animi malo oritur: quomodo in vino non ante lingua titubat quam mens cessit oneri et inclinata vel prodita est, ita ista orationis quid aliud quam ebrietas nulli molesta est nisi animus labat. Ideo ille curetur: ab illo sensus, ab illo verba exeunt, ab illo nobis est habitus, vultus, incessus. Illo sano ac valente oratio quoque robusta, fortis, virilis est: si ille procubuit, et cetera ruinam sequuntur. Rege incolumi mens omnibus una est: amisso rupere fidem. Rex noster est animus; hoc incolumi cetera manent in officio, parent, obtemperant: cum ille paulum vacillavit, simul dubitant. Cum vero cessit voluptati, artes quoque eius actusque marcent et omnis ex languido fluidoque conatus est. Quoniam hac similitudine usus sum, perseverabo. Animus noster modo rex est, modo tyrannus: rex cum honesta intuetur, salutem commissi sibi corporis curat et illi nihil imperat turpe, nihil sordidum; ubi vero inpotens, cupidus, delicatus est, transit in nomen detestabile ac dirum et fit tyrannus. Tunc illum
excipiunt adfectus inpotentes et instant; qui initio quidem gaudet, ut solet populus largitione nocitura frustra plenus et quae non potest haurire contrectans; cum vero magis ac magis vires morbus exedit et in medullas nervosque descendere deliciae, conspectu eorum quibus se nimia aviditate inutilem reddidit laetus, pro suis voluptatibus habet alienarum spectaculum, sumministrator libidinum testisque, quarum usum sibi ingerendo abstulit. Nec illi tam gratum est abundare iucundis quam acerbum quod non omnem illum apparatum per gulam ventremque transmittit, quod non cum omni exoletorum feminarumque turba convolutatur, maeretque quod magna pars suae felicitatis exclusa corporis angustiis cessat. Numquid enim, mi Lucili, non in hoc furor est, quod nemo nostrum mortalem se cogitat, quod nemo inbecillum? Immo quod nemo nostrum unum esse se cogitat? Aspice culinas nostras et concursantis inter tot ignes cocos: unum videri putas ventrem cui tanto tumultu comparatur cibus? Aspice veteraria nostra et plena multorum saeculorum vindemiis horrea: unum putas videri ventrem cui tot consulum regionumque vina cluduntur? Aspice quot locis terra vertatur, quot millia colonorum arent, fodiant: unum videri putas ventrem cui et in Sicilia et in Africa seritur? Sani erimus et modica concupiscemus si unusquisque se numeret, metiatur simul corpus, sciat quam nec multum capere nec diu possit. Nihil tamen aeque tibi profuerit ad temperantiam omnium rerum quam frequens cogitatio brevis aevi et huius incerti: quidquid facies, respice ad mortem. Vale. 115. Nimis anxium esse te circa verba et compositionem, mi Lucili, nolo: habeo maiora quae cures. Quaere quid scribas, non quemadmodum; et hoc ipsum non ut scribas sed ut sentias, ut illa quae senseris magis adplices tibi et velut signes. Cuiuscumque orationem videris sollicitam et politam, scito animum quoque non minus esse pusillis occupatum. Magnus ille remissius loquitur et securius; quaecumque dicit plus habent fiduciae quam curae. Nosti comptulos iuvenes, barba et coma nitidos, de capsula totos: nihil ab illis speraveris forte, nihil solidum. Oratio cultus animi est: si circumtonsa est et fucata et manu facta, ostendit illum quoque non esse sincerum et habere aliquid fracti. Non est ornamentum virile concinnitas. Si nobis animum boni viri liceret inspicere, o quam pulchram faciem, quam sanctam, quam ex magnifico placidoque fulgentem videremus, hinc iustitia, illinc fortitudine, hinc temperantia prudentiaque lucentibus! Praeter has frugalitas et continentia et tolerantia et liberalitas comitasque et (quis credat?) in homine rarum humanitas bonum splendorem illi suum adfunderent. Tunc providentia cum elegantia et ex istis magnanimitas eminentissima quantum, di boni, decoris illi, quantum ponderis gravitatisque adderent! quanta esset cum gratia auctoritas! Nemo illam amabilem qui non simul venerabilem diceret. Si quis viderit hanc faciem altiorem fulgentioremque quam cerni inter humana consuevit, nonne velut numinis occursu obstupefactus resistat et ut fas sit vidisse tacitus precetur, tum evocante ipsa vultus benignitate productus adoret ac supplicet, et diu contemplatus multum extantem superque mensuram solitorum inter nos aspici elatam, oculis mite quiddam sed nihilominus
vivido igne flagrantibus, tunc deinde illam Vergili nostri vocem verens atque attonitus emittat? O quam te memorem, virgo? Namque haut tibi vultus mortalis nec vox hominem sonat … sis felix nostrumque leves quaecumque laborem. Aderit levabitque, si colere eam voluerimus. Colitur autem non taurorum opimis corporibus contrucidatis nec auro argentoque suspenso nec in thensauros stipe infusa, sed pia et recta voluntate. Nemo, inquam, non amore eius arderet si nobis illam videre contingeret; nunc enim multa obstrigillant et aciem nostram aut splendore nimio repercutiunt aut obscuritate retinent. Sed si, quemadmodum visus oculorum quibusdam medicamentis acui solet et repurgari, sic nos aciem animi liberare inpedimentis voluerimus, poterimus perspicere virtutem etiam obrutam corpore, etiam paupertate opposita, etiam humilitate et infamia obiacentibus; cernemus, inquam, pulchritudinem illam quamvis sordido obtectam. Rursus aeque malitiam et aerumnosi animi veternum perspiciemus, quamvis multus circa divitiarum radiantium splendor inpediat et intuentem hinc honorum, illinc magnarum potestatium falsa lux verberet. Tunc intellegere nobis licebit quam contemnenda miremur, simillimi pueris, quibus omne ludicrum in pretio est; parentibus quippe nec minus fratribus praeferunt parvo aere empta monilia. Quid ergo inter nos et illos interest, ut Ariston ait, nisi quod nos circa tabulas et statuas insanimus, carius inepti? Illos reperti in litore calculi leves et aliquid habentes varietatis delectant, nos ingentium maculae columnarum, sive ex Aegyptiis harenis sive ex Africae solitudinibus advectae porticum aliquam vel capacem populi cenationem ferunt. Miramur parietes tenui marmore inductos, cum sciamus quale sit quod absconditur. Oculis nostris inponimus, et cum auro tecta perfudimus, quid aliud quam mendacio gaudemus? Scimus enim sub illo auro foeda ligna latitare. Nec tantum parietibus aut lacunaribus ornamentum tenue praetenditur: omnium istorum quos incedere altos vides bratteata felicitas est. Inspice, et scies sub ista tenui membrana dignitatis quantum mali iaceat. Haec ipsa res quae tot magistratus, tot iudices detinet, quae et magistratus et iudices facit, pecunia, ex quo in honore esse coepit, verus rerum honor cecidit, mercatoresque et venales in vicem facti quaerimus non quale sit quidque sed quanti; ad mercedem pii sumus, ad mercedem impii, et honesta quamdiu aliqua illis spes inest sequimur, in contrarium transituri si plus scelera promittent. Admirationem nobis parentes auri argentique fecerunt, et teneris infusa cupiditas altius sedit crevitque nobiscum. Deinde totus populus in alia discors in hoc convenit: hoc suspiciunt, hoc suis optant, hoc dis velut rerum humanarum maximum, cum grati videri volunt, consecrant. Denique eo mores redacti sunt ut paupertas maledicto probroque sit, contempta divitibus, invisa pauperibus. Accedunt deinde carmina poetarum, quae adfectibus nostris facem subdant, quibus divitiae velut unicum vitae decus ornamentumque laudantur. Nihil illis
melius nec dare videntur di inmortales posse nec habere. Regia Solis erat sublimibus alta columnis, clara micante auro. Eiusdem currum aspice: Aureus axis erat, temo aureus, aurea summae curvatura rotae, radiorum argenteus ordo. Denique quod optimum videri volunt saeculum aureum appellant. Nec apud Graecos tragicos desunt qui lucro innocentiam, salutem, opinionem bonam mutent. Sine me vocari pessimum, ut dives vocer. An dives omnes quaerimus, nemo an bonus. Non quare et unde, quid habeas tantum rogant. Ubique tanti quisque, quantum habuit, fuit. Quid habere nobis turpe sit quaeris? Nihil. Aut dives opto vivere aut pauper mori. Bene moritur quisquis moritur dum lucrum facit. Pecunia, ingens generis humani bonum, cui non voluptas matris aut blandae potest par esse prolis, non sacer meritis parens; tam dulce si quid Veneris in vultu micat, merito illa amores caelitum atque hominum movet. Cum hi novissimi versus in tragoedia Euripidis pronuntiati essent, totus populus ad eiciendum et actorem et carmen consurrexit uno impetu, donec Euripides in medium ipse prosilivit petens ut expectarent viderentque quem admirator auri exitum faceret. Dabat in illa fabula poenas Bellerophontes quas in sua quisque dat. Nulla enim avaritia sine poena est, quamvis satis sit ipsa poenarum. O quantum lacrimarum, quantum laborum exigit! quam misera desideratis, quam misera partis est! Adice cotidianas sollicitudines quae pro modo habendi quemque discruciant. Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur. Quantum damnis ingemescunt, quae et magna incidunt et videntur maiora. Denique ut illis fortuna nihil detrahat, quidquid non adquiritur damnum est. «At felicem illum homines et divitem vocant et consequi optant quantum ille possidet». Fateor. Quid ergo? Tu ullos esse condicionis peioris existimas quam qui habent et miseriam et invidiam? Utinam qui divitias optaturi essent cum divitibus deliberarent; utinam honores petituri cum ambitiosis et summum adeptis dignitatis statum! Profecto vota mutassent, cum interim illi nova suscipiunt cum
priora damnaverint. Nemo enim est cui felicitas sua, etiam si cursu venit, satis faciat; queruntur et de consiliis et de processibus suis maluntque semper quae reliquerunt. Itaque hoc tibi philosophia praestabit, quo equidem nihil maius existimo: numquam te paenitebit tui. Ad hanc tam solidam felicitatem, quam tempestas nulla concutiat, non perducent te apte verba contexta et oratio fluens leniter: eant ut volent, dum animo compositio sua constet, dum sit magnus et opinionum securus et ob ipsa quae aliis displicent sibi placens, qui profectum suum vita aestimet et tantum scire se iudicet quantum non cupit, quantum non timet. Vale. 116. Utrum satius sit modicos habere adfectus an nullos saepe quaesitum est. Nostri illos expellunt, Peripatetici temperant. Ego non video quomodo salubris esse aut utilis possit ulla mediocritas morbi. Noli timere: nihil eorum quae tibi non vis negari eripio. Facilem me indulgentemque praebebo rebus ad quas tendis et quas aut necessarias vitae aut utiles aut iucundas putas: detraham vitium. Nam cum tibi cupere interdixero, velle permittam, ut eadem illa intrepidus facias, ut certiore consilio, ut voluptates ipsas magis sentias: quidni ad te magis perventurae sint si illis imperabis quam si servies? «Sed naturale est» inquis «ut desiderio amici torquear: da ius lacrimis tam iuste cadentibus. Naturale est opinionibus hominum tangi et adversis contristari: quare mihi non permittas hunc tam honestum malae opinionis metum?». Nullum est vitium sine patrocinio; nulli non initium verecundum est et exorabile, sed ab hoc latius funditur. Non obtinebis ut desinat si incipere permiseris. Inbecillus est primo omnis adfectus; deinde ipse se concitat et vires dum procedit parat: excluditur facilius quam expellitur. Quis negat omnis adfectus a quodam quasi naturali fluere principio? Curam nobis nostri natura mandavit, sed huic ubi nimium indulseris, vitium est. Voluptatem natura necessariis rebus admiscuit, non ut illam peteremus, sed ut ea sine quibus non possumus vivere gratiora nobis illius faceret accessio: suo veniat iure, luxuria est. Ergo intrantibus resistamus, quia facilius, ut dixi, non recipiuntur quam exeunt. «Aliquatenus» inquis «dolere, aliquatenus timere permitte». Sed illud «aliquatenus» longe producitur nec ubi vis accipit finem. Sapienti non sollicite custodire se tutum est, et lacrimas suas et voluptates ubi volet sistet: nobis, quia non est regredi facile, optimum est omnino non progredi. Eleganter mihi videtur Panaetius respondisse adulescentulo cuidam quaerenti an sapiens amaturus esset. «De sapiente» inquit «videbimus: mihi et tibi, qui adhuc a sapiente longe absumus, non est committendum ut incidamus in rem commotam, inpotentem, alteri emancupatam, vilem sibi. Sive enim nos respicit, humanitate eius inritamur, sive contempsit, superbia accendimur. Aeque facilitas amoris quam difficultas nocet: facilitate capimur, cum difficultate certamus. Itaque conscii nobis inbecillitatis nostrae quiescamus; nec vino infirmum animum committamus nec formae nec adulationi nec ullis rebus blande trahentibus». Quod Panaetius de amore quaerenti respondit, hoc ego de omnibus adfectibus dico: quantum possumus nos a lubrico recedamus; in sicco quoque parum fortiter
stamus. Occurres hoc loco mihi illa publica contra Stoicos voce: «nimis magna promittitis, nimis dura praecipitis. Nos homunciones sumus; omnia nobis negare non possumus. Dolebimus, sed parum; concupiscemus, sed temperate; irascemur, sed placabimur». Scis quare non possimus ista? Quia nos posse non credimus. Immo mehercules aliud est in re: vitia nostra quia amamus defendimus et malumus excusare illa quam excutere. Satis natura homini dedit roboris si illo utamur, si vires nostras colligamus ac totas pro nobis, certe non contra nos concitemus. Nolle in causa est, non posse praetenditur. Vale. 117. Multum mihi negotii concinnabis et, dum nescis, in magnam me litem ac molestiam inpinges, qui mihi tales quaestiunculas ponis, in quibus ego nec dissentire a nostris salva gratia nec consentire salva conscientia possum. Quaeris an verum sit quod Stoicis placet, sapientiam bonum esse, sapere bonum non esse. Primum exponam quid Stoicis videatur; deinde tunc dicere sententiam audebo. Placet nostris quod bonum est corpus esse, quia quod bonum est facit, quidquid facit corpus est. Quod bonum est prodest; faciat autem aliquid oportet ut prosit; si facit, corpus est. Sapientiam bonum esse dicunt; sequitur ut necesse sit illam corporalem quoque dicere. At sapere non putant eiusdem condicionis esse. Incorporale est et accidens alteri, id est sapientiae; itaque nec facit quicquam nec prodest. «Quid ergo?» inquit «non dicimus: bonum est sapere?». Dicimus referentes ad id ex quo pendet, id est ad ipsam sapientiam. Adversus hos quid ab aliis respondeatur audi, antequam ego incipio secedere et in alia parte considere. «Isto modo» inquiunt «nec beate vivere bonum est. Velint nolint, respondendum est beatam vitam bonum esse, beate vivere bonum non esse». Etiamnunc nostris illud quoque opponitur: «vultis sapere; ergo expetenda res est sapere; si expetenda res est, bona est». Coguntur nostri verba torquere et unam syllabam expetendo interponere quam sermo noster inseri non sinit. Ego illam, si pateris, adiungam. «Expetendum est» inquiunt «quod bonum est, expetibile quod nobis contingit cum bonum consecuti sumus. Non petitur tamquam bonum, sed petito bono accedit». Ego non idem sentio et nostros iudico in hoc descendere quia iam primo vinculo tenentur et mutare illis formulam non licet. Multum dare solemus praesumptioni omnium hominum et apud nos veritatis argumentum est aliquid omnibus videri; tamquam deos esse inter alia hoc colligimus, quod omnibus insita de dis opinio est nec ulla gens usquam est adeo extra leges moresque proiecta ut non aliquos deos credat. Cum de animarum aeternitate disserimus, non leve momentum apud nos habet consensus hominum aut timentium inferos aut colentium. Utor hac publica persuasione: neminem invenies qui non putet et sapientiam bonum et sapere. Non faciam quod victi solent, ut provocem ad populum: nostris incipiamus armis confligere. Quod accidit alicui, utrum extra id cui accidit est an in eo cui accidit? Si in eo est cui accidit, tam corpus est quam illud cui accidit. Nihil enim accidere sine tactu potest; quod tangit corpus est:
nihil accidere sine actu potest; quod agit corpus est. Si extra est, postea quam acciderat recessit; quod recessit motum habet; quod motum habet corpus est. Speras me dicturum non esse aliud cursum, aliud currere, nec aliud calorem, aliud calere, nec aliud lucem, aliud lucere: concedo ista alia esse, sed non sortis alterius. Si valetudo indifferens est, et bene valere indifferens est; si forma indifferens est, et formonsum esse. Si iustitia bonum est, et iustum esse; si turpitudo malum est, et turpem esse malum est, tam mehercules quam si lippitudo malum est, lippire quoque malum est. Hoc ut scias, neutrum esse sine altero potest: qui sapit sapiens est; qui sapiens est sapit. Adeo non potest dubitari an quale illud sit, tale hoc sit, ut quibusdam utrumque unum videatur atque idem. Sed illud libenter quaesierim, cum omnia aut mala sint aut bona aut indifferentia, sapere in quo numero sit? Bonum negant esse; malum utique non est; sequitur ut medium sit. Id autem medium atque indifferens vocamus quod tam malo contingere quam bono possit, tamquam pecunia, forma, nobilitas. Hoc, ut sapiat, contingere nisi bono non potest; ergo indifferens non est. Atqui ne malum quidem est, quod contingere malo non potest; ergo bonum est. Quod nisi bonus non habet bonum est; sapere non nisi bonus habet; ergo bonum est. «Accidens est» inquit «sapientiae». Hoc ergo quod vocas sapere, utrum facit sapientiam an patitur? Sive facit illud sive patitur, utroque modo corpus est; nam et quod fit et quod facit corpus est. Si corpus est, bonum est; unum enim illi deerat quominus bonum esset, quod incorporale erat. Peripateticis placet nihil interesse inter sapientiam et sapere, cum in utrolibet eorum et alterum sit. Numquid enim quemquam existimas sapere nisi qui sapientiam habet? Numquid quemquam qui sapit non putas habere sapientiam? Dialectici veteres ista distinguunt; ab illis divisio usque ad Stoicos venit. Qualis sit haec dicam. Aliud est ager, aliud agrum habere, quidni? Cum habere agrum ad habentem, non ad agrum pertineat. Sic aliud est sapientia, aliud sapere. Puto, concedes duo esse haec, id quod habetur et eum qui habet: habetur sapientia, habet qui sapit. Sapientia est mens perfecta vel ad summum optimumque perducta; ars enim vitae est. Sapere quid est? Non possum dicere «mens perfecta», sed id quod contingit perfectam mentem habenti; ita alterum est mens bona, alterum quasi habere mentem bonam. «Sunt» inquit «naturae corporum, tamquam hic homo est, hic equus; has deinde sequuntur motus animorum enuntiativi corporum. Hi habent proprium quiddam et a corporibus seductum, tamquam video Catonem ambulantem: hoc sensus ostendit, animus credidit. Corpus est quod video, cui et oculos intendi et animum. Dico deinde: Cato ambulat. Non corpus» inquit «est quod nunc loquor, sed enuntiativum quiddam de corpore, quod alii effatum vocant, alii enuntiatum, alii dictum. Sic cum dicimus “sapientiam”, corporale quiddam intellegimus; cum dicimus “sapit”, de corpore loquimur. Plurimum autem interest utrum illud dicas an de illo». Putemus in praesentia ista duo esse (nondum enim quid mihi videatur pronuntio): quid prohibet quominus aliud quidem sit sed nihilominus bonum?
Dicebam paulo ante aliud esse agrum, aliud habere agrum. Quidni? In alia enim natura est qui habet, in alia quod habetur: illa terra est, hic homo est. At in hoc de quo agitur eiusdem naturae sunt utraque, et qui habet sapientiam et ipsa. Praeterea illic aliud est quod habetur, alius qui habet: hic in eodem est et quod habetur et qui habet. Ager iure possidetur, sapientia natura; ille abalienari potest et alteri tradi, haec non discedit a domino. Non est itaque quod compares inter se dissimilia. Coeperam dicere posse ista duo esse et tamen utraque bona esse, tamquam sapientia et sapiens duo sunt et utrumque bonum esse concedis. Quomodo nihil obstat quominus et sapientia bonum sit et habens sapientiam, sic nihil obstat quominus et sapientia bonum sit et habere sapientiam, id est sapere. Ego in hoc volo sapiens esse, ut sapiam. Quid ergo? Non est id bonum sine quo nec illud bonum est? Vos certe dicitis sapientiam, si sine usu detur, accipiendam non esse. Quid est usus sapientiae? Sapere: hoc est in illa pretiosissimum, quo detracto supervacua fit. Si tormenta mala sunt, torqueri malum est, adeo quidem ut illa non sint mala si quod sequitur detraxeris. Sapientia habitus perfectae mentis est, sapere usus perfectae mentis: quomodo potest usus eius bonum non esse quae sine usu bonum non est? Interrogo te an sapientia expetenda sit: fateris. Interrogo an usus sapientiae expetendus sit: fateris. Negas enim te illam recepturum si uti ea prohibearis. Quod expetendum est bonum est. Sapere sapientiae usus est, quomodo eloquentiae eloqui, quomodo oculorum videre. Ergo sapere sapientiae usus est, usus autem sapientiae expetendus est; sapere ergo expetendum est; si expetendum est, bonum est. Olim ipse me damno qui illos imitor dum accuso et verba apertae rei inpendo. Cui enim dubium potest esse quin, si aestus malum est, et aestuare malum sit? Si algor malum est, malum sit algere? Si vita bonum est, et vivere bonum sit? Omnia ista circa sapientiam, non in ipsa sunt; at nobis in ipsa commorandum est. Etiam si quid evagari libet, amplos habet illa spatiososque secessus: de deorum natura quaeramus, de siderum alimento, de his tam variis stellarum discursibus, an ad illarum motus nostra moveantur, an corporibus omnium animisque illinc impetus veniat, an et haec quae fortuita dicuntur certa lege constricta sint nihilque in hoc mundo repentinum aut expers ordinis volutetur. Ista iam a formatione morum recesserunt, sed levant animum et ad ipsarum quas tractat rerum magnitudinem attollunt; haec vero de quibus paulo ante dicebam minuunt et deprimunt nec, ut putatis, exacuunt, sed extenuant. Obsecro vos, tam necessariam curam maioribus melioribusque debitam in re nescio an falsa, certe inutili terimus? Quid mihi profuturum est scire an aliud sit sapientia, aliud sapere? Quid mihi profuturum est scire illud bonum esse, hoc non esse? Temere me geram, subibo huius voti aleam: tibi sapientia, mihi sapere contingat. Pares erimus. Potius id age ut mihi viam monstres qua ad ista perveniam. Dic quid vitare debeam, quid adpetere, quibus animum labantem studiis firmem, quemadmodum quae me ex transverso feriunt aguntque procul a me repellam, quomodo par esse tot malis possim, quomodo istas calamitates
removeam quae ad me inruperunt, quomodo illas ad quas ego inrupi. Doce quomodo feram aerumnam sine gemitu meo, felicitatem sine alieno, quomodo ultimum ac necessarium non expectem sed ipsemet, cum visum erit, profugiam. Nihil mihi videtur turpius quam optare mortem. Nam si vis vivere, quid optas mori? Sive non vis, quid deos rogas quod tibi nascenti dederunt? Nam ut quandoque moriaris etiam invito positum est, ut cum voles in tua manu est; alterum tibi necesse est, alterum licet. Turpissimum his diebus principium diserti mehercules viri legi: «Ita» inquit «quam primum moriar». Homo demens, optas rem tuam. «Ita quam primum moriar». Fortasse inter has voces senex factus es; alioqui quid in mora est? Nemo te tenet: evade qua visum est; elige quamlibet rerum naturae partem, quam tibi praebere exitum iubeas. Haec nempe sunt et elementa quibus hic mundus administratur; aqua, terra, spiritus, omnia ista tam causae vivendi sunt quam viae mortis. «Ita quam primum moriar»: «quam primum» istud quid esse vis? Quem illi diem ponis? Citius fieri quam optas potest. Inbecillae mentis ista sunt verba et hac detestatione misericordiam captantis: non vult mori qui optat. Deos vitam et salutem roga: si mori placuit, hic mortis est fructus, optare desinere. Haec, mi Lucili, tractemus, his formemus animum. Hoc est sapientia, hoc est sapere, non disputatiunculis inanibus subtilitatem vanissimam agitare. Tot quaestiones fortuna tibi posuit, nondum illas solvisti: iam cavillaris? Quam stultum est, cum signum pugnae acceperis, ventilare. Remove ista lusoria arma: decretoriis opus est. Dic qua ratione nulla animum tristitia, nulla formido perturbet, qua ratione hoc secretarum cupiditatium pondus effundam. Agatur aliquid. «Sapientia bonum est, sapere non est bonum»: sic fit ut negemur sapere, ut hoc totum studium derideatur tamquam operatum supervacuis. Quid si scires etiam illud quaeri, an bonum sit futura sapientia? Quid enim dubi est, oro te, an nec messem futuram iam sentiant horrea nec futuram adulescentiam pueritia viribus aut ullo robore intellegat? Aegro interim nil ventura sanitas prodest, non magis quam currentem luctantemque post multos secuturum menses otium reficit. Quis nescit hoc ipso non esse bonum id quod futurum est, quia futurum est? Nam quod bonum est utique prodest; nisi praesentia prodesse non possunt. Si non prodest, bonum non est; si prodest, iam est. Futurus sum sapiens; hoc bonum erit cum fuero: interim non est. Prius aliquid esse debet, deinde quale esse. Quomodo, oro te, quod adhuc nihil est iam bonum est? Quomodo autem tibi magis vis probari non esse aliquid quam si dixero «futurum est»? Nondum enim venisse apparet quod veniet. Ver secuturum est: scio nunc hiemem esse. Aestas secutura est: scio aestatem non esse. Maximum argumentum habeo nondum praesentis futurum esse. Sapiam, spero, sed interim non sapio; si illud bonum haberem, iam hoc carerem malo. Futurum est ut sapiam: ex hoc licet nondum sapere me intellegas. Non possum simul et in illo bono et in hoc malo esse; duo ista non coeunt nec apud eundem sunt una malum et bonum. Transcurramus sollertissimas nugas et ad illa quae nobis aliquam opem sunt latura properemus. Nemo qui obstetricem parturienti filiae sollicitus accersit
edictum et ludorum ordinem perlegit; nemo qui ad incendium domus suae currit tabulam latrunculariam prospicit ut sciat quomodo alligatus exeat calculus. At mehercule omnia tibi undique nuntiantur, et incendium domus et periculum liberorum et obsidio patriae et bonorum direptio; adice isto naufragia motusque terrarum et quidquid aliud timeri potest: inter ista districtus rebus nihil aliud quam animum oblectantibus vacas? Quid inter sapientiam et sapere intersit inquiris? Nodos nectis ac solvis tanta mole inpendente capiti tuo? Non tam benignum ac liberale tempus natura nobis dedit ut aliquid ex illo vacet perdere. Et vide quam multa etiam diligentissimis pereant: aliud valetudo sua cuique abstulit, aliud suorum; aliud necessaria negotia, aliud publica occupaverunt; vitam nobiscum dividit somnus. Ex hoc tempore tam angusto et rapido et nos auferente quid iuvat maiorem partem mittere in vanum? Adice nunc quod adsuescit animus delectare se potius quam sanare et philosophiam oblectamentum facere cum remedium sit. Inter sapientiam et sapere quid intersit nescio: scio mea non interesse sciam ista an nesciam. Dic mihi: cum quid inter sapientiam et sapere intersit didicero, sapiam? Cur ergo potius inter vocabula me sapientiae detines quam inter opera? Fac me fortiorem, fac securiorem, fac fortunae parem, fac superiorem. Possum autem superior esse si derexero eo omne quod disco. Vale.
Liber vicensimus 118. Exigis a me frequentiores epistulas. Rationes conferamus: solvendo non eris. Convenerat quidem ut tua priora essent: tu scriberes, ego rescriberem. Sed non ero difficilis: bene credi tibi scio. Itaque in anticessum dabo nec faciam quod Cicero, vir disertissimus, facere Atticum iubet, ut etiam «si rem nullam habebit, quod in buccam venerit scribat». Numquam potest deesse quod scribam, ut omnia illa quae Ciceronis implent epistulas transeam: quis candidatus laboret; quis alienis, quis suis viribus pugnet; quis consulatum fiducia Caesaris, quis Pompei, quis arcae petat; quam durus sit fenerator Caecilius, a quo minoris centesimis propinqui nummum movere non possint. Sua satius est mala quam aliena tractare, se excutere et videre quam multarum rerum candidatus sit, et non suffragari. Hoc est, mi Lucili, egregium, hoc securum ac liberum, nihil petere et tota fortunae comitia transire. Quam putas esse iucundum tribubus vocatis, cum candidati in templis suis pendeant et alius nummos pronuntiet, alius per sequestrem agat, alius eorum manus osculis conterat quibus designatus contingendam manum negaturus est, omnes attoniti vocem praeconis expectent, stare otiosum et spectare illas nundinas nec ementem quicquam nec vendentem? Quanto hic maiore gaudio fruitur qui non praetoria aut consularia comitia securus intuetur, sed magna illa in quibus alii honores anniversarios petunt, alii perpetuas potestates, alii bellorum eventus prosperos triumphosque, alii divitias, alii matrimonia ac liberos, alii salutem suam suorumque! Quanti animi res est solum nihil petere, nulli supplicare, et dicere, «nihil mihi tecum, fortuna; non facio mei tibi copiam. Scio apud te Catones repelli, Vatinios fieri. Nihil rogo». Hoc est privatam facere fortunam. Licet ergo haec in vicem scribere et hanc semper integram egerere materiam circumspicientibus tot milia hominum inquieta, qui ut aliquid pestiferi consequantur per mala nituntur in malum petuntque mox fugienda aut etiam fastidienda. Cui enim adsecuto satis fuit quod optanti nimium videbatur? Non est, ut existimant homines, avida felicitas sed pusilla; itaque neminem satiat. Tu ista credis excelsa quia longe ab illis iaces; ei vero qui ad illa pervenit humilia sunt. Mentior nisi adhuc quaerit escendere: istud quod tu summum putas gradus est. Omnes autem male habet ignorantia veri. Tamquam ad bona feruntur decepti rumoribus, deinde mala esse aut inania aut minora quam speraverint adepti ac multa passi vident; maiorque pars miratur ex intervallo fallentia, et vulgo bona pro magnis sunt. Hoc ne nobis quoque eveniat, quaeramus quid sit bonum. Varia eius interpretatio fuit, alius illud aliter expressit. Quidam ita finiunt: «bonum est quod invitat animos, quod ad se vocat». Huic statim opponitur: quid si invitat quidem sed in perniciem? Scis quam multa mala blanda sint. Verum et veri simile inter se differunt. Ita quod bonum est vero iungitur; non est enim bonum nisi verum est. At quod invitat ad se et adlicefacit veri simile est: subrepit, sollicitat, adtrahit. Quidam ita finierunt: «bonum est quod adpetitionem sui movet, vel quod impetum
animi tendentis ad se movet». Et huic idem opponitur; multa enim impetum animi movent quae petantur petentium malo. Melius illi qui ita finierunt: «bonum est quod ad se impetum animi secundum naturam movet et ita demum petendum est cum coepit esse expetendum». Iam et honestum est; hoc enim est perfecte petendum. Locus ipse me admonet ut quid intersit inter bonum honestumque dicam. Aliquid inter se mixtum habent et inseparabile: nec potest bonum esse nisi cui aliquid honesti inest, et honestum utique bonum est. Quid ergo inter duo interest? Honestum est perfectum bonum, quo beata vita completur, cuius contactu alia quoque bona fiunt. Quod dico talest: sunt quaedam neque bona neque mala, tamquam militia, legatio, iurisdictio. Haec cum honeste administrata sunt, bona esse incipiunt et ex dubio in bonum transeunt. Bonum societate honesti fit, honestum per se bonum est; bonum ex honesto fluit, honestum ex se est. Quod bonum est malum esse potuit; quod honestum est nisi bonum esse non potuit. Hanc quidam finitionem reddiderunt: «bonum est quod secundum naturam est». Adtende quid dicam: quod bonum, est secundum naturam: non protinus quod secundum naturam est etiam bonum est. Multa naturae quidem consentiunt, sed tam pusilla sunt ut non conveniat illis boni nomen; levia enim sunt, contemnenda. Nullum est minimum contemnendum bonum; nam quamdiu exiguum est bonum non est: cum bonum esse coepit, non est exiguum. Unde adcognoscitur bonum? Si perfecte secundum naturam est. «Fateris» inquis «quod bonum est secundum naturam esse; haec eius proprietas est. Fateris et alia secundum naturam quidem esse sed bona non esse. Quomodo ergo illud bonum est cum haec non sint? Quomodo ad aliam proprietatem pervenit cum utrique praecipuum illud commune sit, secundum naturam esse?». Ipsa scilicet magnitudine. Nec hoc novum est, quaedam crescendo mutari. Infans fuit; factus est pubes: alia eius proprietas fit; ille enim inrationalis est, hic rationalis. Quaedam incremento non tantum in maius exeunt sed in aliud. «Non fit» inquit «aliud quod maius fit. Utrum lagonam an dolium impleas vino, nihil refert: in utroque proprietas vini est. Et exiguum mellis pondus et magnum sapore non differt». Diversa ponis exempla; in istis enim eadem qualitas est; quamvis augeantur, manet. Quaedam amplificata in suo genere et in sua proprietate perdurant; quaedam post multa incrementa ultima demum vertit adiectio et novam illis aliamque quam in qua fuerunt condicionem inprimit. Unus lapis facit fornicem, ille qui latera inclinata cuneavit et interventu suo vinxit. Summa adiectio quare plurimum facit vel exigua? Quia non auget sed implet. Quaedam processu priorem exuunt formam et in novam transeunt. Ubi aliquid animus diu protulit et magnitudinem eius sequendo lassatus est, infinitum coepit vocari; quod longe aliud factum est quam fuit cum magnum videretur sed finitum. Eodem modo aliquid difficulter secari cogitavimus: novissime crescente hac difficultate insecabile inventum est. Sic ab eo quod vix et aegre movebatur processimus ad inmobile. Eadem ratione aliquid secundum naturam fuit: hoc in aliam proprietatem magnitudo sua transtulit et bonum fecit. Vale. 119. Quotiens aliquid inveni, non expecto donec dicas «in commune»: ipse
mihi dico. Quid sit quod invenerim quaeris? Sinum laxa, merum lucrum est. Docebo quomodo fieri dives celerrime possis. Quam valde cupis audire! nec inmerito: ad maximas te divitias conpendiaria ducam. Opus erit tamen tibi creditore: ut negotiari possis, aes alienum facias oportet, sed nolo per intercessorem mutueris, nolo proxenetae nomen tuum iactent. Paratum tibi creditorem dabo Catonianum illum, a te mutuum sumes. Quantulumcumque est, satis erit si, quidquid deerit, id a nobis petierimus. Nihil enim, mi Lucili, interest utrum non desideres an habeas. Summa rei in utroque eadem est: non torqueberis. Nec illud praecipio, ut aliquid naturae neges – contumax est, non potest vinci, suum poscit – sed ut quidquid naturam excedit scias precarium esse, non necessarium. Esurio: edendum est. Utrum hic panis sit plebeius an siligineus ad naturam nihil pertinet: illa ventrem non delectari vult sed impleri. Sitio: utrum haec aqua sit quam ex lacu proximo excepero an ea quam multa nive clusero, ut rigore refrigeretur alieno, ad naturam nihil pertinet. Illa hoc unum iubet, sitim extingui; utrum sit aureum poculum an crustallinum an murreum an Tiburtinus calix an manus concava, nihil refert. Finem omnium rerum specta, et supervacua dimittes. Fames me appellat: ad proxima quaeque porrigatur manus; ipsa mihi commendabit quodcumque conprendero. Nihil contemnit esuriens. Quid sit ergo quod me delectaverit quaeris? Videtur mihi egregie dictum, «sapiens divitiarum naturalium est quaesitor acerrimus». «Inani me» inquis «lance muneras. Quid est istud? Ego iam paraveram fiscos; circumspiciebam in quod me mare negotiaturus inmitterem, quod publicum agitarem, quas arcesserem merces. Decipere est istud, docere paupertatem cum divitias promiseris». Ita tu pauperem iudicas cui nihil deest? «Suo» inquis «et patientiae suae beneficio, non fortunae». Ideo ergo illum non iudicas divitem quia divitiae eius desinere non possunt? Utrum mavis habere multum an satis? Qui multum habet plus cupit, quod est argumentum nondum illum satis habere; qui satis habet consecutus est quod numquam diviti contigit, finem. An has ideo non putas esse divitias quia propter illas nemo proscriptus est? Quia propter illas nulli venenum filius, nulli uxor inpegit? Quia in bello tutae sunt? Quia in pace otiosae? Quia nec habere illas periculosum est nec operosum disponere? «At parum habet qui tantum non alget, non esurit, non sitit». Plus Iuppiter non habet. Numquam parum est quod satis est, et numquam multum est quod satis non est. Post Dareum et Indos pauper est Alexander. Mentior? Quaerit quod suum faciat, scrutatur maria ignota, in oceanum classes novas mittit et ipsa, ut ita dicam, mundi claustra perrumpit. Quod naturae satis est homini non est. Inventus est qui concupisceret aliquid post omnia: tanta est caecitas mentium et tanta initiorum suorum unicuique, cum processit, oblivio. Ille modo ignobilis anguli non sine controversia dominus tacto fine terrarum per suum rediturus orbem tristis est. Neminem pecunia divitem fecit, immo contra nulli non maiorem sui cupidinem incussit. Quaeris quae sit huius rei causa? Plus incipit habere posse qui plus habet. Ad summam quem voles mihi ex his quorum nomina cum Crasso Licinoque numerantur in medium licet protrahas; adferat censum et quidquid
habet et quidquid sperat simul conputet: iste, si mihi credis, pauper est, si tibi, potest esse. At hic qui se ad quod exigit natura composuit non tantum extra sensum est paupertatis sed extra metum. Sed ut scias quam difficile sit res suas ad naturalem modum coartare, hic ipse quem circumcidimus, quem tu vocas pauperem, habet aliquid et supervacui. At excaecant populum et in se convertunt opes, si numerati multum ex aliqua domo effertur, si multum auri tecto quoque eius inlinitur, si familia aut corporibus electa aut spectabilis cultu est. Omnium istorum felicitas in publicum spectat: ille quem nos et populo et fortunae subduximus beatus introsum est. Nam quod ad illos pertinet apud quos falso divitiarum nomen invasit occupata paupertas, sic divitias habent quomodo habere dicimur febrem, cum illa nos habeat. E contrario dicere solemus «febris illum tenet»: eodem modo dicendum est «divitiae illum tenent». Nihil ergo monuisse te malim quam hoc, quod nemo monetur satis, ut omnia naturalibus desideriis metiaris, quibus aut gratis satis fiat aut parvo: tantum miscere vitia desideriis noli. Quaeris quali mensa, quali argento, quam paribus ministeriis et levibus adferatur cibus? Nihil praeter cibum natura desiderat. Num, tibi cum fauces urit sitis, aurea quaeris pocula? Num esuriens fastidis omnia praeter pavonem rhombumque? Ambitiosa non est fames, contenta desinere est; quo desinat non nimis curat. Infelicis luxuriae ista tormenta sunt: quaerit quemadmodum post saturitatem quoque esuriat, quemadmodum non impleat ventrem sed farciat, quemadmodum sitim prima potione sedatam revocet. Egregie itaque Horatius negat ad sitim pertinere quo poculo aut quam eleganti manu ministretur. Nam si pertinere ad te iudicas quam crinitus puer et quam perlucidum tibi poculum porrigat, non sitis. Inter reliqua hoc nobis praestitit natura praecipuum, quod necessitati fastidium excussit. Recipiunt supervacua dilectum: «hoc parum decens, illud parum lautum, oculos hoc meos laedit». Id actum est ab illo mundi conditore, qui nobis vivendi iura discripsit, ut salvi essemus, non ut delicati: ad salutem omnia parata sunt et in promptu, delicis omnia misere ac sollicite comparantur. Utamur ergo hoc naturae beneficio inter magna numerando et cogitemus nullo nomine melius illam meruisse de nobis quam quia quidquid ex necessitate desideratur sine fastidio sumitur. Vale. 120. Epistula tua per plures quaestiunculas vagata est sed in una constitit et hanc expediri desiderat, quomodo ad nos boni honestique notitia pervenerit. Haec duo apud alios diversa sunt, apud nos tantum divisa. Quid sit hoc dicam. Bonum putant esse aliqui id quod utile est. Itaque hoc et divitiis et equo et vino et calceo nomen inponunt; tanta fit apud illos boni vilitas et adeo in sordida usque descendit. Honestum putant cui ratio recti officii constat, tamquam pie curatam patris senectutem, adiutam amici paupertatem, fortem expeditionem, prudentem
moderatamque sententiam. Nos ista duo quidem facimus, sed ex uno. Nihil est bonum nisi quod honestum est; quod honestum, est utique bonum. Supervacuum iudico adicere quid inter ista discriminis sit, cum saepe dixerim. Hoc unum dicam, nihil nobis videri bonum quo quis et male uti potest; vides autem divitiis, nobilitate, viribus quam multi male utantur. Nunc ergo ad id revertor de quo desideras dici, quomodo ad nos prima boni honestique notitia pervenerit. Hoc nos natura docere non potuit: semina nobis scientiae dedit, scientiam non dedit. Quidam aiunt nos in notitiam incidisse, quod est incredibile, virtutis alicui speciem casu occucurrisse. Nobis videtur observatio collegisse et rerum saepe factarum inter se conlatio; per analogian nostri intellectum et honestum et bonum iudicant. Hoc verbum cum Latini grammatici civitate donaverint, ego damnandum non puto, immo in civitatem suam redigendum. Utar ergo illo non tantum tamquam recepto sed tamquam usitato. Quae sit haec analogia dicam. Noveramus corporis sanitatem: ex hac cogitavimus esse aliquam et animi. Noveramus vires corporis: ex his collegimus esse et animi robur. Aliqua benigna facta, aliqua humana, aliqua fortia nos obstupefecerant: haec coepimus tamquam perfecta mirari. Suberant illis multa vitia quae species conspicui alicuius facti fulgorque celabat: haec dissimulavimus. Natura iubet augere laudanda, nemo non gloriam ultra verum tulit: ex his ergo speciem ingentis boni traximus. Fabricius Pyrrhi regis aurum reppulit maiusque regno iudicavit regias opes posse contemnere. Idem medico Pyrrhi promittente venenum se regi daturum monuit Pyrrhum caveret insidias. Eiusdem animi fuit auro non vinci, veneno non vincere. Admirati sumus ingentem virum quem non regis, non contra regem promissa flexissent, boni exempli tenacem, quod difficillimum est, in bello innocentem, qui aliquod esse crederet etiam in hostes nefas, qui in summa paupertate quam sibi decus fecerat non aliter refugit divitias quam venenum. «Vive» inquit «beneficio meo, Pyrrhe, et gaude quod adhuc dolebas, Fabricium non posse corrumpi». Horatius Cocles solus implevit pontis angustias adimique a tergo sibi reditum, dummodo iter hosti auferretur, iussit et tam diu prementibus restitit donec revulsa ingenti ruina tigna sonuerunt. Postquam respexit et extra periculum esse patriam periculo suo sensit, «veniat, si quis vult» inquit «sic euntem sequi» iecitque se in praeceps et non minus sollicitus in illo rapido alveo fluminis ut armatus quam ut salvus exiret, retento armorum victricium decore tam tutus redit quam si ponte venisset. Haec et eiusmodi facta imaginem nobis ostendere virtutis. Adiciam quod mirum fortasse videatur: mala interdum speciem honesti obtulere et optimum ex contrario enituit. Sunt enim, ut scis, virtutibus vitia confinia, et perditis quoque ac turpibus recti similitudo est: sic mentitur prodigus liberalem, cum plurimum intersit utrum quis dare sciat an servare nesciat. Multi, inquam, sunt, Lucili, qui non donant sed proiciunt: non voco ego liberalem pecuniae suae iratum. Imitatur neglegentia facilitatem, temeritas fortitudinem. Haec nos similitudo coegit adtendere et distinguere specie quidem vicina, re autem plurimum inter se dissidentia. Dum observamus eos quos insignes
egregium opus fecerat, coepimus adnotare quis rem aliquam generoso animo fecisset et magno impetu, sed semel. Hunc vidimus in bello fortem, in foro timidum, animose paupertatem ferentem, humiliter infamiam: factum laudavimus, contempsimus virum. Alium vidimus adversus amicos benignum, adversus inimicos temperatum, et publica et privata sancte ac religiose administrantem; non deesse ei in iis quae toleranda erant patientiam, in iis quae agenda prudentiam. Vidimus ubi tribuendum esset plena manu dantem, ubi laborandum, pertinacem et obnixum et lassitudinem corporis animo sublevantem. Praeterea idem erat semper et in omni actu par sibi, iam non consilio bonus, sed more eo perductus ut non tantum recte facere posset, sed nisi recte facere non posset. Intelleximus in illo perfectam esse virtutem. Hanc in partes divisimus: oportebat cupiditates refrenari, metus conprimi, facienda provideri, reddenda distribui: conprehendimus temperantiam, fortitudinem, prudentiam, iustitiam et suum cuique dedimus officium. Ex quo ergo virtutem intelleximus? Ostendit illam nobis ordo eius et decor et constantia et omnium inter se actionum concordia et magnitudo super omnia efferens sese. Hinc intellecta est illa beata vita secundo defluens cursu, arbitrii sui tota. Quomodo ergo hoc ipsum nobis apparuit? Dicam. Numquam vir ille perfectus adeptusque virtutem fortunae maledixit, numquam accidentia tristis excepit, civem esse se universi et militem credens labores velut imperatos subit. Quidquid inciderat non tamquam malum aspernatus est et in se casu delatum, sed quasi delegatum sibi. «Hoc qualecumque est» inquit «meum est; asperum est, durum est, in hoc ipso navemus operam». Necessario itaque magnus apparuit qui numquam malis ingemuit, numquam de fato suo questus est; fecit multis intellectum sui et non aliter quam in tenebris lumen effulsit advertitque in se omnium animos, cum esset placidus et lenis, humanis divinisque rebus pariter aequus. Habebat perfectum animum et ad summam sui adductum, supra quam nihil est nisi mens dei, ex quo pars et in hoc pectus mortale defluxit; quod numquam magis divinum est quam ubi mortalitatem suam cogitat et scit in hoc natum hominem, ut vita defungeretur, nec domum esse hoc corpus sed hospitium, et quidem breve hospitium, quod relinquendum est ubi te gravem esse hospiti videas. Maximum, inquam, mi Lucili, argumentum est animi ab altiore sede venientis, si haec in quibus versatur humilia iudicat et angusta, si exire non metuit; scit enim quo exiturus sit qui unde venerit meminit. Non videmus quam multa nos incommoda exagitent, quam male nobis conveniat hoc corpus? Nunc de capite, nunc de ventre, nunc de pectore ac faucibus querimur; alias nervi nos, alias pedes vexant, nunc deiectio, nunc destillatio; aliquando superest sanguis, aliquando deest: hinc atque illinc temptamur et expellimur. Hoc evenire solet in alieno habitantibus. At nos corpus tam putre sortiti nihilominus aeterna proponimus et in quantum potest aetas humana protendi, tantum spe occupamus, nulla contenti pecunia, nulla potentia. Quid hac re fieri inpudentius, quid stultius potest? Nihil satis est morituris, immo morientibus; cotidie enim propius ab ultimo stamus, et illo unde nobis cadendum est hora nos omnis inpellit. Vide in quanta caecitate mens nostra sit: hoc quod futurum dico cum maxime fit, et pars
eius magna iam facta est; nam quod viximus tempus eo loco est quo erat antequam viximus. Erramus autem qui ultimum timemus diem, cum tantumdem in mortem singuli conferant. Non ille gradus lassitudinem facit in quo deficimus, sed ille profitetur; ad mortem dies extremus pervenit, accedit omnis; carpit nos illa, non corripit. Ideo magnus animus conscius sibi melioris naturae dat quidem operam ut in hac statione qua positus est honeste se atque industrie gerat, ceterum nihil horum quae circa sunt suum iudicat, sed ut commodatis utitur, peregrinus et properans. Cum aliquem huius videremus constantiae, quidni subiret nos species non usitatae indolis? Utique si hanc, ut dixi, magnitudinem veram esse ostendebat aequalitas. Vero tenor permanet, falsa non durant. Quidam alternis Vatinii, alternis Catones sunt; et modo parum illis severus est Curius, parum pauper Fabricius, parum frugi et contentus vilibus Tubero, modo Licinum divitis, Apicium cenis, Maecenatem delicis provocant. Maximum indicium est malae mentis fluctuatio et inter simulationem virtutum amoremque vitiorum adsidua iactatio. Habebat saepe ducentos, saepe decem servos; modo reges atque tetrarchas, omnia magna loquens, modo «sit mihi mensa tripes et concha salis puri, toga quae defendere frigus quamvis crassa queat». Decies centena dedisses huic parco, paucis contento: quinque diebus nil erat. Homines multi tales sunt qualem hunc describit Horatius Flaccus, numquam eundem, ne similem quidem sibi; adeo in diversum aberrat. Multos dixi? Prope est ut omnes sint. Nemo non cotidie et consilium mutat et votum: modo uxorem vult habere, modo amicam, modo regnare vult, modo id agit ne quis sit officiosior servus, modo dilatat se usque ad invidiam, modo subsidit et contrahitur infra humilitatem vere iacentium, nunc pecuniam spargit, nunc rapit. Sic maxime coarguitur animus inprudens: alius prodit atque alius et, quo turpius nihil iudico, inpar sibi est. Magnam rem puta unum hominem agere. Praeter sapientem autem nemo unum agit, ceteri multiformes sumus. Modo frugi tibi videbimur et graves, modo prodigi et vani; mutamus subinde personam et contrariam ei sumimus quam exuimus. Hoc ergo a te exige, ut qualem institueris praestare te, talem usque ad exitum serves; effice ut possis laudari, si minus, ut adgnosci. De aliquo quem here vidisti merito dici potest «hic qui est?»: tanta mutatio est. Vale. 121. Litigabis, ego video, cum tibi hodiernam quaestiunculam, in qua satis diu haesimus, exposuero; iterum enim exclamabis «hoc quid ad mores?» Sed exclama, dum tibi primum alios opponam cum quibus litiges, Posidonium et
Archidemum (hi iudicium accipient), deinde dicam: non quidquid morale est mores bonos facit. Aliud ad hominem alendum pertinet, aliud ad exercendum, aliud ad vestiendum, aliud ad docendum, aliud ad delectandum; omnia tamen ad hominem pertinent, etiam si non omnia meliorem eum faciunt. Mores alia aliter attingunt: quaedam illos corrigunt et ordinant, quaedam naturam eorum et originem scrutantur. Cum quaero quare hominem natura produxerit, quare praetulerit animalibus ceteris, longe me iudicas mores reliquisse? Falsum est. Quomodo enim scies qui habendi sint nisi quid homini sit optimum inveneris, nisi naturam eius inspexeris? Tunc demum intelleges quid faciendum tibi, quid vitandum sit, cum didiceris quid naturae tuae debeas. «Ego» inquis «volo discere quomodo minus cupiam, minus timeam. Superstitionem mihi excute; doce leve esse vanumque hoc quod felicitas dicitur, unam illi syllabam facillime accedere». Desiderio tuo satis faciam: et virtutes exhortabor et vitia converberabo. Licet aliquis nimium inmoderatumque in hac parte me iudicet, non desistam persequi nequitiam et adfectus efferatissimos inhibere et voluptates ituras in dolorem conpescere et votis obstrepere. Quidni? Cum maxima malorum optaverimus, et ex gratulatione natum sit quidquid adloquimur. Interim permitte mihi ea quae paulo remotiora videntur excutere. Quaerebamus an esset omnibus animalibus constitutionis suae sensus. Esse autem ex eo maxime apparet quod membra apte et expedite movent non aliter quam in hoc erudita; nulli non partium suarum agilitas est. Artifex instrumenta sua tractat ex facili, rector navis scite gubernaculum flectit, pictor colores quos ad reddendam similitudinem multos variosque ante se posuit celerrime denotat et inter ceram opusque facili vultu ac manu commeat: sic animal in omnem usum sui mobilest. Mirari solemus saltandi peritos quod in omnem significationem rerum et adfectuum parata illorum est manus et verborum velocitatem gestus adsequitur: quod illis ars praestat, his natura. Nemo aegre molitur artus suos, nemo in usu sui haesitat. Hoc edita protinus faciunt; cum hac scientia prodeunt; instituta nascuntur. «Ideo» inquit «partes suas animalia apte movent quia, si aliter moverint, dolorem sensura sunt. Ita, ut vos dicitis, coguntur, metusque illa in rectum, non voluntas movet». Quod est falsum; tarda enim sunt quae necessitate inpelluntur, agilitas sponte motis est. Adeo autem non adigit illa ad hoc doloris timor ut in naturalem motum etiam dolore prohibente nitantur. Sic infans qui stare meditatur et ferre se adsuescit, simul temptare vires suas coepit, cadit et cum fletu totiens resurgit donec se per dolorem ad id quod natura poscit exercuit. Animalia quaedam tergi durioris inversa tam diu se torquent ac pedes exerunt et obliquant donec ad locum reponantur. Nullum tormentum sentit supina testudo, inquieta est tamen desiderio naturalis status nec ante desinit niti, quatere se, quam in pedes constitit. Ergo omnibus constitutionis suae sensus est et inde membrorum tam expedita tractatio, nec ullum maius indicium habemus cum hac illa ad vivendum venire notitia quam quod nullum animal ad usum sui rude est. «Constitutio» inquit «est, ut vos dicitis, principale animi quodam modo se habens erga corpus. Hoc tam perplexum et subtile et vobis quoque vix enarrabile
quomodo infans intellegit? Omnia animalia dialectica nasci oportet ut istam finitionem magnae parti hominum togatorum obscuram intellegant». Verum erat quod opponis si ego ab animalibus constitutionis finitionem intellegi dicerem, non ipsam constitutionem. Facilius natura intellegitur quam enarratur. Itaque infans ille quid sit constitutio non novit, constitutionem suam novit; et quid sit animal nescit, animal esse se sentit. Praeterea ipsam constitutionem suam crasse intellegit et summatim et obscure. Nos quoque animum habere nos scimus: quid sit animus, ubi sit, qualis sit aut unde nescimus. Qualis ad nos animi nostri sensus, quamvis naturam eius ignoremus ac sedem, talis ad omnia animalia constitutionis suae sensus est. Necesse est enim id sentiant per quod alia quoque sentiunt; necesse est eius sensum habeant cui parent, a quo reguntur. Nemo non ex nobis intellegit esse aliquid quod impetus suos moveat: quid sit illud ignorat. Et conatum sibi esse scit: quis sit aut unde sit nescit. Sic infantibus quoque animalibusque principalis partis suae sensus est non satis dilucidus nec expressus. «Dicitis» inquit «omne animal primum constitutioni suae conciliari, hominis autem constitutionem rationalem esse et ideo conciliari hominem sibi non tamquam animali sed tamquam rationali; ea enim parte sibi carus est homo qua homo est. Quomodo ergo infans conciliari constitutioni rationali potest, cum rationalis nondum sit?» Unicuique aetati sua constitutio est, alia infanti, alia puero, alia adulescenti, alia seni: omnes ei constitutioni conciliantur in qua sunt. Infans sine dentibus est: huic constitutioni suae conciliatur. Enati sunt dentes: huic constitutioni conciliatur. Nam et illa herba quae in segetem frugemque ventura est aliam constitutionem habet tenera et vix eminens sulco, aliam cum convaluit et molli quidem culmo, sed quo ferat onus suum, constitit, aliam cum flavescit et ad aream spectat et spica eius induruit: in quamcumque constitutionem venit, eam tuetur, in eam componitur. Alia est aetas infantis, pueri, adulescentis, senis; ego tamen idem sum qui et infans fui et puer et adulescens. Sic, quamvis alia atque alia cuique constitutio sit, conciliatio constitutionis suae eadem est. Non enim puerum mihi aut iuvenem aut senem, sed me natura commendat. Ergo infans ei constitutioni suae conciliatur quae tunc infanti est, non quae futura iuveni est; neque enim si aliquid illi maius in quod transeat restat, non hoc quoque in quo nascitur secundum naturam est. Primum sibi ipsum conciliatur animal; debet enim aliquid esse ad quod alia referantur. Voluptatem peto. Cui? Mihi; ergo mei curam ago. Dolorem refugio. Pro quo? Pro me; ergo mei curam ago. Si omnia propter curam mei facio, ante omnia est mei cura. Haec animalibus inest cunctis, nec inseritur sed innascitur. Producit fetus suos natura, non abicit; et quia tutela certissima ex proximo est, sibi quisque commissus est. Itaque, ut in prioribus epistulis dixi, tenera quoque animalia et materno utero vel ovo modo effusa quid sit infestum ipsa protinus norunt et mortifera devitant; umbram quoque transvolantium reformidant obnoxia avibus rapto viventibus. Nullum animal ad vitam prodit sine metu mortis. «Quemadmodum» inquit «editum animal intellectum habere aut salutaris aut
mortiferae rei potest?». Primum quaeritur an intellegat, non quemadmodum intellegat. Esse autem illis intellectum ex eo apparet quod nihil amplius, si intellexerint, facient. Quid est quare pavonem, quare anserem gallina non fugiat, at tanto minorem et ne notum quidem sibi accipitrem? Quare pulli faelem timeant, canem non timeant? Apparet illis inesse nocituri scientiam non experimento collectam; nam antequam possint experisci, cavent. Deinde ne hoc casu existimes fieri, nec metuunt alia quam debent nec umquam obliviscuntur huius tutelae et diligentiae: aequalis est illis a pernicioso fuga. Praeterea non fiunt timidiora vivendo; ex quo quidem apparet non usu illa in hoc pervenire sed naturali amore salutis suae. Et tardum est et varium quod usus docet: quidquid natura tradit et aequale omnibus est et statim. Si tamen exigis, dicam quomodo omne animal perniciosa intellegere cogatur. Sentit se carne constare; itaque sentit quid sit quo secari caro, quo uri, quo obteri possit, quae sint animalia armata ad nocendum: horum speciem trahit inimicam et hostilem. Inter se ista coniuncta sunt; simul enim conciliatur saluti suae quidque et iuvatura petit, laesura formidat. Naturales ad utilia impetus, naturales a contrariis aspernationes sunt; sine ulla cogitatione quae hoc dictet, sine consilio fit quidquid natura praecepit. Non vides quanta sit subtilitas apibus ad fingenda domicilia, quanta dividui laboris obeundi undique concordia? Non vides quam nulli mortalium imitabilis illa aranei textura, quanti operis sit fila disponere, alia in rectum inmissa firmamenti loco, alia in orbem currentia ex denso rara, qua minora animalia, in quorum perniciem illa tenduntur, velut retibus inplicata teneantur? Nascitur ars ista, non discitur. Itaque nullum est animal altero doctius: videbis araneorum pares telas, par in favis angulorum omnium foramen. Incertum est et inaequabile quidquid ars tradit: ex aequo venit quod natura distribuit. Haec nihil magis quam tutelam sui et eius peritiam tradidit, ideoque etiam simul incipiunt et discere et vivere. Nec est mirum cum eo nasci illa sine quo frustra nascerentur. Primum hoc instrumentum in illa natura contulit ad permanendum, conciliationem et caritatem sui. Non poterant salva esse nisi vellent; nec hoc per se profuturum erat, sed sine hoc nulla res profuisset. Sed in nullo deprendes vilitatem sui, ne neglegentiam quidem; tacitis quoque et brutis, quamquam in cetera torpeant, ad vivendum sollertia est. Videbis quae aliis inutilia sunt sibi ipsa non deesse. Vale. 122. Detrimentum iam dies sensit; resiluit aliquantum, ita tamen ut liberale adhuc spatium sit si quis cum ipso, ut ita dicam, die surgat. Officiosior meliorque si quis illum expectat et lucem primam excipit: turpis qui alto sole semisomnus iacet, cuius vigilia medio die incipit; et adhuc multis hoc antelucanum est. Sunt qui officia lucis noctisque perverterint nec ante diducant oculos hesterna graves crapula quam adpetere nox coepit. Qualis illorum condicio dicitur quos natura, ut ait Vergilius, pedibus nostris subditos e contrario posuit, nosque ubi primus equis Oriens adflavit anhelis, illis sera rubens accendit lumina Vesper,
talis horum contraria omnibus non regio sed vita est. Sunt quidam in eadem urbe antipodes qui, ut M. Cato ait, nec orientem umquam solem viderunt nec occidentem. Hos tu existimas scire quemadmodum vivendum sit, qui nesciunt quando? Et hi mortem timent, in quam se vivi condiderunt? Tam infausti ominis quam nocturnae aves sunt. Licet in vino unguentoque tenebras suas exigant, licet epulis et quidem in multa fericula discoctis totum perversae vigiliae tempus educant, non convivantur sed iusta sibi faciunt. Mortuis certe interdiu parentatur. At mehercules nullus agenti dies longus est. Extendamus vitam: huius et officium et argumentum actus est. Circumscribatur nox et aliquid ex illa in diem transferatur. Aves quae conviviis comparantur, ut inmotae facile pinguescant, in obscuro continentur; ita sine ulla exercitatione iacentibus tumor pigrum corpus invadit et †superba umbra† iners sagina subcrescit. At istorum corpora qui se tenebris dicaverunt foeda visuntur, quippe suspectior illis quam morbo pallentibus color est: languidi et evanidi albent, et in vivis caro morticina est. Hoc tamen minimum in illis malorum dixerim: quanto plus tenebrarum in animo est! ille in se stupet, ille caligat, invidet caecis. Quis umquam oculos tenebrarum causa habuit? Interrogas quomodo haec animo pravitas fiat aversandi diem et totam vitam in noctem transferendi? Omnia vitia contra naturam pugnant, omnia debitum ordinem deserunt; hoc est luxuriae propositum, gaudere perversis nec tantum discedere a recto sed quam longissime abire, deinde etiam e contrario stare. Non videntur tibi contra naturam vivere qui ieiuni bibunt, qui vinum recipiunt inanibus venis et ad cibum ebrii transeunt? Atqui frequens hoc adulescentium vitium est, qui vires excolunt ut in ipso paene balinei limine inter nudos bibant, immo potent et sudorem quem moverunt potionibus crebris ac ferventibus subinde destringant. Post prandium aut cenam bibere vulgare est; hoc patres familiae rustici faciunt et verae voluptatis ignari: merum illud delectat quod non innatat cibo, quod libere penetrat ad nervos; illa ebrietas iuvat quae in vacuum venit. Non videntur tibi contra naturam vivere qui commutant cum feminis vestem? Non vivunt contra naturam qui spectant ut pueritia splendeat tempore alieno? Quid fieri crudelius vel miserius potest? Numquam vir erit, ut diu virum pati possit? Et cum illum contumeliae sexus eripuisse debuerat, non ne aetas quidem eripiet? Non vivunt contra naturam qui hieme concupiscunt rosam fomentoque aquarum calentium et locorum apta mutatione bruma lilium exprimunt? Non vivunt contra naturam qui pomaria in summis turribus serunt? Quorum silvae in tectis domuum ac fastigiis nutant, inde ortis radicibus quo inprobe cacumina egissent? Non vivunt contra naturam qui fundamenta thermarum in mari iaciunt et delicate natare ipsi sibi non videntur nisi calentia stagna fluctu ac tempestate feriantur? Cum instituerunt omnia contra naturae consuetudinem velle, novissime in totum ab illa desciscunt. «Lucet: somni tempus est. Quies est: nunc exerceamur, nunc gestemur, nunc prandeamus. Iam lux propius accedit: tempus est cenae. Non oportet id facere quod populus; res sordida est trita ac vulgari via vivere. Dies publicus
relinquatur: proprium nobis ac peculiare mane fiat». Isti vero mihi defunctorum loco sunt; quantulum enim a funere absunt et quidem acerbo qui ad faces et cereos vivunt? Hanc vitam agere eodem tempore multos meminimus, inter quos et Acilium Butam praetorium, cui post patrimonium ingens consumptum Tiberius paupertatem confitenti «sero» inquit «experrectus es». Recitabat Montanus Iulius carmen, tolerabilis poeta et amicitia Tiberi notus et frigore. Ortus et occasus libentissime inserebat; itaque cum indignaretur quidam illum toto die recitasse et negaret accedendum ad recitationes eius, Natta Pinarius ait: «numquid possum liberalius agere? Paratus sum illum audire ab ortu ad occasum». Cum hos versus recitasset incipit ardentes Phoebus producere flammas, spargere se rubicunda dies; iam tristis hirundo argutis reditura cibos inmittere nidis incipit et molli partitos ore ministrat, Varus eques Romanus, M. Vinicii comes, cenarum bonarum adsectator, quas inprobitate linguae merebatur, exclamavit «incipit Buta dormire». Deinde cum subinde recitasset iam sua pastores stabulis armenta locarunt, iam dare sopitis nox pigra silentia terris incipit, idem Varus inquit «quid dicis? Iam nox est? Ibo et Butam salutabo». Nihil erat notius hac eius vita in contrarium circumacta; quam, ut dixi, multi eodem tempore egerunt. Causa autem est ita vivendi quibusdam, non quia aliquid existiment noctem ipsam habere iucundius, sed quia nihil iuvat solitum, et gravis malae conscientiae lux est, et omnia concupiscenti aut contemnenti prout magno aut parvo empta sunt fastidio est lumen gratuitum. Praeterea luxuriosi vitam suam esse in sermonibus dum vivunt volunt; nam si tacetur, perdere se putant operam. Itaque aliquotiens faciunt quod excitet famam. Multi bona comedunt, multi amicas habent: ut inter istos nomen invenias, opus est non tantum luxuriosam rem sed notabilem facere; in tam occupata civitate fabulas vulgaris nequitia non invenit. Pedonem Albinovanum narrantem audieramus (erat autem fabulator elegantissimus) habitasse se supra domum Sex. Papini. Is erat ex hac turba lucifugarum. «Audio» inquit «circa horam tertiam noctis flagellorum sonum. Quaero quid faciat: dicitur rationes accipere. Audio circa horam sextam noctis clamorem concitatum. Quaero quid sit: dicitur vocem exercere. Quaero circa horam octavam noctis quid sibi ille sonus rotarum velit: gestari dicitur. Circa lucem discurritur, pueri vocantur, cellarii, coqui tumultuantur. Quaero quid sit: dicitur mulsum et halicam poposcisse, a balneo exisse. «Excedebat» inquit «huius diem cena». Minime; valde enim frugaliter vivebat; nihil consumebat nisi
noctem». Itaque Pedo dicentibus illum quibusdam avarum et sordidum «vos» inquit «illum et lychnobium dicetis». Non debes admirari si tantas invenis vitiorum proprietates: varia sunt, innumerabiles habent facies, conprendi eorum genera non possunt. Simplex recti cura est, multiplex pravi, et quantumvis novas declinationes capit. Idem moribus evenit: naturam sequentium faciles sunt, soluti sunt, exiguas differentias habent; distorti plurimum et omnibus et inter se dissident. Causa tamen praecipua mihi videtur huius morbi vitae communis fastidium. Quomodo cultu se a ceteris distinguunt, quomodo elegantia cenarum, munditiis vehiculorum, sic volunt separari etiam temporum dispositione. Nolunt solita peccare quibus peccandi praemium infamia est. Hanc petunt omnes isti qui, ut ita dicam, retro vivunt. Ideo, Lucili, tenenda nobis via est quam natura praescripsit, nec ab illa declinandum: illam sequentibus omnia facilia, expedita sunt, contra illam nitentibus non alia vita est quam contra aquam remigantibus. Vale. 123. Itinere confectus incommodo magis quam longo in Albanum meum multa nocte perveni: nihil habeo parati nisi me. Itaque in lectulo lassitudinem pono, hanc coci ac pistoris moram boni consulo. Mecum enim de hoc ipso loquor, quam nihil sit grave quod leviter excipias, quam indignandum nihil dum nihil ipse indignando adstruas. Non habet panem meus pistor; sed habet vilicus, sed habet atriensis, sed habet colonus. «Malum panem» inquis. Expecta: bonus fiet; etiam illum tibi tenerum et siligineum fames reddet. Ideo non est ante edendum quam illa imperat. Expectabo ergo nec ante edam quam aut bonum panem habere coepero aut malum fastidire desiero. Necessarium est parvo adsuescere: multae difficultates locorum, multae temporum etiam locupletibus et instructis †advobus optantem prohibent et† occurrent. Quidquid vult habere nemo potest, illud potest, nolle quod non habet, rebus oblatis hilaris uti. Magna pars libertatis est bene moratus venter et contumeliae patiens. Aestimari non potest quantam voluptatem capiam ex eo quod lassitudo mea sibi ipsa adquiescit: non unctores, non balineum, non ullum aliud remedium quam temporis quaero. Nam quod labor contraxit quies tollit. Haec qualiscumque cena aditiali iucundior erit. †Aliquod enim† experimentum animi sumpsi subito; hoc enim est simplicius et verius. Nam ubi se praeparavit et indixit sibi patientiam, non aeque apparet quantum habeat verae firmitatis: illa sunt certissima argumenta quae ex tempore dedit, si non tantum aequus molestias sed placidus aspexit; si non excanduit, non litigavit; si quod dari deberet ipse sibi non desiderando supplevit et cogitavit aliquid consuetudini suae, sibi nihil deesse. Multa quam supervacua essent non intelleximus nisi deesse coeperunt; utebamur enim illis non quia debebamus sed quia habebamus. Quam multa autem paramus quia alii paraverunt, quia apud plerosque sunt! Inter causas malorum nostrorum est quod vivimus ad exempla, nec ratione componimur sed consuetudine abducimur. Quod si pauci facerent nollemus imitari, cum plures facere coeperunt, quasi honestius sit quia frequentius, sequimur; et recti apud nos
locum tenet error ubi publicus factus est. Omnes iam sic peregrinantur ut illos Numidarum praecurrat equitatus, ut agmen cursorum antecedat: turpe est nullos esse qui occurrentis via deiciant, qui honestum hominem venire magno pulvere ostendant. Omnes iam mulos habent qui crustallina et murrina et caelata magnorum artificum manu portent: turpe est videri eas te habere sarcinas solas quae tuto concuti possint. Omnium paedagogia oblita facie vehuntur ne sol, ne frigus teneram cutem laedat: turpe est neminem esse in comitatu tuo puerorum cuius sana facies medicamentum desideret. Horum omnium sermo vitandus est: hi sunt qui vitia tradunt et alio aliunde transferunt. Pessimum genus hominum videbatur qui verba gestarent: sunt quidam qui vitia gestant. Horum sermo multum nocet; nam etiam si non statim proficit, semina in animo relinquit sequiturque nos etiam cum ab illis discessimus, resurrecturum postea malum. Quemadmodum qui audierunt synphoniam ferunt secum in auribus modulationem illam ac dulcedinem cantuum, quae cogitationes inpedit nec ad seria patitur intendi, sic adulatorum et prava laudantium sermo diutius haeret quam auditur. Nec facile est animo dulcem sonum excutere: prosequitur et durat et ex intervallo recurrit. Ideo cludendae sunt aures malis vocibus et quidem primis; nam cum initium fecerunt admissaeque sunt, plus audent. Inde ad haec pervenitur verba: «virtus et philosophia et iustitia verborum inanium crepitus est; una felicitas est bene vitae facere; esse, bibere, frui patrimonio, hoc est vivere, hoc est se mortalem esse meminisse. Fluunt dies et inreparabilis vita decurrit. Dubitamus? Quid iuvat sapere et aetati non semper voluptates recepturae interim, dum potest, dum poscit, ingerere frugalitatem? †Eo† mortem praecurre et quidquid illa ablatura est iam sibi †interere†. Non amicam habes, non puerum qui amicae moveat invidiam; cottidie sobrius prodis; sic cenas tamquam ephemeridem patri adprobaturus: non est istud vivere sed alienae vitae interesse. Quanta dementia est heredis sui res procurare et sibi negare omnia ut tibi ex amico inimicum magna faciat hereditas; plus enim gaudebit tua morte quo plus acceperit. Istos tristes et superciliosos alienae vitae censores, suae hostes, publicos paedagogos assis ne feceris nec dubitaveris bonam vitam quam opinionem bonam malle». Hae voces non aliter fugiendae sunt quam illae quas Ulixes nisi alligatus praetervehi noluit. Idem possunt: abducunt a patria, a parentibus, ab amicis, a virtutibus, et †inter spem vitam misera nisi turpis inludunt†. Quanto satius est rectum sequi limitem et eo se perducere ut ea demum sint tibi iucunda quae honesta! Quod adsequi poterimus si scierimus duo esse genera rerum quae nos aut invitent aut fugent. Invitant divitiae, voluptates, forma, ambitio, cetera blanda et adridentia: fugat labor, mors, dolor, ignominia, victus adstrictior. Debemus itaque exerceri ne haec timeamus, ne illa cupiamus. In contrarium pugnemus et ab invitantibus recedamus, adversus petentia concitemur. Non vides quam diversus sit descendentium habitus et escendentium? Qui per pronum eunt resupinant corpora, qui in arduum, incumbunt. Nam si descendas, pondus suum in priorem partem dare, si escendas, retro abducere, cum vitio, Lucili, consentire est. In voluptates descenditur, in aspera et dura
subeundum est: hic inpellamus corpora, illic refrenemus. Hoc nunc me existimas dicere, eos tantum perniciosos esse auribus nostris qui voluptatem laudant, qui doloris metus, per se formidabiles res, incutiunt? Illos quoque nocere nobis existimo qui nos sub specie Stoicae sectae hortantur ad vitia. Hoc enim iactant: solum sapientem et doctum esse amatorem. «Solus aptus est ad hanc artem; aeque conbibendi et convivendi sapiens est peritissimus. Quaeramus ad quam usque aetatem iuvenes amandi sint». Haec Graecae consuetudini data sint, nos ad illa potius aures derigamus: «nemo est casu bonus: discenda virtus est. Voluptas humilis res et pusilla est et in nullo habenda pretio, communis cum mutis animalibus, ad quam minima et contemptissima advolant. Gloria vanum et volubile quiddam est auraque mobilius. Paupertas nulli malum est nisi repugnanti. Mors malum non est: quid sit quaeris? Sola ius aequum generis humani. Superstitio error insanus est: amandos timet, quos colit violat. Quid enim interest utrum deos neges an infames?» Haec discenda, immo ediscenda sunt: non debet excusationes vitio philosophia suggerere. Nullam habet spem salutis aeger quem ad intemperantiam medicus hortatur. Vale. 124. Possum multa tibi veterum praecepta referre, ni refugis tenuisque piget cognoscere curas. Non refugis autem nec ulla te subtilitas abigit: non est elegantiae tuae tantum magna sectari, sicut illud probo, quod omnia ad aliquem profectum redigis et tunc tantum offenderis ubi summa subtilitate nihil agitur. Quod ne nunc quidem fieri laborabo. Quaeritur utrum sensu conprendatur an intellectu bonum; huic adiunctum est in mutis animalibus et infantibus non esse. Quicumque voluptatem in summo ponunt sensibile iudicant bonum, nos contra intellegibile, qui illud animo damus. Si de bono sensus iudicarent, nullam voluptatem reiceremus; nulla enim non invitat, nulla non delectat; et e contrario nullum dolorem volentes subiremus; nullus enim non offendit sensum. Praeterea non essent digni reprehensione quibus nimium voluptas placet quibusque summus est doloris timor. Atqui inprobamus gulae ac libidini addictos et contemnimus illos qui nihil viriliter ausuri sunt doloris metu. Quid autem peccant si sensibus, id est iudicibus boni ac mali, parent? His enim tradidistis adpetitionis et fugae arbitrium. Sed videlicet ratio isti rei praeposita est: illa quemadmodum de beata vita, quemadmodum de virtute, de honesto, sic et de bono maloque constituit. Nam apud istos vilissimae parti datur de meliore sententia, ut de bono pronuntiet sensus, obtunsa res et hebes et in homine quam in aliis animalibus tardior. Quid si quis vellet non oculis sed tactu minuta discernere? Subtilior adhoc acies nulla quam oculorum et intentior daret bonum malumque dinoscere. Vides in quanta ignorantia veritatis versetur et quam humi sublimia ac divina proiecerit apud quem de summo, bono malo, iudicat tactus. «Quemadmodum» inquit «omnis scientia atque ars aliquid debet habere manifestum sensuque conprehensum ex quo oriatur et crescat, sic beata vita
fundamentum et initium a manifestis ducit et eo quod sub sensum cadat. Nempe vos a manifestis beatam vitam initium sui capere dicitis». Dicimus beata esse quae secundum naturam sint; quid autem secundum naturam sit palam et protinus apparet, sicut quid sit integrum. Quod secundum naturam est, quod contigit protinus nato, non dico bonum, sed initium boni. Tu summum bonum, voluptatem, infantiae donas, ut inde incipiat nascens quo consummatus homo pervenit; cacumen radicis loco ponis. Si quis diceret illum in materno utero latentem, sexus quoque incerti, tenerum et inperfectum et informem iam in aliquo bono esse, aperte videretur errare. Atqui quantulum interest inter eum qui cum maxime vitam accipit et illum qui maternorum viscerum latens onus est? Uterque, quantum ad intellectum boni ac mali, aeque maturus est, et non magis infans adhoc boni capax est quam arbor aut mutum aliquod animal. Quare autem bonum in arbore animalique muto non est? Quia nec ratio. Ob hoc in infante quoque non est; nam et huic deest. Tunc ad bonum perveniet cum ad rationem pervenerit. Est aliquod inrationale animal, est aliquod nondum rationale, est rationale sed inperfectum: in nullo horum bonum, ratio illud secum adfert. Quid ergo inter ista quae rettuli distat? In eo quod inrationale est numquam erit bonum; in eo quod nondum rationale est tunc esse bonum non potest; in eo quod rationale est sed inperfectum iam potest bonum esse, sed non est. Ita dico, Lucili: bonum non in quolibet corpore, non in qualibet aetate invenitur et tantum abest ab infantia quantum a primo ultimum, quantum ab initio perfectum; ergo nec in tenero, modo coalescente corpusculo est. Quidni non sit? Non magis quam in semine. Hoc sic dicas: aliquod arboris ac sati bonum novimus: hoc non est in prima fronde quae emissa cum maxime solum rumpit. Est aliquod bonum tritici: hoc nondum est in herba lactente nec cum folliculo se exerit spica mollis, sed cum frumentum aestas et debita maturitas coxit. Quemadmodum omnis natura bonum suum nisi consummata non profert, ita hominis bonum non est in homine nisi cum illi ratio perfecta est. Quod autem hoc bonum? Dicam: liber animus, erectus, alia subiciens sibi, se nulli. Hoc bonum adeo non recipit infantia ut pueritia non speret, adulescentia inprobe speret; bene agitur cum senectute si ad illud longo studio intentoque pervenit. Si hoc est bonum, et intellegibile est. «Dixisti» inquit «aliquod bonum esse arboris, aliquod herbae; potest ergo aliquod esse et infantis». Verum bonum nec in arboribus nec in mutis animalibus: hoc quod in illis bonum est precario bonum dicitur. «Quod est?» inquis. Hoc quod secundum cuiusque naturam est. Bonum quidem cadere in mutum animal nullo modo potest; felicioris meliorisque naturae est. Nisi ubi rationi locus est, bonum non est. Quattuor hae naturae sunt, arboris, animalis, hominis, dei: haec duo, quae rationalia sunt, eandem naturam habent, illo diversa sunt quod alterum inmortale, alterum mortale est. Ex his ergo unius bonum natura perficit, dei scilicet, alterius cura, hominis. Cetera tantum in sua natura perfecta sunt, non vere perfecta, a quibus abest ratio. Hoc enim demum perfectum est quod secundum universam naturam perfectum, universa autem natura rationalis est: cetera possunt in suo genere esse perfecta. In quo non potest beata vita esse nec id potest quo
beata vita efficitur; beata autem vita bonis efficitur. In muto animali non est beata vita nec id quo beata vita efficitur: in muto animali bonum non est. Mutum animal sensu conprendit praesentia; praeteritorum reminiscitur cum in id incidit quo sensus admoneretur, tamquam equus reminiscitur viae cum ad initium eius admotus est. In stabulo quidem nulla illi viaest quamvis saepe calcatae memoria. Tertium vero tempus, id est futurum, ad muta non pertinet. Quomodo ergo potest eorum videri perfecta natura quibus usus perfecti temporis non est? Tempus enim tribus partibus constat, praeterito, praesente, venturo. Animalibus tantum quod brevissimum est et in transcursu datum, praesens: praeteriti rara memoria est nec umquam revocatur nisi praesentium occursu. Non potest ergo perfectae naturae bonum in inperfecta esse natura, aut si natura talis hoc habet, habent et sata. Nec illud nego, ad ea quae videntur secundum naturam magnos esse mutis animalibus impetus et concitatos, sed inordinatos ac turbidos; numquam autem aut inordinatum est bonum aut turbidum. «Quid ergo?» inquis «muta animalia perturbate et indisposite moventur?». Dicerem illa perturbate et indisposite moveri si natura illorum ordinem caperet: nunc moventur secundum naturam suam. Perturbatum enim id est quod esse aliquando et non perturbatum potest; sollicitum est quod potest esse securum. Nulli vitium est nisi cui virtus potest esse: mutis animalibus talis ex natura sua motus est. Sed ne te diu teneam, erit aliquod bonum in muto animali, erit aliqua virtus, erit aliquid perfectum, sed nec bonum absolute nec virtus nec perfectum. Haec enim rationalibus solis contingunt, quibus datum est scire quare, quatenus, quemadmodum. Ita bonum in nullo est nisi in quo ratio. Quo nunc pertineat ista disputatio quaeris, et quid animo tuo profutura sit? Dico: et exercet illum et acuit et utique aliquid acturum occupatione honesta tenet. Prodest autem etiam quo moratur ad prava properantes. Sed et illud dico: nullo modo prodesse possum magis quam si tibi bonum tuum ostendo, si te a mutis animalibus separo, si cum deo pono. Quid, inquam, vires corporis alis et exerces? Pecudibus istas maiores ferisque natura concessit. Quid excolis formam? Cum omnia feceris, a mutis animalibus decore vinceris. Quid capillum ingenti diligentia comis? Cum illum vel effuderis more Parthorum vel Germanorum modo vinxeris vel, ut Scythae solent, sparseris, in quolibet equo densior iactabitur iuba, horrebit in leonum cervice formonsior. Cum te ad velocitatem paraveris, par lepusculo non eris. Vis tu relictis in quibus vinci te necesse est, dum in aliena niteris, ad bonum reverti tuum? Quod est hoc? Animus scilicet emendatus ac purus, aemulator dei, super humana se extollens, nihil extra se sui ponens. Rationale animal es. Quod ergo in te bonum est? Perfecta ratio. Hanc tu ad suum finem hinc evoca, sine in quantum potest plurimum crescere. Tunc beatum esse te iudica cum tibi ex te gaudium omne nascetur, cum visis quae homines eripiunt, optant, custodiunt, nihil inveneris, non dico quod malis, sed quod velis. Brevem tibi formulam dabo qua te metiaris, qua perfectum esse iam sentias: tunc habebis tuum cum intelleges infelicissimos esse felices. Vale.
Lettere a Lucilio
Premessa Composte fra il 62 e il 65, le Lettere sono 124, divise in 20 libri (quanti ne sono giunti a noi, perché Gellio parla di un XXII libro) e indirizzate a Lucilio, caro amico di Seneca e forse autore del poemetto Aetna incluso nell’Appendix Virgiliana. Le notizie su questo personaggio le ricaviamo da Seneca stesso, che lo dice ormai noto e ammirato «per il vigore dell’ingegno, l’eleganza della scrittura, le illustri e nobili amicizie» (19, 3), più giovane di lui (26, 7), cavaliere romano (44, 2), procuratore, a quell’epoca, in Sicilia (45, 1; 51, 1; 79, 1), originario della Campania e nativo di Pompei (49, 1). Non è certo se si tratti di una corrispondenza realmente avvenuta: i riferimenti continui a lettere inviate a Seneca dall’amico nonché ad altri particolari, come la causa intentata a Lucilio da un suo nemico (24, 1), fanno pensare di sì, almeno per quanto riguarda una parte delle lettere. È indubbio, comunque, che, come in altri autori di epistolari, vi sia stato anche in Seneca un intento letterario e quindi quello di pubblicare la raccolta per lasciare ai posteri un più pieno ricordo di sé, una specie di testamento spirituale («Scrivo per i posteri, è a loro che voglio essere utile, affidando alle mie pagine consigli salutari, come se fossero ricette di medicine, delle quali io stesso ho sperimentato l’efficacia sulle mie ferite… Mostro agli altri la retta via, che ho conosciuto tardi, quando ormai ero stanco per il lungo peregrinare», 8, 2-3; «Godrò del favore dei posteri», 21, 5). Le Lettere sono l’opera più importante di Seneca, sia perché racchiudono il succo delle sue meditazioni, sia perché rivelano maggiore maturità e perché contengono una grande quantità e varietà di temi. C’è poi in esse una più marcata originalità di pensiero. Rispetto alle altre opere il discorso appare qui più profondo e incisivo, giacché l’Autore non si abbandona a disquisizioni generiche e astratte, ma descrive cose e fatti della realtà, analizzando l’uomo nel suo duplice aspetto, fisico e spirituale insieme. Le Lettere sono anche l’opera migliore di Seneca perché in esse egli smette la veste del filosofo per indossare quella del precettore, che più gli si confà. I primi tre libri, pubblicati da Seneca stesso, formano un corpo a sé e trattano di alcune regole di vita (I), della felicità, conseguibile solo attraverso lo studio della filosofia (II), degli ostacoli che a tale studio si oppongono e del modo in cui possono essere superati (III). Gli altri libri trattano di argomenti vari. Nell’insieme i temi svolti – senza un ordine sistematico ma secondo l’estro del momento – sono quelli che ricorrono nei Dialoghi, a cui le Lettere sono affini: la virtù, il vero bene, l’amicizia, il superamento delle passioni, i vizi da combattere, il divino nell’uomo, il dolore e i suoi rimedi, l’atteggiamento di fronte alla morte, tema, quest’ultimo, molto sentito da Seneca, a cui non restano ormai che pochi anni di vita. Seneca non ha la certezza della sopravvivenza dell’anima dopo la morte, che a volte considera semplicemente la fine di tutto, a volte invece un passaggio a un’altra condizione di vita, ma in ogni caso attende quell’evento con serenità: «Non temo di finire nel nulla, in quanto ciò equivale a non aver mai cominciato a vivere, e, anche se la morte non fosse che un trapasso a un’altra vita, non ne ho paura, poiché, dovunque io vada, nessun luogo mi starà così stretto come questo» (65, 24). Ma in tanta varietà di argomenti è sempre presente la figura del saggio (nella quale Seneca traccia il suo ritratto ideale), perché sua è la virtù, sua è la vera felicità, suo l’amore per Dio, sua la serenità di fronte alla morte. Per l’insistenza di questo tema c’è nelle Lettere, nonostante la proclamata serenità di fronte alla morte, un fondo di tristezza e di pessimismo, riscattato da qualche barlume di speranza nell’immortalità. Le Lettere costituiscono un vero e proprio vademecum morale e cronologicamente la prima opera del genere dello stoicismo romano: le altre sono il Manuale di Epitteto e i Pensieri (o Colloqui con sé stesso) di Marco Aurelio. L’ideale del saggio secondo Seneca, anche in riferimento alle altre sue opere, si può sintetizzare così: la meta dell’uomo è la felicità, conseguibile solo attraverso la filosofia, perché soltanto questa può guidarci alla virtù, unico vero bene dell’uomo, al superamento di tutti i piaceri e di tutti i desideri mondani e a un sereno equilibrio interiore. La filosofia è un insieme di contemplazione e di azione: la prima consente di vedere e giudicare le cose dall’alto, con distacco e serenità, attingendo alla Verità assoluta ed eterna, la seconda conduce alla realizzazione, dentro di noi, di quella stessa Verità, la quale è equilibrio, armonia, amore per il prossimo, superamento del male e del dolore. Il saggio non si
abbatte di fronte alle sventure, non è toccato dalla sorte, perché passa indifferente in mezzo alle cose fortuite che provengono da lei. Non si turba nemmeno al pensiero della morte, che è pronto ad affrontare di sua mano, se necessario, giacché considera il suicidio un atto estremo di libertà. Nelle Lettere Seneca anticipa delle teorie che solo molto più tardi cominceranno ad affermarsi, come quella relativa alla schiavitù, secondo la quale gli uomini sono tutti uguali. Ecco un passo della lettera 47, che è, in proposito, la testimonianza più alta: «Si dice: “Sono schiavi”. No, sono uomini. “Ma sono schiavi”. No: compagni che vivono nella nostra stessa dimora. “Ma sono sempre schiavi”. No, sono gli amici più umili. “Ma schiavi!”. Semmai compagni di schiavitù, se pensiamo che sia loro che noi siamo soggetti al potere e alla mutevolezza della sorte». Ma qualunque traduzione non rende l’efficacia e la stringatezza dell’originale, che riproduciamo integralmente: «“Servi sunt”. Immo homines. “Servi sunt”. Immo contubernales. “Servi sunt”. Immo humiles amici. “Servi sunt”. Immo conservi, si cogitaveris tantundem in utrosque licere fortunae». «Mostrami qualcuno che non sia schiavo», conclude Seneca: «uno lo è della libidine, uno della sete di denaro, un altro dell’ambizione, e tutti siamo schiavi della speranza e della paura». Quanto alle fonti delle Lettere, ai pensatori e ai moralisti a cui Seneca mostra di avere attinto, vi sono nominati soprattutto Epicuro, Zenone e Posidonio, e poi Demetrio, Metrodoro e Aristone di Chio, lo stoico, sostenitore dell’indifferenza totale di fronte alle cose esteriori, che, come Seneca dice (89, 13), considerava la logica non solo inutile ma addirittura dannosa, e limitava anche la morale, quam solam reliquerat. Ma di quei princìpi, di quelle teorie, Seneca fa pane quotidiano, nutrimento vivo dello spirito, riuscendo a calare l’ideale nel reale, i più alti valori – che generalmente nei pensatori romani restano sul piano razionale – nel profondo dell’animo, e a ciò contribuisce la forma epistolare del trattato, che offre a Seneca la possibilità di un maggiore e più vivo contatto non solo col suo interlocutore, ma con tutti gli uomini. M. S. A.
Libro primo 1. Mio caro Lucilio, questa è la condotta che devi seguire: disponi di te stesso, com’è tuo diritto, e il tempo che sino a ora gli altri ti portavano via o ti rubavano, o che tu stesso ti lasciavi sfuggire, tienitelo stretto e non fartelo scappare. Convinciti che le cose stanno proprio così come ti dico io: certi momenti ci vengono strappati a forza, altri sottratti furtivamente, altri scivolano via senza che neppure ce ne accorgiamo. Ma la perdita di tempo di cui dobbiamo sommamente vergognarci è quella dovuta alla nostra negligenza. E se ci rifletti, ti renderai conto che una buona parte della nostra esistenza la sprechiamo nel fare il male, la maggior parte nel non far nulla e la vita intera nel fare altro da ciò che dovremmo. Trovami una sola persona che dia al suo tempo il giusto valore, che sappia quanto vale la sua giornata e si renda conto che la vita è un quotidiano morire. È qui l’errore: noi vediamo la morte come un evento che deve ancora venire, mentre una buona parte di essa ce la siamo lasciata alle spalle, poiché la vita trascorsa se l’è già presa lei. Perciò, Lucilio mio, agisci pure così come mi scrivi, non lasciarti sfuggire un solo istante: se terrai in pugno il presente dipenderai meno dal domani. Mentre noi continuiamo a rimandare, la vita intanto se ne va. Di tutte le cose, Lucilio, soltanto il tempo è nostro: è questo l’unico bene, seppur fugace e labile, di cui la natura ci ha reso padroni, ma di cui può espropriarci chiunque. Gli uomini sono talmente sciocchi che si attribuiscono la
proprietà di beni piccolissimi e di nessun valore, facilmente sostituibili, ma nessuno ritiene di dover qualcosa per il tempo che ha ricevuto, quando quello invece è l’unico bene che nemmeno la persona più riconoscente può restituire. Forse ti chiederai come mi comporti io che ti dò questi consigli. Te lo dirò con tutta sincerità: vado incontro alle mie spese a ragion veduta, da persona prodiga, ma attenta. Non posso dire a quanto ammontino le mie perdite, ma so bene cosa perdo, come e per quale motivo. Cercherò di spiegare perché sono povero. La mia condizione, però, è come quella di chi perlopiù si riduce in miseria non per colpa sua: a parole tutti sono con lui, ma di fatto nessuno lo aiuta. Che dire, allora? Per me non è povero chi si accontenta di quel poco che gli rimane, tuttavia preferisco che per ora tu conservi intatto il tuo patrimonio, aspettando un tempo migliore, perché, come dicevano i nostri padri, «è tardi per stringere la cinghia quando ormai si è arrivati al fondo»:1 lì, infatti, insieme al meno resta anche il peggio. Stammi bene. 2. Stando a quel che mi scrivi e che sento, ho motivo di bene sperare per te: non corri di qua e di là e non ti agiti spostandoti continuamente da un luogo all’altro, un’agitazione che è sintomo di una malattia spirituale. Per me, invece, il primo segno di equilibrio interiore è la capacità di starsene tranquilli dovunque ci si trovi e in compagnia di sé stessi. Bada poi che il leggere troppi libri, di ogni genere e di autori diversi, non sia segno di incostanza e di volubilità. Devi fermare la tua attenzione su determinati scrittori e pascerti dei loro sentimenti e dei loro pensieri per trarne un guadagno spirituale che possa durare nel tempo. Chi sta dappertutto non è da nessuna parte. Chi passa la vita in un continuo vagabondaggio potrà ricavarne molti rapporti di ospitalità, ma quanto ad amici non ne avrà nemmeno uno. La stessa cosa capita a chi va sfogliando un libro dietro l’altro ma senza approfondire la conoscenza dei loro autori. Chi vomita il cibo subito dopo il pasto non lo assimila e non ne trae alcun giovamento. Non c’è niente che ostacoli tanto la guarigione quanto il continuo passare da una medicina all’altra: non si cicatrizza una ferita se la si cura in modo sempre diverso, una pianta se la si sposta spesso non si irrobustisce. Non c’è rimedio per quanto efficace che possa giovare in poco tempo. A leggere troppi libri c’è il rischio che il sapere si frantumi, e d’altra parte, visto che non possiamo leggere tutti i libri che vorremmo, accontentiamoci di averne abbastanza per le nostre letture. «Ma io», ribatti tu, «voglio sfogliare un po’ da qua, un po’ da là». Bravo! È di uno stomaco viziato assaggiare molte cose: la varietà di cibi intossica, non nutre. Perciò, leggi sempre autori noti e apprezzati e se ogni tanto ti piace attingere da altri ritorna poi ai primi. Ricerca in essi qualcosa che ti sia quotidianamente di aiuto contro la povertà, contro la morte e tutte le altre avversità, e quando avrai raccolto tante informazioni tirane fuori un concetto da assimilare in quel giorno. Anch’io faccio così: dalle molte cose che leggo degli altri ne ricavo qualcuna delle mie. Il frutto di oggi, per esempio, l’ho tratto da Epicuro (spesso, infatti, m’introduco in territorio altrui, non però come uno che abbia tagliato i ponti col
suo, ma come un esploratore). Ebbene, Epicuro dice: «Nobil cosa è una gioiosa povertà».2 Ma se è vissuta con gioia non è povertà. È povero non chi ha poco, ma chi vuole di più. Che importa, infatti, quanto vi sia nel forziere o nei granai, quanti siano i capi di bestiame o i redditi da usura, se si mettono gli occhi sulla roba altrui e si fa il conto non di quanto si possiede ma di quanto si vorrebbe avere? Vuoi sapere quale sia la giusta misura della ricchezza? Primo, avere il necessario, secondo, quanto basta. Stammi bene. 3. Prima mi dici che hai dato a un tuo amico delle lettere per me, poi mi esorti a non discutere con lui dei fatti tuoi in quanto tu non hai questa abitudine. Sicché in una stessa lettera affermi e neghi che quello sia tuo amico. Ascolta. Se usi una parola specifica in senso lato e chiami uno «amico» così come noi chiamiamo «onorevoli» tutti quelli che aspirano a una carica pubblica, o diciamo «ciao, caro» a chi incontriamo per strada quando non ne ricordiamo il nome, la questione è chiusa. Ma se consideri amico uno e non ti fidi di lui come di te stesso, allora sbagli di grosso e non conosci abbastanza il valore della vera amicizia. Con un amico tratta pure di tutto, ma prima vedi se sia davvero un amico: una volta che hai stretto amicizia con uno ti devi fidare di lui. Prima, però, ripeto, devi assicurarti che sia vera amicizia. Chi, contrariamente agli insegnamenti di Teofrasto, 3 dopo aver concesso a uno il proprio affetto, si mette a criticarlo, e per il fatto di averlo criticato in effetti non l’ama più, confonde i doveri dell’amicizia sovvertendone l’ordine. Rifletti a lungo se sia il caso di accogliere uno come amico, ma una volta che hai deciso di sì accoglilo con tutto il cuore e parla con lui francamente come con te stesso, anzi, comportati in modo da non aver segreti nemmeno per i tuoi nemici. E se ci sono cose che la consuetudine t’induce a tenere nascoste, dividi comunque con l’amico ogni tua preoccupazione e ogni tuo pensiero. Se lo riterrai fidato, tale lo renderai, così come chi mostra di aver paura d’essere ingannato insegna a ingannare e i suoi sospetti forniscono agli altri il diritto di comportarsi allo stesso modo. Perché di fronte a un amico dovrei stare attento a quel che dico? Perché quando sono con lui non dovrei sentirmi come se fossi solo? C’è chi racconta a tutti quelli che incontra cose e fatti che si dovrebbero confidare solo agli amici e scarica nelle orecchie di uno sconosciuto tutto ciò che gli brucia dentro. Altri temono addirittura che le persone più care possano venire a conoscenza di cose che non vogliono far sapere neppure a loro e nascondono sempre più nel profondo i loro segreti per non confidarli, possibilmente, nemmeno a sé stessi. Anche questi sono due estremi da evitare, perché è un errore sia credere a tutti, sia non credere a nessuno; direi, però, che il primo è un difetto più onesto, il secondo più sicuro. Analogamente sono da biasimare tanto gl’irrequieti quanto i posapiano, perché il compiacersi del proprio tumulto interiore non è un’attività che produca qualcosa, è soltanto l’inutile smaniare di una mente esagitata; così come il fastidio per ogni attività non è quiete, è fiacchezza e dissoluzione. Tieni bene a mente, dunque, questa frase che ho letto in Pomponio:4 «Alcuni vivono in una tale oscurità che
tutto ciò che è esposto alla luce gli sembra torbido e confuso». Bisogna mescolare le cose: chi è flemmatico deve darsi una mossa, chi è sempre in moto deve darsi una calmata. Chiedilo alla natura: lei ti dirà che ha creato il giorno e la notte. Stammi bene. 4. Persevera come hai cominciato e affrettati quanto puoi, sì da godere più a lungo di un animo puro e sereno. Anzi, puoi già goderne mentre vai emendandolo e cerchi di calmarlo. Ma ben altro è il piacere che si coglie dalla contemplazione della mente quando questa sia limpida e pura da ogni macchia. Ricorderai certamente la gioia che provasti quando, smessa la veste della fanciullezza, indossasti la toga virile e fosti condotto nel foro: ebbene, aspetta e ne proverai una maggiore quando avrai deposto quel tuo animo infantile e la filosofia ti avrà fatto uomo. La tua, infatti, non è puerizia, ma, quel ch’è più grave, è un atteggiamento puerile, perché, cosa ancora peggiore, alla nostra età noi abbiamo l’autorità degli anziani e i difetti dei bambini, anzi, più che dei bambini, dei neonati, poiché i bambini hanno paura di sciocchezze, i neonati di false immagini, noi delle une e delle altre. Cerca di progredire: ti renderai conto che certe cose sono meno da temere proprio perché fanno molta paura. L’ultimo dei mali è meno grande degli altri. Così è con la Morte: quando la senti venire dovresti temerla se restasse con te, ma, necessariamente, o non è ancora arrivata, o passa oltre, e tu non la senti più. Mi dirai: «È difficile indurre il nostro animo a disprezzare la vita». Ma non vedi per quali motivi banali viene disprezzata? Chi s’impicca davanti alla porta dell’amica, chi si butta giù dal tetto per non sentire più le sfuriate del padrone, chi, fuggito dal carcere, si ficca un coltello nelle viscere per evitare la cattura: non ti sembra che un medesimo gesto si possa compiere per coraggio o per eccessiva paura? Non può vivere una vita serena chi si preoccupa troppo di prolungarla e annovera fra i grandi beni i molti anni vissuti. Pensa quotidianamente a questa verità e sii sempre pronto a lasciare serenamente la vita, alla quale molti si avvinghiano e si tengono stretti, come chi è trascinato via dalla corrente si aggrappa ai rovi e alle rocce. La maggior parte degli uomini ondeggia infelice fra il timore della morte e i tormenti della vita: non vogliono vivere, e non sanno morire. Non dare alcun peso alla vita e te la renderai piacevole. Non serve a niente possedere un bene se non si è pronti a perderlo. E i beni di cui più facilmente si accetta la perdita sono quelli che, una volta perduti, non possono più essere desiderati. Fatti animo, dunque, e corazzati contro i mali che possono capitare anche ai più potenti. La morte di Pompeo fu decisa da un ragazzino e da un eunuco,5 quella di Crasso da un Parto barbaro e crudele. Gaio Cesare6 impose a Lepido di porgere il collo al tribuno Destro, poi egli stesso porse il suo a Cherea. La sorte non ha mai spinto un uomo tanto in alto da non ritorcere contro di lui quanto gli aveva permesso di fare. Non fidarti della tua presente tranquillità: il mare si turba in un istante e nel medesimo giorno le barche affondano là dove si erano spinte per diporto. Pensa che sia un ladro che un nemico possono puntarti un pugnale alla gola, che in assenza di un’autorità
superiore ogni servo ha su di te potere di vita o di morte. In poche parole: chi disprezza la propria vita è padrone della tua. Passa in rassegna gli esempi di uomini che sono stati uccisi dai loro schiavi, o con aperta violenza o con l’inganno, e vedrai che il furore dei servi non ha causato meno stragi dell’ira dei re. Che t’importa, dunque, quanto sia potente colui che temi, quando ciò che tu temi può fartelo chiunque? Se cadi nelle mani dei nemici il loro capo comanderà di condurti esattamente dove il destino ti stava portando. T’inganni se non capisci che quel che ti accade oggi stavi subendolo già da tempo. È proprio così: andiamo verso la morte fin dal momento della nascita. Meditiamo su questa verità e su altri argomenti del genere se vogliamo attendere serenamente la nostra ultima ora che tanto ci spaventa e ci rende ansiosa la vita. Ma prima di porre fine a questa lettera voglio trascriverti il pensiero che ho scelto oggi – anche questo l’ho colto dal giardino di un altro. «Grande ricchezza è una povertà regolata dalla legge di natura».7 Li conosci i confini che ci assegna la legge di natura? Non patire né la fame, né la sete, né il freddo. Per scacciare la fame e la sete non occorre sedere presso la soglia di superbi padroni, o sopportare una pesante arroganza e una falsa umanità, non è necessario mettersi in mare o arruolarsi per la guerra. Quel che natura vuole basta cercarlo e ce lo porge lei stessa. Ma noi, invece, ci consumiamo per procurarci il superfluo: è questo che ci logora la toga, che ci costringe a invecchiare sotto una tenda, che ci spinge in terre straniere, mentre quel che ci basta è a portata di mano. Chi ben si adatta alla povertà non è povero, è ricco. Stammi bene. 5. Sono lieto e soddisfatto che tu, messa da parte ogni altra cosa, attenda unicamente a renderti ogni giorno migliore, perciò non solo ti esorto a perseverare ma ti prego caldamente di ascoltarmi. Ti consiglio di non fare alcuna cosa che contrasti col tuo costume e col tuo genere di vita, di non seguire, cioè, quelle persone che invece di voler progredire pensano solo a mettersi in mostra. Evita gli abiti trasandati, i capelli lunghi e la barba incolta, il disprezzo ostentato per il denaro, il letto steso sul nudo pavimento e in generale tutto ciò che per vie contrarie al buon senso va dietro alla smania di distinguersi dagli altri. Già il solo nome di filosofia è abbastanza odiato, anche se i filosofi generalmente sono piuttosto discreti, figurati dunque cosa direbbero di te se cominciassi a sottrarti alle consuetudini degli uomini comuni. La diversità dev’essere un fatto dello spirito, nell’aspetto esteriore non serve distinguersi dagli altri. La toga non luccichi troppo, ma non sia nemmeno sordida, se riteniamo eccessivo possedere argento cesellato d’oro massiccio non per questo dobbiamo pensare che sia segno di frugalità fare a meno dell’oro e dell’argento. Cerchiamo insomma di vivere meglio della massa, non in modo completamente diverso, altrimenti volgiamo in fuga e ci facciamo nemici coloro che vogliamo correggere, col risultato che quelli, per il timore di doversi sorbire tutti i nostri discorsi, non ci ascolteranno per niente. Poiché le prime cose che promette la filosofia sono il senso comune, l’umanità e la socievolezza, l’essere troppo diversi dagli altri ci
impedirà di attuarle. Stiamo dunque attenti a non suscitare il ridicolo e il fastidio col nostro comportamento, che deve tendere invece a procurarci l’ammirazione. È vero che il nostro proposito è vivere secondo natura, ma far violenza al proprio corpo, disdegnare le più elementari norme d’igiene preferendo la sporcizia e nutrirsi di cibi poveri e persino sgradevoli e disgustosi, tutto ciò è contro natura. Come è segno di mollezza volere alimenti raffinati, così è segno di pazzia disprezzare quelli comuni che si possono avere a poco prezzo. La filosofia richiede frugalità, non sofferenza, e la frugalità può anche essere dignitosa. Per me il filosofo deve tenersi nel giusto mezzo fra la buona morale e quella dominante: la gente ammiri la sua condotta di vita, ma deve anche poterne capire le ragioni. «Dovremo dunque comportarci come gli altri? Non ci sarà nessuna differenza tra noi e loro?». Anzi, grandissima: chi ci guarda più da vicino deve accorgersi che siamo diversi dalla massa; chi entra in casa nostra ammiri noi, non i nostri mobili. Se grande è colui che usa vasi di coccio come se fossero d’argento, non lo è meno chi usa l’argento come se fosse argilla: è proprio degli animi deboli non sapersi dominare vivendo nell’agiatezza. Ma voglio dividere con te il mio piccolo guadagno di oggi: ho letto nel nostro Ecatone8 che la mancanza di forti desideri giova anche come rimedio alla paura. Dice infatti: «Non avrai più paura se smetterai di sperare». «Ma», potresti obiettare, «come possono stare insieme stati d’animo tanto diversi?». È così, Lucilio mio: sembrano in contraddizione e invece si conciliano. Come una medesima catena unisce in un’unica coppia il detenuto e la guardia, così questi due stati d’animo, per quanto diversissimi fra loro, procedono di pari passo: la mancanza di qualsiasi aspettativa elimina automaticamente ogni paura. Non c’è da meravigliarsene: speranza e paura sono entrambe prerogative di un animo inquieto e preoccupato del futuro, dovute originariamente al fatto che, non paghi del presente, proiettiamo i nostri pensieri in tempi lontani. Per questo la tendenza a fare previsioni, che pure è una delle migliori doti dell’uomo, si risolve in un danno per lui. Le bestie non hanno questa preoccupazione: quando vedono o intuiscono un pericolo lo evitano, dopodiché tornano a sentirsi tranquille e sicure. Noi, invece, siamo sempre lì a tormentarci, non solo per il futuro, ma anche per il passato. Spesso le nostre buone prerogative ci danneggiano: la memoria, per esempio, risveglia in noi l’angoscia della paura, la tendenza a prevedere il futuro l’anticipa. Chi pensa solo al presente non è infelice. Stammi bene. 6. Caro Lucilio, mi accorgo che non solo vado correggendo i miei difetti ma che addirittura mi trasformo, anche se in verità non sono certo, e neppure lo spero, che in me non ci sia più nulla da mutare. E perché, poi, non dovrei avere ancora molte cose da rivedere, da attenuare o da potenziare? Scoprire difetti insospettati è già una prova che l’animo ha fatto dei progressi: per questo ci si rallegra quando un malato prende coscienza del suo male. Voglio dunque metterti al corrente di questo mio improvviso cambiamento, perché così comincerò ad
avere una più salda fiducia nella nostra amicizia, un’amicizia autentica, che né la speranza, né la paura, né la ricerca di un interesse personale possono spezzare, quell’amicizia che dura sino alla morte, e per la quale si è pronti a morire. Potrei citarti molte persone a cui se non è mancato un amico è mancata però la vera amicizia, cosa che non può accadere quando gli animi sono spinti ad associarsi da un identico amore per il bene. E sai perché? Perché riconoscono di avere ogni cosa in comune, e in primo luogo le avversità. Non puoi immaginare quanti miglioramenti io veda compiersi in me di giorno in giorno. «Dimmelo», tu mi chiedi, «questo metodo che hai trovato tanto efficace». Sicuro. Voglio trasfondere in te tutto il mio sapere: sono lieto di imparare qualcosa proprio per insegnarla, né potrei compiacermi di apprendere una notizia, per quanto eccezionale e salutare, se dovessi tenerla solo per me. Se mi fosse offerta la saggezza a condizione di tenerla chiusa dentro di me senza trasmetterla ad altri la rifiuterei: non dà gioia il possesso di un bene se non lo si divide con altri. Ti manderò dunque i libri in questione e affinché tu non perda tempo a rintracciare i passi utili che sono sparsi qua e là li sottolineerò, così troverai subito ciò che approvo e ammiro. Più che un discorso scritto, però, ti sarà utile vivere e conversare insieme con me, e bisogna proprio che tu venga innanzitutto perché gli uomini credono più ai loro occhi che alle loro orecchie, poi perché attraverso i precetti il cammino è lungo, mentre avendo davanti gli esempi si fa presto. Cleante9 non avrebbe potuto illustrare pienamente la dottrina di Zenone10 se si fosse limitato ad ascoltare le sue lezioni: partecipò alla vita di lui, ne penetrò i segreti, osservò se metteva in atto i suoi insegnamenti. Platone, Aristotele e tutta la schiera dei filosofi che seguirono Socrate, e che poi avrebbero presero strade diverse, impararono più dalla sua vita che dalle sue parole. Non la scuola di Epicuro, ma il vivere insieme con lui rese grandi Metrodoro, Ermarco e Polieno.11 Del resto non ti chiedo di venire solo perché tu ne tragga giovamento, lo desidero anche perché tu a tua volta possa essermi utile: ci aiuteremo moltissimo a vicenda. Intanto, visto che ti devo il mio piccolo contributo quotidiano, ti dirò cosa mi è piaciuto oggi di Ecatone. «Mi chiedi quali progressi abbia fatto?», scrive. «Ho cominciato a essere amico di me stesso».12 Ha fatto un grande progresso: non sarà mai solo. Sappi che tutti possono avere un tale amico. Stammi bene. 7. Vuoi sapere che cosa, in questo momento, dovresti soprattutto evitare? Secondo me, la folla. Ancora, infatti, non puoi affrontarla senza incorrere in qualche inconveniente. Per quel che mi riguarda ti confesserò la mia debolezza: non rientro mai nelle stesse condizioni di spirito in cui sono uscito: quell’equilibrio interiore che avevo prima si è incrinato e alcuni nèi di cui mi ero liberato riaffiorano. Come gli ammalati indeboliscono a causa di una lunga infermità, tanto che non possono uscire senza risentirne, così accade anche a me, il cui animo è come se si fosse appena ripreso da una lunga malattia. Intrattenersi a parlare con molta gente è deleterio: c’è sempre qualcuno che ci raccomanda
qualche vizio o ce lo trasmette, oppure ce lo attacca senza che ce ne accorgiamo. E quante più sono le persone che contattiamo tanto maggiore è il rischio. In verità non c’è cosa che arrechi più danno alla morale che l’assistere passivamente a certi spettacoli, poiché è proprio attraverso il piacere che i vizi si insinuano più facilmente. Capisci cosa voglio dire? Quando ritorno a casa mi sento più avido, più ambizioso, più dissoluto, addirittura più crudele e più disumano. Perché sono stato fra gli uomini. Una volta mi sono imbattuto per caso in uno spettacolo di mezzogiorno: mi aspettavo qualche scenetta scherzosa, qualche facezia, qualcosa di distensivo che desse agli occhi degli uomini un po’ di pace dopo tanto sangue umano. Macché. Tutto il contrario: gli scontri precedenti al confronto erano atti di pietà; in quel caso altro che scherzi, sono omicidi belli e buoni. I gladiatori non hanno nulla con cui proteggersi, tutto il corpo è esposto a ogni genere di colpi, e questi non vanno mai a vuoto. La gente perlopiù preferisce questo spettacolo alle coppie ordinarie di gladiatori e a quelle su richiesta del pubblico. E perché non dovrebbe preferirlo? Non c’è corazza né scudo che respinga la lama. A che pro le difese? A che serve la bravura? Tutto ciò ritarda la morte. Al mattino gli uomini sono gettati in pasto agli orsi e ai leoni, a mezzogiorno ai loro spettatori. Il pubblico grida che chi ha ucciso venga ucciso a sua volta, e chi scampa alla morte è tenuto in serbo per un altro massacro: la conclusione è che muoiono tutti i combattenti. Uno spettacolo, insomma, fatto di ferro e di fuoco. L’arena è ancora vuota e gli spettatori cominciano a protestare: «Ma quello è un ladro, un assassino!». E allora? Siccome ha ucciso merita di morire. E tu, disgraziato, che cosa hai fatto per meritare di assistere a questo spettacolo? «Uccidilo!», «Brucialo!», «Prendilo a frustate!», «Perché non si lascia ammazzare?», «Perché uccide con così poca violenza?», «Accetta di buon grado la tua morte!», «A suon di frusta fatelo combattere!», «Colpitevi l’un l’altro, affrontandovi a petto nudo!». Non si calmano nemmeno all’intervallo. «Si sgozzi qualcuno, intanto, per non restare con le mani in mano!». Ma non capite che i cattivi esempi si ritorcono su chi li dà? Ringraziate gli dèi perché insegnate la crudeltà a chi non può impararla! Bisogna che gli animi deboli e poco saldi nel bene evitino la folla, perché è facile che si lascino influenzare dalle opinioni della maggioranza. A frequentare una simile massa di gente avrebbero cambiato i loro costumi persino Socrate, Lelio13 e Catone:14 nessuno di noi, infatti, specialmente quando il nostro carattere è ancora in via di formazione, potrebbe resistere all’assalto dei vizi che ci vengono incontro con tanto di accompagnamento. Un solo esempio di lussuria o di avidità produce un danno irreparabile: un commensale raffinato a lungo andare ti snerva e ti infiacchisce, un vicino ricco eccita la tua avidità, un compagno vizioso e malvagio contamina anche i semplici e i puri. Pensa un po’ quale danno possono subire i nostri princìpi morali quando vengono aggrediti da una tale massa di vizi. O li imiti, o li odi, non c’è scampo. E tu, invece, devi evitare entrambi gli estremi, cioè non diventare simile ai cattivi perché sono molti, ma neppure nemico ai molti perché sono diversi da te. Ritirati in te stesso
più che puoi, mescolati con coloro che possono migliorarti e accogli quelli che tu a tua volta puoi rendere migliori. In queste cose c’è una reciprocità nel senso che mentre s’insegna s’impara. Del resto non c’è bisogno che tu vada in mezzo alla folla per soddisfare la tua ambizione, declamando e discutendo pubblicamente, capirei e vorrei che tu lo facessi se avessi argomenti che si convengono alla massa, ma in mezzo a questa non c’è nessuno in grado di comprendere i tuoi discorsi, forse potrà essercene qualcuno, una o due persone al massimo, ma prima dovresti plasmarle, educarle affinché possano capirti. «Ma allora», obietterai, per chi ho imparato tutte queste cose?». Non temere di aver perso il tuo tempo: hai imparato per te. Ma per dimostrarti che al mio stato attuale io non ho imparato solo per me, ti citerò tre belle massime che mi è capitato di leggere pressappoco su questo argomento, una delle quali salda il mio debito per questa lettera; le altre due prendile come anticipo. Dice Democrito:15 «Per me un solo individuo vale quanto il popolo e il popolo quanto un solo individuo». Pure un altro ne ha detta una buona (anche se non si sa di chi si tratti, ma chiunque egli sia stato non ha importanza): a chi gli chiedeva perché mai si applicasse con tanta cura in una materia che pochissimi avrebbero potuto comprendere, rispose: «A me ne bastano pochi, anzi, anche uno solo o nessuno». Eccellente anche questo terzo detto, attribuito a Epicuro, che a un suo compagno di studi scriveva: «Ciò che dico lo dico per te, non per tante persone: noi due siamo l’uno per l’altro un teatro abbastanza grande». Queste massime, caro Lucilio, devi imprimertele bene in mente, per poter disprezzare il piacere che deriva dal consenso della massa. Sono molti quelli che ti lodano, e ciò dovrebbe bastarti: perché dovresti desiderare di essere capito da tanti? È dalla tua coscienza che le tue doti devono essere apprezzate. Stammi bene. 8. «Evita la folla», mi scrivi, «chiuditi in te stesso e ascolta la voce della tua coscienza. Dove sono andati a finire, allora, i vostri insegnamenti che impongono di agire sino alla morte?». Ma cosa dici? Ti sembra che io inviti all’inattività? Mi sono ritirato e ho chiuso le porte non per me ma per poter essere utile a quanta più gente possibile. Non c’è giorno in cui io non faccia qualcosa, persino una parte della notte la dedico agli studi: io non mi abbandono al sonno deliberatamente, finisco col cedervi dopo aver costretto al lavoro gli occhi che si chiudono, stanchi e affaticati dalla veglia. Più che dagli uomini è dalle cose che mi sono allontanato: ho lasciato i miei impegni personali per dedicarmi agli affari dei posteri. È per loro che scrivo, è a loro che voglio essere utile, affidando alle mie pagine consigli salutari, come se fossero ricette di medicine, delle quali io stesso ho sperimentato l’efficacia sulle mie ferite, che se non si sono completamente rimarginate perlomeno hanno delimitato la loro area di azione. Mostro agli altri la retta via, che ho conosciuto tardi, quando ormai ero stanco per il lungo peregrinare. Io grido agli uomini: «Evitate tutto ciò che piace al volgo e che proviene dal caso; guardate con sospetto e timore ogni bene
fortuito, non fate come i pesci e le bestie che si lasciano ingannare da allettanti lusinghe. Credete che questi siano doni della fortuna? Sono trappole. Se volete vivere una vita sicura evitate quanto più potete questi beni appiccicosi, che traggono in inganno noi, sventurati anche in questo, che crediamo di possederli quando invece siamo incappati nella rete. Non ci accorgiamo che questa strada ci porta al precipizio: chi sale troppo in alto è destinato a cadere. E una volta che la buona sorte ha cominciato a farci deviare dalla retta via non ci è più lecito tornare indietro, non ci sono alternative, si prosegue e si va dritti al precipizio. La malasorte non solo ci travolge, ma ci sbatte e ci schianta con la faccia a terra. Seguite questa sana e salutare norma di vita: concedete al corpo solo quanto gli serve per mantenersi in buona salute, trattatelo piuttosto duramente affinché si pieghi alle giuste esigenze dello spirito, mangi e beva quanto basti per placare la fame e spegnere la sete, indossi abiti adatti a proteggerlo dal freddo e la casa gli serva unicamente come riparo contro le intemperie: che sia fatta di zolle o di marmo forestiero e variegato non ha importanza, poiché per coprirsi tanto vale un tetto di foglie quanto un tetto d’oro. Disprezzate tutto ciò che si costruisce, a prezzo di vane fatiche, per vivere nel lusso o per motivi di prestigio: solo l’anima è degna di ammirazione e quando è grande lei niente è grande per lei». Ebbene, non ti sembra che io sia più utile se discuto di queste cose, con me stesso o con i posteri, piuttosto che parlare come avvocato difensore in un processo, mettere i sigilli ai testamenti, o usare la mia voce e i miei gesti a favore di uno che si candida come senatore? Credimi, anche se non sembra, ci sono cose molto più importanti che non costano nulla, come occuparsi delle cose umane e di quelle divine contemporaneamente. Ma la mia lettera volge al termine, ormai, e prima di chiudere devo pagare il tributo che mi sono prefisso. Non attingerò al mio repertorio: ancora una volta saccheggerò Epicuro, di cui oggi ho raccolto questa massima: «Se vuoi essere veramente libero devi votarti alla filosofia». E lo sarai subito, nel medesimo istante in cui ti sottometti e ti consegni a lei, perché chi serve la filosofia è per ciò stesso libero: la filosofia, infatti, è libertà. Adesso, forse, tu mi chiederai: «Perché mi citi tante belle frasi di Epicuro e non invece dei nostri amati stoici?». E perché tu le dici di Epicuro quando sono di pubblico dominio? Quanti poeti esprimono concetti già formulati o che ancora devono essere enunciati dai filosofi! Per non parlare dei poeti tragici e delle nostre commedie togate16 (che per la loro gravità sono una via di mezzo fra la commedia e la tragedia): quanti versi eloquentissimi non ci sono nei mimi! Quante frasi di Publilio Siro17 dovrebbero essere recitate da attori tragici, non da comici o mimi! Ti citerò di lui un solo verso, che riguarda proprio la filosofia e l’argomento appena trattato, in cui si afferma che non dobbiamo considerare nostri i beni casuali: Ciò che da noi ci viene non è nostro. Anche tu, se ben ricordo, hai espresso lo stesso concetto, per giunta molto
meglio e con maggiore concisione: Non è tuo ciò che il caso ha reso tuo. Né va dimenticata quest’altra tua massima, che è ancora migliore: Un bene dato si può pure toglierlo18 Questo, però, non te lo metto in conto, a saldo del mio debito: ti restituisco ciò ch’è già tuo. Stammi bene. 9. Vuoi sapere se sia giusta l’obiezione mossa da Epicuro in una sua lettera a quanti affermano che il saggio basta a sé stesso e che perciò non ha bisogno di amici. La critica è rivolta a Stilbone19 e a quanti credono che il sommo bene sia il non patire alcunché. Ebbene, qui si cade inevitabilmente in un equivoco se si traduce sbrigativamente apàtheia con una sola parola, cioè con impatientia, poiché si rischia di intendere il contrario di quel che si vuol dire. Noi ci riferiamo propriamente alla «capacità di respingere la sensazione» di qualsiasi male, mentre impatientia può essere interpretata nel senso di «incapacità di sopportare il male». Vedi dunque se non sia preferibile parlare di animo invulnerabile o che sta al di là di ogni sofferenza. Fra noi e loro questa è la differenza: il nostro saggio vince ogni male ma lo sente, il loro non lo sente proprio. Ciò che ci accomuna entrambi è la convinzione che il saggio basti a sé stesso. Ma, pur essendo autosufficiente, egli vuole un amico, uno che gli stia vicino o che la pensi come lui. Ed è autosufficiente al punto che se perde qualcosa gli basta quel che gli rimane: se il nemico, mettiamo, o una malattia l’hanno privato di una mano, se un infortunio gli ha portato via un occhio o anche tutti e due, quel che gli resta gli basterà, il suo corpo mutilato lo soddisferà non meno di quando era integro; il che non significa che preferisca la mutilazione, semplicemente non rimpiange la parte che ha perduto. Analogamente il saggio basta a sé stesso non nel senso che non vuole amici bensì nel senso che può stare senza amici, il che significa che è capace di sopportarne la mancanza con serenità. Egli, però non resterà mai senza amici, perché la sua condizione gli consente di procurarsene sempre di nuovi e quanto più presto egli voglia: come Fidia se avesse perso una statua ne avrebbe fatta subito un’altra, così questo artefice di amicizie se perde un amico lo sostituisce con un altro. E vuoi sapere come fa il saggio a stringere in fretta un’amicizia? Te lo dirò, ma prima lascia ch’io saldi subito il mio debito, e con ciò, per quel che riguarda questa lettera, chiudiamo il conto alla pari. Ecatone dice: «Ti indicherò un filtro amoroso senza pozioni, senza erbe e senza formule magiche: se vuoi essere amato, ama». Si ricava grande piacere non solo dalle amicizie che già si hanno e che sono collaudate, ma anche dal cercarle per la prima volta e dal procurarsene di nuove. Fra chi ha già trovato un amico e chi lo sta cercando c’è la stessa differenza che
passa fra un contadino che miete e uno che semina. Anzi, il filosofo Attalo 20 era solito dire che farsi un amico dà più gioia che l’averlo già, «come per un pittore è più bello dipingere che avere dipinto». Si prova infatti una gioia maggiore nell’eseguire l’opera che nello starsene con le mani in mano dopo averla terminata, poiché a quel punto si gode del frutto della propria arte, mentre nel dipingere si godeva dell’arte in sé. I figli quando sono adolescenti ci dànno più frutti, ma da piccoli ci fanno più tenerezza. Ora torniamo al nostro argomento. Il saggio, anche se basta a sé stesso, vuole avere un amico, ma solo per esercitare l’amicizia, per non lasciare inattiva una virtù così nobile; non per i motivi indicati da Epicuro nella lettera citata, cioè «per avere qualcuno che lo assista se si ammala, che lo conforti se è rinchiuso in prigione o è caduto in miseria», ma per avere lui qualcuno da poter assistere se è malato, da liberare se è fatto prigioniero dai nemici. Chi guarda solo al proprio interesse e cerca amici per questo motivo non è saggio, sbaglia strada. Una simile amicizia è destinata a finire così com’è iniziata: chi si procura un amico perché possa aiutarlo se mai finisce in prigione, al primo tintinnar di manette si ritroverà solo. Queste sono le amicizie che il popolo chiama opportunistiche: le amicizie interessate sono gradite finché tornano utili. Per questo chi ha successo è circondato da una folla di amici, mentre chi cade in disgrazia è abbandonato da tutti, i suoi amici fuggono nel momento in cui vengono messi alla prova. Sono tanti gli esempi scellerati di persone che abbandonano l’amico per paura, o che per lo stesso motivo lo tradiscono. All’inizio segue inevitabilmente una conclusione analoga: chi ha stretto amicizia per convenienza, per convenienza la rinnegherà, se nell’amicizia si cerca un utile, per ottenerlo si è disposti anche a tradirla. «E tu per quale motivo ti procuri un amico?». Per avere qualcuno per cui morire, da seguire in esilio, da strappare alla morte anche a costo della mia vita: quella che dici tu non è amicizia, è commercio, perché mira al tornaconto, ai vantaggi che possono derivarne. Senza dubbio c’è una certa somiglianza fra l’amicizia e l’amore, cioè il rapporto che intercorre fra due innamorati, salvo che l’amore si potrebbe definire un’amicizia irrazionale. C’è forse qualcuno che ama veramente per denaro, per ambizione o per gloria? L’amore, per sua stessa natura, noncurante di ogni altra cosa, accende nell’animo un desiderio di bellezza; ovviamente con la speranza di un affetto reciproco. Ma com’è possibile che da una causa piuttosto nobile nasca un sentimento meschino? «Non è questione», tu dici, «se l’amicizia si debba ricercare per sé stessa». E invece è proprio questa la prima cosa da dimostrare, perché se l’amicizia va ricercata per sé stessa vi si può accostare anche chi è autosufficiente. «E in che modo vi si accosta?». Vi si accosta come chi è attirato da qualcosa di molto bello, ma non per lucro e nemmeno per timore della instabilità della sorte: chi cerca l’amicizia solo in vista di circostanze che possano giovargli la priva della sua grandezza. «Il saggio basta a sé stesso». Caro Lucilio, i più interpretano male questa affermazione, nel senso, cioè, che il saggio debba stare lontano da tutto e da tutti, chiuso dentro il suo guscio. È bene chiarire il significato e i limiti di questa
espressione: il saggio basta a sé stesso non per vivere ma per vivere felice: per vivere, infatti, ha bisogno di molte cose, mentre per essere felice gli basta avere un animo onesto, impavido e incurante della sorte. Ascolta a questo proposito l’osservazione di Crisippo.21 Egli dice che il saggio non sente la mancanza di alcunché e tuttavia ha bisogno di molte cose, mentre «lo stolto non ha bisogno di nulla (perché non sa servirsi di alcunché), ma sente la mancanza di tutto». Ebbene, il saggio ha sì bisogno di certe cose, come le mani, gli occhi e altri strumenti indispensabili alle materiali attività quotidiane, ma se gli mancassero non ne risentirebbe: ciò che ci fa sentire la mancanza di una cosa, infatti, è la sua necessità, una sensazione che per il saggio non esiste proprio. Ne consegue che, pur bastando a sé stesso, egli ha bisogno di amici e desidera averne quanti più possibile, ma non per essere felice, perché è felice anche senza amici: la felicità non cerca mezzi esterni per potersi realizzare, si coltiva per così dire in casa, è un bene interiore, dipende solo da noi stessi; se il saggio cercasse fuori anche una sola parte di sé diventerebbe schiavo della sorte. «D’accordo», mi dirai: «ma che vita sarà quella del saggio se, gettato in prigione o relegato fra gente straniera, se trattenuto in mare per troppo tempo o addirittura sbattuto su una spiaggia deserta, resterà senza amici?». Sarà analoga a quella di Giove quando, dissoltosi il mondo e riassorbiti gli altri dèi nell’essenza primigenia, in una temporanea sospensione dell’attività creativa, riposerà come chiuso in sé stesso e tutto dedito ai suoi pensieri. Il saggio fa qualcosa di simile, visto che ha tutto dentro ed è in grado di stare a tu per tu con sé stesso. Ma finché gli è lecito disporre di ogni cosa a suo piacere basta a sé stesso e tuttavia prende moglie, basta a sé stesso e tuttavia alleva dei figli; insomma, pur essendo autosufficiente, non gli va di vivere da solo, in quanto è spinto all’amicizia da una inclinazione naturale, non da interessi personali, perché, come di altre cose, così è innato in noi il piacere dell’amicizia. Come esistono l’avversione per la solitudine e la tendenza a vivere in società, come la natura lega gli uomini fra loro, così anche in questo campo c’è in noi un impulso che ci fa cercare le amicizie. Tuttavia il saggio, benché ami moltissimo gli amici, se li procuri e non di rado li ponga anche al sopra di sé, riporrà ogni suo bene in sé stesso, memore di ciò che disse quel famoso Stilbone, che Epicuro critica nella sua lettera, quando, sconfitta la sua patria, persi i figli e la moglie e uscito solo e tuttavia sereno dall’incendio generale, richiesto da Demetrio22 (chiamato poi Poliorcete per le città che aveva distrutto) se avesse perso qualcosa, rispose: «Tutti i miei beni li ho con me». Ecco un uomo forte e valoroso. «Non ho perduto nulla», disse, costringendo così il nemico a dubitare di aver vinto. «Tutti i miei beni sono con me», cioè giustizia, virtù, saggezza, e soprattutto la convinzione che non è un bene ciò che può esserci tolto. Ci stupiamo che certi animali passino attraverso il fuoco senza farsi alcun male, ma quanto è più da ammirare quest’uomo che uscì indenne e integro dalle armi, dalle rovine e dalle fiamme! Vedi com’è più facile vincere un popolo intero che non un solo uomo? È il medesimo concetto del filosofo stoico: anche costui attraversa l’incendio delle
città portando intatti i suoi beni, perché basta a sé stesso e in quest’ambito circoscrive la sua felicità. Non pensare però che solo noi vantiamo massime così alte, poiché Epicuro stesso, che pur rimproverava Stilbone, pronunciò una frase analoga, di cui voglio farti dono, anche se per oggi ho già pagato il mio debito. «Chi non ritiene più che sufficiente quel che possiede sarà infelice anche se diventasse padrone del mondo». O, per dirla meglio (bisogna infatti badare più che alle parole al significato): «Chi non si considera sommamente felice, pur se padrone del mondo, è un poveraccio». E se vuoi vedere quanto sia comune questo concetto, perché dettato dalla natura, leggi quel poeta comico che ha scritto: Infelice colui che non ritiene d’essere felice!23 Che importa infatti quale sia il tuo stato se a te sembra cattivo? «E che?», ribatterai. «Se uno dicesse di essere felice, o perché spudoratamente ricco, o perché padrone di molti schiavi, ma schiavo a sua volta di molte più persone, lo diventerà in virtù di quella sua frase?». Ciò che conta non è quel che dice, è quel che sente, ma sempre, non un giorno soltanto. Non meravigliarti, poi, che un così grande bene possa toccare anche a un uomo indegno: solo il saggio sa godere veramente di quel che possiede, lo stolto, invece, si macera nel fastidio che prova della sua stoltezza stessa. Stammi bene. 10. È così, e io non cambio parere. Perciò ti dico: evita la folla, come pure i pochi e le singole persone. Non mi risulta che ci sia qualcuno con cui gradirei che tu avessi rapporti di amicizia: ti stimo tanto da scommettere che puoi contare solo su te stesso. Si narra che Cratete,24 un discepolo di quello stesso Stilbone di cui ho parlato nella mia lettera precedente, visto un ragazzo che passeggiava in disparte da tutti, gli chiese che cosa mai facesse lì da solo. E lui: «Parlo con me stesso», rispose. Al che Cratete: «Attento», ribatté: «stai parlando con un cattivo soggetto». Di solito quando vediamo uno che piange o che ha paura lo teniamo d’occhio, nel timore che la solitudine possa indurlo a un gesto insano. Ebbene, chi è avventato non deve mai essere lasciato in balìa di sé stesso, perché rimugina cattivi pensieri, medita qualche guaio, per sé o per gli altri, asseconda turpi passioni: in quella solitudine l’animo butta fuori tutto ciò che teneva nascosto per timore o per pudore, aumenta la sua audacia, fomenta la libidine, stimola l’ira. Per farla breve, quello che in condizioni normali è l’unico vantaggio della solitudine, cioè il tener tutto per sé e non temere spie o delatori, manca nello stolto, quando si trova solo: egli si tradisce da sé. Vedi dunque quali speranze io riponga in te, anzi, quale cieca fiducia (la speranza, infatti, è un bene incerto), poiché non riesco a trovare altra persona se non te con cui vorrei che tu avessi rapporti di amicizia. Mi vengono in mente certe tue frasi magnanime e vigorose che quando te le ho sentite pronunciare mi hanno molto rallegrato, e mi sono detto: «Queste parole vengono dal cuore, non
dalla bocca; costui non è un uomo comune, pensa al bene dello spirito». Parla e vivi, dunque, com’è tuo costume, non abbatterti mai, ringrazia gli dèi per i favori che ti hanno concesso in passato e chiedine di nuovi, cioè, una mente integra e pura, la salute dell’anima innanzitutto, poi quella del corpo. Rinnovale sempre queste richieste, con animo ardito e sicuro, poiché non chiedi nulla di estraneo. Ma poiché, al solito, voglio accompagnare questa lettera con un piccolo dono, eccoti ciò che ho letto in Atenodoro: 25 «Sarai davvero libero da ogni passione quando agli dèi non chiederai altro se non ciò che puoi chiedere alla presenza di tutti». Quanto sono stolti gli uomini! Formulano sottovoce i desideri più turpi e se qualcuno porge l’orecchio si azzittiscono subito: raccontano agli dèi ciò che non vogliono far sapere agli uomini. Vedi, dunque, quanto sia salutare questo insegnamento: vivi fra gli uomini come se dio ti vedesse e parla con dio come se gli uomini ti ascoltassero. Stammi bene. 11. Ho parlato col tuo amico: è di indole buona e fin dalle sue prime parole mi ha dimostrato di possedere intelligenza e grandezza d’animo, e di aver già fatto molti progressi. Mi ha dato un saggio delle sue virtù, alle quali sono certo che non verrà mai meno, poiché discuteva non di cose scontate o su cui si fosse preparato, ma a sorpresa, su ciò che di volta in volta io gli proponevo, e quando si concentrava sull’argomento riusciva a superare solo in parte quella timidezza che in un giovane è già un buon segno, tanto da arrossirne come dal profondo dell’anima. E quel rossore sono certo che lo accompagnerà sempre, anche quando, consolidate le sue virtù e liberatosi da ogni vizio, sarà divenuto saggio: non v’è saggezza, infatti, che possa cancellare i naturali difetti del corpo e dello spirito, in quanto ciò che è innato e radicato in noi non può essere eliminato, si può solo attenuarlo, ma con un esercizio costante e consapevole. Ci sono uomini che pur di carattere molto fermo sudano abbondantemente davanti alla folla, come chi è stanco e accaldato; ad alcuni tremano le ginocchia, quando devono parlare, ad altri battono i denti, s’incespica la lingua, s’incollano le labbra, addirittura; né valgono l’esercizio o l’esperienza a vincere questi difetti, in quanto è la natura stessa che esercita così la sua forza, anche per ricordare la sua presenza e le umane debolezze persino agli individui più robusti e vigorosi. Fra tali difetti c’è appunto il rossore, che si sparge spontaneo e improvviso anche sul volto di personaggi autorevoli. Lo si vede più spesso nei giovani, che si accendono facilmente e hanno la fronte più delicata, ma non risparmia nemmeno gli anziani e i vecchi. Alcuni sono più temuti proprio quando arrossiscono, come avessero deposto ogni pudore. Silla26 diventava violentissimo quando il sangue gli saliva al viso, mentre non c’era nulla di più dolce del volto di Pompeo, quando arrossiva davanti alla folla e soprattutto se doveva tenere un discorso. Ricordo che Fabiano,27 chiamato in Senato come testimone, si fece rosso in viso e quel pudore gli si addiceva meravigliosamente. Ciò è dovuto non a debolezza d’animo ma alla novità di un evento particolare, che, se pur non sgomenta la prima volta, provoca comunque un’emozione in chi ha per natura questo
«difetto»: infatti, mentre alcuni hanno il sangue lento, altri lo hanno veloce e mobile, e perciò affluisce subito al viso. Perciò nemmeno la saggezza, come ho detto, può eliminare questi difetti, e d’altra parte se potesse cancellarli tutti avrebbe il dominio completo sulla natura. Tutte le caratteristiche che sono legate alla nascita o alla costituzione fisica persisteranno in noi anche se avremo tenuto il nostro animo impegnato in una lunga e assidua educazione: come non ce le siamo procurate noi, così non possiamo sradicarle. Gli attori di teatro, che rappresentano i sentimenti, che esprimono la paura, la trepidazione e la tristezza, manifestano la timidezza chinando il volto, parlando con voce sommessa, abbassando gli occhi e tenendoli fissi a terra. Ma non possono esprimere il rossore, in quanto è il risultato di una reazione che non si può né impedire né provocare. Neppure la saggezza può porvi rimedio o giovare in qualche modo, poiché si tratta di fenomeni incontrollabili: vengono e se ne vanno spontaneamente. Ma devo chiudere, ormai. Prenditi dunque questa massima, utile e salutare, e imprimitela bene nell’animo: «Dobbiamo sceglierci un uomo virtuoso da tenere sempre davanti agli occhi, sì da vivere come se lui ci guardasse e agire come se ci vedesse». Questo, Lucilio mio, insegna Epicuro, il quale non senza ragione ci ha dato un custode e un maestro: si evitano molti errori se c’è un testimone quando si sta per commetterli. L’animo ha bisogno di qualcuno da temere e da rispettare, che con la sua autorevolezza renda più puri anche i nostri più segreti sentimenti. Sia benedetto colui che ci aiuta a migliorarci, non solo con la sua presenza fisica ma anche se soltanto lo pensiamo! Fortunato chi nutre un tale rispetto per una persona da correggersi e migliorarsi anche solo ricordandola, perché chi rispetta sarà rispettato. Scegli dunque Catone a tuo modello, ma se ti sembra troppo intransigente prenditi Lelio, più mite di carattere. Scegliti insomma un uomo di cui approvi la vita, il parlare e il volto stesso, che è lo specchio dell’anima; tienilo sempre presente come custode e maestro. Dobbiamo regolare su qualcuno la nostra condotta, poiché i difetti da soli non si correggono: ci vuole una norma di riferimento. Stammi bene. 12. Dovunque io volga lo sguardo, vedo i segni della mia vecchiaia. Ero andato nella mia villa fuori città e nel vederla così malandata brontolavo pensando alle spese necessarie per ristrutturarla. Il fattore mi risponde che non è per sua negligenza se si trova in quello stato, che lui, anzi, fa tutto il possibile per tenerla in piedi, ma l’edificio è vecchio. Questa villa è cresciuta fra le mie mani: che ne sarà di me, se i muri che hanno la mia stessa età sono così fatiscenti? Stizzito, me la prendo col fattore e cambiando argomento afferro il primo pretesto che mi capita a tiro. «Non vedi come sono trascurati questi platani?», gli dico. «Non hanno foglie, i rami sono secchi e nodosi, i tronchi brutti e squallidi! Tutto ciò non succederebbe se qualcuno vi zappasse intorno e li innaffiasse!». «Ma è proprio quello che faccio!», ribatte lui. E giura sul mio genio tutelare28 che non cessa mai di curarsene, ma gli alberi, dice, sono troppo
vecchi ormai. Detto fra noi: li ho piantati io, e ne ho visto nascere le prime foglie. Mi giro verso la porta d’ingresso e…: «Chi è quello là?», gli grido. «Quel vecchio decrepito piazzato sulla soglia e rivolto verso l’esterno?29 Dove l’hai trovato? Come ti è saltato in mente di portare qui il cadavere di uno sconosciuto?». E il vecchio: «Non mi riconosci?», esclama. «Sono Felicione! Mi regalavi sempre le statuette d’argilla.30 Sono figlio del fattore Filosito, ero il tuo prediletto». «Questo è completamente pazzo!», mi dico. «Il mio prediletto diventato un bambino?! Ma sì, perché no? Proprio ora gli cadono i denti!». Dovunque volgessi lo sguardo la mia villa di campagna mi ha mostrato palesemente la mia vecchiaia. Abbracciamola e amiamola: può darci ancora grandi piaceri, se sappiamo farne buon uso. I frutti sono assai più graditi quando cominciano a scarseggiare; la fanciullezza raggiunge il suo massimo splendore quando sta per finire; chi ama il vino gusta di più l’ultimo bicchiere, quello che stordisce, che dà all’ebbrezza il tocco finale; ogni piacere il meglio di sé lo dà proprio alla fine. Dolcissima è l’età avanzata che già comincia a declinare ma non precipita ancora; e anche quella che si trova agli sgoccioli, come l’acqua sull’ultima tegola, credo che abbia i suoi piaceri; o, se non altro, al piacere subentra il non sentirne più il bisogno. Com’è dolce abbandonare le passioni dopo averle estenuate! «È penoso, però», ribatterai, «avere la morte davanti agli occhi». A parte il fatto che è davanti agli occhi di tutti, sia del vecchio che del giovane (la morte, infatti, non ci chiama in base all’età), nessuno è mai tanto vecchio da non poter sperare di vivere ancora un altro giorno. E un giorno è una tappa della vita. La nostra esistenza, infatti, è composta di parti e di cerchi di varia grandezza, ciascuno dei quali al suo interno ne contiene di più piccoli: il più grande, che va dal giorno della nascita a quello della morte, abbraccia e racchiude dentro di sé tutti gli altri, fra i quali c’è quello che comprende uno per uno i cerchi corrispondenti agli anni dell’adolescenza, quello al cui interno si svolge tutta la fanciullezza, e così via. C’è poi il cerchio dell’anno, che contiene in sé tutti gli attimi la cui somma costituisce la vita, e all’interno del quale c’è un cerchio più piccolo che comprende il mese, mentre il giorno ha un giro più breve, ma anche lui va da un inizio a una fine, come dall’alba al tramonto. Per questo Eraclito – detto «l’oscuro» per via del suo linguaggio – sosteneva che «un giorno è uguale a ogni altro»: uguale per numero di ore (e questa mi sembra l’interpretazione corretta), in quanto, essendo il giorno composto da ventiquattro ore, tutti i giorni devono avere lo stesso arco di tempo, e quindi essere uguali fra loro, perché ciò che il giorno va perdendo via via se lo prende la notte. Alcuni, invece, interpretano “uguale” nel senso che un giorno “somiglia” a tutti gli altri: infatti uno solo di essi può contenere una quantità di fenomeni che si trovano in un periodo di tempo molto più lungo di un giorno, come la luce e il buio, e fenomeni come la notte, che non sempre e dovunque ha la stessa durata, nelle alterne vicende dell’universo sono molto numerosi. Di conseguenza ogni giorno deve essere organizzato come se chiudesse il cerchio portando a termine e a compimento la nostra vita. Pacuvio – che fu governatore della Siria per un lungo
periodo di tempo tanto da farla praticamente sua – celebrava le proprie esequie con vino e banchetti funebri: dalla sala da pranzo si faceva portare in camera da letto mentre i suoi beniamini lo applaudivano e accompagnati dalla musica cantavano: «È vissuto, è vissuto». Non c’era giorno in cui non celebrasse il proprio funerale. Ebbene, ciò che Pacuvio faceva per cattiva coscienza, noi facciamolo spinti da quella buona, e andando a dormire lieti e sereni, diciamo: Sono vissuto e ho percorso la via che mi diede il destino.31 Se dio vorrà concederci ancora un giorno, accettiamolo con gioia. È veramente felice e padrone di sé chi attende il domani senza alcuna trepidazione: a colui che sa dire “sono vissuto” svegliarsi e alzarsi ogni mattina appare come un guadagno. Ma devo chiudere, ormai. «Così, senza alcun regalo?». Non temere: la lettera ti porterà qualcosa. Ma che dico “qualcosa”: moltissimo. Non c’è nulla infatti di più splendido della massima che le affido perché te la riferisca. «È un male vivere nella necessità, ma non c’è alcuna necessità di vivere nella necessità».32 E sai perché non c’è? Da ogni parte si aprono molte vie, brevi e facili, verso la libertà. Ringraziamo dio perché nessuno può essere tenuto in vita contro la sua volontà. Come vedi, possiamo schiacciare persino la necessità. «Ma questo lo ha detto Epicuro», mi dirai: «tu cosa c’entri con un estraneo?». È la verità, e ciò che è vero appartiene anche a me. E io continuerò a propinarti Epicuro, affinché quelli che giurano sulle parole, badando non al loro significato ma a chi le pronuncia, sappiano che le cose più belle sono patrimonio di tutti. Stammi bene.
1. Cfr. Esiodo, Opere e giorni, 369. 2. Epicuro. 3. Di Teofrasto, filosofo e scienziato greco, sono molto noti i Caratteri morali. 4. Forse si tratta dello scrittore di teatro del I sec. a.C., autore di Fabulae Atellanae. 5. Pompeo, rifugiatosi in Egitto dopo la sconfitta di Farsalo, fu ucciso a tradimento dietro consiglio del re Tolomeo (allora adolescente). 6. Gaio Cesare è Caligola, che, condannato a morte Emilio Lepido, suo familiare, fu a sua volta ucciso da Cassio Cherea, tribuno dei pretoriani. 7. È una massima di Epicuro. 8. Filosofo stoico, discepolo di Panezio (I sec. a.C.). La frase che segue è sua. 9. Discepolo di Zenone, pervaso da una forte religiosità. 10. Fondatore della scuola stoica (335-263). 11. Sono i più noti discepoli di Epicuro. 12. La frase è di Ecatone. 13. Politico e oratore (II sec. a.C.), soprannominato il Saggio, fece parte del circolo culturale che faceva capo a Scipione l’Emiliano, di cui era intimo amico. 14. Forse si tratta di Marco Porcio Catone, il Censore (234-149 a.C.). 15. Di Democrito, esponente della scuola atomistica, possediamo solo frammenti e testimonianze. 16. Togate sono le commedie di argomento romano, così chiamate perché gli attori indossavano la toga,
mentre palliate erano quelle in cui gli attori indossavano il pallio greco. 17. Di Publilio Siro, autore di mimi (I sec. a.C.), ci è giunta una raccolta di sentenze morali. Il verso che segue è suo. 18. Il verso è di Lucilio il Giovane. 19. Filosofo della scuola megarese, discepolo di Diogene il Cinico. 20. Filosofo stoico maestro di Seneca. 21. Scolarca della Stoà dopo Cleante, nativo di Soli in Cilicia (281-208 a.C.), diede ordine e metodo alle dottrine stoiche. 22. Demetrio Poliorcete (336-283 a.C.) dopo la morte di Alessandro Magno e le lotte dei Diadochi fu proclamato re di Macedonia e poi sconfitto e imprigionato da Seleuco I, Nicatore. 23. Verso di autore incerto, attribuito da qualcuno a Publilio Siro. 24. Filosofo cinico di Tebe (365-285 a.C.), fu autore di poemi, lettere e tragedie. 25. Filosofo stoico (Tarso, I sec. a.C.), amico di Ottaviano. 26. Lucio Cornelio Silla (138-78 a.C.), capo del partito aristocratico, fu antagonista di Mario, esponente dei democratici. Salito al potere, governò con poteri dispotici. 27. Papirio Fabiano, filosofo e retore, fu uno dei maestri di Seneca (v. ep. 100). 28. Il genio tutelare era una divinità che accompagnava la vita di ogni singolo individuo e ne determinava il destino. 29. I Romani usavano esporre i cadaveri sulla porta di casa coi piedi rivolti verso l’esterno. 30. In una festa che si celebrava nel mese di dicembre era usanza scambiarsi dei doni, fra cui figurine di cera o di argilla. 31. Virgilio, Eneide IV 653: parole di Didone. 32. È una frase di Epicuro.
Libro secondo 13. So che il tuo animo è forte e coraggioso: prima ancora che io lo plasmassi coi miei insegnamenti salutari e utili contro le avversità della vita eri già abbastanza temprato di fronte alla sorte, e ancora di più lo sei ora, dopo averla affrontata di petto mettendo alla prova le tue forze. Anche se non si può mai essere pienamente sicuri di sé stessi finché non si siano incontrate numerose difficoltà provenienti da ogni parte e a volte anche piuttosto incalzanti. È così che si sperimenta il coraggio autentico, sordo all’arbitrio altrui: questa è per lui la prova del fuoco. Un atleta che non abbia mai riportato un’ammaccatura non può combattere con accanimento: quello invece che ha già visto sgorgare il proprio sangue, che ha sentito i suoi denti sbriciolarsi sotto il pugno dell’avversario, o che, sbattuto a terra da lui lo ha sentito premere su di sé con tutto quanto il suo corpo, che dopo ogni caduta si è rialzato ancora più determinato, ebbene, quell’atleta si avvia alla lotta con grandi speranze di vittoria. Dunque, per tenermi a questa similitudine, già altre e numerose volte sei stato messo alla prova dalla sorte, ma non ti sei mai arreso, anzi, sei saltato su e hai resistito con maggiore fermezza, perché il valore, quando è provocato, si accresce. Ora, però, se lo ritieni opportuno, accetta le armi che io ti offro perché tu possa difenderti meglio. Intanto, caro Lucilio, le cose che ci spaventano sono più di quelle che ci minacciano effettivamente, e spesso soffriamo più per i nostri timori che per i fatti reali. Te lo dico non col linguaggio degli stoici ma con un tono più sommesso: noi filosofi, infatti, diciamo che devono tenersi in poco conto e quasi disprezzare tutte quelle cose che ci strappano lacrime e lamenti. Ebbene, mettiamo da parte questi paroloni, anche se, dio mio, hanno una loro verità: ciò che io ti consiglio è di non angosciarti prima del tempo, perché i mali che temi come imminenti forse non arriveranno mai, e comunque è certo che non sono ancora arrivati. Ci sono cose che ci tormentano più di quanto dovrebbero, altre che ci affliggono prima del tempo, altre senza alcun motivo, sicché di fronte a esse o accresciamo il nostro dolore, o lo anticipiamo, o ce lo creiamo. Rimandiamo, per ora, il primo punto, perché la questione è controversa e la nostra discussione non è ancora finita, e probabilmente quei mali che io dirò trascurabili per te saranno gravissimi: so bene che c’è chi ride sotto i colpi di frusta e chi geme per un pugno. Ebbene, se questi mali abbiano forza per sé stessi o per la nostra debolezza lo vedremo dopo. Giurami intanto che se chi ti sta intorno cercherà di convincerti che sei infelice tu darai retta non a ciò che senti dire ma a quello che provi e che deciderai in base alla tua capacità di sopportazione, chiedendo a te stesso, che conosci le tue cose meglio di chiunque altro: «Perché costoro mi compiangono? Perché stanno in allarme? Perché hanno paura che io possa contagiarli anche solo standogli vicino, come se le disgrazie potessero passare da una persona all’altra? È veramente un male o è piuttosto qualcosa d’infamante?». Chiediti: «E se mi cruccio e mi affliggo senza alcun
motivo, scambiando per un male ciò che non lo è? In che modo, insomma, posso capire se ciò per cui mi tormento è reale o inconsistente?». Per stabilirlo tieni presente questo concetto: noi ci affliggiamo o per il presente o per il futuro o per entrambi. Sul presente è facile giudicare: se il tuo corpo è libero e sano, e nessuna offesa o contrarietà ti addolora, se ne parlerà domani, oggi non hai motivo di preoccuparti. «Ma domani», dici, «il male ci sarà». Prima di tutto guarda se ci sono indizi sicuri di un male vicino: il più delle volte, infatti, ci allarmiamo solo per dei sospetti, e ci facciamo gabbare da voci simili a quelle che sono capaci d’influenzare l’esito di una guerra, e che a maggior ragione condizionano la sorte dei singoli. Le cose stanno così, Lucilio mio: noi prestiamo subito orecchio a ciò che è opinabile, non ci chiediamo da dove vengano le nostre paure e invece di liberarcene ci lasciamo prendere dall’ansia e voltiamo le spalle, come quei soldati che abbandonano il campo per il polverone sollevato da un branco di pecore in fuga, o come quelle persone che si spaventano per delle voci senza fondamento e di cui non si conosce nemmeno l’autore. Io non so per quale motivo le paure infondate turbino di più: quelle fondate hanno dei limiti, dei confini ben precisi, mentre le altre, come tutto ciò che è incerto, sono in balia delle congetture e del capriccio di un animo impaurito. Perciò non v’è sensazione più dannosa e più irrefrenabile del panico; tutte le altre forme di paura, infatti, derivano da mancanza di ragionamento, il panico da mancanza di senno. Esaminiamo allora attentamente la questione. Che in futuro possa accaderci qualche male è verosimile, ma non certo. Quanti eventi inattesi si sono verificati! E quanti di quelli che ci aspettavamo non sono mai accaduti! E anche se a un certo punto dovessero accadere per quale motivo anticipare il dolore? Ne avrai già abbastanza quando il male arriverà: intanto augurati il meglio, e il tempo sarà un guadagno, per te. Possono infatti sopraggiungere molti fattori per cui un pericolo vicino o addirittura incombente si ferma e aspetta ancora un po’, oppure cessa del tutto, o piomba sulla testa di qualcun altro: in un incendio c’è sempre una via di fuga, a volte in pieno crollo alcuni vengono risucchiati e lentamente deposti incolumi sul terreno, la spada che stava per immergersi nel collo del condannato improvvisamente si ritrae, e c’è chi, colpito, sopravvive al boia. Anche la sfortuna è volubile: forse verrà, forse non verrà. Intanto non c’è, e tu aspettati sempre il meglio. Talvolta, anche se non vi sono segni manifesti che preannuncino una qualche disgrazia, l’animo si crea mali immaginari: o interpreta male una parola ambigua, o ingigantisce un’offesa ricevuta, pensando non a quanto l’aggressore sia arrabbiato con lui, ma a quanto gli sia lecito arrabbiarsi. Ma se si ha paura di tutto ciò che può accadere non c’è alcun limite alle sventure e non vale nemmeno la pena di vivere. Qui bisogna dar prova di saggezza: respingi in ogni caso la paura, anche se è fondata, con tutta la forza dell’animo, diversamente scaccia una debolezza con un’altra, attenuando la paura con la speranza. Fra tutti i timori la cosa più certa è che gli eventi temuti non accadono e quelli sperati deludono. Soppesa dunque speranza e paura e quando tutto ti apparirà incerto fa’ pendere la bilancia
in tuo favore, credendo quel che ti conviene. Anche se il timore avrà più argomenti a suo sostegno propendi tuttavia per la speranza e cessa di angosciarti, pensando che l’animo umano generalmente ondeggia, corre di qua e di là aggrappandosi ora a questo ora a quello anche quando al presente non v’è alcun male, né v’è certezza di mali futuri. L’uomo, infatti, non riesce a resistere una volta che si sia lasciato andare, e non è più capace di ricondurre i suoi timori alla realtà, non pensa, per esempio, «Chi ha detto questo è un bugiardo, o se l’è inventato o ha creduto a voci prive di consistenza». Ci lasciamo trasportare dal vento, ci spaventiamo per ciò ch’è incerto come se fosse certo, non abbiamo il senso della misura, in un istante trasformiamo il dubbio in paura. Mi vergogno […] di parlarti così e di rincuorarti con rimedi tanto banali. Lascia che gli altri dicano «Forse non accadrà», tu, invece, di’: «E quand’anche accadesse? Vedremo chi la spunta dei due: venisse pure la morte, forse ne trarrò un vantaggio, magari sarà proprio lei a dar valore alla mia vita». La cicuta ha reso grande Socrate. Togli a Catone 1 la spada che gli diede la libertà: gli toglierai una gran parte di gloria. Ma sto dandoti troppi consigli, mentre tu hai più bisogno di avvertimenti che di esortazioni. Non ti spingo a un comportamento diverso da quello che è insito nella tua natura: tu, infatti, sei nato proprio con questa stessa disposizione di cui io ti sto parlando, tanto più, dunque, accresci e arricchisci il bene ch’è in te. Ma è tempo che io concluda questa lettera, non senza imprimervi il suo sigillo, cioè consegnandole una bella massima di Epicuro per te. «Fra tutti gli altri mali lo stolto ha pure questo: comincia a vivere sempre».2 Rifletti sul significato di questa frase, mio ottimo Lucilio, e vedrai quanto sia vergognosa la leggerezza di quegli uomini che ogni giorno pongono nuove fondamenta alla loro vita, che concepiscono nuove speranze anche in punto di morte. Guardali uno per uno: vedrai persone anziane che fanno grandi progetti, si dànno ai lunghi viaggi, agli affari. Nulla è più turpe di un vecchio che voglia ricominciare a vivere. Non aggiungerei il nome dell’autore di questa massima se non fosse troppo poco conosciuta, visto che non rientra fra quelle più note di Epicuro, che io mi sono permesso di lodare e di adottare. Stammi bene. 14. Ammetto che l’amore per il nostro corpo è legato a una legge di natura, che ci delega anche alla sua tutela. Però non bisogna esserne schiavi. Con ciò non dico che si debba trascurarlo, voglio solo ricordare che chi è schiavo del proprio corpo, se ne preoccupa eccessivamente e fa tutto in funzione di lui sarà schiavo di molti. Comportiamoci dunque non come se dovessimo vivere per il corpo ma come se non potessimo vivere senza di lui: un amore eccessivo per il nostro ci tiene in agitazione, ci opprime con paure e preoccupazioni, ci espone alle offese; e poi chi ama troppo il proprio corpo non ama la virtù. Trattiamolo pure con la massima cura tenendoci però sempre pronti a gettarlo tra le fiamme quando lo richiedano la ragione, la dignità e la lealtà. Nondimeno, insieme ai pericoli, evitiamo anche i disagi, nei limiti delle nostre possibilità, e mettiamoci
al sicuro, tenendo sempre presente come poter scacciare i timori. I quali, a mio giudizio, sono di tre tipi e riguardano la povertà, la malattia e la violenza dei più forti. Fra questi malanni quello che ci spaventa di più è il terzo, perché la furia dei potenti arriva con grande strepito e tumulto, mentre gli altri mali che ho menzionato, la povertà e la malattia, sopraggiungono in silenzio e non ci fanno paura, perché non li vediamo e non li udiamo: quello che viene dagli altri, invece, si presenta in pompa magna, circondato da ferro, fuoco, catene e una turba di belve pronte a dilaniare le nostre viscere. Pensa al carcere, alle croci, ai cavalletti, all’uncino, al palo conficcato nel corpo sino a uscire dalla bocca, alle membra squarciate dai carri lanciati in direzioni opposte, alla tunica intrisa e intessuta di materiale infiammabile nonché a tutte le altre torture che l’umana ferocia ha concepito. Non c’è dunque da stupirsi se un male che ha una tale varietà di forme e un apparato così raccapricciante provoca tanto spavento, perché, come gli effetti che produce la vista del carnefice sono in rapporto con la quantità e la varietà degli strumenti di tortura messi in mostra (a volte cede solo al vederli chi sarebbe stato capace di resistere al dolore), così fra i mali che fiaccano e domano il nostro animo hanno maggior forza i più appariscenti. Ci sono mali altrettanto gravi, come la fame, la sete, le ulcere interne e la febbre che brucia le viscere, ma sono nascosti e privi di minacce evidenti: quelli, invece, sono come i grandi eserciti in assetto di guerra, e vincono con un vistoso spiegamento di forze. Cerchiamo dunque di tenerci lontani dalle offese dei potenti. A volte è il popolo che dobbiamo temere, a volte, se in una città vige la norma che la maggior parte delle decisioni passino per il Senato, sono i senatori influenti che dobbiamo temere; talvolta anche singoli individui, a cui il popolo stesso ha concesso il potere di decidere sul suo operato. È difficile farsi amici tutti costoro, ma basta non averli nemici. Perciò il saggio non provocherà mai le ire dei potenti, anzi, le eviterà, come si fa con le tempeste durante la navigazione. Per andare in Sicilia attraversi lo stretto, no? Ebbene, il pilota temerario sfida le minacce dell’Austro che sconvolge il mare siciliano e crea vortici pericolosi, non tiene la rotta a sinistra, ma punta là dove Cariddi,3 più vicina, agita le acque dei due mari. Il pilota più prudente, invece, chiede a chi è pratico dei luoghi quali siano le direzioni delle correnti, quali indicazioni diano le nubi, e tiene la rotta lontano dalla zona tristemente famosa per i suoi gorghi. Così fa il saggio: evita i potenti che possono nuocergli, senza però darglielo a vedere: parte della sicurezza, infatti, sta nel non cercarla manifestamente, perché fuggire una cosa o una persona significa condannarla. In che modo, dunque, possiamo metterci al sicuro dalla gente? Prima di tutto mostrando di non avere le stesse aspirazioni, poiché sarebbe come rivaleggiare con lei e ciò comporterebbe una lotta, poi cercando di non possedere cose di valore che possano procurare un grande guadagno a chi riesca a sottrarcele, portando, cioè, con noi il minimo indispensabile di ciò che può esserci rubato: nessuno, infatti, uccide o ferisce un suo simile per puro piacere, o almeno sono pochi quelli che lo fanno, la maggior
parte dei ladri agiscono più per interesse che per odio, chi non porta niente con sé lo lasciano passare; anche in una strada insidiata da malviventi chi è povero può camminare tranquillo. Ci sono poi tre pericoli da evitare con la massima cura, come vuole un antico precetto: l’odio, l’invidia, il disprezzo. Il modo può dircelo solo la saggezza: è difficile, infatti, tenere una giusta via di mezzo, perché la paura dell’invidia può attirarci il disprezzo, e se mostriamo di non voler sopraffare gli altri ci sarà sempre qualcuno che penserà di poterci sopraffare. A molti il poter essere temuti causò motivi di timore. Guardiamoci da tutto questo: l’essere disprezzati nuoce quanto l’essere troppo rispettosi. Non resta dunque che cercar rifugio nella filosofia, il cui studio incute un sacro rispetto non solo nelle persone oneste ma anche in quelle che non sono del tutto malvagie. L’eloquenza forense e qualunque altra attività o disciplina che abbiano presa sul popolo attirano comunque dei nemici: la filosofia, invece, tranquilla e tutta dedita al suo lavoro, non può essere disprezzata, anzi, viene onorata da tutte le professioni e persino dagli uomini peggiori. La malvagità non avrà mai tanta forza, mai vi sarà congiura così potente contro le virtù da infangare il nome sacro e venerabile della filosofia. Bisogna però dedicarsi a questa disciplina con animo moderato e tranquillo. «Ma come?», obietterai. «Ti sembra che Catone abbia indossato le vesti del filosofo moderato quando con le sue accese parole si oppose alla guerra civile? Quando intervenne nella lotta fra i capi scatenati delle opposte fazioni, e mentre gli uni inveivano contro Pompeo, gli altri contro Cesare, lui li attaccò tutti e due?». La cosa è discutibile, perché in quel tempo non era chiaro se un uomo saggio potesse occuparsi di politica. E che vuoi, tu, Marco Catone? Ormai non è più in gioco la libertà: già da un pezzo è andata in malora. Il problema è se il potere cadrà nelle mani di Cesare o di Pompeo: cos’hai a che fare tu con questa disputa? Quale partito mi rappresenti? Non c’è una via di mezzo, si tratta di scegliere un padrone, che t’importa chi vince? Può vincere il migliore, ma chi vincerà non può non essere il peggiore. Questa era la situazione nell’ultimo periodo dell’attività politica di Catone. Ma anche negli anni precedenti il saggio non aveva voce in quella rapina dello Stato. Cos’altro poteva fare Catone se non gridare forte e parlare invano, quando, sollevato di peso dal popolo e coperto di sputi, ora era trascinato via dal Foro, ora dal Senato veniva condotto al carcere? Ma vedremo in seguito se il saggio debba partecipare o no alla vita politica: per ora voglio richiamare la tua attenzione su quegli stoici che, esclusi dagli affari pubblici, si ritirarono a vivere in disparte per dare agli uomini delle leggi che li mettessero al riparo dalla violenza dei potenti. Il saggio non turba la morale pubblica, né converte il popolo col suo strano modo di vivere. «In conclusione: chi seguirà questo esempio sarà completamente al sicuro?». Non posso garantirtelo, così come non posso garantire la salute a un uomo temperante, anche se la temperanza è una buona premessa per il benessere fisico. Alcune navi naufragano addirittura in porto, pensa cosa può succedere in alto mare! Se non si è al sicuro neppure vivendo nell’ozio, quanto maggiore è il pericolo per
chi si dà da fare e si dedica a molte attività! Talvolta sono condannati a morte gli innocenti (e chi lo nega?), ma i colpevoli sono molti di più. Il fatto che un soldato sia stato trafitto attraverso l’armatura non significa che non sappia combattere. Infine per il saggio ciò che conta in ogni cosa che fa è l’intenzione, non il risultato: l’inizio dipende da noi, l’esito lo decide la sorte, e alla sorte io non riconosco il diritto di giudicarmi. «Ma ti apporterà qualche sofferenza, qualche contrarietà». Il rapinatore nel momento in cui uccide una persona non formula un giudizio di condanna. E ora porgi la mano per il dono del giorno. Te lo darò d’oro, e poiché ho parlato di oro, ascolta in che modo puoi usarlo e gioirne con maggior piacere. «Gode della ricchezza soprattutto chi non ne sente affatto il bisogno».4 «E chi è l’autore di questa massima?». Affinché tu sappia quanto sono generoso, mi sono proposto di fare sfoggio dei pensieri altrui. È un detto di Epicuro, o di Metrodoro, o di qualche altro filosofo di quella scuola. Ma che importa chi l’ha detto? È un dono fatto a tutti. Chi accumula ricchezze perché ne sente il bisogno vive col timore di perderle: ma non si può godere di un bene che genera ansia e preoccupazione. Il ricco cerca sempre nuovi espedienti per aumentarle, le sue ricchezze, e mentre pensa come incrementarle dimentica di farne uso. Riceve i resoconti, passa tutto il suo tempo nel Foro e a sfogliare il libro dei crediti: insomma, da padrone diventa amministratore. Stammi bene. 15. Gli antichi erano soliti scrivere all’inizio delle lettere «Se stai bene, ne sono contento, io sto bene»: un’abitudine conservatasi sino ai nostri giorni. Io a buon diritto ti dico: «Se ti dedichi alla filosofia, ne sono contento». Alla fin fine, infatti, stare bene è propriamente questo. Senza la filosofia l’anima è malata, e pure il corpo, anche se in gran forma, è sano al pari di quello di un forsennato o di un pazzo. Se vuoi star bene, dunque, cura prima la salute dell’anima, poi quella del corpo, che non ti costerà molto. È sciocco, infatti, mio caro Lucilio, e sconveniente per un intellettuale esercitare i muscoli, allargare le spalle e irrobustire i fianchi, anche perché, per quanto tu possa accrescere la tua corporatura e sviluppare i tuoi muscoli, non eguaglierai mai la forza e il peso di un bue ben pasciuto. Per non dire che quando il peso del corpo è eccessivo, l’anima ne è come schiacciata e risulta meno agile. Perciò limita la cura del corpo all’essenziale e lascia spazio all’anima. Chi dà troppo peso al corpo va incontro a molti inconvenienti: innanzitutto la fatica che comportano gli esercizi fisici estenua lo spirito, gli rende difficile concentrarsi e attendere a studi che richiedono un impegno maggiore, inoltre un cibo abbondante ottunde l’acutezza mentale. A ciò si aggiunga l’infima qualità degli schiavi assunti come insegnanti: uomini che pensano solo a cospargersi d’olio e a ubriacarsi, che considerano spesa al meglio una giornata in cui hanno fatto una bella sudata, per compensare la quale hanno ingurgitato in abbondanza bevande d’ogni genere, che in quegli stomaci digiuni saranno scesi più in profondità. Così passa la vita chi è ammalato di stomaco: sudando e bevendo.
Ci sono invece esercizi facili e brevi che spossano subito il corpo e fanno risparmiare tempo importante da dedicare ad altre occupazioni: la corsa, il sollevamento pesi, il salto in alto, il salto in lungo, o quello tipico dei Salii,5 o, detto più volgarmente, dei lavandai. Scegli fra questi quello che vuoi: sono esercizi semplici e alla portata di tutti. Ma qualunque cosa tu faccia per il corpo, da questo ritorna subito allo spirito ed esercitalo sempre, di notte e di giorno: l’animo si alimenta con poca fatica, né il freddo né il caldo e nemmeno la vecchiaia impediscono di tenerlo in esercizio. Prenditi cura di questo bene che col tempo migliora. Non ti dico di stare sempre chino sui libri, intento a leggere o a scrivere: anche l’animo ha bisogno di riposarsi, non più di tanto, però, in modo, cioè, che si rilassi ma senza infiacchirsi. Una passeggiata in lettiga, per esempio, stimola il corpo e al tempo stesso consente di studiare: puoi leggere, puoi dettare, puoi parlare, ascoltare, tutte cose che puoi fare anche camminando. Non trascurare poi il tono della voce: non seguire un ritmo, alzandola e abbassandola gradualmente e a intervalli regolari. Se poi tu volessi imparare a passeggiare in modo corretto, chiama uno a cui la fame ha insegnato mestieri insoliti: troverai chi modererà i tuoi passi, chi sorveglierà la tua bocca mentre mangi, e sarà tanto pignolo quanto tu indulgerai alla sua audacia con pazienza e credulità. Quali saranno i risultati? Ti metterai subito a parlare gridando e alzando al massimo il tono della voce? No, dev’essere un fatto naturale: la voce cresca a poco a poco, come fanno le parti in causa in tribunale, che iniziano a parlare piano e finiscono gridando; nessuno invoca subito la protezione dei Quiriti. Dopodichè, seguendo l’impulso dell’animo, fustiga i vizi, ora con veemenza, ora con calma, come ti suggerisce la voce, e quando questa avrà riacquistato il tono consueto falla scendere un poco, lentamente, non tutta d’un colpo: deve infatti fuoriuscire con un tono misurato, senza sbalzi, non infuriare come quella delle persone rozze e ignoranti. Non dobbiamo insomma educare la voce, dev’essere lei a educare. Ti ho tolto un fastidio non da poco, e a questo favore aggiungerò un piccolo regalo, anch’esso di origine greca. Ecco una massima straordinaria: «La vita degli sciocchi è spiacevole e piena di ansie, perché tutta protesa verso il futuro».6 Vuoi sapere chi lo ha detto? Lo stesso autore che ho citato nella lettera precedente: Epicuro. Ora, secondo te, quale vita si può definire da sciocchi? Quella di Baba e Issione?7 No, è quella che conduciamo noi, spinti come siamo da una cieca avidità verso beni che ci faranno male e di cui non saremo mai sazi; noi che, se ci accontentassimo, avremmo già quel che ci basta; noi che non pensiamo quanta gioia possa dare il non chiedere nulla, quanto sia meraviglioso sentirsi pienamente soddisfatti anche di quel poco che si ha, senza dover dipendere dalla sorte. Perciò, Lucilio mio, ricorda sempre quanti benefìci hai ricevuto, e non guardare solo davanti a te, contando quelli che ti precedono: guarda anche alle tue spalle, alla moltitudine che ti sta dietro. Che t’importa di tutti gli altri? Tu hai superato te stesso. Fissati una meta, da non oltrepassare neppure se te ne viene la voglia; lascia perdere una buona volta questi beni pieni
di insidie, che ci appaiono migliori più quando li desideriamo che non quando li abbiamo ottenuti. Se avessero una qualche sostanza alla fine ci appagherebbero, invece, più ne attingiamo, più ce ne cresce la sete. Lascia da parte le belle apparenze, e ciò che del tempo futuro volge l’incerto destino perché dovrei implorare che me lo dia la fortuna e non invece esigere da me di non richiederlo affatto? E perché chiedere, poi? Accumulare beni quando tutto è fragile in noi? Affaticarsi, in che cosa? Ecco: questo giorno è l’ultimo, e se non è l’ultimo, poco ci manca. Stammi bene. 16. Caro Lucilio, nessuno può vivere felice, e nemmeno in maniera tollerabile, se non coltiva la saggezza: ciò, ne sono certo, è evidente anche a te. Ma se una saggezza perfetta rende felice la vita, una saggezza imperfetta, o non ancora pienamente raggiunta, la rende quantomeno sopportabile. Non basta, però, aver chiaro questo concetto, bisogna confermarlo e scolpirlo nel profondo dell’animo giorno per giorno con un’assidua meditazione, perché mantenere i buoni propositi richiede maggiore fatica che concepirli: bisogna insistere e irrobustire tutte le nostre forze con un’applicazione costante, sino a che l’animo non diventi buono, come buona è la nostra intenzione. Non c’è dunque bisogno che tu faccia molti discorsi con me o lunghe assicurazioni. So che hai fatto notevoli progressi e conosco bene da dove provenga ciò che scrivi: tu non fingi e non ingigantisci le cose. Tuttavia ti dirò quel che penso: spero molto in te ma la mia fiducia non è ancora totale. Così voglio che faccia anche tu: non confidare in te troppo facilmente e subito. Fruga bene, scava in ogni angolo della tua coscienza, e per prima cosa cerca di capire se hai fatto più progressi nella filosofia che nella vita pratica. La filosofia non è un artificio, una geniale trovata per incantare la gente o per mettersi in mostra: è fatta di cose concrete, non di parole, né serve a far passare piacevolmente le giornate o a scacciare la nausea generata da un’esistenza oziosa e inconcludente. La filosofia plasma ed educa l’animo, insegna a distribuire opportunamente la vita, guida le nostre azioni, mostra ciò che si deve o non si deve fare, è come un timoniere che mantiene la giusta rotta in un mare agitato e pieno di rischi. Senza di lei nessuno può vivere tranquillo, privo di affanni e di timori. In ogni ora, in ogni momento ci si presentano una grande quantità di situazioni che richiedono un consiglio, e questo non può darcelo che la filosofia. «Ma se esiste il fato», obietterà qualcuno, «se c’è un dio che ci governa, o se è il caso a dettar legge, a che mi giova la filosofia? Ciò che è prestabilito non si può mutare, né è possibile difendersi contro gli eventi incerti. O le mie decisioni dipendono da un dio, che ha stabilito quel che devo fare, o la sorte m’impedisce di prendere qualsiasi iniziativa». Caro Lucilio, qualunque di queste forze esista, o esistessero anche tutte, bisogna comunque dedicarsi alla filosofia: vuoi che sia il destino a legarci con la sua legge inesorabile, vuoi che un dio, arbitro dell’universo, abbia disposto ogni cosa, vuoi che sia il caso a muovere e a determinare disordinatamente le vicende umane, la filosofia ha il compito di proteggerci, nel
senso che ci esorta a obbedire di buon grado a dio e fermamente alla sorte, a seguire il volere di dio e a sopportare il caso. Ma non è questo il momento di discutere sul potere dell’uomo, se sia la provvidenza a reggere le cose o se siamo legati al destino che determina l’alternarsi delle vicende umane, oppure se siamo soggetti a eventi impensati e imprevedibili: io torno a esortarti a far sì che l’impulso del tuo spirito non ceda o perda vigore. Controllalo e rafforzalo in modo che il tuo istinto che ti spinge al bene diventi un tuo comportamento abituale. Se ben ti conosco, non appena leggerai questa lettera andrai a vedere quale dono essa ti porta: scorrila attentamente e lo troverai, ma non credere ch’io sia stato generoso, perché anche questa volta ti regalo un pensiero non mio. Ho detto non mio ma in realtà quando si tratta di concetti buoni e onesti posso ben dire che siano miei. Eccoti dunque un’altra massima di Epicuro: «Se vivrai secondo natura non sarai mai povero, se darai retta alle opinioni non sarai mai ricco». La natura esige poco, le opinioni hanno un potere immenso. Si concentrino nelle tue mani le ricchezze di molti, la sorte ti conceda più denaro di quanto normalmente ne possieda un cittadino privato, ti ricopra d’oro, ti elargisca vesti di porpora e tanto lusso e magnificenza da poter ricoprire di marmo la terra sì che tu possa non solo avere ricchezze ma anche calpestarle; aggiungi statue, dipinti e quant’altro le varie arti hanno creato per soddisfare la lussuria: da questi beni imparerai solo a volerne sempre di più. I desideri naturali hanno limiti certi, quelli che provengono da una falsa opinione non ne hanno: il falso non ha confini, chi percorre una strada si dirige verso una meta, mentre l’andare errando di qua e di là non ha mai fine. Bando, dunque, alle vanità, e quando vuoi sapere se ciò a cui aspiri corrisponda a un desiderio cieco o naturale guarda se abbia un termine, perché se dopo aver camminato a lungo avrai sempre una meta da raggiungere vuol dire che il tuo non è un desiderio naturale. Stammi bene. 17. Se sei saggio, o, meglio, se aspiri alla saggezza, lascia le cose vane e senza perdere tempo volgiti a questa meta con tutte le tue forze, e se qualcosa te lo impedisce adoperati per venirne fuori, o tronca subito ogni legame. «Mi trattiene», dici, «la cura dei miei beni: vorrei disporli in modo che possano bastarmi anche se resto inattivo, perché non mi sia di peso la povertà o non debba io stesso gravare su qualcuno». A sentirti dire queste cose ho l’impressione che tu non conosca la forza e il potere di quel bene a cui aspiri: tu hai una visione generica della filosofia e della sua utilità, riesci ad abbracciarla nell’insieme, ma non sei ancora in grado di vederne i particolari con sufficiente acume, non sai ancora quanto e in quali casi ci sia di aiuto, come ci “soccorra” – per dirla con Cicerone8 – non solo nelle situazioni più importanti ma anche in quelle di pochissimo conto. Dammi retta, chiedile consiglio: ti convincerà a non startene lì seduto a contare le entrate e le uscite. È questo che cerchi e a furia di rinvii vuoi arrivare a non temere la povertà: ma se dovessi cercarla? Per molti la ricchezza è di ostacolo agli studi filosofici, mentre il povero ostacoli non ne ha,
non ha preoccupazioni. Quando ode risuonare la tromba di guerra non si sente in pericolo, quando viene dato l’allarme per un’alluvione cerca come salvarsi, non cosa salvare, se deve andare per mare non lo turba il clamore del porto o sulla spiaggia la folla rumorosa al seguito di una sola persona, non lo circonda una tale torma di servi che per nutrirli non basterebbero tutte le terre fecondate d’oltremare. È facile nutrire lo stomaco di poche persone moderate, il quale altro non chiede che di essere riempito: sfamare costa poco, saziare, invece, molto. Alla povertà è sufficiente soddisfare le necessità più urgenti: perché dunque rifiuti una compagna di cui persino i ricchi, quando hanno senno, seguono le abitudini? Se vuoi dedicarti allo spirito devi essere povero, o perlomeno vivere come se lo fossi. Lo studio non è salutare senza la moderazione, e questa è una povertà volontaria. Metti perciò da parte queste scuse, non dire: «Non possiedo ancora la somma necessaria per potermi dedicare interamente alla filosofia». Ma non bisogna procurarsi alcunché prima della filosofia, che tu invece continui a rimandare con l’intento di accostarti a lei solo dopo esserti procacciato tutto il resto. È proprio dalla filosofia che bisogna cominciare. «Ma io voglio procurarmi il necessario per vivere», dici. D’accordo, ma intanto impara anche a preparare te stesso: se c’è qualcosa che t’impedisce di vivere bene puoi sempre morire bene. Perché mai l’indigenza o la povertà dovrebbero allontanarci dalla filosofia? Chi vi aspira deve saper sopportare anche la fame: c’è chi l’ha sopportata durante un assedio, quando l’unico premio delle sue sofferenze era il non cadere nelle mani del vincitore. Quanto più grande, infatti, è il bene della libertà che ti viene promesso! Una libertà duratura, libera dal timore degli uomini e degli dèi: un bene che anche gli affamati devono arrivare a possedere. Certi eserciti hanno sofferto la mancanza di ogni cosa, si sono nutriti di radici e sfamati con cose che ripugnano solo a nominarle, e tutto questo l’hanno sopportato per un regno, che per giunta – ciò è ancora più straordinario – apparteneva ad altri. C’è qualcuno che esiti a patire la povertà pur di liberarsi dalla furia delle passioni? Che bisogno c’è di premunirsi di beni quando alla filosofia si può arrivare anche senza provviste per il viaggio? È così? Vuoi la ricchezza e in più essere anche saggio? La saggezza per te non è che un’aggiunta, un ornamento, e perdipiù l’ultimo, della vita? Se già possiedi qualcosa, dedicati alla filosofia (come potresti sapere, altrimenti, se quel che possiedi ti basta?), se invece sei povero, cercala prima di qualunque altra cosa. «Ma mi mancherà il necessario». Prima di tutto non ti mancherà, visto che la natura ha esigenze assai modeste, e il saggio si adegua alla natura. E poi se gli accadrà di trovarsi in condizioni decisamente critiche abbandonerà la vita, cessando così di esser di peso a sé stesso. Se invece i suoi mezzi di sostentamento saranno scarsi o limitati se li farà bastare, senza preoccuparsi o angustiarsi più del necessario, dando al suo stomaco e al suo corpo quanto occorre, e, sereno e felice, se la riderà dei ricchi e di quegli uomini che si affannano correndo dietro alla ricchezza, dicendo a sé stesso: «Perché vai tanto per le lunghe? Forse aspetti gl’interessi dell’usura, gli utili del commercio o il testamento di un vecchio riccone quando puoi
diventar ricco subito? La saggezza ti fa ricco subito, e quella ricchezza ti basta e ti avanza». Ma ciò non ti riguarda, poiché tu sei più vicino ai ricchi. Cambiassi epoca, avresti sempre troppo, mentre quanto basta è uguale in ogni tempo. Chiuderei qui la mia lettera se non ti avessi abituato male. Come non c’è persona che si accomiati dai re dei Parti senza donare loro alcunché, così io non posso salutarti senza pagare. E come? Chiederò un prestito a Epicuro. «Per molti la ricchezza ha rappresentato non la fine delle loro miserie, ma solo un cambiamento». Non me ne meraviglio: il male sta non nelle cose ma nell’anima, se è vero che ciò che ha reso insopportabile la povertà finisce col rendere intollerabile anche la ricchezza. Che tu adagi un ammalato su un letto d’oro o di legno non ha importanza: dovunque tu lo metta o lo conduca, egli porterà con sé la sua malattia, sicché non fa differenza se un animo infermo è povero o ricco: il suo male lo segue comunque. Stammi bene. 18. È il mese di dicembre: la città è in fermento come non mai. È stato dato ufficialmente il via alla sfrenatezza e tutto risuona di grandi preparativi, come se ci fosse differenza tra i Saturnali9 e i giorni di lavoro; invece non ce n’è alcuna, visto che una volta – come ha detto qualcuno, e con ragione – dicembre durava un mese, mentre ora dura tutto l’anno. Se tu fossi qui, discuterei volentieri con te, ascoltando il tuo parere, sulla condotta da seguire in circostanze come questa, se cioè non ci si debba discostare minimamente dalle nostre abitudini di ogni giorno o se invece, per non sembrare in contrasto con le usanze popolari, dobbiamo banchettare più allegramente e toglierci la toga. Infatti, mentre una volta ciò accadeva solo in caso di sommossa e quando la città era in grave pericolo, ora cambiamo vestito per divertirci e per festeggiare. Poiché ti conosco bene, tu, assumendo la parte del giudice conciliatore, non accetteresti che noi ci adeguassimo in tutto e per tutto alla folla imberrettata,10 ma neppure vorresti che ci comportassimo in modo completamente diverso; a meno che tu non pensi che tanto più in questi giorni, in cui tutti si abbandonano ai piaceri, soltanto noi ce ne dobbiamo astenere, in quanto mai come in questa occasione l’animo può offrire a sé stesso la prova più sicura della sua fermezza se non cede agli allettamenti licenziosi né vi si lascia trascinare. Essere sobri e temperanti mentre il popolo si ubriaca fino a vomitare è molto più virtuoso e meritorio, ma è segno di maggiore moderazione non isolarsi dagli altri, non cercare di distinguersi dalla massa ma nemmeno mescolarvisi, insomma, fare le stesse cose, ma non nello stesso modo: si può infatti celebrare un giorno di festa senza scalmanarsi tanto. D’altra parte sono così desideroso di mettere alla prova la fermezza del tuo animo che, facendo mio l’insegnamento dei grandi maestri, mi permetto di darti questo consiglio: per qualche giorno accontentati di un cibo scarso e scadente, indossa un vestito ruvido e rozzo, sì che alla fine tu possa dire a te stesso: «È questo ciò che temevo tanto?». Bisogna che l’animo anche nei momenti di tranquillità si prepari ad affrontare tempi difficili e nella prosperità si rafforzi contro i colpi della sorte. Il soldato in tempo di pace si esercita alla guerra, costruisce trincee
senza che vi siano nemici e si sottopone a fatiche inutili in quella circostanza ma che lo mettono in grado di sostenere quelle a cui sarà costretto domani; se non vuoi che uno tremi al momento della prova concreta, fallo esercitare prima. È il metodo seguìto da coloro che ogni mese hanno vissuto qualche giorno in povertà, fino a giungere quasi alla miseria, per non dover temere ciò che più volte avevano già sperimentato. Adesso non credere ch’io voglia tirare in ballo le cene di Timone, 11 le stanzette dei poveri e tutte quelle altre cose con cui i dissoluti giocano quando si annoiano delle loro ricchezze: dormi su un pagliericcio autentico, genuino, indossa un saio e mangia pane secco e nero, per tre o quattro giorni, a volte anche di più, affinché sia una prova, non un gioco. Allora, credimi, Lucilio mio, esulterai per esserti saziato con una moneta da due assi, e ti renderai conto che per vivere tranquilli non occorre il benestare della sorte, perché, anche se ci è contraria, non potrà mai negarci quanto basta alle elementari necessità della vita. In quel caso, però, non ti sembri di fare cosa insolita ed eccezionale, non inorgoglirti, perché quel che farai tu lo fanno abitualmente molte migliaia di schiavi e molte migliaia di poveri: vantatene solo perché lo farai di tua spontanea volontà, perché per te non ci sarà più differenza fra il sopportare la povertà per sempre e lo sperimentarla ogni tanto. Esercitiamoci al palo,12 e affinché la sorte non ci sorprenda impreparati, familiarizziamo con la povertà; vivremo più tranquilli nella ricchezza, se sapremo che non è gravoso essere poveri. Epicuro, quel gran maestro del piacere, si era riservato dei giorni in cui mangiare il minimo indispensabile per vedere se in tal modo venisse a mancare qualcosa e quanto al piacere pieno e perfetto, e se quella mancanza meritasse di essere colmata a prezzo di una grave fatica. Questo dice egli stesso nelle lettere che scrisse a Polieno sotto l’arcontato di Carino, vantandosi di sapersi sfamare con meno di un asse, mentre Metrodoro, ch’era meno progredito di lui, aveva bisogno di un asse intero. Non credi che un tale nutrimento possa dare la sazietà? Anche il piacere vi si può trovare, non quel piacere superficiale e fuggevole che ha bisogno di essere stimolato continuamente, ma un piacere durevole e sicuro. L’acqua, la polenta o un pezzo di pane d’orzo non sono gradevoli, di per sé, ma dà un immenso piacere il poter trarre piacere anche da questi cibi e l’essere giunti al punto che nessuna avversità della sorte può toglierci alcunché. Nelle prigioni il vitto è più abbondante: ai condannati a morte il carnefice non dà un cibo così scarso. Quale grandezza d’animo, dunque, dimostrano coloro che si sottopongono volontariamente a un regime di vita che non devono temere neppure i condannati a morte! Questo significa prevenire i colpi della sorte. Comincia, dunque, Lucilio mio, a seguire le abitudini di costoro, e fissati dei giorni in cui stare lontano dai tuoi agi e familiarizzare col poco; comincia ad avere rapporti con la povertà: ospite, orsù, disprezza le ricchezze, e renditi anche tu degno di dio.13
Nessun altro è degno di dio quanto colui che disprezza le ricchezze. Io non ti vieto di possederle, voglio che tu le possieda senza dover temere di perderle, e ciò potrai ottenerlo in un solo modo, convincendoti di poter vivere felice anche senza di esse, se le guarderai sempre come cose destinate a scomparire. Ma è tempo ormai di chiudere la lettera. «Prima paga il tuo debito, però!». Lo farà Epicuro, con questa massima: «L’ira sfrenata genera pazzia». Quanto ciò sia vero lo sai benissimo, perché hai avuto schiavi e nemici. L’ira è una passione che può scattare contro chiunque: nasce tanto dall’odio quanto dall’amore, non solo in circostanze serie ma anche mentre si gioca o si scherza, e quel che importa, più che la causa, è l’animo in cui essa insorge. Così è del fuoco, di cui ciò che conta è il materiale su cui si sviluppa, non la violenza, visto che i corpi solidi non lo alimentano neppure se è violentissimo, mentre quelli secchi e infiammabili sono capaci di trasformare anche una scintilla in un incendio. Tale, caro Lucilio, è il risultato di una grande ira, cioè la pazzia, e perciò bisogna evitare di adirarsi, per non rompere l’equilibrio, e soprattutto per mantenersi sani. Stammi bene. 19. Ogni volta che ricevo le tue lettere faccio salti di gioia, perché mi riempiono di buone speranze e ormai mi portano non promesse ma solide garanzie sulla tua evoluzione spirituale. Continua così, ti prego e ti scongiuro: che cosa infatti posso chiedere di meglio a un amico se non ciò che gli chiedo per il suo bene stesso? Se puoi, sottraiti a codeste occupazioni, altrimenti staccatene a viva forza. Abbiamo già sprecato troppo tempo: ora che siamo vecchi cominciamo a raccogliere i nostri bagagli. Non vergogniamocene: siamo vissuti in mezzo ai marosi, moriamo almeno in porto. Con ciò non ti consiglio di cercare la fama sottraendoti alla vista di tutti: la tua vita non devi sbandierarla ai quattro venti ma nemmeno nasconderla. Pur condannando la follia degli uomini, io non potrei mai volere che tu viva nell’oscurità dimenticato da tutti: fa’ in modo, insomma, che il tuo ritiro non risalti troppo, ma sia comunque palese. Lascia la scelta, di una vita oscura o manifesta, a coloro che sono agli inizi e possono prendere le loro prime decisioni in piena libertà: tu non sei libero di scegliere, poiché il vigore del tuo ingegno, l’eleganza dei tuoi scritti, le tue amicizie con uomini nobili e illustri ti hanno posto al centro dell’attenzione; ormai sei famoso, e anche se ti apparti e ti nascondi completamente agli occhi di tutti, il tuo passato di per sé stesso parlerà. Non puoi restare nell’ombra, dovunque tu fugga, gran parte dell’antica luce ti seguirà: puoi, però, pretendere la tranquillità senza inimicarti nessuno, senza rimpianti o rimorsi. Cosa lascerai, infatti, che tu possa pensare di aver lasciato a malincuore? I clienti? Essi non cercano te ma solo ciò che a loro può venire da te: una volta si cercava l’amicizia, oggi si cercano i vantaggi che se ne possono ricavare; i vecchi che si vedono abbandonati da chi un tempo si curava di loro cambiano il testamento, il cliente va a bussare ad altre porte. Ciò che vale molto non può costare poco:
vedi dunque se preferisci rinunciare a te stesso o a qualcuno dei tuoi privilegi. Ti fosse toccato di invecchiare nel medesimo stato in cui nascesti e la fortuna non ti avesse condotto così in alto! La tua rapida carriera, il governo della provincia, la carica di procuratore e tutti i vantaggi che ne derivano ti hanno allontanato dalla visione di una vita sana; d’ora in poi ti toccheranno cariche sempre più importanti, una dietro l’altra: quale sarà il risultato? Che aspetti, di non aver più nulla da desiderare? Quel momento non arriverà mai. Come c’è una serie di cause dalla cui concatenazione scaturisce il fato così è per i desideri: sono tutti legati fra loro, finito uno ne nasce un altro. Hai intrapreso un tipo di vita che di per sé non porrà mai termine alle tue miserie e alla tua schiavitù: ritrai dal giogo il collo ormai piagato, è meglio un taglio netto che un’oppressione continua. Se ti ritirerai a vita privata avrai un minor numero di vantaggi e di privilegi, ma sarai soddisfatto, mentre ora, pur avendone in gran quantità e provenienti da ogni parte, non te ne sazi. Preferisci la sazietà nell’indigenza o la fame nell’abbondanza? Il ricco è avido ed esposto all’avidità altrui: finché avrai sempre bisogno di qualcosa non riuscirai mai a soddisfare gli altri. «E come ne uscirò?», mi chiederai. In qualunque modo. Pensa alle ansie e ai timori che ti ha procurato il denaro, a quanto hai dovuto faticare per ottenere incarichi e privilegi! Ebbene, bisogna osare anche per conquistarsi il riposo, se non si vuole invecchiare in codeste ansie dell’amministrazione casalinga e poi delle cariche pubbliche, fra mille agitazioni e sempre in mezzo a nuovi marosi, a cui non si può sfuggire né con la moderazione né con una vita tranquilla. Che senso ha, infatti, il tuo voler vivere tranquillo quando non lo vuole la tua sorte? E che accadrà se tu continuerai a darle spago? Quanto più aumentano i successi, tanto più crescono le preoccupazioni. A questo proposito voglio citarti una frase di Mecenate:14 «Le grandi altezze attirano i fulmini». È una verità che ha detto mentre stava sul cavalletto. E vuoi sapere dove sta scritta? Nel libro che s’intitola Prometeo. Significa che chi sta in alto è maggiormente esposto ai colpi della sorte. O forse pensi che un uomo potente come Mecenate potesse dire una frase degna di un ubriaco? Egli era dotato di molto ingegno, e avrebbe offerto un grande esempio di eloquenza romana se non lo avesse infiacchito, anzi, castrato, la prosperità. Questa è la fine che ti attende, se non cominci ad ammainare le vele e a dirigerti verso la terraferma: una decisione che Mecenate prese troppo tardi. Con questa massima potrei saldare il mio debito verso di te, ma poiché so per esperienza che protesterai e vorrai ricevere il dovuto in moneta fresca e di buon conio, stando così le cose, occorre ch’io chieda in prestito a Epicuro quella frase in cui dice: «Prima di sapere cosa si mangia e si beve bisogna guardare con chi, perché pranzare senza un amico è come dividere la carne con un leone o un lupo», cosa che non ti accadrà se non ti ritirerai a vita privata; diversamente i tuoi commensali saranno quelli che fornisce lo schiavo addetto alla scelta dei nomi15 fra la massa dei clienti: sbaglia chi cerca gli amici nella sala d’attesa della sua casa o li sperimenta a tavola. Il male peggiore per chi è tutto dedito
agli affari e all’amministrazione dei suoi beni sta nel ritenere amici persone delle quali non è amico e pensare che i suoi favori possano accattivargli gli animi, mentre gli uomini generalmente più sono debitori verso qualcuno più lo odiano: un prestito piccolo crea un debitore, uno grande un nemico. «Ma come? I benefìci non procurano amicizie?». Sì, se si possono scegliere le persone destinate a riceverli, se sono elargiti con accortezza, non distribuiti a caso. Perciò, chi comincia a ragionare con la propria testa segua questo consiglio dei saggi: «Giudica il beneficato più importante del beneficio». Stammi bene. 20. Se stai bene e ti ritieni degno di essere un giorno tutto tuo16 ne sono contento, anche perché potrò gloriarmi se riuscirò a tirarti fuori da questa situazione in cui ondeggi senza speranza di uscirne. Ma, Lucilio mio, ti prego caldamente di far discendere sin nel profondo dell’animo i princìpi basilari della filosofia e giudica i tuoi progressi non dai discorsi o dagli scritti ma dalla tua fermezza d’animo e dalla diminuzione delle passioni: dimostra coi fatti il valore delle tue parole. Tale non è l’obiettivo degli oratori e di coloro che mirano al consenso dell’uditorio, e neppure di quelli che intrattengono le orecchie dei giovani e dei perdigiorno con dissertazioni spigliate sui più vari argomenti: la filosofia insegna ad agire, non a parlare, e pretende che ciascuno viva secondo la sua legge, affinché la vita non sia in contrasto con le parole o addirittura con sé stessa, e tutte le nostre azioni si uniformino a un principio unico. Questo è il primo compito e l’indizio stesso della saggezza, che le azioni, appunto, siano coerenti con le parole, sì che uno sia sempre uguale e identico a sé medesimo. Mi chiedi chi potrà riuscire in questa impresa. Pochi, ma ce ne sono. È difficile, lo so, e io non dico che il saggio camminerà sempre con lo stesso passo, ma è certo che procederà sempre sulla medesima strada. Osservati bene, dunque, guarda se i tuoi abiti siano in contrasto con la tua casa, se tu sia generoso con te e avaro coi tuoi, se consumi pasti frugali, se ti fai costruire dimore lussuose. Datti insomma una regola di vita e conforma a essa tutta la tua esistenza. C’è chi fa il moderato in casa, e fuori, invece, si abbandona a una vita sregolata: questa incoerenza è un difetto e indice di un animo volubile che non ha ancora trovato la sua strada. Ti dirò anche da dove provengano questa incostanza e questa incoerenza fra pensieri e azioni. L’uomo non ha quasi mai un’idea chiara di cosa voglia esattamente, e se si pone il problema non lo sviscera sino in fondo, ma lo accantona e passa ad altro; e dopo aver preso una nuova strada torna indietro, rivolgendosi nuovamente a ciò che aveva abbandonato e rinnegato. Perciò, lasciando da parte le vecchie definizioni di saggezza e abbracciando tutta la vita umana nelle sue diverse espressioni, mi accontento di questa: che cos’è la saggezza? Volere o non volere sempre la medesima cosa. E non occorre aggiungere «a condizione che ciò che si vuole sia bene», poiché nessuno può gradire sempre la stessa cosa se non la trova buona. Gli uomini non sanno che cosa vogliono se non nel momento in cui lo vogliono; non c’è persona che abbia chiaro in modo stabile e definitivo ciò che vuole e ciò che non vuole, perché tutti
ogni giorno cambiano parere, passando magari a uno contrario, e i più prendono la vita come un gioco. Sforzati, dunque, di portare a termine ciò che hai cominciato e forse giungerai alla vetta, o a un punto dove tu solo potrai capire di non essere ancora in cima. «Che farà», ti domandi, «questa schiera di domestici quando il mio patrimonio si sarà esaurito?». Si manterrà da sola, visto che non potrà più contare su di te; e tu conoscerai dalla povertà ciò che ora i tuoi privilegi t’impediscono di conoscere, cioè quali siano gli amici veri e sicuri: questi non ti abbandoneranno, mentre chi stava dietro non a te ma ad altro se ne andrà. Perché, dunque, non amare la povertà, quando è proprio lei che ci dimostra chi ci ama davvero? Ben venga il giorno in cui le manifestazioni di stima e di rispetto non celeranno nel fondo la menzogna! A questo tendano i tuoi pensieri, questo solo cerca e desidera: essere pago di te stesso e dei beni che provengono da te, rimettendo a dio ogni altro desiderio. Quale felicità è più a portata di mano? Risolviti a vivere modestamente, a un livello da cui tu non possa mai precipitare. A questo proposito, affinché tu sia più sollecito e meglio disposto a farlo, ti darò il mio solito tributo epistolare con un argomento ad hoc. E pure questa volta, anche se non sei d’accordo, sarà Epicuro a pagare al posto mio, e lo farà volentieri. «Se dormirai in un letto modesto e vestirai umili panni, le tue parole, credimi, sembreranno ancora più nobili, e i fatti le confermeranno». Ti confesso che, dopo aver visto il nostro Demetrio17 disteso su meno ancora che un pagliericcio con un semplice indumento, ho cominciato ad ascoltare con spirito diverso le sue parole: egli non è solo un maestro, è un testimone di verità. «Dunque», obietterai, «non si può disprezzare la ricchezza, pur possedendola?». E perché no? Anzi, ha un animo sommamente nobile chi ride delle ricchezze che lo circondano, stupito egli stesso di possederle: così gli dicono gli altri, ma lui, dentro di sé, non le sente sue. È già una grande conquista non lasciarsi corrompere dal contatto e dalla familiarità con la ricchezza: grande è colui che ci convive come se fosse povero. Tu dirai: «Non so come costui sopporterebbe la povertà, se dovesse incapparvi». E io, da parte mia, caro Epicuro, non so se questo povero disprezzerebbe la ricchezza qualora gli piovesse addosso. Dunque, in un caso e nell’altro, bisogna valutare la disposizione d’animo di entrambi, vedere, cioè, se il ricco si adatterebbe alla povertà e se il povero non si compiacerebbe della ricchezza. Il letto modesto e gli umili panni non bastano a dimostrare la buona disposizione d’animo per la povertà, a meno che non sia evidente che si tratta di una libera scelta, non di una necessità. D’altra parte è segno di un animo grande non l’andare spediti verso la povertà, come se fosse una condizione migliore della ricchezza, ma l’esservi preparati, come a uno stato facile a tollerarsi. Ed è davvero facile, Lucilio, e persino piacevole, se vi si arriva dopo lunga e matura riflessione, poiché in essa è possibile trovare quella serenità che si accompagna appunto al piacere e alla gioia. A tale scopo ritengo necessario ciò che i grandi uomini – come ti ho già scritto – hanno fatto spesso: intercalare fra gli altri alcuni giorni in cui vivere in
uno stato di povertà immaginaria sì da prepararsi a quella vera; un espediente tanto più necessario in quanto viviamo immersi nei piaceri e tutto ci sembra duro e difficile. Bisogna scuotere il nostro animo dal sonno, stimolarlo e ricordargli che la natura ci ha dato la possibilità di vivere col minimo delle sue risorse. L’uomo non nasce ricco: ai neonati sono sufficienti un panno e un po’ di latte. Ciononostante, con un simile inizio, tutti i regni di questo mondo non bastano alla nostra ingordigia. Stammi bene. 21. Mi scrivi di avere dei problemi con certe persone. Ebbene, quelli più gravi li hai con te stesso: il primo che non sopporti sei proprio tu. Non sai che cosa vuoi, apprezzi la virtù ma non la segui, vedi dov’è riposta la felicità, ma non osi raggiungerla. Ti dirò io qual è il tuo problema, visto che tu non riesci a capirlo. Dài troppa importanza a ciò che stai per lasciare, e ogni volta che ti figuri la tranquillità che ti aspetta, lo splendore di questa vita da cui stai per allontanarti ti frena, quasi che da qui dovessi precipitare in un’esistenza sordida e oscura. Sbagli, caro Lucilio: da questa vita a quella si sale; fra le due c’è la stessa differenza che passa fra lo splendore e la luce, perché la luce ha un’origine propria e sicura, mentre lo splendore brilla di luce riflessa. Questa vita è illuminata da una luce che viene dall’esterno: basta che uno s’interponga che automaticamente vi getta sopra una densa ombra; l’altra vita, invece, splende di luce propria. I tuoi studi ti renderanno illustre e famoso. Ti porterò l’esempio di Epicuro, il quale, in una lettera a Idomeneo,18 che allora era funzionario di un potente re e trattava affari importanti, per distoglierlo da una vita apparentemente bella, ma vuota e passeggera, verso una gloria stabile e sicura, scriveva: «Se cerchi la gloria, pensa che ti renderanno più famoso le mie lettere che non tutte queste faccende di cui ti occupi e per le quali sei onorato da tutti». Credi che non abbia detto la verità? Chi conoscerebbe Idomeneo se Epicuro non ne avesse inciso il nome nelle sue lettere? Tutti quei magnati e quei satrapi nonché il re stesso da cui derivavano gli onori attribuiti a Idomeneo sono caduti nell’oblio. Le lettere di Cicerone hanno reso immortale il nome di Attico. 19 Senza di esse a nulla gli sarebbe servito l’avere come genero Agrippa, 20 Tiberio 21 come marito della nipote e Druso Cesare22 come pronipote: fra personaggi tanto illustri non si parlerebbe di lui se Cicerone non lo avesse legato a sé. Anche su di noi si addenserà la sconfinata profondità del tempo: pochi ingegni ne emergeranno a capo scoperto, resistendo all’oblio e sfuggendogli a lungo, ma prima o poi pure loro cadranno nel generale silenzio. Ebbene, ciò che Epicuro poté promettere al suo amico, io lo prometto a te, caro Lucilio: poiché godrò del favore dei posteri posso portare con me nomi che dureranno a lungo. Il nostro Virgilio promise a due giovani di eternare la loro memoria e ha mantenuto la promessa: Oh, fortunati entrambi! Se i miei versi hanno qualche potere, mai nessun giorno al ricordo vi sottrarrà dei posteri, fin che la stirpe di Enea starà sul Campidoglio,
fin che il padre romano conserverà l’impero.23 Tutti coloro che la sorte mette in luce per essere parte o strumento della potenza altrui godono di grande favore e la loro casa è sede di molte e lunghe frequentazioni. Ma con la loro morte ne scompare anche il ricordo, mentre i grandi ingegni sono sempre più stimati e onorati, e insieme a essi si conserva anche tutto ciò che è legato alla loro memoria. Ma ora, visto che l’ho nominato, Idomeneo stesso pagherà di tasca sua il mio debito epistolare, con questa nobile frase che gli scrisse Epicuro, esortandolo a far ricco Pitocle24 con mezzi non volgari o poco sicuri: «Se vuoi far ricco Pitocle non devi accrescere il suo denaro, devi diminuire i suoi desideri». La frase è troppo chiara per aver bisogno di una spiegazione e troppo eloquente per dover essere avvalorata. Io ti prego solo di non credere che valga unicamente per la ricchezza, perché si adatta benissimo a qualunque tema o argomento, sicché puoi anche dire: se vuoi rendere onesto Pitocle non devi aumentare le sue cariche, devi diminuire i suoi desideri; se vuoi che Pitocle sia sempre felice non devi accrescere i suoi piaceri, devi ridurre i suoi desideri; se vuoi che Pitocle diventi vecchio e muoia nella pienezza della sua vita non devi aggiungergli anni, devi diminuire i suoi desideri. Non c’è bisogno di sapere che tali massime sono di Epicuro, perché appartengono a tutti. Io credo che si debba fare anche in filosofia ciò che di solito si fa in Senato, cioè chiedere a chi esprime un parere che si condivide solo in parte di distribuirne i contenuti, sì da poter dare il proprio assenso a quelle parti che si approvano. Vado citando queste belle massime di Epicuro tanto più volentieri per dimostrare a coloro che ricorrono a lui indotti da una falsa speranza di trovare una copertura ai propri vizi che, dovunque essi vadano, devono vivere onestamente. Se ti capiterà di andare nei suoi giardini – dove c’è la scritta OSPITE, QUI STARAI BENE, QUI IL PIACERE È IL SOMMO BENE – ti si farà incontro il custode della casa, uomo ospitale e affabile, che ti offrirà della polenta e acqua in abbondanza, e poi ti chiederà: «Non sei stato accolto bene? Questi giardini non stimolano la fame, la saziano, e non accrescono la sete con le bevande, ma la placano con un rimedio naturale e gratuito. Io sono diventato vecchio in mezzo a questi piaceri». Ti parlo di desideri che non si appagano con parole di conforto, ma a cui bisogna dare qualcosa di concreto affinché si plachino. Per quelli non comuni, che è possibile rinviare, contenere e reprimere, tieni presente solo questo: si riferiscono a piaceri naturali, ma non necessari, ai quali non sei debitore di nulla, se paghi qualcosa, lo fai volontariamente. Lo stomaco non ascolta consigli o insegnamenti, chiede, reclama. Ma non è un creditore molesto: si accontenta di poco, se soltanto gli dài quanto gli devi, non quanto puoi. Stammi bene.
1. È Marco Porcio Catone, l’Uticense (pronipote di Catone il Censore), che per amore della libertà non volle arrendersi a Cesare e si suicidò. 2. La frase è di Epicuro. 3. È il mitico mostro marino, di cui parla Omero nell’Odissea (XII 101 sgg.), che si narra vivesse, invisibile sotto uno scoglio di fronte a Scilla, nello stretto di Messina. 4. Epicuro, Lettera a Meneceo. 5. I Salii erano i dodici sacerdoti preposti alla custodia degli scudi sacri a Marte e alle cerimonie di guerra. 6. La frase è di Epicuro. 7. Sono personaggi proverbiali, sinonimi di persone sciocche. 8. Cicerone, Ortensio. 9. Festa in onore del dio Saturno (17-23 dicembre), durante la quale veniva concesso agli schiavi di trattare i padroni come loro pari e si allestivano grandi banchetti a cui partecipavano persone di diversa condizione sociale. 10. Il berretto era il pilleum, di forma semiovale o conica, indossato nei banchetti e nelle feste, e che gli schiavi portavano quando erano messi in vendita o affrancati. 11. Cittadino ateniese, noto per la sua misantropia. 12. Così i soldati romani si esercitavano nella scherma. 13. Virgilio, Eneide VII 364-5. Sono le parole con cui Evandro invita Enea a entrare nella sua reggia. 14. Mecenate, amico e consigliere di Augusto, fu l’ideatore di un cenacolo di artisti e di intellettuali che prese il nome da lui. 15. Il nomenclator era lo schiavo incaricato di ricordare al padrone non solo il nome degli ospiti ma anche di quelli incontrati lungo la strada. 16. Quel tuo con l’aggiunta di tutto ricorda l’espressione di Leonardo: «Se sarai solo, tu sarai tutto tuo». 17. Filosofo cinico amico di Seneca, condannato al confino da Nerone perché ostile alla monarchia imperiale. 18. Era un seguace di Epicuro, nativo di Lampsaco. 19. Attico era un uomo d’affari amico di Cicerone con cui ebbe una ricca corrispondenza. 20. Ammiraglio e collaboratore di Augusto, realizzò anche, quando rivestiva la carica di edile, numerose opere pubbliche. 21. Si tratta dell’imperatore. 22. Figlio di Germanico e di Agrippina, fu accusato di cospirare contro Tiberio e morì in prigionia. 23. Virgilio, Eneide IX 446-49: i due sono Eurialo e Niso. 24. Amico e discepolo di Epicuro.
Libro terzo 22. Hai capito ormai che devi liberarti da questo tipo di occupazioni, allettanti, sì, ma dannose, e però mi chiedi in che modo. Certi consigli si possono dare solo di persona: il medico non può prescrivere per lettera l’ora del pranzo o del bagno, deve tastare il polso. Un vecchio proverbio dice che il gladiatore decide nell’arena come deve comportarsi: alcune indicazioni gliele forniscono l’espressione del volto dell’avversario, il movimento delle sue mani, il modo in cui piega il corpo, gesti su cui egli va concentrando la sua attenzione. Per quel che riguarda cose che si fanno di solito o che conviene fare in generale si può scriverlo o comunicarlo per mezzo di qualcuno: suggerimenti di tal genere sono destinati agli assenti, magari anche ai posteri, ma sul tempo e le modalità delle azioni nessuno può dare consigli da lontano, occorre decidere sul posto. Né basta essere presenti per dire quel che si deve fare, bisogna tenere gli occhi bene aperti e cogliere il momento opportuno, che a volte passa in un lampo. Cercala, dunque, l’occasione, e come la vedi coglila al volo e metti tutto il tuo slancio e tutta la tua forza per liberarti da quegli impegni inutili e dannosi. E ascolta bene come la penso: o ti tiri fuori da questo genere di vita, o esci dalla vita stessa. Ma non in modo traumatico: più che spezzare i legami in cui ti sei malamente impigliato devi scioglierli, ma se non ci riesci, se proprio non ci sarà altro mezzo, allora spezzali. Non c’è individuo per quanto pavido e vile che preferisca restare sempre in bilico piuttosto che cadere e farla finita. Nel frattempo, mentre cerchi di venirne fuori, non crearti altri impedimenti: ti bastino gli affari in cui ti sei cacciato, o, come vorresti far credere, sei caduto. Se infatti te ne cerchi altri, dopo non avrai più giustificazioni, e allora sarà chiaro che in quegli affari non ci sei cascato per caso. Le scuse che di solito si accampano sono false: «Non ho potuto fare diversamente. Che sarebbe accaduto se mi fossi rifiutato? Era necessario». Ma nessuno ti obbliga a rincorrere la fortuna: anche se non vuoi contrastarla, basta che rallenti il passo e non l’incalzi, visto che è sempre lei che ti porta avanti. Non avertela a male se i suggerimenti che ti dò non sono tutti farina del mio sacco, ma io stesso, quando devo prendere una decisione, faccio ricorso ad altri che sono certo più saggi di me. A questo proposito leggi la lettera che Epicuro scrisse a Idomeneo, nella quale lo prega di ritirarsi al più presto possibile, prima che lo costringa una forza maggiore, privandolo così della sua libertà. Poi, però, aggiunge che non ci si deve ritirare se non quando si abbia la certezza di farlo in modo giusto e nel momento opportuno, e che appena si presenta l’occasione lungamente attesa bisogna balzarle addosso. Per questo dice che chi pensa alla fuga non deve sonnecchiare e assicura un esito favorevole anche nelle più grandi difficoltà a condizione che non ci si affretti prima del tempo e non si indugi al momento di ritirarsi. A questo punto vorrai conoscere anche il parere degli stoici, i quali sono più cauti che coraggiosi, ma non possono certo essere accusati di temerarietà. Forse ti aspetti che dicano: «È vergognoso sottrarsi a un
peso: lotta con l’impegno che ti sei assunto. Chi fugge la fatica e non si mostra sempre più coraggioso di fronte alle crescenti difficoltà è un debole e un vigliacco». Ti diranno così se varrà la pena di perseverare, se non ci saranno da compiere o da sopportare cose indegne di un uomo onesto, il quale certo non si consumerà in occupazioni vili e infamanti, né rimarrà impigliato negli affari per puro e semplice gusto. E non resterà neppure bloccato nella morsa dell’ambizione (come pensi tu), disposto sempre a sopportare l’inquietudine e i guai che ne derivano, ma solo quando avrà constatato che la situazione in cui si dibatte è grave, incerta e ambigua, soltanto allora ritrarrà il piede, retrocedendo passo dopo passo, ma senza volgere le spalle, sino a mettersi al sicuro. È facile, Lucilio mio, sottrarsi alle pubbliche faccende se ne disprezzi i vantaggi: sono questi, infatti, che ci fanno indugiare e ci trattengono. «E che?», obietterai. «Devo abbandonare così grandi speranze? Piantare il mio lavoro proprio quando dovrei raccoglierne i frutti? Nessuno più al mio fianco, la mia lettiga senza accompagnatori, l’atrio della mia casa completamente deserto?». Già. Gli uomini si allontanano a malincuore da queste miserie, e mentre da un lato le maledicono, dall’altro sono attaccati alle ricompense che ne derivano. Si lamentano dell’ambizione come di un’amante, voglio dire, se vai a guardare i loro veri sentimenti ti rendi conto che lo fanno non per odio ma per il vizio di polemizzare. Esamina a fondo queste persone che a parole disprezzano quanto hanno desiderato e protestano di voler fuggire da quei beni di cui però non possono fare a meno: vedrai che in quello stato ci sguazzano, e come!, anche se dicono di sopportarlo malvolentieri e con tanta pena. È proprio così, Lucilio: sono pochi gli schiavi costretti a servire di fronte a coloro che s’incatenano da sé. Ma se hai intenzione di ritirarti perché cerchi davvero la libertà e chiedi una dilazione solo per poterlo fare senza star sempre in assillo, perché non dovrebbe approvarti tutta la schiera degli stoici? Tutti gli Zenoni e tutti i Crisippi converranno che sei una persona onesta e moderata. Se però tergiversi per vedere quanto puoi portare con te e con quale somma di denaro puoi predisporre il tuo ritiro non troverai mai una via d’uscita: non si scampa da un naufragio portandosi dietro i bagagli. Innàlzati a una vita migliore col favore degli dèi, non quello, però, che essi usano verso coloro a cui concedono, benevoli e benigni, mali vistosi, con la scusante che tali doni, molesti e fastidiosi, li dispensano su richiesta. Stavo già chiudendo la lettera e ho dovuto rimetterci mano per inserirvi il consueto piccolo regalo e fartela arrivare con qualche nobile massima. Me ne viene in mente una, non so se più valida per la verità che racchiude o per la sua eloquenza. Vuoi sapere di chi è? Di Epicuro. Ancora una volta mi approprio dei bagagli altrui. «Non c’è uomo che muoia senza l’impressione di essere appena nato»: sia giovane, vecchio o di mezza età, tutti sono ugualmente paurosi della morte, ugualmente ignari della vita. Non c’è uno che abbia concluso qualcosa, anche perché rimandiamo tutto al futuro. Ciò che più mi diverte di questa massima è che dà ai vecchi dei “rimbambiti”. Non è poi esatto dire che «nessuno
esce dalla vita diverso da come è nato», poiché in realtà moriamo peggiori, e la colpa è nostra, non della natura, la quale ha il diritto di lamentarsi con noi e dire: «Che fate? Vi ho generato senza desideri, senza paure, senza superstizioni, senza perfidie e senza altri mali: uscite dalla vita quali siete entrati». Saggio è colui che muore tranquillo come lo era alla nascita: noi, invece, appena si avvicina un pericolo tremiamo, siamo presi da vigliaccheria, sbianchiamo in volto, versiamo lacrime senza alcun frutto. Niente è più vergognoso che l’essere turbati proprio alle soglie della quiete. Il fatto è che siamo privi di ogni autentico bene e alla fine ci arrabbiamo perché abbiamo sprecato la vita. Non ce ne resta, infatti, nemmeno un pezzettino: è passata, scivolata via. Ci preoccupiamo di vivere a lungo, non di vivere bene, quando tutti, volendo, possono vivere bene, a lungo non può vivere nessuno. Stammi bene. 23. Dovrei parlarti dell’inverno, di quanto è stato benevolo, breve e temperato, della primavera malevola, del freddo fuori stagione e di altre simili sciocchezze tipiche di chi non sa che cosa dire? Affronterò invece un argomento che può giovare a te e a me. E cosa di meglio che esortarti alla saggezza? Vuoi sapere quale ne sia il fondamento? Non compiacersi delle vanità. Ho detto “fondamento” ma in realtà è il culmine, perché proprio chi sa di cosa gioire è giunto al vertice della saggezza, chi non pone la sua felicità nelle mani di altri, mentre chi si lascia sedurre da qualche speranza, anche se l’ha a portata di mano o non è difficile da realizzare, anche se non è mai rimasto deluso, è un uomo insicuro e pieno di preoccupazioni. Fa’ questo, innanzitutto, Lucilio mio: impara a gioire. Pensi che io ti privi di molti piaceri tenendo lontano da te ciò che dipende dal caso e ritenendo che si debba evitare il dolcissimo conforto della speranza? Al contrario, io voglio che tu sia sempre contento. Voglio, però, che la contentezza ti nasca in casa, cioè dentro di te. Gli altri tipi di gioia non riempiono il cuore: rasserenano il volto, ma sono fugaci, a meno che tu non creda che chi ride gioisca davvero. È l’animo che deve essere allegro, fiducioso, ed ergersi al di sopra di tutto. La vera gioia è una cosa seria, credimi. O forse ritieni che uno col volto sereno – o “gaio”, come dicono questi sdolcinati – disprezzi la morte, apra la sua casa alla povertà, tenga a freno i piaceri, sia disposto a sopportare i dolori? Chi medita su questi argomenti prova una grande gioia, anche se poco allettante. È questa la gioia che devi conquistare: non ti abbandonerà mai, una volta che tu abbia scoperto da dove proviene. I metalli leggeri si trovano in superficie, quelli preziosi, invece, sono nascosti nelle viscere della terra e procurano un guadagno maggiore a chi ha la costanza di scavare. Ebbene, ciò di cui si compiace il volgo offre un piacere superficiale e inconsistente: la gioia esteriore, infatti, è priva di fondamento. Quella di cui ti parlo, invece, e alla quale cerco di condurti, è concreta e tale che si sviluppa maggiormente nell’intimo. Ti prego, Lucilio mio carissimo, fa’ la sola e unica cosa che può renderti felice: calpesta e distruggi questi beni che splendono solo esteriormente, che non dipendono da te ma ti sono dati da altri, dalla sorte;
aspira al bene vero e godi solo di te. Quanto al corpo, questa piccola cosa materiale, consideralo pure necessario, poiché niente possiamo senza di lui, ma non più importante dello spirito: i piaceri che ci procura sono vani, di breve durata, tanto che poi ci pentiamo di averli provati, e se non sono tenuti a freno da una grande moderazione producono addirittura l’effetto contrario. È così: il piacere cammina come su un filo sospeso sopra un precipizio e se non si tiene dentro la giusta misura si trasforma in dolore. Ma è difficile tenere la giusta misura in ciò che, a torto, si considera un bene. Solo la voglia del vero bene, anche se smodata, è priva di rischi. Vuoi sapere quale sia questo bene e da dove provenga? Te lo dico subito: è quello che deriva da una coscienza retta, da propositi onesti e da un agire conforme, dal disprezzo di tutto ciò ch’è fortuito, da un tenore di vita tranquillo e costante, quale è quello di chi non si allontana mai dal giusto cammino intrapreso. Infatti, quelli che passano da un proposito all’altro, anzi, che sono trasportati dal caso, come possono avere qualcosa di sicuro e duraturo se sono insicuri e incostanti? Sono pochi quelli che dispongono di sé e delle proprie cose secondo un progetto ben preciso: gli altri, come tutto ciò che galleggia sui fiumi, non procedono di loro iniziativa, ma vengono trasportati; fra questi, alcuni sono trattenuti o mossi dolcemente da una corrente leggera, altri sono trascinati da un’onda più violenta, altri vengono deposti vicino alla riva da una corrente che s’infiacchisce, altri sono gettati in mare da un torrente impetuoso. Perciò dobbiamo stabilire cosa vogliamo e perseverare nei nostri propositi. Ma è giunto il momento di pagare il mio debito, magari con una frase del tuo Epicuro, e affrancare così questa lettera: «È penoso cominciare sempre la vita»; o forse, per renderne più chiaro il significato, è meglio così: «Vive male chi vive ogni momento della propria vita come se fosse sempre la prima volta». «Perché?», mi chiedi: la frase, infatti, va spiegata. Perché la vita per certe persone è sempre incompiuta, e chi comincia a vivere non può essere pronto a morire. Bisogna fare in modo di aver vissuto abbastanza, ma questo non lo fa chi inizia sempre a tessere la trama della sua vita. Non credere che si tratti di una sparuta minoranza: gli uomini sono quasi tutti così. Alcuni, poi, cominciano a vivere proprio quando dovrebbero smettere. Se ti sembra strano, aggiungerò una cosa che ti parrà ancora più strana: certi finiscono di vivere ancora prima di cominciare. Stammi bene. 24. Mi dici di essere preoccupato per l’esito della causa intentatati da un nemico infuriato, e ritieni che io ti consiglierò di pensare a cose più piacevoli e di trovare conforto in qualche dolce prospettiva. Non c’è infatti alcuna necessità di tirarsi addosso i guai o di anticiparli, perché quando arriveranno dovrai sopportarli già abbastanza presto, e perché rovinarsi il presente per timore del futuro? È senza dubbio da pazzi soffrire oggi solo perché prima o poi ti dovrà capitare. Ma voglio tranquillizzarti per un’altra via: se vuoi liberarti da ogni preoccupazione, pensa che ciò che temi accadrà in ogni caso, e qualunque sia
quel male misuralo con te stesso e poi valuta attentamente la tua paura: comprenderai senz’altro che il male temuto o non è grave o è di breve durata. Non serve perdere tempo a cercare esempi per rincuorarti, visto che se ne trovano in ogni epoca. Richiama alla tua mente un periodo qualsiasi della storia, nazionale o estera, e incontrerai uomini illustri per i loro progressi spirituali o per i loro nobili slanci. Se sei condannato può forse succederti qualcosa di più grave che l’essere incarcerato o mandato in esilio? C’è da temere qualcosa di peggio del rogo o della morte? Ebbene, considera questi mali uno per uno e cita coloro che li hanno disprezzati: non avrai bisogno di cercarli, dovrai solo sceglierli. Rutilio1 sopportò la sua condanna come se per lui niente fosse più molesto di una cattiva reputazione. Se Metello2 affrontò l’esilio con coraggio, Rutilio lo tollerò persino volentieri: l’uno giurò alla Repubblica che sarebbe tornato, l’altro rifiutò il rimpatrio concessogli da Silla, al quale allora era impossibile negare qualcosa. Socrate in carcere continuò a discutere di filosofia e sebbene qualcuno gli assicurasse la fuga non l’accettò, e rimase in prigione per insegnare agli uomini come liberarsi dalla paura dei due mali ritenuti più gravi, il carcere e la morte. Muzio3 mise la mano sul fuoco: già è doloroso essere bruciati, ma quanto più lo è soffrire tale tormento se tu stesso te lo sei procurato! Hai di fronte un uomo incolto, sprovvisto di antidoti contro la sofferenza e il timore della morte, dotato solo del suo vigore combattivo e che s’infligge spontaneamente una punizione per un tentativo fallito. Ebbene, restò immobile e impassibile a guardare la sua mano destra che cadeva a gocce sul braciere del nemico, e non la ritrasse, dopo che si fu ridotta alle nude ossa, se non quando il nemico gli portò via il braciere. Avrebbe potuto compiere in quell’accampamento un’impresa più fortunata, ma non più coraggiosa. Vedi quanto il valore sia più celere nell’affrontare un male che non la crudeltà nell’infliggerlo. Più facilmente Porsenna perdonò a Muzio di averlo voluto uccidere che non Muzio a sé stesso di non averlo ucciso. «Queste», dici, «sono leggende che si ripetono in tutte le scuole; e ora, quando si parlerà del disprezzo della morte, mi racconterai di Catone». Ti racconterò di quella famosa ultima notte in cui, posata la spada vicino alla sua testa, si mise a leggere un libro di Platone. In quel momento supremo si era procurato questi due strumenti, uno che gli desse la volontà di morire, l’altro la possibilità. Così, dopo aver disposto alla meglio le sue cose, come si poteva in quella situazione estrema e terribile, ritenne di dover fare in modo che nessuno potesse uccidere Catone o cercare di salvarlo e, impugnata la spada che fino a quel giorno non aveva mai macchiato di sangue, esclamò: «O Fortuna, non hai ottenuto nulla contrastando tutti i miei tentativi. Finora ho combattuto non per la mia libertà, ma per quella della patria, e ho agito con tanta determinazione non per vivere libero, ma per vivere in mezzo a uomini liberi: ora, poiché la condizione del genere umano è disperata, Catone si metta al sicuro». Quindi s’inferse la ferita mortale, e quando i medici gliela fasciarono, benché perdesse sangue e gli venissero meno le forze, con lo stesso coraggio di prima e adirato
non tanto con Cesare quanto con sé stesso, infilò le mani nude nella ferita e non esalò ma liberò dalle catene quella sua anima nobile e sprezzante di ogni potenza. Vado raccogliendo questi esempi non per un puro esercizio della mente, ma per darti coraggio contro un male che sembra il più terribile di tutti, e vi riuscirò più facilmente mostrandoti che non solo uomini valorosi hanno affrontato sprezzantemente il momento della morte, ma che alcuni, vili in altre circostanze, hanno eguagliato, nel morire, il coraggio dei più forti. Fra questi il famoso Scipione,4 suocero di Gneo Pompeo, il quale, spinto dal vento contrario verso le coste africane, essendosi accorto che la sua nave era caduta nelle mani dei nemici, si trafisse con la spada, e a quelli che gli chiedevano dove fosse il generale rispose: «Il generale sta bene». Questa frase lo ha messo alla pari dei suoi antenati e ha fatto sì che la fatidica gloria degli Scipioni in Africa non venisse interrotta. Fu una grande impresa vincere Cartagine, ma ancora più grande fu vincere la morte. «Il generale sta bene»: sarebbe forse dovuto morire diversamente un generale, e per di più il generale di Catone? Non intendo evocare le vicende storiche e neppure passare in rassegna tutte le epoche per citarti quegli uomini – numerosissimi – che hanno disprezzato la morte: volgi lo sguardo ai tempi nostri, di cui lamentiamo la fiacchezza e l’amore per i piaceri: vedrai uomini di ogni classe sociale, di ogni condizione, di ogni età, che hanno posto fine ai loro mali con la morte. Credimi, Lucilio, la morte è così poco temibile che grazie a lei non dobbiamo temere nulla. Ascolta dunque tranquillamente le minacce del tuo nemico, e per quanto la tua retta coscienza t’infonda fiducia, poiché in un processo s’inseriscono spesso anche molti fattori che con la vicenda in questione non hanno nulla a che vedere, spera sì in una sentenza che sia davvero giusta, ma preparati anche a una totalmente ingiusta. Innanzitutto ricordati di spogliare i fatti dal fracasso e dall’agitazione che gli si creano intorno e di esaminarli nella loro sostanza: scoprirai che in essi non c’è nulla di terribile, tranne il timore che suscitano. Ciò che vedi succedere ai bambini accade anche a noi, fanciulli un po’ più grandi: se vedono mascherate le persone che amano, alle quali sono abituati e con le quali giocano, si spaventano. Bisogna togliere la maschera anche alle cose e restituire loro il vero aspetto. Perché mi mostri spade, fuoco e una folla di carnefici che fremono intorno a te? Togliti, o morte, questo apparato sotto il quale ti nascondi e atterrisci gli stolti: tu sei quella che poco fa un mio servo, una mia ancella hanno affrontato sprezzantemente. Perché di nuovo mi dispieghi davanti, con grande messa in scena, flagelli e cavalletti di tortura? Perché mi mostri i vari arnesi costruiti per slogare le diverse articolazioni e i mille altri attrezzi che servono a straziare un uomo brano a brano? Getta questi strumenti di terrore, lascia che cessino i gemiti, le grida e gli urli lancinanti strappati con la tortura: tu sei il dolore che quel gottoso lì riesce a disprezzare, che quel malato di stomaco sopporta coraggiosamente anche in mezzo ai piaceri della tavola, a cui resiste una giovinetta durante i travagli del parto. Se posso sopportarti, sei lieve, se non
posso, duri poco. Medita su queste parole che spesso hai udito e pronunciato tu stesso; dimostra coi fatti se le hai ascoltate e dette con sincerità: la cosa più vergognosa, infatti, e che di solito ci viene rinfacciata, è che discutiamo di filosofia, ma non la mettiamo in pratica. E che? Ti rendi conto adesso, per la prima volta, che incombono su di te la morte, l’esilio, il dolore? Siamo nati anche per patire queste sventure, perciò qualunque cosa possa toccarci pensiamola come certa. Del resto, avrai sicuramente agito secondo i miei consigli, non ne dubito. Ora, però, ti esorto a non sommergere il tuo animo in queste preoccupazioni, perché altrimenti, quando dovrà drizzarsi e lottare concretamente, sarà indebolito e avrà minor vigore. Distoglilo dai tuoi problemi personali e volgilo a quelli generali; ripetigli che hai un corpicino debole e mortale che dovrà sperimentare il dolore derivante non solo dalle offese o dalle violenze dei potenti, perché anche i piaceri si trasformano in tormenti, i banchetti provocano indigestione, l’ubriachezza intorpidimento e tremiti nervosi, la lussuria può deformare i piedi, le mani e le articolazioni. Diventerai povero? Sarai tra i più. Andrai in esilio? Fa’ conto di essere nato là dove sarai mandato. Sarai incatenato? E con ciò? Ora sei forse libero? La natura ti ha inchiodato a questo grave peso del tuo corpo. Morirai? È come dire che cesserai di ammalarti, di essere incatenato, di morire. Non sono tanto sciocco da ripetere a questo punto il ritornello epicureo e dire che i timori dell’oltretomba sono infondati, che né una ruota fa girare Issione,5 né Sisifo6 spinge un masso con le spalle su per una salita, né i visceri di alcuno possono ogni giorno ricrescere ed essere divorati. Nessuno è così infantile da temere Cerbero,7 le tenebre e gli scheletri sotto forma di spettri. La morte o ci distrugge o ci libera: se ci libera, tolto il peso del corpo, resta la parte migliore di noi; se ci distrugge, di noi non resta niente, scompaiono parimenti sia il bene che il male. A questo punto consentimi di citare un tuo verso, che prima t’invito a considerare scritto non solo per gli altri, ma anche per te. Se è disonesto dire una cosa e pensarne un’altra, ancora di più lo è scrivere ciò che non si pensa. Ricordo che una volta hai scritto che non precipitiamo nella morte all’improvviso ma ci avviciniamo a lei a poco a poco. Moriamo ogni giorno: ogni giorno ci viene sottratta una parte della vita, la quale va accorciandosi via via che noi cresciamo. Prima perdiamo l’infanzia, poi la fanciullezza, poi la giovinezza: tutto il tempo trascorso fino a ieri è perduto; anche la giornata che stiamo vivendo la dividiamo con la morte. Come non è l’ultima goccia d’acqua che nel cadere provoca lo svuotamento della clessidra, ma è tutta quella scesa prima, così non è l’ultima ora in cui cessiamo di esistere a provocare la morte, essa è solo quella che la porta a compimento: moriamo in quel momento, ma alla morte eravamo già avviati da tempo. Ebbene, dopo aver esposto questi concetti con la tua solita facondia, sempre sostenuta ma mai più efficace di quando accordi le parole con la verità, hai scritto: La morte non viene una volta sola:
quella che ci porta via è la morte definitiva.8 Ma è meglio che tu legga te stesso invece della mia lettera; ti sarà più chiaro che quella da noi temuta è la morte ultima, non l’unica e sola. So dove miri: vuoi sapere cos’ho inserito nella mia lettera, quale massima, e di chi, volta a infondere coraggio, quale utile consiglio. Eccoti alcune osservazioni sull’argomento trattato. Epicuro biasima chi brama la morte non meno di chi la teme, e dice: «È ridicolo che tu corra verso la morte perché sei stanco della vita quando è il tuo modo di vivere che ti fa correre verso la morte». E altrove scrive: «Che c’è di così ridicolo come desiderare la morte quando è proprio la paura della morte che ci ha reso impossibile la vita?». A queste riflessioni aggiungine una dello stesso tenore: tale è l’ignoranza, anzi, la follia degli uomini, che alcuni sono spinti alla morte dal timore della morte.9 Quale che sia tra questi il pensiero su cui ti soffermerai a meditare, prenderai coraggio per sopportare o la morte o la vita: dobbiamo infatti essere consigliati e incoraggiati sia a non amare che a non odiare troppo la vita. Anche quando la ragione ci convince a porre termine alla nostra esistenza, non dobbiamo prendere decisioni impulsive e avventate. L’uomo forte e saggio non deve fuggire dalla vita, deve semplicemente uscirne, ma senza provare quella smania che afferra molte persone. Infatti, Lucilio mio, anche verso la morte, come verso altre cose, l’animo spesso mostra una sconsiderata inclinazione, che s’impossessa sia di uomini generosi e di fierissima indole, sia di uomini deboli e vili: gli uni disprezzano la vita, gli altri ne sentono il peso. In alcuni subentra la sazietà di fare e di vedere sempre le stesse cose e non propriamente l’odio ma un senso di fastidio per la vita, in cui scivoliamo sotto la spinta della filosofia stessa, allorché ci chiediamo: «Fino a quando le stesse cose? Mi sveglierò, dormirò, avrò fame, avrò caldo, avrò freddo. Ogni cosa si ripete e tutte sono collegate e concatenate fra loro come in un giro vizioso, fuggono e inseguono: la notte incalza il giorno, il giorno la notte, l’estate finisce nell’autunno, l’autunno è inseguito dall’inverno, che a sua volta viene fermato dalla primavera; tutto passa per ritornare. Non faccio niente di nuovo, non vedo niente di nuovo, e tutto questo a un certo momento ti fa venire la nausea». Molti giudicano la vita non penosa, ma inutile. Stammi bene. 25. Per quel che riguarda i nostri due amici bisogna seguire una via diversa, poiché i difetti dell’uno devono essere corretti, quelli dell’altro vanno stroncati. Ti parlerò con la massima libertà: se non lo tratto con durezza significa che non gli voglio bene. «Come?», mi dirai. «Pensi di tenere sotto la tua tutela un pupillo di quarant’anni? Tieni presente che ormai, data l’età, si è fatto tosto e non si lascia manipolare facilmente; non è possibile cambiarlo: solo una materia duttile si può plasmare». Non so se ci riuscirò, ma alla rinuncia preferisco l’insuccesso. Non bisogna disperare: anche gli ammalati cronici possono guarire, se ci si oppone alle loro intemperanze, se li si costringe a fare e a sopportare molte cose
controvoglia. Non nutro buone speranze neppure per l’altro nostro amico, se non per il fatto che riesce ancora ad arrossire per i suoi peccati. Bisogna dunque alimentare questo suo pudore: finché durerà nel suo animo, la speranza non morirà. Con questo peccatore incallito occorre agire con più tatto, per evitare che finisca col disperare di sé stesso. Questo è il momento migliore per avvicinarlo, visto che si trova in uno stato di quiete e sembra sulla via della guarigione, anche se una interruzione di questo genere potrebbe nascondere un inganno. Ma a me non la dà da bere, io temo che i vizi gli torneranno, e pure con qualche aggiunta: ora non si vedono, d’accordo, ma non sono spariti. Comunque, dedicherò qualche giorno a questo problema e vedrò se e cosa si può fare. Tu dimostrati forte, come fai, e riduci i tuoi bagagli; niente di ciò che abbiamo è necessario. Torniamo alla legge di natura: la ricchezza è a portata di mano. Ciò che ci serve costa poco o nulla: pane e acqua, solo di queste cose abbiamo bisogno, e nessuno è tanto povero da non potersele procurare; se uno limita a ciò i suoi desideri può gareggiare in felicità con Giove stesso, come dice Epicuro, di cui voglio inserire un pensiero in questa lettera. «Comportati in tutto come se Epicuro ti vedesse», dice il grande filosofo. Indubbiamente è utile imporsi un custode e avere qualcuno a cui tenere rivolto lo sguardo, facendolo partecipe dei propri pensieri. Però è molto meglio vivere come se si fosse sempre sotto gli occhi di un uomo virtuoso. Ma a me basta che tu agisca come sotto lo sguardo di una persona qualsiasi: la solitudine c’induce a ogni genere di mali. Quando avrai fatto tali progressi nella tua evoluzione spirituale da provare imbarazzo persino di fronte a te stesso, potrai congedare il tuo pedagogo: nel frattempo fatti sorvegliare da un personaggio autorevole – magari il celebre Catone, oppure Scipione, o Lelio, o un altro, davanti ai quali anche gli uomini più corrotti cercherebbero di reprimere i propri vizi – finché diventerai tale da non avere il coraggio di peccare nemmeno di fronte a te stesso. Quando avrai raggiunto questo risultato e comincerai a nutrire una qualche stima verso di te, potrò permetterti ciò che consiglia ancora Epicuro: «Ritirati in te stesso soprattutto quando sei costretto a stare in mezzo alla folla». Devi diventare diverso dalla massa per poterti ritirare in te stesso senza alcun rischio. Guarda uno per uno quelli che ti circondano: vedrai che quasi tutti ritengono più utile stare con chiunque altro piuttosto che con sé stessi. «Ritirati in te soprattutto quando sei costretto a stare in mezzo alla folla», a condizione, però, che tu sia un uomo onesto, tranquillo e temperante. Diversamente devi scappare da te stesso e andare fra la gente, perché da solo saresti troppo vicino a un uomo malvagio. Stammi bene. 26. Qualche tempo fa ti ho scritto di essere già in cospetto della vecchiaia, ora temo di averla superata: ai miei anni e soprattutto a questo mio corpo conviene ormai un altro nome, poiché vecchiaia indica un’età stanca ma non priva di forze. Annoverami dunque fra gli uomini decrepiti e prossimi alla fine. Posso dirti, però, che mi congratulo con me stesso, perché nello spirito non sento
i danni dell’età come li avverto nel corpo. Sono invecchiati solo i vizi e i loro amministratori: l’animo è forte e si compiace di non avere molto a che fare col corpo, ormai ha deposto gran parte del suo peso. Esulta e disserta con me sulla vecchiaia: dice che è il suo fiore all’occhiello. Crediamogli: si goda il suo bene. Mi esorta a riflettere e a scoprire quanto di questa tranquillità e moderazione di costumi io debba alla saggezza e quanto, invece, all’età, e a esaminare attentamente ciò che non posso fare e ciò che non voglio fare, essendo ormai prossimo ad andarmene, e io mi compiaccio di considerare quel che non posso fare come se non volessi farlo: che motivo ho di lamentarmi, quale danno ne ricevo se quel che doveva finire è finito? «Ma è un danno gravissimo», ribatti, «consumarsi, deperire, o, per meglio dire, disfarsi, visto che non veniamo colpiti e abbattuti all’improvviso, ci consumiamo a poco a poco, ogni giorno ci toglie un po’ di forze». E quale conclusione migliore per il corpo che scivolare verso la propria fine per dissoluzione naturale? Non dico che un colpo e un’uscita improvvisa dalla vita siano un male, ma essere portati via a poco a poco è certamente meglio. Io, come se si avvicinasse il momento della prova estrema, il giorno che dovrà giudicare di tutti i miei anni, mi osservo e mi dico: «Ciò che finora ho mostrato coi fatti o con le parole non è niente al confronto, sono pegni dell’animo ingannevoli e di poco conto, avviluppati in mille ornamenti esteriori: mi affiderò alla morte per sapere quali progressi ho fatto. Perciò mi preparo con coraggio a quel giorno in cui, deposti ogni calcolo e ogni artificio, giudicherò di me stesso, se sono forte solo a parole o anche nell’intimo, se sono state farsa e simulazione tutte le frasi arroganti che ho scagliato contro la sorte. Metti da parte le opinioni degli uomini, che sono sempre incerte e ambigue, via gli studi a cui hai atteso per tutta la vita: sarà la morte a giudicarti. Questo voglio dire: le dispute, le conversazioni dotte, le frasi raccolte dagli insegnamenti dei saggi e i discorsi eruditi non mostrano la vera forza d’animo; anche i più vili sono capaci di parole coraggiose. Ciò che hai fatto apparirà chiaro quando esalerai l’ultimo respiro. Accetto questa condizione, non ho paura del giudizio finale». Così dico a me stesso, ma fa’ conto ch’io mi rivolga anche a te. Tu sei più giovane: che importa? Gli anni non contano. Non puoi sapere dove ti attenda la morte, perciò, aspettala dovunque. Volevo ormai terminare e la mano mirava alla conclusione, ma devo pagare il mio debito e dare anche a questa lettera le provviste per il viaggio. Anche se non ti dico da chi prenderò il prestito, tu sai da quale forziere attingo. Aspetta un pochettino e pagherò con denaro mio, ma intanto provvederà ancora una volta Epicuro, con quel precetto che dice: «Medita sulla morte», o se il senso può risultare più chiaro così: «Nobile cosa è imparare a morire». O pensi che conoscere ciò di cui dobbiamo servirci una volta sola sia una cosa inutile? E invece è proprio questo il motivo per cui dobbiamo meditare sulla morte: bisogna sempre imparare ciò che non possiamo essere certi di sapere. «Medita sulla morte»: è come meditare sulla libertà. Chi ha imparato a morire ha disimparato a essere schiavo; è superiore a ogni potere, o certamente ne è al di
fuori. Che gl’importano il carcere, le guardie, le catene? Ha sempre una porta aperta. Una sola è la catena che ci tiene legati alla vita: l’amore per la vita, che noi dobbiamo non eliminare, ma ridurre, in modo che, se le circostanze lo richiedano, niente ci trattenga né c’impedisca di essere pronti a fare subito ciò che prima o poi dev’essere fatto. Stammi bene. 27. «Tu dài consigli a me?», mi dirai. «E a te stesso li hai già dati? Ti sei già corretto? Ed è per questo che impieghi il tuo tempo a correggere gli altri?». Non sono così disonesto da assumermi, io malato, la cura del prossimo, ma, come se ci trovassimo nello stesso ospedale, ti parlo del nostro male comune e divido con te le medicine. Grido a me stesso: «Conta i tuoi anni e ti vergognerai di desiderare e di cercare le medesime cose di quando eri fanciullo. Si avvicina il giorno della morte: datti da fare affinché i tuoi vizi muoiano prima di te. Lascia questi torbidi piaceri, che ti tocca scontare a caro prezzo: non solo quelli futuri, ma anche i passati nuocciono. Come rimane sempre il rimorso o l’angoscia per i misfatti commessi, anche se non vengono scoperti, così resta il pentimento che proviene dai piaceri disonesti. Non sono solidi né durevoli: anche se non danneggiano, svaniscono. Cerca piuttosto un bene duraturo, e tale è soltanto quello che l’animo trova in sé stesso. Solo la virtù procura una gioia stabile e sicura; anche se incontra un ostacolo, questo fa come le nubi, che si frappongono fra l’alto e il basso ma non vincono mai la luce del giorno». A quando una simile gioia? Non siamo rimasti inoperosi finora, ma bisogna affrettarsi: c’è ancora molto lavoro da fare, e tu, da parte tua, devi stare in guardia, dedicarti a questa fatica senza risparmio, se vuoi che vada a buon fine; in altri tipi di studio ci si può far aiutare, qui non è consentita alcuna delega. Calvisio Sabino, un ricco signore dei miei tempi, aveva un patrimonio e un’indole da liberto; non ho mai visto un uomo più sfacciatamente beato. Aveva una memoria così debole che una volta dimenticava il nome di Ulisse, un’altra quello di Achille o di Priamo, personaggi che conosceva benissimo come noi conosciamo i nostri maestri. Nemmeno un vecchio schiavo nomenclatore, che invece di riferire i nomi al padrone di casa se li inventa, ha mai salutato a uno a uno i cittadini commettendo tanti errori quanti ne commetteva lui parlando dei Troiani e degli Achei. Ciononostante voleva apparire colto. Perciò, escogitò questo espediente: comprò a caro prezzo alcuni servi, uno che imparasse a memoria tutto Omero, un altro tutto Esiodo, inoltre destinò uno schiavo a ciascuno dei nove lirici.10 Non ti sorprenda che abbia speso tanto, anche perché, non avendoli trovati già istruiti, dovette farli preparare. Procuratasi tutta questa servitù, cominciò a mettere in crisi i suoi ospiti. Durante il pranzo teneva questi schiavi ai suoi piedi e di volta in volta si faceva dire da loro i versi che voleva recitare. Ma nonostante ciò nel bel mezzo di una frase s’interrompeva. Satellio Quadrato, uno sfruttatore di ricchi sfondati ma senza cervello, e conseguentemente sornione e schernitore – caratteristica, quest’ultima, strettamente connessa alle altre due –, gli suggerì di assumere degli schiavi raccoglitori di avanzi di citazioni. Quando Sabino disse
che ciascuno schiavo gli costava centomila sesterzi, l’altro replicò: «A minor prezzo avresti comprato altrettante casse di libri». Sabino, tuttavia, era convinto di saperne più di quanto in casa sua ne sapesse chiunque altro. Quello stesso Satellio cominciò a incitarlo a praticare la lotta, benché fosse malato, pallido e macilento. Al che Sabino gli rispose: «E come potrei farlo? A mala pena mi reggo in piedi!». E lui: «Ma cosa dici? Con i servi forzuti che ti ritrovi?». La saggezza non si prende in prestito e non si compra, e anche se fosse in vendita, non troverebbe compratori: la stupidità, invece, si compra ogni giorno. Ma prendi ormai quanto ti devo e a risentirci. «Una povertà regolata secondo la legge di natura è una ricchezza»: lo dice spesso Epicuro, ora in un modo ora in un altro, ma non si ripete mai troppo ciò che non s’impara mai abbastanza. I rimedi ad alcuni basta indicarli, ad altri bisogna inculcarli a forza. Stammi bene. 28. Pensi che questo sia capitato soltanto a te e ti stupisci, come di un fatto strano, che, pur avendo viaggiato a lungo e visitato tanti luoghi diversi, non sei riuscito a scacciare la tristezza e la malinconia? Devi cambiare l’animo, non il cielo. Attraversa pure il vasto mare, lascia che, come dice il nostro Virgilio, scompaiano terre e città,11 i tuoi vizi ti seguiranno dovunque. A un tale che si lamentava per la stessa ragione Socrate disse: «Perché ti meravigli se i viaggi non ti giovano a nulla? Porti in giro te stesso. Ti segue il motivo medesimo che ti ha fatto fuggire». A che giova visitare nuovi paesi, conoscere città e luoghi diversi? Vano è tutto questo agitarsi. Ti chiedi perché questa fuga non ti sia di aiuto: tu fuggi con te stesso; prima devi deporre il peso dell’animo, diversamente non vi sarà luogo che possa soddisfarti. Pensa che il tuo stato d’animo è simile a quello che il nostro Virgilio rappresenta nella profetessa esaltata e invasata da uno spirito non suo: s’agita la profetessa, tentando di espellere il dio fuori dal petto suo.12 Ti sposti da un luogo all’altro per scuoterti di dosso il peso che ti sta nell’animo, e che si fa più gravoso proprio per via di questa tua agitazione, così come in una nave i carichi sballottati dal movimento fanno affondare il fianco su cui pesano, mentre quelli stabili gravano di meno. Qualunque cosa tu faccia ti riesce dannosa e i tuoi continui spostamenti non ti giovano certo: tu muovi, infatti, un ammalato. Solo quando avrai rimosso questo tuo male ogni cambiamento di luogo ti risulterà piacevole; anche se dovessi essere esiliato in terre lontanissime o trasferito nelle zone più barbare, qualunque luogo ti sembrerà ospitale. Conta più lo stato d’animo con cui si arriva in un luogo che non il luogo stesso, e per questo l’animo deve restare indipendente. Dobbiamo
convincerci che non siamo nati per starcene relegati in un cantuccio: la nostra patria è il mondo! Se tu avessi chiaro questo concetto non ti stupiresti di non trarre giovamento dalla varietà delle regioni, in cui vai trasferendoti via via perché ti sono venute a noia le precedenti: ti sarebbe piaciuta già la prima, se le considerassi tutte come tue. Così tu non viaggi, vai vagando di qua e di là, lasciandoti trascinare e passando da un luogo all’altro, mentre quello che cerchi, cioè una vita calma e serena, si trova dovunque. C’è forse un posto più turbolento del Foro? Eppure anche lì si può vivere serenamente, se è necessario. Ma se potessimo disporre liberamente di noi stessi, io fuggirei lontano anche dalla vista e dalla vicinanza del Foro, perché come i luoghi malsani possono intaccare anche una salute di ferro, così esistono luoghi poco salubri per un animo virtuoso non ancora perfetto e che va rinvigorendosi. Io non approvo chi si spinge in mezzo ai marosi e predilige una vita agitata, lottando ogni giorno animosamente contro difficoltà e avversità di ogni genere. Il saggio senza dubbio le sopporta, ma non va certo a cercarle, preferendo vivere in pace piuttosto che in guerra: a che serve avere scacciato i propri vizi se si deve combattere con quelli degli altri? «Trenta tiranni», 13 tu dici, «incalzarono Socrate, ma non poterono infrangerne l’animo». Non conta il numero dei padroni: la schiavitù è una sola; chi la disprezza è libero, quanti che siano i suoi padroni. È tempo ch’io concluda, non prima, però, di aver pagato il mio tributo epistolare. «Il primo passo verso la saggezza è aver coscienza delle proprie colpe». Questo concetto di Epicuro mi sembra molto azzeccato: chi non si accorge di sbagliare, infatti, non vuole correggersi, visto che per correggersi bisogna prima cogliersi in fallo. Alcuni si vantano dei propri vizi: evidentemente chi ne fa sfoggio come se fossero delle virtù non cerca un rimedio. Dunque, per quanto puoi, incolpa te stesso, fa’ l’esame di coscienza: prima assumi il ruolo di accusatore, poi quello di giudice, infine quello di intercessore. E talvolta punisciti. Stammi bene. 29. Mi chiedi notizie del nostro Marcellino,14 e vuoi sapere cosa fa. Viene a trovarmi raramente, perché teme di sentirsi dire la verità, un pericolo da escludersi, ormai: la verità, infatti, bisogna dirla solo a chi è disposto ad ascoltarla. Per questo c’è da chiedersi se fosse giusta l’abitudine di Diogene e degli altri Cinici15 di correggere con indiscriminata libertà chiunque gli capitasse fra i piedi. Che dire, infatti, se qualcuno rimproverasse i sordi o i muti per nascita o per malattia? «E perché risparmiare le parole?», mi dirai. «Non costano niente. Non posso sapere se gioverò a colui che ammonisco, so, però, che se ammonisco tanti potrò giovare a qualcuno. Bisogna sempre tendere la mano: chi ci prova molte volte prima o poi qualcosa di utile la farà». Lucilio mio, non credo che un uomo importante debba comportarsi in questo modo, perché così la sua autorità diminuisce e non pesa più abbastanza su chi si propone di correggere, essendo tanto a buon mercato. Un bravo arciere non deve colpire il bersaglio di quando in quando, può sbagliare una volta, non più: non è
un’arte quella che raggiunge lo scopo per caso. Lo è quella del saggio, il quale deve mirare al sicuro, scegliere persone in grado di progredire e lasciar perdere quelle in cui non crede, o quanto meno non rinunci subito e anche in casi disperati qualche rimedio estremo lo tenti pure. Quanto al nostro Marcellino non ho perso del tutto la speranza: si può ancora salvare, purché gli si tenda subito la mano. C’è il rischio, però, che trascini con sé chi gliela porge, visto che la grande forza d’ingegno che possiede è indirizzata al male. Ciò nonostante correrò questo pericolo e oserò mostrargli i suoi vizi. Lui, come al solito, ricorrerà a quelle facezie capaci di far ridere anche chi sta piangendo e si burlerà prima di sé stesso, poi di noi; anticiperà tutto ciò che intendo dirgli, frugherà nelle nostre scuole e rinfaccerà ai filosofi i regali che gli hanno fatto, le amanti, le ghiottonerie: mi mostrerà che dietro quegli insegnamenti uno ha commesso adulterio, un altro è finito in una bettola, un altro fra i cortigiani; mi indicherà Aristone, 16 l’arguto filosofo che dissertava di filosofia passeggiando in lettiga (quello, infatti, era il luogo e il momento in cui lavorava). Scauro,17 essendogli stato chiesto a quale setta appartenesse Aristone, rispose: «Certamente non è un peripatetico». Giulio Grecino,18 personaggio di spicco, richiesto di un parere su di lui, dichiarò: «Non posso dir nulla, perché non so cosa sia capace di fare a piedi»: come se fosse stato interrogato su un gladiatore che combatte dal carro. Da parte sua Marcellino mi sbatterà in faccia questi ciarlatani che sarebbero stati più onesti se avessero lasciato perdere la filosofia, di cui invece fanno mercato. Comunque, ho deciso di sopportare pazientemente le sue ingiurie: mi faccia pure ridere, io forse lo farò piangere, oppure, se continuerà a ridere, gioirò com’è possibile gioire in casi tristi, come se fosse stato preso da una forma allegra di pazzia. Questo tipo di allegria non dura a lungo, però: fa’ attenzione e vedrai i medesimi personaggi in un breve arco di tempo sfrenatamente ridere e subito dopo scoppiare di rabbia. Intendo avvicinarlo e dimostrargli quanto varrebbe di più se la massa lo stimasse di meno. Magari non riuscirò a estirpare i suoi vizi, ma li attenuerò, e se non cesseranno definitivamente si prenderanno un po’ di riposo ogni tanto, per cui a forza d’interrompersi, se questa diventa un’abitudine, alla fine possono pure scomparire: sarebbe un risultato da non sottovalutare, poiché una grave malattia se lascia un po’ di respiro è quasi una guarigione. Mentre io mi dispongo a curare lui, nel frattempo, tu che puoi e sai bene da che cosa ti sei salvato, e perciò riesci a capire dove potrai arrivare, datti una regola, innalza un po’ lo spirito, stattene saldo contro ciò che temi, non contare quanti siano quelli che t’incutono paura: è da sciocchi temere la folla in uno spazio dove può passare solo una persona per volta. Analogamente non sono molti coloro che possono ucciderti, anche se sono molti a minacciarti. Così vuole la natura: uno soltanto può toglierti la vita, come uno soltanto te l’ha data. Se avessi un po’ di rispetto mi avresti condonato il pagamento di quest’ultimo mio debito epistolare, ma io, d’altra parte, giunto alla fine, non mi comporterò da spilorcio, per cui ti darò per forza quanto ti devo. «Non ho mai
voluto piacere al popolo, perché il popolo non apprezza ciò che io so, e io non so ciò che il popolo apprezza». «Chi è l’autore di questa frase?», mi domandi, come se ormai non sapessi chi ha l’incarico di saldare il mio conto. Epicuro. Anche se questo stesso concetto lo ribadiranno insieme a gran voce i filosofi di tutte le scuole, peripatetici, accademici, stoici, Cinici. Come può infatti piacere al popolo uno che ama la virtù? Il favore popolare si ottiene con mezzi disonesti. Bisogna rendersi simili alla massa, la quale non apprezza se non quelli in cui si riconosce: solo con mezzi disonesti ci si può accattivare il favore dei disonesti. Ma l’opinione che uno ha di sé stesso vale molto più di quella che gli altri hanno di lui. E cosa potrà insegnarti quella filosofia tanto lodata e preferibile a tutte le arti e a tutti i beni? Certamente a voler piacere a te stesso più che al popolo, a considerare i giudizi in base al loro effettivo valore, non al numero di coloro che li formulano, a vivere senza paura degli dèi e degli uomini, a vincere i mali o a porvi un limite. Se poi vedrò che la tua fama dipende dai giudizi favorevoli del popolo, che alla tua apparizione risuonano grida e applausi, onori riservati ai pantomimi, che ti lodano tutte le donne e tutti i bambini della città, perché non dovrei provare compassione per te quando so bene quale sia la strada che conduce a questo tipo di favore? Stammi bene.
1. Uomo politico, giurista e scrittore, fu console nel 105, proconsole in Asia nel 94. Accusato di concussione, venne esiliato. 2. Combatté contro Giugurta, meritandosi il soprannome di Numidico. Nemico di Mario, nel 100 a.C. fu costretto all’esilio e richiamato in patria l’anno dopo. 3. È Gaio Mucio Cordo, soprannominato Scevola, il mancino, perché si bruciò volontariamente su un braciere la mano destra, avendo fallito il tentativo di uccidere Porsenna, il re etrusco che assediava Roma (VI sec. a.C.). 4. È Quinto Cecilio Metello Pio Scipione, figlio di Publio Cornelio Scipione Nasica, discendente dall’Africano, il vincitore di Annibale, e dell’Emiliano, il conquistatore di Cartagine. Parteggiò per Pompeo, di cui fu collega nel consolato (52 a.C.), e, sconfitto a Tapso, si suicidò. 5. Mitico re dei Lapiti, tentò di sedurre Giunone, ma Giove lo ingannò dando a una nuvola l’aspetto della dea. Da quel connubio nacquero i Centauri. 6. Figlio di Eolo e fondatore di Corinto, riuscì a incatenare la morte. 7. Il cane a tre teste. Guardiano dell’Ade. 8. Lucilio il Giovane. 9. Epicuro. 10. I nove lirici sono: Alceo, Saffo, Anacreonte, Alcmane, Stesicoro, Ibico, Simonide, Bacchilide, Pindaro. 11. Virgilio, Eneide III 72. 12. Virgilio, Eneide VI 78-79: è la Sibilla cumana. 13. Sono i Trenta eletti alla fine della guerra del Peloponneso per elaborare una nuova costituzione. Furono chiamati tiranni per il loro governo reazionario e dispotico. 14. Personaggio a noi sconosciuto. 15. Diogene, di Sinope, fondò la setta cinica, che non fu propriamente una scuola, i cui adepti, chiamati cinici da kuvwn, cane, vagavano di città in città predicando il ritorno alla natura. 16. Forse Aristone di Alessandria (I sec. a.C.), che passò dall’Accademia alla Scuola peripatetica. 17. Mamerco Emilio Scauro, avvocato e oratore del tempo di Tiberio: accusato di lesa maestà si suicidò
insieme con la moglie. 18. Giulio Grecino, padre dell’Agricola di cui Tacito scrisse la vita, era un eccellente oratore e scrittore: inviso a Caligola, fu da lui condannato a morte.
Libro quarto 30. Ho visto Aufidio Basso, 1 uomo eccellentissimo, malridotto e in lotta con l’età, la quale ormai lo grava a tal punto da rendergli impossibile risollevarsi: la vecchiaia gli sta addosso con tutto il suo grande peso. Sai che ha sempre avuto un corpo debole e smunto: l’ha sostenuto a lungo, anzi, per meglio dire, lo ha rabberciato, poi, improvvisamente, è crollato. Come in una nave che imbarca acqua si può rimediare tappando una o due falle, ma quando lo scafo comincia a cedere e ad aprirsi in diversi punti non si può più porre rimedio all’imbarcazione che si avvia inevitabilmente verso lo sfascio, così anche un corpo vecchio e debole si può tenere in piedi e puntellare sino a un certo punto. Quando tutte le giunture si aprono, come in un edificio fatiscente, e mentre se ne ripara una se ne squarcia un’altra, bisogna cercare il modo di venirne fuori. Per fortuna il nostro Basso è di spirito vivace, un dono, questo, della filosofia, che consente di essere sereni di fronte alla morte, lieti e forti in qualunque condizione fisica, e di non perdersi d’animo anche se vengono meno le forze del corpo. Un pilota esperto naviga pure con le vele a brandelli e se ha perso tutta l’armatura continua a seguire la rotta con quel che resta della nave. Così fa il nostro Basso, e guarda alla sua fine con uno spirito e un volto che potrebbero sembrare troppo tranquilli persino per uno che osservasse la morte di un estraneo. È una grande lezione, questa, caro Lucilio, che va imparata e assimilata per lungo tempo: andarsene con animo, sereno quando giunge l’ora fatale. Altri annunci di morte lasciano qualche speranza: da una grave malattia si può guarire, un incendio può spegnersi, un crollo talvolta lascia indenni persone che sembrava dovesse travolgere, il mare vomita sani e salvi dei naufraghi con la stessa violenza con cui li aveva inghiottiti, vi sono soldati che ritraggono la spada dal collo di chi stavano per trafiggere, ma nulla può contro la morte colui che vi è trascinato dalla vecchiaia; a una fine simile non c’è opposizione che tenga. Ma non c’è morte più dolce né più lungamente distribuita nel tempo. Mi è parso come se il nostro Basso assistesse al suo funerale e alla sua sepoltura e poi continuasse a vivere quasi superstite a sé stesso, sopportando da saggio la propria perdita. Parla molto, infatti, della morte e si sforza di convincerci che se in questa faccenda c’è qualcosa di spiacevole o di pauroso la colpa è solo di chi muore, poiché nella morte, come anche dopo, non c’è alcun dolore. Temere ciò che non potrà far male è come temere ciò che non si avvertirà. O forse qualcuno crede che sentirà la morte, quando per merito suo non sentirà più niente? «Quindi», conclude Basso, «la morte è così al di fuori da ogni male da essere anche al di fuori da ogni paura». Io so bene che questi concetti sono stati ripetuti spesso, e devono esserlo sempre, ma quando li leggevo o li ascoltavo da chi appunto sosteneva che non bisogna temere la morte – e però ne era lontano – non mi hanno mai giovato [come invece mi è accaduto con Basso], il quale è per me doppiamente autorevole, perché parla della sua fine ormai vicina. Ti dirò come la penso: per me fra due che si mostrano coraggiosi di fronte alla morte lo è di
più chi sta per morire che non chi è prossimo alla fine. La morte imminente, infatti, dà anche a uomini ignoranti il coraggio di affrontare l’inevitabile: il gladiatore, che durante tutto il combattimento ha avuto paura, alla fine offre la gola all’avversario e dirige contro di sé la spada, anche se incerta; mentre la morte vicina, che non sai esattamente quando ti arriverà, per essere affrontata con coraggio richiede in chi l’aspetta una lunga preparazione e una grande forza d’animo, che è molto rara e che soltanto il saggio può dimostrare. Perciò ascoltavo Basso molto volentieri, come se esprimesse un giudizio sulla morte e ne indicasse la vera natura avendola osservata molto da vicino. Certo, daremmo maggior credito alla testimonianza autorevole di uno che, resuscitato, ci confermasse per esperienza diretta che nella morte non c’è alcun male, ma il turbamento che provoca il sopraggiungere della morte potrebbero descrivertelo benissimo coloro che le sono stati vicino, che l’hanno vista arrivare e l’hanno accolta. Tra questi possiamo includere Basso, che non ha voluto deluderci. Egli dice che chi teme la morte è altrettanto stolto di chi teme la vecchiaia; infatti, come la vecchiaia segue la giovinezza così la morte segue la vecchiaia. Chi non vuole morire è come se non volesse vivere, visto che la vita è condizionata alla morte, verso la quale tutti ci avviamo. Per questo è da pazzi temerla, perché si può temere solo ciò che è incerto, mentre ciò che è certo dobbiamo solo aspettarlo. Come ci si può lamentare di trovarsi in una condizione che è comune a tutti, quando la morte è una necessità naturale e incontrastabile? Il primo requisito della giustizia è l’eguaglianza. Non serve dunque assumere la difesa della natura, dato che ci ha sottoposti alla sua legge stessa, non ad altra: essa distrugge ciò che ha messo insieme e rimette insieme ciò che ha distrutto. Se a un vecchio è toccato in sorte di uscire dalla vita a poco a poco, non bruscamente, ma in modo da allontanarsene via via, costui non deve ringraziare tutti gli dèi perché, ormai sazio e soddisfatto, è condotto a quel riposo, necessario e gradito a chi è stanco? Non vedi che alcuni desiderano e chiedono la morte più intensamente di quanto di solito si chiede la vita? Io non so se ci diano maggior coraggio coloro che implorano la morte o coloro che l’aspettano sereni e tranquilli, poiché il primo caso talvolta nasce da furore o da sdegno improvviso, l’altro da una lunga e ponderata riflessione. C’è chi va incontro alla morte pieno d’ira e di rabbia, mentre solo chi si è preparato a lungo a quell’evento l’accoglie serenamente quando giunge. Ti confesso di essere andato molto spesso da Basso, uomo a me caro per parecchi motivi, per vedere se ogni volta si trovasse nel medesimo stato d’animo, o se insieme alla sua forza fisica diminuisse anche il suo vigore spirituale, il quale invece andava aumentando via via, come cresce l’esultanza degli aurighi quando, al settimo giro, si avvicinano alla vittoria. Sulla scia degli insegnamenti di Epicuro, mi diceva che innanzitutto sperava di non provar dolore nel momento del trapasso, ma che se mai l’avesse provato, essendo di breve durata già per questo avrebbe avuto in sé un qualche sollievo, visto che nessun dolore intenso dura a lungo. D’altra parte, anche se il momento della separazione
dell’anima dal corpo fosse stato doloroso lo avrebbe confortato il pensiero che dopo quella sofferenza non avrebbe più potuto soffrire. Era convinto, poi, che essendo l’anima di un vecchio ormai a fior di labbra si staccasse dal corpo con un piccolo strappo. «Il fuoco», diceva, «quando raggiunge materiali infiammabili bisogna spegnerlo con l’acqua e a volte abbattendo tutto, mentre se gli manca l’alimento si estingue spontaneamente». Queste parole, Lucilio mio, le ascolto sempre volentieri, non perché mi giungano nuove ma perché mi pongono direttamente di fronte alla realtà. E dire che ne ho visti molti togliersi la vita, ma per me è più credibile chi arriva alla morte e l’accoglie senza odiare la vita che non chi, invece, se la tira addosso. Basso, poi, diceva anche che quel tormento lo sentiamo per colpa nostra, perché, temendo che la morte ci sia vicina, ci lasciamo prendere dall’agitazione: ma a chi mai non è vicina la morte, sempre pronta ad afferrarlo in ogni luogo e in ogni momento? «Quando ci sembra che si avvicini un qualche pericolo di morte», diceva Basso, «pensiamo quanto ci siano più vicini altri pericoli di cui non abbiamo paura». Un tale era minacciato di morte da un suo nemico, e invece morì di indigestione. Se volessimo analizzare le cause della nostra paura scopriremmo che sono diverse da quelle che sembrano. Abbiamo paura non della morte, ma del pensiero della morte; dalla morte siamo sempre ugualmente lontani. Perciò, se la morte va temuta, bisogna temerla sempre, visto che non c’è istante della vita che ne sia esente. Ma poiché temo che lettere così lunghe tu finisca per odiarle più della morte, arrivo alla conclusione: pensa sempre alla morte per non temerla mai. Stammi bene. 31. Riconosco il mio Lucilio: comincia a mostrarsi quale aveva promesso. Continua a seguire quell’impulso dell’animo con cui, calpestati i beni cari alla massa, ti sei diretto verso i più alti: non desidero che tu divenga più grande o migliore di quanto hai cercato di essere. Le tue radici sono molto estese: manda a effetto quanto hai intrapreso e metti in atto i tuoi propositi. In poche parole, raggiungerai la saggezza solo se diverrai sordo ai rumori del mondo. Ma non basta che ti tappi gli orecchi con la cera: a te occorre un materiale ben più solido di quello imposto da Ulisse ai suoi compagni: le voci che temeva l’eroe greco erano allettanti ma provenivano da un punto solo e non da una moltitudine di persone, mentre queste che dobbiamo temere noi risuonano non da uno scoglio ma da ogni angolo della terra. Non devi oltrepassare un unico luogo sospetto per il pericoloso piacere che promette, ma tutte le città. Non ascoltare neppure le persone che ti amano di più, poiché, nonostante le loro buone intenzioni, ti prospettano un danno, anzi, se vuoi essere felice, prega gli dèi che non ti accada nulla di quanto esse ti augurano. Non sono infatti beni veri quelli di cui costoro vogliono colmarti: uno solo è il bene, causa e sostegno della felicità, la fiducia in sé stessi. Ma questa non si realizza se non si è disprezzato il vano affaccendarsi, relegandolo fra quelle cose che non sono né buone né cattive: non è possibile, infatti, che una medesima cosa ora sia cattiva, ora sia buona, ora
lieve e tollerabile, ora terribile. L’affaccendarsi non è un bene, dunque, è un bene il disprezzo dell’affaccendarsi. Ecco perché io biasimerò sempre coloro che si dànno da fare inutilmente, mentre ammirerò chi tende alla virtù, impegnandosi al massimo e poco o nulla concedendo all’abbattimento o al riposo, e gli griderò: «Bravo! Alzati, respira e supera questo pendio, tutto d’un fiato, se puoi». La fatica nutre gli animi nobili. Non c’è dunque motivo perché tu scelga ciò che vuoi che ti accada e ciò che desideri in base a quel vecchio voto dei tuoi genitori: è vergognoso per chi ha già raggiunto le più alte mete importunare ancora gli dèi. Che bisogno c’è di preghiere? Renditi felice da te stesso, e tale ti renderai se comprenderai che sono beni quelli a cui è unita la virtù, mali quelli a cui è unito il vizio. Come non c’è cosa che risplenda senza la luce, com’è oscuro solo ciò che sta nelle tenebre o che ha preso su di sé qualcosa dell’oscurità, come alcunché di caldo non può esserci senza il fuoco e di freddo senza l’aria, così l’unione con la virtù o con il vizio rende le azioni oneste o disoneste. Cos’è dunque il bene? La giusta conoscenza delle cose. E il male? L’ignoranza di esse. Il saggio, prudente ed esperto com’è, respinge o sceglie ogni cosa secondo le circostanze, e, poiché ha un animo grande e invincibile, non teme ciò che respinge e non prova ammirazione per ciò che sceglie. Non voglio che tu ti arrenda e ti avvilisca. Non basta non respingere la fatica: bisogna cercarla. «E come?», mi domandi. «Non è un male una fatica futile e superflua, motivata da cause meschine?». Non più di quella che s’impiega in nobili azioni, poiché è la pazienza stessa che si esorta a compiere azioni aspre e difficili, e dice: «Perché ti fermi? Non è da uomo temere il sudore». E affinché la virtù sia perfetta bisogna che a ciò si aggiungano uniformità di pensiero e una condotta di vita coerente in tutte le cose, il che è impossibile se mancano la conoscenza della realtà e il possesso di quell’arte, la filosofia, attraverso la quale è possibile avere una chiara comprensione non solo delle cose umane ma anche di quelle divine. Ecco, questo è il sommo bene, e se lo raggiungi cominci a essere compagno degli dèi, non più uno che si rivolge a loro implorandone l’aiuto. «E come vi si arriva?», mi domandi. Non attraverso montagne impervie come le Alpi Graie o le Pennine, e neppure attraverso i deserti della Candavia;2 né devi affrontare le difficili Sirti3 e tanto meno Scilla o Cariddi: ostacoli di tal genere hai dovuto superarli per procurarti il tuo piccolo impiego; la strada verso la saggezza, invece, è sicura, piacevole, per giunta, e la natura stessa ti ha fornito i mezzi per intraprenderla, ti ha dato qualità che, se saprai farle fruttare, ti innalzeranno alla pari di dio, mentre il denaro non può renderti uguale a lui, poiché dio non possiede alcunché. E neppure la toga pretesta4 può renderti uguale a lui, poiché dio è nudo, né la fama, l’ostentazione o la notorietà del tuo nome fra i popoli: nessuno conosce dio, molti ne dànno un giudizio errato e irriflessivo. Nemmeno una turba di schiavi che portano la tua lettiga per le strade della città o di paesi lontani possono farti simile a dio: è lui, l’essere più grande e più potente, che porta tutte le cose. Neppure la bellezza e la forza possono renderti felice, poiché nessuno di questi beni resiste alla
vecchiaia. Bisogna cercare un bene che non si deteriori giorno dopo giorno, che non conosca ostacoli. Qual è questo bene? L’animo, ma l’animo retto, grande e onesto. E come potresti chiamarlo altrimenti se non un dio che dimora nel corpo umano? Tale animo può trovarsi tanto in un cavaliere romano quanto in un liberto o in uno schiavo. Cosa sono, infatti, un cavaliere romano, un liberto o uno schiavo? Nomi nati dall’ambizione o dall’ingiustizia. Si può balzare in cielo anche dall’angolo più remoto della terra: innalzati e renditi anche tu degno di un dio.5 Ma non con l’oro o con l’argento, poiché da questi metalli non si può tirar fuori un’immagine che somigli alla divinità. Pensa che gli dèi, quando ci erano propizi, erano fatti di creta. Stammi bene. 32. Chiedo tue notizie a tutti coloro che vengono dalla Sicilia e cerco di sapere cosa fai, dove stai e con chi. Non puoi ingannarmi, dunque, perché io sono con te. Comportati come se io ti sentissi e addirittura vedessi quel che fai. Vuoi sapere cosa mi è più gradito in ciò che sento su di te? Il fatto che la maggior parte di coloro a cui chiedo non sanno cosa fai: non avere rapporti con chi ha indole e aspirazioni diverse da noi è un grandissimo vantaggio. Sono certo che nessuno potrà mai distoglierti dalla retta via e che tu persevererai nei tuoi propositi, anche se sei circondato da una massa di gente che cerca di corromperti. Voglio dire, non ho paura che possano cambiarti, temo solo che ti creino ostacoli: ci danneggia, infatti, anche chi soltanto ci fa perdere tempo, soprattutto perché la vita è breve, e noi l’accorciamo ancora di più con la nostra incostanza, dandole ora un indirizzo, ora un altro: così la spezzettiamo in tante piccole parti e la sciupiamo. Affrettati, dunque, Lucilio carissimo, e pensa quanto accelereresti il passo se il nemico ti incalzasse alle spalle, se temessi l’arrivo della cavalleria all’inseguimento dei fuggiaschi. Ed è proprio questo che avviene: sei incalzato; affrettati e fuggi, mettiti al sicuro e pensa quanto sia bello portare a compimento la propria vita prima che sopraggiunga la morte, e poi aspettare serenamente il tempo che rimane, senza desiderare nulla per sé, nel pieno possesso di un’esistenza serena, che non diventa più serena se dura di più. Oh, felice quel giorno in cui ti renderai conto che il tempo non ti riguarda, in cui sarai tranquillo e beato, incurante del domani e pienamente pago di te stesso! Vuoi sapere che cosa rende gli uomini avidi del futuro? Il fatto che nessuno è padrone di sé stesso. I tuoi genitori hanno desiderato ben altri beni per te; io, invece, desidero che tu disprezzi quei beni che essi ti augurano in abbondanza. I loro voti spogliano molti per arricchire te; tutto ciò che vogliono darti dev’essere pur tolto a qualcuno. Al contrario io voglio che tu eserciti la facoltà di disporre di te stesso, sì che la tua mente agitata da pensieri volubili si fermi e stia salda, sia soddisfatta di sé stessa e, riconosciuti i veri beni, che si
possiedono appena se ne prenda atto, non senta il bisogno di prolungare la vita. Chi continua a vivere dopo aver portato a compimento la propria esistenza, ha ormai superato tutte le necessità ed è completamente libero e indipendente. Stammi bene. 33. Tu vuoi che anche in queste lettere, come nelle precedenti, io inserisca qualche massima dei nostri maestri, i quali propriamente non si sono occupati di sentenze, ma in tutta la loro opera hanno infuso un vigore particolare. Dove si notano concetti che spiccano sugli altri non c’è omogeneità: in un bosco un solo albero non può essere oggetto di ammirazione, quando tutti sono cresciuti alla medesima altezza. Di frasi simili sono piene la poesia e le opere storiche, perciò non voglio che tu attribuisca a Epicuro quelle massime, che invece appartengono a tutti e soprattutto a noi stoici. Sennonché in lui risaltano di più perché sopraggiungono di rado e inaspettate, e anche perché sorprende che queste espressioni virili siano state pronunciate da un uomo che professa la rilassatezza dei costumi. Così, infatti, lo giudicano i più: per me, invece, Epicuro è virile anche se indossa un vestito dalle lunghe maniche come le donne; il coraggio, l’operosità e lo spirito combattivo si trovano tanto nei Persiani quanto negli uomini che indossano abiti succinti. Non c’è ragione, dunque, che tu mi chieda massime scelte e frasi ripetute: nei nostri filosofi è continuo ciò che negli altri si trova qua e là. Non abbiamo, per dire, oggetti che saltano all’occhio, e non inganniamo il compratore, il quale, una volta entrato, troverà solo gli articoli che sono in mostra sulla facciata del negozio, e noi gliene lasciamo prendere un esemplare dove vuole. Supponi che noi vogliamo estrapolare singole massime da tutto l’insieme: a chi le attribuiremo? A Zenone, a Cleante, a Crisippo, a Panezio,6 a Posidonio?7 Non siamo sotto un re: ciascuno rivendica i propri diritti. Presso gli epicurei, invece, ciò che han detto Ermarco o Metrodoro viene attribuito a uno solo, perché tutto il pensiero di quella comunità è stato espresso sotto la guida e gli auspici di una sola persona. Noi, anche se ci provassimo, non possiamo da una così grande quantità di concetti dello stesso valore estrarne qualcuno: È il povero che conta le sue pecore.8 Dovunque ti capiterà di leggere incontrerai pensieri che spiccherebbero se non si trovassero in mezzo ad altri di uguale importanza. Abbandona dunque la speranza di poter gustare per sommi capi le opere d’ingegno dei più grandi scrittori: devi esaminarle e giudicarle nel loro insieme. Il pensiero procede con continuità e l’opera dell’ingegno è concatenata nelle sue linee fondamentali, talché nulla può essere tolto senza che crolli l’intero edificio. Io non t’impedisco di prendere in considerazione le singole membra una per una, purché tu non perda di vista l’individuo: bella non è la donna di cui si lodano le braccia o le gambe, ma quella il cui aspetto nell’insieme distoglie dall’ammirare le singole
parti. Tuttavia, se me lo chiederai, non sarò con te così meschino da rifiutarmi, ma ti darò sentenze a piene mani: grande, infatti, è la quantità di massime che si trovano sparse qua e là; basterà prenderle, senza bisogno di sceglierle, visto che non spuntano di tanto in tanto, ma scorrono con continuità, ininterrotte e collegate fra loro. Non dubito che servano molto alle persone ancora incolte e che ascoltano come dall’esterno: singoli pensieri circoscritti e racchiusi in forma poetica si imprimono più facilmente, ed è per questo che ai fanciulli facciamo imparare a memoria le massime e quelle che i Greci chiamano chreiai,9 perché la mente dei fanciulli le può comprendere, mentre non capirebbe ancora concetti più difficili. Ma per un uomo maturo è vergognoso andare in cerca di fiorellini e fissarsi su pochissime e notissime massime, basandosi sulla memoria: ormai deve appoggiarsi su sé stesso. Esprima con parole sue concetti del genere, invece di impararli a memoria. È riprovevole per un vecchio o per uno ormai prossimo alla vecchiaia avere un sapere fondato su un elenco di appunti. «Questo l’ha detto Zenone»: e tu cosa dici? «Questo l’ha detto Cleante». Fino a quando ti muoverai sotto la guida di un altro? Assumi tu il comando e tira fuori pensieri degni di essere imparati a memoria, ma siano qualcosa di tuo. Perciò tutti costoro, mai autori ma solamente interpreti, nascosti all’ombra degli altri, a mio giudizio non hanno niente di buono, né hanno mai osato fare una buona volta ciò che per tanto tempo avevano imparato. Hanno esercitato la memoria su opere altrui; ma altro è ricordare, altro è sapere. Ricordare è custodire concetti affidati alla memoria, mentre sapere è fare propria ogni cosa, non dipendere da un modello e non citare sempre il maestro. «Questo l’ha detto Zenone, questo Cleante». Deve esserci una differenza fra te e un libro. Fino a quando imparerai? Insegna pure, ormai. Perché dovrei ascoltare ciò che posso leggere? «La viva voce fa più effetto», dirai. Non se si prendono in prestito le parole altrui fungendo da segretario. Aggiungi che costoro, i quali non diventano mai autonomi, seguono le opinioni dei filosofi precedenti anche nelle questioni sulle quali tutti si sono dissociati dal primo e poi in quelle sulle quali ancora si indaga. Ma se ci si accontenta di quanto è già stato scoperto non si troverà mai nulla di nuovo, per non dire che chi segue pedissequamente le orme di un altro come non trova non cerca. Dunque non devo seguire le orme dei predecessori? Non dico di no: percorrerò la strada vecchia, ma se ne scoprirò una più breve e più piana cercherò di aprire quella. Quelli che prima di noi hanno mosso questi problemi non sono nostri padroni, sono nostre guide. La verità è aperta a tutti; nessuno se n’è ancora impossessato; gran parte di essa è stata lasciata da scoprire anche ai posteri. Stammi bene. 34. Sono fiero ed esulto, e toltami di dosso la vecchiaia riprendo vigore ogni volta che da quello che fai e che scrivi comprendo quanto tu abbia superato te stesso – la massa, infatti, l’hai già lasciata indietro da tempo. Se l’agricoltore è contento quando un albero produce i frutti, se il pastore gioisce per i piccoli nati del suo gregge, se uno, guardando il figlio che ha allevato, si considera giovane
come lui, cosa pensi che provi chi ha educato un discepolo e dopo averlo plasmato quand’era ancora tenero lo vede improvvisamente maturo? Ebbene io ti rivendico come mio, perché sei opera mia. Quando ho capito quale fosse il tuo carattere ti ho preso sotto la mia tutela, ti ho esortato, spronato, non ho lasciato che tu procedessi lentamente ma ti ho incitato in continuazione; e ora faccio lo stesso, ma ormai incito uno che già corre e che a sua volta incita me. «Ma che dici?», ribatti. «Finora ho mostrato solo di avere buona volontà». Questo è già molto, ma non nel senso in cui si dice che chi ben comincia è alla metà dell’opera, è una questione d’animo, come dire che gran parte della bontà consiste nel voler diventare buono. E sai tu chi definisco buono? L’uomo perfetto, completo, che nessuna forza, nessuna necessità può rendere malvagio. Ebbene, io sono certo che diverrai tale, se persevererai, t’impegnerai e farai in modo che tutte le tue azioni e le tue parole siano coerenti, conformi e con un’impronta unica. Non segue la retta via quell’animo le cui azioni sono in contrasto fra loro. Stammi bene. 35. Quando ti prego con tanta insistenza di dedicarti allo studio lo faccio per me: voglio avere un amico, il che non può accadermi se tu non continui, come hai cominciato, a coltivare te stesso. Ora, infatti, mi ami, ma non mi sei amico. «Come?», mi chiedi. «Amore e amicizia sono due cose diverse?». Certo, anzi, completamente dissimili. Chi è amico ama; chi ama non sempre è amico; perciò, l’amicizia giova sempre, mentre l’amore talvolta può anche nuocere. Cerca dunque di fare progressi, se non altro per imparare ad amare davvero. Sbrigati, affinché i tuoi progressi siano utili a me e tu non impari per un altro. Io ne raccolgo già i frutti, quando penso che noi saremo un’anima sola e tutto il mio vigore che se n’è andato col tempo mi verrà restituito dai tuoi anni, anche se fra noi non c’è molta differenza di età; ma voglio essere contento anche di come stanno ora le cose. Dalle persone che amiamo, anche se sono lontane, ci viene una gioia, ma effimera e leggera: la vista, la presenza e i rapporti diretti dànno un piacere vivo, specialmente se la persona che ci sta davanti è non solo quella che vogliamo ma anche come la vogliamo. Perciò vieni da me, mi farai un immenso regalo, e per essere più sollecito pensa che tu sei mortale e io sono vecchio. Affrettati verso di me, ma prima verso di te. Cerca di migliorarti e per prima cosa preoccupati di essere coerente con te stesso. Ogni volta che vuoi constatare se hai fatto qualche progresso guarda se oggi vuoi le stesse cose di ieri: il cambiamento di volontà, infatti, indica che l’animo è incerto, si mostra ora qua ora là, a seconda di come lo porta il vento. Ciò che è saldo e ha buone fondamenta non va di qua e di là: è la prerogativa del perfetto saggio, e, in certa misura, anche di chi avanza e fa progressi. Qual è dunque la differenza fra i due? Il secondo è scosso, ma non si muove, ondeggia restando al suo posto, il primo non è neppure scosso. Stammi bene. 36. Esorta il tuo amico a disprezzare coraggiosamente quelli che lo
rimproverano perché si è ritirato all’ombra di una vita contemplativa, abbandonando la sua brillante posizione e, pur potendo arrivare più in alto, ha preferito a tutto la tranquillità: mostri loro ogni giorno di aver fatto bene i suoi calcoli. Coloro che sono oggetto d’invidia non cesseranno mai di scomparire: alcuni saranno eliminati, altri cadranno. La prosperità non dà una pace stabile e sicura, si tormenta da sé, turba la mente in vari modi, spinge gli animi a passioni diverse, quali verso la sete di potere, quali verso il lusso; rende tronfi gli uni, snerva e infiacchisce completamente gli altri. «Ma qualcuno la regge bene», dirai. Sì, come il vino. Perciò non farti convincere da costoro che è felice chi è attorniato da molta gente, perché accorrono da lui come si corre a una sorgente, che intorbidano ed esauriscono. «Lo chiamano inetto e buono a nulla». Sai che certi parlano a rovescio e dànno alle parole il significato opposto. Lo dicevano felice: e allora? Lo era veramente? E non mi preoccupo neppure del fatto che ad alcuni sembra troppo duro e severo. Aristone 10 diceva di preferire un giovane serio a uno allegro e benvoluto dal volgo; il vino che da nuovo sembra acerbo e asprigno diventa buono, mentre quello che è gradevole fin dalla botte non regge all’invecchiamento. Lascia pure che lo chiamino triste e nemico dei propri successi: quando sarà vecchio la sua tristezza gli sembrerà un fatto positivo, sempre che insista nel coltivare la virtù e assimili gli studi liberali, non quelli in cui basta avere un’infarinatura, ma quelli che t’impregnano lo spirito. È questo il tempo d’imparare. «Come? C’è un tempo in cui non bisogna imparare?». No; ma se è giusto studiare a ogni età, non va bene andare sempre a scuola. È sconveniente e ridicolo un vecchio che faccia ancora lo scolaretto: la scienza si apprende da giovani, da vecchi la si esercita. Ti sarà dunque molto utile se renderai il tuo amico quanto più preparato possibile: i benefìci da ricercare e da ricevere, che appartengono indubbiamente alla specie migliore, sono quelli ch’è utile sia fare che ricevere. Infine, il tuo amico non è più libero poiché ha dato la sua parola, ed è meno vergognoso mancare di parola verso un creditore che deludere una buona speranza. Il commerciante ha bisogno di una navigazione propizia per poter pagare i suoi debiti, l’agricoltore della fertilità del terreno che coltiva e di un clima favorevole, mentre al tuo amico serve solo la volontà per saldare quanto deve: la sorte non ha alcun diritto sulla condotta morale. Si comporti in modo che il suo animo raggiunga la perfezione con la massima tranquillità possibile, uno stato in cui non ci si accorge se ci viene tolto o dato alcunché, poiché comunque vadano le cose la disposizione d’animo non muta: chi è perfetto è al di sopra di qualunque bene gli si possa aggiungere che sia gradito alla massa e se il caso gliene toglie alcuni o anche tutti non per questo si sentirà sminuito. Se il tuo amico fosse nato fra i Parti, fin da bambino tenderebbe l’arco, se fosse nato fra i Germani fin da fanciullo scaglierebbe l’asta flessibile, se fosse vissuto ai tempi dei nostri avi avrebbe imparato a cavalcare e a colpire il nemico combattendo corpo a corpo. È il modo di vivere della propria gente a consigliare e comandare agli individui queste attività. Dunque, su cosa deve meditare costui? Su ciò che è utile contro ogni arma e contro ogni genere di
nemici e disprezzare la morte: che essa abbia in sé qualcosa di terribile che offende il nostro animo amante per natura di sé stesso nessuno lo mette in dubbio; non ci sarebbe infatti alcun bisogno di prepararsi e allenarsi di fronte a un evento incontro al quale ci spinge un impulso volontario, così come tutti sono portati spontaneamente alla propria conservazione. Nessuno impara a starsene tranquillamente disteso sopra un letto di rose, se ce ne fosse la necessità, ma ci si esercita affinché le spine, i tormenti, non pieghino la fiducia in noi stessi, per abituarsi a vegliare, se serve, restando in piedi, magari anche feriti, a difesa della trincea, senza appoggiarsi neppure al giavellotto, perché il sonno suole cogliere di sorpresa chi si appoggia a un qualsiasi sostegno. La morte non arreca alcun danno, visto che una cosa per provocare un danno deve esistere. Se proprio hai un così grande desiderio di vivere più a lungo consolati pensando che nessuna delle creature che scompaiono dal nostro sguardo, e disfacendosi si celano in seno alla natura dalla quale sono uscite e da cui usciranno nuovamente in altra forma, va distrutta: tutte vengono meno, non vanno perdute, perché la morte, che tanto temiamo e cerchiamo di allontanare, non toglie la vita, la interrompe, finché torna il giorno che ci riporta alla luce, e quel giorno molti lo rifiuterebbero se dovessero tornare in vita con la medesima coscienza di prima e memori del loro passato. Più avanti ti dimostrerò dettagliatamente che tutto ciò che sembra perire in realtà muta soltanto. Ora, se uno è destinato a ritornare deve uscire dalla vita con animo sereno: segui il corso degli astri, che ritornano sulla loro via e vedrai che in questo mondo nulla si estingue e che, con vece alterna, tutto declina e rinasce. L’estate se n’è andata, ma il prossimo anno la ricondurrà con sé; l’inverno è terminato, ma i mesi a lui destinati lo riporteranno; la notte ha nascosto il sole, ma presto il giorno la scaccerà. Gli astri nel loro corso ripercorrono i luoghi già attraversati; ininterrottamente una parte del cielo si solleva, una parte sprofonda. Concluderò la lettera aggiungendo questa sola osservazione: né i bambini né i fanciulli né i pazzi temono la morte, dunque sarebbe una vergogna se la ragione non fosse in grado di darci quella serenità interiore a cui conduce l’assenza di raziocinio. Stammi bene. 37. Hai promesso di essere un uomo virtuoso, impegnandoti con un giuramento, e questo è il vincolo più grande per ottenere una mente saggia e onesta. Se qualcuno ti dicesse che è un’impresa lieve e facile ti prenderebbe in giro. Non voglio che tu sia ingannato. Le parole di questo giuramento, che è il più nobile, sono identiche a quelle pronunciate dai gladiatori nella loro solenne promessa, che è il più infame dei giuramenti: «lasciarsi bruciare, incatenare e uccidere dalla spada». Ebbene, mentre da quelli che prestano la propria opera nell’arena e mangiano e bevono quanto poi restituiranno col sangue si pretende che patiscano tali tormenti anche controvoglia, da te si chiede che li sopporti volontariamente e di buon grado. A loro è concesso abbassare le armi e invocare la pietà del popolo, tu non potrai né abbassare le armi né implorare la grazia
della vita: devi morire in piedi e invitto. A che serve poi guadagnare pochi giorni o pochi anni? Siamo tutti nati per combattere, e senza tregua. «Come, dunque, potrò cavarmi d’impaccio?», mi chiedi. Non puoi sottrarti alla legge della necessità, ma puoi vincerla. Ci si apre la strada con la forza,11 e questa te la indicherà la filosofia. Rifugiati in lei, se vuoi essere salvo, tranquillo, felice e, ciò ch’è più importante, libero: non c’è altro modo per riuscirvi. La stoltezza è una cosa meschina, ignobile, sordida, da schiavi, e soggetta a molte e ferocissime passioni. La saggezza, che è l’unica vera libertà, allontana da te questi padroni così duri, che comandano a volte a turno a volte tutti insieme. Unica e dritta è la strada che conduce alla saggezza; non puoi sbagliare: procedi con passo sicuro. Se vuoi piegare ogni cosa, sottomettiti alla ragione; guiderai molti, se la ragione ti guiderà. Da lei saprai ciò che devi fare e come; quali che siano gli eventi, non ti sorprenderai. Non puoi citarmi una sola persona che sappia come ha cominciato a volere ciò che vuole: vi è arrivato seguendo un impulso, non di proposito. La fortuna ci viene incontro tanto spesso quanto noi andiamo incontro a lei. È vergognoso farsi trascinare invece di procedere da soli, e poi, improvvisamente, in mezzo al turbine degli eventi, chiedersi meravigliati: «Come sono arrivato a questo punto?». Stammi bene. 38. Giustamente mi richiedi di intensificare questa nostra corrispondenza epistolare. Una conversazione alla buona giova moltissimo, perché si insinua a poco a poco nell’animo: le dissertazioni preparate ed esposte alla presenza del pubblico fanno più rumore, ma sono meno familiari. La filosofia è un buon consiglio ma nessuno dà un consiglio ad alta voce. Talvolta bisogna ricorrere alle cosiddette “concioni”, quando occorre stimolare una persona incerta, ma quando si vuole semplicemente che uno impari, non indurlo a imparare, bisogna far ricorso a queste parole più sommesse, che penetrano nell’animo più facilmente restandovi impresse; e non ne servono molte, basta che siano efficaci. Bisogna spargerle come un seme, che quando si trova in un terreno adatto, anche se piccolissimo, sprigiona le sue forze e si sviluppa in modo eccezionale. Lo stesso fa la ragione, che se guardi bene non appare grande, ma via via che opera va crescendo sempre di più. Sono poche le cose che si dicono, ma se l’animo le accoglie bene si rafforzano e crescono andando verso l’alto. I precetti, secondo me, sono come i semi: producono grandi effetti, pur essendo piccola cosa. Occorre solo che siano afferrati e assimilati da una mente adatta, che a sua volta produrrà molti frutti e restituirà più di quanto ha ricevuto. Stammi bene. 39. Raccoglierò gli appunti che desideri, ordinati con cura e concisi; tieni però presente che il metodo abituale è più utile di questo che comunemente si chiama breviarium, e che una volta, quando parlavamo un buon latino, si chiamava summarium: il primo, che insegna, è più necessario a chi impara, il
secondo, che richiama alla memoria, serve a chi sa già. Comunque te ne farò avere di entrambi abbondantemente. Tu non devi chiedermi questo o quell’autore, perché chi presenta un testimone è uno sconosciuto. Ti scriverò, dunque, ciò che mi chiedi, ma a modo mio; intanto hai a disposinone molti scrittori, le cui opere, però, non so se siano abbastanza ordinate. Prendi in mano l’elenco dei filosofi: già questo ti scuoterà, facendoti vedere quanti abbiano faticato per te. Tu stesso vorrai essere uno di loro: la dote migliore per un animo nobile è lo sprone verso la virtù. Un uomo d’animo elevato non si compiace di cose meschine e volgari, è attratto e innalzato dalla bellezza delle cose grandi. Come la fiamma si leva diritta nell’aria, incapace di star ferma o di abbassarsi, così il nostro animo si muove, e tanto più è mobile e attivo quanto più forte è l’impeto. Fortunato colui che questo impulso volge a nobili cose, perché riesce a sottrarsi al dominio totale della sorte! Moderato nella prosperità, attenuerà le sventure e sdegnerà ciò che per gli altri è oggetto di ammirazione. È segno di magnanimità disprezzare la grandezza e preferire la moderazione agli eccessi, poiché la prima è utile e vitale, gli eccessi, invece, nuocciono proprio perché sono superflui. Perciò una fertilità eccessiva piega le messi buttandole a terra, il troppo peso spezza i rami degli alberi, i frutti troppo abbondanti non giungono a maturazione. La stessa cosa avviene anche all’animo: una soverchia prosperità – che spesso porta a oltraggiare non solo gli altri, ma anche sé stessi – lo fiacca e lo danneggia. Non v’è nemico che rechi a uno una così grave offesa quale quella che a certe persone recano i loro stessi piaceri. Si può perdonare la loro sfrenatezza e la loro folle passione solo perché gli effetti di ciò che hanno fatto ricadono su di loro. E giustamente questo furore li tormenta, perché il desiderio che supera il limite naturale sfocia inevitabilmente nella dismisura. I desideri naturali, infatti, hanno dei loro limiti, mentre quelli vani e scaturiti dalla libidine non ne hanno. È l’utilità che dà la misura del necessario, ma la misura del superfluo qual è? Ecco perché molti si immergono nei piaceri e una volta che vi hanno preso l’abitudine non possono più farne a meno e si riducono in un ben misero stato, visto che per loro ciò che prima era superfluo è diventato necessario. Non godono dei piaceri, ne sono schiavi, e – questo è il colmo del male – amano il proprio male; l’infelicità si fa completa quando le azioni turpi non solo attraggono ma addirittura piacciono, né alcun rimedio è possibile se i vizi diventano abitudini. Stammi bene. 40. Ti sono grato perché mi scrivi spesso: mi dimostri quale sei in un modo veramente unico. In ogni lettera che ricevo mi ritrovo subito con te. I ritratti degli amici assenti, che ravvivano in noi il loro ricordo e ne alleviano la nostalgia con un conforto pur ingannevole e vano, ci sono graditi, ma quanto più ci allietano le lettere che portano le vere tracce, i segni autentici dell’amico lontano! La sensazione più dolce che proviamo al cospetto di un amico, ce la dà nella lettera l’impronta della sua mano. Scrivi di aver ascoltato il filosofo Serapione12 quando è approdato costì, in
Sicilia: «Suole ammucchiare le parole una dietro l’altra, storpiandole, con grande velocità senza, consentire loro di diffondersi in modo chiaro e preciso, ma è come se le buttasse fuori tutte insieme accavallandole: gli arrivano alle labbra troppo numerose perché possano pronunciarsi bene con un solo fiato». Beh, questo non lo approvo in un filosofo, che deve parlare in modo ordinato e composto, com’è la sua vita, e ciò che va di fretta e precipitosamente non può dirsi ordinato. Per questo Omero mette in bocca a un oratore giovane il discorrere concitato e senza interruzioni che vien giù come la neve, mentre a un vecchio attribuisce un linguaggio che scorre calmo e più dolce del miele.13 Credimi, questo tipo di eloquenza, impetuosa e straripante, si addice più a un ciarlatano che a chi tratta e insegna argomenti seri e importanti. Non dico che debba pronunciare le parole lentamente e neppure che debba correre, costringere gli ascoltatori a tendere le orecchie o a tapparsele: anche l’eloquenza povera e scarna, infatti, rende meno attenti per via della noia provocata dalla lentezza e dalle frequenti interruzioni; ma s’imprime più facilmente nell’animo una frase che si fa attendere rispetto a una che scorre velocemente. Si dice che i maestri trasmettano ai discepoli i loro insegnamenti, ma non si può trasmettere una cosa che fugge via. Inoltre, l’eloquenza che è al servizio della verità dev’essere ordinata e semplice, mentre quella rivolta al popolo non rispecchia il vero. Vuole far presa sulla folla e trascinare nel suo impeto gli ascoltatori sconsiderati, non accetta di farsi condurre, anzi, cerca di evitarlo: ma come può governare chi non può governarsi? Inoltre questo tipo di oratoria, essendo volta a sanare gli animi, deve imprimersi nel profondo. I farmaci non giovano se non dimorano a lungo nell’organismo. Quel modo di parlare, poi, è vuoto e sterile, ridonda ma non fa effetto. Ciò che deve fare la vera eloquenza è attenuare le paure, frenare gl’impulsi, dissipare gl’inganni, reprimere la lussuria, sradicare l’avidità: nulla di tutto ciò si può fare all’istante. Quale medico cura di corsa gli ammalati? E che dire del fatto che un tale strepito di parole che scorrono alla rinfusa, senza alcuna oculatezza, non produce nemmeno alcun piacere? Come la maggior parte delle cose che ritenevamo impossibili è sufficiente averle viste una sola volta, così questi oratori da strapazzo è più che sufficiente averli sentiti una volta sola. Cosa c’è da imparare o da imitare, infatti? Che pensare dell’animo di costoro che parlano in modo confuso, prolisso e senza freni? Come chi corre giù per un pendio non riesce a fermarsi nel punto stabilito, ma, soggetto al peso del corpo lanciato a gran velocità, va più lontano del voluto, così questo parlare precipitoso non ha alcun dominio su di sé e non si addice abbastanza alla filosofia, che deve disporre con ordine le parole, non buttarle fuori di getto, e procedere passo dopo passo. «Ma come?», mi dirai. «Certe volte l’eloquenza non dovrà anche salire di tono?». Perché no? Purché sia salva la dignità di comportamento, che questa forza eccessiva e violenta le toglie. Sia vigorosa, ma moderata, simile a una corrente perenne, ma non torrenziale. Se si può stentare ad ammettere in un oratore una tale velocità nel parlare, irrefrenabile e senza regole, come pensare che un giudice – ce ne sono pure di rozzi e incompetenti –
possa tenergli dietro? Anche se trascinato dalla smania di protagonismo o da una passione sfrenata, parli pure rapidamente e mangiandosi le parole ma entro i limiti di un ascolto possibile e ragionevole. Farai dunque bene a non prestare ascolto a costoro che badano più a quanto dicono che non al modo in cui lo dicono, e sarà meglio allora che tu parli come P. Vinicio. 14 «E come?». Interrogato su come parlasse costui, Asellio rispose: «Lentamente». Gemino Vario infatti diceva: «Non so come possiate definirlo eloquente: stenta a mettere insieme tre parole». E perché non dovresti preferire di parlare come Vinicio? Certo, potrebbe saltar su uno sciocco come quel tale che mentre Vinicio scandiva le parole a una a una come se dettasse gli gridò: «E parla una buona volta!». Secondo me un uomo assennato deve guardarsi bene dalla fretta di Q. Atrio, oratore famosissimo ai suoi tempi: non aveva mai un attimo di esitazione, non una pausa, come cominciava arrivava sino in fondo. Comunque penso che certe prerogative nel modo di parlare siano più o meno tipiche di questo o di quel popolo. I Greci tollerano quella libertà sfrenata, noi, invece, siamo abituati a fare delle pause anche nello scrivere. Cicerone stesso, da cui discende l’eloquenza romana, procedeva posatamente. L’oratoria latina è più critica e attenta, si controlla, valuta e si presta a essere valutata. Fabiano, uomo insigne per vita, cultura ed eloquenza, dote, questa, conseguente alle altre due, aveva un modo di discorrere spedito più che concitato, talché si poteva definirlo facilità di parola, non rapidità. In un uomo saggio è ammissibile, ma non la ritengo essenziale; tuttavia, purché proceda senza difficoltà, preferisco un discorrere normale piuttosto che precipitoso. Tanto più dunque ti esorto a tenerti lontano da questo vizio perché altrimenti corri il rischio di perdere ogni pudore: strofinati la fronte per cacciare la vergogna e smettila di ascoltarti; quella rapidità incontrollata, infatti, porta con sé molti difetti da censurare. Ripeto, quel vizio non può toccarti se mantieni integro il tuo pudore. Bisogna inoltre che ti eserciti ogni giorno e sposti l’attenzione dalle cose alle parole, le quali anche se si presentano spontaneamente e scorrono dalla bocca senza fatica alcuna, vanno sempre moderate: a un uomo saggio, infatti, si addice un’andatura alquanto composta, dunque anche il suo parlare dev’essere cauto non avventato e ridondante. In definitiva: parla lentamente. Stammi bene. 41. Fai cosa ottima e a te salutare se, come scrivi, persisti nel tendere alla saggezza, che è da stolti chiedere agli dèi, visto che puoi raggiungerla da te. Non occorre levare al cielo le mani o implorare il custode del tempio affinché ci consenta di accostarci all’orecchio della statua, come se così potessimo farci sentire meglio: dio è vicino a te, è con te, è dentro di te. Sì, Lucilio, io sono convinto che dentro di noi risiede uno spirito sacro, il quale osserva e controlla tutte le nostre azioni, quelle buone e quelle cattive, e si comporta con noi allo stesso modo in cui noi ci comportiamo con lui. Nessun uomo virtuoso, in verità, può essere tale se in lui non c’è la presenza di un dio: chi potrebbe infatti elevarsi al di sopra della sorte senza l’aiuto della divinità? È lei che ci ispira
nobili e alti princìpi. In ogni uomo virtuoso abita un dio (ma quale non si sa).15 Se ti trovi di fronte a un bosco fitto di alberi secolari dall’altezza inconsueta, che toglie la vista del cielo coi suoi rami frondosi che si estendono e s’intrecciano coprendosi l’un l’altro, quell’altezza smisurata, la solitudine del luogo e la meraviglia che suscita un’ombra così densa e ininterrotta in uno spazio aperto ti dicono che c’è un dio. Se una grotta, scavata non dalla mano dell’uomo ma da cause naturali in uno spazio piuttosto esteso, sostiene su rocce profondamente erose una montagna, il tuo animo non potrà che provare un certo senso di religioso timore. Del resto noi veneriamo le sorgenti dei grandi fiumi, innalziamo altari là dove all’improvviso erompe impetuosa dal profondo una ricca corrente, facciamo oggetto di culto le fonti di acque termali e consacriamo certi laghi per il loro colore cupo o per la loro smisurata profondità. Quando vedi un uomo imperterrito di fronte ai pericoli, libero da passioni, tranquillo nelle avversità, che contempla gli uomini dall’alto, come fanno gli dèi, non ti pervade un senso di rispetto per lui? Non ti dici: «Questa sua dote è troppo grande e troppo alta perché possa appartenere al piccolo e misero corpo in cui si trova»? Una forza divina è discesa in quest’uomo, una potenza celeste guida il suo spirito straordinario, equilibrato, che va oltre le cose esteriori, come se non contassero niente, che se la ride dei nostri timori e dei nostri desideri. Un tale essere non potrebbe mantenersi così saldo, senza l’aiuto di un dio. Perciò la parte maggiore di lui non sta qui sulla terra, ma lassù, da dove appunto è discesa. Come i raggi del sole raggiungono la terra ma restano attaccati al loro punto di partenza, così quest’animo grande e sacro, incarnatosi in noi per farci conoscere più da vicino le cose divine, dimora con noi, ma rimane unito alla sua origine: da essa dipende, a essa guarda e tende e sta in mezzo a noi ma come un essere migliore. E qual è quest’animo? Quello che risplende solo del suo proprio bene. Che c’è, infatti, di più stolto che lodare in un uomo beni non suoi? Chi è più insensato di chi ammira beni che possono passare sempre ad altri? Le briglie d’oro non rendono migliore un cavallo. Un leone dalla criniera dorata, lisciato e costretto, ormai stanco, a sopportare le bardature, ha uno slancio diverso da quello di un leone selvaggio che conserva intatto il suo vigore: di certo quest’ultimo, impetuoso nella sua furia, come lo volle la natura, splendido nel suo aspetto feroce e bello per il terrore che suscita a chi lo guarda, è preferito a quello fiacco e coperto di pagliuzze dorate. Ognuno deve vantarsi solo di ciò che gli appartiene. Lodiamo una vite se i suoi tralci sono carichi di frutti, se sotto il loro peso la pianta stessa piega fino a terra i sostegni che prima sopportava: forse qualcuno potrebbe preferire una vite da cui pendono grappoli e foglie d’oro? La virtù che distingue la vite è la fertilità, così anche nell’uomo bisogna lodare ciò che è proprio dell’uomo. Ha splendidi schiavi e una casa meravigliosa, coltiva molte terre, presta a interesse molto denaro, ma tutto ciò
sta intorno a lui, non dentro di lui. Nell’uomo devi lodare ciò che non può essergli né tolto né dato, che gli è proprio ed esclusivo. Che cos’è?, mi domandi. L’anima, e nell’anima una ragione perfetta. L’uomo, infatti, è un essere razionale, dunque il suo bene si realizza in pieno se adempie al fine per il quale è nato. E che cosa esige da lui la ragione? Una cosa facilissima: che viva secondo la sua natura. Ma la generale follia rende ciò molto difficile: ci trasciniamo l’un l’altro nei vizi. E come si può salvare chi è spinto dalla massa senza che alcuno lo trattenga? Stammi bene.
1. Storico, seguace dell’epicureismo, scrisse una storia delle guerre germaniche, sotto Tiberio, e sotto Claudio una storia dei suoi tempi. 2. Regione montuosa dell’Illiria, oggi Albania. 3. Grande e Piccola Sirte, due insenature sulla costa dell’Africa settentrionale. 4. Sopravveste listata di porpora indossata dai sommi magistrati e dai nati liberi (ingenui) sino all’età virile. 5. Virgilio, Eneide VIII 364-5. 6. Filosofo stoico nato a Rodi (185-109 a.C.), frequentò il circolo di Scipione l’Emiliano. 7. Discepolo di Panezio, fondò a Rodi una sua scuola filosofica, in cui ebbe come allievi Cicerone e Pompeo. Si occupò anche di storia e di geografia. 8. Ovidio, Metamorfosi XIII 824. 9. Il termine era usato per indicare una sentenza proposta come tema per una esercitazione retorica. 10. Aristone di Chio propugnava l’indifferenza completa dalle cose esterne. 11. Virgilio, Eneide II 494. 12. Di questo filosofo si ha notizia solo in questa lettera. 13. Cfr. Omero, Iliade III 221 e I 249, in cui si parla di Ulisse e di Nestore. 14. Retore dell’età di Augusto, come pure Asellio e Gemino Vario. 15. Virgilio, Eneide VIII 352.
Libro quinto 42. Costui ti ha già convinto di essere un uomo virtuoso? È impossibile diventarlo ed essere riconosciuto tale così presto. Sai chi intendo in questo caso per uomo virtuoso? Quello di seconda qualità, poiché quello perfetto nasce forse come la Fenice,1 una volta ogni cinquecento anni, né c’è da meravigliarsi che creature straordinarie vengano alla luce a distanza di tanto tempo: la sorte produce spesso cose mediocri e destinate alla massa, ma quelle eccezionali acquistano valore per il fatto appunto di essere rare. Ora, costui in realtà è ancora molto lontano dal livello a cui dichiara di essere arrivato: se sapesse davvero che cos’è un uomo virtuoso non si crederebbe ancora tale e forse perderebbe addirittura la speranza di poterlo diventare. «Ma ha una cattiva opinione dei malvagi», mi rispondi. Anche i malvagi, e la più grande punizione per loro sta proprio nel fatto che hanno disgusto di sé stessi e dei propri simili. «Ma il malvagio detesta chi abusa di un grande e improvviso potere». E così si comporterà egli stesso quando quel potere l’avrà raggiunto lui. I vizi di molti restano nascosti perché sono ancora deboli, ma quando questi acquisteranno vigore l’audacia di quei malvagi sarà pari a quella dei vizi che il successo avrà reso visibili. Per il momento a quella gente mancano i mezzi per mettere in pratica la malvagità. È come quando si tocca un serpente velenoso impunemente perché è irrigidito dal freddo: non è che sia privo di veleno, è semplicemente intorpidito. Ciò che manca alla crudeltà, all’ambizione e alla sfrenatezza di molti è il favore della sorte, ed è per questo che essi non osano comportarsi come i peggiori individui. Dàgli la possibilità di fare ciò che vogliono e vedrai che le loro intenzioni sono le stesse di quelle dei malvagi matricolati. Ricordi quando affermavi che un tale era in tuo potere e io dissi ch’era volubile e incostante e che tu lo tenevi non per un piede ma per un’ala? Ebbene, mi sbagliavo: lo tenevi per una piuma, che lui ha lasciato andare ed è volato via. Sai bene che brutti scherzi ti ha giocato dopo e quante cattiverie ha tentato, che sarebbero poi cadute su di lui. Non si rendeva conto, infatti, che inguaiando gli altri andava verso la sua rovina; non pensava quanto fosse gravoso, anche se non inutile, ciò a cui aspirava. Perciò dobbiamo pensare o di non trarre alcun vantaggio dalle nostre aspirazioni, che cerchiamo di realizzare anche con grande sforzo, o che sia maggiore lo svantaggio che può derivarcene: alcune, infatti, sono inutili, altre non valgono lo sforzo. Ma noi non ce ne accorgiamo e ci sembrano gratuite cose che invece paghiamo a carissimo prezzo. La nostra stupidità risulta evidente da questo: noi riteniamo che si comprino solo quelle cose per le quali sborsiamo del denaro, mentre consideriamo gratuite quelle che paghiamo sulla nostra pelle, con la nostra persona stessa. Cose che non vorremmo comprare se per averle dovessimo dare in cambio la nostra casa o un podere ameno e fecondo, siamo prontissimi a procurarcele a prezzo di preoccupazioni, pericoli e disonore, con perdita di tempo e di libertà, e ciò perché ciascuno di noi tiene meno a sé stesso
che a qualunque altra cosa. Per questo ogni volta che, in qualsiasi circostanza, dobbiamo prendere una decisione comportiamoci come quando al mercante da cui ci rechiamo per comprare qualcosa chiediamo prima il prezzo della merce che desideriamo. Spesso un oggetto per cui non si paga nulla ha un prezzo altissimo. Potrei citartene molte di cose che una volta acquisite e accettate ci hanno tolto la libertà: se non fossero venute in nostro possesso saremmo ancora padroni di noi stessi. Rifletti dunque su ciò, sia in vista di un guadagno sia nel caso di una perdita. «Ma questo bene», dici, «andrà perduto». È venuto da fuori: senza di esso potrai vivere bene ugualmente, come sei vissuto sinora. Se ne hai goduto per molto tempo, in compenso te ne sei saziato e non sarà una grande perdita, altrimenti lo perdi prima di essertici attaccato. «Avrò meno denaro». Ma anche meno guai. «Meno prestigio». E minore invidia. Se consideri quei beni, che ci portano alla follia e per la cui perdita versiamo un mare di lacrime, ti renderai conto che ciò che pesa non è la loro perdita, ma l’opinione di averli perduti. Tu credi di soffrire perché non li hai più, ma la mancanza di una cosa di per sé non può farci soffrire. Chi è pago di sé stesso non perde nulla; ma quanti sono paghi di sé stessi? Stammi bene. 43. Mi chiedi come e da chi io abbia avuto questa notizia, chi sia stato a raccontarmi i tuoi pensieri che mi dici di non aver confidato ad alcuno. È stata la voce del popolo che tutto sa «Come? Sono tanto importante da suscitare le chiacchiere della gente?». Devi considerare la tua città di residenza, Siracusa, non Roma: è da lì che vengono le chiacchiere. Ciò che emerge nell’ambiente che lo circonda è grande in quell’ambito: non esiste il grande in assoluto, è il confronto che fa apparire una cosa maggiore o minore. Un’imbarcazione che sembra grande su un fiume sul mare si rimpicciolisce; non solo, ma un timone che su una nave sembra grande su un’altra di maggior dimensione appare piccolo. Ora, tu che stai in provincia, anche se lì ti tieni in minore considerazione rispetto a Roma, sei grande. Lì la gente si interessa di te, vuole sapere cosa fai, cosa mangi, come dormi, quindi devi vivere con maggiore cautela. Considerati felice solo quando potrai vivere tranquillo in pubblico, quando le pareti serviranno a ripararti, non a nasconderti. Di solito, infatti, pensiamo che ci servano per nascondere meglio i nostri peccati non per proteggere la nostra sicurezza fisica. Voglio dirti una cosa dalla quale potrai giudicare la nostra onestà morale: difficilmente si trova una persona che in casa viva con la porta aperta. Non è la superbia che ci spinge a piazzare dei guardiani di fronte alle porte delle nostre case, è la nostra cattiva coscienza; viviamo infatti in modo tale che il solo fatto di essere visti all’improvviso è come essere colti in fallo. Ma a che giova nascondersi e sfuggire agli occhi e alle orecchie del prossimo? La buona coscienza fa notizia, richiama la gente, quella cattiva sta in ansia e si preoccupa anche in solitudine. Se le tue azioni sono oneste le sappia pure il mondo intero, se sono vergognose, e tu le conosci, che importa se non le conosce nessuno? Povero te se non ascolti questo testimone! Stammi bene.
44. Ti fai di nuovo piccolo ai miei occhi dicendo che prima la natura e poi la sorte ti hanno trattato piuttosto male, quando tu potresti benissimo emergere dalla massa e raggiungere il più alto gradino dell’umana felicità. La filosofia, fra le altre cose, ha questo di buono, non guarda alla casata di uno, perché tutti, se si risale alla loro prima origine, discendono dagli dèi. Tu sei un cavaliere romano ed è stata la tua operosità a condurti a questo gradino della scala sociale: pochi hanno diritto alle prime quattordici file2 e il senato da parte sua non accoglie tutti coloro che vi aspirano; anche nel campo militare gli uomini destinati a imprese rischiose vengono scelti attraverso un esame severo: la saggezza, invece, è accessibile a tutti, tutti possediamo a sufficienza la nobiltà d’animo per perseguirla. La filosofia porge a tutti la sua luce, non respinge e non sceglie alcuno. Socrate non era patrizio, Cleante attingeva l’acqua per il suo giardino, che irrigava egli stesso, Platone quando si diede agli studi filosofici non era un nobile, è stata la filosofia a renderlo tale. Perché dunque disperi di poter diventare uguale a loro? Sono tutti tuoi antenati, se solo cercherai di esserne degno, e lo sarai se fin da questo momento ti convincerai che non c’è persona più nobile di te. Tutti abbiamo un egual numero di antenati, la nostra origine va molto al di là di quanto noi possiamo ricordare. Per Platone non c’è re che non discenda da schiavi e schiavo che non discenda da re.3 Codesta varietà di condizioni sociali col passar dei secoli si è tutta mescolata e la fortuna ha sovvertito le categorie. Chi è nobile, in realtà? Colui che la natura ha ben disposto alla virtù. Solo a questo dobbiamo guardare, diversamente, se andiamo ai tempi antichi, non c’è alcuno che non venga da dove prima non c’è niente. Una serie alterna di splendori e di miserie ci ha condotto dalla prima origine del mondo sino ai tempi nostri. Non è un ingresso pieno di ritratti anneriti dal tempo che ci rende nobili, nessuno è vissuto per dar la gloria a noi e ciò che è stato prima di noi non ci appartiene: è l’anima che ci rende nobili, la quale da qualsiasi condizione può ergersi al di sopra della sorte. Immagina dunque di essere un liberto, non un cavaliere romano: puoi ottenere di essere il solo uomo libero fra uomini nati liberi. «Come?», mi chiedi. Se sarai in grado di distinguere il male e il bene senza seguire l’opinione del volgo. È al fine che bisogna guardare non all’origine. Se c’è una cosa che può rendere felice la vita è di per sé stessa un bene per il solo fatto che non può degenerare in un male. Allora, visto che tutti desiderano la felicità, qual è l’errore che commettiamo? Quello di confonderla con i mezzi usati per conseguirla, sicché, mentre la cerchiamo, in realtà ce ne allontaniamo. Il colmo di una vita felice consiste in una tranquillità sicura e in una fiducia immutabile in essa, e invece tutti raccolgono motivi di affanno e portano, o per meglio dire trascinano i loro bagagli attraverso l’insidioso cammino della vita, così si allontanano sempre di più dal fine a cui tendono e quanto più si ostinano tanto più si creano ostacoli e perdono terreno. La stessa cosa accade a chi pretende di correre in un labirinto: la velocità stessa lo intralcia. Stammi bene.
45. Ti lamenti che costì, a Siracusa, ci siano pochi libri. Ciò che conta non è la quantità, è il loro valore. Una lettura specifica è senza dubbio utile, mentre una varia è piacevole, ma per arrivare dove si è stabilito bisogna seguire una sola via, non andare di qua e di là, così non si procede, si va vagando. Vorresti – così mi dici – che io ti dessi più libri. Ebbene, sono pronto a spedirti tutti i volumi che vuoi e a svuotare la mia biblioteca, anzi, se mi fosse possibile, mi trasferirei anch’io lì da te, e se non sperassi che lascerai presto l’incarico avrei già organizzato questa spedizione senile, né avrebbero potuto spaventarmi Scilla e Cariddi e il loro mitico mare. L’avrei attraversato addirittura a nuoto pur di poter abbracciarti e constatare di persona quanto sei spiritualmente cresciuto. Peraltro il fatto che tu mi chieda di mandarti i miei libri non mi rende più eloquente di quanto lo sarei se mi chiedessi invece il mio ritratto. So bene che questa tua richiesta è frutto di benevolenza, non nasce da una decisione meditata e se pur deriva da una determinazione te l’ha imposta la tua indulgenza. Tu comunque leggili questi libri, tenendo presente che io la verità non la possiedo ancora, sto cercandola con ostinazione. Non sono schiavo di questo o di quel filosofo, non porto il nome di alcuno di essi, stimo e rispetto l’opinione di molti grandi, ma rivendico qualche diritto anche al mio cervello. Loro stessi hanno intuito molte verità che ancora non sono state scoperte, che vanno indagate, e forse avrebbero trovato una risposta se non si fossero dedicati anche alla ricerca di verità superflue. Le conversazioni cavillose e le dispute capziose, esercizio di un’inutile acutezza di pensiero, hanno sottratto molto tempo alla loro ricerca. Noi siamo soliti intrecciare nodi e legare alle parole significati ambigui per poi sciogliergli: abbiamo proprio tanto tempo per far ciò? Sappiamo vivere, ormai, sappiamo morire? Dobbiamo usare tutta la nostra intelligenza cercando di non farci ingannare non tanto dalle parole quanto dalle cose. Perché far distinzione fra parole simili che possono trarre in inganno solo in una disputa? Non è la parola che c’inganna, è la realtà, ed è qui che serve distinguere. Noi abbracciamo il male scambiandolo per bene, formuliamo desideri opposti a quelli di un momento prima, le nostre preghiere e le nostre decisioni fanno a pugni fra loro. Quanto somiglia all’amicizia l’adulazione! Non solo la imita ma la vince e la supera, viene recepita da orecchie pronte e ben disposte e scende nella parte più profonda dell’anima, resa gradita proprio da ciò che reca danno. Impariamo a conoscere il perché di questa somiglianza. Ci si presenta un nemico tutto ossequioso spacciandosi per amico, si insinuano in noi i vizi sotto l’apparenza di virtù, la temerarietà si camuffa da valore, chiamiamo moderazione la pigrizia, prudente il timido. Ci perdiamo in questi errori di giudizio con nostro grande pericolo, imprimendovi un marchio sicuro. D’altra parte se tu chiedi a uno se abbia le corna, quello non è tanto sciocco da toccarsi la fronte, e nemmeno tanto stupido e tanto ottuso da non sapere che non le ha, a meno che tu non l’abbia convinto del contrario con qualche sottile argomentazione. Questi scherzi ingannano ma non sono dannosi, come i bussolotti
e le pietruzze dei prestigiatori che divertono proprio per via dei loro trucchi. Svelato il meccanismo, finito il divertimento. La stessa cosa vale per questi cavilli (e come potrei chiamarli altrimenti piuttosto che sofismi?), non nuocciono a chi li ignora, non giovano a chi li scopre. Se vuoi sciogliere interamente le ambiguità delle parole insegnaci che non è felice l’uomo ritenuto tale dal volgo e che possiede molto denaro, lo è quello che ha ogni suo bene nell’intimo e che, nobile e fiero, disprezza ciò che gli altri ammirano, che non si cambierebbe con nessuno, che giudica un uomo unicamente per quella parte che lo caratterizza come tale, che utilizza gli insegnamenti della natura, si uniforma alle sue leggi e secondo quelle vive; l’uomo a cui nessuna forza può togliere i suoi beni, che volge il male in bene, sicuro nei suoi giudizi, intrepido e costante, che qualche forza può commuovere ma nessuna turbare, che può essere punto, e raramente, dalla sorte quando gli scaglia contro con la massima violenza la sua arma più malefica, ma non ferito: le altre armi che la sorte usa per piegare il genere umano rimbalzano da lui come la grandine che batte sui tetti delle case strepitando senza minimamente danneggiare chi vi abita, e poi si scioglie. Ma perché mi intrattieni su un argomento che tu stesso consideri cavilloso e di cui si parla in tanti libri? Ecco, per me la vita è tutta un inganno: scoprine gli altarini, riconducila al vero, se hai perspicacia. Essa giudica necessari dei beni che nella maggior parte sono superflui, ma anche quelli necessari spesso non ci rendono felici e fortunati, perché non è detto che il necessario sia decisamente un bene; eppure sviliamo il concetto di bene se diamo questo nome al pane e alla polenta e ad altre cose necessarie a vivere. Insomma, ciò che è un bene è senza dubbio necessario, ma ciò che è necessario non è necessariamente un bene, perché sono necessarie anche cose che valgono poco o nulla. Non c’è persona che ignori a tal punto la dignità del bene da abbassarlo al livello di queste cose che servono al vivere quotidiano. Dunque, adoperati piuttosto per far sapere a tutti che si ricercano con grande perdita di tempo beni superflui e che molti hanno passato la vita intera alla ricerca dei mezzi necessari per poter vivere. Prendi gli uomini uno per uno, poi considerali tutti quanti insieme: ciascuno vive pensando al domani. Ti domandi che male ci sia in questo atteggiamento: un male grandissimo. Costoro non vivono, aspettano di vivere, rimandano ogni cosa. Intanto, mentre noi indugiamo, la vita ci precede e passa oltre, come se appartenesse ad altri, e benché finisca l’ultimo giorno, se ne va giorno per giorno. Ma, per non superare la giusta misura della lettera (che nel riavvolgersi non deve riempire la mano sinistra di chi legge), rimanderò a un altro momento questo dibattito con i dialettici troppo sottili che badano solo alle minuzie e a niente altro. Stammi bene. 46. Ho ricevuto il tuo libro promessomi e l’ho aperto con l’intenzione di leggerlo con comodo, gustandone solo un po’, ma poi via via sono andato avanti. Da quel che ti dirò potrai capire quanto sia scritto bene: pur non essendo al
nostro livello, tuttavia è gradevole e a prima vista potrebbe sembrare di Tito Livio o di Epicuro. Mi ha intrattenuto con tanta piacevolezza e mi ha assorbito a tal punto che l’ho letto sino alla fine tutto d’un fiato. Il sole mi invitava, la fame mi provocava, le nuvole incombevano minacciose, ma l’ho divorato tutto. E non ne ho provato solo piacere, ne sono rimasto estasiato. Che ingegno l’autore, e che spirito! «Che impeto!», direi. Niente pause, niente intervalli, per compiere poi qualche volo: non procede infatti per slanci, ma va avanti con un’andatura costante, un costrutto virile e venerando, anche se a tratti dimostra un tono dolce e pacato. Sei grande e fiero: voglio che tu continui a procedere per questa via. Anche l’argomento ha fatto la sua parte, perciò occorre che esso sia fertile, produttivo, che tenga impegnata la mente e che la sproni. Mi riprometto di parlare del libro più distesamente quando lo avrò ripreso in mano: per ora ne ho un giudizio sommario, incompleto, come se i contenuti li avessi ascoltati invece di leggerli. Consentimi di esaminarlo più a fondo. Non temere, ti dirò la verità. Beato te, perché non dài motivo di mentirti da così lontano, tanto più oggi in cui si mente per abitudine e senza alcun motivo. Stammi bene. 47. Mi ha fatto piacere sentire da persone provenienti da Siracusa che tratti i tuoi domestici con familiarità: è un comportamento degno della tua saggezza e della tua cultura. Si dice: «Sono schiavi». No, sono uomini. «Ma sono schiavi». No: compagni che vivono nella nostra stessa dimora. «Ma sono sempre schiavi». No, sono gli amici più umili. «Ma schiavi!». Semmai compagni di schiavitù, se pensiamo che sia loro che noi siamo soggetti al potere e alla mutevolezza della sorte. Per questo io rido di chi considera disonorevole cenare col proprio domestico. E perché no? Solo perché è una consuetudine dettata dalla più grande superbia che intorno al padrone seduto a tavola ci sia una schiera di schiavi pronti a servirlo? Egli mangia più di quanto il suo stomaco possa contenere, riempiendo con grande avidità il ventre rigonfio ormai disabituato alle sue funzioni, indaffarato più nel vomitare il cibo che nell’ingerirlo, mentre quei poveri schiavi non possono neppure muovere le labbra per parlare, ogni loro mormorio viene represso a suon di frusta e persino i rumori non voluti, come la tosse, il singhiozzo e gli starnuti, non sfuggono alle percosse: chi rompe il silenzio anche con una sola parola la paga cara. Tutta la notte in piedi, zitti e digiuni. Questo è il motivo per cui, non potendo parlare in presenza del padrone, ne parlano male. Mentre quei servi a cui era concesso di parlare non solo in presenza del padrone ma con lui stesso, che non avevano la bocca cucita, erano pronti a farsi tagliare la gola per il padrone, a volgere contro sé stessi un pericolo che lo minacciasse: parlavano durante i banchetti, ma tacevano sotto la tortura. Viene poi ripetuto spesso il proverbio, frutto di quella stessa superbia, «Tanti nemici quanti schiavi», mentre questi non ci sono affatto nemici, siamo noi che ce li rendiamo tali. Tralascio qui i maltrattamenti crudeli e disumani: ne abusiamo come se fossero bestie, non esseri umani. Quando noi stiamo a tavola
uno di loro deterge gli sputi, un altro, che sta sotto il divano, raccoglie gli avanzi di quelli che si ubriacano, un altro squarcia volatili costosi ruotando la mano esperta con gesto sicuro attraverso il petto e le cosce, ne stacca i piccoli pezzi, vive solo per questo, poveraccio, per tagliare convenientemente il pollame. Ma chi insegna tutto ciò per il suo piacere è più sventurato di chi impara per necessità. Un altro, incaricato di mescere il vino, vestito da donna, combatte con l’età, non può sottrarsi alla fanciullezza, vi è trattenuto, e pur essendo ormai idoneo al servizio militare, glabro, coi peli rasati o sradicati veglia tutta la notte dividendola fra l’ubriachezza e la libidine del padrone, facendogli da uomo in camera da letto e da servo durante il banchetto. Un altro schiavo, incaricato di esprimere un giudizio sui commensali, se ne sta in piedi, sventurato, a guardare quali di loro potranno essere invitati l’indomani per aver saputo adulare il padrone di casa e si sono lasciati andare nel mangiare o nei loro discorsi. Ci sono poi gli schiavi incaricati delle provviste, che conoscono a puntino i gusti del padrone e sanno di quale vivanda lo stuzzichi il sapore, di quale invece l’aspetto, quale piatto insolito possa togliergli la nausea di quelli già assaggiati, quale invece lo disgusti dopo essersi saziato, cosa infine desideri mangiare in quel giorno determinato. Con tutto ciò il padrone disdegna di sedere a mensa con costoro, considerando una diminuzione della sua dignità stare alla stessa tavola con un suo servo. Ma, buon dio, quanti padroni ha fra costoro! Ho visto sostare davanti alla porta di Callisto4 il suo ex padrone e mentre gli altri entravano veniva lasciato fuori proprio lui che l’aveva considerato uno schiavo da scartare mettendogli addosso il cartello perché fosse venduto. E quello, che il banditore per provarne la voce aveva messo fra i primi dieci, gli rese pan per focaccia: a sua volta lo respinse giudicandolo indegno della sua casa. Il padrone vendette Callisto, ma questi come ripagò il suo padrone! Tieni presente che costui che tu chiami tuo schiavo è nato dal medesimo seme da cui sei nato tu, gode dello stesso cielo, respira, vive e muore come te! Può toccare a lui di essere libero, come a te di diventare schiavo. Con la sconfitta di Varo5 molti uomini di nobilissima origine che da militari aspiravano a diventare senatori furono dalla cattiva sorte socialmente declassati, alcuni diventarono pastori, altri guardiani di casa. Prova ora a disprezzare un uomo che si trova in uno stato in cui, proprio nel momento che lo disprezzi, puoi cadere tu. Ma non voglio impelagarmi in un argomento così impegnativo e mettermi a discutere su come debbano essere trattati gli schiavi; è certo che verso di loro siamo eccessivamente altezzosi, insolenti e crudeli. Ti dirò solo in sintesi quale sia a questo proposito il mio insegnamento: comportati col tuo inferiore come vorresti che il tuo superiore si comportasse con te. Ogni volta che penserai quanto potere hai sul tuo schiavo rifletti che il tuo padrone ha altrettanto potere su di te. «Ma io», ribatti, «non ho padrone». È un buon momento, per ora, in seguito forse lo avrai. Lo sai a quale età divenne schiava Ecuba? E Creso,6 la madre di Dario,7 Platone e Diogene? Sii clemente col tuo servo, e anche cortese, parlagli, chiedigli consiglio e mangia con lui.
A questo punto tutta la schiera degli schizzinosi mi griderà: «Sarebbe un’umiliazione, una vergogna!». Badino, però, che io potrei sorprendere proprio uno di loro mentre bacia la mano di servi altrui. Né riflettete poi sul fatto che i nostri antenati vollero che non vi fossero motivi di odio verso i padroni e di oltraggio verso gli schiavi. Chiamarono padre di famiglia il padrone e domestici gli schiavi, un appellativo che è rimasto nei mimi, stabilirono un giorno festivo perché almeno in quello, ma non solo in quello, i padroni mangiassero insieme ai servi, gli consentissero di occupare posti importanti nella casa, di amministrare la giustizia e considerarono la famiglia come un piccolo stato. «Dunque dovrei invitare alla mia tavola tutti gli schiavi di casa?». Come tutti gli uomini liberi. Se pensi che io respinga qualcuno perché fa un lavoro troppo umile, come quel tal mulattiere o quel tal bifolco, ti sbagli. Io li giudico non in base al loro mestiere, ma in base alla loro condotta, poiché di questa siamo responsabili, mentre il mestiere ce lo assegna la sorte. Sieda a mensa con te non solo chi ne è degno, ma anche chi può diventarlo: se in qualcuno c’è ancora un residuo di servilismo, per il suo rapporto con gente di umili condizioni, potrà essere eliminato dalla familiarità con uomini di livello più elevato. Caro Lucilio, non devi cercare gli amici solo nel Foro o nel senato: basta che tu vi faccia attenzione, li troverai anche in casa tua. Spesso un buon materiale, se non trova uno che lo lavori, resta inservibile: prova a sperimentarlo. Chi per comprare un cavallo guarda la sella e le briglie e non esamina lui è stupido, e ancora di più lo è chi giudica un uomo dall’abbigliamento e dalla condizione sociale che ci portiamo addosso come un vestito. «È uno schiavo». Ma forse è libero nell’animo. «È uno schiavo». E ciò deve danneggiarlo? Mostrami chi non lo è: si può essere schiavi della lussuria, dell’avidità, dell’ambizione, tutti sono schiavi della speranza, della paura. Posso indicarti un ex console schiavo di una vecchietta, un ricco signore servo di un’ancella, giovani nobilissimi che sono schiavi di pantomimi; non c’è schiavitù più vergognosa di quella volontaria. Dunque codesti schizzinosi non devono impedirti di essere cortese coi tuoi servi quando tu non ti senti altezzosamente superiore a loro: più che temerti, ti rispettino. A questo punto qualcuno dirà che io istigo gli schiavi alla rivolta per abbattere l’autorità dei padroni, e ciò solo perché ho detto: «Il padrone più che temerlo devono rispettarlo». «Proprio così?», chiederanno. «Lo rispettino come i clienti, come le persone che fanno la visita di omaggio?». Chi si scandalizza dimentica quanto sia importante ciò che basta a un dio. Chi rispetta ama: l’amore non si mescola al timore. Io penso, perciò, che tu giustamente non voglia che i tuoi servi ti temano e li corregga solo con le parole: con la frusta si puniscono le bestie. Non tutto ciò che ci opprime ci danneggia pure, ma i piaceri ci fanno arrivare all’ira, tutto ciò che non va come desideriamo è per noi motivo di collera. Ci comportiamo come i re: dimentichi delle proprie forze e della debolezza altrui, anche loro vanno in escandescenze e infieriscono, come se avessero ricevuto un’offesa, quando il grande potere che la sorte gli ha dato li preserva al massimo dal pericolo di essere oltraggiati. Loro lo sanno bene, ma si
lamentano per avere occasione di fare del male: dicono di essere stati offesi per potere offendere. Non voglio trattenerti più a lungo: non hai bisogno di esortazioni tu. I retti costumi hanno fra gli altri questo vantaggio, si compiacciono di sé stessi e sono duraturi. La malvagità è incostante e spesso muta, non in meglio, ma in una forma diversa. Stammi bene. 48. Alla lettera che mi hai spedito durante il tuo viaggio, lunga quanto il viaggio stesso, risponderò in seguito, poiché ora devo ritirarmi in me stesso e meditare sui consigli da darti. Tu stesso, del resto, prima di chiedermi il mio parere ci hai pensato a lungo, dunque a maggior ragione devo riflettere io: la soluzione di un problema richiede più tempo che non la sua formulazione, anche perché a me interessa una cosa, a te un’altra. Parlo di nuovo come un epicureo? In realtà a me preme la stessa cosa che a te, altrimenti non sarei un amico se ciò che riguarda te non riguardasse pure me. L’amicizia ci fa consoci di tutto, circostanze avverse o propizie ci toccano entrambi, è come se facessimo una vita in comune. Del resto non può vivere felice chi bada solo a sé stesso, se ogni cosa che fa la fa nel suo esclusivo interesse: devi vivere per il prossimo, se vuoi vivere per te. Questo vincolo sociale, diligentemente e santamente rispettato, che ci unisce agli altri uomini e dimostra che esiste una legge comune per il genere umano, serve moltissimo anche per coltivare quella società interiore a cui ho accennato, cioè l’amicizia, perché chi ha molto in comune col prossimo avrà tutto in comune con l’amico. Mio ottimo Lucilio, preferirei che da questi sottili disquisitori mi fosse insegnato quali doveri ho verso un amico e verso gli uomini, piuttosto che in quanti modi si possa dire «amico» e quanti significati abbia la parola «uomo». Come vedi, la saggezza e la stoltezza vanno in direzioni opposte! A quale delle due accostarsi? Da quale parte mi consigli di andare? Per il saggio “uomo” significa amico, per lo stolto “amico” non significa nemmeno uomo; l’uno si procura un amico, l’altro si offre all’amico: quelli storpiano le parole e le dividono in sillabe. È ovvio che se non avrò costruito argomentazioni sottilissime e fatto nascere, con una falsa conclusione, una menzogna dalla verità, non potrò distinguere ciò che devo ricercare da ciò che devo fuggire. Mi vergogno: scherziamo, da vecchi, su una questione così seria. «Mus [il topo] è una sillaba, mus rode il formaggio, dunque, una sillaba rode il formaggio». Metti che io non sappia sciogliere questo nodo: quale pericolo incombe su di me per questa mia ignoranza? Quale danno? Indubbiamente c’è il rischio che un giorno io prenda in trappola le sillabe, o, se sarò troppo distratto, un libro mangi il formaggio. Ma c’è un sillogismo ancora più sottile: «Mus è una sillaba, la sillaba non rosicchia il formaggio, dunque mus non rosicchia il formaggio». Che sciocchezze puerili! Per cose di questo genere abbiamo corrugato le sopracciglia, ci siamo fatti crescere la barba? È questo che insegniamo, tristi e pallidi? Vuoi sapere cosa prometta al genere umano la
filosofia? Prudenza. Uno lo chiama la morte, un altro l’opprime la povertà, un terzo lo tormenta la ricchezza, sua o di altri, quello ha paura della cattiva sorte, questo vuole sottrarsi alla sua prosperità, a uno fanno male gli uomini, a un altro gli dèi. Perché mi fai questi giochetti? Non è il momento di scherzare: sei chiamato per soccorrere degli sventurati. Hai promesso di aiutare naufraghi, prigionieri, ammalati, bisognosi, persone che devono sottoporre il capo alla scure del carnefice. Dove guardi? Che fai? Quest’uomo con cui scherzi ha paura: aiutalo, […]. Tutti da ogni parte ti tendono le mani, implorando soccorso per la loro vita fallita o che sta per fallire, in te sono la loro speranza e i mezzi per aiutarli, ti chiedono di essere liberati da un’angoscia così grande, di mostrar loro, sradicati ed errabondi, la chiara luce della verità, insegna loro quali siano le cose necessarie e quali le superflue che la natura ha generato, quali semplici norme essa abbia dato agli uomini, quanto sia bella la vita e quanto facile per chi vi obbedisce e quanto dura, invece, e complicata per chi ha creduto più ai pregiudizi che alla voce della natura * * *, ma prima dovrai indicargli quale parte dei loro mali potrà essere alleviata. Quale di queste argomentazioni può spegnere le passioni, o attenuarle? Almeno si limitassero a non giovare! Invece nuocciono, per giunta. Quando vorrai, ti dimostrerò in modo chiaro e lampante che anche un’indole magnanima si debilita e infiacchisce se si abbandona a queste sottigliezze. Mi vergogno di dire che armi offrano costoro a chi si accinge a combattere contro la sorte e come lo istruiscano. È per questa via che si va al sommo bene? Attraverso questi «sia che, sia che non» della filosofia e attraverso obiezioni vergognose e infamanti anche per degli avvocaticchi. Che altro fate, infatti, quando traete in inganno consapevolmente l’interrogato, se non fargli credere di aver perso la causa per una formula? Ma come il pretore rende giustizia agli innocenti, così fa la filosofia. Perché venite meno alle vostre ingenti promesse, allorché mi affermaste solennemente che avreste fatto sì che lo splendore dell’oro non mi abbagliasse gli occhi più di quello della spada, che avrei calpestato con grande fermezza tutto ciò che gli uomini desiderano o temono, e ora vi abbassate ai princìpi elementari dei grammatici? Che dite? Così si sale alle stelle?8 Ciò infatti mi promette la filosofia, di rendermi simile alla divinità; a questo sono stato invitato e per questo sono venuto. Mantieni le tue promesse. Sta’ lontano quanto ti è possibile, Lucilio mio, da queste sottigliezze e obiezioni dei filosofi: l’onestà vuole un linguaggio semplice e chiaro. Anche se avessimo ancora molto tempo da vivere dovremmo amministrarlo oculatamente, affinché basti per quel che è necessario: non è dunque da folli imparare cose superflue quando il tempo che abbiamo è così poco? Stammi bene. 49. Caro Lucilio, è da persone apatiche e sbadate ricordarsi di un amico solo quando lo richiama alla mente la vista di qualche luogo, anche se questa a volte
evoca una nostalgia ch’era già latente dentro di noi, non riaccende un ricordo ormai spento ma lo desta dal torpore, così come lo schiavo di una persona scomparsa che gli era molto affezionata, oppure un suo vestito o la casa risvegliano il dolore di quella perdita, anche se mitigato dal tempo. Ecco, è incredibile come la Campania ma soprattutto Napoli e la vista della tua Pompei abbiano reso in me così viva la nostalgia di te: ti ho tutto davanti agli occhi nel momento in cui mi congedo da te, ti rivedo mentre inghiotti le lacrime e non riesci a frenarti nonostante cerchi di contenere l’impeto del tuo affetto. Mi sembra di averti lasciato poco fa: ma cos’è “poco fa” quando lo si ricorda? Poco fa sedevo fanciullo alla scuola del filosofo Sozione,9 poco fa cominciavo a discutere le cause, poco fa decidevo di lasciarle, poco fa cominciavo a non poterle più discutere: il tempo scorre velocissimo e ce ne rendiamo conto specialmente quando guardiamo indietro, mentre quando badiamo al presente passa inosservato, tanto svelto s’invola nella sua fuga precipitosa. Perché? Tutto il tempo passato si trova in un medesimo luogo: simultaneamente se ne vedono tutti i momenti; sta tutto insieme, ogni istante precipita in una stessa voragine, e d’altra parte non possono esserci lunghi intervalli fra un istante e l’altro quando ciascuno è breve. La nostra vita stessa è un attimo, anzi, meno di un attimo, ma la natura c’inganna, dando a questo spazio minimo di tempo l’apparenza di uno spazio più lungo: di una parte di esso ne ha fatto l’infanzia, di un’altra la fanciullezza, poi l’adolescenza, quindi il declino dall’adolescenza alla vecchiaia e la vecchiaia stessa. Quanti gradini in una scala così corta! Poco fa ti ho salutato; e tuttavia questo «poco fa» è una buona porzione della nostra esistenza, la cui breve durata – ricordiamolo – un giorno finirà. In passato non avevo l’impressione che il tempo scorresse così velocemente, mentre ora la sua rapidità mi sbalordisce, sia perché sento che la meta si avvicina, sia perché ho cominciato a farci attenzione e a contare quel che ho perduto. Tanto più, dunque, m’indigno con coloro che spendono in occupazioni inutili la maggior parte di questo tempo che già non basta nemmeno per le attività necessarie nonostante il massimo impegno che vi si mette. Cicerone scrive che anche se gli venisse raddoppiata la vita non avrebbe il tempo per leggere i poeti lirici;10 lo stesso io dico per i dialettici, i quali sono più tristemente inutili. Quelli vaneggiano, e consapevolmente, questi ritengono di fare qualcosa di utile. Non dico che non si debba dare uno sguardo anche a queste frivolezze, ma solo un’occhiata e un saluto dalla soglia, facendo attenzione a questo, che non ci traggano in inganno facendoci credere che in esse vi sia un grande bene nascosto. Perché ti tormenti e ti maceri su un problema che è più intelligente disprezzare che risolvere? Chi si sposta da un luogo all’altro tranquillamente e a suo comodo può raccogliere anche le minutaglie, ma quando il nemico incalza alle spalle e il soldato ha l’ordine di sbrigarsi bisogna gettar via ciò che si è andati raccogliendo nella quiete oziosa della pace. Non ho tempo di andar dietro alle loro frasi ambigue e sperimentarvi il mio acume.
Guarda che folla di popoli, che città, sbarrate le porte, affilino le armi.11 Devo ascoltare con animo coraggioso questo strepito di guerra che mi risuona intorno. Sembrerei davvero un pazzo a tutti quanti se, mentre vecchi e donne ammassano pietre a fortificazione delle mura, mentre i giovani in armi aspettano o chiedono il segnale della sortita da dietro le porte, contro cui dall’esterno si conficcano vibrando i giavellotti dei nemici, e persino il suolo trema per gli scavi dei cunicoli, io me ne stessi in ozio seduto ponendomi questioncelle del tipo: «Hai ciò che non hai perduto; non hai perduto le corna; dunque, hai le corna», e altre costruite sull’esempio di questo acuto delirio. Ebbene, anche adesso sono assediato e se mi dedicassi a questi problemi ti sembrerei ugualmente un pazzo. E però nell’assedio di una città il pericolo mi minaccerebbe dall’esterno, un muro mi separerebbe dal nemico, mentre qui i pericoli mortali sono dentro di me. Non ho tempo per queste sciocchezze; ho per le mani un affare importante. Che cosa devo fare? La morte incalza, la vita fugge. Insegnami come affrontare questa situazione; fa’ ch’io non fugga la morte, che la vita non fugga me. Dammi coraggio contro le difficoltà, contro i mali inevitabili; allunga il poco tempo di cui dispongo, insegnami che il valore della vita sta non nella sua durata ma nell’uso che se ne fa: può succedere, anzi accade molto spesso, che pur vivendo a lungo si viva poco. Quando vado a dormire avvertimi: «Puoi non svegliarti più!», e quando mi sono svegliato: «Potresti non addormentarti più!». E così quando esco: «Potresti non tornare più», e quando ritorno: «Potresti non uscire più». Sbagli se pensi che solo in viaggio per mare sia minima la distanza che separa la vita dalla morte: in ogni luogo la distanza è ugualmente breve. La morte non si mostra dovunque così vicina, ma dovunque lo è. Dissipa queste tenebre e potrai trasmettermi più facilmente quegli insegnamenti a cui sono preparato. La natura ci ha dato facilità di apprendimento e una ragione imperfetta, ma capace di perfezionamento. Discuti con me della giustizia, della pietà, della frugalità, delle due forme di pudore, sia di quella che non offende il corpo altrui, sia di quella che consiste nel rispetto del proprio. Se non mi condurrai fuori strada giungerò più facilmente alla meta cui tendo: come dice quel famoso poeta tragico, «il linguaggio della verità è semplice»,12 perciò non bisogna ingarbugliarlo; a chi aspira a grandi cose niente si addice meno di questa subdola acutezza d’ingegno. Stammi bene. 50. Ho ricevuto la tua lettera dopo molti mesi da quando l’hai spedita, perciò ho ritenuto inutile chiedere al portatore che cosa tu stessi facendo. Comunque ha una buona memoria e se lo ricorda. Spero tuttavia che la tua vita sia tale ch’io possa sapere cosa fai dovunque tu ti trovi. Cos’altro fai, infatti, se non renderti ogni giorno migliore, liberarti di qualche errore, capire che i difetti attribuiti alle cose sono in noi stessi? Certuni li imputiamo ai luoghi e alle circostanze, e però
ci seguono dovunque noi ci rechiamo. Arpaste, quella povera matta con cui si trastulla mia moglie, come sai mi è rimasta in casa quale peso di una fastidiosa eredità. Io, infatti, sono assolutamente contrario a questi esseri anormali, se ho voglia di divertirmi con un buffone non vado a cercarlo lontano: rido di me stesso. Ebbene, questa matta ha perso improvvisamente la vista. Ti racconto un fatto incredibile ma vero: non sa di essere cieca, prega continuamente il suo accompagnatore di condurla altrove perché – dice – la casa è buia. Chiaramente ciò che in lei ci fa ridere accade a tutti noi: nessuno si rende conto di essere avaro, nessuno sa di essere avido. I ciechi, però, cercano qualcuno che li guidi, noi, invece, andiamo errando senza guida e diciamo: «Io non sono ambizioso, ma a Roma nessuno può vivere diversamente. Io non sono uno spendaccione, ma è la città che richiede grandi spese. Non è colpa mia se sono collerico, se non ho ancora stabilito una precisa condotta di vita: dipende dalla giovane età». Perché ci inganniamo? Il nostro male non viene dal di fuori, è dentro di noi, risiede nelle nostre viscere stesse, perciò difficilmente possiamo guarire, perché non sappiamo di essere malati. Se pure cominciassimo a curarci, quando riusciremo a sconfiggere malattie così forti e numerose? Non cerchiamo neppure un medico, il quale avrebbe meno da fare se il male fosse recente: animi docili e semplici seguirebbero facilmente chi gli mostra la retta via. È difficile ricondurre alla natura solo chi le si è ribellato: ci vergogniamo di apprendere la saggezza. Ma, per Ercole, se è vergognoso cercare un maestro che c’insegni quest’arte, come possiamo sperare che un bene così grande possa penetrare in noi per puro caso? Dobbiamo faticare, anzi, a dire il vero, non è nemmeno una grave fatica se, come ho detto, cominciamo a educare il nostro animo e a correggerlo prima che il male lo abbrutisca. Ma io non dispero di poter correggere anche i vizi incalliti: tutto si può vincere con un impegno costante e una cura attenta e minuziosa. Puoi raddrizzare alberi dal legno duro, anche se molto piegati; il calore riesce a distendere travi incurvate e, per quanto all’origine diverse, vengono modellate come richiede l’uso che ne vogliamo fare: a maggior ragione è più facile plasmare l’animo, che è più flessibile e più docile di qualsiasi liquido! Cos’altro è l’anima, infatti, se non un soffio che ha un suo particolare modo di essere? E non vedi che il soffio è tanto più duttile di ogni altra materia quanto più è sottile? Mio caro Lucilio, il fatto che la malvagità ci domini e già da un pezzo ci tenga in suo potere non deve impedirci di sperar bene di noi: la saggezza non precede la malvagità, che è la prima a impadronirsi di noi; imparare la virtù significa disimparare il vizio. Ma quanto maggiore sarà lo slancio con cui ci accingiamo a correggerci tanto più potremo mantenere quel bene che una volta ottenuto non si perde più: la virtù non si disimpara. Ciò che è contrario, infatti, mal si concilia con un luogo che gli è estraneo, e perciò può essere estirpato e distrutto, mentre ciò che capita in un terreno adatto mette salde radici. La virtù è secondo natura, i vizi, invece, sono ostili e contrari. Ma come le virtù, una volta acquisite, non possono uscire dal nostro animo ed è facile custodirle, così inizialmente è difficile avvicinarsi a esse, perché è proprio di un
animo debole e malato aver paura di ciò che non conosce; bisogna dunque costringerlo a cominciare. La medicina in un secondo momento non sembra più amara, e risulta gradita, mentre risana. Gli altri rimedi arrecano piacere dopo la guarigione: la filosofia, invece, è al tempo stesso salutare e gradevole. Stammi bene. 51. Ciascuno come può, Lucilio mio: tu hai l’Etna, famosissimo monte della Sicilia (che non capisco perché Messalla13 e Valgio 14 – come ho letto in entrambi – abbiano definito unico, visto che sono moltissimi i luoghi che vomitano fuoco, e non solo quelli elevati ma anche quelli bassi, anche se ai primi accade più di frequente, evidentemente perché il fuoco tende verso l’alto). Io, per quanto posso, mi accontento di Baia,15 che però ho lasciato il giorno dopo il mio arrivo: è un posto da evitare, nonostante certe sue bellezze naturali, perché famoso per la sua dissolutezza. «E che, dunque», dirai: «bisogna giurare odio a certe località?». Assolutamente no, ma come a un uomo saggio e onesto si conviene un vestito invece che un altro, anche se lui personalmente non detesta alcun colore ma ritiene solo che certi siano poco adatti a chi fa professione di sobrietà, così ci sono luoghi che un uomo saggio o che tende alla saggezza evita, perché sono contrari alla moralità. Perciò, se vuole un luogo in cui ritirarsi, non sceglierà mai Canopo,16 sebbene Canopo non impedisca a nessuno di essere sobrio, e neppure Baia: sono luoghi che stanno diventando asilo di vizi, vi si concede molto alla dissolutezza; lì, più che altrove, si mette da parte ogni ritegno, come se gli fosse dovuta una certa licenza. Dobbiamo scegliere una località salutare non solo per il corpo, ma anche per la nostra condotta morale: come non vorrei abitare fra carnefici, così non vorrei vivere neppure in mezzo a delle bettole. Che bisogno c’è di vedere gente ubriaca che gironzola per le spiagge o che fa baldoria sulle navi, specchi d’acqua risonanti di concerti e altre brutture che la dissolutezza, quasi sciolta da ogni legge, non solo commette, ma pone sotto gli occhi di tutti? Dobbiamo fuggire il più lontano possibile da ciò che stimola i vizi, fortificare l’animo e sottrarlo agli allettamenti dei piaceri. Un solo inverno trascorso negli accampamenti bastò a fiaccare Annibale, e gli agi della Campania sfibrarono quell’uomo che le nevi delle Alpi non erano riuscite a domare: vinse con le armi, fu vinto dai vizi. Anche la nostra è una milizia, di un genere che non concede mai tregua o riposo: prima di tutto bisogna debellare i piaceri, che, come vedi, attirano anche i caratteri più forti. Se uno si sofferma a considerare la gravità dell’opera intrapresa, capirà che non può comportarsi come un effeminato. A che mi servono questi bagni caldi? Queste stanze per sudare, nelle quali si immette del vapore asciutto che indebolisce il corpo? Sia la fatica a farci gocciolare di sudore. Se facessimo come Annibale e, accantonate la guerra e le nostre imprese, ci volgessimo alla cura del nostro corpo, tutti giustamente ci rimprovererebbero questa inerzia inopportuna, che se è pericolosa per chi ha vinto, tanto più lo è per chi si trova a un passo dalla vittoria: noi possiamo concederci un minor numero di distrazioni rispetto alle truppe
cartaginesi; per noi maggiore è il pericolo se ci ritiriamo, maggiore la fatica se proseguiamo la lotta. La sorte mi fa guerra? Non le obbedirò, non mi piegherò al suo giogo, anzi, me lo scuoto di dosso, mostrandomi così più coraggioso. Non devo infiacchire l’animo: se cedo al piacere, dovrò cedere al dolore, alla fatica, alla povertà, e l’ira e l’ambizione pretenderanno su di me gli stessi diritti; fra tante passioni mi troverò diviso, anzi sarò fatto a pezzi. La posta in gioco è la libertà: per questo premio io lavoro. Chiedi che cosa sia la libertà? Non essere schiavi di niente, di nessuna necessità, di nessun caso, trattare con la fortuna da pari a pari; e quando mi renderò conto di essere più potente io, lei non potrà più nulla su di me: perché dovrei esserle sottomesso quando potrò dominare la morte? Chi si dedica a queste riflessioni deve scegliere luoghi austeri e puri; l’amenità eccessiva del paesaggio infiacchisce l’animo, e certamente un luogo può contribuire in certa misura a sminuirne il vigore. Le bestie da soma, i cui zoccoli si sono induriti su terreni scoscesi, sopportano qualsiasi tipo di strada, mentre gli zoccoli di quelle ingrassate in un terreno di pascolo molle e paludoso si logorano subito. Il soldato che proviene da luoghi aspri è più forte, quello vissuto in una casa di città è pigro. Le mani che passano dall’aratro alle armi accettano qualsiasi lavoro, mentre l’uomo elegante e profumato crolla alla prima fatica. Un luogo che induca a una più severa disciplina rafforza il carattere e lo rende adatto a grandi imprese. Scipione17 ritenne più dignitoso andare in esilio a Literno piuttosto che a Baia: una simile sventura non può trovar posto in mezzo alla mollezza. Anche Caio Mario,18 Gneo Pompeo e Cesare, ai quali per primi la sorte affidò pubblici poteri sul popolo romano, fecero erigere le loro ville nei dintorni di Baia, ma le collocarono sulle cime dei monti, poiché gli sembrava una prerogativa più da soldati osservare dall’alto in lungo e in largo la zona sottostante. Se guardi la posizione che hanno scelto, i luoghi in cui hanno innalzato case e di che tipo esse siano, ti accorgerai che non sono ville, ma accampamenti. Pensi che Catone avrebbe accettato di abitare laggiù, per contare le adultere che passavano in barca là davanti e i tanti tipi di imbarcazioni dipinte di vari colori e le rose galleggianti su tutta la superficie del lago, o per sentire gli schiamazzi notturni dei cantanti? Non avrebbe preferito stare in una trincea scavata con le sue mani stesse in una notte? Perché un vero uomo non dovrebbe preferire che il suo sonno venga interrotto da una tromba di guerra piuttosto che da un concerto? Ma abbiamo criticato Baia abbastanza; non così possiamo fare invece coi vizi: ti prego, Lucilio, di combatterli senza limite e senza fine, poiché essi non hanno né l’uno né l’altra. Scaccia tutti quei vizi che dilaniano il tuo cuore, e se non possono essere estirpati diversamente strappa via con essi il tuo cuore stesso. Caccia via soprattutto i piaceri e detestali profondamente, poiché ci abbracciano per strangolarci, come fanno i banditi, che gli Egiziani chiamano “fileti”. Stammi bene.
52. Cos’è, Lucilio, questa forza che ci trascina nella direzione opposta a quella verso cui tendiamo e ci spinge dove non vorremmo andare? Cos’è che lotta col nostro animo e c’impedisce di volere con fermezza e decisione? Ondeggiamo fra propositi contrastanti; non c’è cosa che scegliamo in piena libertà, in modo assoluto e costante. «È la stoltezza», tu dici, «che in quanto volubile si stanca presto della scelta fatta». Ma come o quando potremo togliercela di dosso? Da soli non siamo abbastanza forti per liberarcene: bisogna che qualcuno ci tenda la mano e ce ne tiri fuori. Epicuro dice che certi sono giunti alla verità senza l’aiuto di alcuno, che si sono aperti la strada da soli, e loda moltissimo costoro, che hanno trovato in sé stessi la spinta, che sono andati avanti con le proprie forze; certi, invece, hanno bisogno di essere aiutati, non avanzano se nessuno li guida, ma seguono bene chi li precede. Fra questi Epicuro pone Metrodoro, un personaggio eccellente ma che appartiene alla seconda categoria, come noi, che facciamo progressi se rientriamo appunto nella seconda. Non disprezzare però chi si salva con l’aiuto altrui: anche la volontà di salvarsi è già molto. Oltre a queste due c’è un’altra categoria di uomini, che neppure sono da disprezzarsi, quelli, cioè, che possono essere o costretti o spinti al bene, che hanno bisogno non solo di una guida, ma anche di qualcuno che li assista e li sproni: questo è il terzo gruppo, a cui Epicuro dice che apparteneva Ermarco. Perciò se si congratula di più con l’uno, ammira maggiormente l’altro; sebbene entrambi siano arrivati allo stesso fine, tuttavia merita maggior lode chi ha ottenuto il medesimo risultato in una condizione più difficile. Fa’ conto, infatti, che siano stati eretti due edifici uguali, alti e splendidi allo stesso modo: uno è sorto su un’area libera ed è cresciuto in fretta, l’altro ha stentato per via delle fondamenta, gettate in un terreno molle e cedevole, e si è faticato molto per rassodarlo. Il lavoro richiesto dal primo è tutto visibile, del secondo gran parte rimane nascosta, ed è la più ostica. Certi caratteri sono vivaci e pronti, altri, invece, devono essere per così dire plasmati a mano fin dalle fondamenta. Perciò secondo me è più fortunato chi non ha avuto problemi con sé stesso, ma più meritevole chi è riuscito a vincere i suoi limiti naturali ed è giunto alla saggezza con difficoltà, innalzandosi a forza. Pensa che noi abbiamo un carattere aspro e difficile, procediamo in mezzo a ostacoli, dunque dobbiamo lottare, invocare l’aiuto di qualcuno! «Di chi?», mi domandi. «Di Tizio, o di Caio?». Rivolgiti a coloro che ci hanno preceduto, di cui possiamo facilmente disporre: non solo i vivi ma anche i morti possono aiutarci. Fra i vivi, però, non dobbiamo scegliere quelli che buttano fuori una parola dietro l’altra a gran velocità e ripetono luoghi comuni e in privato fanno i ciarlatani, ma quelli che insegnano con l’esempio della loro vita stessa, che non si limitano a dire cosa si deve fare ma lo dimostrano coi fatti, che indicano ciò che si deve evitare e non sono mai sorpresi a compiere delle azioni che dicono di disapprovare. Fatti dunque aiutare da un uomo di cui ammiri più le azioni che le parole. Non ti vieto nemmeno di ascoltare coloro che sono soliti raccogliere gente intorno a sé e mettersi a dissertare, purché lo facciano col proposito di
diventare migliori e di rendere migliori, non già per ambizione. Nulla, infatti, è più riprovevole della filosofia che va in cerca di applausi. Forse che l’ammalato loda il medico che lo opera? Tacete, siate ben disposti e sottoponetevi alla cura: anche se griderete la vostra approvazione io vi ascolterò come se gemeste dal dolore perché ho toccato le vostre piaghe. Volete dimostrare che prestate attenzione e siete toccati dall’importanza degli argomenti? D’accordo, ma perché dovrei permettervi di esprimere il vostro giudizio e approvare ciò che vi sembra migliore? Nella scuola di Pitagora i discepoli dovevano tacere per cinque anni: credi che subito dopo fosse loro lecito parlare e tessere lodi? Quanto è stolto l’oratore che se ne va via tutto contento per gli applausi di un pubblico ignorante! Perché ti rallegri di essere stato lodato da persone che non puoi a tua volta lodare? Fabiano parlava al popolo, che lo ascoltava composto: ogni tanto scoppiava un forte applauso di approvazione, ma nasceva dall’importanza di ciò che aveva detto, non dalla facilità e dalla gradevolezza del suo discorso. Fra l’applauso del teatro e quello della scuola dev’esserci una differenza: c’è una certa eleganza anche nel modo di lodare. Ogni cosa, a ben guardare, è piena di indizi rivelatori, e da particolari minimi si può intuire il carattere di una persona: il portamento, la gestualità, a volte anche una sola risposta, un dito portato alla fronte, il movimento degli occhi rivelano l’uomo impudico; il modo di ridere rivela il disonesto, l’atteggiamento del viso il pazzo. Questi vizi vengono allo scoperto attraverso segni particolari: puoi capire il carattere di una persona da come riceve e da come dispensa le lodi. Da ogni parte il pubblico tende le mani al filosofo e la folla degli ammiratori lo assedia: se fai bene attenzione, costui non viene lodato, viene acclamato. Lasciamo questo strepito a quelle arti che vogliono essere gradite alla massa: la filosofia deve essere venerata. Talvolta bisogna permettere ai giovani di seguire l’impulso dell’animo, ma solo se lo fanno istintivamente, quando non possono imporsi il silenzio: elogi simili spronano un po’ anche il pubblico che ascolta e stimolano l’entusiasmo dei giovani. Badino, però, alla sostanza, non alle belle parole, diversamente l’eloquenza non gli gioverà, se solo si compiace di sé stessa, della forma, senza interesse per i contenuti. Ma rimandiamo per ora questo argomento, che richiede una trattazione lunga e particolareggiata su come si debba dissertare in pubblico, che cosa l’oratore possa permettersi di fronte agli ascoltatori e che cosa possano permettersi gli ascoltatori di fronte all’oratore. Indubbiamente la filosofia ha subìto un danno da quando si è prostituita, ma può ancora mostrarsi degnamente nei suoi santuari, purché trovi non dei mercanti, ma dei sacerdoti. Stammi bene.
1. Uccello sacro venerato dagli Egizi, il cui mito è raccontato da Erodoto nelle Storie (II 73). Secondo la leggenda la Fenice al cinquecentesimo anno moriva per rinascere dalle sue stesse ceneri.
2. In teatro le prime quattordici file erano riservate ai cavalieri. 3. Platone, Teeteto, 174-175. 4. Schiavo affrancato dall’imperatore Claudio. 5. La sconfitta avvenne in Germania in seguito a un’imboscata tesa dal principe Arminio nella selva di Teutoburgo. Varo si suicidò. 6. Re di Lidia noto per le sue favolose ricchezze, sconfitto e catturato da Ciro, re di Persia. 7. La madre di Dario III (380-330 a.C.) divenne schiava quando il re persiano fu sconfitto da Alessandro Magno. 8. Virgilio, Eneide IX 641. 9. Discepolo di Q. Sesto, uno dei maestri di Seneca. 10. Cicerone, Ortensio. 11. Virgilio, Eneide VIII 385-86. 12. Euripide, Fenicie 469. 13. Messalla Corvino, politico, poeta, oratore e soldato, fondò il circolo letterario, che prese nome da lui, del quale fecero parte, fra altri, Ovidio e Tibullo. 14. Valgio Rufo, poeta del circolo di Mecenate, scrisse elegie ed epigrammi nonché opere scientifiche e grammaticali. 15. Città della Campania nota per la proprietà delle sue acque termali. 16. Città dell’Egitto meridionale, famosa per la lussuria dei suoi abitanti. 17. P. Cornelio Scipione l’Africano Maggiore, vincitore di Annibale a Zama, si ritirò in esilio a Literno perché accusato di concussione per aver ricevuto denaro dallo sconfitto Antioco III di Siria. 18. È il generale vincitore di Giugurta, dei Cimbri e dei Teutoni, fiero avversario di Silla.
Libro sesto 53. Di cosa ormai non mi si può convincere dopo che mi sono arreso alla navigazione? Salpai col mare tranquillo, anche se il cielo era carico di quei nuvoloni neri che solitamente portano acqua e vento, ma pensai di farcela a percorrere le poche miglia fra la tua Napoli e Pozzuoli, nonostante il tempo incerto e foriero di tempesta. Perciò per mettermi subito al sicuro presi il largo in direzione di Nisida, per evitare tutte le insenature, ma quando stavo già a metà strada e non faceva più differenza se proseguire o tornare indietro quella calma che mi aveva fatto bene sperare se ne andò: la burrasca non era ancora scoppiata ma il mare era mosso e andava agitandosi sempre di più. Allora pregai il timoniere di farmi scendere in un posto sicuro della costa, ma lui mi rispose che il litorale era scosceso lungo tutto il tratto e privo di approdi e che durante una tempesta ciò che temeva di più era la terra. Io intanto stavo così male che il pericolo non m’importava più, mi aveva preso una nausea spossante ma senza vomito, di quelle che smuovono la bile senza cacciarla fuori. Perciò a furia di insistere costrinsi il timoniere, suo malgrado, a dirigersi verso terra e come ci fummo avvicinati abbastanza, senza aspettare che il pilota eseguisse una di quelle manovre descritte da Virgilio, Volgono al largo le prore1 o Si getta l’ancora dalla prua,2 memore della mia abilità di vecchio amante dell’acqua gelida, mi getto in mare come si conviene a chi fa un bagno freddo, vestito di panno grosso. Sapessi che cosa ho passato arrampicandomi su per gli scogli, mentre cercavo una via, anzi aprendomela io stesso! Ho capito perché giustamente i marinai temono la terra. È incredibile quel che ho sofferto nello sforzo che facevo per proseguire: sappi che Ulisse non era predestinato a trovare mari così agitati da fare sempre e dovunque naufragio, visto che soffriva di mal di mare. E pure io, dovunque dovrò recarmi per mare, vi arriverò dopo vent’anni. Non appena il mio stomaco si rimise a posto – la nausea, come sai, non cessa nel momento in cui ci si allontana dal mare – ristorato il corpo ungendolo, cominciai a meditare su come ci dimentichiamo dei nostri difetti fisici che si fanno sentire spesso, nonché di quelli spirituali che quanto più sono grandi tanto più restano nascosti. Una febbriciattola può andar via, ma quando si sviluppa e diventa una vera febbre anche un uomo forte e avvezzo alla sofferenza deve confessarla. Ci dolgono i piedi, avvertiamo leggere fitte alle articolazioni, ma noi ancora fingiamo, dicendo che ci siamo slogati una caviglia o che ci siamo affaticati facendo ginnastica, inizialmente cerchiamo di dare un nome al male
incerto, ma quando comincia a interessare le caviglie e a deformare entrambi i piedi bisogna ammettere che si tratta di gotta. Nelle malattie dello spirito accade il contrario: più il male è forte meno ce ne rendiamo conto. Non c’è da stupirsene, Lucilio carissimo: quando il sonno è leggero si percepiscono delle immagini e a volte ci si accorge di dormire, ma un sonno profondo cancella anche i sogni e la mente vi si annega a tal punto da non avere più coscienza di sé stessa. Perché nessuno confessa i propri difetti? Perché vi è ancora immerso: come è tipico di chi è sveglio raccontare il sogno che ha fatto, così è segno di sanità spirituale confessare i propri difetti. Svegliamoci, dunque, per poterci rendere conto dei nostri errori. Ma solo la filosofia può destarci, può scuoterci dal nostro sonno profondo: dédicatici completamente, tu sei degno di lei, lei è degna di te: abbracciatevi. Respingi con forza e apertamente tutte le altre occupazioni: non puoi dedicarti alla filosofia di tanto in tanto. Se tu fossi malato, avresti smesso di curarti del tuo patrimonio e dimenticato gli affari forensi, non stimeresti nessuno così importante da assisterlo come avvocato nei momenti di tregua della malattia: cercheresti con tutte le tue forze di liberarti della malattia al più presto possibile. Dunque? Perché non fai lo stesso anche adesso? Rimuovi ogni impedimento e dedicati alla saggezza: non vi si giunge se si è pieni di impegni. La filosofia esercita il suo potere in modo assoluto e perentorio, è lei che assegna il tempo, non lo riceve da noi, è un’attività fondamentale, non accessoria, è padrona, ci sta dappresso e ci comanda. Alessandro, a una città che gli prometteva una parte delle terre e la metà di tutte le ricchezze, rispose: «Non sono venuto in Asia per accettare ciò che voi mi avreste dato, ma affinché voi aveste ciò che io vi avrei lasciato». La stessa cosa dice la filosofia: «Non intendo accettare il tempo che avanza a voi: voi avrete quello che io ricuserò». Rivolgile dunque tutta la tua attenzione, stalle accanto, onorala: si creerà un grande divario fra te e gli altri; sarai di molto superiore agli uomini e gli dèi non saranno di molto superiori a te. Vuoi sapere quale differenza ci sarà fra te e loro? Gli dèi vivranno più a lungo, ma, per Èrcole, è proprio di un valente artista racchiudere tutto in un piccolo spazio. Ebbene, la vita del saggio si estende quanto per dio l’eternità. E c’è qualcosa in cui il saggio è superiore a dio: questi non teme alcunché in conseguenza della sua natura, il saggio per merito suo. Ecco una cosa grandiosa: avere la debolezza di un uomo e la tranquillità di un dio. Incredibile è la forza della filosofia nel respingere ogni attacco della sorte. Nessun dardo penetra nel suo corpo, è ben difesa e salda; alcuni dardi li neutralizza, parandoli con le pieghe dell’ampia veste, come se fossero piume, altri li rende vani e li respinge contro chi li aveva lanciati. Stammi bene. 54. La malattia mi aveva concesso una lunga tregua; all’improvviso mi ha assalito nuovamente. Mi chiedi di che malattia si tratti, e giustamente, visto che le conosco tutte. Ma in particolar modo sono soggetto a una, che non so perché chiamerei con un’espressione greca: “difficoltà di respiro” è una definizione
abbastanza appropriata. L’attacco è di breve durata e somiglia a una tempesta, generalmente se ne va nel giro di un’ora: nessuno, infatti, può esalare il respiro in un tempo così lungo. Su di me sono passati tutti i malanni e i pericoli a cui può essere soggetto il nostro corpo, ma questo è il più fastidioso. E come potrebbe non esserlo? Essere affetti da qualunque altro male significa essere ammalati, ma questo è come esalare l’anima. Perciò i medici lo chiamano “preparazione alla morte”; prima o poi il respiro fa ciò che spesso ha tentato. Credi che ti scriva queste cose contento per averla scampata? Sarei ridicolo se mi compiacessi di questa cessazione del male quasi che fosse una guarigione, come chi credesse di avere vinto una causa perché è riuscito a rinviarla. Tuttavia anche mentre mi sentivo soffocare ho trovato conforto in lieti e forti pensieri. «Cos’è questo?», mi dico. «La morte mi mette alla prova così spesso? Faccia pure: io l’ho sperimentata a lungo». «Quando?», mi chiedi. Prima di nascere. La morte è non esistere, e io ormai so in che consiste: dopo di me sarà ciò che è stato prima di me. Se nella morte c’è tormento, necessariamente vi fu anche prima che venissimo alla luce; eppure, allora non provammo alcun dolore. Ti chiedo: se uno credesse che per una lucerna sia peggio quando è stata spenta che prima di essere accesa non lo giudicheresti uno stupido? Anche noi ci accendiamo e ci spegniamo: nell’intervallo proviamo qualche sofferenza, ma prima e dopo c’è una profonda tranquillità. In questo, infatti, Lucilio mio, se non m’inganno, ci sbagliamo: crediamo che la morte ci segua, mentre essa ci ha preceduto e ci seguirà. Tutto ciò che è stato prima di noi è morte; che importa, allora, non cominciare a vivere o finire, quando il risultato in entrambi i casi è non esistere? Durante l’attacco continuavo a rivolgere a me stesso queste esortazioni e altre dello stesso genere (in silenzio, naturalmente, poiché non potevo parlare); poi, a poco a poco, quella difficoltà di respiro, che ormai si era trasformata in affanno, mi concesse pause più lunghe, finché si placò. Ma ha lasciato uno strascico e, benché l’attacco sia terminato, la respirazione non è ancora regolare, è come impacciata e rallentata. Sia come sia, purché l’affanno non provenga dall’animo. Quanto a me, sta’ sicuro: non trepiderò nell’istante supremo, ormai sono preparato, non pianifico l’intera giornata. Tu apprezza e imita colui che non si rammarica di dover morire, anche se gli piace vivere: che coraggio ci vuole, infatti, a uscire di scena quando ne sei cacciato? Anche in questo caso, però, può esserci coraggio: sono sfrattato, sì, ma è come se me ne andassi spontaneamente. Perciò il saggio non si sentirà mai scacciato, perché scacciato significa espulso da un luogo da cui ci si allontana contro la propria volontà, mentre il saggio non fa nulla contro voglia: egli sfugge alla necessità in quanto vuole ciò che essa lo costringe a subire. Stammi bene. 55. Sono appena tornato da una passeggiata in lettiga, stanco come se avessi camminato tutto il tempo in cui sono stato seduto: anche l’essere trasportati a lungo, infatti, è una fatica, forse maggiore perché contro natura, che ci ha dato i
piedi per camminare e gli occhi per vedere. Le comodità ci hanno infiacchito e non possiamo più fare ciò che per lungo tempo non abbiamo voluto. Ma dovevo scuotere il corpo, sia perché se ne andasse la bile che mi si era fermata in gola, sia perché lo sballottolamento – che indubbiamente mi ha giovato – normalizzasse il respiro che per qualche motivo s’era fatto troppo frequente. Per questo ho continuato a farmi trasportare, attirato dalla spiaggia, che si incurva tra Cuma e la villa di Servilio Vazia, 3 chiusa da una parte dal mare e dall’altra da un lago4 sì da formare uno stretto passaggio. Una recente burrasca aveva reso l’arenile compatto poiché se le onde impetuose e continue lo livellano una calma prolungata lo disgrega, inquantoché la sabbia, ch’è tenuta insieme dall’acqua, si prosciuga. Com’è mia abitudine, ho cominciato a guardarmi attorno per trovare qualcosa che potesse essermi utile, e ho rivolto lo sguardo alla villa che un tempo era di Vazia: è lì che invecchiò quel ricco ex pretore, famoso unicamente per l’ozio in cui viveva, e per questo solo motivo ritenuto fortunato, talché ogni volta che qualcuno cadeva in disgrazia, vuoi per l’amicizia di Asinio Gallo, 5 vuoi per l’odio o l’amore per Seiano6 (era infatti pericoloso tanto l’averlo offeso quanto l’averlo amato), la gente esclamava: «O Vazia, soltanto tu sai vivere!». Ma lui sapeva stare nascosto, non vivere, e c’è una grande differenza fra una vita ritirata e una vita inoperosa. Quando Vazia era vivo ogni volta che passavo davanti a questa villa esclamavo: «Qui è sepolto Vazia!». Ma, caro il mio Lucilio, la filosofia è così sacra e venerabile che ciò che le assomiglia anche se contraffatto ci piace. La massa, infatti, considera chi conduce una vita appartata una persona libera da impegni, tranquilla e soddisfatta di sé, che vive per sé stessa, quando queste, invece, sono cose che possono capitare soltanto al saggio. Lui solo sa vivere per sé stesso, semplicemente perché sa vivere, che è la cosa più importante. Chi fugge uomini e cose, chi si apparta perché deluso nelle sue aspettative, chi non ha potuto resistere alla vista di gente più fortunata, chi si nasconde per paura, come un animale pavido e imbelle, non vive per sé, vive per il ventre, per il sonno, per la lussuria, cosa vergognosissima: non vive per sé chi non vive per alcuno. Tuttavia, la costanza e la perseveranza nei propri propositi è una cosa così grande che anche una ostinata inoperosità incute un certo rispetto. Sulla villa non posso dirti nulla di preciso, poiché non ne conosco che la facciata e l’esterno, visibili a chiunque vi passi davanti. Ci sono due grotte artificiali, frutto di un grande lavoro, ampie come un vasto atrio, delle quali una non è mai illuminata dal sole, l’altra lo è fino al tramonto. Un ruscello che raccoglie le acque del mare e del lago Acherusio, simile a un canale, attraversa un boschetto di platani e basta ad alimentare dei pesci, anche se vi si attinge in continuazione. Ma quando il mare è accessibile lo si risparmia: solo se la burrasca costringe i pescatori al riposo si mette mano a quella comoda riserva. La maggiore comodità della villa, però, sta nel fatto che al là di essa c’è Baia, di cui così si godono i piaceri senza averne gli inconvenienti. So che la villa ha anche questo vantaggio: è abitabile tutto l’anno, poiché vi soffia lo zefiro e in
tale abbondanza da toglierne a Baia. Vazia non è stato certo sciocco a scegliere questa località per condurvi da vecchio una vita ritirata e inoperosa. Ma il luogo in cui si risiede non reca un gran contributo alla serenità: è l’animo che dà valore alle cose. Ho visto uomini tristi in ville amene e ridenti, uomini che sembravano indaffarati in piena solitudine. Non devi dunque pensare di non star bene perché non sei in Campania. E perché poi non ci sei? Rivolgi qui i tuoi pensieri: ci si può intrattenere con gli amici assenti ogni volta e per tutto il tempo che si vuole. La lontananza ci rende più gradito questo enorme piacere, mentre la frequentazione ci fa esigenti, e poiché parliamo, passeggiamo e sediamo in compagnia, dopo che ci siamo separati non pensiamo più alle persone che abbiamo visto da poco. Perciò dobbiamo sopportare di buon animo la lontananza, anche perché si può essere molto lontano da uno pur standogli vicino. Pensa prima di tutto alle notti passate da soli, poi alle occupazioni diverse, agli studi fatti in solitudine, agli spostamenti fuori città: vedrai che i viaggi non ci tolgono molto. L’amico bisogna averlo nel cuore, e questo non è mai lontano: ogni giorno vede chiunque vuole. Perciò studia con me, pranza con me, passeggia con me: avremmo un orizzonte davvero ristretto se ci fosse qualcosa che il nostro pensiero non potesse abbracciare. Io ti vedo, Lucilio, ti sento al massimo, ti sono tanto vicino che non so se cominciare a scriverti dei biglietti più che delle lettere. Stammi bene. 56. Possa io morire se quando si sta appartati a studiare il silenzio è necessario come generalmente si crede. Ecco, intorno a me risuonano da tutti i lati strepiti di ogni genere: io abito proprio sopra i bagni pubblici. Ebbene, immagina qualsiasi tipo di rumore fastidioso agli orecchi: quando i più robusti si allenano sollevando i pesi e si affaticano o fingono di affaticarsi sento dei gemiti e ogni volta che respirano mi arrivano sibili e ansiti; quando poi c’è qualche pigro a cui basta farsi massaggiare sento lo scroscio delle mani che picchiano sulle sue spalle e che producono un suono diverso a seconda che le mani battano piatte o incavate. Se poi ci si mettono anche quelli che giocano a palla e contano i colpi, è finita. Aggiungi a questi il litigioso, il ladro colto in flagrante, quello a cui piace ascoltarsi mentre fa il bagno, le persone che si tuffano in piscina e nello smuovere l’acqua fanno un grande fracasso. Oltre a costoro, le cui voci almeno sono normali, pensa al depilatore che il più delle volte per farsi notare parla con una vocina stridula e sottile e tace solo quando depila le ascelle perché un altro grida in vece sua. Ci sono infine gli strilli del venditore di bibite, del salsicciaio, del pasticcere e di tutti i gestori delle taverne che vendono la loro merce con una particolare intonazione della voce. Tu dici che sono di ferro oppure sordo se riesco a restare presente a me stesso fra tanti rumori diversi e discordi, mentre al nostro Crisippo7 sembra di morire solo a furia di salutare la gente. Ma io, per Ercole, di tutto questo baccano non mi curo più che del rumore che fa lo scorrere o il cadere dell’acqua, anche se so di un popolo che ha cambiato sede per questo solo
motivo: non poteva sopportare il fragore delle cascate del Nilo. A me sembra che la voce distragga più del rumore, perché la voce attira l’attenzione, mentre il rumore si limita a colpire e a riempire le orecchie. Fra i rumori che mi risuonano intorno senza distrarmi ci sono quelli delle vetture che passano di corsa, l’artigiano, mio coinquilino, e il fabbro che gli sta accanto, oppure quel tale che prova flauti e trombette presso la Meta Sudante,8 il quale non suona, ma strepita: un suono intermittente mi infastidisce più di uno continuo. Ormai, però, sono diventato così refrattario a tutti questi rumori che potrei persino sentire il capo dei rematori battere il tempo con la sua voce stridula. Costringo la mia mente a rimanere assorta senza farsi distrarre dai rumori esterni: risuoni pure fuori di me ogni tipo di rumore, purché dentro di me non vi sia alcun tumulto, non combattano fra loro la cupidigia e la paura, e l’avarizia e l’intemperanza non lottino e non si tormentino a vicenda. A che serve infatti il silenzio di tutto il quartiere se dentro di noi fremono le passioni? Tutto era calmo e tranquillo nella placida quiete notturna.9 Non è vero : la sola placida quiete che esiste è quella disposta dalla ragione; la notte, infatti non elimina l’inquietudine ma la fa sentire, cambia solo i tipi di affanni. Quando dormiamo i nostri sogni sono tormentati come le nostre giornate: la vera tranquillità è quella in cui si distende la saggezza. Guarda quell’uomo a cui si cerca di facilitare il sonno facendo silenzio nella vasta abitazione: tutta la schiera dei servi tace e quelli che passano vicino alla sua stanza camminano in punta di piedi affinché nessun rumore disturbi le sue orecchie: nonostante ciò, lui si gira di qua e di là cercando di cogliere una manciata di sonno in mezzo alle preoccupazioni che lo agitano; si lamenta di aver sentito un rumore mentre in realtà non ha udito niente. Qual è secondo te la ragione? È l’anima che strepita dentro di lui, è questa che bisogna calmare, è la sua rivolta che va sedata; non devi credere che l’anima sia tranquilla quando il corpo riposa: a volte anche la quiete è piena di inquietudine; perciò quando l’inoperosità, insofferente di sé stessa, ci fa star male dobbiamo agire e impegnarci in qualche nobile attività. I grandi generali, quando vedono che un soldato obbedisce contro voglia, gli fanno fare qualcosa, lo impiegano in spedizioni militari. A chi è molto impegnato manca il tempo per dedicarsi alla dissolutezza. È indubbio che il lavoro elimina i vizi generati dall’ozio. Spesso ci si ritira a vita privata apparentemente perché disgustati dall’attività politica e intolleranti di una condizione spiacevole e non gradita; e però in quel rifugio, in cui ci hanno confinato la paura e la stanchezza, certe volte si risveglia l’ambizione, che non avevamo rimosso del tutto, ma che si era come abbattuta o risentita perché le nostre aspettative erano andate in fumo. La stessa cosa dico per la dissolutezza: a volte sembra che sia definitivamente scomparsa, ma poi tormenta chi si atteggia a moderato e anche nella parsimonia va ricercando i piaceri: questi, infatti erano solo stati abbandonati, non condannati; così quanto più la dissolutezza è nascosta tanto
maggiore è l’impeto con cui li ricerca. Tutti i vizi sono meno gravi quando si vedono, le malattie si avviano già verso la guarigione nel momento in cui esplodono e mostrano la loro virulenza. Tieni presente che l’avarizia, l’ambizione e le altre malattie spirituali dell’uomo sono molto pericolose se si celano sotto una salute apparente. Sembriamo calmi ma in realtà non è così. Se siamo in buona fede, se raccogliamo tutte le nostre forze se, come ho detto poco fa, disprezziamo le belle apparenze, nulla ci distrarrà: non ci saranno voci d’uomini o canti di uccelli che potranno interrompere i nostri buoni propositi ormai fermi e decisi. Chi bada alle voci e agli eventi occasionali possiede un carattere incostante e incapace di raccoglimento interiore, sta in ansia per timori e preoccupazioni, come scrive il nostro Virgilio: e me, che prima non atterriva il lancio delle frecce o alcun assalto dei Greci serrati in folta schiera, adesso ogni più lieve soffio d’aria spaventa, ogni rumore tiene sospeso, timoroso insieme per chi mi segue e per il dolce peso.10 Il primo è il saggio, che non teme i dardi scagliatigli contro, né l’urto delle schiere in fila serrata, né il fragore di una città assediata, il secondo è il profano, che sta in ansia per i suoi beni e trasale al minimo rumore, si abbatte per una qualsiasi voce, scambiandola per una minaccia, trattiene il respiro al più lieve movimento e teme per i suoi bagagli. Prendi uno qualunque tra questi fortunati che si portano dietro o sulle spalle molti beni e lo vedrai “temere per il compagno e per il peso”. Sappi che sarai veramente tranquillo solo quando non ti toccherà alcun rumore, non ti scuoterà alcuna voce, né carezzevole, né minacciosa, né vana o falsa che sia. «E che, dunque? Non è più conveniente, allora, evitare tutto questo frastuono?». Senz’altro: perciò lascerò questa casa. Ho voluto mettermi alla prova e fare esperienza: perché continuare a soffrire quando Ulisse trovò per i suoi compagni un rimedio semplicissimo anche contro le Sirene? Stammi bene. 57. Dovendo tornare da Baia a Napoli, ho finto di credere che ci fosse burrasca per non rifare una seconda volta l’esperienza della nave; ma la strada era tutta così fangosa che è come se avessi viaggiato per mare. Quel giorno ho dovuto sopportare sino in fondo il destino degli atleti: dopo l’unguento ci è toccata la polvere nella galleria di Posillipo. Niente è più lungo di quella specie di carcere, niente più oscuro di quelle torce, che ci servono non per vedere attraverso le tenebre, ma per vedere le tenebre. Del resto quand’anche ci fosse la luce ci penserebbe la polvere a mangiarsela: già è tanto fastidiosa e molesta all’aperto, pensa cosa sia là dentro, dove gira vorticosamente su sé stessa e chiusa com’è senza alcuno spiraglio ricade su chi la solleva camminando. Abbiamo sopportato contemporaneamente due inconvenienti opposti: sulla stessa strada, nello stesso giorno abbiamo penato per il fango e per la polvere.
Tuttavia quell’oscurità mi ha dato modo di fare alcune riflessioni, poiché ho sentito come un colpo al cuore e un’alterazione del mio stato, senza paura, però, provocato dalla novità e dalla turpitudine di quel fatto insolito. Non ti parlo di me, che sono molto lontano dall’essere paziente e dall’aver raggiunto la perfezione, ma di uno che pur essendosi sottratto al dominio della sorte è tuttavia sensibile ai colpi e sbianca in volto. Nemmeno l’uomo più virtuoso, infatti, Lucilio mio, riesce a sfuggire a certe reazioni: la natura gli ricorda che è mortale. Perciò anche lui contrae il viso di fronte al dolore, viene colto dai brividi davanti agli imprevisti e gli si annebbia la vista se dall’orlo di un abisso guarda giù: non è paura, questa, è una sensazione istintiva che la ragione non riesce a dominare. Ecco perché anche uomini coraggiosi e prontissimi a versare il proprio sangue non sopportano la vista del sangue altrui, alcuni nel veder medicare o esaminare una ferita, recente ma anche vecchia e purulenta, cadono a terra e svengono, altri preferiscono ricevere un colpo di spada piuttosto che vederlo vibrare. Dunque, come dicevo, avvertii non un turbamento, ma una alterazione: poi, appena vidi riapparire la luce, senza pensarci sopra e tanto meno impormelo, ripresi la mia consueta vitalità e cominciai a dirmi quanto siamo sciocchi a temere certe cose di più e certe di meno, quando il risultato è comunque lo stesso. Che differenza c’è se ci crolla addosso il casotto delle sentinelle o una montagna? Nessuna. Eppure c’è chi teme di più il crollo di questa che non di quello, sebbene entrambi siano ugualmente mortali: la paura, dunque, bada più alle cause che agli effetti. A questo punto pensi ch’io ti parli degli stoici, secondo i quali l’anima di un uomo schiacciato sotto un grave peso, non trovando una via d’uscita, non può durare a lungo e si dissolve subito? In verità io non la penso così: chi dice questo a mio parere sbaglia. Come una fiamma non può essere schiacciata, poiché fugge di qua e di là intorno a ciò che la comprime, come l’aria non viene ferita da colpi e frustate e nemmeno si lacera ma si riversa intorno all’oggetto che ne ha preso il posto, allo stesso modo l’anima, fatta di una sostanza sottilissima, non può essere presa o uccisa dentro il corpo, ma, in virtù della sua sottigliezza, si apre un varco attraverso ciò che la comprime. Come il fulmine, dopo aver colpito e illuminato un ampio spazio, si ritira attraverso una piccola apertura, così l’anima, che è ancora più sottile del fuoco, può fuggire attraverso ogni corpo. Da qui sorge il problema se sia immortale oppure no. Tieni per certo questo: se sopravvive al corpo non c’è nulla che possa annientarla, poiché l’immortalità non ammette eccezioni, e, d’altra parte, nulla può nuocere a ciò che è eterno. Stammi bene. 58. Non mi sono mai reso conto come oggi della nostra povertà o penuria di parole. Si parlava per caso di Platone e intervenivano mille concetti che richiedevano un vocabolo appropriato e non lo si trovava, e altri che, pur avendolo avuto in passato, avevano finito col perderlo per la nostra schizzinosità. Ma si può essere schizzinosi nella miseria? I nostri avi
chiamavano asilus quello che i greci chiamano oistros, cioè l’insetto che perseguita il bestiame e lo disperde per i pascoli. Devi credere a Virgilio che dice: Prossimo al bosco del Silaro e all’Alburno fiorente di lecci vola in fitti sciami un insetto, che asìlo si chiama a Roma, in Grecia oistro: molesto, col verso stridente turba gli armenti e li volge in fuga per i boschi.11 È chiaro che il vocabolo è caduto in disuso. Per non allungare il discorso si usavano delle forme semplici come cernere ferro inter se . Lo testimonia Virgilio stesso: ingentis genitos diversis partibus orbis, inter se coiisse viros et cernere ferro.12 Noi ora diciamo decernere, essendosi perso l’uso della parola semplice. Gli antichi dicevano si iusso, ora si dice iussero. Non devi credere a me, ma sempre a Virgilio, che dice: cetera, qua iusso, mecum manus inferat arma.13 Tutto questo mio scrupolo non è per dimostrarti quanto tempo ho perduto per studiare la grammatica, ma per farti capire quante parole usate da Ennio e da Accio siano cadute in disuso, visto che sono state eliminate parole di Virgilio che pure leggiamo ogni giorno. «Che significa questo preambolo? Dove vuole arrivare?». Non te lo nasconderò: voglio, se è possibile, usare la parola essentia col tuo consenso; ma la userò ugualmente anche se non ti piace. Garante autorevole di questo vocabolo è Cicerone e, se ne vuoi uno più fresco, Fabiano, facondo e raffinato, brillante per eloquenza anche per i nostri gusti difficili. Altrimenti cosa accadrà, Lucilio mio? Come rendere la parola ousìa, la realtà necessaria, la sostanza che racchiude in sé il fondamento di tutte le cose? Consentimi dunque, ti prego, di usare questa parola. Tuttavia cercherò di esercitare con molta parsimonia il diritto che mi concedi, anzi mi basterà di averlo ottenuto. Ma a cosa mi gioverà il tuo consenso se non posso esprimere in nessun modo in latino il concetto in base al quale ho criticato la nostra lingua? Tanto più condannerai i limiti della lingua latina, sapendo che è una sola la sillaba che non posso tradurre. Quale? Tò on. Ti sembrerò un po’ ottuso: è chiaro, infatti, che si può tradurre con “ciò che è”. Ma vedo una grande differenza, poiché sono costretto a usare un verbo invece di un sostantivo; ma se è necessario dirò “ciò che è”. Oggi il nostro amico, uomo molto erudito, mi diceva che Platone usa questo termine con sei significati differenti. Te li dirò tutti, ma prima devo spiegarti che
una cosa è il “genere” un’altra la “specie”. Cerchiamo ora quel genere primo da cui dipendono le altre specie, da cui deriva ogni divisione, in cui sono comprese tutte le cose. Lo troveremo passando in rassegna a ritroso uno per uno tutti gli esseri, arrivando così al primo genere. Come dice Aristotele, l’uomo è una specie; il cavallo è una specie, e così pure il cane. Occorre dunque cercare un legame comune a questi esseri, che li abbracci e li comprenda sotto di sé. Qual è questo legame? Il genere animale. Dunque comincia a esserci un genere di tutte le specie di esseri che ho menzionato – uomo, cavallo, cane – cioè l’animale. Però ci sono esseri che hanno un principio vitale ma non sono animali: alle piante e agli alberi infatti si attribuisce uno spirito vitale e perciò diciamo che vivono e muoiono. Gli esseri animati, quindi, occuperanno il primo posto, perché in questa categoria sono compresi gli animali e le piante. Sennonché esistono cose prive di spirito vitale, come i sassi, dunque ci sarà qualcosa che viene prima degli esseri animati, cioè il corpo. Ebbene, dividerò i corpi in due categorie: animati e inanimati. Ma al di sopra del corpo c’è ancora qualcosa, visto che parliamo di cose corporee e incorporee. Cosa sarà, dunque, ciò da cui derivano? Quello che poco fa abbiamo definito impropriamente “ciò che è”. Ora lo divideremo in specie e diremo: “ciò che è” o è corporeo o è incorporeo: questo è il genere primo, il più antico e, per così dire, universale, mentre gli altri sono generi particolari. Per esempio, l’uomo è un genere, e ha in sé come specie le nazionalità: Greci, Romani, Parti; i colori: bianchi, neri, biondi; gli individui: Catone, Cicerone, Lucrezio. Perciò, poiché racchiude molte specie di esseri è un genere, ed è una specie in quanto è subordinato a un altro genere. Il genere generale “ciò che è” non ha niente al di sopra di sé: è il principio delle cose, a cui è subordinato tutto. Gli stoici vogliono porre al di sopra di questo un altro genere, che viene ancora prima. Ne parlerò subito dopo aver dimostrato che quel genere di cui ti ho detto occupa a ragione il primo posto, perché può contenere in sé tutte le cose. “Ciò che è” lo divido in due specie, in modo che ci siano una corporea e una incorporea, una terza non ce n’è. E il corpo come lo divido? In esseri animati o inanimati. E gli esseri animati, a loro volta, come li divido? Alcuni hanno l’anima, altri hanno solo il principio vitale; oppure: certi si muovono, avanzano, si spostano da un luogo all’altro, certi, fissi al suolo, si nutrono attraverso le radici e crescono. E ancora: gli esseri animati in quali specie li divido? In esseri mortali o immortali. Alcuni stoici ritengono che il primo genere sia un quid, un qualcosa. Ed ecco il motivo. «In natura», dicono, «certe cose esistono, altre non esistono; ma la natura comprende anche quelle che non esistono, o che esistono solo nella nostra immaginazione, come i Centauri,14 i Giganti15 e tutto ciò che, nato da una falsa credenza, ha assunto una qualche immagine, sebbene priva di sostanza». Torno ora all’argomento che ti ho promesso, cioè come Platone divida tutti gli esseri in sei categorie. Quel primo elemento definito “ciò che è” non si percepisce né con la vista né col tatto né con qualcun altro senso: può essere solo pensato. Ciò che esiste in universale, come il genere uomo, non è visibile: è
visibile il particolare, come Cicerone e Catone. Così il genere animale non lo si vede, lo si pensa. Però se ne vede la specie, il cavallo e il cane. Al secondo posto fra tutti gli esseri Platone colloca quello che sovrasta ed è superiore a tutti, definendolo l’essere per eccellenza. Poeta è un nome comune (e infatti tutti coloro che compongono versi sono chiamati così); ma già presso i Greci la parola ne designava uno solo, per cui sentendo dire poeta si intendeva Omero. Chi è dunque questo essere? Evidentemente dio, il più grande e il più potente di tutti gli esseri. La terza categoria comprende quegli esseri che hanno un’esistenza propria: sono innumerevoli, ma non visibili da noi. Quali sono? Sono le suppellettili proprie di Platone; egli le chiama “idee”, dalle quali derivano tutte le cose che vediamo e sulle quali tutte si modellano. Sono immortali, immutabili, inviolabili. Ascolta ora che cosa è un’idea o più precisamente che cosa Platone ritiene che sia: «l’idea è il modello eterno di tutto ciò che la natura crea». Ti spiegherò questa definizione affinché il concetto ti sia più chiaro. Voglio fare il tuo ritratto. Tu sei il modello del mio dipinto, dal quale la mia mente deriva un aspetto da fissare nell’opera. Ebbene quell’immagine che mi ammaestra e mi indirizza e a cui io mi rivolgo per imitarla è l’idea. La natura possiede un numero infinito di tali modelli, di uomini, di pesci, di alberi, su cui si conforma tutto ciò che nasce da essa. Il quarto posto lo occupa l’idos. Devi fare attenzione per capire cosa sia questo idos e attribuire a Platone, non a me, la difficoltà di questi concetti; d’altra parte non c’è sottigliezza priva di difficoltà. Poco fa ho usato l’esempio del pittore. Ebbene, questi, volendo fare il ritratto di Virgilio, doveva osservarlo. Il volto di Virgilio era l’idea, il modello dell’opera futura; ciò che l’artista ne ricava e ha impresso nella sua opera è appunto l’idos. Che differenza c’è?, mi domandi. L’idea è il modello, l’ idos la forma ricavata dal modello e impressa nell’opera; l’artista una la imita, l’altra la crea. La statua ha un suo certo aspetto; questo è l’idos. Anche il modello ha un suo certo aspetto, osservando il quale l’artista ha forgiato la statua: questa è l’idea. Se vuoi un’altra distinzione ti dirò ancora: l’idos è nell’opera, l’idea è fuori dell’opera, e non solo fuori ma precedente a essa. Alla quinta categoria appartengono gli esseri che esistono in senso comune e sono quelli che cominciano a riguardarci; qui c’è tutto: uomini, bestie, cose. La sesta categoria comprende ciò che quasi esiste, come lo spazio e il tempo. Tutto ciò che vediamo o tocchiamo Platone non lo annovera fra gli esseri che secondo lui hanno un’esistenza propria, poiché essi scorrono e diminuiscono o crescono continuamente. Nessuno di noi, infatti, nella vecchiaia è lo stesso di quello che era in gioventù, nessuno di noi al mattino è lo stesso del giorno prima. I nostri corpi sono trascinati via come le acque di un fiume, tutto ciò che vedi vola insieme col tempo, niente di ciò che cade sotto i nostri occhi permane, io stesso mentre dico che queste cose mutano sono già cambiato. Eraclito dice: «Non ci si può immergere due volte nello stesso fiume». Infatti il nome del fiume resta sempre lo stesso, ma l’acqua è passata oltre. Il fenomeno è più evidente in un corso d’acqua che nell’uomo; ma un flusso altrettanto veloce trascina via
anche noi, perciò mi meraviglio della nostra insensatezza: amiamo tanto una cosa fugacissima come il nostro corpo e temiamo di dover morire un giorno o l’altro quando ogni momento è la morte del nostro stato precedente, per cui è sciocco temere che accada una volta ciò che accade ogni giorno! Ho parlato dell’uomo, materia fragile e caduca, esposta a ogni accidente, ma anche l’universo, eterno e indistruttibile, muta e non rimane mai uguale a sé stesso. Infatti, sebbene contenga in sé tutti gli elementi originari, li ha diversi dallo stadio primitivo: cambia l’ordine. Mi dirai: «A che mi servono queste sottigliezze?». A niente, se devo dirti il mio parere; ma come l’incisore distoglie e rivolge altrove gli occhi stanchi per la lunga concentrazione e, come si suol dire, li ristora, così anche noi di tanto in tanto dobbiamo concedere riposo al nostro animo e ricrearlo con qualche distrazione. Anche le distrazioni, però, devono essere attività, se farai attenzione potrai ricavare anche da esse utili insegnamenti. Caro Lucilio, io di solito mi comporto così: da qualsiasi nozione cerco di tirar fuori e di procurarmi qualcosa di utile, indipendentemente dal fatto che abbia o no a che fare con la filosofia. Gli argomenti che abbiamo appena trattati non hanno niente a che vedere con la condotta morale. Come possono infatti migliorarmi le idee platoniche? Quale insegnamento posso trarne per dominare le mie passioni? Questo, per esempio: Platone nega che tutte quelle cose soggette ai sensi che ci infiammano e ci eccitano abbiano un’esistenza vera e propria. Sono dunque cose immaginarie, hanno solo temporaneamente una forma esteriore, ma non sono né stabili né concrete, eppure noi le desideriamo come se fossero eterne o potessimo possederle per sempre. Deboli e fragili come siamo, ci soffermiamo fra cose prive di sostanza, quando invece dovremmo rivolgere l’animo a ciò che è eterno. Ci meravigliamo vedendo le forme di tutte le cose volare in alto in alto e in mezzo a loro dio, che provvede a difendere dalla morte quegli esseri che non ha potuto creare immortali per via della materia che è mortale e a vincere con la ragione i difetti del corpo. L’universo resta in vita non perché sia eterno ma perché è difeso dalla cura di chi lo governa: se fosse immortale non avrebbe bisogno di un protettore. Il sommo artefice lo conserva, vincendo con la sua potenza la caducità della materia. Disprezziamo, dunque, tutto ciò che è privo di valore, tanto da dubitare persino della sua esistenza. Al tempo stesso pensiamo che se la provvidenza sottrae ai pericoli l’universo, che è mortale come noi, anche noi con la nostra previdenza possiamo, entro certi limiti, prolungare la vita di questo misero corpo, se saremo capaci di governare e frenare i piaceri, che causano la morte della maggior parte degli uomini. Platone giunse alla vecchiaia per la cura che dedicava a sé stesso. Aveva avuto in sorte un fisico forte e robusto, tanto che dall’ampiezza del torace gli era derivato quel soprannome,16 ma i viaggi per mare e i pericoli avevano diminuito molto le sue forze; tuttavia la sobrietà e la moderazione dei piaceri che suscitano i desideri dell’uomo, più la scrupolosa cura di sé stesso, gli consentirono di arrivare alla vecchiaia nonostante i molti ostacoli. Tu sai bene, infatti, che Platone, grazie alla sua
cautela, morì esattamente il giorno del suo ottantunesimo compleanno. Per questo alcuni magi, che casualmente si trovavano ad Atene, celebrarono un sacrificio in onore del defunto, poiché ritenevano che gli fosse toccato un destino superiore alle umane possibilità, in quanto i suoi anni corrispondevano a un numero perfettissimo risultante dalla moltiplicazione di nove per nove. Sono certo che tu saresti pronto a rinunciare sia a pochi giorni fra tanti anni, sia al sacrificio in tuo onore. La sobrietà può prolungare la vecchiaia: io non ritengo né che si debba desiderare ardentemente né che sia da rifiutarsi, poiché è piacevole stare in compagnia di sé stessi il più a lungo possibile, quando ci si sia resi degni di goderne. Perciò ti dirò il mio parere sulla questione: se si debba disdegnare la vecchiaia avanzata e non aspettare che arrivi la morte, ma darsela con le proprie mani. Chi attende inoperoso il suo destino finale non è molto diverso da chi lo teme, così come è un ubriacone colui che vuota la bottiglia e beve anche la feccia. Tuttavia viene da chiederci se l’ultima parte della vita sia feccia o invece qualcosa di limpidissimo e di purissimo, naturalmente a condizione che le facoltà mentali siano integre e i sensi, anch’essi integri, aiutino l’anima, e il corpo, da parte sua, non sia sfinito e morto prima del tempo; è infatti molto importante se si prolunga la vita o la morte. Ma se il corpo non assolve più le sue funzioni, perché non si dovrebbe liberare l’anima oppressa dalla sofferenza? E forse bisogna farlo un po’ prima del dovuto, affinché, quando poi arrivi il momento, non ci si trovi nella impossibilità di farlo; il pericolo di vivere male è maggiore di quello di morire presto, quindi è pazzo chi non evita il rischio di una grande disgrazia per guadagnare pochi giorni di vita. Pochi uomini sono morti vecchissimi senza subire alcun danno; molti sono vissuti passivamente e senza alcuna utilità: credi che sia più crudele aver perduto una parte della vita piuttosto che il diritto di mettervi fine? Non ascoltarmi contro tua voglia, come se queste mie riflessioni ti riguardassero ormai personalmente, e fa’ bene attenzione a ciò che ti dico: io non abbandonerò la vecchiaia se mi conserverà integro, ma integro nella parte migliore di me; ma se comincerà a turbarmi e a sconvolgermi la mente, se non mi lascerà la vita ma solo il soffio vitale, balzerò fuori dall’edificio marcio e cadente. Non fuggirò la malattia con la morte, purché sia guaribile e non danneggi l’anima. Non mi ucciderò per paura del dolore: morire così significa darsi per vinto. Tuttavia se saprò di dover sopportare quel dolore per tutta la vita me ne andrò, non per il dolore in sé stesso, ma perché esso mi sarebbe di ostacolo a tutte quelle attività che sono lo scopo dell’esistenza; è debole e vile chi si dà la morte per il dolore, è stolto chi continua a vivere per soffrire. Ma sto andando troppo per le lunghe, per di più l’argomento è così vasto che potrebbe richiedere una giornata intera; e come potrà mettere fine alla propria vita uno che non è capace di terminare una lettera? Addio, dunque leggerai questo commiato più volentieri di tutti i miei ragionamenti sulla morte. Stammi bene.
59. La tua lettera mi ha fatto molto piacere: permettimi di usare le parole secondo l’uso comune senza rifarmi a quello degli stoici. Noi crediamo che il piacere sia un vizio. Ammettiamolo, tuttavia di solito usiamo questa parola per indicare uno stato d’animo allegro. Certo, lo so che il piacere, se ci atteniamo al vocabolario stoico, è una cosa infamante, e che la gioia può toccare solo all’uomo saggio, essendo essa un’elevazione dell’animo fiducioso del bene e del vero che ha in sé stesso. Tuttavia generalmente diciamo di aver provato una grande gioia per l’elezione a console di un amico, o per le sue nozze, o perché la moglie ha partorito, tutti avvenimenti che sono ben lontani dall’essere una gioia, anzi, spesso sono inizio di sofferenze, mentre una caratteristica della gioia è il suo non venire mai meno e il non trasformarsi in dolore. Perciò quando il nostro Virgilio scrive le malvagie gioie dell’animo,17 si esprime con eleganza, ma con poca proprietà di linguaggio, poiché non esiste una gioia cattiva. Egli ha dato questo nome ai piaceri e così è riuscito a esprimere con chiarezza il suo pensiero, indicando gli uomini che sono contenti del proprio male. Tuttavia non a torto ho detto che la tua lettera mi ha fatto molto piacere; infatti, anche se è onesto il motivo per cui un uomo ignorante gioisce, quel sentimento che egli non sa dominare e che tende a mutarsi subito nel suo opposto, io lo chiamo piacere, in quanto nasce dall’idea di un falso bene, senza misura e moderazione. Ma per tornare al tema del nostro discorso, ti dirò cosa è che nella tua lettera mi ha recato piacere, il fatto, cioè, che riesci a dominare le parole e non ti lasci trasportare dalla foga oltre i limiti stabiliti. Molti sono indotti a scrivere ciò che non si erano proposti perché trascinati dalla bellezza di qualche parola affascinante; a te questo non succede: il tuo stile è stringato e attinente all’argomento; esponi chiaramente le tue idee e riesci a far capire più di quanto dici, il che è indice di un fatto importante: è chiaro, cioè, che nel tuo animo non c’è nulla di superfluo né di esagerato. Vi trovo, però, delle metafore ardite, anche se non al punto di essere pericolose; immagini che secondo alcuni non si dovrebbero usare perché consentite solo ai poeti. Costoro credo che non abbiano letto nessuno degli scrittori antichi, i quali non ricercavano ancora gli applausi coi loro discorsi, ma parlavano con semplicità per dimostrare la verità di un fatto e facevano largo uso di similitudini, che io ritengo necessarie non per lo stesso motivo per cui sono necessarie ai poeti, ma come dei sostegni alla nostra debolezza, per concentrare l’attenzione di chi parla e di chi ascolta sull’argomento di cui si tratta. Ora sto leggendo con molta attenzione Sestio,18 uomo acuto che scrive di filosofia in lingua greca, ma conformemente ai costumi dei Romani. Mi ha colpito questa sua immagine: un esercito marcia a colonne affiancate, pronto al combattimento, quando si teme un attacco nemico proveniente da ogni parte. «La
stessa cosa», egli dice, «deve fare l’uomo saggio, spiegare, cioè, in ogni direzione tutte le sue virtù, e dovunque si intraveda un pericolo, lì siano pronte le difese e rispondano al cenno del comandante senza scompigliarsi». Ciò che vediamo accadere negli eserciti guidati da grandi condottieri, che cioè il comando del capitano è sentito contemporaneamente da tutte le truppe disposte in modo che il segnale dato da uno solo arrivi simultaneamente ai fanti e ai cavalieri, secondo Sesto è ancora più necessario per noi. I soldati, infatti, spesse volte temono il nemico senza alcun motivo e la via che prima temevano tanto si rivela poi la più sicura: lo stolto, invece, non è mai tranquillo, la paura lo assale tanto dal basso quanto dall’alto, da destra e da sinistra, i pericoli gli vengono incontro e gli stanno anche dietro, ha paura di tutto, è sempre colto di sorpresa e persino gli aiuti che gli vengono portati lo atterriscono. Il saggio, invece è sempre pronto e premunito contro ogni attacco, non indietreggia se lo assalgono la povertà, i lutti, il dolore e l’infamia: egli avanza imperterrito contro di essi e in mezzo a essi. Sono molte le cose che ci legano e ci indeboliscono. Se siamo rimasti a lungo immersi nei vizi ci riesce difficile liberarcene: non ci siamo solo macchiati, ci siamo addirittura infettati. Per non passare da una similitudine all’altra, ti chiederò una cosa su cui rifletto spesso: perché la stoltezza ci domina con tanta ostinazione? Prima di tutto perché non la respingiamo con decisione e non tendiamo con tutte le nostre forze alla salvezza, in secondo luogo perché non confidiamo abbastanza nelle verità scoperte dai saggi, non le accogliamo a cuore aperto e ci dedichiamo con leggerezza a una questione tanto importante. Come può imparare ciò che serve per combattere i vizi chi vi si applica solo nei ritagli di tempo che gli lasciano i vizi? Noi non andiamo al fondo delle cose, cogliamo solo ciò che è in superficie, e per chi è così affaccendato i pochi momenti dedicati alla filosofia bastano e avanzano. Siamo ostacolati soprattutto dal fatto che ci accontentiamo troppo presto di noi stessi e se c’è qualcuno che ci considera virtuosi, onesti e assennati, noi subito ci crediamo. Non ci accontentiamo di lodi misurate, ma accogliamo come se ci fossero dovute tutte le adulazioni che ci vengono rivolte senza alcun ritegno. Siamo d’accordo con coloro che ci definiscono virtuosissimi e molto saggi, pur sapendo che essi mentono spesso e volentieri, e siamo così indulgenti con noi stessi perché vogliamo essere lodati proprio per quelle virtù a cui noi siamo massimamente contrari. Il carnefice si sente definire l’uomo più mite del mondo proprio nel momento in cui tortura, il ladro che vive di ruberie l’uomo più generoso, il libertino l’uomo più temperante proprio mentre si abbandona alla lussuria e all’ubriachezza; il risultato è che non vogliamo correggerci perché crediamo di esseri perfetti. Alessandro andava girando ormai per tutta l’India e combatteva devastando territori quasi sconosciuti anche ai popoli confinanti. Durante l’assedio di una città, mentre girava intorno alle mura per individuarne i punti più deboli, fu colpito da una freccia, ma ciò nonostante rimase a lungo seduto a cavallo e proseguì la sua ricognizione. Poi, quando il sangue cominciò a coagulare, costretto a desistere perché il dolore della ferita asciutta si faceva
sempre più forte e la gamba che penzolava dal cavallo gli si era intorpidita, esclamò: «Tutti giurano che sono figlio di Giove, ma questa ferita grida che sono un uomo». Facciamo anche noi così. Ciascuno, in misura diversa, si lascia infatuare dall’adulazione; ebbene, diciamo: «Voi affermate che sono saggio, ma io mi rendo conto di avere molti desideri di cose inutili e dannose, non capisco neppure ciò che la sazietà mostra agli animali, quale misura si debba tenere nel mangiare e nel bere, non so ancora quanto il mio stomaco possa contenere». T’insegnerò ora come tu possa capire se possiedi o no la saggezza. Il saggio è pieno di gioia, tranquillo, sereno, imperturbabile, vive alla pari con gli dèi. E adesso guarda te: se non sei mai triste, se non hai alcuna speranza che ti faccia trepidare in attesa del futuro, se notte e giorno il tuo animo, fiero e soddisfatto di sé, mantiene sempre lo stesso atteggiamento, allora sei pervenuto al culmine dell’umano bene; ma se vai in cerca dei piaceri, di qualunque specie e dovunque tu possa trovarli, non potrai essere né saggio né felice. Sbagli se, pur avendone la volontà, speri di raggiungere la saggezza fra le ricchezze e gli onori, che è come ricercare la felicità in mezzo agli affanni e alle preoccupazioni: codesti beni a cui aspiri, illudendoti che possano darti gioia e piacere, sono causa di dolori. Tutti, ripeto, tendono alla gioia, ma non sanno dove si possa trovarne un’intensa e duratura: alcuni la cercano nei banchetti e nella dissolutezza, altri nell’ambizione e nella folla dei clienti che li circondano, altri nell’amante, altri ancora nella vana ostentazione degli studi liberali e di quelli letterari che non ti ridanno certo la salute. Ebbene, tutti costoro sono ingannati da piaceri falsi e caduchi , come l’ubriachezza che fa scontare la lieta follia di un’ora con un lungo malessere, come gli applausi e il favore della folla esultante ottenuti a prezzo di grandi affanni. Rifletti, dunque: il risultato della saggezza è una felicità stabile. L’animo del saggio è come il cielo sulla luna: è sempre limpido e sereno. Vedi quindi se non hai un valido motivo per desiderare la saggezza, quando questa ti procura una gioia costante e sicura. Una gioia che nasce unicamente dalla coscienza delle proprie virtù, e dunque può provarla solo l’uomo forte, giusto e temperante. «Ma allora gli stolti e i malvagi non provano gioia?». Non più dei leoni quando conquistano la preda. Dopo che si sono stancati di ubriacarsi e di gozzovigliare, trascorrendo la notte negli stravizi, e i piaceri accumulatisi nel corpo esiguo più di quanto esso possa contenere hanno cominciato a farlo marcire, allora, poveretti, gridano quel famoso verso di Virgilio: Sai come noi passammo l’ultima notte immersi tra fallaci bagordi.19 I lussuriosi passano ogni notte tra false gioie e come se fosse l’ultima: ma quella gioia che tocca agli dèi e a chi li emula non s’interrompe, non finisce mai; finirebbe se provenisse da altri, ma poiché non è un dono di altri non è neppure soggetta all’arbitrio altrui: la sorte, infatti, non può toglierci ciò che non ci ha dato. Stammi bene.
60. Mi lamento, litigo, mi arrabbio. Desideri ancora ciò che ti hanno augurato la tua nutrice, il pedagogo, tua madre? Non hai ancora capito quanto male in realtà ti augurassero? Oh, quanto danno ci procurano i voti dei nostri cari! E tanto più ci risultano ostili quanto più si sono realizzati. Ormai non mi meraviglio che i mali ci perseguitino fin dalla prima fanciullezza: siamo cresciuti fra le imprecazioni dei familiari. Preghiamo gli dèi disinteressatamente per il nostro bene e che una buona volta essi esaudiscano i nostri voti. Ma sino a quando chiederemo a loro qualcosa, come se non fossimo ancora capaci di provvedere a noi stessi da soli? Fino a quando riempiremo di piantagioni i terreni che sono destinati a grandi città? Fino a quando un’intera popolazione mieterà per noi? Fino a quando molte navi provenienti da diversi mari trasporteranno le provviste per una sola mensa? Un toro si sazia pascolando in un terreno di pochissimi iugeri; una sola selva basta a più elefanti: l’uomo per nutrirsi ha bisogno della terra e del mare. Ma come? La natura ci ha dato un corpo così piccolo e un ventre così insaziabile da superare l’ingordigia degli animali più grossi e più voraci? Assolutamente no; quanto è poco, infatti, ciò che serve alla nostra natura! La si soddisfa con poco: non è la fame del ventre che ci costa molto, è l’ambizione. Perciò, quelli che, come dice Sallustio, sono «schiavi del ventre»20 annoveriamoli fra gli animali, non fra gli uomini, anzi certuni consideriamoli morti, nemmeno animali. Vivo è colui che si rende utile a molti, che fa buon uso di sé stesso, mentre quelli che se ne stanno ritirati e inoperosi nella loro casa vivono come in una tomba. Puoi inciderne il nome nel marmo della soglia: sono morti prima del tempo. Stammi bene. 61. Smettiamola di volere ciò che abbiamo voluto in passato! Quanto a me certamente mi sforzo di non desiderare da vecchio le stesse cose che desideravo da bambino. A questo solo tendono i miei giorni e le mie notti, questa è la mia occupazione, questo il mio pensiero: porre fine ai mali di un tempo. Mi conduco in modo che un solo giorno valga quanto tutta la vita, e, per Ercole, non lo afferro come se fosse l’ultimo, ma lo considero come se potesse anche essere l’ultimo. Con tale stato d’animo ti scrivo questa lettera, come se la morte dovesse chiamarmi proprio mentre vado scrivendoti: sono pronto ad andarmene e al tempo stesso continuerò a godermi la vita appunto perché non mi preoccupo troppo di quanto possa ancora durare. Prima di diventare vecchio cercavo di vivere bene; ora che sono vecchio, cerco di morire bene; ma morire bene significa morire volentieri. Cerca di non fare mai nulla contro la tua volontà: tutto ciò che risulta necessario a chi vi si oppone non è una necessità per chi lo accetta di buon grado. Voglio dire: chi obbedisce volentieri agli ordini si sottrae alla parte più dura della schiavitù, quella, cioè, di fare ciò che non vuole; non è infelice chi fa qualcosa dietro comando, è infelice chi lo fa controvoglia. Disponiamo dunque il nostro animo a volere tutto ciò che le circostanze esigeranno, e prima di tutto a pensare alla nostra fine senza rattristarci. Prima che
a vivere prepariamoci a morire: per vivere ci è sufficiente quello che abbiamo, ma noi siamo sempre avidi dei suoi beni, ci sembra e ci sembrerà sempre che ci manchi qualcosa: non gli anni e nemmeno i giorni, sarà l’animo a dirci se siamo vissuti abbastanza. E io, carissimo Lucilio, sono vissuto abbastanza: sazio, attendo la morte. Stammi bene. 62. Mente chi fa mostra di essere come uno a cui la quantità dei suoi impegni impedisce di dedicarsi agli studi: s’inventa occupazioni, le aumenta ed è lui stesso il primo responsabile delle sue preoccupazioni. Io sono libero, Lucilio, sono libero e padrone di me stesso, dovunque mi trovi. Infatti, non mi abbandono alle cose, mi dò in prestito a esse, e non cerco pretesti per perdere tempo; e dovunque mi fermi, lì mi occupo dei miei pensieri e medito su qualcosa di utile. Quando mi concedo agli amici, neanche allora mi distolgo da me stesso, né mi intrattengo a lungo con quelli ai quali mi hanno avvicinato le circostanze o gli obblighi di qualche pubblico ufficio, ma sto con i migliori: è a loro che rivolgo il mio pensiero, quali che siano il luogo e il tempo in cui sono vissuti. Porto sempre con me Demetrio, il migliore degli uomini, e, lasciati da parte i porporati, parlo con lui, anche se vestito poveramente, e lo ammiro. E perché non dovrei? Mi sono accorto che non gli manca nulla. Uno può disprezzare tutto, ma nessuno può avere tutto: la via più breve per giungere alla vera ricchezza è il disprezzo delle ricchezze. Il nostro Demetrio vive così, non come se avesse in disprezzo ogni cosa, ma come se ne avesse lasciato il possesso ad altri. Stammi bene.
1. Virgilio, Eneide VI 3. 2. Virgilio, Eneide III 277. 3. Un aristocratico del tempo di Tiberio. 4. È il lago di Averno. 5. Uomo politico, figlio di Asinio Pollione: imprigionato dall’imperatore Tiberio, morì in carcere. 6. Prefetto del pretorio sotto Tiberio, potentissimo, fu condannato a morte per le sue trame politiche. 7. È un personaggio ignoto. 8. Fontana a forma di colonnetta conica situata davanti all’anfiteatro Flavio. 9. Frammento di Varrone Atacino, poeta neoterico, contenuto nella traduzione delle Argonautiche di Apollonio Rodio. 10. Virgilio, Eneide II 726-29: parte del racconto che Enea fa a Didone della sua fuga da Troia. 11. Virgilio, Georgiche III 146-50. Il Silaro è un fiume, l’Alburno un monte della Lucania (oggi rispettivamente Sele e Monte di Postiglione). 12. Virgilio, Eneide XII 708-709: duello fra Enea e Turno («Lo stesso re Latino si stupisce / che quei grandi guerrieri, nati in luoghi / tanto lontani e diversi del mondo / si affrontino e combattano fra loro»). 13. Virgilio, Eneide XI 467 («Un gruppo / sbarri qualunque accesso alla città, / presidiando i bastioni»): è Turno che impartisce gli ordini. 14. Esseri mitologici che avevano il corpo metà d’uomo e metà di cavallo. 15. I Giganti erano figli di Gea, la Terra (Esiodo, Teogonia), e combatterono contro gli dèi
(Gigantomachia). 16. Il suo vero nome era Aristocle: Platone gli derivò da platùs, che significa largo. 17. Virgilio, Eneide VI 278-79. 18. Filosofo della seconda metà del I sec. a.C., fondatore di una scuola eclettica che attingeva dal pitagorismo, dal platonismo e dallo stoicismo. 19. Virgilio, Eneide VI 513-14: parole di Deifobo che racconta a Enea come morì nell’ultima notte di Troia. 20. Sallustio, La congiura di Catilina 1, 1.
Libro settimo 63. Sono molto dispiaciuto per la morte del tuo amico Flacco,1 ma non vorrei che tu ne soffrissi più del giusto. Non oso pretendere che tu non te ne dolga affatto, anche se so che sarebbe meglio. Ma solo chi ormai è molto al di sopra della sorte può avere una tale forza d’animo: un simile evento toccherà anche il suo animo, ma sarà solo una puntura. Scoppiare in lacrime è perdonabile, purché non se ne versino a fiotti e si cerchi di reprimerle. Quando muore un amico gli occhi non restino asciutti, ma nemmeno devono versare un mare di lacrime: bisogna piangere, ma non a dirotto. Credi ch’io t’imponga una regola dura, visto che il più grande poeta greco concede il diritto di piangere ma per un solo giorno e racconta che anche Niobe si preoccupò di preparare il cibo?2 Vuoi sapere da dove provengano i lamenti e i pianti sfrenati? Noi cerchiamo di dimostrare il nostro rimpianto attraverso le lacrime e più che seguire il dolore lo ostentiamo; nessuno è triste per sé stesso. Povera stupidità! Si ostenta anche il dolore. «E che?», ribatti. «Dovrò dimenticarmi di un amico?». Il ricordo che gli prometti è breve se dura quanto il dolore: un evento fortuito distenderà il tuo volto al sorriso. E non rimando questa occasione a un tempo più lontano, quando ogni rimpianto si placa, quando anche i lutti più dolorosi si attenuano: appena avrai smesso di controllarti quella immagine di tristezza svanirà. Ora sei tu a custodire il tuo dolore, ma questo sfugge anche a chi lo custodisce, e più è forte, più rapidamente finisce. Facciamo sì che il ricordo dei nostri cari perduti ci riesca gradevole. Nessuno ritorna volentieri con la mente a ciò che non si può pensare senza soffrirne, ed è inevitabile che il ricordo di chi abbiamo amato e perduto ci provochi una fitta d’angoscia, la quale, tuttavia, ha una sua certa dolcezza. Per questo il nostro Attalo soleva dire che: «Il ricordo degli amici defunti è dolce come certi frutti gradevolmente aspri, come è piacevole l’amaro del vino troppo vecchio: quando è passato un po’ di tempo cessa ogni motivo di pena e subentra un piacere puro». Se vogliamo credergli, «pensare agli amici vivi è come gustare miele e focaccia, mentre il ricordo di quelli scomparsi è dolce e amaro nello stesso tempo. Qualcuno forse può negare che anche i cibi agri e un po’ asprigni stuzzichino l’appetito?». Io non sono d’accordo: per me il pensiero degli amici defunti è dolce e gradevole; quando erano vivi, infatti, sapevo che li avrei perduti, ora che li ho perduti mi sembra che siano ancora vivi. Comportati, dunque, Lucilio mio, come si conviene al tuo equilibrio, smettila di interpretare male un beneficio della sorte: ti ha tolto, ma ti ha dato. Perciò, godiamo intensamente della presenza degli amici, perché non sappiamo fino a quando potremo goderne. Se pensiamo a quante volte li abbiamo lasciati per intraprendere un viaggio in paesi lontani o, pur abitando nello stesso luogo, non li abbiamo visti, ci renderemo conto che abbiamo perduto più tempo senza di loro quando erano vivi. Come si può tollerare chi non si cura affatto degli amici e poi li piange disperatamente, e non sa amarli se non dopo averli perduti? A quel punto si abbandonano alla disperazione perché temono che si dubiti del loro
affetto, di cui cercano di dare testimonianze tardive. Se abbiamo altri amici, e non riescono a esserci di conforto per la perdita di uno solo, ci comportiamo male nei loro confronti e li stimiamo poco; se non ne abbiamo, il male che ci facciamo da noi stessi è superiore a quello che abbiamo ricevuto dalla sorte: questa ci ha tolto un solo amico, noi tutti quelli che non siamo riusciti a procurarci. Per non dire che chi non sa amare più di un amico non ama abbastanza nemmeno quel solo. Non ti sembrerebbe completamente pazzo uno che, rimasto nudo per aver perso l’unica veste che possedeva, preferisca compiangersi piuttosto che cercare come proteggersi dal freddo e trovare qualcosa con cui coprirsi le spalle? Hai seppellito una persona che amavi: cerca di amarne un’altra. È meglio trovarsi un nuovo amico piuttosto che piangere quello perduto. So bene che quanto sto per aggiungere è trito e ritrito, ma non lo tacerò solo perché l’hanno già detto tutti: anche chi non è riuscito a porre fine al dolore con la ragione vi riuscirà col tempo. Tuttavia è vergognoso che per chi ha senno il rimedio contro il dolore sia la stanchezza di soffrire: è meglio che sia tu a lasciare il dolore piuttosto che il dolore a lasciare te; e cessa di fare al più presto ciò che poi non potrai fare neppure volendolo. I nostri padri stabilirono che le donne osservassero il lutto per un anno, non perché dovessero piangere per tanto tempo, ma affinché non piangessero più a lungo: per gli uomini, invece, non è stato fissato alcun periodo di tempo, poiché per loro non sarebbe dignitoso. Ma citami una sola di quelle donnette, tirate via dal rogo a fatica, strappate a stento dal cadavere del marito, che abbia versato lacrime per un mese! Non c’è cosa che venga in odio più rapidamente del dolore, il quale se è recente trova chi lo consola e attira gente a sé, ma se è di vecchia data, viene deriso, e non a torto: infatti, o è simulato o è stupido. Ti scrivo queste cose proprio io che ho pianto senza ritegno il mio carissimo amico Anneo Sereno, 3 e così, mio malgrado, sono fra gli esempi di chi si è lasciato vincere dal dolore. Oggi, però, condanno il mio comportamento e capisco che il motivo principale di quel mio pianto eccessivo era dovuto al fatto che non avevo mai pensato che potesse morire prima di me. Solo questo vedevo, che era più giovane di me, molto più giovane: come se la morte rispettasse l’ordine di anzianità! Riflettiamo sempre, dunque, che tanto noi quanto tutti i nostri cari siamo mortali. Allora avrei dovuto dire: «Il mio Sereno è più giovane di me: che importa? Dovrebbe morire dopo di me, ma può morire prima». Non l’ho pensato e la sventura mi ha colpito all’improvviso, impreparato. Ora penso che tutto è mortale e che in quanto tale non segue una legge precisa; potrebbe accadere oggi ciò che può capitare in qualunque momento. Riflettiamo, dunque, Lucilio carissimo, che presto andremo anche noi là dove ci duole che sia andato l’amico; forse, se è vero quel che dicono i saggi, c’è un luogo che ci accoglie tutti quanti, e l’amico, che per noi è scomparso, ci ha solo preceduti. Stammi bene.
64. Ieri sei stato con noi. Potresti lamentarti se si trattasse solo di ieri; per questo ho precisato “con noi”, dato che tu sei sempre con me. Ieri, infatti, sono venuti alcuni amici e ciò ha aumentato il fumo, non parlo di quello che solitamente sale dalle cucine dei signori e allarma i vigili, ma di quello moderato che indica l’arrivo di ospiti. Abbiamo parlato di vari argomenti, come accade nei banchetti, senza che alcuno di essi giungesse a conclusione, ma saltando dall’uno all’altro. Poi abbiamo letto il libro di Quinto Sestio padre, un grand’uomo, parola mia, e stoico, anche se lui lo nega. Quanto vigore c’è in lui, buon dio, che temperamento! Non lo si trova in tutti i filosofi: gli scritti di alcuni, pur se famosi, mancano di nerbo. Ammaestrano, discutono, cavillano, ma non infondono quel vigore spirituale, perché non ne hanno, quando leggerai Sestio dirai: «È vivo, è vigoroso, è libero, è superiore agli uomini comuni, mi lascia pieno di una sicurezza straordinaria». Ti confesserò in quale stato d’animo mi trovi io quando lo leggo: ho voglia di sfidare ogni situazione, di gridare: «Che cosa aspetti, o sorte? Attacca: sono pronto». Indosso l’animo di uno che cerca di sperimentare sé stesso, di dar prova del suo valore, e spera che venga fra gl’imbelli armenti un cinghiale schiumante o che dal monte scenda un fulvo leone.4 Mi piace avere qualche difficoltà da vincere, in cui esercitare la mia fermezza. Anche questa è un’altra singolare dote di Sestio: ti mostra quanto sia grandiosa la felicità, ma non ti fa disperare di ottenerla. Comprenderai che sta molto in alto, ma è accessibile, se uno vuole. Ed è proprio questo che la virtù ti darà: un senso di ammirazione per essa e la speranza di raggiungerla. Io di solito passo molto tempo a contemplare la saggezza; la guardo con la stessa meraviglia con cui talvolta osservo l’universo, che spesso vedo come un novello spettatore. Perciò provo un senso di venerazione per le scoperte della saggezza e per chi le fa: mi piace possederle, come se fossero un’eredità di molti. È per me che sono state conquistate, per me che sono stati fatti questi sforzi. Ma comportiamoci come un buon padre di famiglia, accresciamo i beni che abbiamo ricevuto; che questa eredità passi, accresciuta, da me ai posteri. Resta ancora molto da fare e molto ne resterà, e a nessuno, anche fra mille secoli, sarà preclusa la possibilità di aggiungere ancora qualcosa. Ma anche ammesso che gli antichi abbiano scoperto tutto, la conoscenza, l’organizzazione e l’applicazione delle scoperte altrui sarà sempre una novità. Come se ci fossero state lasciate delle medicine per guarire gli occhi: non occorre cercarne altre, basta adoperare quelle in base alle varie malattie e alle circostanze. Una allevia il bruciore degli occhi, un’altra fa diminuire il gonfiore delle palpebre, questa arresta un improvviso flusso di lacrime, quella rende più acuta la vista: bisogna poi triturare queste erbe mediche, scegliere il momento giusto e dosarle opportunamente. Gli antichi hanno trovato i rimedi contro i mali dell’anima, ma tocca a noi individuare come o quando vadano applicati. I nostri predecessori hanno fatto molto, ma non tutto.
E però dobbiamo ammirarli e venerarli come dèi. Perché non dovrei custodire i ritratti dei grandi uomini come sprone alla virtù e festeggiare l’anniversario della loro nascita? Perché non dovrei ricordarli sempre e rendergli onore? La stessa venerazione che ho per i miei maestri la devo a loro, che sono maestri del genere umano, la fonte di un bene così prezioso. Quando incontro un console o un pretore rendo onore alla loro carica, scendo giù da cavallo, mi scopro il capo, cedo loro il passo. E che, dunque? I due Catoni, Lelio il Saggio e Socrate con Platone e Zenone e Cleante li accoglierò nel mio animo senza il massimo rispetto? In verità io li venero e mi alzo sempre in piedi di fronte a nomi così importanti. Stammi bene. 65. Ieri ho diviso la giornata con la malattia: si è presa la mattina, nel pomeriggio mi ha risparmiato. Perciò in un primo momento ho messo alla prova l’animo dandomi alla lettura, poi, visto che reggeva bene, ho osato imporgli, anzi, permettergli di più: ho scritto qualcosa e con un impegno maggiore del solito, trattandosi di una materia difficile e non volendo arrendermi, finché sono sopraggiunti gli amici e con le cattive mi hanno costretto a smettere, come se fossi un ammalato intemperante. Così alla scrittura è subentrata la conversazione, della quale ti riferirò la parte controversa. Abbiamo scelto te come arbitro. Hai un grattacapo più grosso di quanto immagini: triplice è la controversia. Come sai, i nostri stoici affermano che in natura esistono solo due elementi, da cui deriva ogni cosa: la causa e la materia. La materia giace inerte, come un oggetto pronto a subire qualsiasi trasformazione ma destinato all’immobilità se non c’è qualcuno che lo muove; la causa, invece, cioè la ragione, plasma la materia e la modifica come vuole, ricavandone varie opere. Deve dunque esserci ciò di cui una cosa è fatta e ciò da cui una cosa è fatta: la materia e la causa. Ogni arte è imitazione della natura, perciò quel che dicevo dell’universo trasferiscilo a ciò che viene fatto dall’uomo. Una statua ha avuto sia una materia che subisse l’azione dell’artista, sia un artista che imprimesse nella materia la forma; dunque, in una statua il bronzo, mettiamo, è la materia, lo scultore la causa. Idem per tutte le cose, le quali risultano dall’insieme di ciò che subisce l’azione e di ciò che agisce. Per gli stoici la causa è una sola: ciò che agisce. Per Aristotele vi sono tre modi di essere della causa: «La prima causa», egli dice, «è la materia stessa, senza la quale nulla può essere prodotto; la seconda è l’artefice, la terza è la forma, che viene imposta a ciascuna opera, come per esempio alla statua»,5 e che Aristotele chiama idos. «A queste tre», egli dice, «se ne aggiunge una quarta: il fine dell’opera nella sua interezza». Ti spiegherò meglio come stiano le cose. Il bronzo, mettiamo, è la prima causa di una statua, la quale non si sarebbe mai potuta fare se non fosse esistita la materia da cui ricavarla. La seconda causa è l’artefice: quel bronzo, infatti, non avrebbe mai potuto assumere la forma di una statua se non vi si fossero accostate mani esperte. La terza causa è la forma: la statua, cioè, non si chiamerebbe «Doriforo» o «Diadumeno»6 se non le fosse
stata impressa quella determinata figura. La quarta causa è il fine, visto che senza di esso la statua non sarebbe nata. Che cos’è il fine? Ciò che ha spinto l’artefice e a cui egli ha mirato nel suo lavoro: può essere il denaro, se l’ha foggiata per venderla, può essere la gloria, se ha lavorato per farsi un nome, può essere la devozione religiosa, se si è trattato di un dono per un tempio. Anche questa, dunque, è una causa, quella in vista della quale una cosa viene fatta: o forse credi che non dovremmo annoverare tra le cause di un’opera quella senza la quale l’opera stessa non potrebbe essere fatta? A queste quattro cause Platone ne aggiunge una quinta, cioè l’esemplare, che egli chiama «idea», a cui l’artista ha tenuto rivolto lo sguardo per realizzare ciò che si prefiggeva. E non importa se quell’esemplare a cui rivolge lo sguardo sia fuori o dentro di lui, da lui concepito e costruito. Gli esemplari di tutte le cose sono nella mente di dio, che col pensiero abbraccia le proporzioni e le misure di tutto il creabile. Dio è pieno di queste figure che Platone chiama “idee”, immortali, immutabili, instancabili. Pertanto gli uomini muoiono, ma l’umanità, su cui ogni singolo uomo viene modellato, rimane, e mentre gli uomini si affannano e scompaiono, lei non patisce alcun danno. Cinque sono dunque le cause, come dice Platone: ciò da cui (la materia), ciò dal quale (colui che agisce su di essa), ciò in cui (la forma), ciò in base a cui (l’idea), ciò in vista di cui (il fine). Da ultimo c’è ciò che risulta da tutte queste cause. Nella statua, per esempio (poiché di questa abbiamo cominciato a parlare), “ciò da cui” è il bronzo, “ciò dal quale” è l’artefice, “ciò in cui” è la forma che le viene data, “ciò secondo cui” è il modello che viene imitato, “ciò in vista di cui” è il fine che si prefigge l’artefice, “ciò che risulta da tutte queste cause” è la statua stessa. Anche il mondo, come dice Platone, è il risultato di tutte queste cause: quella che fa, cioè dio; ciò di cui la cosa è fatta, cioè la materia; la forma, che è l’aspetto e l’ordine del mondo che vediamo; l’esemplare, ossia ciò in base a cui dio fece quest’opera grandiosa e bellissima; il fine, cioè il motivo per cui l’ha fatta. Mi chiedi quale sia per dio il fine? La bontà. Così ci dice sicuramente Platone: «Quale motivo ebbe dio per fare il mondo? Egli è buono, e in quanto tale non è geloso di alcun bene; di conseguenza lo ha creato nel miglior modo possibile».7 Emetti, dunque, come giudice, la sentenza, dichiarando chi ti sembra dire la cosa più verosimile, non quella vera in assoluto, perché ciò è tanto al di sopra delle nostre possibilità quanto la verità stessa. Questa serie di cause esposte da Aristotele e da Platone è eccessiva o difettosa. Se cioè ritengono che sia una causa tutto ciò senza cui nulla si può fare ne hanno elencate poche. Devono infatti porre fra le cause anche il tempo, senza il quale non è possibile fare niente, poi il luogo, visto che se non c’è un luogo dove poterla fare la cosa non si può fare, quindi il moto, senza il quale nulla si fa e nulla si distrugge, e se manca il moto non c’è nessuna attività, nessun mutamento. Ma noi ora cerchiamo la causa prima e universale, la quale dev’essere semplice, come la materia. E che cos’è? Evidentemente è la ragione creatrice, cioè dio: quelle che sono state citate non sono cause molteplici e
singole, dipendono tutte da una unica, quella efficiente. Dici che la forma è una causa? È l’artefice che la imprime all’opera, quindi è parte di una causa, non una causa. Anche l’esemplare non è una causa, è uno strumento necessario della causa. L’esemplare è necessario all’artefice come lo scalpello e la lima, senza di cui la tecnica non può operare, e tuttavia non sono parti della tecnica, e nemmeno cause. «Il fine, in vista del quale l’artefice si accinge a fare qualche cosa», si dice, «è una causa». Ammettiamolo, però non è causa efficiente, è causa accessoria, e le cause accessorie sono innumerevoli, mentre noi cerchiamo la causa generale. In verità Platone e Aristotele non hanno dimostrato la loro abituale sottigliezza dicendo che l’universo intero, opera perfetta, è una causa: c’è infatti molta differenza fra l’opera e la causa dell’opera. Sta a te, ora, dire cosa ne pensi, oppure, visto che in casi analoghi è più comodo, rimandalo a una nostra prossima convocazione. Mi dirai: «Che gusto ci provi a passare il tempo fra queste dispute, che non ti liberano da passioni o desideri?». Io, in verità, mi occupo degli argomenti che servono ad acquietare l’animo, e prima studio me stesso, poi questo mondo. E nemmeno adesso sto perdendo tempo, come tu credi: tutte queste discussioni, se non si spezzettano e non si disperdono in cavilli inutili, alleviano e innalzano l’anima, che, oppressa da un grave fardello, desidera liberarsene e tornare colà da dove proviene. Questo corpo, infatti, è un ingombro per l’anima, che resta incatenata sotto il suo peso se non sopraggiunge la filosofia che l’induce a riprendere fiato di fronte allo spettacolo della natura e l’allontana dalle cose terrene per condurla verso quelle divine. Questa è la sua libertà, la sua evasione: così si sottrae alla prigione in cui è racchiusa e si rigenera nel cielo. Come gli artigiani, che impegnati in un lavoro di precisione che affatica la vista poiché richiede molta attenzione, se dispongono di un lume debole e incerto escono fra la gente e ristorano gli occhi in piena luce in un luogo destinato al pubblico svago, così l’anima, chiusa in questa buia e triste dimora, quando può esce all’aperto e si riposa nella contemplazione della natura. Certo, anche il saggio o chi aspira alla saggezza è attaccato al proprio corpo, ma la sua parte migliore ne è lontana e rivolge i pensieri a cose elevate. Come un soldato che ha prestato giuramento, il saggio considera la vita un servizio militare, e ha una tale forma mentis che non ama la vita e non la odia e sopporta le vicende mortali sapendo che lo attende un destino migliore. Mi proibisci di indagare sulla natura allontanandomi dal tutto per limitarmi alla parte? Non dovrò dunque ricercare i principi dell’universo? Chi ha dato forma alle cose? Chi ha separato l’insieme degli elementi immersi in un’unica massa e confusi in una materia inerte? Non dovrò cercare l’artefice di questo mondo? In virtù di quale disegno una massa così grande sia arrivata a una legge e a un ordine? Chi ha raccolto gli elementi sparsi, distinto quelli confusi, dato un aspetto particolare a ciò che giaceva in un’unica massa informe? Da dove si diffonda una luce così intensa? Se sia il fuoco o qualcosa di ancora più luminoso? Non indagherò tutto questo? Ignorerò da dove vengo? Se mi è dato di vedere questo mondo una sola volta o se rinascerò più volte? Dove andrò
allontanandomi da qui? Quale sede attende l’anima liberata dalle leggi della schiavitù umana? Mi vieti di essere partecipe delle cose celesti, cioè mi imponi di vivere tenendo abbassata la testa? Io sono troppo grande e destinato a cose troppo alte per essere schiavo del mio corpo, che vedo solo come una catena posta intorno alla mia libertà; lo oppongo alla sorte perché vi si arresti contro e non consento che alcun colpo giunga fino a me trapassandolo. Il corpo è l’unica parte di me che può subire danno: in questa fragile dimora abita un’anima libera. Mai questa carne mi costringerà ad aver paura, mai m’indurrà alla simulazione, che è indegna di un uomo onesto; mai per riguardo a questo corpiciattolo sarò indotto a mentire. Quando mi parrà opportuno romperò ogni legame con lui; ma anche ora, finché restiamo uniti, non saremo soci alla pari: l’anima reclamerà per sé ogni diritto. Il disprezzo del proprio corpo è libertà sicura. Per tornare al nostro tema, ai fini di questa libertà gioverà molto anche quell’indagine della natura di cui abbiamo poc’anzi parlato, visto che tutto è composto di materia e di dio. dio regola le cose che sparse intorno a lui lo seguono come re e come guida. Chi agisce, cioè dio, è più potente e più prezioso della materia, che di dio subisce l’azione. L’anima occupa nell’uomo il posto che dio occupa nell’universo; in noi il corpo è ciò che là rappresenta la materia. Dunque ciò che è inferiore sia sottomesso a ciò che è superiore; siamo forti contro la sorte, non temiamo le offese, le ferite, il carcere, la povertà. Che cos’è la morte? O la fine o un passaggio. Ma io non temo di finire, poiché è la stessa cosa che non aver cominciato, e neppure temo di passare, perché in nessun luogo starò tanto ristretto come qui. Stammi bene. 66. Ho rivisto dopo molti anni Clarano,8 mio ex compagno di scuola: è superfluo dirti che è vecchio, però è fresco e vigoroso di spirito e in continua lotta col suo fragile corpo. La natura è stata ingiusta con lui e ha alloggiato male un’anima come la sua; o forse ha voluto dimostrarci proprio questo: che sotto qualsiasi scorza può nascondersi un carattere felicissimo e coraggiosissimo. Comunque, lui ha superato ogni ostacolo e dal disprezzo di sé è arrivato a disprezzare tutte le altre cose. Mi pare che Virgilio sbagli laddove dice piace di più la virtù se proviene da un corpo ben fatto.9 La virtù, infatti, non ha bisogno di alcun ornamento: è lei stessa il suo ornamento e rende sacro il corpo in cui risiede. Ho cominciato davvero a osservare il nostro Clarano con occhi diversi: mi sembra bello e così perfetto di corpo e di animo. Come da una capanna può sbucare un grand’uomo così da un corpiciattolo debole e deforme può emergere un’anima bella ed elevata. Perciò ritengo che la natura generi uomini come questi per dimostrare che la virtù può nascere dovunque. Se potesse creare anime senza corpo lo avrebbe fatto, ma fa anche di più: genera individui menomati nel fisico e tuttavia capaci di abbattere ogni ostacolo. Secondo me Clarano è stato generato come esempio, per farci
capire che non è la bruttezza del corpo a rendere brutta l’anima, è la bellezza dell’anima a rendere bello il corpo. Benché siamo stati insieme solo pochissimi giorni, abbiamo trattato molti argomenti, che andrò trascrivendo via via per inviarteli. Questa è la questione del primo giorno: come possono i beni avere lo stesso valore se si distinguono in tre categorie? Alcuni, secondo i nostri stoici, appartengono alla prima, come la gioia, la pace, la salvezza della patria; altri alla seconda, e si manifestano in circostanze sfortunate, come la capacità di sopportare i tormenti e la serenità nelle gravi malattie. I primi li desidereremo senz’altro, i secondi solo se sarà necessario. Ci sono poi quelli della terza categoria, come un portamento composto, un volto sereno e onesto e l’atteggiamento tipico dell’uomo virtuoso. Ebbene, come possono avere lo stesso valore questi beni se alcuni sono da desiderarsi, altri da respingersi? Consideriamoli distinti e torniamo al primo bene per esaminarlo. Qual è questo bene? Un animo rivolto al vero, che sa cosa si debba fuggire e cosa invece ricercare, che valuta le cose non in base alle opinioni, ma in base alla loro natura, che penetra nell’universo e ne contempla i fenomeni, teso sia al pensiero che all’azione, grande e impetuoso, parimenti insensibile alle minacce e alle lusinghe, indomito sia di fronte alla buona che alla cattiva sorte, al di sopra di tutto ciò che accade, bellissimo e ordinatissimo per dignità e vigore, sano e temperante, imperturbabile e ardito, indenne da ogni violenza, non euforico e non abbattuto di fronte agli imprevisti della sorte: ecco, questa è la virtù. Questo sarebbe il suo volto se potesse avere un solo aspetto e mostrarsi tutta in una volta. Ma i suoi aspetti sono molti e derivano dalle azioni e dalle varie circostanze della vita: la virtù non diventa né più grande né più piccola, perché il sommo bene non può diminuire e la virtù non può retrocedere; essa muta di volta in volta le sue proprietà, adattandosi alle azioni che compie. Rende simile a sé e colora di sé ogni cosa che tocca, adorna azioni, amicizie, talvolta addirittura le case in cui è entrata riconducendovi l’armonia; rende amabile, bellissimo, straordinario tutto ciò a cui si accosta. Perciò la sua forza e la sua grandezza non possono aumentare, poiché ciò che ha raggiunto il massimo non è suscettibile di ulteriore accrescimento: non troverai niente di più giusto della giustizia, niente di più vero della verità, di più moderato della moderazione. Ogni virtù consiste nella misura; e la misura ha limiti ben precisi; la costanza non può andare oltre sé stessa, così come la fiducia, la verità o la fede. Che cosa può aggiungersi a ciò che è perfetto? Nulla, diversamente non è perfetto ciò a cui si aggiunge qualcosa; dunque, niente può aggiungersi alla virtù: se si è potuto aggiungerle qualcosa è segno che le mancava. Anche l’onestà non può essere accresciuta: essa è tale per i motivi che ho detto. E allora? Non credi che dignità, giustizia e legittimità appartengano alla stessa categoria, che siano cioè comprese entro limiti ben precisi? Poter crescere significa essere imperfetti. Ogni bene rientra sotto le stesse leggi: utilità pubblica e utilità privata sono unite e, per Ercole, così inseparabili come ciò che è lodevole e ciò a cui si deve
aspirare. Dunque, le virtù hanno tutte lo stesso valore, come le opere che da esse derivano e gli uomini che le possiedono. Le virtù delle piante e degli animali, essendo mortali, sono fragili, incerte e caduche; si innalzano e si abbassano e perciò non hanno tutte il medesimo valore. La regola che si applica alle virtù umane è una sola, poiché una sola è la ragione, semplice e retta. Niente è più divino del divino, più celeste del celeste. Le cose mortali si consumano e finiscono, si logorano e crescono, si vuotano e si riempiono, sicché, trovandosi in una condizione così precaria, sono disuguali: la natura delle cose divine, invece, è una sola. Da parte sua la ragione non è altro che una scintilla dello spirito divino infusa nel corpo umano; se la ragione è divina, e se non esiste bene senza ragione, ogni bene è divino. Per di più le cose divine non hanno fra loro alcuna differenza; dunque, non c’è neppure fra i beni. Ecco perché la gioia e la sopportazione forte e risoluta dei tormenti sono uguali; in entrambe c’è la stessa grandezza d’animo, mite e pacata nell’una, forte e pugnace nell’altra. E che? Non credi che sia uguale la virtù di chi espugna coraggiosamente le mura dei nemici e quella di chi resiste con tenacia a un assedio? Grande è Scipione che assedia Numanzia e costringe i cittadini a darsi la morte con le proprie mani invitte, ma grande è anche il coraggio degli assediati, i quali sanno che non c’è assedio che tenga per chi vi si sottragga con la morte e spiri fra le braccia della libertà. Parimenti anche le altre virtù sono uguali tra loro, la serenità, la lealtà, la generosità, la costanza, l’equanimità, la tolleranza: alla base di tutte c’è una sola virtù, che rende l’animo retto e inflessibile. «Ma come? Non c’è alcuna differenza fra la gioia e la capacità di sopportare fermamente il dolore?». Per quel che riguarda le virtù in sé stesse nessuna: moltissima, invece, nelle circostanze in cui i due tipi di virtù si manifestano; nel primo caso, infatti, c’è una naturale rilassatezza e distensione dello spirito, nel secondo un dolore innaturale, cose che, essendo agli antipodi fra loro, sono intermedie, mentre la virtù è uguale in entrambi i casi. La situazione non modifica la virtù: se è dura e difficile non la rende peggiore, se allegra e piacevole non la rende migliore, dunque, essa resta necessariamente uguale. Infatti, in entrambe le situazioni le azioni che si compiono sono rette, sagge, oneste, dunque i beni sono uguali e al di là di essi non può comportarsi meglio né chi è nella gioia né chi si trova nella sofferenza, e se di due cose non può esserci niente di meglio esse sono uguali. Se poi c’è qualcosa di estraneo alla virtù che possa diminuirla o accrescerla, l’onestà non è più l’unico bene, e se così fosse ogni virtù scomparirebbe. Perché? Te lo dirò: perché un’azione non è virtuosa se compiuta contro voglia o per costrizione; tutto ciò che è onesto muove dalla volontà. Se vi aggiungi, mescolandole, pigrizia, querele, esitazione e paura l’onestà perde la sua prerogativa migliore, l’essere contenta di sé. Non può essere onesto ciò che non è libero: chi teme è schiavo. L’uomo virtuoso è sicuro, tranquillo: se uno rifiuta qualcosa, se se ne lamenta, se la giudica un male, resta turbato e si agita in gravi contrasti; infatti, da una parte lo attrae la bellezza del bene, dall’altra lo respinge il sospetto del male. Perciò chi intende agire
onestamente, anche se incontra un ostacolo, pur essendone infastidito, non lo consideri un male, non rinunci ad agire, agisca volentieri, poiché ogni azione virtuosa non è legata a comandi o costrizioni, è pura e immune da ogni male. So cosa mi si può rispondere a questo punto: «Tenti di persuaderci che non c’è alcuna differenza fra l’essere pieno di gioia e il giacere sul cavalletto di tortura stancando il carnefice?». Potrei ribattere che anche per Epicuro il saggio, se fosse messo a bruciare dentro il toro di Falaride,10 griderebbe: «È piacevole, la cosa non mi tocca». Perché dunque ti meravigli se dico che sono sullo stesso piano i beni di chi se ne sta seduto a banchettare e di chi resiste coraggiosamente in mezzo alle torture, quando Epicuro dice una cosa ancora più incredibile, che cioè è piacevole essere bruciati? Ti rispondo invece che c’è moltissima differenza fra la gioia e il dolore; se dovessi scegliere ricercherei l’una, eviterei l’altro: quella è secondo natura, questo è contrario. C’è un’enorme differenza tra loro, se le guardiamo sotto questo aspetto, ma quando si arriva alla virtù, essa è uguale in entrambi i casi, che si riveli in situazioni liete o dolorose. I maltrattamenti, il dolore e qualsiasi altra molestia non hanno alcun peso sulla virtù, la quale annienta tutto ciò che può contrastarla. Come il chiarore del sole oscura le piccole luci, così la virtù con la sua grandezza schiaccia e smorza i dolori, gli affanni, le offese, e dovunque risplende lei tutto ciò che senza di lei aveva un rilievo sparisce: le avversità quando si imbattono nella virtù non hanno più peso di un acquazzone sull’ampia distesa del mare. Per convincerti che le cose stanno proprio così ti dirò che l’uomo virtuoso si slancia senza esitare verso ogni bella azione: che lo aspetti il carnefice o l’aguzzino col fuoco, egli persisterà considerando non cosa dovrà subire ma cosa dovrà fare, e si affiderà a un’azione onorevole come a un uomo virtuoso; la giudicherà utile, sicura, felice. Un’azione onesta, ma dolorosa e difficile, la terrà nello stesso conto di un uomo virtuoso, povero o esule, oppure gracile e smorto. Metti da una parte un uomo onesto e molto ricco, dall’altra uno che non possiede niente, ma ha tutta la ricchezza dentro di sé: entrambi sono ugualmente uomini virtuosi, anche se si trovano in condizioni assai diverse. Lo stesso criterio di giudizio vale per le cose e per gli uomini: la virtù è ugualmente lodevole in un corpo robusto e libero quanto in uno ammalato e in catene. Dunque, se la sorte ti ha dato un corpo perfetto non loderai la tua virtù più che se fossi mutilato in qualche parte: diversamente sarebbe come giudicare il padrone dall’aspetto degli schiavi. Tutti i beni soggetti al caso, denaro, corpo, onori, sono come schiavi, deboli, mutevoli, mortali, di possesso incerto: le opere della virtù, invece, sono libere e invincibili, né vanno desiderate di più se trattate benevolmente dalla sorte, o di meno se sono oppresse da qualche avversità. Ciò che negli uomini è l’amicizia è nelle cose il desiderio. Non credo che ameresti un uomo virtuoso ricco piuttosto che uno povero, né uno robusto e muscoloso piuttosto che uno gracile e fiacco; così non desidererai o amerai una condizione lieta e tranquilla più di una gravosa e tormentata. O, per restare in questo paragone, fra due uomini ugualmente virtuosi non credo che preferirai uno elegante e profumato a uno
impolverato e in disordine, e che arriverai al punto di preferire uno con le membra intatte e sano a uno storpio e cieco da un occhio; di questo passo i tuoi gusti difficili si spingeranno sino a preferire tra due uomini ugualmente giusti e virtuosi quello coi capelli lunghi e ricci. Quando la virtù è uguale in entrambi, sparisce qualsiasi disuguaglianza; tutte le altre prerogative della persona sono accessori, non parti integranti di essa. C’è forse qualcuno che giudica in maniera così ingiusta i propri figli da amare quello sano più di quello ammalato, quello alto e slanciato più di quello basso e tozzo? Le fiere non fanno distinzioni fra i loro piccoli e si sdraiano per allattarli tutti allo stesso modo; gli uccelli distribuiscono il cibo ai loro nati in parti uguali. Ulisse si affretta verso la sua pietrosa Itaca come Agamennone alle celebri mura di Micene; nessuno ama la patria perché è grande, l’ama perché è sua. A che mira questo discorso? A convincerti che la virtù guarda le sue opere come se fossero suoi figli, ed è ugualmente benevola con tutte, anzi particolarmente con quelle più affaticanti, poiché anche l’amore dei genitori si volge maggiormente verso i figli che suscitano maggiore compassione. Anche la virtù non ama di più le sue opere che vede afflitte e oppresse dalla sorte, ma, come i genitori, le abbraccia e le coccola maggiormente. Perché non esiste un bene più grande di un altro? Perché non esiste niente di più armonico dell’armonico, di più evidente dell’evidente. Se due cose sono uguali a un’altra non puoi dire che la prima è più uguale della seconda, dunque non esiste niente di più onesto dell’onesto. E se è uguale la natura di tutte le virtù sono uguali anche i tre generi di bene. Cioè, il gioire con moderazione e il dolersi con moderazione sono sullo stesso piano. La gioia è pari alla fermezza d’animo di chi reprime i gemiti sotto la tortura: quei beni sono da desiderare, questi da ammirare, ma sono entrambi sullo stesso piano, perché quanto c’è di negativo è coperto dalla forza di un bene tanto più grande. Chi giudica questi beni disuguali non guarda la virtù in sé stessa ma ne osserva gli elementi esteriori. I veri beni hanno il medesimo peso, la medesima grandezza: quelli falsi sono privi di sostanza: grandiosi e magnifici a vedersi, se si pesano si rivelano inconsistenti. È così, Lucilio mio: tutto ciò che la vera ragione approva è solido ed eterno, rafforza l’animo e lo innalza per sempre in una sfera superiore; quei beni che vengono lodati avventatamente e sono beni per il volgo fanno inorgoglire chi si compiace di cose vane, mentre quelli che sono temuti come mali gettano spavento negli animi e li rendono inquieti come gli animali di fronte a un pericolo apparente. Entrambe le cose, dunque, rasserenano e tormentano l’animo senza motivo: quelli non meritano gioia, questi non meritano timore. Solo la ragione è immutabile e ferma nel suo giudizio, poiché non è schiava dei sensi ma li domina. La ragione è uguale alla ragione come il giusto al giusto, dunque anche la virtù è uguale alla virtù: la virtù, infatti, altro non è che la retta ragione. Tutte le virtù sono aspetti della ragione, visto che sono rette, e se sono rette sono anche uguali. Quale la ragione, tali anche le azioni, le quali, quindi, sono tutte uguali, dato che, essendo simili alla ragione, sono anche simili fra
loro. Dico che le azioni sono uguali fra loro, in quanto oneste e rette, ma differiscono molto col variare della materia, che ora è più estesa ora più ristretta, ora nobile, ora umile, ora riguarda molti, ora pochi. Tuttavia, in tutte queste azioni l’elemento migliore è uguale: sono azioni oneste. Come gli uomini virtuosi, che sono tutti uguali, in quanto appunto virtuosi, ma diversi per età: l’uno è più vecchio, l’altro è più giovane; per aspetto fisico: l’uno è bello, l’altro è brutto; per sorte: quello è ricco, questo è povero, quello è influente, potente, noto a città e a popoli, questo è sconosciuto ai più e oscuro. Ma quanto alla virtù sono tutti uguali. I sensi non possono giudicare sui beni e sui mali: non sanno che cosa sia utile e che cosa inutile. Non possono esprimere un parere, se non sono messi di fronte alla realtà del momento; non prevedono il futuro, non ricordano il passato; ignorano la concatenazione di cause ed effetti. Ma è in base a questa che si compongono l’ordine e la successione degli eventi e l’unità di una vita che procederà sulla retta via. Dunque, la ragione è arbitro dei beni e dei mali; tiene in poco conto le cose estranee ed esteriori, e quelle che non sono né beni né mali, le giudica elementi accessori privi di qualsiasi importanza: per lei ogni bene è nell’animo. D’altronde, alcuni li considera beni primari, e li ricerca di proposito, come la vittoria, i figli virtuosi, la salvezza della patria; altri secondari, quelli che si manifestano solo nelle avversità, come il sopportare serenamente una malattia, il fuoco, l’esilio; altri indifferenti, che non sono più secondo natura che contro natura, come il camminare cautamente, lo star seduti in modo composto. Infatti, star seduti non è meno secondo natura che stare in piedi o camminare. I primi due tipi di beni sono diversi: gli uni, infatti, sono secondo natura, come gioire dell’affetto dei figli, dell’incolumità della patria; gli altri sono contro natura, come resistere coraggiosamente alle torture e sopportare la sete quando la malattia brucia le viscere. «Ma come? È un bene qualcosa contro natura?». Niente affatto: è contro natura, a volte, la situazione in cui quel bene si manifesta. Infatti, essere ferito e consumarsi tra le fiamme ed essere tormentati da una malattia sono cose contro natura, ma conservare un animo imperturbabile in mezzo a queste sofferenze è secondo natura. E, per dirla in breve, la materia del bene è talvolta contro natura, il bene mai, poiché non c’è alcun bene senza ragione, e la ragione segue la natura. «Che cos’è, dunque, la ragione?». La facoltà di imitare la natura. «Qual è il sommo bene dell’uomo?». Comportarsi secondo natura. «Non c’è dubbio», si dice, «che una pace stabile sia più fortunata di una riconquistata a prezzo di molto sangue, che una salute di ferro sia più fortunata di una riacquistata con sforzo e tenacia da malattie gravi e prossime alla morte. Parimenti non ci sarà dubbio che sia un bene più grande la gioia che non la fermezza d’animo di chi sopporta i tormenti delle ferite o del fuoco». Niente affatto: i beni fortuiti sono molto differenti fra loro, in quanto vengono valutati in base all’utilità di chi se ne serve. L’unico scopo dei veri beni è essere in accordo con la natura; e questo è uguale in tutti. Quando in Senato assentiamo al
parere di qualcuno, non si può dire che uno sia più d’accordo di un altro: tutti aderiamo al medesimo parere. La stessa cosa vale per le virtù: tutte sono conformi a natura. Uno è morto giovane, un altro vecchio, qualcuno ancora bambino, o si è soltanto affacciato alla vita: tutti costoro erano ugualmente mortali, anche se la morte ha fatto sì che la vita di alcuni fosse più lunga, ha reciso quella che era nel suo fiore e troncato quella di altri appena sbocciata. C’è chi muore mentre mangia, chi mentre dorme, chi mentre fa l’amore. Aggiungi quelli trafitti da una spada o uccisi dal morso di serpenti o sfracellati da un crollo o deformati a poco a poco da contrazioni nervose. Puoi dire che la morte degli uni sia migliore e quella degli altri peggiore, ma la morte è uguale per tutti. Le vie per le quali vi si giunge sono diverse, ma unico è il punto d’arrivo. Non c’è morte più grave o meno grave, essa si comporta con tutti allo stesso modo: pone fine alla vita. Lo stesso vale per i beni: un bene si manifesta fra i piaceri, un altro in mezzo a dolori e difficoltà; quello ha governato la benevolenza della sorte, questo ne ha domato la violenza: sono entrambi beni, anche se il primo ha percorso una strada facile e piana, il secondo una difficile. Il fine di tutti, infatti, è il medesimo: sono beni, sono da lodare, si accompagnano alla virtù e alla ragione; la virtù mette sullo stesso piano tutte le cose che riconosce. Non devi ammirare questo concetto come se appartenesse ai nostri stoici. Secondo Epicuro due sono i beni da cui deriva il sommo bene: che il corpo sia senza dolore e l’animo senza turbamento. Questi beni, essendo completi, non crescono: come potrebbe crescere, infatti, ciò che è completo? Se il corpo è senza dolore cosa si può aggiungere a questa assenza di dolore? L’animo è tranquillo e imperturbabile: cosa si può aggiungere a questa tranquillità? Come il cielo sereno non può diventare ancora più sereno quando è pulito nel suo più puro splendore, così è perfetta la condizione dell’uomo il cui bene deriva dalla cura del corpo e dell’anima e che realizza il massimo dei suoi desideri se non c’è inquietudine nell’animo né dolore nel corpo. Gli allettamenti esteriori non accrescono il sommo bene, ma se possibile lo rendono più gradevole e dilettevole; per l’uomo il bene assoluto consiste nella pace del corpo e dell’anima. Ti citerò ancora una divisione dei beni fatta da Epicuro molto simile alla nostra. Egli preferirebbe che gli toccassero in sorte alcuni beni, come la salute del corpo libero da ogni molestia e la serenità dell’animo che gioisce contemplando i propri beni, ma loda e ne apprezza anche altri, pur non volendo che gli capitino, come la capacità di sopportare malattie e dolori terribili, della quale parlavo poco fa, che Epicuro mostrò in quel suo ultimo e fortunatissimo giorno. Egli infatti dice di provare dolori tali alla vescica e al ventre piagato che più forti non potrebbero essere e che tuttavia quello è per lui un giorno felice. Ma solo chi possiede il sommo bene può vivere un giorno felice. Dunque, anche secondo Epicuro ci sono beni che preferiresti non sperimentare, ma che, se si presenta la necessità, devi accettare, lodare e considerare uguali a quelli più grandi. Non si può dire, infatti, che non sia uguale ai più grandi quel bene che
mise fine a una vita felice e che Epicuro ringraziò con le sue ultime parole. Lascia, mio ottimo Lucilio, che io esprima un pensiero alquanto ardito: se certi beni potessero essere più grandi di altri io ai dolci e piacevoli preferirei quelli che sembrano dolorosi, e li direi migliori. È più meritevole, infatti, vincere le difficoltà che tenere la giusta regola nelle circostanze propizie. Così accade che alcuni mantengano la moderazione nella prosperità e la fortezza nella sventura. Può essere ugualmente forte chi ha montato la guardia davanti alla trincea senza che il nemico assalisse l’accampamento e chi combattendo, pur con le caviglie spezzate, si è retto sulle ginocchia e non ha abbandonato le armi: «Gloria a voi per il vostro valore!», si dice ai soldati che tornano insanguinati dalla battaglia. Io, perciò, loderei di più i beni sottoposti a dure prove, che richiedono coraggio in lotta con la fortuna. Dovrei esitare a lodare quel moncherino bruciato di Muzio Scevola più della mano intatta di qualsiasi uomo valorosissimo? Rimase fermo, disprezzando i nemici e le fiamme e guardò la propria mano consumarsi sul braciere del nemico, finché Porsenna provò invidia per la gloria di colui che voleva punire e ordinò di portar via il braciere contro la sua volontà. Perché non dovrei annoverare fra i primi un simile bene e ritenerlo tanto più grande di quelli tranquilli e non messi alla prova dalla sorte avversa, quanto più raro è vincere il nemico con una mano perduta che con una mano armata? «E che, dunque?», mi chiedi. «Devo augurarti questo bene?». Perché no? Solo chi osa desiderarlo può procurarselo. O dovrei piuttosto farmi massaggiare le articolazioni dai miei amanti? Che una donnetta o un eunuco mi stiri le dita? Perché non dovrei considerare più fortunato Muzio, che si è comportato col fuoco come se avesse porto la mano a un massaggiatore? Rimediò così all’errore compiuto: inerme e mutilato pose fine alla guerra e con quella mano monca vinse due re.11 Stammi bene. 67. Comincerò con un argomento banale, dicendoti che la primavera iniziata da poco dovrebbe già andare verso l’estate e portarci il caldo, invece si è rinfrescata e non c’è ancora da fidarsi poiché spesso sembra che si ripiombi nell’inverno. Vuoi sapere quanto il tempo sia incerto? Non mi bagno ancora nell’acqua completamente fredda, ma ne attenuo il rigore. Mi dirai che ciò significa non sopportare né il caldo né il freddo. È così, Lucilio mio: ormai la mia età deve accontentarsi del freddo che le è proprio e che solo in piena estate se ne va. Per questo passo la maggior parte del tempo sotto le coperte. Ringrazio la vecchiaia che mi costringe a letto: e perché non dovrei ringraziarla per questo? Prima, infatti, ero costretto a non fare certe cose, ora non le faccio perché non posso farle. Mi intrattengo a lungo coi miei libri, e quando mi arrivano tue lettere, mi sembra di stare con te e di risponderti a voce, non per iscritto. Perciò, discuteremo insieme, come se io parlassi con te, la questione che poni. Mi chiedi se ogni bene sia desiderabile. «Se è un bene», dici, «sopportare con fermezza la tortura, stare in mezzo alle fiamme con coraggio e tollerare
pazientemente una malattia, ne consegue che queste cose sono desiderabili; eppure, io non vedo alcuna di esse degna di esser desiderata. Di certo non conosco una sola persona che abbia sciolto un voto per essere stata frustata, storpiata dalla gotta o allungata dal cavalletto». Se distingui bene, Lucilio mio, ti renderai conto che in queste situazioni c’è qualcosa di desiderabile. Io vorrei che la tortura se ne stesse sempre lontana da me, ma se dovrò subirla vorrò comportarmi con fortezza, con dignità e con coraggio. Io preferisco che non scoppi la guerra, ma se scoppierà vorrò sopportare da valoroso le ferite, la fame e tutti i mali che la guerra inevitabilmente comporta. Non sono tanto pazzo da volermi ammalare, ma se mi ammalerò non sarò intemperante e non mi comporterò come una femminuccia. Desiderabili non sono i disagi, desiderabile è la virtù con cui si sopportano i disagi. Alcuni stoici ritengono che sopportare con fermezza tutti questi mali non sia desiderabile, ma non è nemmeno da respingere, perché bisogna tendere al bene puro, tranquillo e privo di ogni turbamento. Io non sono d’accordo. Perché? Prima di tutto perché non è possibile che una cosa sia buona e al tempo stesso non desiderabile; in secondo luogo, se la virtù è desiderabile e non esiste alcun bene senza virtù ne consegue che ogni bene è desiderabile; inoltre, anche se i tormenti non sono desiderabili è desiderabile la capacità di sopportare coraggiosamente i tormenti. E ancora ti chiedo: non è forse desiderabile il coraggio? Eppure disprezza e sfida i pericoli; la sua prerogativa più bella e sorprendente è il non arrendersi al fuoco, l’andare incontro alle ferite, certe volte il non evitare i colpi, ma il porgere il petto per riceverli. Se il coraggio è desiderabile lo sarà anche la capacità di sopportare pazientemente i tormenti: anche questa, infatti, è una prerogativa del coraggio. Ma fa’ una distinzione, come ti ho detto: niente potrà indurti in errore. Desiderabile non è il subire i tormenti, è il sopportarli con coraggio: è questo che io desidero, è qui che sta la virtù. «Ma chi mai ha desiderato una cosa simile?». Certi desideri sono aperti e palesi, quando sono dichiarati singolarmente; altri restano nascosti, se un solo desiderio ne comprende molti. Per esempio, io mi auguro una vita virtuosa, ma una vita virtuosa è composta di diverse azioni: comprende la botte di Attilio Regolo, la ferita che Catone si inferse con la sua stessa mano, l’esilio di Rutilio, la coppa col veleno che portò Socrate dal carcere al cielo. Dunque, quando desidero una vita virtuosa desidero anche quelle cose senza le quali la vita non può essere virtuosa. Tre, quattro volte beato colui che al cospetto dei padri ebbe la morte cadendo sotto le mura di Troia.12 Che differenza c’è tra l’augurare a uno questa sorte e il riconoscere che è desiderabile? Decio13 offrì sé stesso per la salvezza della patria, e, spronato il cavallo, si lanciò in mezzo ai nemici cercando la morte. Dopo di lui il figlio,
emulo del valore paterno, pronunciata la formula sacra a lui familiare, si gettò nel folto della schiera nemica, spinto dal solo amore del sacrificio perché considerava desiderabile una morte da eroe. E tu dubiti che morire gloriosamente compiendo un’azione valorosa sia la cosa più bella? Quando uno sopporta i tormenti con coraggio mette in pratica tutte le virtù. Forse una sola virtù risalta e si manifesta più di tutte, la sopportazione; del resto è lì che c’è il coraggio, di cui la sopportazione, la resistenza e la tolleranza sono come dei rami; così c’è l’assennatezza, senza la quale non si prende alcuna decisione, e che ti spinge a sopportare con la maggiore fermezza possibile ciò che non puoi evitare; c’è la costanza, che non può essere rimossa e costretta da alcuna forza ad abbandonare il suo proposito; c’è, insomma, tutta l’inseparabile compagnia delle virtù. Ogni azione virtuosa è compiuta da una sola virtù, ma per decisione unanime di tutte le altre. Dunque, un’azione approvata da tutte le virtù, anche se sembra compiuta da una sola, è desiderabile. E che? Tu ritieni che sia desiderabile solo ciò che ci viene attraverso il piacere e una vita tranquilla, che si riceve con le porte ornate a festa? Ci sono beni apparentemente dolorosi, ci sono voti la cui realizzazione viene esaltata non da una schiera di gente che si congratula ma da una folla che ci ammira e ci guarda con religioso timore. Non credi che Regolo desiderasse giungere a Cartagine? Mettiti nei panni di quel grande uomo e lascia stare le opinioni del volgo; cerca di afferrare, nel giusto valore, la bellezza e la magnificenza della virtù, che dobbiamo onorare non con incenso e ghirlande, ma con sudore e sangue. Guarda Catone, che accosta al suo santo petto le purissime mani e allarga le ferite non abbastanza profonde. Che gli dici? «Vorrei quel che vuoi tu», «Mi dispiace», o «Ben vada quel che fai»? A questo punto mi viene in mente il nostro Demetrio, che chiama mare morto una vita tranquilla e senza alcun attacco da parte della fortuna. Non avere niente che ti stimoli, che t’infiammi, che con minacce e assalti metta alla prova la fermezza del tuo animo, ma startene in un riposo indisturbato non è tranquillità, è apatia. Lo stoico Attalo soleva dire: «Preferisco che la sorte mi tenga fra le battaglie piuttosto che fra i piaceri. Soffro, ma con coraggio, e questo è bene. Cado colpito a morte, ma con coraggio, e questo è bene». Epicuro dice che è anche piacevole, ma io non userò mai un aggettivo così delicato per un atteggiamento così virtuoso e austero. Le fiamme mi divorano, ma non mi dò per vinto: e perché non dovrebbe essere desiderabile? Non l’essere bruciato dal fuoco, ma il fatto che il fuoco non riesca a domarmi. Non c’è niente di più nobile della virtù, niente di più bello; e tutto ciò che si fa dietro suo ordine è buono e desiderabile. Stammi bene. 68. Approvo la tua decisione: conduci pure una vita appartata, ma nascondila agli altri. Sappi che così ti comporterai seguendo, se non l’insegnamento, l’esempio degli stoici, e tuttavia anche secondo il loro insegnamento, come potrai dimostrare a te e a chi vorrai. Noi non diciamo che il saggio debba partecipare sempre e senza alcun limite alla vita politica. D’altra parte, quando
gli diamo uno Stato degno di lui, cioè il mondo, egli non vive al di fuori della politica, anche se si è ritirato; anzi, forse, messo da parte un unico cantuccio, si dedica a questioni più importanti e più vaste, e, guardando le cose dall’alto, comprende com’era basso il luogo in cui si trovava quando saliva sulla sedia curule o sulla tribuna. Pensa che il saggio non è mai più attivo di quando si trova al cospetto sia delle cose umane che delle cose divine. Ritorno ora al consiglio iniziale, di tenere nascosta la tua vita appartata. Non c’è ragione che tu ne spieghi il perché attribuendone il motivo al tuo desiderio di startene tranquillo e di dedicarti alla filosofia: da’ un altro nome a questa tua decisione, chiamala cattiva salute, debolezza o anche pigrizia. Vantarsi della vita ritirata è un’ambizione senza senso. Certi animali, per non essere scoperti, confondono le loro tracce intorno alla tana: tu devi fare lo stesso, altrimenti ci sarà sempre qualcuno che non ti lascerà in pace. Molti, infatti, non si curano dei luoghi scoperti e facilmente accessibili, ma esplorano quelli nascosti, come un ladro che si eccita maggiormente di fronte a uno scrigno chiuso. Tutto ciò che si vede sembra di poco valore: lo scassinatore non guarda nemmeno ciò che è a portata di mano. Il volgo e tutte le persone ignoranti hanno queste abitudini: vogliono penetrare a forza nei luoghi più nascosti. Perciò la cosa migliore è non vantarsi della propria vita ritirata, già è una forma di ostentazione il nascondersi troppo e l’allontanarsi dal cospetto degli uomini. Uno si è ritirato a Taranto, un altro si è confinato a Napoli, un altro ancora da molti anni non varca la soglia di casa: chi crea sul suo ritiro un alone di leggenda attira molta gente. Una volta che tu ti sia ritirato devi fare in modo non che gli uomini parlino di te, ma che tu parli con te stesso. E di che cosa? Fa’ ciò che gli uomini fanno molto volentieri nei confronti degli altri: critica te stesso, così ti abituerai a dire e ad ascoltare la verità. E concentrati soprattutto sui lati più deboli del tuo carattere. Ciascuno conosce bene i difetti del proprio corpo, per cui c’è chi libera lo stomaco col vomito, chi lo vuota e purifica col digiuno, chi lo sostiene con pasti frequenti. Chi soffre di gotta si astiene dal vino e dai bagni: trascura tutto il resto e si premunisce contro il male che spesso lo molesta. Analogamente nel nostro animo ci sono alcune parti, per così dire, inferme, che vanno curate. Che cosa faccio nel mio ritiro? Curo la mia piaga. Se ti mostrassi uno dei miei piedi gonfio, una mano livida o i muscoli flaccidi di una gamba contratta, mi permetteresti di starmene sdraiato sempre nello stesso posto e di curare la mia malattia. Più grave è il male che non posso mostrarti: la piaga ulcerosa che ho nell’animo. No, non voglio che tu mi lodi, non voglio che tu dica: «Oh, che grand’uomo! Ha disprezzato tutto e dopo aver ripudiato le follie della vita umana se n’è fuggito». Io non ho condannato altro che me stesso. Non c’è motivo perché tu voglia venire da me per migliorarti. Sbagli se speri di trovare da me qualche aiuto: qui abita non un medico, ma un ammalato. Preferisco che quando te ne sarai andato tu dica: «Credevo che costui fosse un uomo felice e colto, avevo drizzato le orecchie: sono rimasto deluso, poiché non ho visto né sentito alcunché che rispondesse al mio desiderio e che mi inducesse a ritornare». Se pensi e se parli
così hai fatto un certo progresso: preferisco che tu provi compassione piuttosto che invidia per la mia vita ritirata. Potresti obiettare: «E proprio tu, Seneca, mi raccomandi una vita ritirata? Stai forse scivolando verso la dottrina epicurea?». Ti raccomando una vita ritirata in cui svolgere attività più importanti e più belle di quelle che hai lasciato: bussare alle superbe porte dei potenti, stilare un elenco dei vecchi privi di eredi, godere di grande autorità nel Foro sono cose che destano invidia, di breve durata e, a dire il vero, spregevoli. Uno mi supererà per il prestigio di cui gode nel Foro, un altro per le imprese militari e per la posizione così conquistata, un altro ancora per la folla di clienti. Non posso essere uguale a loro, che sono più favoriti di me: vale la pena che tutti mi superino, purché io superi la sorte. Oh se tu avessi deciso da tempo di attuare questo proposito! Se non discutessimo della felicità ora che siamo in vista della morte! Ma anche adesso non perdiamo tempo: infatti molte cose che prima la ragione c’induceva a considerare inutili e dannose ora le giudichiamo tali in base all’esperienza. Acceleriamo il passo come fanno quelli che essendo usciti troppo tardi vogliono recuperare il tempo perduto camminando velocemente. La nostra età è la più adatta a queste riflessioni: ormai si è calmata, i vizi, indomabili nel primo ardore dell’adolescenza, si sono sopiti e fra non molto spariranno del tutto. «E quando», obietti, «o a quale scopo ti gioverà ciò che impari in punto di morte?». Mi serve a questo: a uscire più saggio dalla vita. Non credere che ci sia un’età più adatta alla saggezza di quella che ha raggiunto il dominio di sé attraverso molte esperienze e lunghi e frequenti pentimenti; di quella che, placate le passioni, si occupa della salvezza spirituale. Questa è l’età più adatta per un tale bene: chi giunge alla saggezza da vecchio vi è giunto attraverso gli anni. Stammi bene. 69. Non mi piace che tu cambi continuamente sede e salti da un luogo all’altro, prima di tutto perché uno spostamento così frequente è indizio di un animo incostante: non ci si fortifica nell’isolamento se non si smette di guardarsi attorno e di vagabondare. Se vuoi tenere a freno lo spirito metti fine alla fuga del corpo. In secondo luogo tieni presente che i rimedi giovano davvero se sono continui: non bisogna interrompere la quiete né l’oblio della vita precedente; lascia che i tuoi occhi dimentichino, che le tue orecchie si abituino a parole più sane. Ogni volta che uscirai fra la gente, anche solo di passaggio, ti imbatterai in qualcosa che ridesterà i tuoi desideri. Come chi cerca di liberarsi di un amore deve evitare tutto ciò che gli ricorda la persona amata (non c’è cosa, infatti, che riarda più facilmente dell’amore), così chi vuole spegnere il rimpianto di ciò per cui bruciava di desiderio deve distogliere gli occhi e le orecchie da ciò che ha abbandonato. La passione torna presto all’attacco. Dovunque si volga, troverà qualche ricompensa immediata alla sua attività. Ogni vizio promette un compenso: l’avidità, il denaro, la lussuria, numerosi e svariati piaceri, l’ambizione, vesti di porpora e consensi, quindi potere e tutto ciò che il potere comporta. I vizi allettano con una ricompensa, la virtù non si fa pagare. A stento
può accadere che in una vita intera i vizi, imbaldanziti per una troppo lunga sfrenatezza, si sottomettano e accettino il giogo, e tanto meno se spezzettiamo un tempo così breve con frequenti intervalli; a stento si può condurre a perfezione una qualsiasi cosa con una cura e un’applicazione continue. Se vuoi prestarmi ascolto, medita ed esercitati sì che tu possa accettare la morte e, se necessario, cercarla: non c’è alcuna differenza se è la morte a venire da noi o se siamo noi ad andare da lei. Convinciti che è falsa quella frase pronunciata da tutti gli uomini più ignoranti: «È bello morire di morte naturale». Tutti muoiono di morte naturale. Rifletti poi su questo: tutti muoiono nel giorno stabilito dal destino. Non perdi nulla del tempo che ti compete; quello che lasci non è tuo. Stammi bene.
1. Personaggio sconosciuto. 2. Omero, Iliade XIX 229; XXIV 602. 3. Filosofo epicureo a cui Seneca dedicò i dialoghi La fermezza del saggio, La tranquillità dell’animo e La vita contemplativa, nel tentativo di convertirlo allo stoicismo. 4. Virgilio, Eneide IV 158-59: è il desiderio di Ascanio, figlio di Enea, durante la caccia indetta da Didone in onore dei Troiani. 5. Aristotele, Metafisica IV 1013, 24 sgg. 6. Sono le celebri statue di Policleto (V sec. a.C.): il portatore di lancia e l’atleta col capo cinto dalla benda della vittoria. 7. Platone, Timeo 29. 8. Personaggio ignoto. 9. Virgilio, Eneide V 344. 10. Tiranno di Agrigento, noto per la sua crudeltà. 11. Tarquinio il Superbo e Porsenna. 12. Virgilio, Eneide I 94-96: sono parole di Enea durante la tempesta che minaccia la sua flotta. 13. Publio Decio Mure, console nel 340 a.C., e il figlio, che combatté a Sentino.
Libro ottavo 70. Dopo parecchi anni ho rivisto la tua Pompei. Mi ha ricordato la mia giovinezza e ho sentito quel tempo tanto vicino che mi sembrava di potervi ripetere le mie imprese di allora. Caro Lucilio, rapida è stata la nostra traversata della vita e come in mare, a quanto scrive il nostro Virgilio, si allontanano paesi e città,1 così in questa corsa velocissima del tempo ci siamo lasciati dietro prima la fanciullezza, poi l’adolescenza, poi l’età intermedia fra giovinezza e vecchiaia, che confina con entrambe, poi gli anni migliori della vecchiaia; in ultimo comincia a mostrarsi all’orizzonte quella che è la fine comune di tutti gli uomini, che noi, nella nostra stoltezza, consideriamo uno scoglio, e che invece è un porto, da cercare, non da rifiutare, e chi vi arriva nei suoi primi anni di vita non deve lamentarsene in quanto è come uno che abbia compiuto velocemente la sua traversata per mare. Nella navigazione, infatti, c’è chi è trattenuto da venti deboli che si prendono gioco di lui e lo stancano con una bonaccia esasperata e tenace, e chi invece è portato alla meta molto velocemente da un vento costante. Ebbene, a noi accade la stessa cosa: alcuni la vita li conduce molto rapidamente verso la meta, alla quale, pur temporeggiando, devono comunque arrivare, altri li stanca e li consuma. La vita non sempre va conservata, poiché il bene consiste non già nel vivere, ma nel vivere bene. Perciò, il saggio vivrà quanto deve, non quanto può. Deciderà dove vivere, con chi, in che modo e cosa fare. Egli bada sempre alla qualità della vita, non alla sua lunghezza. Se è colpito da molte disgrazie che turbano la sua serenità, se ne va, e non solo se si trova in uno stato di estrema necessità, ma non appena comincia a sospettare della sorte considera seriamente se non sia il caso di farla finita. Per lui non è importante morire o accettare la morte, che questa avvenga presto o tardi, egli non la teme come se fosse un grave danno: uno stillicidio non può causare ad alcuno grandi perdite. Non importa, insomma, morire presto o tardi, importa morire bene o male; morire bene significa sfuggire al pericolo di vivere male. Perciò giudico assai vili le parole di quel famoso rodiese2 che, gettato dal tiranno in una gabbia e nutrito come una fiera, a chi gli consigliava di non toccare cibo rispose: «Finché c’è vita c’è speranza». Anche se questo è vero, non ci si deve comprare la vita a qualunque prezzo. Mi offrano pure beni grandi e sicuri, io non vorrei ottenerli con una vergognosa professione di viltà: dovrei pensare che la sorte ha pieni poteri su chi vive e non che è impotente su chi sa morire? A volte, tuttavia, anche se su di lui incombe una morte sicura ed egli sa di essere destinato alla pena capitale, il saggio non presterà la sua mano al supplizio: farebbe un piacere a sé stesso. È da stolti morire per paura della morte: viene il boia? Aspettalo. Perché lo precedi? Perché ti fai carico della
crudeltà altrui? Invidi il tuo carnefice o ne hai compassione? Socrate avrebbe potuto mettere fine alla sua vita col digiuno e morire di fame invece che di veleno; eppure, passò trenta giorni in carcere aspettando la morte, non perché credesse che tutto fosse possibile, che un tempo così lungo consentisse molte speranze, ma per obbedire alle leggi, per far sì che gli amici potessero trarre profitto dai suoi ultimi giorni. Che cosa sarebbe stato più stolto che disprezzare la morte, ma temere il veleno? Scribonia,3 donna severa, era zia paterna di Druso Libone,4 un giovane stupido quanto nobile, che coltivava speranze più grandi di quelle che chiunque potesse nutrire in quell’epoca o egli stesso in ogni altra. Malato, ricondotto in lettiga dal Senato con un piccolo seguito (tutti i parenti lo avevano abbandonato senza pietà, quasi fosse un cadavere, ormai, più che un colpevole), cominciò a riflettere se darsi la morte o aspettarla. Ebbene, Scribonia gli disse: «Che piacere provi a sbrigare una faccenda che spetta ad altri?». Non riuscì a convincerlo: egli si suicidò, e non senza ragione. Infatti, chi è destinato ad essere ucciso da un suo nemico nel giro di tre o quattro giorni, se vive, svolge proprio un compito che tocca ad altri. Perciò, quando una forza esterna minaccia la morte non si può stabilire in generale se la si debba prevenire o aspettare, poiché sono molti i fattori che possono farci decidere in un senso o nell’altro. Se una morte è accompagnata da tormenti, mentre l’altra è agevole e facile, perché non dovrei decidere per quest’ultima? Come scelgo la nave dovendo viaggiare per mare e la casa per abitarvi, così scelgo un tipo di morte per uscire dalla vita. E poi, se una vita più lunga non è necessariamente migliore, una morte attesa più lungamente è senz’altro peggiore. In nessuna cosa più che nella morte dobbiamo assecondare il volere della nostra anima: esca per quella via verso cui l’ha sospinta l’impulso, sia che preferisca la spada, il cappio o qualche veleno che penetri nelle vene, avanzi decisa e spezzi le catene della schiavitù. Ciascuno di noi deve rendere accettabile anche agli altri la propria vita, la morte solo a sé stesso: quella che gli risulta più gradita è la migliore. Stolto è chi pensa: «Qualcuno dirà che mi sono comportato poco coraggiosamente, altri troppo avventatamente, o che c’era un tipo di morte più coraggioso». Convinciti che si tratta di una decisione in cui non contano le opinioni altrui. Bada a una cosa sola: a sottrarti al più presto al dominio della sorte; d’altra parte ci sarà sempre qualcuno che criticherà il tuo gesto. Troverai anche alcuni che si professano saggi i quali sostengono che non si debba fare violenza alla propria vita, giudicando il suicidio un’empietà: bisogna aspettare la fine che la natura ha stabilito, dicono. Chi afferma ciò non si rende conto che in tal modo ci si preclude la via della libertà: la legge eterna non poteva far niente di meglio che darci una sola via d’entrata alla vita, ma molte vie d’uscita da essa. Dovrei aspettare la crudeltà di una malattia o di un uomo, quando posso sottrarmi ai tormenti e sconfiggere le avversità? Questo è l’unico motivo per cui non possiamo lamentarci della vita: non trattiene nessuno. La condizione umana è buona: nessuno è infelice se non per propria colpa. La vita ti
piace? Vivi. Non ti piace? Puoi ritornare là da dove sei venuto. Per liberarsi dal mal di testa si fa spesso ricorso a un salasso, per far calare la pressione si apre una vena. Non occorre lacerarsi il petto con una larga ferita, basta un bisturi ad aprire la via a quella grande libertà: la serenità dipende da un forellino. Cos’è, allora, che ci rende pigri e inerti? Nessuno di noi pensa che prima o poi dovremo abbandonare questa dimora; l’attaccamento a essa e l’abitudine ci trattengono come vecchi inquilini anche in mezzo ai disagi. Vuoi essere libero dai legami del corpo? Abitalo come se dovessi lasciarlo da un momento all’altro per trasferirti altrove. Tieni presente che questa convivenza prima o poi cesserà, e tu sarai più forte di fronte alla necessità di andartene. Ma chi non ha limiti ai suoi desideri come potrà pensare alla sua fine? La morte è l’oggetto su cui più di ogni altra cosa si deve meditare; per altri casi ci si esercita forse inutilmente. L’animo si è preparato contro la povertà, ma intanto le nostre ricchezze ci sono rimaste. Ci siamo fortificati per disprezzare il dolore, ma il nostro corpo, rimasto fortunatamente integro e sano, non ci ha mai richiesto di mettere alla prova questa virtù. Ci siamo preparati a sopportare con coraggio la perdita dei nostri cari, e la sorte ha conservato in vita tutti quelli che amavamo. Ma verrà il giorno che richiederà la pratica unica e sola della meditazione sulla morte. Non credere che solo i grandi uomini abbiano avuto la forza di spezzare le catene della schiavitù umana, che nessuno possa fare quel che ha fatto Catone, il quale trasse fuori con la mano quell’anima che non era riuscito a far uscire con la spada: uomini di infima condizione sociale si sono messi in salvo con un impeto eccezionale, non potendo morire a modo loro né scegliere a proprio arbitrio gli strumenti per darsi la morte, hanno afferrato tutto ciò che gli capitava a tiro e con la loro forza hanno trasformato in armi oggetti innocui per natura. Recentemente, in vista di un combattimento di gladiatori con bestie feroci, uno dei Germani, mentre si preparava per gli spettacoli del mattino, si appartò per scaricare l’intestino – l’unica cosa che potesse fare senza essere sorvegliato – e come lì c’era un bastone con in cima una spugna per pulirsi dagli escrementi se lo ficcò tutto in gola e morì soffocato. Fu uno sfregio alla morte. Proprio così, in maniera immonda e indecente; ma cosa c’è di più stupido che fare gli schizzinosi davanti alla morte? Oh uomo forte, degno di poter scegliere il proprio destino! Con quale fermezza avrebbe usato la spada, con quanto coraggio si sarebbe gettato negli abissi del mare o in un precipizio! Privo di ogni mezzo, trovò comunque il modo e l’arma per darsi la morte, sicché ora tu sai che l’unico indugio al morire è la volontà. Ciascuno giudichi come crede il gesto di quest’uomo fierissimo, ma sia ben chiaro che è meglio la morte più sudicia che la schiavitù più pulita. E visto che ho fatto ricorso a esempi sconvenienti proseguirò così, poiché, vedendo che la morte può essere disprezzata anche dagli uomini più spregevoli esigeremo da noi stessi di più. Noi crediamo che i Catoni, gli Scipioni e gli altri i cui nomi siamo abituati a sentire con ammirazione siano troppo grandi per poter essere imitati: ebbene, io ti dimostrerò che esempi di questa virtù sono tanti tra i gladiatori che combattono contro le belve quanti tra i capi della guerra civile.
Poco tempo fa un gladiatore, mentre, seduto sul carro, attendeva di essere trasportato sotto scorta allo spettacolo del mattino, come se gli ciondolasse la testa per il sonno, la piegò fino a infilarla tra i raggi di una delle ruote, e rimase fermo al suo posto finché questa, girando, non gli spezzò il collo; si sottrasse al supplizio con lo stesso mezzo che ve lo conduceva. Non ci sono ostacoli per chi vuole slegarsi e fuggire: la natura ci tiene in custodia in un luogo aperto. Chi è favorito dalle circostanze cerchi una via d’uscita agevole; chi ha a portata di mano più mezzi con cui liberarsi scelga quello che gli consenta di farlo nel modo migliore. Colui al quale mancano occasioni favorevoli afferri la prima che gli capita come se fosse la migliore, anche se nuova e insolita. Chi ha coraggio non manca di ingegnosità di fronte alla morte. Non vedi che anche gli schiavi più umili, quando li stimola il dolore, si svegliano ed eludono anche la più attenta sorveglianza? Grande è colui che non solo è deciso a morire, ma trova anche il mezzo per farlo. Eccoti, come promesso, altri esempi dello stesso genere. Durante il secondo spettacolo di naumachia5 un barbaro si conficcò in gola tutta intera la lancia che gli era stata data per combattere gli avversari. «Perché, perché», egli disse, «non sfuggo subito a ogni tormento, a ogni umiliazione? Perché, armato, aspetto da altri la morte?». Questo spettacolo fu tanto più bello quanto è più dignitoso che gli uomini imparino a morire piuttosto che a uccidere. E che, dunque? Il coraggio che di fronte alla morte hanno anche sciagurati e delinquenti non lo avranno coloro che a essa sono stati preparati da una lunga meditazione e dalla ragione, che è maestra di vita? Essa c’insegna che le vie della morte sono molte e diverse, ma che il punto d’arrivo è uno solo, che non importa da dove parta ciò che arriva senz’altro. La ragione stessa ci invita a morire, come ci piace, se è lecito, altrimenti come possiamo, e ad afferrare qualunque cosa capiti per darci la morte. È vergognoso vivere di rapina, morire di rapina, invece, è bellissimo. Stammi bene. 71. Spesso mi chiedi consigli su questioni particolari, dimenticando che ci divide un largo tratto di mare. L’efficacia di un consiglio dipende in gran parte dalla tempestività con cui viene dato, sicché è inevitabile che il mio parere su certe questioni ti arrivi quando ormai sarebbe più opportuna la soluzione opposta. I consigli, infatti, si adattano alla realtà del momento, mentre la nostra muta, anzi, si evolve rapidamente; un consiglio, dunque, dovrebbe nascere nell’arco di un giorno, ma anche così è troppo tardi: deve nascere, come si dice, su due piedi. Ti mostrerò come lo si trovi. Ogni volta che vorrai sapere cosa devi evitare e cosa ricercare, volgi lo sguardo al sommo bene, che è il fine supremo di tutta la tua vita. Ogni nostra azione deve conformarsi a esso e solo chi avrà già dato un orientamento generale alla propria vita potrà deciderne i particolari. Nessuno, pur avendo a portata di mano tutti i colori, può fare un ritratto somigliante se non sa già ciò che vuole dipingere. Noi invece sbagliamo perché decidiamo sugli episodi singoli della nostra vita, non sulla vita nella sua totalità. Chi vuole scagliare una freccia deve sapere qual è il bersaglio e solo
allora dirigere e regolare l’arma con la mano: i nostri consigli sbandano perché non hanno un obiettivo preciso; a chi non sa a quale porto dirigersi nessun vento è propizio. Viviamo a caso e perciò il caso ha un ruolo fondamentale nella nostra vita. Come alcuni non sono consapevoli di sapere determinate cose, così spesso cerchiamo chi ci sta accanto e per lo più ignoriamo che il traguardo del sommo bene è lì davanti a noi. E non serviranno molte parole né lunghe perifrasi per definire il sommo bene: lo si deve indicare, per così dire, col dito, senza frantumarlo. A che serve, infatti, spezzettarlo in tante parti quando puoi dire: «Il sommo bene è l’onestà» e, cosa ancor più straordinaria: «L’unico bene è l’onestà, gli altri sono beni falsi e fittizi»? Se te ne convincerai e amerai appassionatamente la virtù (amarla soltanto, infatti, sarebbe troppo poco), tutto ciò che essa toccherà sarà per te prospero e felice, comunque la pensino gli altri. Anche la tortura, se sei più tranquillo del carnefice stesso, anche la malattia, se non maledirai la sorte e non ti lascerai sopraffare dalla malattia, come tutto ciò che agli altri sembra un male si addolcirà e si trasformerà in bene, se saprai innalzarti al di sopra di esso. Sia ben chiaro che niente è buono se non è onesto: e tutti i guai a ragione saranno chiamati beni se li abbellirà la virtù. Molti ritengono che si prometta più di quanto consenta la condizione umana, e non a torto, visto che guardano al corpo. Si volgano all’anima, e misureranno l’uomo in base al divino. Innalzati, mio ottimo Lucilio, e abbandona questo gioco infantile dei filosofi, che riducono a sillabe una disciplina magnifica e insegnando quisquilie deprimono e inaridiscono l’animo: diverrai simile a coloro che queste cose le hanno scoperte, non a quelli che le insegnano facendo apparire la filosofia non nobile ma difficile. Socrate, che riconduce tutta la filosofia alla morale e sostiene che la somma saggezza consiste nel distinguere il bene dal male, dice: «Se mi dài un po’ di credito, segui l’esempio di quei grandi uomini per essere felice, e lascia pure che qualcuno ti giudichi uno sciocco. Ti insulti e ti offenda chi vuole, tu non soffrirai se la virtù sarà con te. Se vuoi essere felice», aggiunge, «se vuoi essere davvero virtuoso, lascia che qualcuno ti disprezzi». Nessuno arriverà a questo se non avrà prima egli stesso disprezzato ogni cosa, se non avrà posto tutti i beni sullo stesso piano, perché non esiste bene senza l’onestà, e l’onestà è uguale in tutti i beni. «Allora non c’è differenza se Catone ottiene la pretura o non viene eletto? Non c’è differenza se a Farsalo perde o vince? Non poter essere sconfitto nonostante la sconfitta del suo partito e tornare vincitore in patria e ristabilire la pace erano entrambi un bene per lui?». E perché no? La virtù che vince l’avversa fortuna e quella che regola la buona sorte è la medesima, e la virtù non può diventare maggiore o minore: la sua statura è sempre la stessa. «Ma Gneo Pompeo perderà l’esercito; ma il più bell’ornamento dello Stato, il patriziato e la prima linea del partito pompeiano, il Senato in armi, saranno sconfitti in una sola battaglia, e le rovine di un così grande impero si disperderanno per tutta la terra: una parte cadrà in Egitto, una in Africa, una in Spagna. Alla sventurata
repubblica non toccherà nemmeno di crollare tutta in una volta». Capiti pure di tutto: a Giuba6 nel suo regno non sia di alcun aiuto la conoscenza dei luoghi, né il valore indomabile di un popolo in difesa del suo re; venga meno anche la fedeltà degli Uticensi, infranta dalle sventure, e la fortuna legata al suo nome abbandoni Scipione in Africa: già da un pezzo si era provveduto affinché Catone non subisse alcun danno. «Però è stato battuto». Metti anche questo fra gli insuccessi di Catone: egli sopporterà con la stessa fermezza d’animo che gli siano state negate la vittoria e la pretura. Il giorno in cui fu sconfitto lo passò giocando a palla e la notte in cui doveva morire la trascorse leggendo: tenne nello stesso conto la perdita della pretura e della vita, convinto com’era che si devono sopportare tutte le avversità. E perché non avrebbe dovuto sopportare con fermezza e serenità il rivolgimento dello Stato? Nemmeno la terra si sottrae al rischio del cambiamento, nemmeno il cielo e l’intero universo così strettamente connesso nei suoi elementi, benché sia retto dall’azione di dio; non manterrà sempre quest’ordine, ma un bel giorno devierà dal suo corso attuale. Tutti gli esseri procedono secondo tempi ben precisi e programmati: nascono, crescono e muoiono. Tutti i corpi celesti che vedi correre sopra di noi e quello su cui siamo stati posti e poggiamo come se fosse solidissimo si frantumeranno e verranno meno; ogni cosa ha la sua vecchiaia. A intervalli diversi la natura conduce tutti alla medesima fine: tutto ciò che esiste non esisterà più, ma non finirà nel nulla, si disgregherà. Per noi disgregarsi significa scomparire, perché vediamo solo le cose che ci stanno davanti agli occhi, la nostra mente ottusa e schiava del corpo non guarda più in là; d’altro canto sopporteremmo con maggior fermezza la fine nostra e dei nostri cari se avessimo la speranza che la vita e la morte, come tutto il resto, si avvicendano e che la materia composta si dissolve e una volta dissolta si ricompone, ed è in quest’opera che si svolge l’eterna attività di dio che tutto governa. Perciò, come Catone, riandando con la memoria al passato, diremo: «Tutto il genere umano che è e che sarà è destinato a morire; di tutte le città che detengono il potere in qualche parte del mondo e di quelle che sono splendidi ornamenti degli imperi altrui, ci si chiederà un giorno dove sorgessero: esse, infatti, scompariranno ciascuna in modo diverso, quali distrutte dalle guerre, quali logorate dall’inerzia e dalla pace trasformatasi in ozio e dalla dissolutezza, fatale alle grandi potenze. Un’inondazione improvvisa sommergerà queste fertili pianure o il franare del suolo che si sprofonda le precipiterà in una voragine apertasi improvvisamente. Perché, dunque, dovrei sdegnarmi o dolermi se precedo di un esiguo momento il destino comune?». Un animo nobile obbedisca a dio e si sottometta senza esitare a qualunque norma della legge universale: o sarà avviata a un’esistenza migliore per vivere in un’atmosfera più luminosa e serena fra le cose divine, o certamente sarà immune da ogni molestia, se si unirà di nuovo alla natura e ritornerà al tutto. Dunque, la vita virtuosa di Catone non è un bene maggiore della sua morte virtuosa, poiché la virtù non si accresce. Socrate diceva che virtù e verità sono la medesima cosa: non cresce la
verità, non cresce la virtù, che è completa in tutte le sue parti. Non c’è dunque da stupirsi che i beni siano uguali, sia quelli che bisogna ricercare deliberatamente, sia quelli che ci portano le circostanze. Se fra loro, infatti, ammetti delle disparità e consideri un bene minore il sopportare con fermezza la tortura, questo stesso bene finirai per annoverarlo fra i mali, e giudicherai infelice Socrate in carcere e infelice Catone, che riaprì le sue ferite con un coraggio maggiore di quello con cui se le era inferte, e più infelice di tutti Regolo, che pagò il prezzo di un giuramento rispettato anche di fronte al nemico. E tuttavia nessuno, neppure fra i meno virili, ha osato affermare una cosa simile; non dicono che sia stato felice, ma nemmeno pensano che sia stato infelice. I filosofi dell’antica Accademia ammettono che uno può essere felice anche fra i tormenti, ma non in modo pieno e perfetto; è una tesi del tutto inaccettabile, perché se uno non è felice, non possiede il sommo bene, il quale non ha nulla sopra di sé, purché in esso sia insita la virtù e non la indeboliscano le avversità, e rimanga intatta anche quando il corpo è fatto a pezzi: e tale infatti resta. Quella virtù, voglio dire, nobile e coraggiosa, per la quale qualsiasi avversità è uno stimolo. È la saggezza a trasmetterci e a infonderci questo coraggio, di cui spesso sono dotati giovani di animo nobile, colpiti a tal punto dalla bellezza di qualche grande azione da essere indotti a disprezzare tutto ciò che è soggetto al caso; essa ci convincerà che esiste un unico bene, la virtù, e che non si può né allentarla né tenderla, come non si può piegare il regolo con cui si controlla se una linea è retta: qualunque modifica apporti, rechi un danno a ciò che deve essere diritto. La stessa cosa vale per la virtù: anch’essa è retta e non ammette storture, può diventare più rigida, ma non tendersi di più. La virtù giudica ogni cosa, ma non è giudicata da alcuna, e se non può diventare più dritta di quanto è, neppure le azioni che da essa derivano possono variare quanto a dirittura, ma devono necessariamente essere conformi a essa, e dunque sono uguali. «E allora?», mi dirai. «Starsene sdraiati a un banchetto ed essere torturati sono la stessa cosa?». Ti sembra strano? Dovresti stupirti di più se ti dicessi che starsene sdraiati a un banchetto è male, essere distesi sul cavalletto è un bene, se nel primo caso ti comporti in modo vergognoso e nel secondo virtuosamente. Non è la materia, è la virtù che rende buone o cattive le azioni; dovunque essa si manifesti tutto assume la stessa misura e lo stesso valore. A questo punto uno che giudicasse l’animo di tutti gli altri in base al proprio vorrebbe cavarmi gli occhi in quanto io sostengo che per chi giudica con onestà sono uguali sia i beni di chi celebra il trionfo sia quelli di chi è condotto davanti al carro trionfale come prigioniero ma con animo invitto. Gente simile, infatti, ritiene impossibile ciò che essa non può fare: esprime un giudizio sulla virtù in base alla propria debolezza. Perché ti meravigli se l’essere bruciati, feriti, uccisi, incatenati può essere gradito, anzi può addirittura piacere? Per il dissoluto la frugalità è una pena, per il pigro la fatica è un supplizio, l’effeminato compatisce le persone attive e operose, per l’indolente applicarsi è un tormento: analogamente ci sembrano gravose e insopportabili quelle cose di fronte alle quali ci sentiamo
incapaci, dimenticando che per molti è un tormento non avere vino o alzarsi all’alba. Non sono cose difficili per natura, siamo noi fragili e senza nerbo. Delle cose grandi bisogna giudicare con animo grande, diversamente attribuiremo a esse difetti che invece sono nostri. Così un’asta drittissima immersa nell’acqua ci sembra curva e spezzata. Non conta ciò che guardi, conta come lo guardi: la nostra mente si ottenebra quando scruta la verità. Prendi un giovane incorrotto e di intelligenza vivace: dirà che gli sembra più felice chi sopporta a testa alta tutto il peso delle avversità, chi si innalza al di sopra della fortuna. Non è straordinario non essere scossi quando tutto è tranquillo, c’è da meravigliarsi, invece, che qualcuno si sollevi quando tutti si lasciano abbattere, che qualcuno stia in piedi mentre tutti giacciono a terra. Qual è il male nei tormenti e nelle altre cose che chiamiamo avversità? Questo, io credo: il venir meno dello spirito, il piegarsi e il lasciarsi sopraffare. Niente di tutto ciò può accadere all’uomo saggio, che sta dritto sotto qualsiasi peso. Niente lo sminuisce, nessuna avversità che gli accade di sopportare gli riesce sgradita: non si lamenta, infatti, dal momento che qualunque cosa gli capiti rientra in tutto ciò che può accadere a un uomo. Conosce bene le sue forze, sa di essere destinato a portare dei pesi. Con tutto ciò non considero il saggio un’eccezione fra gli uomini, né gli nego il dolore, quasi fosse una roccia priva di sensibilità. Non dimentico che è formato di due parti, una delle quali è irrazionale, e perciò soffre, è agitata dai sensi e dal fuoco delle passioni, l’altra è razionale, e come tale ha le sue convinzioni, ed è animosa e indomabile. È in questa che risiede il sommo bene dell’uomo. Certo, finché non è satura di conoscenza, la mente è instabile, indecisa, ma quando è giunta alla perfezione, quando si è pienamente realizzata, nulla la smuove dalla sua fermezza. Perciò, chi si avvia verso la vetta e coltiva la virtù, anche se si avvicina al bene perfetto, finché non l’avrà raggiunto retrocederà talvolta, allentando la tensione del suo animo, perché ancora non ha superato le incertezze e cammina su un terreno scivoloso. Ma l’uomo felice che ha raggiunto la virtù perfetta è tanto più contento di sé quanto più si è messo a dura prova e non solo sopporta ciò che gli altri temono, se è il prezzo di qualche nobile azione, ma lo sceglie, e preferisce di gran lunga sentirsi dire: «Bravo!» invece di: «Sei fortunato!». Vengo ora alla questione su cui hai richiesto il mio parere. Affinché la nostra virtù non sembri una dote estranea alla natura umana, aggiungo che anche il saggio è soggetto ad aver paura, a soffrire, a impallidire: tutte queste, infatti, sono sensazioni fisiche, ma non costituiscono un male, diventano mali se avviliscono l’animo, se lo spingono a dichiararsene schiavo e a provare disgusto di sé. Il saggio con la virtù vince la sorte, ma molti che si professano saggi a volte si lasciano atterrire da minacce di poco conto. In questo caso l’errore è nostro, poiché pretendiamo da chi ancora procede sulla via della saggezza lo stesso comportamento del saggio. Io mi esorto a seguire questi princìpi che lodo, ma non ne sono ancora del tutto convinto, e anche se lo fossi non mi ritengo preparato ed esercitato abbastanza per affrontare ogni evenienza. Come la lana
prende subito certi colori, mentre altri li assume solo dopo essere stata ripetutamente messa a bagno e cotta nella tintura, così la mente assimila immediatamente alcuni insegnamenti: la saggezza, invece, se non penetra in profondità e non sedimenta a lungo ma colora solo leggermente e non permea l’animo sin nel profondo non mantiene alcuna delle sue promesse. Tale concetto si può anche esprimere in breve e con queste pochissime parole: l’unico bene è la virtù, non esiste alcun bene senza la virtù, e la virtù risiede nella parte migliore di noi, quella razionale. E cos’è questa virtù? La capacità di un giudizio certo e immutabile; e poiché da un simile giudizio derivano gl’impulsi della mente, le immagini generate da tali impulsi saranno necessariamente limpide e certe. Secondo questo modo di giudicare sarà logico considerare tutte quelle situazioni che sono in rapporto con la virtù come beni e uguali tra loro. I beni fisici sono sì beni per il corpo ma non in assoluto: avranno qualche valore, ma nessuna nobiltà, ci sarà tra loro una grande differenza, alcuni saranno più piccoli, altri più grandi. E dobbiamo riconoscere che anche tra i seguaci della saggezza ci sono grandi differenze: uno ha già fatto tali progressi da osare alzare gli occhi contro la sorte, ma non resiste e li abbassa perché abbagliato dal troppo splendore, un altro è progredito tanto da poterla guardare a tu per tu, quando non sia già arrivato alla vetta e pieno di fiducia in sé stesso. È inevitabile che chi è ancora imperfetto vacilli, ora proceda, ora scivoli indietro o si lasci abbattere. Ma scivolerà indietro se non persevererà nell’andare avanti con tutte le sue forze; se allenterà l’impegno e la tenacia dei propositi arretrerà. Nessuno lungo la via del progresso si ritrova al punto in cui si è lasciato. Insistiamo, dunque, e perseveriamo; ci restano da abbattere più ostacoli di quanti sino a ora non ne abbiamo abbattuti, ma il volere andare avanti è già un progresso notevole. Per quel che mi riguarda sono conscio di questo: io voglio, e voglio con tutte le forze della mente e dell’animo. Vedo che anche tu provi gli stessi stimoli e che con grande slancio aneli di pervenire alle più belle conquiste. Affrettiamoci a raggiungerle: soltanto allora la vita ci apparirà un beneficio; diversamente essa non è che un indugiare inutile, e per di più spregevole per coloro che vivono in mezzo alle brutture. Comportiamoci in modo che il tempo che trascorriamo sia interamente nostro, e non lo sarà se prima non avremo pensato a noi stessi. Quando ci capiterà di disprezzare la buona e la cattiva sorte, di soffocare tutte le passioni e di ridurle all’obbedienza gridando: «Ho vinto»? Chi, mi chiederai. Non certo i Persiani, né i lontanissimi Medi, né le popolazioni bellicose che forse abitano oltre i Dai,7 ma l’avidità, l’ambizione, il timore della morte, che ha vinto anche i grandi conquistatori. Stammi bene. 72. La questione che mi poni la conoscevo bene una volta (l’avevo infatti sviscerata a fondo), ma è da molto tempo che non esercito la mia memoria, perciò non mi è facile ricordarla. Mi è capitato ciò che suole accadere alle pagine dei libri, che si attaccano fra loro per il lungo disuso: la mente va messa a
punto e tutte le cognizioni che vi si sono depositate vanno passate continuamente in rassegna affinché siano pronte ogni volta che occorre servirsene. Dunque, tralasciamo per ora questo argomento, che richiede molto impegno e molta attenzione. Lo riprenderò in mano non appena potrò fermarmi più a lungo nel medesimo posto. Su certi argomenti si può scrivere anche viaggiando in calesse, altri richiedono un divano, tranquillità e solitudine. Tuttavia anche in quelle giornate in cui si è pieni di impegni si deve fare qualcosa e senza eccezione. Le occupazioni si succedono sempre una dopo l’altra, e siamo noi a seminarle, così da una sola ne nascono molte. Per di più ci concediamo delle proroghe: «Quando avrò concluso questa faccenda mi applicherò con tutta l’anima», diciamo. Oppure: «Se risolverò questo affare molesto mi dedicherò allo studio». Non devi dedicarti alla filosofia quando hai tempo libero, ma devi procurarti del tempo libero per dedicarti alla filosofia; dobbiamo trascurare tutto il resto per applicarci a essa, per la quale nessun tempo è abbastanza lungo, anche se la vita va dalla fanciullezza alla vecchiaia più inoltrata. Non c’è molta differenza fra il trascurare del tutto la filosofia e l’interromperne lo studio, poiché questo non resta fermo al punto in cui l’hai interrotto, ma, come una corda che si spezza perché troppo tesa, ritorna al punto di partenza, essendo venuta a mancare la continuità. Non si deve cedere agli impegni, bisogna non sbrigarli ma liberarsene. Non c’è un periodo poco adatto a uno studio utile e salutare, eppure molti non vi si applicano, pur trovandosi in situazioni che lo richiedono. «Ma capita sempre qualche impedimento». Non certo a una persona il cui animo è lieto e pronto in ogni sua attività: per chi è ancora imperfetto, la serenità può spezzarsi, mentre la gioia del saggio è senza interruzioni, non c’è nessun motivo, nessun rovescio di fortuna che possa interromperla, inquantoché il saggio è sempre e dovunque tranquillo, non dipende da altri e non attende il favore della sorte o degli uomini. La sua felicità è interiore, se provenisse dall’esterno potrebbe uscire dal suo animo, e invece gli nasce dentro. A volte qualche fattore esterno gli ricorda la sua condizione mortale, ma è cosa di poca importanza e lo tocca appena superficialmente. Insomma, non è che non abbia qualche fastidio, ma il sommo bene in lui è profondamente radicato. Voglio dire, ci sono fastidi esteriori, superficiali, come in un corpo forte e vigoroso delle eruzioni cutanee, delle vescichette e delle piccole piaghe, che all’interno non hanno alcunché di male. Fra chi ha raggiunto la saggezza e chi è ancora sulla sua strada c’è la stessa differenza che passa tra un uomo sano e uno che esce da una lunga e grave malattia, per il quale un attacco più leggero sembra già una guarigione, ma mentre costui se non sta in guardia subito si aggrava e ha una ricaduta, il saggio non può avere ricadute, né altri nuovi mali. La salute del corpo, infatti, ha una certa durata e il medico, anche se l’ha restituita, non può garantirla, e spesso ritorna al capezzale della stessa persona che lo aveva chiamato: l’animo, invece, una volta che è guarito, resta sempre tale. Che sia sano si capisce dal fatto che basta a sé stesso, che ha fiducia in sé stesso e sa che tutti i desideri degli uomini, tutti i benefìci concessi e richiesti non hanno alcuna importanza per la felicità.
Infatti, ciò a cui può aggiungersi qualcosa è imperfetto, ciò a cui può essere tolto qualcosa non è eterno: chi vuole essere sempre felice gioisca del suo. Tutte le cose che il volgo desidera ardentemente sono instabili: la sorte non concede alcuna cosa in proprietà. Ma anche questi beni fortuiti possono dare gioia, quando la ragione li regola e li combina in giusta misura: è la ragione a dar valore anche ai beni che provengono dall’esterno, il cui uso a chi ne è troppo avido finisce con l’essere persino spiacevole. Attalo era solito ricorrere a questa immagine: «Hai mai visto un cane che cerca di afferrare con la bocca aperta i pezzi di pane o di carne gettatigli dal padrone? Divora subito tutto intero quel che ha afferrato, e sta sempre a bocca aperta in attesa di un altro boccone. La stessa cosa succede a noi: tutto ciò che la fortuna ci getta davanti, mentre aneliamo in trepidante attesa, lo mandiamo subito giù senza nemmeno il tempo di gustarlo, attenti e ansiosi di afferrarne un altro». Al saggio questo non accade, perché è sazio; anche se gli arriva qualcosa di buono lo prende tranquillo e lo mette da parte; gode di una gioia grandissima, continua, tutta sua. C’è chi ha buona volontà, fa progressi, ma è ancora molto lontano dalla perfezione, e perciò ora si abbatte, ora si esalta, ora si innalza fino al cielo, ora precipita a terra. Per gli uomini ignoranti e rozzi non c’è fine alla loro caduta: precipitano giù nel famoso caos epicureo, nel vuoto senza confini. C’è poi una terza categoria di uomini che procedono sulla via della saggezza, che non l’hanno ancora raggiunta, ma ormai ne sono in vista e, per così dire, l’hanno a portata di mano: costoro non si turbano e non vanno alla deriva: non hanno ancora messo piede sulla terra, ma sono ormai in porto. In conclusione, poiché è così grande la differenza tra chi ha raggiunto la vetta della saggezza e chi è ancora in basso, poiché anche chi è arrivato a metà strada è trascinato dalla corrente e corre il grave pericolo di ritrovarsi in una condizione peggiore, non dobbiamo indulgere alle nostre occupazioni. Chiudiamole fuori, perché una volta che siano entrate ne seguiranno altre al loro posto. Stronchiamole sul nascere: è meglio non dar loro modo di cominciare piuttosto che doverle eliminare. Stammi bene. 73. A me sembra che sbaglino coloro che ritengono che chi si dedica alla filosofia con animo sincero sia superbo e ribelle e disprezzi i magistrati, i sovrani o coloro che amministrano lo Stato. Al contrario, non c’è nessuno più riconoscente di loro verso tali persone, e non a torto, in quanto esse giovano più che a ogni altro ai filosofi, a cui consentono di vivere una vita tranquilla e ritirata. Per questo è inevitabile che i filosofi, al cui proposito di vivere virtuosamente contribuisce molto la tranquillità pubblica, rispettino come un padre il responsabile di questo bene, certo molto più di quegli uomini turbolenti e traffichini che devono molto ai governanti ma gli addossano anche molte colpe: né vi è atto di generosità che possa saziare le loro brame, che crescono via via mentre vengono soddisfatte. Chi pensa ai benefìci che si aspetta si è già dimenticato di quelli che ha ricevuto, e il male peggiore dell’avidità è l’ingratitudine. Aggiungi che chi si dà alla politica guarda al numero non di
quelli che supera ma di quelli da cui è superato, e per lui più che piacevole vedere molti dietro di sé è penoso vederne qualcuno davanti. Ogni ambizione ha questo difetto: non guarda mai indietro. E instabile non è soltanto l’ambizione ma anche ogni forma di avidità, perché come raggiunge uno scopo ricomincia sempre da capo. Ma colui che onesto e sincero ha lasciato il Senato, il Foro e ogni incarico pubblico per ritirarsi e dedicarsi a questioni più importanti, ama coloro che gli consentono di farlo tranquillamente, ed è il solo che gli dimostri una sincera gratitudine e si senta debitore nei confronti di essi che non lo sanno neppure. Come venera e rispetta i suoi maestri, grazie ai quali è riuscito a venir fuori da situazioni senza via di uscita, così venera e rispetta anche costoro, sotto la cui protezione può coltivare la saggezza. «Ma il re protegge anche gli altri col suo potere». E chi lo nega? Ma, come fra gente che ha navigato con mare calmo e tranquillo si sente più debitore a Nettuno chi ha trasportato merci più preziose e in maggiore quantità, e il mercante ringrazia il dio con maggiore slancio del passeggero, e tra gli stessi mercanti esprime più vivamente la sua gratitudine quello che trasportava profumi, porpora e oggetti da pagare a peso d’oro che non quello che aveva ammassato merce di scarsissimo valore solo per farne zavorra, così il beneficio della pace concessa dal sovrano, che pure riguarda tutti, tocca maggiormente coloro che sanno farne buon uso. Molti cittadini, infatti, sono più operosi in pace che in guerra: o forse credi che siano ugualmente riconoscenti per la pace di cui godono quelli che la spendono nell’ubriachezza o nella lussuria o in altri vizi che dovrebbero essere debellati persino con la guerra? A meno che tu non pensi che il saggio sia tanto ingiusto da ritenersi immune da ogni obbligo personale per i beni che si godono in comune. Io devo molto al sole e alla luna, che tuttavia non sorgono solo per me; ho un obbligo personale di riconoscenza nei confronti dell’anno e di dio che ne regola il corso, benché le stagioni * * * non siano state ripartite singolarmente in mio onore. Gli uomini, nella loro stolta avidità, distinguono il possesso e la proprietà e non giudicano propri i beni pubblici, mentre il saggio giudica suo soprattutto ciò che possiede in comune con l’intera umanità. Questi beni, infatti, non sarebbero comuni se ai singoli individui non ne spettasse una parte, e si è comproprietari anche se in comune si possiede la più piccola quantità di bene. Inoltre i grandi e veri beni non si dividono, come se a ciascuno dovesse toccarne una piccola parte, ma pervengono interi a ogni singola persona. Da un’elargizione ciascuno prende quanto è stato assegnato a uno per uno; un banchetto pubblico, una distribuzione di carne al popolo e qualunque altro bene tangibile si divide in parti: ma i beni indivisibili, come la pace e la libertà, appartengono interi tanto ai singoli quanto a tutti gli uomini nella loro totalità. Il saggio, dunque, pensa per opera di chi gli tocchi l’uso e il frutto di questi beni, per opera di chi la situazione dello Stato sia tale da non chiamarlo alle armi o a montare la guardia, a difendere le mura e a pagare i molteplici tributi di guerra, e per questo motivo è grato a chi lo governa. La filosofia insegna soprattutto a sentirsi debitori per i benefìci ricevuti e a ricambiarli
giustamente: talvolta il riconoscere un debito è già un pagamento. Pertanto il saggio riconoscerà di essere molto debitore nei confronti di chi, col suo assennato governo, gli consente di godere di un ritiro fecondo, di disporre liberamente del suo tempo e di vivere una vita tranquilla, non turbata da occupazioni pubbliche. O Melibeo, un dio concesse a noi questa pace; egli, infatti, per me sempre un dio resterà.8 Se si è molto debitori a chi rende possibile quella quiete, il cui dono più grande è questo: Egli ha permesso ai miei buoi di andar pascolando e a me stesso, come tu vedi, di esprimere sulla zampogna i miei canti9 quanto dobbiamo apprezzare questa vita ritirata che si conduce tra gli dèi, che ci rende dèi? È così, Lucilio, ti chiamo in cielo per la via più breve. Sestio era solito dire che Giove non è più potente di un uomo virtuoso. Egli, in quanto dio, può donare agli uomini un maggior numero di beni, ma tra due uomini virtuosi non è migliore quello più ricco, come tra due timonieri ugualmente esperti nell’arte della navigazione non è migliore quello che possiede la nave più grande e più bella. In che cosa Giove è superiore a un uomo buono? È buono più a lungo, ma il saggio non si ritiene inferiore a lui per il fatto che la sua virtù è circoscritta in un arco di tempo più breve. Come tra due saggi quello che è morto più vecchio non è più felice dell’altro, la cui virtù è durata un minor numero di anni, così dio non supera il saggio in felicità, anche se lo supera nella quantità di tempo: una virtù che dura più a lungo non per questo è più grande. Giove possiede tutti i beni, ma ha dato ad altri la possibilità di goderne; egli può farne solo questo uso: concedere che ne usino tutti. Il saggio guarda i beni posseduti dagli altri con animo sereno e con distacco, come Giove, ma è più degno di ammirazione, perché mentre Giove non può farne uso, egli, invece, non vuole. Crediamo dunque a Sestio, che ci indica una via bellissima e grida: «Di qua si sale alle stelle,10 di qua seguendo la frugalità, la temperanza, la fortezza d’animo». Gli dèi non sono né altezzosi né invidiosi: dànno accoglienza e tendono la mano a chi sale. Ti meravigli che l’uomo salga fino agli dèi? dio scende fra gli uomini, anzi, più propriamente, negli uomini: non c’è infatti anima virtuosa senza la presenza di dio. Semi divini sono stati sparsi nei corpi degli uomini, e se li riceve un buon coltivatore si sviluppano e crescono conformemente alla loro origine, uguali a quelli da cui sono derivati; se invece il coltivatore è un buono a nulla li fa
morire, non diversamente da quel che accade in un terreno sterile e paludoso, e poi spuntano erbacce invece di buone messi. Stammi bene. 74. Ho molto gradito la tua lettera, che ha rimosso il mio torpore e risvegliato la mia memoria, ormai pigra e lenta. Perché, Lucilio mio, non dovresti pensare che il mezzo migliore per vivere una vita felice sia la virtù, l’unico nostro vero e autentico bene? Chi crede infatti che altri siano i beni si pone alla mercé della sorte, diventa schiavo del volere altrui, e perciò non può essere felice. C’è chi si addolora per aver perso i figli, o si preoccupa perché sono malati, chi si rattrista perché compiono azioni disoneste e si sono coperti d’infamia, chi è tormentato dall’amore per la propria donna o per quella di un altro; né manca chi si affligge per un insuccesso elettorale o sta in ansia perché occupa un posto di prestigio. Ma la massa più numerosa di infelici è quella tormentata dall’attesa della morte che incombe da ogni parte, poiché non c’è luogo da cui essa non possa sopraggiungere. Per questo gli uomini, come soldati che si aggirano in territorio nemico, devono guardarsi attorno a destra e a sinistra e voltare il capo a ogni rumore: se non si scaccia dall’animo questa paura si vive col batticuore. Incontrerai uomini cacciati in esilio e privati dei loro beni; uomini poveri pur in mezzo alle ricchezze, che è il caso più terribile di povertà; incontrerai uomini vittime di un naufragio o di esperienze simili a un naufragio, che il furore o l’invidia popolare, arma funesta contro i migliori, ha travolto inaspettatamente, come una tempesta che scoppia dopo che tutti confidavano nel cielo sereno, o come un fulmine improvviso che dove colpisce fa tremare anche i dintorni. E come chi si è trovato troppo vicino al fulmine è rimasto attonito al pari di chi ne è stato colpito, così in una disgrazia causata da un atto di violenza uno solo ne subisce il danno ma gli altri sono assaliti dalla paura e si angustiano quanto la vittima per il timore di poter subire la stessa sorte. I mali improvvisi che capitano agli altri turbano tutti. Come gli uccelli si spaventano anche al suono di una fionda vuota, così noi ci agitiamo non solo per il colpo che ci tocca ma anche al suo rumore. Dunque, non può essere felice chi si abbandona a questi timori che non hanno alcun fondamento. Felice è solo chi è imperturbabile: in mezzo ai sospetti si vive male. Chi si attacca troppo ai beni fortuiti si crea molti e insuperabili motivi di turbamento: c’è una sola strada per mettersi al sicuro, disprezzare i beni esteriori e trovare appagamento nella virtù. Chi ritiene che vi sia qualcosa di meglio della virtù o qualche altro bene al di là di essa, apre il grembo ai beni che dispensa la sorte e attende con ansia i suoi doni.11 Ora immagina che la fortuna organizzi dei giochi e riversi sulla gente lì radunata cariche, ricchezze e favori, di cui una parte finisca in pezzi tra le mani di coloro che se li contendono, una parte se la spartiscano soci inaffidabili e un’altra, per la mischia determinatasi fra quelli su cui è caduta si risolva per loro in un danno. Così è dei beni, alcuni dei quali cadono nelle mani di chi non se ne dava alcun pensiero, altri sfuggono e si perdono perché si cercava di afferrarne troppi e con avidità: nessuno, però, anche se è riuscito a impossessarsi di quel che voleva,
gode a lungo del suo bottino. Ecco perché gli uomini molto assennati appena vedono comparire dei piccoli doni fuggono dalla pubblica piazza, anche se sanno che quelle piccole cose costano molto. Nessuno viene alle mani con chi si allontana, nessuno colpisce chi se ne va: la zuffa avviene intorno al bottino. Lo stesso accade per i beni che la fortuna ci getta dall’alto: noi sventurati ci agitiamo, ci affliggiamo, vorremmo avere molte mani, guardiamo ora di qua ora di là come se la sorte tardasse troppo a mandar giù quei beni, che eccitano i nostri desideri e che tutti aspettano ma che toccheranno a pochi. Vorremmo afferrarli già mentre cadono; ci rallegriamo se riusciamo a coglierne qualcuno e se altri rimangono delusi nella loro speranza: una preda di nessun conto la paghiamo con gravi fastidi o ci sentiamo ingannati. Allontaniamoci, dunque, da questi giochi e lasciamo via libera ai predatori: contemplino pure questi beni sospesi in aria e stiano essi stessi ancora più in sospeso. Chi vuole essere felice si convinca che l’unico bene è la virtù; se infatti pensa che ce ne sia qualche altro, prima di tutto giudica erroneamente la provvidenza, visto che alle persone oneste capitano molte disgrazie e i beni che essa ci concede sono di breve durata e meschini di fronte all’età dell’universo. Se ci lamentiamo è evidente che non siamo grati a dio dei benefìci che riceviamo: ci doliamo che non siano continui, che siano scarsi, incerti e caduchi. È come se non volessimo né vivere né morire: odiamo la vita, temiamo la morte. Esitiamo in ogni decisione e non siamo mai pienamente felici. Il fatto è che non abbiamo raggiunto quel bene immenso e insuperabile in cui si fermi necessariamente la nostra volontà, perché oltre la vetta non si va da nessuna parte. Chiedi perché la virtù non abbia bisogno di nulla? Perché gode di quello che ha, non desidera ciò che non ha; per lei è grande quanto le basta. Se non ragioni così non ci saranno né religiosità né lealtà, perché per mantenerle entrambe bisogna sopportare molti dei cosiddetti mali e rinunciare a molte di quelle cose di cui ci compiacciamo come se fossero beni. Non c’è più la fortezza d’animo, inutile se non è messa alla prova, non c’è più la magnanimità, che non può spiccare se non disprezza come cose di poco conto tutte quelle che il volgo desidera come se avessero grande valore; scompaiono la gratitudine e le relazioni che essa comporta, se pensiamo che ci sia qualcosa di più prezioso della lealtà, se non miriamo al meglio. Ma, per passare ad altro, o questi cosiddetti beni non sono beni, o l’uomo è più fortunato di dio, perché dio non può godere di quei piaceri di cui godiamo noi; non lo riguardano, infatti, né la lussuria, né i lauti banchetti, né le ricchezze, né alcuna di quelle cose che allettano gli uomini attraendoli con la promessa di bassi piaceri. Dunque, o dobbiamo credere che dio sia privo di alcuni beni, oppure il fatto che dio non li possiede dimostra che non sono beni. Aggiungi che molti di quelli che vogliono sembrare beni toccano più abbondantemente agli animali che all’uomo. Le bestie si nutrono più avidamente, si stancano meno nell’accoppiamento, hanno forze maggiori e più costanti, dal che consegue che sono molto più felici dell’uomo. Vivono infatti senza malvagità e senza inganni;
godono dei piaceri più intensamente e con maggiore facilità, senza alcun pudore o timore di doversene pentire. Rifletti dunque se si possa definire bene una cosa in cui dio è superato dall’uomo e l’uomo dagli animali. Il sommo bene è racchiuso nella nostra anima, perde valore se passa dalla parte migliore alla parte peggiore di noi trasferendosi ai sensi, che sono più pronti negli animali, a cui manca la parola. Non dobbiamo riporre nella carne la nostra massima felicità: i veri beni sono quelli che dà la ragione, solidi e duraturi, che non possono venir meno e neppure decrescere o diminuire. Gli altri sono beni che noi crediamo tali e a cui diamo lo stesso nome dei beni autentici, ma non possiedono le medesime caratteristiche del bene vero; chiamiamoli dunque comodità, e, per usare il nostro linguaggio, «cose preferibili». Del resto dobbiamo tener presente che sono in mano nostra ma non fanno parte di noi: teniamoceli pure, ma ricordiamoci che sono beni esteriori e perciò anche se ce li teniamo annoveriamoli tra le cose inferiori e di poco conto, per le quali nessuno deve inorgoglirsi. Cosa c’è infatti di più stolto che compiacerci di ciò che non abbiamo fatto noi? Lasciamo pure che vengano tutti questi falsi beni ma evitiamo che ci si attacchino in modo da non soffrirne se ce li portano via. Serviamocene senza vantarci, e con moderazione, come se ci fossero stati lasciati in deposito. Se non si possiedono con raziocinio non si conservano a lungo, come la prosperità senza moderazione finisce col distruggere sé stessa; se si affida a beni troppo fugaci presto li perde, e se non li perde se ne affligge. Sono pochi coloro che hanno potuto perdere senza traumi la loro prosperità: gli uomini perlopiù rovinano insieme con quei beni grazie ai quali si erano distinti dagli altri e vengono schiacciati proprio da ciò che li aveva esaltati. Occorre dunque essere assennati per imporre a quei beni misura e moderazione, poiché la sfrenatezza manda in rovina e dissipa le ricchezze, e il troppo non dura a lungo, se la ragione moderatrice non vi pone un freno. La fine di molte città può dimostrarti quanto ciò sia vero: i loro fastosi imperi sono crollati proprio nel momento del massimo splendore, sicché l’intemperanza ha finito col distruggere quanto era stato creato con la virtù. Dobbiamo premunirci contro queste evenienze. Non c’è muro inespugnabile per la fortuna: fortifichiamoci interiormente, poiché se l’animo è al sicuro, l’uomo può essere colpito ma non catturato. Vuoi sapere quale sia questo espediente? Non indignarsi, qualunque cosa accada, ed essere consapevoli che quegli eventi stessi che apparentemente ci danneggiano servono alla conservazione di tutto l’insieme e fanno parte di quei fenomeni che consentono al mondo di portare a compimento il suo cammino e la sua funzione; l’uomo deve accettare quanto è piaciuto a dio, per cui guardi con ammirazione sé stesso e ciò che fa, poiché egli è invincibile, tiene in suo potere i mali, e con la ragione, che è la forza più grande, vince il caso, il dolore e l’ingiustizia. Ama la ragione! L’amore per essa ti armerà contro le più dure avversità. L’amore per i propri cuccioli spinge le fiere contro le lance dei cacciatori, la loro ferocia e il loro impeto istintivo le rendono indomabili; a volte la brama di gloria induce l’animo dei giovani al disprezzo del ferro e del fuoco; la parvenza o l’ombra
della virtù spinge alcuni a cercare volontariamente la morte: la ragione quanto più è forte e più tenace di tutti questi istinti, tanto più impetuosamente sfiderà paure e pericoli. «Parlate a vuoto», ribattono alcuni, «quando affermate che non c’è altro bene che la virtù: questo baluardo non vi metterà al sicuro né vi sottrarrà alla sorte. Dite infatti che tra i beni ci sono i figli devoti, la patria ben costumata e i genitori buoni. Non potete stare a guardare tranquillamente mentre sono in pericolo: l’assedio della patria, la morte dei figli, la schiavitù dei genitori vi sconvolgeranno». Ora ti dirò ciò che siamo soliti rispondere in nostra difesa contro queste obiezioni, poi cosa penso che si possa aggiungere a tale risposta. Diversa è la condizione di quei beni che, una volta tolti, lasciano al loro posto qualche male: per esempio, la buona salute, se si guasta, si trasforma in malattia, se perdiamo la vista diventiamo ciechi, se ci si spezzano le gambe non solo non possiamo più correre, ma siamo immobilizzati. I beni che ho elencato prima sono immuni da questo rischio. Perché? Se perdo un amico leale non devo al suo posto sopportarne uno sleale, se perdo dei figli virtuosi non devo sostituirli con dei figli empi. Peraltro la perdita riguarda non i figli o gli amici ma i loro corpi. Il bene muore solo nel caso in cui diventa un male, ma ciò la natura non lo consente perché le virtù e le opere della virtù non sono soggette a corruzione. E anche se sono morti amici o figli buoni come li desiderava il padre qualcosa ne prenderà il posto. Vuoi sapere che cosa? La virtù che aveva reso buoni anche loro. Essa non lascia che ci sia alcuno spazio vuoto, occupa l’animo intero, rimuove qualsiasi desiderio, basta da sola, poiché in lei sono la forza e l’origine di tutti i beni. Che importanza ha se un corso d’acqua s’interrompe e si disperde quando la sorgente da cui proviene è intatta? Non dirai che quando i figli sono vivi la vita è più giusta di quando li hai perduti, né che è più regolata, più saggia, più virtuosa; dunque, non è neppure migliore. Procurarsi un amico non rende più saggi, come il perderlo non rende più stolti, dunque, neppure più felici o più infelici. Finché sarà salva la virtù, qualunque cosa ti venga tolta non ne risentirai. «Ma come? Non è più felice chi è circondato da un gran numero di amici e di figli?». E perché dovrebbe esserlo? Il sommo bene non diminuisce e non aumenta, resta sempre uguale, comunque si comporti la sorte: sia ch’egli viva a lungo sia che muoia prima di diventare vecchio, il sommo bene ha sempre la stessa misura, indipendentemente dall’età. Se tracci un cerchio più grande o uno più piccolo la differenza riguarda lo spazio, non la forma, e benché uno sia rimasto disegnato più a lungo e l’altro sia stato subito cancellato e sia stata dispersa anche la polvere nella quale era stato disegnato, hanno avuto entrambi la medesima forma. La rettitudine non si valuta in base alla grandezza, alla quantità, alla durata: non si può allungare né accorciare. Abbrevia quanto vuoi una vita virtuosa di cento anni e riducila a un giorno solo: è ugualmente virtuosa. La virtù ora occupa vasti spazi, governa regni, città, province, emana leggi,
coltiva amicizie, distribuisce compiti fra genitori e figli, ora è racchiusa nei ristretti confini della povertà, dell’esilio, della mancanza di persone care, e tuttavia non diminuisce se si sposta da un rango più elevato a uno più basso, dalla condizione regale a quella di un privato cittadino, da un ambiente pubblico ampio a una casa angusta o a un cantuccio. Resta ugualmente grande: anche se, isolata da ogni parte, si è ritirata in sé stessa, ha sempre uno spirito nobile ed elevato, una saggezza perfetta, una giustizia inflessibile. Dunque, è ugualmente felice, perché la felicità ha una sola sede, l’anima, stabile, grande, serena, ma non può realizzarsi senza la conoscenza delle cose umane e divine. Eccoti ora la risposta che ti avevo preannunciato. Il saggio non si addolora per la perdita di un figlio o di un amico, ma ne sopporta la morte con la stessa forza d’animo con cui è pronto ad accettare la sua: non ha paura di questa più di quanto non si dolga di quella. La virtù, infatti, è armonia, e a questa si conforma e si accorda la condotta del saggio, in tutte le cose. Se lo spirito, la cui funzione è quella di elevarsi al di sopra di tutto ciò che è terreno, è sopraffatto dai lutti e dal rimpianto, non c’è virtù: non sono un bene le ansie, le preoccupazioni e l’indolenza nell’agire; lo sono invece la serenità, la libertà, l’imperturbabilità e la combattività. «Ma come?», obietterai. «Il saggio non patirà alcunché che possa avvicinarsi a un’emozione? Non sbiancherà in viso, non avrà mai un segno di turbamento nel volto, mai un brivido percorrerà il suo corpo? Non avrà, insomma, nessuna di quelle manifestazioni che dipendono non dalla volontà, dal dominio della ragione, ma da un inconsulto impulso naturale?». Le avrà, sì, ma resterà comunque fermo nella convinzione che nessuna di quelle cose che lo toccano sia un male e che di fronte a esse una mente saggia non debba cedere. Farà ciò che deve con coraggio e prontezza. Qualcuno dirà che è proprio dello stolto agire con pigrizia e ostinazione, spingere il corpo in una direzione, l’animo in un’altra, ed essere lacerato tra impulsi contrastanti. Lo stolto, infatti, è disprezzato per gli stessi motivi per cui si vanta e si pavoneggia, e non compie volentieri nemmeno quelle azioni di cui si vanta. Se poi teme qualche male, si angoscia nell’attesa, come se il male fosse già arrivato, e soffre già per paura tutto ciò che teme di dover soffrire. Come nel corpo i sintomi precedono la malattia – indolenza, fiacchezza, una stanchezza non causata da alcuna fatica, uno sbadigliare continuo, brividi che si diffondono per tutte le membra – così un animo debole è scosso dai mali molto prima di esserne assalito: li suppone e si abbatte prima del tempo. Ma cosa c’è di più insensato che angosciarsi per il futuro e non risparmiarsi i tormenti, anzi chiamare e tirarsi addosso le disgrazie? Se non si possono evitare, la cosa migliore è ritardarle. Vuoi sapere come nessuno deve tormentarsi per il futuro? Se uno sa che da lì a cinquant’anni dovrà soffrire gravi pene, non si preoccupa, a meno che non salti con l’immaginazione tutto quell’intervallo e non s’immerga in quelle preoccupazioni che lo coglieranno dopo quel periodo di tempo: così accade che disgrazie vecchie e dimenticate rattristino gli animi inclini alla malinconia e che cercano motivi di dolore. Gli eventi passati e quelli futuri sono lontani da noi: non ci toccano né gli
uni né gli altri. Il dolore non può venirci se non da quello che sentiamo. Stammi bene.
1. Virgilio, Eneide III 72. 2. È Telesforo, che fu mutilato dal re Lisimaco e costretto a stare chinato in una gabbia come un animale in mezzo ai propri escrementi. 3. Seconda moglie di Ottaviano. 4. Nipote di Sesto Pompeo, costretto a suicidarsi, insieme al senatore Firmio Cato, per avere ordito con lui un colpo di stato contro Tiberio. 5. Le naumachie erano battaglie navali che si svolgevano su laghi artificiali o nel Colosseo allagato per l’occasione. 6. Re di Numidia, alleato dei Pompeiani: sconfitto a Tapso, si suicidò. 7. I Dai abitavano nella parte meridionale del Caucaso (oggi Daghestan). 8. Virgilio, Bucoliche I 6-7: parla Titiro, per bocca del quale Virgilio esprime a Ottaviano la sua gratitudine per la restituzione delle sue terre confiscate, insieme a quelle di altri, in favore dei veterani dopo la vittoria di Filippi. 9. Virgilio, Bucoliche I 9-10. 10. Virgilio, Eneide IX 641. 11. I missilia erano propriamente i doni che l’imperatore gettava al popolo: prodotti commestibili e tavolette sui cui era scritta la quantità di denaro e di frumento che avrebbe ricevuto chi le avesse afferrate.
Libro nono 75. Ti lamenti perché le mie ultime lettere sono meno accurate. Ma chi si esprime con cura se non chi ama la ricercatezza? Io voglio che le mie lettere corrispondano al mio modo di parlare se sedessimo o passeggiassimo insieme, che siano cioè semplici e spontanee e non abbiano niente di artificioso o falso. Se fosse possibile preferirei mostrarteli i miei sentimenti invece di far ricorso alle parole, e comunque anche parlando non batterei i piedi, né agiterei le mani o alzerei la voce, ma lascerei questi espedienti agli oratori, accontentandomi di esternarti i miei pensieri e i miei sentimenti senza eleganza e accuratezza. Una sola cosa vorrei dimostrarti chiaramente: che sento davvero tutto ciò che dico, e non solo lo sento ma lo amo. Gli uomini baciano i figli senza quel trasporto che hanno con l’amante, ma anche in un abbraccio così puro e misurato l’affetto si manifesta pienamente. Perbacco, io non voglio usare un linguaggio arido e scarno per argomenti così importanti (la filosofia, infatti, non rinuncia agli accorgimenti stilistici), ma non bisogna affaticarsi troppo nella ricerca delle parole. Sia questo il nostro intento principale: dire ciò che sentiamo, sentire ciò che diciamo; le parole siano coerenti con la vita. Adempie alla sua promessa colui che si mostra sempre il medesimo a chi lo vede e a chi lo ascolta. Ne vedremo al tempo stesso la grandezza e la qualità, come se fossero un tutt’uno. Le nostre parole devono soprattutto essere utili più che piacevoli. Tuttavia se l’eloquenza viene facile e spontanea e non richiede molto sforzo ben venga, e tratti argomenti nobilissimi: ma sia tale da mettere in evidenza la sostanza, non sé stessa. Le altre arti riguardano tutte intere la mente, questa, invece, è una faccenda dell’animo. L’ammalato non cerca un medico eloquente, ma se gli capita un uomo che può guarirlo e al tempo stesso parli forbitamente delle cure a cui deve sottoporsi ne sarà contento, senza avere però motivo di rallegrarsi per aver incontrato un medico così eloquente; è come se un timoniere esperto fosse anche bello. Perché solletichi le mie orecchie? Perché le blandisci? Di ben altro si tratta: devo essere cauterizzato, operato, messo a dieta. A questo servi: devi curare una malattia vecchia, grave e diffusa; hai da fare tanto quanto un medico in un’epidemia. Ti preoccupi delle parole? Rallegrati se riesci a bastare a ciò che devi fare. Quando imparerai così tante cose? Quando imprimerai nella tua mente le conoscenze apprese sì che non possa più dimenticarle? Quando le metterai in pratica? Non basta, infatti, impararle a memoria, come le altre: bisogna sperimentarle concretamente; è felice non chi le conosce ma chi le mette in pratica. «Dunque al di sotto di costui non ci sono gradini? Appena sotto la saggezza c’è l’abisso?». Credo di no: chi sta facendo progressi è ancora nel numero degli stolti, ma è già andato molto avanti. E anche tra quelli che progrediscono ci sono grandi differenze: alcuni li dividono in tre categorie. Alla prima appartengono quelli che non possiedono ancora la saggezza ma vi sono ormai giunti vicino; tuttavia anche ciò che è vicino è fuori. Vuoi sapere chi
sono? Sono quelli che si sono liberati da tutte le passioni e da tutti i vizi, che hanno appreso le conoscenze necessarie, ma a cui manca ancora una certezza sperimentata. Non hanno dimestichezza col bene raggiunto e tuttavia non possono più cadere nei mali da cui sono fuggiti; ormai si trovano in una condizione dalla quale è impossibile tornare indietro, ma questo non gli è ancora del tutto chiaro: ricordo di averlo scritto in una lettera: «Non sanno di sapere». Fruiscono del loro bene, ma non ne hanno ancora piena fiducia. C’è chi annovera in questa categoria di persone che si avviano verso la saggezza, di cui ho appena parlato, quegli uomini che sono ormai sfuggiti alle malattie dell’anima, ma non ancora alle passioni, e si trovano su un terreno sdrucciolevole, perché solo chi si è scrollato completamente di dosso la malvagità non corre più rischi, e solo il saggio autentico se ne è veramente liberato. Ho già detto più volte quale differenza intercorra fra le malattie dell’anima e le passioni, ma voglio ricordartela ancora: le malattie dell’anima sono vizi inveterati e induriti, come l’avidità e l’ambizione; hanno avviluppato l’anima troppo strettamente e sono diventati mali permanenti. Per farla breve, la malattia in questo caso consiste nel pensare ostinatamente al male, come quando scambiamo per desiderabili cose trascurabilissime, o, se preferisci, tendiamo troppo a cose che si dovrebbero ricercare con moderazione o non ricercare affatto, oppure teniamo in gran conto cose che valgono poco o nulla. Le passioni, invece, sono moti dell’animo biasimevoli, improvvisi e violenti, che se frequenti e trascurati provocano la malattia, come il catarro, per esempio, che quando è occasionale e non ancora cronico provoca la tosse, ma se è cronico e di vecchia data fa venire la tisi. Perciò, chi è progredito molto sulla via della virtù è ormai fuori dalla malattia, ma pur essendo vicino alla perfezione è ancora soggetto alle passioni. La seconda categoria comprende quelle persone che si sono liberate sia dai più grandi mali dell’anima che dalle passioni, ma non al punto da possedere in pieno la serenità raggiunta, poiché possono sempre ricadere nei medesimi vizi. Alla terza categoria appartengono quelli che si sono liberati da molti e gravi vizi ma non da tutti. Sono sfuggiti all’avidità, ma restano ancora soggetti all’ira; non sono più agitati dalla lussuria, ma lo sono dall’ambizione; non hanno più desideri sfrenati, ma hanno ancora molte paure, e nella paura in certi casi restano abbastanza saldi, in altri cedono: disprezzano la morte, temono il dolore. Su questo punto è bene fare alcune riflessioni: siamo già fortunati se rientriamo nell’ultima categoria. La seconda riusciremo a raggiungerla se avremo una buona predisposizione naturale e se ci applicheremo allo studio attentamente e con assiduità; ma non dobbiamo disprezzare nemmeno la terza categoria. Pensa a quanti mali vedi intorno a te; guarda quanti esempi di nefandezze di ogni tipo, quanti progressi faccia ogni giorno la malvagità, quante colpe si commettano in pubblico e in privato: ammetterai che abbiamo già ottenuto abbastanza se non siamo tra i peggiori. «Ma io spero», mi dici, «di poter giungere anche alla categoria superiore». Più che una promessa sarebbe un augurio, per noi: siamo assaliti da ogni parte; tendiamo alla virtù ma siamo trattenuti dai vizi. Mi
vergogno a dirlo: coltiviamo la virtù nei ritagli di tempo. Ma che grande premio ci attende se riusciremo a farla finita con le nostre faccende e coi mali più ostinati! Non cupidigia, non terrore potranno agitarci; senza i turbamenti della paura e la corruzione dei piaceri non temeremo né la morte né gli dèi; ci renderemo conto che la morte non è un male e che gli dèi non ci sono ostili. Ciò che nuoce è debole quanto colui a cui si nuoce: ciò che è sommamente buono è privo di forza nociva. Se mai riusciremo a innalzarci da questa feccia a quella sfera sublime ed eccelsa, ci aspettano la serenità dell’animo e, dissipati tutti gl’inganni, una libertà assoluta. E cos’è questa libertà? Non temere né gli uomini né gli dèi; non avere desideri turpi o sfrenati; possedere il pieno dominio di sé stessi: è un bene inestimabile appartenere a sé stessi. Stammi bene. 76. Minacci di togliermi la tua amicizia se non ti terrò informato di tutto ciò che faccio quotidianamente. Ebbene, guarda come sono schietto con te: ti confiderò anche questo. Da cinque giorni sto recandomi da un filosofo, ne frequento la scuola e ascolto i suoi discorsi alle due del pomeriggio. «All’età giusta!», esclamerai tu. E perché non dovrebbe essere l’età giusta? Cosa c’è di più stolto che non voler imparare solo perché non lo si è fatto per tanto tempo? «E con ciò? Dovrei fare allora quel che fanno i giovani e i bellimbusti?». Buon per me se solo questo fosse sconveniente alla mia vecchiaia: quella scuola accoglie uomini di ogni età. «E noi invecchiamo per andar dietro ai giovani?». Sono vecchio, eppure vado a teatro, mi lascio portare al circo e non mi perdo un solo combattimento di gladiatori: perché dovrei arrossire se frequento le lezioni di un filosofo? Devi imparare finché non sai, anzi, se crediamo al proverbio, finché vivi. Il che coincide con quest’altra massima: devi imparare a vivere finché hai vita. Lì, però, anch’io insegno qualcosa. Cioè? Che anche da vecchi si deve imparare. Ogni volta che entro a scuola mi vergogno del genere umano. Per andare a casa di Metronatte,1 come tu sai, si deve oltrepassare il teatro dei Napoletani. È zeppo di gente che con grande attenzione giudica chi sia un buon flautista; anche il trombettiere greco e il banditore attirano molti spettatori: invece in quella scuola in cui si cerca l’uomo virtuoso e si impara a diventare virtuosi siedono pochissime persone, che per i più sembrano dei fannulloni, gente che non abbia niente di buono da fare; li chiamano inetti e sfaccendati. Che deridano pure me: bisogna ascoltare con indifferenza gli insulti degli ignoranti, e chi tende alla virtù deve disprezzare il disprezzo stesso. Coraggio, Lucilio, affrettati affinché non ti accada quel ch’è accaduto a me, di imparare da vecchio; anzi, sii ancora più sollecito, perché hai intrapreso ora uno studio che da vecchio potresti portare a termine a stento. Mi chiedi quanti progressi farai? Proporzionati ai tuoi sforzi. Che aspetti? A nessuno capita di diventar saggio per caso: il denaro può giungerti senza che tu lo cerchi, una carica può esserti offerta, il favore e la stima ti saranno anche dati spontaneamente, ma la virtù non può capitarti per caso. E non si può apprenderla con poca fatica o poco impegno. Vale però la pena di darsi da fare per
impadronirsi in una sola volta di tutti i beni: unico, infatti, è il bene: la virtù; gli altri, che sono apprezzati dalla massa, non hanno niente di vero e di sicuro. E poiché nella mia lettera precedente, come tu dici, non sono stato esauriente sull’argomento e ho dedicato più spazio alle lodi che alle dimostrazioni, ti spiegherò perché l’unico bene sia la virtù. Ogni cosa vale per il bene che ha in sé. Il sapore del vino, come la sua produzione, dà pregio alla vite, la velocità al cervo; alle bestie da soma, usate solo per trasportare carichi, si richiede una schiena forte, nel cane la qualità principale è il fiuto, se deve scovare le fiere, la velocità, se deve inseguirle, il coraggio, se deve assalirle e azzannarle: ciascuno deve raggiungere la perfezione in quello per cui nasce e per cui viene valutato. E nell’uomo qual è la prerogativa migliore? La ragione, grazie alla quale egli è superiore agli animali e di poco inferiore agli dèi. Dunque, il suo bene peculiare è la ragione, le altre qualità sono in comune con animali e piante. È forte: anche i leoni lo sono. È veloce: anche i cavalli lo sono. Non mi riferisco a queste doti, nelle quali non possiede il primato, non cerco la sua qualità migliore, cerco quella sua peculiare. Ha un corpo: anche gli alberi lo hanno. Ha impulsi e movimenti volontari: li hanno anche le bestie e i vermi. Ha la voce: ma quanto è più chiara quella dei cani, quanto più acuta quella delle aquile, più profonda quella dei tori, più dolce e modulabile quella degli usignoli! Qual è la dote peculiare dell’uomo? La ragione, e se questa è onesta e perfetta dà all’uomo una felicità totale. Quindi, come ogni cosa che abbia condotto a perfezione il suo bene è degna di lode e ha raggiunto il suo fine naturale, così l’uomo quando abbia condotto a perfezione la ragione, che è il suo bene peculiare, è degno di lode e ha raggiunto il suo fine naturale. Questa ragione perfetta si chiama virtù e s’identifica con l’onestà, ed è l’unico e vero bene dell’uomo poiché è quello proprio e unicamente suo: non stiamo infatti cercando che cosa sia il bene ma quale sia il bene proprio dell’uomo. Se all’infuori della ragione non esiste altro bene che sia proprio dell’uomo, la ragione sarà il suo unico bene, il cui valore risulterà dal confronto con tutti gli altri. Un uomo malvagio non può che essere disapprovato, un uomo virtuoso apprezzato. Quindi la prima e sola qualità dell’uomo è quella in base alla quale egli viene giudicato positivamente o negativamente. Tu non dubiti che questo sia un bene, dubiti che sia il solo bene. Uno che possedesse tutti gli altri, la salute, la ricchezza, molti antenati illustri, un atrio pieno di clienti, ma fosse unanimemente ritenuto malvagio, lo biasimeresti; analogamente uno che non avesse alcuno dei beni su menzionati e fosse cioè privo di denaro, di clienti, di nobiltà e di una lunga serie di avi e di proavi ma ritenuto da tutti virtuoso, lo apprezzeresti. Dunque, la virtù è l’unico bene dell’uomo: chi lo possiede, anche se è privo di tutti gli altri beni, merita lode, chi non lo possiede, pur avendo in abbondanza tutti gli altri beni, è disprezzato e respinto. E com’è dell’uomo così è delle cose: una nave è buona non se è dipinta con colori preziosi, se ha il rostro d’oro o d’argento, se reca l’immagine della
divinità tutelare scolpita in avorio, o se è carica di tesori e di ricchezze regali, ma se è stabile e forte e ha le giunture saldamente connesse, tali che non lascino entrare l’acqua, solida e resistente all’urto delle onde, docile al timone, veloce e insensibile a ogni soffio di vento. Così non definirai buona una spada perché pende da una cintura dorata o ha un fodero ornato di gemme, ma perché possiede una lama dal taglio ben affilato e una punta capace di trapassare ogni difesa; una riga si vuole che sia dritta, non bella: ciascuna cosa è apprezzata in virtù dell’uso per cui è fatta e che le è proprio. Dunque anche nell’uomo non importa quanta terra possieda, quanto interesse ricavi dal suo denaro, quanta gente lo saluti, se dorma in un letto prezioso o beva in una coppa scintillante, importa quanto sia buono. Ed è buono se la sua ragione è libera, retta e conforme all’inclinazione della sua natura. Questa si chiama virtù, questa è l’onestà ed è l’unico bene dell’uomo. E poiché solo la ragione può rendere perfetto l’uomo ne consegue che solo la ragione può renderlo perfettamente felice, sicché in definitiva l’unico bene è quello che da solo rende l’uomo felice. Noi definiamo beni anche quelli che nascono dalla virtù e sono a essa legati, cioè tutte le sue opere, perciò l’unico bene è la virtù, poiché non esiste bene senza di lei. Se ogni bene risiede nell’animo, tutto ciò che lo rafforza, lo innalza o lo accresce è un bene; ma è la virtù che rende l’animo più forte, più elevato o più grande. Gli altri beni che accendono i nostri desideri avviliscono l’animo, lo indeboliscono, e quando sembra che lo elevino in realtà lo gonfiano e lo ingannano con false apparenze. Dunque, l’unico bene è quello che rende l’animo migliore. Tutte le azioni della nostra intera esistenza sono regolate dal concetto di bene e di male: è su queste due categorie che si basa la norma del fare e del non fare una cosa, cioè la seguente: l’uomo virtuoso farà tutto ciò che riterrà onesto, anche se gli costerà fatica, se gli riuscirà dannoso o rischioso; non compirà invece alcuna azione disonesta, anche se dovesse procurargli denaro, piacere o potere; niente potrà distoglierlo dal bene o spingerlo al male. Dunque, se perseguirà sempre l’onestà, eviterà sempre la disonestà e in ogni azione della sua vita terrà presenti questi due princìpi, che non c’è bene all’infuori dell’onestà, né male all’infuori della disonestà; se la virtù sola è incorrotta ed essa sola si mantiene sempre uguale a sé stessa, la virtù è l’unico bene, a cui non può accadere di non essere un bene. Non c’è pericolo che essa possa mutare: lo stolto può salire, sia pure con fatica, alla saggezza, il saggio non può ricadere nella stoltezza. Ho già detto, se te ne ricordi, che molti, seguendo l’impulso istintivo, hanno calpestato tutto ciò che la massa desidera o teme: c’è chi ha buttato via le ricchezze, chi ha messo la mano sul fuoco, chi non ha cessato di sorridere nemmeno sotto tortura, chi non ha versato neppure una lacrima al funerale dei figli, chi ha affrontato intrepido la morte; l’amore, l’ira, l’ambizione li hanno spinti a sfidare i pericoli. Ebbene, se una risolutezza momentanea, prodotta da qualche stimolo, arriva a tanto, quanto più potrà fare la virtù, la cui forza non deriva da un impulso improvviso ma è costante e continua? Conseguentemente ciò che viene disprezzato spesso dai temerari e sempre dai saggi non è né bene
né male. L’unico bene, dunque, è la virtù, la quale incede superba fra la buona e la cattiva sorte, disprezzando sia l’una che l’altra. Se però sei convinto che vi sia qualche altro bene oltre all’onestà, allora nessuna virtù si salverà, poiché la virtù non è tale se volge lo sguardo a qualcosa fuori di sé. Se così fa è in contrasto con la ragione, da cui derivano le virtù, e con la verità, che non esiste senza la ragione; falsa è poi qualunque opinione che sia in contrasto con la verità. Devi ammettere che l’uomo virtuoso nutre verso gli dèi una grandissima venerazione. Egli perciò sopporterà con animo sereno qualunque cosa gli accada, convinto che tutto avviene in virtù di quella legge divina che regola la vita dell’universo. Se è così, per lui l’unico bene sarà l’onestà, che consiste nell’obbedire agli dèi, nel non adirarsi di fronte agli imprevisti e nel non lamentarsi della propria sorte, ma nell’accettare con rassegnazione il destino e nel fare ciò che esso comanda. Chi vede qualche altro bene oltre all’onestà è perseguitato dalla smania di vivere, dalla brama dei beni che corredano la vita, desideri insopportabili, perché instabili e senza limiti. L’unico bene, dunque, è l’onestà, che ha una sua misura ben precisa. Ho detto che la vita degli uomini sarebbe più felice di quella degli dèi se fossero beni veri quelle cose che non toccano gli dèi, come il denaro e gli onori. Aggiungi che se le anime sopravvivono alla morte fisica le attende una condizione più felice di quella in cui si trovano quando sono nel corpo. Però, se quelli di cui godiamo per mezzo del corpo fossero dei beni, le anime, una volta uscite dal corpo, verrebbero a trovarsi in una condizione peggiore, ma è assurdo credere che le anime rinchiuse e imprigionate nei corpi siano più felici di quando saranno libere e proiettate nell’universo. Avevo anche detto che se fossero veri beni quelli che toccano tanto agli uomini quanto agli animali, anche questi condurrebbero una vita felice, e ciò non è assolutamente possibile. Per essere virtuosi bisogna sopportare tutto, ma ciò non sarebbe necessario se ci fosse qualche altro bene oltre alla virtù. Ho riassunto ed esposto brevemente questi argomenti, sebbene in una precedente lettera li abbia trattati più estesamente. E però questa opinione non può sembrarti veritiera se non elevi il tuo spirito e non ti senti pronto a offrire la tua testa, non solo con rassegnazione ma volentieri, nel caso in cui le circostanze ti chiedessero di morire per la patria e pagare con la tua vita la salvezza di tutti i concittadini. Talvolta una bellissima azione provoca una grande gioia, anche se per poco, e benché chi muore non ne raccolga il frutto, che viene strappato alla vita, tuttavia fa piacere pensare all’azione che si compirà, e l’uomo forte e giusto, se considera il prezzo del suo sacrificio, la libertà della patria, la salvezza di tutti quelli per i quali ha dato la vita, prova una gioia immensa e gode del pericolo che affronta. Ma anche colui al quale è negata la gioia che deriva da quel supremo e nobilissimo gesto corre verso la morte senza alcuna esitazione, pago di agire in modo giusto e pio. Per quanti motivi tu gli opponga per dissuaderlo e gli dica che al suo gesto seguirà subito l’oblio e una scarsa gratitudine da parte dei concittadini, egli ti risponderà: «Tutto ciò non riguarda la
mia azione, io la considero in sé stessa; sono convinto che sia onesta, e perciò vado dovunque mi conduca o mi chiami». Questo, dunque, è l’unico bene, avvertito non solo da un animo perfetto ma anche da uno generoso e di indole buona: gli altri beni sono futili e instabili, ed è per questo che il loro possesso rende inquieti; anche se la buona sorte li ha concentrati su una sola persona, gravano su chi li possiede e lo opprimono sempre, a volte anche si fanno beffe di lui. Nessuno di costoro che vedi vestiti di porpora è felice, non più di quanto lo sia uno di quelli ai quali il dramma assegna lo scettro e la clamide sulla scena: davanti al pubblico avanzano maestosi e alti sui coturni,2 ma appena escono, se li tolgono e ritornano alla loro statura normale. Nessuno di quelli che ricchezze e cariche collocano in una condizione sociale più elevata è grande. E perché allora lo sembra? Perché lo misuri con tutto il suo piedistallo. Un nano non è grande anche se sta sulla cima di una montagna; un gigante conserva la sua grandezza anche se sta in fondo a un pozzo. Questo è l’errore in cui cadiamo: non stimiamo le persone per quello che sono, vi aggiungiamo anche i loro ornamenti. Se vuoi valutare esattamente un uomo e sapere com’è veramente, guardalo nudo; togligli il suo il patrimonio, privalo delle sue cariche e degli altri doni ingannevoli della sorte, spoglialo anche del corpo e guarda la sua anima se vuoi vederne la qualità e la grandezza e capire se vale per merito suo o di altri. Chiamalo felice se sa guardare le spade lampeggianti senza piegare lo sguardo, se giudica indifferente che la sua anima esca attraverso la bocca o attraverso la gola, se minacciato di tormenti fisici, casuali o dovuti alla violenza di un potente, di prigione o di esilio, o di tutto ciò che riempie di vano terrore l’animo degli uomini, ascolta tranquillamente e dice: «Vergine, non v’è genere di pene che mi risulti nuovo o inaspettato; ho già previsto e calcolato tutto.3 Tu oggi mi annunci queste sventure: io le ho sempre annunciate a me stesso e come uomo mi sono preparato a tutto ciò che può capitare a un uomo». Meno duro è il colpo di una disgrazia prevista. Solo agli stolti e a coloro che si affidano alla sorte ogni evento sembra nuovo e inatteso: per gli ignoranti gran parte del male sta proprio nella novità, tanto è vero che una volta fatta l’abitudine alle disgrazie, anche se insopportabili, le affrontano con maggior coraggio. Perciò il saggio si abitua ai mali futuri e quelli che per gli altri diventano lievi dopo una lunga sofferenza egli li alleggerisce con una lunga meditazione. «Questo me l’aspettavo», dice a volte l’ignorante: il saggio sa che può capitargli di tutto e perciò qualunque cosa gli accada dice: «Lo sapevo». Stammi bene. 77. Oggi all’improvviso ci sono apparse le navi alessandrine, che solitamente precedono e annunciano l’arrivo della flotta: si chiamano “navi
staffetta”. In Campania è uno spettacolo molto gradito: tutta la popolazione di Pozzuoli si accalca sul molo e anche fra tante navi riconosce quelle alessandrine per il particolare tipo di vele: solo loro, infatti, possono mantenere spiegata sino a breve distanza dal porto la vela di gabbia che tutte le altre navi spiegano in alto mare. È la parte più alta della velatura che favorisce la velocità della nave, che riceve da lì la spinta più forte. Per questo se il vento aumenta e soffia più del necessario l’antenna viene abbassata: in basso il soffio ha minor forza. Quando le alessandrine arrivano nelle vicinanze di Capri e del promontorio da cui Pallade su una cima tempestosa contempla l’alto mare4 le altre navi sono tenute ad accontentarsi della vela ordinaria: quella di gabbia, infatti, è il segno distintivo delle alessandrine. Mentre tutti sciamavano di corsa sulla spiaggia, io mi compiacevo assai della mia pigrizia, poiché, pur attendendo lettere dai miei, non avevo fretta di sapere come andassero i miei affari laggiù, quali notizie mi portassero, poiché da tempo ormai per me non ci sono né perdite né guadagni. La penserei così anche se non fossi vecchio, tanto più ora che lo sono: per quanto poco io abbia, le provviste mi bastano per il viaggio che devo compiere, soprattutto perché la strada che ho intrapreso non devo percorrerla sino in fondo. Un viaggio è incompiuto se ci si ferma a metà strada o prima di aver raggiunto la meta, la vita, invece, non è mai incompiuta se è virtuosa: dovunque tu la concluda, se la concludi bene, è completa. Spesso poi bisogna porvi fine con coraggio e non per motivi molto importanti; del resto, non lo sono nemmeno quelli che ci tengono in vita. Tullio Marcellino, che conoscevi molto bene, un giovane tranquillo e invecchiato precocemente, colpito da una malattia non inguaribile, ma lunga e fastidiosa e che richiedeva molte cure, cominciò a pensare al suicidio. Radunò numerosi amici. Alcuni, perché timidi, gli davano quei consigli che avrebbero dato a sé stessi, altri, perché adulatori e lusingatori, quelli che pensavano potessero riuscirgli più graditi. Il consiglio migliore, a mio avviso, glielo diede un nostro amico stoico, uomo eccezionale e – per lodarlo con parole degne di lui – forte e coraggioso. Esordì così: «Non tormentarti, Marcellino mio, come se dovessi prendere una decisione su una faccenda importante. Vivere non è poi una gran cosa: tutti i tuoi schiavi vivono, tutti gli animali vivono, l’importante è morire con dignità, con saggezza, con coraggio. Pensa da quanto tempo fai sempre le stesse cose: mangi, dormi, fai l’amore. È un circolo vizioso. Può volere la morte non solo un uomo saggio, coraggioso o infelice, ma anche uno disgustato». Marcellino aveva bisogno non di uno che lo consigliasse, ma di uno che lo aiutasse: gli schiavi non volevano obbedirgli. Lo stoico allora li tranquillizzò, dimostrandogli che la servitù avrebbe corso dei rischi se ci fossero stati dei dubbi sulla volontà di morire del padrone; del resto sarebbe stato riprovevole tanto uccidere il padrone quanto impedirgli di uccidersi. Poi ricordò a Marcellino che sarebbe stato un atto di gentilezza se prima di morire avesse
offerto qualcosa a coloro che l’avevano servito per tutta la vita, così come alla fine della cena si distribuiscono gli avanzi agli schiavi presenti. Marcellino, che era d’animo buono e generoso anche nel dare del suo, distribuì piccole somme di denaro agli schiavi in lacrime e cercò anche di consolarli. Non ebbe bisogno della spada o di tagliarsi le vene: digiunò per tre giorni e ordinò di mettere una tenda nella camera da letto. Poi fu portata una tinozza, lui vi entrò e vi rimase disteso a lungo finché a poco a poco, mentre gli versavano continuamente dell’acqua calda, venne meno, provando, come diceva, un certo piacere, il piacere che suole arrecare quel lieve dissolversi ch’io ben conosco quando mi prende uno svenimento. Ho fatto una digressione che certo non ti sarà sgradita, affinché tu ti renda conto che la morte del tuo amico non è stata difficile né dolorosa. Benché egli si sia lasciato morire se n’è andato dolcemente, come scivolando dalla vita. Non ti avrò raccontato inutilmente questo episodio: spesso, infatti, simili esempi sono necessari. Molte volte dovremmo morire e non vogliamo, o moriamo e non vogliamo. Nessuno è così ignorante da non sapere che un giorno o l’altro dovrà morire, eppure, quando l’ora si avvicina, temporeggia, trema, piange. Non ti sembrerebbe completamente stupido uno che piangesse per non essere vissuto mille anni prima? Altrettanto stupido è uno che piange perché non sarà vivo fra mille anni. I due casi sono uguali: come una volta non c’eri, così una volta non ci sarai: passato e futuro non ci appartengono. Sei stato gettato in questo punto del tempo: per quanto tu lo possa, sino a dove riuscirai a prolungarlo? Perché piangi? Che cosa vuoi? Fatica sprecata. Non aspettarti di poter piegare con preghiere i decreti degli dèi.5 Sono stati stabiliti, sono immutabili e governati da una necessità potente ed eterna: andrai là dove vanno tutti gli esseri. Ti sembra una cosa nuova? Sei nato per sottostare a questa legge, così è accaduto a tuo padre, a tua madre, ai tuoi avi, a tutti coloro che sono venuti prima di te, e così accadrà a chi verrà dopo di te. Una successione ineluttabile, che nessuna forza può infrangere, lega e trascina ogni cosa. Quale folla di morituri ti seguirà, quale folla di gente morirà con te! Credo che avresti più coraggio se insieme a te morissero molte migliaia di individui. Ma proprio in questo momento in cui tu esiti a morire stanno esalando l’ultimo respiro migliaia di esseri umani e di animali. O forse non pensavi che un giorno o l’altro saresti giunto al punto verso il quale sempre ti dirigevi? Non c’è viaggio che non abbia una fine. Non aspettarti da me esempi di grandi uomini: ti parlerò dei fanciulli. Ancora vivo è il ricordo di quello spartano imberbe che, fatto prigioniero, gridava nel suo dialetto dorico: «Non sarò mai schiavo!». E mantenne fede alle sue parole: appena gli fu ordinato il primo lavoro umiliante e servile (doveva portare un vaso da notte) si fracassò la testa sbattendola contro il muro. La libertà è tanto
vicina e c’è chi vive schiavo? Non preferiresti che tuo figlio morisse così piuttosto che invecchiare nell’inerzia? Perché dunque turbarsi quando persino un fanciullo sa morire con coraggio? Anche se tu ti rifiuti di seguire il destino comune vi sarai comunque costretto. Fa’ che sia in tuo potere ciò che dipende da altri. Non imiterai il coraggio di quel fanciullo dicendo anche tu: «No, non sarò mai schiavo»? Poveretto, sei schiavo degli uomini, sei schiavo delle cose, sei schiavo della vita, poiché la vita, se manca il coraggio di morire, è una schiavitù. E che motivi hai per aspettare? Anche i piaceri, che ti fanno esitare e ti trattengono, li hai sperimentati tutti sino in fondo: non ce n’è alcuno che sia nuovo per te, che non ti disgusti, ormai, per la troppa sazietà. Conosci il sapore del vino, puro o mischiato col miele, e non importa se per la tua vescica ne passano cento o mille anfore: non sei che un filtro. Conosci benissimo il gusto delle ostriche e delle triglie: la tua dissolutezza non ti ha lasciato nulla di ignoto da godere negli anni futuri. Eppure, sono queste le cose da cui ti distacchi a malincuore. C’è qualcos’altro che ti dispiace se ti viene tolto? Gli amici? Ma sai, tu, essere amico? La patria? E l’ami tanto da ritardare per essa la cena? Il sole? Ma se potessi lo spegneresti: hai mai compiuto, infatti, qualche azione degna della luce? Confessalo: non è il desiderio del Senato, del Foro o della natura che ti trattiene dal morire: tu lasci malvolentieri un mercato in cui non hai lasciato alcunché. Hai paura della morte: eppure, come la disprezzi per un piatto di funghi! Vuoi vivere: ma come? Hai paura di morire: e perché? Vivere non è morire? Mentre Gaio Cesare passava per la via Latina uno dei prigionieri, vecchio e con la barba lunga fino al petto, lo pregava di dargli la morte, al che lui gli rispose: «Perché, adesso vivi?». Ecco come rispondere a chi considera la morte un toccasana: «Hai paura di morire, e perché, adesso vivi?». «Ma io voglio vivere», dirà lui: «compio molte nobili azioni, non intendo venir meno ai doveri della vita, che adempio con zelo e fedeltà». E che? Non sai che anche il morire è uno dei doveri della vita? Tu non lasci alcun dovere, poiché non c’è un numero determinato di doveri da compiere. Ogni vita è breve: di fronte alla natura è breve anche quella di Nestore e di Sattia,6 la quale volle che sulla sua tomba si scrivesse ch’era vissuta novantanove anni. Vedi come ci sia qualcuno che si vanta di una lunga vecchiaia? Chi avrebbe potuto sopportarla se fosse arrivata a cento anni? La vita è come una commedia: non importa quanto sia lunga, ciò che conta è che sia rappresentata bene. Non importa dove muori, scegli tu il luogo, cerca solo di morire bene. Stammi bene. 78. Che tu soffra per il catarro continuo e per quelle febbriciattole che sono la conseguenza di un catarro cronico e di vecchia data mi dispiace molto, tanto più perché anch’io ho sperimentato questo genere di malattia: inizialmente non gli davo peso – essendo giovane potevo ancora sopportare i danni di qualsiasi male e assumere nei suoi confronti un atteggiamento di superiorità – in seguito, però, ho dovuto cedere e sono giunto al punto d’essere tutt’uno col catarro e di ridurmi quasi a uno scheletro. Più volte sono stato preso dalla voglia di farla
finita, ma mi ha trattenuto la vecchiaia del mio amorevolissimo padre. Pensavo non come potessi io morire da forte, ma come potesse lui non avere la forza di sopportare la mia perdita. Perciò m’imposi di vivere: talvolta, infatti, anche vivere è un atto di coraggio. Ti dirò che cosa mi sia stato allora di conforto, ma prima voglio dirti che ciò in cui trovavo sollievo ebbe per me l’effetto di una medicina: i buoni conforti, infatti, si trasformano in medicine e ciò che solleva l’anima giova anche al corpo. La mia salvezza sono stati gli studi, è merito della filosofia se mi sono risollevato, se sono guarito: a lei devo la vita, anche se questo è il debito minore che ho con la filosofia. Alla mia guarigione contribuirono molto anche gli amici, che mi confortavano coi loro consigli, le loro veglie e le loro conversazioni. Mio ottimo Lucilio, ciò che più ristora un ammalato e lo aiuta a ristabilirsi è proprio l’affetto degli amici, tanto efficace da ingannare l’attesa e il timore della morte: pensavo di non morire poiché loro restavano in vita, cioè ritenevo che sarei vissuto non con loro ma attraverso di loro, mi sembrava non di esalare l’anima ma di trasmetterla ad altri. Ciò mi ha dato la volontà di farmi forza e di sopportare ogni tormento; d’altronde è cosa assai meschina temere di morire e non avere il coraggio di vivere. Prendi dunque questi farmaci: il medico ti prescriverà quante passeggiate o quanto moto devi fare; ti consiglierà di non abbandonarti all’ozio, a cui si tende quando a causa di una malattia si è costretti all’inattività, di leggere a voce alta, per stimolare la respirazione, le cui vie e i polmoni lavorano male, di andare in barca affinché quel dolce ondeggiamento smuova le viscere; ti dirà quali cibi mangiare, quando bere vino per prendere un po’ di vigore, quando astenertene per non irritare e aggravare la tosse. Da parte mia ti prescrivo un rimedio che vale non solo per questa malattia ma per tutta la vita: disprezza la morte. Non c’è cosa che possa farci soffrire una volta che ci siamo liberati dal timore della morte. In ogni malattia ci sono tre cose gravi: il timore della morte, il dolore fisico e l’interruzione dei piaceri. Della morte ho detto abbastanza: aggiungerò solo che il timore di morire non è tipico della malattia, è proprio della natura umana. A molti succede che una malattia li distolga dal pensiero della morte e che la sensazione di dover morire sia per loro salutare. Morirai non perché sei ammalato, ma perché vivi. La morte ti attende anche dopo la guarigione: una volta guarito, infatti, sarai sfuggito non alla morte, ma alla malattia. Torniamo ora al guaio vero e proprio: una malattia può provocare gravi sofferenze, ma a intervalli che le rendono sopportabili. Inoltre un dolore quando è giunto alla sua massima intensità trova una fine al suo sfogo; nessuno può soffrire intensamente e a lungo: la natura, così amorosa verso di noi, ha disposto le cose in modo che il dolore sia sopportabile o di breve durata. I dolori più forti si localizzano nelle parti più magre del corpo: i nervi, le articolazioni e le parti più esili provocano dolori acutissimi quando il male si concentra in uno spazio ristretto. Ben presto, però, queste parti diventano insensibili e l’intensità
stessa del dolore ne annulla la sensazione, sia perché lo spirito vitale è impedito nel suo corso naturale e deteriorandosi perde la forza da cui trae vigore e con cui ci sollecita, sia perché l’umore corrotto, non avendo più dove affluire, si neutralizza da sé, togliendo la sensibilità a quelle parti che ha invaso in quantità eccessiva. Così la gotta, che colpisce mani e piedi, e tutti quei dolori che interessano le vertebre e i nervi si calmano quando hanno reso insensibili le parti che tormentavano; il primo attacco di tutte queste malattie provoca dolori lancinanti, poi, se durano, termina la fase acuta e l’intorpidimento segna la fine del dolore. Il mal di denti, di occhi e di orecchie è molto acuto proprio perché nasce in parti ristrette del corpo, così come il mal di testa; ma se è troppo violento, si trasforma in delirio e stordimento. In definitiva il sollievo di un dolore eccessivo consiste nel fatto che se è troppo forte si finisce necessariamente per non sentirlo più. Ma c’è una cosa che tormenta gli ignoranti nelle sofferenze fisiche: non sono abituati a trovare ristoro nello spirito, perché sono troppo legati al corpo. Perciò l’uomo saggio e magnanimo separa l’anima dal corpo e si intrattiene a lungo con quella che è la parte migliore di sé e di natura divina, mentre con quella lamentosa e fragile s’intrattiene solo quanto è necessario. «Ma è penoso», si obietta, «non poter godere dei piaceri a cui siamo abituati, astenersi dal cibo, soffrire la sete e la fame». Queste privazioni pesano in un primo momento, poi il desiderio del piacere si attenua, proprio per la stanchezza e l’illanguidimento degli organi del desiderio stesso; così lo stomaco diventa schizzinoso, l’ingordigia si trasforma in disgusto per il cibo. I desideri stessi si spengono, sicché a quel punto non è più penoso essere privo di ciò che hai smesso di desiderare. Aggiungi che ogni dolore ha i suoi momenti di tregua, o quanto meno diminuisce, che ci si può premunire contro uno che verrà e opporsi con dei rimedi a uno imminente: non c’è infatti dolore che non sia preceduto da segni premonitori, specie se si ripete di frequente. Una malattia è tollerabile se ne disprezzi le conseguenze estreme. Non renderti più gravosi i tuoi mali e non buttarti giù con i lamenti: il dolore risulta lieve se non lo si accresce con la suggestione. Se tu ti fai coraggio e ti dici: «Non è nulla, o comunque è cosa da poco, resistiamo, finirà presto», considerandolo lieve lo renderai tale. Tutto dipende dalla nostra opinione: a essa non sono legati solo l’ambizione, il lusso e l’avidità, è legato anche il dolore. Ciascuno è tanto infelice quanto ritiene di esserlo. Secondo me si devono bandire i lamenti per i dolori passati e le frasi di questo tipo: «A nessuno è mai capitato di peggio. Quanti tormenti, quanti mali ho sopportato! Tutti erano convinti che non mi sarei mai ripreso. Quante volte i miei mi hanno pianto come perduto, quante volte i medici mi hanno dato per spacciato! Neppure chi è sotto tortura patisce simili tormenti». Anche se questo è vero, ormai è acqua passata, a che serve rinnovare i dolori sofferti ed essere infelice perché lo sei stato in passato? Che dire poi del fatto che tutti esagerano i loro mali e mentono a sé stessi? Per di più fa piacere che sia finito ciò che è stato duro sopportare: è naturale gioire di un male che non c’è più. Due sono dunque le cose che vanno
eliminate: il timore di un male futuro e il ricordo di un male passato; questo non mi riguarda più, quello non mi riguarda ancora. Proprio quando si sta male si deve dire: Dolce un giorno sarà ricordare anche queste vicende.7 Combattiamo con tutta la nostra forza; saremo vinti se cederemo, vinceremo se sapremo resistere al nostro dolore: invece i più si tirano addosso le disgrazie che dovrebbero contrastare. Il male che t’incalza, che incombe su di te e non ti dà tregua, se cerchi di schivarlo ti inseguirà e ti minaccerà più gravemente; se invece resti saldo e lo contrasti riuscirai a respingerlo. Quanti colpi ricevono gli atleti sulla faccia e su tutto il corpo! Tuttavia, sopportano ogni dolore per desiderio di gloria, e non solo quando combattono ma anche durante l’addestramento, il quale pure provoca sofferenza. Ebbene, vinciamoli anche noi i nostri mali; il premio per la vittoria non è una corona, una palma o un trombettiere che impone il silenzio per proclamare il nostro nome, sono la virtù, la fermezza d’animo e la pace conquistata per tutto il tempo a venire, se una volta in qualche contesa vinceremo del tutto la fortuna. «Sento un grande dolore!». E che, se lo sopporti come una donna non lo senti? Come il nemico è più pericoloso per chi fugge, così ogni sventura dovuta al caso incalza maggiormente chi volge le spalle e si ritira. «Ma è grave!». E allora? Siamo forti per portare pesi leggeri? Preferisci che una malattia sia lunga o violenta e di breve durata? Se è lunga ha degli intervalli, dei momenti di tregua, concede un certo lasso di tempo e, necessariamente, come comincia finisce: una malattia breve e violenta ha due alternative: o finisce o conduce alla fine. Che differenza fa se non c’è più lei o non ci sono più io? In entrambi i casi il dolore è finito. Gioverà anche rivolgere l’animo ad altri pensieri e distrarsi dal dolore. Pensa alle azioni oneste e coraggiose che hai compiuto; considerane gli aspetti positivi; ricorda le imprese che hai ammirato di più, tutti gli uomini più forti che hanno vinto il dolore: quello che ha continuato a leggere un libro, mentre gli tagliavano le vene varicose, quell’altro che non ha smesso di sorridere mentre i carnefici, adirati proprio per questo, sperimentavano su di lui tutti gli strumenti della loro crudeltà. Quel dolore che è stato vinto dal riso non sarà vinto dalla ragione? Ora puoi descrivere tutto ciò che vuoi, il catarro e la violenza della tosse continua che ti fa vomitare anche le viscere, la febbre che ti brucia il petto, la sete e le membra storpiate dalla deformazione delle articolazioni: ma ben più gravi sono il fuoco e il cavalletto, le lamine arroventate e tutto ciò che si affonda nelle ferite gonfie per riaprirle e tormentarle in profondità. Eppure, c’è chi fra simili tormenti non ha emesso un gemito. Non solo: non ha implorato. Non solo: non ha risposto. Non solo: ha riso, e di cuore. E tu, di fronte a questi esempi, non vuoi ridere del dolore? «Ma», tu dici, «la malattia non mi permette di fare niente, mi ha distolto da tutte le mie occupazioni». La malattia domina il tuo corpo, non l’animo. Può
frenare i piedi del corridore, impedire le mani del sarto o del fabbro, ma se tieni impegnato l’animo puoi dare consigli, insegnare, ascoltare e imparare, domandare e ricordare. E poi, se sei temperante nel corso della malattia fai sempre qualcosa, dimostri che una malattia si può vincere o almeno sopportare. Credimi, anche in un lettuccio c’è posto per la virtù. Non sono solo le armi e le battaglie a rivelare l’ardimento di un animo che non si lascia domare dalle paure, l’uomo forte si vede anche sotto le coperte. Qualcosa da fare ce l’hai pure da malato: combattere valorosamente contro la malattia. Anche se questa ti costringerà o ti porterà all’inerzia darai sempre un esempio insigne. Che meravigliosa occasione di gloria potremmo sfruttare se tutti ci vedessero quando siamo ammalati! Ma tu osservati e lodati da te stesso. Ci sono poi due generi di piaceri. La malattia inibisce quelli fisici, ma non li elimina del tutto; anzi, a ben guardare, li stimola. Se si ha sete il piacere di bere è più sentito, se si ha fame il cibo riesce più gradito; tutto ciò che si riceve dopo un periodo di astinenza si accoglie con maggiore avidità. Ma i piaceri dell’animo, che sono più grandi e più sicuri, nessun medico li nega all’ammalato. Chi aspira a questi piaceri e li conosce bene disprezza tutte le lusinghe dei sensi. «Poveretto l’ammalato!». E perché? Perché non può sciogliere la neve nel vino? Perché non può rinfrescare la sua bevanda, preparata in una coppa capace, spezzandovi sopra del ghiaccio? Perché sulla tavola non gli vengono aperte le ostriche del lago Lucrino? Perché mentre mangia non c’è un andirivieni di cuochi che insieme alle pietanze trasportano persino i fornelli? Ormai la raffinatezza ha inventato anche questo: affinché il cibo non s’intiepidisca e risulti poco caldo al palato ormai indurito la cena si porta dietro la cucina. «Povero malato!». Mangerà quanto può digerire: non gli si metterà davanti un cinghiale, bandito dalla mensa come carne poco pregiata, non si ammucchieranno sul vassoio petti di uccelli (vederli interi darebbe la nausea). Che cosa c’è di male? Mangerai come un ammalato, anzi una buona volta come una persona sana. Ma sopporteremmo facilmente tutto questo – i brodini, l’acqua calda e ogni altra cosa che sembra insopportabile agli schizzinosi infiacchiti dal lusso e più infermi nell’anima che nel corpo – se cessassimo di avere il terrore della morte. E la smetteremmo se conoscessimo i confini del bene e del male: allora non proveremmo più disgusto per la vita né timore della morte. Infatti, chi studia tante cose, varie, grandi e divine, non può provare disgusto per la vita: solitamente è l’ozio inconcludente che porta a odiare la vita. Chi indaga la natura non proverà mai nausea per la verità, poiché solo ciò ch’è falso finisce con lo stancare. E poi, se la morte arriva e lo chiama, anche se prematuramente, anche se lo coglie nel mezzo della vita, egli ha già raccolto i frutti di un’esistenza lunghissima. Ha una conoscenza più che sufficiente della natura, sa che la virtù col passare del tempo non si accresce: solo a chi la misura in base a piaceri vani e sfrenati la vita appare necessariamente breve. Tirati su con questi pensieri, e intanto leggi le mie lettere. Prima o poi verrà il momento in cui torneremo a vivere insieme, e per quanto possa essere breve se
sapremo usarlo lo renderemo lungo. Posidonio dice che «per gli uomini colti un solo giorno è più lungo di un’esistenza lunghissima per gli ignoranti». Nel frattempo tieniti stretto coi denti a questa regola: non cedere alle avversità, non fidarsi della fortuna, tenere ben presenti i capricci della sorte, come se essa dovesse attuare tutto ciò che è in suo potere. Gli eventi che si aspettano da lungo tempo quando giungono sono più sopportabili. Stammi bene. 79. Aspetto tue lettere per sapere cos’hai trovato di nuovo girando per tutta la Sicilia e avere notizie più precise su Cariddi. So benissimo, infatti, che Scilla è uno scoglio e che non fa paura ai naviganti, su Cariddi, invece, vorrei che tu mi scrivessi se è vero quanto narra la leggenda e m’informassi – se ci hai fatto caso (e la cosa merita attenzione) – se è un vento particolare a provocare i vortici o se sono le burrasche a sconvolgere ugualmente quel tratto di mare, e se è vero che i relitti afferrati da quel gorgo vengono trascinati per molte miglia sottacqua per emergere vicino alla spiaggia di Taormina. Se mi darai notizie dettagliate su questo argomento oserò chiederti di salire anche sull’Etna per conto mio, visto che, a detta di alcuni, questo vulcano sta consumandosi e abbassandosi a poco a poco: ciò si dedurrebbe dal fatto che una volta appariva ai naviganti più da lontano. Il fenomeno, però, può verificarsi non perché il vulcano diminuisce di altezza ma perché il fuoco si è indebolito ed esce con minore violenza e abbondanza, e per lo stesso motivo anche il fumo durante il giorno si fa più lento. Entrambe le ipotesi sono credibili, sia che il monte si consumi e si abbassi giorno dopo giorno, sia che rimanga tale e quale, in quanto il fuoco non lo divora, ma, formatosi in qualche cavità sotterranea, ribolle e si nutre di altra materia, trovando nel monte non un alimento ma una via d’uscita. In Licia c’è una regione molto nota, che gli abitanti chiamano Efestione, dove il suolo presenta numerose buche circondate da un fuoco innocuo e che non danneggia la vegetazione, perciò la zona è ridente ed erbosa, le fiamme non bruciano nulla, brillano solo di una luce debole e fiacca. Ma rimandiamo questo argomento a quando mi avrai scritto quanto dista dal cratere la neve, la quale è così ben riparata che pur essendo vicina al fuoco non si scioglie nemmeno d’estate. Non devi però addebitarmi la fatica della scalata perché anche se nessuno te lo avesse chiesto l’avresti fatto per soddisfare la tua viva curiosità. Cosa potrebbe infatti distoglierti dal descrivere l’Etna nel tuo poema e dal toccare questo soggetto che sono soliti trattare tutti i poeti? Il fatto che Virgilio ne avesse già parlato distesamente non impedì a Ovidio di trattare l’argomento,8 né i due distolsero Cornelio Severo9 dall’affrontarlo ugualmente. Inoltre questo soggetto ha offerto a tutti il pretesto di parlarne, e con successo, e mi sembra che quelli che ne hanno scritto in precedenza non abbiano portato via agli altri ciò che ancora si poteva dire, ma gli abbiano spianato la via. C’è una grande differenza tra l’accostarsi a un argomento ormai esaurito e l’accostarsi a uno su cui hanno già lavorato altri: il materiale cresce di giorno in giorno e le cose scoperte non sono di impedimento a chi intende scoprirne altre. Per non
dire che chi arriva per ultimo si trova nella condizione migliore: ha già belle e pronte le parole, che, disposte diversamente, acquistano un aspetto nuovo. E non ruba niente a nessuno poiché le parole appartengono a tutti. O io non ti conosco o l’Etna ti fa venire l’acquolina in bocca; e già pensi di scrivere qualcosa di grande che sia allo stesso livello delle opere precedenti. La tua modestia non ti permette di sperare di più: è così grande che secondo me saresti pronto a trattenere le forze del tuo ingegno se temessi di superare gli altri, a tal punto rispetti gli scrittori che ti hanno preceduto. Fra l’altro la saggezza ha anche questo di buono: l’iniziato può superare un altro solo durante l’ascesa, ma una volta giunti alla vetta si è tutti uguali, non c’è più possibilità di avanzare, si sta fermi. Il sole aumenta forse la sua grandezza? La luna supera i limiti della sua orbita consueta? I mari non crescono, l’universo mantiene sempre lo stesso aspetto e le stesse dimensioni. Come le cose che hanno raggiunto la loro giusta grandezza si fermano lì, così tutti coloro che avranno raggiunto la saggezza saranno uguali e alla pari, anche se ciascuno avrà delle doti particolari: chi sarà più affabile, chi più pronto nel parlare, chi più eloquente, ma la virtù, di cui si discute e che rende felici, è uguale in tutti. Forse il tuo Etna potrà abbassarsi e rovinare su sé stesso e la violenza continua del fuoco consumare questa alta vetta visibile per un lungo tratto di mare, ma né fiamma né crollo potrà trascinare in basso la virtù, l’unica maestosità che non conosce diminuzioni. Non può né avanzare né indietreggiare, la sua grandezza è fissa, come quella dei corpi celesti. Cerchiamo di raggiungerla. Abbiamo fatto molto, o meglio, per esser sinceri, non molto. La bontà non consiste nell’essere migliori dei peggiori: chi può vantarsi della propria vista se intravede appena la luce del giorno? Chi vede splendere il sole attraverso una fitta nebbia, benché sia lieto di essere sfuggito in quel momento alle tenebre, non gode ancora del bene della luce. Dunque l’anima nostra potrà essere pienamente soddisfatta non quando, uscita dalle tenebre che l’avvolgono, scorgerà con debole vista le realtà più splendenti, ma quando accoglierà l’intera luce del giorno e sarà restituita al suo cielo, quando riprenderà il posto che occupava per sorte nell’istante in cui è venuta in questo mondo. Le sue origini la chiamano in alto, e ci arriverà anche prima di liberarsi dalla prigione del corpo, se disperderà i vizi e si slancerà, pura e leggera, verso pensieri divini. È questo che dobbiamo fare, carissimo Lucilio: dobbiamo perseguire questo scopo con tutto il nostro slancio, anche se pochi sanno raggiungerlo, forse nessuno. La gloria è l’ombra della virtù: l’accompagnerà anche se lei non vorrà. Ma come l’ombra a volte ci precede, a volte ci segue o sta alle nostre spalle, così la gloria a volte è davanti a noi e si fa vedere, a volte è dietro, ed è tanto più grande quanto più tardi arriva, allorché sia scomparsa l’invidia. Per quanto tempo Democrito fu considerato pazzo! Socrate conquistò la fama a fatica. Per quanto tempo Catone fu ignorato dai suoi concittadini, i quali lo respinsero e lo compresero solo dopo averlo perduto! L’integrità e la virtù di Rutilio sarebbero rimaste sconosciute se non avessero subìto un’ingiustizia: esse risplendettero
proprio nel momento in cui venivano offese. Non fu forse grato alla sua sorte e non accolse volentieri l’esilio? Parlo di quegli uomini che la sorte ha reso celebri angariandoli, ma di quanti si son conosciuti i meriti solo dopo la morte! Quanti la fama non accolse subito, ma li trasse in seguito dall’oblio! Vedi quanto è ammirato Epicuro non solo dalle persone colte ma anche dalla massa degli ignoranti: eppure, quando viveva ritirato nei dintorni di Atene, in Atene era sconosciuto. Molti anni dopo la morte di Metrodoro, in una lettera, celebrando, memore e riconoscente, la sua amicizia con lui, alla fine aggiunse che fra i tanti beni di cui entrambi avevano goduto non era stato un danno né per sé né per Metrodoro il fatto che la celebre Grecia non solo non li avesse conosciuti ma quasi non li avesse mai sentiti nominare. Non fu forse scoperto dopo la sua morte? Non rifulse la sua fama? Anche Metrodoro in una lettera confessa che lui ed Epicuro non erano abbastanza famosi, ma che dopo di loro quelli che avessero voluto seguire le loro orme avrebbero ottenuto grande e rapida fama. Non c’è virtù che rimanga nascosta e l’essere stata nell’ombra non le reca alcun danno: verrà il giorno che la porterà alla luce dalle tenebre in cui la malevolenza dei tempi l’aveva schiacciata. Chi pensa agli uomini del suo tempo è nato per pochi. Devi guardare alle molte migliaia di anni e di generazioni che si susseguiranno: anche se l’invidia avrà indotto i tuoi contemporanei a non curarsi di te, ti giudicheranno i posteri, senza risentimento e senza compiacenza. Se dalla fama deriva un premio alla virtù, neanche questo andrà perduto. Le lodi dei posteri non ci toccheranno, ma essi ci onoreranno e ci ricorderanno spesso, anche se non potremo sentirli. La virtù ricompensa tutti, o da vivi o da morti, purché la seguiamo con lealtà e non ce ne serviamo come di un ornamento esteriore, ma rimanendo sempre gli stessi, sia che sappiamo di essere visti, sia che siamo colti di sorpresa, impreparati. Non serve simulare, una maschera superficiale può ingannare pochi: la verità è uguale in ogni sua parte. Ciò che inganna non ha consistenza. La menzogna è sottile: se guardi con attenzione, è trasparente. Stammi bene. 80. Oggi sono libero di dedicarmi a me stesso, non tanto per merito mio, quanto per via di uno spettacolo di pugilato, che ha richiamato tutti i seccatori. Nessuno farà irruzione a casa mia, nessuno disturberà le mie riflessioni, che proprio per questo motivo saranno più ardite. La porta non cigolerà all’improvviso, nessuno solleverà la tenda all’ingresso della mia stanza: potrò procedere tranquillamente, e ciò è particolarmente necessario per chi cammina da solo e tira dritto per la sua strada. Non seguo dunque le orme dei miei predecessori? Sì, ma mi permetto di scoprire, di cambiare e di tralasciare qualcosa: non sono loro schiavo, ma mi trovo d’accordo con loro. Ho esagerato, però, nel ripromettermi silenzio e solitudine, senza importuni: mi giungono infatti dallo stadio forti grida, che non mi distraggono dalle mie riflessioni, ma mi inducono a soffermarmi su questo rumore. Penso quanto siano numerosi quelli che allenano il corpo e quanto pochi quelli che esercitano lo
spirito; quanta gente accorra a uno spettacolo futile e inconsistente, e quale deserto vi sia attorno alle buone arti; quanto sia debole l’animo di coloro di cui ammiriamo tanto i muscoli e le spalle. E soprattutto medito su questo: se con la pratica un corpo può essere indotto a sopportare pugni e calci di più uomini contemporaneamente e uno può passare un giorno intero sotto il sole cocente e in mezzo alla polvere rovente, imbrattato di sangue, quanto più facilmente si potrebbe rafforzare l’animo, in modo da ricevere senza piegarsi i colpi della sorte, da rialzarsi appena atterrato e calpestato. Il corpo ha bisogno di molte cose per stare bene, l’animo invece cresce da sé, si nutre e si esercita con le sue forze. Gli atleti hanno bisogno di molto cibo, di molte bevande, di molto olio e di un lungo esercizio, la virtù, invece, si può ottenere senza alcuna preparazione o spesa. Tutto ciò che può renderti buono risiede in te. Cosa ti serve per diventare virtuoso? La volontà. Ma cosa puoi volere di meglio che sottrarti a questa servitù che ci opprime e da cui perfino gli schiavi di infimo grado e nati in questa abiezione cercano in tutti i modi di liberarsi? Loro per avere la libertà tirano fuori i risparmi che hanno messo insieme privandosi del cibo, e tu, che credi di essere nato libero, non desideri ottenere a ogni costo la libertà? Perché guardi la cassaforte? La libertà non puoi comprarla. Perciò è inutile scrivere sui documenti la parola libertà: non la possiedono né quelli che l’hanno comprata né quelli che l’hanno venduta: questo bene devi procurartelo tu stesso, devi chiederlo a te stesso. Prima di tutto liberati dalla paura della morte, che ci impone il suo giogo, poi dalla paura della povertà. Se vuoi renderti conto che in essa non c’è alcunché di male, confronta il volto dei poveri con quello dei ricchi: il povero ride più spesso e più sinceramente; nel suo intimo non ha preoccupazioni di sorta, e anche se gliene arriva qualcuna, passa come una nube leggera: l’allegria di coloro che vengono definiti fortunati è finta, o gravata e inquinata da una segreta tristezza, tanto più penosa perché a volte non possono mostrare apertamente la loro infelicità, ma devono fingersi felici anche in mezzo agli affanni che gli rodono il cuore. Dovrei servirmi più spesso di questo esempio, perché esprime più efficacemente di qualunque altro la commedia della vita umana, in cui ci vengono assegnate parti che recitiamo male. Colui che maestoso avanza sulla scena pronunciando a testa alta queste battute: Ecco, io comando su Argo: Pelope mi lasciò quelle terre là dove l’Istmo è battuto dalle onde dell’Ellesponto e del mar Ionio10 è uno schiavo, ricompensato con cinque moggi di farina e cinque denari. Quell’altro, che superbo, tracotante e gonfio perché confida nella sua forza, dice: Se non starai tranquillo, Menelao, perirai per opera della mia mano11
è pagato a giornata e dorme su un pagliericcio. La stessa cosa si può dire di tutti questi effeminati che la lettiga tiene sollevati sulle teste della folla. La felicità di tutti costoro è una maschera: se li spogli li disprezzi. Quando compri un cavallo ordini che gli tolgano la gualdrappa, agli schiavi messi in vendita fai togliere le vesti, affinché non ti sfugga qualche difetto fisico, e poi pretendi di giudicare un uomo avvolto in ricchi paludamenti? I mercanti di schiavi nascondono con degli espedienti tutto ciò che può riuscire sgradito, per questo i compratori guardano con sospetto gli ornamenti: se tu vedessi una gamba o un braccio bendati, li faresti scoprire e mettere a nudo. Vedi quel re di Scizia 12 o di Sarmazia13 col capo ornato di diadema? Se vuoi giudicarlo e sapere com’è veramente, levagli la corona: sotto di essa si nasconde qualche magagna. Ma perché parlo degli altri? Se vuoi sapere quanto vali metti da parte il denaro, la casa, la posizione sociale, esaminati nell’intimo: solo così puoi prestar fede al giudizio degli altri. Stammi bene.
1. Filosofo stoico, contemporaneo di Seneca. 2. Calzature greche indossate dagli attori tragici. 3. Virgilio, Eneide VI 103-105: parole di Enea rivolte alla Sibilla cumana. 4. Di autore sconosciuto. 5. Virgilio, Eneide VI 376: la Sibilla cumana a Palinuro, che non può attraversare l’Acheronte perché il suo corpo non è stato sepolto. 6. Nobildonna morta sotto il regno di Claudio. 7. Virgilio, Eneide I 203. 8. Virgilio, Eneide III 571 sgg., e Ovidio, Metamorfosi XV 340 sgg. Fra l’altro l’Appendice Virgiliana contiene un poemetto intitolato Etna. 9. Poeta dell’età di Augusto, scrisse un poema sulla guerra in Sicilia del 38-36 a.C. 10. Frammento di una tragedia romana di autore incerto. 11. Vedi nota precedente. 12. Regione tra i Carpazi e il Don. 13. Territorio situato sulla sponda orientale del Don, fra l’Europa e l’Asia (nell’odierno Astrakan).
Libro decimo 81. Ti duoli d’esserti imbattuto in un ingrato: se questa è la prima volta, ringrazia la sorte o la tua prudenza, anche se la prudenza in questo caso non può che renderti gretto, perché se vuoi evitare gl’ingrati non aiuterai più nessuno, così se ti asterrai dal compiere qualcosa di buono ci rimetterai anche tu. È meglio che i benefìci non siano contraccambiati piuttosto che non farli: anche dopo un cattivo raccolto bisogna seminare. Spesso la produzione abbondante di un solo anno compensa le perdite dovute alla persistente sterilità di un terreno infecondo. Vale la pena sperimentare anche l’ingratitudine pur di trovare una persona grata. Per quanto sicuri si possa essere nell’elargire benefìci non di rado ci s’inganna, dunque, cadano pure nel vuoto il più delle volte purché ogni tanto attecchiscano. Un naufragio non impedisce di affrontare il mare di nuovo, un debitore insolvente non induce l’usuraio ad abbandonare i suoi affari. La vita s’intorpidirebbe presto in un ozio sterile se si dovesse lasciar perdere tutto ciò che può andar male. Proprio questo, invece, deve renderti più generoso; infatti, quando l’esito di un’azione è incerto bisogna fare più tentativi perché una volta o l’altra vada a buon segno. Ma di questo argomento ho parlato abbastanza nel mio libro intitolato I benefìci:1 mi sembra invece che si debba approfondire un punto che secondo me non è stato abbastanza sviluppato, se cioè colui che prima ci ha aiutato e poi ci ha fatto del male abbia pareggiato i conti, sciogliendoci così dal debito di riconoscenza. Aggiungi magari anche questo: ci ha danneggiato più di quanto ci ha giovato? Se chiedi la giusta sentenza di un giudice severo, egli affermerà che un’azione compensa l’altra e dirà: «Benché le offese siano più gravi, la parte in eccesso sia condonata in nome dei benefìci ricevuti». Il male, insomma, è stato maggiore, ma prima ci ha fatto del bene, dunque anche il tempo va considerato. Ci sono poi dei fattori troppo evidenti perché io debba ricordarteli: bisogna infatti vedere se il beneficio è stato disinteressato e il male involontario, poiché il loro valore dipende dallo spirito con cui si compiono. Come dire: «Non volevo farglielo questo favore ma mi ci hanno spinto un senso di riguardo o l’insistenza del richiedente, oppure una qualche speranza». Ogni favore va ricambiato con lo stesso spirito con cui è stato fatto, e bisogna giudicarne il valore non dall’entità ma dalla volontà che lo ha originato. Ora, mettiamo da parte le ipotesi: quello è stato un beneficio e questa è un’offesa, che supera l’entità del beneficio. L’uomo buono nel fare i calcoli s’imbroglia per sua stessa natura: ingrandisce il beneficio e diminuisce l’offesa. Un giudice più indulgente, quale vorrei essere io, imporrà di dimenticare l’offesa e di ricordare il beneficio. «Ma la giustizia», potresti ribattere, «esige che ciascuno sia ricambiato in modo analogo, il benefattore con la gratitudine, chi offende con la legge del taglione, o almeno col rancore». Questo sarà vero se si tratta di due persone diverse, una ci ha fatto del bene, un’altra del male, ma se è la stessa persona la gravità dell’offesa viene annullata dal beneficio. Se infatti è da
perdonarsi chi ci ha fatto del male, senza che in precedenza abbia meritato nulla da noi, si deve più che il perdono a chi ci fa del male dopo averci elargito un beneficio. Per me il beneficio e l’offesa non hanno il medesimo valore: il primo vale di più. Non tutti sanno essere riconoscenti: anche un uomo sciocco e rozzo può sentirsi obbligato per un beneficio, soprattutto se l’ha ricevuto da poco, ma ignora in quale misura. Solo il saggio sa quanto valore attribuire a ogni cosa, mentre lo sciocco di cui parlavo, anche se ha buona volontà, o ricambia in misura inferiore al dovuto, o non ricambia a luogo e a tempo debito, così disperde e getta via la riconoscenza. Per certe cose ci sono parole straordinariamente appropriate, e l’uso dell’antica lingua designa alcuni concetti con espressioni efficacissime per indicare i doveri. Così siamo soliti dire: «Gli ha ricambiato il favore», dove ricambiare significa dare spontaneamente ciò che si deve. Non diciamo: «Ha restituito il favore», perché restituisce anche chi lo fa dietro richiesta o contro voglia o dove gli piace o per mezzo di un altro. Non diciamo «Ha reso il favore» o «Ha pagato il suo debito», perché quelle parole che si usano per i debiti non ci piacciono. Ricambiare è portare una cosa a chi te l’ha data. Questa parola indica un rapporto spontaneo, in quanto chi ricambia fa appello a sé stesso. Il saggio esamina fra sé tutto ciò che ha ricevuto, da chi, il motivo, il momento, il luogo e il modo. Perciò diciamo che solo il saggio sa ricambiare il favore, così come è il solo che lo sa fare, e certamente egli gode nel farlo più di quanto non godano gli altri nel riceverlo. Qualcuno annovera questo concetto fra quelli che noi sembriamo sostenere contro l’opinione comune (che i Greci chiamano paravdoxa), e dice: «Nessuno, dunque, tranne il saggio, sa ricambiare un favore? Nessun altro sa restituire al suo creditore ciò che gli deve o, quando compra qualcosa, pagare il prezzo al venditore?». Perché non mi si guardi male, sappi che Epicuro dice altrettanto. Di certo Metrodoro afferma che solo il saggio sa ricambiare un favore. Quello stesso poi si meraviglia quando diciamo: «Solo il saggio sa amare, solo il saggio è un vero amico». Eppure il dimostrare riconoscenza è parte integrante dell’amore e dell’amicizia, anzi, è più comune e più frequente della vera amicizia. E ancora si meraviglia quando affermiamo che solo il saggio è leale, come se non dicesse la stessa cosa. O forse ti sembra che sia leale chi non sa essere riconoscente? La smettano allora di screditarci come se sostenessimo cose incredibili, e sappiano che nel saggio c’è la vera onestà, mentre nel volgo ci sono solo immagini e parvenze di onestà. Nessuno tranne il saggio sa essere riconoscente. Anche lo sciocco mostri la sua riconoscenza, come sa e come può; gli manchi la scienza ma non la volontà: questa, infatti, non ha bisogno di studi. Il saggio metterà a confronto fra loro tutti gli elementi di un’azione, la quale, pur restando la stessa, ha maggiore o minor valore a seconda del momento, del luogo e delle cause che l’hanno determinata, così come il più delle volte la ricchezza piovuta in una casa non ha avuto lo stesso effetto di mille denari dati al momento opportuno. C’è molta differenza, infatti, fra regalare e soccorrere, fra salvare una persona direttamente con la propria liberalità e metterla in condizione di star meglio; spesso ciò che si dà è
poco ma produce molto. Che differenza credi che ci sia fra dare a uno attingendo dal suo o da un beneficio ricevuto? Ma, per non ritornare sugli stessi argomenti già sufficientemente trattati, in questo confronto fra beneficio e offesa il saggio giudicherà nel modo più equo, ma attribuirà maggiore importanza al beneficio, pendendo più dalla sua parte. In casi del genere molto dipende dal carattere della persona, sicché uno può dire: «Mi hai fatto un favore aiutando un mio schiavo, ma hai offeso mio padre; hai salvato mio figlio, ma mi hai tolto il padre». Poi il saggio proseguirà facendo tutti i debiti confronti, e se la differenza sarà insignificante ci passerà sopra; anche se sarà notevole non se ne curerà, ma solo nel caso in cui siano salvaguardati il dovere e la lealtà, cioè trascurerà l’offesa se questa riguarderà interamente lui solo. Insomma, sarà generoso nel cambio; permetterà che gli si metta in conto più del dovuto; sarà restio a ritenere il favore ricevuto compensato dall’offesa patita; sarà propenso e incline a desiderare di essere riconoscente e di ricambiare. Provare infatti un maggior piacere nel ricevere un beneficio che nel ricambiarlo è sbagliato: come chi paga un debito è più contento di chi lo contrae, così chi si libera dal grandissimo debito di un beneficio ricevuto deve essere più contento di chi lo contrae. Gli ingrati, infatti, sbagliano anche in questo: da un lato pagano al creditore, oltre al capitale, interessi superiori al dovuto, dall’altro ritengono di dover godere gratuitamente dei benefìci, quando questi, se non si saldano, vanno aumentando col tempo e quanto più tardi si paga tanto più bisogna sborsare. È ingrato chi ricambia un beneficio senza gli interessi, perciò bisognerà tener conto anche di questo quando si confronterà ciò che si è ricevuto con ciò che si è dato. Dobbiamo fare di tutto per dimostrare la massima gratitudine. Questo è un bene che appartiene a noi, al pari della giustizia, che non riguarda gli altri, come comunemente si crede: gran parte di essa ricade su sé stessa. Chi giova a un altro giova anche a sé stesso, e lo dico non perché chi è stato aiutato vorrà aiutare, chi è stato difeso vorrà difendere, e perché il buon esempio ritorna su chi lo ha dato (così come i cattivi esempi ricadono sugli autori e non si può provare compassione per chi riceve un’offesa quando lui stesso con le sue azioni ha insegnato a offendere), lo dico perché il premio di ogni virtù è nella virtù stessa. Non si pratica la virtù in vista di un premio: la ricompensa di un’azione virtuosa consiste nell’averla compiuta. Sono grato non affinché un altro, stimolato dal mio precedente esempio, mi aiuti più volentieri, ma per compiere un’azione dolcissima e bellissima; sono grato non perché mi conviene, ma perché mi piace. Perché tu ti convinca che le cose stanno così, sappi che, se potrò dimostrare la mia gratitudine solo sembrando ingrato, se potrò ricambiare un favore solo sotto l’apparenza di un’offesa, attuerò con animo sereno questo onesto proposito anche a costo di rimetterci l’onore. Secondo me nessuno tiene in maggior conto la virtù e le è più devoto di chi accetta di perdere la propria reputazione di uomo onesto per non tradire la propria coscienza. Perciò, come ho accennato, la tua gratitudine è un bene maggiore sia per te che per il tuo prossimo, poiché a lui
capita una cosa normale, di tutti i giorni, riavere, cioè, quello che ha dato, mentre a te capita un fatto importante generato da uno stato d’animo di intensa felicità, l’essere stato riconoscente. Se infatti la malvagità rende infelici e la virtù felici, e l’essere grati è una virtù, hai restituito una cosa comune e ne hai ottenuta una di valore inestimabile, la coscienza della gratitudine, che proviene solo da un animo straordinario e fortunato. Dal sentimento contrario a questo nasce la più grave infelicità: chi è ingrato verso altri non è gradito a sé stesso. Credi ch’io dica che l’ingrato sarà infelice? Non uso il futuro: è infelice subito. Evitiamo, dunque, di essere ingrati, non per gli altri, ma per noi stessi. La malvagità che ricade sugli altri è minima e leggerissima: quella peggiore, e direi più pesante, tocca e opprime il malvagio. Come soleva dire il nostro Attalo: «La malvagità stessa beve la maggior parte del suo veleno». Quel veleno che i serpenti emettono per uccidere gli altri, e che tengono dentro di sé senza subire alcun danno, è ben diverso da questo, che è pestifero anche per chi lo possiede. L’ingrato si tormenta e si macera, odia i benefìci ricevuti perché dovrà ricambiarli, e li sminuisce, mentre ingrandisce e aumenta le offese. Ma chi è più infelice di chi dimentica i favori e ricorda le offese? Il saggio, invece, abbellisce i benefìci, li esalta e si compiace di richiamarli sempre alla memoria. Per i malvagi il piacere del beneficio è unico e di breve durata: lo provano solo nel momento in cui lo ricevono, mentre il saggio ne ricava una gioia lunga e duratura, perché trova piacere non nel ricevere, ma nell’aver ricevuto, e questo piacere non ha fine né interruzione. Egli non si cura dei torti subìti e li dimentica, non per trascuratezza, ma deliberatamente. Non volge tutto al peggio e non cerca sempre un capro espiatorio, ma attribuisce le colpe degli uomini alla sorte. Non interpreta malignamente le parole o l’espressione del volto, qualunque cosa accada la minimizza e la guarda con benevolenza. Non ricorda le offese più che i favori; per quanto può, cerca di conservare, se è migliore, il ricordo precedente, non muta i suoi sentimenti nei confronti di chi ha ben meritato, a meno che non gli vengano fatti molti torti e la differenza non sia evidente pure a occhi chiusi, e anche dopo aver subìto un’offesa maggiore cercherà di mantenere lo stesso stato d’animo in cui si trovava prima di ricevere il beneficio. Infatti quando il beneficio è pari all’offesa resta nell’animo un po’ di benevolenza. Come a parità di voti un imputato viene assolto e un sentimento di umanità induce a interpretare positivamente ciò che è dubbio, così l’animo del saggio, quando i meriti sono pari alle colpe, cessa di essere in debito ma non di volersi sentire in debito, e si comporta come quelli che pagano anche dopo che i loro debiti sono stati cancellati. Nessuno poi può mostrare gratitudine se non disprezza quelle sventure che terrorizzano il volgo: se vuoi ricambiare un favore, devi essere pronto ad andare in esilio, a versare sangue, ad affrontare la povertà, spesso a macchiare la tua onestà e a esporti a calunnie immeritate. La gratitudine costa parecchio. Noi valutiamo moltissimo un favore nel momento in cui lo chiediamo, mentre dopo
che lo abbiamo ottenuto lo sviliamo. Vuoi sapere cos’è che ci fa dimenticare i favori ricevuti? La brama di riceverne altri. Pensiamo non a quanto abbiamo ottenuto ma a quanto dobbiamo chiedere. Ci allontanano dalla retta via la ricchezza, gli onori, il potere e gli altri beni che a nostro avviso valgono molto e che invece in sé stessi non hanno alcun valore. Non sappiamo valutare cose che vanno giudicate non in base all’opinione comune, ma in base alla natura; esse non hanno niente di magnifico che possa attrarre il nostro spirito, se non la nostra abitudine di ammirarle. Non vengono infatti lodate perché siano desiderabili, ma vengono desiderate perché sono lodate, e quando l’errore dei singoli ha provocato un errore generale, questo a sua volta genera l’errore dei singoli. Ma come abbiamo creduto all’opinione comune su quei beni, così dobbiamo crederle anche in questo, che cioè non c’è niente di più bello della gratitudine; tutte le città, tutti i popoli, anche quelli dei paesi barbari, lo proclameranno; su questo buoni e cattivi saranno d’accordo. Ci sarà chi loda i piaceri e chi preferisce la fatica, chi dice che il dolore è il male più grave e chi non lo definisce neppure un male; qualcuno sosterrà che la ricchezza fa parte del sommo bene, altri che è stata inventata per la rovina dell’uomo, altri ancora che nessuno è più ricco di colui al quale la fortuna non sa che cosa dare: ebbene, in tanta diversità di opinioni tutti affermeranno unanimemente che si deve essere riconoscenti verso i propri benefattori. La massa, di per sé così discorde, sarà d’accordo su questo, mentre noi ricambiamo benefìci con offese, e la causa principale dell’ingratitudine è il non aver potuto essere abbastanza grati. La follia umana è giunta a tal punto che fare grandi favori a qualcuno diventa pericolosissimo: chi infatti ritiene vergognoso non ricambiare vorrebbe eliminare il creditore. Tieniti pure quel che ti ho dato; non lo chiedo, non lo rivoglio: purché l’averti giovato non sia per me motivo di pericolo. Non c’è odio più funesto di quello che nasce dalla vergogna di un beneficio tradito. Stammi bene. 82. Ormai ho smesso di preoccuparmi per te. Mi chiedi quale dio io abbia accettato come garante. Ovviamente quello che non inganna alcuno: l’animo che ama il bene e la giustizia. La parte migliore di te è al sicuro. La fortuna può farti del male, ma, ciò che più importa, non temo che tu possa farne a te stesso. Prosegui per la via intrapresa e disponiti a un tipo di vita tranquillo, non molle. Preferisco vivere male piuttosto che con mollezza: intendi “male” nel senso con cui la parola è usata dal popolo, cioè duramente, aspramente, con fatica. Di solito sentiamo che la vita di certa gente che è oggetto d’invidia viene lodata così: «Vive nella mollezza», che significa: «È un effeminato». L’animo a poco a poco si infiacchisce e si snerva, conformemente all’ozio e alla pigrizia in cui giace. E allora? Non è meglio per un uomo abituarsi alla vita dura? * * * e poi quegli effeminati temono la morte, alla quale hanno reso simile la propria vita. C’è una grande differenza tra il riposo e il sepolcro. «E che dunque?», ti chiedi. «Non è meglio giacere inerti così piuttosto che essere travolti nel vortice di
queste occupazioni?». L’attività esasperata e l’inerzia sono entrambe detestabili. Secondo me, chi giace tra i profumi è morto come chi viene trascinato con l’uncino,2 l’ozio senza lo studio è come la morte e la sepoltura di un uomo vivo. E poi, a che cosa serve appartarsi? Come se i motivi di preoccupazione non ci seguissero anche al di là del mare. C’è forse un nascondiglio in cui non penetri la paura della morte? Un luogo così ben difeso e posto tanto in alto dove poter vivere tranquillamente senza che il dolore ci atterrisca? Dovunque ti nasconderai, i mali umani strepiteranno intorno a te. Molti sono fuori di noi e ci circondano per ingannarci o per tormentarci, molti ci stanno dentro e ribollono anche nella più totale solitudine. Dobbiamo fare della filosofia un baluardo, un muro inespugnabile intorno a noi, che la fortuna non riesca a oltrepassare anche assalendolo con numerose macchine da guerra. L’anima che non si cura dei beni esteriori sta in una posizione inaccessibile e si difende dalla sua rocca: tutti i colpi cadono prima di raggiungerla. La fortuna non ha, come noi crediamo, le mani lunghe: afferra solo chi le sta attaccato. Abbandoniamola, dunque, per quanto ci è possibile, e l’unico mezzo per farlo è la conoscenza di noi stessi e della natura. L’uomo sappia a quale mèta deve tendere e donde ha avuto origine, che cosa sia per lui il bene e cosa il male, a che debba aspirare e cosa evitare, quale sia il criterio in base al quale discernere ciò che si deve ricercare e ciò che si deve fuggire e come placare il furore delle passioni e frenare la violenza delle paure. Alcuni credono di aver represso queste forze anche senza la filosofia: ma appena qualche sventura li mette alla prova mentre se ne stanno tranquilli e sicuri ecco che spunta una tardiva confessione di debolezza; le solenni parole svaniscono quando il carnefice gli afferra le mani, quando la morte si avvicina sempre più. Potresti dirgli: «Era facile sfidare i mali quando erano lontani: ecco ora il dolore, di cui dicevi che era sopportabile, ecco la morte, contro la quale hai pronunciato tante parole coraggiose; sibila la frusta, sfolgora la spada: ora ci vuole coraggio, Enea, ora animo saldo».3 E saldo lo renderai con una meditazione assidua, esercitando lo spirito, non le parole, preparandoti ad affrontare la morte, contro la quale non riuscirà a darti coraggio né a rinfrancarti colui che cercherà di convincerti con cavilli che la morte non è un male. Mi piace, mio ottimo Lucilio, ridere di certe sciocchezze greche che, con mia meraviglia, non mi sono ancora tolto di mente. Il nostro Zenone usa questo sillogismo: «Nessun male può dare la gloria; la morte può dare la gloria; dunque, la morte non è un male». Ci sei riuscito! Mi sono liberato dalla paura; dopo questa riflessione non esiterò a porgere il collo al carnefice. Non vuoi parlare più seriamente senza far ridere chi sta per morire? Perbacco, non saprei dirti facilmente se sia più sciocco chi ha creduto di distruggere la paura della morte con questo sillogismo o chi ha cercato di confutarlo, come se avesse importanza. Il filosofo stesso, infatti, a questo ragionamento ne ha
contrapposto uno contrario, derivato dal fatto che noi annoveriamo la morte fra le cose indifferenti, quelle che i Greci chiamano ajdiavfora. «Una cosa indifferente», dice, «non può dare la gloria; la morte dà la gloria; dunque, la morte non è indifferente». Vedi qual è l’errore di questo sillogismo: non è la morte che può dare la gloria, è il morire da eroe. E quando dici: «Una cosa indifferente non può dare la gloria» sono d’accordo, nel senso, però, che niente può dare la gloria se non in rapporto alle cose indifferenti; e per indifferenti (cioè né beni né mali) intendo la malattia, il dolore, la povertà, l’esilio, la morte. Nessuna di queste cose, di per sé, può dare la gloria, ma non vi è gloria senza di esse. Non si loda infatti la povertà, si loda colui che non si lascia soggiogare e piegare dalla povertà; non si loda l’esilio, si loda colui che va in esilio con un’espressione del volto più intrepida che se fosse stato lui a esiliare un altro; non si loda il dolore, si loda colui che non si lascia vincere dal dolore; nessuno loda la morte, si loda colui al quale la morte tolse la vita prima che il coraggio. Tutte queste cose di per sé non dànno né onore né gloria, è la virtù che intervenendo e governandole le rende onorevoli e gloriose. Esse stanno al centro; la differenza la fanno la malvagità o la virtù, a seconda che vi metta mano l’una o l’altra: la morte, che ha dato la gloria a Catone, diventa subito turpe e vergognosa per Bruto,4 il quale, cercando un pretesto per ritardare l’esecuzione, si appartò per scaricare il corpo, e quando lo chiamarono e gli ordinarono di porgere il collo, esclamò: «Lo porgerò, e così potessi vivere!». Per poco non aggiunse: «Anche sotto Antonio». O uomo degno di essere lasciato in vita! Vedi dunque che la morte, come avevo cominciato a dire, di per sé non è né un male né un bene, dato che Catone l’affrontò nel modo più onorevole, Bruto nel modo più vergognoso. Ogni cosa può ricevere dalla virtù, quando ne sia toccata, uno splendore che di per sé non possiede. Una stanza, che di giorno diciamo luminosa, di notte è completamente buia: il giorno le dà la luce, la notte gliela toglie. Così a tutte quelle cose che giudichiamo indifferenti e neutre, come la ricchezza, la forza, la bellezza, gli onori, il potere e, al contrario, la morte, l’esilio, la malattia, il dolore e tutto ciò di cui abbiamo più o meno paura, la malvagità o la virtù dànno il nome di beni o di mali. Un pezzo di metallo di per sé non è né caldo né freddo: gettato in una fornace, si riscalda, immerso nell’acqua, si raffredda. La morte è resa nobile da ciò che è nobile, cioè dalla virtù e da un animo che disprezza le cose esteriori. Ma anche fra le cose stesse che diciamo neutre, o Lucilio, c’è una grande differenza. La morte, infatti, non è indifferente come il fatto di avere un numero di capelli pari o dispari: la morte è fra quelle cose che, pur non essendo mali, hanno l’apparenza di mali: nell’uomo sono innati l’amor di sé, la volontà di vivere a lungo e di conservarsi e la ripugnanza del dissolvimento, * * * poiché sembra privarci di molti beni e allontanarci da una moltitudine di cose a cui siamo abituati. Ad accrescere la nostra avversione per la morte è anche il fatto che questa vita ormai la conosciamo, mentre non sappiamo cosa sia ciò a cui andiamo incontro e abbiamo terrore dell’ignoto. Abbiamo poi una naturale paura
delle tenebre, in cui crediamo che la morte ci condurrà. Perciò, anche se la morte è cosa indifferente, non è tuttavia tale da potersi trascurare facilmente: bisogna rafforzare l’animo con un grande esercizio, affinché ne sopporti il sopraggiungere e la vista. Bisogna disprezzare la morte più di quanto si è soliti fare; abbiamo prestato fede a molte favole su di lei, molti ingegni hanno fatto a gara per accrescerne la cattiva fama, si è descritto un carcere sotterraneo e una regione oppressa da una notte eterna, in cui il gran custode con i suoi latrati spaventi pure in eterno nell’antro l’ombre smorte.5 Anche quando ti sarai persuaso che queste sono favole e che i morti non possono temere alcunché, un’altra paura subentrerà: si teme tanto il nulla quanto l’aldilà. Di fronte a questi timori generati da una credenza secolare, perché l’affrontare coraggiosamente la morte non dovrebbe essere un gesto pieno di gloria e tra i più belli dell’animo umano? L’animo non s’innalzerà mai alla virtù se crederà che la morte sia un male: vi salirà se la giudicherà una cosa indifferente. La natura non consente all’uomo di affrontare con coraggio qualcosa che giudica un male: egli vi si accosterà svogliatamente e con esitazione. Ma un’azione compiuta contro voglia e con riluttanza non può dare la gloria; la virtù non conosce costrizione. Aggiungi che nessuna azione può essere nobile se l’animo non vi si è applicato con tutte le sue forze e senza che alcuna sua parte opponesse resistenza. Quando si va incontro a un male, o per paura di mali più gravi o per la speranza di beni in vista dei quali vale la pena di sopportare un solo male, chi deve agire si trova di fronte a decisioni contrastanti: da una parte sente la spinta ad attuare i suoi propositi, dall’altra vorrebbe ritirarsi e fuggire da una cosa sospetta e pericolosa; perciò è lacerato da impulsi opposti. In questo caso la gloria svanisce, dato che la virtù attua i suoi propositi con animo concorde, non ha paura di ciò che fa. Tu non cedere ai mali, anzi, resisti con maggiore ardimento, più di quanto non ti consenta la fortuna.6 Se li riterrai dei mali non li affronterai col coraggio dovuto. Bisogna scacciare dall’animo questo sospetto che ci fa esitare, altrimenti rallenterà il nostro slancio e noi verremo trascinati là dove saremmo dovuti entrare con entusiasmo. Gli stoici vorrebbero che fosse giudicato valido il sillogismo di Zenone e ingannevole e falso quello che gli viene opposto. Io non riduco la questione a formule dialettiche e ad arzigogoli oziosi e artificiosi: ritengo che si debbano eliminare tutti questi tipi di argomentazione, perché chi è interrogato teme di essere raggirato e, costretto a esprimere il proprio parere, dice una cosa mentre ne pensa un’altra. Per difendere la verità occorre più schiettezza, e contro la
paura ci vuole maggior coraggio. Io preferirei sciogliere e spiegare questi loro nodi, per persuadere, non per ingannare. Chi si accinge a condurre sul campo di battaglia un esercito affinché affronti la morte in difesa delle mogli e dei figli in che modo gli infonderà coraggio? Prendi i Fabi, che hanno addossato a una sola famiglia il peso di tutta una guerra dello Stato. Ti cito l’esempio degli Spartani appostati al passo delle Termopili: 7 non sperano né nella vittoria né nel ritorno; quel luogo sarà il loro sepolcro. Come li spronerai a sostenere, opponendo i loro corpi, l’impeto di un intero popolo e a lasciare la vita piuttosto che il loro posto? Dirai: «Ciò che è male non può dare la gloria; la morte dà la gloria, dunque, la morte non è un male»? Che discorso efficace! Chi, dopo averlo udito, esiterà a lanciarsi contro le spade nemiche e a morire restando fermo al suo posto? Ma che parole ardimentose rivolse loro quel Leonida! «Compagni», disse, «pranzate come se doveste cenare agli Inferi». Il cibo non gli si accumulò in bocca, non si fermò in gola, non cadde dalle loro mani: solleciti, essi assicurarono che sarebbero andati sia a pranzo che a cena. E che dire di quel famoso condottiero romano,8 che nel mandare i soldati contro un ingente esercito di nemici per occupare una posizione parlò loro così: «Compagni, bisogna andare là da dove non è necessario tornare»? Vedi come sia semplice e decisa la virtù: i vostri giri di parole non possono rendere più forti e più coraggiosi, fiaccano lo spirito, che al contrario non deve essere frenato e costretto in questioni capziose e di poco conto, soprattutto quando si prepara a una grande impresa. Ebbene, non a trecento, ma a tutti quanti gli uomini si deve togliere la paura della morte. Come gli dimostrerai che non è un male? Come abbatterai le credenze antichissime di cui siamo imbevuti fin dall’infanzia? Quale aiuto troverai per la debolezza umana? Che gli dirai affinché si gettino tra i pericoli con l’animo infiammato? Con quali parole allontanerai questa paura generale, con quali forze dell’ingegno questa convinzione condivisa da tutta l’umanità e che contrasta col tuo pensiero? Metterai assieme discorsi capziosi per trarne assurde argomentazioni? I grandi mostri si colpiscono con grandi armi. In Africa i soldati cercarono invano di colpire con frecce e fionde quel terribile serpente che terrorizzava le legioni romane più della stessa guerra:9 nemmeno Apollo avrebbe potuto ferirlo. La grandezza smisurata del suo corpo respingeva la spada e tutte le armi scagliate dalle mani degli uomini, finché non fu schiacciato sotto enormi macigni. E tu contro la morte scagli armi così deboli? Affronti un leone con una lesina? Le tue argomentazioni sono sottili: niente è più sottile di una spiga; ma proprio la loro sottigliezza rende inutili e inefficaci certe cose. Stammi bene. 83. Mi chiedi di descriverti dettagliatamente come trascorro le mie giornate: devi stimarmi molto se ritieni che io non abbia nulla da nasconderti. Certo, dobbiamo vivere come se ci vedessero tutti e pensare come se qualcuno potesse guardarci nel profondo del cuore, il che è possibile. A che giova, infatti, nascondere qualcosa agli uomini, quando dio vede tutto? Egli è nella nostra anima e interviene nei nostri pensieri – ho detto «interviene», come se qualche
volta se ne allontanasse! Farò dunque come vuoi e ti dirò le cose che faccio e in quale ordine. Prima di tutto osserverò me stesso e, cosa utilissima, passerò in rassegna la mia giornata. Nessuno fa l’esame della propria vita, e ciò ci rende molto cattivi; pensiamo, e raramente, alle nostre azioni future, mai a quelle passate; eppure, è dal passato che ci viene l’insegnamento per il futuro. La giornata di oggi è stata piena, nessuno me ne ha rubato un attimo solo: l’ho divisa interamente fra il letto e la lettura; ho dedicato pochissimo tempo agli esercizi fisici, e di ciò ringrazio la vecchiaia: non mi costa molto. Come mi muovo mi stanco: ma questo è il fine della ginnastica, anche per i più forti. Vuoi sapere chi sono i miei allenatori? Mi basta uno solo, quel fanciullo di Faro, amabile, come sai. Ma lo cambierò: ormai ne cerco uno più giovane. A sentir lui noi due stiamo attraversando la stessa crisi, poiché a entrambi cadono i denti. Nella corsa gli tengo dietro a stento e tra pochissimi giorni non ce la farò più: vedi come mi giova l’esercizio quotidiano? La distanza fra noi due che procediamo in direzioni opposte presto sarà grande: nello stesso periodo di tempo in cui lui sale io scendo, e tu sai bene quanto la discesa sia più veloce della salita. Ma non l’ho detta giusta: ormai la mia vita non scende, precipita. Mi chiedi com’è finita la gara di oggi? Alla pari, il che capita raramente ai corridori. Dopo questa corsa, che è stata una fatica più che un esercizio, ho fatto subito un bagno nell’acqua fredda: fredda per me vuol dire poco calda. Io che amavo tanto i bagni freddi, che il primo gennaio andavo a salutare il canale che gira attorno al Circo Massimo, che cominciavo l’anno nuovo non solo leggendo, scrivendo, declamando qualcosa, ma anche tuffandomi nella sorgente detta della Vergine,10 ho trasferito le tende prima sul Tevere, poi in questa tinozza riscaldata dal sole, ma solo quando sono più in forze e tutto va bene: non per molto tempo ancora farò bagni. Poi c’è il pranzo: pane secco, senza mettermi a tavola, dopodiché non ho neppure bisogno di lavarmi le mani. Dormo pochissimo. Tu conosci le mie abitudini: faccio sonni molto brevi e intervallati; mi basta interrompere la veglia; talvolta so di aver dormito, talaltra ne dubito. Ecco che risuona il clamore del Circo; un vociare improvviso e generale mi ferisce le orecchie, ma non mi distoglie dalle mie meditazioni, né le interrompe. Il rumore lo sopporto con molta pazienza; le voci della folla, confuse in una sola, sono per me come l’infrangersi delle onde, il vento che sferza gli alberi o altri suoni indistinti. A cosa ho rivolto oggi la mente? Te lo dirò. Da ieri continuo a pensare a che mirassero uomini sapientissimi, dando su questioni davvero importanti soluzioni superficialissime e complicate che, anche se vere, sembrano false. Zenone, uomo eccezionale, fondatore di questa fortissima e venerabilissima scuola filosofica, vuole tenerci lontani dall’ubriachezza. Ascolta, dunque, come dimostra che l’uomo virtuoso non sarà mai ubriaco: «Nessuno», dice, «confida un segreto a un ubriaco, lo si confida a un uomo virtuoso; dunque, l’uomo virtuoso non sarà mai ubriaco». Ebbene, guarda come questo sillogismo venga messo in ridicolo da uno simile ma contrario (basta ricordarne uno tra i molti): «Nessuno confida un
segreto a uno che dorme, lo si confida a un uomo virtuoso; dunque, l’uomo virtuoso non dorme». Posidonio tenta di difendere il nostro Zenone nell’unico modo possibile, ma nemmeno così, secondo me, può essere difeso. Sostiene infatti che ubriaco si può intendere in due sensi: il primo quando uno è pieno di vino e non è più padrone di sé stesso, il secondo quando uno è solito ubriacarsi ed è schiavo di questo vizio: ora, Zenone si riferisce non a chi è ubriaco occasionalmente ma a chi lo è per abitudine; a costui nessuno affiderebbe un segreto, che potrebbe essere svelato sotto l’influsso del vino. Ciò è falso; la prima parte del sillogismo riguarda colui che è ubriaco, non colui che lo diverrà. Ammetterai che c’è una grande differenza tra chi è ubriaco adesso e chi si ubriaca abitualmente: chi è ubriaco può esserlo ora per la prima volta e non avere questo vizio, e chi si ubriaca abitualmente non sempre è ubriaco; perciò, io intendo questo vocabolo nel suo significato comune, tanto più perché adoperato da un uomo notoriamente preciso e che pesa le parole. Aggiungi poi che se Zenone l’ha inteso in un modo e voleva che noi lo intendessimo in un altro ha voluto ingannarci utilizzando una parola ambigua, e questo non si deve fare quando si cerca la verità. Ma ammettiamo pure che l’abbia inteso così: la seconda parte, però, cioè che non si affida un segreto a chi è abitualmente ubriaco, è falsa. Pensa, infatti, a quanti soldati non sempre sobri il comandante, il tribuno e il centurione hanno affidato messaggi su cui mantenere il silenzio. Per l’assassinio di Cesare, parlo di chi prese il potere dopo aver vinto Pompeo, ci si affidò sia a Tillio Cimbro, sia a Cassio.11 Cassio per tutta la vita non bevve altro che acqua, Tillio Cimbro, invece, era un assiduo bevitore di vino e un attaccabrighe, un particolare su cui scherzava egli stesso: «Come potrei sopportare qualcuno», diceva, «io che non posso sopportare il vino?». A questo punto ciascuno di noi potrebbe fare il nome di persone alle quali sa che non è bene affidare del vino, ma un segreto sì; io riferirò un solo esempio che mi viene in mente, affinché non vada perduto: la nostra vita va formata con esempi celebri, non facendo sempre ricorso a quelli antichi. Pisone, prefetto di Roma, era sempre ubriaco fin dal giorno in cui era stato eletto. Trascorreva la maggior parte della notte banchettando; dormiva quasi fino a mezzogiorno, ch’era per lui l’inizio del mattino. Nonostante ciò, svolse con la massima diligenza il suo compito, che riguardava la difesa della città. A lui diedero incarichi segreti sia il divo Augusto, quando gli affidò il governo della Tracia, che egli riuscì a domare, sia Tiberio, che partì per la Campania lasciando in città una situazione incerta e ostile. E poiché Pisone, nonostante la sua ubriachezza, gli aveva reso buoni servigi, in seguito nominò prefetto della città Cosso, uomo serio, moderato, ma talmente dedito al vino, di cui era letteralmente impregnato, che una volta, recatosi in Senato dopo un banchetto, colto da un sonno così profondo che non si riuscì a svegliarlo, fu portato via di peso. Tuttavia Tiberio gli scrisse di suo pugno molte cose che riteneva di non poter confidare neppure ai suoi ministri. Cosso non si lasciò sfuggire nessun segreto su questioni pubbliche o private.
Togliamo dunque di mezzo espressioni ampollose di questo tipo: «Chi è dedito all’ubriachezza non è padrone di sé: come la fermentazione del mosto fa scoppiare anche le botti e la forza del calore spinge in alto ciò che sta sul fondo, così il vino, ribollendo dentro di noi, butta fuori ciò che si cela nel fondo della nostra anima rendendolo manifesto. Chi è pieno di vino, come non riesce a trattenere il cibo perché il vino gli esce fuori dalla bocca, così non mantiene neppure i segreti e rivela sia quelli degli altri che i suoi». Con tutto ciò accade anche che su questioni molto importanti chiediamo consiglio a persone di cui sappiamo che bevono volentieri: dunque, è falso quel che si dice a sostegno della tesi di Zenone, cioè che a un ubriacone non si deve confidare un segreto. Quanto sarebbe meglio accusare l’ubriachezza senza mezzi termini, evidenziandone i vizi! Se da questi deve tenersi lontano un uomo normale a maggior ragione li eviterà uno saggio e perfetto, al quale basta spegnere la sete e che comunque, anche se è spinto a bere da un’allegria che si protrae non per sua volontà, si ferma prima di ubriacarsi. Vedremo in seguito se l’animo del saggio possa essere turbato da una quantità eccessiva di vino e se egli si comporti come gli ubriachi: intanto, per arrivare alla conclusione che un uomo virtuoso non deve ubriacarsi non c’è bisogno di tirarla per le lunghe a forza di sillogismi. Di’ piuttosto quanto sia vergognoso ingoiare più di quanto si può contenere, ignorare la capacità del proprio stomaco, quante azioni che farebbero arrossire i sobri compiano gli ubriachi, come l’ubriachezza non sia altro che una follia volontaria. Protrai per alcuni giorni il comportamento di un ubriaco e non avrai dubbi che si tratti davvero di pazzia. Anche l’ubriachezza momentanea non è da meno, ma dura per un periodo più breve. Guarda l’esempio di Alessandro il Macedone, che durante un banchetto trafisse Clito, il suo amico più caro e più fedele, e poi, resosi conto del suo delitto, voleva darsi la morte, cosa che indubbiamente avrebbe dovuto fare. L’ubriachezza alimenta tutti i vizi e li mette allo scoperto, elimina il pudore che si oppone ai cattivi impulsi: infatti, più che la buona volontà è la vergogna di fare il male che distoglie la maggior parte degli uomini dal compiere azioni illecite. Quando l’animo è in preda all’effetto violento del vino, tutto il male nascosto viene a galla. L’ubriachezza non produce i vizi, li rende manifesti: a quel punto l’uomo libidinoso non aspetta neppure di entrare in camera da letto, ma concede subito alle sue voglie quanto esse comandano; allora l’impudico confessa e fa conoscere a tutti la sua malattia; allora l’insolente non tiene più a freno né la lingua né la mano. Così nell’arrogante cresce la superbia, nel violento la crudeltà, nell’invidioso la malignità: ogni vizio esplode e s’ingigantisce. Aggiungi lo stato di incoscienza, il parlare incerto e poco chiaro, lo sguardo velato, il passo vacillante, i giramenti di testa, la sensazione che la stanza si muova come se un vortice facesse girare tutta la casa, il mal di stomaco quando il vino fermenta e dilata le viscere. Tuttavia in quel caso l’ubriachezza, finché manifesta il suo effetto naturale, è in qualche modo tollerabile, ma che dire quando il vino è guastato dal sonno e l’ebrietà diventa indigestione? Pensa quali rovine ha provocato l’ubriachezza di un popolo intero:
ha consegnato al nemico genti fiere e bellicose, ha aperto mura difese per molti anni con una lotta accanita, ha assoggettato a nazioni straniere popoli ostinatissimi e restii a qualsiasi dominazione, ha domato col vino uomini invincibili in guerra. Alessandro, che ho appena ricordato, superò incolume tante marce, tante battaglie, tanti inverni trascorsi vincendo l’asprezza del clima e dei luoghi, tanti fiumi dalle sorgenti sconosciute, tanti mari: lo fecero fuori l’intemperanza nel bere e quella fatale coppa di Ercole.12 Che gloria può venire da un ventre molto capace? Quando avrai fra le mani la palma della vittoria e i tuoi commensali, prostrati dal sonno e vomitando, rifiuteranno i tuoi inviti a bere, quando sarai l’unico superstite di tutto il banchetto, quando avrai trionfato su tutti con questa tua straordinaria prova di resistenza e nessuno sarà stato capace di bere altrettanto vino, una botte ti annienterà. M. Antonio, grande uomo e di nobile ingegno, cos’altro lo mandò il rovina e lo trascinò a costumi stranieri e a vizi ignoti ai Romani se non l’ubriachezza e l’amore per Cleopatra, non meno potente del vino? Questo lo rese nemico della patria e inferiore ai suoi nemici; questo lo rese crudele: mentre cenava gli venivano portate le teste dei notabili della città, e lui, in mezzo a banchetti riccamente imbanditi e a un lusso regale, riconosceva il volto e le mani dei proscritti e, pur essendo pieno di vino, aveva ancora sete di sangue. Se già era intollerabile che si ubriacasse mentre commetteva queste atrocità, quanto più lo era che le commettesse da ubriaco! Il vizio del bere conduce quasi sempre alla crudeltà, poiché guasta ed esaspera la sanità dell’animo. Come le lunghe malattie rendono gli uomini intrattabili, suscettibili e furiosi alla più piccola offesa, così un’ubriachezza continua abbrutisce gli animi, poiché, essendo gli ubriachi il più delle volte fuori di sé, lo stato di pazzia permane e i vizi generati dal vino durano anche senza i suoi effetti immediati. Spiega, dunque, perché il saggio non deve ubriacarsi; mostra coi fatti, non con parole, l’infamia e la brutalità di questo vizio. Dimostra, cosa oltremodo facile, che i cosiddetti piaceri quando superano la misura diventano sofferenze. Se infatti cercherai di provare che il saggio, pur bevendo molto vino, non si ubriaca e che anche se ubriaco può mantenersi sulla retta via, potrai concludere che non morirà se berrà un veleno, non si addormenterà se prenderà un sonnifero e non vomiterà ciò che ha nello stomaco se prenderà l’elleboro. Ma se i suoi piedi sono malfermi, se la sua lingua si inceppa, come puoi dire che sia in parte sobrio e in parte ubriaco? Stammi bene.
1.I benefìci I 1, 9 sgg. 2. Ai malfattori condannati a morte si configgeva nel collo un uncino prima che venissero gettati nel Tevere. 3. Virgilio, Eneide VI 261. 4. Decimo Giunio Bruto, uno dei congiurati che si opposero a Cesare, condannato a morte da Antonio.
5. Cfr. Virgilio, Eneide VI 400-401, e VIII 296-297. Il brano è contaminato da Seneca: qui è riportato l’originale. 6. Virgilio, Eneide VI 95-96: esortazione della Sibilla a Enea. 7. Nella prima guerra persiana (480 a.C.) alle Termopili un manipolo di trecento spartani al comando di Leonida si immolò per contrastare il passo all’esercito di Serse. 8. È il tribuno militare Q. Cecidio: l’episodio avvenne durante la prima guerra punica (264-241 a.C.). 9. Si tratta ancora della prima guerra punica: comandava l’esercito Attilio Regolo. 10. Si chiamava così perché era stata scoperta da una vergine. Oggi quell’acqua (portata a Roma da M. Agrippa) alimenta la fontana di Trevi. 11. Cimbro e Cassio furono due dei congiurati che progettarono l’uccisione di Cesare. 12. La coppa di Eracle era una grande tazza in cui si beveva ricordando la morte dell’eroe.
Libro undicesimo 84. Questi viaggi che mi scuotono di dosso l’apatia giovano alla mia salute e ai miei studi. Per quel che riguarda la salute lo vedi bene: poiché l’amore per gli studi mi rende pigro e mi fa trascurare il corpo faccio esercizio con l’aiuto di altri. Quanto allo studio ti spiegherò perché mi fanno bene. Non ho abbandonato le mie letture: ritengo che siano necessarie, prima di tutto perché non devo appagarmi soltanto dei miei pensieri, poi perché, conoscendo le ricerche altrui, intendo giudicarne i risultati e riflettere su quanto resta ancora da scoprire. La lettura alimenta l’ingegno e quando la mente è affaticata dallo studio la ristora, anche se richiede una certa applicazione. Non dobbiamo limitarci a scrivere o a leggere: la sola scrittura riduce ed esaurisce le forze, mentre la sola lettura le infiacchisce e le disperde. Bisogna dunque passare alternativamente dall’una all’altra attività e combinarle in giusta misura, in modo che la scrittura riduca a un insieme organico ciò che si è raccolto attraverso la lettura. Dobbiamo imitare, come si dice, le api, le quali volano di qua e di là e suggono i fiori adatti per fare il miele, poi dispongono e distribuiscono nei favi quello che hanno portato e, come scrive il nostro Virgilio, vanno stipando il luccicante miele – nettare dolce – nelle loro celle.1 Non si sa bene se esse estraggano dai fiori un succo che è già miele o se trasformino la sostanza raccolta in questo alimento saporito mescolandovi il loro alito dotato di una particolare qualità. Alcuni, infatti, ritengono che le api non posseggano l’arte di fare il miele, ma siano solo in grado di raccoglierlo. Dicono che in India il miele si trova nelle foglie di canna e che lo produce o la rugiada di quel clima o una secrezione dolce e piuttosto densa della canna stessa; anche nelle nostre erbe si trova la medesima sostanza, meno facile da individuare e da cogliere, che le api, nate per questo scopo, cercano e concentrano. Secondo altri ciò che gl’insetti suggono dalle erbe e dai fiori più teneri si trasformerebbe in miele perché impastato e depositato in un certo modo, e mediante l’aggiunta di una sorta di lievito che fonde sostanze diverse in una sola. Ma, per non allontanarmi da questo argomento, anche noi dobbiamo imitare le api e classificare ordinatamente ciò che abbiamo raccolto da letture diverse (le cose, infatti, si conservano meglio divise), poi, utilizzando tutte le capacità e l’impegno della nostra mente, dobbiamo fondere in un unico sapore i vari assaggi, in modo che, pur essendone chiara l’origine, appaiano però diversi dalle fonti. La natura opera nel nostro corpo senza alcun intervento da parte nostra (gli alimenti che abbiamo ingerito, finché conservano le loro caratteristiche e galleggiano allo stato solido nello stomaco, sono un peso; ma quando si trasformano, allora si mutano in forze e sangue). Ebbene, facciamo così col nutrimento dello spirito, in modo da non lasciare intatto, e quindi estraneo, ciò
che abbiamo ingerito. Digeriamolo, altrimenti finirà nella memoria, non nella nostra capacità di elaborazione. Aderiamovi totalmente e facciamolo nostro, sì che da molti elementi ne risulti un’unità, come i singoli numeri diventano un numero unico quando somme minori e diverse vengono riunite per ricavarne una somma complessiva. Così faccia il nostro animo: tenga nascosti tutti i contributi di cui si è giovato e mostri solo il risultato della sua attività. Anche se in noi s’intravede una somiglianza con qualcuno che la nostra ammirazione ci ha profondamente impresso, dobbiamo assomigliargli come un figlio, non come un ritratto, che sarebbe cosa morta. «Dunque, non si capirà chi è l’autore di cui imiti lo stile, il pensiero, il modo di ragionare?». Io credo che certe volte non si possa nemmeno capire, quando un uomo di grande ingegno dà un’impronta personale a tutto ciò che ha preso dal suo modello formando un’unità armonica. Non vedi di quante voci si compone un coro? Eppure, dall’insieme di esse viene fuori un suono solo. Ci sono voci acute, gravi, medie, a quelle maschili si uniscono quelle femminili, vi si inseriscono i flauti: le voci dei singoli non si distinguono più, si percepiscono tutte fuse insieme. Parlo del coro quale lo conoscevano gli antichi filosofi: ora nelle nostre manifestazioni musicali i cantanti sono più numerosi di quanti erano una volta gli spettatori a teatro. Quando le file dei cantanti riempiono tutti i corridoi e le gradinate sono circondate dai trombettieri, e dal palco risuonano insieme flauti e strumenti d’ogni genere, da suoni discordi si genera una concorde armonia. Così vorrei che fosse il nostro animo, ricco di capacità, di cognizioni, di esempi di età diverse, ma fusi armonicamente insieme. Mi chiedi come si possa giungere a questo risultato. Con un’applicazione continua: senza il consiglio della ragione non concluderemo nulla e nulla potremo evitare. Se saprai ascoltarla, essa ti dirà: abbandona subito codeste cose verso le quali corrono tutti; abbandona le ricchezze, che sono un peso o un pericolo per chi le possiede, abbandona i piaceri del corpo e dello spirito, che indeboliscono e fiaccano; abbandona l’ambizione, che è una cosa gonfia, inconsistente e volubile, senza limiti, e che non vuole avere alcuno alla pari o davanti a sé, e quindi soffre doppiamente di invidia. Guarda poi quanto sia infelice colui che invidia ed è invidiato. Non vedi le case dei potenti, le soglie strepitanti per le risse dei clienti che portano il loro saluto mattutino? Devi litigare parecchio prima di entrare, e dopo ancora di più. Oltrepassa queste scale dei ricchi e gli atri sospesi su grandi terrazze: ti troverai su un terreno non solo scosceso ma anche scivoloso. Volgiti piuttosto alla saggezza e aspira a quei beni grandi e sicuri che essa promette. Tutto ciò che emerge tra le cose umane, benché sia meschino e risalti solo in rapporto alle cose più vili, si raggiunge per sentieri difficili e malagevoli. Scabrosa è la via che conduce ai più alti gradi; ma se vuoi raggiungere la vetta, rispetto alla quale si piega anche la sorte, scorgerai sotto di te tutto ciò che gli uomini credono eccelso, e però in cima ci arriverai per un sentiero pianeggiante. Stammi bene. 85. Ti avevo risparmiato, tralasciandone la discussione, tutti i punti
complicati che ancora restavano, pago di darti come un assaggio degli argomenti che i nostri stoici adducono per dimostrare che la virtù da sola basta a rendere la vita pienamente felice. Ora vuoi che io raccolga tutte le argomentazioni della nostra scuola oppure quelle escogitate da altri per metterci in ridicolo: se volessi farlo, dovrei scrivere un libro, non una lettera. Ti ho ripetuto tante volte che questo tipo di argomenti non mi piace; mi vergogno di scendere in campo a combattere in difesa di dèi e uomini armato di una lesina. «L’uomo saggio è anche temperante; chi è temperante è anche tenace; chi è tenace è imperturbabile; chi è imperturbabile non è mai triste; chi non è mai triste è felice: dunque, il saggio è felice, e la saggezza è sufficiente per rendere la vita felice». A questo sillogismo alcuni peripatetici rispondono che intendono “imperturbabile, tenace, mai triste” nel senso in cui si definisce “imperturbabile” chi si turba raramente e leggermente, non chi non si turba mai. Analogamente affermano che “mai triste” si definisce chi non è soggetto alla tristezza e non cede spesso o in modo eccessivo a questa debolezza, poiché la natura umana non consente che l’animo di chicchessia sia immune dalla tristezza; il saggio non si lascia abbattere dalla tristezza, ma ne è toccato. E aggiungono altre affermazioni in linea con le tendenze della loro scuola, concludendo che il saggio non elimina le passioni, le domina. Certo, riconosciamo ben pochi meriti al saggio dichiarandolo più forte dei più deboli, più allegro dei più tristi, più moderato dei più sfrenati e più nobile dei più umili! Che diresti se Lada2 trovasse eccezionale la sua velocità confrontandola con la lentezza degli zoppi e dei malati? Ella potrebbe sfrecciare sugli steli delle messi senza toccarli, senz’alcuna offesa, nella sua corsa, per le tenui spighe, o volare sospesa sui marosi senza bagnare nemmeno le piante dei suoi celeri piedi.3 Questa è la velocità apprezzata per sé stessa, non quella che viene lodata nel confronto con i più lenti. Che dire se chiami sano chi ha una febbre leggera? Una malattia lieve non è salute. «Così», osservi, «si dice che il saggio è imperturbabile come si dice che sono senza nocciolo non i frutti privi di semi ma quelli che li hanno più piccoli». Ciò è falso, perché l’uomo virtuoso, secondo me, non deve avere vizi minori, deve non averne affatto; i vizi devono essere completamente assenti, non essere piccoli; se, infatti, ce n’è qualcuno, crescerà e gli sarà pur sempre d’ostacolo. Come la cataratta, che quando è all’inizio offusca la vista, ma quando ormai è sviluppata e matura rende ciechi. Se al saggio attribuisci alcune passioni, la ragione sarà incapace di frenarle e verrà trascinata via come da un torrente, soprattutto se, come tu credi, deve lottare non contro una sola passione, ma contro tutte. Una folla di passioni, anche se moderate, ha più violenza di una sola fortissima. È avido, ma non troppo; è ambizioso, ma non
esageratamente; è irascibile, ma si calma facilmente; è incostante, ma non eccessivamente volubile e mutevole; è lussurioso, ma non maniaco. È molto meglio avere a che fare con chi ha un solo vizio completo che con chi li ha tutti, anche se più lievi. Non importa poi quanto sia grande una passione: per piccola che sia, non sa obbedire, non accetta consigli. Come nessun animale, né selvatico né domestico, obbedisce alla ragione (la loro natura, infatti, è sorda alle sue ammonizioni), così le passioni, per quanto deboli siano, non seguono la ragione e non le dànno ascolto. Tigri e leoni non si spogliano mai della loro ferocia, talvolta la mitigano, ma, quando meno te l’aspetti, la loro ferocia, temporaneamente placata, si inasprisce. Non ci si può mai fidare dei vizi che sembrano addomesticati. Per non dire che se la ragione agisce con efficacia le passioni non nascono nemmeno; ma se nascono a dispetto della ragione, a dispetto della ragione continueranno a vivere. È più facile impedirne la nascita che dominarne l’impeto. È dunque sbagliato e inutile parlare di una via di mezzo, sarebbe come dire che uno può ammalarsi o impazzire soltanto un po’. Solo la virtù conosce la moderazione, i vizi non la tollerano, è più facile eliminarli che dominarli. Non c’è alcun dubbio che i vizi inveterati e incalliti dell’animo umano, che chiamiamo malattie, siano sfrenati come l’avarizia, la crudeltà, la prepotenza. Perciò anche le passioni sono sfrenate, poiché è dai vizi che si arriva a esse. E poi se concediamo un qualche diritto alla tristezza, alla cupidigia e agli altri impulsi perversi non riusciremo più a dominarli. E perché? Perché le cause che li eccitano sono fuori di noi, e pertanto gl’impulsi cresceranno in rapporto all’intensità degli stimoli esterni, che possono essere maggiori o minori. Se si guarda più a lungo o più da vicino ciò che ci spaventa la paura è maggiore, analogamente la cupidigia è più accesa se la stimola la speranza di una cosa più preziosa. Se non siamo capaci di impedire l’insorgere delle passioni, non siamo in grado nemmeno di regolarne l’intensità: se abbiamo permesso loro di nascere, esse cresceranno con le loro cause, e la loro forza sarà proporzionata al loro sviluppo. Aggiungi poi che le passioni, per quanto deboli siano, tendono ad aumentare, poiché ciò che è nocivo non mantiene mai la giusta misura; le malattie, benché inizialmente lievi, si diffondono, e anche l’attacco più leggero talvolta debilita un organismo malato. Che pazzia è poi quella di credere di poter porre fine a quelle passioni di cui non siamo stati capaci di contrastare l’insorgere! Come posso avere abbastanza forza per mettere fine a una cosa che non sono riuscito a impedire, quando è più facile tenere lontana una cosa che frenarla dopo averle dato via libera? Alcuni filosofi operano questa distinzione: «L’uomo temperante e saggio è sereno per disposizione e atteggiamento dell’animo, ma non lo è di fronte a eventi improvvisi. Il suo abito mentale, infatti, gl’impedisce di turbarsi o di rattristarsi, ma non può evitare che una serie di cause esterne arrechino all’animo un turbamento». Con ciò intendono dire che egli non è irascibile, tuttavia talvolta si infuria; che non è pauroso, tuttavia talvolta ha paura: cioè è immune dal vizio,
ma non dal sentimento della paura. Ora, se ammettiamo questo, la paura, sperimentata ripetutamente, si trasformerà in vizio, e l’ira, una volta entrata nell’animo, annienterà la disposizione che lo preservava da essa. Inoltre, se uno bada alle cause esterne e nutre dei timori, quando dovesse procedere coraggiosamente contro il nemico e le fiamme in difesa della patria, delle leggi e della libertà, si muoverà lentamente e con riluttanza. Ma questi sentimenti contrastanti non riguardano il saggio. Ritengo poi che si debba stare attenti a non confondere due cose che vanno esaminate separatamente, quando da un lato si argomenta che l’unico bene è l’onestà, e dall’altro che la virtù basta a rendere felice la vita. Se infatti unico bene è l’onestà, tutti ammettono che la virtù basta alla felicità; viceversa, se è solo la virtù a rendere felici allora l’onestà non è l’unico bene. Senocrate4 e Speusippo5 ritengono che si possa diventare felici anche con la sola virtù, ma non ritengono che l’unico bene sia l’onestà. Anche Epicuro pensa che con la virtù si sia felici, ma la virtù non basti a rendere felice la vita, perché a rendere felici è il piacere che deriva dalla virtù, non la virtù in sé. La distinzione è inopportuna, in quanto Epicuro stesso sostiene che non c’è virtù che non sia accompagnata da piacere. Dunque, se è sempre unita al piacere e ne è inseparabile, basta anche da sola; infatti, anche quando è sola ha con sé il piacere, senza il quale non esiste. È assurdo poi sostenere che si può essere felici con la sola virtù ma non in modo completo; io non sono d’accordo, visto che la felicità ha in sé un bene perfetto e insuperabile, e se non c’è nulla di più grande o di migliore della vita degli dèi, che è sommamente felice, essa non può raggiungere vertici più alti. Inoltre se la felicità non ha bisogno di nulla, ogni felicità è perfetta, e dunque felice e felicissima. Dubiti forse che la felicità sia il sommo bene? Perciò chi possiede il sommo bene è felice al massimo grado. Come il sommo bene non può subire aumenti, perché al di sopra della sommità non c’è alcunché, analogamente non può subirne neppure la felicità, che senza il sommo bene non esiste. Perché se ammetti che esista uno “più” felice, devi anche ammettere che ci sia uno “molto” più felice. Insomma, tu fai innumerevoli distinzioni del sommo bene, mentre io per sommo bene intendo ciò che non ha alcun grado sopra di sé. Se uno è meno felice di un altro è evidente che preferisce alla sua vita quella dell’altro; ma l’uomo felice non preferisce nulla alla sua vita. Entrambi i casi sono inverosimili, sia che per l’uomo felice ci sia qualcosa da preferire al suo stato, sia che egli non preferisca uno stato migliore del suo. Quanto più uno è saggio tanto più tenderà al meglio e desidererà conseguirlo a ogni costo. Ma come può essere felice chi ha ancora qualcosa da desiderare? Ti spiegherò da dove viene l’errore. Si ignora che la felicità è una sola: è la sua qualità, non la sua grandezza che la rende perfetta, perciò, sia lunga o breve, estesa o ristretta, distribuita in molti luoghi e in molte parti, o raccolta in un unico posto, è sempre uguale. Chi la valuta in base a numeri, misure e parti, le toglie ciò che essa ha di eccezionale. E cosa c’è di eccezionale nella felicità? La sua completezza. Lo scopo del mangiare e del bere, direi, è la sazietà. C’è chi
mangia di più e chi mangia di meno: ciò non fa differenza, quando entrambi sono sazi. Uno beve di più, un altro di meno; che differenza c’è? Nessuno dei due ha più sete. Uno è vissuto più a lungo, un altro di meno: non importa, dal momento che i molti anni di vita hanno reso felice l’uno come i pochi anni l’altro. Colui che tu definisci meno felice non è felice, perché questo aggettivo non può subire limitazioni. «Chi è coraggioso non ha paura; chi non ha paura non è triste; chi non è triste è felice». Questo è un sillogismo dei nostri stoici. Si cerca di confutarlo dicendo che noi diamo per dimostrata un’affermazione falsa e controversa, cioè che chi è coraggioso non ha paura. «Ma come?», dicono. «L’uomo coraggioso non temerà i mali che lo sovrastano? Questo atteggiamento è tipico di un pazzo, di un insensato, non di una persona coraggiosa che sa dominare la sua paura ma non ne è del tutto immune». Chi così pensa ricade nuovamente nel medesimo errore, quello, cioè, di considerare virtù i vizi più lievi, come dire che se uno ha paura ma più raramente e meno degli altri non è che non abbia questo vizio, ne è affetto in misura minore. «Per me è un pazzo chi non teme i mali che lo minacciano». Ciò sarebbe vero se si trattasse di mali, ma se uno sa che quelli non sono mali e giudica un male solo la disonestà, guarderà i pericoli senza paura e disprezzerà i timori degli altri. Oppure, se è da stolti o da pazzi non temere i mali, quanto più uno è saggio tanto più ne avrà timore. «Secondo voi», così continuano, «l’uomo forte deve esporsi ai pericoli?». Niente affatto: non ne avrà paura ma cercherà comunque di evitarli; a lui si addice la cautela, non la paura. «Ma come?», chiedono. «Non avrà paura della morte, della prigione, delle fiamme e degli altri colpi della sorte?». No, perché sa che non sono mali ma lo sembrano soltanto, li giudica come spauracchi della vita umana. Descrivigli la prigionia, le frustate, le catene, la povertà, le membra straziate dalle malattie o dalla violenza e qualunque altro tormento tu voglia aggiungere: egli considera tutto ciò come paure degne di una mente malata, di cui solo i deboli hanno paura. O forse giudichi un male quello che certe volte dobbiamo affrontare volontariamente? Chiedi quale sia il male? Cedere a quelli che sono chiamati mali e sacrificare a essi la propria libertà per la quale bisogna sopportare ogni sofferenza: se non disprezziamo ciò che ci impone un giogo la libertà finisce. Se si sapesse cosa è il coraggio non ci sarebbero dubbi sull’atteggiamento che si addice a un uomo coraggioso. Il coraggio non è temerarietà sconsiderata o amore del pericolo o ricerca di situazioni spaventose: è la capacità di distinguere cosa è male e cosa non lo è. L’uomo coraggioso si difende ma nello stesso tempo sopporta con fermezza ciò che ha la falsa apparenza di un male. «E che, dunque? Se all’uomo forte viene puntato un pugnale al collo, se egli viene colpito ripetutamente in più parti del corpo, se vede le sue viscere uscirgli dal ventre squarciato, se viene torturato più volte e a intervalli affinché senta maggiormente i tormenti e nuovo sangue gli esca dalle ferite rimarginate, dirai forse che non ha paura e che non prova nemmeno dolore?». No, il dolore lo prova (non c’è virtù che possa togliere all’uomo la sensibilità), ma non ha paura, egli guarda incrollabile
dall’alto le sue sofferenze. Vuoi sapere quale sia in quel momento il suo stato d’animo? È quello di chi conforta un amico ammalato. «Ciò che è male nuoce; ciò che nuoce rende peggiori, il dolore e la povertà non rendono peggiori, quindi non sono mali». «Questo è un ragionamento falso» dicono, «perché non è detto che ciò che nuoce renda peggiori. Le tempeste e le burrasche nuocciono al timoniere ma non lo rendono peggiore». Qualche stoico ribatte così: le tempeste e le burrasche rendono peggiore il timoniere perché non può raggiungere la meta e mantenere la rotta, egli non diventa peggiore nella sua arte, lo diventa nel realizzarla. A questi filosofi i peripatetici rispondono: «Dunque la povertà, il dolore e qualunque altra disgrazia del genere rendono peggiore anche il saggio, nel senso che non gli tolgono la virtù ma ne impediscono l’attuazione». Questa osservazione sarebbe giusta se le due condizioni, del timoniere e del saggio, non fossero diverse. Il saggio, infatti, si propone non di realizzare a ogni costo i suoi propositi, ma di agire sempre con rettitudine; il timoniere, invece, si propone di condurre in porto a ogni costo la nave. Le arti sono degli strumenti e devono mantenere ciò che promettono, mentre la saggezza è signora e padrona; le arti sono al servizio della vita, la saggezza la comanda. Credo dunque che la risposta da dare sia diversa, e cioè nessuna burrasca rende peggiore l’arte del timoniere, né la sua pratica attuazione. Il timoniere ti promette non un esito fortunato ma un’opera utile e la capacità di governare una nave, la quale risulta tanto più evidente quanto maggiore è la forza imprevista che l’ostacola. Chi ha potuto dire: «Nettuno, non avrai mai questa nave se non sulla giusta rotta», ha fatto tutto ciò che era possibile alla sua arte: la tempesta non impedisce l’opera del timoniere, ne impedisce il successo. «Ma come? Al timoniere non nuoce una cosa che gli impedisce di arrivare in porto, che rende vani i suoi sforzi, che lo spinge indietro o non lo fa procedere e distrugge l’attrezzatura della nave?». Gli nuoce non in quanto timoniere ma in quanto navigante, poiché sotto altri aspetti egli non è un timoniere. Non impedisce la sua arte, anzi la mette in risalto, visto che col mare calmo – come dice il proverbio – tutti sanno fare il timoniere. Questi inconvenienti danneggiano la nave, non il timoniere in quanto tale. Costui, infatti, riveste due ruoli: uno in comune con tutti i passeggeri della nave, dato che anche lui è un passeggero, l’altro, invece, suo particolare, l’essere, cioè, un timoniere. Inoltre l’arte del timoniere è un bene che riguarda gli altri, cioè i passeggeri, così come quella del medico riguarda i pazienti da lui curati. L’arte del saggio è un bene comune, sia di coloro con cui vive, sia suo proprio. Perciò, mentre il timoniere può subire un danno quando la tempesta gl’impedisce di portare a termine un servizio promesso ad altri, il saggio, invece, non può subire alcun danno né dalla povertà né dal dolore né dalle tempeste della vita: queste, infatti, non gli impediscono ogni attività, gli precludono solo quelle che riguardano gli altri; egli è sempre in azione e consegue risultati migliori soprattutto quando la sorte gli è sfavorevole, perché allora agisce nell’interesse della saggezza stessa, che, come accennato, è un bene
suo e al tempo stesso degli altri. Per di più il saggio può giovare agli altri anche se è oppresso dalle difficoltà. La povertà può impedirgli di insegnare come si debba governare lo Stato, ma egli insegna come governare la povertà. La sua opera dura per tutta la vita. Non vi è insomma alcun caso, alcuna circostanza che possano impedire al saggio di agire: egli si occupa di ciò che gli impedisce di occuparsi d’altro, è pronto all’una e all’altra evenienza: saper governare la buona sorte e vincere quella avversa. Voglio dire che egli si è esercitato a mostrare la sua virtù sia nella buona che nella cattiva sorte e a badare non alla materia in cui si esplica la virtù ma alla virtù stessa, perciò non lo fermano né la povertà, né il dolore, né qualunque altro caso che svia e manda in rovina gli ignoranti. Pensi che sia abbattuto dai mali? Al contrario, se ne serve. Fidia non scolpiva solo statue d’avorio, sapeva farle anche di bronzo. Se avesse disposto del marmo o di un materiale ancora meno pregiato ne avrebbe tratto il meglio che la materia potesse consentire. Allo stesso modo il saggio mostrerà la sua virtù, se sarà possibile, nella ricchezza, altrimenti nella povertà; se potrà in patria, diversamente in esilio; come comandante supremo, se no come soldato; se possibile sano altrimenti da invalido. Insomma, qualunque sia il suo destino egli ne ricaverà sempre qualcosa di memorabile. Ci sono domatori che addomesticano bestie ferocissime che a trovarsele davanti incutono terrore, né si accontentano di averle private della loro ferocia, ma le ammansiscono sino al punto di averne familiarità: il domatore infila la mano nelle fauci del leone, il sorvegliante bacia la tigre, un piccolissimo etiope fa inginocchiare e camminare su una fune l’elefante. Così il saggio possiede l’arte di domare i mali: il dolore, la miseria, il disonore, il carcere e l’esilio, sempre spaventosi, davanti a lui si fanno mansueti. Stammi bene. 86. Ti scrivo mentre mi riposo proprio nella villa di Scipione l’Africano, dopo aver reso onore al suo spirito e all’ara che credo sia il sepolcro di un così grande uomo. Sono convinto che la sua anima sia ritornata in cielo, donde era venuta, non perché egli abbia comandato grandi eserciti (cosa che fece anche Cambise,6 un forsennato che sfruttò con successo la sua pazzia), ma per la sua nobile moderazione e per il suo amor di patria, che per me fu in lui più ammirevole quando lasciò la sua città che quando la difese: doveva scegliere: o Scipione a Roma, o Roma libera. «Non voglio», disse, «venir meno alle leggi, né alle istituzioni; i diritti siano uguali per tutti i cittadini. Godi senza di me, o patria, il bene che ti ho fatto. Sono stato l’artefice della tua libertà, ne sarò anche il testimone: se la mia autorità è cresciuta più di quanto ti convenga me ne vado». Perché non dovrei ammirare questa grandezza d’animo che lo spinse a ritirarsi in volontario esilio e a liberare da un peso la città? Si era giunti a un punto tale che o la libertà faceva violenza a Scipione o Scipione alla libertà. In entrambi i casi sarebbe stato un sacrilegio, perciò egli cedette alle leggi e si ritirò a Literno, riversando sullo Stato la responsabilità del suo esilio e di quello di Annibale.7
Ho visto la villa, costruita con pietre quadrate, il muro che cinge il bosco e le torri erette sui due lati a difesa della casa, la cisterna, nascosta da edifici e da piante, che potrebbe bastare persino a un esercito, il bagno, angusto e buio secondo le abitudini antiche: ai nostri antenati non sembrava caldo se non era buio. Ho provato un grande piacere nel mettere a confronto con i nostri i costumi di Scipione: in questo cantuccio il “terrore di Cartagine”,8 a cui Roma deve di essere stata invasa una sola volta, lavava il corpo affaticato dai lavori campestri. Lavorava, infatti, e dissodava la terra (com’era abitudine degli antichi). Abitò sotto questo tetto così squallido e calpestò questo pavimento così rozzo: ma oggi chi sopporterebbe di lavarsi in questo modo? Ci riteniamo poveri e meschini se le pareti non risplendono di specchi grandi e preziosi, se i marmi di Alessandria non sono adorni di rivestimenti numidici e coperti da ogni parte di colorazioni artistiche e varie come dei dipinti, se il soffitto non è rivestito di cristallo, se il marmo di Taso, che una volta, e raramente, si ammirava in qualche tempio, non circonda le nostre vasche, in cui immergiamo il corpo spossato dall’abbondante sudore, se l’acqua non esce da rubinetti d’argento. E sto parlando di bagni plebei: che dire quando arriverò ai bagni dei liberti? Quante statue, quante colonne che sostengono il vuoto, piazzate lì solo per ornamento e per ostentazione del denaro che sono costate! Quante cascate che vengono giù con fragore dai gradini! Siamo giunti a un tal punto di lusso che vogliamo calpestare solo pietre preziose. In questo bagno di Scipione più che finestre ci sono piccolissime fenditure praticate nel muro di pietra affinché la luce nell’entrare non comprometta la solidità della costruzione: ora, invece, dicono che i bagni si riempiono di scarafaggi se non sono disposti in modo da ricevere il sole tutto il giorno attraverso finestre grandissime, se non ci si lava e ci si abbronza nello stesso tempo, se dalla vasca non si vedono il mare o la campagna. Sicché quei bagni che all’inaugurazione della villa richiamarono molta folla destando l’ammirazione di tutti ora sono relegati tra le anticaglie, poiché il lusso ha escogitato altre novità con cui superare sé stesso. Un tempo i bagni erano pochi e privi di ornamenti: a che scopo adornare luoghi del valore di un quarto di asse e destinati a soddisfare un bisogno, non a procurare un piacere? L’acqua non sgorgava dal basso e non scorreva sempre nuova come da una sorgente calda: allora non si pensava che per togliersi di dosso la sporcizia l’acqua dovesse essere trasparente. Ma, buon dio, quanto sarebbe bello entrare in uno di quei bagni bui e coperti di intonaco scadente, sapendo che l’ha preparato per te con la sua mano un edile come Catone o Fabio Massimo,9 o qualcuno dei Corneli! Quegli edili illustri, infatti, avevano anche il compito di entrare in quei locali destinati al popolo, di verificare che fossero puliti e che l’acqua avesse una temperatura conveniente e salutare, non come quella scoperta da poco, tanto calda da sembrare un incendio e da poter essere utilizzata per immergervi e scorticare vivo uno schiavo colto in flagrante. Ormai non c’è differenza tra un bagno caldo e uno bollente. Oggi c’è chi accusa di rozzezza Scipione perché nel
suo bagno non entrava da ampie finestre la luce, perché lui non si coceva nell’acqua bollente e non aspettava di digerire in bagno! Poveretto! Non sapeva vivere. L’acqua con cui si lavava non era filtrata, anzi spesso era torbida e, quando pioveva più forte, quasi fangosa. E non gli importava molto di lavarsi in questo modo, poiché andava a togliersi il sudore, non gli unguenti profumati. Cosa pensi che dirà ora qualcuno? «Non invidio Scipione: è vissuto davvero in esilio uno che si lavava così». Anzi, se vuoi saperlo, non si lavava tutti i giorni: stando, infatti, a coloro che ci hanno tramandato gli antichi costumi di Roma, i nostri antenati si lavavano tutti i giorni le braccia e le gambe, che naturalmente si insudiciavano per via del lavoro, mentre il corpo intero lo lavavano una volta alla settimana. A questo punto qualcuno dirà: «È chiaro che erano molto sporchi!». Ma che odore credi che avessero? Odore di guerra, di fatica, di uomo. Ebbene, dopo l’invenzione dei nostri bagni raffinati, c’è gente anche più sporca. Che dice Orazio Flacco nel descrivere un uomo malfamato e noto per la sua libidine sfrenata? Buccillo odora di pastiglie profumate.10 Ebbene, immagina un Buccillo dei nostri giorni: sarebbe come se puzzasse di caprone, e starebbe al posto di quel Gargonio che sempre Orazio contrappose a Buccillo. È poco spalmarsi l’unguento una volta, bisogna ripetere l’operazione due o tre volte al giorno, perché il profumo non svanisca. E poi si vantano di questo odore come se fosse il loro! Se questi discorsi ti sembrano troppo pesanti danne la colpa alla villa di Scipione, nella quale ho imparato da Egialo, coscienziosissimo padre di famiglia (è lui ora il padrone di questo podere), che un albero, per quanto vecchio, può essere trapiantato. Dobbiamo impararlo noi vecchi, che piantiamo uliveti per gli altri: io ho visto Egialo trapiantare un uliveto costituito da alberi di tre o quattro anni che producevano frutti non disprezzabili. Coprirà anche te quell’albero che cresce lento e domani farà ombra ai tardi nipoti,11 come dice il nostro Virgilio; il quale non badò tanto a dire cose vere quanto a dirle in modo elegante, e non intese dare consigli agli agricoltori, ma volle recare piacere ai lettori. Per non parlare di tutti gli altri errori, ne citerò uno che oggi non ho potuto fare a meno di notare: Si seminano fave a primavera, i molli solchi accolgono anche te, erba medica, e inizia la coltura annuale del miglio.12 Se queste piante vadano seminate insieme e a primavera puoi giudicarlo tu stesso, visto che ora, mentre ti scrivo, siamo a giugno, anzi, quasi a luglio, e io nel medesimo giorno ho visto raccogliere le fave e seminare il miglio.
Ma torniamo agli ulivi, che ho visto piantare in due modi: Egialo ha trapiantato i tronchi di grandi alberi col loro ceppo, dopo averne potato i rami a circa trenta centimetri dal fusto e tagliato le radici, lasciando solo il nodo centrale a cui esse erano attaccate. Li ha conficcati in una fossa, dopo averla cosparsa di letame; poi ha ammucchiato della terra e l’ha calcata e pressata. Dice che non c’è nulla di più efficace di questa pestatura, perché tiene lontano il freddo e il vento, rende l’albero più saldo e consente alle nuove radici di aderire meglio al terreno, poiché quando sono ancora tenere e non aderiscono bene una scossa anche leggera le svelle. Poi raschia il ceppo prima di coprirlo di terra, poiché, così dice, da qualunque punto scoperto del legno possono spuntare nuove radici. Il tronco non deve sporgere dal terreno più di tre o quattro piedi: così si rivestirà subito di germogli fin dal basso e non sarà in gran parte secco e inaridito come i vecchi ulivi. Egialo ha anche un altro sistema di trapianto: interra nello stesso modo dei rami forti e dalla corteccia non dura, come sono di solito quelli degli alberi giovani: questi tardano un po’ a crescere, ma poiché si sviluppano come dalla pianta non sono brutti o secchi. Ho visto trapiantare anche una vecchia vite, staccandola dal suo albero di sostegno; possibilmente bisogna raccoglierne pure i filamenti, poi distenderla con cura in modo che metta radici anche dal tronco. E ho visto piantare viti non solo a febbraio, ma anche alla fine di marzo; hanno attecchito e si sono abbarbicate ai nuovi olmi. Egialo dice che tutti questi alberi di alto fusto vanno aiutati con acqua di cisterna; e se questa giova siamo liberi dalla schiavitù della pioggia. Ma non voglio darti ulteriori insegnamenti, per non avere in te un antagonista, come io lo sono stato per Egialo. Stammi bene. 87. Ho fatto naufragio prima ancora di salire sulla nave: non ti dico come sia accaduto, altrimenti potresti annoverare anche questo fra i paradossi stoici, ma, che tu lo voglia o no, ti dimostrerò che nessuno di essi è falso, né così strano come sembra a prima vista. Intanto questo viaggio mi ha dimostrato quante cose inutili abbiamo e come sarebbe facile farne a meno, visto che se ci capita di esserne privi per necessità non ci accorgiamo della loro mancanza. Con pochissimi schiavi, quanti poteva contenerne una sola vettura, e senza altri oggetti che quelli indossati, io e il mio amico Massimo già da due giorni viviamo qui perfettamente felici. Dormo su un materasso steso per terra, un mantello mi fa da lenzuolo, un altro da coperta. Il pranzo è ridotto al minimo indispensabile ed è bello e pronto in meno di un’ora, non mancano mai i fichi secchi e le tavolette per scrivere: i fichi, se c’è pane, fanno da companatico, altrimenti fanno da pane. Ogni giorno comincia per me un nuovo anno, che io rendo propizio e fortunato con buoni pensieri ed elevando il mio spirito, il quale non è mai così in alto come quando ha messo da parte ogni cosa estranea e ottenuto una pace senza timore e una ricchezza priva di desideri. La vettura su cui sono salito è una campagnola; le mule dimostrano di essere vive solo perché camminano; il mulattiere è scalzo, ma non perché sia estate. A fatica
cerco di dare a intendere agli altri che la vettura non è mia: permane infatti in me un distorto senso del pudore e ogni volta che ci imbattiamo in una comitiva più elegante arrossisco involontariamente, e ciò dimostra che i princìpi che apprezzo e che lodo non sono ancora ben radicati e saldi nel mio animo. Chi arrossisce di una vettura rozza si gloria di una sontuosa. Finora ho fatto pochi progressi: non oso ancora manifestare apertamente la mia frugalità; mi preoccupo ancora del giudizio dei passanti. Avrei dovuto gridare a tutti gli uomini: «Pazzi che non siete altro, vi sbagliate, restate a bocca aperta di fronte a cose inutili e non giudicate una persona per ciò che è veramente suo. In fatto di patrimonio siete bravissimi a calcolare quanto possiedono quelli a cui dovete prestare denaro o fare un favore (anche i favori, infatti, li mettete fra le spese): ha vasti poderi, ma anche molti debiti; ha una casa splendida, ma comprata con denaro preso a prestito; nessuno può vantare una servitù più cospicua, ma non la paga quando dovrebbe; se soddisfa i suoi debiti non gli resta più niente. La stessa cosa dovete fare con gli altri beni per vedere quanto ciascuno possiede realmente». Giudichi ricco uno perché anche in viaggio si porta dietro stoviglie d’oro, perché ha terreni in ogni provincia, perché sfoglia un grosso libro dei crediti e fuori città possiede tanto terreno quanto susciterebbe invidia anche nella deserta pianura pugliese: elenca pure tutti i suoi averi e ti renderai conto che è povero. Perché? Perché è pieno di debiti. «A quanto ammontano?». A tutto. A meno che tu non ritenga che ci sia differenza tra il prendere in prestito da un uomo e il prendere in prestito dalla fortuna. Che importa se le mule sono ben pasciute e tutte del medesimo colore? Se la vettura è cesellata? Svelti destrieri bardati di porpora e con i drappi ricamati. Pende dai loro petti una collana d’oro; coperti d’oro, serrano fra i denti un fulvo morso d’oro.13 Questi ornamenti non possono rendere migliore né il padrone né la mula. Catone il Censore, la cui nascita giovò allo Stato quanto quella di Scipione (l’uno, infatti, combatté contro i nostri nemici, l’altro contro la corruzione), cavalcava un somaro e per giunta carico delle bisacce, per portare con sé il necessario. Come vorrei che lo incontrasse uno di questi bellimbusti che ostentano le loro ricchezze anche per strada e si fanno precedere da corrieri e da cavalieri numidici e da nuvoloni di polvere! Senza dubbio sembrerebbe più raffinato e meglio accompagnato di Catone costui, che in mezzo a tanto fasto è fortemente indeciso se combattere con la spada o col coltello. Com’erano belli quei tempi in cui un condottiero, un trionfatore, un ex censore e soprattutto un Catone si accontentava di un solo cavallo e neppure tutto per lui, visto che una parte era occupata dai bagagli appesi su entrambi i lati! A tutti questi puledri ben pasciuti, ai cavalli d’Asturia e da trotto non preferiresti quell’unico cavallo strigliato da Catone stesso?
Vedo che su questo argomento potrei proseguire all’infinito se non m’imponessi un limite, per cui smetterò di parlare di bagagli, che chi per primo li ha chiamati “impedimenti” prevedeva certamente che in futuro sarebbero stati tali. Ora ti citerò ancora pochissimi sillogismi dei nostri stoici relativi alla virtù, che noi riteniamo sufficiente alla felicità. «Ciò che è buono rende buoni (anche nella musica, infatti, ciò che è buono fa il musicista); i beni fortuiti non rendono buoni, dunque, non sono beni autentici». Secondo i peripatetici la premessa di questo sillogismo è falsa. «Non sempre», essi dicono, «gli uomini sono resi buoni da ciò che è buono». In musica c’è qualcosa di buono, come il flauto, la cetra o qualche strumento adatto ad accompagnare il canto, ma nessuno di questi, propriamente, rende musicisti. Ebbene, noi a nostra volta ribattiamo: «Non avete capito cosa intendiamo per ciò che è buono in musica. Noi ci riferiamo non agli strumenti usati dal musicista, ma a ciò che lo rende tale: tu ti riferisci agli strumenti dell’arte musicale, non all’arte della musica in sé. Se c’è qualcosa di buono nell’arte musicale in sé, ciò renderà senz’altro musicisti». Voglio chiarire meglio questo concetto. In musica “buono” si usa in due sensi: uno relativo a ciò che serve all’esecuzione musicale, l’altro relativo all’arte: gli strumenti, flauti, organi, cetre, riguardano l’esecuzione, non l’arte in sé. L’artista, infatti, è tale anche senza di essi, pur non potendo senza di essi esercitare la sua arte. Questo doppio significato nell’uomo non c’è: il buono dell’uomo e quello della vita sono la medesima cosa. «Ciò che può capitare agli uomini più spregevoli e disonesti non è un bene; le ricchezze toccano in sorte anche a un lenone e a un maestro di gladiatori, dunque le ricchezze non sono beni». «Anche qui la premessa», dicono, «è falsa, poiché vediamo che nella grammatica, nella medicina o nell’arte nautica i beni toccano anche agli uomini più umili». Già, però queste arti non promettono la grandezza d’animo, non si elevano in alto e non disprezzano i beni occasionali: la virtù innalza l’uomo e lo pone al di sopra delle cose care ai mortali; e non desidera troppo né teme troppo quelli che sono chiamati beni e quelli che sono chiamati mali. Chelidone, uno degli eunuchi di Cleopatra, possedeva un grande patrimonio. Poco tempo fa Natale, uomo dalla lingua tanto disonesta quanto impudica, nella cui bocca le donne si ripulivano, fu erede di molti ed ebbe molti eredi. Dunque? Fu il denaro a insozzare lui o lui a insozzare il denaro? Il denaro cade su certi uomini come una moneta d’argento in una cloaca. La virtù sta al di sopra di tutto ciò; viene giudicata in base al suo valore; non giudica buona nessuna di quelle cose che possono capitare a chiunque. La medicina e l’arte di guidare la nave non vietano a sé stesse e a chi le pratica di ammirare tali beni; un uomo non buono può benissimo essere medico, timoniere o letterato, come anche essere cuoco, perbacco. Uno a cui capita di possedere una cosa non comune lo considererai un uomo non comune; ciascuno vale tanto quanto possiede. Una cassetta vale in ragione del suo contenuto, anzi, il valore di questo la fa diventare un accessorio. A un borsellino pieno di denaro non daremo forse il valore in base alla quantità
delle monete che vi sono contenute? Analogamente chi possiede un grande patrimonio non ne è che un accessorio, un’appendice. Perché allora il saggio è grande? Perché ha un’anima grande. Dunque è vero che quanto accade agli uomini più spregevoli non è un bene. Io, perciò, non dirò mai che l’insensibilità è un bene: ce l’ha la cicala, ce l’ha la pulce. E non dirò neppure che la tranquillità e l’essere privo di noie è un bene: chi è più tranquillo di un verme? Chiedi che cosa renda saggio il saggio? Ciò che rende dio un dio. Devi attribuirgli qualcosa di divino, di celeste, di magnifico: il bene non capita a tutti e non tocca un possessore qualsiasi. Guarda ciò che un terreno produce e ciò che invece rifiuta: qui son più ricche le messi, là l’uva o le piante da frutto, l’erba spontanea e verde. Non vedi come il Tmolo ci mandi lo zafferano aromatico, l’India l’avorio, l’incenso i femminei Sabei e i nudi Calibi il ferro?14 Questi prodotti sono stati distribuiti in regioni diverse affinché gli uomini potessero commerciare fra loro nel caso in cui cercassero vicendevolmente gli uni i frutti degli altri. Anche il sommo bene ha una sua propria dimora: non nasce dove si trovano il ferro o l’avorio. Vuoi sapere qual è la sede del sommo bene? L’anima. Ma se questa non è pura e santa non può accogliere dio. «Il bene non nasce dal male; la ricchezza nasce dall’avidità, dunque la ricchezza non è un bene». «Non è vero», ribattono, «che il bene non nasce dal male, visto che il denaro può provenire da un sacrilegio o da un furto. Perciò il sacrilegio e il furto sono mali nel senso che producono più mali che beni: procurano infatti un guadagno, ma anche paura e agitazione, nonché tormenti fisici e spirituali». Chi sostiene ciò deve considerare il sacrilegio un male in quanto causa molti mali, ma anche un bene in quanto causa qualche bene: che cosa può esserci di più mostruoso? Benché abbiamo appena dimostrato che il sacrilegio, il furto e l’adulterio possano essere annoverati fra i beni, quanti non arrossiscono di un furto o si vantano di un adulterio! I piccoli sacrilegi, infatti, vengono puniti, quelli grandi sono portati alle stelle. Aggiungi che se il sacrilegio, da un certo punto di vista, è decisamente un bene, sarà anche una cosa onesta e verrà considerato un’azione retta […], e questa è una conclusione inaccettabile. I beni, dunque, non possono nascere da un male. Se infatti, come dite, il sacrilegio è un male solo in quanto arreca molto male, qualora condonassimo la pena e assicurassimo al sacrilego l’impunità, il sacrilegio finirebbe con l’essere un bene sotto tutti gli aspetti. Eppure, la più grave pena dei delitti è nei delitti stessi, e per questo ti dico che sbagli se differisci la punizione rimettendola al carnefice o al carcere, giacché i delitti subiscono la punizione nel momento stesso in cui vengono commessi. Perciò un bene non nasce da un male, come un fico non nasce da un ulivo: i frutti
corrispondono ai semi, i beni non possono degenerare. Come dal turpe non nasce l’onesto, così neppure dal male deriva un bene; onestà e bene, infatti, sono la stessa cosa. Alcuni dei nostri stoici ribattono così: «Supponiamo che il denaro sia un bene, da qualunque parte provenga; perciò, anche se deriva da un sacrilegio, non è sacrilego. Un esempio. In uno stesso scrigno ci sono dell’oro e una vipera: ora, se dallo scrigno prendi l’oro, tu non lo prendi perché lì c’è anche la vipera; dirò meglio: lo scrigno mi dà l’oro non perché contenga una vipera, mi dà l’oro nonostante contenga anche una vipera. Analogamente da un sacrilegio si ricava un guadagno non perché il sacrilegio sia un’azione vergognosa e scellerata, ma perché può procurare anche un guadagno. Come in quello scrigno il male è la vipera, non l’oro che sta accanto alla vipera, così nel sacrilegio il male è il misfatto, non il guadagno». Non sono d’accordo: i due casi sono completamente diversi. Nel primo posso prendere l’oro senza la vipera, nel secondo non posso ricavare un guadagno senza commettere il sacrilegio; un guadagno che non è accanto al delitto, ma vi è strettamente unito. «Ciò che otteniamo attraverso una serie di mali non è un bene; la ricchezza la conseguiamo a prezzo di molti mali, dunque, la ricchezza non è un bene». «La vostra enunciazione», dicono, «può significare due cose: primo, che mentre cerchiamo di raggiungere la ricchezza ci imbattiamo in molti mali. Ma ci imbattiamo in molti mali anche mentre cerchiamo di raggiungere la virtù: c’è chi durante un viaggio per motivi di studio fa naufragio e chi viene fatto prigioniero. Secondo, che non è un bene ciò che è causa di mali. Da questa premessa non consegue che ci imbattiamo nei mali a causa della ricchezza o dei piaceri; o che se a causa della ricchezza ci imbattiamo in molti mali la ricchezza non solo non è un bene, ma è un male: voi dite solo che la ricchezza non è un bene. Inoltre», dicono, «voi ammettete che la ricchezza abbia una qualche utilità, annoverandola fra i vantaggi. Ma secondo lo stesso criterio non è nemmeno un vantaggio, visto che arreca molti svantaggi». Alcuni a queste argomentazioni ribattono così: «Sbagliate ad attribuire svantaggi alla ricchezza, essa non danneggia nessuno: il danno viene o dalla propria stoltezza o dall’altrui malvagità, così come la spada di per sé non uccide nessuno, è l’arma per chi ha intenzione di uccidere. Perciò la ricchezza non ti danneggia, anche se ricevi un danno a causa sua». Migliore, a mio parere, l’argomentazione di Posidonio, secondo cui la ricchezza è causa di mali non perché essa li commetta ma perché stimola gli altri a commetterne. Una cosa è la causa efficiente, che di necessità provoca direttamente il male, un’altra è la causa antecedente. La ricchezza è la causa antecedente: inorgoglisce gli animi, genera superbia, suscita invidia, e ci fa uscire di senno a tal punto che ci rallegriamo della fama derivante dal denaro anche se ci danneggerà. Tutti i beni, invece, devono essere immuni da colpa; sono puri, non corrompono l’animo, non lo turbano; lo elevano e lo dilatano ma senza gonfiarlo. I veri beni rendono sicuri, la ricchezza ci fa arroganti; i veri beni generano grandezza d’animo, la ricchezza tracotanza, la quale non è altro che una falsa apparenza di grandezza.
«Così», si dice, «la ricchezza, non solo non è un bene ma è anche un male». Lo sarebbe se di per sé danneggiasse, se fosse, come ho detto, la causa efficiente: invece è la causa antecedente, che non solo eccita gli animi, ma li attira; mostra una falsa immagine del bene simile al vero, alla quale i più prestano fede. Anche la virtù è una causa antecedente rispetto all’invidia, visto che molti sono invidiati per la loro sapienza, molti per la loro giustizia. Ma tale causa non nasce dalla virtù stessa, né è simile al vero; al contrario, la virtù offre all’animo quell’aspetto più simile al vero che li richiama all’amore e all’ammirazione. Posidonio dice che bisogna argomentare così: «Le cose che non dànno all’animo né grandezza, né fiducia, né sicurezza non sono beni; la ricchezza, la salute e altre cose simili non procurano niente di tutto ciò, dunque, non sono beni». Egli spinge ancora più oltre questo sillogismo, dicendo: «Quelle cose che non procurano all’animo né grandezza, né fiducia, né sicurezza, ma, al contrario, generano tracotanza, orgoglio e presunzione, sono mali, e poiché a essi ci spingono i doni della fortuna non sono beni». «In base a questo ragionamento», si osserva, «essi non sono neppure dei vantaggi». Infatti: vantaggi e beni sono due cose diverse: per vantaggio s’intende ciò che porta utilità più che danno; il bene deve essere puro e innocuo sotto ogni aspetto. È un bene non ciò che giova di più, ma ciò che giova soltanto. Inoltre il vantaggio riguarda anche gli animali, oltre che gli uomini imperfetti e gli stolti, quindi può essere unito a uno svantaggio, ma viene detto vantaggio perché vi predominano le caratteristiche tipiche del vantaggio: il bene riguarda solo il saggio e deve essere incontaminato. Coraggio, ti resta un solo nodo da sciogliere, anche se difficile: «Dai mali non deriva il bene; la ricchezza nasce da molte povertà, dunque la ricchezza non è un bene». I nostri filosofi stoici non accettano questo sillogismo, i peripatetici, invece, lo formulano e lo risolvono. Da parte sua Posidonio dice che questo sofisma, discusso in tutte le scuole dei dialettici, viene così confutato da Antipatro: 15 «La povertà viene definita tale in relazione non a un possesso ma alla sottrazione di qualcosa» (o, come dicevano gli antichi, per privazione, mentre i Greci dicono kata; stevrhsin); non indica, insomma, ciò che si possiede, indica ciò che non si possiede. Con molti vuoti non si può riempire nulla: voglio dire, la ricchezza è formata da molte sostanze, non da molte mancanze. Così s’intende la povertà in modo diverso da come si dovrebbe. Povertà, infatti, non è possedere poche cose, è non possederne molte; essa viene definita in rapporto non a quanto possiede ma a quanto le manca. Esprimerei più facilmente ciò che intendo se ci fosse una parola latina per indicare ajnuparxiva.16 Antipatro la attribuisce alla povertà: per me la povertà non è altro che il possesso di poco. Se un giorno ne avremo il tempo vedremo cosa siano in sostanza la ricchezza e la povertà; ma anche allora rifletteremo se sia meglio mitigare la povertà e togliere arroganza alla ricchezza piuttosto che discettare sulle parole, come se sulla sostanza si fosse già espresso un giudizio.
Supponiamo di trovarci in un’assemblea popolare, in cui si propone una legge per l’abolizione della ricchezza. La sosterremo o la combatteremo con questi sillogismi? Faremo sì che il popolo romano apprezzi e ricerchi la povertà, fondamento e origine del suo impero, e tema la sua ricchezza; che pensi di averla trovata presso i popoli vinti e che da lì siano penetrati in una città completamente sobria e tollerante intrighi, corruzioni e disordini; che le prede di guerra vengano ostentate troppo superbamente, e che i beni strappati da un solo popolo a tutti gli altri possano essere da tutti strappati a uno solo più facilmente? È meglio persuaderlo di ciò e vincere le passioni piuttosto che far ricorso a giri di parole. Parliamo con più forza se possibile, se no, con maggiore chiarezza. Stammi bene. 88. Vuoi sapere cosa penso degli studi liberali: io non stimo e non considero un bene ciò che mira al denaro. Sono arti venali, risultano utili solo se si limitano a esercitare la mente, non se la tengono occupata in esclusiva. A quegli studi bisogna dedicarsi finché l’animo non è in grado di affrontare cose più impegnative: sono il nostro tirocinio, non il nostro lavoro. Lo sai perché si chiamano studi liberali: perché sono degni di un uomo libero. Ma l’unico studio veramente liberale è quello che rende liberi, cioè lo studio della saggezza, sublime, forte, grande: gli altri sono insignificanti e puerili. Credi che possa esserci qualcosa di buono in questi studi di cui sono maestri gli uomini più infami e dissoluti? Queste cose non vanno studiate, occorre averle imparate. Secondo alcuni filosofi bisogna chiedersi se gli studi liberali rendano buono l’uomo: essi, però, non lo promettono, né vi aspirano. La filologia si cura della lingua, se vuole spaziare di più, della storia e, al limite, della poesia. Ebbene, quale di queste discipline spiana la via alla virtù? La scansione delle sillabe, la cura nella scelta delle parole, la mitologia, le leggi e la misura dei versi? Quale di queste cose toglie il timore, libera dalle passioni, frena la libidine? Passiamo alla geometria e alla musica: non vi troverai nulla che blocchi i timori e i desideri. Se uno ignora ciò è inutile che conosca altro. *** Bisogna vedere se costoro insegnano la virtù o no: se non la insegnano non possono nemmeno trasmetterla; se la insegnano sono filosofi. Vuoi capire perché non si sono mai soffermati a insegnare la virtù? Guarda come sono diversi gli studi di tutti costoro: eppure, se insegnassero tutti la stessa cosa dovrebbero essere simili fra loro. A meno che non ti persuadano che Omero fu un filosofo, quando le argomentazioni che usano a tale riguardo dimostrano il contrario; ora, infatti, ne fanno uno stoico, che apprezza solo la virtù, rifugge i piaceri e non si allontana dall’onestà neppure a prezzo dell’immortalità; ora ne fanno un epicureo, che loda la condizione di una città tranquilla che passa la vita fra canti e banchetti; ora ne fanno un peripatetico, che ammette tre tipi di beni; ora un accademico, secondo il quale tutto è incerto. È chiaro che nessuna di queste dottrine si trova in lui, poiché ci sono tutte, e sono in contrasto fra loro. Ammettiamo che Omero sia stato un filosofo: certamente divenne saggio prima di conoscere la poesia; dunque, impariamo la disciplina che lo rese saggio.
Chiedersi se sia vissuto prima Omero o Esiodo non è più importante che sapere perché Ecuba, pur essendo più giovane di Elena, portasse così male i suoi anni. Perché credi che sia importante indagare sull’età di Patroclo e di Achille? Ti chiedi in quali paesi andò vagando Ulisse invece di adoperarti affinché noi non si vada sempre errabondi per il mondo? Non c’è tempo per ascoltare se fu sbattuto fra l’Italia e la Sicilia o al di là del mondo da noi conosciuto (dato che non avrebbe potuto vagare così a lungo in uno spazio così ristretto): le tempeste dell’animo ci scuotono ogni giorno e la malvagità ci caccia in tutti i mali patiti da Ulisse. Non manca certo la bellezza ad attirare i nostri sguardi, né i nemici; da una parte mostri feroci bramosi di sangue umano, dall’altra insidiose lusinghe per le orecchie, dall’altra ancora naufragi e disgrazie di ogni genere. Insegnami come amare la patria, la moglie, il padre, come, pur avendo fatto naufragio, io possa navigare verso una meta così onesta come la virtù. A che indagare se Penelope sia stata una donna impudica e abbia ingannato i suoi contemporanei? Se prima di scoprirlo sospettasse già che quello che le stava davanti era Ulisse? Insegnami piuttosto che cos’è la pudicizia e quanto bene vi sia in essa, se ha sede nel corpo o nell’anima. Passiamo alla musica. Tu mi insegni come suoni acuti e gravi si accordino fra loro, come da corde che emettono suoni diversi si generi l’armonia: fa’ invece in modo che il mio animo sia coerente con sé stesso e che le mie decisioni non siano in contrasto fra loro. Mi mostri quali siano i toni lamentosi: mostrami piuttosto come in mezzo alle avversità io possa non emettere un lamento. Il geometra mi insegna a misurare vaste estensioni di terra invece di insegnarmi quanto basta a un uomo; mi insegna a fare i conti prestando le dita alla mia avidità, invece di insegnarmi che questi calcoli non hanno alcuna importanza, che non è più felice chi possiede un patrimonio tale da stancare i contabili, anzi, quanto siano superflui i beni che possiede chi sarebbe infelicissimo se dovesse calcolarli da sé. A che mi giova saper dividere un campicello se non so dividerlo con mio fratello? Calcolare con precisione i piedi di uno iugero e accorgermi anche di una differenza sfuggitami nella misurazione, se mi rattrista un vicino prepotente e che si appropria di un po’ del mio terreno? M’insegna come non perdere niente dei miei possedimenti: ma io voglio imparare come perderli tutti conservando il buonumore. «Vengo cacciato dal podere che fu di mio padre e di mio nonno», dice. E allora? Chi ne fu il proprietario prima di tuo nonno? E per non parlare del singolo uomo, puoi sapere a quale popolazione appartenne? Ci sei entrato non come padrone, ma come colono. E tu di chi sei colono ora? Se ti va bene, dell’erede. Secondo i giuristi ciò che è di pubblica proprietà non si acquista per prescrizione, quindi quel che possiedi, che definisci tuo, è pubblico, o, più precisamente, appartiene al genere umano. Che arte meravigliosa la geometria! Sappiamo misurare il cerchio, ridurre al quadrato qualunque figura, calcolare le distanze delle stelle, non c’è nulla che sfugga alla nostra capacità di misurazione, ma se siamo
veramente esperti proviamo a misurare l’anima, diciamo quanto è grande o quanto è meschina. A che ci serve conoscere la linea retta quando ignoriamo cos’è la rettitudine? Veniamo ora all’astrologia, che si vanta di conoscere i corpi celesti, di sapere dove al tramonto Saturno, la gelida stella, riposi, che traiettoria percorra nel cielo il pianeta Mercurio.17 A che serve conoscere tutto ciò? Affaticarsi per sapere quando Saturno e Marte saranno in opposizione o Mercurio tramonterà di sera in vista di Saturno? Meglio imparare che gli astri, ovunque si trovino, sono propizi e immutabili. Un ordine continuo di leggi fatali e un corso inevitabile li spingono; ritornano periodicamente in un avvicendarsi stabilito e determinano o preannunciano tutti gli eventi. Ma se sono loro i responsabili di tutti i fenomeni dell’universo a che serve conoscere un fatto che deve necessariamente accadere? E se lo preannunciano che importa prevedere ciò a cui non si può sfuggire? Che tu lo sappia o no, accadrà ugualmente. Ma se contempli il sole nella sua rapida corsa, se osserverai le stelle nel loro ordinato cammino, mai nelle tue previsioni potrà ingannarti il domani, né ti sorprenderà la malia di una notte serena.18 Io mi sono premunito abbondantemente per stare al sicuro dalle insidie. «Il domani non m’ingannerà? Inganna, infatti, ciò che accade a colui che lo ignora». Io non so cosa accadrà, so, però, cosa può accadere. Non cercherò di scongiurare nulla, mi aspetto di tutto: se mi viene risparmiato qualche male non posso che rallegrarmene. Il tempo che mi risparmia m’inganna, ma neppure ingannandomi m’inganna. Infatti io so che può accadere di tutto, ma so anche che non c’è cosa di cui si possa dire che è certo che accada; perciò, aspetto gli eventi propizi e sono pronto a quelli sfavorevoli. A questo punto consentimi di scostarmi dalla via già tracciata: non me la sento di accogliere tra le arti liberali quella dei pittori, degli scultori, dei marmisti o degli altri che operano al servizio del lusso. Analogamente escludo da queste occupazioni liberali i lottatori e quell’arte che consiste interamente nel cospargersi d’olio e di fango, diversamente dovrei includere nell’elenco anche i profumieri, i cuochi e tutti quegli altri che dedicano il loro ingegno all’appagamento dei nostri piaceri. Dimmi, infatti, cos’hanno di liberale costoro che vomitano a digiuno, dal corpo obeso e dall’animo torpido e smunto? O dobbiamo credere che codesta sia un’arte liberale per i giovani quando i nostri antenati l’usavano per scagliare lance col corpo eretto, per vibrare il bastone, per spronare il cavallo e maneggiare le armi? Ai loro figli non insegnavano alcunché da imparare standosene sdraiati. Ma né queste arti né altre insegnano o
aumentano la virtù; a che serve saper guidare un cavallo e regolarne la corsa con le redini se ci lasciamo trascinare dalle passioni più sfrenate? Vincere molti nella lotta o nel pugilato se ci lasciamo vincere dall’ira? «E che, dunque? Gli studi liberali non ci arrecano alcun vantaggio?». In altri campi sì, e molti, ma non per la virtù: anche le arti manuali chiaramente vili servono moltissimo a darci di che vivere ma non riguardano la virtù. «Perché, allora, istruiamo i nostri figli negli studi liberali?». Non perché essi diano la virtù ma perché preparano l’anima ad accoglierla. Come la grammatica elementare – così la chiamavano gli antichi – attraverso la quale i fanciulli apprendono i primi rudimenti del sapere non insegna le arti liberali ma prepara ad apprenderle, così le arti liberali non conducono l’anima alla virtù, ma ve la preparano. Quattro sono per Posidonio i generi di arti: quelle popolari e umili, quelle ricreative, quelle per i fanciulli e quelle liberali. Le popolari sono proprie degli artigiani, richiedono l’uso delle mani e servono a fornire il necessario per vivere; in esse non c’è apparenza di bellezza o di virtù morale. Quelle ricreative hanno lo scopo di procurare piacere agli occhi e alle orecchie; fra esse si può annoverare quella degli ideatori di macchine teatrali che si sollevano da sole, di palchi che si alzano silenziosamente e di altre varie improvvisazioni, quali elementi uniti che si separano, pezzi staccati che si attaccano automaticamente o che dall’alto si abbassano a poco a poco. Tali macchinari colpiscono gli ignoranti, che guardano stupiti tutti questi cambiamenti improvvisi perché non ne conoscono le cause. Sono invece per i ragazzi e hanno qualcosa di simile alle arti liberali quelle che i Greci chiamano ejgkuvklioi e noi «liberali». Ma le sole e vere arti liberali, anzi, per essere più precisi, libere, sono quelle che si occupano della virtù. «Come nella filosofia ci sono diverse branche, una che studia la natura, una che studia la morale e una che studia la logica, così anche questa moltitudine di arti liberali rivendica nella filosofia un suo posto particolare. Nello studio dei fenomeni naturali, per esempio, ci si basa sulle testimonianze della geometria, e se la geometria è utile alla filosofia evidentemente ne fa parte». Molte cose ci sono di aiuto ma non per questo sono parte di noi; anzi, se lo fossero non ci servirebbero di aiuto. Il cibo sostiene il corpo, ma non ne fa parte. La geometria ci serve, e serve alla filosofia come alla geometria è necessario chi fabbrica gli strumenti, ma né costui è parte della geometria, né la geometria della filosofia. Inoltre entrambe hanno confini ben precisi: il saggio ricerca e conosce le cause dei fenomeni naturali, mentre il geometra ne stabilisce e ne calcola la grandezza e la quantità. Il saggio conosce le leggi su cui si reggono i corpi celesti, quali ne siano la forza e la natura, mentre il matematico ne calcola i corsi e ricorsi e certe orbite lungo le quali essi salgono e scendono e talvolta sembrano immobili, quando i corpi celesti non possono stare fermi. Il saggio sa perché un’immagine si riflette nello specchio: il geometra può dire quanto un corpo debba essere distante dalla sua immagine e quale forma di specchio restituisca un determinato
genere di immagine. Il filosofo dimostrerà che il sole è grande, il matematico, che si basa sulla pratica e sull’esperienza, dirà quanto è grande. Ma per poterlo fare deve apprendere certi princìpi, e quella scienza che non ha in sé stessa le leggi fondamentali che le sono proprie non è indipendente. Ora, la filosofia non chiede nulla agli altri, innalza essa stessa fin dalla base tutto il suo edificio: la matematica è, per così dire, affittuaria, costruisce su terreno altrui: riceve i primi elementi, in virtù dei quali procede verso mete ulteriori. Se andasse da sola verso la verità, se potesse comprendere la natura dell’intero universo, direi che porterebbe un gran contributo allo spirito umano, il quale cresce studiando i fenomeni celesti e trae vantaggi dall’alto. Una sola cosa può rendere l’anima perfetta: la scienza immutabile del bene e del male, sui quali non c’è arte che possa indagare. Ora esaminiamo le singole virtù. La fortezza non si cura di ciò che suscita timore; disdegna, sfida, vince le paure che soggiogano la nostra libertà: possono forse rafforzarla le arti liberali? La lealtà è il bene più sacro dell’anima umana, non v’è circostanza che possa indurla all’inganno, né ricompensa che riesca a corromperla: «Brucia», dice, «colpisci, uccidi, io non tradirò, ma quanto più si cercherà di carpire i miei segreti attraverso il dolore, tanto più li terrò nascosti». Ebbene, gli studi liberali possono mai formare animi del genere? La temperanza domina i piaceri, alcuni li odia e li elimina, altri li regola e li riconduce alla giusta misura, né mai vi si avvicina per via dei loro effetti; sa che la misura migliore di ciò che desideriamo è prenderne non quanto vogliamo, ma quanto dobbiamo. La nostra umanità ci vieta di essere superbi e scortesi col prossimo; nelle parole, nelle azioni, nei sentimenti si mostra affabile e disponibile con tutti; fa propri i mali altrui e ama il suo bene, soprattutto quando può essere utile ad altri. Gli studi liberali c’insegnano forse un simile comportamento? Certamente no. Come non c’insegnano la schiettezza, la modestia e la moderazione, la frugalità e la parsimonia, la clemenza, che c’induce a risparmiare il sangue altrui come se fosse il nostro e sa che l’uomo non deve abusare di un suo simile. Alcuni ribattono: «Visto che senza gli studi liberali, a vostro dire, non si può giungere alla virtù, come potete affermare che essi non vi apportano comunque il proprio contributo?». Perché nemmeno senza nutrirsi si può giungere alla virtù, e tuttavia il cibo non ha niente a che fare con la virtù; il legno non giova alla nave, ma senza legno non si può costruire una nave; voglio dire, non c’è ragione di credere che una cosa sia fatta con l’aiuto di un’altra se senza di essa non può esser fatta. Si può anche sostenere che sia possibile giungere alla saggezza senza gli studi liberali, visto che la virtù, benché si debba impararla, non la si impara attraverso tali studi. Perché dovrei credere che non diventa saggio chi è privo di cultura, quando la saggezza non si identifica con la cultura? Essa insegna cose, non parole, e penso che forse sia più affidabile quella memoria che confida solo in sé stessa. La saggezza è cosa grande e vasta, per cui le serve uno spazio libero; bisogna apprendere nozioni sulle realtà divine e umane, sul passato e sul futuro, sul caduco e sull’eterno, sul tempo. E guarda un po’ su questo solo e
ultimo argomento quante questioni sorgono: primo, se il tempo sia qualcosa di per sé; poi se ci sia qualcosa prima di esso e senza di esso; se il tempo abbia avuto inizio insieme col mondo o se, dato che prima del mondo c’era qualcosa, sia esistito allora anche il tempo. Innumerevoli sono poi le questioni relative all’anima: donde provenga, quale sia la sua essenza, quando cominci a esistere, quanto duri, se passi da un luogo all’altro e cambi dimora, gettata nel corpo ora di uno ora di un altro animale, oppure sia schiava una sola volta e poi, liberata, vaghi nel tutto; se sia qualcosa di materiale o no; che cosa farà quando cesserà di agire per mezzo di noi, come utilizzerà la sua libertà una volta fuggita da questa gabbia; se dimentichi il passato e cominci a conoscere sé stessa dal momento in cui, separatasi dal corpo, sale in cielo. Qualunque parte delle questioni umane e divine prenderai in esame ti sentirai affaticato dall’enorme mole di problemi da risolvere e di nozioni da apprendere. Bisogna rimuovere dal nostro animo le cose inutili, affinché possano trovarvi posto nozioni così importanti e numerose. La virtù non può stare entro stretti confini: ciò che è grande richiede un ampio spazio. Bisogna scacciare dall’animo tutto ciò che non serve alla virtù e lasciare posto solo per lei. Obietterai: «Ma mi piace avere nozioni in molte discipline». Ricordiamo di esse solo quanto è necessario. Credi che sia da biasimare chi si circonda di oggetti superflui facendo sfoggio di suppellettili preziose e non chi ha la mente ingombra di inutili gingilli letterari? Voler conoscere più di quanto basta è una forma di intemperanza. E che dire di questa affannosa ricerca delle arti liberali, che rende gli uomini molesti, prolissi, inopportuni, compiaciuti di sé stessi, e dunque incapaci di apprendere il necessario perché si nutrono del superfluo? Il grammatico Didimo19 scrisse quattromila libri: proverei compassione per lui se avesse letto una tale quantità di cose inutili. In questi libri si indaga sulla patria di Omero, sulla vera madre di Enea, sulla questione se Anacreonte fosse dedito al sesso più che al vino, se Saffo fosse una prostituta, e altre simili questioni che se le conoscessi dovresti dimenticare. E ora dimmi che la vita non è lunga! Anche quando parleremo dei nostri stoici ti mostrerò che bisogna tagliar via molto con la scure. Quale perdita di tempo, quale fastidio arreca all’ascoltatore questo elogio: «Che uomo colto!». Accontentiamoci di questo titolo più semplice: «Che uomo onesto!». Non è così? Sfoglierò gli annali di tutti i popoli per scoprire chi è stato il primo a scrivere versi? Poiché non dispongo dei fasti calcolerò quanti anni intercorrano tra Orfeo e Omero? Esaminerò le note con cui Aristarco20 segnò i versi apocrifi e consumerò la vita dietro le sillabe? O mi fermerò a tracciare figure geometriche sulla polvere? Fino a tal punto ho dimenticato quel famoso e salutare precetto: «Risparmia il tempo»? Dovrei conoscere tutti questi argomenti? E cosa dovrei ignorare? Il grammatico Apione,21 che sotto il regno di Caligola girò per tutta la Grecia e fu accolto da tutte le città in nome di Omero, diceva che Omero, terminata la composizione di entrambi i poemi, l’Iliade e l’Odissea, vi aggiunse un proemio che abbracciava tutta la guerra di Troia. A prova della sua affermazione adduceva il fatto che il
Poeta nel primo verso dell’Iliade aveva inserito deliberatamente due lettere che indicavano il numero dei libri dei due poemi. Cose di questo genere bisogna conoscerle se si vuole sapere molto! Pensa quanto tempo ci portano via le malattie, quanto gli affari pubblici e privati, quanto le faccende quotidiane, quanto il sonno. Misura la tua vita: non può contenerle tante cose. Parlo degli studi liberali, ma anche i filosofi a quante questioni inutili e superflue non si dedicano! Anch’essi si sono abbassati a distinguere le sillabe e a studiare le proprietà delle congiunzioni e delle preposizioni, hanno avuto invidia dei grammatici e dei geometri: quanto c’era di inutile nelle loro discipline l’hanno trasferito nella propria, col risultato che parlano meglio di come vivono. Senti quanto sia dannosa e nemica della verità la sottigliezza eccessiva. Protagora22 dice che è possibile argomentare pro e contro su qualsivoglia questione, compresa quella che su ogni questione è possibile dire e contraddire. Secondo Nausifane23 ciò che sembra esistere è e al tempo stesso non è. Per Parmenide24 di tutto ciò che si vede non esiste che l’Uno. Da parte sua Zenone di Elea elimina ogni problema, sostenendo che nulla esiste. Più o meno della stessa opinione sono i pirroniani,25 i megarici,26 gli eretriaci27 e gli accademici,28 i quali hanno introdotto una nuova scienza, quella del non sapere niente. Getta dunque tutte queste dottrine nell’inutile massa degli studi liberali: quali mi insegnano una scienza che non mi servirà a nulla, quali mi tolgono ogni speranza di conoscenza. Conoscere cose inutili è meglio che niente, ma intanto gli uni non portano una luce che diriga lo sguardo verso la verità, gli altri mi cavano addirittura gli occhi. Se credo a Protagora, tutto in natura è incerto, se credo a Nausifane, una sola cosa è certa: che niente è certo, se credo a Parmenide, non esiste niente all’infuori dell’Uno, se credo a Zenone, non esiste nemmeno l’Uno. Dunque, noi che cosa siamo? Che cosa sono queste cose che ci circondano, che ci nutrono, che ci sostengono? Tutta la natura è un’ombra, ingannevole o vana. Non saprei dirti se ce l’ho più con quei filosofi che hanno voluto privarci di ogni conoscenza o con quelli che non ci hanno lasciato nemmeno la certezza di non avere alcuna conoscenza. Stammi bene.
1. Virgilio, Eneide I 432-433. 2. Lada era un atleta spartano, vincitore nella corsa a Olimpia. 3. Virgilio, Eneide VII 808-811: si tratta di Camilla, figlia del re dei Volsci e alleata di Turno. 4. Filosofo ateniese, discepolo di Platone. 5. Nipote di Platone. 6. Re di Persia, figlio di Ciro il Grande. 7. Scipione fu costretto all’esilio perché accusato di tramare una nuova guerra contro Annibale. 8. Lucrezio, De rerum natura III 1034. 9. Generale e politico romano (275-203 a.C.), detto il Temporeggiatore per la tattica usata con Annibale dopo la sconfitta subìta dai Romani al lago Trasimeno. 10. Orazio, Satire I 2, 27 e 4, 92.
11. Virgilio, Georgiche II 58. 12. Virgilio, Georgiche I 215-216. 13. Virgilio, Eneide VII 277-79: sono i cavalli regalati agli ambasciatori troiani dal re Latino. 14. Virgilio, Georgiche I 53-58: il Tmolo è un monte della Libia, i Sabei sono una popolazione dell’Arabia, i Calibi abitavano una terra di fronte al Mar Nero. 15. Filosofo stoico del II sec. a.C., maestro di Panezio. 16. Significa «niente», «non esistenza», ma anche «mancanza di beni». 17. Virgilio, Georgiche I 336-37. 18. Virgilio, Georgiche I 424-26. 19. Grammatico alessandrino. 20. Aristarco di Samotracia, autore di commenti e trattati su Omero e Esiodo. 21. Esponente della scuola Alessandrina. 22. Famoso sofista (481-411 a.C.) di cui è nota la frase: «L’uomo è la misura di tutte le cose». 23. Nausifane di Teo, seguace di Democrito. 24. Fondatore della scuola Eleatica. 25. Seguaci di Pirrone di Elide, fondatore dello scetticismo. 26. Filosofi della scuola di Euclide di Megara. 27. Seguaci della scuola di Menedemo di Eretria. 28. Filosofi della Media e Nuova Accademia, di indirizzo scettico.
Libro quattordicesimo 89. Tu dici che per chi aspira a diventare saggio sarebbe utile e necessario dividere la filosofia, cioè smembrare il suo corpo enorme, poiché alla conoscenza dell’insieme si giunge più facilmente attraverso le singole parti. Come appaiono al nostro sguardo tutti i corpi celesti, così potesse presentarsi alla nostra mente tutta la filosofia, offrendoci uno spettacolo molto simile a quello dell’universo! Certamente rapirebbe tutti gli uomini in ammirazione, inducendoci a trascurare ciò che ora riteniamo importante per ignoranza di ciò che è grande davvero. Ma poiché ciò non è possibile dobbiamo osservare la filosofia nello stesso modo in cui si scrutano i segreti dell’universo. L’animo del saggio ne abbraccia tutta la mole e la percorre con la stessa velocità con cui attraversa il cielo; ma noi, che dobbiamo squarciare la nebbia e abbiamo la vista limitata alle cose vicine, possiamo vederne più facilmente le singole parti, poiché ancora non possediamo una visione globale. Esaudirò dunque la tua richiesta e dividerò la filosofia in parti, ma non in frammenti, poiché non giova a pezzi, e d’altra parte abbracciare le cose molto piccole è difficile quanto quelle molto grandi. Il popolo lo si divide in tribù, l’esercito in centurie; tutto ciò che ha grandi dimensioni si riconosce più facilmente se viene distinto in parti, che, però, come ho già detto, non devono essere innumerevoli e troppo piccole. Una divisione eccessiva, infatti, ha lo stesso difetto della mancanza di divisione: un insieme di briciole somiglia a un ammasso confuso. Perciò, se sei d’accordo, ti spiegherò innanzitutto la differenza tra saggezza e filosofia. La saggezza è il bene perfetto della mente umana; la filosofia è amore e ricerca della saggezza, questa tende colà dove quella è arrivata. Perché la filosofia si chiami così è chiaro: la parola stessa dichiara quale sia l’oggetto del suo amore. Alcuni hanno definito la saggezza «scienza delle cose divine e umane», altri «conoscenza delle cose divine e umane e delle loro cause»: questa aggiunta mi sembra superflua, perché le cause delle cose divine e umane sono parte delle cose divine. Sono state date anche molte altre definizioni della filosofia: alcuni l’hanno definita ricerca della virtù, altri sforzo di correggere l’animo, altri ricerca di una retta ragione. Quasi tutti, però, sono d’accordo che c’è qualche differenza tra la filosofia e la saggezza, poiché l’oggetto e il soggetto di un desiderio non possono essere la medesima cosa. Come c’è una grande differenza tra l’avidità e il denaro, poiché l’avidità desidera e il denaro è desiderato, così anche la filosofia e la saggezza sono due cose diverse, perché la saggezza è conseguenza e premio della filosofia; quella viene, all’altra si va. La saggezza è ciò che i Greci chiamano sofiva. Anche i Romani usavano questo vocabolo, così come ora usano filosofia; lo testimoniano le antiche commedie togate e l’epigrafe scolpita sul sepolcro di Dossenno: Fermati, o forestiero, e leggi la sofìa di Dossenno.1
Alcuni dei nostri stoici, benché la filosofia sia ricerca di virtù e la virtù l’oggetto della ricerca, non ritengono che filosofia e virtù possano essere disgiunte, dal momento che la filosofia non può esistere senza la virtù, né la virtù senza la filosofia. La filosofia, infatti, è ricerca di virtù ma attraverso la virtù stessa, e la virtù non può esistere senza la ricerca di sé, né la ricerca della virtù senza la virtù. Quando si cerca di colpire un oggetto da lontano, da una parte c’è chi lancia, dall’altra il bersaglio; così pure le strade che conducono a una città sono fuori dalla città medesima: le vie che conducono alla virtù, invece, non sono fuori dalla virtù, alla quale dunque si giunge attraverso la virtù stessa, che è intimamente connessa con la filosofia. Stando alla maggioranza dei più grandi autori, le parti della filosofia sono tre: etica, fisica e logica. La prima regola l’anima, la seconda indaga la natura, la terza esamina la proprietà del linguaggio, la giusta disposizione delle parole e le argomentazioni, affinché il falso non si insinui al posto del vero. Altri, però, dividono la filosofia in un numero minore o maggiore di parti. Certi peripatetici vi aggiungono una quarta parte, la politica, che richiede una pratica sua propria e si occupa di una materia diversa. Altri vi aggiungono ancora un’altra parte che chiamano oikonomiké, la scienza di amministrare il patrimonio; alcuni infine vi distinguono anche una parte che tratta i vari modi di vivere. Ma tutti questi elementi sono riconducibili alla parte della filosofia che riguarda la morale. Per gli epicurei in un primo tempo le parti della filosofia erano due, la fisica e l’etica, poiché non vi includevano la logica. Poi, costretti dall’evidenza a chiarire le ambiguità e a individuare il falso nascosto sotto l’apparenza del vero, introdussero anch’essi una terza parte chiamata “del giudizio e della regola” – praticamente la logica con un nome diverso – ma considerandola come un’appendice della fisica. I cirenaici2 hanno eliminato la fisica e la logica accontentandosi della morale, ma poi anch’essi reintroducono sotto altra forma quel che hanno rimosso, dividendo la morale in cinque parti: la prima riguarda ciò che si deve evitare e ciò che si deve ricercare, la seconda le passioni, la terza le azioni, la quarta le cause, la quinta le argomentazioni. Ma le cause fanno parte della fisica, le argomentazioni della logica. Aristone di Chio affermò che la fisica e la logica sono non solo inutili, ma addirittura dannose, e limita anche la morale, unica superstite. Ha soppresso, infatti, quella parte che comprende i precetti, attribuendola al pedagogo, non al filosofo, come se il saggio fosse qualcosa di diverso dal pedagogo del genere umano. Ora, posto che la filosofia si compone di tre parti, cominciamo a esaminare la morale, che a sua volta si è ritenuto opportuno suddividere in tre parti, sicché la prima è l’indagine volta a stabilire ciò che dev’essere assegnato a ciascuno e a determinare il valore di ogni cosa (indagine utilissima, poiché nulla è più necessario che il determinare il valore delle cose), la seconda riguarda l’impulso, la terza le azioni. Innanzitutto, infatti, va giudicato il valore di ciascuna cosa, secondariamente deve nascere verso di essa un impulso ordinato e moderato, in terzo luogo occorre fare in modo che ci sia accordo fra l’impulso
e l’azione, così da essere in ogni momento coerenti con sé stessi. La mancanza di una sola di queste tre cose scombina l’intero ordine. A che serve, infatti, aver ponderato tutto se il tuo impulso è smodato? A che serve aver represso gli impulsi e controllato le passioni se agisci intempestivamente e non sai come, dove e quando si deve fare ciascuna cosa? Un conto è conoscere il grado e il valore delle cose, un altro i momenti in cui decidere, un altro ancora è frenare gli impulsi e accingersi ad agire senza precipitarsi. La vita è coerente con sé stessa quando l’azione è mossa da un impulso che sia in proporzione al valore dell’oggetto, e quindi è più debole o più forte in base a quanto l’oggetto meriti di essere ricercato. La fisica si divide in due parti: una riguarda le realtà corporee, l’altra quelle incorporee; ciascuna si articola, per così dire, in gradi. I corpi si dividono in quelli che generano e quelli che sono generati, e gli elementi sono generati. L’ambito degli elementi, poi, secondo alcuni è semplice, secondo altri si divide nella materia, nella causa, che muove tutto, e negli elementi veri e propri. Mi resta da suddividere la logica. Ogni discorso o è continuo o è spezzato fra domande e risposte; quest’ultima forma si è voluto chiamarla dialektiké, la prima retoriké, che si occupa delle parole, dei pensieri e della loro collocazione; la dialektiké si divide in due parti, parole e significati, cioè in concetti espressi e vocaboli a essi conformi. Entrambe hanno poi ulteriori e numerose suddivisioni. Perciò, mi fermo qui e per sommi capi toccherò le cose,3 perché a voler suddividere le parti in parti ne verrebbe fuori un libro di questioni. Non ti distolgo, mio ottimo Lucilio, dal leggere trattati su tali argomenti, purché tu riconduca subito alla morale tutte le tue letture. Frena la tua ostinazione, risveglia ciò che langue in te, rinvigorisci quel che è rilassato, doma ciò che si ribella, perseguita per quanto puoi le tue passioni e quelle degli altri; e a chi ti obietta «Fino a quando continuerai a ripetere sempre le stesse cose?» rispondi: «Sono io che dovrei dire: Fino a quando commetterete sempre gli stessi errori? Volete che i rimedi cessino prima dei mali? Io parlerò ancora di più, e insisterò proprio perché voi recalcitrate; una medicina comincia a giovare quando un corpo che aveva perso la sensibilità reagisce allo stimolo con dolore. Ascoltate anche controvoglia ciò che vi dirò. È bene che vi giunga pure qualche parola un po’ dura, e se non volete ascoltare la verità singolarmente, ascoltatela tutti insieme. Fin dove estenderete i confini dei vostri possedimenti? Un territorio che conteneva un popolo è troppo piccolo per un padrone solo? Fin dove spingerete i vostri aratri, se non vi basta neppure lo spazio di una provincia per delimitare i vostri poderi? Fiumi famosi che scorrono attraverso proprietà private e grandi corsi d’acqua, che segnano i confini di grandi popoli, vi appartengono dalla
sorgente alla foce. E questo è ancora poco, se con i vostri latifondi non avete circondato i mari, se il vostro amministratore non ha potere al di là dell’Adriatico, dello Ionio e dell’Egeo, se le isole, dimora di illustri condottieri, non sono annoverate fra le cose di poco conto. Abbiate possedimenti estesi quanto vi pare, sia una tenuta privata quello che una volta si chiamava impero, arraffate tutto ciò che potete finché gli altri possiedono più di voi. Ora mi rivolgo a voi, la cui dissolutezza si estende non meno dell’avidità di quegli altri, e vi dico: fino a quando non ci sarà lago su cui non si affaccino i tetti delle vostre ville, o fiume le cui rive non siano costellate dalle vostre case? Ovunque scaturiranno vene d’acqua calda, lì si innalzeranno nuove e lussuose dimore. Ovunque il litorale si incurverà a formare una baia, voi subito vi getterete le fondamenta, e, paghi solo del terreno che create artificialmente, con le vostre costruzioni vi addentrerete nel mare, costringendolo a retrocedere. I vostri palazzi risplendano pure ovunque, sia sulla cima dei monti con ampia vista sulla terra e sul mare, sia in pianura, alti come montagne, ma avrete costruito numerosi e smisurati palazzi, sarete sempre nient’altro che un corpo e piccolo per giunta. A che cosa servono molte camere da letto? Dormite in una sola: non è vostro il posto in cui non state. E ora passo a voi, la cui golosità insaziabile e senza fondo fruga i mari e le terre: con ami, con lacci, con vari tipi di reti vi sforzate di catturare ogni genere di animali, e a nessuno di essi date tregua fintantoché non ve ne è venuta la nausea. Ma di tutti questi banchetti, preparati col lavoro di tante persone, quanto potete gustare con la vostra bocca, stanca di tante prelibatezze? Di questa bestia catturata con tanto rischio quanto può assaggiare un signore che digerisce male e soffre di nausea? Di tante ostriche portate da lontano quante ne scivolano dentro questo stomaco insaziabile? Poveretti, non vi rendete conto che la vostra fame è più grande del vostro ventre?». Di’ queste cose agli altri, affinché tu stesso le ascolti mentre parli, scrivile, affinché tu stesso le legga mentre le scrivi, e riconduci tutto alla morale, placando il furore delle tue passioni. Cerca non di non sapere di più, ma di saper meglio. Stammi bene. 90. Nessuno, Lucilio mio, può dubitare che vivere sia un dono degli dèi immortali e vivere bene, invece, della filosofia, sicché dovremmo essere più debitori verso la filosofia che verso gli dèi in quanto una vita virtuosa è senza dubbio un beneficio maggiore della vita nuda e cruda. Sennonché sono stati gli dèi a darci la filosofia, non nel senso che ogni essere umano nasce filosofo, bensì nel senso che tutti abbiamo la possibilità di conseguirne la conoscenza. Se anche questa, infatti, fosse un bene comune e noi nascessimo saggi, la saggezza perderebbe la sua straordinaria caratteristica di non essere un bene fortuito, che dipende dal caso, mentre ciò che essa ha di prezioso e di stupefacente è proprio il fatto di essere non un dono della sorte ma una conquista personale, non un bene concessoci da altri. Cosa ci sarebbe da ammirare nella filosofia se ce ne fosse
elargita la conoscenza come un beneficio? Il suo unico compito è scoprire la verità sulle cose divine e umane: da essa non si allontanano mai la religione, il sentimento del dovere, la giustizia e il complesso di tutte le altre virtù strettamente connesse fra loro. Essa ci ha insegnato a venerare gli dèi, ad amare gli uomini, che l’autorità è nelle mani degli dèi e che gli uomini sono uniti in società. Ciò fu rispettato per un certo periodo di tempo, finché l’avidità non ruppe l’associazione e fece diventare poveri anche coloro che una volta aveva reso ricchissimi, e che, desiderando di possedere dei beni propri cessarono di possedere ogni cosa. Ma i primi uomini e i loro discendenti seguivano incorrotti la natura, assumevano un medesimo uomo come guida e come legge, affidandosi alle decisioni del migliore, poiché è proprio della natura sottoporre i più deboli ai più forti. A capo delle greggi stanno gli animali più grossi o più impetuosi: le mandrie di buoi sono precedute non da un toro debole ma da quello che per grossezza e per forza supera gli altri; il branco degli elefanti è guidato dal più alto, mentre fra gli uomini conta non il più forte, ma il migliore: il capo, infatti, veniva scelto in base alle sue qualità interiori, sicché i popoli più prosperi erano quelli in cui solo il migliore poteva essere il più potente, dal momento che può fare con sicurezza ciò che vuole solo chi ritiene di potere unicamente ciò che deve. Secondo Posidonio nell’età dell’oro il potere era nelle mani dei saggi, i quali reprimevano la violenza e difendevano i più deboli dai più forti, persuadevano e dissuadevano, indicavano ciò che era utile o no; la loro preveggenza faceva sì che al popolo non mancasse nulla, il loro coraggio teneva lontani i pericoli, la loro liberalità accresceva la ricchezza e il benessere dei sudditi. Comandare era un dovere, non una tirannide. Nessuno esercitava il suo potere contro chi glielo aveva dato, e nessuno, per natura o per qualche motivo, era portato a offendere in quanto i sudditi obbedivano con sollecitudine a chi comandava rettamente, e la minaccia più grave che il re potesse fare a coloro che disobbedivano era quella di rinunciare al potere. Quando, però, con l’insinuarsi dei vizi, i regni si trasformarono in tirannidi, cominciò a sentirsi la necessità delle leggi, le quali inizialmente furono elaborate dai saggi. Solone,4 che diede ad Atene le basi di una retta giustizia, fu uno dei sette famosi sapienti; Licurgo, 5 se fosse vissuto nella stessa epoca, sarebbe entrato in quella sacra schiera come ottavo. Si lodano codici di Zaleuco6 e di Caronda,7 i quali non nel Foro o negli atri degli avvocati ma nel ritiro sacro e silenzioso di Pitagora impararono le leggi che avrebbero dato alla Sicilia allora fiorente e, attraverso l’Italia meridionale, alla Grecia. Fin qui sono d’accordo con Posidonio, ma dissento da lui quando sostiene che le arti di cui ci si serve nella vita quotidiana siano state inventate dalla filosofia, alla quale dunque non mi sento di attribuire la gloria dei mestieri artigianali. «La filosofia», dice Posidonio, «insegnò a costruire case agli uomini che vivevano sparsi qua e là e che si riparavano in capanne, in grotte o nel tronco cavo di un albero». Io, però, non credo che la filosofia abbia escogitato
una fabbrica di abitazioni costruite su altre abitazioni e di città che sovrastano altre città, così come non ha ideato i vivai di pesci per evitare alla gola il rischio delle tempeste e per dare alla mollezza, quando il mare s’infuria, porti tranquilli in cui ingrassare diverse specie di pesci. Forse che la filosofia ha insegnato agli uomini a usare chiavi e serrature? Sarebbe stato un dare spago all’avidità. La filosofia avrebbe dunque sospeso in alto queste case che ci sovrastano con gran pericolo per chi vi abita? Non bastava proteggersi con ripari occasionali, trovarsi un qualche rifugio naturale che non richiedesse alcuna fatica e il ricorso a tecniche particolari? Credi a me: felice quell’epoca in cui non esistevano ancora architetti e decoratori! Si cominciò a tagliare il legname in forme regolari e a segare le travi con mano sicura, seguendo la linea segnata, quando si diffuse il lusso: prima, infatti, con cunei si spaccava il fissile legno.8 Gli uomini non costruivano abitazioni con apposite sale destinate ai banchetti, né trasportavano pini o abeti con lunghe file di carri che facevano tremare le strade, per farne soffitti carichi d’oro sospesi sulle loro teste. Puntelli su entrambi i lati sostenevano la capanna, rami secchi e fronde ammassate e disposte in pendenza consentivano il deflusso dell’acqua piovana, anche se abbondante. Così protetti si sentivano al sicuro: allora un tetto di paglia riparava uomini liberi, oggi sotto il marmo e l’oro abitano degli schiavi. Anche su un altro punto dissento da Posidonio, laddove egli sostiene che gli strumenti artigianali sono stati inventati dai filosofi: con lo stesso criterio si potrebbe dire che furono i saggi a inventare il modo di prender le fiere coi lacci e d’ingannarle col vischio, di circondare coi cani le grandi balze selvose.9 Tutte queste furono invenzioni della sagacia umana, non della saggezza dei filosofi. Non credo nemmeno che siano stati i saggi a scoprire le miniere di ferro e di rame quando l’incendio delle foreste riversò dalla terra bruciata le vene liquefatte di metalli che stavano in superficie: queste cose le trova chi se ne occupa. E neppure mi sembra tanto acuta come a Posidonio la questione se il martello sia entrato in uso prima delle tenaglie. Entrambi furono inventati da qualcuno d’ingegno brillante e sottile, non nobile ed elevato, e ciò vale per ogni altra cosa che va cercata col corpo chinato e tenendo lo sguardo fisso a terra. Il saggio ha sempre condotto una vita semplice e modesta. E perché non dovrebbe essere così quando anche oggi desidera essere quanto più possibile libero e indipendente? Suvvia, come puoi ammirare Diogene e Dedalo insieme? Quale dei due ti sembra saggio? L’inventore della sega o il filosofo che, avendo visto un fanciullo bere acqua nel cavo della mano, tirò fuori il bicchiere dalla bisaccia e dopo averlo rotto esclamò con tono di rimprovero: «Per quanto tempo ho
portato come uno stolto dei pesi inutili!», lui che dormiva rannicchiato in una botte? E fra quelli di oggi chi ritieni più saggio, uno che ha inventato il modo di spruzzare essenze a grandi altezze attraverso tubi nascosti, chi riempie i canali con un getto d’acqua improvviso o li prosciuga, chi congiunge i soffitti girevoli delle sale da pranzo in modo che le immagini si susseguano una dopo l’altra e il soffitto muti aspetto a ogni portata, oppure chi dimostra a sé e agli altri che la natura non ci ha imposto nulla di difficile e faticoso, che possiamo avere case senza ricorrere al marmista e al fabbro, che possiamo vestirci senza importare sete e avere il necessario per i nostri bisogni se ci accontentiamo di ciò che la terra ha posto in superficie? Se gli uomini vorranno dare ascolto a costui, capiranno quanto sia inutile per loro avere un cuoco o un soldato. Erano saggi o certamente simili ai saggi quegli uomini che curavano il proprio corpo in modo sbrigativo e superficiale. Il necessario costa poco, i piaceri, invece, comportano affanni e preoccupazioni. Non hai bisogno di artigiani: segui la natura, la quale non ha voluto che ci occupassimo di troppe cose, ci ha fornito lo stretto necessario per soddisfare i nostri bisogni. «Ma se si è nudi il freddo è insopportabile». E che? Le pelli delle fiere e degli altri animali non possono proteggerci abbondantemente dal freddo? Molti popoli non si coprono il corpo con la corteccia degli alberi? Non si intrecciano penne di uccelli per usarle come vestiti? Anche oggi la maggior parte degli Sciti non indossano pelli di volpi e di martore, che sono morbide al tatto e impenetrabili ai venti? E gli uomini non intrecciavano a mano un graticcio di vimini, lo spalmavano di fango e poi coprivano il tetto con paglia e rami trascorrendo tranquilli l’inverno mentre la pioggia scivolava giù lungo gli spioventi del tetto? «Però d’estate fa molto caldo e bisogna pur difendersi dai roventi raggi del sole creando un’ombra piuttosto fitta». E che? Col passare degli anni non si sono formati molti anfratti che, scavati dalla corrosione del tempo o da qualche altro accidente, hanno provocato delle caverne? Non si rifugiano sottoterra i popoli delle Sirti e quelli che per l’eccessivo calore del sole non hanno una difesa sufficiente contro il caldo se non la terra arida stessa? La natura, che ha concesso a tutti gli altri animali di vivere facilmente, non è stata ingiusta al punto da non permettere all’uomo di vivere senza tanti mestieri, non ci ha imposto niente di gravoso, niente da ricercare con fatica per salvaguardare la nostra vita. Già al momento della nascita abbiamo trovato tutto a portata di mano: siamo stati noi a renderci tutto difficile, perché le cose facili e semplici ci sono venute a noia. Le case, i vestiti, i rimedi per il corpo, il cibo e ciò che ora è diventato per noi causa di grande fatica erano a portata di mano, gratuiti, e si poteva procurarseli con poca fatica. Tutto, infatti, era commisurato al bisogno: noi abbiamo reso queste cose preziose e straordinarie ottenibili solo con molte e grandi arti. Ma la natura basta da sola a soddisfare i suoi bisogni. Il lusso si è allontanato dalla natura e si incita da sé stesso, quotidianamente, cresce di generazione in generazione e alimenta industriosamente i vizi. Dapprima ha cominciato a desiderare cose inutili, poi cose dannose, infine ha asservito l’anima al corpo,
ingiungendole di obbedire alle sue voglie. Tutte queste arti, che mettono in moto le città e le riempiono di rumori, fanno gl’interessi del corpo, al quale una volta si dava tutto come a uno schiavo, mentre ora glielo si offre come a un padrone. Perciò, ecco qui le botteghe dei tessitori, là quelle dei fabbri, gli odori dei profumieri e le scuole dei maestri di danze lascive e di canti languidi ed effeminati. È scomparso, infatti, quel naturale senso della misura che limitava i desideri al necessario, sicché ormai accontentarsi di quanto basta è da persone rozze e miserabili. Lucilio mio, è incredibile con quanta facilità la suggestione della parola allontani dalla verità persino i grandi uomini! Posidonio, uno di quelli che a mio giudizio hanno dato un grandissimo contributo alla filosofia, mentre prima cerca di descrivere come si ritorcano alcuni fili, come altri siano tratti da una sostanza morbida e sciolta, quindi come il telaio tenga teso e diritto l’ordito per mezzo di pesi attaccati e come con la spatola si uniscano e si stringano i fili inseriti per ammorbidire la durezza della trama che preme sui due lati, poi afferma che anche l’arte della tessitura è stata inventata dai saggi, dimenticando che in seguito fu trovato un sistema più ingegnoso, in cui stretta è la tela al subbio, il largo pettine va separando i fili con l’aiuto delle dita, la spola affusolata inserisce la trama, che, passando tra un filo e l’altro, è compressa da un colpo dato dai denti intagliati nel pettine.10 Che avrebbe detto se avesse potuto vedere i tessuti di oggi, con cui si confezionano vestiti trasparenti che non sono di alcun aiuto non dico al corpo ma nemmeno al pudore? Posidonio passa poi ai contadini, descrivendo con la stessa eloquenza il terreno solcato più volte dall’aratro affinché, ammorbiditosi, accolga più facilmente le radici, poi descrive lo spargimento delle sementi e l’asportazione manuale delle erbacce, utile a evitare che cresca casualmente qualche pianta selvatica che faccia morire il raccolto. Pure questa secondo lui è opera dei saggi, come se anche oggi i contadini non escogitassero moltissimi sistemi nuovi per aumentare la produttività. Poi, non bastandogli queste arti, infila il saggio anche nei mulini, narrando come cominciò a fare il pane seguendo l’esempio della natura. «Le due file di denti con la loro durezza spezzano», egli dice, «i cereali che mettiamo in bocca, e quanto sfugge viene nuovamente riportato ai denti dalla lingua, quindi il tutto si mescola con la saliva affinché passi più facilmente per la gola; quando poi arriva nello stomaco viene digerito col suo calore uniforme e infine assimilato dal corpo. Qualcuno», così continua, «seguendo questo esempio, pose due pietre ruvide una sull’altra, a somiglianza dei denti, delle quali quella sottostante stava ferma in attesa che l’altra si muovesse; poi con lo sfregamento delle due pietre sminuzzò i chicchi ripetendo l’operazione finché non si ridussero in polvere; a quel punto cosparse d’acqua la farina, e lavorandola a lungo la impastò, facendone il pane, che in un primo
tempo fece cuocere con cenere calda e un mattone rovente, poi nei forni successivamente inventati e con altri mezzi con cui si potesse regolare il calore». Mancava solo che Posidonio dicesse che anche il mestiere di calzolaio l’hanno inventato i saggi. È la ragione – non la retta ragione – che ha escogitato tutte queste cose. Sono invenzioni dell’uomo comune, non del saggio, così come le navi su cui attraversiamo fiumi e mari dopo aver sistemato le vele in modo da sfruttare la spinta dei venti e collocato a poppa il timone per seguire questa o quella rotta. L’esempio è stato preso dai pesci, che dirigono i loro movimenti con la coda e con un suo lieve moto, da una parte o dall’altra, cambiano velocemente direzione. «Tutte queste cose», dice Posidonio, «le ha inventate il saggio, ma, ritenendole troppo vili per occuparsene lui, le ha lasciate a persone meno nobili». Invece queste arti sono state scoperte proprio da coloro che oggi vi si dedicano. D’altra parte è noto che certe invenzioni risalgono a tempi recenti, come l’uso dei vetri che attraverso il loro materiale trasparente lasciano passare la luce in tutto il suo fulgore, come le volte dei bagni e i tubi infissi sui muri dai quali emana un calore diffuso che riscalda uniformemente le parti basse e quelle alte delle stanze. E che dire dei marmi di cui risplendono i templi e le case? E delle colonne di pietra rotonde e levigate che sostengono portici e palazzi capaci di accogliere una grande quantità di gente? E dei segni stenografici che consentono di trascrivere discorsi anche se rapidi e di seguire con la mano la velocità della lingua? Queste sono invenzioni degli schiavi più umili: la saggezza sta più in alto e insegna non alle mani, ma agli animi. Vuoi sapere cos’ha scoperto, che cosa ha prodotto? Non già i movimenti aggraziati del corpo o le varie melodie della tromba e del flauto, che trasformano in suono il fiato che passa ed esce dallo strumento. Non fabbrica armi, né mura o arnesi da guerra: favorisce la pace e invita il genere umano alla concordia. La saggezza, ripeto, non crea strumenti volti a soddisfare i bisogni materiali. Perché le assegni compiti di così poco conto? Hai di fronte l’artefice della vita, che ha il dominio sulle altre arti, perché ciò che abbellisce la vita ne ha la signoria: del resto la saggezza tende alla felicità, ce ne apre la via e ci porta a quella meta. Ci mostra i mali veri e quelli apparenti, libera le menti dalla vanità, dà una grandezza autentica, abbatte quella tronfia, fatta di vane apparenze, ci fa conoscere la differenza fra la magnanimità e la superbia, nonché la sua natura stessa e quella dell’universo. Ci rivela l’essenza e le qualità degli dèi, che cosa siano gli Inferi, i lari, i geni, le anime che sopravvivono sotto forma di divinità secondarie, dove dimorino, che cosa facciano, quali siano il loro potere e la loro volontà. Questa è la sua iniziazione, attraverso la quale ci dischiude non il sacrario di una città ma il vasto tempio di tutti gli dèi, il cielo stesso, di cui presenta all’esame della nostra mente le vere immagini e i veri aspetti: la vista, infatti, è troppo debole per spettacoli così grandiosi. Dopodiché risale ai princìpi delle cose, alla ragione eterna immanente nell’universo e alla forza di tutti i semi che dà una forma particolare a ciascuno dei vari esseri. Comincia quindi a indagare
sull’anima, sulla sua origine, sulla sua sede, sulla sua durata, sulle parti in cui essa è divisa, poi passa dagli esseri corporei a quelli incorporei, esamina la verità e le prove della verità, dopodiché mostra come si possano distinguere le ambiguità nella vita e nei discorsi, poiché vero e falso in entrambi sono confusi insieme. Posidonio dice che il saggio, dopo averle inventate, si allontanò da queste arti: secondo me, invece, non vi si accostò mai, poiché non avrebbe giudicato meritevole un’invenzione che non ritenesse degna di essere utilizzata per sempre; non avrebbe mai intrapreso un’opera da dover poi abbandonare. Egli ancora sostiene che «Anacarsi,11 inventò il tornio, che girando dà forma ai vasi». Ebbene, poiché Omero cita la ruota del vasaio,12 si è preferito ritenere falsi i suoi versi piuttosto che falso quanto afferma Posidonio. Io non discuto se sia stato davvero Anacarsi l’inventore di tale strumento, dico però che se lo fu lo inventò non in quanto saggio, visto che anche i saggi compiono molte azioni che hanno in comune con gli uomini. Supponiamo che un saggio sia velocissimo: supererà tutti nella corsa perché è veloce, non perché è saggio. Vorrei mostrare a Posidonio qualche vetraio, che soffiando dà al vetro moltissime forme, ottenibili a stento con una mano precisa. Queste invenzioni furono fatte quando di saggi non se ne trovarono più. Posidonio dice ancora: «Si afferma che Democrito abbia inventato l’arco, in cui la pietra centrale tiene ferme le altre che si inclinano via via». È falso, dico io, visto che prima di Democrito c’erano sicuramente ponti e porte, la cui sommità di solito s’incurva. Vi sfugge poi di dire che il medesimo Democrito inventò il modo di lavorare l’avorio e di trasformare una pietruzza in smeraldo facendola riscaldare, un sistema con cui tuttora si colorano le pietre adatte a questo scopo. Ebbene, scoperte del genere le avrà pure fatte un saggio, ma non le ha fatte, ripeto, in quanto saggio, dato che il saggio fa molte cose che vediamo fare ugualmente bene o anche con maggiore abilità e pratica da persone completamente ignoranti. Vuoi sapere quali siano le vere ricerche e le vere scoperte del saggio? Per prima cosa egli indaga la natura e la verità, non con occhi tardi che stentino a comprendere la realtà divina, come fanno gli altri esseri animati; poi la legge della vita, che regola secondo l’ordine universale, e insegna non solo a conoscere, ma anche a obbedire agli dèi e ad accogliere ogni accadimento come se fosse un comando. Vieta di seguire false credenze e stima esattamente il valore di ogni cosa; condanna i piaceri che portano con sé il pentimento, loda i beni che dànno sempre gioia, dimostra che l’uomo più felice è quello che non ha bisogno della felicità e il più potente quello che è padrone di sé stesso. Mi riferisco non a quella filosofia che ha posto il cittadino fuori dalla patria e gli dèi fuori dal mondo, e che ha subordinato la virtù al piacere, ma a quella che ritiene non esservi altro bene che l’onestà, che non si lascia sedurre né dai doni degli dèi né da quelli della sorte e il cui valore consiste nel non lasciarsi corrompere in alcun modo. Non credo che questa filosofia esistesse in quell’età rozza in cui non c’erano
ancora le arti ed era l’esperienza a insegnare ciò che poteva essere utile. Credo invece che sia venuta dopo i tempi fortunati in cui i beni della natura erano in comune e tutti potevano servirsene insieme, prima che l’avidità e la dissolutezza dividessero gli uomini facendoli passare dalla comunione dei beni alle ruberie. Non erano saggi quelli, anche se facevano ciò che devono fare i saggi. Nessuno potrebbe ammirare di più una diversa condizione del genere umano, e anche se dio concedesse a qualcuno di governare le cose terrene e dare i costumi ai popoli non potrebbe ritenere più giusta una condizione diversa da quella in cui nessun colono lavorava i campi, né si poteva segnare o dividere il terreno con linee di confine: comune era il raccolto e da sé stessa la terra offriva generosamente i suoi prodotti, senza che qualcuno li ricercasse.13 Come poteva esserci, dunque, una generazione di uomini più felice di quella? Tutti si servivano in comune dei prodotti della natura, la quale, come una madre, bastava al sostentamento di tutti, garantendo a ciascuno il diritto su una proprietà comune. E perché non dovrei definire ricchissimi quegli uomini tra i quali non avresti potuto trovare un solo povero? Ebbene, in tali meravigliose condizioni di vita irruppe l’avidità, che, sottraendo dei beni alla comunità e appropriandosene, finì col rendere estranea ogni cosa, e una ricchezza prima smisurata si ridusse quasi alla miseria. L’avidità introdusse la povertà e, desiderando troppo, perse ogni cosa. Ora è inutile che si sforzi di recuperare ciò che ha perduto, che aggiunga campi ai campi, scacciandone il vicino col denaro o con la violenza, che estenda le campagne alle dimensioni di intere provincie sì che la parola possesso significhi un lunghissimo giro attraverso le proprie terre: nessun ampliamento di confini potrà riportarci al punto da cui ci siamo allontanati. Facendo tutto il possibile potremo avere molto, ma prima avevamo tutto. La terra allora, anche senza essere lavorata, era più fertile e generosa verso le necessità degli uomini, che non avevano bisogno di accaparrarsene i frutti, anzi, era un piacere trovarli e mostrarli agli altri; non c’era alcuno che potesse avere troppo o troppo poco, perché tutto veniva diviso in pieno accordo. Ancora il più forte non aveva messo le mani addosso al più debole, né l’avaro aveva sottratto al prossimo lo stretto necessario, nascondendo il suo raccolto, che restava inutilizzato: ciascuno si curava di sé quanto degli altri. Non c’erano lotte armate fra gli uomini, le cui mani, non macchiate di sangue fraterno, scaricavano tutta la loro aggressività sulle fiere. Le notti passavano tranquille e senza ansia, che si vivesse in un folto bosco per proteggersi dal sole eccessivo o in un modesto riparo sotto le fronde per difendersi dal rigore dell’inverno o dalla violenza della pioggia. Oggi le preoccupazioni ci fanno rivoltare nei nostri letti di porpora e ci tormentano con acutissimi stimoli. Quali placidi sonni su quella terra dura! Non soffitti intagliati sulle loro teste, su cui invece, mentre giacevano all’aperto, scorrevano le stelle e, meraviglioso spettacolo notturno, l’universo si
muoveva rapido, compiendo in silenzio un’opera così grande. Sia di giorno che di notte si apriva loro la vista di questa splendida dimora, ed era una delizia contemplare in mezzo al cielo il tramonto delle stelle e il sorgere di altre dal buio pieno di mistero. Non era forse piacevole vagare fra tante meraviglie sparse in ogni dove? Ora, invece, ogni più piccolo rumore della casa ci fa trasalire e al minimo scricchiolio ce ne fuggiamo spaventati fra le nostre pareti decorate. Gli antichi non possedevano case grandi come una città: l’aria col suo soffio libero per gli spazi aperti, l’ombra leggera di una rupe o di un albero, fonti e ruscelli limpidi non ancora deturpati dalla mano dell’uomo con tubature o condotte forzate ma liberi anch’essi nel loro corso, prati belli senza artificio, e in mezzo a tutte queste cose una rustica dimora, ben rifinita da mani semplici: questa era la casa secondo natura, in cui era bello abitare, senza dover temere né da essa né per essa, mentre ora la casa costituisce gran parte delle nostre paure. Tuttavia, benché la loro vita fosse eccellente e immune da colpe, essi non furono saggi, poiché questa parola è indice di un’attività più elevata. Con ciò non nego che furono uomini di nobile sentire e, per così dire, appena usciti dalle mani degli dèi, poiché è indubbio che il mondo, quando ancora non era stanco, abbia prodotto esseri migliori. Ma se tutti avevano un carattere più forte e più adatto a sopportare le fatiche, non tutti avevano un’intelligenza perfetta. La natura, infatti, non dà la virtù: diventare virtuosi è un’arte. Quelli non cercavano oro, argento o pietre preziose nelle viscere della terra, e risparmiavano anche gli animali: erano così lontani dal ritenere che si potesse uccidere un uomo, non per ira o per paura, ma solo per il gusto di vederlo morire. Non usavano ancora vestiti ricamati, non tessevano l’oro, anzi non lo estraevano neppure. Si dirà che erano innocenti perché ignoranti: ma c’è grande differenza fra il non volere il male e il non saperlo fare. Ignoravano cosa fossero giustizia, prudenza, fortezza e temperanza, anche se quella vita primitiva aveva qualcosa di simile a tali virtù, ma solo un animo educato, istruito e giunto alla perfezione con un esercizio costante può raggiungere e conoscere la virtù. Tutti sin dalla nascita siamo avviati a questa perfezione, ma anche nei migliori, finché non la possiedono e prima che vengano istruiti, c’è la materia della virtù, non la virtù. Stammi bene. 91. Il nostro Liberale14 è triste perché ha saputo dell’incendio che ha distrutto la colonia di Lione;15 una disgrazia che commuoverebbe chiunque, ma che tanto più colpisce un diretto interessato che ama molto la sua patria. Un tale evento ha fatto venir meno in lui quella fermezza d’animo che aveva esercitato per quelle disgrazie che gli sembravano temibili. Né mi meraviglio che non avesse temuto un disastro così imprevedibile e quasi inaudito, poiché non aveva precedenti: gli incendi hanno devastato molte città, ma non ne hanno mai cancellata alcuna. Infatti, anche quando il fuoco viene appiccato dai nemici è possibile spegnerlo in molti luoghi, e pur se attizzato più volte raramente accade che divori tutto al punto da far cessare l’uso delle armi. Anche il terremoto fu di rado così grave e rovinoso da annientare intere città. E poi un incendio non
divampò mai così violento da non lasciare nulla per un altro incendio. In una sola notte sono bruciati tanti bellissimi edifici, ciascuno dei quali avrebbe potuto dar lustro a una città, e in un periodo di pace così totale è accaduto ciò che neppure in guerra si potrebbe temere. Chi lo crederebbe? Mentre le armi tacciono dovunque e regna la tranquillità su tutta la terra si cerca invano Lione, vanto della Gallia. A tutte le vittime di una calamità la sorte ha sempre concesso di prevedere i loro guai futuri, poiché tutto ciò che è grande non va in rovina tutto in un colpo, mentre in questo caso è intercorsa una sola notte fra l’esistenza di una città grandissima e la sua totale distruzione. Insomma, la scomparsa di Lione è avvenuta in un tempo più breve di quello necessario per raccontarla. Ora tutti questi eventi abbattono l’animo del nostro Liberale, che pure è sempre stato saldo e forte di fronte alle sue sventure. Ma il suo turbamento non è senza ragione, poiché gli imprevisti risultano sempre più gravosi: la novità aumenta il peso delle sventure e chiunque sia colto di sorpresa soffre di più. Ecco perché dobbiamo fare in modo che per noi non ci sia nulla di imprevisto: dobbiamo preparare l’animo a tutti gli eventi e pensare non a ciò che accade di solito, ma a ciò che può accadere. Non c’è infatti cosa che la sorte, se vuole, non possa togliere a chi si trova al massimo della prosperità, o che non assalga e abbatta con tanto maggiore violenza quanto più è splendida e appariscente. Nulla è arduo o difficile per lei, che ci colpisce in modi sempre diversi, ora volgendoci contro le nostre mani stesse, ora creandoci, paga delle sue forze, dei pericoli che non vengono da fuori. Non v’è circostanza che faccia eccezione: persino in mezzo ai piaceri nascono motivi di dolore. La guerra scoppia in piena pace e ciò che prima ci dava sicurezza ora è motivo di paura, sicché l’amico diventa un nemico, l’alleato un avversario. Dalla calma estiva si passa improvvisamente alle tempeste, più violente di quelle invernali, i mali che subiamo senza nemici sono uguali a quelli che ci vengono dai nemici e, se ne mancano altri, a trovarli ci pensa l’eccessiva prosperità. La malattia colpisce gli uomini più temperanti, la tisi i più robusti, la punizione i più innocenti, i tumulti i più solitari; il caso sceglie qualche nuovo sistema per far sentire la sua forza a chi se n’è dimenticato. Basta un solo giorno a disperdere e a distruggere ciò che una lunga serie di anni ha costruito con molte fatiche e col favore degli dèi. Dire un giorno significa assegnare un tempo troppo lungo ai mali che ci incalzano: basta un’ora, un attimo per rovesciare un impero. Potremmo trarre un po’ di conforto per la nostra debolezza e la fragilità dei nostri beni se le cose andassero in rovina con la stessa lentezza con cui si producono, invece gli accrescimenti avvengono lentamente, la rovina è precipitosa. Non c’è alcunché di stabile né nella vita individuale né in quella collettiva; il destino degli uomini e delle città segue il suo corso. Nella tranquillità più completa nasce il terrore, e i mali esplodono là dove erano del tutto inattesi, senza alcuna causa apparente. I regni che avevano resistito alle lotte civili e alle guerre esterne crollano senza aver ricevuto alcuna spinta: quanto sono poche le città che hanno mantenuto la prosperità! Bisogna dunque pensare a ogni eventualità e rafforzare l’animo
contro tutto ciò che può accadere. Pensa all’esilio, alle sofferenze, alle guerre, ai naufragi. Un accidente può strappare te alla patria o la patria a te, può cacciarti in un deserto, e tale potrebbe diventare anche un luogo in cui la folla si ammassa fino a soffocare. Mettiamoci davanti agli occhi ogni aspetto del destino umano: immaginiamo non quanto accade spesso, ma quanto può accadere nelle diverse forme, se non vogliamo farci schiacciare e rimanere storditi di fronte a eventi insoliti come se fossero straordinari; la fortuna va pensata nell’insieme, non in questo o quel caso particolare. Quante volte città dell’Asia e della Grecia sono crollate per una sola scossa di terremoto! Quante città in Siria, quante in Macedonia sono state ingoiate dalla terra! Quante volte Cipro è stata devastata da calamità di questo genere! Quante volte Pafo16 è crollata su sé stessa! Spesso ci viene annunciata la sparizione di intere città, e noi, che frequentemente riceviamo notizie di tali disgrazie, quale piccola parte siamo di tutto l’insieme! Leviamoci, dunque, contro i casi fortuiti ma con la consapevolezza che qualunque cosa accada non è poi così grave come si va dicendo. È bruciata una città ricca, ch’era il gioiello delle provincie di cui faceva parte, occupando un posto di particolare rilievo, costruita però su un solo colle e per di più non molto grande. Ebbene, di tutte queste città, di cui ora senti celebrare lo splendore e la fama, il tempo cancellerà anche le tracce: non vedi, infatti, che in Grecia sono ormai corrose le fondamenta di città famosissime e non resta un minimo segno da cui risulti almeno che sono esistite? Non va in rovina solo ciò che è stato costruito dalle nostre mani, il tempo non distrugge soltanto le opere erette dall’arte e dall’attività dell’uomo: le catene dei monti si abbassano, intere regioni sprofondano, paesi che erano lontani dalla vista del mare vengono sommersi dalle onde; il fuoco con la sua furia devastatrice ha consumato i colli sui quali risplendeva e abbassato cime una volta altissime, conforto ai naviganti e punti di vedetta. Persino le opere della natura vengono devastate. Sopportiamo dunque con animo sereno la rovina delle città. Stanno in piedi destinate a cadere: questa è la fine che le attende tutte, sia che la forza interna dei venti e il loro violento soffiare entro luoghi chiusi scuota le pesanti mura che li schiaccia, sia che l’impeto dei torrenti, che è più forte nel sottosuolo, abbatta ogni resistenza, sia che la violenza delle fiamme spacchi la massa compatta del terreno, sia che la vecchiaia, da cui niente si salva, le distrugga a poco a poco, sia che l’insalubrità del clima ne scacci gli abitanti e la muffa guasti quei luoghi deserti. Sarebbe lungo elencare tutte le vie del destino: io so solo che ogni opera dei mortali è mortale, che viviamo in mezzo a cose destinate a finire. Queste e altre simili parole di conforto rivolgo dunque al nostro Liberale, che arde di un amore straordinario per la sua patria, la quale forse è stata distrutta per risorgere più bella. Spesso una sventura apre la strada a un destino migliore: molte opere cadono per poter risorgere più splendide di prima. Timagene,17 che mal tollerava la fortuna di Roma, diceva che gli incendi della città lo addoloravano solo perché sapeva che i suoi edifici sarebbero risorti più grandiosi di quelli ch’erano bruciati. È probabile che anche sulle rovine di Lione
tutti faranno a gara per ricostruire edifici più grandi e maestosi di quelli che sono andati perduti. Voglia il cielo che durino a lungo e siano eretti con auspici migliori per una durata maggiore, visto che dalla fondazione di questa colonia sono passati cento anni, che non costituiscono il limite massimo nemmeno per la vita di un uomo. Fondata da Planco,18 divenne così popolosa per la sua posizione favorevole, ma quante terribili sventure ha subìto nell’arco di una vita umana! Educhiamo quindi il nostro animo affinché comprenda e sopporti la propria sorte, sapendo che non c’è nulla che non osi la fortuna, la quale ha gli stessi diritti su chi governa e su chi è governato, lo stesso potere sulle città e sugli uomini. Non indigniamoci per simili eventi: queste sono le leggi che vigono nel mondo in cui viviamo, se sei d’accordo, accettale, se non sei d’accordo vattene per la via che preferisci. Sdegnati pure, se personalmente hai ricevuto una qualche ingiustizia, ma di fronte a una necessità che ci lega tutti quanti, dai più grandi ai più umili, riconciliati col destino, che forza ogni cosa. Non giudicare gli uomini dalle tombe e dai monumenti vari che adornano la strada: la cenere rende tutti uguali. Nasciamo diversi, moriamo uguali. Ciò che dico dei cittadini vale anche per le città: Ardea 19 fu espugnata al pari di Roma. L’autore delle leggi che governano gli uomini distingue ciascuno di noi solo per nascita e per la notorietà conseguita nel corso della nostra vita, ma quando siamo giunti alla fine che attende tutti i mortali, dice: «Vattene, o ambizione: la legge sia uguale per tutti gli esseri che vivono su questa terra». Siamo uguali di fronte alla sofferenza; ciascuno è parimenti debole e incerto come gli altri del proprio domani. Alessandro Magno, re dei Macedoni, si mise a studiare la geometria per sapere, sventurato, quanto fosse piccola la terra di cui aveva occupato solo una minima parte. Ho detto sventurato perché avrebbe dovuto capire che portava un soprannome sbagliato, visto che nessuno può essere grande in uno spazio piccolissimo. Gli insegnamenti che gli venivano impartiti erano sottili e richiedevano una diligente attenzione per essere imparati: non poteva comprenderli un pazzo che spingeva i suoi propositi al di là dell’oceano. «Insegnami cose facili», disse al precettore, e questi gli rispose: «Sono le stesse per tutti, ugualmente difficili». Immagina che la natura ti dica: «Questi mali di cui ti lamenti sono uguali per tutti; non posso darne a nessuno di più tollerabili, ma tali potrà renderseli chiunque lo vorrà». In che modo? Con l’imperturbabilità. E dovrai soffrire, patire la sete e la fame, invecchiare (se ti toccherà di restare più a lungo fra gli uomini), ammalarti, consumarti e morire. Tuttavia non c’è ragione che tu creda ai lamenti di quelli che ti stanno intorno, poiché nessuna di tali cose è un male, nessuna è insopportabile o penosa. Fanno paura perché così dicono tutti. Tu temi la morte, come le donne, ma non c’è più stolto di uno stolto che teme le parole. Argutamente il nostro Demetrio suole dire che le parole degli ignoranti vanno tenute nello stesso conto dei rumori del ventre. «Che differenza fa», sostiene, «se risuonano dall’alto o dal basso?». Quale follia è temere di essere screditati da gente screditata! E come è immotivata la tua paura dell’opinione pubblica, così lo sono anche i timori che non avresti se l’opinione
pubblica non te li avesse insinuati. Subirebbe forse un danno un uomo onesto coperto di calunnie? Dunque non può danneggiarci nemmeno quel che si dice della morte, solo perché la morte ha una pessima fama. Nessuno di coloro che la accusano l’ha sperimentata: è da temerari condannare ciò che non si conosce. Ma tu sai a quanti essa sia utile, quanti liberi dalle sofferenze, dalla povertà, dai lamenti, dalle pene, dalla noia. Se teniamo in pugno la morte, nessuno avrà potere su di noi. Stammi bene. 92. Credo che tu convenga con me che i beni materiali li ricerchiamo per il corpo, che il corpo lo curiamo nell’interesse dell’anima, che nell’anima ci sono parti intermediarie, assegnateci per l’elemento principale, per mezzo delle quali ci muoviamo e ci nutriamo. Nell’elemento principale ci sono una parte irrazionale e una razionale, di cui la prima è al servizio della seconda, la quale è l’unica a non essere subordinata ad altro, ma a subordinare tutto a sé. Anche la ragione divina è preposta a tutto e non dipende da alcuno; così è pure la nostra ragione, che da quella deriva. Se siamo d’accordo su questo punto lo saremo anche sul fatto che la felicità consiste unicamente nell’avere una ragione perfetta, la quale è la sola a non scoraggiarsi, a rimanere salda contro la fortuna e a mantenere la padronanza di sé in qualunque situazione. Ed è anche l’unico bene che non si spezza mai. Per me è felice colui che non può essere indebolito da nulla, che occupa la vetta e si appoggia solo a sé stesso: chi si regge con l’aiuto altrui può cadere, e se noi ricorriamo ad altri per sostenerci finiranno con l’avere grande potere su di noi le cose che non sono nostre. Ma chi vuole dipendere dalla fortuna, o chi, se è saggio, ammira sé stesso per beni che non sono suoi? Che cos’è la felicità? Sicurezza e tranquillità durature, che ci saranno date dalla grandezza d’animo e dalla continuità nei buoni propositi. Come ci si arriva? Avendo una piena visione della verità nella sua interezza, mantenendo in ogni azione l’ordine, la misura, la convenienza, una volontà che fa il bene, non il male, che non perde mai di vista la ragione e non se ne allontana, degna di essere amata e ammirata. Infine, per dirla in breve, l’animo del saggio dev’essere degno di dio. Che altro può desiderare chi ha tutte le virtù? Se infatti i vizi potessero contribuire al raggiungimento della felicità, questa consisterebbe anche in essi, senza i quali non potrebbe esistere. E cosa c’è di più vergognoso e di più stolto che legare all’irrazionale il bene di un’anima razionale? Tuttavia alcuni filosofi ritengono che il sommo bene si accresca, perché non è perfetto quando la sorte è avversa. Anche Antipatro, 20 uno dei grandi esponenti della nostra scuola, attribuisce una certa importanza alle cose esterne, ma molto piccola. Pensa quanto sarebbe assurdo non accontentarsi della luce del giorno e accendere una fiammella in più: che valore può avere una scintilla di fronte allo splendore del sole? Se non ti accontenti della sola virtù è inevitabile che tu voglia aggiungervi la quiete, che i Greci chiamano aoclesìa, o il piacere. La quiete si può accettare comunque, poiché l’animo privo di affanni è libero di
contemplare l’universo e la natura, il piacere è il bene tipico delle bestie: così si aggiunge l’irrazionale al razionale, l’immorale al morale, il piccolo al grande. L’eccitazione dei sensi rende felice la vita? Perché, allora, non dire che l’uomo sta bene se sta bene il palato? E tu annoveri non dico fra gli uomini di valore ma fra gli uomini comuni quest’individuo per il quale il sommo bene consiste nei sapori, nei colori e nei suoni? Esca costui dalla bellissima categoria di esseri viventi, che è seconda solo agli dèi, e si aggreghi alle bestie, visto che si accontenta solo di mangiare. La parte irrazionale dell’anima a sua volta si divide in due: una audace, ambiziosa, sfrenata, immersa nelle passioni, l’altra timida, vile, fiacca, dedita ai piaceri: la prima, sfrenata e tuttavia migliore, certo più forte e più degna di un uomo, viene trascurata, la seconda, senza vigore e spregevole, è ritenuta necessaria alla felicità. Hanno asservito a questa la ragione e svilito e reso spregevole il sommo bene dell’essere più nobile, facendone una mescolanza mostruosa di membra diverse che male si accordano fra loro. Così dice di Scilla il nostro Virgilio: Ha volto umano; vergine dal bel seno sino al pube, mostra di sotto il corpo smisurato d’una pistrice, code di delfini inframmischiate con ventri di lupi.21 A questa Scilla, però, stanno attaccati animali selvaggi, orribili e veloci, ma la saggezza con che razza di mostri l’hanno messa insieme? La dote principale dell’uomo è la virtù, alla quale si unisce la carne inutile e caduca, capace solo di ricevere il cibo, come dice Posidonio. Così quella virtù, che è di origine divina, finisce in qualcosa di instabile e alle sue parti elevate, celesti e degne di venerazione, si aggiunge un animale inerte e putrescente. Quanto alla sua seconda parte, cioè la serenità, essa, di per sé, non assicura niente all’anima, rimuove solo gli ostacoli, mentre il piacere, da parte sua, distrugge e fiacca ogni forza. Si può mai trovare un’unione di corpi così discordi fra loro? A un elemento fortissimo se ne aggiunge uno decisamente inerte, a uno severissimo uno poco serio, a uno virtuosissimo uno intemperante sino all’empietà. «Ma come?», si obietterà. «Se la salute, la serenità, l’assenza di dolore non sono di ostacolo alla virtù non cercherai di ottenerle?». Certamente, non però in quanto beni, ma perché sono secondo natura e perché io le sceglierò con criterio. Cosa avranno, allora, di buono? Solo il fatto di essere scelte opportunamente. Quando indosso un vestito adatto, quando cammino come si conviene o mangio come si deve, il bene consiste non nel vestito, nel modo di camminare o di mangiare ma nella mia intenzione di mantenere in ogni circostanza un comportamento conforme alla ragione. Aggiungerò che l’uomo deve scegliere un abito pulito, perché egli è per natura un essere pulito ed elegante. Analogamente il bene non è un abito pulito, è la scelta di un abito pulito, perché il bene consiste non nella cosa in sé ma nel tipo di scelta: come dire che l’onestà risiede non nell’oggetto delle nostre azioni ma nelle azioni stesse. Ciò che ho detto del
vestito trasferiscilo al corpo, visto che la natura lo ha messo intorno all’anima proprio come un vestito: è il suo mantello. Ebbene, chi mai giudica i vestiti in base all’armadio che li contiene? Il fodero di una spada non rende l’arma né buona né cattiva. Dunque anche per il corpo ti darò la medesima risposta: se mi sarà consentito, sceglierò la salute e il vigore fisico, ma il bene consisterà non in queste due prerogative, bensì nel giudizio che ne ho. «D’accordo», dicono, «il saggio è felice, ma raggiunge il sommo bene solo se lo aiutano i mezzi naturali. Analogamente non può essere infelice chi possiede la virtù, ma non è veramente felice chi ha perso la salute o il vigore fisico, che sono dei beni naturali». Tu ammetti ciò che sembra più incredibile, cioè che un uomo possa non essere infelice in mezzo a dolori gravissimi e continui, anzi, che sia addirittura felice, mentre neghi la cosa più semplice, che egli, cioè, sia veramente felice. Eppure, se la virtù può far sì che uno non sia infelice, più facilmente potrà renderlo molto felice, visto che tra un uomo felice e uno molto felice c’è una distanza minore che tra un uomo infelice e uno felice. O forse ciò che riesce a strappare un uomo alle disgrazie rendendolo felice non può aggiungere un tassello mancante a quella felicità rendendolo molto felice? Ti pare che possa venir meno proprio al culmine della salita? Nella vita ci sono beni e mali, entrambi fuori di noi. Se l’uomo virtuoso, per quanto oppresso da ogni male, non è infelice, come può non essere molto felice anche se gli manca qualche bene? Se il peso dei mali non riesce ad abbatterlo sino a renderlo infelice, la mancanza di beni non può strapparlo dalla sua condizione di uomo perfettamente felice, ma egli è felicissimo senza beni quanto non è infelice sotto il peso dei mali, diversamente il suo bene se può essere diminuito può anche essergli tolto. Poco fa ho detto che una fiammella non aggiunge nulla alla luce del sole, poiché il suo splendore nasconde qualunque altra luce che brilli per conto suo. Si dirà che ci sono corpi che ostacolano anche il sole. Ma tali ostacoli non intaccano la sua integrità, e anche se noi non lo vediamo egli continua a splendere e a proseguire il suo corso: quando brilla fra le nubi non è né più lento né più debole di quando c’è il sereno, poiché c’è una grande differenza se ha solo un ostacolo davanti a sé o un vero e proprio impedimento. Analogamente ciò che si oppone alla virtù non le sottrae nulla, non la rende più debole, la fa splendere di meno, forse non la vediamo neppure o non brilla allo stesso modo, ma resta identica a sé stessa e, pur senza mostrarsi, esercita la sua forza, come il sole quando è coperto. Così le sventure, i danni e le offese hanno sulla virtù lo stesso potere che una nube ha sul sole. Alcuni, poi, sostengono che il saggio malato di corpo se non è infelice non è neppure felice. Anche qui si commette un errore, poiché si equiparano i beni fortuiti alle virtù e si mettono sullo stesso piano l’onesto e il disonesto, e non c’è nulla di più ignobile e di più indegno che paragonare cose rispettabilissime con cose spregevoli. Rispettabili, infatti, sono la giustizia, la pietà, la lealtà, la fortezza, la prudenza, mentre quei beni che il più delle volte toccano in abbondanza agli uomini più infimi, come gambe robuste, muscoli e denti sani e
forti, non hanno alcun valore. Inoltre, se invece di giudicare felice o infelice il saggio afflitto da sofferenze fisiche lo collochiamo in una posizione di mezzo, allora anche la sua vita non dovrà essere né desiderata né evitata. Ma è assurdo pensare che la vita del saggio non sia desiderabile, come non è credibile che esista un tipo di vita da non desiderare e al tempo stesso da non evitare. Per non dire che i difetti fisici se non rendono necessariamente infelici non escludono la possibilità di essere felici: se una condizione non può essere peggiorata niente può impedirle di diventare addirittura ottima. Si può obiettare che come tra il freddo e il caldo c’è il tiepido, così tra il felice e l’infelice c’è chi non è né felice né infelice. Il paragone non è appropriato e te lo dimostrerò con un esempio. Se io aggiungo più liquido freddo a un liquido tiepido, questo diventa freddo, se gliene aggiungo una quantità maggiore di caldo, diventa caldo. Ma se vado aggiungendo altre disgrazie a chi non è né felice né infelice, non necessariamente egli diventa infelice. Se ai mali di uno che non è né felice né infelice aggiungo la cecità, non per questo egli diventa infelice; gli aggiungo anche la debolezza: resta come prima; dolori gravi e continui: nemmeno così diventa infelice. Se dunque tanti mali non riescono a condurlo all’infelicità, essi non possono nemmeno precludergli la felicità. Se il saggio, che è felice, non può diventare infelice, non può neppure essere privato della felicità. Uno che comincia a scivolare perché a un certo punto dovrebbe fermarsi? Ciò che non lo lascia precipitare sino in fondo lo trattiene in cima. E perché la felicità dovrebbe poter essere distrutta quando non può neppure essere diminuita? È per questo che a raggiungerla basta la sola virtù. «Ma come?», si obietterà. «Il saggio che è vissuto più a lungo, che non è stato distratto da alcun dolore, non è più felice di quello che ha dovuto lottare sempre contro la cattiva sorte?». Dimmi un po’: è forse migliore e più virtuoso? Se così non è, non è nemmeno più felice. Per essere più felice dovrebbe vivere più rettamente, ma come non può vivere più rettamente, in quanto appunto è saggio, così non può neppure essere più felice, quando la sua felicità è piena e totale. La virtù, infatti, non si accresce, dunque non cresce nemmeno la felicità, che nasce dalla virtù, la quale è un bene così grande che non avverte certi dettagli insignificanti, come la brevità del tempo, il dolore e le varie malattie, visto che il piacere non è degno di essere preso in considerazione. Una delle prerogative della virtù è non aver bisogno del futuro e non fare il conto dei giorni che passano: in un tempo brevissimo essa raggiunge la pienezza dei beni eterni. Ciò ci sembra incredibile e superiore alla natura umana, perché noi misuriamo la grandezza della virtù in base alla nostra debolezza e diamo ai nostri vizi il nome di virtù. E che, dunque? Non sembra egualmente incredibile che un uomo dica di essere felice anche fra i tormenti più atroci? Eppure questa affermazione è uscita proprio dalla scuola del piacere. Epicuro, benché tormentato da difficoltà urinarie e dal dolore di un’ulcera inguaribile al ventre, esclamò: «Sono felicissimo anche in questo mio ultimo giorno». Ora, perché un simile atteggiamento dovrebbe sembrare impossibile in chi pratica la virtù, se lo
si trova anche in coloro che, come Epicuro, obbediscono al piacere? Anche questa gente degenere e vilissima d’animo sostiene che pur in mezzo alle sofferenze più gravi e alle più terribili disgrazie il saggio se non è felice non è nemmeno infelice. Ebbene, anche qui siamo nell’assurdo, anzi, ancora di più, poiché non vedo come la virtù, cacciata dal suo grado più alto, non precipiti in fondo. O deve assicurare all’uomo la felicità, o, se le viene tolta questa facoltà, non gl’impedirà di diventare infelice. Finché sta in campo non può ritirarsi: o vince, o perde. «La virtù e la felicità», dicono, «toccano solo agli dèi immortali, mentre a noi di tali beni non arriva che un’ombra, ci avviciniamo a essi ma non li raggiungiamo». In verità gli dèi e gli uomini hanno in comune la ragione, che nei primi è perfetta, in noi può diventarlo. Ma i nostri vizi ci portano a disperare, perché chi è instabile e incerto nella sua capacità di ragionare e di giudicare si trova svantaggiato rispetto a chi invece è fermo e deciso nel mantenere i suoi buoni propositi. Per quanto egli desideri di possedere una vista e un udito perfetti, buona salute, un bell’aspetto e una vita lunga e fisicamente integra, così potrà vivere senza rimorsi e pentimenti, ma in quest’uomo imperfetto c’è una certa dose di malizia, poiché il suo animo è incline al male, anche se non si tratta di una malizia profondamente radicata e costante, non è ancora un uomo virtuoso ma si sforza di esserlo, però chi manca di qualcosa per essere buono è come se fosse cattivo. Ma colui che ha coraggio e vigore nel suo petto22 eguaglia gli dèi e, memore della sua origine divina, tende verso di loro, perché tutti, giustamente, si sforzano di risalire là da dove sono discesi. E perché non dovresti credere che vi sia qualcosa di divino in chi è parte di dio? Tutto ciò che circonda è dio, e noi siamo le sue membra e i suoi consoci. La nostra anima è in grado di raggiungerlo, se i vizi non la trascinano in basso. Come il nostro corpo ha una posizione eretta e guarda al cielo, così l’anima, che può protendersi a suo piacimento, ha per natura la prerogativa di volere le stesse cose che vogliono gli dèi; e se usa le sue forze e procede nel suo ambito tende alla vetta per la via che le è propria. Salire al cielo sarebbe stata una grande fatica, ma lei vi ritorna. Una volta che abbia trovato la strada, avanza coraggiosamente, disprezzando tutto, e non bada al denaro, all’oro e all’argento, degni dell’oscurità in cui si trovavano, li giudica non dal loro splendore, che abbaglia gli occhi degli ignoranti, ma dall’antico fango da cui la nostra cupidigia li ha separati ed estratti. L’anima, voglio dire, sa bene che le vere ricchezze si trovano in un luogo diverso da quello in cui vengono ammucchiate, sa che si deve riempire lo spirito, non il forziere. Si può darle il dominio dell’universo, il possesso della natura, sì che l’oriente e l’occidente siano i confini delle sue proprietà e, come gli dèi, sia padrona dell’universo e guardi dall’alto i ricchi, le cui ricchezze non lo fanno tanto contento quanto invece lo rendono triste quelle
degli altri. Giunta a una tale altezza, l’anima non ama il corpo, se ne cura come di un peso necessario, ma non vi si sottomette, poiché gliene è stato dato il dominio. Chi è schiavo del corpo non è libero; per non contare gli altri suoi padroni che l’eccessiva preoccupazione per lui ci procura, il potere del corpo è capriccioso ed esigente. L’anima del saggio ora esce dal corpo serenamente, ora ne balza fuori con coraggio, né si chiede quale fine faranno i suoi resti mortali, ma, come noi non ci curiamo della barba e dei capelli che ci sono stati tagliati, nel momento di staccarsi dal corpo essa non si cura minimamente di sapere quel che accadrà dell’involucro che la rivestiva, se lo divorerà il fuoco, lo ricoprirà la terra o lo dilanieranno le fiere, così come la placenta non riguarda il bambino appena nato. Che importa a chi non è più, se il suo corpo viene abbandonato ai morsi degli uccelli rapaci o gettato come preda ai pescecani23 e divorato? Ma anche da vivo il saggio non teme alcuna minaccia da parte di quei fantasiosi spauracchi che spingono al di là della morte i timori degli uomini. «Non mi spaventa», dice, «l’immagine dell’uncino o dello strazio orrendo del cadavere esposto all’oltraggio. Non chiedo nessuno ufficio funebre, non affido a nessuno i miei resti. La natura provvede a non lasciare alcuno insepolto: il tempo seppellirà chi è stato abbandonato dalla crudeltà umana». Dice bene Mecenate: non mi curo della tomba: la natura seppellisce gli insepolti. Potresti pensare che a parlare così sia stato un grand’uomo: avrebbe avuto, infatti, un’indole nobile e virile, se una fortuna troppo benevola non l’avesse infiacchita. Stammi bene.
1. Cfr. Afranio: Dossenno è un personaggio delle Atellane. 2. Seguaci della scuola fondata a Cirene da Aristippo, che fondava la felicità sul piacere. 3. Virgilio, Eneide I 342. 4. Il legislatore che riformò la costituzione ateniese e fu anche poeta. 5. Fu il fondatore della costituzione di Sparta. 6. È il legislatore più antico che si conosca, che avrebbe redatto la costituzione di Locri. 7. Legislatore di Reggio, di Catania e di altre colonie calcidesi dell’Italia meridionale, noto per la severità delle pene. 8. Virgilio, Georgiche I 144. 9. Virgilio, Georgiche I 139-40. 10. Ovidio, Metamorfosi VI 55-58. 11. Principe della Scizia, ebbe fama di saggezza e fu giustiziato per aver tentato d’introdurre nel paese il culto della Grande Madre. 12. Omero, Iliade XVIII 600-601. 13. Virgilio, Georgiche I 125-28.
14. Ebuzio Liberale, a cui Seneca dedicò il trattato I benefìci. 15. L’incendio di Lione avvenne nel 58 d.C. 16. Città dell’isola di Cipro. 17. Retore e storico alessandrino. 18. Lucio Munazio Planco, cesariano, fu proconsole in Gallia, dove fondò le colonie di Lione e di Raurica. 19. Città dei Rutuli. 20. Filosofo stoico, maestro di Panezio e capo della scuola di Atene. 21. Virgilio, Eneide III 426-428. 22. Virgilio, Eneide V 363. 23. Virgilio, Eneide IX 485.
Libro quindicesimo 93. Nella lettera in cui ti dolevi della morte del filosofo Metronatte, come se avesse potuto e dovuto vivere più a lungo, ho sentito la mancanza di quel senso di equanimità che in te abbonda in ogni situazione, in ogni attività, e di cui però sei privo in una sola cosa, come tutti: ho trovato, cioè, molte persone giuste verso gli uomini, ma verso gli dèi nessuna. Ogni giorno rimproveriamo il destino: «Perché Tizio è stato rapito nel pieno della vita? Perché Caio no? Perché prolunga una vecchiaia penosa a sé e agli altri?». Ascolta: ritieni più giusto che sia tu a obbedire alla natura o che la natura obbedisca a te? Che importa che tu esca presto o tardi dalla vita, da cui devi in ogni caso uscire? Dobbiamo cercare di vivere non a lungo ma quanto basta; vivere a lungo, infatti, dipende dal destino, vivere quanto basta dalla nostra anima. La vita è lunga se è piena, e diventa piena quando l’anima ha ripreso possesso del bene che le appartiene e ha acquistato il dominio di sé. A che giovano a quel tale ottant’anni trascorsi nell’inerzia? Costui non è vissuto, si è attardato nella vita, e non è morto tardi, ma a poco a poco. «È vissuto ottant’anni». Quel che conta è da quale giorno fai iniziare la sua morte. «Quello è morto nel fiore degli anni». Ma ha adempiuto ai doveri di buon cittadino, di buon amico, di buon figlio, ai quali non è mai venuto meno: anche se la sua età non è completa lo è la sua vita. «È vissuto ottant’anni». Di’ piuttosto che è esistito per ottant’anni; a meno che tu non intenda che è vissuto come si dice che vivono gli alberi. Ti prego, Lucilio, facciamo sì che la nostra vita, come le cose preziose, più che molta estensione abbia molto peso; misuriamola in base alle azioni, non in base al tempo. Vuoi sapere che differenza c’è tra un uomo vigoroso e sprezzante della fortuna, che ha assolto a tutti i suoi doveri e ha conseguito il sommo bene, e un uomo che ha ottenuto molti anni? L’uno vive anche dopo la morte, l’altro ha chiuso la sua esistenza ancor prima di morire. Lodiamo, dunque, e annoveriamo fra gli uomini felici colui che ha impiegato bene il tempo che gli è toccato in sorte, anche se breve. Egli, infatti, ha visto la vera luce; non è stato uno dei tanti: è vissuto ed è stato forte. Talvolta ha goduto di giorni pienamente sereni, talvolta la sua luce, come solitamente accade anche all’astro più luminoso, si è mostrata attraverso le nuvole. Perché chiedi quanto è vissuto? Continua a vivere: è balzato fino ai posteri ed è rimasto nella loro memoria. Con ciò non rifiuterei di aggiungere degli anni alla mia vita, ma non dirò mai che sia mancato qualcosa alla mia felicità se la mia vita viene troncata, poiché non ho mai regolato la mia vita su quel giorno che un’avida speranza mi aveva promesso come ultimo, ma non c’è stato giorno che io non abbia guardato come se fosse l’ultimo. Perché mi chiedi quando sono nato o se sono ancora annoverato fra i giovani? Ho quanto mi spetta. Come può esserci perfezione in un corpo piccolo, così può essere perfetta una vita più breve del normale. L’esistenza dipende da fattori esterni, la durata della vita non dipende da me: da me dipende, però, vivere veramente il tempo che vivrò. Questo a me devi chiedere, che io non conduca un’esistenza ignobile in mezzo alle tenebre,
che guidi la mia vita, non che mi lasci vivere. Chiedi quale sia la vita più lunga? Quella che conduce alla saggezza: chi la raggiunge tocca non la meta più lontana, ma la più importante. Se ne vanti pure orgogliosamente, ringrazi gli dèi e fra gli dèi anche sé stesso, e imputi alla natura quel ch’egli è stato: e sarà bene che lo faccia, poiché le ha restituito una vita migliore di quella ricevuta. Ha dato un esempio di uomo virtuoso, ha mostrato le sue qualità e il suo valore: se fosse vissuto di più tutto sarebbe rimasto uguale. Dunque, fino a quando vogliamo vivere? Abbiamo goduto della conoscenza di tutto, sappiamo su quali princìpi si regga la natura, come ordini il mondo, attraverso quali vicende faccia ritornare l’anno, in che modo abbia raccolto tutte le cose che stavano qua e là e abbia posto sé come limite a sé stessa; sappiamo che le stelle si muovono per loro impulso, che nessun corpo celeste all’infuori della terra sta fermo e che gli altri corrono veloci incessantemente; sappiamo come la luna sorpassi il sole e perché, pur essendo più lenta, se lo lasci alle spalle, pur essendo egli più veloce, come essa si illumini o si oscuri, quale causa determini l’avvicendarsi del giorno e della notte: bisogna andare là dove questi fenomeni si contemplano più da vicino. «Non esco dalla vita con maggior fermezza d’animo», dice il saggio, «nella speranza che sia aperta davanti a me la strada verso i miei dèi. Mi sono reso degno di essere ammesso fra loro, e ci sono già stato, ho spinto lassù il mio spirito e il loro è disceso in me. Ma supponi che io sia tolto di mezzo, che dopo la morte non resti nulla dell’uomo: ho ugualmente un’anima grande, anche se me ne vado senza trasferirmi in alcun altro luogo». «Non visse tanti anni quanti avrebbe potuto». Anche un libro di pochi versi può essere apprezzabile e utile: sai quanto siano voluminosi gli annali di Tanusio e come siano chiamati. La lunga vita di certa gente è simile e segue la stessa sorte degli annali di Tanusio. Forse che il gladiatore ucciso alla fine dello spettacolo è più felice di quello che muore a metà giornata? Credi che ce ne sia uno così stupidamente avido della vita da preferire di essere sgozzato nello spogliatoio piuttosto che nell’arena? Noi non ci precediamo nella morte a maggiore distanza di questa. La morte passa accanto a tutti: chi uccide segue la sua vittima. Ci tormentiamo tanto per una cosa da nulla. In definitiva che importanza ha per quanto tempo riesci a evitare ciò che comunque è inevitabile? Stammi bene. 94. Alcuni hanno accolto della filosofia solo quella parte che dà precetti particolari a ciascuno ma non all’uomo una formazione generale, che consiglia al marito come comportarsi con la moglie, al padre come educare i figli, al padrone come governare i servi, trascurando le altre parti, quasi che fossero inutili e si potessero dare consigli su questioni particolari senza abbracciare la vita nella sua totalità. Lo stoico Aristone, invece, considera tale parte poco importante e incapace di penetrare intimamente nell’animo, con i suoi insegnamenti da vecchietta, e sostiene che giovano moltissimo i princìpi generali della filosofia e la definizione del sommo bene, talché «chi l’ha compresa e imparata a dovere sa da sé che cosa debba fare in ogni situazione». Come chi impara a scagliare il
giavellotto cerca di colpire il bersaglio addestrando la mano a dirigere il tiro, e quando poi, con la disciplina e l’esercizio, ha acquisito tale abilità, se ne serve in ogni campo (poiché ha imparato a colpire non questo o quel bersaglio, ma tutti quelli che vuole), così chi si è preparato alla vita nella sua totalità non sente il bisogno di ricevere consigli sui dettagli in quanto, appunto, è preparato a tutto, non a come vivere con la moglie o col figlio, ma a come vivere bene, uno stato, questo, in cui è incluso anche come si debba vivere con la moglie e coi figli. Per Cleante anche questa parte ha la sua importanza, ma è inefficace se non procede da una conoscenza universale, se ignora i precetti e i princìpi stessi della filosofia. Su questo argomento, dunque, i problemi sono due: se la precettistica particolare sia utile o inutile, e se da sola sia in grado di rendere l’uomo virtuoso, cioè, se sia superflua o se renda superflue le altre parti della filosofia. Chi la ritiene superflua dice: se un oggetto posto davanti agli occhi impedisce la vista bisogna toglierlo; finché rimane è inutile dare insegnamenti: «Cammina così, tendi la mano da quella parte». Analogamente quando qualcosa offusca l’anima, impedendole di vedere la scala dei doveri, insegna a vuoto chi dà consigli del genere: «Così devi vivere col padre, così con la moglie». Gli ammaestramenti non giovano a nulla finché la mente è offuscata dall’errore: quando questo verrà eliminato, solo allora sapremo chiaramente come adempiere ai nostri doveri. Diversamente si insegna a uno cosa deve fare un uomo sano, ma non lo si rende sano. È come insegnare a un povero a comportarsi da ricco: ma finché resta povero non lo potrà mai fare. È inutile mostrare a un affamato cosa potrebbe fare se fosse sazio: levagli piuttosto la fame che gli stringe le viscere. Ciò vale per tutti i vizi: bisogna eliminarli, non insegnare cose impossibili a realizzarsi finché essi permangono. Se non si rimuovono i pregiudizi che ci affliggono l’avaro non comprenderà come si debba usare il denaro, né il pauroso come disprezzare i pericoli. All’uno devi far capire che il denaro non è né un bene né un male, mostrargli quanto siano miserabili i ricchi, all’altro devi dimostrare che ciò di cui tutti abbiamo paura non è così terribile come si dice, che nessuno soffre a lungo e nessuno muore più di una volta: nella morte, legge che tutti debbono subire, è un gran conforto il pensiero che non ritorna per alcuno; nel dolore sarà un rimedio la fermezza d’animo, che rende meno penoso ciò che si sopporta con coraggio; la natura del dolore è assai buona, perché il dolore che dura a lungo non può essere forte, e quello che è forte non può durare a lungo. Bisogna insomma accettare con coraggio tutto ciò che c’impone la legge fatale dell’universo. Quando, stabiliti questi princìpi, avrai reso un uomo cosciente della sua condizione ed egli avrà compreso che si è felici vivendo non secondo piacere ma secondo natura, quando amerà appassionatamente la virtù come unico bene dell’uomo e fuggirà il vizio come unico male, sapendo che tutto il resto – ricchezza, onori, salute, forza, potere – è indifferente, da non annoverare né tra i beni né tra i mali, allora egli non sentirà il bisogno di uno che lo consigli caso per caso nelle singole circostanze, dicendogli: «Cammina così,
mangia così; questo si addice all’uomo, questo alla donna, questo a chi è sposato, questo a chi è celibe». Chi dà con tanta cura tali consigli non è in grado di metterli in pratica neppure lui: questi precetti li dà il pedagogo al bambino, la nonna al nipote, e il maestro più irascibile discute sulla necessità di non adirarsi. Se entrerai in una scuola, ti accorgerai che questi precetti che i filosofi espongono con aria così severa si trovano già nei manuali per i bambini. E poi che insegnerai, cose evidenti o dubbie? Quelle evidenti non hanno bisogno di consiglieri, e chi insegna cose dubbie non è creduto, dunque non serve insegnare. Tieni presente soprattutto questo: se dài consigli oscuri e ambigui devi sostenerli con delle prove, se offri le prove bastano queste e valgono più dei consigli. «Comportati così con l’amico, così col concittadino, così col compagno». «Perché?». «Perché è giusto». Tutte queste cose me le insegna la parte della filosofia che riguarda la giustizia, e la giustizia è desiderabile per sé stessa, non vi siamo costretti dalla paura o indotti dal guadagno, e non è uomo giusto chi in questa virtù gode di cose che non la riguardano. Ebbene, quando mi sono convinto intimamente di ciò, a che mi servono questi precetti che presumono di insegnare a chi già sa? Dare precetti a chi sa è inutile, a chi non sa è poco, perché costui deve apprendere non solo ciò che gli viene insegnato ma anche perché. I precetti, voglio dire, sono necessari a chi ha le idee chiare sul bene e sul male o a chi non le ha? Chi non le ha non può ricevere da te alcun aiuto, poiché le sue orecchie, piene come sono di voci contrarie ai tuoi consigli, non ti sentono; se uno sa esattamente cosa va evitato e cosa ricercato sa benissimo ciò che deve fare anche se tu non glielo dici. Ne consegue che tutta questa parte della filosofia può essere eliminata. Noi sbagliamo per due motivi: o c’è nel nostro animo una malvagità prodotta da opinioni errate, oppure, anche se non siamo in preda all’errore, vi siamo inclini e ci lasciamo rovinare facilmente da apparenze fuorvianti. Perciò, dobbiamo o curare bene lo spirito ammalato e liberarlo dai vizi, oppure, se è esente dai vizi ma è propenso al male, prenderne in anticipo il dominio. I princìpi generali della filosofia adempiono a entrambi i compiti, dunque i precetti particolari non servono a nulla. Inoltre, impartire precetti per ogni singolo caso è un’impresa infinita, poiché bisogna darne di diverso tipo all’usuraio e all’agricoltore, al commerciante, a chi ricerca l’amicizia dei re, a chi quella dei suoi pari o dei suoi sottoposti. Quanto al matrimonio, insegnerai come un uomo debba comportarsi con la donna che ha sposato vergine o con quella che ha già avuto un marito, con una moglie ricca o con una senza dote. O ritieni che non vi sia differenza fra una moglie sterile e una feconda, tra una donna matura e una giovinetta, tra una madre e una matrigna? Non possiamo abbracciare tutti i singoli casi, ciascuno dei quali richiede regole particolari, mentre le norme della filosofia sono brevi e comprendono tutto. Aggiungi che i precetti della saggezza devono essere certi e ben definiti, perché se tali non sono non rientrano nella saggezza, che ben conosce i limiti delle cose. Bisogna dunque eliminare questa parte precettistica perché non è in grado di garantire a tutti ciò
che promette a pochi, mentre la saggezza si rivolge a tutti. Tra la follia collettiva e quella curata dai medici non c’è alcuna differenza se non nel fatto che la seconda è provocata da una malattia, la prima da false opinioni; la causa dell’una è l’infermità fisica, dell’altra l’infermità dello spirito. Chi desse consigli a un pazzo sul modo di parlare, di camminare, di comportarsi in pubblico e in privato, sarebbe più pazzo di colui al quale dà consigli: bisogna curare la bile nera e rimuovere la causa stessa della pazzia. Altrettanto si deve fare con la pazzia dello spirito: bisogna scacciarla, altrimenti i consigli cadranno nel vuoto. Queste sono le affermazioni di Aristone, a cui noi replicheremo punto per punto. Primo: egli sostiene che se un ostacolo davanti ai nostri occhi c’impedisce la vista bisogna toglierlo. Ebbene, è ovvio che per vedere non sono necessari consigli, ma in questo caso occorre liberare la vista eliminando l’ostacolo, dato che noi vediamo grazie alla natura e chi rimuove dai nostri occhi un ostacolo ne ripristina l’azione; ma la natura non insegna cosa richieda ogni nostro dovere. Secondo: chi è stato curato di cataratta non può, una volta riacquistata la vista, restituirla anche ad altri, mentre chi è stato liberato dalla malvagità può, a sua volta, liberare gli altri. Non c’è bisogno di esortazioni o di consigli affinché l’occhio percepisca le proprietà dei colori: distinguerà il bianco dal nero anche senza che qualcuno glielo insegni. L’animo, invece, ha bisogno di molti precetti per sapere come ci si debba comportare nella vita. Del resto, l’oculista non si limita a curare gli ammalati ma gli dà anche dei consigli. «Non esporre subito la vista ancora debole a una luce violenta», dice: «dal buio totale passa prima alla penombra, poi osa di più e abituati a poco a poco a sopportare la piena luce. Non metterti a studiare dopo aver mangiato, non sforzare gli occhi umidi e gonfi, evita il vento e il freddo pungente sul volto». Questi e altri consigli del genere dà il medico, che giovano non meno delle medicine. La medicina ai farmaci aggiunge i consigli. «L’errore», dice Aristone, «è la causa delle nostre pecche: i precetti non eliminano l’errore, né distruggono le errate opinioni sul bene e sul male». Ammetto che i precetti da soli non riescano a sradicare le convinzioni errate, ma non per questo non servono, aggiunti ad altri mezzi. Prima di tutto rinfrescano la memoria, in secondo luogo quelle cose che prese insieme apparivano piuttosto confuse una volta divise si osservano meglio. In questo modo puoi definire inutili anche le consolazioni e le esortazioni, e invece non sono inutili, dunque non lo sono neppure i precetti. «È da stolti», dice Aristone, «insegnare a un malato cosa debba fare come se fosse sano: bisognerebbe restituirgli la salute, senza la quale i precetti sono vani». Che dire poi che in certi casi sia gli ammalati che i sani hanno bisogno degli stessi consigli? Per esempio: non mangiare troppo avidamente, evitare di affaticarsi. E ci sono precetti comuni anche al povero e al ricco. «Guarisci l’avidità», dice Aristone, «e non dovrai dare consigli né al povero né al ricco, una volta placata la cupidigia di entrambi». Ma altro è non desiderare il denaro, altro saperlo usare. Gli avari ignorano la misura. «Elimina
gli errori», dice, «e i precetti non servono più». È falso. Supponi che l’avidità si sia mitigata, che la dissolutezza sia stata repressa, che la temerità sia tenuta a freno e che l’ignavia sia spronata: anche se i vizi sono stati rimossi, bisogna imparare che cosa fare e come. «Gli ammonimenti», dice, «non avranno alcun effetto contro i vizi gravi». Neppure la medicina vince le malattie incurabili, eppure viene usata per curarne alcune e per alleviarne altre. Neppure la forza della filosofia, pur chiamando a raccolta tutte le sue risorse, potrà estirpare dall’animo un male ormai radicato e inveterato, ma non si può dire che non guarisce niente solo perché non guarisce tutto. «A che giova», dice Aristone, «mostrare cose evidenti?». Giova moltissimo, invece: talvolta, infatti, sappiamo le cose, ma non vi prestiamo attenzione. I precetti di per sé non insegnano, ma richiamano l’attenzione, stimolano, mantengono viva la memoria e non la lasciano svanire. Spesso ci sfuggono cose che abbiamo davanti agli occhi: ammonire è un modo di esortare. Non di rado l’animo finge di non vedere anche ciò che è manifesto, perciò bisogna inculcargli anche la conoscenza delle cose più note. A questo proposito è utile ricordare la frase pronunciata da Calvo1 contro Vatinio:2 «Voi sapete che c’è stato un broglio elettorale e tutti sanno che voi lo sapete». Sai che bisogna venerare come sacre le amicizie, ma non lo fai. Sai che è immorale chi pretende la pudicizia dalla moglie e poi seduce le donne altrui; sai che, come lei non deve avere un altro uomo, così tu non devi avere un’amante, ma non lo fai. Ecco perché di tanto in tanto bisogna rinfrescare la memoria, tenendo a portata di mano questi princìpi, non lasciandoli in un cantuccio. Tutte le norme salutari devono essere esaminate e meditate spesso, affinché ci siano non solo note ma anche a portata di mano. Così anche i concetti più evidenti si fanno ancora più chiari. «Se i tuoi precetti sono dubbi», dice Aristone, «devi aggiungere delle prove: dunque, saranno queste a giovare, non i precetti». Ma anche senza le prove non giova pure l’autorità di chi consiglia? Così come sono validi i pareri dei giureconsulti anche senza alcuna spiegazione. Analogamente gli insegnamenti hanno molto peso già di per sé, soprattutto se sono formulati in versi o contenuti in massime in prosa, come quelli di Catone: «Compra non ciò che è utile, ma ciò che è necessario; ciò che non è utile è caro anche se costa un asse»;3 di questo tipo sono anche i responsi dell’oracolo o simili, come «Risparmia il tempo», «Conosci te stesso». Chiedi forse la spiegazione quando uno ti recita questi versi? Il rimedio contro le offese è l’oblio.4 La fortuna aiuta gli audaci.5 Il pigro è di ostacolo a sé stesso. Queste massime non hanno bisogno del sostegno di un avvocato: toccano il cuore e giovano utilizzando la forza stessa della natura. L’animo ha in sé i semi di tutte le virtù, i quali germogliano dietro la spinta degli insegnamenti, così come una scintilla, attizzata da un soffio leggero, sviluppa la sua fiamma; la virtù cresce se è spronata e stimolata. Nel nostro animo, poi, ci sono alcuni princìpi
non molto evidenti che cominciano ad attivarsi quando vengono espressi; altri sono sparsi qua e là e solo una mente bene esercitata è in grado di raccoglierli. Occorre dunque riunirli e collegarli fra loro, affinché siano più efficaci e sollevino meglio l’animo. Ma se i precetti non servono bisogna abolire ogni forma d’insegnamento e accontentarsi della sola natura. Coloro che sostengono questa tesi non tengono conto del fatto che non tutti sono uguali, c’è chi è di ingegno pronto e vivace, chi è lento e ottuso: insomma, il grado d’intelligenza – che si nutre di precetti, cresce, aggiunge nuove convinzioni a quelle che già possiede e corregge quelle false – varia da persona a persona. «Se uno», dice Aristone, «non ha retti princìpi, a che gli serviranno gli ammonimenti se è legato a consuetudini errate?». Evidentemente a liberarsene, poiché le sue qualità naturali non sono scomparse, sono solo ottenebrate e compresse, e anche in queste condizioni esse tentano di risollevarsi e si sforzano di opporsi al male, finché, trovato un aiuto e sorrette dai consigli, riprendono forza, sempre che una lunga malattia non le abbia guastate e uccise, perché in tal caso neppure la disciplina filosofica, facendo ricorso a tutte le sue forze, riuscirebbe a salvarle. Dove sta infatti la differenza fra i princìpi filosofici e i precetti se non nel fatto che i primi sono generali, gli altri, invece, particolari? Entrambi ammaestrano, ma gli uni in generale, gli altri in particolare. «Se uno ha dei princìpi giusti e buoni è inutile dargli consigli», egli dice. Non è vero, perché anche se conosce i suoi doveri non ne ha, necessariamente, una visione chiara e precisa. Non sono solo le passioni a esserci di ostacolo nel compiere buone azioni, è anche l’incapacità di scoprire quel che richiede ogni singola circostanza. Talvolta il nostro animo è ben regolato, ma inerte e incapace di trovare la via dei doveri, che un buon consiglio, invece, è in grado di indicare. «Rimuovi le opinioni errate sul bene e sul male», egli dice, «sostituiscile con quelle giuste e i consigli non serviranno». D’accordo, con questo sistema si educa l’animo, ma ciò non basta, perché sebbene la logica ci indichi ciò che è bene e ciò che è male i consigli sono sempre utili. La prudenza e la giustizia, per esempio, sono formate da doveri, ma questi sono regolati dai precetti. Perciò anche il giudizio sul bene e sul male trova conferma nell’adempimento dei doveri, e a esso ci conducono i precetti. Sono due cose in armonia fra di loro: gli uni precedono necessariamente gli altri, i quali seguono un loro ordine, quindi è chiaro che i doveri vengono prima. «I precetti», dice Aristone, «sono infiniti». È falso: non lo sono quelli che riguardano le questioni più importanti e necessarie: esistono differenze, anche se minime, dovute ai momenti, ai luoghi, alle persone, ma pure in questi casi si dànno precetti generali. «La pazzia non si cura con i precetti, dunque, neppure la malvagità». Non è la stessa cosa: se si elimina la pazzia si ristabilisce la salute mentale; se si eliminano le false opinioni, non ne consegue immediatamente la capacità di distinguere le azioni da compiere; e anche se ciò avverrà l’ammonimento rafforzerà comunque il nostro giudizio sul bene e sul male. Ed è ugualmente falso
che ai pazzi i precetti non servano, perché se è vero che da soli non giovano, sono però di sostegno alla cura; le minacce e le punizioni se non altro tengono i pazzi a freno – parlo naturalmente di quelli la cui mente vacilla ma non è sconvolta completamente. «Le leggi», dice ancora Aristone, «non riescono a farci comportare come dovremmo, e cos’altro sono, le leggi, se non precetti mescolati a minacce?». Innanzitutto le leggi non persuadono perché minacciano, mentre i precetti non costringono, ma cercano di convincere, e poi le leggi distolgono dal commettere delitti, mentre i precetti esortano al dovere. Aggiungi che anche le leggi giovano ai buoni costumi, specialmente se non comandano soltanto, ma insegnano pure. Su questo non sono d’accordo con Posidonio quando dice: «A chi giova che alle leggi di Platone siano stati aggiunti dei princìpi? La legge dev’essere breve, affinché gli sprovveduti la ricordino meglio. Sia come una voce che viene dal cielo: comandi, non discuta. Niente mi sembra più insulso e più vano di una legge con un preambolo. Comanda, dimmi cosa vuoi che faccia: non imparo, obbedisco». Le leggi, invece, giovano: vedrai infatti che le città rette da cattive leggi sono corrotte. «Ma non giovano a tutti». Nemmeno la filosofia, ma non per questo è inutile e inadatta a formare gli animi. E come? La filosofia non è la legge della vita? Ma supponiamo che le leggi non giovino: significa che non giovano neppure gli ammonimenti? Allora si dovrebbe dire che non giovano neppure i discorsi fatti per dissuadere, per consolare, i rimproveri e le lodi. Tutti questi sono forme diverse di ammonimenti, in virtù delle quali si raggiunge la perfezione spirituale. Non c’è cosa che renda più virtuosi gli animi e li riconduca sulla retta via, se sono incerti e inclini al male, quanto la compagnia dei buoni, la cui azione a poco a poco penetra nel cuore e il vederli e l’ascoltarli costantemente ha la stessa efficacia dei precetti. Già il solo incontrare persone sagge fa bene, perbacco, e da un grand’uomo puoi trarre vantaggio anche se non parla. Per quel che mi riguarda è più facile intuire che uno mi è stato utile che non spiegarne il come e il perché. Come dice Fedone,6 «certi animaletti molto piccoli quando pungono non li sentiamo, tanto è debole la loro forza e ci inganna sul pericolo; il gonfiore rivela la puntura, eppure nel gonfiore non si vede alcuna ferita». La stessa cosa ti accadrà frequentando i saggi: non ti accorgerai di come e quando ti giovino, ma ti accorgerai che ti hanno giovato. Mi chiedi a cosa miri questo discorso? I buoni precetti, se li tieni sempre presenti, gioveranno come i buoni esempi. Pitagora dice che l’animo di chi entra in un tempio e osserva da vicino le statue degli dèi attendendo il responso dell’oracolo subisce interiormente una trasformazione. E chi può negare che questi precetti colpiscano nel segno anche gli animi dei più ignoranti? Come queste sentenze, lapidarie ma di grande effetto: Niente di troppo. Non c’è guadagno che sazi l’animo dell’avaro. Aspettati dagli altri ciò che tu hai fatto a loro.7
Nell’udire queste parole restiamo come fulminati, né ci assale alcun dubbio o ce ne chiediamo il perché, tanto la verità risulta evidente, anche senza spiegazioni. Se il rispetto frena gli animi e reprime i vizi, perché non dovrebbe fare lo stesso anche l’ammonimento? Se il castigo costringe l’uomo a vergognarsi, perché non lo dovrebbe l’ammonimento, anche se si avvale di semplici precetti? Certo, saranno più efficaci e penetreranno più a fondo quei precetti sostenuti con delle prove, se a essi si aggiungeranno le ragioni per cui una cosa si debba fare e quale frutto attenda chi agisce obbedendo a quei consigli. Come servono gli ordini, così servono anche i consigli. La virtù si divide in due parti: contemplazione del vero e azione. All’una ci guidano gli insegnamenti, all’altra gli ammonimenti. L’azione retta è esercizio e al tempo stesso prova di virtù. Se all’azione giova il consiglio, le gioverà anche l’ammonimento. Dunque, se l’azione retta è necessaria alla virtù e l’ammonimento indica le azioni rette, ne consegue che anche l’ammonimento è necessario. Due cose danno all’animo una grandissima forza, la fede nella verità e la fiducia in sé stessi, due prerogative che ci vengono dagli ammonimenti, poiché questi sono credibili e, poiché vi si crede, l’animo si eleva e acquista fiducia, dunque l’ammonimento non è inutile. Agrippa – uomo di forte temperamento, l’unico, fra quanti le guerre civili resero famosi e potenti, che ebbe fortuna nella vita pubblica – soleva dire di dover molto a questa massima: «La concordia fa crescere i piccoli stati, la discordia manda in rovina i più grandi».8 Era stata la concordia – diceva – a renderlo un eccellente amico e fratello. Se massime del genere, una volta divenute familiari al nostro animo, ci educano, perché non dovrebbe educarci quel ramo della filosofia che è formato da tali massime? Parte della virtù si basa sull’insegnamento, parte sull’esercizio; occorre imparare e rafforzare con l’azione quanto si è appreso. E se è così, giovano non solo i princìpi della saggezza, ma anche i precetti, che reprimono e scacciano le nostre passioni come in forza di un editto. «La filosofia», dice Aristone, «si divide in conoscenza e disposizione d’animo: chi infatti ha imparato e compreso ciò che si deve fare e ciò che si deve evitare non è ancora saggio, se quanto ha appreso non ha trasformato il suo animo. La terza parte della filosofia, cioè l’insegnamento, si fonda su entrambe le precedenti, perciò è inutile per raggiungere la virtù: a quello scopo bastano le prime due». Se si ragiona così è inutile anche la consolazione, che pure si fonda su quelle due parti, nonché l’esortazione, la persuasione e il ragionamento stesso, poiché anch’esso proviene da uno stato d’animo equilibrato e forte. Ma, benché queste cose provengano da un’ottima disposizione dell’animo, questa a sua volta proviene da quelle, cioè le produce e al tempo stesso ne è prodotta. Per altro ciò che tu dici riguarda l’uomo che ha già raggiunto la perfezione e il culmine dell’umana felicità. Ma a questa meta si arriva lentamente e nel frattempo bisogna indicare come agire anche all’uomo che è ancora imperfetto ma in via di evoluzione. Forse questa strada saprà indicarla la saggezza anche senza
ammonimenti, qualora abbia già condotto l’animo a un punto tale da non potersi muovere se non verso il bene. Ma i caratteri più deboli hanno bisogno di una giuda che gli dica: «Evita questo, fa’ quello». E poi, se per agire aspettiamo il momento in cui sapremo quale sia la cosa migliore da fare, nel frattempo sbaglieremo e il nostro errore ci impedirà di giungere al punto in cui possiamo bastare a noi stessi. Occorre quindi essere guidati fino a quando si potrà cominciare a guidarsi da sé. I bambini imparano a scrivere seguendo un modello; le loro dita vengono tenute e guidate dalla mano di altri lungo i segni delle lettere, poi, in base a essi, sono invitati a copiare i modelli e a migliorare la loro grafia: allo stesso modo riceve aiuto il nostro animo mentre viene istruito con un modello. Con questi argomenti si dimostra che tale parte della filosofia non è inutile. Si chiede poi se essa basti da sola a rendere saggi. A questa domanda risponderemo a tempo debito: per ora, messe da parte le prove, non è forse chiaro che abbiamo bisogno di un difensore che ci dia precetti contrari a quelli della massa? Ogni parola che giunge alle nostre orecchie ha i suoi effetti: ci nuoce sia chi ci augura il bene, sia chi ci augura il male. Infatti le imprecazioni degli uni ci incutono false paure e l’amore degli altri col bene che ci augura ci dà cattivi insegnamenti perché ci indirizza verso beni lontani, incerti e instabili, mentre la felicità potremmo trovarla in noi stessi. Secondo me non si può procedere per la retta via, poiché i nostri genitori e i servi ci portano fuori strada. Ciascuno non solo sbaglia a proprio danno ma riversa su chi gli sta vicino la sua insensatezza e a sua volta la riceve da lui. Per questo negli individui si ritrovano gli stessi vizi della massa, perché è stata lei a trasmetterglieli. Nel momento stesso in cui rendiamo peggiore un altro ci facciamo peggiori anche noi, impariamo il male e poi lo insegniamo, ed è così che è nata quella enorme malvagità, perché si accumulano in un solo individuo i vizi peggiori di ognuno. Bisogna dunque che qualcuno ci sorvegli, che di tanto in tanto ci tiri le orecchie, che tenga lontane da noi le chiacchiere della gente e protesti contro le lodi della folla. Sbagli se pensi che i vizi nascano con noi: ci sono venuti addosso, ci sono stati inculcati. Siano dunque respinte con moniti frequenti le opinioni che ci risuonano intorno. La natura non ci induce al vizio, ci ha generati liberi e puri. Non ha messo in mostra cose che possano eccitare la nostra avidità: ci ha posto sotto i piedi l’oro e l’argento e ci ha dato da calpestare ciò per cui siamo calpestati e schiacciati. Ha indirizzato il nostro sguardo al cielo e ha voluto che alzando gli occhi vedessimo quanto lei ha fatto di magnifico e di mirabile: il sorgere e il tramontare degli astri, il rapido moto del mondo, che di giorno mostra le bellezze della terra e di notte quelle del cielo, i moti dei pianeti, lenti se confrontati con quello dell’universo ma velocissimi se si pensa quali immensi spazi percorrano a velocità costante; e ancora le eclissi del sole e della luna che si oscurano a vicenda e altri fenomeni ammirevoli, sia che si presentino secondo un ordine determinato, sia che si manifestino per cause improvvise, come strisce fiammeggianti nella notte, lampi
nel cielo che si apre senza produrre alcun colpo o rumore, colonne, travi e figure diverse generate dal fuoco. Queste cose la natura le ha poste sopra di noi, mentre ha nascosto l’oro, l’argento e il ferro, il quale a causa dei primi due non sta mai in pace. Siamo stati noi a portare alla luce questi elementi e per essi combattiamo, siamo stati noi a tirar fuori, squarciando la terra, gli strumenti e le cause dei nostri pericoli, siamo stati noi ad affidare alla fortuna i mali con cui essa possa colpirci e non ci vergogniamo di tenere in somma considerazione cose che stanno sotto terra a grande profondità. Vuoi sapere quanto sia falso lo splendore che ha ingannato i tuoi occhi? Non c’è niente di più brutto e di più ignobile di questi metalli finché giacciono coperti nel fango. Vengono estratti attraverso tenebrosi e lunghissimi cunicoli e mentre vengono lavorati e separati dalle impurità non c’è cosa più informe di essi. Guarda infine gli operai stessi che con le mani ripuliscono questa specie di terra sterile e sepolta tanto in basso: vedrai di quanta fuliggine sono ricoperti. Eppure questi metalli contaminano più l’animo che il corpo e c’è più sporco in chi li possiede che in chi li lavora. Ecco perché dobbiamo avere qualcuno che ci consigli e che difenda la causa della saggezza, e dare ascolto, fra tanto strepito e confusione di falsità, a una voce sola. E quale sarà questa voce? Naturalmente quella che, assordato come sei dal gran rumore dell’ambizione, ti sussurri parole salutari e ti dica: «Non c’è motivo di invidiare coloro che la massa definisce grandi e fortunati, non c’è motivo per cui gli applausi ti privino della tua serenità e della tua salute spirituale, per cui quel tale vestito di porpora e preceduto dai fasci ti faccia venire a noia la tua tranquillità, non c’è motivo per cui tu ritenga quell’uomo, al cui passaggio tutti fanno largo, mentre il littore li caccia ai bordi della strada, più fortunato di te. Se vuoi esercitare un’autorità che sia utile a te e non sia di peso a nessuno caccia via i vizi». Ci sono molti che incendiano città e distruggono costruzioni che avevano resistito per secoli rimanendo intatte per generazioni, molti che erigono terrapieni alti come rocche e abbattono con arieti e macchine da guerra mura di altezza eccezionale, altri che spingono schiere davanti a sé e incalzano incessantemente alle spalle il nemico o giungono fino all’oceano bagnati del sangue di innumerevoli uccisi, ma che per vincere il nemico sono stati vinti dalla cupidigia: nessuno ha saputo resistere al loro avanzare, ma essi a loro volta non avevano saputo resistere all’ambizione e alla crudeltà, sicché sembrava che trascinassero gli altri ma in realtà si lasciavano trascinare. Una folle smania di devastare paesi stranieri animava l’infelice Alessandro, spingendolo verso l’ignoto. O tu ritieni sano di mente uno che comincia a mietere le prime stragi proprio in Grecia9 dove è stato educato? Uno che strappa a ogni popolo ciò che ha di meglio e impone a Sparta la schiavitù e ad Atene il silenzio? Non pago di aver fatto strage di tante città, che il padre Filippo aveva vinto e comprato, ne abbatté altre in vari luoghi portando la guerra in tutto il mondo senza mai dare tregua alla sua crudeltà instancabile come quella delle belve che sbranano più di quanto la loro fame richieda. E dopo aver riunito molti regni in uno solo, quando
ormai i Greci e i Persiani lo temono come un tiranno e anche le nazioni libere dal dominio di Dario si sottomettono al suo giogo, varca l’oceano e l’oriente, insofferente perché le sue vittorie non calcano le orme di Ercole e di Bacco,10 e vuole fare violenza alla natura stessa. Più che volere andare, non può fermarsi, come un peso gettato in un burrone che si arresta solo quando giace sul fondo. Anche Gneo Pompeo era spinto a fare guerre fuori e dentro la patria non dalla virtù o dalla ragione ma da un amore insensato per una falsa ed effimera grandezza. Ora muoveva contro la Spagna e gli eserciti di Sertorio,11 ora andava a contrastare i pirati e a pacificare i mari: tutti pretesti per conservare il potere. Che cosa lo trascinò in Africa e nel Nord, contro Mitridate, 12 in Armenia e in tutti gli angoli dell’Asia? Una brama di potere insaziabile, sempre maggiore, perché solo a lui sembrava di non averne abbastanza. Che cosa spinse Cesare alla rovina sua e dello Stato? La gloria, l’ambizione e il desiderio smodato di primeggiare su tutti. Non riuscì a tollerare nemmeno uno sopra di sé, mentre lo Stato ne tollerava due. Credi che Mario, una sola volta console (con regolare elezione, perché le altre le usurpò), affrontasse tanti pericoli mosso da virtù quando massacrava i Teutoni e i Cimbri 13 e inseguiva Giugurta per i deserti dell’Africa? Se Mario guidava gli eserciti l’ambizione guidava Mario. Ebbene, costoro, mentre sconvolgevano tutto, venivano a loro volta sconvolti come i cicloni che nel turbine trascinano ciò che afferrano ma prima sono essi stessi a essere trascinati nel turbine e per questo irrompono con maggior impeto, perché non hanno alcun controllo su di sé, e quindi, dopo aver danneggiato molti, sperimentano su sé stessi quella violenza distruttiva con cui hanno recato danno a tanti. Non credere che l’infelicità altrui possa rendere più felici. Dobbiamo cancellare tutti questi esempi che ci riempiono gli occhi e le orecchie, e liberare l’animo dai cattivi discorsi di cui si è riempito, introducendo al loro posto la virtù, affinché sradichi le menzogne e tutto ciò che piace pur essendo contrario alla verità, affinché ci separi dal volgo di cui ci fidiamo troppo e ci restituisca ai sani pensieri: in questo, infatti, consiste la saggezza. Torniamo dunque alla natura e riprendiamoci il posto da cui l’errore generale ci aveva allontanato. Gran parte del nostro buon senso sta nell’abbandonare chi ci incita alla follia e nell’allontanarsi da una compagnia in cui ci si danneggia a vicenda. Per convincertene guarda come ciascuno di noi in pubblico si comporti diversamente che in privato. La solitudine non è di per sé maestra di onestà, né la frugalità ce la insegna la campagna, però quando non ci sono testimoni e spettatori i vizi si attenuano perché non possono più pavoneggiarsi. Non si indossa una veste di porpora se non c’è qualcuno a cui mostrarla, chi è solo non mette tutte le vivande in stoviglie d’oro. Chi mai fa sfoggio della sua ricchezza quando se ne sta solo in campagna disteso all’ombra di un albero? Nessuno sfoggia per il piacere dei propri occhi, di poche persone o di quelli dei familiari, ma tutti sfoderano il repertorio dei loro vizi in rapporto al numero di persone che li guardano. E così: lo stimolo a tutte le nostre follie è la presenza di qualcuno che ci ammiri e ci faccia da testimone. Se ci si toglie la possibilità di
ostentazione anche il desiderio se ne va. L’ambizione, la magnificenza, la sfrenatezza hanno bisogno di un pubblico: se le terrai nascoste ne guarirai. Perciò se ci troviamo in mezzo al frastuono delle città ci stia accanto uno che ci ammonisca e che a dispetto di chi loda i grandi patrimoni lodi chi è ricco con poco e misura le sue ricchezze in base all’uso che ne fa; che a dispetto di chi esalta la popolarità e il potere, ammiri la vita ritirata dedita allo studio e l’animo che dalle cose esterne rientra in sé stesso, che dimostri come coloro che secondo il volgo sono felici stanno invece tremanti e spaventati in quella loro posizione invidiata e hanno di sé un’opinione ben diversa da quella degli altri, giacché quelle che agli altri appaiono come delle vette per loro sono dei precipizi. Perciò si scoraggiano e tremano ogni volta che rivolgono lo sguardo verso il baratro della loro grandezza: pensano all’instabilità del caso che è tanto più infido per chi sta in alto. Allora hanno paura di ciò che hanno ricercato e la stessa fortuna che li rende insopportabili agli altri grava ancor più su di loro. Così finiscono col lodare la vita ritirata, calma e indipendente, odiano lo sfarzo e cercano di fuggire prima che crolli tutto. E magari li vedrai darsi alla filosofia per paura e fare saggi propositi per timore dell’avversa fortuna. Infatti, come se buona fortuna e assennatezza fossero cose contrarie fra loro, noi siamo più saggi nelle avversità: la fortuna ci toglie la capacità di un retto giudizio. Stammi bene. 95. Vuoi che affronti subito quell’argomento che avevo deciso di rimandare ad altro momento, e che ti scriva se la parte della filosofia che i Greci definiscono parenetica e noi chiamiamo precettistica sia sufficiente per raggiungere la perfetta saggezza. So che non te l’avresti a male se io mi rifiutassi, tanto più dunque mi impegno per non smentire il proverbio «Non chiedere nuovamente ciò che non vorrai aver ottenuto». A volte, infatti, domandiamo con insistenza cose che rifiuteremmo se qualcuno ce le offrisse. Sia leggerezza o servilismo, questo comportamento va punito con una pronta accondiscendenza. Vogliamo dare l’impressione di volere molte cose che in realtà non vogliamo. Una volta un lettore portò un enorme volume di storia scritto a caratteri minutissimi e avvolto molto strettamente, e dopo averne letto una gran parte disse: «Se volete, smetto». Al che gli ascoltatori: «Continua, continua», gridarono, quando in realtà volevano che tacesse. Spesso vogliamo una cosa e ne chiediamo un’altra e non diciamo la verità neppure agli dèi, i quali o non ci dànno retta o ci compatiscono. Io, invece, non avrò pietà e mi vendicherò infliggendoti una lettera lunghissima, così se la leggerai malvolentieri dirai: «Sono io che l’ho voluto», e ti porrai nel numero di coloro che sono tormentati da una donna che hanno sposato dopo averla corteggiata a lungo, di coloro che sono oppressi dalla ricchezza acquistata con molto sudore, che sono torturati dalle cariche ottenute con ogni espediente e con fatica, o che sono causa dei propri mali. Ma bando ai preamboli e affrontiamo la questione. «La felicità», dicono, «consiste nell’agire rettamente; alle azioni rette conducono i precetti, dunque per
essere felici bastano i precetti». Ora, non sempre i precetti portano a un retto agire, ciò avviene solo quando l’indole è docile; a volte è inutile dispensarli quando la mente è ingombra di cattivi pensieri. Per non dire che alcuni, anche se agiscono rettamente, non se ne rendono conto, perché se non si è stati educati fin da principio e regolati da una ragione perfetta non si può controllare in ogni suo aspetto la propria azione morale in modo da sapere quando, in quale misura, con chi, come e perché si debba agire. Non si può aspirare al bene con tutto l’animo e neppure con costanza o volentieri, quindi o si faranno spallucce o si esiterà. «Se l’azione onesta», dicono, «deriva dai precetti, questi sono più che sufficienti per raggiungere la felicità: se la premessa è vera, sarà vera anche la conclusione». A costoro risponderemo che le azioni oneste derivano sì dai precetti ma non solo da essi. «Se i precetti», aggiungono, «bastano alle altre arti, basteranno anche alla saggezza, la quale pure è un’arte: l’arte di saper vivere. Se il pilota è formato da un insegnante che gli dice: “Muovi così il timone, ammaina così le vele, sfrutta così il vento favorevole, resisti così a quello contrario, approfitta così di quello variabile e incerto”, evidentemente i precetti formano anche chi attende ad altre arti, dunque possono formare anche chi si dedica all’arte del vivere». Tutte queste arti riguardano gli strumenti della vita, non la vita nel suo insieme, perciò sono ostacolate e intralciate da molti fattori esterni: la speranza, la cupidigia e il timore. Ma l’esercizio della saggezza, che si professa quale arte del vivere, non può impedirlo a nessuno: essa abbatte e rimuove ogni ostacolo. Vuoi sapere quanto quest’arte sia diversa dalle altre? Nelle altre è più scusabile uno sbaglio volontario che non uno casuale, in questa la colpa più grave consiste nello sbagliare deliberatamente. Le cose stanno proprio così. Un grammatico non arrossisce di un solecismo se l’ha usato consapevolmente, arrossisce se lo ha fatto senza accorgersene; un medico se non si rende conto che l’ammalato sta per morire commette una mancanza di fronte alla sua professione, tanto più se finge di non capirlo: ma nell’arte del vivere è più grave la colpa di chi sbaglia volontariamente. Aggiungi poi che la maggior parte delle arti – specie quelle più liberali, come la medicina – hanno propri princìpi teorici, non soltanto precetti, perciò ci sono diverse scuole, una di Ippocrate, una di Asclepiade, una di Temisone.14 Inoltre non c’è scienza contemplativa che non abbia propri princìpi, che i greci chiamano dogmata e noi chiamiamo decreta, scita o placita, e che trovi anche nella geometria e nell’astronomia. La filosofia, poi, è teoretica e pratica, contemplativa e attiva, in quanto contemporaneamente contempla e agisce. Sbagli, infatti, se pensi che essa riguardi solo le attività terrene, essa vive in una sfera più alta: «Io indago l’universo intero», dice, «e non mi limito ai rapporti umani, paga di persuadervi o di dissuadervi: mi chiamano questioni ben più importanti, che stanno al di sopra di voi». Come dice Lucrezio, Ti dirò dei princìpi basilari del cielo e degli dèi, ti svelerò quegli elementi primordiali,
donde la natura produce tutti gli esseri, li accresce e nutre, e in cui di nuovo, sfatti, li dissolve.15 Ne consegue che essendo un’attività contemplativa la filosofia ha princìpi propri. Per non dire che nessuno potrà compiere convenientemente un buon lavoro se non avrà appreso la norma che gli consenta di svolgere bene i suoi compiti in ogni circostanza, cosa che non potrà fare chi avrà ricevuto precetti particolari per casi singoli, non insegnamenti generali. I precetti particolari sono di per sé deboli e per così dire senza radici. Sono i princìpi generali a difenderci, a tutelare la nostra sicurezza e la nostra serenità: essi abbracciano tutta la nostra vita e l’intera natura. Tra i princìpi della filosofia e i precetti c’è la stessa differenza che esiste tra gli elementi e le parti di un organismo: queste dipendono da quelli, quelli sono causa di esse e di tutte le cose. Dicono che «l’antica saggezza insegnava solo ciò che si deve fare e ciò che si deve evitare e che a quel tempo gli uomini erano di gran lunga migliori: da quando sono comparsi i dotti, i buoni non ci sono più, quella virtù semplice e chiara si è trasformata in una scienza oscura e complicata e noi impariamo a discutere, non a vivere». Indubbiamente, come dite voi, quell’antica saggezza, soprattutto appena nata, fu rudimentale come le altre discipline che si sono raffinate via via. Ma allora non c’era ancora bisogno di rimedi studiati diligentemente, la malvagità non era ancora cresciuta tanto e non si era diffusa così estesamente: a vizi semplici si potevano opporre rimedi semplici. Ora, invece, le difese devono essere tanto più efficaci quanto più violente sono le forze che ci aggrediscono. Un tempo la medicina consisteva nella conoscenza di poche erbe capaci di far coagulare il sangue e rimarginare le ferite, poi a poco a poco si è fatta varia e complessa. Ne c’è da meravigliarsi che allora avesse meno da fare, poiché i corpi erano ancora sani e robusti, il cibo era semplice e non alterato dagli artifici e dal piacere: da quando si è cominciato a ricercare il cibo non per placare la fame ma per eccitarla e si sono escogitati mille condimenti per stuzzicare l’appetito, quelli che erano alimenti per i bisognosi sono diventati un peso per chi è già sazio. Da qui il pallore, il tremito delle membra molli di vino e la magrezza più miserevole quando proviene non dalla fame ma dalle indigestioni; da qui il passo incerto e malfermo e il barcollare continuo come di chi è completamente ubriaco; da qui il sudore diffuso su tutta la pelle, il ventre gonfio per la cattiva abitudine di ricevere più di quanto può contenere; da qui l’itterizia, il volto pallido e il decomporsi degli organi che si imputridiscono, le dita rattrappite per l’irrigidirsi delle articolazioni, il torpore dei nervi che hanno perso la sensibilità, o il loro tremito continuo. E che dire delle vertigini? Dei dolori agli occhi e alle orecchie, delle fitte al cervello in fiamme e delle ulcere intestinali? E, ancora, degli innumerevoli tipi di febbre, alcuni dei quali attaccano con violenza, altri si insinuano come un veleno sottile, altri sopraggiungono con brividi e forti sussulti delle membra? Ma a che serve
elencare tutti gli innumerevoli mali con cui si sconta la dissolutezza? Da essi erano immuni gli uomini quando non si erano ancora infiacchiti nei piaceri, quando erano padroni e servi di sé stessi. Irrobustivano il corpo col lavoro e con la vera fatica, stancandosi o nella corsa, o nella caccia, o rivoltando la terra: si cibavano di quanto bastava a soddisfare il piacere di chi aveva fame. Non avevano dunque bisogno di una così vasta schiera di medici, di tanti ferri e vasetti. Le malattie erano semplici perché semplici erano le cause, il troppo mangiare ha prodotto molte malattie. Guarda come la dissolutezza che infesta terra e mare mescoli tante cose che finiscono nella gola di uno solo. È ovvio che sostanze così diverse fra loro non si accordino e una volta inghiottite siano difficili da digerire, perché provocano effetti contrari. Ed è naturale che una malattia causata da cibi contrastanti fra loro abbia anch’essa un decorso irregolare e vario, e che quei cibi provenienti da sostanze così eterogenee e introdotti in uno stesso stomaco siano poi rigettati. Così ci siamo creati malattie nuove e un nuovo genere di vita. Ippocrate, il più grande medico e fondatore della medicina, diceva, ai suoi tempi, che le donne non perdevano i capelli e non soffrivano di gotta; ora, invece, sì. La natura delle donne non è cambiata, è stata vinta anch’essa dalla dissolutezza degli uomini, talché le donne, imitandoli, li hanno eguagliati anche nelle malattie. Come loro, passano le notti vegliando, bevono e li sfidano nella lotta e nel vino, vomitano i cibi ingeriti per forza e rigettano tutto il vino bevuto, e sgranocchiano il ghiaccio per spegnere il fuoco che hanno nello stomaco. Persino nei piaceri erotici sono pari agli uomini; destinate per natura a un ruolo passivo, hanno escogitato (che gli dèi le stramaledicano!) un genere così perverso di impudicizia che invece di farsi penetrare sono loro a penetrare gli uomini. Che meraviglia, dunque, se il più grande medico e il più profondo conoscitore della natura viene smentito, visto che tante donne sono calve e malate di gotta? A causa dei vizi hanno perso i vantaggi propri del loro sesso e poiché si sono spogliate della natura femminile sono state condannate alle malattie degli uomini. I medici antichi non conoscevano l’usanza di somministrare agli ammalati un cibo più abbondante e di rianimare col vino le forze illanguidite, non conoscevano il salasso e la possibilità di alleviare le malattie croniche con bagni e sudorazioni, l’uso di legare gambe e braccia per buttar fuori la virulenza del male, annidato al centro del corpo. Non c’era bisogno di cercare molti tipi di rimedi, poiché pochissimi erano i pericoli. Ma quanti progressi non hanno fatto le malattie! Questo è il prezzo che paghiamo per i piaceri che abbiamo voluto al di là del limite e del lecito. Non c’è da stupirsi che le malattie siano innumerevoli, basta contare i cuochi. Così diminuisce l’amore per il sapere e chi insegna discipline liberali parla ad aule deserte, nelle scuole dei retori e dei filosofi regna la solitudine: quanto sono affollate invece le cucine, quanti giovani si accalcano attorno ai focolari degli scialacquatori! Non parlo delle schiere di poveri fanciulli che, terminato il banchetto, attendono altri oltraggi nella camera
da letto; non parlo delle schiere di amanti divisi per nazionalità e per colore sì che abbiano tutti la stessa freschezza, la stessa prima peluria, lo stesso tipo di capelli, e chi non li ha lisci stia con quelli che li hanno ricci; non parlo della folla dei fornai e dei servi che al segnale corrono a servire la cena. Buoni dèi, quanti uomini per uno stomaco solo! Pensi che quei funghi dal veleno gustoso non lavorino sotto sotto, anche se non hanno avuto un effetto immediato? Non pensi che quella neve d’estate provochi un indurimento del fegato? E quelle ostriche, carne insipida ingrassata nel fango, non pensi che ti arrechino una pesantezza fangosa? E quel garo proveniente dalle provincie, poltiglia preziosa di pesci andati a male, non credi che bruci le viscere con la sua acida putredine? E come sono repellenti e pestilenziali quei rutti, e che disgusto smaltire la sbornia del giorno precedente! Sappi che tali cibi non vengono digeriti, imputridiscono. Una volta, ricordo, si faceva un gran parlare di un piatto famoso nel quale un oste, a suo danno, aveva messo insieme tutto ciò che di solito si serve ai signori per tirare in lungo un banchetto: conchiglie di Venere, spondili e ostriche, tagliate tutto attorno fin dove sono commestibili, separate da tordi, ricci di mare e triglie fatte a pezzi senza lische ricoprivano tutto il piatto. Ormai non piace più gustare i cibi uno per uno: si mescola tutto in un solo sapore. Durante il pranzo si fa ciò che dovrebbe accadere nello stomaco: c’è solo da aspettarsi che i cibi vengano serviti già masticati. E poco ci manca che si tolgano gusci e ossa e si faccia svolgere al cuoco la funzione dei denti. «Costa fatica gozzovigliare assaporando una vivanda per volta: mettiamo insieme tutto, mescolato in un sapore unico. Perché stendere la mano per prendere una vivanda sola? Ne vengano servite molte contemporaneamente, si metta assieme e si unisca il meglio di molte portate. Chi affermava che tutto ciò si fa per ostentazione e per vanità sappia che questi cibi non sono messi in mostra ma sono sottoposti al giudizio di ciascuno. Le vivande che di solito si imbandiscono separatamente siano mescolate in un’unica salsa, non ci siano differenze: ostriche, ricci, spondili, triglie siano messi in tavola mescolati e cotti insieme». Il cibo che si vomita non potrebbe essere più mescolato. Ebbene, come questi piatti sono complicati, così anche le malattie che ne derivano sono complesse, oscure, varie e multiformi, e contro di esse la medicina ha cominciato a munirsi di molti metodi terapeutici e di molte ricette. La stessa cosa vale per la filosofia. Una volta era semplice, quando la gente commetteva colpe meno gravi a cui si poteva porre rimedio facilmente: ora, di fronte a una corruzione morale così diffusa bisogna tentare di tutto. E volesse il cielo che questo flagello fosse infine debellato! La nostra follia invade non solo la vita privata ma anche quella pubblica. Reprimiamo gli omicidi e le uccisioni dei singoli uomini, ma che dire delle guerre e dello sterminio tanto celebrato di intere popolazioni? L’avidità e la crudeltà non hanno limiti. E questi delitti quando sono commessi di nascosto e da individui singoli sono meno dannosi e meno mostruosi, ma che dire quando le atrocità vengono compiute per deliberazione del senato e per decreto del popolo, e in nome dello stato si ordina
di fare ciò che in privato viene proibito? Quelle azioni che compiute di nascosto sarebbero punite con la morte noi le lodiamo quando chi le commette indossa una divisa. Non si vergognano gli uomini, che per natura sono molto miti, di godere del sangue reciprocamente versato, di fare la guerra e di trasmettere ai figli il compito di continuarla, mentre persino le bestie e le fiere vivono in pace fra loro? Contro una follia così potente e diffusa la filosofia è diventata più attiva, ha raccolto tante più forze quanto più crescevano quelle dei mali da combattere. Un tempo era facile rimproverare chi si dava al vino o ricercava cibi troppo raffinati, non occorreva un grande sforzo per ricondurre gli animi alla frugalità, dalla quale non si erano ancora allontanati molto. Ora occorrono mani rapide e grande maestria.16 Dovunque non si cerca che il piacere. Nessun vizio rimane entro i suoi limiti: la lussuria precipita nell’avidità, l’onestà è caduta nell’oblio, nessuna vergogna per ciò che ci procura piacere. L’uomo, creatura sacra all’uomo, ormai viene ucciso per divertimento e per gioco, e mentre prima era ritenuto un misfatto addestrare uno a infliggere e a ricevere ferite, ora lo si spinge nell’arena nudo e inerme, e l’uccisione di un uomo da parte di un altro uomo è diventata uno spettacolo. In tanta corruzione morale si avverte il bisogno di un intervento più energico, che distrugga i mali più antichi, occorre agire in base ai princìpi generali per estirpare completamente le convinzioni false acquisite. Se ai princìpi si aggiungeranno precetti, consigli, esortazioni, essi, allora, potranno essere efficaci: da soli non lo sono. Se gli uomini vogliono restare attaccati al bene ed essere strappati ai mali che li sovrastano imparino cosa sono il male e il bene, sappiano che tutte le cose, tranne la virtù, cambiano nome, ora sono mali, ora sono beni. Come il primo legame di un soldato sono il giuramento, l’amore per la bandiera e l’orrore per la diserzione, e a chi ha prestato giuramento si può chiedere e comandare facilmente qualunque cosa, così in coloro che si vogliono condurre alla felicità bisogna gettare le prime fondamenta e inculcare la virtù. Ad essa si tengano stretti quasi con religiosa venerazione, l’amino e vogliano vivere con lei, non senza di lei. «Ma come? Non esistono persone che sono diventate buone anche senza un’istruzione approfondita e che hanno fatto notevoli progressi obbedendo solo a semplici consigli?». Sì, ma erano dotate di buona indole e hanno afferrato gli insegnamenti principali, perché come gli dèi immortali non hanno bisogno di imparare le virtù, in quanto le possiedono già e l’essere buoni fa parte della loro natura, così certi uomini dotati di un’indole eccellente arrivano senza un lungo ammaestramento a ciò che di solito viene insegnato, e abbracciano la virtù appena ne sentono parlare: è da qui che provengono queste nature così avide di virtù e persino feconde di per sé stesse. Invece a coloro che sono di mente debole e ottusa o dominati dalle cattive abitudini, bisogna togliere la ruggine che copre il loro animo. Del resto, chi insegna i princìpi filosofici e porta più rapidamente alla perfezione quelli che
sono inclini al bene aiuterà anche i più deboli, sottraendoli alle false opinioni; e quanto siano necessari questi princìpi, puoi vederlo da te. Ci sono in noi delle inclinazioni che ci rendono pigri verso alcune cose, temerari verso altre; e quest’audacia non si può frenare, né quell’inerzia può essere scossa, se non sopprimendone le cause, cioè l’ammirazione e la paura senza fondamento. Finché ne siamo in balia, puoi dire: «Questo devi al padre, questo ai figli, questo agli amici, questo agli ospiti»; l’avidità contrasterà tutti i tuoi sforzi. Uno saprà che bisogna combattere per la patria, ma la paura lo dissuaderà; saprà che bisogna affaticarsi fino allo stremo delle forze per gli amici, ma l’amore per i propri comodi glielo vieterà; saprà che avere un’amante è il peggiore torto che si possa fare alla moglie, ma la passione sarà più forte. Dunque, non servirà a nulla dare consigli se prima non avrai rimosso ciò che li ostacola, così come non serve mostrare a uno le armi e mettergliele accanto se non gli si slegano le mani. Perché l’animo possa volgersi ai precetti che gli si dànno deve essere liberato. Supponiamo che uno faccia ciò che è bene fare, ma non in modo continuo e regolare, poiché non sa perché lo fa. Alcune sue azioni risulteranno buone per caso o per abitudine, ma lui non saprà su cosa misurarle, sì da poter ritenere giusto quel che ha fatto. Chi è buono per caso non può esserlo per sempre. Forse coi consigli costui farà ciò che si deve fare, ma non è sicuro che quelli lo portino alla virtù. Se sarà ammonito farà ciò che deve, d’accordo, ma è troppo poco, perché il merito non sta nell’azione, sta nel modo di compierla. Cosa c’è di più scandaloso di una cena sontuosa, che costa il patrimonio di un cavaliere? Non c’è persona più riprovevole di chi – come dicono questi crapuloni – offre una cena simile a sé e al proprio genio familiare. Eppure, certi pranzi per festeggiare una nomina sono costati a uomini frugalissimi un milione di sesterzi. Se sono fatti per soddisfare la gola la cosa è vergognosa, ma se per una carica ottenuta non è da biasimarsi: si tratta di dissolutezza, è una spesa richiesta dalle consuetudini. Un giorno fu portata a Tiberio una triglia di dimensioni enormi (perché non aggiungere il peso per sollecitare la golosità di qualcuno? Dicevano che pesasse quattro libbre e mezzo). Tiberio ordinò di portarla al mercato e di metterla in vendita: «Amici», disse, «scommettiamo che questa triglia la comprerà Apicio 17 o Ottavio». La sua previsione ebbe un esito superiore all’aspettativa: si fecero le offerte, vinse Ottavio e ottenne grande gloria tra i suoi per aver comprato per cinquemila sesterzi il pesce che Tiberio aveva messo in vendita e che neppure Apicio aveva acquistato. Pagare una somma così elevata fu vergognoso per Ottavio, non per chi aveva comprato la triglia per offrirla a Tiberio, benché, secondo me, anche lui sarebbe da rimproverare, visto che gli era parsa così straordinaria da essere degna di Cesare. Chi assiste l’amico ammalato è da lodarsi! Ma se lo fa in vista dell’eredità è un avvoltoio, aspetta il cadavere. Così le stesse azioni possono essere buone o cattive: ciò che conta è il motivo, nonché il modo in cui sono compiute. Ma tutte le azioni saranno oneste se ci voteremo all’onestà e considereremo questa e ciò
che ne deriva l’unico bene della vita; gli altri sono beni per un giorno. Bisogna dunque imprimersi nella mente questa convinzione che deve valere per tutta la vita: e questo è per me un principio. Quale sarà questa convinzione, tali saranno anche le nostre azioni e i nostri pensieri. I consigli particolari per i singoli casi sono troppo poco per chi vuole mettere ordine alla sua intera esistenza. Bruto nel libro intitolato perì kathékontos dà molti precetti a genitori, figli e fratelli: ma nessuno li metterà in pratica come si deve se non avrà un principio generale a cui riferirli. Dobbiamo proporci come fine il sommo bene e tendervi con ogni nostra azione e ogni nostra parola, così come i marinai orientano la rotta guardando a una stella. La vita senza una meta è errabonda, e se vogliamo avere una meta sono necessari i princìpi. Penso che tu riconosca che non c’è cosa più vergognosa dell’incertezza e del tornare sui propri passi. E questo ci accadrà sempre se non rimuoviamo dall’animo ciò che frena e gli impedisce di avanzare e di impegnarsi sino in fondo. Di solito si dànno precetti su come venerare gli dèi. Si proibisca invece di accendere lucerne di sabato, perché gli dèi non hanno bisogno di luce e per gli uomini il fumo non è piacevole. Si vieti l’uso del saluto mattutino e lo stare seduti alle porte dei templi: solo l’ambizione umana fa compiere questi atti d’omaggio, il vero culto consiste nel conoscere dio. Così si vieti di portare a Giove manti e strìgili e di reggere lo specchio a Giunone: dio non cerca servitori, è lui al servizio degli uomini, a disposizione di tutti. Anche se si fanno i sacrifici nel modo giusto e ci si tiene lontani dalle superstizioni dannose non si fanno progressi se non ci si forma una giusta idea di dio, che tutto possiede, tutto dona e fa il bene senza chiedere nulla in cambio. E cos’è che spinge gli dèi a fare il bene? La loro natura. Sbaglia chi crede che essi non vogliano fare il male: non possono farlo. Come non possono né subire né arrecare offese, dato che fare il male e subirlo sono cose strettamente legate. La loro natura, la più alta e la più bella, sottraendoli ai rischi, li ha resi anche non pericolosi. Il primo atto di venerazione verso gli dèi è credere in loro; poi vengono il riconoscerne la maestà e la bontà, senza la quale non c’è maestà, il sapere che sono loro a governare il mondo, a regolare tutto con la propria forza, a proteggere il genere umano, trascurando a volte i singoli individui. Essi non infliggono e non subiscono il male, però puniscono alcuni, li tengono a freno e talvolta infliggono punizioni sotto l’apparenza di benefìci. Vuoi propiziarti gli dèi? Sii buono. Chi li imita rende loro il giusto culto. Un altro problema è come ci si debba comportare con gli uomini. Cosa fare? Quali consigli dare? Di non versare sangue umano? È ben poco limitarsi a non fare del male al prossimo quando si dovrebbe fare del bene! Certo è un gran merito per l’uomo essere mite verso un suo simile. Dobbiamo insegnare a tendere la mano al naufrago, a indicare la strada a chi si è smarrito, a dividere il pane con chi ha fame? Perché elencare tutte le azioni che si devono fare o non fare, quando posso insegnare questa breve formula, che comprende tutti i doveri dell’uomo? Ogni cosa che vedi, che racchiude il divino e l’uomo, è un tutt’uno:
siamo le membra di un immenso organismo. La natura ci ha creato fratelli, poiché ci ha fatto della stessa materia e per gli stessi fini; ci ha infuso un amore reciproco e ci ha reso socievoli. Ha stabilito l’equità e la giustizia: per sua regola è più triste fare il male che subirlo, per suo comando le mani siano sempre pronte ad aiutare. Teniamo sempre questo verso nel cuore e sulle labbra: Sono un uomo, non v’è cosa umana che mi sia estranea.18 Mettiamo tutto in comune poiché siamo nati per questo. La nostra società è molto simile a una volta di pietre: cadrebbe, se le pietre non si sostenessero reciprocamente, ed è proprio questo che la sorregge. Dopo aver parlato degli dèi e degli uomini, vediamo come ci si debba servire delle cose. I precetti saranno gettati al vento se prima non avremo un’esatta opinione di tutto, sulla povertà e sulla ricchezza, sulla gloria e sull’infamia, sulla patria e sull’esilio. Valutiamole una per una, non curandoci dell’opinione generale, e cerchiamo di scoprire cosa sono, non con quale parola vengano chiamate. Passiamo alle virtù. Qualcuno ci raccomanderà di stimare molto la prudenza, di abbracciare la fortezza, di stringerci, se possibile, alla giustizia ancor più che alle virtù; ma sarà inutile se noi ignoriamo cosa sia la virtù, se ce ne sia una sola o tante, separate o collegate fra loro, se chi ne possiede una possegga anche le altre, in che cosa differiscano l’una dall’altra. Un artigiano non ha bisogno di chiedere notizie sull’origine e sull’utilità del suo mestiere, così come non ne ha bisogno un pantomimo sull’arte della danza: queste arti basta conoscerle, non serve altro, poiché non riguardano la vita nella sua totalità. La virtù è conoscenza delle altre cose e di sé stessa: per impararla occorre imparare ciò che essa è. Un’azione non sarà retta se non sarà retta la volontà, poiché da questa deriva l’azione. A sua volta la volontà non sarà retta se non sarà retta la disposizione d’animo, poiché da questa deriva la volontà. La disposizione d’animo non sarà perfetta se non avrà colto le leggi della vita intera ed esaminato quale giudizio bisogna dare di ogni cosa, se non avrà ricondotto tutto alla verità. La serenità può averla solo chi è arrivato a formarsi un giudizio immutabile e sicuro: gli altri cadono spesso, si rimettono in piedi e ondeggiano fra rinunce e aspirazioni. E sai qual è la causa della loro instabilità? Che niente è chiaro per chi si affida all’opinione pubblica, il più incerto dei criteri. Se vuoi avere una volontà ferma devi volere la verità. Ma al vero non si giunge senza princìpi: essi abbracciano tutta la vita. Il bene e il male, l’onestà e la disonestà, la giustizia e l’ingiustizia, la pietà e l’empietà, le virtù e l’esercizio delle virtù, il possesso degli agi, la stima e l’onore, la salute, le forze, la bellezza, l’acutezza dei sensi: tutte queste cose hanno bisogno di uno che sappia valutarle. Che si sappia quanto valga ciascuna. Sbagliamo, infatti, e stimiamo certe cose più di quanto valgano, al punto che quanto ai nostri occhi conta di più – la ricchezza, la popolarità, il potere – non vale un soldo. Ma non potrai conoscere il giusto valore se non
esaminerai la norma in base alla quale queste cose vengono valutate fra loro. Come le foglie non possono verdeggiare da sole, ma hanno bisogno di un ramo a cui stare attaccate, dal quale trarre la linfa, così questi precetti se sono soli appassiscono: devono essere legati a una dottrina filosofica. Inoltre, coloro che eliminano i princìpi generali non si rendono conto che li affermano proprio perché li eliminano. Cosa dicono, infatti? Che i precetti sono sufficienti per regolare la vita e che i princìpi della saggezza sono superflui. Eppure, proprio questa affermazione è un principio, perbacco! Come se io ora dicessi che bisogna abbandonare i precetti perché inutili e servirsi dei princìpi, concentrarsi solo su questi: proprio dicendo che non bisogna curarsi dei precetti impartirei un precetto. Certe parti della filosofia richiedono un ammonimento, altre una dimostrazione, e per di più ampia, perché sono complicate e si chiariscono a stento procedendo con molta attenzione e acutezza. Se le dimostrazioni sono necessarie lo sono anche i princìpi, che conducono alla verità attraverso le argomentazioni. Certi princìpi sono evidenti, altri oscuri: sono evidenti quelli che si afferrano coi sensi e si ricordano; sono oscuri quelli che non rientrano in queste due facoltà. Ma la ragione non si appaga di ciò che è evidente: la sua funzione maggiore e più bella riguarda ciò che è oscuro, che richiede una dimostrazione, e la dimostrazione non è possibile senza i princìpi; dunque, i princìpi sono necessari. Ciò che forma il senso comune forma anche il senso perfetto, e i due sensi scaturiscono da un’opinione certa sulle cose; se l’animo ne è privo tutto è incerto e sono necessari i princìpi, che dànno la fermezza nel giudicare. Infine, quando esortiamo qualcuno a considerare l’amico come sé stesso, a pensare che da nemici si può diventare amici, ad accrescere il suo amore per l’uno, a moderare l’odio per l’altro, aggiungiamo: «Ciò è giusto, onesto». Ma il giusto e l’onesto fanno parte dei princìpi generali; dunque, questi sono necessari, perché senza di essi non esisterebbero neppure i precetti. Ma uniamo gli uni e gli altri perché senza radici i rami sono inservibili e le radici stesse traggono profitto dai rami che hanno generato. Quanto siano utili le mani nessuno lo ignora, perché la loro utilità è evidente: ma il cuore, grazie al quale le mani hanno vita e da cui ricevono la forza per muoversi, è nascosto. La stessa cosa si può dire dei precetti: sono manifesti, mentre i princìpi della saggezza sono nascosti. Come soltanto gli iniziati conoscono i riti più sacri, così i segreti della filosofia sono svelati solo a coloro che sono ammessi e accolti nel suo santuario; ma i precetti e gli altri insegnamenti del genere sono noti anche ai profani. Posidonio ritiene necessaria non solo la precettistica (niente ci vieta di usare questo termine), ma anche la persuasione, la consolazione e l’esortazione; a queste aggiunge la ricerca delle cause, che non capisco perché non osiamo chiamare eziologia, visto che i grammatici, custodi della lingua latina, a buon diritto la chiamano così. Posidonio ritiene utile la definizione di ciascuna virtù, una scienza che egli chiama ethologìa, altri charakterismòs, che mette in luce le caratteristiche e i segni tipici mediante i quali si distinguono cose simili tra loro.
Dare definizioni equivale a dare precetti; infatti, chi dà precetti dice: «Farai questo, se vorrai essere temperante», chi dà definizioni dice: «Temperante è chi fa questo e si astiene da quello». Chiedi che differenza ci sia? Il primo dà precetti di virtù, il secondo offre un modello. Confesso che queste definizioni o iconismi – per usare un termine da esattori – sono utili: mettiamo davanti agli occhi esempi lodevoli, e si troverà chi li imiterà. Ritieni utile che ti vengano dati dei segni in base ai quali riconoscere un cavallo di razza, per evitare di fare un acquisto sbagliato e di perdere tempo con un animale pigro? Quanto è più utile conoscere i segni caratteristici di un animo eccezionale, e che possono essere riprodotti in sé stessi. Alto procede il puledro di buona razza nei campi, agile posa le zampe, osando per primo partire: fiumi rischiosi attraversa e ponti sconosciuti, né lo spaventano strepiti o inutili rumori. Erto ha il collo, la testa squadrata, piccolo il ventre, ampio il dorso; superbo, il petto è gonfio di muscoli… … Se da lontano sente un risuonare di armi, lui non si arresta, ma drizza le orecchie agitando le membra, soffia dalle narici, sprigionando l’ardore raccolto.19 Senza volerlo, il nostro Virgilio ha descritto l’uomo forte: anch’io, se volessi effigiare un grand’uomo, non userei un’immagine diversa. Se dovessi raffigurare Catone impavido in mezzo al fragore delle guerre civili, che per primo si scaglia contro gli eserciti ormai vicini alle Alpi, non gli darei un aspetto e un atteggiamento diverso. Nessuno, certo, potrebbe avanzare più eretto di lui, che si levò contro Cesare e Pompeo, e mentre alcuni sostenevano le forze di Cesare, altri quelle di Pompeo, lui li sfidò entrambi, mostrando che c’era anche un partito dello Stato. Di Catone, infatti, è poco dire: «Non si lascia spaventare da vani rumori», perché lui non si lasciava spaventare da rumori reali e vicini, e contro dieci legioni, le truppe ausiliarie della Gallia e le armi barbariche mescolate a quelle cittadine, levava la sua voce libera per esortare lo Stato a non rinunciare alla lotta per la libertà, ma a tentare tutto, perché è più dignitoso cadere in schiavitù che andarle incontro. Quanto vigore e quanta forza d’animo, quanta fiducia in mezzo al panico generale! Egli sa di essere l’unico sulla cui condizione non c’è da discutere: si tratta di sapere non se Catone sia un uomo libero, ma se viva tra uomini liberi; di qui il suo disprezzo dei pericoli e delle armi. Ammirando l’invincibile fermezza di quell’uomo che non vacillò in mezzo al crollo generale, piace dire: «Il petto animoso è gonfio di muscoli». Sarà utile non soltanto dire come sono di solito gli uomini buoni e delinearne la figura e i tratti, ma anche narrare e descrivere come siano stati: l’ultima e coraggiosissima ferita di Catone, attraverso cui la libertà esalò l’ultimo respiro, la saggezza di Lelio e l’amicizia con il suo Scipione, le nobili azioni, nella vita
privata e pubblica, dell’altro Catone, i letti di legno di Tuberone, 20 allestiti per un pranzo ufficiale, con pelli di capra al posto delle coperte e i vasi di terracotta posti per i conviti proprio davanti alla cella di Giove. Che altro significa se non consacrare la povertà sul Campidoglio? Anche se io non conoscessi altre sue azioni per metterlo tra i Catoni, crediamo che ciò non sarebbe sufficiente? Quella non fu una cena, fu un giudizio. Oh come gli uomini bramosi di gloria ignorano che cosa essa sia e come la si acquisti! Quel giorno il popolo romano vide le stoviglie di molti, ma ammirò solo quelle di Turberone. L’oro e l’argento di tutti gli altri è stato rotto e fuso mille volte, ma i vasi di terracotta di Turberone dureranno in eterno. Stammi bene.
1. Oratore e poeta, accusò Vatinio di broglio. 2. Partigiano di Cesare, violento e corrotto, nemico di Cicerone, che tuttavia, costretto dai triumviri, lo difese dall’accusa di broglio. 3. Catone, Precetti al figlio Marco, fr. 10. 4. È un verso di Publilio. 5. Virgilio, Eneide X 284. 6. Uno dei discepoli di Socrate. 7. Versi attribuiti a Publilio Siro. 8. Sallustio, La guerra giugurtina 10, 6. 9. Alessandro distrusse la città di Tebe che si era ribellata (335 a.C.). 10. Ercole e Bacco secondo il mito arrivarono fino all’India, mentre Alessandro fu costretto a tornare indietro perché l’esercito si rifiutò di proseguire. 11. Esponente del partito democratico, fu pretore in Spagna, dove progettò una ribellione contro Roma. Fu ucciso da un suo luogotenente. 12. Il grande re del Ponto che sconfitto dai Romani si fece uccidere da un suo ufficiale. 13. Popolazioni germaniche, sconfitte da Mario ad Aquae Sextiae e ai Campi Raudii (102-191 a.C.). 14. Medici famosi. 15. Lucrezio, De rerum natura I 54-57. 16. Virgilio, Eneide VIII 442, e VI 261. 17. Famoso cuoco del tempo di Augusto. 18. Terenzio, Heautontimorumenos (Il punitore di sé stesso), 77. 19. Virgilio, Georgiche III 75-81 e 83-85. 20. Q. Elio Tuberone, giurista e annalista, partecipò alle guerre civili prima con Pompeo, poi con Cesare.
Libro sedicesimo 96. Ma perché t’indigni e ti lamenti per cose di scarsa importanza? Non capisci che non c’è niente di male in queste piccole contrarietà, se non il fatto, appunto, che t’indigni e ti lamenti? Vuoi sapere come la penso io? L’uomo si sente infelice unicamente perché ritiene che la natura offra motivi per essere infelici. Da parte mia non sopporterò più me stesso quando non fossi più capace di sopportare qualche disgrazia. Se sto male è il destino che vuole così. La servitù è malata, sono pieno di debiti, la casa scricchiola, danni, malanni, pene e fame mi sono piombati addosso, ma sono cose che capitano, anzi, devono capitare, fatti non casuali ma stabiliti per legge. Non mi credi? Ti svelerò ciò che sento intimamente: in tutte le situazioni che mi sembrano avverse e dure a sopportarsi io mi comporto non come uno che si sottometta al volere di dio, ma come uno che sia d’accordo con lui, aderisco, cioè, alla sua volontà, e lo faccio spontaneamente, non perché spinto dalla necessità. Perciò, qualunque cosa accada l’accetto, senza mostrarmi triste o scontento, col volto accigliato, non pago contro voglia alcun tributo: tutto ciò che ci fa piangere o ci spaventa, infatti, è un tributo che paghiamo alla vita, necessariamente. Quindi, Lucilio mio, non sperare di poter esserne immune, non chiederlo neppure (perché non serve a nulla). Soffri di dolori alla vescica? Hai ricevuto lettere poco gradite? Hai subìto danni continui? Dirò di più: hai avuto paura di morire? Ma come? Quando ti auguravi di diventare vecchio non sapevi che ti auguravi la morte? Come in un lungo viaggio devi combattere con la polvere, col fango e con la pioggia, così in una vita lunga ci si imbatte in simili disgrazie. Dirai: «Io volevo vivere, ma senza avere tutti questi fastidi». Sono parole di donnicciole, indegne di un uomo. Vedi tu come accogliere l’augurio che ti faccio, col cuore e con animo generoso: che gli dèi non ti permettano di essere nelle grazie della fortuna. Fatti questa domanda: metti che un dio ti chieda di scegliere se vivere in un mercato o in un accampamento. Caro Lucilio, la vita è una milizia. Perciò quelli che sono sbattuti di qua e di là e costretti a percorrere, per dritto o per traverso, strade difficili e faticose, e vanno incontro a spedizioni piene di pericoli, sono uomini valorosi, i primi fra i soldati; quelli, invece, che si abbandonano mollemente a un ozio nauseabondo, mentre gli altri sgobbano, sono delle colombelle, e pagano i loro agi e la loro sicurezza col disonore. Stammi bene. 97. Sbagli, Lucilio mio, se pensi che la dissolutezza sia un vizio esclusivo del nostro secolo, come la trascuratezza dei buoni costumi e gli altri mali che si rimproverano alla propria epoca: questi sono da imputarsi agli uomini, non ai tempi. Non c’è età che possa dirsi immune da colpe, e se tu volessi prenderti la briga di passare in rassegna secolo per secolo l’umana dissolutezza ti renderesti conto – rincresce doverlo dire – che la depravazione più sfacciata ci fu proprio nell’epoca di Catone. Nessuno potrebbe credere che sia stato sborsato del denaro nel processo in cui Clodio1 era accusato di adulterio, commesso in un
penetrale con la moglie di Cesare, in violazione dei riti religiosi di un sacrificio celebrato – dicono – a favore del popolo, durante il quale tutti gli uomini sono esclusi dallo spazio sacro in base a una regola così ferrea che addirittura si coprono con un velo le pitture raffiguranti animali maschi.2 Eppure fu dato ai giudici del denaro e – cosa ancora più turpe di questo accordo – si pretese che in sovrappiù si consumassero degli stupri di matrone e di giovani nobili. Ma il delitto fu meno grave dell’assoluzione: l’accusato di adulterio distribuì adultèri e solo dopo aver reso i giudici simili a lui poté essere sicuro di scamparla. E ciò avvenne in un processo che, per non dire altro, aveva fra i testimoni Catone. Citerò le parole stesse di Cicerone,3 perché la cosa supera ogni credibilità. «Chiamò in privato i giudici, gli fece delle promesse, delle regalie, li supplicò. E poi… che infamia, buon dio!, alcuni di essi ottennero in sovrappiù anche i favori di certe donne e le grazie di giovani nobili». Lasciamo perdere il denaro, la cosa peggiore sono state le aggiunte. «Vuoi la moglie di quell’uomo così severo? Ci penso io a fartela avere. O quella di quest’uomo tanto ricco? Ti farò andare a letto con lei. Se non ci sarà intesa fra voi, condannami pure. Desideri quella bella donna? Verrà. Ti prometto una notte con lei. Subito, dammi tempo tre giorni e la mia promessa sarà esaudita». Distribuire adultèri è più grave che commetterli: questo è un vero ricatto alle madri di famiglia. I giudici di Clodio avevano chiesto e ottenuto dal Senato una scorta, necessaria solo in caso di condanna, per cui Catulo4 dopo l’assoluzione disse loro argutamente: «Perché ci avete chiesto una scorta? Per paura che vi portassero via il denaro?». E così, scherzando scherzando, adultero prima e ruffiano durante il processo, Clodio la fece franca e sfuggì alla condanna con atti ancora più vergognosi di quelli per cui era stato processato. Ora dimmi, ci fu mai una corruzione maggiore di quando neppure i riti sacri, i processi e un’inchiesta straordinaria promossa con delibera del Senato potevano frenare la dissolutezza, e si commisero azioni peggiori di quelle per cui si era stati inquisiti? Si indagava se dopo un adulterio si potesse stare al sicuro: fu chiaro che non si poteva esserlo senza adulterio. Questo è ciò che avvenne al tempo di Cesare e Pompeo, di Cicerone e Catone, quel Catone durante la cui magistratura il popolo non osò chiedere gli spettacoli della dea Flora con prostitute nude, se ti sembra credibile che allora negli spettacoli ci fosse una severità maggiore che nelle sentenze dei processi. Ebbene, questi misfatti, come sono accaduti, accadranno ancora in futuro, poiché in una città la corruzione può cessare a volte per disciplina o per paura, ma mai spontaneamente. Perciò non devi credere che abbiamo concesso moltissimo alla libidine e quasi niente alle leggi: la gioventù di oggi è molto più moderata di quella d’una volta, quando l’accusato nei processi negava l’adulterio e i giudici glielo rinfacciavano, quando si commetteva uno stupro per costruirvi sopra un processo, quando Clodio, ammirato per quegli stessi vizi per cui veniva processato, faceva il ruffiano persino durante la sua difesa. Chi lo crederebbe? Uno, condannato per un solo adulterio, fu assolto per averne causati molti! Ogni epoca avrà i suoi Clodi, ben poche avranno dei Catoni. Siamo portati al
peggio, sia perché a tale scopo non ci mancano né guide né compagni, sia perché la corruzione va avanti anche da sola, senza guide e compagni. La via del vizio non solo è in discesa, ma addirittura scende giù a precipizio. Per non dire che in questo caso c’è un particolare che rende gli uomini incorreggibili: in altri campi almeno ci si vergogna degli errori commessi, chi ha sbagliato si mortifica, qui, invece, ci si compiace del tenore di vita che si conduce. Il pilota non si rallegra se l’imbarcazione si rovescia, né il medico se il malato finisce al camposanto, né l’avvocato se l’imputato perde la causa per colpa del suo difensore, tutti, invece, si rallegrano delle proprie malefatte, chi è soddisfatto del suo adulterio, a cui l’ha spinto proprio la difficoltà di realizzarlo, chi gode di una truffa o di un furto e si dispiace non per il peccato compiuto ma solo se la sorte non l’ha portato a buon fine. Ciò è dovuto a una cattiva abitudine. Del resto tu sai che il senso del bene, sotto sotto, alberga anche negli uomini più abietti e che la disonestà più che ignorata è trascurata. Tutti dissimulano i propri peccati e benché abbiano un esito felice ne godono i frutti di nascosto: diversamente dalla buona coscienza, che ama mostrarsi ed essere ammirata, la malvagità ha paura anche del buio. Perciò, secondo me, bene ha detto Epicuro, che «un delinquente può restare nascosto, ma non può esserne certo», o, se ritieni che il senso sia più chiaro così: «Ai colpevoli non giova nascondersi, perché, anche se la fortuna gliene offre la possibilità, non hanno la certezza di non essere scoperti». È così: chi commette un misfatto può starsene al sicuro ma non essere tranquillo. Non credo che questo pensiero, così come l’ho spiegato, sia in contrasto coi nostri insegnamenti. E sai perché? Perché la prima e più grave punizione di un malfattore sta nell’aver commesso il misfatto: nessun delitto, infatti, per quanto la fortuna lo riempia di doni, lo protegga e lo difenda, resta impunito, perché la pena del misfatto sta nel misfatto stesso. Per giunta a questa punizione ne seguono altre, incalzanti: la paura continua, il terrore e la mancanza di sicurezza. A che pro, dunque, liberare la malvagità da questo tormento? Perché non tenerla sempre nell’incertezza? Noi stoici non siamo d’accordo con Epicuro quando afferma che niente è giusto per natura e che i crimini vanno evitati perché non si può evitare la paura; siamo d’accordo invece sul fatto che le cattive azioni sono flagellate dalla coscienza, il cui maggior tormento è l’essere straziata ininterrottamente da un’ansia continua e il non poter credere a chi promette tranquillità. Questa, caro Epicuro, è proprio la prova che noi detestiamo il crimine per disposizione naturale: tutti i delinquenti hanno paura, anche se stanno al sicuro. La buona sorte libera molti dalla prigione, nessuno dalla paura, perché in noi è radicata l’avversione per ciò che la natura ha condannato. È per questo che chi sta nascosto non ha mai la certezza di poterlo restare, perché è la sua coscienza che lo accusa e lo pone di fronte a lui stesso. È proprio dei peccatori vivere sempre nell’ansia. Poiché sono molti i delitti che sfuggono alla legge, alle pene da lei stabilite, ai giudici stessi, sarebbe ben grave se i delinquenti non scontassero subito le dure punizioni della natura e se la paura non facesse le veci della pena. Stammi bene.
98. Non devi credere felice chi dipende dai beni materiali, perché costui poggia su basi fragili e gode di cose esteriori: la sua gioia come è venuta se ne andrà, mentre quella che proviene dall’intimo è stabile e duratura, cresce e ci accompagna sino alla fine. I beni esteriori, apprezzati dalla massa, non durano che un giorno. «Ma come?», obietterai. «Non possono essere utili e piacevoli?». E chi lo nega? Lo sono, ma solo se li padroneggiamo, non se ne siamo schiavi. Tutti i beni che dipendono dalla fortuna sono piacevoli e fruttuosi se chi li possiede è anche padrone di sé stesso e non è schiavo delle cose. Caro Lucilio, è sbagliato pensare che la sorte ci dispensi il bene o il male, essa ci dà solo materia di beni o di mali e i germi di ciò che per noi si tradurrà in bene o in male. L’anima è più forte di qualsiasi fortuna, è lei stessa che ne conduce gli eventi, in un verso o nell’altro, è lei la causa della propria felicità o infelicità. Se è malvagia volge tutto in male, anche ciò che si presenta sotto l’aspetto di un bene massimo; se è pura e virtuosa corregge i mali derivanti dalla fortuna e insegna a sopportarli, addolcisce le ansie e le difficoltà, accoglie la buona sorte con gratitudine e moderazione, quella avversa con resistenza e forza. Ma con tutta la sua saggezza, e pur agendo sempre ponderatamente e non osando più di quanto può, non raggiungerà mai quel bene puro e perfetto che niente e nessuno può minacciare, se non si mostra salda contro i capricci della sorte. Se osserverai con obiettività te stesso e gli altri (coi quali siamo più sereni nel giudicare), ti renderai conto e ammetterai che nessuna cosa desiderabile e gradita riesce utile se non si è pronti ad affrontare la volubilità del caso e dei beni che ne conseguono, se a ogni singolo male che ti colpisca non ripeterai spesso, senza lamentarti, queste parole: Gli dèi hanno deciso diversamente.5 Anzi, cercherò un verso più giusto e più efficace per sostenere meglio l’animo tuo, e cioè ogni volta che ti accadrà qualche cosa contraria a quel che ti aspettavi, di’: «Gli dèi hanno deciso meglio». Se farai così nulla potrà mai coglierti impreparato. Ma potrai comportarti così solo se avrai previsto, prima ancora di farne esperienza, le conseguenze che possono derivare dalle vicende umane, se saprai godere dei figli, del coniuge e dei tuoi beni con la consapevolezza che sono passeggeri e non godibili per sempre, e se, perdendoli, non accrescerai la tua infelicità: chi infatti sta in ansia per il futuro è infelice ancora prima che l’infelicità sopraggiunga, per l’angoscia che prova di fronte a beni caduchi che non può conservare sino alla sua morte. Così egli non vivrà mai in pace e l’ansia per il futuro gli farà praticamente perdere quei beni di cui godrebbe se pensasse solo al presente, poiché pari sono il dolore per la perdita di un bene e il timore di perderlo. Tuttavia non ti consiglio di essere indifferente, ti dico solo: sfuggi ciò che ha in sé motivi di timore, prevedi ciò che si può saggiamente intuire, scruta e allontana ciò che può danneggiarti prima ancora che ti colpisca. A tale scopo ti sarà utile la fiducia in te stesso e un animo deciso a
sopportare ogni avversità. Può infatti opporsi alla mala sorte solo chi ha la capacità di sopportarla, e certamente chi ha un animo tranquillo non si lascia turbare da lei. Non c’è cosa più misera e più stolta di un timore anticipato: che pazzia è mai quella di prevenire i propri mali? Infine, per esprimerti brevemente ciò che penso, ti dirò che chi si affanna ed è di peso a sé stesso non ha misura, quanto a disgrazie, né prima né dopo. Si duole più del necessario chi si duole prima del necessario, è un debole e non sa valutare il dolore, così come non sa aspettarlo; con la stessa sfrenatezza si immagina eterna la sua felicità, crede che i beni avuti dalla sorte siano duraturi e che a essi debbano aggiungersene altri e, dimentico dell’instabilità delle vicende umane, pretende a suo proprio uso e consumo la stabilità dei beni della fortuna. Mi sembra molto bella questa frase di Metrodoro nella lettera indirizzata alla sorella che aveva perso un figlio eccezionale: «Ogni bene dei mortali è mortale». Si riferisce ai beni comuni, a cui aspirano tutti, perché il bene vero, come la saggezza e la virtù, non muore, è eterno e sicuro, l’unica cosa immortale che tocca ai mortali. Ma gli uomini sono talmente stolti e dimentichi della meta a cui quotidianamente vanno incontro che si indignano di perdere qualcosa quando in un solo giorno perderanno tutto. I beni di cui ti senti padrone li hai con te ma non sono tuoi: chi vive nell’incertezza non può avere alcunché di sicuro, niente di eterno e durevole c’è per chi è destinato a finire. Com’è inevitabile perdere la vita, così lo è perdere i beni; se comprendiamo ciò possiamo trarne conforto. Siamo destinati a morire: accettiamo dunque di perdere ogni cosa con animo sereno. Contro queste perdite può esserci di aiuto ricordare i beni passati e far sì che con essi non svaniscano i frutti che ce ne sono venuti: ciò che ci è tolto, infatti, è il possesso concreto dei beni, non l’averli posseduti. Chi ha perso qualcosa che gli è stato dato resta comunque in debito per averlo ricevuto, diversamente sarebbe un ingrato. Il caso ci toglie un bene, ma ce ne lascia l’usufrutto, e noi coi nostri ingiusti rimpianti perdiamo anche quello. Di’ a te stesso: «Nessuno di questi mali che sembrano terribili è invincibile». Sono tanti gli uomini che in passato li hanno vinti, quale uno quale un altro, Muzio il fuoco, Regolo il supplizio, Socrate il veleno, Rutilio l’esilio, Catone la morte inflittasi con la spada: vinciamone qualcuno anche noi di questi mali. D’altra parte questi beni che attraggono la massa, belli e proficui in apparenza, molti li hanno spesso disprezzati. Fabrizio,6 che pur era generale a quell’epoca, rifiutò la ricchezza e da censore la biasimò, Tuberone giudicò la povertà degna di lui e del Campidoglio, allorché in un pranzo ufficiale si servì di stoviglie di terracotta, dimostrando che l’uomo deve accontentarsi di ciò che si usa ancora nei sacrifici agli dèi. Suo padre Sesto, che per nascita avrebbe dovuto intraprendere la carriera politica, non accettò il laticlavio che gli offriva il divo Giulio, perché capiva che quanto viene dato può anche essere tolto. Facciamo pure noi qualcosa di coraggioso, siamo un esempio fra gli altri. Perché arrenderci? Perché disperare? Ciò ch’è stato fatto in passato si può farlo anche oggi, purché si mantenga pura l’anima e si segua la natura: chi se ne allontana si fa schiavo della
paura, delle passioni e del caso. È possibile tornare sulla retta via, ritrovare l’integrità perduta: recuperiamola, dunque, potremo così sopportare qualunque dolore fisico e dire alla sorte: «Hai a che fare con un uomo vero: se vuoi vincere cercati un altro». * * * Con questi e altri simili discorsi si lenisce la violenza di quella ferita che io, dio buono, desidero che si attenui e guarisca, o almeno si mantenga così e invecchi con lui. Ma io per lui sto tranquillo: il danno è nostro, perché ci viene strappato un vecchio straordinario. Lui è vissuto abbastanza e vuole vivere ancora non per sé ma per le persone a cui può essere utile. Per lui vivere è un atto di altruismo: un altro con quei tormenti l’avrebbe già fatta finita. Lui considera vergognoso fuggire la morte tanto quanto rifugiarsi in essa. Dirai: «Ma come? Se il suo stato lo consiglia così non deve lasciare la vita?». Certo, se non ci sarà più alcuno che possa giovarsi di lui e non gli resterà altro che la sua sofferenza. Questo, Lucilio mio, significa imparare la filosofia attraverso l’azione ed esercitarsi alla realtà; significa vedere quale forza d’animo l’uomo saggio sia capace di dimostrare di fronte alla morte quando si fa vicina o di fronte al dolore quando ne è tormentato. Cosa si debba fare bisogna impararlo da chi lo fa. Sino a ora abbiamo discusso se sia possibile resistere al dolore e se la morte, quando si avvicina, possa piegare anche gli animi grandi. Che bisogno c’è di parole? Veniamo al dunque: la morte non rende il saggio più coraggioso di fronte al dolore, né il dolore di fronte alla morte; contro l’una e contro l’altro egli confida solo in sé stesso, né soffre con pazienza perché spera nella morte, né muore volentieri perché stanco del dolore: il dolore lo sopporta, la morte l’aspetta. Stammi bene. 99. Ti mando la lettera che ho scritto a Marullo 7 per la perdita di suo figlio: era ancora piccolo e lui, dicono, non ha la forza di reagire. In quella lettera non gli ho scritto le solite cose e non ho ritenuto di doverlo trattare con dolcezza, poiché più che conforto merita un rimprovero. In un primo tempo bisogna accondiscendere al dolore di chi soffre e mal sopporta una grande ferita, lasciando che sfoghi il primo impeto sino alla sazietà, ma chi si mette a piangere dev’essere rimproverato subito, affinché impari che anche le lacrime sono disdicevoli. Ti aspetti un conforto? E invece, eccoti dei rimproveri. Se ti mostri così debole per la morte di un figlio piccolo cosa faresti se avessi perso un amico? Ti è morto un figlio di speranze incerte, che era ancora un bambino, è poco il tempo che ha passato. Ci procuriamo motivi di dolore e anche a torto ci lagniamo della sorte, come se già non ci desse giuste ragioni di pianto; ma tu, perdio, mi sembravi abbastanza forte anche di fronte a mali reali, tanto più verso quei mali apparenti di cui gli uomini si lamentano perché così sono abituati a fare. Anche se tu avessi perso un amico, che è la perdita più grave, dovresti gioire per averlo avuto più che piangere per averlo perduto. Ma i più non tengono conto dei beni ricevuti, delle gioie che hanno provato. Del resto il dolore per la perdita di un
amico ha un inconveniente: non solo è inutile, è anche ingrato, perché l’avere avuto un amico degno di essere amato non ti ha forse dato dei frutti? Tanti anni passati insieme, una vita e tanti studi in comune, amichevolmente, non sono serviti a nulla? Insieme all’amico seppellisci l’amicizia? E perché ti duoli di averlo perduto se l’averlo avuto non ti giova a nulla? Credimi, molti di coloro che abbiamo amato, anche se la morte li ha portati via, restano con noi, perché il passato ci appartiene e solo ciò che è stato ha un suo posto sicuro. Siamo ingrati verso i beni ricevuti perché speriamo nel futuro, come se il futuro, ammesso che arrivi, non si trasformasse presto a sua volta in passato. Chi gode solo del presente riduce a ben poca cosa i frutti della vita: futuro e passato sono entrambi fonte di piacere, il primo per via dell’attesa, delle aspettative, il secondo per via dei ricordi. Il futuro, però, è incerto e può anche non arrivare, mentre il secondo non può non essere esistito. Che pazzia è dunque disfarsi del più certo dei beni! Accontentiamoci delle gioie di cui abbiamo goduto, sempreché il nostro animo non se le sia lasciate sfuggire, così come un vaso rotto perde tutto il suo contenuto. Sono innumerevoli gli esempi di uomini che hanno seppellito senza una lacrima i propri figli giovinetti, che dal rogo sono tornati in Senato o ai pubblici affari, o si sono subito dedicati ad altre occupazioni. E hanno fatto bene, innanzitutto perché è inutile lamentarsi se il dolore non giova a nulla, e poi perché non è giusto dolersi di quanto accade ad altri. Per non dire che tutti siamo destinati a morire ed è da pazzi lagnarci e rimpiangere ciò che non c’è più: breve è il tempo che intercorre fra la scomparsa di una persona e quella di chi la rimpiange, dunque dobbiamo rassegnarci perché presto seguiremo chi abbiamo perduto. Guarda come il tempo fugge via velocissimo, pensa quanto sia breve questo spazio che percorriamo di corsa, precipitosamente, guarda come l’intera umanità tenda alla medesima meta, a intervalli brevissimi, anche se a noi sembrano molto lunghi: chi se ne è andato in realtà non ha fatto che precederti, anche tu sei su quella strada, dunque è da pazzi piangere la perdita di chi ti ha preceduto. È come piangere per un fatto che si sa che deve accadere. Se poi pensavi che quella persona fosse immortale ti sei voluto ingannare da te. Piangi una persona per un fatto che tu stesso consideri inevitabile. Lamentarsi per la morte di uno è come dolersi ch’egli sia stato un uomo. Siamo tutti legati alla medesima sorte: chi nasce deve morire; anche se in tempi diversi la fine è uguale per tutti. Il tempo che si vive fra il primo e l’ultimo giorno è vario e incerto, lungo anche per un bambino, se ci metti dentro le pene, breve anche per un vecchio, se ne consideri la velocità. Tutto è instabile, ingannevole e più mutevole di ogni tempesta, tutto si turba e si trasforma come comanda la sorte: l’unica cosa certa, fra tanto variare di casi umani, è la morte, e nonostante ciò tutti si lamentano della sola cosa che non inganna alcuno. «Ma è morto un bambino!». Io non ho detto che sia meglio se uno abbandona presto la vita, ma prendiamo chi invecchia e vedremo quanto sia breve il tempo che lo separa da lui. Immagina di abbracciare l’immensità del tempo e dello
spazio, poi metti di fronte all’infinito quella che noi chiamiamo vita umana, vedrai quanto sia poca cosa questa vita che desideriamo e cerchiamo di prolungare. Quanta parte ne occupano le lacrime e gli affanni? E quando desideriamo morire prima del tempo? E le malattie, le paure? Quanta parte di tempo occupano nella vita gli anni dell’incoscienza o dell’inattività e quelli inutili della vecchiaia? Per non dire che metà della vita la passiamo dormendo. Aggiungi poi fatiche, dolori e pericoli e ti renderai conto che anche di un’esistenza lunghissima se ne vive una minima parte. E chi ti dice che non stia meglio chi è morto presto, chi termina il suo cammino prima di stancarsi? La vita non è né un bene né un male, è bene e male insieme. Così quel bambino non ha perso altro che il rischio e forse la certezza di disgrazie maggiori. Sarebbe potuto diventare un uomo moderato e saggio, formarsi nel modo migliore, sotto la tua cura, ma poteva anche diventare simile ai più, e questo non è un timore infondato. Guarda quei giovani che, benché di famiglia nobilissima, la lussuria ha gettato nell’arena, e quegli altri che senza alcun pudore sfogano reciprocamente la propria e l’altrui libidine, ubriacandosi ogni giorno e macchiandosi di qualche grave misfatto: ti sarà chiaro che per siffatti giovani ci sarebbe più da temere che da sperare. Non procurarti, dunque, motivi di dolore e non accrescere con la tua indignazione mali di scarsa importanza. Io non ti esorto affinché ti sforzi per risollevarti: non ti giudico così giù da pensare che tu debba ricorrere a tutta la tua forza per affrontare questa disgrazia. Questo non è dolore, è una semplice fitta, sei tu che ne fai un dolore. Indubbiamente la filosofia ti ha giovato molto se riesci a sopportare con animo forte la perdita di un bambino che oltretutto era più conosciuto alla nutrice che non al padre suo. Con ciò non ti esorto all’insensibilità, a restare col volto impassibile persino al funerale e a non provare nemmeno una stretta al cuore, assolutamente no: è crudeltà, non virtù, guardare la sepoltura dei propri cari con gli stessi occhi con cui li si vedevano da vivi e non commuoversi all’atto del distacco da loro. Ma fa’ conto che io te lo vieti, visto che certe azioni sono spontanee, le lacrime sgorgano anche se si cerca di trattenerle, e d’altra parte sono di sollievo all’animo. Che dire, allora? Lasciamole pure cadere, ma non comandiamoglielo noi, che scorrano seguendo l’impulso della commozione, non perché vediamo piangere gli altri. Non accresciamo così il nostro dolore, non aumentiamolo sull’esempio altrui. L’ostentazione del dolore esige più di quanto il dolore stesso non richieda. Quanti sono tristi spontaneamente? In presenza di altri ci lamentiamo ad alta voce e mentre da soli ce ne stiamo taciti e calmi, appena vediamo qualcuno ci rimettiamo a piangere, ci percuotiamo il capo (cosa che avremmo potuto fare più liberamente quando non c’era alcuno che ci spingesse), ci auguriamo magari di morire anche noi, ci rotoliamo sul letto, ma appena se ne va il pubblico scompaiono pure i segni del dolore. Anche in questa circostanza, come in altre, commettiamo l’errore di seguire l’esempio dei più, badando alle consuetudini, non alla convenienza. Ci allontaniamo dalla natura, ci consegniamo al popolo, sempre cattivo consigliere e in questo caso volubilissimo, come in
tutti gli altri. Se vede uno che sopporta il dolore coraggiosamente lo giudica empio e crudele, se vede un altro gettarsi e svenire sul cadavere di un suo parente lo definisce debole ed effeminato. Ogni cosa, dunque, va ricondotta alla ragione. È quanto mai sciocco farsi la fama di persone tristi e ritenere giuste le lacrime. Io dico che vi sono lacrime a cui anche il saggio si lascia andare, e altre che neppure lui può trattenere. Qui sta la differenza. Come ci giunge notizia di una morte prematura restiamo sconvolti, e quando stringiamo un cadavere che dal nostro abbraccio passerà sul rogo, per una legge naturale ci sgorgano le lacrime e il respiro sotto la stretta del dolore ci squassa tutto il corpo, e al tempo stesso gli occhi si comprimono facendo uscire l’umore che li circonda. Queste lacrime sgorgano contro la nostra volontà, per una compressione interna, mentre quelle a cui diamo libero sfogo quando ripensiamo ai nostri cari scomparsi sono diverse, e pur nella tristezza che ci afferra c’è una certa dolcezza allorché ci sovvengono alla mente i loro amabili discorsi, la loro allegra compagnia, il loro affetto pieno di premure, e allora gli occhi si abbandonano al pianto come accade quando si è felici. Ebbene, nel primo caso siamo vinti dalle lacrime, nel secondo le assecondiamo. Non dobbiamo dunque trattenerle o versarle solo perché intorno o vicino a noi c’è qualcuno, inquantoché in entrambi i casi non lo facciamo spontaneamente, e fingere è vergognoso. Possiamo però farle scorrere pacatamente e in modo composto, ed è così che il saggio le versa, anche spesso, senza perdere la propria dignità ma in tale misura da mantenere insieme umanità e decoro. Io penso che si possa seguire la natura conservando la propria dignità. Ho visto persone rispettabilissime ai funerali di loro familiari che pur recando impressi sul volto i segni evidenti di affetto non avevano tracce esteriori di lutto, e sì che i loro atteggiamenti nascevano da sentimenti sinceri. C’è un decoro anche nel dolore, e il saggio sa bene come mantenerlo, non solo nel caso di un lutto ma sempre: anche nelle lacrime c’è un limite, chi non ha senno, invece, eccede sia nella gioia che nel dolore. Accogli con animo sereno ciò che è inevitabile, poiché nulla di straordinario, nulla d’insolito accade nella vita. Pensa per quanta gente in questo momento si prendono accordi per il funerale o si acquistano i paramenti funebri, a tutti i pianti versati dopo il tuo lutto. Non pensare solo che era un bambino, pensa anche che era un essere umano, che per l’uomo non ci sono certezze e la sorte non lo porta necessariamente alla vecchiaia, lo licenzia a suo capriccio. Quanto al resto parla spesso di lui, esalta quanto più possibile il suo ricordo, e se questo non sarà doloroso ti tornerà alla memoria più frequentemente: nessuno, infatti, sta volentieri con una persona triste, e tanto meno con la tristezza. Se c’è qualche suo discorso, qualche sua battuta di spirito, anche se di bambino, che hai ascoltato con piacere, ricordali spesso, di’ pure senza esitare che avrebbe potuto realizzare ciò che tu come padre speravi. È di un animo crudele dimenticarsi dei propri cari e insieme al loro cadavere seppellirne anche il ricordo, o piangerli prima a dirotto e poi ricordarli di rado. È così che gli uccelli e le belve amano i propri piccoli: il loro amore è concitato, quasi furioso, ma quando li hanno
perduti se ne va interamente. Ciò non si addice a chi è saggio: perseveri nel ricordo ma cessi di piangere. Non sono affatto d’accordo con quanto dice Metrodoro, che cioè esiste un piacere affine alla tristezza e che noi in questi casi dobbiamo coglierlo. Ti trascrivo di seguito le sue precise parole: Metrodòrou epistolòn pròs tèn adelfén. Estin gàr tis edonè lùpe sunghenés, èn chrè therèuein katà toùton tòn kairòn. Non ho dubbi su ciò che pensi in proposito: cosa c’è infatti di più turpe che cogliere il piacere proprio nel dolore, anzi, attraverso il dolore, e cercare un godimento anche fra le lacrime? Sono queste le persone che ci rimproverano un rigore eccessivo e accusano di durezza i nostri insegnamenti perché diciamo che il dolore non va accolto nell’animo o va scacciato subito. E che, dunque? È più assurdo e più disumano non soffrire affatto per la perdita di un amico o cercare il piacere proprio nel dolore? Ciò che insegniamo noi è onesto: dopo che l’affetto ci ha fatto versare qualche lacrima ed è, per così dire, sbollito, non dobbiamo abbandonarci al dolore. Vuoi mescolarlo al piacere? È così che consoliamo i bambini dandogli uno zuccherino, è così che ne smorziamo il pianto dandogli del latte. Non accetti che il piacere cessi neppure mentre tuo figlio brucia sul rogo e muore il tuo amico, ma vuoi solleticare persino la tristezza? È più onesto rimuovere dall’animo il dolore o accordare il piacere anche al dolore? Ma che dico accordare, si cerca di ricavarlo dal dolore stesso! «C’è un piacere», dicono, «affine alla tristezza». Questo possiamo dirlo noi, a voi non è concesso. Voi conoscete un solo bene, il piacere, e un solo male, il dolore: che affinità può esservi fra il bene e il male? Facciamo pure conto che ci sia: la scopriamo adesso? E scrutiamo il dolore per vedere se ha in sé qualcosa di piacevole e di voluttuoso? Certi rimedi che sono salutari per alcune parti del corpo non si possono usare per altre, che sono turpi e indecorose, e ciò che altrove gioverebbe senza offendere il pudore diventa indecente per il posto della ferita: non ti vergogni di guarire un dolore col piacere? Codesta piaga va curata con un rimedio più serio. Piuttosto ricordati che chi è morto non sente alcun male: chi lo sente non è morto. Chi non c’è più, ti ripeto, non può soffrire alcunché, se uno soffre vuol dire che è vivo. Pensi forse che uno possa star male perché non esiste più, o perché esiste ancora? Eppure non può soffrire per il fatto di non esistere (il nulla ha forse sensibilità?), e nemmeno per il fatto di esistere, perché in questo caso è sfuggito al non essere, che è un danno ancora più grave della morte. Diciamo anche questo a chi piange e rimpiange il figlio morto nella prima infanzia: giovani e vecchi, se confrontiamo la nostra breve vita con quella dell’universo, siamo tutti alla pari. Di tutto il tempo possibile a noi tocca meno ancora di quello che si potrebbe definire il minimo, perché il minimo è pur sempre una parte, mentre la nostra vita è quasi un niente, e con tutto ciò noi, pazzi, facciamo progetti a non finire. Ti ho scritto queste cose non perché tu ti attenda da me un rimedio così tardivo (sono certo, infatti, che ti sei già detto ciò che leggerai), ma per rimproverarti di aver deviato, sia pure per un momento, dalla tua strada, e per
spingerti a farti coraggio contro la sorte e a guardare a tutti i suoi colpi non come possibili ma come sicuri. Stammi bene. 100. Mi scrivi di aver letto con sommo desiderio i libri di Fabiano Papirio sulla politica, ma di esserne rimasto deluso perché ti aspettavi di più; inoltre ne critichi anche lo stile, dimenticando che l’autore è un filosofo. Pensa pure che le cose stiano così come tu dici e che le parole siano buttate giù senza un disegno preventivo. Ebbene, innanzitutto uno stile simile ha un suo fascino e la dignità propria di un discorso che scorre dolcemente, una prerogativa che secondo me fa a pugni con una prosa che vien fuori a precipizio. In secondo luogo c’è una grande differenza anche nel fatto che Fabiano sembra mantenere la sua eloquenza entro canali ben precisi, senza disperderla, un’eloquenza vasta, pacata e al tempo stesso impetuosa, e ciò dimostra chiaramente che non è artificiosa e meditata. Ma ammettiamo pure che sia come tu dici: considera che Fabiano con quei libri intendeva dare una regola ai costumi non alle parole, ha scritto per educare, non per compiacere i gusti del lettore, e poi se tu lo avessi sentito parlare non avresti fatto caso ai particolari, tanto ti avrebbe rapito il contenuto. D’altra parte ciò che piace per l’impeto diretto dell’oratore mentre parla e lo si ascolta, quando lo si trascrive rende di meno. Ma è già molto che lo scritto attragga a prima vista l’interesse del lettore, anche se successivamente un esame più attento ne rivelerà certi difetti. Se vuoi saperlo, chi viene apprezzato d’istinto vale più di uno che tale apprezzamento lo merita a ragion veduta, anche se in questo caso l’oratore mostra una sicurezza maggiore e può nutrire speranze più certe di successi futuri. L’eloquenza di un filosofo non deve essere troppo ricercata: non si può essere forti e vigorosi né sfidare sé stessi se si bada troppo alle parole. Fabiano non si curava della forma e tuttavia non era sciatto, in lui non troverai nulla di volgare, le sue parole sono scelte, non ricercate, né usate in un senso opposto alla regola, come vuole invece la moda di oggi, e tuttavia, benché siano prese dal linguaggio comune, riescono eleganti, i concetti sono nobili e alti, espressi piuttosto diffusamente, non sentenziosi. Potremo incontrare qualcosa di eccessivo, qualche frase faticosa, qualche elemento privo di quell’eleganza che si usa oggi, ma nell’insieme non troverai pensieri inutili e meschini. Una casa anche se non dispone di marmi vari, di acqua corrente nelle stanze, della cosiddetta stanza del povero8 e di tutto ciò che il lusso, non pago di ornamenti semplici, può mettere insieme, è sempre, come si dice, una buona casa. Aggiungi che c’è chi preferisce uno stile oratorio, chi un altro, alcuni vogliono una bellezza semplice, ad altri piace una certa asprezza, tanto che se qualche espressione risulta troppo dolce la guastano a bella posta e spezzano le clausole per far sì che giungano inaspettate. Leggi Cicerone: il suo stile è unitario, procede con un ritmo lento e dolce, ma senza esagerare. Quello di Asinio Pollione,9 invece, è scabro, diseguale, e si ferma quando meno te lo aspetti. Insomma, in Cicerone i periodi terminano, in Pollione si interrompono, tranne pochissime eccezioni in cui seguono un ritmo determinato e un unico
modello. Tu dici inoltre che in Fabiano tutto il discorso si mantiene a un livello basso o poco elevato. Io non credo che abbia questo difetto: le sue espressioni non sono modeste, sono pacate, nascono da uno stato d’animo calmo e sereno, dunque non sono basse, sono chiare. Non hanno quel vigore oratorio e quella capacità di stimolare e di colpire con frasi inaspettate, come piace a te, ma l’insieme è bello, non ti sarà sfuggita la sua eleganza. Anche se priva di grandiosità, la sua eloquenza ne dà la sensazione. Citami qualcuno da poter anteporre a Fabiano. Cicerone, d’accordo, i cui libri di filosofia sono numerosi quasi quanto quelli di Fabiano, ma se uno scrittore è inferiore rispetto a uno grandissimo non per questo vale poco. Asinio Pollione, d’accordo, ma occupare il terzo posto in un campo così importante significa farsi notare. Citami ancora Tito Livio, il quale ha scritto dei dialoghi che si possono considerare storici e filosofici e dei libri propriamente filosofici. Bene, ci metto anche lui. Ma nonostante ciò, guarda quanti scrittori superi uno che è superato solo da tre e per giunta eloquentissimi. Fabiano, però, non supera gli altri in tutto: la sua eloquenza, per quanto elevata, non è vigorosa, anche se scorrevole, non è impetuosa e irruenta, è schietta, ma non limpida. Tu dici che dovrebbe essere più severo contro i vizi, più ardito contro i pericoli, più altero di fronte alla fortuna, più offensivo contro l’ambizione. Vorresti che biasimasse il lusso, che sferzasse la libidine, che rintuzzasse l’arroganza, che mostrasse la veemenza propria dell’oratoria, la grandezza della tragedia, l’essenzialità della commedia. Vorresti, insomma, che Fabiano badasse a una cosa da poco, le parole, mentre lui, preoccupato della grandezza dell’argomento, non si è curato dell’eloquenza, che si trascina dietro come un’ombra. D’accordo, i singoli elementi indubbiamente sono poco studiati e collegati male fra loro, le parole non sono tutte accese e pungenti, molte espressioni scivolano via senza colpire e a volte il discorso è privo di forza, ma in ogni pagina ci sono lampi di luce e se ne possono leggere lunghi brani senza annoiarsi. Infine riconoscerai che ciò che ha scritto lo sentiva, comprenderai che il suo intento era non già quello di piacere ma di far sapere ciò che a lui piaceva. La sua opera ha lo scopo di rendere migliori, di educare lo spirito. Tali sono i suoi scritti, almeno così credo, perché ne ho solo un ricordo vago, non li ho ben chiari e bene impressi nella mia mente con tutte le loro peculiarità: li ricordo in modo sommario non come se li avessi letti di recente. Quando lo ascoltavo i suoi discorsi mi sembravano sostanziosi, anche se non legati in maniera organica, capaci di entusiasmare un giovane onesto e di spingerlo all’emulazione, offrendogli magari la possibilità di superarlo, e questa esortazione mi sembra quanto mai efficace. Chi infatti insinua nei giovani il desiderio dell’imitazione distrae la mente e toglie la speranza di riuscire. Del resto l’eloquenza di Fabiano era ridondante e magnifica nell’insieme, ma senza pregi particolari nelle singole componenti. Stammi bene.
1. Il suo vero nome era Publio Claudio Pulcro. Fu tribuno della plebe, violento e fazioso, partigiano di Cesare, avversò Cicerone. Fu ucciso dal tribuno Milone, suo avversario. 2. Era la festa in onore della dea Bona, protettrice della pastorizia e dei boschi. 3. Cicerone, Epistulae ad Atticum I 16, 5. 4. Uomo politico, partigiano di Silla. 5. Virgilio, Eneide II 428. 6. Politico, console e generale, trattò la pace con Pirro dopo la sconfitta di Ascoli, rifiutando l’oro offertogli dal re. 7. Personaggio sconosciuto. 8. Era una stanza in cui i ricchi romani si ritiravano per viverci qualche giorno in povertà. 9. Politico e scrittore, amico di Orazio e di Virgilio, fece costruire a Roma la prima biblioteca pubblica.
Libro diciassettesimo 101. Ogni giorno, ogni ora ci mostra che siamo niente e con qualche nuovo argomento ci ricorda la nostra caducità, di cui spesso ci dimentichiamo, e mentre facciamo progetti a lungo termine, come se fossimo eterni, ci costringe a guardare alla morte. Vuoi sapere il perché di questo esordio? Conosci Cornelio Senecione,1 illustre e cortese cavaliere romano, giunto, da umile origine, a un elevato grado sociale e destinato a ulteriori e facili successi: lo sviluppo di una carriera, infatti, è più facile del suo inizio. Se si è poveri anche il denaro tarda non poco ad arrivare. Si resta attaccati alla povertà finché non si riesce a uscirne. Senecione, ormai, mirava ad arricchirsi e a ciò era spinto da due ottime qualità: la capacità di procurarsi il denaro e quella di saperlo conservare, ma una sola di queste due gli sarebbe stata sufficiente per arricchirsi. Ebbene, quest’uomo, ch’era molto frugale e si curava tanto del suo patrimonio quanto del suo corpo, una mattina era venuto a farmi visita, com’era sua abitudine, e poi per tutta la giornata, sino alla notte, aveva assistito un amico malato costretto a letto senza speranza di poter guarire: dopo aver cenato di buona voglia, colpito da un male fulminante, l’angina, sopravvisse a stento sino all’alba, rantolando a causa delle via respiratorie che gli si erano bloccate. Dunque, in pochissime ore, dopo avere svolto tutte le attività di un uomo sano e forte, se ne andò. Quell’uomo, che faceva girare il denaro per terra e per mare, che aveva partecipato anche a pubblici appalti, senza trascurare alcun tipo di guadagno, proprio quando tutto gli andava bene e il denaro gli arrivava in abbondanza, morì. Ora innesta i peri, disponi in filari le viti, o Melibeo.2 È da stolti disporre della propria vita quando non siamo sicuri nemmeno del domani. Quanto sono pazzi coloro che fanno progetti lontani nel futuro: comprerò, presterò denaro, ne riscuoterò, ricoprirò cariche pubbliche e alla fine trascorrerò nell’ozio la vecchiaia, stanco ma soddisfatto. Credimi, tutto è incerto, anche per i più fortunati, è inutile ripromettersi qualcosa per il futuro quando ciò che abbiamo al presente ci sfugge e il caso tronca anche l’ora a cui siamo attaccati. Il tempo scorre in virtù di una legge ben precisa, che noi non conosciamo, e che c’importa che per la natura sia certo ciò che per noi è incerto? Progettiamo di fare lunghi viaggi per mare e di tornare in patria dopo aver vagato a lungo per lidi stranieri, sogniamo imprese militari e ricompense tardive di fatiche belliche, amministrazioni di province e avanzamenti di carriera, una carica dietro l’altra, mentre la morte cammina al nostro fianco, e poiché ci pensiamo solo quando tocca agli altri, ogni tanto ci si offrono esempi della nostra caducità, che non durano in noi più dello stupore che ne proviamo. Ma è da stolti stupirsi che accada un giorno ciò che può accadere in ogni momento. La nostra fine sta dove l’ha fissata l’inesorabile ineluttabilità del destino, ma nessuno di noi sa quanto tempo ci separi da lei, perciò prepariamo il nostro
animo come se vi fossimo già arrivati, non rimandiamo nulla, chiudiamo ogni giorno i conti con la vita. Il più grande difetto della vita sta nel fatto che resta sempre in sospeso e che se ne rimanda sempre una parte, ma chi ogni giorno dà l’ultima mano alla sua vita non ha bisogno di tempo, ed è da qui, da questo bisogno, che nascono la paura e la bramosa attesa del futuro che consuma l’animo. Non c’è nulla di più triste che il chiedersi come si concluderanno gli eventi futuri, chi sta in ansia pensando quanto tempo gli resta ancora da vivere è agitato da una paura inesplicabile. Come sfuggire a questa inquietudine? C’è un solo modo: se non proiettiamo la nostra vita verso il futuro ma la raccogliamo in sé stessa; è il presente che va vissuto, altrimenti si resta in balìa del futuro, e chi ha pagato il debito che aveva con sé stesso e ha capito chiaramente che non c’è differenza fra un giorno e un secolo può guardare con distacco il susseguirsi dei giorni e dei fatti futuri e sorridere al succedersi degli anni. Chi resta saldo di fronte a ciò che è incerto non può essere turbato dall’incostanza e dalla varietà dei casi della vita. Affrettati dunque a vivere, Lucilio mio, e ogni giorno sia per te come una vita. Chi così si adatta alla realtà e ogni giorno lo vive come se la sua esistenza fosse compiuta, vive tranquillo e sereno, se invece uno si nutre di speranze gli sfugge anche il tempo più vicino e subentra in lui la brama della vita e la paura meschina della morte che rende infelice ogni cosa. È da qui che nasce quel turpe voto di Mecenate, che, pur di continuare a vivere anche fra le sventure, è disposto ad accettare malattie e deformità e persino il supplizio del palo: fammi storpio di una mano e zoppo di una gamba, fammi crescere la gobba, fammi cadere i denti: purché continui a vivere, va bene; mantienimi pure in vita su un palo di tortura. Egli, insomma, si augurava un destino molto infelice, se si fosse realizzato, e, pur di vivere, chiedeva un supplizio continuo. Per me è già spregevolissimo il voler vivere sino al patibolo, ma lui dice di più: «Storpiami pure, purché lo spirito rimanga in questo corpo inutile e privo di forze; sfigurami pure, purché, anche deforme e mostruoso, io possa vivere ancora un poco; impalami, crocifiggimi». Ebbene, vale la pena premersi la ferita e penzolare dalla forca con gli arti slogati, pur di rinviare la cosa che dovrebbe essere la più desiderabile quando si soffre, cioè la fine dei tormenti? Vale la pena avere la vita solo per esalarla? Cos’altro potrebbe augurarsi a un individuo simile se non che gli dèi l’accontentino? A cosa mira codesta vergogna di versi così effeminati? Questo patto ispirato da una paura totalmente insensata? E questo mendicare così oscenamente la vita? Potresti mai pensare che Virgilio non abbia
recitato a Mecenate questo verso: Per te morire è dunque così triste?3 Ma cosa ci guadagna ad augurarsi i mali più atroci e a voler prolungare e sopportare le più terribili sofferenze? Una vita più lunga, evidentemente. Ma che vivere è un così lungo morire? Può mai esserci qualcuno che preferisce consumarsi fra i tormenti, morire pezzo per pezzo ed esalare l’anima ripetutamente in uno stillicidio continuo, invece di morire in un colpo solo? Può mai esserci qualcuno che vuole prolungare una vita siffatta, causa di tante sofferenze, attaccato a quel palo maledetto, storpio, deforme, con una turpe gobba sul petto e sulla schiena, quando avrebbe avuto già motivi bastanti per morire senza arrivare alla croce? Di fronte a un tale esempio dimmi che la morte, nella sua ineluttabilità, non è un grande beneficio della natura. Molti sono disposti a fare patti ancora più vergognosi, anche a tradire un amico, pur di allungarsi la vita, a consegnare personalmente i propri figli allo stupro, pur di poter vedere la luce, testimone di tanti delitti. Scuotiamoci di dosso questa smania di vivere e impariamo che non importa sapere quando ci toccherà ciò che prima o poi dovremo subire: ciò che conta è vivere bene, non vivere a lungo, ma spesso il vivere bene consiste proprio nel non vivere a lungo. Stammi bene. 102. Quando stiamo facendo un bel sogno chi ci sveglia c’infastidisce perché ci toglie un piacere, il quale, benché falso, ha effetti reali. Ebbene, la tua lettera mi ha procurato un dispiacere analogo: mi ha distolto dalla meditazione in cui ero concentrato e che se fosse dipeso da me non avrei interrotto. Stavo indagando piacevolmente sull’immortalità dell’anima, anzi, perbacco, ci credevo; ero pronto ad accogliere l’opinione di grandi uomini i quali, più che dimostrare, promettono una realtà graditissima. Mi lasciavo andare a una speranza così insolita, provavo disgusto di me stesso, disprezzavo i resti di un’esistenza spezzata per passare all’eternità, in possesso di ogni tempo, quando l’arrivo della tua lettera improvvisamente mi ha risvegliato e ho perso un sogno tanto bello. Ma quando ti avrò congedato, voglio riprendermelo e rientrarne in possesso. All’inizio della lettera tu dici che io non ho spiegato interamente la questione, quando ho cercato di dimostrare la tesi degli stoici secondo cui la gloria ottenuta dopo la morte è un bene. Non avrei, cioè, risposto all’obiezione che ci viene rivolta: «Non c’è bene dove c’è separazione, e in questo caso c’è separazione». Ciò che mi chiedi, Lucilio mio, rientra nello stesso argomento, ma è un altro punto della questione ed è per questo che avevo rimandato il problema, insieme ad altri analoghi, dato che, come ben sai, certe parti della logica sono legate alla morale. Per questo ho trattato prima quella parte che riguarda direttamente la morale, se cioè non sia inutile e insensato spingere le nostre preoccupazioni al di là dell’ultimo giorno di vita, se i nostri beni finiscano con
noi e non resti più niente di chi se ne va, se di una cosa che quando accadrà non la percepiremo si possa cogliere qualche frutto o almeno cercare di coglierlo prima che essa si verifichi. Tutti questi problemi riguardano la morale: perciò li ho messi al loro posto. Ma le argomentazioni dei dialettici contro questa tesi dovevano essere separate e perciò le ho staccate. Ora, poiché esigi una trattazione completa, esporrò tutte le loro obiezioni, poi le confuterò una per una. Devo però fare una premessa affinché le mie confutazioni risultino chiare. Qual è questa premessa? Esistono dei corpi unitari, come l’uomo; altri, invece, composti, come una nave, una casa, in poche parole tutti quelli che sono formati dall’unione di parti diverse; altri ancora costituiti da elementi distinti, le cui membra sono divise, come un esercito, un popolo, un’assemblea. Gli individui che compongono tali organismi sono uniti per legge o per funzioni analoghe, ma distinti per natura e a sé stanti. Un’altra premessa: secondo noi non esiste bene che sia formato da elementi separati tra loro; un bene deve essere racchiuso e retto da un solo principio, unica deve essere la sua essenza. Questo principio, quando ti andrà, troverai che si dimostra da sé, ma io intanto ho dovuto premetterlo perché ci rivolgono contro le nostre stesse armi. «Voi sostenete che non c’è bene formato da elementi separati tra loro; ma», ribattono, «la gloria di un uomo nasce dal consenso di persone virtuose. Come la fama e l’infamia non sono date dalle parole di un solo individuo, così la gloria non la dà l’approvazione di una sola persona virtuosa, ma affinché si formi richiede il consenso di molti uomini insigni e ragguardevoli. La gloria, però, deriva dal parere di più persone, cioè di elementi distinti; quindi non è un bene. «La gloria» – continuano – è la lode tributata da uomini virtuosi a un uomo virtuoso; la lode è un’espressione, una frase che indica qualcosa; e una frase, anche se pronunciata da uomini virtuosi, non è un bene: non tutto ciò che fa un uomo virtuoso è un bene; egli applaude e fischia, ma, anche se ogni suo gesto è degno di ammirazione e di lode, un applauso o un fischio, come uno starnuto o un colpo di tosse, nessuno può definirli un bene. Quindi, la gloria non è un bene. «Insomma, diteci se la gloria è un bene di chi loda o di chi è lodato: se dite che è un bene di chi è lodato la vostra è un’affermazione ridicola, come dire che è un bene mio la salute di un altro. Ma lodare chi è degno di lode è un’azione virtuosa; perciò è un bene di chi loda, cioè di chi compie l’azione, non di noi, che siamo lodati. Questo è appunto l’oggetto della nostra indagine». Ora risponderò rapidamente a ciascun problema. La prima domanda è se un bene possa derivare da elementi separati: su questo punto i pareri sono discordi. La gloria, poi, ha bisogno del consenso di molti, o basta il giudizio di una sola persona virtuosa? Un uomo virtuoso può giudicare della nostra virtù. «Ma come?», si ribatte. «La fama deriverà dalla stima e l’infamia dalla maldicenza di un solo individuo? Anche la gloria noi la intendiamo ampiamente diffusa, poiché richiede il consenso di molti». Sono due casi diversi. Perché se un uomo virtuoso mi giudica bene è come se così mi giudicassero tutti gli uomini virtuosi, visto che tutti costoro se mi conoscessero mi giudicherebbero allo stesso modo.
Il loro giudizio è uguale e identico, perché improntato unicamente alla verità. Non possono esserci discordanze, dunque è come se tutti fossero del medesimo parere, poiché non possono pensarla diversamente l’uno dall’altro. Per la gloria, invece, o per la fama, non basta l’opinione di una sola persona. Nel primo caso un solo parere vale quanto quello di tutti, perché, se si domandasse a tutti, uno per uno, unica sarebbe la risposta: nel secondo caso i giudizi sono diversi, poiché sono diverse le persone. Difficilmente troverai l’unanimità: sempre dubbi, sospetti o leggerezza. Credi che tutti possano esprimere un parere unico? Ma se non ce l’ha nemmeno una sola persona! Gli uomini virtuosi amano la verità e la verità ha una sola forza, una sola faccia: gli altri invece dànno il loro consenso a opinioni false. Le persone false sono incostanti; variano e discordano fra loro. «Però la lode», dicono, «è solo una frase, e una frase non è un bene». Ma quando affermano che la gloria è una lode tributata a uomini virtuosi da uomini virtuosi si riferiscono non alle parole ma al giudizio espresso. Anche se un uomo virtuoso non lo dice ma giudica uno degno di lode, costui viene lodato. Inoltre, la lode e il lodare non sono la stessa cosa: il lodare richiede anche la parola, per cui, a esempio, non diciamo lode funebre, l’espressione corretta è orazione funebre, poiché si tratta di un ufficio basato sulla parola. Quando invece diciamo che uno è meritevole di lode gli attribuiamo giudizi benevoli, non parole. In definitiva è lode anche quella di chi non parla ma giudica positivamente e loda un uomo virtuoso dentro di sé. E poi, come ho detto, la lode riguarda l’animo, non le parole, che fungono da tramite e la rendono nota a più persone. Se si ritiene che una lode sia dovuta questo è già un lodare. Quando Nevio, quel famoso poeta tragico latino, dice che è splendido «essere lodato da un uomo lodato», intende dire da un uomo degno di lode. E quando quell’altro poeta altrettanto antico4 dice che «la lode alimenta le arti» non intende il lodare, che in realtà corrompe le arti, poiché niente ha guastato tanto l’eloquenza e ogni altra arte destinata alle orecchie quanto il consenso popolare. In ogni caso la fama ha bisogno della voce, mentre la gloria può nascere anche senza, basta un giudizio benevolo, anzi, nulla le tolgono non solo il silenzio ma nemmeno le proteste. Ecco la differenza fra gloria e celebrità: questa si fonda sul giudizio di molti, la gloria su quello delle persone virtuose. «La gloria», chiedono, «cioè la lode tributata a un uomo virtuoso da uomini virtuosi, è un bene di chi è lodato o di chi loda?». Di entrambi. Appartiene anche a me che vengo lodato, e poiché la natura mi ha creato disposto ad amare tutti, godo di aver fatto del bene e mi rallegro di aver trovato grati interpreti delle virtù. Questo essere grati è un bene di molti, ma è anche mio; la mia disposizione d’animo è tale che giudico mio un bene di altri, soprattutto di coloro a cui sono motivo di bene. La gloria è un bene anche di chi loda: è un atto della virtù e ogni azione virtuosa è un bene. Ma questo bene non sarebbe toccato loro se io non fossi quale sono. Perciò una lode meritata è un bene di entrambi, di chi loda e di chi è lodato, come esprimere un giusto giudizio è un bene di chi giudica e di
colui a favore del quale è stato pronunciato quel giudizio. Dubiti forse che la giustizia sia un bene vuoi per chi la esercita, vuoi per colui al quale paga un debito? Lodare chi lo merita è una forma di giustizia, dunque, è un bene di entrambi. Abbiamo risposto abbondantemente a questi cavillatori. Ma noi non dobbiamo fare queste sottili discussioni, abbassando la filosofia dalla sua altezza a questi limiti ristretti: è meglio avanzare per una via aperta e diritta, invece che costruirsi da sé un cammino tortuoso da percorrere con grave disagio. Queste dispute non sono che passatempi di persone che cercano abilmente di sorprendersi a vicenda. Dimmi piuttosto come sia conforme alla natura distendere la mente nell’immensità dell’universo. L’anima dell’uomo è una cosa grande e nobile; non sopporta che le siano posti altri limiti se non quelli comuni anche agli dèi. Prima di tutto non si accontenta di una patria piccola, si tratti di Efeso, di Alessandria o di qualunque altra terra anche più popolosa e più ricca di case: la sua patria è quella che cinge l’intero universo nel suo cerchio, è tutta la volta celeste entro cui giacciono mari e terre, entro cui l’atmosfera distingue e insieme congiunge l’umano e il divino, in cui sono distribuite tante divinità che attendono vigili all’adempimento delle proprie funzioni. Per di più l’anima non consente che le venga assegnata un’esistenza angusta: «Tutti gli anni», dice, «sono miei; nessuna epoca è preclusa ai grandi spiriti, ogni tempo è aperto al pensiero. Quando arriverà il giorno che separerà questo insieme di umano e di divino lascerò il mio corpo qui dove l’ho trovato, e tornerò fra gli dèi. Non che ora io sia del tutto separato da loro, semplicemente sono trattenuto dal grave peso terreno». Queste tappe della vita mortale sono una preparazione a quell’altra vita, migliore e più lunga. L’utero materno ci ospita per nove mesi e ci prepara non per sé, ma per quel luogo in cui veniamo alla luce già capaci di respirare e di resistere all’aria aperta; allo stesso modo in questo periodo che va dall’infanzia alla vecchiaia maturiamo per un altro parto. Ci aspetta una nuova nascita, una nuova condizione di vita. Noi per ora possiamo sostenere la vista del cielo solo da lontano, dunque guarda sicuro all’ora decisiva che ci aspetta: è l’ultima, ma per il corpo, non per l’anima. Guarda tutte le cose che ti stanno intorno come se fossero le suppellettili di una residenza provvisoria: dobbiamo andare altrove. La natura spoglia chi se ne va, come chi viene, non ci è lecito portar via più di quanto avevamo nel momento in cui siamo nati, anzi, dobbiamo lasciare gran parte anche di ciò che ci siamo portati dietro per vivere: questo involucro esterno che ci avvolge, la pelle, la carne e il sangue che scorre per l’intero organismo, tutto ci sarà tolto, anche le ossa e i nervi che sostengono gli elementi liquidi e molli. Questo giorno che temiamo come ultimo è il primo dell’eternità. Deponi il peso della materia: che aspetti? Anche allora non sei venuto alla luce lasciando il corpo in cui eri avvolto e nascosto? Ti aggrappi, opponi resistenza: anche allora tua madre ti espulse con un grande sforzo. Ti lamenti, supplichi di poter restare: anche questo è un pianto tipico di un neonato, ma allora avevi una giustificazione perché eri venuto al mondo inesperto e
ignaro. Uscito dal caldo e morbido rifugio delle viscere materne, ti carezzò il soffio dell’aria libera, poi sentisti il contatto di una mano ruvida, e ancora tenero e del tutto inconsapevole rimanesti attonito di fronte a una realtà sconosciuta: ora, invece, non è per te una cosa nuova essere separato da un corpo a cui prima appartenevi; abbandona serenamente queste membra ormai inutili e lascia questo corpo in cui hai abitato a lungo. Sarà lacerato, sepolto, si consumerà: perché ti affliggi? Così è: va sempre perduto l’involucro che avvolge chi nasce. Perché ami questo corpo come se fosse tuo? Ti ha solo ricoperto: verrà il giorno che ti separerà strappandoti alla convivenza con questo sconcio e putrido ventre. Ma tu liberatene già adesso per quanto ti è possibile, e sii indifferente ai piaceri tranne a quelli * * * connessi alle necessità della vita, medita fin da ora su qualcosa di più profondo e nobile: un giorno ti si sveleranno i misteri della natura, si dissiperà codesta nebbia e da ogni parte ti colpirà una luce splendente. Immagina quanto è grande il bagliore di tanti astri che uniscono le loro luci. Nessun’ombra offuscherà il sereno; ogni parte del cielo splenderà ugualmente luminosa: giorno e notte si avvicendano solo nella nostra infima atmosfera. Dirai di essere vissuto nelle tenebre, quando con tutto te stesso vedrai la luce nel suo pieno fulgore, quella luce che ora vedi confusamente attraverso la strettissima fessura degli occhi, e che tuttavia, anche da lontano, guardi con stupore. Quale ti apparirà la luce divina quando la vedrai nella sua sede? Questo pensiero scaccia dall’animo tutto ciò che è meschino, vile e crudele. Ci dice che gli dèi sono testimoni di tutto; c’impone di essergli graditi, di prepararci al futuro incontro e di guardare fin da ora all’eternità. Chi concepisce questo pensiero non prova terrore per qualsivoglia esercito, non si spaventa nell’udire la tromba di guerra, non teme minaccia alcuna. Se si spera nella morte non si può avere paura. E chi crede che l’anima esista soltanto finché è trattenuta dai legami del corpo, e che una volta libera scompaia, si comporta in modo da poter essere utile anche dopo la morte. Benché venga sottratto alla vista del prossimo, tuttavia sempre assedia la sua mente la grande virtù dell’eroe e la sua nobile stirpe.5 Pensa quanto ci giovino gli esempi di virtù: ti renderai conto che il ricordo dei grandi uomini ci è utile quanto la loro presenza. Stammi bene. 103. Perché ti preoccupi di ciò che può accaderti quando potrebbe anche non accaderti? Voglio dire un incendio, un crollo e altri eventi simili che avvengono ma che non stanno lì a minacciarci: piuttosto cerca di tener d’occhio quei mali che sembrano spiarci e volerci cogliere di sorpresa e adoperati per evitarli. Fare naufragio e finire sotto un carro, anche se gravi, sono casi rari, mentre è facile e frequente un pericolo che viene dall’uomo, è questo che devi sempre essere pronto ad affrontare e dunque tienilo d’occhio continuamente, perché non ci sono mali più costanti, più ostinati e più striscianti di questi. Il cielo rumoreggia
prima che si scateni il temporale, le case scricchiolano prima di crollare, l’incendio è preannunciato dal fumo, ma il danno che proviene dall’uomo è improvviso e quanto più è vicino tanto più si nasconde. Non credere a chi ti viene incontro col volto sereno, perché ha sempre l’aspetto di un uomo e l’animo di una belva, la quale, però, è pericolosa proprio al primo attacco, una volta che ti supera senza avventarsi non ti cerca più. Le belve nuocciono solo se sono spinte dalla necessità, assalgono per fame o per paura, mentre l’uomo gode nel distruggere un suo simile. Tuttavia il pensiero del pericolo che può venirti dall’uomo non ti faccia dimenticare il tuo dovere di uomo, quello, cioè, di non far torti, e bada a non subirne. Gioisci del bene di tutti, commuoviti delle disgrazie altrui e ricorda ciò che devi fare e ciò che devi evitare. Vivendo così, avrai almeno il vantaggio di sfuggire agli inganni, se proprio non puoi sottrarti alle offese. Per quanto ti è possibile cerca rifugio nella filosofia: ti proteggerà nel suo grembo, nel suo santuario sarai sicuro, o almeno più sicuro. Si scontrano solo quelli che procedono sulla medesima strada. Non devi però vantarti della filosofia: molti, praticandola con arroganza e con insolenza, ne hanno ricavato un pericolo: servitene, insomma, per emendare te stesso dai vizi, non per rinfacciarli agli altri, fa’ che essa non si allontani dalla moralità comune e non ti mostri come uno che condanna tutto ciò che non fa. Si può essere saggi senza darlo a vedere e senza rendersi odiosi. Stammi bene. 104. Mi sono rifugiato nella mia villa di Nomento,6 cercando scampo non dalla città, come potresti credere, ma da una febbre per di più insidiosa che si era già impadronita di me. Dai battiti del polso, alterati e irregolari tanto da turbare le normali funzioni, il medico diagnosticava l’inizio di una malattia. Perciò ho ordinato subito la carrozza e, nonostante l’opposizione della mia Paolina,7 ho insistito per partire. Mi era davanti agli occhi l’immagine di mio fratello Gallione,8 che in Grecia, essendosi preso la febbre, si era imbarcato sull’istante, proclamando che il male era non del suo corpo ma di quel luogo. Così ho detto alla mia Paolina, che mi raccomanda sempre di badare alla mia salute, e io, sapendo che noi due siamo uno spirito solo, per un riguardo a lei, comincio a riguardare me stesso. E se da un lato la vecchiaia mi ha reso più forte sotto tanti aspetti, praticamente perdo questo beneficio dell’età, pensando che in questo vecchio c’è anche una giovane a cui devo attenzione, e poiché non posso ottenere che lei mi ami con maggior forza lei ottiene da me che io mi ami con maggior cura. Bisogna assecondare gli affetti onesti, e talvolta, anche di fronte a motivi gravi e a costo di sofferenze, occorre richiamare lo spirito vitale per rispetto dei propri cari, trattenerlo coi denti, visto che un uomo virtuoso deve vivere non fino a quando gli piace, ma fino a quando è necessario: chi non stima la moglie o un amico al punto da prolungare la propria esistenza, chi si ostina a voler morire, è un effeminato. L’anima, quando lo esiga il vantaggio delle persone care, deve imporsi di rinviare non solo se ha deciso di morire, ma anche se ha cominciato a morire, e di compiacere i suoi cari. È di un animo nobile
tornare alla vita per amore degli altri e i grandi uomini l’hanno fatto spesso. Ma io, benché il più grande vantaggio della vecchiaia consista in una minore preoccupazione di sé e in un uso più coraggioso della vita, ritengo segno di alta umanità anche curare con maggiore attenzione la propria condizione di salute, se si sa che ciò è caro, utile e augurabile per qualcuno dei propri cari. Oltretutto un simile comportamento è persino piacevole e gratificante: cosa c’è, infatti, di più gradito che essere alla moglie tanto caro da diventare più caro anche a sé stesso? Così la mia Paolina può imputarmi non solo i suoi timori, ma anche i miei. Vuoi sapere, dunque, quale risultato abbia avuto la mia decisione di partire? Appena mi sono lasciato alle spalle l’aria pesante della città e l’odore delle cucine fumanti che quando sono accese diffondono con la polvere tutti i vapori pestiferi che hanno assorbito, subito mi sono accorto che il mio stato di salute era mutato. E non ti dico come mi sia sentito più in forze appena giunto nei miei vigneti. Uscito nel pascolo, mi sono buttato sul cibo e subito mi sono ripreso, è scomparso quel torpore di un fisico malfermo e inoperoso. Mi getto a capofitto nello studio: per studiare, infatti, non è tanto il luogo che conta quanto la concentrazione; uno, se vuole, può crearsi un suo spazio anche in mezzo a tutte le occupazioni, ma chi si limita a scegliersi un posto e a cercare un po’ di tranquillità, troverà dovunque motivi di distrazione. Si narra che Socrate a un tizio che si lamentava di non aver tratto alcun giovamento dai suoi continui viaggi rispose: «È naturale: viaggiavi con te stesso!». Come starebbero bene certuni se si staccassero da sé stessi! E invece si opprimono, si affliggono, si guastano, si spaventano: tutto da soli. A che serve cambiare città, attraversare gli oceani? Se vuoi liberarti dai tuoi affanni non devi trasferirti altrove, devi diventare un altro. Fa’ conto di essere andato ad Atene, a Rodi o in un’altra città a tua scelta: che importanza hanno, per te, gli usi e i costumi locali? Tu vi porti i tuoi. Se giudichi un bene il denaro, ti angustierà una povertà falsa, che è la cosa più triste. Sebbene tu possieda molto, se c’è uno più ricco di te ti sentirai inferiore a lui per quanto ha in più. Se per te le cariche pubbliche contano molto ti dispiacerà che Tizio sia stato nominato console, che Caio sia stato rieletto, proverai invidia ogni volta che leggerai il nome di qualcuno negli atti ufficiali. Il furore della tua ambizione sarà così grande che se hai qualcuno davanti a te ti sembrerà di avere una folla dietro di te. Giudicherai la morte il peggiore dei mali, mentre in realtà nella morte non c’è nulla di male se non il timore che la precede. Ti spaventeranno non tanto i pericoli quanto i sospetti; sarai sempre agitato da vani fantasmi. Allora a che ti avrà giovato l’essere uscito illeso, con la fuga da tanti Greci e tanta gente ostile?9 Persino la pace scatenerà le tue paure, poiché quando la mente è turbata, non ci si fida più neppure di ciò che è sicuro, e quando questi timori infondati diventano un’abitudine, non si è più capaci di proteggere sé stessi: i pericoli non
li evitiamo, li fuggiamo, e chi gira le spalle è più vulnerabile. Perdere una persona cara lo giudicherai un male gravissimo, e invece questo atteggiamento è sciocco quanto piangere perché le belle piante che adornano la tua casa perdono le foglie. Guarda le cose che ti dànno gioia con lo stesso occhio con cui guarderesti quelle piante: godine, finché sono in fiore. Il caso strappa alla vita un giorno uno, un giorno un altro; ma come la perdita delle foglie è facile sopportarla perché esse rinascono, così è facile sopportare anche la perdita di quelli che amavi e che consideravi la gioia della tua vita, perché, anche se non rinascono, puoi sostituirli. «Ma non saranno gli stessi», dirai. Neppure tu sarai lo stesso. Ogni giorno, ogni ora che passa, ti cambia; ma negli altri questa rapina del tempo è più evidente, mentre in noi passa inosservata, perché non è manifesta. Gli altri ci vengono strappati, ma noi siamo sottratti a noi stessi furtivamente. Perché invece di pensare a questo e cercare di curare le ferite, ti crei da te stesso motivi di preoccupazione ora con la speranza, ora con la disperazione? Se sei saggio, modera l’una con l’altra: non sperare senza disperarti e non disperare senza nutrire qualche speranza. Un viaggio, di per sé, che giovamento ha mai potuto dare? Non modera i piaceri, non frena le passioni, non reprime l’ira, non stanca gli indomabili istinti dell’amore, in poche parole non libera l’anima da alcun male. Non rende assennati, non dissolve l’errore, ma ci attrae temporaneamente con qualche novità come un bambino che ammiri cose sconosciute. Rende invece lo spirito, già gravemente infermo, ancora più incostante, e questo agitarsi lo fa diventare più instabile e volubile. Così gli uomini abbandonano ancora più smaniosi quei posti che avevano tanto smaniosamente cercato, li oltrepassano a volo e se ne vanno più velocemente di quando erano venuti. Viaggiare ti farà conoscere altre genti, ti mostrerà monti di forme mai viste, pianure di singolare estensione e valli irrigate da corsi d’acqua perenni; attirerà la tua attenzione sulla natura particolare di qualche fiume, come il Nilo, che d’estate è gonfio di acque, o come il Tigri, che scompare alla vista e dopo aver percorso un tratto sottoterra riprende la grandezza di prima, o come il Meandro,10 piacevole palestra di tutti i poeti, che si avvolge su sé stesso con un corso sempre tortuoso, e spesso, quando è vicino al suo letto, devia, prima di affluire nelle proprie acque: ma un viaggio non ti renderà migliore né più assennato. È allo studio che dobbiamo dedicarci e avere familiarità coi maestri di saggezza per apprendere i frutti delle loro esperienze e ricercare le verità non ancora scoperte. Così, sottraendo l’animo alla più misera schiavitù, si rivendica la propria libertà. Ma fintantoché ignorerai cosa si debba fuggire, che cosa ricercare, cosa sia necessario o superfluo, giusto o ingiusto, il tuo non sarà viaggiare, sarà vagabondare. Correre qua e là non ti servirà a nulla, quando vai in giro con le tue passioni e i tuoi mali ti seguono, anzi, almeno ti seguissero, sarebbero abbastanza lontani; né tu li precedi: li porti con te. Perciò ti assillano dovunque e ti bruciano con la stessa intensità di prima. L’ammalato deve cercare la medicina adatta, non un nuovo paese. Chi si è rotto una gamba o si è provocato una distorsione non sale su una
carrozza o su una nave, chiama il medico affinché gli riduca la frattura o gli aggiusti la lussazione. E allora? Pensi che cambiando paese puoi guarire un’anima che ha subìto tante fratture e distorsioni? Questo male è troppo grave perché si possa curarlo con una passeggiata in vettura. Viaggiare, poi, non rende medici o oratori, non c’è scienza che si possa apprendere da un luogo. Dunque? La saggezza, la più importante di tutte le scienze, si può forse acquisire in un viaggio? Non c’è strada, credimi, che ti porti fuori dalle passioni, dall’ira, dalla paura: se ci fosse, l’umanità vi si dirigerebbe in massa. Finché ne porterai le cause con te, questi mali ti incalzeranno e ti tormenteranno nei tuoi vagabondaggi per terra e per mare. Ti stupisci che fuggire non ti serva? I mali che fuggi sono in te. Correggiti, dunque, liberati dai pesi che porti, e contieni i tuoi desideri entro limiti convenienti; estirpa dall’anima tutto ciò che è malvagio. Vuoi fare dei viaggi piacevoli? Guarisci chi ti accompagna. Finché vivrai insieme a un taccagno l’avarizia ti resterà attaccata addosso, e così l’orgoglio finché frequenterai un superbo; se vivrai con un carnefice non ti libererai della tua crudeltà; l’amicizia degli adulteri infiammerà la tua libidine. Se vuoi spogliarti dei vizi devi stare lontano da esempi di vizi. L’avaro, il corruttore, il crudele, il truffatore, che già nuocerebbero molto se ti fossero vicini, li hai dentro di te. Passa a compagni migliori: vivi con Catone, Lelio, Tuberone. E se ti piace anche stare insieme ai Greci intrattieniti con Socrate, con Zenone: l’uno ti insegnerà a morire se sarà necessario, l’altro prima che sia necessario. Vivi con Crisippo, con Posidonio: ti trasmetteranno la conoscenza dell’umano e del divino, ti inviteranno ad agire, non solo a parlare con eleganza e a ostentare belle parole per il piacere dell’uditorio, a rafforzare l’animo e a ergerlo contro tutte le minacce. In questa vita incerta e agitata non c’è che un porto: disprezzare il futuro, essere fermi, decisi e pronti a ricevere i colpi della fortuna, in pieno petto, senza nascondersi o temporeggiare. La natura ci ha creati magnanimi e come ad alcuni animali ha dato la ferocia, ad altri l’astuzia, ad altri la paura, a noi ha elargito uno spirito desideroso di gloria e di grandezza, che si sforza di vivere onestamente, non in modo totalmente tranquillo; uno spirito molto simile a quell’universo che egli segue e imita per quanto è consentito alle sue forze; così cerca di progredire, convinto di essere ammirato e lodato. Padrone di tutte le cose, è superiore a tutto, dunque non si sottometta a niente, niente giudichi gravoso, niente capace di piegare l’uomo. Spettri orrendi a vedersi, la Sofferenza, la Morte.11 Niente affatto: se siamo capaci di guardarle con sguardo fermo, squarciando le tenebre; molti fantasmi che di notte ci atterriscono, di giorno ci fanno sorridere. Spettri orrendi a vedersi, la Sofferenza, la Morte:
ha detto bene il nostro Virgilio: terribili a vedersi, nella forma, non nella sostanza, cioè sembrano, non sono. Che c’è in loro di tanto spaventoso quanto si va dicendo? Andiamo, Lucilio, per quale motivo un uomo dovrebbe temere la sofferenza e la morte? Tante volte incontro persone che giudicano irrealizzabile ciò che loro non possono fare e dicono che parliamo di cose insostenibili dalla nostra umana natura. Ma io non la penso così! Anche loro sono in grado di fare tali cose, ma non vogliono. E poi, è stato mai deluso chi ha tentato di farle? All’atto pratico non sono apparse più facili? Non è che non osiamo perché sono difficili, sono difficili perché non osiamo. Vuoi un esempio? Guarda Socrate, vecchio e paziente: tormentato da ogni sorta di sventure, non fu piegato né dalla povertà, che il peso della famiglia gli rendeva ancora più grave, né dai disagi che dovette sopportare anche in guerra. In casa, poi, fu messo a dura prova: la moglie scorbutica di carattere e petulante, i figli ribelli e più simili alla madre che al padre. Visse poi o in guerra, o sotto la tirannide, o in una libertà più crudele della guerra e della tirannide. La guerra durò ventisette anni e alla fine la città si piegò al funesto dominio dei trenta tiranni, di cui la maggior parte gli era ostile. In ultimo fu condannato con accuse gravissime: lo incolpavano di vilipendio alla religione, di corruzione dei giovani, che aveva istigato contro gli dèi, contro gli avi e la città. E alla fine gli toccarono pure il carcere e il veleno. Ma non un turbamento, nell’animo e nel volto. Oh, quale vanto, unico e sublime! Nessuno vide Socrate sino all’ultimo istante della sua vita o più lieto o più triste: in tanto variare di casi egli rimase sempre lo stesso. Un altro esempio? Catone il giovane. Contro di lui il destino fu ancora più avverso e ostinato. Benché la sorte lo avesse sempre contrastato e da ultimo anche in punto di morte, egli dimostrò che un uomo valoroso può vivere e morire a dispetto di lei. Passò tutta la vita in una continua guerra civile, o in una pace che la covava nel seno, ed è lecito dire che si affrancò dalla schiavitù non meno degnamente di Socrate, salvo che non si creda che Gneo Pompeo, Cesare e Crasso si siano alleati in nome della libertà. Ebbene, in tanto mutare dello Stato nessuno vide mai un solo cambiamento in Catone: egli fu sempre lo stesso in ogni condizione, nella pretura, nella sconfitta elettorale, nel momento dell’accusa, nel governo della provincia, nei discorsi in pubblico, nella morte. Infine, in quel turbamento generale dello Stato, mentre da una parte c’era Cesare, sostenuto da dieci agguerritissime legioni e da interi presìdi di milizie straniere, e dall’altra Pompeo, che bastava da solo contro tutti, mentre alcuni parteggiavano per Cesare, altri per Pompeo, solo Catone prese le parti della repubblica. E se si guarda il quadro del tempo si vedrà da un lato la plebe e tutto il popolino teso alle novità, dall’altro gli ottimati e i cavalieri, che rappresentavano la parte migliore e più onesta della città, e in mezzo, soli, la repubblica e Catone. Ti stupirai di sicuro vedendo: Priamo e l’Atride, e Achille ostile a tutti e due:12
Catone disapprova entrambi e vorrebbe disarmare sia l’uno che l’altro. Su loro pronuncia questo giudizio: se vincerà Cesare, morirà; se Pompeo, andrà in esilio. Che cosa aveva da temere, quando – fosse egli uscito vincitore o vinto nella lotta tra Cesare e Pompeo (al di sopra dei quali lui, unico fra tutti, poneva la repubblica) – si era già votato alla morte, una pena che solo i più accesi nemici potevano infliggergli? Morì, dunque, per sua determinazione. Guarda se gli uomini non possono sopportare la fatica: egli condusse a piedi l’esercito attraverso i deserti dell’Africa. Guarda se non è possibile sopportare la sete: su aride colline, senza vettovaglie, trascinandosi dietro i resti dell’esercito sconfitto, tollerò la mancanza d’acqua con tutta la corazza addosso e quando trovava una sorgente era sempre l’ultimo a bere. Guarda se non si possono disprezzare al medesimo tempo onore e infamia: nel giorno stesso in cui fu battuto alle elezioni giocò a palla nel luogo dove si tenevano i comizi. Guarda se si può non temere il potere dei più forti: osò sfidare Cesare e Pompeo contemporaneamente, quando nessuno aveva il coraggio di offendere l’uno senza accattivarsi al tempo stesso il favore dell’altro. Guarda se non si possono disprezzare e l’esilio e la morte: egli impose a sé stesso sia l’uno che l’altra, e, nel frattempo, la guerra. Anche noi, dunque, possiamo mostrare di fronte alle sventure la stessa forza d’animo, se vogliamo liberarci dalla loro schiavitù. Rifiutiamo innanzitutto i piaceri, i quali snervano, rendono fiacchi e pretendono molto, un molto che poi dipende dalla fortuna. Disprezziamo quindi le ricchezze, che sono il prezzo di una schiavitù. Mettiamo da parte l’oro, l’argento e tutto ciò che riempie le case dei ricchi: la libertà richiede sacrifici. Se la si apprezza molto, tutto il resto non conta. Stammi bene. 105. Queste sono le regole che devi osservare per vivere sereno. Ti chiedo però di ascoltare i miei insegnamenti come se io ti consigliassi il modo di proteggere la tua salute nella zona malsana di Ardea. Considera i motivi che possono spingere un uomo a far del male a un altro: vi troverai la speranza, l’invidia, l’odio, la paura, il disprezzo. Quest’ultimo è il meno grave di tutti, tanto è vero che molti per difendersi si trincerano dietro di esso. Chi disprezza calpesta, è vero, ma passa oltre: nessuno si accanisce più di tanto contro una persona che disprezza, così come in una battaglia si scavalcano i caduti per combattere con chi sta in piedi. La speranza dei malvagi potrai evitarla se non possederai nulla di rilevante che possa suscitare la loro cattiva cupidigia: si desiderano infatti anche beni di poco conto, quando siano insoliti e rari. All’invidia potrai sottrarti se eviterai di metterti in mostra, di ostentare i tuoi beni esteriori, se saprai godere solo di quelli che sono dentro di te. Quanto all’odio, esso o nasce da un’offesa, e tu allora potrai evitarlo non provocando nessuno, oppure è gratuito, e in questo caso sarà il buon senso a difendertene. Tieni però presente che molti sono stati odiati ingiustamente, senza che avessero un nemico. Per non essere temuto ti bastano un’indole mite e una fortuna modesta: la gente sappia che ti si può offendere senza che tu reagisca, e tu sia
pronto e sicuro nel riconciliarti con chi ti ha offeso. Essere temuti, sia in casa che fuori, sia dagli schiavi che dalle persone libere, è dannoso, perché tutti sono abbastanza forti per fare del male. Aggiungi che chi è temuto teme a sua volta, e chi terrorizza gli altri non vive tranquillo. Resta il disprezzo: se uno se lo procura deliberatamente, se cioè viene disprezzato per sua volontà e non perché se lo meriti, può controllarlo, regolarne la dose. Dal fastidio che ci provoca ci liberano i nostri sani principi e l’amicizia di cui godono delle persone influenti presso un potente, con le quali sarà utile avere dei rapporti, ma non troppo stretti, affinché il rimedio non sia peggiore del pericolo che in quel caso si corre. Nulla, però, giova di più che lo starsene tranquilli, parlare pochissimo con gli altri e il più possibile con sé stessi. Il conversare ha una sua certa dolcezza, che blandamente si insinua nell’animo e, come fanno l’amore o l’ubriachezza, tira fuori i segreti. Nessuno tacerà o dirà solo ciò che ha udito e chi parlerà di un fatto ne citerà anche l’autore, perché ciascuno ha un amico a cui confidare ciò che è stato confidato a lui e per quanto cerchi di frenare la sua loquacità e racconti il fatto a una sola persona, a poco a poco il numero di quelli che sanno andrà crescendo e il segreto sarà sulla bocca di tutti. Gran parte della sicurezza, poi, risiede nel non commettere ingiustizie: i prepotenti conducono una vita inquieta e agitata, la loro paura è proporzionale al male che compiono e non hanno mai pace, le loro cattive azioni li rendono incerti e pieni di timori, la loro coscienza non gli consente di pensare ad altro e li costringe a presentarsi al suo tribunale. L’attesa della pena è già essa stessa una pena, e chi sa di meritarla l’aspetta. Chi ha un delitto sulla coscienza a volte può restare impunito ma non potrà mai essere sereno, in quanto anche se l’ha fatta franca teme sempre di essere scoperto, fa sogni agitati e quando sente parlare del delitto di un altro, pensa al suo, che per lui non è mai abbastanza dimenticato o coperto. Chi fa del male può avere la fortuna di restare nascosto ma non può mai esserne certo. Stammi bene. 106. Rispondo alle tue lettere con un po’ di ritardo non perché sia preso dagli impegni: guàrdati dal credere a una simile scusa, il tempo ce l’ho e ce l’hanno tutti, basta volerlo. Gli impegni non inseguono nessuno: sono gli uomini che li assumono, perché li ritengono un segno di felicità. Qual è allora il motivo per cui non ti ho risposto subito? L’argomento che mi chiedevi rientrava nel piano del mio lavoro; tu sai, infatti, che intendo trattare la filosofia morale nel suo insieme ed esaminarne tutti i problemi che la riguardano. Perciò non sapevo se rinviare la risposta finché non fossi arrivato al punto, o soddisfare la tua richiesta, senza seguire la successione degli argomenti e alla fine mi è parso più cortese non far aspettare chi viene da tanto lontano. Estrapolerò dunque questo tema dalla successione di quelli che vi sono connessi e se ce ne saranno altri simili te li riferirò senza che tu me lo chieda. Mi chiedi quali siano: sono problemi la cui conoscenza è più piacevole che utile, come l’oggetto della tua domanda: il bene ha un corpo? Il bene agisce in
quanto è utile; e ciò che agisce è un corpo. Il bene sprona l’anima e in un certo modo la forma e le dà una regola, e queste sono attività di un corpo. Se i beni del corpo sono corpi, lo sono dunque anche i beni dell’animo, perché anche l’anima è un corpo. Il bene dell’uomo è necessariamente un corpo, perché l’uomo è un essere corporeo. Mentirei se dicessi che anche le sostanze che lo nutrono e gli assicurano la salute o gliela restituiscono non sono corpi, quindi anche il suo bene è corpo. Non penso che tu dubiti che i sentimenti, come l’ira, l’amore, la tristezza, siano corpi (lo dico per aggiungere anche argomenti da te non richiesti), visto che ci fanno cambiare espressione, corrugare la fronte, distendere il volto, arrossire, impallidire. E allora? Non credi che solo un corpo possa provocare delle reazioni così manifestamente fisiche? Se sono corpi i sentimenti, lo saranno anche i mali dell’anima, come l’avarizia, la crudeltà, i vizi incalliti e incorreggibili, quindi anche la malvagità e tutte le sue forme, cioè il malanimo, l’invidia, la superbia, e conseguentemente anche i beni, prima di tutto perché sono il loro contrario, poi perché si presentano coi medesimi segni. Non vedi forse che vigore dia allo sguardo la fortezza? Che intensità la prudenza? Che aria di modestia e di calma la verecondia? Che serenità la gioia? Che comportamento austero la severità? Che senso di remissività la dolcezza? Ergo, quei fattori che cambiano il colore e lo stato dei corpi e che esercitano su di essi il loro potere sono corpi. Ora, tutte le virtù che ho elencato e tutto ciò che ne deriva sono beni. Ogni cosa che abbia la capacità di toccare indubbiamente è un corpo. Niente, infatti, può toccare o esser toccato se non il corpo,13 dice Lucrezio. Ma tutte le cose che ho detto non potrebbero trasformare un corpo se non lo toccassero, dunque, sono corpi. Orbene, anche quegli elementi che hanno tanta forza da spingere, costringere, trattenere, frenare sono corpi. E che? Il timore non ci trattiene? L’audacia non ci spinge? La fortezza non ci incita e ci dà slancio? La moderazione non ci frena e ci richiama? La gioia non ci esalta? La tristezza non ci abbatte? Infine, chi comanda ogni nostra azione se non la virtù o la malvagità? Ciò che comanda il corpo è corpo, ciò che fa violenza al corpo è corpo. Il bene del corpo è corporeo, il bene dell’uomo è anche bene del corpo, dunque è corporeo. Ora, dopo che ti ho risposto, come desideravi, arriverò alla medesima conclusione a cui, sono certo, arriverai tu: ci perdiamo in giochetti, in sottigliezze superflue: questi ragionamenti ci rendono dotti, non virtuosi. La saggezza è cosa più chiara, anzi, più semplice: basta poco studio per arrivarvi; noi, invece, sciupiamo in speculazioni inutili anche la filosofia, come tutto il resto. Soffriamo di intemperanza anche negli studi, come in ogni altra attività: impariamo per la scuola, non per la vita. Stammi bene. 107. Dove è finita la tua prudenza? Dove la tua cavillosità? E la tua
grandezza d’animo? Ti turba una cosuccia da poco? Le tue occupazioni hanno dato ai tuoi schiavi l’opportunità di fuggire. E allora? Lo capirei se ti ingannassero degli amici (chiamiamoli pure con questo nome sbagliato per non usare termini troppo dispregiativi) * * *, ma a tutti i tuoi averi mancano ora delle persone che disprezzavano la tua attività e ti consideravano un peso per il prossimo. Non c’è nulla di insolito e di inaspettato: è ridicolo arrabbiarsi per fatti del genere, è come lamentarsi di essere spruzzati in un bagno pubblico, spintonati in mezzo alla folla o imbrattati stando nel fango. Nella vita accadono le stesse cose che ai bagni pubblici, tra la folla o durante un viaggio: qualche torto ti viene fatto di proposito, qualche altro è fortuito. Vivere non è una delicatezza. Hai intrapreso un lungo cammino: scivolerai, andrai a sbattere, cadrai, ti sentirai stanco, invocherai – mentendo – la morte. Qui lascerai un compagno, là ne seppellirai un altro, più avanti un altro ancora ti farà paura: devi affrontare simili avversità per percorrere questo aspro sentiero. E che, vogliamo morire? Prepariamoci, invece, a ogni evenienza, convinti di essere arrivati dove scoppia il fulmine, dove hanno il loro covo il Pianto e i vindici Affanni dove dimoran le pallide Malattie e la triste Vecchiaia.14 È con questi compagni che dobbiamo vivere. Non puoi sfuggirli, ma puoi disprezzarli, e non gli darai peso se rifletterai spesso e saprai prevedere quelli che ti colpiranno. Coloro che vi si sono preparati a lungo affrontano con maggiore coraggio gli eventi e resistono anche alle difficoltà, se le hanno previste: chi, invece, è impreparato teme anche le piccolezze. Facciamo dunque in modo che niente ci giunga inaspettato, e poiché l’imprevisto rende le disgrazie più pesanti sarà bene che tu rifletta costantemente per non farti sorprendere da alcun male. «Gli schiavi mi hanno abbandonato». E allora? Un altro lo hanno spogliato, accusato, ucciso, tradito, malmenato, hanno attentato alla sua vita col veleno e con false imputazioni: qualunque cosa tu dica è capitata a molti, e a molti ancora capiterà. Tanti e tanto vari sono i colpi diretti contro di noi. Alcuni ci hanno già feriti, altri balenano e stanno per arrivare, altri, che non erano diretti a noi, ci sfiorano. Non stupiamoci di cose alle quali siamo destinati dalla nascita; nessuno se ne deve lagnare: sono uguali per tutti. Così dico, pari sono, poiché anche se uno sfugge a quei colpi, avrebbe potuto subirli. Una legge è equa non perché serve a tutti, ma perché vale per tutti. Sforziamoci di stare calmi e paghiamo senza lagnarci il tributo della nostra mortalità. L’inverno porta il freddo? Avremo freddo. L’estate porta il caldo? Patiremo il caldo. Il clima instabile attenta alla nostra salute? Rassegniamoci a star male. In qualche posto ci imbatteremo in una belva o magari in un uomo più pericoloso di tutte le belve. Qualcosa ce la toglierà l’acqua, qualcosa il fuoco. Questo stato non possiamo cambiarlo: possiamo però formarci un animo grande e degno di un uomo
virtuoso, per sopportare da forti gli imprevisti ed essere in armonia con la natura. È coi cambiamenti che la natura governa il regno che tu vedi: alle nuvole succede il sereno; il mare è calmo e poi si agita; i venti soffiano ora in una direzione, ora in un’altra; il giorno segue la notte; una parte del cielo si leva, un’altra sprofonda: è la legge degli opposti a perpetuare l’universo. Noi dobbiamo uniformarvi il nostro spirito; seguiamola, obbediamole; e ogni avvenimento facciamo conto che sia necessario: non rimproveriamo la natura. L’atteggiamento migliore sta nel sopportare ciò che non si può correggere e seguire la volontà di dio senza lagnarsi: tutto proviene da lui; non è un buon soldato chi segue il comandante e si lamenta. Accettiamo dunque gli ordini prontamente, con sollecitudine, e non abbandoniamo il corso di questa meravigliosa opera, intessuta anche di ogni nostra sofferenza; e rivolgiamoci a Giove, che governa e dirige l’universo, con quegli eloquentissimi versi con cui gli si è rivolto il nostro Cleante, e che io, sull’esempio di Cicerone, uomo di grande eloquenza, mi permetto di tradurre nella nostra lingua. Se ti piacciono prendili per buoni; in caso contrario tieni presente che in ciò ho seguìto l’esempio di Cicerone. Portami dove tu vuoi, Signore e Padre del cielo: non mancherò di ubbidirti. Sono pronto: se non lo volessi, io ti dovrei seguire piangendo e subir controvoglia ciò che potevo fare volentieri. Il destino conduce chi l’asseconda, trascina colui che vi si oppone.15 Sia questa la nostra vita, siano queste le nostre parole; il destino ci trovi pronti e solleciti: grande è l’anima che vi si abbandona, mentre vile e meschina è quella che lotta contro di lui e disprezza l’ordine dell’universo, presumendo di correggere gli dèi piuttosto che sé stessa. Stammi bene. 108. L’argomento di cui mi hai chiesto è uno di quelli che importa conoscere solo per il gusto di conoscere. Ciò nonostante, poiché serve a qualcosa, hai fretta e non vuoi aspettare i libri che proprio ora sto preparando e che riguardano tutta la parte morale della filosofia. Ti accontenterò subito, ma prima voglio scriverti come tu debba regolare questa smania di conoscere, di cui vedo che tu bruci, affinché non sia d’impaccio a sé stessa. Non bisogna attingere qua e là e nemmeno gettarsi avidamente sull’intero sapere: attraverso le singole parti si arriverà al tutto. Occorre adeguare il peso alle forze e non assumerne uno superiore alle nostre capacità. Prendi non quanto vuoi ma quanto puoi comprendere. Cerca solo di mantenere l’animo onesto perché così potrai contenere quanto vorrai. L’animo quanto più riceve tanto più si dilata. Questo m’insegnava Attalo quando frequentavo la sua scuola, ed ero il primo ad arrivare e l’ultimo a uscire, lo invitavo a discutere anche mentre passeggiava, e lui non solo era sempre disponibile ma veniva anche incontro ai suoi discepoli.
«Maestro e allievo devono avere lo stesso proposito», diceva, «l’uno deve far progredire, l’altro deve voler progredire». Chi frequenta un filosofo deve portar via ogni giorno qualcosa di buono, tornare a casa o più sano o più sanabile. E così ritornerà, perché la filosofia ha una tale efficacia da giovare non solo a quelli che la studiano ma anche a coloro che hanno con essa un minimo di familiarità. Chi sta al sole si abbronza, anche se il suo scopo non era questo; chi si ferma in una profumeria e vi si trattiene per un po’ di tempo ne riporta l’odore: così anche chi frequenta un filosofo, sia pure distrattamente, ne trae per forza qualche vantaggio. Attento però: ho detto «distrattamente», non «opponendo resistenza». «E che, dunque? Forse che non conosciamo certuni che hanno frequentato per molti anni un filosofo senza riportarne nemmeno una infarinatura? «E perché non dovrei conoscerli? Sono uomini molto assidui e tenaci che io chiamo non discepoli, ma inquilini dei filosofi. Alcuni vanno per ascoltare, non per imparare, così come si va a teatro per il piacere di farsi accarezzare le orecchie da un bel discorso, da una bella voce o da una buona commedia. Vedrai che per la maggior parte dei frequentatori la scuola di un filosofo è un luogo in cui trascorrere il tempo libero. Essi cercano non di scrollarsi di dosso qualche vizio, di imparare una legge di condotta per regolare la propria, ma di godere dei piaceri dell’udito. Certi portano anche un taccuino per segnarvi non dei concetti ma delle parole che poi ripeteranno senza alcun profitto né per se né per gli altri. Alcuni poi si entusiasmano nell’udire splendidi discorsi e commossi nel volto e nell’animo si immedesimano in chi parla e si eccitano come gli eunuchi al suono del flauto frigio invasati da quel segnale. Essi sono trascinati e stimolati dalla bellezza dei concetti, non dal suono vuoto delle parole. Se hanno udito qualcuno parlare con coraggio contro la morte o con disprezzo contro la fortuna subito vogliono mettere in pratica ciò che hanno udito. Restano colpiti da quei discorsi e si comportano come è stato loro insegnato, a meno che non mutino la loro disposizione di spirito perché il volgo, che distoglie sempre dalla virtù, distrugge quel nobile slancio, sicché pochi riescono a tornare a casa con i propositi che avevano fatto. Non è difficile spingere chi ascolta a desiderare il bene, perché la natura ha gettato le fondamenta e il seme delle virtù in ogni uomo. Siamo nati tutti per compiere il bene, basta che uno ci stimoli e quei nobili istinti che erano come addormentati si risvegliano. Non senti come echeggino gli applausi in teatro quando risuonano quelle massime che tutti riconosciamo e che siamo tutti concordi nel proclamare vere? Molto manca alla povertà, all’avarizia tutto.16 L’avaro non è buono con nessuno ed è pessimo con sé stesso.17 Nell’udire questi versi anche l’uomo più avaro applaude e si compiace che i suoi vizi siano biasimati. Non ti sembra che ciò accada ancora di più quando a parlare è un filosofo, quando ai precetti salutari si mescolano dei versi che li
fanno penetrare con maggiore efficacia nell’animo degli ignoranti? Cleante diceva: «Come il nostro fiato produce un suono più squillante quando passa attraverso lo stretto e lungo canale di una tromba e fuoriesce da un’apertura più grande, così le ferree leggi della poesia rendono più vivi i nostri pensieri». Se invece sono detti in prosa, i medesimi concetti si ascoltano distrattamente e fanno meno presa: quando però vi si aggiunga il ritmo e dei versi ben precisi esprimono in forma sintetica un pensiero interessante, allora quella stessa massima risulta come scagliata da un braccio più robusto. Si dicono molte cose sul disprezzo del denaro e con lunghissimi discorsi si insegna agli uomini che la ricchezza sta nell’anima, non nei beni materiali, che è veramente ricco chi si adatta alla sua povertà e si rende ricco con poco. Tuttavia gli animi sono più colpiti da versi di questo genere: L’uomo che ha pochissimi desideri ha pochissime necessità.18 Chi desidera quanto basta ha ciò che vuole.19 Quando ascoltiamo codeste e altre simili massime non possiamo non riconoscerne la veridicità, e anche coloro che non sono mai contenti si entusiasmano, applaudono e dichiarano odio per il denaro. Ebbene, quando li vedi in questo stato d’animo incalzali, premi, insisti, lasciando da parte le ambiguità, i sillogismi, i cavilli e gli altri giochetti inutili. Parla contro l’avarizia e contro la dissolutezza, e quando ti sembrerà di aver ottenuto un risultato e toccato l’animo degli ascoltatori incalza con forza maggiore: è incredibile quanto sia efficace questo tipo di eloquenza che tende a risanare ed è tutta rivolta al bene di chi ascolta. Le anime dei giovani, infatti, si lasciano indirizzare facilmente all’amore dell’onestà e della virtù perché sono ancora plasmabili e incorrotti, e la verità, se trova un buon avvocato, se ne impadronisce agevolmente. Io, quando sentivo Attalo fustigare i vizi, gli errori, i mali della vita, spesso provavo compassione per il genere umano e per questo lo giudicavo un animo nobile e superiore alla condizione umana. Diceva di essere un re ma a me sembrava ancora di più, perché lui i re poteva biasimarli. Quando poi si metteva a lodare la povertà e a dimostrare come tutto ciò che oltrepassa il necessario sia un peso inutile e pesante a sopportarsi, più di una volta avrei voluto uscire povero dalla scuola. Quando cominciava a schernire i piaceri, a lodare la castità, la frugalità, la purezza di un’anima contraria non solo ai piaceri illeciti ma anche a quelli superflui, avrei voluto frenare la mia gola e il mio ventre. Caro Lucilio, mi è rimasto qualcosa di quegli insegnamenti: ero andato a quella scuola con grande entusiasmo per tutto ciò che avrei potuto apprendere, poi, tornato alla vita della città, di quei miei buoni propositi ne ho mantenuti ben pochi. Da allora ho rinunciato per tutta la vita alle ostriche e ai funghi, visto che non sono cibi ma capricci che costringono a mangiare anche quando si è sazi (il che è graditissimo agli ingordi e a chi si rimpinza più di quanto può contenere), alimenti che vanno giù con facilità e che con altrettanta facilità ti tornano su. Da
allora per tutta la vita non ho più usato profumi, perché il migliore odore sul corpo è non averne alcuno; da allora non ho più bevuto vino, ho sempre evitato i bagni caldi, poiché ritengo inutile e segno di mollezza riscaldare il corpo e fiaccarlo col sudore. Altre abitudini che in un primo tempo ero riuscito a eliminare sono ritornate ma in modo tale che in quelle in cui non ho mantenuto l’astinenza totale conservo una misura che le è molto vicina, forse anche più difficile, poiché certe abitudini si possono più facilmente eliminare che moderare. Ti ho raccontato come da giovane mi sia accostato alla filosofia con uno slancio maggiore di quello con cui continuo ora da vecchio. Adesso non mi vergognerò di confessarti il mio amore per la filosofia pitagorica. Sozione spiegava perché Pitagora si era astenuto dal mangiar carne e perché in seguito se ne era astenuto Sestio. I motivi erano diversi ma entrambi nobili. Sestio diceva che l’uomo dispone di una quantità sufficiente di cibi senza bisogno di dover versare sangue e che quando si lacerano dei corpi per il proprio piacere ci si abitua alla crudeltà. Aggiungeva poi che dobbiamo ridurre le cause della dissolutezza, concludendo che la varietà di alimenti nuoce alla salute e al corpo. Pitagora, invece, sosteneva che c’è una parentela fra tutti gli esseri viventi e credeva nella trasmigrazione delle anime da una forma di vita a un’altra. Secondo lui nessuna anima muore e solo nell’istante in cui passa in un altro corpo resta inerte. Vedremo più avanti attraverso quali vicende e quando, dopo aver cambiato diverse dimore, l’anima torni nel corpo di un uomo: per ora ti dirò che in questo modo Pitagora ha fatto nascere negli uomini la paura di un delitto e di un parricidio, visto che ci si può imbattere senza saperlo nell’anima di un genitore e di oltraggiarla, che si può straziare o mangiare la carne di un essere in cui alberga lo spirito di qualche familiare. Ebbene, Sozione mi illustrò queste teorie e dopo avervi aggiunto alcune sue argomentazioni mi domandò: «A questo punto non credi che le anime siano successivamente assegnate a corpi diversi e che quella che noi chiamiamo morte non sia altro che un trapasso? Non credi che negli animali domestici o feroci o acquatici possa esserci l’anima che una volta fu di un uomo? Che nulla in questo mondo finisca ma cambi soltanto sede? Che non solo i corpi celesti percorrano un cammino stabilito ma che anche gli esseri animati abbiano dei loro cicli e che le anime seguano una propria orbita? Grandi uomini hanno creduto a queste teorie. Tu, però, non emettere un giudizio e lascia tutto in sospeso: se queste teorie sono vere, l’astinenza dal mangiar carne ci rende immuni da colpe, se invece sono false ci rende frugali. Cosa ci perdi a crederci? Io ti vieto di nutrirti come i leoni e gli avvoltoi». Ebbene, sollecitato da questi discorsi, cominciai a non mangiare carne: dopo un anno divenne per me un’abitudine non solo facile ma anche piacevole. Mi sembrava che il mio spirito fosse più vivo, anche se oggi non posso dirti con certezza se lo fosse veramente. Vuoi sapere come mai ho abbandonato questa consuetudine? La mia giovinezza coincise con i primi anni del regno di Tiberio: allora i culti stranieri erano banditi e l’astinenza dalle carni di certi animali era ritenuta segno di pratiche
superstiziose. Così, in seguito alle preghiere di mio padre, che non aveva timore delle accuse false ma odiava la filosofia, tornai alle vecchie abitudini: egli non ebbe difficoltà a convincermi di mangiare meglio. Attalo, inoltre, consigliava di dormire sul materasso duro e io anche adesso, da vecchio, ne uso uno su cui non resta l’impronta del corpo. Ti ho raccontato tutto ciò per farti vedere come siano inizialmente impetuosi gli slanci degli inesperti verso tutte le virtù se qualcuno li stimola e li sprona. Tuttavia si commette qualche errore per colpa dei maestri, quando ci insegnano a discutere ma non a vivere, qualche altro per colpa dei discepoli che frequentano le scuole col proposito di esercitare l’ingegno ma non lo spirito. Così la filosofia è diventata filologia. È sempre molto importante il proposito con cui ci si accosta a una materia, quale che essa sia. Chi studia Virgilio come grammatico non legge con questo spirito quel verso straordinario: Fugge inesorabile il tempo.20 «Dobbiamo stare all’erta, se non ci affrettiamo rimarremo indietro; i giorni ci incalzano e si incalzano veloci; siamo trascinati via e non ce ne rendiamo conto; rinviamo tutto al futuro e mentre ogni cosa precipita noi indugiamo». Guarda come Virgilio ogni volta che parla della velocità del tempo usi il verbo «fuggire». Fuggono i giorni migliori della vita ai mortali per primi; giungono le malattie, gli affanni e la triste vecchiaia, via ci trascina la morte spietatamente crudele.21 Chi guarda alla filosofia interpreta questi stessi versi nella giusta maniera, cioè osserva: «Virgilio non dice mai che i giorni passano, dice che fuggono, un verbo che indica il modo più rapido di correre, e che i giorni migliori ci vengono strappati per primi: perché dunque non cerchiamo di uguagliare la rapidità di una cosa tanto veloce? Il meglio svanisce, subentra il peggio». Come da un’anfora fuoriesce prima il vino più schietto, mentre il più pesante e torbido resta nel fondo, così la parte migliore della nostra esistenza è la prima. Con tutto ciò noi lasciamo che l’attingano altri e ce ne riserviamo la feccia? Fissiamoci bene nell’anima questi versi e consideriamoli come il responso di un oracolo: Fuggono i giorni migliori della vita ai mortali per primi. Perché sono i migliori? Perché il tempo che rimane è incerto. Perché, ancora, i migliori? Perché da giovani possiamo imparare, possiamo indirizzare al meglio l’anima ancora docile e malleabile, perché questo periodo è adatto alle fatiche, a stimolare la mente con gli studi e a esercitare il corpo col lavoro, mentre negli anni successivi siamo più deboli e fiacchi e più vicini alla fine. Inseguiamo
dunque con tutta l’anima un unico scopo e senza distrarci adoperiamoci solo a questo fine, che cioè non ci si debba accorgere, quando ormai siamo rimasti indietro, di questa rovinosissima e irrefrenabile velocità del tempo. Apprezziamo i nostri primi giorni come i migliori e traiamone vantaggio, impadroniamoci del tempo che fugge. Chi legge questi versi con gli occhi del grammatico non pensa che i giorni più belli sono i primi, perché poi subentrano le malattie, la vecchiaia incalza e schiaccia gli uomini quando pensano all’adolescenza, ma nota come Virgilio colleghi sempre malattie e vecchiaia, e giustamente, perché la vecchiaia è una malattia inguaribile. «Inoltre», egli aggiunge, «Virgilio chiama triste la vecchiaia: subentrano le malattie e la triste vecchiaia. Altrove scrive: pallide vi dimorano le Malattie e la triste vecchiaia».22 Non c’è da stupirsi se da una medesima materia ciascuno trae argomenti che servono ai suoi studi, così come in uno stesso prato il bue cerca l’erba, il cane la lepre, la cicogna le lucertole. Un filologo, un grammatico o un filosofo che prendano in mano il De re publica di Cicerone rivolgono la loro attenzione a particolari diversi: il filosofo, per esempio, si stupirà che uno abbia potuto parlare tanto contro la giustizia. Il filologo, invece, osserverà che ci sono due re di Roma di cui non si conosce dell’uno il padre, dell’altro la madre: non si sa infatti con certezza chi fosse la madre di Servio, mentre non si nomina il padre di Anco, di cui si dice solo ch’era nipote di Numa. Il filologo, inoltre, noterà che il magistrato detto da noi dittatore, e che così è definito nei libri di storia, gli antichi lo chiamavano «maestro del popolo». Oggi ciò risulta evidente dal libro degli àuguri, e ne è la prova il fatto che la persona nominata dal dittatore è detto «maestro della cavalleria». Analogamente osserverà che Romolo morì durante un’eclissi di sole, che ci si poteva appellare al popolo anche contro le sentenze dei re, come, secondo Fenestella23 e altri studiosi, risulterebbe dai libri dei pontefici. Se infine è il grammatico a commentare i medesimi libri annoterà subito che Cicerone scrive reapse, cioè re ipsa, e sepse, cioè se ipse. Poi passerà alle espressioni che nel tempo sono cambiate, come quella che si trova nel passo di Cicerone poiché la sua interruzione ci ha riportati indietro dalla calce,24 dove calx allora era la meta nel circo, che noi ora chiamiamo creta. Quindi raccoglierà i versi di Ennio, e soprattutto quelli sull’Africano: a cui nessun concittadino o nemico potrà reddere opis pretium per le sue imprese.
Da quell’espressione egli dedurrà che in passato ops significava non solo “aiuto”, ma anche “opera”. Ennio, infatti, vuol dire che nessun concittadino o nemico poté compensare l’opera di Scipione. Gioirà poi per aver trovato il modello di Virgilio nel verso: sopra di lui rimbomba l’immensa porta del cielo.25 Dirà che Ennio l’ha preso da Omero, e Virgilio da Ennio, poiché in Cicerone, sempre nei libri del De re publica, si trova questo epigramma di Ennio: se lecito a un uomo è salire alle regioni celesti, solo per me si schiude l’immensa porta del cielo. Ma non voglio finire anch’io, che ho ben altri propositi, tra i filologi e i grammatici, perciò ti ricordo che i filosofi vanno ascoltati o letti guardando alla felicità, per cogliere non gli arcaismi o i neologismi, le metafore assurde e le figure retoriche, ma i precetti utili, le massime nobili e coraggiose da mettere subito in pratica. Assimiliamo questi insegnamenti sì che le parole si traducano in opere. Per me gli uomini più dannosi all’umanità sono quelli che apprendono la filosofia come un’arte per arricchirsi e vivono in contrasto coi loro insegnamenti. Diventano essi stessi esempio di una disciplina inutile, quando sono schiavi di tutti i vizi che condannano. Un maestro simile mi è utile quanto un timoniere che vomita in piena tempesta. Bisogna tener fermo il timone contro la violenza delle onde, lottare col mare, sottrarre le vele alla furia del vento: come può essermi di aiuto un timoniere frastornato che dà di stomaco? Non credi che la nostra vita sia turbata da burrasche più violente di quelle che colpiscono una nave? C’è bisogno di una guida sicura, non di parole. Oltretutto le massime esposte da quegli individui non sono nemmeno le loro, sono di Platone, Zenone, Crisippo, Posidonio e di un vasto gruppo di tanti filosofi illustri. Si comportino come parlano se vogliono dimostrare che tali princìpi sono i loro. Ormai ti ho detto quanto volevo: ora soddisferò il tuo desiderio e ti scriverò tutte le spiegazioni che hai chiesto, ma in un’altra lettera: non voglio che tu affronti già stanco una questione spinosa che va ascoltata con le orecchie ben tese. Stammi bene. 109. Vuoi sapere se un saggio può essere utile a un altro saggio. Per noi stoici il saggio ha in sé ogni bene e ha raggiunto la perfezione: come può dunque qualcuno essere utile a chi possiede il sommo bene? Tuttavia i buoni si giovano fra loro poiché praticano le virtù e mantengono costante la loro saggezza; ognuno di loro sente il bisogno di un altro con cui comunicare, con cui discutere. I lottatori professionisti si tengono in esercizio con combattimenti continui; il
musicista riceve stimoli da un suo pari. Anche il saggio deve esercitare le sue virtù: come è di sprone a sé stesso, così è spronato da un altro saggio. E in che modo un saggio potrà essere utile a un altro saggio? Dandogli appunto degli stimoli, indicandogli le occasioni per agire virtuosamente. Gli esporrà inoltre certi suoi pensieri, gli comunicherà le sue scoperte, poiché anche lui avrà sempre qualcosa da scoprire e in cui il suo spirito possa spaziare. Il malvagio, invece, nuoce al malvagio, lo rende peggiore perché ne eccita l’ira, ne asseconda la durezza, ne approva i piaceri, e allora i malvagi si affaticano soprattutto quando uniscono i loro vizi e i loro istinti malvagi si mescolano e si fondono insieme. Al contrario il buono sarà utile al buono. Vuoi sapere come? Gli recherà gioia, rafforzerà il suo coraggio, e nella constatazione reciproca della loro serenità la contentezza di entrambi ne sarà accresciuta. L’uno, poi, trasmetterà all’altro la conoscenza di certe cose: il saggio, infatti, non conosce tutto, e quand’anche conoscesse tutto qualcun altro potrebbe trovare e indicargli vie più brevi per diffondere più agevolmente l’opera sua. Il saggio può essere utile al saggio non solo in virtù delle proprie forze ma anche con quelle di colui che viene aiutato. Certo, anche se vive per conto suo il saggio può svolgere egualmente i propri compiti e lo farà procedendo al ritmo che gli è consono, così come un corridore può essere aiutato da uno che lo sprona. «Il saggio non giova al saggio, giova a sé stesso. Ne vuoi una prova? Togligli la sua forza e non potrà fare più nulla». Sarebbe come dire che il miele non è dolce solo perché uno che lo mangia non ha lingua e palato conformati in modo da apprezzarne quel sapore e ne resta nauseato; ci sono certi, infatti, che per una malattia sentono amaro il miele. Bisogna che entrambi i saggi abbiano eguali poteri in modo che l’uno sia in grado di giovare e l’altro gliene offra il materiale. «Sì, però, com’è inutile riscaldare un corpo che ha raggiunto il massimo calore, così è inutile aiutare chi ha raggiunto il sommo bene. Forse che un agricoltore fornito di tutti gli attrezzi chiede di riceverne da un altro? E un soldato sufficientemente armato per scendere in campo sente forse il bisogno di altre armi? Quindi neppure il saggio: ha attrezzi e armi sufficienti per affrontare la vita». Ebbene, anche un corpo riscaldato al massimo ha bisogno di un’aggiunta di calore affinché la temperatura si mantenga costante. «Ma», si può obiettare, «il calore si conserva da sé». Innanzitutto c’è una grande differenza tra gli elementi confrontati: il calore è unico, l’aiuto varia. E poi, affinché il calore sia tale, non serve alcuna aggiunta: il saggio, invece, non può mantenersi tale se non ha altri da rendere partecipi delle proprie virtù. Inoltre tutte le virtù sono in amicizia fra loro, per cui chi ama le virtù di qualcuno simile a lui e gli offre altre amabili virtù non può che giovare. Le somiglianze sono gradite, specialmente fra persone oneste che sanno apprezzare e farsi apprezzare. E poi, come soltanto l’uomo può con la ragione influire sull’uomo, così nessun altro, se non il saggio, può influire con la sua esperienza sull’animo del saggio. Se per influire sulla ragione occorre la ragione, per influire su una ragione perfetta occorre una
ragione perfetta. In genere si definiscono utili quelle persone che ci dispensano beni indifferenti, come denaro, favori, incolumità e altri ancora graditi o necessari ai bisogni della vita, e in questo campo anche lo stolto può essere utile al saggio. Ma essere utili significa propriamente indirizzare l’animo di qualcuno secondo natura con la propria virtù. Ciò si traduce in un bene sia dell’oggetto che del soggetto di questa azione perché chi stimola la virtù altrui necessariamente esercita la propria. Ma anche lasciando da parte i grandissimi beni o le loro cause, i saggi possono egualmente giovarsi a vicenda. Per il saggio, infatti, trovare un altro saggio è cosa di per sé desiderabile, poiché ogni bene è per sua natura caro a colui che è buono, sicché ciascuno va d’accordo con chi è buono come con sé stesso. L’argomento esige che da questo problema io passi a un altro, e cioè se il saggio debba decidere da solo o chiedere consiglio ad altri. Ebbene, deve ricorrere ad altri quando si tratta di questioni civili, familiari e relative alla nostra vita mortale, così come ha bisogno del medico, del timoniere, dell’avvocato e del giudice. Talvolta, dunque, il saggio sarà utile al saggio dandogli dei consigli. Ma anche nei grandi problemi e in quelli che riguardano il divino, come ho detto, potrà essergli utile unendosi a lui nel compiere il bene, in comunione d’anime e di pensieri. Inoltre essere uniti agli amici e rallegrarsi dei loro progressi come dei propri è tipico della natura umana; se non agiamo così, non manteniamo viva in noi la virtù che trae la sua forza dall’esercizio del pensiero. La virtù ci consiglia di ordinare bene il presente, di provvedere al futuro, di meditare ed elevare l’anima, e questo progresso spirituale è più facile per chi si è preso un compagno, che sia un uomo perfetto o sulla strada della perfezione. E quest’uomo perfetto sarà utile unendo nelle decisioni la sua saggezza a quella dell’amico. Si dice che gli uomini vedano più chiaro nelle faccende altrui […]. Ciò accade a chi è accecato dall’amore di sé, oppure a chi nei pericoli si lascia prendere dal panico e perde di vista l’utile: comincerà a mostrarsi assennato dopo essersi rasserenato e liberato dalla paura. Tuttavia ci sono faccende in cui anche i saggi vedono per gli altri con maggiore chiarezza che per sé stessi. Il saggio inoltre offrirà al saggio quel «volere e non volere le stesse cose», così ricco di dolcezza e di virtù, e compiranno insieme, sotto lo stesso giogo, la loro nobile opera. Ho risposto a quel che mi chiedevi, anche se tutto questo si trova già fra gli argomenti trattati nei miei libri di filosofia morale. Rifletti su ciò che ti ripeto spesso: con simili questioni noi esercitiamo solo la nostra intelligenza. Tante volte mi domando: a che mi serve questo genere di speculazioni? Parliamo invece di cose che ci rendano più forti, più giusti, più temperanti. Io non ho tempo per questi esercizi mentali: ho ancora bisogno del medico. Perché mi richiedi nozioni che non servono a nulla? Mi sono state fatte grandi promesse: che vengano mantenute! Mi dicevi che sarei rimasto imperterrito anche in mezzo al balenare delle spade, anche col pugnale alla gola, che non avrei avuto paura neanche tra il divampare di un incendio o se una tempesta improvvisa avesse
trascinato la mia nave per tutti i mari: aiutami a disprezzare il piacere e la gloria. Mi insegnerai dopo a sciogliere i nodi, a distinguere le ambiguità, a capire concetti oscuri: per ora insegnami il necessario. Stammi bene.
1. Personaggio sconosciuto. 2. Virgilio, Bucoliche I 73. 3. Virgilio, Eneide XII 646. 4. Personaggio non bene identificato. 5. Virgilio, Eneide IV 3-4: è Didone che pensa a Enea. 6. Oggi Mentana, nei pressi di Roma. 7. Seconda moglie di Seneca, volle morire con lui, ma fu salvata dalle guardie di Nerone. 8. È il fratello maggiore di Seneca, M. Anneo Novato, che assunse il nome di L. Giunio Anneano Gallione in quanto adottato dal retore Giunio Gallione. 9. Virgilio, Eneide III 282-3. 10. Oggi Menderes, in Asia Minore. 11. Virgilio, Eneide VI 277: fantasmi che il Poeta immagina di vedere sulle soglie dell’Averno. 12. Virgilio, Eneide I 458. 13. Lucrezio, De rerum natura I 304. 14. Virgilio, Eneide VI 274-5. 15. I primi quattro versi sono di Cleante (Epitteto, Manuale 53), il quinto o di Cleante o di Seneca stesso. 16. Publilio Siro. 17. Forse Publilio Siro. 18. Forse Publilio Siro. 19. Forse Publilio Siro. 20. Virgilio, Georgiche III 284. 21. Virgilio, GeorgicheIII 66-68. 22. Virgilio, Eneide VI 275. 23. Storico e antiquario, scrisse le Epitomi e gli Annali. 24. Cicerone, La Repubblica. 25. Virgilio, Georgiche III 260-61.
Libro diciannovesimo 110. Ti mando un saluto dalla mia villa di Nomento e ti consiglio di mantenere onesto l’animo tuo, cioè di renderti propizi tutti gli dèi, i quali guardano con benevolenza e aiutano chi è in pace con sé stesso. Non pensare per ora, come credono alcuni, che ciascuno di noi abbia un dio come guida, non uno dei maggiori, ma una divinità di grado inferiore tra quelle che Ovidio definisce «divinità plebee». Lascia stare queste favole, ma ricordati che vi credevano i nostri antenati, i quali, essendo stoici, assegnavano a ciascun uomo un Genio e una Giunone.1 Vedremo poi se gli dèi hanno il tempo di occuparsi delle nostre faccende private, ma intanto sappi che, assegnati o no che noi siamo a una divinità o in balìa di noi stessi e della sorte, non c’è maledizione più grave che augurare a uno di non essere in pace con sé stesso. Ma se uno merita una punizione, non c’è motivo di desiderare che gli dèi gli siano ostili: li ha nemici, per me, anche se sembra che gli siano propizi. Sta’ attento, guarda non al nome delle cose ma alla loro realtà e ti renderai conto che in gran parte i mali arrivano a proposito, non a caso. Quante volte quella che consideravamo una disgrazia è stata causa e inizio di prosperità! Quante volte un avvenimento accolto con grande gioia è stato il primo passo verso la rovina e ha innalzato ancora di più chi stava già in alto, quasi che stesse in una posizione che potesse metterlo al sicuro da una caduta. Ma anche una caduta in sé stessa non è un male se guardi al traguardo finale oltre il quale la natura non ha mai abbattuto nessuno. Tutto finisce presto: è vicina, ti dico, sia la fine di quella prosperità da cui viene sbalzato chi è felice, sia di quelle disgrazie da cui è liberato l’infelice: noi le prolunghiamo entrambe con la speranza o col timore. Ma, se tu sei saggio, misura tutto in rapporto alla condizione umana; abbrevia le tue gioie e i tuoi timori. Vale la pena non godere a lungo di niente per non temere a lungo alcunché. Ma perché minimizzo questo male? Non c’è cosa che tu debba giudicare terribile: sono vane le paure che ci turbano, che ci lasciano storditi. Nessuno controlla prima se in esse vi sia qualcosa di vero, e così uno trasmette a un altro quella paura sì che nessuno osa poi accostarsi a ciò che lo turbava per conoscere la natura del suo timore e quel che in esso può esserci di bene, talché una visione falsa e vana trova credito perché nessuno ne ha dimostrato l’infondatezza. Aguzziamo dunque la vista e vedremo subito come siano brevi, incerte e senza pericolo le cose che temiamo. La confusione del nostro animo è proprio quale la giudicò Lucrezio: Come i fanciulli trepidano e temono tutto nel buio, noi ogni cosa, così, temiamo in piena luce.2 E che, dunque? Non siamo più insensati di un fanciullo noi che abbiamo paura in piena luce? Ma non è vero quel che dici, Lucrezio: noi non abbiamo paura in piena luce, perché in realtà intorno a noi abbiamo fatto le tenebre. Non
vediamo nulla, né danno, né vantaggio alcuno: per tutta la vita urtiamo contro degli ostacoli, ma non per questo ci fermiamo o avanziamo con maggiore circospezione. Non capisci che è una pazzia correre nelle tenebre? Ma in questo modo, perbacco, dobbiamo poi essere richiamati da più lontano e, pur ignorando dove siamo diretti, continuiamo a tutta velocità nella direzione che abbiamo preso. Eppure, se volessimo, potrebbe splendere la luce. E l’unico modo per ottenerlo è avere la giusta conoscenza delle cose umane e divine, ma dev’essere una conoscenza profonda, non superficiale. Per quanto infatti si sappiano, le cose bisogna riesaminarle e riferirle a sé stessi frequentemente, bisogna chiedersi che cosa siano il bene e il male, e indagare, al di là delle false definizioni, sulla provvidenza, sull’onestà e l’abiezione. Ma l’intelligenza umana nella sua acutezza non si ferma a questi problemi, vuole guardare anche al di là del mondo terreno, capire quali siano la sua origine e la sua meta e verso quale fine si diriga così velocemente l’universo. Noi abbiamo distolto l’animo dalla pura contemplazione del divino per trascinarlo a cose meschine e spregevoli che soddisfano la nostra avidità, affinché, dimentico dei confini del mondo e dei signori che regolano ogni cosa, scavi la terra e, non pago dei mali che ha già davanti a sé, cerchi di tirarne fuori altri. Tutto ciò che poteva esserci utile dio, nostro padre, ce lo ha messo vicino; non ha aspettato che noi lo cercassimo, ce lo ha dato spontaneamente: le cose nocive, invece, le ha nascoste nelle viscere della terra. È con noi stessi che dobbiamo prendercela: abbiamo portato alla luce quelle cose che sono diventate la causa della nostra rovina, facendo violenza alla natura che ce le nascondeva. Abbiamo assoggettato l’anima al piacere, dando origine a tutti i nostri mali; l’abbiamo consegnata all’ambizione, alla sete di gloria e ad altre aspirazioni ugualmente futili e vane. Che ti consiglio, dunque? Niente di nuovo, non stiamo cercando rimedi per mali nuovi. Ma una cosa soprattutto ti consiglio: cerca di capire cos’è necessario e cosa invece è superfluo. Il necessario ti si presenterà da sé dovunque tu voglia, il superfluo dovrai cercarlo sempre con grandi sforzi. Però non devi compiacerti troppo per aver disprezzato letti d’oro e suppellettili ornate di pietre preziose: che virtù c’è a disprezzare il superfluo? Potrai essere fiero di te stesso solo quando disprezzerai il necessario. Non è un granché se riesci a vivere senza lo sfarzo di un re, se non senti il bisogno di cinghiali enormi o di lingue di fenicottero e altre singolari trovate di un lusso che ormai snobba gli animali nella loro integrità e di ciascuno sceglie determinate parti. Avrai la mia ammirazione se disprezzerai anche il pane nero, se ti convincerai che l’erba, in caso di necessità, spunta non solo per le bestie ma anche per l’uomo, se capirai che il nostro ventre possono nutrirlo e saziarlo i germogli delle piante, mentre noi vi ammassiamo cibi pregiati, come se potesse conservare ciò che riceve. Lo stomaco dobbiamo riempirlo senza tante raffinatezze: che importa il genere di cibo che gli mettiamo dentro, dal momento che tutto va perduto? Ti piace vedere in tavola animali marini e terrestri: gli uni sono più graditi se arrivano freschi alla mensa, gli altri se nutriti a lungo e ingrassati a forza grondano grasso e
sembra quasi che scoppino; ti piace la loro squisitezza ottenuta ad arte. Ma queste pietanze, perbacco, procurate con enorme fatica e preparate in tanti modi diversi, una volta finite nello stomaco diventeranno una poltiglia ripugnante. Se vuoi disprezzare il piacere del cibo guarda la fine che fa. Ricordo che Attalo tra l’ammirazione generale diceva: «Per troppo tempo le ricchezze mi hanno ingannato. Quando le vedevo splendere qua e là restavo affascinato: pensavo che non vi fosse tanta differenza fra l’apparenza e la sostanza. Ma nel corso di una festa vidi tutti i tesori di Roma, oggetti cesellati in oro e argento con pietre ancora più preziose, vesti colorate e raffinate giunte da terre al di là non solo dei nostri confini ma anche di quelli dei nemici; da una parte uno stuolo di giovani schiavi di rara bellezza ed eleganza, dall’altra una schiera di schiave, e altri beni ancora che la fortuna dell’impero più potente del mondo aveva esposto passando in rassegna le sue ricchezze». Mi domando: «Cos’è questo, se non stimolare la cupidigia degli uomini già di per sé eccitata? Che scopo ha questo sfoggio di ricchezza? Siamo venuti qui per imparare l’avidità?». E invece, guarda un po’, me ne vado meno avido di quando sono venuto. Disprezzo la ricchezza non perché superflua, ma perché è cosa di poco conto. Hai visto? Quel lungo corteo, benché procedesse lento e ordinato, è passato in poche ore. Dunque, una cosa che non è durata un giorno intero dovrà occupare tutta la nostra vita? Perdipiù queste ricchezze mi sono sembrate superflue non solo per gli spettatori ma anche per i possessori. Ecco perché ogni volta che qualcosa di simile mi abbaglia, che mi trovo davanti a una casa sontuosa, a un elegante stuolo di schiavi o a una lettiga sostenuta da servi di bell’aspetto, dico a me stesso: «Perché guardi con tanta ammirazione? Perché rimani sbalordito? È uno sfoggio, una messinscena: queste ricchezze non sono veramente possedute; non fanno in tempo a piacere che già sono passate». Volgiti piuttosto alla vera ricchezza; impara a essere contento di poco e grida con forza ed entusiasmo: «Abbiamo acqua, abbiamo polenta; gareggiamo in felicità con Giove stesso!». Ma ti prego, gareggiamo con lui anche se ci mancano entrambe; se è vergognoso riporre la felicità nell’oro e nell’argento lo è altrettanto riporla nell’acqua e nella polenta. «Che farò, allora, se mi mancheranno anche questi cibi?». Chiedi quale sia il rimedio all’indigenza? La fame mette fine alla fame, altrimenti che differenza c’è se a ridurti in schiavitù sono beni grandi o piccoli? Che importa quanto sia poco ciò che la sorte ti può negare? Anche acqua e polenta, infatti, dipendono dal volere altrui: è veramente libero non l’uomo contro cui la fortuna ha poco potere, ma quello contro cui non può nulla. È così: non devi aver bisogno di niente se vuoi competere con Giove che non ha bisogno di niente». Questo ci ha detto Attalo, questo la natura ha detto a tutti gli uomini, e se vi rifletterai spesso sarai felice, realmente, non in apparenza, e ti basterà esserlo di fronte a te stesso, non davanti agli altri. Stammi bene. 111. Mi chiedi come si chiamino in latino i sophismata. Si è tentato spesso
di dargli un nome, ma nessuno era appropriato: evidentemente, poiché noi non ne afferravamo il concetto, che non rientrava nell’uso comune, si è respinto anche il vocabolo. Tuttavia il sostantivo più adatto mi sembra quello usato da Cicerone: cavillationes. Chi vi si dedica tesse questioncelle davvero acute, che però non servono a vivere: non diventa più forte, o più temperante, o più nobile. Chi, invece, esercita la filosofia per migliorarsi, diventa magnanimo, pieno di fiducia, e appare insuperabile e superiore a chi gli sta vicino. Capita così con le alte montagne: a guardarle da lontano sembrano più basse, ma avvicinandosi si vede quanto siano elevate le loro cime. Tale è, Lucilio mio, il vero filosofo: in concreto, non con imbrogli. Sta in alto, degno di ammirazione, fiero, veramente grande; non si alza sulla pianta dei piedi, non cammina sulle punte come le persone che cercano di aumentare con l’inganno la loro statura e vogliono sembrare più alte di quanto non siano; è contento della sua altezza. E perché non dovrebbe godere di essere cresciuto fino al punto in cui la fortuna non può raggiungerlo? Egli, dunque, è al di sopra delle vicende umane, uguale a sé stesso in ogni situazione, sia nella buona che nella cattiva sorte, fra ostacoli e avversità di ogni genere: i cavilli, di cui poc’anzi ho parlato, non possono darci questa fermezza. Con essi l’anima gioca, non progredisce, e dall’altezza in cui si trova trascina in basso la filosofia. Io non ti vieto di dedicarti talvolta a questi cavilli, ma potrai farlo solo quando non avrai nulla da fare. I cavilli, però, hanno questo di veramente dannoso: procurano un certo diletto, trattengono e intrattengono l’animo con la loro apparente sottigliezza, mentre lo aspetta una mole di problemi e una vita intera non basta a imparare una sola cosa: il disprezzo della vita. «E per governarla?», mi chiedi. Questo lo imparerai in un secondo momento; nessuno può governare bene la vita se prima non la disprezza. Stammi bene. 112. Vorrei davvero che il tuo amico si potesse formare ed educare secondo il tuo desiderio, ma tu l’hai trovato già molto indurito, anzi – e ciò è più grave – proprio imbelle e infiacchito da vecchie e cattive abitudini. Voglio farti un esempio, tratto dalla mia attività agricola. Non tutte le viti sopportano l’innesto: se la pianta è vecchia e corrosa, o se è malata e fragile, non riceverà la marza, o non riuscirà a nutrirla, né ci saranno l’unione e il passaggio di natura e di qualità. Perciò di solito si taglia la vite al livello del terreno, così che, se l’innesto non riesce, si possa tentare un’altra volta e ripetere l’operazione sotto terra. Ebbene, l’individuo di cui parli e che raccomandi non ha forza: ha assecondato troppo i suoi vizi, si è fatto marcio e duro nel medesimo tempo; non è più in grado di ascoltare la ragione e tanto meno di nutrirla. «Ma è lui stesso a volerlo». Non crederci. Non dico che menta, è davvero convinto di volerlo. La sua dissolutezza gli è venuta a nausea: ma presto si riconcilierà con essa. «Ma lui sostiene di essere disgustato dalla sua vita». Lo credo: chi non ne proverebbe disgusto? Gli uomini amano e al tempo stesso odiano i propri vizi. Perciò lo giudicheremo quando ci dimostrerà con certezza che detesta quella vita corrotta: per ora è solo
in disaccordo con sé stesso. Stammi bene. 113. Tu vuoi che io ti dica il mio parere sull’argomento di cui abbiamo parlato, se cioè la giustizia, la fortezza, la prudenza e le altre virtù siano animali. Con questi cavilli, carissimo Lucilio, sembra che noi esercitiamo la mente in questioni inutili perdendo tempo in discussioni altrettanto inutili. Tuttavia farò come vuoi e ti esporrò il parere dei filosofi stoici, dai quali però ti confesso di dissentire: secondo me, infatti, ci sono problemi più convenienti ai filosofi greci che indossano il pallio e i calzari bianchi. Io dunque ti illustrerò le questioni che hanno interessato e fatto discutere i filosofi antichi. È noto che l’anima è animale, poiché ci rende esseri animati, e che questi hanno derivato da lei tale nome. Ebbene, la virtù altro non è che un certo stato dell’anima, quindi la virtù è animale. Inoltre, essa agisce, e poiché una delle prerogative degli animali è lo slancio e non si può mai agire senza slancio, la virtù è animale. «Se la virtù è animale», si osserva, «ha in sé la virtù». E perché mai la virtù non dovrebbe possedere sé stessa? Il saggio agisce sempre attraverso la virtù, dunque la virtù agisce attraverso sé stessa. «Allora», si dice, «anche tutte le arti sono animali, anche i nostri pensieri e tutto ciò che noi abbracciamo con la mente; di conseguenza nello spazio angusto del nostro petto dimorano molte migliaia di animali e ciascuno di noi è formato da molti animali, oppure abbiamo in noi molti animali». Ora ti dico cosa si può controbattere a questa osservazione. Ciascuna delle cose che hai detto sarà un animale ma non ci saranno molti animali. Perché? Se mi presterai la massima attenzione e la tua acuta intelligenza te lo dirò. Gli animali singoli hanno ciascuno una loro propria essenza, mentre tutte queste cose hanno insieme una sola anima, perciò possono esistere singolarmente ma non possono essere molte. Io sono uomo e animale, ma non si può dire che noi siamo due animali, perché dovremmo essere due elementi distinti e per essere due occorre che l’uno sia separato dall’altro. Tutto ciò che in un unico essere è molteplice appartiene a un’unica natura, dunque è uno. La mia anima è un animale, io sono un animale e tuttavia noi non siamo due esseri, in quanto l’anima è parte di me stesso: una cosa, infatti, conta per sé stessa quando esiste di per sé ma quando fa parte di un altro essere non può esserne distinta. Ti spiego perché: un essere distinto deve appartenere interamente a sé, avere caratteristiche proprie ed essere completo e compiuto in sé stesso. Ti ho già detto che io la penso diversamente. Se infatti si accetta questa teoria saranno animali non solo le virtù ma anche i vizi, che sono il loro opposto, e le passioni, come l’ira, la paura, il cordoglio e il sospetto. Ma la cosa non si ferma qui, giacché saranno animali anche tutte le idee e tutti i pensieri, il che è assolutamente inaccettabile, visto che non tutto ciò che è fatto dall’uomo è uomo. Ci si chiede: «Cos’è la giustizia?». Una condizione dell’anima. «Allora», si risponde, «se l’anima è un animale lo è anche la giustizia». Niente affatto, la giustizia è un modo di essere dell’anima e una forza, è l’anima stessa che assume vari aspetti, ma non per questo diventa un animale diverso ogni volta che agisce
diversamente, e neppure ciò che viene fatto dall’anima è animale. Il punto è: se la giustizia è un animale, se lo sono la fortezza e le altre virtù, esse cessano di volta in volta di essere animali e ricominciano a esserlo, oppure lo sono sempre? Le virtù non possono finire, quindi nell’anima si trovano molti, anzi, innumerevoli animali. Si obietterà: «No, sono molti, perché legati a un unico essere di cui sono parti e membra». Facciamo dunque conto che l’anima sia simile all’Idra,3 il serpente dalle innumerevoli teste ognuna delle quali combatte e fa del male da sola. Ebbene, nessuna di quelle teste si può dire che sia un animale, è semplicemente una testa di animale, in quanto l’Idra è di per sé stessa un solo animale. Nessuno ha mai detto che nella Chimera4 il leone o il drago fossero animali, poiché entrambi ne erano parte e le parti non sono animali. Come puoi dunque concludere che la giustizia è un animale? «Agisce ed è utile, ciò che agisce ed è utile ha uno slancio e ciò che ha uno slancio è un animale». Lo è se ha uno slancio proprio, mentre lo slancio non è della giustizia, è dell’anima. Ogni animale resta sempre lo stesso dalla nascita alla morte: così l’uomo è uomo sino a quando muore, il cavallo cavallo e il cane cane. L’animale, insomma, non può diventare un altro. La giustizia, ovverosia l’anima che si trova in una determinata condizione, è, si dice, un animale. Ammettiamolo, ma se si ragiona così è un animale anche la fortezza, cioè l’anima che si trova in un determinato stato. Ma quale anima? Quella che prima era giustizia? Ma è prigioniera nell’animale precedente e non può passare in un altro: deve continuare a restare in quell’animale in cui ha cominciato a esistere. Inoltre una sola anima non può appartenere a due animali e tanto meno a un numero maggiore e se la giustizia, la fortezza, la temperanza e le altre virtù sono animali come possono avere un’unica anima? O ciascuno ha la sua o non sono animali, visto che un solo corpo non può appartenere a più animali. Questo lo ammettono anche i filosofi stoici. Qual è il corpo della giustizia? «L’anima». E il corpo del coraggio? «La medesima anima». Ma un solo corpo non può appartenere a due animali. «È la stessa anima che prende l’aspetto della giustizia, della fortezza e della temperanza». Ciò potrebbe accadere se nel momento in cui l’anima è giustizia non fosse anche coraggio, e quando è fortezza non fosse anche temperanza. Ma in realtà tutte le virtù esistono contemporaneamente. Allora se l’anima è una sola e non può formare più di un solo animale, come potranno essere animali le singole virtù? Infine nessun animale è parte di un altro animale, e se la giustizia è parte dell’anima non è un animale. Vedo che sto perdendo tempo in una questione così evidente di per sé: questo argomento merita sdegno più che una discussione. Nessun animale è uguale a un altro. Guardane i corpi: ciascuno ha un suo colore, un suo aspetto, una sua statura. Io dico che l’ingegno del divino artefice va ammirato anche per questo, perché in tanta varietà di esseri non si è mai ripetuto. Anche gli animali che sembrano simili, messi a confronto fra loro risultano diversi. Dio ha creato tanti tipi di foglie, ciascuna con caratteristiche proprie, tanti animali, ciascuno di grandezza diversa: c’è insomma sempre qualche differenza. Egli ha voluto che
esseri diversi fossero dissimili e disuguali. Come voi dite, tutte le virtù sono uguali, quindi non sono animali. Ogni animale agisce da sé, la virtù, invece, agisce con l’uomo. Tutti gli animali sono o razionali, come gli uomini e gli dèi, o irrazionali, come le belve e gli animali domestici; le virtù sono senz’altro razionali, ma non sono né uomini né dèi, quindi non sono animali. Ancora: ogni animale razionale agisce solo sotto lo stimolo di un’immagine, poi prende lo slancio quindi l’assenso conferma tale slancio. L’assenso è questo: devo camminare ma camminerò solo quando lo avrò detto a me stesso e avrò approvato questa mia idea; devo sedermi, ma mi siederò solo alla fine del suddetto ragionamento. Ebbene, questo assenso nella virtù non c’è. Supponiamo che si tratti della prudenza: come potrà la prudenza dare il proprio consenso alla necessità di camminare? La natura non lo consente. La prudenza guarda non a sé stessa ma alla persona a cui appartiene, non può né passeggiare né sedere. Ecco perché non ha l’assenso, e poiché non ce l’ha non è un animale razionale. Altrettanto dicasi della virtù, la quale sarebbe razionale se fosse un animale ma non è razionale, quindi non è un animale. Inoltre se la virtù fosse un animale, essendo la virtù ogni bene, ogni bene sarebbe un animale. Questo è il pensiero dei nostri filosofi: è un bene salvare il padre, è un bene fare discorsi saggi in senato, è un bene giudicare con giustizia, quindi salvare il padre è un animale e fare un discorso saggio è un animale. La questione arriverà a un punto in cui non ci si potrà più trattenere dal ridere nel sentir dire: «Tacere al momento opportuno è un bene, cenare frugalmente è un bene, dunque tacere e cenare sono animali». Io, perbacco, non smetterò di dilettarmi e di giocare con queste sottili sciocchezze, del tipo: la giustizia e la fortezza se sono animali sono indubbiamente terrestri; tutti gli animali terrestri soffrono il freddo, la fame e la sete, quindi la giustizia soffre il freddo, la fortezza la fame, la clemenza la sete. E dovrò fermarmi qui? Non chiederò ai filosofi che aspetto hanno questi animali? Di uomo, di cavallo o di fiera? Se gli attribuiamo una forma rotonda, come a dio, chiederò a essi se l’avarizia, la dissolutezza, la follia siano anch’esse rotonde, visto che anch’esse sono animali. Se poi anche a queste attribuisco una forma rotonda, chiederò loro se passeggiare compostamente sia un animale. Dovranno rispondere di sì e dire che passeggiare è un animale, e per di più rotondo. A questo punto non pensare che io sia il primo dei nostri filosofi stoici a non seguire le vecchie teorie e a esprimere un’opinione personale. Cleante, per esempio, e il suo discepolo Crisippo non sono d’accordo fra loro su che cosa sia il passeggiare. Per Cleante è lo spirito vitale che passa dall’elemento principale ai piedi, per Crisippo, invece, è l’elemento principale stesso. Perché, dunque, sull’esempio di Crisippo, ciascuno non rivendica la propria libertà e non se la ride di tutti questi animali che l’universo intero non potrebbe contenere? Si dice: «Le virtù non sono molti animali e tuttavia sono animali. Ebbene, come uno può essere poeta e oratore, pur restando tuttavia un unico individuo, così le virtù sono animali ma non molti animali. Infatti, l’anima e l’anima giusta,
saggia e forte, che si trova in una certa disposizione di fronte alle singole virtù, è la stessa». Eliminata la controversia, siamo d’accordo. Anch’io per ora riconosco che l’anima è un animale e mi riservo di esaminare in seguito il mio parere su questo argomento, tuttavia nego che le azioni dell’anima siano animali, altrimenti saranno animali anche tutte le parole e tutti i versi. Se infatti un discorso saggio è un bene e ogni bene è un animale ne consegue che un discorso sarà un animale. Così se un verso saggio è un bene e ogni bene è un animale, ne conseguirà che un verso è un animale. Perciò Canto le armi e l’uomo5 è un animale. Però non possono dire che sia rotondo, visto che l’esametro è costituito da sei piedi. «Perbacco, l’argomento in questione», tu dici, «è proprio capzioso». Mi vien da ridere se immagino come animali i solecismi, i barbarismi e i sillogismi e gli attribuisco una figura adeguata come se fossi un pittore. Dovremmo discutere di questo argomento corrugando i sopraccigli e aggrottando la fronte? A questo punto mi viene da pronunciare quel famoso verso di Celio: «Che squallide sciocchezze!». Sono ridicole. Piuttosto perché non trattiamo qualche argomento utile e salutare, indagando come si possa arrivare alla virtù e quale sia la strada che può condurci a essa? Insegnami non se la fortezza sia un animale, ma che nessun animale è felice senza la fortezza se non si è rafforzato contro la sorte e non è capace di dominare gli eventi con la riflessione prima di essere colto di sorpresa. Cos’è la fortezza? La difesa inespugnabile della debolezza umana, e chi se ne circonda resiste sicuro all’assedio della vita; si serve infatti di armi e di forze sue. E qui voglio citarti una massima del nostro Posidonio: «Non pensare mai di essere al sicuro grazie alle armi della fortuna: combatti con le tue. La fortuna non fornisce a uno armi contro sé stesso, dunque, anche se abbiamo quanto ci serve per combattere i nemici siamo inermi di fronte a lei». Alessandro volgeva in fuga i Persiani, gli Ircani,6 gli Indi e tutti i popoli orientali fino all’oceano e devastava i loro territori, ma lui, o per la morte di un amico o per la perdita di un altro, aveva la mente ottenebrata, angosciato dalle sue stragi o dal rimpianto; lui, vincitore di tanti re e di tanti popoli, si lasciava prendere dall’ira e dal dolore: aveva cercato di tenere in suo potere ogni cosa, ma non le passioni. Quanto si ingannano coloro che vogliono spingere il loro dominio al di là del mare e si ritengono felici se occupano con le armi molte regioni, aggiungendone di nuove a quelle vecchie, e sono ignari di quello straordinario potere che è il dominio di sé stessi, il più grande che ci uguaglia agli dei! Insegnami quanto sia sacra la giustizia che guarda al bene altrui e non chiede nulla a sé stessa se non di essere praticata, senza riguardo alcuno alla fama e all’ambizione, ma paga soltanto di sé. Ogni uomo si convinca innanzitutto di una cosa, che occorre essere giusti senza sperarne una ricompensa. Ma ciò non basta: dobbiamo anche convincerci che per questa bellissima virtù dobbiamo spendere tutti noi stessi, che i nostri pensieri
devono essere del tutto alieni da interessi privati. Chi agisce rettamente non bada al premio: il più grande premio consiste nell’atto stesso di giustizia. Tieni ben presente ciò che ho detto poc’anzi: non deve importarti se e quanti conoscano il tuo senso di giustizia, giacché chi vuole far mostra di una sua virtù pensa non alla virtù ma alla gloria. Tu non vuoi essere giusto senza averne gloria? Ma spesso, perbacco, dovrai essere giusto con disonore e allora, se sei saggio ti compiacerai di una cattiva fama ben conquistata. Stammi bene. 114. Vuoi sapere come mai in certi periodi uomini d’ingegno abbiano mostrato inclinazione per particolari difetti e perché si sia sviluppato un genere di eloquenza corrotto, per cui talvolta è stato in auge uno stile gonfio, talvolta spezzato e strascicato come una cantilena, perché siano stati apprezzati ora concetti arditi e assurdi, ora frasi rotte e ambigue, piene di sottintesi, e perché si sia fatto abuso della metafora. Il motivo è quello che dicono tutti e che presso i Greci è diventato un proverbio: il linguaggio degli uomini è uguale alla loro vita. L’agire di ciascuno somiglia al suo modo di parlare, talché a volte se un popolo devia dal retto comportamento e si abbandona ai piaceri, il suo modo di parlare si conforma ai pubblici costumi. Così un’eloquenza corrotta, se non è un fatto isolato che riguardi una o due persone ma è accettata e seguita da tutti, è segno di una dissolutezza generale. La mente non può essere diversa dallo spirito: se lo spirito è sano, ordinato, austero e temperante anche la mente è sobria e assennata, se è corrotto ne è contagiata. Se lo spirito è fiacco si trascinano a stento le gambe e si cammina a fatica. Se è effeminato, la sua rilassatezza è evidente già nell’incedere, se è fiero e animoso, il passo è concitato, se è pazzo o in preda all’ira, passione simile alla pazzia, il corpo altera i movimenti, non procede ma è come trascinato. Non credi che ciò si verifichi ancor più con la mente, che è tutt’uno con lo spirito? Essa ne è plasmata, gli obbedisce e ne trae la sua legge. Il modo di vivere di Mecenate è troppo noto perché ti debba dire come passeggiasse, quanto fosse raffinato, come volesse mettersi in mostra e non nascondere i suoi vizi. Ebbene, la sua eloquenza non fu trasandata come lo era lui? Le sue parole non erano particolari quanto la sua eleganza, il suo sèguito, la sua casa, la sua consorte? Sarebbe stato un uomo di grande ingegno se la sua mente lo avesse indirizzato su una via più retta, se non avesse ricercato l’oscurità, se lui non fosse stato trascurato anche nel linguaggio. La sua era l’eloquenza tipica di un uomo ubriaco: involuta, degenerata, corrotta. «Il fiume e la riva chiomata di selve»: cosa c’è di più brutto? Guarda come «arano con le barche il letto del fiume e rivoltando le acque si lasciano dietro i giardini». E che dire di uno che «arriccia il viso ammiccando alla sua donna, fa il colombo con le labbra e comincia sospirando come col collo stanco infuriano i signori del bosco»? E ancora: «Gente incorreggibile, frugano nei banchetti, attentano alle case con le bottiglie e passano la loro morte sperando», «A stento chiamerei il Genio come testimone del suo giorno festivo», «I fili dell’esile candela e la
focaccia crepitante», «La madre o la sposa adornano il focolare». Appena leggerai queste parole ti verrà in mente Mecenate che girava per la città con la tunica slacciata e che anche quando sostituiva Augusto si faceva notare per la sua veste discinta; che in ogni pubblica assemblea mostrava il capo coperto dal mantello da cui spuntavano solo le orecchie, come fanno i mimi che scimmiottano gli schiavi fuggitivi di un ricco; che mentre infuriavano le guerre civili e nella città sconvolta tutti i cittadini erano in armi si mostrava in pubblico scortato da due eunuchi, i quali, però, erano più virili di lui; che si sposò mille volte pur avendo una sola moglie. Ebbene, tali parole, distribuite così male, buttate lì con trascuratezza, disposte in un modo totalmente insolito, sono la dimostrazione che anche le abitudini di Mecenate erano altrettanto insolite, corrotte e singolari. La sua dote più ammirevole era la mansuetudine: si astenne infatti dall’usare la spada e dal versare sangue, e il suo potere lo mostrò solo con la sua dissolutezza. Ma guastò questa sua buona qualità con le raffinatezze del suo linguaggio del tutto inusuale. Più che un uomo mite fu un debole. Questi suoi scritti contorti, questi concetti strani, spesso notevoli ma privi di vigore, dimostrano chiaramente che la troppa prosperità gli aveva dato alla testa. Ora, questo difetto può caratterizzare non solo un uomo ma anche un’epoca. Quando la fortuna eccessiva produce una dissolutezza diffusa dapprima si nota una cura più ricercata del proprio corpo, poi ci si preoccupa per le suppellettili, quindi si rivolge ogni attenzione alla casa, che dev’essere vasta come una campagna, le pareti devono risplendere di marmi importati d’oltre oceano, i soffitti devono essere laminati d’oro e lo splendore dei pavimenti deve conformarsi a quello dei soffitti. Il lusso passa dalla casa alla tavola, che si cerca di impreziosire con le stramberie e sovvertendo l’ordine consueto: si presentano come primi piatti quelli che solitamente concludono il pranzo e agli invitati che se ne vanno si dànno i cibi distribuiti all’arrivo. Ebbene, l’anima quando è nauseata dalle abitudini e le ritiene spregevoli cerca anche un linguaggio nuovo: ora tira fuori parole vecchie e in disuso, ora ne conia di nuove e ne cambia i significati, ora – questa è l’ultima moda – ritiene segno di eleganza metafore audaci e frequenti. C’è chi non finisce i concetti, lasciando le frasi in sospeso e suggerendone appena il senso, pensando così di essere applaudito dagli ascoltatori; c’è chi si dilunga e allunga i pensieri; e chi non arriva a questi difetti (perché deve fare il grande scrittore) se ne compiace e li ama. Perciò dove c’è un’eloquenza corrotta, applaudita da tutti, ci sarà senz’altro anche una corruzione dei costumi. Banchetti e vestiti sfarzosi sono indice di una società malata e conseguentemente la licenza del linguaggio, quando è diffusa, mostra che anche gli animi, da cui nascono le parole, sono in decadenza. Non devi stupirti che l’eloquenza corrotta sia accolta benevolmente non solo dal pubblico più grossolano ma anche dai più colti, in quanto colti e incolti differiscono fra loro nelle vesti, non nelle opinioni. Ti stupirai piuttosto che insieme a quelle opere siano lodati anche i difetti. È sempre stato così: agli uomini d’ingegno i difetti vengono perdonati. Citami un uomo famoso a tuo
piacere e io ti dirò che cosa i suoi contemporanei gli hanno perdonato e che cosa, consapevolmente, hanno fatto finta di non vedere. Posso citarti molti che non sono stati minimamente danneggiati dai loro difetti e altri che addirittura ne hanno tratto giovamento: uomini famosissimi, ammirati che se ti azzardi a correggere potresti distruggere, tanto i vizi sono uniti alle virtù da trascinarle via con sé. A ciò si aggiunga che il linguaggio non ha regole fisse ma viene trasformato dalle consuetudini sociali in una rapida e continua evoluzione. Molti afferrano parole da altre epoche, parlano la lingua delle Dodici Tavole, per loro Gracco, Crasso e Curione7 sono troppo moderni e raffinati, per cui tornano indietro sino ad Appio Claudio Cieco e a Coruncanio. 8 Altri, invece, vanno in cerca di espressioni consumate e comuni e cadono nella volgarità. Entrambi questi due stili sono corrotti, sia pure in modo diverso, come quando, perbacco, si vogliono usare solo vocaboli splendidi, altisonanti e poetici, ed evitare quelli usuali e indispensabili. Secondo me sbagliano sia gli uni che gli altri: i primi per troppa cura, i secondi per troppa trascuratezza, gli uni si depilano anche le gambe, gli altri nemmeno le ascelle. Ora passiamo alla disposizione delle parole. Quanti tipi di strafalcioni pensi che posso mostrarti? Ad alcuni piacciono le frasi spezzate e diseguali, le scompongono deliberatamente se hanno un ritmo troppo scorrevole; non vogliono creare legami senza che l’espressione risulti scabra e difficile: per loro sono forti e virili quelle parole che colpiscono l’orecchio perché disuguali. Altri più che costruire le frasi ne variano il timbro, rendendole fluide e carezzevoli. Che dire poi dei periodi in cui si rinviano le parole facendole attendere a lungo e comparire a stento alla fine? Che dire del periodo come quello di Cicerone che comincia lento e scorrevole, si trattiene mollemente e segue sempre il suo andamento e il suo ritmo abituali? Ma i difetti non si trovano solo * * * nel tipo dei concetti, se sono meschini e puerili o malvagi e spudorati, se sono ornati e troppo sdolcinati, se cadono nel vuoto e non generano altro effetto che il loro suono. Ebbene, questi difetti vengono introdotti da un oratore che in quel determinato momento detta legge in fatto di eloquenza: gli altri li imitano e se li trasmettono fra loro. Così quando era di moda Sallustio venivano considerati eleganti i pensieri tronchi, le parole inaspettate, le locuzioni concise e oscure. Il console Arrunzio, 9 uomo di eccezionale sobrietà, autore di una storia della guerra punica, fu un sallustiano e si distinse in quel genere di prosa. In Sallustio si trova la frase: «fece l’esercito col denaro», cioè lo allestì con denaro. Ebbene, questa espressione ad Arrunzio piacque tanto che la inserì in ogni pagina. In un passo dice: «fecero la fuga ai nostri», in un altro: «Gerone, re di Siracusa, fece la guerra». E ancora: «questa notizia fece che i Palermitani si arrendessero ai Romani». Ho voluto darti un assaggio, ma tutto il libro è infarcito di simili espressioni, che se in Sallustio sono rare, in Arrunzio, invece, sono frequenti e quasi continue. Il motivo è questo, che per Sallustio erano occasionali, mentre
Arrunzio le cercava di proposito. Vedi quindi quali sono le conseguenze quando un difetto si prende a esempio! Sallustio scrive: «acque invernali», Arrunzio nel primo libro della guerra punica scrive: «all’improvviso il tempo divenne invernale». In un altro passo, volendo dire che quell’anno era stato freddo, scrive: «tutto l’anno fu invernale», e in un altro ancora: «da lì inviò sessanta navi da carico leggere oltre ai soldati e ai marinai necessari sotto un aquilone invernale»; e questa parola la infilò continuamente dappertutto. In un altro passo Sallustio scrive: «Mentre, durante le guerre civili, aspirava alle reputazioni di uomo giusto e onesto». Ebbene, Arrunzio corse subito a scrivere nel primo libro che grandi erano «le reputazioni» di Regolo. Questi e altri analoghi difetti, che si acquistano per imitazione, non sono segno di dissolutezza, né di un animo corrotto: affinché tu possa giudicare in base ai difetti le passioni di un uomo occorre che quei difetti siano personali e nati da quel medesimo individuo che li usa. Voglio dire: un linguaggio iracondo è proprio di una persona iraconda, uno troppo concitato è tipico di una persona appassionata, uno voluttuoso e fiacco è caratteristico di un uomo effeminato. Se ci fai caso questo modo di esprimersi è tipico di quelli che si tagliano la barba o se la sfoltiscono, che si radono accuratamente i baffi o li tagliano via, ma conservano e fanno crescere i peli nelle altre parti del corpo, che indossano mantelli di colori sgargianti, vesti trasparenti e non fanno nulla che passi inosservato agli occhi della gente: vogliono insomma suscitare l’interesse degli altri attirandolo su di sé; accettano persino il biasimo pur di farsi notare. Tale è l’eloquenza di Mecenate e di tutti coloro che non commettono errori di stile per caso ma consapevolmente e di proposito. All’origine di ciò c’è un profondo malessere spirituale: quando uno beve, la lingua si inceppa solo se la mente cede al peso del vino e vacilla o si abbandona, sicché questa sorta di ubriachezza del linguaggio non è dannosa finché l’anima rimane salda. Dobbiamo dunque curare l’anima, poiché da essa derivano i pensieri, le parole, il nostro comportamento, l’espressione del volto e il modo di camminare. Se l’anima è sana e vigorosa, anche il linguaggio è virile, forte e robusto: se l’anima cede, anche il resto la segue nella caduta. Tutti sono concordi, fintanto che incolume è il re: quando scompare il re, ogni promessa è violata.10 Il nostro re è l’anima: finché essa è sana le altre parti adempiono al proprio dovere, obbediscono e sono sottomesse; quando l’anima vacilla un po’, tutto nello stesso momento si fa incerto. Quando cede al piacere, anche le sue facoltà e le sue azioni si indeboliscono e tutti gli impulsi diventano fiacchi e senza vigore. Visto che ho usato questo esempio, continuerò così. La nostra anima ora è un re, ora un tiranno: è un re quando guarda alla virtù, quando ha cura della salute del corpo che le è stato affidato e non gli comanda niente di abietto o di
meschino; ma quando è sfrenata, avida e voluttuosa si trasforma in un tiranno, nome funesto e detestabile. A quel punto diventa preda e vittima di passioni sfrenate. Inizialmente ne gode, come fa il popolo che quando c’è una distribuzione di cibo si ingozza inutilmente a suo danno arraffando ciò che non può inghiottire. Poi quando il male ha consumato via via le forze e la lussuria è penetrata nelle midolla e nei nervi, alla vista di quelle dissolutezze, che l’eccessiva avidità ha reso impossibili, si compiace e considera come suoi piaceri lo spettacolo di quelli altrui, complice e testimone di dissolutezze del cui godimento, approfittandone, si è privata, e il piacere di possedere in abbondanza tali delizie supera l’angustia di non poter riempire la gola e lo stomaco di tutto ciò che è stato imbandito, di non potersi avvoltolare con tutta quella massa di amanti e di femmine, e si duole perché gran parte della sua felicità è impedita e viene a mancare per i suoi limiti fisici. Questa pazzia, caro Lucilio, non consiste forse nel fatto che ciascuno di noi pensa di essere debole e mortale, anzi di essere uno solo? Guarda le nostre cucine e i cuochi che vanno da un fornello all’altro: ti pare che con un trambusto simile si prepari cibo per un solo stomaco? Guarda le nostre provviste di vino vecchio e le cantine piene delle vendemmie di molte generazioni: ti pare che vini di tanti anni e di tante regioni siano conservate per un solo stomaco? Guarda in quanti luoghi si vanga la terra, quante migliaia di contadini arano e zappano: ti pare che in Sicilia e in Africa si semini per un solo stomaco? Saremo sani e concepiremo desideri moderati se ciascuno di noi conterà sé stesso e contemporaneamente misurerà il proprio corpo e capirà che esso non può contenere molto, né per lungo tempo. La cosa però che più ti servirà per essere temperante è il pensare spesso che la vita è breve e incerta: guarda alla morte qualunque cosa tu faccia. Stammi bene. 115. Caro Lucilio, non pensare troppo alle parole e a come devono essere disposte nel discorso: io ho per te questioni più importanti. Preoccupati del contenuto, non della forma, e non tanto di scrivere, quanto di sentire ciò che scrivi, sì da imprimertelo nell’animo come se ti rivolgessi a te stesso. Se senti uno parlare con uno stile ricercato ed elegante pensa che anche la sua anima è impegnata in simili meschinità. Una persona magnanima parla in modo più pacato e tranquillo. Tutte le sue parole rivelano più sicurezza che preoccupazione formale. Hai presenti certi bellimbusti con la barba e i capelli tirati a lucido, tutti agghindati? Ebbene, da loro non puoi aspettarti niente di forte, di solido. Il linguaggio è ornamento dell’anima, se è ricercato, artificioso ed elaborato dimostra che anche l’anima non è sincera e ha delle debolezze. La ricercatezza non è un ornamento virile. Se potessimo guardare nell’anima di un uomo onesto, che singolare bellezza, che dignità, che splendore di magnificenza e di serenità vi scorgeremmo! Vedremmo splendervi la giustizia, la fortezza, la temperanza e la saggezza, e su di essa la frugalità, la moderazione, la pazienza, la generosità, l’affabilità e l’umanità, un bene raro (chi lo crederebbe?) in un uomo, diffonderebbero la loro luce. Per non parlare, buon dio, della bellezza, della
gravità, del peso, dell’autorità e del credito che vi aggiungerebbero la prudenza, la correttezza e la magnanimità, la più insigne tra queste virtù! Tutti definirebbero quell’anima meritevole di amore e di venerazione. Chi vedesse la sua bellezza, più alta e più splendida di quanto si sia soliti vedere fra le cose umane, non resterebbe lì incantato e pieno di stupore come di fronte a una divinità, ma prima pregherebbe in silenzio perché gli è stato concesso di avere quella visione, poi, ispirato dall’espressione benevola del volto, la adorerebbe supplicandola e dopo averla a lungo contemplata così eminente e alta più della statura delle cose che siamo abituati a vedere, con gli occhi pieni di dolcezza e ardenti di un vivido fuoco, preso da sacro rispetto e sbalordito pronuncerebbe quel verso del nostro Virgilio: Vergine, come chiamarti? Non hai aspetto mortale, umana non è la tua voce… sii propizia e, chiunque tu sia, mitiga il nostro soffrire.11 Se vorremo venerarla ci assisterà e ci porgerà aiuto. Ma un’anima simile la si venera non sacrificando pingui tori, e nemmeno con doni votivi d’oro e d’argento o con offerte versate al tesoro del tempio, ma con pii e onesti propositi. Io dico che tutti arderemmo d’amore per lei se ci toccasse di vederla, ma molti ostacoli o accecano i nostri occhi con l’eccessivo splendore o gli impediscono di vedere per la troppa oscurità. Ma come con certi farmaci rendiamo più limpida e più acuta la nostra vista, così, se potremo vedere l’anima senza alcun impedimento, scorgeremo la virtù anche se nascosta dal corpo, anche se la povertà, una condizione umile e il disonore le fanno da schermo. Vedremo, insomma, la sua bellezza anche coperta di stracci. D’altra parte riusciremo ugualmente a vedere un’anima torbida e malvagia anche se si frappongono fra lei e chi guarda il vivido splendore della ricchezza e la falsa luce degli onori e del potere. Ci accorgeremo allora che spregevoli sono quei beni che ammiriamo, come i bambini che tengono in gran conto i giochi e ai genitori e ai fratelli preferiscono monili di poco prezzo. L’unica differenza tra noi e loro, come dice Aristone,12 sta nel fatto che noi facciamo follie per quadri e statue pagando di più la nostra stoltezza, e i bambini si divertono con i sassolini lisci e colorati che trovano sulla spiaggia e noi con grandi colonne variopinte, importate dai deserti dell’Egitto e dell’Africa, che sostengono un portico o una sala da pranzo capace di contenere una gran folla di gente. Ammiriamo le pareti ricoperte da marmi sottili pur sapendo che cosa c’è sotto, inganniamo i nostri occhi, lusingati dall’errore, quando ricopriamo d’oro i soffitti, pur sapendo che quell’oro nasconde delle brutte travi. Ma non sono solo le pareti e il soffitto a essere ricoperti da tale ornamento: anche la felicità di tutti costoro che vedi camminare a testa alta è del tutto esteriore. Guarda bene e vedrai quanto male si annidi sotto questa sottile patina di dignità. Da quando l’uomo ha cominciato a venerare il denaro, che attrae tanti magistrati e tanti giudici, e li fa eleggere, le cose hanno
perduto il loro effettivo valore, e noi, diventati ora mercanti, ora merce in vendita, guardiano non alla qualità, ma al prezzo; siamo onesti o disonesti per interesse, pratichiamo la virtù finché c’è una speranza di guadagno, pronti a fare dietro front se la scelleratezza promette di più. È colpa dei nostri genitori se ammiriamo l’oro e l’argento, e la cupidigia, che ci è stata inculcata fin da piccoli, ha messo profonde radici ed è cresciuta insieme a noi. Tutto il popolo, discorde su altre questioni, è concorde su questo punto: ammira l’oro, lo desidera per i suoi cari, lo consacra agli dèi come il più grande dei beni umani per dimostrare la sua gratitudine. Infine l’immoralità è tale che la povertà viene maledetta e ritenuta infamante, disprezzata dai ricchi, malvista dai poveri. Aggiungi a tutto ciò le opere dei poeti, che accendono le nostre passioni lodando la ricchezza come unico decoro e ornamento della vita. Per costoro gli dèi immortali non possono concedere o possedere essi stessi niente di meglio. S’erge la reggia del sole su alte colonne, dorata, splendida e scintillante.13 E guarda il carro del sole: D’oro era l’asse, d’oro il timone e il cerchio delle ruote, era d’argento la serie dei raggi.14 Infine chiamano aurea l’età che vogliono indicare come la migliore. Persino nei tragici greci non mancano personaggi che barattano per interesse l’onestà, la salute dello spirito e la reputazione. Mi stimino pure il peggiore degli uomini, purché mi stimino ricco. Tutti chiediamo se uno sia ricco, nessuno chiede se sia onesto. Di uno si vuol sapere solo cosa possieda, non il come e il perché. Dovunque ogni uomo è stimato tanto quanto ha. Chiedi cosa per noi sia vergognoso avere? Niente. Se ricco, voglio vivere, se povero, voglio morire. Muore bene chi muore mentre guadagna.15 Denaro, grande bene del genere umano, a cui non può essere pari l’amore della madre o dei dolci figli, non il genitore venerando per i suoi meriti; se qualcosa nel volto di Venere brilla con tanta dolcezza a ragione la dea fa innamorare dèi e uomini.16 Dopo che furono recitati questi ultimi versi della tragedia di Euripide tutto il pubblico con un impeto unanime scattò in piedi per cacciare l’autore e interrompere lo spettacolo, finché Euripide in persona si precipitò alla ribalta chiedendo che aspettassero di vedere che fine avrebbe fatto quell’ammiratore
dell’oro. In quella tragedia Bellerofonte17 pagava il fio che ciascuno paga nella propria vita. L’avidità si accompagna sempre alla punizione, sebbene essa sia già di per sé stessa una pena sufficiente. Quante lacrime esige, quanti affanni! Quanto è infelice l’avido per ciò che brama e per ciò che si è procurato! E poi ci sono le preoccupazioni quotidiane, che affliggono gli uomini in rapporto ai loro averi. Possedere denaro dà più tormento che acquistarlo. E come ci si strugge per le perdite che per quanto siano considerevoli sembrano ancora maggiori. Infine, anche se la sorte non sottrae nulla, si considera una perdita tutto ciò che non si riesce ad avere. «Ma gli uomini lo chiamano ricco e fortunato e desiderano ottenere quanto possiede lui». È vero, e allora? Pensi che ci sia qualcuno che sta peggio di chi è povero e invidioso? Oh, se chi desidera la ricchezza interrogasse i ricchi, se chi aspira alle cariche politiche interrogasse gli ambiziosi e quelli che hanno raggiunto i più alti livelli del potere! Vedendo che costoro non si fermano, concepiscono nuovi desideri e rinnegano quelli precedenti, la smetterebbe di avere simili velleità. Nessuno è soddisfatto della propria prosperità, anche se è arrivata rapidamente; ci si lamenta delle decisioni prese e dei successi ottenuti, e si preferisce sempre ciò che si è lasciato. La filosofia ti garantirà questo bene, che io considero il più grande: non ti pentirai mai delle tue azioni. A questa felicità, così solida che nessuna tempesta può abbattere, non condurranno certo le frasi ben costruite o un linguaggio dolce e scorrevole: le parole fluiscano pure liberamente, purché l’anima mantenga il suo equilibrio, purché sia grande e noncurante dei pregiudizi, purché si congratuli con sé stessa per quelle sue buone azioni che gli altri non approvano, giudichi i suoi progressi in rapporto alla sua vita, e ritenga di essere saggia solo in quanto non ha desideri né timori. Stammi bene. 116. Si discute spesso se sia meglio nutrire passioni moderate o non averne affatto. Gli stoici ritengono che siano da eliminare, i peripatetici da moderare. Io non vedo come una malattia, per quanto sia leggera, possa essere utile o salutare. Non temere: non ti tolgo nulla di ciò che tu non vuoi che ti sia negato. Guarderò con benevolenza e indulgenza le cose a cui aspiri e che ritieni necessarie alla vita, oppure utili o piacevoli: ti strapperò solo il vizio, proibendoti di nutrire desideri sfrenati, ma non di volerne, sì che tu possa fare le stesse cose senza timore e con maggiore risolutezza e godere più intensamente anche dei piaceri: perché non dovresti sentirli maggiormente se sarai tu a dominarli, invece di esserne schiavo? «Ma è naturale», ribatti, «che io mi dolga per la perdita di un amico: considera legittime queste lacrime così giuste. È naturale tener conto del giudizio altrui e rattristarsi se è sfavorevole: perché non vuoi concedermi questo onesto timore di avere una cattiva reputazione?». Tutti i vizi sono giustificabili, all’inizio, perché moderati e domabili, ma poi divampano, e se si permette che nascano non si riuscirà a stroncarli. Inizialmente ogni passione è debole, poi si infiamma e acquista forza via via: è più facile tenerle lontane che estirparle. Tutte le passioni in fondo scaturiscono da un’origine naturale, nessuno può
negarlo. La natura ci ha affidato la cura dei nostri corpi, ma quando gli stiamo troppo dietro nasce il vizio. La natura ha mescolato alle necessità della vita il piacere affinché questo ci rendesse più gradite le cose indispensabili alla nostra esistenza, non perché noi lo ricercassimo deliberatamente: quando però il piacere la fa da padrone nasce la dissolutezza. Impediamo dunque alle passioni di farsi strada in noi perché, come ho detto, non accoglierle è più facile che scacciarle. Dirai: «Concedimi almeno un certo grado di dolore, di paura». Ma questo “un certo grado” si espande e non si ferma a tuo piacere. Il saggio è al sicuro senza doversi sorvegliare continuamente, e le sue lacrime e i suoi piaceri li arresta quando vuole: per noi, dato che non è facile tornare indietro, la cosa migliore è non avanzare affatto. Secondo me Panezio diede una bella risposta a quell’adolescente che gli chiedeva se il saggio possa amare. «Del saggio», disse, «parleremo dopo: poiché noi due siamo ancora molto lontani dalla saggezza non dobbiamo correre il rischio di imbatterci in un sentimento impetuoso e incontrollabile, che ci rende schiavi di altri e spregevoli a noi stessi. Se chi amiamo ci corrisponde, la sua dolcezza ci infiamma; se invece ci disprezza, la sua superbia ci eccita. Fortuna e sfortuna in amore sono ugualmente nocive: dell’una siamo preda, con l’altra lottiamo. Perciò, consapevoli della nostra debolezza, stiamocene quieti: la nostra anima è debole, non affidiamola al vino o alla bellezza, all’adulazione o agli allettamenti». Ebbene, ciò che Panezio rispondeva al giovinetto che lo interrogava sull’amore io lo estendo a tutte le passioni: allontaniamoci il più possibile dai terreni fangosi, visto che fatichiamo a stare in piedi anche su quelli asciutti. A questo punto ribatterai con quella nota obiezione rivolta agli stoici: «Promettete cose troppo grandi, date precetti troppo severi. Noi siamo esseri deboli; non possiamo negarci tutto. Ci dorremo, ma poco; avremo desideri, ma modesti; ci arrabbieremo, ma poi ci calmeremo». Sai perché non possiamo comportarci così? Perché dubitiamo di farcela. Anzi, perbacco, il motivo in effetti è un altro: difendiamo i nostri vizi perché li amiamo e preferiamo scusarli piuttosto che scacciarli. La natura ci ha dato forza sufficiente perché l’usiamo, a condizione che raduniamo le nostre forze e le muoviamo tutte in nostro favore, non contro di noi. La verità è che ci manca volontà, l’impossibilità che accampiamo è un pretesto. Stammi bene. 117. Con le tue questioncelle m’imbarazzi non poco, impegnandomi in una grossa e fastidiosa disputa: io non posso alienarmi gli stoici dissentendo dalle loro teorie e neppure dirmi d’accordo con loro senza fare torto alla mia coscienza. Gli stoici sostengono che la saggezza è un bene e l’essere saggi no, e tu vuoi sapere se ciò sia vero. Ebbene, io prima ti esporrò la teoria stoica, e soltanto dopo oserò dire il mio parere. Per gli stoici il bene è corpo, poiché ciò che è bene agisce e tutto ciò che agisce è corpo. Ciò che è bene giova, ma per giovare deve agire, e se agisce è corpo. Ora se, come dicono, la saggezza è un bene ne consegue necessariamente che anch’essa dev’essere corporea. Però per
gli stoici l’essere saggi è diverso, è una cosa incorporea e accessoria della saggezza, perciò non agisce e non giova. «Ma come?», si obietta. «Non diciamo che essere saggi è un bene?». Sì, ma in riferimento alla saggezza, cioè a ciò da cui l’essere saggi dipende. Ora ascolta cosa controbattono gli altri, prima che io lasci questo argomento per affrontarne uno nuovo. «Ragionando così», dicono, «neppure vivere felici è un bene, sicché, sia pure a denti stretti, bisogna rispondere che una vita felice è un bene, ma non lo è vivere felici». E ancora si obietta: «Voi volete essere saggi, quindi l’essere saggi è cosa desiderabile, e se è desiderabile è buona». Gli stoici, insomma, sono costretti a stravolgere i termini e a inserire nel verbo expetere una sillaba, cosa che la nostra lingua non consentirebbe. «Expetendum – dicono – è ciò che è bene, expetibile è ciò che ci tocca quando abbiamo conseguito un bene, che non si ricerca come un bene ma si aggiunge al bene che si ricerca». Io non la penso così e ritengo che gli stoici arrivino a questa affermazione perché sono legati al punto di partenza del loro ragionamento e non possono cambiare la formula. Noi di solito attribuiamo una grande importanza alle opinioni generali e il fatto che un’opinione sia condivisa da tutti è per noi indizio di verità: l’esistenza degli dèi, per esempio, la ricaviamo anche da questa argomentazione: in tutti è insito il concetto della divinità e non c’è popolo così estraneo alla leggi e ai costumi civili che non creda in un qualche dio. Quando discutiamo dell’immortalità dell’anima è determinante per noi il fatto che tutti gli uomini temono oppure onorano gli inferi. Ora, richiamandoci all’opinione generale, non si troverà una sola persona che non giudichi un bene sia la saggezza che l’essere saggi. Io tuttavia non mi appellerò al popolo, come fanno di solito i vinti, ma comincerò a combattere con le mie armi. Dunque. Ciò che accade a una cosa è esterno o interno alla cosa a cui accade? Se è dentro è corpo, come la cosa alla quale accade. Non c’è infatti cosa che possa accadere senza un contatto, e ciò che crea contatto è corpo, come non c’è cosa che possa accadere senza un’azione, e ciò che agisce è corpo. Se quel che accade alla cosa è al di fuori della cosa stessa vuol dire che dopo essere accaduto se ne stacca, e ciò che si stacca ha un movimento, e ciò che ha movimento è corpo. Adesso tu ti aspetti ch’io dica che la corsa e il correre non sono cose diverse, come il calore e l’essere caldo, lo splendore e il risplendere: ammetto che siano cose diverse, ma non di diversa specie. Se la salute è indifferente, anche lo star bene è indifferente; se la bellezza è indifferente lo è anche l’essere belli. Se la giustizia è un bene lo è anche l’essere giusti; se la bruttezza è un male lo è anche l’essere brutti, come, perbacco, se la cisposità è un male, anche l’essere cisposi è un male. Vedi, dunque, che l’una cosa non può esistere senza l’altra: chi possiede la saggezza è saggio, chi è saggio possiede la saggezza. È talmente impossibile dubitare che siano entrambe cose uguali che secondo alcuni addirittura si identificano. Vorrei però chiedere, visto che ogni cosa o è male o è bene o è indifferente, in quale categoria rientri l’essere saggi. Dicono che non sia un bene, però non è un male, dunque sarebbe una via di mezzo. Ebbene, noi chiamiamo
via di mezzo o indifferente ciò che può accadere sia al buono che al cattivo, come il denaro, la bellezza, la nobiltà. Ora, la saggezza può capitare solo all’uomo buono, quindi non è indifferente. Ma non è neppure un male, perché non può accadere al malvagio, quindi è un bene ed è bene ciò che possiede solo l’uomo buono. Allora, l’essere saggi è un possesso del buono, quindi è un bene. «Ma», dicono, «è una circostanza accidentale della saggezza». Dunque ciò che tu chiami essere saggi crea la saggezza o la subisce? Che la crei o che la subisca, in entrambi i casi è corpo, poiché sia ciò che crea, sia ciò che è creato è corpo, e se è corpo è un bene, visto che una sola cosa gl’impediva di essere un bene, cioè l’incorporeità. Per i peripatetici non c’è differenza fra la saggezza e l’essere saggi, poiché in ciascuna delle due cose c’è anche l’altra. Non pensi, infatti, che sia saggio solo chi ha la saggezza? E che abbia la saggezza solo chi è saggio? Gli antichi dialettici operano una distinzione che da loro è arrivata sino agli stoici. Ti dirò in cosa consista: una cosa è un campo, un’altra cosa è possedere un campo. O no? Possedere un campo riguarda il possessore, non il campo. Analogamente una cosa è la saggezza, altra è l’essere saggi. Riconoscerai che la cosa posseduta e il possessore sono due cose distinte: la saggezza è posseduta mentre il saggio possiede. La saggezza è lo spirito perfetto o arrivato al sommo di ogni bene, è l’arte della vita. Ora, l’essere saggi non si può definirlo “spirito perfetto”, si può dire che sia ciò che tocca a chi possiede uno spirito perfetto. Allo stesso modo una cosa è uno spirito onesto, un’altra avere uno spirito onesto. Si obietterà: «C’è nella natura dei corpi una varietà, come dire questo è un uomo, quest’altro è un cavallo. Anche gl’impulsi dell’anima si uniformano alla natura dei corpi poiché sono una loro enunciazione. Ebbene, gl’impulsi hanno qualcosa di proprio che è diverso dal corpo. Per esempio: vedo passeggiare Catone: questo è ciò che mi mostrano i sensi, e l’animo vi crede. Ciò che vedo è il corpo, è a lui che sono rivolti sia il mio occhio che il mio spirito. Poi invece dico: Catone passeggia. Ora», prosegue il ragionamento, «non parlo del corpo, ma indico qualcosa che è enunciativo del corpo, o, come variamente lo chiamano, un “enunciato”, una “proposizione”, una “sentenza”. Così quando diciamo “saggezza” ci riferiamo a qualcosa di corporeo, quando diciamo “è saggio” parliamo del corpo. Ma c’è una grande differenza se una cosa si indica o se ne parla». Ammettiamo per il momento che siano due cose distinte (ancora non dico il mio pensiero): che cosa impedisce che siano diverse ma nondimeno un bene? Poc’anzi ho detto che una cosa è un campo, un’altra possedere un campo. Perché no? Il possessore ha una natura, la cosa posseduta ne ha un’altra: questa è terra, quello è uomo. Ma nel nostro caso entrambe le cose hanno la stessa natura, sia la saggezza, sia chi la possiede. Inoltre nel primo esempio una cosa è ciò che si possiede, un’altra il possessore, mentre in questo esempio la cosa posseduta e il possessore si identificano. Il campo si possiede per legge, la saggezza per natura, il campo può essere ceduto e trasmesso ad altri, la saggezza non si
distacca da chi la possiede. Dunque non si possono paragonare cose che tra loro sono diverse. Avevo cominciato col dire che queste possono essere due cose distinte e tuttavia costituire entrambe un bene, così come la saggezza e l’essere saggio sono due cose distinte ma riconosciamo che entrambe sono dei beni. D’altra parte nulla impedisce che sia la saggezza sia colui che la possiede siano beni, così come nulla impedisce che siano beni tanto la saggezza quanto il possederla, cioè l’essere saggi. Io voglio essere saggio per avere la saggezza. E che, dunque? Questo non è forse un bene senza il quale neppure l’altro è un bene? Voi dite che la saggezza non si conquisterebbe se non si potesse farne uso. Ma qual è l’uso della saggezza? L’essere saggi: questa è la sua più preziosa prerogativa, se noi la eliminiamo, la saggezza diventa inutile. Se la tortura è un male, lo è anche l’essere torturati, ma entrambe le cose non sarebbero mali se se ne potessero eliminare le conseguenze. La saggezza è lo stato dello spirito perfetto, l’essere saggi è l’uso che lo spirito perfetto fa della saggezza: e come può non essere un bene l’uso della saggezza che se non è usata non è un bene? Ti domando se si debba aspirare alla saggezza, e tu mi rispondi di sì. Poi ti chiedo se bisogna aspirare all’uso della saggezza, e tu mi rispondi ancora di sì, aggiungendo che se non potessi usarla non la vorresti. Ora, ciò a cui bisogna aspirare è un bene, essere saggi è l’uso della saggezza, così come parlare è l’uso del linguaggio e come vedere è l’uso degli occhi. Quindi essere saggi è l’uso della saggezza ed è a questo che bisogna aspirare: bisogna dunque aspirare a essere saggi e se bisogna aspirarvi è un bene. Ormai da tempo mi condanno da me stesso, imitando chi accuso e spendendo parole per una questione di per sé evidente. Chi infatti può mettere in dubbio che se il caldo è un male lo è anche aver caldo? E se il freddo è un male lo è anche aver freddo? E se la vita è un bene, anche vivere è un bene? Tutto ciò riguarda la saggezza ma non la sostanza della saggezza ed è su di essa che dobbiamo soffermarci. La saggezza, se vogliamo allargarci un po’, ci offre orizzonti ampi e spaziosi: possiamo indagare sulla natura degli dèi, sulla vita degli astri, sulle varie orbite dei corpi celesti, se le vicende umane dipendono dal loro influsso, se il corpo e l’anima di tutti gli esseri umani traggano il loro impulso da lì, se anche i fatti casuali obbediscano a leggi precise e se non ci sia nulla in questo mondo che accada inaspettatamente o senza seguire un ordine. Questi argomenti non rientrano nella questione morale ma sollevano lo spirito e lo innalzano al livello degli argomenti trattati, mentre i problemi di cui parlavo prima lo abbassano e lo avviliscono, non lo rendono più acuto, come dite voi, ma più debole. Suvvia, dobbiamo proprio interessarci di questioni se non false certamente inutili, quando invece dovremmo rivolgere la nostra attenzione a problemi più importanti e profondi? A cosa mi serve sapere se la saggezza e l’essere saggi sono due cose diverse? A che mi serve sapere se quella è un bene e l’altro no? Voglio essere temerario e correre il rischio di questo augurio: tocchi a te la saggezza, a me l’essere saggio. Saremo pari. Cerca piuttosto di
indicarmi la via che mi porti a questa meta, dimmi cosa devo evitare, a cosa devo aspirare, con che cosa posso rafforzare il mio spirito che vacilla, come allontanare da me i mali che mi colpiscono all’improvviso e mi perseguitano, come fronteggiare tante sventure, come respingere queste disgrazie che mi hanno colpito e come quelle che io stesso mi sono procurato. Insegnami come sopportare le tribolazioni senza alcun lamento e la felicità senza provocare i lamenti altrui, come non aspettare l’ultima e inevitabile ora ma rinunciare io stesso alla vita quando mi parrà opportuno. Niente a me sembra più vergognoso che desiderare la morte. Se vuoi vivere, perché desideri morire? Se non vuoi, perché chiedi agli dèi una cosa che ti hanno dato al momento della nascita? È stabilito che un giorno o l’altro tu muoia, anche se non vuoi, e d’altra parte tu hai la facoltà di morire quando vuoi: nel primo caso è una necessità, nel secondo una possibilità. In questi giorni ho letto l’inizio di un discorso, veramente vergognoso, di uno scrittore che è pure oratore: «Possa io morire al più presto!». Che sciocco, tu desideri una cosa tua, che dipende da te. «Possa io morire al più presto». Evidentemente a furia di dire queste parole sei diventato vecchio, altrimenti perché indugi? Nessuno ti trattiene: fuggi via per la strada che credi, scegli un qualunque elemento che ti offre la natura e fatti indicare una via di uscita. Gli elementi su cui si regge il mondo sono l’acqua, la terra e l’aria, e sono tutti il fondamento della vita e al tempo stesso anche mezzi di morte. «Possa io morire al più presto»: che significa “al più presto” per te? A quale giorno ti riferisci? Può venire prima di quanto tu desideri. Queste sono le parole di uno spirito debole che con una tale imprecazione vuole suscitare pietà. Chi si augura di morire non vuole morire. Chiedi agli dèi vita e salute: se hai deciso di morire, pensa che il primo vantaggio della morte è non avere più desideri. Questi, Lucilio mio, sono i problemi di cui dobbiamo occuparci e con cui educare il nostro spirito. Questa è la saggezza, questo l’essere saggi, non un esercizio intellettuale sterilissimo e sottile su vane discussioncelle. La sorte ti ha messo di fronte a tanti problemi, tu non li hai ancora risolti e stai lì a cavillare? E da sciocchi menare colpi a vuoto dopo aver ricevuto il segnale di combattimento. Butta via queste armi-giocattolo, servono armi vere. Dimmi come posso evitare che la tristezza e la paura turbino l’anima mia, come posso liberarmi dal peso delle mie segrete passioni. Bisogna fare qualcosa. «La saggezza è un bene, l’essere saggi non è un bene»: così si finisce per affermare che non siamo saggi e che tutto questo studio viene deriso perché è dedicato ad attività inutili. Cosa diresti, poi, se pensassi che si tratta anche di sapere se è un bene la saggezza futura? E che, si può forse dubitare che i granai sono inconsapevoli del grano che conteranno in futuro e che il fanciullo, al di là delle sue forze e della sua robustezza, non comprenda quale sarà la sua adolescenza? Al malato, finché è tale, non giova la salute futura, così come un riposo che verrà dopo molti mesi non può al presente ridare forza al corridore o al lottatore. Lo sanno tutti che ciò che deve ancora venire non è un bene proprio perché non è ancora venuto. Un
bene, infatti, giova e può giovare solo se è presente, se non giova non è un bene, se giova lo è già. Diventerò saggio: questo sarà un bene quando lo sarò diventato, ma per il momento non è un bene. Prima, insomma, bisogna che una cosa esista, poi che abbia una qualità. Ora, come può essere un bene ciò che ancora non esiste? E come vuoi che ti provi che una cosa non esiste se non dicendoti “sarà”? È evidente che ciò che verrà non è ancora venuto. Verrà la primavera: so che ora è inverno. Verrà l’estate: so che ora non è estate. La prova più evidente che una cosa non esiste ancora è che esisterà. Sarò saggio: lo spero, ma intanto non lo sono; se possedessi quel bene non avrei questo male. Sarò saggio: da ciò si può dedurre che non lo sono ancora. Non è possibile che io abbia contemporaneamente un bene e un male, in quanto il bene e il male non coesistono e non possono trovarsi insieme nella medesima persona. Mettiamo dunque da parte queste inutili quisquilie e volgiamo la nostra attenzione a quegli argomenti che possono esserci in qualche modo utili. Chi corre a chiamare l’ostetrica per la figlia che sta per partorire se è pieno d’ansia per lei non si ferma a leggere l’avviso e il bando dei giochi; chi corre verso la sua casa in fiamme non studia sulla scacchiera la mossa per liberare una pedina imprigionata. Ma dico: da tutte le parti ti vengono annunciate queste disgrazie, la casa brucia, i figli sono in pericolo, la patria è assediata, i tuoi beni sono saccheggiati, e i naufragi, i terremoti e tanti altri possibili motivi di ansia, e tu, turbato da tanti pensieri, hai il tempo di dedicarti a svaghi del genere? Cerchi la differenza fra la saggezza e l’essere saggi ? Intrecci e sciogli nodi quando ti sta sul capo un simile macigno? La natura non è stata con noi così generosa da concederci una tale abbondanza di tempo per cui ce ne resti un poco da perdere. Vedi quanto ne sciupino anche le persone più diligenti: un po’ ce lo tolgono le nostre malattie, un po’ quelle dei nostri familiari, una parte gli affari privati, una parte quelli pubblici, il sonno, poi, ci sottrae metà della vita. A che serve dunque spendere in tali sciocchezze la maggior parte di questo tempo così esiguo e veloce che trascina via anche noi? Inoltre l’animo ha l’abitudine di svagarsi, invece di curarsi e di fare della filosofia un divertimento, quando invece è un rimedio. Io non so che differenza ci sia fra la saggezza e l’essere saggi: so che a me non importa saperlo o non saperlo. Dimmi un po’: quando avrò imparato che differenza c’è fra la saggezza e l’essere saggi sarò saggio? E perché m’intrattieni sulle parole della saggezza più che sulle sue opere? Rendimi più forte, più tranquillo, pari, anzi, superiore alla sorte. E potrò esserle superiore se indirizzerò ogni mia conoscenza a questo fine. Stammi bene.
1. Il Genio era la divinità tutelare per l’uomo, Giunone per la donna. 2. Lucrezio, De rerum natura II 55-56. 3. L’Idra, mitico mostro dalle innumerevoli teste rinascenti, viveva nelle paludi di Lerna; fu ucciso da
Ercole. 4. La Chimera aveva la testa di leone, il corpo di capra e la coda di serpente. Fu uccisa da Bellerofonte. 5. Virgilio, Eneide I 1. 6. Gli Ircani abitavano sulle rive del Mar Caspio. 7. I personaggi sono: C. Sempronio Gracco, tribuno della plebe; Lucio Licinio Crasso, oratore; G. Scribonio Curione, politico e collaboratore di Cicerone e di Cesare. 8. Appio Claudio Cieco, censore e console, fece costruire il primo acquedotto e l’omonima via; Tiberio Coruncanio, giurista e letterato, fu il primo pontefice massimo di famiglia plebea. 9. Personaggio noto per la semplicità e l’austerità della sua vita. 10. Virgilio, Georgiche IV 212-13. 11. Virgilio, Eneide I 327-328 e 330: Enea alla madre Venere. 12. Aristone di Chio. 13. Ovidio, Metamorfosi II 1-2 14. Ovidio, Metamorfosi 107-108. 15. Frammenti adespoti di tragici greci. 16. Versi o del Bellerofonte o della Danae di Euripide. 17. Eroe mitico che combatté contro la Chimera e le Amazzoni; morì tentando la scalata all’Olimpo con Pegaso, il suo cavallo alato.
Libro ventesimo 118. Vuoi che io ti scriva più spesso. Tiriamo le somme: tu sei in debito. Si era infatti convenuto che tu scrivessi per primo e che io rispondessi. Ma non farò il difficile: so che si può farti credito. Pagherò in anticipo e non farò ciò che l’eloquentissimo Cicerone esortava Attico a fare: «Se non hai nulla da dire, butta giù tutto quello che ti viene in mente». A me non manca mai da scrivere – anche a voler togliere tutto ciò che riempie le lettere di Cicerone: quale candidato si dia da fare, chi combatta con forze altrui, chi con le proprie, chi aspiri al consolato con l’appoggio di Cesare, chi con quello di Pompeo, chi col proprio patrimonio, che usuraio spietato sia Cecilio, da cui i parenti non possono cavare un soldo a un interesse inferiore al dodici per cento,1 e così via. È meglio occuparsi dei propri mali invece che di quelli altrui, analizzarsi a fondo e vedere a quante cose ci candidiamo noi senza impegnarci. Non chiedere nulla e mettere da parte tutti i bei discorsi della fortuna: questa, Lucilio mio, è la scelta migliore, che ci rende liberi e sereni. Quando, indette le elezioni, i candidati se ne stanno incerti nei loro spazi, e chi promette denaro, chi si dà da fare attraverso i suoi mediatori, chi consuma di baci le mani a persone da cui, una volta eletto, non vorrà neppure essere sfiorato, e tutti aspettano ansiosi la voce del banditore, non credi che sia piacevole starsene in ozio a guardare quel mercato senza comprare o vendere niente? Quanto è più felice chi guarda con noncuranza non solo i comizi per l’elezione dei pretori o dei consoli, ma anche a quelli più grandi in cui si cercano cariche annuali o poteri perpetui, imprese vittoriose e trionfi, oppure ricchezze o matrimoni e figli, o salute per sé e per i propri familiari! Che grandezza d’animo quella di chi, solo, non chiede nulla, non supplica nessuno e dice: «Non ho niente a che spartire con te, o sorte; non mi faccio tuo schiavo. So che tu respingi i Catoni e porti al successo i Vatinii. 2 Io non chiedo nulla». Questo vuol dire infischiarsene della fortuna. Scriviamoci pure, dunque, su questi argomenti, tratteremo una materia sempre nuova, vedendo intorno a noi migliaia di uomini indaffarati che, per conseguire una meta rovinosa, vanno ricercando il male attraverso il male e aspirano a beni che sono da fuggire o tali da procurare disgusto. Una cosa quando la si desidera sembra straordinaria, ma dopo che la si è ottenuta non soddisfa più. La prosperità non è avida, come comunemente si crede, è cosa di poco conto, perciò non sazia nessuno. Tu pensi che tali mete siano eccelse perché sono lontane, ma chi le ha raggiunte le giudica poco elevate e cerca di salire ancora, ne sono certo: quella che tu ritieni la vetta per loro è solo un gradino. Ignorare la verità è un male comune. Gli uomini, ingannati dall’opinione generale, si fanno attirare da falsi beni, poi, quando li hanno conquistati dopo molte traversie, si accorgono che sono mali o comunque inutili o inferiori alle loro aspettative, perché guardano le cose da lontano e perciò sbagliano: tengono in gran conto quelli che la massa considera dei beni. Vediamo dunque cos’è il bene affinché non capiti anche a noi la stessa cosa.
Del bene sono state date diverse interpretazioni, chi l’ha definito in un modo, chi in un altro. Per alcuni «il bene è ciò che attrae l’anima e la chiama a sé». Ma c’è subito da obiettare: e se la attrae verso la rovina? Sai bene quanti mali siano lusinghieri. Il vero e il verosimile non sono la stessa cosa. Il bene è strettamente congiunto al vero; non è un bene se non è vero. Ciò che attrae e alletta, invece, è verosimile: si insinua, stimola, trascina a sé. Per altri «il bene è ciò che spinge al desiderio di sé, o, meglio, suscita lo slancio dell’anima, che a esso tende». Anche qui si può avanzare la medesima obiezione: ci sono infatti molte cose che suscitano uno slancio dell’anima ma arrecano gravi mali a chi le ricerca. Migliore è la definizione di altri: «Il bene è ciò che suscita verso di sé uno slancio dell’anima secondo natura e che va ricercato solo quando lo merita». In questo caso si identifica con l’onestà, poiché l’onestà va senz’altro ricercata. A questo punto bisogna che io spieghi la differenza tra il bene e l’onesto. I due hanno tra loro qualcosa di comune e di inseparabile: non c’è bene che non abbia in sé un che di onesto e l’onesto coincide senz’altro col bene. In che differiscono, dunque? L’onesto è il bene nella sua perfezione, rende la vita compiutamente felice e ogni cosa che tocca diventa un bene. Voglio dire: certe cose propriamente non sono né beni, né mali, come la carriera militare, politica o giuridica. Quando queste attività vengono svolte onestamente cominciano a essere beni, cioè diventano tali passando da uno stato indeterminato a uno ben definito. Ora, il bene è un bene se unito all’onesto, l’onesto, invece, è un bene di per sé: il bene, dunque, scaturisce dall’onesto, l’onesto da sé stesso. Ergo: quello che è un bene avrebbe potuto essere un male, mentre ciò che è onesto non avrebbe potuto essere altro che bene. Altri, poi, dicono che «per bene s’intende ciò che è secondo natura». Ora fa’ attenzione: ciò che è bene è secondo natura, ma ciò che è secondo natura non è necessariamente un bene. Molte cose sono conformi a natura, ma valgono così poco che non si può definirle beni: sono insignificanti, disprezzabili, mentre non c’è bene che possa essere disprezzabile anche se di poco conto. Una cosa, infatti, finché è di scarso valore non è un bene, e quando comincia a essere un bene non è più di scarso valore. Da che cosa si riconosce il bene? Dalla sua perfetta conformità alla natura. Dirai: «Tu sostieni che il bene è secondo natura: questa è la sua caratteristica. Ma dici anche che non tutto ciò che è secondo natura può considerarsi necessariamente un bene. Com’è possibile, dunque, che uno sia un bene e l’altro no? Questo come arriva ad avere una caratteristica diversa quando entrambi hanno in comune la prerogativa di essere secondo natura?». Per la grandezza di questa prerogativa, ovviamente. Non è strano, infatti, che certi esseri crescendo cambino. Era un bimbo, è diventato un adulto: il suo carattere distintivo è cambiato in quanto prima era un essere irrazionale, ora è razionale. Certi esseri con la crescita non solo diventano più grandi, ma mutano condizione. «Si potrebbe ribattere che se una cosa diventa più grande non per questo cambia. Non importa se di vino riempi un fiasco o una botte: in entrambi c’è la caratteristica propria del vino. Allo stesso modo una piccola o una grande
quantità di miele non hanno un sapore diverso». Sono esempi non pertinenti: in questi casi, infatti, la qualità è la stessa e rimane tale anche se la quantità aumenta. Certe cose accrescendosi mantengono la propria specie e la propria caratteristica, altre dopo molte aggiunte cambiano con l’ultima che imprime loro una qualità nuova, diversa dalla precedente. La pietra che forma la volta è una sola: quella che s’incunea tra i due fianchi inclinati e li congiunge. Perché l’ultima aggiunta, anche se piccola, è determinante? Perché in questo caso non accresce, ma completa. Ci sono poi cose che sviluppandosi perdono la forma precedente e ne acquistano una nuova. Quando con la mente ingigantiamo un oggetto e a un certo punto non riusciamo più a seguirne la grandezza quello prende il nome di infinito: è diventato molto diverso da come era quando sembrava grande, ma finito. Analogamente pensiamo a una massa difficile a dividersi: ebbene, crescendo la difficoltà, alla fine intuiamo l’indivisibile. Così da un corpo che si muove a fatica arriviamo al concetto di immobilità. Per lo stesso motivo una cosa che è secondo natura, ingrandendosi, assume altre caratteristiche e diventa un bene. Stammi bene. 119. Ogni volta che scopro qualcosa di nuovo non aspetto che tu mi chieda di comunicartelo, ma sono io il primo a pensarlo. Vuoi sapere che cosa ho trovato? Apri la borsa, vedrai che bel guadagno! T’insegnerò come puoi diventare ricco in un batter d’occhio. Ardi dalla voglia di saperlo, eh? E non hai torto, visto che ti condurrò alla più grande ricchezza attraverso una scorciatoia. Avrai però bisogno di qualcuno che ti faccia credito, poiché non si commercia senza fare debiti; ma non voglio che tu li contragga per mezzo di un intermediario, non voglio che i mediatori mettano in giro il tuo nome. Ti indicherò uno pronto a farti credito: è Catone che lo suggerisce. Contrai un prestito con te stesso. Per quanto sia piccolo basterà, se quello che manca lo chiederemo solo a noi stessi. Non fa differenza, Lucilio mio, fra avere e non desiderare; il risultato è il medesimo: non tormentarti. Ora io non voglio togliere nulla alla natura – è ostinata, invincibile, chiede quello che le spetta – sappi, però, che quanto va al di là della natura è effimero e non indispensabile. Ho fame: devo mangiare. Ma che il pane sia comune o raffinato non riguarda la natura, che non vuole far godere lo stomaco, vuole riempirlo. Ho sete: se l’acqua l’ho attinta dalla vicina cisterna o l’ho messa sotto la neve per rinfrescarla, anche questo non riguarda la natura, la quale chiede solo di estinguere la sete. E non importa neppure se beviamo da una coppa d’oro o di cristallo, di murra, in un calice di Tivoli o nel cavo della mano. Di ogni cosa guarda il fine e tralascerai ciò che è superfluo. La fame si fa sentire: afferro la prima cosa che mi capita, tanto sarà proprio la fame a rendermi gradito qualunque cibo io prenda. Chi ha fame non rifiuta niente. Allora: vuoi sapere che cosa mi è piaciuto? Questa massima che mi sembra eccellente: «Il saggio è il più accanito ricercatore delle ricchezze naturali». «Tu mi offri un piatto vuoto», dici: «ma che cos’è? Avevo già preparato le casse e cercavo in quale mare mi sarei dato al commercio, quale appalto assumere, quali
merci importare. È un inganno, questo! Promettere la ricchezza e predicare la povertà». Perché, secondo te, l’uomo a cui non manca nulla è povero? «Merito suo e della sua pazienza, non della sorte». Dunque, per te non è ricco chi non può perdere la sua ricchezza? Preferisci avere molto o quanto basta? Chi possiede molto desidera di più, e questa è la prova che non possiede ancora abbastanza; chi possiede abbastanza ha raggiunto ciò che a un ricco non tocca mai, cioè la fine dei desideri. Oppure per te quelle non sono ricchezze perché per esse nessuno è mai stato esiliato, mai avvelenato dalla moglie o dal figlio? Perché sono sicure in guerra? E tranquille in tempo di pace? Perché possederle non è pericoloso e non è faticoso amministrarle? «Ma non possiede molto chi semplicemente non soffre il freddo, né ha fame o sete». Giove non possiede di più. Non è mai poco quello che basta e non è mai molto ciò che non basta. Dopo aver sconfitto Dario e gli Indiani, Alessandro è sempre povero. Non è così? Cerca nuove terre da conquistare, esplora mari sconosciuti, invia nell’oceano nuove flotte e vuole quasi infrangere le barriere che cingono il mondo. Ciò che basta alla natura non basta all’uomo. C’è chi desidera ancora qualcosa dopo aver avuto tutto, tanto cieca è la nostra mente e a tal punto ciascuno dimentica i suoi primi passi una volta raggiunto il successo. L’uomo che poco prima dominava, in mezzo a tanti contrasti, un oscuro, piccolo territorio, raggiunto l’estremo limite del mondo, si rammarica di dover ritornare attraversando la terra ch’è diventata sua. Il denaro non ha mai reso ricco nessuno, anzi ha suscitato in tutti una cupidigia maggiore. Vuoi saperne il motivo? Chi più possiede è in grado di possedere ancora di più. Fammi il nome di uno fra quanti sono considerati alla pari di Crasso e di Licino;3 che porti il registro dei suoi averi, li sommi e faccia il totale di quanto possiede e di quanto spera di possedere: ebbene, per me costui è povero, per te può esserlo. Chi invece si adegua alle esigenze della natura la povertà non solo non la sente, ma non la teme neppure. Sappi, tuttavia, che è molto difficile ridurre le proprie ricchezze nei limiti voluti dalla natura: proprio quella persona che abbiamo definito, che per te è povera, possiede anche qualcosa di superfluo. Eppure le ricchezze accecano e attirano la massa, se da una casa esce molto denaro liquido, se anche il tetto è ricoperto d’oro, se la servitù è prestante fisicamente e ben vestita. La felicità di codesta gente è tutta esteriore: chi invece si sottrae al condizionamento della massa e della fortuna è felice dentro. Questi individui, chiamati a torto ricchi e che in realtà sono poveri, pieni di impegni e occupazioni, hanno la ricchezza come noi diciamo di avere la febbre, quando in effetti è la febbre ad avere noi. Spesso diciamo anche al contrario: «Lo ha preso la febbre». Analogamente dovremmo dire: «Lo ha preso la ricchezza». Ciò che io vorrei soprattutto consigliarti – una raccomandazione che non si fa mai abbastanza – è di prendere sempre come misura i desideri naturali: soddisfarli ti costerà poco o nulla, bada solo a non confondere i vizi coi desideri. Perché vuoi sapere su quale tavola, con quale argenteria, da quali servitori tutti uguali e con la pelle liscia debba essere servito il cibo? La natura
richiede solo il cibo. Forse che, quando la sete ti brucia la gola, tu chiedi coppe dorate, e se hai fame arraffi il rombo e il pavone?4 La fame non chiede molto, si accontenta di non esserci più; del come non si cura troppo. È la sciagurata intemperanza a tormentarci: si sforza di aver fame anche dopo essersi saziata, e cerca non come riempire lo stomaco ma come rimpinzarlo, come far ritornare la sete placata con la prima coppa. Perciò Orazio dice bene che alla sete non importa in quale tazza o con quanta raffinatezza venga servita l’acqua. Se pensi che sia importante che ti serva uno schiavo dai capelli lunghi e che il bicchiere sia splendente vuol dire che non hai sete. Il vantaggio maggiore che tra gli altri ci ha dato la natura è di aver tolto al bisogno il disgusto. Solo il superfluo consente di scegliere: questo è poco conveniente, quest’altro poco sfarzoso, questo offende i miei occhi. Dio, quando ha creato l’universo e ci ha imposto le regole di vita, si è preoccupato della nostra sopravvivenza, non delle nostre raffinatezze: per vivere tutto è pronto e a portata di mano, per soddisfare i nostri piaceri, invece, ci vogliono affanni e sofferenze. Serviamoci, dunque, di questo grande beneficio della natura, pensando che il suo maggior merito verso di noi sta nell’averci consentito di prendere senza disgusto ciò di cui abbiamo necessità. Stammi bene. 120. La tua lettera affronta parecchie questioncelle, ma tu ti soffermi su una in particolare e vuoi che venga risolta: come l’uomo, cioè, sia pervenuto alla cognizione del bene e dell’onesto. Per altri filosofi sono due concetti diversi, per me soltanto distinti. Ti dirò perché. Alcuni ritengono che il bene coincida con l’utile, perciò dànno questo nome alla ricchezza, al cavallo, al vino, alle scarpe: guarda quanto sia scarso il valore che attribuiscono al bene e quanto lo mortifichino! Per loro è onesto ciò che si addice a un giusto concetto di dovere, come prendersi cura del vecchio padre, aiutare l’amico povero, comportarsi da valoroso in una spedizione militare, parlare con saggezza e moderazione. Per me sono due cose distinte, ma con un unico fondamento. È un bene solo ciò che è onesto, e l’onesto è senz’altro un bene. Ritengo superfluo aggiungere quale differenza ci sia tra loro, visto che l’ho ripetuto spesso. Dirò solo che noi non riteniamo un bene ciò di cui si può fare anche un cattivo uso, e tu vedi quanti fanno cattivo uso della ricchezza, della nobiltà, della forza. Ritorno ora all’argomento di cui vuoi che si parli, cioè come abbiamo acquistato la prima cognizione del bene e dell’onesto. Non ce l’ha insegnata la natura, che ci ha dato i semi della scienza, non la scienza. Alcuni ritengono che tale cognizione l’abbiamo acquisita per caso, ma non verosimile che la virtù ci sia arrivata per caso. Secondo me è nata dall’osservazione e dal confronto tra fatti ricorrenti: per gli stoici si è arrivati a comprendere il bene e l’onesto per analogia. Poiché i grammatici latini hanno conferito a questa parola il diritto di
cittadinanza, penso che non si debba scartarla ma che anzi vada ricondotta a quel suo diritto. Me ne servirò, dunque, non solo come di una parola acquisita ma ormai di uso comune. Ora ti spiegherò cos’è l’analogia. La salute del corpo, da noi conosciuta, ci ha fatto pensare che ve ne fosse anche una dell’anima. Conoscevamo le forze fisiche, ebbene, partendo da esse abbiamo concluso che ci fosse anche una forza spirituale. Così, stupiti da certe azioni generose, piene di umanità o di coraggio, abbiamo cominciato ad ammirarle come immagini di perfezione, e vedendo che a esse si accompagnavano spesso molti vizi, nascosti dalla bellezza e dallo splendore di una nobile azione, quelli abbiamo finto di non vederli. Per natura, infatti, siamo portati a ingigantire le lodevoli azioni, tutti esaltano un gesto glorioso al di là del vero: da qui, dunque, abbiamo derivato l’immagine di un bene smisurato. Fabrizio rifiutò l’oro di Pirro perché per lui disprezzare le ricchezze di un re valeva più di un regno. Egli stesso, quando il medico di Pirro promise che avrebbe avvelenato il re, avvertì Pirro di guardarsi dal tradimento. Fu parimenti segno di nobiltà d’animo non farsi vincere dall’oro e non voler vincere col veleno. Noi siamo rimasti ammirati dal gesto di quell’uomo straordinario, che non si lasciò piegare dalle promesse di un re, né da quelle fatte contro un re, esempio costante di virtù e, cosa difficilissima, di onestà pure in guerra: per Fabrizio certe azioni erano disoneste anche se compiute contro i nemici. Nella sua estrema povertà, di cui andava orgoglioso, egli ricusò sia la ricchezza che il veleno. «Vivi per merito mio», disse a Pirro, «e rallegrati per ciò di cui prima ti dolevi: Fabrizio è incorruttibile». Orazio Coclite, da solo, per impedire l’accesso ai nemici, sbarrò lo stretto passaggio del ponte e ordinò che gli fosse tagliata alle spalle la via del ritorno, e resistette al lungo assalto, finché sentì crollare le travi a pezzi. Guardò indietro e quando si accorse che la patria era salva a prezzo del suo pericolo personale, gridò: «Chi vuole seguirmi venga per questa via!», e si gettò a capofitto nel Tevere: preoccupandosi di salvare dai gorghi del fiume tanto le armi quanto la vita, mantenuto l’onore delle armi vittoriose, ritornò sicuro come se fosse venuto dal ponte. Sono queste e altre simili azioni che ci hanno dato l’immagine della virtù. Aggiungerò una verità che forse può sembrare sorprendente: a volte certe azioni disoneste si presentano sotto l’apparenza dell’onestà e il bene supremo emerge dal suo contrario. Ci sono, infatti, come sai, dei vizi che confinano con la virtù, e anche azioni infami somigliano apparentemente al bene, per cui il prodigo si spaccia per liberale, pur essendoci una grande differenza fra chi sa dare e chi non sa conservare. Ci sono molte persone, caro Lucilio, che non donano, ma gettano: non si può chiamare liberale uno che ha in odio il proprio denaro. L’indifferenza somiglia alla condiscendenza, la temerità al coraggio. Tale somiglianza c’induce a stare in guardia e a distinguere fatti apparentemente vicini ma fra loro molto diversi nella sostanza. Osservando uomini diventati famosi per qualche gloriosa impresa, abbiamo notato che alcuni avevano agito con magnanimità e slancio ma in una sola occasione, che uno era coraggioso in guerra, ma vile nel foro, che un altro sopportava con fermezza la povertà, ma era
debole se qualcuno lo disonorava: abbiamo insomma lodato l’impresa ma disprezzato l’uomo. Per contro abbiamo osservato che uno era benevolo verso gli amici, moderato verso i nemici, irreprensibile e virtuoso sia nella vita pubblica che in quella privata, paziente nel sopportare e prudente nell’agire. Lo abbiamo visto donare a piene mani quando occorreva essere liberali, tenace, deciso e in grado di resistere alla stanchezza fisica con le risorse dello spirito. Inoltre era sempre uguale a sé stesso in ogni sua azione, istintivamente onesto ed esercitato nella virtù al punto non solo di agire correttamente, ma di non poter agire se non correttamente. Ne abbiamo dedotto che in lui la virtù era perfetta. Abbiamo quindi suddiviso in sezioni la virtù, vedendo che bisognava frenare le passioni, reprimere le paure, decidere con saggezza il da farsi, dare a ciascuno il suo: abbiamo così capito cosa siano la temperanza, la fortezza, la saggezza, la giustizia, e attribuito a ciascuna i suoi compiti. Da che cosa dunque ci è derivato il concetto di virtù? Ce l’hanno indicato l’ordine, la bellezza e la fermezza che le sono proprie, l’armonia di tutte le sue azioni e la sua grandezza che si eleva al di sopra di tutto. Da qui è nata l’idea della vita felice che scorre propizia, interamente padrona di sé. E come siamo arrivati a questa idea? Così: l’uomo perfetto che ha raggiunto la virtù non si è mai scagliato contro la sorte, non si è lasciato affliggere dalle disgrazie, le ha subìte come fatiche impostegli, sentendosi soldato e cittadino dell’universo. Tutte le avversità che gli sono toccate non le ha respinte come un male assegnatogli dalla sorte, ma le ha accolte come un impegno, dicendo a sé stesso: «Comunque stiano le cose, la faccenda è mia: è dura, difficile, devo impegnarmi a fondo». Non poteva quindi non apparire grande ai nostri occhi chi non ha mai pianto sui suoi mali e non si è lamentato mai del suo destino, chi si è fatto conoscere da molti, ha brillato come una fiaccola nelle tenebre e si è attirato la benevolenza generale col suo carattere mite e moderato, ugualmente giusto con gli uomini e con gli dèi. Aveva un animo perfetto e giunto al massimo livello, al di là del quale non c’è che lo spirito divino, di cui una parte è discesa anche nell’anima dei mortali; ed è proprio quando medita sulla morte e capisce che l’uomo è nato per morire che l’anima rivela la sua divinità: questo corpo non è la sua casa, è solo un albergo per un breve soggiorno, e bisogna lasciarlo quando ci si accorge di essere sgraditi all’ospite. Per me, Lucilio, la prova più evidente che l’anima proviene da una sede più elevata sta nel fatto che considera ignobile e misera la condizione in cui si trova e che non teme di uscire da questa vita: chi ricorda la propria origine, infatti, sa dove andrà a finire. Non vediamo forse quanti disagi ci affliggono, come ci pesi questo corpo? Ora ci lamentiamo di un dolore alla testa, ora di un mal di pancia, di petto o di gola, a volte sono i nervi a farci soffrire, a volte i piedi, la diarrea, il catarro, un flusso di sangue eccessivo o insufficiente: siamo sballottati e gettati di qua e di là come chi non abita in casa propria. E tuttavia, benché ci sia toccato in sorte un corpo tanto guasto, facciamo progetti per un futuro lontano e spingiamo le nostre speranze fino al limite estremo della vita, e non c’è denaro, né potere che ci accontenti. Ci comportiamo proprio da stupidi e
da sfrontati. Non c’è limite ai nostri desideri: eppure siamo destinati a morire, anzi, stiamo morendo, ogni giorno ci avviciniamo all’ultimo, ogni ora ci spinge a quell’istante da cui precipiteremo nella morte. Guarda la nostra cecità mentale! Il futuro è già nel presente, anzi, in gran parte è già accaduto: il tempo che abbiamo vissuto è là dov’era prima che lo vivessimo. Sbagliamo a temere l’ultimo giorno: ogni giorno concorre in ugual misura alla morte. La nostra fine non la segna il gradino su cui cadiamo, quello la rende solo evidente: alla morte ci porta l’ultimo giorno, ma tutti i giorni ci avvicinano a lei; giorno per giorno la morte ci consuma, non ci trascina via all’improvviso. Per questo un’anima grande, consapevole della sua natura superiore, cerca di comportarsi con onestà e con impegno in questa dimora in cui è stata posta, e non considera suo niente di quanto la circonda, ma, simile a un viaggiatore frettoloso, ne fa uso come se lo avesse in prestito. Quando vediamo qualcuno così costante ci balza subito agli occhi l’immagine di un’indole fuori del comune; soprattutto se la sua costanza ha dimostrato che questa, come ho detto, è la vera grandezza. Il vero, infatti, è costante, il falso discontinuo. Certi sono a volte Vatinii, a volte Catoni, e ora giudicano poco austero Curio,5 poco povero Fabrizio, poco frugale e parco Tuberone, ora invece gareggiano con Licino nella ricchezza, con Apicio nei banchetti, con Mecenate nei piaceri. Che un’anima sia corrotta lo prova inequivocabilmente la sua instabilità, l’ondeggiare continuo tra la simulazione della virtù e l’amore dei vizi. Aveva duecento servi, ora ne ha dieci; parlava di grandi cose, di re e di tetrarchi: «Mi basta un tavolo a tre piedi e una conchiglia», diceva, «piena di sale schietto, e per sfuggire al freddo una toga anche rozza». Però, anche se davi a quest’uomo, parco e contento di poco, mille sesterzi o di più, nel giro di cinque giorni senza un soldo restava.6 Ci sono molti uomini tali e quali a questo descritto da Orazio Flacco, mai uguale e neppure simile a sé stesso, tanto è incoerente. Ho detto molti? In realtà sono così quasi tutti. Ciascuno cambia ogni giorno opinioni e desideri: ora vuole una moglie, ora un’amante, ora si atteggia a re, ora non c’è schiavo più servizievole di lui, ora è tronfio e detestabile, ora si abbassa al di sotto degli umili, ora spreca il denaro, ora lo rapina. È così che massimamente si rivela un animo sconsiderato: passa da un atteggiamento all’altro, e, ciò che per me è più vergognoso, non è mai coerente con sé stesso. Credimi, è importante che un uomo sia sempre lo stesso. Ma nessuno, eccetto il saggio, è così, siamo tutti volubili. Ora sembriamo frugali e seri, ora prodighi e frivoli, cambiamo spesso maschera e ne indossiamo un’opposta a quella che ci siamo appena tolti. Imponiti, dunque,
di mantenerti fino alla morte quale hai deciso di essere, fa’ in modo di meritare lodi, o almeno di essere riconosciuto per quello che eri, poiché di qualcuno che hai visto ieri potresti giustamente chiederti, tanto è cambiato: «Chi è costui?». Stammi bene. 121. So che avrai da ridire quando ti avrò esposto una questioncella su cui oggi mi sono soffermato a lungo, e griderai ripetutamente: «Che c’entra questo con la morale?». Protesta pure, ma io prima ti opporrò altri avversari, Posidonio e Archidemo,7 i quali saranno lieti di essere chiamati in causa, e poi ti dirò: non tutto ciò che ha a che vedere con la morale rende buoni i costumi. Ci sono questioni che riguardano il cibo, il lavoro, il vestire, l’insegnamento, lo svago, anche se non tutte rendono migliore l’uomo. Altre riguardano la moralità, ciascuna in modo diverso: certe la correggono e la regolano, certe ne studiano la natura e l’origine. Secondo te se indago perché la natura abbia generato l’uomo, avvantaggiandolo rispetto agli altri animali, trascuro il problema morale? Certamente no. Come si può conoscere la condotta da seguire se non si trova cosa sia il meglio per l’uomo e non se studia la natura? Ciò che dobbiamo fare o evitare lo vedremo dopo che avremo appreso quali siano i nostri naturali doveri. Dirai: «Io voglio imparare ad avere meno desideri, meno timori. Liberami dalla superstizione, insegnami che quella che noi chiamiamo felicità è cosa vana e fugace e diventa facilmente il contrario se solo le si premette una sillaba». Soddisferò il tuo desiderio: stimolerò le virtù e fustigherò i vizi. Mi giudichino pure esagerato su questo argomento, ma io continuerò a deplorare la depravazione, a reprimere le passioni violente, a frenare i piaceri, che sono spesso causa di sofferenze, a proclamare la mia condanna contro i desideri dell’uomo. E perché no, quando proprio dal compiacimento dei mali peggiori che abbiamo desiderato è nata questa discussione? Intanto consentimi di trattare alcune questioni che non sono poi tanto lontane dal nostro argomento. Il problema era se tutti gli animali siano consapevoli della propria natura, visto che i loro movimenti sono appropriati e spediti come se tenessero deliberatamente le membra sotto esercizio, mostrando tutti una grande agilità fisica. Come l’artigiano maneggia con facilità i suoi attrezzi, il pilota manovra abilmente il timone della nave, il pittore distingue subito i vari e numerosi colori che si è messo davanti per fare un ritratto e passa facilmente con lo sguardo e con le mani dalla cera al quadro, così, con la stessa rapidità, gli animali usano i loro arti. Noi ammiriamo i mimi perché sono abili nell’interpretare con le mani tutte le situazioni e i sentimenti, e i loro gesti sono veloci come le parole: ebbene, ciò che nei mimi è un fatto artistico negli animali è frutto di qualità naturali, loro non sono minimamente impacciati nell’usare le proprie capacità, non faticano a muovere le membra, lo fanno subito, appena nati, vengono al mondo con queste cognizioni, nascono già ammaestrati. Si obietterà: «Gli animali muovono le loro membra nel modo giusto perché altrimenti sentirebbero dolore. Praticamente, come dite voi, sono costretti a fare così ed è
la paura, non la volontà, a determinare i loro corretti movimenti». Le cose non stanno così: i movimenti fatti per necessità sono cauti, quelli spontanei sono agili, non è dunque la paura di soffrire che costringe gli animali: essi tendono ai movimenti naturali, anche se sono impediti dal dolore. Analogamente il bimbo che cerca di stare dritto e si abitua a reggersi in piedi, come comincia a provare le sue forze cade e ogni volta si rialza piangendo finché, a furia di sforzarsi e di soffrire, riesce a compiere i movimenti naturali. Certi animali dal dorso rigido, se si rovesciano si contorcono a lungo, stendono le zampe e si piegano su un fianco finché non si rimettono a posto. La tartaruga non soffre se è supina, ma si agita e cerca di riprendere la sua posizione naturale, e non cessa di tentare e di agitarsi finché non si rimette dritta. Tutti gli animali, dunque, hanno coscienza della loro natura ed è per questo che muovono così speditamente le membra: la prova più evidente che nascono con questa cognizione sta nel fatto che tutti sanno come usare le proprie capacità. «Voi dite», si ribatte, «che nell’atteggiamento assunto dall’anima nei confronti del corpo l’elemento fondamentale è la sua costituzione. Come può dunque un neonato capire un concetto così complesso e sottile, che voi stessi faticate a spiegare? Tutti gli animali dovrebbero nascere maestri di dialettica per comprendere questa definizione che risulta oscura a gran parte delle persone istruite». L’obiezione non è pertinente: io non ho detto che gli animali comprendono la definizione di costituzione, ho parlato della costituzione in sé stessa. La natura è più facile capirla che spiegarla. Perciò il neonato non conosce l’essenza della sua costituzione, conosce la sua costituzione; e non sa che cosa sia un animale, ma sente di essere un animale. Peraltro la sua costituzione può comprenderla solo in maniera grossolana, per sommi capi e confusamente. Anche noi sappiamo di avere un’anima, ma non ne conosciamo l’essenza, la dimora, la natura e l’origine. Come noi abbiamo coscienza della nostra anima, pur ignorandone la natura e la sede, così tutti gli animali hanno coscienza della loro costituzione. Devono necessariamente avere coscienza di quell’elemento attraverso il quale percepiscono tutte le cose; devono essere consapevoli di ciò a cui obbediscono e che li governa. Noi intuiamo che esiste un quid che determina i nostri impulsi, ma ignoriamo che cosa sia. Sappiamo di avere un istinto, ma non quale sia e da dove nasca. Così anche i neonati e gli animali non hanno una coscienza sufficientemente limpida e chiara della loro essenza. «Voi», ribattono, «sostenete che ogni animale si adatta subito alla sua costituzione, la costituzione dell’uomo è razionale, quindi l’uomo si adatta a sé stesso non quale animale, ma quale essere razionale: l’uomo, infatti, è caro a sé per quell’elemento che lo fa uomo. Come può dunque il neonato adattarsi alla sua costituzione di essere razionale se non è ancora in grado di ragionare?». Ogni età ha una sua costituzione, perciò quella del neonato, del bambino, del giovane e del vecchio sono diverse: tutti si adattano alla costituzione in cui si trovano. Il neonato è senza denti: si adatta a questa sua costituzione. Gli spuntano i denti: si adatta a questa nuova costituzione. Anche l’erba che si trasformerà in messe e
grano quando è tenera e spunta appena dal solco ha una sua costituzione, poi ne assume un’altra quando è cresciuta e si erge sullo stelo ancora cedevole ma capace di sopportare il suo peso, e un’altra costituzione ancora quando, oramai bionda e con la spiga dura, aspetta di essere portata sull’aia. Insomma, qualunque costituzione assuma, la mantiene e vi si adatta. L’infanzia, la fanciullezza, la giovinezza e la vecchiaia sono età diverse, e tuttavia io sono lo stesso di quando fui bambino, fanciullo e adolescente. Così, benché ogni età abbia una sua propria e diversa costituzione, l’adattamento a quella che ha in quel determinato periodo è sempre lo stesso. La natura mi affida me stesso, non il fanciullo, il giovane o il vecchio. Il neonato, dunque, si adatta alla sua attuale costituzione di neonato, non a quella futura di giovane: anche se deve passare a uno stadio superiore, ciò non vuol dire che lo stadio in cui è nato non sia secondo natura. L’animale innanzitutto si adatta a sé stesso: deve infatti esserci qualcosa a cui tutte le altre fanno riferimento. Aspiro al piacere: per chi? Per me, quindi mi curo di me stesso. Fuggo il dolore: per chi? Per me, quindi mi curo di me stesso. Se ogni cosa la faccio per curarmi di me stesso antepongo a tutto la cura di me stesso. Tutti gli animali possiedono questo istinto, che è innato, non viene dall’esterno. La natura non abbandona i figli che genera, ma affida ciascuno di essi a sé stesso, poiché la difesa più sicura viene da chi ci è più vicino. Perciò, come ho detto nelle lettere precedenti, gli animali, anche giovani, appena usciti dall’utero materno o dall’uovo sanno subito che cosa li minacci ed evitano i rischi mortali; gli animali che sono preda degli uccelli rapaci ne temono anche l’ombra quando questi passano in volo. Non c’è animale che nasca senza la paura della morte. Ci si chiede: «Come può un animale appena nato capire se una cosa è letale o salutare?». Prima di tutto bisogna chiedersi non come capisce ma se capisce. Che gli animali capiscano si desume dal fatto che si comportano come se capissero. Perché la gallina non fugge il pavone o l’oca ma evita lo sparviero che neppure conosce e che è tanto più piccolo? Perché i pulcini temono il gatto e non il cane? È chiaro che hanno innato il senso del pericolo: se ne guardano prima ancora di poterlo sperimentare. Questo comportamento, poi, non è casuale, nel senso che temono solo ciò che devono temere e sanno sempre difendersi con attenzione, cioè fuggono costantemente dal pericolo e per tutta la vita non hanno più paura. È dunque evidente che a renderli tali non è l’esperienza ma un naturale istinto di conservazione. L’insegnamento che gli viene dall’esperienza è tardivo e varia da animale ad animale, anche se il bagaglio di nozioni naturali è uguale per tutti e immediato. Ma, se lo vuoi, ti spiegherò come faccia l’animale a riconoscere il pericolo. Egli sente che il suo corpo è fatto di carne, di conseguenza intuisce ciò che può tagliare, bruciare o schiacciare la carne e quali sono gli animali in grado di nuocere, dei quali si forma un’immagine ostile e nemica. Si tratta di due istinti strettamente legati fra loro nel senso che la bestia, non appena si adatta alla sua conservazione, ricerca ciò che può giovarle e teme ciò che può danneggiarla. L’istinto verso l’utile è naturale, com’è naturale l’avversione alle cose nocive.
L’animale risponde ai comandi della natura ma è un fatto spontaneo, non sono frutto di una riflessione o di un calcolo. Non vedi con quanta precisione le api plasmano la loro casa, con quanta concordia da parte di tutte ciascuna attende al proprio lavoro? Non vedi che non c’è uomo capace di imitare la tela del ragno, quanto sia laborioso disporne i fili, quali diritti per creare un sostegno, quali in cerchio, più fitti e più radi, e come gli animali più piccoli contro cui sono stati tesi vi restino impigliati, quasi in una rete? Quest’arte è innata, non s’impara. Perciò non esiste un animale più esperto di un altro: le tele dei ragni sono tutte uguali, e uguali sono tutti i fori nei favi delle api. L’insegnamento che proviene da un’arte è incerto e diverso, mentre uguale e sicuro è quello che dà la natura, la quale insegna solo un’abile difesa di sé stessi, sicché gli animali cominciano contemporaneamente a vivere e a imparare. Non è strano che nascano con quelle capacità, visto che senza di esse non potrebbero sopravvivere, e per sopravvivere il primo mezzo che la natura gli ha dato è appunto la capacità di adattamento e l’amore di sé. Insomma, non potrebbero sopravvivere se non lo volessero; la volontà da sola non servirebbe a nulla, ma nulla servirebbe senza la volontà. Non c’è essere che disprezzi o trascuri se stesso; anche i bruti e i muti, per quanto tardi in tutto il resto, si dànno da fare per vivere. Se guardi bene ti renderai conto che gli esseri inutili agli altri non trascurano sé stessi. Stammi bene. 122. Ormai le giornate si sono fatte più brevi, ma c’è ancora tempo libero se ci si alza all’alba. Più zelante e lodevole è chi l’aspetta in piedi e vede sorgere il sole: è vergognoso, infatti, starsene a letto dormicchiando e alzarsi a mezzogiorno quando il sole è già alto; per molti questa è un’ora antelucana! C’è chi scambia la notte per il giorno e non apre gli occhi appesantiti dalla baldoria della sera precedente se non quando comincia a imbrunire. Inversa alla nostra è la condizione di quei popoli che la natura, come scrive Virgilio, ha collocato agli antipodi: Quando ci alita Oriente coi suoi cavalli ansanti Vespero rosseggiante tarde accende le luci per loro.8 Così la vita di quella gente è inversa alla nostra, ma non la regione. Agli antipodi in una medesima città ci sono uomini che, come dice Catone,9 non hanno mai visto il sorgere o il tramontare del sole. Secondo te sanno come vivere se non sanno neppure quando? E costoro temono la morte, visto che praticamente sono dei sepolti vivi? Sono di cattivo augurio, come gli uccelli notturni. Anche se passano le notti tra il vino e i profumi, anche se trascorrono tutto il tempo della veglia all’incontrario in pranzi di molte portate ben cotte, non banchettano, ma celebrano il proprio funerale, anche se per i morti almeno i funerali si celebrano di giorno. Tuttavia per chi ha sempre qualcosa da fare il giorno non è mai lungo. Allunghiamo la vita: agire è doveroso e fondamentale. Limitiamo la
notte e trasferiamone una parte nel giorno. I volatili destinati ai banchetti sono tenuti chiusi al buio affinché, stando immobili, ingrassino facilmente. Così, non muovendosi mai, il loro corpo impigrito si gonfia e un grasso flaccido cresce sulle loro membra. Il fisico di queste persone che si sono votate alle tenebre è ripugnante a vedersi: hanno un colorito più impressionante del pallore degli ammalati: sono bianchicci, deboli e fiacchi; pur essendo vivi, hanno la carne morta. E questo, tuttavia, è il male minore: quanto più fitte, infatti, sono le tenebre della loro anima! Vivono come istupiditi e avvolti nel buio più dei ciechi. Chi mai dalla natura ha avuto gli occhi se deve vivere al buio? Mi domando come si possa diventare così depravati da odiare il giorno e travasare nella notte tutta la propria vita. I vizi sono contro natura e contrastano l’ordine prestabilito; l’uomo dissoluto vuole godere di gioie perverse e non solo devia dal retto cammino, ma se ne allontana quanto più possibile sino a trovarsi agli antipodi. Secondo te non vivono contro natura quelle persone che bevono a digiuno, immettendo il vino nelle vene e siedono a tavola già ubriachi? Eppure questo è un vizio frequente in quei giovani che vogliono esercitare il proprio fisico e tracannano il vino fin sulla soglia del bagno tra i compagni nudi e si detergono continuamente il sudore provocato dalle tante bevande calde. Solo i cafoni bevono dopo il pranzo o la cena, perché non conoscono il vero piacere, godono del vino puro che non galleggia sul cibo, che penetra liberamente fino ai nervi, trovano piacere nell’ubriacarsi a digiuno. E quegli uomini che indossano abiti da donna non vivono contro natura? E quelli che cercano di apparire come giovinetti in fiore quando ormai quella stagione è passata? Che c’è di più crudele, di più miserabile? Non diventare mai un uomo maturo per potersi piegare a un uomo? Neppure l’età avanzata li sottrarrà a quella violenza, quando almeno il sesso avrebbe dovuto impedirglielo. E non vivono contro natura quelli che vogliono avere le rose d’inverno e con l’uso di acqua calda e con opportuni trapianti fanno nascere i gigli nella fredda stagione? Non vivono contro natura quelli che piantano frutteti in cima alle torri? E quelli che sui tetti delle loro case ergono boschetti che ondeggiano al vento? Le radici di quegli alberi nascono là dove a stento arriverebbe la cima. Non vive contro natura chi getta le fondamenta delle terme nel mare e non prova piacere a nuotare se le vasche d’acqua calda non sono sbattute dalle onde in tempesta? Vogliono tutto contro natura e alla fine se ne staccano completamente. «Si fa giorno: è ora di dormire. Tutto è tranquillo: facciamo ginnastica, andiamo a passeggio, pranziamo. Oramai è l’alba: è ora di cenare. Non bisogna fare ciò che fa il popolo: che squallore la solita vita ordinaria. Non trascorriamo il giorno come lo passano tutti gli altri: ci sia per noi un mattino speciale!». Costoro sono come morti; quanto sono vicini alla fine, e per di più precoce, vivendo alla luce di fiaccole e ceri! Ci fu un periodo, ricordo, in cui a Roma erano in molti a condurre questo genere di vita: fra loro c’era un ex pretore, Acilio Buta, il quale, dopo aver dilapidato un ingente patrimonio, quando confidò a Tiberio la sua povertà si ebbe da lui questa risposta: «Ti sei svegliato tardi». Giulio Montano, 10 un poeta
discreto, noto prima per l’amicizia e poi per l’inimicizia con Tiberio, era solito leggere le sue poesie, in cui molto spesso infilava albe e tramonti. Una volta un tale, indispettito perché aveva recitato i suoi versi per un giorno intero, protestò che si dovessero disertare le sue letture, al che Natta Pinario, un cortigiano dell’imperatore,11 esclamò: «Io, invece, sarei più gentile: sono disposto ad ascoltarlo dall’alba al tramonto». Un giorno lesse questi versi: Febo comincia a emettere ardenti fiamme e rossa già si diffonde la luce. La rondine più volte, mesta tornando ai nidi pigolanti, già porta il cibo e delicatamente lo va dispensando col becco. Allora Varo, cavaliere romano amico di Vinicio, assiduo frequentatore di cene raffinate che si guadagnava con la sua maldicenza, esclamò: «E Buta comincia a dormire». Poi, dopo che questi ebbe recitato i versi Hanno rinchiuso gli armenti nelle stalle i pastori: ormai sparge la pigra notte sulle terre dormienti il silenzio,12 Varo aggiunse: «Come? È già notte? Andrò a dare il buongiorno a Buta». La vita di costui, contraria alla normalità, era più nota delle sue poesie, ma, come ho detto, in quel periodo molti vivevano come lui. Certi si comportano così non perché ritengano che la notte sia più piacevole ma perché snobbano le consuetudini, per non dire che chi ha la coscienza sporca non gradisce la luce e chi ama o disdegna le cose a seconda che costino tanto o poco, la luce la disprezza perché non costa niente. Inoltre questi dissoluti amano sentir parlare di sé mentre sono vivi e vegeti, diversamente, se nessuno li vede, pensano di sciupare il proprio tempo. Per questo a volte si comportano in modo da suscitare scandalo. Molti sperperano i loro beni, molti hanno delle amanti, poiché per farsi un nome non gli basta la dissolutezza, devono emergere fra i loro simili: in una società così indaffarata, infatti, una perversità ordinaria non dà motivo di chiacchiere. Un giorno Pedone Albinovano, 13 elegantissimo narratore, ci raccontò di aver abitato sopra l’appartamento di Sesto Papinio, uno di questa compagnia di nottambuli. «Verso le nove di sera», esordì, «sento, da sotto, schioccare la frusta. “Che sta facendo Papinio?”, domando. “Si fa fare i conti”, mi rispondono. Verso mezzanotte sento delle grida concitate. “Che sta accadendo, adesso?”, m’informo. “Esercita la voce”. Verso le due sento un rumore di ruote. “Ma che fa?”. “Va a passeggio”. All’alba sento correre, chiamare gli schiavi, agitarsi i cantinieri e i cuochi. “E ora che accade?”. “È appena uscito dal bagno: ha chiesto del vino mielato e orzata”. “Il suo pranzo, allora, durava più di una giornata?”. No, viveva molto frugalmente: mangiava solo la notte». Perciò Pedone a chi definiva Papinio gretto e avaro, rispondeva: «Chiamatelo pure nottambulo».
Non devi stupirti di trovare tante varietà di vizi: sono diversi, hanno innumerevoli forme, non si possono classificare i loro generi: la ricerca del bene è semplice, quella del male complessa e assume sempre nuove deviazioni. Lo stesso accade per i modi di vivere: se conformi a natura sono semplici, liberi e presentano scarse differenze; se perversi, sono in contrasto fra loro e con sé stessi. Per me, però, la causa prima di questa corruzione sta nel disgusto per la vita normale. Questi individui si distinguono dagli altri per l’eleganza, la raffinatezza delle cene, il lusso delle carrozze, e così vogliono distinguersi anche nella disposizione dei tempi. Per costoro una cattiva reputazione è il premio dei loro vizi, perciò non vogliono commettere i soliti peccati. E tutti questi che, per così dire, vivono al contrario, cercano appunto una cattiva reputazione.Perciò, Lucilio mio, dobbiamo seguire la via segnata dalla natura, senza distaccarcene: chi la percorre trova tutto facile e comodo; chi va nel senso opposto vive come se remasse controcorrente. Stammi bene. 123. Sfinito da un viaggio più scomodo che lungo, a notte alta arrivo nella mia villa di Alba: non c’è niente di pronto, salvo che il mio stomaco, sicché, spossato, mi getto sul divano, senza arrabbiarmi per il ritardo del cuoco e del fornaio: se una cosa, mi dico, si prende alla leggera non è grave e non dovremmo andare in collera per una inezia, sempre che non siamo noi a ingrandirla con la nostra indignazione. Il mio fornaio non ha pane: ne hanno, però, il fattore, il custode, il colono. «Pane cattivo», dirai. Aspetta: diventerà buono, la fame renderà morbido e bianco anche questo. Perciò non bisogna mangiare finché la fame non lo comanda. Aspetterò dunque, e non mangerò prima di avere un buon pane o di non provare più disgusto per quello cattivo. Bisogna abituarsi al poco: anche chi è ricco e ha tutto si troverà in luoghi e circostanze sfavorevoli che gli impediranno di soddisfare i suoi piaceri. Non si può avere tutto ciò che si vuole, ma si può non volere ciò che non si ha e godere delle gioie che si presentano. Gran parte della libertà consiste in uno stomaco moderato e capace di sopportare le privazioni. Non si può immaginare quanto piacere mi dia il sentire che la stanchezza se ne va da sé; non voglio né massaggi, né bagni, unico rimedio è il tempo: il riposo elimina gli effetti della fatica, una cena qualunque è più piacevole di un banchetto inaugurale. […] Dunque, ho messo il mio animo alla prova inaspettatamente e perciò ne ho tratto un’esperienza più schietta e più vera. Se c’imponiamo di essere pazienti, predisponendo così il nostro animo, non possiamo sapere esattamente se la nostra fermezza sia reale o no. Le prove più sicure sono quelle che si presentano all’improvviso, quando l’animo di fronte ai dispiaceri non solo si rassegna ma si mantiene sereno, non dà in escandescenze e non si mette a litigare, quando a ciò che si aspettava supplisce scacciando il desiderio e pensa che manchi qualcosa alle sue abitudini ma non a lui stesso. Solo quando certe cose cominciano a mancare ci accorgiamo della loro inutilità: le usiamo non per bisogno, ma perché le abbiamo. E quante sono poi le
cose che ci procuriamo perché le hanno gli altri o perché le possiedono quasi tutti! Ecco una delle cause dei nostri mali: viviamo imitando il prossimo e ci facciamo trascinare dall’abitudine, non guidare dalla ragione. Una cosa che non vorremmo fare se a farla fossero pochi quando diventa una moda la seguiamo, come se fosse più giusta perché la fanno molti; l’errore quando è comune ai più prende il posto del bene. Ormai tutti viaggiano come se li precedesse la cavalleria numidica e una schiera di battistrada: sarebbe infatti una vergogna non avere nessuno che faccia scansare i passanti e mostri, alzando un polverone, che arriva un uomo importante! Tutti hanno muli carichi di vasellame di cristallo, di murra, cesellato a mano da grandi artisti: sarebbe una vergogna se si sapesse che nei bagagli porti solo roba infrangibile! Tutti si trascinano dietro giovani schiavi col viso unto di crema perché il sole o il freddo non rovinino la loro pelle delicata: sarebbe una vergogna se al tuo seguito ci fossero schiavi col viso fresco senza bisogno di creme. Dobbiamo evitare di attaccar discorso con tutti questi individui, che trasmettono i vizi e li diffondono da un posto all’altro. Sembrava che i calunniatori fossero la razza peggiore, e invece sono quelli che diffondono i vizi. Le loro chiacchiere sono veramente dannose: benché al momento non provochino alcun effetto, seminano nella nostra anima i germi del male e ci seguono anche quando ne siamo lontani, poiché il male si svilupperà più tardi. Come dopo aver ascoltato un concerto ci risuona nelle orecchie il ritmo e la dolcezza di quella musica, impedendoci di pensare e di attendere a cose importanti, così i discorsi degli adulatori e di quanti lodano le cattive azioni ci restano impressi anche quando non li sentiamo più. E non è facile liberarsi di quella carezzevole musica, poiché ci perseguita con insistenza e a intervalli ritorna. Non ascoltiamo, dunque, fin dall’inizio, quelle parole oscene, anche perché la loro sfrontatezza cresce quando sono raccolte, al punto che si sentono discorsi di questo tenore: «La virtù, la filosofia, la giustizia sono parole vuote e altisonanti; l’unica felicità è vivere bene, mangiare, bere, godersi le ricchezze: questa è la vita, questo è ricordarsi che dobbiamo morire. I giorni scivolano via, veloce e inesorabile fugge la vita. Hai dei dubbi? A che serve, alla nostra età, essere saggi e imporsi di vivere morigeratamente, quando ora possiamo godere dei piaceri (mentre domani non lo potremo), anzi ne sentiamo il bisogno; che senso ha precedere la morte e privarsi fin da ora di ciò che essa ci porterà via? Non avere un’amante, un ragazzo che susciti la sua gelosia, mostrarsi sobrio ogni giorno e mangiare come se si dovesse sottoporre al proprio genitore il libro dei conti: questo non è vivere, è guardar vivere gli altri. Che pazzia preoccuparsi del patrimonio destinato all’erede e privarsi di tutto perché una grande eredità ti faccia nemico un amico: egli infatti godrà della tua morte in rapporto all’entità del lascito. Codesti tristi e sopraccigliosi censori della vita altrui, nemici della propria, pubblici pedagoghi non tenerli in alcun conto e non esitare a preferire una buona vita a una buona reputazione». Bisogna fuggire queste voci come le sirene davanti a cui Ulisse non volle passare se non legato: il loro potere è identico,
allontanano dalla patria, dai genitori, dagli amici, dalle virtù e ci spingono *** a una vita infelice e disonorevole. Meglio seguire la retta via e arrivare a gioire solo dell’onestà, e lo potremo prendendo atto che due sono le categorie di cose che ci attraggono o ci respingono. La ricchezza, i piaceri, la bellezza, l’ambizione e ciò che c’è di accattivante e lusinghiero ci attraggono; ci respingono la fatica, la morte, il dolore, il disonore, un tenore di vita troppo severo. Esercitiamoci, dunque, a non temere le une e a non desiderare le altre. Combattiamo in due modi diversi: ritiriamoci davanti alle lusinghe, affrontiamo le difficoltà. Non vedi come sia diverso l’atteggiamento di chi scende e di chi sale? Chi scende porta il peso del corpo indietro, chi sale si piega in avanti. Fare il contrario, caro Lucilio, significa tenere una posizione viziata. La strada verso i piaceri è in discesa, quella verso azioni difficili e impegnative è in salita: in questo caso dobbiamo spingere il corpo in avanti, nell’altro frenarlo. Non pensare che io consideri pericoloso per le nostre orecchie solo chi loda il piacere e chi ci incute la paura del dolore, cose che sono temibili di per sé stesse. Per me ci nuocciono anche quelle persone che sotto la maschera dello stoicismo ci esortano ai vizi. Dicono che solo l’uomo saggio e istruito sa amare. «È l’unico adatto a quest’arte, ed è pure il più esperto nel bere e nel mangiare in compagnia. Vediamo fino a quale età si debbano amare i giovani». Queste abitudini lasciamole ai Greci, noi ascoltiamo piuttosto queste massime: «Nessuno è onesto per caso: la virtù s’impara. Il piacere è una cosa vile e meschina, di nessun valore, comune anche alle bestie: vi aspirano gli esseri inferiori e volgari. La gloria è cosa effimera e vana, più instabile dell’aria. La povertà è un male solo per chi non l’accetta. La morte non è un male: è la sola legge che sia uguale per tutti gli uomini. La superstizione è pura follia: teme le divinità che dovrebbe amare e profana quelle che venera. Che differenza c’è, infatti, tra il negare gli dèi e l’offenderli?». Queste sono le massime che vanno imparate, a memoria: la filosofia non deve fornire giustificazioni al vizio. Non può sperare di guarire un ammalato se il medico lo spinge all’intemperanza. Stammi bene. 124. Posso citarti parecchi precetti degli antichi, se non ti annoia e accetti conoscere semplici cure.14 Ma a te piacciono le sottigliezze, poiché la tua eleganza non insegue solo i grandi problemi, perciò approvo anche il fatto che tu voglia trarre profitto da ogni argomento e che ti secchi soltanto quando la troppa sottigliezza non porta alcun frutto. Per quel che mi riguarda mi adopererò affinché ciò non accada. Si discute se il bene si apprenda coi sensi o con la mente; in quest’ultimo caso ne sarebbero esclusi gli animali e i neonati. Tutti i filosofi che considerano il piacere il primo dei beni ritengono che il bene si percepisca coi sensi, mentre per noi stoici, che il bene lo attribuiamo all’anima, è intelligibile. Se a giudicare il bene fossero i sensi, non rifiuteremmo alcun piacere perché i piaceri ci
attraggono e ci lusingano tutti, e d’altra parte non accetteremmo volontariamente alcun dolore, in quanto tutti i dolori colpiscono i sensi. E poi non si potrebbe muovere alcuna critica a chi ama troppo il piacere e teme moltissimo il dolore. Noi, infatti, biasimiamo i golosi e i lussuriosi e disprezziamo i vili perché hanno paura del dolore. Ma se obbediscono ai sensi, giudici del bene e del male, che colpa ne hanno, quando si rimette a essi la valutazione di ciò che va ricercato e di ciò che si deve fuggire? Questo, invece, ovviamente, è compito della ragione: è lei che decide del bene e del male, come della felicità, della virtù e dell’onestà. Costoro, insomma, attribuiscono alla parte più vile dell’uomo la facoltà di giudicare sulla migliore: del bene deciderebbero i sensi, che sono ottusi e deboli, meno sviluppati nell’uomo che negli animali. Che diresti a uno che pretendesse di distinguere gli oggetti minuscoli col tatto e non con gli occhi? A questo scopo non c’è facoltà più acuta e più intensa di quella della vista, ma questa potrebbe mai dare la possibilità di distinguere il bene dal male? Vedi come ignori la verità e svilisca cose nobili o divine, come la ragione, chi giudica coi sensi il sommo bene e il sommo male. Si potrebbe ribattere: «Tutte le scienze e tutte le arti nascono e si sviluppano da qualche elemento tangibile e manifesto, allo stesso modo la felicità ha le sue origini e il suo inizio in fattori concreti e manifesti. Lo dite voi stessi». Ebbene, noi diciamo felice ciò che è secondo natura, e cosa sia secondo natura è del tutto evidente, come lo è un oggetto nella sua interezza. Ciò che è secondo natura e riguarda un neonato per me non è un bene, è l’inizio di un bene. Tu attribuisci all’infanzia il sommo bene, cioè il piacere, dunque il neonato comincerebbe dal punto a cui arriva l’uomo completo e perfetto: così metti la cima della pianta al posto delle radici. Dire che il feto nascosto nell’utero materno, di sesso ancora incerto, delicato, imperfetto e informe ha già un qualche bene sarebbe un errore evidente. E che differenza c’è tra il bimbo appena nato e il feto che pesa dentro le viscere materne? Riguardo alla cognizione del bene e del male entrambi sono ugualmente immaturi: il neonato non è capace di bene più di quanto possa esserlo una pianta o un animale. Ma perché in una pianta o in un animale non c’è il bene? Perché sono privi di ragione. Per questo il bene non c’è neppure nel neonato, perché anche lui è privo di ragione, arriverà al bene solo all’età della ragione. Ci sono esseri irrazionali, altri non ancora razionali, altri razionali ma imperfetti: in nessuno di loro c’è il bene, il quale nasce solo con la ragione. Qual è allora la differenza? Nell’essere irrazionale il bene non ci sarà mai; nell’essere non ancora razionale non c’è ancora; nell’essere razionale ma imperfetto potrebbe esserci ma non c’è. Io, Lucilio, la penso così: il bene non si trova in qualunque corpo, a qualunque età, ed è tanto lontano dall’infanzia quanto dal primo l’ultimo, quanto una cosa compiuta è lontana dal suo inizio. Quindi il bene in un piccolo corpo delicato ancora in formazione non c’è. È lo stesso che in un seme. Diciamo meglio: in un albero o in una pianta c’è un certo bene, ma non in un virgulto appena spuntato dalla terra. Un certo bene c’è nel grano, ma non nell’erbetta ancora bianca, e nemmeno quando la tenera spiga si libera dalla
scorza: c’è solo quando, d’estate, il suo sviluppo naturale ha maturato il frumento. Come la natura in ogni suo aspetto non rivela il proprio bene se non quando arriva a compimento, così il bene proprio dell’uomo non è presente nell’individuo se non quando la ragione è perfetta. Ma qual è questo bene? Uno spirito libero, fiero, che tutto assoggetta a sé ma non si assoggetta a nessuno. L’infanzia non può possedere questo bene, la fanciullezza non può sperarlo e l’adolescenza è difficile che lo realizzi: può ritenersi fortunato il vecchio che lo raggiunge dopo un lungo e intenso studio. Se questo è il bene, è pure intelligibile. Si potrebbe ribattere: «Tu hai detto che c’è un bene dell’albero e un bene dell’erba, dunque può esserci anche un bene del neonato». Il vero bene non si trova negli alberi e nemmeno nelle bestie: il bene che è in loro lo chiamiamo impropriamente bene. «E qual è, allora?», mi domandi. Ciò che è conforme alla natura di ciascuno. Il bene non può in alcun modo infilarsi in una bestia, in quanto è proprio di una natura migliore e più felice. Il bene si trova solo dove c’è la ragione. Quattro sono i tipi di natura: vegetale, animale, umana, divina: le ultime due, che sono razionali, hanno la medesima natura, ma sono diverse in quanto l’una è immortale, l’altra mortale. Il bene di dio è insito nella sua natura, il bene dell’uomo nasce dalla sua attività. Gli altri esseri sono perfetti solo nell’ambito della loro natura, ma non sono veramente perfetti, perché non possiedono la ragione. Perfetto è solo ciò che è tale secondo la natura universale, e la natura universale è razionale: gli altri esseri possono essere perfetti solo nel loro genere. L’essere in cui non può esserci la felicità non può avere nemmeno ciò che produce la felicità, e ciò che produce la felicità è il bene. Nelle bestie non c’è felicità e neppure ciò che produce la felicità, quindi in loro non c’è il bene. È coi sensi che la bestia percepisce la realtà che la circonda: si ricorda del passato quando si imbatte in qualcosa che stimola i suoi sensi, così il cavallo ricorda la strada quando lo portano dove comincia. Se si trova nella stalla non ha alcun ricordo della strada, anche se l’ha percorsa spesso. La terza dimensione temporale, cioè il futuro, non conta per le bestie. Come può dunque ritenersi perfetta la loro natura se non hanno una perfetta nozione del tempo? Il tempo consta di tre parti, passato, presente, futuro. Gli animali hanno solo la nozione del presente, la parte più breve e fugace, del passato hanno un vago ricordo dovuto all’impatto col presente. Perciò il bene, che è proprio di una natura perfetta, non può albergare in una natura imperfetta, altrimenti lo possiederebbero anche le piante. Non nego che le bestie provino forti e impetuosi slanci verso ciò che è secondo natura, ma si tratta di impulsi disordinati e confusi, mentre il bene non è mai tale. «Ma come? Le bestie si muovono in modo disordinato e confuso?». In realtà si muovono semplicemente secondo la loro natura: si potrebbe dire che si muovono in maniera disordinata e confusa se la loro natura obbedisse a una regola. È disordinato ciò che può anche seguire un ordine, come è turbato ciò che può anche essere tranquillo; vizioso è chi può avere la virtù: nelle bestie questi movimenti sono del tutto naturali. Ma, per non farla lunga, ci sarà nelle bestie un qualche bene, ci sarà una qualche
virtù, una qualche perfezione, ma non il bene, né la virtù, né la perfezione in assoluto, che toccano solo agli esseri razionali, ai quali oltretutto è concesso di conoscere il perché, i limiti e le modalità dell’agire. Ecco perché il bene è presente solo negli esseri razionali. Ti chiedi a che miri questa discussione e quale utilità possa arrecarti. Giova al tuo spirito perché lo esercita, lo rende più acuto e lo impegna in un’occupazione onesta. E poi perché trattiene dal male chi ne è attratto. Ma ti dico anche che in nessun altro modo posso giovarti se non mostrandoti il tuo bene, operando una distinzione tra le bestie e mettendoti accanto a dio. E ora ti chiedo: «Perché eserciti e accresci il tuo vigore fisico?». La natura ha concesso forze ben maggiori alle bestie, domestiche e feroci. «Perché curi la tua bellezza?». Per quanto tu ti adoperi, gli animali saranno sempre più leggiadri di te. «Perché ti acconci i capelli con tanta accuratezza?». Anche se li portassi sciolti come i Parti, annodati come i Germani, o scomposti come gli Sciti, la criniera di qualsiasi cavallo ondeggerà più folta ed una ancora più bella si drizzerà sul collo del leone. E per quanto ti eserciti nella corsa non potrai eguagliare in velocità il leprotto. Metti dunque da parte tutto ciò in cui non sarai mai superiore agli altri, non sforzarti in cose che sono estranee alla tua natura e volgiti al tuo bene. E qual è questo bene? Un animo puro, senza difetti, emulo di dio, che si innalza al di sopra delle vicende umane, che ripone tutto in sé stesso. Sei un animale fornito di ragione: rendila perfetta, questo è il tuo bene. Richiamala alla sua meta, falla crescere quanto più può. Ritieniti felice solo quando ogni gioia ti verrà dal tuo intimo, quando in mezzo a tutti quei beni che gli uomini cercano, acchiappano e custodiscono gelosamente non ne troverai uno solo che tu possa non dico preferire ma neppure desiderare. Ed eccoti una piccola norma in base alla quale potrai misurare via via il tuo cammino verso la saggezza e accorgerti, alla fine, di avere raggiunto la perfezione: quando avrai capito che gli uomini comunemente felici sono in realtà i più infelici, allora e soltanto allora avrai pieno possesso della tua ricchezza. Stammi bene.
1. È ancora Cicerone, Lettere ad Attico (I 12). 2. Si riferisce alla sconfitta di Catone nelle elezioni per la pretura. 3. Liberto di Augusto. 4. Orazio, Satire I 2, 114-116. 5. Manio Curio Dentato, generale, combatté contro i Sanniti, i Galli e Pirro; fu eletto console tre volte, esempio di onestà e di incorruttibilità. 6. Orazio, Satire I 3, 11-17. 7. Filosofo stoico (II sec. a.C.), fondò una scuola a Babilonia. 8. Virgilio, Georgiche I 250-251. 9. Catone, Detti 76. 10. Poeta epico ed elegiaco (I sec. d.C.). 11. Tiberio.
12. Giulio Montano. 13. Poeta epico ed epigrammatico, scrisse la Teseide e un poema sulla spedizione in Germania di Giulio Cesare, il Germanico (nipote di Augusto). 14. Virgilio, Georgiche I 176-177.
Apokolokyntosis
1. Quid actum sit in caelo ante diem III idus Octobris anno novo, initio saeculi felicissimi, volo memoriae tradere. Nihil nec offensae nec gratiae dabitur. Haec ita vera. Si quis quaesiverit unde sciam, primum, si noluero, non respondebo. Quis coacturus est? Ego scio me liberum factum, ex quo suum diem obiit ille, qui verum proverbium fecerat, aut regem aut fatuum nasci oportere. Si libuerit respondere, dicam quod mihi in buccam venerit. Quis umquam ab historico iuratores exegit? Tamen si necesse fuerit auctorem producere, quaerito ab eo qui Drusillam euntem in caelum vidit: idem Claudium vidisse se dicet iter facientem «non passibus aequis». Velit nolit, necesse est illi omnia videre quae in caelo aguntur: Appiae viae curator est, qua scis et divum Augustum et Tiberium Caesarem ad deos isse. Hunc si interrogaveris, soli narrabit: coram pluribus numquam verbum faciet. Nam ex quo in senatu iuravit se Drusillam vidisse caelum ascendentem et illi pro tam bono nuntio nemo credidit quod viderit, verbis conceptis affirmavit se non indicaturum etiam si in medio foro hominem occisum vidisset. Ab hoc ego quae tum audivi, certa clara affero, ita illum salvum et felicem habeam. 2. Iam Phoebus breviore via contraxerat arcum lucis et obscuri crescebant tempora Somni, iamque suum victrix augebat Cynthia regnum, et deformis Hiems gratos carpebat honores divitis Autumni iussoque senescere Baccho carpebat raras serus vindemitor uvas. Puto magis intellegi si dixero: mensis erat October, dies III idus Octobris. Horam non possum certam tibi dicere (facilius inter philosophos quam inter horologia conveniet) tamen inter sextam et septimam erat. «Nimis rustice! ‹Adeo his› adquiescunt omnes poetae, non contenti ortus et occasus describere, ut etiam medium diem inquietent: tu sic transibis horam tam bonam?». Iam medium curru Phoebus diviserat orbem et propior Nocti fessas quatiebat habenas obliquo flexam deducens tramite lucem: 3. Claudius animam agere coepit nec invenire exitum poterat. Tum Mercurius, qui semper ingenio eius delectatus esset, unam e tribus Parcis seducit et ait: «Quid, femina crudelissima, hominem miserum torqueri pateris? Nec umquam tam diu cruciatus cesset? Annus sexagesimus et quartus est, ex quo cum anima luctatur. Quid huic et reipublicae invides? Patere mathematicos aliquando verum dicere, qui illum, ex quo princeps factus est, omnibus annis omnibus mensibus efferunt. Et tamen non est mirum si errant et
horam eius nemo novit: nemo enim umquam illum natum putavit. Fac quod faciendum est: dede neci, melior vacua sine regnet in aula». Sed Clotho «Ego mehercules» inquit «pusillum temporis adicere illi volebam, dum hos pauculos qui supersunt civitate donaret» (constituerat enim omnes Graecos, Gallos, Hispanos, Britannos togatos videre). «Sed quoniam placet aliquos peregrinos in semen relinqui et tu ita iubes fieri, fiat». Aperit tum capsulam et tres fusos profert: unus erat Augurini, alter Babae, tertius Claudii. «Hos» inquit «tres uno anno exiguis intervallis temporum divisos mori iubebo, nec illum incomitatum dimittam. Non oportet enim eum, qui modo se tot milia hominum sequentia videbat, tot praecedentia, tot circumfusa, subito solum destitui. Contentus erit his interim convictoribus». 4. Haec ait et turpi convolvens stamina fuso abrupit stolidae regalia tempora vitae. At Lachesis, redimita comas, ornata capillos, Pieria crinem lauro frontemque coronans, candida de niveo subtemina vellere sumit felici moderanda manu, quae ducta colorem assumpsere novum. Mirantur pensa sorores: mutatur vilis pretioso lana metallo, aurea formoso descendunt saecula filo. Nec modus est illis: felicia vellera ducunt et gaudent implere manus: sunt dulcia pensa. Sponte sua festinat opus nulloque labore mollia contorto descendunt stamina fuso; vincunt Tithoni, vincunt et Nestoris annos. Phoebus adest cantuque iuvat gaudetque futuris et laetus nunc plectra movet, nunc pensa ministrat: detinet intentas cantu fallitque laborem. Dumque nimis citharam fraternaque carmina laudant, plus solito nevere manus humanaque fata laudatum transcendit opus. «Ne demite, Parcae» Phoebus ait «vincat mortalis tempora vitae ille mihi similis vultu similisque decore nec cantu nec voce minor. Felicia lassis saecula praestabit legumque silentia rumpet. Qualis discutiens fugientia Lucifer astra aut qualis surgit redeuntibus Hesperus astris, qualis, cum primum tenebris Aurora solutis induxit rubicunda diem, Sol aspicit orbem lucidus et primos a carcere concitat axes: talis Caesar adest, talem iam Roma Neronem
aspiciet. Flagrat nitidus fulgore remisso vultus et adfuso cervix formosa capillo». Haec Apollo. At Lachesis, quae et ipsa homini formosissimo faveret, fecit illud plena manu et Neroni multos annos de suo donat. Claudium autem iubent omnes χαίροντας, εὑφημοῦντας ἑκπέμπειν δόμων. Et ille quidem animam ebulliit, et ex eo desiit vivere videri. Expiravit autem dum comoedos audit, ut scias me non sine causa illos timere. Ultima vox eius haec inter homines audita est, cum maiorem sonitum emisisset illa parte, qua facilius loquebatur: «Vae me, puto, concacavi me». Quod an fecerit, nescio; omnia certe concacavit. 5. Quae in terris postea sint acta supervacuum est referre. Scitis enim optime, nec periculum est ne excidant quae memoriae gaudium publicum impresserunt: nemo felicitatis suae obliviscitur. In caelo quae acta sint audite: fides penes auctorem erit. Nuntiatur Iovi venisse quendam bonae staturae, bene canum; nescio quid illum minari, assidue enim caput movere; pedem dextrum trahere. Quaesisse se cuius nationis esset: respondisse nescio quid perturbato sono et voce confusa; non intellegere se linguam eius: nec Graecum esse nec Romanum nec ullius gentis notae. Tum Iuppiter Herculem, qui totum orbem terrarum pererraverat et nosse videbatur omnes nationes, iubet ire et explorare quorum hominum esset. Tum Hercules primo aspectu sane perturbatus est, ut qui etiam non omnia monstra timuerit. Ut vidit novi generis faciem, insolitum incessum, vocem nullius terrestris animalis sed qualis esse marinis beluis solet, raucam et implicatam, putavit sibi tertium decimum laborem venisse. Diligentius intuenti visus est quasi homo. Accessit itaque et quod facillimum fuit Graeculo, ait: τίς πόθτεν εἱς ἁνδρῶν, ποίη πόλις ἡδὲ τοκῆες Claudius gaudet esse illic philologos homines: sperat futurum aliquem historiis suis locum. Itaque et ipse Homerico versu Caesarem se esse significans ait: Ἱλιόθεν με φέρων ἄνεμος Κικόνεσσι πέλασσεν (erat autem sequens versus verior, aeque Homericus: ἔνθα δ’ἑγὼ πόλιν ἔπραθον, ὤλεσα δ’αὐτούς). 6. Et imposuerat Herculi minime vafro, nisi fuisset illic Febris, quae fano suo relicto sola cum illo venerat: ceteros omnes deos Romae reliquerat. «Iste» inquit «mera mendacia narrat. Ego tibi dico, quae cum illo tot annis vixi: Luguduni natus est, Munati municipem vides. Quod tibi narro, ad sextum decimum lapidem natus est a Vienna, Gallus germanus. Itaque quod Gallum facere oportebat, Romam cepit. Hunc ego tibi recipio Luguduni natum, ubi Licinus multis annis regnavit. Tu autem, qui plura loca calcasti quam ullus mulio perpetuarius, Lugudunenses scire debes multa milia inter Xanthum et Rhodanum interesse». Excandescit hoc loco Claudius et quanto potest murmure irascitur. Quid diceret
nemo intellegebat. Ille autem Febrim duci iubebat. Illo gestu solutae manus, et ad hoc unum satis firmae, quo decollare homines solebat, iusserat illi collum praecidi. Putares omnes illius esse libertos: adeo illum nemo curabat. 7. Tum Hercules «Audi me» inquit «tu desine fatuari. Venisti huc, ubi mures ferrum rodunt. Citius mihi verum, ne tibi alogias excutiam». Et quo terribilior esset, tragicus fit et ait: «Exprome propere sede qua genitus cluas, hoc ne peremptus stipite ad terram accidas: haec clava reges saepe mactavit feros. Quid nunc profatu vocis incerto sonas? quae patria, quae gens mobile eduxit caput? edissere. Equidem regna tergemini petens longinqua regis, unde ab Hesperio mari Inachiam ad urbem nobile advexi pecus, vidi duobus imminens fluviis iugum, quod Phoebus ortu semper obverso videt, ubi Rhodanus ingens amne praerapido fluit Ararque, dubitans quo suos cursus agat, tacitus quietis adluit ripas vadis. estne illa tellus spiritus altrix tui?». Haec satis animose et fortiter, nihilo minus mentis suae non est et timet μωρο πληγήν. Claudius, ut vidit virum valentem, oblitus nugarum, intellexit neminem Romae sibi parem fuisse, illic non habere se idem gratiae: gallum in suo sterquilino plurimum posse. Itaque quantum intellegi potuit, haec visus est dicere: «Ego te, fortissime deorum Hercule, speravi mihi adfuturum apud alios, et si qui a me notorem petisset, te fui nominaturus, qui me optime nosti. Nam, si memoria repetis, ego eram qui tibi ante templum tuum ius dicebam totis diebus mense Iulio et Augusto. Tu scis quantum illic miseriarum ego contulerim, cum causidicos audirem diem et noctem. In quod si incidisses, valde fortis licet tibi videaris, maluisses cloacas Augeae purgare: multo plus ego stercoris exhausi. Sed quoniam volo * * *» 8. «* * * non mirum quod in curiam impetum fecisti: nihil tibi clausi est. Modo dic nobis qualem deum istum fieri velis. πικούρειος θε ς non potest esse: ο τε α τ ς πρ γμα χει τι ο τε λλοις παρέχει. Stoicus? Quomodo potest «rotundus» esse, ut ait Varro, «sine capite, sine praeputio»? Est aliquid in illo Stoici dei, iam video: nec cor nec caput habet. Si mehercules a Saturno petisset hoc beneficium, cuius mensem toto anno celebravit Saturnalicius princeps, non tulisset. Illum deum ‹induci› ab Iove, quem, quantum quidem in illo fuit, damnavit incesti! Silanum enim generum suum occidit. «Oro, propter quid?». Sororem suam, festivissimam omnium puellarum, quam omnes Venerem vocarent, maluit Iunonem vocare. «Quare» inquit, «quaero enim, sororem suam?» stulte, stude:
Athenis dimidium licet, Alexandriae totum. Quia «Romae» inquis, «mures molas lingunt», hic nobis curva corriget? Quid in cubiculo suo faciat nesciet: iam «caeli scrutatur plagas». Deus fieri vult? Parum est quod templum in Britannia habet, quod ‹hunc› nunc barbari colunt et ut deum orant μωροῦ εὐιλὰτου τυχεῖν?». 9. Tandem Iovi venit in mentem, privatis intra curiam morantibus, nec sententiam dicere nec disputare. «Ego» inquit «p.c., interrogare vobis permiseram, vos mera mapalia fecistis. Volo ut servetis disciplinam curiae. Hic, qualiscumque est, quid de nobis existimavit?» illo dimisso primus interrogatur sententiam Ianus pater. Is designatus erat in kal. Iulias postmeridianus consul, homo, quantum via sua fert, qui semper videt μα πρόσσω κα ρισσω. Is multa diserte, quod in foro viv‹eb›at, dixit, quae notarius persequi non potuit et ideo non refero, ne aliis verbis ponam quae ab illo dicta sunt. Multa dixit de magnitudine deorum: non debere hunc vulgo dari honorem. «Olim» inquit «magna res erat deum fieri: iam Fabam mimum fecisti. Itaque ne videar in personam, non in rem dicere sententiam, censeo ne quis post hunc diem deus fiat ex his, qui ρούρης καρπ ν δουσιν aut ex his, quos alit ζείδωρος ρουρα. Qui contra hoc senatus consultum deus factus dictus pictusve erit, eum dedi larvis et proximo munere inter novos auctoratos ferulis vapulare placet». Proximus interrogatur sententiam Diespiter Vicae Potae filius, et ipse designatus consul, nummulariolus. Hoc quaestu se sustinebat: vendere civitatulas solebat. Ad hunc belle accessit Hercules et auriculam illi tetigit. Censet itaque in haec verba: «Cum divus Claudius et divum Augustum sanguine contingat nec minus divam Augustam aviam suam, quam ipse deam esse iussit, longeque omnes mortales sapientia antecellat sitque e re publica esse aliquem qui cum Romulo possit “ferventia rapa vorare”, censeo uti divus Claudius ex hac die deus sit ita uti ante eum quis optimo iure factus sit, eamque rem ad Metamorphosis Ovidi adiciendam». Variae erant sententiae, et videbatur Claudius sententiam vincere. Hercules enim, qui videret ferrum suum in igne esse, modo huc modo illuc cursabat et aiebat: «Noli mihi invidere, mea res agitur; deinde tu si quid volueris, in vicem faciam: manus manum lavat». 10. Tunc divus Augustus surrexit sententiae suae loco dicendae et summa facundia disseruit: «Ego» inquit «p.c., vos testes habeo, ex quo deus factus sum, nullum me verbum fecisse: semper meum negotium ago. Et non possum amplius dissimulare et dolorem, quem graviorem pudor facit, continere. In hoc terra marique pacem peperi? Ideo civilia bella compescui? Ideo legibus urbem fundavi, operibus ornavi, ut… Quid dicam, p.c., non invenio: omnia infra indignationem verba sunt. Confugiendum est itaque ad Messalae Corvini, disertissimi viri, illam sententiam «pudet imperii». Hic, p.c., qui vobis non posse videtur muscam excitare, tam facile homines occidebat quam canis adsidit. Sed quid ego de tot ac talibus viris dicam? Non vacat deflere publicas clades intuenti domestica mala. Itaque illa omittam, haec referam; nam etiam si †sormea† graece
nescit, ego scio: γγιον γόνυ κνήμης. Iste quem videtis, per tot annos sub meo nomine latens, hanc mihi gratiam retulit, ut duas Iulias proneptes meas occideret, alteram ferro, alteram fame; unum abnepotem L. Silanum: videris, Iuppiter, an in causa mala – certe in tua, si aequos futurus es. Dic mihi, dive Claudi: quare quemquam ex his, quos quasque occidisti, antequam de causa cognosceres, antequam audires, damnasti? Hoc ubi fieri solet? In caelo non fit. 11. Ecce Iuppiter, qui tot annos regnat, uni Volcano crus fregit, quem ῥῖψε ποδὸς τεταγὼν ἀπὸ βελοῦ θεσπεσίοιο, et iratus fuit uxori et suspendit illam: numquid occidit? Tu Messalinam, cuius aeque avunculus maior eram quam tuus, occidisti. «Nescio» inquis? Di tibi malefaciant: adeo istuc turpius est quod nescisti quam quod occidisti. C. Caesarem non desiit mortuum persequi. Occiderat ille socerum: hic et generum. Gaius Crassi filium vetuit Magnum vocari: hic nomen illi reddidit, caput tulit. Occidit in una domo Crassum, Magnum, Scriboniam [tristionias], ‹non› Assar‹aci nat›ionem, nobiles tamen, Crassum vero tam fatuum ut etiam regnare posset. Hunc nunc deum facere vultis? Videte corpus eius dis iratis natum. Ad summam, tria verba cito dicat et servum me ducat. Hunc deum quis colet? Quis credet? Dum tales deos facitis, nemo vos deos esse credet. Summa rei, p.c., si honeste inter vos gessi, si nulli clarius respondi, vindicate iniurias meas. Ego pro sententia mea hoc censeo» (atque ita ex tabella recitavit): «Quandoquidem divus Claudius occidit socerum suum Appium Silanum, generos duos Magnum Pompeium et L. Silanum, socerum filiae suae Crassum Frugi, hominem tam similem sibi quam ovo ovum, Scriboniam socrum filiae suae, uxorem suam Messalinam et ceteros quorum numerus iniri non potuit, placet mihi in eum severe animadverti nec illi rerum iudicandarum vacationem dari eumque quam primum exportari et caelo intra triginta dies excedere, Olympo intra diem tertium». Pedibus in hanc sententiam itum est. Nec mora, Cyllenius illum collo obtorto trahit ad inferos a caelo unde negant redire quemquam. 12. Dum descendunt per viam Sacram interrogat Mercurius quid sibi velit ille concursus hominum, num Claudii funus esset. Et erat omnium formosissimum et impensa cura, plane ut scires deum efferri: tubicinum, cornicinum, omnis generis aenatorum tanta turba, tantus conventus, ut etiam Claudius audire posset. Omnes laeti, hilares: populus Romanus ambulabat tamquam liber. Agatho et pauci causidici plorabant, sed plane ex animo. Iurisconsulti e tenebris procedebant, pallidi, graciles, vix animam habentes, tamquam qui tum maxime reviviscerent. Ex his unus, cum vidisset capita conferentes et fortunas suas deplorantes causidicos, accedit et ait: «Dicebam vobis: non semper Saturnalia erunt». Claudius, ut vidit funus suum, intellexit se mortuum esse. Ingenti enim μεγάλωι χορικῶι nenia cantabatur anapaestis: Fundite fletus, edite planctus,
resonet tristi clamore forum: cecidit pulchre cordatus homo, quo non alius fuit in toto fortior orbe. Ille citato vincere cursu poterat celeris, ille rebelles fundere Parthos levibusque sequi Persida telis, certaque manu tendere nervum, qui praecipites vulnere parvo figeret hostes pictaque Medi terga fugacis, ille Britannos ultra noti litora ponti et caeruleos scuta Brigantas dare Romuleis colla catenis iussit et ipsum nova Romanae iura securis tremere Oceanum. Deflete virum, quo non alius potuit citius discere causas, una tantum parte audita, saepe neutra. Quis nunc iudex toto lites audiet anno? Tibi iam cedet sede relicta qui dat populo iura silenti, Cretaea tenens oppida centum. Caedite maestis pectora palmis o causidici, venale genus, vosque poetae lugete novi, vosque in primis qui concusso magna parastis lucra fritillo. 13. Delectabatur laudibus suis Claudius et cupiebat diutius spectare. Inicit illi manum Talthybius deorum nuntius et trahit capite obvoluto, ne quis eum possit agnoscere, per campum Martium, et inter Tiberim et viam Tectam descendit ad inferos. Antecesserat iam compendiaria Narcissus libertus ad patronum excipiendum, et venienti nitidus, ut erat a balineo, occurrit et ait: «Quid di ad homines?» «Celerius» inquit Mercurius «et venire nos nuntia». Dicto citius Narcissus evolat. Omnia proclivia sunt, facile descenditur. Itaque quamvis podagricus esset, momento temporis pervenit ad ianuam Ditis, ubi iacebat Cerberus vel, ut ait Horatius, «belua centiceps». Pusillum perturbatur (subalbam canem in deliciis habere adsueverat) ut illum vidit canem nigrum, villosum, sane non quem velis tibi in tenebris occurrere, et magna voce «Claudius» inquit «veniet». Cum plausu
procedunt cantantes «Ε ρήκαμεν σθγχαίρωμεν». Hic erat C. Silius consul designatus, Iuncus praetorius, Sex. Traulus, M. Helvius, Trogus, Cotta, Vettius Valens, Fabius, equites R. Quos Narcissus duci iusserat. Medius erat in hac cantantium turba Mnester pantomimus, quem Claudius decoris causa minorem fecerat ad Messalinam. Cito rumor percrebuit Claudium venisse. Convolant primi omnium liberti Polybius, Myron, Arpocras, Ampheus, Pheronaotus, quos Claudius omnes, necubi imparatus esset, praemiserat. Deinde praefecti duo Iustus Catonius et Rufrius Pollio. Deinde amici Saturninus Lusius et Pedo Pompeius et Lupus et Celer Asinius consulares. Novissime fratris filia, sororis filia, generi, soceri, socrus, omnes plane consanguinei. Et agmine facto Claudio occurrunt. Quos cum vidisset Claudius, exclamat «Πάντα φίλων πλήρη! quomodo huc venistis vos?». Tum Pedo Pompeius «Quid dicis, homo crudelissime? Quaeris quomodo? Quis enim nos alius huc misit quam tu, omnium amicorum interfector? In ius eamus: ego tibi hic sellas ostendam». 14. Ducit illum ad tribunal Aeaci (is lege Cornelia, quae de sicariis lata est, quaerebat). Postulat, nomen eius recipiat; edit subscriptionem: occisos senatores XXXV, equites R. CCXXI, ceteros σα ψάμαθός τε κόνις τε. Advocatum non invenit. Tandem procedit P. Petronius, vetus convictor eius, homo Claudiana lingua disertus, et postulat advocationem. Non datur. Accusat Pedo Pompeius magnis clamoribus. Incipit patronus velle respondere. Aeacus, homo iustissimus, vetat et illum, altera tantum parte audita, condemnat et ait: αἴκε πάθοις τὰ ἔρεξας δίκη εὐθεῖα γένοιτο. Ingens silentium factum est. Stupebant omnes novitate rei attoniti, negabant hoc umquam factum. Claudio magis iniquum videbatur quam novum. De genere poenae diu disputatum est, quid illum pati oporteret. Erant qui dicerent, Sisyphum diu laturam fecissent, Tantalum siti periturum nisi illi succurreretur, aliquando Ixionis miseri rotam sufflaminandam. Non placuit ulli ex veteribus missionem dari, ne vel Claudius umquam simile speraret. Placuit novam poenam constitui debere, excogitandum illi laborem irritum et alicuius spem sine effectu. Tum Aeacus iubet illum alea ludere pertuso fritillo. Et iam coeperat fugientes semper tesseras quaerere et nihil proficere: 15. Nam quotiens missurus erat resonante fritillo utraque subducto fugiebat tessera fundo; cumque recollectos auderet mittere talos, lusuro similis semper semperque petenti, decepere fidem: refugit digitosque per ipsos fallax adsiduo dilabitur alea furto. Sic cum iam summi tanguntur culmina montis, inrita Sisyphio volvuntur pondera collo. Apparuit subito C. Caesar et petere illum in servitutem coepit. Producit testes, qui illum viderant ab illo flagris, ferulis, colaphis vapulantem.
Adiudicatur. C. Caesari illum Aeacus donat. Is Menandro liberto suo tradidit, ut a cognitionibus esset.
Apocolocintosi
Premessa Questo breve componimento è molto simile alla satira menippea, così chiamata dalle opere (non pervenuteci) del filosofo cinico Menippo di Gadara (III secolo a.C.), caratterizzate dall’alternarsi di prosa e versi (prosimetrum) e dallo stile fra il comico e il serio (spudaiogeloion), che diedero origine a un nuovo genere letterario. Oltre a queste caratteristiche tale componimento presentava una struttura narrativa a tre piani in cui l’azione si svolgeva agli Inferi, sulla Terra e sull’Olimpo, dalla cui sommità si potevano contemplare con distacco le vicende del mondo. Vi si trovavano inoltre vocaboli stranieri e ambientazioni fantastiche o grottesche: il tutto ne faceva una parodia letteraria non priva di un certo realismo popolaresco. Il titolo, Apocolocintosi, ricalca ironicamente la parola greca apotheosis («trasformazione in dio») e significa trasformazione in zucca o «zucchificazione» (dove theos, dio, è sostituito da kolokynthe, «zucca»). Ma nel testo non si parla di zucche e d’altra parte più che di «trasformazione in zucca» (il titolo non si dice di chi) si tratta di «deificazione di una zucca», nel senso di “zuccone”, dunque «deificazione di quello zuccone di Claudio». I titoli latini dicono Ludus de morte Claudii, o Divi Claudii apotheosis per saturam. Tacito negli Annali (XIII 3) scrive che Seneca aveva composto una laudatio funebris dell’imperatore, pronunciata da Nerone, ma successivamente Seneca, ch’era stato condannato all’esilio da Claudio, sfogò contro di lui il suo risentimento scrivendo appunto (sembra nel 54) l’Apocolocintosi. L’opera, dunque, è una caricatura della apoteosi di Claudio appena morto. Dopo avere ironizzato sulla dichiarazione di chi, dopo la morte di un imperatore, sosteneva di averlo visto salire in cielo – una prova necessaria per poterne effettuare la divinizzazione e così appunto avvenne alla morte di Claudio – Seneca introduce la scena delle Parche che recidono lo stame della vita dell’imperatore e prendono a filarne uno lunghissimo per Nerone, il suo successore. Dopodiché la scena si sposta sull’Olimpo, dove Giove e gli altri dèi non solo non riescono a capire quel che Claudio dice, ma dubitano persino ch’egli sia un essere umano. Per fortuna interviene la Febbre (l’unica che l’ha accompagnato lassù), la quale si fa garante dell’identità di Claudio. Ma gli dèi sono perplessi, non sapendo che razza di dio egli possa diventare: epicureo, no, perché non ha problemi, né li crea; stoico neppure, perché dovrebbe essere di forma sferica. Per di più si è macchiato d’incesto e di una serie innumerevole di omicidi, persino di suoi parenti. Giano non ammette alcuna divinizzazione per nessun essere mortale, Diespiter propone che Claudio venga fatto dio come Romolo, mentre Augusto, da parte sua, si oppone decisamente, denunciando le numerose condanne a morte fatte eseguire da Claudio senza neppure uno straccio di processo, e chiede che Claudio venga immediatamente cacciato dal cielo. La proposta è accolta. A questo punto la scena si sposta sulla terra, dove Claudio, nella sua discesa agl’Inferi, s’imbatte nel proprio funerale. Tutti sono contenti della sua morte, perché hanno riacquistato la libertà, tranne gli avvocati corrotti che sotto di lui avevano fatto fortuna. Agl’Inferi Claudio trova il suo liberto Narciso e tutti quelli che aveva mandato a morte, i quali lo trascinano davanti a Eaco, giudice infernale. Costui, senza dargli la possibilità di difendersi o di essere difeso (come del resto lui non l’aveva data a coloro che aveva fatto uccidere), lo condanna a un supplizio ridicolo e vano, quello, cioè, di giocare ai dadi con un bossolo privo di fondo. M. S. A.
1. È mia intenzione tramandare ai posteri i fatti che si svolsero nei cieli il tredici di ottobre di quest’anno straordinario, il primo di un’età beatissima. In questo resoconto non troveranno posto né insolenze né simpatie di sorta. Se
qualcuno mi chiederà come faccio a conoscere con tanta precisione tali fatti, prima di tutto non risponderò, se non mi garba. E chi mi può costringere? Io sono un uomo libero, ormai, da quando se ne andò colui che aveva convalidato il proverbio che dice: «Si nasce re o cretini». Se, al contrario, mi garberà di rispondere, allora ciò che alle labbra mi verrà dirò: chi infatti ha mai preteso da uno storico dei testimoni oculari? Del resto se volete conoscere la fonte chiedetelo a chi vide un dì Drusilla salire al cielo: quello vi dirà di aver visto anche Claudio a passi dispari andar per quella strada. Che lo voglia oppure no, deve vedere tutto quel che succede in cielo: sovrintende alla via Appia, che presero, lo sai, anche Tiberio Cesare e Augusto per andar fra gli dèi. Se glielo chiedi a quattr’occhi te lo confermerà: davanti a più persone non si lascia cavare una parola, e ciò perché dal giorno in cui in senato giurò di aver visto Drusilla andare in cielo – e tuttavia, di fronte a una notizia così bella nessuno volle credergli – con parole solenni dichiarò che non avrebbe raccontato nulla, manco se avesse visto in mezzo al foro far fuori un uomo. Quel che seppi da lui qui ve lo dico papale papale. Che lieto egli mi stia, prospero e sano. 2. Con più breve cammino aveva Febo affrettato il suo corso e delle tenebre l’ore il sonno allungavano e il riposo, e Cinzia già, vittoriosa, vedeva più vasto il regno suo; l’inverno squallido strappava i lieti doni dell’autunno e da Bacco, già presso al suo tramonto, coglieva i frutti il tardo agricoltore. Forse è meglio che dica: Era d’ottobre, il tredici del mese. Non so dirti con precisione l’ora: è assai più facile che si trovino d’accordo due filosofi che non due orologi; a ogni modo si era fra l’ora settima e la sesta. «Te la cavi così? Tutti i poeti non sarebbero paghi di descrivere la levata e il tramonto, addirittura scomoderebbero anche il mezzogiorno, e tu glissi su un’ora tanto bella?». Già col suo carro Febo aveva corso la sua strada a metà, verso la notte, agitando sfinito le sue briglie lungo il sentiero obliquo, ormai volgendo al tramonto la luce declinante. 3. Claudio cercò di mandar fuori l’anima, ma non riusciva a trovare l’uscita. Mercurio, allora, che sempre godeva dell’ingegno sottile di quell’uomo, chiama in disparte una delle Parche e le dice: «Perché, donna crudele, lasci quel disgraziato nelle pene dell’agonia? Non avrà mai riposo costui da queste lunghe sofferenze? Sono oramai sessantaquattro anni che va lottando con il suo respiro: perché vuoi male a lui e al suo popolo? Lascia che almeno una volta gli astrologi dicano il vero: non passa mai anno, non passa mese che non lo spediscano
all’altro mondo. Non c’è da stupirsi, d’altra parte, se non si raccapezzano e nessuno conosce la sua ora, quando tutti credevano che mai egli non fosse nato. A ogni modo, fa’ quel che devi: affidalo alla morte e che al suo posto regni uno migliore». Ma Cloto: «E dire ch’io volevo aggiungergli ancora un po’ di tempo, affinché desse a quei tre o quattro la cittadinanza: sono gli ultimi, ormai. S’era proposto, infatti, di vedere tutti in toga: Greci, Galli, Britanni, Ispani. Ma, se deve rimaner qualche straniero, perché non se ne perda il seme, e tu desideri così, sia pure». Allora apre una cassettina e tira fuori tre fusi: uno di Baba, uno di Claudio e uno di Augurino. «Questi tre», sentenzia Cloto, «li farò morire nello spazio di un anno, così Claudio non resterà senza compagni. È brutto che chi prima vedeva tanta gente al suo seguito e tanta per staffetta, e tanta ai lati, si trovi a un tratto abbandonato da tutti. Per ora gli basteranno questi tre». 4. Così disse e avvolgendo intorno al fuso i suoi stami troncò d’un tratto il corso della stolta esistenza di quel principe. Lachesi intanto, il capo incoronato e con le chiome adorne, un pierio lauro intorno al crine e alla fronte cingendo, deduce fili candidi da fiocchi simili a neve, con mano sicura avvolgendoli, e quelli via via prendono nuovo colore. Le sorelle ammirano, mentre la rozza lana si tramuta in prezioso metallo, sì che secoli d’oro in fulgido stame ne discendano. Non han riposo: il ricco vello filano liete al vederne ricolme le mani: tanto è dolce il lavoro. Alacre l’opera volge da sé; senza alcuna fatica molli stami si allungano dal fuso oltrepassando gli anni di Titòne e di Nestore. Febo col suo canto le asseconda e gioisce dei presagi, muovendo il plettro o porgendo la lana, e avvincendo col canto le sorelle dimentiche, per lui, della fatica. Mentre alla cetra e al canto del fratello indugiano le lodi, più del solito filan le mani, e i fati mortali il lavoro mirabile trascende. «Parche, non recidete!», esorta Febo.
«D’ogni vita mortal superi il corso colui che mi somiglia nell’aspetto e nella cetra e nel canto non cede. Ai tristi ridarà gli anni beati e romperà il silenzio delle leggi. Quale sperde Lucifero la luce delle stelle cadenti, quale Espero sorge, annunciando il ritorno degli astri, quale al primo svanire delle tenebre la rossa Aurora diffonde la luce e il sol saluta fulgido la terra spingendo il carro fuori dal cancello, tale Cesare appare: fra non molto Roma saluterà Nerone. Mite chiaror di luce raggia dal suo volto e dal suo collo lungo il quale scendono i bei capelli come un ornamento». Così Apollo; e Lachesi, propizia verso un uomo così bello, l’accontenta, elargendo generosamente a Nerone molti anni ancora. Claudio, invece, tutte gridano di spedirlo fuori da casa con saluti e baci. E difatti spirò. Da quel momento in poi Claudio cessò di parer vivo. Spirò mentre assisteva a una commedia: tanto perché tu sappia che a ragione mi guardo dagli attori. L’espressione ultima che di lui si udì nel mondo, dopo ch’emise un suono ancor più forte da quella parte con cui si esprimeva più facilmente, fu: «Povero me, me la son fatta addosso!». Ora, io non so se lui l’avesse fatta veramente, ma certo ha insudiciato dappertutto. 5. Quel che successe dopo sulla terra è superfluo narrarlo: lo sapete e non c’è rischio che esca di mente ciò che il gaudio del popolo ha segnato nella memoria: nessuno dimentica la sua felicità. Sentite, invece, quello che accadde in cielo: la conferma la troverete nella mia fonte. Viene annunciato a Giove un nuovo arrivo: un personaggio di media statura mezzo imbiancato e male intenzionato, visto che dondolava continuamente la testa e strascicava il piede destro. Alla domanda da dove venisse aveva borbottato qualche cosa con suoni incerti e inarticolati, ma nessuno capiva la sua lingua: non era infatti greco, né romano, né di un altro paese conosciuto. Allora il sommo Giove disse a Ercole, che per aver girato in lungo e in largo il mondo conosceva tutti i popoli, di andar lui a cercare di scoprire di quale razza fosse. Ercole, appena l’ebbe davanti ne provò sgomento, inquantoché ormai era convinto di non aver più nulla a che fare con i mostri, sicché come vide quel brutto ceffo insolito, quel modo di camminare strano, quella voce che non era di un essere terrestre, ma come quella dei mostri marini, cavernosa e impacciata, ebbe il timore di dover affrontare una
tredicesima fatica. Ma guardandolo poi più attentamente vide che aveva una parvenza d’uomo e a quel punto gli si avvicinò e in lingua greca, cosa molto facile per un greculo: «Chi sei? Da dove vieni?», gli domandò. «Dove sono a te patria e famiglia?». A Claudio allora gli si allarga il cuore, nel vedere colà dei classicisti, e così spera d’esser bene accolto per le sue storie. E per significare, con un bel verso omerico anche lui, d’essere Cesare, in greculo risponde: «L’aure da Troia ai Cìconi m’han spinto, trasportandomi qui». Sarebbe stato però più vero e pur non meno omerico, quest’altro verso: «La città per me là fu distrutta e perduta coi suoi». 6. Ercole, niente affatto malizioso, l’avrebbe anche bevuta, se non fosse che là c’era la Febbre, che, venuta insieme a lui, aveva abbandonato il proprio tempio: tutti gli altri dèi erano rimasti a Roma. «Costui», disse, «frottole belle e buone ti racconta. Io te lo dico perché son vissuta tanti anni con lui: è di Lione, concittadino di Planco. Ripeto, a sedici miglia da Vienna egli è nato, ed è un Gallo di razza. E da buon Gallo, s’impadronì di Roma. Ti assicuro ch’egli è nato a Lione, proprio dove regnò tanti anni Licino. Ora, tu che hai camminato più d’un mulattiere di professione, devi ben conoscere la gente di Lione e ben sapere che dallo Xanto al Rodano ci corrono molte miglia». A quel punto Claudio piglia fuoco e si sfoga facendo un gran chiasso. Che dicesse nessuno lo capiva; ma intanto lui voleva che mettessero la Febbre a morte, con quel gesto tremulo della mano che stava ferma solo quando ordinava di tagliare la testa della gente. Ma come diede l’ordine di mozzare il capo della Febbre nessuno se lo filava, come se lì fossero tutti suoi liberti. 7. «Sentimi bene», disse allora Ercole, «e smettila di smaniare. Tu qui sei in un paese dove i topi rosicchiano il ferro. Presto, sputa la verità, se non vuoi ch’io ti faccia svaporare codeste frenesie». Quindi, per mettergli più paura, assunta una posa tragica, gli fa: «Dimmi, su, presto, da dove tu vieni? Bada che questa clava non ti uccida: già molti re crudeli ha giustiziato. Ma che razza di suono emetti adesso con questa voce strana? Quale patria, quale famiglia, dimmi, generarono questo tuo capo tremulo? Racconta! Io, recandomi ai regni di Gerione, triplice re, d’onde dal mare esperio trassi il nobile armento alla città d’Inaco, vidi una rupe che incombe sopra due fiumi e che Febo contempla
al suo levarsi mattutino, dove il Rodano imponente col suo corso vorticoso fluisce e dove l’Arar con l’acque sue volubili e incerte bagna le rive tacito. Di’, forse quella terra è nutrice del tuo spirito?». Così disse con impeto e vigore, ma non era tranquillo e si aspettava da lui un colpo di follia. Ma Claudio, vedendosi davanti quel colosso, messe da parte le ciance, capì che se a Roma nessuno gli era pari, lì la faccenda era diversa e lui non aveva alcun potere: un gallo è re solo nella sua stalla. Onde per cui, per quel che si poté capire, sembra che dicesse così: «Speravo in te, Ercole, il più potente fra gli dèi, certo che avresti preso le mie parti al cospetto degli altri, e se mi avessero chiesto un garante avrei fatto il tuo nome, visto che mi conosci più degli altri. Se frughi bene nella tua memoria ricorderai che io sono quel desso che a Tivoli davanti al tempio tuo per giorni interi nei mesi di luglio e di agosto amministravo la giustizia, e lo sai bene tu quante noie ho dovuto sopportare a sentir quei causidici di giorno e di notte: ci fossi stato tu, per quanto bravo, avresti preferito pulir le stalle d’Augia: ho ramazzato più letame di te. Ma poiché voglio * * *». 8. «* * * Nulla di strano se hai fatto irruzione nella curia: per te non ci son sbarre che tengano. Ma dicci quale dio vuoi che facciamo di costui. Un dio epicureo non si può: quello lì non ha problemi e non ne dà. Stoico? E come può essere “rotondo”, come dice Varrone, “senza testa né prepuzio”? Anzi, ora che ci penso, qualcosa del dio stoico ce l’ha: non ha né cuore né cervello. Caspita, anche se avesse chiesto al dio Saturno questo favore, lui che festeggiava tutto l’anno da principe il suo mese, non l’avrebbe ottenuto; tanto meno da Giove che, per quanto stava in lui, dichiarò reo di incesto. Fece uccidere giustappunto suo genero, Silano, perché a una delle sue sorelle, la più bella di tutte le ragazze, che chiamavano Venere, affibbiò il nome di Giunone. “Perché”, disse, “domando, proprio sua sorella?” Studia, ignorante: se ad Atene è lecito la metà, ad Alessandria lo è tutto. “Siccome a Roma”, disse, “i topi sono contenti di leccar le macine”, costui pretende di venire qui a farci da maestro. Ignora quello che accade nel suo letto e “ficca gli occhi negli spazi celesti”? Ora pretende di diventare un dio! Ma non gli basta di avere un tempio in Britannia, che i barbari lo vezzeggino e come un dio lo preghino “di aver propizio un folle”?». 9. Alla fine Giove si risovvenne che neppure agli dèi è concesso far proposte finché dentro la Curia sono presenti persone estranee: «Io, Padri Coscritti», disse, «vi avevo dato facoltà d’intervenire e voi mi avete fatto un gran casino. Voglio che osserviate le leggi della Curia. Questo qui, chiunque egli sia, quale idea potrà farsi di noi?». Fattolo uscire, fu primamente richiesto il parere al padre Giano, designato console – ma solo al pomeriggio – alle calende di luglio,
uomo sagace quanto vuoi, che guarda “insieme davanti e di dietro”. Dato che vive nel foro, egli parlò lungamente e con foga, tanto che lo stenografo non riusciva a stargli dietro, onde per cui non posso riportar le sue parole, per non doverle poi parafrasare. Disse della grandezza degli dèi; che non s’ha da conceder questo onore a chicchessia. «Una volta», concluse, «era gran cosa diventare un dio; or se n’è fatto il mimo della Fama. Dunque, affinché il mio verdetto non sembri emesso più su un fatto personale che non su una questione di principio, propongo che da oggi in poi nessuno venga divinizzato fra coloro che “mangiano i prodotti della terra”, o che “la terra prodiga di messi alimenta”. Chiunque, in violazione di quanto qui deliberato, venga divinizzato e dipinto o scolpito in effigie divina, sia consegnato ai fantasmi e nel prossimo spettacolo di gladiatori venga frustato a sangue con i nuovi arruolati». La parola passa ora a Dièspiter, il figlio di Vica Pota, designato anch’egli console. Piccolo cambiavalute, si sosteneva con questo mestiere vendendo cittadinanze alle città di poco conto. Con bel garbo Ercole gli si accostò toccandogli l’orecchio. Quello allora avanzò questa proposta: «Visto che il divo Claudio ha legami di sangue anche col divo Augusto, nonché con la sua nonna diva Augusta, da lui divinizzata; considerato che supera tutti i mortali per la sua saggezza e che infine è di pubblico interesse il fatto che qualcuno nello Stato insieme con Romolo “mangi rape bollenti”, propongo che da oggi il divo Claudio venga divinizzato, come prima lo sono stati a buon diritto altri, e che questa delibera ipso facto venga inserita nelle Metamorfosi di Ovidio». I pareri non erano concordi, ma Claudio stravinceva, in quanto Ercole, vedendo che il suo ferro era sul fuoco, correva ora di qua, ora di là, dicendo: «Non negatemi il favore: per me è una questione personale. Se un’altra volta avrete mai bisogno di qualche cosa, vi ricambierò: una mano, si sa, lava quell’altra». 10. Quindi a parlare si levò il divo Augusto, il quale svolse con sovrana eloquenza il suo discorso, esordendo così: «Padri Coscritti, mi siete testimoni che da quando sono stato eletto dio non ho più detto una parola, ma ho badato sempre ai fatti miei. Ora, però, non posso continuare a far conto di niente, reprimendo il dolor che la vergogna rende ancora più grave. È per questo che assicurai la pace sulla terra e sui mari? Per questo soffocai le discordie civili? A tale scopo “con le leggi ho fondato la Città”, l’ho abbellita di opere… Che dire, Padri Coscritti? Ogni parola è poco per il mio sdegno: devo far ricorso alla celebre frase di Messala Corvino, uomo d’alta eloquenza: “Io mi vergogno del potere”. Costui, Padri Coscritti, che a voi sembra incapace di dar noia a una mosca, ammazzava la gente con la spregiudicatezza con cui un cane divora una trippa. Ma a che pro ricordare tante vittime famose? Non mi resta il tempo di pianger le sventure della patria se guardo ai lutti della mia famiglia. Lascerò dunque da parte le prime e parlerò degli altri; perché, anche se [mia sorella] il greco non lo sa, io lo so. […].Costui, che voi vedete, dopo essere stato per tanti anni all’ombra del mio nome, mi ripaga uccidendo due Giulie, mie nipoti, una
col ferro, l’altra con la fame, e poi anche un mio pronipote, Silano: giudica Giove tu se quella causa era buona o cattiva, certamente, a essere giusti, era la tua. Or dimmi, divo Claudio, perché quelle persone che hai messo a morte le hai condannate senza uno straccio di processo, senza sentirne le ragioni? Dove mai s’usa così? In cielo no di certo. 11. Guarda il caso di Giove che governa da tanti secoli: solo a Vulcano ruppe una gamba quando gli afferrò uno dei piedi e lo scaraventò oltre le soglie divine. Arrabbiatosi poi con sua moglie, la sollevò da terra. Ma che forse li ammazzò? Tu invece Messalina l’accoppasti, eppure il suo prozio era più nobile del tuo. “Non ne sapevo nulla”, dici. Stramaledetto sia tu: peggio ancora, se non sapevi, che averla ammazzata. Cesare gli fu sempre sullo stomaco, persino dopo morto. Quello aveva ammazzato suo suocero? Ma lui fece fuori anche il genero. E se Cesare non consentì che il rampollo di Crasso fosse chiamato Magno, ebbene, lui gli rese il nome e gli tolse la vita. E così, dentro un’unica famiglia eliminò Scribonia, Magno e Crasso, ch’eran pur sempre nobili. E poi Crasso, per quanto fosse sciocco, avrebbe anche potuto governare. E di costui volete farne un dio? Guardate il suo corpo, se non è maledetto dagli dèi. Basta: che dica solo tre parole di seguito e mi lascio portar via come uno schiavo. Un dio come costui chi lo venererà, con che fiducia? Finché farete dèi gente del genere nessuno crederà che siate dèi. Padri Coscritti, per non farla lunga: se mi son comportato rettamente fra tutti voi, se ho dato mai responsi rigorosi ad alcuno, allontanate da me codesto affronto. Il mio verdetto, secondo le ragioni addotte, è questo». E così lesse da una tavoletta: «Visto che il divo Claudio ha ucciso il suocero Appio Silano, Silano e Pompeo, generi entrambi, e Crasso, uomo dabbene, suocero di sua figlia, simile a Claudio come due gocce d’acqua, e poi Scribonia, suocera di sua figlia, Messalina, la sua consorte e tutti quanti gli altri che manco non si possono contare, chiedo che si proceda duramente contro di lui senza giudizio alcuno, che sia sbattuto fuori quanto prima: fuori dai cieli entro trenta giorni, e dall’Olimpo nel giro di tre». Il caso fu risolto così. Senza esitare il Cillenio lo afferra per il collo e, pur contro sua voglia, lo trascina all’inferno, “donde si dice che mai ritorni alcùn”. 12. Mentre scendono giù per la via Sacra, Mercurio chiede cosa significhi tutta quella massa di gente: che sia il funerale di Claudio? Era il più lussuoso che mai si fosse visto, e poi curato fin nei minimi dettagli: era evidente ch’era quello di un dio, tale lo stuolo di corni, flautisti e d’ogni genere di strumenti, e il frastuono così forte che persino Claudio avrebbe potuto sentirlo. Che festa! Tutti felici e contenti. Il popolo romano andava avanti e indietro, indietro e avanti come chi fosse libero. Agatone e pochi causidici piangevano, ma di cuore, lo si vedeva bene. Dalle loro prigioni i legulei avanzavano, pallidi, emaciati, con solamente un filo di respiro, come resuscitati. Uno di questi, vedendo tutti gli
altri azzeccagarbugli riuniti a conciliabolo che piangevano la loro sorte, si accostò gridando: «Ve lo dicevo io che non sarebbe stata sempre festa!». Claudio, vedendo il proprio funerale, capì d’essere morto, anche perché un grande coro solenne intonava un inno funebre in versi anapesti: Piangete tutti, squassate i petti; di tristi grida risuoni il Foro: è morto un uomo di grande ingegno, uno non ebbe il mondo intero di lui più prode. Snello e veloce vinceva in corsa i più veloci; i Parti indocili volgeva in fuga; tirando l’arco con salda mano, scagliava i dardi dietro al Persiano, pronto a trafiggere con lieve colpo i fuggitivi, e ai Medi in rotta le tinte spalle. Egli ai Britanni di là dai lidi del noto mare, e ai Briganti con scudi azzurri fece piegare il collo al giogo di Roma. E pure tremò l’Oceano sotto la scure delle sue leggi. Piangete il grande, prima del quale nessuno ardiva gestir le cause con una sola
delle due parti, o con nessuna. Ora che giudice per tutto un anno udrà i processi? A te già lascia il proprio seggio quegli che giudica nei regni taciti, signor di cento città cretesi. Battete il petto con meste palme, o causidici, razza venale: e voi piangete, vati alla moda, e voi per primi, che raccoglieste grossi guadagni gettando i dadi. 13. Claudio si compiaceva delle lodi a lui rivolte e voleva restare ancora lì a godersi lo spettacolo. Ma il messaggero degli dèi, Taltibio, l’afferra a una spalla e lo trascina con il capo coperto, per sottrarlo alla vista, attraverso il Campo Marzio, e fra la via Coperta e il fiume Tevere agl’Inferi discende. Innanzi a lui per una scorciatoia era già corso il liberto Narciso per ricevere il suo padrone, e come vede il dio gli si fa incontro lindo lindo, uscito proprio allora dal bagno e: «Che ci fanno», chiede, «gli dèi fra gli uomini?». «Fa’ presto», lo interrompe Mercurio, «e va’ di corsa ad annunciare il nostro arrivo». Quello in men che non si dica corre giù. La strada è tutta in discesa, si va ch’è un gran piacere, talché in un momento, con tutta la sua gotta, il divo Claudio fu alla porta di Dite, dove Cerbero, ossia “la fiera dalle cento teste”, come lo chiama Orazio, se ne stava bellamente sdraiato. Per un attimo resta interdetto (aveva sempre avuto fra i suoi sollazzi un cagnolino bianco), per cui appena vede quel cagnaccio nero e peloso (non ti piacerebbe se te lo trovassi davanti al buio), a squarciagola grida: «Arriva Claudio!». Allora tutti gli altri fra gli applausi: «L’abbiamo ritrovato, orsù, suvvia, facciamogli la festa». C’erano Silio, console designato, Sesto Traulo, Giunio Pretorio, Marco Elvio Trogo, Cotta, Vezzio Valente, Fabio, tutti cavalieri romani che Narciso aveva fatto condurre al supplizio. In mezzo a quella folla che vociava c’era financo il pantomimo Mnestre, che Claudio, per renderlo più bello, aveva minorato. In un momento giunge la voce sino a Messalina ch’era arrivato Claudio: primi arrivano di gran carriera Polibio e Anfeo, Arpocrate,
Mirone e Feronatto, tutti liberti mandati da Claudio per non trovarsi solo ovunque fosse. Poi due prefetti, il figlio di Pompeo, Rufo Pollione, e Catonio, gli amici Saturnino, Pedone, Lupo, Asinio, personaggi di rango consolare. In ultimo la figlia del fratello, quella della sorella, e ancora generi, suoceri, insomma gli stretti parenti, che tutti in fila vanno incontro a Claudio, il quale nel vederli esclama: «Amici dappertutto! Come ci siete venuti?». E Pedone: «Ma cosa dici, mostro ripugnante? Dici come, in che modo? E ce lo chiedi? Chi altri ci ha mandato se non tu, l’assassino di tutti i tuoi amici? Presto, andiamo in giudizio: lo vedrai che tribunali ci sono quaggiù!». 14. E così lo trascina al tribunale d’Eaco, che teneva i suoi processi sull’omicidio in ossequio alle norme della legge Cornelia sui sicarii, gli dà il nome dell’imputato, inscrivendo la causa, e gli presenta il testo dell’accusa: Uccisi trentacinque senatori, duecentoventi cavalieri romani e altre duecentoventuno persone, “quanti sono i grani di polvere e di sabbia”. Non c’è un cane disposto alla difesa. Finalmente si fa avanti Petronio, un vecchio amico, esperto assai nella lingua di Claudio, il quale chiede tempo alla difesa. Non gli è concesso. Sostiene l’accusa Pompeo Pedone, che gridando sbraita. Il difensore vorrebbe rispondere, ma Eaco, uomo giusto, glielo vieta, e dopo aver sentito solamente la parte avversa condanna il colpevole. «S’abbia pan per focaccia, e questa sia giusta sentenza». A quel verdetto il pubblico trasecola di fronte alla stranezza di quella procedura inquantoché non si era mai seguito quel sistema. A Claudio più che una novità sembrava un’ingiustizia. Si discusse lungamente sul modo della pena, cioè come scontarla. Chi diceva che Sisifo oramai da troppi secoli faceva quella sfacchinata e Tantalo sarebbe morto di sete restando per tanto tempo senza un goccio d’acqua; che prima o poi bisognava frenare la ruota a quello sventurato d’Issìone. Ma non si volle mettere a riposo nessuno di quei tristi veterani, affinché Claudio non dovesse illudersi di avere un giorno un trattamento analogo. Doveva invece essere inventata una pena diversa, inusitata, una fatica vana, una speranza di qualcosa a lui caro senza fine e senza effetto: condannarlo al gioco vano dei dadi con un bussolotto tutto sfondato. E difatti eccolo lì che cerca vanamente di acchiappare i suoi dadi, che ogni volta gli sfuggono via inesorabilmente. 15. Ogni qual volta quello li gettava dal risonante bossolo, i due dadi gli sfuggivano, essendo aperto il fondo. E quando poi, raccoltili, tentava di rilanciarli ancora, rincorrendoli, la sua speranza era sempre delusa: di tra le dita gli sfuggono i dadi, scivolan via gli eterni traditori,
come quando, raggiunta ormai la cima della montagna, i massi, invano spinti, rirotolano giù dalla cervice di Sisifo. A un tratto sbucò fuori Gaio Cesare e prese a reclamarlo come servo, esibendo testimoni che lo avevano visto prender botte e frustate da lui. Donato a Cesare, questi, poi, ripensandoci, lo passa a Eaco, che a sua volta lo consegna al liberto Menandro, destinandolo alle necessità del tribunale.
De clementia
Prooemium 1. Scribere de clementia, Nero Caesar, institui, ut quodam modo speculi vice fungerer et te tibi ostenderem perventurum ad voluptatem maximam omnium. Quamvis enim recte factorum verus fructus sit fecisse nec ullum virtutum pretium dignum illis extra ipsas sit, iuvat inspicere et circumire bonam conscientiam, tum inmittere oculos in hanc inmensam multitudinem discordem, seditiosam, inpotentem, in perniciem alienam suamque pariter exultaturam, si hoc iugum fregerit, et ita loqui secum: «Egone ex omnibus mortalibus placui electusque sum, qui in terris deorum vice fungerer? Ego vitae necisque gentibus arbiter; qualem quisque sortem statumque habeat, in mea manu positum est; quid cuique mortalium fortuna datum velit, meo ore pronuntiat; ex nostro responso laetitiae causas populi urbesque concipiunt; nulla pars usquam nisi volente propitioque me floret; haec tot milia gladiorum, quae pax mea conprimit, ad nutum meum stringentur; quas nationes funditus excidi, quas transportari, quibus libertatem dari, quibus eripi, quos reges mancipia fieri quorumque capiti regium circumdari decus oporteat, quae ruant urbes, quae oriantur, mea iuris dictio est. In hac tanta facultate rerum non ira me ad iniqua supplicia conpulit, non iuvenilis inpetus, non temeritas hominum et contumacia, quae saepe tranquillissimis quoque pectoribus patientiam extorsit, non ipsa ostentandae per terrores potentiae dira, sed frequens magnis imperiis gloria. Conditum, immo constrictum apud me ferrum est, summa parsimonia etiam vilissimi sanguinis; nemo non, cui alia desunt, hominis nomine apud me gratiosus est. Severitatem abditam, at clementiam in procinctu habeo; sic me custodio, tamquam legibus, quas ex situ ac tenebris in lucem evocavi, rationem redditurus sim. Alterius aetate prima motus sum, alterius ultima; alium dignitati donavi, alium humilitati; quotiens nullam inveneram misericordiae causam, mihi peperci. Hodie dis inmortalibus, si a me rationem repetant, adnumerare genus humanum paratus sum». Potes hoc, Caesar, audacter praedicare omnia, quae in fidem tutelamque tuam venerunt, tuta haberi, nihil per te neque vi neque clam adimi rei publicae. Rarissimam laudem et nulli adhuc principum concessam concupisti innocentiam. Non perdit operam nec bonitas ista tua singularis ingratos aut malignos aestimatores nancta est. Refertur tibi gratia; nemo unus homo uni homini tam carus umquam fuit, quam tu populo Romano, magnum longumque eius bonum. Sed ingens tibi onus inposuisti; nemo iam divum Augustum nec Ti. Caesaris prima tempora loquitur nec, quod te imitari velit, exemplar extra te quaerit; principatus tuus ad gustum exigitur. Difficile hoc fuisset, si non naturalis tibi ista bonitas esset, sed ad tempus sumpta. Nemo enim potest personam diu ferre, ficta cito in
naturam suam recidunt; quibus veritas subest quaeque, ut ita dicam, ex solido enascuntur, tempore ipso in maius meliusque procedunt. Magnam adibat aleam populus Romanus, cum incertum esset, quo se ista tua nobilis indoles daret; iam vota publica in tuto sunt; nec enim periculum est, ne te subita tui capiat oblivio. Facit quidem avidos nimia felicitas, nec tam temperatae cupiditates sunt umquam, ut in eo, quod contigit, desinant; gradus a magnis ad maiora fit, et spes inprobissimas conplectuntur insperata adsecuti; omnibus tamen nunc civibus tuis et haec confessio exprimitur esse felices et illa nihil iam his accedere bonis posse, nisi ut perpetua sint. Multa illos cogunt ad hanc confessionem, qua nulla in homine tardior est: securitas alta, adfluens, ius supra omnem iniuriam positum; obversatur oculis laetissima forma rei publicae, cui ad summam libertatem nihil deest nisi pereundi licentia. Praecipue tamen aequalis ad maximos imosque pervenit clementiae tuae admiratio; cetera enim bona pro portione fortunae suae quisque sentit aut expectat maiora minoraque, ex clementia omnes idem sperant; nec est quisquam, cui tam valde innocentia sua placeat, ut non stare in conspectu clementiam paratam humanis erroribus gaudeat. 2. Esse autem aliquos scio, qui clementia pessimum quemque putent sustineri, quoniam nisi post crimen supervacua est et sola haec virtus inter innocentes cessat. Sed primum omnium, sicut medicinae apud aegros usus, etiam apud sanos honor est, ita clementiam, quamvis poena digni invocent, etiam innocentes colunt. Deinde habet haec in persona quoque innocentium locum, quia interim fortuna pro culpa est; nec innocentiae tantum clementia succurrit, sed saepe virtuti, quoniam quidem condicione temporum incidunt quaedam, quae possint laudata puniri. Adice, quod magna pars hominum est, quae reverti ad innocentiam possit, si Non tamen volgo ignoscere decet; nam ubi discrimen inter malos bonosque sublatum est, confusio sequitur et vitiorum eruptio; itaque adhibenda moderatio est, quae sanabilia ingenia distinguere a deploratis sciat. Nec promiscuam habere ac volgarem clementiam oportet nec abscisam; nam tam omnibus ignoscere crudelitas quam nulli. Modum tenere debemus; sed quia difficile est temperamentum, quidquid aequo plus futurum est, in partem humaniorem praeponderet. Sed haec suo melius loco dicentur. Nunc in tres partes omnem hanc materiam dividam. Prima erit humanissimi Neronis; secunda, quae naturam clementiae habitumque demonstret: nam cum sint vitia quaedam virtutes imitantia, non possunt secerni, nisi signa, quibus dinoscantur, inpresseris; tertio loco quaeremus, quomodo ad hanc virtutem perducatur animus, quomodo confirmet eam et usu suam faciat.
Pars prima 1. Ut de clementia scriberem, Nero Caesar, una me vox tua maxime conpulit, quam ego non sine admiratione et, cum diceretur, audisse memini et deinde aliis
narrasse, vocem generosam, magni animi, magnae lenitatis, quae non conposita nec alienis auribus data subito erupit et bonitatem tuam cum fortuna tua litigantem in medium adduxit. Animadversurus in latrones duos Burrus praefectus tuus, vir egregius et tibi principi natus, exigebat a te, scriberes, in quos et ex qua causa animadverti velles; hoc saepe dilatum ut aliquando fieret, instabat. Invitus invito cum chartam protulisset traderetque, exclamasti: «Vellem litteras nescirem!». O dignam vocem, quam audirent omnes gentes, quae Romanum imperium incolunt quaeque iuxta iacent dubiae libertatis quaeque se contra viribus aut animis adtollunt! O vocem in contionem omnium mortalium mittendam, in cuius verba principes regesque iurarent! O vocem publica generis humani innocentia dignam, cui redderetur antiquum illud saeculum! Nunc profecto consentire decebat ad aequum bonumque expulsa alieni cupidine, ex qua omne animi malum oritur, pietatem integritatemque cum fide ac modestia resurgere et vitia diuturno abusa regno dare tandem felici ac puro saeculo locum. 2. Futurum hoc, Caesar, ex magna parte sperare et confidere libet. Tradetur ista animi tui mansuetudo diffundeturque paulatim per omne imperii corpus, et cuncta in similitudinem tuam formabuntur. A capite bona valetudo: inde omnia vegeta sunt atque erecta aut languore demissa, prout animus eorum vivit aut marcet. Erunt cives, erunt socii digni hac bonitate, et in totum orbem recti mores revertentur; parcetur ubique manibus tuis. Diutius me morari hic patere, non ut blandum auribus tuis (nec enim hic mihi mos est; maluerim veris offendere quam placere adulando); quid ergo est? Praeter id, quod bene factis dictisque tuis quam familiarissimum esse te cupio, ut, quod nunc natura et inpetus est, fiat iudicium, illud mecum considero multas voces magnas, sed detestabiles, in vitam humanam pervenisse celebresque volgo ferri, ut illam: «oderint, dum metuant», quoi Graecus versus similis est, qui se mortuo terram misceri ignibus iubet, et alia huius notae. Ac nescio quomodo ingenia in inmani et invisa materia secundiore ore expresserunt sensus vehementes et concitatos; nullam adhuc vocem audii ex bono lenique animosam. Quid ergo est? Ut raro, invitus et cum magna cunctatione, ita aliquando scribas necesse est istud, quod tibi in odium litteras adduxit, sed, sicut facis, cum magna cunctatione, cum multis dilationibus.
Pars secunda 1. Et ne forte decipiat nos speciosum clementiae nomen aliquando et in contrarium abducat, videamus, quid sit clementia qualisque sit et quos fines habeat. Clementia est temperantia animi in potestate ulciscendi vel lenitas superioris adversus inferiorem in constituendis poenis. Plura proponere tutius est, ne una finitio parum rem conprehendat et, ut ita dicam, formula excidat; itaque dici potest et inclinatio animi ad lenitatem in poena exigenda. Illa finitio contradictiones inveniet, quamvis maxime ad verum accedat, si dixerimus
clementiam esse moderationem aliquid ex merita ac debita poena remittentem: reclamabitur nullam virtutem cuiquam minus debito facere. Atqui hoc omnes intellegunt clementiam esse, quae se flectit citra id, quod merito constitui posset. 2. Huic contrariam imperiti putant severitatem; sed nulla virtus virtuti contraria est. Quid ergo obponitur clementiae? Crudelitas, quae nihil aliud est quam atrocitas animi in exigendis poenis. «Sed quidam non exigunt poenas, crudeles tamen sunt, tamquam qui ignotos homines et obvios non in conpendium, sed occidendi causa occidunt nec interficere contenti saeviunt, ut Busiris ille et Procrustes et piratae, qui captos verberant et in ignem vivos inponunt». Haec crudelitas quidem; sed quia nec ultionem sequitur (non enim laesa est) nec peccato alicui irascitur (nullum enim antecessit crimen), extra finitionem nostram cadit; finitio enim continebat in poenis exigendis intemperantiam animi. Possumus dicere non esse hanc crudelitatem, sed feritatem, cui voluptati saevitia est; possumus insaniam vocare: nam varia sunt genera eius et nullum certius, quam quod in caedes hominum et lancinationes pervenit. Illos ergo crudeles vocabo, qui puniendi causam habent, modum non habent, sicut in Phalari, quem aiunt non quidem in homines innocentes, sed super humanum ac probabilem modum saevisse. Possumus effugere cavillationem et ita finire, ut sit crudelitas inclinatio animi ad asperiora. Hanc clementia repellit longe iussam stare a se; cum severitate illi convenit. Ad rem pertinet quaerere hoc loco, quid sit misericordia; plerique enim ut virtutem eam laudant et bonum hominem vocant misericordem. Et haec vitium animi est. Utraque circa severitatem circaque clementiam posita sunt, quae vitare debemus; per speciem enim severitatis in crudelitatem incidimus, per speciem clementiae in misericordiam. In hoc leviore periculo erratur, sed par error est a vero recedentium. 3. Ergo quemadmodum religio deos colit, superstitio violat, ita clementiam mansuetudinemque omnes boni viri praestabunt, misericordiam autem vitabunt; est enim vitium pusilli animi ad speciem alienorum ‹malorum› succidentis. Itaque pessimo cuique familiarissima est; anus et mulierculae sunt, quae lacrimis nocentissimorum moventur, quae, si liceret, carcerem effringerent. Misericordia non causam, sed fortunam spectat; clementia rationi accedit. Scio male audire apud inperitos sectam Stoicorum tamquam duram nimis et minime principibus regibusque bonum daturam consilium; obicitur illi, quod sapientem negat misereri, negat ignoscere. Haec, si per se ponantur, invisa sunt; videntur enim nullam relinquere spem humanis erroribus, sed omnia delicta ad poenam deducere. Quod si est, quidnam haec scientia, quae dediscere humanitatem iubet portumque adversus fortunam certissimum mutuo auxilio cludit? Sed nulla secta benignior leniorque est, nulla amantior hominum et communis boni adtentior, ut propositum sit usui esse et auxilio nec sibi tantum, sed universis singulisque consulere. Misericordia est aegritudo animi ob alienarum miseriarum speciem
aut tristitia ex alienis malis contracta, quae accidere inmerentibus credit; aegritudo autem in sapientem virum non cadit; serena eius mens est, nec quicquam incidere potest, quod illam obducat. Nihilque aeque hominem quam magnus animus decet; non potest autem magnus esse idem ac maestus. Maeror contundit mentes, abicit, contrahit; hoc sapienti ne in suis quidem accidet calamitatibus, sed omnem fortunae iram reverberabit et ante se franget; eandem semper faciem servabit, placidam, inconcussam, quod facere non posset, si tristitiam reciperet. 4. Adice, quod sapiens et providet et in expedito consilium habet; numquam autem liquidum sincerumque ex turbido venit. Tristitia inhabilis est ad dispiciendas res, utilia excogitanda, periculosa vitanda, aequa aestimanda; ergo non miseretur, quia id sine miseria animi non fit. Cetera omnia, quae, qui miserentur, volo facere, libens et altus animo faciet; succurret alienis lacrimis, non accedet; dabit manum naufrago, exuli hospitium, egenti stipem, non hanc contumeliosam, quam pars maior horum, qui misericordes videri volunt, abicit et fastidit, quos adiuvat, contingique ab iis timet, sed ut homo homini ex communi dabit; donabit lacrimis maternis filium et catenas solvi iubebit et ludo eximet et cadaver etiam noxium sepeliet, sed faciet ista tranquilla mente, voltu suo. Ergo non miserebitur sapiens, sed succurret, sed proderit, in commune auxilium natus ac bonum publicum, ex quo dabit cuique partem. Etiam ad calamitosos pro portione inprobandosque et emendandos bonitatem suam permittet; adflictis vero et forte laborantibus multo libentius subveniet. Quotiens poterit, fortunae intercedet; ubi enim opibus potius utetur aut viribus, quam ad restituenda, quae casus inpulit? Voltum quidem non deiciet nec animum ob crus alicuius aridum aut pannosam maciem et innixam baculo senectutem; ceterum omnibus dignis proderit et deorum more calamitosos propitius respiciet. Misericordia vicina est miseriae; habet enim aliquid trahitque ex ea. Inbecillos oculos esse scias, qui ad alienam lippitudinem et ipsi subfunduntur, tam mehercules quam morbum esse, non hilaritatem, semper adridere ridentibus et ad omnium oscitationem ipsum quoque os diducere; misericordia vitium est animorum nimis miseria paventium, quam si quis a sapiente exigit, prope est, ut lamentationem exigat et ‹in› alienis funeribus gemitus. 5. «At quare non ignoscet?» Agedum constituamus nunc quoque, quid sit venia, et sciemus dari illam a sapiente non debere. Venia est poenae meritae remissio. Hanc sapiens quare non debeat dare, reddunt rationem diutius, quibus hoc propositum est; ego ut breviter tamquam in alieno iudicio dicam: «Ei ignoscitur, qui puniri debuit; sapiens autem nihil facit, quod non debet, nihil praetermittit, quod debet; itaque poenam, quam exigere debet, non donat. Sed illud, quod ex venia consequi vis, honestiore tibi via tribuet; parcet enim sapiens, consulet et corriget; idem faciet, quod, si ignosceret, nec ignoscet, quoniam, qui ignoscit, fatetur aliquid se, quod fieri debuit, omisisse. Aliquem verbis tantum
admonebit, poena non adficiet aetatem eius emendabilem intuens; aliquem invidia criminis manifeste laborantem iubebit incolumem esse, quia deceptus est, quia per vinum labsus; hostes dimittet salvos, aliquando etiam laudatos, si honestis causis pro fide, pro foedere, pro libertate in bellum acciti sunt. Haec omnia non veniae, sed clementiae opera sunt. Clementia liberum arbitrium habet; non sub formula, sed ex aequo et bono iudicat; et absolvere illi licet et, quanti vult, taxare litem. Nihil ex his facit, tamquam iusto minus fecerit, sed tamquam id, quod constituit, iustissimum sit. Ignoscere autem est, quem iudices puniendum, non punire; venia debitae poenae remissio est. Clementia hoc primum praestat, ut, quos dimittit, nihil aliud illos pati debuisse pronuntiet; plenior est quam venia, honestior est. De verbo, ut mea fert opinio, controversia est, de re quidem convenit. Sapiens multa remittet, multos parum sani, sed sanabilis ingenii servabit. Agricolas bonos imitabitur, qui non tantum rectas procerasque arbores colunt; illis quoque, quas aliqua depravavit causa, adminicula, quibus derigantur, adplicant; alias circumcidunt, ne proceritatem rami premant, quasdam infirmas vitio loci nutriunt, quibusdam aliena umbra laborantibus caelum aperiunt. Videbit, quod ingenium qua ratione tractandum sit, quo modo in rectum prava flectantur».
Pars tertia 1. Tertio loco quaerimus, quomodo ad hanc virtutem perducatur animus, quomodo confirmet eam et usu suam faciat. Nullam ex omnibus virtutibus homini magis convenire, cum sit nulla humanior, constet necesse est non solum inter nos, qui hominem sociale animal communi bono genitum videri volumus, sed etiam inter illos, qui hominem voluptati donant, quorum omnia dicta factaque ad utilitates suas spectant; nam si quietem petit et otium, hanc virtutem naturae suae nanctus est, quae pacem amat et manus retinet. Nullum tamen clementia ex omnibus magis quam regem aut principem decet. Ita enim magnae vires decori gloriaeque sunt, si illis salutaris potentia est; nam pestifera vis est valere ad nocendum. Illius demum magnitudo stabilis fundataque est, quem omnes tam supra se esse quam pro se sciunt, cuius curam excubare pro salute singulorum atque universorum cottidie experiuntur, quo procedente non, tamquam malum aliquod aut noxium animal e cubili prosilierit, diffugiunt, sed tamquam ad clarum ac beneficum sidus certatim advolant. Obicere se pro illo mucronibus insidiantium paratissimi et substernere corpora sua, si per stragem illi humanam iter ad salutem struendum sit, somnum eius nocturnis excubiis muniunt, latera obiecti circumfusique defendunt, incurrentibus periculis se obponunt. Non est hic sine ratione populis urbibusque consensus sic protegendi amandique reges et se suaque iactandi, quocumque desideravit imperantis salus; nec haec vilitas sui est aut dementia pro uno capite tot milia excipere ferrum ac multis mortibus unam animam redimere nonnumquam senis et invalidi. Quemadmodum totum corpus
animo deservit et, cum hoc tanto maius tantoque speciosius sit, ille in occulto maneat tenuis et in qua sede latitet incertus, tamen manus, pedes, oculi negotium illi gerunt, illum haec cutis munit, illius iussu iacemus aut inquieti discurrimus, cum ille imperavit, sive avarus dominus est, mare lucri causa scrutamur, sive ambitiosus, iam dudum dextram flammis obiecimus aut voluntarii terram subsiluimus, sic haec inmensa multitudo unius animae circumdata illius spiritu regitur, illius ratione flectitur pressura se ac fractura viribus suis, nisi consilio sustineretur. 2. Suam itaque incolumitatem amant, cum pro uno homine denas legiones in aciem deducunt, cum in primam frontem procurrunt et adversa volneribus pectora ferunt, ne imperatoris sui signa vertantur. Ille est enim vinculum, per quod res publica cohaeret, ille spiritus vitalis, quem haec tot milia trahunt nihil ipsa per se futura nisi onus et praeda, si mens illa imperii subtrahatur. Rege incolumi mens omnibus una; amisso rupere fidem. Hic casus Romanae pacis exitium erit, hic tanti fortunam populi in ruinas aget; tam diu ab isto periculo aberit hic populus, quam diu sciet ferre frenos, quos si quando abruperit vel aliquo casu discussos reponi sibi passus non erit, haec unitas et hic maximi imperii contextus in partes multas dissiliet, idemque huic urbi finis dominandi erit, qui parendi fuerit. Ideo principes regesque et quocumque alio nomine sunt tutores status publici non est mirum amari ultra privatas etiam necessitudines; nam si sanis hominibus publica privatis potiora sunt, sequitur, ut is quoque carior sit, in quem se res publica convertit. Olim enim ita se induit rei publicae Caesar, ut seduci alterum non posset sine utriusque pernicie; nam et illi viribus opus est et huic capite. 3. Longius videtur recessisse a proposito oratio mea, at mehercules rem ipsam premit. Nam si, quod adhuc colligit, tu animus rei publicae tuae es, illa corpus tuum, vides, ut puto, quam necessaria sit clementia; tibi enim parcis, cum videris alteri parcere. Parcendum itaque est etiam inprobandis civibus non aliter quam membris languentibus, et, si quando misso sanguine opus est, sustinenda est ‹manus›, ne ultra, quam necesse sit, incidat. Est ergo, ut dicebam, clementia omnibus quidem hominibus secundum naturam, maxime tamen decora imperatoribus, quanto plus habet apud illos, quod servet, quantoque in maiore materia adparet. Quantulum enim nocet privata crudelitas! principum saevitia bellum est. Cum autem virtutibus inter se sit concordia nec ulla altera melior aut honestior sit, quaedam tamen quibusdam personis aptior est. Decet magnanimitas quemlibet mortalem, etiam illum, infra quem nihil est; quid enim maius aut fortius quam malam fortunam retundere? Haec tamen magnanimitas in bona fortuna laxiorem locum habet meliusque in tribunali quam in plano conspicitur.
Clementia, in quamcumque domum pervenerit, eam felicem tranquillamque praestabit, sed in regia, quo rarior, eo mirabilior. Quid enim est memorabilius quam eum, cuius irae nihil obstat, cuius graviori sententiae ipsi, qui pereunt, adsentiuntur, quem nemo interpellaturus est, immo, si vehementius excanduit, ne deprecaturus est quidem, ipsum sibi manum inicere et potestate sua in melius placidiusque uti hoc ipsum cogitantem: «Occidere contra legem nemo non potest, servare nemo praeter me»? Magnam fortunam magnus animus decet, qui, nisi se ad illam extulit et altior stetit, illam quoque infra ad terram deducit; magni autem animi proprium est placidum esse tranquillumque et iniurias atque offensiones superne despicere. Muliebre est furere in ira, ferarum vero nec generosarum quidem praemordere et urguere proiectos. Elephanti leonesque transeunt, quae inpulerunt; ignobilis bestiae pertinacia est. Non decet regem saeva nec inexorabilis ira, non multum enim supra eum eminet, cui se irascendo exaequat; at si dat vitam, si dat dignitatem periclitantibus et meritis amittere, facit, quod nulli nisi rerum potenti licet; vita enim etiam superiori eripitur, numquam nisi inferiori datur. Servare proprium est excellentis fortunae, quae numquam magis suspici debet, quam cum illi contigit idem posse quod dis, quorum beneficio in lucem edimur tam boni quam mali. Deorum itaque sibi animum adserens princeps alios ex civibus suis, quia utiles bonique sunt, libens videat, alios in numerum relinquat; quosdam esse gaudeat, quosdam patiatur. 4. Cogitato, in hac civitate, in qua turba per latissima itinera sine intermissione defluens eliditur, quotiens aliquid obstitit, quod cursum eius velut torrentis rapidi moraretur, in qua tribus eodem tempore theatris caveae postulantur, in qua consumitur, quidquid terris omnibus aratur, quanta solitudo ac vastitas futura sit, si nihil relinquitur, nisi quod iudex severus absolverit. Quotus quisque ex quaesitoribus est, qui non ex ipsa ea lege teneatur, qua quaerit? Quotus quisque accusator vacat culpa? Et nescio, an nemo ad dandam veniam difficilior sit, quam qui illam petere saepius meruit. Peccavimus omnes, alii gravia, alii leviora, alii ex destinato, alii forte inpulsi aut aliena nequitia ablati; alii in bonis consiliis parum fortiter stetimus et innocentiam inviti ac retinentes perdidimus; nec deliquimus tantum, sed usque ad extremum aevi delinquemus. Etiam si quis tam bene iam purgavit animum, ut nihil obturbare eum amplius possit ac fallere, ad innocentiam tamen peccando pervenit. 5. Quoniam deorum feci mentionem, optime hoc exemplum principi constituam, ad quod formetur, ut se talem esse civibus, quales sibi deos velit. Expedit ergo habere inexorabilia peccatis atque erroribus numina, expedit usque ad ultimam infesta perniciem? Et quis regum erit tutus, cuius non membra haruspices colligant? Quod si di placabiles et aequi delicta potentium non statim fulminibus persecuntur, quanto aequius est hominem hominibus praepositum miti animo exercere imperium et cogitare, uter mundi status gratior oculis pulchriorque sit, sereno et puro die, an cum fragoribus crebris omnia quatiuntur
et ignes hinc atque illinc micant! Atqui non alia facies est quieti moratique imperii quam sereni caeli et nitentis. Crudele regnum turbidum tenebrisque obscurum est, inter trementes et ad repentinum sonitum expavescentes ne eo quidem, qui omnia perturbat, inconcusso. Facilius privatis ignoscitur pertinaciter se vindicantibus; possunt enim laedi, dolorque eorum ab iniuria venit; timent praeterea contemptum, et non rettulisse laedentibus gratiam infirmitas videtur, non clementia; at cui ultio in facili est, is omissa ea certam laudem mansuetudinis consequitur. Humili loco positis exercere manum, litigare, in rixam procurrere ac morem irae suae gerere liberius est; leves inter paria ictus sunt; regi vociferatio quoque verborumque intemperantia non ex maiestate est. 6. Grave putas eripi loquendi arbitrium regibus, quod humillimi habent. «Ista» inquis «servitus est, non imperium». Quid? Tu non experiris istud nobis esse, tibi servitutem? Alia condicio est eorum, qui in turba, quam non excedunt, latent, quorum et virtutes, ut adpareant, diu luctantur et vitia tenebras habent; vestra facta dictaque rumor excipit, et ideo nullis magis curandum est, qualem famam habeant, quam qui, qualemcumque meruerint, magnam habituri sunt. Quam multa tibi non licent, quae nobis beneficio tuo licent! Possum in qualibet parte urbis solus incedere sine timore, quamvis nullus sequatur comes, nullus sit domi, nullus ad latus gladius; tibi in tua pace armato vivendum est. Aberrare a fortuna tua non potes; obsidet te et, quocumque descendis, magno adparatu sequitur. Est haec summae magnitudinis servitus non posse fieri minorem; sed cum dis tibi communis ipsa necessitas est. Nam illos quoque caelum adligatos tenet, nec magis illis descendere datum est quam tibi tutum; fastigio tuo adfixus es. Nostros motus pauci sentiunt, prodire nobis ac recedere et mutare habitum sine sensu publico licet; tibi non magis quam soli latere contingit. Multa circa te lux est, omnium in istam conversi oculi sunt; prodire te putas? Oriris. Loqui non potes, nisi ut vocem tuam, quae ubique sunt gentes, excipiant; irasci non potes, nisi ut omnia tremant, quia neminem adfligere, nisi ut, quidquid circa fuerit, quatiatur. Ut fulmina paucorum periculo cadunt, omnium metu, sic animadversiones magnarum potestatum terrent latius quam nocent, non sine causa; non enim, quantum fecerit, sed quantum facturus sit, cogitatur in eo, qui omnia potest. Adice nunc, quod privatos homines ad accipiendas iniurias oportuniores acceptarum patientia facit, regibus certior est ex mansuetudine securitas, quia frequens vindicta paucorum odium obprimit, omnium inritat. Voluntas oportet ante saeviendi quam causa deficiat; alioqui, quemadmodum praecisae arbores plurimis ramis repullulant et multa satorum genera, ut densiora surgant, reciduntur, ita regia crudelitas auget inimicorum numerum tollendo; parentes enim liberique eorum, qui interfecti sunt, et propinqui et amici in locum singulorum succedunt. 7. Hoc quam verum sit, admonere te exemplo domestico volo. Divus Augustus fuit mitis princeps, si quis illum a principatu suo aestimare incipiat; in communi quidem rei publicae gladium movit. Cum hoc aetatis esset, quod tu nunc
es, duodevicensimum egressus annum, iam pugiones in sinum amicorum absconderat, iam insidiis M. Antonii consulis latus petierat, iam fuerat collega proscriptionis. Sed cum annum quadragensimum transisset et in Gallia moraretur, delatum est ad eum indicium L. Cinnam, stolidi ingenii virum, insidias ei struere; dictum est, et ubi et quando et quemadmodum adgredi vellet; unus ex consciis deferebat. Constituit se ab eo vindicare et consilium amicorum advocari iussit. Nox illi inquieta erat, cum cogitaret adulescentem nobilem, hoc detracto integrum, Cn. Pompei nepotem, damnandum; iam unum hominem occidere non poterat, cui M. Antonius proscriptionis edictum inter cenam dictarat. Gemens subinde voces varias emittebat et inter se contrarias: «Quid ergo? Ego percussorem meum securum ambulare patiar me sollicito? Ergo non dabit poenas, qui tot civilibus bellis frustra petitum caput, tot navalibus, tot pedestribus proeliis incolume, postquam terra marique pax parata est, non occidere constituat, sed inmolare?» (nam sacrificantem placuerat adoriri). Rursus silentio interposito maiore multo voce sibi quam Cinnae irascebatur: «Quid vivis, si perire te tam multorum interest? Quis finis erit suppliciorum? Quis sanguinis? Ego sum nobilibus adulescentulis expositum caput, in quod mucrones acuant; non est tanti vita, si, ut ego non peream, tam multa perdenda sunt». Interpellavit tandem illum Livia uxor et: «Admittis» inquit «muliebre consilium? Fac, quod medici solent, qui, ubi usitata remedia non procedunt, temptant contraria. Severitate nihil adhuc profecisti; Salvidienum Lepidus secutus est, Lepidum Murena, Murenam Caepio, Caepionem Egnatius, ut alios taceam, quos tantum ausos pudet. Nunc tempta, quomodo tibi cedat clementia; ignosce L. Cinnae. Deprensus est; iam nocere tibi non potest, prodesse famae tuae potest». Gavisus, sibi quod advocatum invenerat, uxori quidem gratias egit, renuntiari autem extemplo amicis, quos in consilium rogaverat, imperavit et Cinnam unum ad se accersit dimissisque omnibus e cubiculo, cum alteram Cinnae poni cathedram iussisset: «Hoc» inquit «primum a te peto, ne me loquentem interpelles, ne medio sermone meo proclames; dabitur tibi loquendi liberum tempus. Ego te, Cinna, cum in hostium castris invenissem, non factum tantum mihi inimicum sed natum, servavi, patrimonium tibi omne concessi. Hodie tam felix et tam dives es, ut victo victores invideant. Sacerdotium tibi petenti praeteritis conpluribus, quorum parentes mecum militaverant, dedi; cum sic de te meruerim, occidere me constituisti». Cum ad hanc vocem exclamasset procul hanc ab se abesse dementiam: «Non praestas» inquit «fidem, Cinna; convenerat, ne interloquereris. Occidere, inquam, me paras»; adiecit locum, socios, diem, ordinem insidiarum, cui conmissum esset ferrum. Et cum defixum videret nec ex conventione iam, sed ex conscientia tacentem: «Quo» inquit «hoc animo facis? Ut ipse sis princeps? Male mehercules cum populo Romano agitur, si tibi ad imperandum nihil praeter me obstat. Domum tueri tuam non potes, nuper libertini hominis gratia in privato iudicio superatus es; adeo nihil facilius potes quam contra Caesarem advocare. Cedo, si spes tuas solus inpedio, Paulusne te et Fabius Maximus et Cossi et Servilii ferent tantumque agmen nobilium non inania nomina praeferentium, sed
eorum, qui imaginibus suis decori sint?». Ne totam eius orationem repetendo magnam partem voluminis occupem (diutius enim quam duabus horis locutum esse constat, cum hanc poenam, qua sola erat contentus futurus, extenderet): «Vitam» inquit «tibi, Cinna, iterum do, prius hosti, nunc insidiatori ac parricidae. Ex hodierno die inter nos amicitia incipiat; contendamus, utrum ego meliore fide tibi vitam dederim an tu debeas». Post hoc detulit ultro consulatum questus, quod non auderet petere. Amicissimum fidelissimumque habuit, heres solus illi fuit. Nullis amplius insidiis ab ullo petitus est. 8. Ignovit abavus tuus victis; nam si non ignovisset, quibus imperasset? Sallustium et Cocceios et Deillios et totam chortem primae admissionis ex adversariorum castris conscripsit; iam Domitios, Messalas, Asinios, Cicerones, quidquid floris erat in civitate, clementiae suae debebat. Ipsum Lepidum quam diu mori passus est! per multos annos tulit ornamenta principis retinentem et pontificatum maximum non nisi mortuo illo transferri in se passus est; maluit enim illum honorem vocari quam spolium. Haec eum clementia ad salutem securitatemque perduxit; haec gratum ac favorabilem reddidit, quamvis nondum subactis populi Romani cervicibus manum inposuisset; haec hodieque praestat illi famam, quae vix vivis principibus servit. Deum esse non tamquam iussi credimus; bonum fuisse principem Augustum, bene illi parentis nomen convenisse fatemur ob nullam aliam causam, quam quod contumelias quoque suas, quae acerbiores principibus solent esse quam iniuriae, nulla crudelitate exequebatur, quod probrosis in se dictis adrisit, quod dare illum poenas adparebat, cum exigeret, quod, quoscumque ob adulterium filiae suae damnaverat, adeo non occidit, ut dimissis quo tutiores essent, diplomata daret. Hoc est ignoscere, cum scias multos futuros, qui pro te irascantur et tibi sanguine alieno gratificentur, non dare tantum salutem, sed praestare. 9. Haec Augustus senex aut iam in senectutem annis vergentibus; in adulescentia caluit, arsit ira, multa fecit, ad quae invitus oculos retorquebat. Conparare nemo mansuetudini tuae audebit divum Augustum, etiam si in certamen iuvenilium annorum deduxerit senectutem plus quam maturam; fuerit moderatus et clemens, nempe post mare Actiacum Romano cruore infectum, nempe post fractas in Sicilia classes et suas et alienas, nempe post Perusinas aras et proscriptiones. Ego vero clementiam non voco lassam crudelitatem; haec est, Caesar, clementia vera, quam tu praestas, quae non saevitiae paenitentia coepit, nullam habere maculam, numquam civilem sanguinem fudisse; haec est in maxima potestate verissima animi temperantia et humani generis conprendens ut sui amor non cupiditate aliqua, non temeritate ingenii, non priorum principum exemplis corruptum, quantum sibi in cives suos liceat, experiendo temptare, sed hebetare aciem imperii sui. Praestitisti, Caesar, civitatem incruentam, et hoc, quod magno animo gloriatus es nullam te toto orbe stillam cruoris humani misisse, eo maius est mirabiliusque, quod nulli umquam citius gladius conmissus est. Clementia
ergo non tantum honestiores sed tutiores praestat ornamentumque imperiorum est simul et certissima salus. Quid enim est, cur reges consenuerint liberisque ac nepotibus tradiderint regna, tyrannorum execrabilis ac brevis potestas sit? Quid interest inter tyrannum ac regem (species enim ipsa fortunae ac licentia par est), nisi quod tyranni in voluptatem saeviunt, reges non nisi ex causa ac necessitate? 10. «Quid ergo? Non reges quoque occidere solent?». Sed quotiens id fieri publica utilitas persuadet; tyrannis saevitia cordi est. Tyrannus autem a rege factis distat, non nomine; nam et Dionysius maior iure meritoque praeferri multis regibus potest, et L. Sullam tyrannum adpellari quid prohibet, cui occidendi finem fecit inopia hostium? Descenderit licet e dictatura sua et se togae reddiderit, quis tamen umquam tyrannus tam avide humanum sanguinem bibit quam ille, qui septem milia civium Romanorum contrucidari iussit et, cum in vicino ad aedem Bellonae sedens exaudisset conclamationem tot milium sub gladio gementium, exterrito senatu: «Hoc agamus» inquit, «P. C.; seditiosi pauculi meo iussu occiduntur»? Hoc non est mentitus; pauci Sullae videbantur. Sed mox de Sulla, cum quaeremus, quomodo hostibus irascendum sit, utique si in hostile nomen cives et ex eodem corpore abrupti transierint; interim, hoc quod dicebam, clementia efficit, ut magnum inter regem tyrannumque discrimen sit, uterque licet non minus armis valletur; sed alter arma habet, quibus in munimentum pacis utitur, alter, ut magno timore magna odia conpescat, nec illas ipsas manus, quibus se conmisit, securus adspicit. Contrariis in contraria agitur; nam cum invisus sit, quia timetur, timeri vult, quia invisus est, et illo execrabili versu, qui multos praecipites dedit, utitur: «Oderint, dum metuant», ignarus, quanta rabies oriatur, ubi supra modum odia creverunt. Temperatus enim timor cohibet animos, adsiduus vero et acer et extrema admovens in audaciam iacentes excitat et omnia experiri suadet. Sic feras linea et pinnae clusas contineant, easdem a tergo eques telis incessat: temptabunt fugam per ipsa, quae fugerant, proculcabuntque formidinem. Acerrima virtus est, quam ultima necessitas extundit. Relinquat oportet securi aliquid metus multoque plus spei quam periculorum ostentet; alioqui, ubi quiescenti paria metuuntur, incurrere in pericula iuvat et ut aliena anima abuti. 11. Placido tranquilloque regi fida sunt auxilia sua, ut quibus ad communem salutem utatur, gloriosusque miles (publicae enim securitati se dare operam videt) omnem laborem libens patitur ut parentis custos; at illum acerbum et sanguinarium necesse est graventur stipatores sui. Non potest habere quisquam bonae ac fidae voluntatis ministros, quibus in tormentis ut eculeo et ferramentis ad mortem paratis utitur, quibus non aliter quam bestiis homines obiectat, omnibus reis aerumnosior ac sollicitior, ut qui homines deosque testes facinorum ac vindices timeat, eo perductus, ut non liceat illi mutare mores. Hoc enim inter cetera vel pessimum habet crudelitas: perseverandum est nec ad meliora patet regressus; scelera enim sceleribus tuenda sunt. Quid autem eo infelicius, cui iam
esse malo necesse est? O miserabilem illum, sibi certe! nam ceteris misereri eius nefas sit, qui caedibus ac rapinis potentiam exercuit, qui suspecta sibi cuncta reddidit tam externa quam domestica, cum arma metuat, ad arma confugiens, non amicorum fidei credens, non pietati liberorum; qui, ubi circumspexit, quaeque fecit quaeque facturus est, et conscientiam suam plenam sceleribus ac tormentis adaperuit, saepe mortem timet, saepius optat, invisior sibi quam servientibus. E contrario is, cui curae sunt universa, qui alia magis, alia minus tuetur, nullam non rei publicae partem tamquam sui nutrit, inclinatus ad mitiora, etiam, si ex usu est animadvertere, ostendens, quam invitus aspero remedio manus admoveat, in cuius animo nihil hostile, nihil efferum est, qui potentiam suam placide ac salutariter exercet adprobare imperia sua civibus cupiens, felix abunde sibi visus, si fortunam suam publicarit, sermone adfabilis, aditu accessuque facilis, voltu, qui maxime populos demeretur, amabilis, aequis desideriis propensus, etiam iniquis ‹non› acerbus, a tota civitate amatur, defenditur, colitur. Eadem de illo homines secreto locuntur quae palam; tollere filios cupiunt et publicis malis sterilitas indicta recluditur; bene se meriturum de liberis suis quisque non dubitat, quibus tale saeculum ostenderit. Hic princeps suo beneficio tutus nihil praesidiis eget, arma ornamenti causa habet. 12. Quod ergo officium eius est? Quod bonorum parentium, qui obiurgare liberos non numquam blande, non numquam minaciter solent, aliquando admonere etiam verberibus. Numquid aliquis sanus filium a prima offensa exheredat? Nisi magnae et multae iniuriae patientiam evicerunt, nisi plus est, quod timet, quam quod damnat, non accedit ad decretorium stilum; multa ante temptat, quibus dubiam indolem et peiore iam loco positam revocet; simul deploratum est, ultima experitur. Nemo ad supplicia exigenda pervenit, nisi qui remedia consumpsit. Hoc, quod parenti, etiam principi faciendum est, quem adpellavimus Patrem Patriae non adulatione vana adducti. Cetera enim cognomina honori data sunt; Magnos et Felices et Augustos diximus et ambitiosae maiestati quidquid potuimus titulorum congessimus illis hoc tribuentes; Patrem quidem Patriae adpellavimus, ut sciret datam sibi potestatem patriam, quae est temperantissima liberis consulens suaque post illos reponens. Tarde sibi pater membra sua abscidat, etiam, cum absciderit, reponere cupiat et in abscidendo gemat cunctatus multum diuque; prope est enim, ut libenter damnet, qui cito; prope est, ut inique puniat, qui nimis. 13. Trichonem equitem Romanum memoria nostra, quia filium suum flagellis occiderat, populus graphiis in foro confodit; vix illum Augusti Caesaris auctoritas infestis tam patrum quam filiorum manibus eripuit. Tarium, qui filium deprensum in parricidii consilio damnavit causa cognita, nemo non suspexit, quod contentus exilio et exilio delicato Massiliae parricidam continuit et annua illi praestitit, quanta praestare integro solebat; haec liberalitas effecit, ut, in qua civitate numquam deest patronus peioribus, nemo dubitaret, quin reus merito
damnatus esset, quem is pater damnare potuisset, qui odisse non poterat. Hoc ipso exemplo dabo, quem conpares bono patri, bonum principem. Cogniturus de filio Tarius advocavit in consilium Caesarem Augustum; venit in privatos penates, adsedit, pars alieni consilii fuit, non dixit: «Immo in meam domum veniat»; quod si factum esset, Caesaris futura erat cognitio, non patris. Audita causa excussisque omnibus, et his, quae adulescens pro se dixerat, et his, quibus arguebatur, petit, ut sententiam suam quisque scriberet, ne ea omnium fieret, quae Caesaris fuisset; deinde, priusquam aperirentur codicilli, iuravit se Tarii, hominis locupletis, hereditatem non aditurum. Dicet aliquis: «Pusillo animo timuit, ne videretur locum spei suae aperire velle fili damnatione». Ego contra sentio; quilibet nostrum debuisset adversus opiniones malignas satis fiduciae habere in bona conscientia, principes multa debent etiam famae dare. Iuravit se non aditurum hereditatem. Tarius quidem eodem die et alterum heredem perdidit, sed Caesar libertatem sententiae suae redemit; et postquam adprobavit gratuitam esse severitatem suam, quod principi semper curandum est, dixit relegandum, quo patri videretur. Non culleum, non serpentes, non carcerem decrevit memor, non de quo censeret, sed cui in consilio esset; mollissimo genere poenae contentum esse debere patrem dixit in filio adulescentulo inpulso in id scelus, in quo se, quod proximum erat ab innocentia, timide gessisset; debere illum ab urbe et a parentis oculis submoveri. 14. O dignum, quem in consilium patres advocarent! o dignum, quem coheredem innocentibus liberis scriberent! Haec clementia principem decet; quocumque venerit, mansuetiora omnia faciat. Nemo regi tam vilis sit, ut illum perire non sentiat, qualiscumque pars imperii est. In magna imperia ex minoribus petamus exemplum. Non unum est imperandi genus; imperat princeps civibus suis, pater liberis, praeceptor discentibus, tribunus vel centurio militibus. Nonne pessimus pater videbitur, qui adsiduis plagis liberos etiam ex levissimis causis conpescet? Uter autem praeceptor liberalibus studiis dignior, qui excarnificabit discipulos, si memoria illis non constiterit aut si parum agilis in legendo oculus haeserit, an qui monitionibus et verecundia emendare ac docere malit? Tribunum centurionemque da saevum: desertores faciet, quibus tamen ignoscitur. Numquidnam aecum est gravius homini et durius imperari, quam imperatur animalibus mutis? Atqui equum non crebris verberibus exterret domandi peritus magister; fiet enim formidolosus et contumax, nisi eum blandiente tactu permulseris. Idem facit ille venator, quique instituit catulos vestigia sequi quique iam exercitatis utitur ad excitandas vel persequendas feras: nec crebro illis minatur (contundet enim animos et, quidquid est indolis, conminuetur trepidatione degeneri) nec licentiam vagandi errandique passim concedit. Adicias his licet tardiora agentes iumenta, quae, cum ad contumeliam et miserias nata sint, nimia saevitia cogantur iugum detractare. 15. Nullum animal morosius est, nullum maiore arte tractandum quam homo,
nulli magis parcendum. Quid enim est stultius quam in iumentis quidem et canibus erubescere iras exercere, pessima autem condicione sub ‹homine› hominem esse? Morbis medemur nec irascimur; atqui et hic morbus est animi; mollem medicinam desiderat ipsumque medentem minime infestum aegro. Mali medici est desperare, ne curet: idem in iis, quorum animus adfectus est, facere debebit is, cui tradita salus omnium est, non cito spem proicere nec mortifera signa pronuntiare; luctetur cum vitiis, resistat, aliis morbum suum exprobret, quosdam molli curatione decipiat citius meliusque sanaturus remediis fallentibus; agat princeps curam non tantum salutis, sed etiam honestae cicatricis. Nulla regi gloria est ex saeva animadversione (quis enim dubitat posse?), at contra maxima, si vim suam continet, si multos irae alienae eripuit, neminem suae inpendit. 16. Servis imperare moderate laus est. Et in mancipio cogitandum est, non quantum illud inpune possit pati, sed quantum tibi permittat aequi bonique natura, quae parcere etiam captivis et pretio paratis iubet. Quanto iustius iubet hominibus liberis, ingenuis, honestis non ut mancipiis abuti sed ut his, quos gradu antecedas quorumque tibi non servitus tradita sit, sed tutela. Servis ad statuam licet confugere; cum in servum omnia liceant, est aliquid, quod in hominem licere commune ius animantium vetet. Quis non Vedium Pollionem peius oderat quam servi sui, quod muraenas sanguine humano saginabat et eos, qui se aliquid offenderant, in vivarium, quid aliud quam serpentium, abici iubebat? O hominem mille mortibus dignum, sive devorandos servos obiciebat muraenis, quas esurus erat, sive in hoc tantum illas alebat, ut sic aleret. Quemadmodum domini crudeles tota civitate conmonstrantur invisique et detestabiles sunt, ita regum et iniuria latius patet et infamia atque odium saeculis traditur; quanto autem non nasci melius fuit, quam numerari inter publico malo natos! 17. Excogitare nemo quicquam poterit, quod magis decorum regenti sit quam clementia, quocumque modo is et quocumque iure praepositus ceteris erit. Eo scilicet formosius id esse magnificentiusque fatebimur, quo in maiore praestabitur potestate, quam non oportet noxiam esse, si ad naturae legem conponitur. Natura enim conmenta est regem, quod et ex aliis animalibus licet cognoscere et ex apibus; quarum regi amplissimum cubile est medioque ac tutissimo loco; praeterea opere vacat exactor alienorum operum, et amisso rege totum dilabitur, nec umquam plus unum patiuntur melioremque pugna quaerunt; praeterea insignis regi forma est dissimilisque ceteris cum magnitudine tum nitore. Hoc tamen maxime distinguitur: iracundissimae ac pro corporis captu pugnacissimae sunt apes et aculeos in volnere relinquunt, rex ipse sine aculeo est; noluit illum natura nec saevum esse nec ultionem magno constaturam petere telumque detraxit et iram eius inermem reliquit. Exemplar hoc magnis regibus ingens; est enim illi mos exercere se in parvis et ingentium rerum documenta in minima parere. Pudeat ab exiguis animalibus non trahere mores, cum tanto hominum moderatior esse animus debeat, quanto vehementius nocet. Utinam
quidem eadem homini lex esset et ira cum telo suo frangeretur nec saepius liceret nocere quam semel nec alienis viribus exercere odia! facile enim lassaretur furor, si per se sibi satis faceret et si mortis periculo vim suam effunderet. Sed ne nunc quidem illi cursus tutus est; tantum enim necesse est timeat, quantum timeri voluit, et manus omnium observet et eo quoque tempore, quo non captatur, peti se iudicet nullumque momentum inmune a metu habeat. Hanc aliquis agere vitam sustinet, cum liceat innoxium aliis, ob hoc securum, salutare potentiae ius laetis omnibus tractare? Errat enim, si quis existimat tutum esse ibi regem, ubi nihil a rege tutum est; securitas securitate mutua paciscenda est. Non opus est instruere in altum editas arces nec in adscensum arduos colles emunire nec latera montium abscidere, multiplicibus se muris turribusque saepire: salvum regem clementia in aperto praestabit. Unum est inexpugnabile munimentum amor civium. Quid pulchrius est quam vivere optantibus cunctis et vota non sub custode nuncupantibus? Si paulum valetudo titubavit, non spem hominum excitari, sed metum? Nihil esse cuiquam tam pretiosum, quod non pro salute praesidis sui conmutatum velit? O ne ille, cui contingit, ut sibi quoque vivere debeat; in hoc adsiduis bonitatis argumentis probavit non rem publicam suam esse, sed se rei publicae. Quis huic audeat struere aliquod periculum? Quis ab hoc non, si possit, fortunam quoque avertere velit, sub quo iustitia, pax, pudicitia, securitas, dignitas florent, sub quo opulenta civitas copia bonorum omnium abundat? Nec alio animo rectorem suum intuetur, quam, si di inmortales potestatem visendi sui faciant, intueamur venerantes colentesque. Quid autem? Non proximum illis locum tenet is, qui se ex deorum natura gerit, beneficus ac largus et in melius potens? Hoc adfectare, hoc imitari decet, maximum ita haberi, ut optimus simul habeare. 18. A duabus causis punire princeps solet, si aut se vindicat aut alium. Prius de ea parte disseram, quae ipsum contingit; difficilius est enim moderari, ubi dolori debetur ultio, quam ubi exemplo. Supervacuum est hoc loco admonere, ne facile credat, ut verum excutiat, ut innocentiae faveat et, ut adpareat, non minorem agi rem periclitantis quam iudicis sciat; hoc enim ad iustitiam, non ad clementiam pertinet; nunc illum hortamur, ut manifeste laesus animum in potestate habeat et poenam, si tuto poterit, donet, si minus, temperet longeque sit in suis quam in alienis iniuriis exorabilior. Nam quemadmodum non est magni animi, qui de alieno liberalis est, sed ille, qui, quod alteri donat, sibi detrahit, ita clementem vocabo non in alieno dolore facilem, sed eum, qui, cum suis stimulis exagitetur, non prosilit, qui intellegit magni animi esse iniurias in summa potentia pati nec quicquam esse gloriosius principe inpune laeso. 19. Ultio duas praestare res solet: aut solacium adfert ei, qui accepit iniuriam, aut in relicum securitatem. Principis maior est fortuna, quam ut solacio egeat, manifestiorque vis, quam ut alieno malo opinionem sibi virium quaerat. Hoc dico, cum ab inferioribus petitus violatusque est; nam si, quos pares
aliquando habuit, infra se videt, satis vindicatus est. Regem et servus occidit et serpens et sagitta; servavit quidem nemo nisi maior eo, quem servabat. Uti itaque animose debet tanto munere deorum dandi auferendique vitam potens. In iis praesertim, quos scit aliquando sibi ‹par› fastigium optinuisse, hoc arbitrium adeptus ultionem inplevit perfecitque, quantum verae poenae satis erat; perdidit enim vitam, qui debet, et, quisquis ex alto ad inimici pedes abiectus alienam de capite regnoque sententiam expectavit, in servatoris sui gloriam vivit plusque eius nomini confert incolumis, quam si ex oculis ablatus esset. Adsiduum enim spectaculum alienae virtutis est; in triumpho cito transisset. Si vero regnum quoque suum tuto relinqui apud eum potuit reponique eo, unde deciderat, ingenti incremento surgit laus eius, qui contentus fuit ex rege victo nihil praeter gloriam sumere. Hoc est etiam ex victoria sua triumphare testarique nihil se, quod dignum esset victore, apud victos invenisse. Cum civibus et ignotis atque humilibus eo moderatius agendum est, quo minoris est adflixisse eos. Quibusdam libenter parcas, a quibusdam te vindicare fastidias et non aliter quam ab animalibus parvis sed opterentem inquinantibus reducenda manus est; at in iis, qui in ore civitatis servati punitique erunt, occasione notae clementiae utendum est. 20. Transeamus ad alienas iniurias, in quibus vindicandis haec tria lex secuta est, quae princeps quoque sequi debet: aut ut eum, quem punit, emendet, aut ‹ut› poena eius ceteros meliores reddat, aut ut sublatis malis securiores ceteri vivant. Ipsos facilius emendabis minore poena; diligentius enim vivit, cui aliquid integri superest. Nemo dignitati perditae parcit; inpunitatis genus est iam non habere poenae locum. Civitatis autem mores magis corrigit parcitas animadversionum; facit enim consuetudinem peccandi multitudo peccantium, et minus gravis nota est, quam turba damnationum levat, et severitas, quod maximum remedium habet, adsiduitate amittit auctoritatem. Constituit bonos mores civitati princeps et vitia eluit, si patiens eorum est, non tamquam probet, sed tamquam invitus et cum magno tormento ad castigandum veniat. Verecundiam peccandi facit ipsa clementia regentis; gravior multo poena videtur, quae a miti viro constituitur. 21. Praeterea videbis ea saepe conmitti, quae saepe vindicantur. Pater tuus plures intra quinquennium culleo insuit, quam omnibus saeculis insutos accepimus. Multo minus audebant liberi nefas ultimum admittere, quam diu sine lege crimen fuit. Summa enim prudentia altissimi viri et rerum naturae peritissimi maluerunt velut incredibile scelus et ultra audaciam positum praeterire quam, dum vindicant, ostendere posse fieri; itaque parricidae cum lege coeperunt, et illis facinus poena monstravit; pessimo vero loco pietas fuit, postquam saepius culleos vidimus quam cruces. In qua civitate raro homines puniuntur, in ea consensus fit innocentiae et indulgetur velut publico bono. Putet se innocentem esse civitas, erit; magis irascetur a communi frugalitate desciscentibus, si paucos esse eos viderit. Periculosum est, mihi crede, ostendere civitati, quanto plures mali sint.
22. Dicta est aliquando a senatu sententia, ut servos a liberis cultus distingueret; deinde adparuit, quantum periculum inmineret, si servi nostri numerare nos coepissent. Idem scito metuendum esse, si nulli ignoscitur; cito adparebit, pars civitatis deterior quanto praegravet. Non minus principi turpia sunt multa supplicia quam medico multa funera; remissius imperanti melius paretur. Natura contumax est humanus animus et in contrarium atque arduum nitens sequiturque facilius quam ducitur; et ut generosi ac nobiles equi melius facili freno reguntur, ita clementiam voluntaria innocentia inpetu suo sequitur, et dignam putat civitas, quam servet sibi. Plus itaque hac via proficitur. 23. Crudelitas minime humanum malum est indignumque tam miti animo; ferina ista rabies est sanguine gaudere ac volneribus et abiecto homine in silvestre animal transire. Quid enim interest, oro te, Alexander, leoni Lysimachum obicias an ipse laceres dentibus tuis? Tuum illud os est, tua illa feritas. O quam cuperes tibi potius ungues esse, tibi rictum illum edendorum hominum capacem! Non exigimus a te, ut manus ista, exitium familiarium certissimum, ulli salutaris sit, ut iste animus ferox, insatiabile gentium malum, citra sanguinem caedemque satietur; clementia iam vocatur, ad occidendum amicum ‹cum› carnifex inter homines eligitur. Hoc est, quare vel maxime abominanda sit saevitia, quod excedit fines primum solitos, deinde humanos, nova supplicia conquirit, ingenium advocat, ‹ut› instrumenta excogitet, per quae varietur atque extendatur dolor, delectatur malis hominum; tunc illi dirus animi morbus ad insaniam pervenit ultimam, cum crudelitas versa est in voluptatem et iam occidere hominem iuvat. Matura talem virum a tergo sequitur aversio, odia, venena, gladii; tam multis periculis petitur, quam multorum ipse periculum est, privatisque non numquam consiliis, alias vero consternatione publica circumvenitur. Levis enim et privata pernicies non totas urbes movet; quod late furere coepit et omnes adpetit, undique configitur. Serpentes parvolae fallunt nec publice conquiruntur; ubi aliqua solitam mensuram transit et in monstrum excrevit, ubi fontes sputu inficit et, si adflavit, deurit opteritque, quacumque incessit, ballistis petitur. Possunt verba dare et evadere pusilla mala, ingentibus obviam itur. Sic unus aeger ne domum quidem perturbat; at ubi crebris mortibus pestilentiam esse adparuit, conclamatio civitatis ac fuga est, et dis ipsis manus intentantur. Sub uno aliquo tecto flamma adparuit: familia vicinique aquam ingerunt; at incendium vastum et multas iam domos depastum parte urbis obruitur. 24. Crudelitatem privatorum quoque serviles manus sub certo crucis periculo ultae sunt; tyrannorum gentes populique et, quorum erat malum, et ei, quibus inminebat, excindere adgressi sunt. Aliquando sua praesidia in ipsos consurrexerunt perfidiamque et inpietatem et feritatem et, quidquid ab illis didicerant, in ipsos exercuerunt. Quid enim potest quisquam ab eo sperare, quem malum esse docuit? Non diu nequitia adparet nec, quantum iubetur, peccat. Sed
puta esse tutam crudelitatem, quale eius regnum est? Non aliud quam captarum urbium forma et terribiles facies publici metus. Omnia maesta, trepida, confusa; voluptates ipsae timentur; non convivia securi ineunt, in quibus lingua sollicite etiam ebriis custodienda est, non spectacula, ex quibus materia criminis ac periculi quaeritur. Adparentur licet magna inpensa et regiis opibus et artificum exquisitis nominibus, quem tamen ludi in carcere iuvent? Quod istud, di boni, malum est occidere, saevire, delectari sono catenarum et civium capita decidere, quocumque ventum est, multum sanguinis fundere, adspectu suo terrere ac fugare? Quae alia vita esset, si leones ursique regnarent, si serpentibus in nos ac noxiosissimo cuique animali daretur potestas? Illa rationis expertia et a nobis inmanitatis crimine damnata abstinent suis, et tuta est etiam inter feras similitudo: horum ne a necessariis quidem sibi rabies temperat, sed externa suaque in aequo habet, quo plus se exercitat, ‹eo incitat›ior. A singulorum deinde caedibus in exitia gentium serpit et inicere tectis ignem, aratrum vetustis urbibus inducere potentiam putat; et unum occidi iubere aut alterum parum imperatorium credit; nisi eodem tempore grex miserorum sub ictu stetit, crudelitatem suam in ordinem coactam putat. Felicitas illa multis salutem dare et ad vitam ab ipsa morte revocare et mereri clementia civicam. Nullum ornamentum principis fastigio dignius pulchriusque est quam illa corona ob cives servatos, non hostilia arma detracta victis, non currus barbarorum sanguine cruenti, non parta bello spolia. Haec divina potentia est gregatim ac publice servare; multos quidem occidere et indiscretos incendi ac ruinae potentia est.
La clemenza
Premessa Il trattato è stato composto fra il 54 e il 56, ma secondo alcuni Seneca l’avrebbe scritto durante il primo anno del regno di Nerone, secondo altri prima della morte di Britannico, cioè tra la fine del 54 e l’inizio del 55. Stando alla disposizione dei capitoli quale ci è pervenuta, l’opera sembrerebbe mutila e incompiuta, e ciò ha dato luogo a diverse supposizioni. Secondo alcuni constava di tre libri, dei quali circa una metà (una parte del libro II e tutto il III) sarebbe andata perduta, per cui noi, secondo la tradizione, disporremmo solo del I libro e di sette capitoli del II. Ma c’è chi ritiene il trattato integrale (anche se non portato a termine) e che sia solo questione di porre i capitoli nel loro posto originario. Così la pensa Préchac, che ha distinto La clemenza in un Proemio (primi due capitoli del I libro delle edizioni precedenti), una Prima parte (primi due capitoli del II libro), una Seconda parte (capitoli dal terzo al settimo del II libro) e una Terza parte (capitoli dal terzo in poi del I libro). Del resto Seneca stesso scrive: «Dividerò tutta questa materia in tre parti. La prima riguarderà la grande umanità di Nerone; la seconda mostrerà la natura e l’atteggiamento propri della clemenza…, la terza spiegherà in quale modo si possa condurre l’animo alla clemenza e come questa virtù possa essere rinforzata e fatta propria con l’uso». Se si pensa agli imperatori precedenti (Claudio, Caligola e Tiberio), La clemenza, che ha alle sue spalle un periodo di assolutismo pieno di sangue e di paure, nasce dalla speranza che Nerone, così promettente da giovane, restauri tempi nuovi e pacifici per l’Impero. In realtà i primi anni del suo governo furono molto equilibrati, anche per merito di Seneca stesso che insieme a Burro, prefetto del palazzo, era consigliere di Nerone. Cadeva dunque a proposito, per Seneca, sempre tempestivo nei suoi scritti, l’occasione di un appello al nuovo principe affinché non deviasse dalla sua buona natura e usasse con moderazione del suo potere di punire e di vendicarsi, anche se il suo – come scrive Carlo Giussani (Letteratura romana) – fu «un tentativo onesto ma vano di stornare ciò che faceva presentire il carattere dell’augusto allievo». Seneca esordisce dicendo di voler «assolvere alla funzione di specchio» («Sublime specchio di veraci detti, / mostrami in corpo e in anima qual sono», dice Vittorio Alfieri nel suo Autoritratto), sì che Nerone possa riconoscere se stesso nella descrizione che egli ne fa. Elogia poi il giovane imperatore perché, pur avendo un potere illimitato, ha dimostrato di esercitarlo con sorprendente mitezza. La clemenza, infatti, dice sempre Seneca, è la prima virtù di un re, che per questo sta alla pari con gli dèi, gli procura l’amore dei cittadini e garantisce, più di quanto non faccia la paura, il bene e la stabilità dell’impero. Trattando con indulgenza chi l’ha offeso, il re dimostra la propria superiorità su tutti gli altri uomini. Nerone, dice Seneca, è più grande di Augusto, perché questi fu clemente in vecchiaia e dopo aver versato il sangue di molti concittadini, mentre Nerone lo è per natura e in età giovanile. A differenza del tiranno, temuto per la sua crudeltà e perciò odiato e costretto a temere a sua volta, il re buono e clemente è come un padre per i suoi sudditi, punisce contro sua voglia solo quando è indispensabile e avendo sempre di mira il bene dei cittadini. Le pene inflitte per crudeltà incrementano i delitti invece di ridurli, perché scoraggiano i buoni e tolgono ai colpevoli la possibilità di ravvedersi e redimersi. Seneca spiega poi cosa sia la clemenza, la quale, dice, è mitezza nell’infliggere le punizioni. Essa non contrasta con la severità, che pure è una virtù, ma è l’opposto della crudeltà, che della severità è una degenerazione per eccesso e costituisce un vizio così come la clemenza eccessiva a sua volta sconfina nella compassione, un vizio anch’essa, come la tristezza, tipico delle anime deboli. La clemenza va anche distinta dal perdono, il quale è la remissione di una pena giusta e necessaria, e perciò contrasta con la giustizia, mentre la clemenza risparmia il colpevole per correggerlo e ricondurlo sulla retta via. Essa, inoltre, non solo fa onore a chi la pratica, ma lo rende più sicuro. Un principe clemente, infatti, è amato dai suoi sudditi, che per quella sua dote sono disposti a difenderlo, per cui le forze armate di cui egli si circonda servono solo a dargli lustro e ornamento. All’inizio, dunque, la clemenza di Nerone è presentata come una dote naturale per il semplice motivo che il giovane imperatore non ha mostrato sinora neppure un minimo di crudeltà. Seneca muove quindi da una constatazione, da un’immagine positiva di Nerone che lascia ben sperare per il futuro. Ma a questa sua immagine attuale aggiunge l’esortazione a coltivare le buone doti che egli già
possiede, anche perché l’andazzo dei tempi, i costumi corrotti, l’assenza di un controllo esercitato dall’esterno sul principe inducono a pensare che in quella situazione solo l’iniziativa personale di Nerone sia in grado di garantire la stabilità dell’Impero e conseguentemente anche l’affetto e il sostegno del popolo. Seneca, dunque, preso e dato atto delle buone inclinazioni del giovane principe, gli spiega perché debba continuare a mantenersi tale quale è apparso finora, nel suo stesso interesse, perché un sovrano buono e clemente non può essere odiato dai suoi sudditi, i quali, anche se qualcuno lo insidiasse, si leverebbero a sua difesa. Ma Seneca per clemenza non intende solo il trattenersi dallo spargere sangue, dall’infliggere pene crudeli, egli pone la clemenza quale fondamento di un retto e concorde vivere civile, visto che nel rapporto non solo fra il principe e i suoi sudditi, ma fra i cittadini stessi, la clemenza è la virtù umana per eccellenza, perché significa tolleranza, comprensione dei motivi che possono spingere a compiere il male, che rientra nella natura stessa dell’uomo, solidarietà verso i propri simili e conseguentemente pace e giustizia per la collettività. Le osservazioni di Seneca sono in se stesse giuste e bene argomentate, ma un conto è il desiderio, un conto è la realtà, che d’altra parte Seneca aveva già sperimentato e descritto, osservando quanto sia difficile per l’uomo raggiungere l’equilibrio e la saggezza. Con questo trattato, in cui sono evidenti l’intento adulatorio e il tentativo di accattivarsi Nerone (Petrarca a questo proposito espresse un giudizio negativo, considerando La clemenza una umiliazione della dignità dell’Autore), Seneca in effetti mette le mani avanti, si costruisce una sorta di salvacondotto per una clemenza che alla fine non gli sarà concessa, quando, ritiratosi ormai a vita privata, gli arriverà dal suo antico discepolo l’ordine di togliersi la vita. In questa traduzione abbiamo seguito l’edizione latina di Préchac, tanto più perché ci è parso che la parte finale, soprattutto negli ultimi capitoli (Parte terza, 20-24), sia per gli argomenti, sia per la forza espressiva, abbia proprio il sapore di una conclusione: quasi che Seneca, sotto l’impulso di un’ispirazione sincera (un conto, infatti, sono l’elogio di Nerone e l’intento parenetico, un conto i contenuti), avesse riservato alla fine i concetti più forti e più impegnativi, come nel brano in cui scrive che i figli osarono molto meno uccidere i loro padri quando questo delitto non era ancora previsto dalla legge, e che pertanto con grande buon senso i legislatori «avevano preferito passare sotto silenzio tale delitto piuttosto che mostrare, prevedendo una punizione, che esso può venire commesso». Perciò, aggiunge, con quella legge cominciarono a verificarsi più parricidi e fu la pena stessa a dare l’idea del delitto. È una considerazione che dovrebbe indurci a riflettere sull’opportunità (invocata in omaggio alla libertà d’informazione e al diritto di dire, costi quel che costi, tutta la verità) di raccontare certe cose o di fare leggi, per esempio, che attengono alla vita privata, in cui lo Stato (quando non si tratti di reati) non dovrebbe mettere il naso. E così pure quando dice che una volta il Senato decretò con un voto che gli schiavi si distinguessero dai cittadini liberi per l’abbigliamento, ma che poi «ci si rese conto di quale pericolo ci avrebbe minacciato se i nostri schiavi avessero cominciato a contarci». E infine che se non si perdona a nessuno si scopre che la parte prevalente dei cittadini è quella peggiore. L’ultimo capitolo, che si svolge in un crescendo inquietante, suona come un monito spaventoso, che dovrebbe mettere in guardia, in ogni istante e per sempre, Nerone, il quale ben diversamente risponderà all’appello del suo vecchio maestro. Tantum crudelitas potuit suadere malorum! M. S. A.
Proemio 1. Nerone Cesare, ho deciso di scrivere un’opera sulla clemenza per assolvere in qualche modo alla funzione di specchio e mostrarti a te stesso nel momento in cui stai per conseguire il massimo di ciò che si possa desiderare. Benché il vero vantaggio delle azioni giuste consista nell’averle compiute e nessuna ricompensa degna delle virtù esista al di fuori delle virtù stesse, giova
innanzitutto esaminare ed esplorare la buona coscienza, poi mettere gli occhi su questa immensa moltitudine di gente, discorde, ribelle, sfrenata, capace di imbaldanzire parimenti per la propria rovina e per quella degli altri, se mai riuscisse a spezzare il giogo, e parlare così con sé stessi: «Io, dunque, fra tutti i mortali sono stato favorito e scelto per svolgere sulla terra il compito degli dèi? Io sono per i popoli arbitro di vita e di morte; quale stato e quale sorte ciascuno abbia è posto nelle mie mani; cosa la sorte voglia che sia assegnato a ciascun mortale lo dice attraverso la mia bocca; i popoli e le città traggono motivi di gioia dai miei responsi; nessuna parte dell’Impero prospera senza il mio volere e il mio favore; tutte queste migliaia di spade che la mia pace tiene a bada saranno brandite a un mio cenno; quali popoli bisogna che siano distrutti dalle fondamenta, quali trasferiti, a quali bisogna che sia data la libertà e a quali invece si debba toglierla, quali re occorre che diventino schiavi e quali teste invece debbano essere insignite della corona reale, quali città debbano essere gettate in rovina e quali debbano nascere: tutto ciò dipende dalla mia autorità. Ma benché io abbia tutto questo potere non sono mai stato spinto a infliggere supplizi ingiusti, né dall’ira, né dall’impeto giovanile, né dalla temerarietà o dalla tracotanza degli uomini, che spesso fa perdere la pazienza anche agli animi più tranquilli, né tantomeno dalla furia, tipica di chi è a capo di grandi imperi, di ostentare il proprio potere attraverso il terrore. La mia spada è riposta, anzi è legata, nel fodero, e io mi guardo il più possibile dallo spargere sangue, fosse anche il più vile: non c’è alcuno che, pur privo di ogni altro titolo, non trovi grazia da me per il solo fatto di essere un uomo. Tengo nascosta la severità, ma ho sempre pronta la clemenza; sorveglio me stesso, come se dovessi rendere conto alle Leggi, che ho richiamato dall’oblio e dalle tenebre alla luce. Mi sono commosso ugualmente per la tenera età di uno e per quella estrema di un altro; a chi ho perdonato per la sua dignità, a chi per la sua umiltà, e quando non ho trovato un motivo per risparmiare qualcuno l’ho fatto per me stesso. Oggi se gli dèi immortali me lo chiedono, sono pronto a mettere nel conto tutto il genere umano». Tu puoi, o Cesare, proclamare audacemente questo: tutto ciò che è stato posto sotto la tua protezione e la tua tutela è pienamente al sicuro e non si sta tramando alcunché di male alla repubblica, né per via violenta né di nascosto, giacché tu aspiri a una lode rarissima e che sino a ora nessun principe ha meritato: l’innocenza da colpe. Questa tua singolare bontà non è vana, né trova uomini irriconoscenti o estimatori maligni. Tutti ti sono grati, poiché nessun individuo fu mai tanto caro quanto lo sei tu al popolo romano, per il quale rappresenti un bene grande e duraturo. Ma ti sei assunto un’enorme responsabilità: non c’è più persona, infatti, che parli del divo Augusto né dei primi tempi di Tiberio Cesare, o che vada cercando, fuori di te, un modello da offrirti affinché tu lo imiti: tutti vogliono che il tuo principato sia conforme a questo primo assaggio che ne hai dato, cosa che sarebbe stata difficile se tu non fossi buono per natura, ma avessi assunto temporaneamente la bontà come una
maschera, poiché nessuno può fingere a lungo e ben presto le cose simulate finiscono col mostrare la loro vera natura, mentre quelle che portano in sé la verità e che, per così dire, emergono da qualcosa di solido col tempo si accrescono e migliorano. Il popolo romano correva un grande rischio, poiché non sapeva quale piega avrebbe preso la tua nobile indole: ora le sue speranze sono al sicuro, poiché non c’è pericolo che tu all’improvviso possa dimenticarti di te stesso. La prosperità eccessiva rende insaziabili, e i desideri non hanno mai una tale moderazione da perderla quando si sia raggiunto ciò a cui si aspirava: gradualmente si passa dal grande all’ancora più grande, e una volta ottenute cose insperate, si abbracciano speranze smisurate. Ma oggi tutti i tuoi concittadini confessano apertamente di essere felici e che a questi beni non si potrebbe aggiungere nulla, se non il desiderio che siano duraturi. Molte cose li inducono a questa confessione, a cui gli uomini solitamente arrivano piuttosto tardi: una sicurezza totale e ben fondata, il riconoscimento di un diritto che sta al di sopra di ogni offesa; l’avere davanti agli occhi una forma di governo quanto mai gradita alla quale, tranne la possibilità di essere distrutta, non manca nulla per il raggiungimento di una libertà assoluta. Tuttavia ciò che ha destato pari ammirazione, nei più grandi come nei più umili, è la tua clemenza; gli altri beni, infatti, ciascuno li sente o se li aspetta maggiori o minori in proporzione alla sua condizione personale, mentre le aspettative della clemenza sono uguali in tutti, e non c’è alcuno che si compiaccia tanto della sua innocenza da non rallegrarsi comunque di avere a che fare con la clemenza, preposta agli errori dell’uomo. 2. Ora, io so che secondo alcuni la clemenza si applica solo a vantaggio dei peggiori, dato che essa è inutile se non c’è un delitto, ed è l’unica virtù che resta inoperosa fra uomini privi di colpe. Ma innanzitutto bisogna osservare che, come la medicina, pur riguardando i malati, è tenuta in onore anche dalle persone sane, così la clemenza, benché invocata da chi merita una punizione, è però venerata anche da persone incolpevoli. Essa trova posto pure fra gli innocenti, perché talvolta la nostra condizione stessa è ritenuta una colpa, e la clemenza, d’altronde, non soccorre solo l’innocenza, ma spesso va incontro anche alla virtù, poiché in certe circostanze occasionali si verificano fatti che possono essere puniti anche se degni di lode. Aggiungi che una gran parte degli uomini può ritornare innocente dopo essere stata perdonata. Ciò non vuol dire che si debba perdonare indiscriminatamente, perché se togli la differenza tra buoni e cattivi ne conseguono confusione e il dilagare dei vizi. Occorre dunque usare una moderazione che sappia distinguere le indoli in grado di guarire e quelle che non offrono alcuna speranza. Non bisogna avere, insomma, né una clemenza indiscriminata, al livello della massa, né una clemenza inaccessibile: è una crudeltà, infatti, sia il perdonare a tutti sia il non perdonare ad alcuno. Bisogna tenere una via di mezzo, ma poiché è difficile trovare la giusta proporzione occorre che tutto ciò che esorbita dal giusto inclini verso un atteggiamento più
umano. Ma queste cose saranno spiegate meglio una per una al momento opportuno. Ora dividerò tutta questa materia in tre parti. La prima riguarderà la grande umanità di Nerone; la seconda mostrerà la natura e l’atteggiamento propri della clemenza, dato che, essendoci vizi che imitano le virtù, le due cose non si possono riconoscere se non si pongono dei paletti che consentano di distinguere gli uni dalle altre; in terzo luogo ricercheremo in quale modo si possa condurre l’animo alla clemenza e come questa virtù possa essere rinforzata e fatta propria con l’uso.
Parte prima 1. Mi ha spinto a scrivere sulla clemenza, Nerone Cesare, soprattutto un tuo detto, che ricordo di aver udito con ammirazione, mentre lo pronunciavi, e di aver poi riferito ad altri: un detto generoso, rivelatore di un animo grande e di una grande benignità, che ti è venuto all’improvviso senza alcuna preparazione e non destinato a essere ascoltato da altri, indice della tua bontà in lotta contro i doveri della tua condizione. Burro,1 tuo prefetto, uomo straordinario e nato per averti come principe, dovendo punire due briganti, ti chiedeva di scrivere i loro nomi e il motivo della punizione, e poiché tu continuavi a rinviare insisteva perché tu alla fine ti decidessi. Suo malgrado, aveva portato con sé la carta e, contrariamente al tuo volere, te la consegnò, al che tu esclamasti: «Come vorrei non saper leggere e scrivere!».2 Oh parole degne di essere udite da tutti i popoli, sia da quelli che abitano nell’impero romano sia da quelli che vi sono vicini in uno stato di libertà precaria, nonché da quelli che si levano contro l’impero materialmente o idealmente!3 Oh parole da portare nell’assemblea di tutti gli uomini, con le quali dovrebbero giurare principi e re! Parole degne dell’età dell’innocenza assoluta del genere umano, alle quali restituire quell’antica età! Ora sì converrebbe davvero che gli uomini si unissero per l’equità e per il bene, rimuovendo la brama delle cose altrui, dalla quale deriva ogni male dell’anima; che risorgessero la pietà e l’integrità insieme con la lealtà e la modestia, e che i vizi, dopo aver abusato del loro lunghissimo dominio, cedessero finalmente il passo a un’età pura e felice. 2. Piace sperare e confidare che ciò in gran parte si avveri, o Cesare. Questa mitezza dell’animo tuo a poco a poco si comunicherà e si diffonderà per tutto l’immenso corpo dell’impero, e ogni cosa si conformerà sul tuo esempio. La salute si diffonde dalla testa a tutte le parti del corpo, così le membra se il principio che le anima è vivace sono salde e solide, se è languido la debolezza le infiacchisce. Analogamente se i cittadini romani saranno degni di questa tua bontà, lo saranno anche gli alleati, e in tutto il mondo ritorneranno i retti costumi: dovunque ti sarà risparmiato di far ricorso alle mani per infliggere punizioni.
Consentimi di soffermarmi più a lungo su questo argomento, non per blandire le tue orecchie (non è infatti mia abitudine: preferirei offendere dicendo la verità piuttosto che piacere adulando): a quale scopo, allora? Oltre ad augurarti che ti diventino molto familiari le tue buone azioni e le tue buone parole, perché ciò che ora è natura e istinto divenga frutto di riflessione, fra e me e me vado constatando che nella vita umana molti detti, grandi ma detestabili, passano per veri, e sono sempre sulla bocca di tutti, come quel famoso «Mi odino, purché mi temano»,4 al quale è simile il verso greco in cui uno ordina che, morto lui, la terra si mescoli col fuoco,5 e altre frasi di tal genere. Mi chiedo come mai l’ingegno umano abbia saputo esprimere su argomenti odiosi e mostruosi, in cui sembra essere più fecondo, pensieri energici e impetuosi, mentre ancora non si è sentito alcun detto appassionato che riguardi la mitezza e la bontà. E allora? Bisognerà che qualche rara volta, anche se contro voglia e dopo molte esitazioni, tu lo scriva ciò che ti ha portato a odiare la scrittura, ma bisogna che tu lo scriva, come del resto fai, con molta esitazione e molti rinvii.
Parte seconda 1. Affinché il magnifico nome di clemenza non ci tragga in inganno e non ci trascini al suo opposto, esaminiamo cosa sia la clemenza, che natura abbia e quali siano i suoi limiti. La clemenza è la moderazione dell’animo di chi ha il potere di punire; oppure è mitezza di chi dispensa una punizione a un suo sottoposto. Per sicurezza occorre attribuire alla clemenza più definizioni per evitare che una sola non basti alla sua comprensione e, per così dire, sia condannata per un vizio di forma. La clemenza può dunque essere definita anche un’inclinazione dell’animo alla mitezza nell’infliggere una pena. Quest’ultima definizione potrà non essere condivisa, pur essendo quella che più si avvicina al vero, se si afferma che la clemenza è la moderazione che attenua entro certi limiti la pena meritata e dovuta. A ciò si può obiettare che non c’è virtù che dia a qualcuno meno di quanto gli è dovuto. Eppure tutti capiscono che essere clementi significa fermarsi prima di arrivare a quel grado di punizione che a buon diritto si poteva stabilire. 2. Gli ignoranti reputano contraria alla clemenza la severità, ma non c’è virtù che sia contraria a una virtù. Cos’è, dunque, ciò che si oppone alla clemenza? La crudeltà, la quale altro non è che la ferocia dell’animo nell’infliggere le pene. «Ma certi», si obietterà, «non puniscono, e tuttavia sono crudeli, come quelli che uccidono uomini che non conoscono, o che hanno incontrato per caso, non per trarne un guadagno, ma semplicemente per il gusto di ucciderli, e non paghi di ammazzare si accaniscono sulle loro vittime, come quel famoso Busiride,6 Procruste,7 o i pirati, che frustano i prigionieri e li gettano vivi nel fuoco». Certamente, anche questa è crudeltà, ma non rientra nella nostra definizione,
poiché non persegue una vendetta, non avendo ricevuto alcuna offesa, né punisce una colpa, poiché non c’è stato alcun delitto. L’oggetto della nostra definizione era l’intemperanza dell’animo nell’infliggere le pene: questa non è crudeltà, è ferocia, che prova piacere nel far soffrire; possiamo chiamarla follia, poiché la ferocia è di varie specie, ma nessuna di esse è più evidente di quella che arriva a massacrare e straziare gli uomini. Perciò io definisco crudeli coloro che hanno un motivo per punire, ma non possiedono la misura, come nel caso di Falaride,8 di cui si dice non solo che infierisse anche contro persone innocenti, ma che oltrepassasse appunto ogni misura umana e consentita. Senza stare a cavillare, possiamo definire la crudeltà come una inclinazione dell’animo verso la massima durezza: è questa crudeltà che la clemenza respinge ingiungendole di stare lontano da lei, mentre va d’accordo con la severità. Ora, restando in argomento, occorre chiedersi cosa sia la compassione, visto che i più la lodano come virtù e chiamano buono l’uomo compassionevole. Eppure, anche questo è un vizio dell’animo. I due eccessi da evitare si trovano rispettivamente al confine l’uno della severità, l’altro della clemenza, poiché col pretesto della severità si cade nella crudeltà, col pretesto della clemenza si cade nella compassione: in questo caso si sbaglia con minor pericolo, ma l’errore è uguale in entrambi i casi, inquantoché ci si allontana dal vero. 3. Perciò, come la religione venera gli dèi e la superstizione li offende, così tutti gli uomini buoni mostreranno clemenza e mitezza, evitando, però, la compassione, la quale è il vizio di un animo debole, che si sgomenta di fronte ai mali altrui, e dunque è comune fra gli uomini più vili: sono le vecchiette e le donnicciole che si lasciano commuovere dalle lacrime dei peggiori delinquenti e che, se potessero, forzerebbero le porte del carcere. La compassione guarda dritta alla sorte, non indaga le cause, mentre la clemenza agisce secondo ragione. So che presso gli ignoranti la setta degli stoici non gode di una buona reputazione perché giudicata troppo dura e incapace di dare buoni consigli a principi e re; le si rimprovera di negare al saggio la compassione e il perdono, tesi che in sé e per sé sono odiose, poiché sembra che colpiscano indiscriminatamente qualsiasi colpa, senza lasciare alcuno spiraglio agli errori umani. Se le cose stessero così, che fondamento di verità avrebbe una dottrina che impone di metter da parte l’umanità e chiude completamente il porto più sicuro contro gli assalti della fortuna, quello, cioè, dell’assistenza reciproca? In realtà non c’è scuola più benevola e più mite di quella stoica, più amante degli uomini e più attenta al bene comune, tanto da porsi come fine quello di essere utile, di aiutare e di provvedere non soltanto a sé stessi ma anche a tutti in generale e a ciascuno in particolare. La compassione, insomma, è una malattia dell’animo che deriva da una visione triste e dolorosa dei mali altrui, nella convinzione che essi accadano a persone che non li meritano: una malattia, che non si verifica nel saggio, la cui mente è serena e nulla può accaderle che riesca a offuscarla. Non c’è cosa che più si addica all’uomo quanto la grandezza d’animo, ma l’animo non può essere
grande e al tempo stesso triste. La tristezza colpisce lo spirito, lo abbatte, gli provoca una stretta, cosa che non accade al saggio neppure di fronte alle proprie sventure, poiché egli rintuzza la furia della sorte e la spezza davanti a sé, mantiene il suo volto sempre nel medesimo atteggiamento, tranquillo e impassibile, il che non gli sarebbe possibile se accogliesse in sé la tristezza. 4. Aggiungi che il saggio è previdente e ha sempre pronto un consiglio opportuno, e da ciò che è torbido non può venir fuori alcunché di limpido e puro. La tristezza è incapace di distinguere, di escogitare qualcosa di utile, di evitare i pericoli, di valutare i danni nel giusto modo, dunque, il saggio non prova compassione perché questa renderebbe misero e triste l’animo suo. Tutto ciò che può fare una persona compassionevole egli lo farà, ma spontaneamente e con animo nobile: porgerà aiuto alle lacrime altrui, ma non vi parteciperà; tenderà la mano al naufrago, offrirà ospitalità all’esule, farà l’elemosina all’indigente, non però quell’obolo umiliante che i più gettano come con disprezzo, volendo apparire misericordiosi, mentre in realtà provano disgusto verso chi aiutano e si guardano bene dall’esserne toccati: egli donerà come un uomo dà a un suo simile qualcosa che appartiene a un patrimonio comune; donerà un figlio alle lacrime della madre, ordinerà di sciogliergli le catene, lo sottrarrà ai giochi dell’arena e seppellirà nella terra il suo cadavere nonostante i delitti da lui commessi: ma tutto questo lo farà con mente tranquilla e col volto impassibile. Il saggio, dunque, non proverà compassione, ma soccorrerà e aiuterà i suoi simili, in quanto egli è nato per giovare a tutti e per contribuire al bene pubblico, del quale darà una parte a ciascuno. Elargirà la sua bontà, nelle giuste proporzioni, anche a malfattori e a persone degne di riprovazione, ma capaci di migliorarsi e redimersi, volgendo più volentieri la sua attenzione verso chi è afflitto e soffre per la cattiva sorte. Se sarà possibile contrasterà l’avversità della sorte, rimettendo in piedi, con le sue forze e le sue ricchezze, ciò che il caso ha abbattuto. Egli non distoglierà né il volto né l’animo di fronte a una gamba stecchita, a una magrezza rugosa o a una vecchiaia che si appoggia al bastone, ma darà aiuto a tutte le persone che ne saranno degne e, come fanno gli dèi, sarà benevolo verso gl’infelici. La compassione è prossima alla miseria, perché partecipa della sua natura. Sono deboli quegli occhi che vedendone altri malati di congiuntivite si velano anch’essi di lacrime, così come il ridere o lo sbadigliare vedendo altri che ridono o che sbadigliano è una malattia, non un segno di allegria. La compassione è un vizio degli animi che hanno paura della miseria, pretenderla dal saggio è come chiedergli di lamentarsi o di piangere ai funerali di persone estranee. 5. «Ma perché il saggio non perdona ad alcuno?». Prima stabiliamo cos’è il perdono e così vedremo che non è di pertinenza del saggio. Il perdono, infatti, è l’annullamento di una giusta pena, e perché il saggio non debba concederlo lo spiegano dettagliatamente coloro che si occupano di questo argomento specifico:
io, per essere breve, obiettivamente, come in un processo, dirò: «Si perdona a chi doveva essere punito; ma il saggio non fa nulla di ciò che non deve fare e fa sempre tutto ciò che deve fare, dunque non condona la pena che “deve” infliggere. Ma quel risultato che si vuole ottenere col perdono lui lo procurerà per una via più conforme al bene, risparmiando il colpevole, prendendosi cura di lui, correggendolo: farà, insomma, le stesse cose che farebbe se perdonasse, ma non perdonerà, poiché chi perdona non può non riconoscere di non aver fatto una cosa che si doveva fare. Uno punirà con le parole senza infliggere una pena materiale, tanto più se l’età del colpevole è passibile di correzione; un altro, data l’odiosità della colpa, lo lascerà incolume in quanto ha sbagliato o perché ingannato o perché era ubriaco: così lascerà liberi i nemici, e talvolta addirittura li loderà, se sono stati trascinati alla guerra da motivi onorevoli, per aver dato la parola, per un trattato, per la libertà. Tutti questi sono atti di clemenza, non di perdono. La clemenza nasce dal libero arbitrio, giudica non in base a una formula, ma in base all’equità e alla bontà, e le è concesso di assolvere o di commisurare i danni all’entità della somma che ritiene opportuna. E queste cose le fa nella convinzione di agire secondo giustizia, che ciò che ha deciso sia la cosa più giusta. Perdonare, invece, significa non punire uno che si ritiene debba essere punito: il perdono, insomma, è la remissione di una pena dovuta, mentre la clemenza vuole significare innanzitutto che chi viene lasciato libero da lei senza alcuna punizione doveva essere trattato così, dunque la clemenza è più perfetta del perdono, più conforme al bene». Secondo me si tratta di una questione formale, c’è discordanza solo sulla parola ma sostanzialmente c’è accordo. In definitiva il saggio rimetterà molte punizioni, salverà molte persone di indole poco sana, ma sanabile, imitando così i buoni agricoltori, i quali non si limitano a coltivare gli alberi alti e diritti ma applicano dei sostegni per raddrizzare quelli la cui crescita è stata deformata da qualche motivo imprevisto; ad altri tagliano i rami tutt’intorno affinché la crescita non ne sia ostacolata, altri, che vengono su deboli per l’aridità del terreno, li concimano, alcuni, che soffrono per l’ombra di altre piante, li mettono allo scoperto, creandogli uno spiraglio di luce. Tocca al saggio vedere, indole per indole, in che modo la si debba trattare, e come si possa raddrizzare ciò che è storto.
Parte terza 1. Ora, in terzo luogo vediamo in quale modo l’animo possa essere condotto alla virtù della clemenza e come si possa rinforzarla e farla propria praticandola. Che fra tutte le virtù non ce n’è un’altra che si addica maggiormente all’uomo, in quanto è la più umana, dev’essere palesemente riconosciuto non solo da noi, che riteniamo l’uomo un animale sociale nato per il bene comune, ma anche da coloro che destinano l’uomo al piacere e le cui parole e azioni mirano tutte all’interesse personale. Infatti, se è vero che l’uomo tende
alla quiete e all’ozio, egli raggiunge il massimo grado della sua natura proprio con questa virtù che ama la pace e non infierisce contro alcuno. E però la clemenza si addice soprattutto a un re o a un principe. Un grande potere, infatti, è motivo di onore e di gloria se è salutare, se invece serve solo per nuocere è rovinoso. Infine, è stabile e ben fondata la grandezza di chi, a giudizio unanime, opera al di sopra e a favore di tutti gli uomini, che quotidianamente fanno esperienza della sua premura sempre rivolta alla salute degli altri e che al suo apparire non scappano di qua e di là come di fronte a un animale cattivo o pericoloso balzato fuori dalla sua tana, ma anzi, fanno a gara per andargli incontro come a una stella benefica e luminosa. Prontissimi ad affrontare in sua difesa le spade di aggressori in agguato e a stendersi a terra per dargli modo di salvarsi, come aprendosi una via di scampo attraverso un cumulo di cadaveri, proteggono il suo sonno con veglie notturne, difendono i suoi fianchi mettendoglisi intorno e davanti, e fanno muro contro i pericoli che lo minacciano. Un tale consenso di popoli e di città nel proteggere così amorevolmente i loro re e nell’offrire sé stessi e i propri beni dovunque lo richieda l’incolumità del capo, non è senza ragione; e non è insensatezza o disprezzo della propria vita il fatto che tante migliaia di uomini si espongano alle spade nemiche per la salvezza di uno solo e riscattino con molte morti una vita che non di rado è quella di un uomo invalido e vecchio. Il corpo è al servizio dell’anima e benché sia molto più grande di lei e molto più appariscente, mentre l’anima se ne sta nascosta ed è così evanescente e sfuggevole che non si sa bene dove risieda, tuttavia le mani, i piedi, gli occhi si dànno da fare per lei, è lei che la pelle protegge, è per ordine dell’anima che stiamo sdraiati o corriamo irrequieti di qua e di là; e quando lei ce lo ordina, se è una padrona avida, esploriamo il mare per lucro, se è ambiziosa già da un pezzo abbiamo messo la mano sul fuoco9 o ci siamo lanciati volontariamente sotto terra.10 Analogamente questa immensa moltitudine che sta attorno a un solo individuo è governata dallo spirito di lui, è diretta dalla sua ragione, e se non fosse trattenuta dalla sua saggezza si precipiterebbe e si spezzerebbe con le sue forze stesse. 2. Gli uomini, dunque, amano la propria incolumità, quando per difendere un solo uomo, schierano dieci legioni in ordine di battaglia, si lanciano in prima linea offrendo il petto alle ferite affinché le insegne del loro comandante non siano volte in fuga. Egli, infatti, è il legame in virtù del quale lo Stato resta unito e compatto, egli è quel soffio vitale che respirano tutte queste migliaia di uomini, che di per sé sarebbero un peso e una preda, se venisse loro sottratta quella mente che li comanda: Finché il re è incolume, uno solo è il volere di tutti; perso lui, il patto è spezzato.11 Questo evento sarebbe la fine della pace romana, sarebbe causa di rovina per
la prosperità di un popolo così grande; e da tale pericolo il popolo si manterrà lontano fino a quando saprà sopportare i freni; se invece li spezzerà, o se, rimossi da qualche accidente, non permetterà che gli vengano rimessi, questa unità e questo legame si frantumeranno, e finiranno a un tempo l’obbedienza e il dominio. Non c’è dunque da meravigliarsi che principi, re e tutti coloro che a diverso titolo hanno la tutela dello Stato siano amati anche al di là dei vincoli privati, ché se per gli uomini assennati le cose pubbliche sono più importanti di quelle private, ne consegue che a loro è più caro colui nel quale lo Stato si identifica. Da tempo, infatti, l’imperatore si è talmente immedesimato nello Stato che non si può separare l’uno dall’altro senza che si danneggino entrambi, poiché l’uno ha bisogno di forze, l’altro di un capo. 3. Pare che il mio discorso si sia allontanato molto da quanto m’ero proposto, ma, perbacco, tocca proprio il nocciolo della questione: giacché se tu sei l’anima della repubblica e la repubblica è il tuo corpo – come finora appare chiaro – è evidente, credo, che la clemenza è necessaria: mentre infatti sembra che tu badi agli altri, in realtà salvaguardi te stesso. Perciò bisogna risparmiare anche i cittadini riprovevoli, così come si risparmiano le membra malate, e se talvolta è necessario spargere sangue bisogna trattenere la spada affinché non penetri più del necessario. Dunque, come dicevo, la clemenza è secondo natura per tutti gli uomini, ma si addice specialmente agli imperatori, perché in loro e attraverso di loro salva più gente e ha maggiori occasioni per esplicarsi. Quanto poco nuoce, infatti, la crudeltà privata! Quella dei principi, invece, è guerra totale. Per non dire che se fra le virtù c’è concordia, nel senso che nessuna è migliore o più bella di un’altra, tuttavia alcune sono più adatte a certe persone. La magnanimità, per esempio, si addice a qualsiasi mortale, anche a chi non ha nessuno al di sotto di sé: cosa può esserci, infatti, di più grande o di più forte del respingere gli attacchi dell’avversa fortuna? Tuttavia questa magnanimità ha un campo più vasto nella buona sorte, e si vede meglio in un palco piuttosto che a terra. La clemenza rende felice e tranquilla qualunque casa in cui entra, ma in una reggia, quanto è più rara, tanto più è ammirevole. Cosa c’è di più memorabile di colui alla cui ira nulla si opponga, alla cui sentenza più severa assentono gli stessi condannati a morte, al quale nessuno può rivolgere obiezioni, anzi, neppure preghiere, se è andato un po’ su di giri, che fa violenza a sé stesso usando il suo potere nel modo migliore e più pacifico, pensando: «Tutti possono uccidere contro la legge, ma io solo posso salvare»? A una grande fortuna si addice un animo grande, ma l’animo che non si innalzi fino a essa e non la domini trascina in basso anche lei. È di un animo grande essere sereno e tranquillo e guardare le offese dall’alto. È da donne, invece, l’uscire di senno quando si è adirati; è proprio delle fiere, ma non di quelle più nobili, l’assalire a morsi e l’accanirsi sulle vittime già abbattute. Gli elefanti e i leoni passano oltre, dopo aver atterrato la vittima: l’ostinazione è propria delle bestie ignobili. Un’ira crudele e inesorabile non si addice a un re, che così si innalza ben poco al
di sopra di colui al quale, adirandosi, si è reso uguale; se invece lascia la vita e la dignità a chi gli è stato condotto davanti per essere giudicato e condannato, fa ciò che non è consentito se non a chi detiene il sommo potere: la vita, infatti, si toglie anche a un superiore, ma non la si concede mai se non a un inferiore. Salvare è proprio di una fortuna eccellente, che non deve mai essere più ammirata di quando le accade di avere un potere pari a quello degli dèi, per beneficio dei quali noi veniamo alla luce, buoni e cattivi. Perciò il principe, assumendo quella disposizione d’animo propria degli dèi, guardi con benevolenza quei suoi concittadini che sono utili e buoni, gli altri li lasci nella massa; gioisca dell’esistenza di alcuni, sopporti quella di altri. 4. Pensa in quale solitudine e in quale deserto si trasformerebbe questa città – in cui la folla, scorrendo continuamente per vie larghissime, si schiaccia ogni volta che incontra un ostacolo che freni il suo corso, simile a quello di un rapido torrente, una città nei cui teatri tre cavee si riempiono contemporaneamente di pubblico, in cui si consuma ciò che si coltiva in tutte le terre – qualora vi rimanessero solo quelli che sono stati assolti da un giudice severo. Quanti giudici istruttori vi sono che non cadano sotto quella stessa legge in virtù della quale indagano? Quanti accusatori senza colpa? E non so se vi sia qualcuno che a dare il perdono sia più restio di chi troppo spesso è stato in condizione di chiederlo. Tutti abbiamo commesso delle colpe, chi più gravi, chi più lievi, alcuni deliberatamente, altri spinti dal caso o trascinati dalla malvagità altrui; alcuni tra noi non hanno perseverato con sufficiente energia nei loro buoni propositi e hanno perso l’innocenza loro malgrado, pur cercando di conservarla; e non solo abbiamo commesso colpe ma ne commetteremo finché vivremo. E c’è chi, pur avendo ormai purificato il suo animo così bene che nulla può più turbarlo o ingannarlo, tuttavia è giunto all’innocenza attraverso la colpa. 5. Visto che ho citato gli dèi, penso che la cosa migliore sia mostrare a un principe questo modello, affinché vi si conformi e voglia essere tale verso i suoi concittadini quali vuole che siano gli dèi verso di lui. Conviene avere delle divinità inesorabili di fronte ai peccati e agli errori, conviene averli ostili fino alla nostra ultima rovina? E quale re sarà così al sicuro che gli aruspici non debbano poi raccogliere le sue membra? E se gli dèi, che sono equi e indulgenti, non puniscono subito coi fulmini i delitti dei potenti, quanto è più giusto che un uomo preposto al governo di altri uomini eserciti il suo comando con animo mite, pensando quale aspetto del mondo sia più gradevole agli occhi e più bello, se quello di un giorno sereno e puro o quello in cui tutto sia scosso da continui fragori di tuono e con fuochi che balenano di qua e di là. Ebbene, l’aspetto di un impero tranquillo e ben ordinato non è diverso da quello di un cielo sereno e luminoso. Un regno crudele è torbido e oscurato da tenebre, è composto di gente che trema e si spaventa per un suono improvviso, e persino chi è responsabile di tutto questo sconquasso non resta immune da turbamento. Un cittadino privato che
esagera nel vendicarsi, in quanto è stato ferito – e il suo risentimento deriva dall’offesa subìta – e che se non si vendica teme di essere disprezzato, visto che il non punire chi ci offende sembra un atto di debolezza, non di clemenza, non è difficile perdonarlo, ma chi si vendica facilmente se rinuncia alla vendetta viene lodato per la sua mansuetudine. Se due persone di umili condizioni vengono alle mani, litigano, si azzuffano e assecondano la propria ira, sono più tollerate, poiché i colpi tra pari sono lievi, ma per un re anche il solo alzare la voce e il lasciarsi andare nel parlare sono atti disdicevoli alla sua maestà. 6. Tu ritieni che sia grave privare i re di quella libertà di parlare che hanno anche i più umili. «Questa», dici, «non è comando, è schiavitù». E che? Non sperimenti tu stesso che quella che per noi è una libertà per te è una schiavitù? Una cosa, infatti, è la condizione di chi sta nascosto nella folla, sulla quale non s’innalza, le cui virtù per mostrarsi devono lottare a lungo, mentre i suoi vizi sono immersi nelle tenebre, una cosa è, invece, la condizione dei re, le cui azioni e parole sono note all’opinione pubblica, sicché nessuno deve curarsi della propria reputazione più di coloro che, qualunque fama si siano meritati, avranno una grande notorietà. Quante cose a te non sono lecite che sono lecite a noi, grazie a te! Io posso camminare tranquillamente da solo in qualunque parte della città senza paura, anche se non mi segue alcun compagno e non ho spada al fianco o a casa mia, tu nella tua pace devi vivere armato. Tu non puoi deviare dalla tua sorte: essa ti sta vicino, e dovunque tu discenda, ti segue con grande apparato. La schiavitù di chi è grande al massimo grado è appunto questa: il non poter diventare più piccola. Ma questa necessità ti è comune con gli dèi. Anch’essi, infatti, sono legati al cielo, non gli è permesso di discendere, così come non lo è a te: sei inchiodato all’altezza in cui ti trovi. Pochi sentono i nostri movimenti: noi possiamo infatti farci avanti e ritrarci e cambiare atteggiamento senza che la gente se ne accorga, mentre a te non è permesso stare nascosto, come non lo è al sole. Attorno a te c’è molta luce, e verso di essa sono rivolti gli occhi di tutti: credi di uscire [quando varchi la soglia della reggia]? No: in realtà tu sorgi! Non puoi parlare senza che tutti i popoli del mondo sentano la tua voce; non puoi adirarti senza che tutto tremi, poiché non puoi colpire qualcuno senza che ciò che ti circonda ne sia scosso. Come i fulmini cadono con pericolo di pochi, ma con paura di tutti, così le pene inflitte da chi è molto potente seminano terrore più estesamente di quanto nuocciano, e non senza ragione, poiché di colui che può tutto si pensa non tanto a ciò che ha fatto, quanto a ciò che farà. Aggiungi che i cittadini privati sono più adatti a ricevere le offese proprio perché le sopportano pazientemente, mentre ai re da quella mansuetudine deriva una sicurezza più certa, poiché una vendetta continua soffoca, è vero, l’odio di pochi, ma eccita quello di tutti. Bisogna che prima del motivo che ci spinge a essere crudeli venga meno in noi la volontà, altrimenti, come gli alberi tagliati rimettono nuovi germogli moltiplicando i rami e molte specie di seminagioni vengono recise affinché ricrescano più fitte, così la crudeltà dei re, eliminando i nemici, ne
accresce il numero, perché i genitori, i figli degli uccisi e i loro amici e parenti prendono il posto dei singoli che sono stati eliminati. 7. Quanto ciò sia vero voglio ricordartelo con un esempio della tua famiglia. Il divo Augusto fu un principe mite, se si comincia a giudicarlo dall’inizio del suo principato, ma quando la repubblica fu in pericolo impugnò la spada: alla stessa età che hai tu adesso, uscito dal diciottesimo anno, aveva già cercato di pugnalare al fianco a tradimento il console Antonio, ch’era già stato suo collega nella proscrizione. Quando poi ebbe superato i sessant’anni e soggiornava in Gallia fu informato che Cinna,12 uomo d’indole sciocca, tendeva insidie contro di lui, e gli fu detto dove, come e quando intendeva assalirlo: era stato uno dei complici a denunciare Cinna. Augusto decise di vendicarsi e convocare a consiglio i suoi amici. Passò una notte agitata, perché gli rincresceva di condannare a morte un giovane nobile e per tutto il resto integerrimo, nonché nipote di Gneo Pompeo: ormai non era più capace di uccidere un solo uomo, lui, al quale Antonio aveva dettato a cena l’editto di proscrizione. Mentre gemeva andava pronunciando frasi varie e in contraddizione fra loro: «Ma come», si diceva, «io permetterò che chi meditava di uccidermi se ne vada in giro tranquillo, mentre io me ne sto in ansia? Dunque, non sarà punito costui che ha deciso non solo di uccidere, ma di immolare (si era infatti scelto di assalire Augusto mentre compiva un sacrificio) una testa che invano è stata presa di mira in tante guerre civili, in tante battaglie navali e terrestri, e ciò dopo che è stata assicurata la pace per terra e per mare?». Poi, dopo un momento di silenzio, si adirava con sé stesso alzando la voce molto più di quanto avesse fatto nei confronti di Cinna: «Perché vivi», chiedeva a sé stesso, «se a tanti interessa che tu muoia? Come finirà questo supplizio? Quando si smetterà di versare sangue? La mia testa è in balìa di nobili giovincelli perché affilino contro di me le loro spade; la vita vale ben poco se affinché io non muoia si deve sacrificarne tanti». Alla fine la moglie Livia lo interruppe, dicendogli: «Accetti il consiglio di una donna? Fa’ come sogliono fare i medici, che quando i rimedi soliti non hanno effetto provano quelli contrari. Finora con la severità non hai ottenuto nulla: a Salvidieno è seguito Lepido, a Lepido Murena, a Murena Cepione, a Cepione Ignazio,13 per non parlare degli altri, che si vergognano d’aver osato tanto. Ora prova a vedere quale risultato puoi ottenere con la clemenza: perdona Cinna. È stato colto in flagrante: ormai non può più nuocerti, mentre può giovare alla tua fama». Lieto di aver trovato un consigliere, Augusto ringraziò la moglie, informò subito gli amici di avere annullato la convocazione del consiglio e fece chiamare Cinna, da solo. Dopodiché, congedati tutti coloro che si trovavano nella stanza, richiesta un’altra sedia per Cinna, gli disse: «Prima di tutto ti chiedo di non interrompermi mentre parlo e di non lasciarti sfuggire esclamazioni di sorta: ti dirò io quando potrai parlare. Pur avendoti trovato nell’accampamento dei nemici, non solo divenuto ma nato mio nemico, ti ho salvato la vita e ti ho lasciato tutto il tuo patrimonio. Oggi sei così felice e così ricco che i vincitori
invidiano un vinto come te. Quando hai chiesto il sacerdozio, te l’ho dato, escludendo molti i cui genitori avevano combattuto con me. E dopo che io mi sono acquistato presso di te tutti questi meriti, tu hai deciso di uccidermi». A queste parole Cinna gridò che era ben lungi da lui una simile follia, al che Augusto gli disse: «Cinna, tu non mantieni la promessa: ci eravamo messi d’accordo che non mi avresti interrotto. Ripeto: tu ti accingi a uccidermi». E specificò il luogo, i complici, il giorno, il piano dell’agguato, il nome di colui al quale era stato affidato il compito di colpirlo. E quando vide che Cinna teneva lo sguardo fisso a terra e taceva, non più per osservare il patto ma perché consapevole della sua colpa, aggiunse: «Con quale animo, con quale proposito lo fai? Per diventare principe tu stesso? Il popolo romano è ben malridotto, perbacco, se tu non incontri alcun ostacolo tranne me per ottenere l’impero. Non sei nemmeno capace di proteggere la tua casa: non molto tempo fa sei stato sconfitto in un processo privato per la fiducia accordata a un liberto […]: avessi chiamato in tuo aiuto Cesare! Ebbene, se io solo costituisco un impedimento alle tue speranze, mi ritiro: forse ti sopporteranno Paolo e Fabio Massimo, i Cossi, i Servili14 e una così grande schiera di nobili che non vantano nomi vani, ma sono tali da far onore alle immagini dei loro antenati?». Per non occupare gran parte del mio volume ripetendo tutto il suo discorso (visto che Augusto parlò per più di due ore, tirando a lungo questa pena che già gli sarebbe bastata), ricorderò solo che disse: «Ti dono la vita per la seconda volta, o Cinna, che prima eri mio nemico e ora sei un attentatore e un parricida. Da oggi torniamo a essere amici; facciamo a gara per vedere chi di noi due sarà più leale, io che ti ho dato la vita o tu che me la devi». Dopodiché, gli conferì il consolato, dolendosi che lui non osasse chiederlo. Cinna gli fu amicissimo e fedelissimo e fu il suo unico erede. Non fu più richiesto da alcuno di tendere agguati. 8. Il tuo trisavolo perdonò ai vinti: infatti, se non avesse perdonato, su chi avrebbe regnato? Sallustio e i Coccei,15 i Dellii e tutto il suo seguito di prima qualità, li arruolò dagli accampamenti degli avversari; già i Domizi, i Messala, gli Asinii,16 i Ciceroni e tutto il fìor fiore della città li doveva alla sua clemenza. E quanto a lungo seppe aspettare la morte di Lepido! Per molti anni sopportò che conservasse le insegne di principe e non trasferì a sé stesso il titolo di pontefice massimo se non dopo la morte di lui: preferì, infatti, che fosse chiamato onore piuttosto che spoglia. Questa clemenza gli garantì salute e sicurezza, procurandogli il consenso e il favore popolare, benché egli avesse fatto pesare la sua mano sul collo non ancora sottomesso del popolo romano: oggi egli deve alla clemenza la sua fama, quella fama che a stento è al servizio anche dei principi viventi, e se crediamo che ora sia un dio non è perché ci sia stato ordinato: riconosciamo che Augusto è stato un principe buono, a cui si addice il nome di padre della patria proprio perché non puniva con crudeltà neppure le offese commesse contro di lui, che di solito per i principi sono più gravi degli attentati, che rispondeva con un sorriso alle parole infamanti pronunciate contro di lui, che
quando infliggeva una punizione era come se la subisse egli stesso, che non solo non uccise coloro che aveva condannato per aver commesso adulterio con sua figlia, ma li lasciò andare, dandogli dei salvacondotti affinché fossero maggiormente al sicuro. Questo è perdonare, quando sai che molti si adireranno in tua difesa, decisi a compiacerti versando il sangue altrui: non solo lasciare salva la vita, ma garantirla. 9. Tale fu Augusto nella vecchiaia o quando la sua vita già volgeva al tramonto; da giovane fu inquieto, si lasciò trasportare dall’ira e fece molte cose che poi ricordava a malincuore. Nessuno oserà paragonare alla tua mitezza il divo Augusto, anche se nel confronto fra gli anni giovanili di entrambi si sottraesse la vecchiaia più che matura di lui. Egli fu moderato e clemente, ma lo fu dopo aver tinto il mare di Azio con sangue romano, dopo aver distrutto in Sicilia le flotte sue e quelle degli altri, dopo gli altari di Perugia e le proscrizioni, e per me non è clemenza una crudeltà che si è stancata. La vera clemenza è la tua, o Cesare, questa di cui dài prova tu, che non nasce dal rimorso per la crudeltà, che non ha alcuna macchia, che non ha mai versato il sangue dei cittadini. Questa clemenza consiste nella più sincera temperanza dell’animo al culmine del potere, nell’amore per il genere umano, non nell’aver sperimentato materialmente il proprio potere sulla pelle dei cittadini per una corruzione dovuta a una qualche brama, ad avventatezza o all’esempio dei principi precedenti, ma nello smussare la punta del proprio comando. Tu, Cesare, hai evitato che nella città scorresse sangue umano, e il fatto che tu ti sia potuto vantare di non averne sparso una sola goccia in tutto il mondo è tanto più grande e meraviglioso perché a nessuno fu mai affidata la spada in un’età più giovane della tua. La clemenza, dunque, rende non solo più degni di onore, ma anche più sicuri, ed è al tempo stesso ornamento e salute certissima degli imperi. Per quale motivo, infatti, i re diventano vecchi e affidano il regno a figli e nipoti, mentre il potere dei tiranni è breve e odioso? C’è una grande differenza fra un tiranno e un re (anche se la loro condizione di fortuna e il loro potere sono uguali a vedersi), perché i tiranni sono crudeli per il gusto di esserlo, mentre i re lo sono solo per necessità e per giustificati motivi. 10. «E che, dunque? I re non sogliono uccidere anch’essi?». Sì, ma solo quando vi sono spinti dall’interesse pubblico, i tiranni, invece, la crudeltà l’hanno nel cuore. Il tiranno è diverso dal re per le azioni che compie, non per il nome: infatti, anche Dionigi il Vecchio 17 può essere preferito giustamente e a buon diritto a molti re, mentre cosa c’impedisce di chiamare tiranno Silla, che smise di uccidere solo perché scarseggiavano i nemici? Sarà pure disceso dal ruolo di dittatore e tornato alla toga civile, ma chi fra i tiranni bevve sangue umano così avidamente come lui, che ordinò di trucidare settemila cittadini romani, e che avendo udito le grida di tante migliaia di persone che gemevano sotto i colpi delle spade – era seduto nelle vicinanze, presso il tempio di Bellona
– di fronte ai senatori atterriti esclamò: «Proseguiamo la seduta, Padri Coscritti: pochissimi sediziosi vengono uccisi per mio ordine»? In questo non mentì: a Silla quei morti sembravano pochi. Fra un po’ vedremo come ci si debba adirare contro i nemici, tanto più se nelle loro schiere sono passati dei cittadini, come membra strappate da uno stesso corpo. Intanto, come ho detto, la clemenza determina una grande differenza fra un re e un tiranno, benché entrambi siano ugualmente protetti da una barriera di soldati, ma mentre il re utilizza le sue forze armate per difendere la pace, il tiranno se ne serve per reprimere grandi odii e con tanta paura che non è sicuro nemmeno delle mani a cui si è affidato. Dai contrasti che incontra è spinto a nuovi contrasti, talché, essendo odiato perché è temuto, vuole essere temuto perché è odiato, e si serve di quel verso esecrando che ha condotto molti alla rovina: «Mi odino, purché mi temano». Non sa quanto furore produca l’odio quando è cresciuto oltre misura. Un timore moderato riesce a tenere gli animi a freno, ma un timore vivo e continuo, che fa intravedere mali gravissimi, spinge all’audacia anche i più fiacchi e li convince a tentare di tutto. Le fiere si possono tenere a bada rinchiudendole con reti e penne, ma se un cavaliere le aggredisce alle spalle con le frecce, tenteranno la fuga proprio attraverso quegli stessi impedimenti da cui fuggivano, calpestando ciò che le impauriva. Il coraggio più ardimentoso è quello che nasce da un’estrema necessità. Bisogna che la paura lasci un po’ di sicurezza e mostri molte più speranze che pericoli, altrimenti, quando, pur standosene al sicuro, si temono gli stessi rischi, giova affrontarli e abusare della propria vita come se fosse di un altro. 11. A un re pacifico e tranquillo tutti i suoi sostenitori sono fedeli in quanto egli si serve di loro per il bene comune, e i soldati – orgogliosi perché si rendono conto di collaborare per la sicurezza pubblica – sopportano volentieri ogni fatica, considerandosi quali custodi del padre di tutti, mentre un re feroce e sanguinario inevitabilmente è sopportato di mal animo dalle sue guardie. Un re non può avere ministri fedeli e volonterosi se se ne serve per infliggere torture, con cavalletti o con altri strumenti di morte, se gli getta in pasto esseri umani come a delle bestie, altrimenti, se lo fa, ne prova ansia e tormento più di qualunque colpevole, poiché teme sempre la vendetta di uomini e dèi che sono stati testimoni dei suoi delitti, né a quel punto può più tornare indietro e mutare il suo comportamento. Fra gli altri guai, infatti, la crudeltà ha anche questo: è costretta a perseverare e non ha alcuna via per redimersi, poiché i delitti vanno difesi coi delitti. E quale infelicità maggiore c’è per uno a cui la cattiveria appare ormai una necessità? Oh, come fa compassione, per lo meno a sé stesso! Per gli altri, infatti, sarebbe un’empietà provar compassione per uno che ha esercitato il suo potere attraverso stragi e rapine, che si è comportato in modo tale da dover sospettare di tutto, sia in casa che fuori, e che temendo le armi fa ricorso alle armi, non crede alla lealtà degli amici né all’affetto dei figli, e che guardatosi attorno per vedere cos’ha fatto e cosa farà e messa a nudo la sua
coscienza piena di delitti e di tormenti, spesso teme la morte, più spesso se la augura, odioso più a sé stesso che a coloro che lo servono. Quel re, invece, che si prende cura di ogni cosa, che protegge, più o meno, ciò che va protetto, che dà sostegno a tutte le parti dello Stato mostrandosi incline a provvedimenti più miti, che anche quando è utile punire lo fa malvolentieri essendo restio a ricorrere a rimedi duri, che non nutre nell’animo alcun sentimento di ostilità, nessuna ferocia, che esercita il suo potere in modo pacifico e salutare, pensoso del consenso popolare, che si ritiene felicissimo se è riuscito a estendere a tutti la sua fortuna, che è affabile nel parlare, disponibile a lasciarsi avvicinare, amabile nel viso (la prima cosa per procurarsi il favore popolare), moderato nei desideri, aspro a malapena persino coi malvagi, ebbene, un simile sovrano è amato, difeso e venerato da tutti i cittadini. Di lui la gente dice in segreto le stesse cose che in pubblico, desidera procreare, ponendo così fine a quel controllo delle nascite imposto dai mali dello Stato, e tutti sono sicuri che i figli saranno grati ai genitori per averli fatti vivere in un’epoca simile. Un siffatto principe, protetto dal bene che fa, non ha bisogno di scorte e i soldati li tiene solo come ornamento. 12. Qual è dunque il suo dovere? Quello dei buoni genitori, i quali sono soliti rimproverare i figli a volte blandamente, a volte minacciandoli, a volte anche picchiandoli. Forse che un uomo assennato disereda il figlio alla prima offesa ricevuta da lui? Se molti e gravi torti non hanno vinto completamente la sua pazienza, se ciò che egli teme non è più grave di ciò che condanna, un padre non firma la sua sentenza definitiva: prima fa molti tentativi per richiamare al dovere un’indole incerta, anche se è già avviata verso il peggio; solo quando ormai dispera, tenta soluzioni estreme. Non v’è genitore che arrivi a infliggere supplizi se non dopo aver esaurito tutti i rimedi. Ebbene, ciò che deve fare il padre, deve farlo anche il principe, al quale non per vana adulazione abbiamo attribuito il nome di Padre della Patria. Gli altri soprannomi, infatti, sono stati dati a titolo onorifico: alcuni sovrani li abbiamo chiamati Grandi, Felici, Augusti, e per onorarli abbiamo coperto di tutti i titoli una maestà ambiziosa; ma abbiamo chiamato il principe Padre della Patria perché sapesse che gli era stata data la patria potestà, la quale è la più moderata che ci sia, poiché si prende cura dei figli e mette i propri interessi dopo i loro. In quanto padre sia tardo nel decidersi a tagliare una delle proprie membra, e anche dopo averla tagliata sia desideroso di rimetterla al posto in cui si trovava, e gema nel tagliarla dopo molta e lunga esitazione: chi infatti condanna in fretta è prossimo al condannare volentieri, e chi punisce esageratamente è prossimo al punire ingiustamente. 13. Ai nostri tempi il popolo nel Foro trafisse a colpi di stilo Tricone, cavaliere romano, perché aveva ucciso un suo figlio a frustate, e l’autorità di Cesare Augusto lo strappò a stento alle mani minacciose di padri e di figli. Tutti ammirino Tario, che, avendo colto il figlio mentre progettava il parricidio, nel
processo che ne seguì si accontentò di condannarlo all’esilio, anzi a un esilio piacevole, confinandolo a Marsiglia e assegnandogli una somma annuale pari a quella che gli dava quando non aveva ancora commesso la colpa. Questa generosità fece sì che, in una città in cui c’è sempre qualcuno pronto a difendere gli uomini peggiori, nessuno dubitò che fosse meritata la punizione di un reo che aveva potuto essere condannato da un padre incapace di odiare. Con questo stesso esempio ti presenterò il buon principe, affinché tu lo confronti col buon padre. Prima di processare il figlio, Tario chiamò in consiglio Cesare Augusto, il quale si recò in quella casa privata, si sedette accanto a lui, quale membro di un consiglio convocato da altri, e non disse: «Venga lui a casa mia!», perché diversamente il processo sarebbe stato svolto da Cesare, non dal padre. Sentita la questione ed esaminato sotto ogni aspetto sia ciò che il giovane aveva detto in sua difesa, sia ciò che sosteneva l’accusa, Cesare chiese che ciascuno scrivesse il proprio giudizio, per evitare che tutti si conformassero al suo; poi, prima che venissero aperte le tavolette, giurò che non avrebbe mai accettato l’eredità di Tario, che era molto ricco. Qualcuno dirà: «Fu segno di animo meschino l’aver paura che con la condanna del figlio potesse nutrire qualche speranza». Io non la penso così: chiunque di noi di fronte a ipotesi maligne avrebbe dovuto fidarsi abbastanza dell’onestà della sua coscienza, ma i principi devono tener conto anche dell’opinione pubblica. Giurò dunque che non avrebbe accettato l’eredità. Tario nello stesso giorno perse anche un secondo erede, ma Cesare rivendicò la piena libertà del suo voto; e dopo aver dimostrato che la sua severità era disinteressata, cosa di cui il principe deve sempre preoccuparsi, disse che il giovane doveva essere relegato dove fosse sembrato opportuno al padre. Non decise né per il sacco,18 né per i serpenti, né per il carcere, pensando non a chi doveva essere giudicato ma a chi l’aveva chiamato in consiglio; disse che il padre doveva accontentarsi di una pena molto mite nei confronti di un figlio ancora adolescente che si era lasciato spingere a quel delitto e poi si era comportato in modo così timido da rasentare l’innocenza, e che il reo doveva essere allontanato dalla città e dalla vista del padre. 14. Oh, principe degno di essere chiamato in consiglio dai padri! E degno di comparire nei testamenti come coerede di figli privi di colpe! È questa la clemenza che si addice al principe: dovunque egli vada, renda ogni cosa più mite. Che un re non consideri alcuno così spregevole da non accorgersi della sua morte, poiché ogni singolo individuo, qualunque sia la sua condizione, è parte dell’impero! Ai grandi imperi siano d’esempio quelli più piccoli. Non esiste un solo tipo di governo: il principe governa sui suoi concittadini, il padre sui figli, il precettore sui discepoli, il tribuno o il centurione sui soldati. Non ci sembrerà un pessimo padre quello che tiene a freno i figli ricorrendo spesso alle percosse anche per i più piccoli motivi? E quale precettore sarà più degno della sua professione, quello che tortura i discepoli se dimenticano qualcosa o se gli occhi poco svegli esitano nella lettura, o quello che preferisce insegnare e correggere
solo attraverso i rimproveri e provocando negli animi la vergogna? Presentami un centurione crudele: produrrà dei disertori, che noi finiremo col perdonare. È forse giusto, infatti, comandare a un uomo con più altezzosità e durezza che alle bestie? Un maestro esperto nel domare i cavalli non terrorizza l’animale frustandolo spesso, perché quello diventerà pauroso e riottoso se non lo si rabbonisce con carezze affettuose. La stessa cosa fa il cacciatore che addestra i cagnolini a seguire le tracce di un animale, o che, dopo averli addestrati, se ne serva per stanare o per inseguire le fiere: non li minaccia continuamente (poiché così ne fiaccherebbe l’ardore e vanificherebbe le loro qualità infondendogli una trepidazione contraria alla loro natura), né lascia loro la libertà di vagabondare e di andare in giro dappertutto. A questi esempi aggiungi quello di chi conduce le bestie da soma più lente, che una eccessiva crudeltà, anche se sono portate per natura a sopportare oltraggi e miserie, costringerebbe a rifiutare il giogo. 15. Non c’è animale più ombroso dell’uomo che vada trattato con maggior cautela e risparmiato di più. Cosa può esserci infatti di più stolto che arrossire di esercitare la propria ira sulle bestie da soma e sui cani quando per l’uomo non c’è condizione peggiore di quella d’essere alla mercé dell’uomo? Curiamo le malattie senza adirarci, eppure anche questa è una malattia, che riguarda l’anima e richiede una medicina dolce e un medico che non sia minimamente ostile al malato. È proprio di un cattivo medico disperare per non curare: la stessa cosa dovrà fare nei confronti di chi è malato nell’anima colui al quale è affidata la salute di tutti, cioè non abbandonare troppo presto la speranza e non parlare di sintomi mortali: lotti contro i vizi, resista, rimproveri ad alcuni la loro malattia, inganni altri con una cura blanda, poiché li guarirà più rapidamente e meglio con rimedi che li illudano; il principe si preoccupi non solo della salute, ma anche di lasciare cicatrici decorose. Al principe, o Nerone, non viene alcuna gloria dall’infliggere pene crudeli (chi dubita, infatti, che lo possa fare?), anzi, ne ha moltissima se tiene a freno la sua forza e se sottrae molti all’ira altrui. 16. È meritorio comandare ai servi con moderazione. E nei confronti di uno schiavo bisogna pensare non quanto lo si possa maltrattare impunemente, ma quanto consentano la giustizia e il bene, che ordinano di rispettare anche i prigionieri e coloro che sono stati comprati col denaro. Quanto più giusto ancora è non abusare, come se fossero schiavi di uomini liberi, nati da genitori liberi e onorevoli, ma trattarli come persone alle quali si è superiori solo per condizione sociale e che ti sono state affidate non per stare in schiavitù, ma per essere protette. Ai servi è permesso rifugiarsi presso una statua! Mentre tutto è lecito nei confronti di uno schiavo, il diritto comune agli esseri animati non consente di autorizzare certe cose nei confronti di un uomo. Tutti odiavano Vedio Pollione più dei suoi schiavi, perché ingrassava le sue murene con sangue umano e faceva gettare quelli che lo avevano offeso in un vivaio di serpenti. Oh, uomo degno di mille morti, sia che gettasse gli schiavi in pasto alle murene, che poi avrebbe
mangiato, sia che le allevasse solo per nutrirle in questo modo! Come i padroni crudeli sono detestati e maledetti e segnati a dito da tutti i cittadini, così le offese arrecate dai re sono molto più estese e l’infamia e l’odio che si sono procurati si tramandano alle generazioni successive. Meglio non nascere piuttosto che essere annoverati fra coloro che sono nati per il male di un popolo intero! 17. Non si potrà mai immaginare alcunché che per un governante sia più onorevole della clemenza, in qualunque modo e a qualunque titolo egli si trovi a capo degli altri. Ed essa, per unanime riconoscimento, sarà tanto più bella e magnifica quanto più grande sarà il potere che la attua, un potere che se regolato in base alla legge naturale non può e non deve nuocere. Il re, infatti, l’ha inventato la natura, come si può dedurre dagli altri esseri animati e dalle api, il cui sovrano sta in un giaciglio più grande e situato nel luogo più centrale e più sicuro; egli, inoltre, non lavora ma sorveglia l’opera degli altri; morto il re, tutta la schiera si disperde e gli animali non tollerano che ve ne sia più di uno ma nel caso in cui gli aspiranti siano due sarà un combattimento a decidere quale sia il migliore. Per di più il re ha una corporatura eccezionale e diversa da quella degli altri sia per la grandezza, sia per lo splendore dei colori. Ma fra le api si distingue soprattutto perché è privo di pungiglione, mentre tutte le altre sono molto colleriche e sommamente combattive in proporzione alla loro corporatura, e lasciano il pungiglione nella ferita: la natura non ha voluto che il loro capo fosse crudele né che potesse compiere vendette che mettessero a repentaglio la sua vita, e per questo non gli ha dato l’arma e ha lasciato disarmata la sua ira. Ecco un esempio straordinario per i grandi re: la natura, infatti, usa esercitarsi nelle cose piccole traendo da esse gli insegnamenti per quelle più grandi. Dovremmo vergognarci di non ispirare i nostri costumi a questi animaletti, anche perché l’animo umano dev’essere tanto più moderato quanto maggiore è il male che può arrecare. Oh, se l’uomo seguisse la stessa legge e l’ira si spezzasse insieme alle sue armi, o non gli fosse consentito di nuocere più di una volta sola, né di soddisfare il proprio odio servendosi delle forze di altri! Il suo furore, infatti, si stancherebbe facilmente se per appagarsi dovesse ricorrere unicamente alla propria forza e se dovesse sfogare la sua ira pagando di persona. Ma nemmeno così la sua vita è sicura, poiché il principe deve necessariamente temere tanto quanto vuole essere temuto e tenere sotto controllo le mani di tutti, e anche se nessuno gli tende insidie teme sempre che si trami qualcosa contro di lui, sicché non vive un solo istante senza paura. Ma può uno rassegnarsi a condurre un’esistenza simile, quando, senza nuocere agli altri e standosene in pace, potrebbe esercitare il suo potere salutare con soddisfazione di tutti? Sbaglia chi ritiene che un re stia al sicuro là dove nulla sta al sicuro dal re: la sicurezza dell’uno si ottiene con la sicurezza dell’altro. Non serve che un sovrano eriga altissime rocche, fortifichi colli difficili a scalarsi, tagli a picco i fianchi dei monti o si circondi di torri e di molteplici mura quando la clemenza è in grado di garantirgli l’incolumità anche all’aperto. L’unico baluardo
inespugnabile è l’amore dei cittadini. Cosa c’è di più bello che vivere fra gente che desidera e si augura che tu viva, senza che alcuno ti sorvegli? Che suscitare negli animi, se la tua salute poco poco vacilla, non la speranza ma il timore? Che nessuno abbia alcunché di tanto prezioso da essere disposto a darlo in cambio per la salute del suo capo? Chi fa sì che tutti vivano per lui non è inferiore, quanto a felicità, neppure a dio. Chi oserebbe tendergli insidie dopo che egli abbia dimostrato con molti ragionamenti che non lo Stato appartiene a lui ma lui allo Stato? Chi non vorrebbe, potendolo, deviare i colpi della malasorte da questo principe sotto il cui scettro fioriscono la giustizia, la pace, la pudicizia, la sicurezza, la dignità e la città doviziosa abbonda di beni di ogni genere? Guarderemo a lui che ci governa con lo stesso animo con cui, se potessimo vederli, guarderemmo gli dèi immortali, pieni di venerazione e di riverenza. E che? Non è forse vicinissimo a loro chi ne segue la natura, chi è benevolo e generoso e usa del suo potere nel miglior modo? Bisogna tendere a questo comportamento, imitare questo modello, aspirare a essere considerato non solo Massimo ma al tempo stesso anche Ottimo. 18. Solitamente il principe punisce o per rendere giustizia a sé stesso o per vendicare altri. Esaminerò la prima eventualità, perché è più difficile trattenersi quando la vendetta è dovuta a un dolore personale che quando si voglia dare un esempio. Nel primo caso non serve ammonire il principe a non credere facilmente all’offesa, a ricercare la verità, a propendere per l’innocenza e a mostrare che si tratta di una questione non meno importante per il giudice che per l’imputato, visto che ciò riguarda la giustizia, non la clemenza. Dunque lo esortiamo a mantenere il dominio del suo animo, quando sia stato palesemente offeso, a condonare la pena, se potrà farlo senza correre rischi, e diversamente a mitigarla, a essere insomma molto più indulgente quando l’offeso è stato lui, non altri. Come infatti è di animo grande non colui che fa il generoso con ciò che appartiene ad altri, ma chi per donare toglie a sé stesso, così per me è clemente non colui che è indulgente verso il dolore altrui, ma colui che, soffrendo in prima persona, non salta su e capisce che è proprio di un animo grande sopportare le ingiurie quando ci si trova al massimo del potere e che non c’è alcuno più glorioso di un principe impunemente offeso. 19. Solitamente la vendetta produce due risultati: o consola colui che ha subìto l’offesa o dà sicurezza per il futuro. Ma la condizione di un principe è troppo alta perché egli abbia bisogno di consolazione e la sua forza è troppo evidente perché, per farsi credere forte, egli debba far del male agli altri. Parlo del caso in cui il principe sia stato aggredito e oltraggiato da individui di condizione inferiore, visto che quelli che un tempo erano suoi pari ora sono sotto di lui, sicché per questo egli si è già vendicato abbastanza. Anche uno schiavo, un serpente o una freccia possono uccidere un re: ma non salva se non colui che è più forte della persona che salva. Il principe, dunque, deve servirsi con fierezza
di questo dono degli dèi, quello, cioè, di dare e di togliere la vita. E soprattutto con coloro che una volta erano alla sua stessa altezza, per il fatto di avere su di loro diritto di vita o di morte, egli ha già ottenuto la più piena vendetta, quanto basti a infliggere una punizione: infatti, chi deve ad altri la vita è come se l’avesse perduta, e un sovrano, caduto dall’alto ai piedi del nemico, che decide della sua vita e del suo regno, sopravvive solo per dar gloria a colui che lo ha risparmiato contribuendo più da vivo che da morto alla fama di lui, poiché costituisce una testimonianza costante della clemenza altrui, mentre nel corteo del trionfo sarebbe passato in un fiat. E se un re lascia al vinto, oltre che la vita, anche il suo regno e addirittura, senza correre alcun rischio, lo rimette al posto da cui era caduto, a quel punto la gloria di lui, che di quella sola si è preoccupato, si accresce e s’innalza sino alle stelle. Ciò significa anche trionfare sulla propria vittoria e dimostrare di non aver trovato nulla fra i vinti che fosse degno del vincitore. Con i concittadini, con gli sconosciuti e con gli umili bisogna comportarsi con moderazione tanto maggiore quanto minore è l’importanza che siano abbattuti. Alcuni li risparmierai volentieri, altri ti renderanno odiosa la vendetta, e tu perciò trarrai indietro la mano, come si fa con quegli animaletti che se li schiacci ti sporcano, mentre coloro che, salvati e puniti, saranno sulla bocca di tutti i cittadini, ti offriranno l’occasione per far conoscere la tua clemenza. 20. Passiamo ora alle offese subìte da altri, nel vendicare le quali la legge persegue questi tre obiettivi, a cui deve tendere anche il principe: o correggere colui che punisce, o che la sua punizione renda migliori gli altri, o che, eliminati i malvagi, gli altri vivano più sicuri. I colpevoli li correggerai più facilmente con una pena minore, poiché chi non ha perduto completamente il proprio onore sta più attento a come comportarsi. Infatti, chi ha perso del tutto e definitivamente la propria dignità non se ne cura più, e il non poter più subire punizioni è un modo per sfuggire alle punizioni. I costumi dei cittadini, però, si correggono meglio se si punisce con moderazione: infatti il gran numero di peccatori accresce l’abitudine al peccato, e il valore della pena diminuisce se il numero delle condanne è elevato, mentre la severità quando è troppo frequente perde l’efficacia del rimedio, quello, cioè, di ispirare rispetto. È il principe che fonda i buoni costumi del suo Stato, lo purifica dai vizi se in qualche modo li sopporta, non come se li approvasse ma come chi li punisca contro voglia e con grande sofferenza. È proprio la clemenza di chi governa che rende vergognoso il peccare, poiché la pena imposta da un uomo mite sembra molto più grave. 21. Noterai poi che spesso vengono commesse proprio quelle colpe che vengono punite più frequentemente. Tuo padre in cinque anni ha fatto cucire nel sacco più persone di quante lo siano state in tutti i secoli passati. Finché il più grande sacrilegio, il parricidio, non era previsto dalla legge i figli osavano commetterlo in misura minore, perciò gli uomini più magnanimi e più esperti
della natura umana con grande buon senso preferirono ignorare questo delitto come una scelleratezza inconcepibile e al di là di ogni spregiudicatezza, piuttosto che dimostrare, con una punizione, che può venire commesso. Con questa legge i parricidi cominciarono a pullulare e fu la pena stessa che fornì l’idea di quel delitto; mai la pietà filiale si trovò in condizione peggiore di quando si cominciarono a vedere più sacchi che croci. In uno Stato in cui si punisce raramente si stabilisce una sorta di congiura in favore della moralità, a cui si bada come a un bene pubblico. Se i cittadini si considerano privi di colpe lo saranno e si adireranno maggiormente contro chi devia dalla rettitudine popolare se saranno pochi. È pericoloso mostrare ai cittadini che i cattivi sono più numerosi. 22. Un tempo fu decretato con un voto del Senato che gli schiavi per essere riconosciuti e distinguersi dagli uomini liberi dovessero vestirsi diversamente da loro. Poi, però, ci si rese conto del pericolo in cui saremmo incorsi se i nostri schiavi avessero cominciato a contarci. Ebbene, bisogna temere lo stesso pericolo se non si perdona a nessuno, poiché diversamente si scopre che la parte prevalente dei cittadini è quella peggiore. Un gran numero di supplizi non sono meno disonorevoli per un principe di quanto non lo siano per un medico tanti funerali. Si obbedisce meglio a chi governa con mitezza, poiché l’animo umano è per natura ostinato, si sforza di fronte a ciò che gli è contrario e difficile e segue più facilmente di quanto non si lasci condurre; come i cavalli generosi e nobili si governano meglio con un freno leggero, così l’innocenza spontaneamente per un impulso innato segue la clemenza, e i cittadini credono che la si debba mantenere per il proprio interesse. Perciò con questo sistema si ottiene meglio e di più. 23. La crudeltà è un male assolutamente inumano e indegno di un animo mite, è una rabbia bestiale godere del sangue e delle ferite, rinunciare alla propria natura e trasformarsi in un animale selvaggio. Che differenza c’è, infatti, dimmi, Alessandro, fra il gettare Lisimaco in pasto a un leone e lo sbranarlo tu stesso con i tuoi denti? Quella bocca spalancata è la tua, quella ferocia è la tua! Come vorresti avere tu quegli artigli e quelle fauci capaci di mangiare uomini! Noi non pretendiamo da te che questa tua mano, infallibilmente mortale ai tuoi amici, sia salutare a qualcuno, che il tuo animo feroce, insaziabilmente cattivo con gli uomini, si sazi prima di arrivare al sangue e alla strage: si compie già un atto di clemenza quando per uccidere un amico si fa ricorso a un carnefice. La principale ragione per cui la crudeltà è abominevole sta nel fatto che essa prima supera i limiti consueti, poi quelli umani, inventando nuovi supplizi, fa ricorso alla immaginazione per trovare strumenti con cui prolungare e rendere vario il dolore, gode dei mali degli uomini. E questo morbo funesto dell’animo arriva al culmine della follia quando la crudeltà si trasforma in voluttà e si prova piacere nell’uccidere un uomo. Ebbene, alle spalle di un uomo simile procedono ostilità, odi, veleni e spade, egli è minacciato da tanti pericoli quanti sono coloro per i
quali lui stesso rappresenta un pericolo ed è insidiato sia da congiure private sia da sollevazioni popolari, poiché mentre un danno privato è leggero e non induce alla ribellione intere città, quello che estende i suoi furori e minaccia tutti viene trafitto da ogni parte. I serpenti piccoli sfuggono alla vista e non si fanno battute pubbliche per trovarli, ma quando il fenomeno supera la misura consueta e diventa generale, contaminando col suo sputo le sorgenti, bruciando e schiacciando tutto ciò su cui soffia e su cui passa, bisogna aggredirlo con le balestre.19 Così i mali piccoli possono ingannarci e sfuggirci mentre i mali molto grandi devono essere affrontati. Analogamente un solo malato non porta scompiglio all’interno di casa sua, ma dove le morti sono frequenti tutti i cittadini gridano, fuggono e alzano le mani minacciose persino contro gli dèi. Se si vede una fiamma sotto un tetto la famiglia e i vicini vi gettano acqua ma un incendio che si è diffuso e ha già divorato molte case per essere soffocato richiede l’abbattimento di un intero quartiere. 24. La crudeltà dei privati è stata vendicata anche da schiavi che correvano il pericolo di una sicura crocifissione, ma quella dei tiranni l’hanno aggredita per distruggerla genti e popoli interi, sia coloro che ne avevano ricevuto del male sia coloro che potevano riceverlo. A volte le guardie stesse dei tiranni si sono levate contro di loro praticando su di essi quella perfidia, quella efferatezza, quella ferocia e tutto ciò che avevano imparato da loro. Cosa si può sperare, infatti, da colui a cui si è insegnato a essere cattivo? La scelleratezza non si mostra a lungo, né si limita al male che le viene comandato. Ma ammettiamo anche che la crudeltà stia al sicuro: che regno è il suo? Niente altro che l’immagine di una città espugnata dai nemici e l’aspetto terribile del terrore popolare. Tutto è triste, trepidante e confuso; si temono persino i piaceri, non si va tranquilli neppure ai banchetti, nei quali anche chi è ubriaco deve stare attento a come parla, né si va agli spettacoli dove c’è sempre chi cerca pretesti per accusare e compromettere qualcuno. Si spendono ingenti somme per questi spettacoli con regali e artisti di fama, ma a chi potrebbero giovare in un carcere? Che cos’è, buoni dèi, questo male di uccidere, di far soffrire, di compiacersi del rumore delle catene, di tagliare le teste dei cittadini, di versare sangue oltre ogni misura, dovunque si vada, di terrorizzare e di mettere in fuga la gente col proprio aspetto? Quale altra vita condurremmo se a regnare fossero gli orsi e i leoni, se fosse dato il potere su di noi ai serpenti o a qualunque altro animale nocivo? Quelle bestie prive di ragione, che noi condanniamo per la loro ferocia, non toccano gli animali della loro stessa specie, sicché il fatto che si somiglino è una garanzia di immunità: ma la rabbia dei tiranni non risparmia nemmeno i più vicini, anzi, pone sullo stesso piano i familiari e gli estranei, e quanto più si esercita, tanto più si eccita. Poi dalle uccisioni di singoli individui il tiranno passa all’annientamento di popoli interi, e giudica che sia una dimostrazione di potenza appiccare il fuoco alle case e radere al suolo antiche città; crede che sia disdicevole alla dignità imperiale ordinare la morte di una sola persona o di due,
e ritiene che la sua crudeltà sia troppo limitata se non espone ai suoi colpi un intero gregge di infelici. La tanto celebrata felicità consiste nel dare la salvezza a molti, nel richiamare dalla morte alla vita, nel meritare con la clemenza la corona civica.20 Nessun ornamento è più degno della grandezza di un principe e più bello di questa corona conferita «per aver salvato i cittadini»: né le armi nemiche sottratte ai vinti, né i carri macchiati del sangue dei barbari, né le spoglie conquistate in guerra. Salvare in massa e in nome dello Stato è potenza divina, mentre uccidere molti e senza discriminazione alcuna è potenza di crolli e d’incendi.
1. È Sesto Afranio Burro, capo dei pretoriani sotto Claudio e Nerone, poi tribuno e prefetto del pretorio. Fu con Seneca consigliere di Nerone. 2. Cfr. Svetonio, Nerone, 10. 3. Nel 54 d.C. Vologeso I, re dei Parti, occupò il territorio dell’Armenia, usurpato da Radamisto, e mise sul trono suo fratello Tiridate (Tacito, Annali, XIII 6, 1). 4. È un verso dell’Atreo di Accio ed era il motto preferito di Caligola. 5. Era il motto preferito di Tiberio. 6. Busiride, tiranno d’Egitto, figlio di Posidone, sacrificava a Zeus gli stranieri di passaggio dalla sua città. Fu ucciso da Èrcole. 7. Procruste, «colui che allunga a martellate», era il soprannome del predone Polipemone ucciso da Teseo. 8. Falaride, tiranno di Agrigento, famoso per la sua crudeltà, faceva morire bruciati dentro un toro di bronzo i colpevoli di lesa maestà. 9. Si riferisce a Muzio Scevola (cfr. Lettere, 24, 5 s.). 10. Si riferisce a Marco Curzio, cavaliere romano molto amato dal popolo, che per chiudere una voragine apertasi nel Foro, seguendo il responso degli aruspici (secondo cui tale voragine si sarebbe colmata solo se si fosse sacrificato in essa ciò che il popolo aveva di più prezioso), vi si gettò con le armi e col cavallo. 11. Virgilio, Georgiche, IV 212-213. 12. Lucio Cornelio Cinna, uomo politico (I sec. a.C.) e cognato di Cesare, fu con Lepido uno degli avversari di Silla e partecipò con lui al colpo di mano del 78. Eletto pretore nel 44, fu ritenuto uno degli assassini di Cesare. 13. Quinto Salvidieno Rufo fu condannato a morte nel 40. Il complotto di M. Lepido avvenne nel 30; quello di Terenzio Varrone Murena e di Fannio Cepione nel 22; quello di Rufo Ignazio nel 20. 14. Personaggi appartenenti alle famiglie più antiche e nobili. 15. C. Crispino Sallustio è il nipote dello storico; M. Cocceio Nerva è un antenato dell’imperatore Nerva. 16. Domizio è bisavolo di Nerone; Asinio Pollione e Valerio Messalla Corvino sono oratori del tempo di Augusto. 17. Dionigi il Vecchio (432-367 circa) fu tiranno di Siracusa. 18. Il culleum era un sacco in cui venivano chiusi con una scimmia o una vipera i parricidi, che poi erano gettati in acqua. 19. Allusione al serpente del fiume Bagrada che terrorizzò l’esercito di Attilio Regolo (Aulo Gellio, Notti Attiche, VII 3). 20. La corona civica veniva data a chi salvava in battaglia un cittadino.
De beneficiis
Liber primus 1. Inter multos ac varios errores temere inconsulteque viventium nihil propemodum, vir optime Liberalis, dixerim, quod beneficia nec dare scimus nec accipere. Sequitur enim, ut male conlocata male debeantur; de quibus non redditis sero querimur; ista enim perierunt, cum darentur. Nec mirum est inter plurima maximaque vitia nullum esse frequentius quam ingrati animi. Id evenire ex causis pluribus video. Prima illa est, quod non eligimus dignos, quibus tribuamus. Sed nomina facturi diligenter in patrimonium et vitam debitoris inquirimus, semina in solum effetum et sterile non spargimus: beneficia sine ullo dilectu magis proicimus quam damus. Nec facile dixerim, utrum turpius sit infitiari an repetere beneficium; id enim genus huius crediti est, ex quo tantum recipiendum sit, quantum ultro refertur; decoquere vero foedissimum ob hoc ipsum, quia non opus est ad liberandam fidem facultatibus sed animo; reddit enim beneficium, qui debet. Sed cum sit in ipsis crimen, qui ne confessione quidem grati sunt, in nobis quoque est. Multos experimur ingratos, plures facimus, quia alias graves exprobratores exactoresque sumus, alias leves et quos paulo post muneris sui paeniteat, alias queruli et minima momenta calumniantes; gratiam omnem corrumpimus non tantum postquam dedimus beneficia, sed dum damus. Quis nostrum contentus fuit aut leviter rogari aut semel? Quis non, cum aliquid a se peti suspicatus est, frontem adduxit, voltum avertit, occupationes simulavit, longis sermonibus et de industria non invenientibus exitum occasionem petendi abstulit et variis artibus necessitates properantes elusit, in angusto vero conprensus aut distulit, id est timide negavit, aut promisit, sed difficulter, sed subductis superciliis, sed malignis et vix exeuntibus verbis? Nemo autem libenter debet, quod non accepit, sed expressit. Gratus adversus eum esse quisquam potest, qui beneficium aut superbe abiecit aut iratus inpegit aut fatigatus, ut molestia careret, dedit? Errat, si quis sperat responsurum sibi, quem dilatione lassavit, expectatione torsit. Eodem animo beneficium debetur, quo datur, et ideo non est neglegenter dandum – sibi enim quisque debet, quod a nesciente accepit –; ne tarde quidem, quia, cum omni in officio magni aestimetur dantis voluntas, qui tarde fecit, diu noluit; utique non contumeliose: nam cum ita natura conparatum sit, ut altius iniuriae quam merita descendant et illa cito defluant, has tenax memoria custodiat, quid expectat, qui offendit, dum obligat? Satis adversus illum gratus est, si quis beneficio eius ignoscit. Non est autem, quod tardiores faciat ad bene merendum turba ingratorum. Nam primum, ut dixi, nos illam augemus; deinde ne deos quidem inmortales ab
hac tam effusa nec cessante benignitate sacrilegi neglegentesque eorum deterrent: utuntur natura sua et cuncta interque illa ipsos munerum suorum malos interpretes iuvant. Hos sequamur duces, quantum humana inbecillitas patitur; demus beneficia, non feneremus. Dignus est decipi, qui de recipiendo cogitavit, cum daret. At male cesserit. Et liberi et coniuges spem fefellerunt, tamen et educamus et ducimus, adeoque adversus experimenta pertinaces sumus, ut bella victi et naufragi maria repetamus. Quanto magis permanere in dandis beneficiis decet! quae si quis non dat, quia non recepit, dedit, ut reciperet, bonamque ingratorum facit causam, quibus turpe est non reddere, si licet. Quam multi indigni luce sunt! tamen dies oritur. Quam multi, quod nati sunt, queruntur! tamen natura subolem novam gignit ipsosque, qui non fuisse mallent, esse patitur. Hoc et magni animi et boni proprium est, non fructum beneficiorum sequi, sed ipsa et post malos quoque bonum quaerere. Quid magnifici erat multis prodesse, si nemo deciperet? Nunc est virtus dare beneficia non utique reditura, quorum a viro egregio statim fructus perceptus est. Adeo quidem ista res fugare nos et pigriores ad rem pulcherrimam facere non debet, ut, si spes mihi praecidatur gratum hominem reperiendi, malim non recipere beneficia quam non dare, quia, qui non dat, vitium ingrati antecedit. Dicam, quod sentio: qui beneficium non reddit, magis peccat; qui non dat, citius. 2. Beneficia in volgus cum largiri institueris, Perdenda sunt multa, ut semel ponas bene. In priore versu utrumque reprehendas; nam nec in volgum effundenda sunt, et nullius rei, minime beneficiorum, honesta largitio est; quibus si detraxeris iudicium, desinunt esse beneficia, in aliud quodlibet incident nomen. Sequens sensus mirificus est, qui uno bene posito beneficio multorum amissorum damna solatur. Vide, oro te, ne hoc et verius sit et magnitudini bene facientis aptius, ut illum hortemur ad danda, etiam si nullum bene positurus est. Illud enim falsum est «perdenda sunt multa»; nullum perit, quia, qui perdit, conputaverat. Beneficiorum simplex ratio est: tantum erogatur; si redit aliquid, lucrum est, si non redit, damnum non est. Ego illud dedi, ut darem. Nemo beneficia in calendario scribit nec avarus exactor ad horam et diem appellat. Numquam illa vir bonus cogitat nisi admonitus a reddente; alioqui in formam crediti transeunt. Turpis feneratio est beneficium expensum ferre. Qualiscumque priorum eventus est, persevera in alios conferre; melius apud ingratos iacebunt, quos aut pudor aut occasio aut imitatio aliquando gratos poterit efficere. Ne cessaveris, opus tuum perage et partes boni viri exequere. Alium re, alium fide, alium gratia, alium consilio, alium praeceptis salubribus adiuva. Officia etiam ferae sentiunt, nec ullum tam inmansuetum animal est, quod non cura mitiget et in amorem sui vertat. Leonum ora a magistris inpune tractantur, elephantorum feritatem usque in servile obsequium demeretur cibus; adeo etiam,
quae extra intellectum atque aestimationem beneficii posita sunt, adsiduitas tamen meriti pertinacis evincit. Ingratus est adversus unum beneficium? Adversus alterum non erit; duorum oblitus est? Tertium etiam in eorum, quae exciderunt, memoriam reducet. 3. Is perdet beneficia, qui cito se perdidisse credit; at qui instat et onerat priora sequentibus, etiam ex duro et inmemori pectore gratiam extundit. Non audebit adversus multa oculos adtollere; quocumque se convertit memoriam suam fugiens, ibi te videat: beneficiis illum tuis cinge. Quorum quae vis quaeve proprietas sit, dicam, si prius illa, quae ad rem non pertinent, transilire mihi permiseris, quare tres Gratiae et quare sorores sint, et quare manibus inplexis, et quare ridentes et iuvenes et virgines solutaque ac perlucida veste. Alii quidem videri volunt unam esse, quae det beneficium, alteram, quae accipiat, tertiam, quae reddat; alii tria beneficorum esse genera, promerentium, reddentium, simul accipientium reddentiumque. Sed utrumlibet ex istis iudica verum: quid ista nos scientia iuvat? Quid ille consertis manibus in se redeuntium chorus? Ob hoc, quia ordo beneficii per manus transeuntis nihilo minus ad dantem revertitur et totius speciem perdit, si usquam interruptus est, pulcherrimus, si cohaeret et vices servat. In eo est aliqua tamen maioris dignatio, sicut promerentium. Voltus hilari sunt, quales solent esse, qui dant vel accipiunt beneficia; iuvenes, quia non debet beneficiorum memoria senescere; virgines, quia incorrupta sunt et sincera et omnibus sancta; in quibus nihil esse adligati decet nec adstricti: solutis itaque tunicis utuntur; perlucidis autem, quia beneficia conspici volunt. Sit aliquis usque eo Graecis emancipatus, ut haec dicat necessaria; nemo tamen erit, qui etiam illud ad rem iudicet pertinere, quae nomina illis Hesiodus inposuerit. Aglaien maximam natu adpellavit, mediam Euphrosynen, tertiam Thaliam. Horum nominum interpretationem, prout cuique visum est, deflectit et ad rationem aliquam conatur perducere, cum Hesiodus puellis suis, quod voluit, nomen inposuerit. Itaque Homerus uni mutavit, Pasithean adpellavit et in matrimonium promisit, ut scias non esse illas virgines Vestales. Inveniam alium poetam, apud quem praecingantur et spissis aut Phryxianis prodeant. Ergo et Mercurius una stat, non quia beneficia ratio conmendat vel oratio, sed quia pictori ita visum est. Chrysippus quoque, penes quem subtile illud acumen est et in imam penetrans veritatem, qui rei agendae causa loquitur et verbis non ultra, quam ad intellectum satis est, utitur, totum librum suum his ineptiis replet, ita ut de ipso officio dandi, accipiendi, reddendi beneficii pauca admodum dicat; nec his fabulas, sed haec fabulis inserit. Nam praeter ista, quae Hecaton transcribit, tres Chrysippus Gratias ait Iovis et Eurynomes filias esse, aetate autem minores quam Horas, sed meliuscula facie et ideo Veneri datas comites. Matris quoque nomen ad rem iudicat pertinere: Eurynomen enim dictam, quia late patentis patrimonii sit beneficia dividere; tamquam matri post filias soleat nomen inponi aut poetae vera
nomina reddant. Quemadmodum nomenclatori memoriae loco audacia est et, cuicumque nomen non potest reddere, inponit, ita poetae non putant ad rem pertinere verum dicere, sed aut necessitate coacti aut decore corrupti id quemque vocari iubent, quod belle facit ad versum. Nec illis fraudi est, si aliud in censum detulerunt; proximus enim poeta suum illas ferre nomen iubet. Hoc ut scias ita esse, ecce Thalia, de qua cum maxime agitur, apud Hesiodum Charis est, apud Homerum Musa. 4. Sed ne faciam, quod reprehendo, omnia ista, quae ita extra rem sunt, ut ne circa rem quidem sint, relinquam. Tu modo nos tuere, si quis mihi obiciet, quod Chrysippum in ordinem coegerim, magnum mehercules virum, sed tamen Graecum, cuius acumen nimis tenue retunditur et in se saepe replicatur; etiam cum agere aliquid videtur, pungit, non perforat. Hic vero quod acumen est? De beneficiis dicendum est et ordinanda res, quae maxime humanam societatem adligat; danda lex vitae, ne sub specie benignitatis inconsulta facilitas placeat, ne liberalitatem, quam nec deesse oportet nec superfluere, haec ipsa observatio restringat, dum temperat; docendi sunt libenter dare, libenter accipere, libenter reddere et magnum ipsis certamen proponere, eos, quibus obligati sunt, re animoque non tantum aequare sed vincere, quia, qui referre gratiam debet, numquam consequitur, nisi praecessit; hi docendi sunt nihil inputare, illi plus debere. Ad hanc honestissimam contentionem beneficiis beneficia vincendi sic nos adhortatur Chrysippus, ut dicat verendum esse, ne, quia Charites Iovis filiae sunt, parum se grate gerere sacrilegium sit et tam bellis puellis fiat iniuria. Tu me aliquid eorum doce, per quae beneficentior gratiorque adversus bene merentes fiam, per quae obligantium obligatorumque animi certent, ut, qui praestiterunt, obliviscantur, pertinax sit memoria debentium. Istae vero ineptiae poetis relinquantur, quibus aures oblectare propositum est et dulcem fabulam nectere. At qui ingenia sanare et fidem in rebus humanis retinere, memoriam officiorum ingerere animis volunt, serio loquantur et magnis viribus agant; nisi forte existimas levi ac fabuloso sermone et anilibus argumentis prohiberi posse rem perniciosissimam, beneficiorum novas tabulas. 5. Sed quemadmodum supervacua transcurram, ita exponam necesse est hoc primum nobis esse discendum, quid accepto beneficio debeamus. Debere enim se ait alius pecuniam, quam accepit, alius consulatum, alius sacerdotium, alius provinciam. Ista autem sunt meritorum signa, non merita. Non potest beneficium manu tangi: res animo geritur. Multum interest inter materiam beneficii et beneficium; itaque nec aurum nec argentum nec quicquam eorum, quae pro maximis accipiuntur, beneficium est, sed ipsa tribuentis voluntas. Inperiti autem id, quod oculis incurrit et quod traditur possideturque, solum notant, cum contra illud, quod in re carum atque pretiosum. Haec, quae tenemus, quae aspicimus, in quibus cupiditas nostra haeret, caduca sunt, auferre nobis et fortuna et iniuria
potest; beneficium etiam amisso eo, per quod datum est, durat; est enim recte factum, quod inritum nulla vis efficit. Amicum a piratis redemi, hunc alius hostis excepit et in carcerem condidit: non beneficium, sed usum beneficii mei sustulit. Ex naufragio alicui raptos vel ex incendio liberos reddidi, hos vel morbus vel aliqua fortuita iniuria eripuit: manet etiam sine illis, quod in illis datum est. Omnia itaque, quae falsum beneficii nomen usurpant, ministeria sunt, per quae se voluntas amica explicat. Hoc in aliis quoque rebus evenit, ut aliubi sit species rei, aliubi ipsa res. Imperator aliquem torquibus, murali et civica donat: quid habet per se corona pretiosum? Quid praetexta? Quid fasces? Quid tribunal et currus? Nihil horum honor est, sed honoris insigne. Sic non est beneficium id, quod sub oculos venit, sed beneficii vestigium et nota. 6. Quid est ergo beneficium? Benevola actio tribuens gaudium capiensque tribuendo in id, quod facit, prona et sponte sua parata. Itaque non, quid fiat aut quid detur, refert, sed qua mente, quia beneficium non in eo, quod fit aut datur, consistit, sed in ipso dantis aut facientis animo. Magnum autem esse inter ista discrimen vel ex hoc intellegas licet, quod beneficium utique bonum est, id autem, quod fit aut datur, nec bonum nec malum est. Animus est, qui parva extollit, sordida inlustrat, magna et in pretio habita dehonestat; ipsa, quae adpetuntur, neutram naturam habent, nec boni nec mali: refert, quo illa rector inpellat, a quo forma rebus datur. Non est beneficium ipsum, quod numeratur aut traditur, sicut ne in victimis quidem, licet opimae sint auroque praefulgeant, deorum est honor sed ‹in› recta ac pia voluntate venerantium. Itaque boni etiam farre ac fitilla religiosi sunt; mali rursus non effugiunt inpietatem, quamvis aras sanguine multo cruentaverint. 7. Si beneficia in rebus, non in ipsa bene faciendi voluntate consisterent, eo maiora essent, quo maiora sunt, quae accipimus. Id autem falsum est; non numquam enim magis nos obligat, qui dedit parva magnifice, qui «regum aequavit opes animo», qui exiguum tribuit sed libenter, qui paupertatis suae oblitus est, dum meam respicit, qui non voluntatem tantum iuvandi habuit sed cupiditatem, qui accipere se putavit beneficium, cum daret, qui dedit tamquam ‹non› recepturus, recepit, tamquam non dedisset, qui occasionem, qua prodesset, et occupavit et quaesiit. Contra ingrata sunt, ut dixi, licet re ac specie magna videantur, quae danti aut extorquentur aut excidunt, multoque gratius venit, quod facili quam quod plena manu datur. Exiguum est, quod in me contulit, sed amplius non potuit; at hic quod dedit, magnum est, sed dubitavit, sed distulit, sed, cum daret, gemuit, sed superbe dedit, sed circumtulit et placere non ei, cui praestabat, voluit; ambitioni dedit, non mihi. 8. Socrati cum multa pro suis quisque facultatibus offerrent, Aeschines, pauper auditor: «Nihil» inquit «dignum te, quod dare tibi possim, invenio et hoc uno modo pauperem esse me sentio. Itaque dono tibi, quod unum habeo, me
ipsum. Hoc munus rogo, qualecumque est, boni consulas cogitesque alios, cum multum tibi darent, plus sibi reliquisse». Cui Socrates: «Quidni tu» inquit «magnum munus mihi dederis, nisi forte te parvo aestimas? Habebo itaque curae, ut te meliorem tibi reddam, quam accepi». Vicit Aeschines hoc munere Alcibiadis parem divitiis animum et omnem iuvenum opulentorum munificentiam. 9. Vides, quomodo animus inveniat liberalitatis materiam etiam inter angustias? Videtur mihi dixisse: «Nihil egisti, fortuna, quod me pauperem esse voluisti; expediam dignum nihilo minus huic viro munus, et quia de tuo non possum, de meo dabo». Neque est, quod existimes illum vilem sibi fuisse: pretium se sui fecit. Ingeniosus adulescens invenit, quemadmodum Socraten sibi daret. Non quanta quaeque sint, sed a quali profecta, prospiciendum. Callidus non difficilem aditum praebuit inmodica cupientibus spesque inprobas nihil re adiuturus verbis fovit; at peior opinio, si lingua asper, voltu gravis cum invidia fortunam suam explicuit. Colunt enim detestanturque felicem et, si potuerint, eadem facturi odere facientem. Coniugibus alienis ne clam quidem sed aperte ludibrio habitis suas aliis permisere. Rusticus, inhumanus ac mali moris et inter matronas abominandus convicio est, si quis coniugem suam in sella prostare vetuit et vulgo admissis inspectoribus vehi perspicuam undique. Si quis nulla se amica fecit insignem nec alienae uxori annuum praestat, hunc matronae humilem et sordidae libidinis et ancillariolum vocant. Inde decentissimum sponsaliorum genus est adulterium et in consensu viduitas caelibatusque: nemo uxorem duxit, nisi qui abduxit. Iam rapta spargere, sparsa fera et acri avaritia recolligere certant, nihil pensi habere, paupertatem alienam contemnere, suam ‹magis› quam ullum aliud vereri malum, pacem iniuriis perturbare, inbecilliores vi ac metu premere. Nam provincias spoliari et nummarium tribunal audita utrimque licitatione alteri addici non mirum, quoniam, quae emeris, vendere gentium ius est. 10. Sed longius nos inpetus evehit provocante materia; itaque sic finiamus, ne in nostro saeculo culpa subsidat. Hoc maiores nostri questi sunt, hoc nos querimur, hoc posteri nostri querentur, eversos mores, regnare nequitiam, in deterius res humanas et omne nefas labi; at ista eodem stant loco stabuntque, paulum dumtaxat ultro aut citro mota, ut fluctus, quos aestus accedens longius extulit, recedens interiore litorum vestigio tenuit. Nunc in adulteria magis quam in alia peccabitur, abrumpetque frenos pudicitia; nunc conviviorum vigebit furor et foedissimum patrimoniorum exitium, culina; nunc cultus corporum nimius et formae cura prae se ferens animi deformitatem; nunc in petulantiam et audaciam erumpet male dispensata libertas; nunc in crudelitatem privatam ac publicam ibitur bellorumque civilium insaniam, qua omne sanctum ac sacrum profanetur; habebitur aliquando ebrietati honor, et plurimum meri cepisse virtus erit. Non expectant uno loco vitia, sed mobilia et inter se dissidentia tumultuantur, pellunt in vicem fuganturque; ceterum idem semper de nobis pronuntiare debebimus,
malos esse nos, malos fuisse, – invitus adiciam, et futuros esse. Erunt homicidae, tyranni, fures, adulteri, raptores, sacrilegi, proditores; infra omnia ista ingratus est, nisi quod omnia ista ab ingrato sunt, sine quo vix ullum magnum facinus adcrevit. Hoc tu cave tamquam maximum crimen ne admittas, ignosce tamquam levissimo, si admissum est. Haec est enim iniuriae summa: beneficium perdidisti. Salvum est enim tibi ex illo, quod est optimum: dedisti. Quemadmodum autem curandum est, ut in eos potissimum beneficia conferamus, qui grate responsuri erunt, ita quaedam, etiam si male de illis sperabitur, faciemus tribuemusque, non solum si iudicabimus ingratos fore, sed si sciemus fuisse. Tamquam si filios alicui restituere potero magno periculo liberatos sine ullo meo, non dubitabo. Dignum etiam inpendio sanguinis mei tuebor et in partem discriminis veniam; indignum si eripere latronibus potero clamore sublato, salutarem vocem homini non pigebit emittere. 11. Sequitur, ut dicamus, quae beneficia danda sint et quemadmodum. Primum demus necessaria, deinde utilia, deinde iocunda, utique mansura. Incipiendum est autem a necessariis; aliter enim ad animum pervenit, quod vitam continet, aliter, quod exornat aut instruit. Potest in eo aliquis fastidiosus esse aestimator, quo facile cariturus est, de quo dicere licet: «Recipe, non desidero; meo contentus sum». Interim non reddere tantum libet, quod acceperis, sed abicere. Ex his, quae necessaria sunt, quaedam primum optinent locum, sine quibus non possumus vivere, quaedam secundum, sine quibus non debemus, quaedam tertium, sine quibus nolumus. Prima huius notae sunt: hostium manibus eripi et tyrannicae irae et proscriptioni et aliis periculis, quae varia et incerta humanam vitam obsident. Quidquid horum discusserimus, quo maius ac terribilius erit, hoc maiorem inibimus gratiam; subit enim cogitatio, quantis sint liberati malis, et lenocinium est muneris antecedens metus. Nec tamen ideo debemus tardius quemquam servare, quam possumus, ut muneri nostro timor inponat pondus. Proxima ab his sunt, sine quibus possumus quidem vivere, sed ut mors potior sit, tamquam libertas et pudicitia et mens bona. Post haec habebimus coniunctione ac sanguine usuque et consuetudine longa cara, ut liberos, coniuges, penates, cetera, quae usque eo animus sibi adplicuit, ut ab illis quam vita divelli gravius existimet. Subsecuntur utilia, quorum varia et lata materia est; hic erit pecunia non superfluens sed ad sanum modum habendi parata; hic erit honor et processus ad altiora tendentium; nec enim utilius quicquam est quam sibi utilem fieri. Iam cetera ex abundanti veniunt delicatos factura; in his sequemur, ut opportunitate grata sint, ut non volgaria, quaeque aut pauci habuerint aut pauci intra hanc aetatem aut hoc modo, quae, etiam si natura pretiosa non sunt, tempore aut loco fiant. Videamus, quid oblatum maxime voluptati futurum sit, quid frequenter occursurum habenti, ut totiens nobiscum quotiens cum illo sit; utique cavebimus, ne munera supervacua mittamus, ut feminae aut seni arma venatoria, ut rustico libros, ut studiis ac litteris dedito retia. Aeque ex contrario circumspiciemus, ne, dum grata mittere volumus, suum cuique morbum
exprobratura mittamus, sicut ebrioso vina et valetudinario medicamenta. Maledictum enim incipit esse, non munus, in quo vitium accipientis adgnoscitur. 12. Si arbitrium dandi penes nos est, praecipue mansura quaeremus, ut quam minime mortale munus sit. Pauci enim sunt tam grati, ut, quid acceperint, etiam si non vident, cogitent. Ingratos quoque memoria cum ipso munere incurrit, ubi ante oculos est et oblivisci sui non sinit, sed auctorem suum ingerit et inculcat. Eo quidem magis duratura quaeramus, quia numquam admonere debemus; ipsa res evanescentem memoriam excitet. Libentius donabo argentum factum quam signatum; libentius statuas quam vestem et quod usus brevis deterat. Apud paucos post rem manet gratia; plures sunt, apud quos non diutius in animo sunt donata, quam in usu. Ego, si fieri potest, consumi munus meum nolo; extet, haereat amico meo, convivat. Nemo tam stultus est, ut monendus sit, ne cui gladiatores aut venationem iam munere edito mittat et vestimenta aestiva bruma, hiberna solstitio. Sit in beneficio sensus communis; tempus, locum observet, personas, quia momentis quaedam grata et ingrata sunt. Quanto acceptius est, si id damus, quod quis non habet, quam cuius copia abundat? Quod diu quaerit nec invenit, quam quod ubique visurus est? Munera non tam pretiosa quam rara et exquisita sint, quae etiam apud divitem sibi locum faciant, sicut gregalia quoque poma et post paucos dies itura in fastidium delectant, si provenere maturius. Illa quoque non erunt sine honore, quae aut nemo illis alius dedit aut nos nulli alii. 13. Alexandro Macedoni, cum victor Orientis animos supra humana tolleret, Corinthii per legatos gratulati sunt et civitate illum sua donaverunt. Cum risisset hoc Alexander officii genus, unus ex legatis: «Nulli» inquit «civitatem umquam dedimus alii quam tibi et Herculi». Libens accepti non dilutum honorem et legatos invitatione aliaque humanitate prosecutus cogitavit, non qui sibi civitatem darent, sed cui dedissent; et homo gloriae deditus, cuius nec naturam nec modum noverat, Herculis Liberique vestigia sequens ac ne ibi quidem resistens, ubi illa defecerant, ad socium honoris sui respexit a dantibus, tamquam caelum, quod mente vanissima conplectebatur, teneret, quia Herculi aequabatur. Quid enim illi simile habebat vesanus adulescens, cui pro virtute erat felix temeritas? Hercules nihil sibi vicit; orbem terrarum transivit non concupiscendo, sed iudicando, quid vinceret, malorum hostis, bonorum vindex, terrarum marisque pacator; at hic a pueritia latro gentiumque vastator, tam hostium pernicies quam amicorum, qui summum bonum duceret terrori esse cunctis mortalibus, oblitus non ferocissima tantum, sed ignavissima quoque animalia timeri ob malum virus. 14. Ad propositum nunc revertamur. Beneficium qui quibuslibet dat, nulli gratum dat; nemo se stabularii aut cauponis hospitem iudicat nec convivam dantis epulum, ubi dici potest: «Quid enim in me contulit? Nempe hoc, quod et in illum vix bene notum sibi et in illum etiam inimicum ac turpissimum hominem.
Numquid enim me dignum iudicavit? Morbo suo morem gessit». Quod voles gratum esse, rarum effice: quivis patitur sibi inputari. Nemo haec ita interpretetur, tamquam reducam liberalitatem et frenis artioribus reprimam; illa vero, in quantum libet, exeat, sed eat, non erret. Licet ita largiri, ut unusquisque, etiam si cum multis accepit, in populo se esse non putet. Nemo non habeat aliquam familiarem notam, per quam speret se propius admissum; dicat: «Accepi idem, quod ille, sed ultro. Accepi, quod ille, sed ego intra breve tempus, cum ille diu meruisset. Sunt, qui idem habeant, sed non eisdem verbis datum, non eadem comitate tribuentis. Ille accepit, cum rogasset; ego non rogaram. Ille accepit, sed facile redditurus, sed cuius senectus et libera orbitas magna promittebat; mihi plus dedit, quamvis idem dederit, quia sine spe recipiendi dedit». Quemadmodum meretrix ita inter multos se dividet, ut nemo non aliquod signum familiaris animi ferat, ita, qui beneficia sua amabilia esse vult, excogitet, quomodo et multi obligentur et tamen singuli habeant aliquid, quo se ceteris praeferant. 15. Ego vero beneficiis non obicio moras; quo plura maioraque fuerint, plus adferent laudis. At sit iudicium; neque enim cordi esse cuiquam possunt forte ac temere data. Quare si quis existimat nos, cum ista praecipimus, benignitatis fines introrsus referre et illi minus laxum limitem aperire, ne perperam monitiones nostras exaudit. Quam enim virtutem magis veneramur? Cui magis stimulos addimus? Quibusve tam convenit haec adhortatio quam nobis societatem generis humani sancientibus? Quid ergo est? Cum sit nulla honesta vis animi, etiam si a recta voluntate incepit, nisi quam virtutem modus fecit, veto liberalitatem nepotari. Tunc iuvat accepisse beneficium et supinis quidem manibus, ubi illud ratio ad dignos perducit, non quolibet casus et consilii indigens inpetus defert; quod ostentare libet et inscribere sibi. Beneficia tu vocas, quorum auctorem fateri pudet? At illa quanto gratiora sunt quantoque in partem interiorem animi numquam exitura descendunt, cum delectant cogitantem magis a quo, quam quid acceperis? Crispus Passienus solebat dicere quorundam se iudicium malle quam beneficium, quorundam beneficium malle quam iudicium, et subiciebat exempla: «Malo» aiebat «divi Augusti iudicium, malo Claudii beneficium». Ego vero nullius puto expetendum esse beneficium, cuius vile iudicium est. Quid ergo? Non erat accipiendum a Claudio, quod dabatur? Erat, sed sicut a fortuna, quam scires posse statim malam fieri. Quid ista inter se mixta dividimus? Non est beneficium, cui deest pars optima, datum esse iudicio; alioqui pecunia ingens, si non ratione nec recta voluntate donata est, non magis beneficium est quam thesaurus. Multa sunt autem, quae oportet accipere nec debere.
Liber secundus 1. Inspiciamus, Liberalis virorum optime, id quod ex priori parte adhuc superest, quemadmodum dandum sit beneficium; cuius rei expeditissimam videor monstraturus viam: sic demus, quomodo vellemus accipere. Ante omnia libenter, cito, sine ulla dubitatione; ingratum est beneficium, quod diu inter dantis manus haesit, quod quis aegre dimittere visus est et sic dare, tamquam sibi eriperet. Etiam si quid intervenit morae, evitemus omni modo, ne deliberasse videamur; proximus est a negante, qui dubitavit, nullamque iniit gratiam. Nam cum in beneficio iucundissima sit tribuentis voluntas, quia nolentem se tribuisse ipsa cunctatione testatus est, non dedit sed adversus ducentem male retinuit; multi autem sunt, quos liberales facit frontis infirmitas. Gratissima sunt beneficia parata, facilia, occurrentia, ubi nulla mora fuit nisi in accipientis verecundia. Optimum est antecedere desiderium cuiusque, proximum sequi; illud melius, occupare ante quam rogemur, quia, cum homini probo ad rogandum os concurrat et subfundatur rubor, qui hoc tormentum remittit, multiplicat munus suum. Non tulit gratis, qui, cum rogasset, accepit, quoniam quidem, ut maioribus nostris gravissimis viris visum est, nulla res carius constat, quam quae precibus empta est. Vota homines parcius facerent, si palam facienda essent; adeo etiam deos, quibus honestissime supplicamus, tacite malumus et intra nosmet ipsos precari. 2. Molestum verbum est, onerosum, demisso voltu dicendum, rogo. Huius facienda est gratia amico et quemcumque amicum sis promerendo facturus; properet licet, sero beneficium dedit, qui roganti dedit. Ideo divinanda cuiusque voluntas et, cum intellecta est, necessitate gravissima rogandi liberanda est; illud beneficium iucundum victurum in animo scias, quod obviam venit. Si non contigit praevenire, plura rogantis verba intercidamus; ne rogati videamur sed certiores facti, statim promittamus facturosque nos, etiam ante quam interpellemur, ipsa festinatione adprobemus. Quemadmodum in aegris opportunitas cibi salutaris est et aqua tempestive data remedii locum optinuit, ita, quamvis leve et volgare beneficium est, si praesto fuit, si proximam quamque horam non perdidit, multum sibi adicit gratiamque pretiosi sed lenti et diu cogitati muneris vincit. Qui tam parate facit, non est dubium, quin libenter faciat; itaque laetus facit et induit sibi animi sui voltum. 3. Ingentia quorundam beneficia silentium aut loquendi tarditas imitata gravitatem et tristitiam corrupit, cum promitterent voltu negantium; quanto melius adicere bona verba rebus bonis et praedicatione humana benignaque conmendare, quae praestes! Ut ille se castiget, quod tardior in rogando fuit, adicias licet familiarem querellam: «Irascor tibi, quod, cum aliquid desiderasses, non olim scire me voluisti, quod tam diligenter rogasti, quod quemquam adhibuisti. Ego
vero gratulor mihi, quod experiri animum meum libuit; postea, quidquid desiderabis, tuo iure exiges; semel rusticitati tuae ignoscitur». Sic efficies, ut animum tuum pluris aestimet quam illud, quidquid est, ad quod petendum venerat. Tunc est summa virtus tribuentis, tunc benignitas, ubi ille, qui discessit, dicet sibi: «Magnum hodie lucrum feci; malo, quod illum talem inveni, quam si multiplicatum hoc ad me, de quo loquebar, alia via pervenisset; huic eius animo numquam parem gratiam referam». 4. At plerique sunt, qui beneficia asperitate verborum et supercilio in odium adducunt eo sermone usi, ea superbia, ut inpetrasse paeniteat. Aliae deinde post rem promissam secuntur morae; nihil autem est acerbius, quam ubi quoque, ‹quod› inpetrasti, rogandum est. Repraesentanda sunt beneficia, quae a quibusdam accipere difficilius est quam inpetrare. Hic rogandus est, ut admoneat, ille, ut consummet; sic unum munus per multorum manus teritur, ex quo gratiae minimum apud promittentem remanet, quia auctori detrahit, quisquis post illum rogandus est. Hoc itaque curae hebebis, si grate aestimari, quae praestabis, voles, ut beneficia tua inlibata, ut integra ad eos, quibus promissa sunt, perveniant, sine ulla, quod aiunt, deductione. Nemo illa intercipiat, nemo detineat; nemo in eo, quod daturus es, gratiam suam facere potest, ut non tuam minuat. 5. Nihil aeque amarum quam diu pendere; aequiore quidam animo ferunt praecidi spem suam quam trahi. Plerisque autem hoc vitium est ambitione prava differendi promissa, ne minor sit rogantium turba, quales regiae potentiae ministri sunt, quos delectat superbiae suae longum spectaculum, minusque se iudicant posse, nisi diu multumque singulis, quid possint, ostenderint. Nihil confestim, nihil semel faciunt; iniuriae illorum praecipites, lenta beneficia sunt. Quare verissimum existima, quod ille comicus dixit: Quid? Tu non intellegis tantum te gratiae demere, quantum morae adicis? Inde illae voces, quas ingenuus dolor exprimit: «Fac, si quid facis» et: «Nihil tanti est; malo mihi iam neges». Ubi in taedium adductus animus incipit beneficium odisse, dum expectat, potest ob id gratus esse? Quemadmodum acerbissima crudelitas est, quae trahit poenam, et misericordiae genus est cito occidere, quia tormentum ultimum finem sui secum adfert, quod antecedit tempus, maxima venturi supplicii pars est, ita maior est muneris gratia, quo minus diu pependit. Est enim etiam bonarum rerum sollicita expectatio, et cum plurima beneficia remedium alicuius rei adferant, qui aut diutius torqueri patitur, quem protinus potest liberare, aut tardius gaudere, beneficio suo manus adfert. Omnis benignitas properat, et proprium est libenter facientis cito facere; qui tarde et diem de die extrahens profuit, non ex animo
fecit. Ita duas res maximas perdidit, et tempus et argumentum amicae voluntatis; tarde velle nolentis est. 6. In omni negotio, Liberalis, non minima portio est, quomodo quidque aut dicatur aut fiat. Multum celeritas adiecit, multum abstulit mora. Sicut in telis eadem ferri vis est, sed infinitum interest, utrum excusso lacerto torqueantur an remissa manu effluant, gladius idem et stringit et transforat, quam presso articulo venerit, refert, ‹ita› idem est, quod datur, sed interest, quomodo detur. Quam dulce, quam pretiosum est, si gratias sibi agi non est passus, qui dedit, si dedisse, dum dat, oblitus est! Nam corripere eum, cui cum maxime aliquid praestes, dementia est et inserere contumeliam meritis. Itaque non sunt exasperanda beneficia nec quicquam illis triste miscendum. Etiam si quid erit, de quo velis admonere, aliud tempus eligito. 7. Fabius Verrucosus beneficium ab homine duro aspere datum panem lapidosum vocabat, quem esurienti accipere necessarium sit, esse acerbum. Ti. Caesar rogatus a Nepote Mario praetorio, ut aeri alieno eius succurreret, edere illum sibi nomina creditorum iussit; hoc non est donare sed creditores convocare. Cum edita essent, scripsit Nepoti iussisse se pecuniam solvi adiecta contumeliosa admonitione; effecit, ut Nepos nec aes alienum haberet nec beneficium: liberavit illum a creditoribus, sibi non obligavit. Aliquid Tiberius secutus est; puto, noluit plures esse, qui idem rogaturi concurrerent. Ista fortasse efficax ratio fuerit ad hominum inprobas cupiditates pudore reprimendas, beneficium vero danti tota alia sequenda est via. Omni genere, quod des, quo sit acceptatius, adornandum est; hoc vero non est beneficium dare, deprehendere est. 8. Et ut in transitu de hac quoque parte dicam, quid sentiam, ne principi quidem satis decorum est donare ignominiae causa. «Tamen» inquit «effugere Tiberius ne hoc quidem modo, quod vitabat, potuit; nam aliquot postea, qui idem rogarent, inventi sunt, quos omnes iussit reddere in senatu aeris alieni causas, et ita illis certas summas dedit». Non est illud liberalitas, censura est; auxilium est, principale tributum est: beneficium non est, cuius sine rubore meminisse non possum. Ad iudicem missus sum; ut inpetrarem, causam dixi. 9. Praecipiunt itaque omnes auctores sapientiae quaedam beneficia palam danda, quaedam secreto: palam, quae consequi gloriosum, ut militaria dona, ut honores et quidquid aliud notitia pulchrius fit; rursus, quae non producunt nec honestiorem faciunt, sed succurrunt infirmitati, egestati, ignominiae, tacite danda sunt, ut nota sint solis, quibus prosunt. 10. Interdum etiam ipse, qui iuvatur, fallendus est, ut habeat nec, a quo acceperit, sciat. Arcesilan aiunt amico pauperi et paupertatem suam dissimulanti, aegro autem et ne hoc quidem confitenti deesse sibi in sumptum ad necessarios
usus, clam succurrendum iudicasse; pulvino eius ignorantis sacculum subiecit, ut homo inutiliter verecundus, quod desiderabat, inveniret potius quam acciperet. «Quid ergo? Ille nesciet, a quo acceperit?» Primum nesciat, si hoc ipsum beneficii pars est; deinde multa alia faciam, multa tribuam, per quae intellegat et illius auctorem; denique ille nesciet accepisse se, ego sciam me dedisse. «Parum est» inquis. Parum, si fenerare cogitas; sed si dare, quo genere accipienti maxime profuturum erit, dabis. Contentus eris te teste; alioqui non bene facere delectat sed videri bene fecisse. «Volo utique sciat». Debitorem quaeris. «Volo utique sciat». Quid? Si illi utilius est nescire, si honestius, si gratius, non in aliam partem abibis? «Volo sciat». Ita tu hominem non servabis in tenebris? Non nego, quotiens patitur res, respiciendum gaudium ex accipientis voluntate; sin adiuvari illum et oportet et pudet, si, quod praestamus, offendit, nisi absconditur, beneficium in acta non mitto. Quidni? Ego illi non sum indicaturus me dedisse, cum inter prima praecepta ac maxime necessaria sit, ne umquam exprobrem, immo ne admoneam quidem. Haec enim beneficii inter duos lex est: alter statim oblivisci debet dati, alter accepti numquam. 11. Lacerat animum et premit frequens meritorum conmemoratio. Libet exclamare, quod ille triumvirali proscriptione servatus a quodam Caesaris amico exclamavit, cum superbiam eius ferre non posset: «Redde me Caesari!» Quousque dices: «Ego te servavi, ego eripui morti»? Istud, si meo arbitrio memini, vita est, si tuo, mors est; nihil tibi debeo, si me servasti, ut haberes, quem ostenderes. Quousque me circumducis? Quousque oblivisci fortunae meae non sinis? Semel in triumpho ductus essem. Non est dicendum, quid tribuerimus: qui admonet, repetit; non est instandum, non est memoria renovanda, nisi ut aliud dando prioris admoneas. Ne aliis quidem narrare debemus; qui dedit beneficium, taceat, narret, qui accepit. Dicetur enim, quod illi ubique iactanti beneficium suum: «Non negabis» inquit «te recepisse»; et cum respondisset: «Quando?» «Saepe quidem» inquit «et multis locis, id est, quotiens et ubicumque narrasti». Quid opus est eloqui, quid alienum occupare officium? Est, qui istud facere honestius possit, quo narrante et hoc laudabitur, quod ipse non narras. Ingratum me iudicas, si istud te tacente nemo sciturus est. Quod adeo non est conmittendum, ut etiam, si quis coram nobis narrabit, respondendum sit: «Dignissimus quidem ille est maioribus beneficiis, sed ego magis velle me scio omnia illi praestare quam adhuc praestitisse»; et haec ipsa non verniliter nec ea figura, qua quidam reiciunt, quae magis ad se volunt adtrahere. Deinde adicienda omnis humanitas. Perdet agricola, quod sparsit, si labores suos destituit in semine; multa cura sata perducuntur ad segetem; nihil in fructum pervenit, quod non a primo usque ad extremum aequalis cultura prosequitur. Eadem beneficiorum condicio est. Numquid ulla maiora possunt esse, quam quae in liberos patres conferunt? Haec tamen inrita sunt, si in infantia deserantur, nisi longa pietas munus suum nutrit. Eadem ceterorum beneficiorum condicio est: nisi illa adiuveris, perdes; parum est dedisse, fovenda
sunt. Si gratos vis habere, quos obligas, non tantum des oportet beneficia, sed ames. Praecipue, ut dixi, parcamus auribus; admonitio taedium facit, exprobratio odium. Nihil aeque in beneficio dando vitandum est quam superbia. Quid opus adrogantia voltus, quid tumore verborum? Ipsa res te extollit. Detrahenda est inanis iactatio; res loquentur nobis tacentibus. Non tantum ingratum, sed invisum est beneficium superbe datum. 12. C. Caesar dedit vitam Pompeio Penno, si dat, qui non aufert; deinde absoluto et agenti gratias porrexit osculandum sinistrum pedem. Qui excusant et negant id insolentiae causa factum, aiunt socculum auratum, immo aureum, margaritis distinctum ostendere eum voluisse. Ita prorsus: quid hic contumeliosum est, si vir consularis aurum et margaritas osculatus est alioquin nullam partem in corpore eius electurus, quam purius oscularetur? Homo natus in hoc, ut mores liberae civitatis Persica servitute mutaret, parum iudicavit, si senator, senex, summis usus honoribus in conspectu principum supplex sibi eo more iacuisset, quo hostes victi hostibus iacuere; invenit aliquid infra genua, quo libertatem detruderet. Non hoc est rem publicam calcare, et quidem, licet id aliquis non putet ad rem pertinere, sinistro pede? Parum enim foede furioseque insolens fuerat, qui de capite consularis viri soccatus audiebat, nisi in os senatoris ingessisset imperator epigros suos. 13. O superbia, magnae fortunae stultissimum malum! ut a te nihil accipere iuvat! ut omne beneficium in iniuriam convertis! ut te omnia dedecent! quoque altius te sublevasti, hoc depressior es ostendisque tibi non datum adgnoscere ista bona, quibus tantum inflaris; quidquid das, corrumpis. Libet itaque interrogare, quid se tanto opere resupinet, quid voltum habitumque oris pervertat, ut malit personam habere quam faciem? Iucunda sunt, quae humana fronte, certe leni placidaque tribuuntur, quae cum daret mihi superior, non exultavit supra me, sed quam potuit benignissimus fuit descenditque in aequum et detraxit muneri suo pompam, si observavit idoneum tempus, ut in occasione potius quam in necessitate succurreret. Uno modo istis persuadebimus, ne beneficia sua insolentia perdant, si ostenderimus non ideo videri maiora, quod tumultuosius data sunt; ne ipsos quidem ob id cuiquam posse maiores videri; vanam esse superbiae magnitudinem et quae in odium etiam amanda perducat. 14. Sunt quaedam nocitura inpetrantibus, quae non dare sed negare beneficium est; aestimabimus itaque utilitatem potius quam voluntatem petentium. Saepe enim noxia concupiscimus, nec dispicere, quam perniciosa sint, licet, quia iudicium interpellat adfectus; sed cum subsedit cupiditas, cum inpetus ille flagrantis animi, qui consilium fugat, cecidit, detestamur perniciosos malorum munerum auctores. Ut frigidam aegris negamus et lugentibus ac sibi iratis ferrum, ut amentibus, quidquid contra se usurus ardor petit, sic omnium, quae nocitura
sunt, inpense ac submisse, non numquam etiam miserabiliter rogantibus perseverabimus non dare. Cum initia beneficiorum suorum spectare tum etiam exitus decet et ea dare, quae non tantum accipere, sed etiam accepisse delectet. Multi sunt, qui dicant: «Scio hoc illi non profuturum, sed quid faciam? Rogat, resistere precibus eius non possum; viderit: de se, non de me queretur». Falsum est: immo de te et merito quidem; cum ad mentem bonam redierit, cum accessio illa, quae animum inflammabat, remiserit, quidni eum oderit, a quo in damnum ac periculum suum adiutus est? Exorari in perniciem rogantium saeva bonitas est. Quemadmodum pulcherrimum opus est etiam invitos nolentesque servare, ita rogantibus pestifera largiri blandum et adfabile odium est. Beneficium demus, quod in usu magis ac magis placeat, quod numquam in malum vertat. Pecuniam non dabo, quam numeraturum adulterae sciam, nec in societate turpis facti aut consilii inveniar; si potero, revocabo, si minus, non adiuvabo scelus. Sive illum ira, quo non debebit, inpellet, sive ambitionis calor abducet a tutis, in nullum malum vires a ‹me› sumere ipsas patiar nec conmittam, ut possit quandoque dicere: «Ille amando me occidit». Saepe nihil interest inter amicorum munera et hostium vota; quidquid illi accidere optant, in id horum intempestiva indulgentia inpellit atque instruit. Quid autem turpius quam quod evenit frequentissime, ut nihil intersit inter odium et beneficium? 15. Numquam in turpitudinem nostram reditura tribuamus. Cum summa amicitiae sit amicum sibi aequare, utrique simul consulendum est: dabo egenti, sed ut ipse non egeam; succurram perituro, sed ut ipse non peream, nisi si futurus ero magni hominis aut magnae rei merces. Nullum beneficium dabo, quod turpiter peterem. Nec exiguum dilatabo nec magna pro parvis accipi patiar; nam ut qui, quod ‹dedit›, inputat, gratiam destruit, ita qui, quantum det, ostendit, munus suum conmendat, non exprobrat. Respiciendae sunt cuique facultates suae viresque, ne aut plus praestemus, quam possumus, aut minus. Aestimanda est eius persona, cui damus; quaedam enim minora sunt, quam ut exire a magnis viris debeant, quaedam accipiente maiora sunt. Utriusque itaque personam confer et ipsum inter illas, quod donabis, examina, numquid aut danti grave sit aut parum, numquid rursus, qui accepturus est, aut fastidiat aut non capiat. 16. Urbem cuidam Alexander donabat, vesanus et qui nihil animo nisi grande conciperet. Cum ille, cui donabatur, se ipse mensus tanti muneris invidiam refugisset dicens non convenire fortunae suae: «Non quaero» inquit, «quid te accipere deceat, sed quid me dare». Animosa vox videtur et regia, cum sit stultissima. Nihil enim per se quemquam decet; refert, qui det, cui, quando, quare, ubi, et cetera, sine quibus facti ratio non constabit. Tumidissimum animal! si illum accipere hoc non decet, nec te dare; habetur personarum ac dignitatium portio et, cum sit ubique virtus modus, aeque peccat, quod excedit, quam quod deficit. Liceat istud sane tibi et te in tantum fortuna sustulerit, ut congiaria tua
urbes sint (quas quanto maioris animi fuit non capere quam spargere!): est tamen aliquis minor, quam in sinu eius condenda sit civitas. 17. Ab Antigono Cynicus petit talentum: respondit plus esse, quam quod Cynicus petere deberet; repulsus petit denarium: respondit minus esse, quam quod regem deceret dare. «Turpissima eiusmodi cavillatio est: invenit, quomodo neutrum daret. In denario regem, in talento Cynicum respexit, cum posset et denarium tamquam Cynico dare et talentum tamquam rex. Ut sit aliquid maius, quam quod Cynicus accipiat, nihil tam exiguum est, quod non honeste regis humanitas tribuat». Si me interrogas, probo; est enim intolerabilis res poscere nummos et contemnere. Indixisti pecuniae odium; hoc professus es, hanc personam induisti: agenda est. Iniquissimum est te pecuniam sub gloria egestatis adquirere. Adspicienda ergo non minus sua cuique persona est quam eius, de quo iuvando quis cogitat. Volo Chrysippi nostri uti similitudine de pilae lusu, quam cadere non est dubium aut mittentis vitio aut excipientis; tum cursum suum servat, ubi inter manus utriusque apte ab utroque et iactata et excepta versatur. Necesse est autem lusor bonus aliter illam conlusori longo, aliter brevi mittat. Eadem beneficii ratio est: nisi utrique personae, dantis et accipientis, aptatur, nec ab hoc exibit nec ad illum perveniet, ut debet. Si cum exercitato et docto negotium est, audacius pilam mittemus; utcumque enim venerit, manus illam expedita et agilis repercutiet; si cum tirone et indocto, non tam rigide nec tam excusse sed languidius et in ipsam eius derigentes manum remisse occurremus. Idem faciendum est in beneficiis: quosdam doceamus et satis iudicemus, si conantur, si audent, si volunt. Facimus autem plerumque ingratos et, ut sint, favemus, tamquam ita demum magna sint beneficia nostra, si gratia illis referri non potuit; ut malignis lusoribus propositum est conlusorem traducere, cum damno scilicet ipsius lusus, qui non potest, nisi consentitur, extendi. Multi sunt tam pravae naturae, ut malint perdere, quae praestiterunt, quam videri recepisse, superbi et inputatores; quanto melius quantoque humanius id agere, ut illis quoque partes suae constent, et favere, ut gratia sibi referri possit, benigne omnia interpretari, gratias agentem non aliter, quam si referat, audire, praebere se facilem ad hoc, ut, quem obligavit, etiam exolvi velit! Male audire solet fenerator, si acerbe exigit, aeque, si in recipiendo tardus ac difficilis moras quaerit. Beneficium tam recipiendum est quam non exigendum. Optimus ille, qui facile dedit, numquam exegit, reddi gavisus est, bona fide, quid praestitisset, oblitus, qui accipientis animo recepit. 18. Quidam non tantum dant beneficia superbe, sed etiam accipiunt, quod non est conmittendum; iam enim transeamus ad alteram partem tractaturi, quomodo se gerere homines in accipiendis beneficiis debeant. Quodcumque ex duobus constat officium, tantundem ab utroque exigit: qualis pater esse debeat, cum inspexeris, scies non minus operis illic superesse, ut
dispicias, qualem esse oporteat filium; sunt aliquae partes mariti, sed non minores uxoris. In vicem ista, quantum exigunt, praestant et parem desiderant regulam, quae, ut ait Hecaton, difficilis est; omne enim honestum in arduo est, etiam quod vicinum honesto est; non enim tantum fieri debet, sed ratione fieri. Hac duce per totam vitam eundum est, minima maximaque ex huius consilio gerenda; quomodo haec suaserit, dandum. Haec autem hoc primum censebit non ab omnibus accipiendum. A quibus ergo accipiemus? Ut breviter tibi respondeam: ab his, quibus dedissemus. Videamus, num etiam maiore dilectu quaerendus sit, cui debeamus, quam cui praestemus. Nam ut non sequantur ulla incommoda (secuntur autem plurima), grave tamen tormentum est debere, cui nolis; contra iucundissimum ab eo accepisse beneficium, quem amare etiam post iniuriam possis, ubi amicitiam alioqui iucundam causa fecit et iustam. Illud vero homini verecundo et probo miserrimum est, si eum amare oportet, quem non iuvat. Totiens admoneam necesse est non loqui me de sapientibus, quos, quidquid oportet, et iuvat, qui animum in potestate habent et legem sibi, quam volunt, dicunt, quam dixerunt, servant, sed de inperfectis hominibus honestam viam sequi volentibus, quorum adfectus saepe contumaciter parent. Itaque eligendum est, a quo beneficium accipiam; et quidem diligentius quaerendus beneficii quam pecuniae creditor. Huic enim reddendum est, quantum accepi, et, si reddidi, solutus sum ac liber; at illi et plus solvendum est, et nihilo minus etiam relata gratia cohaeremus; debeo enim, cum reddidi, rursus incipere, manetque amicitia; ‹et ut in amicitiam› non reciperem indignum, sic ne in beneficiorum quidem sacratissimum ius, ex quo amicitia oritur. «Non semper» inquit «mihi licet dicere: nolo; aliquando beneficium accipiendum est et invito. Dat tyrannus crudelis et iracundus, qui munus suum fastidire te iniuriam iudicaturus est: non accipiam? Eodem loco latronem pone, piratam, regem animum latronis ac piratae habentem. Quid faciam? Parum dignus est, cui debeam?» Cum eligendum dico, cui debeas, vim maiorem et metum excipio, quibus adhibitis electio perit. Si liberum est tibi, si arbitrii tui est, utrum velis an non, id apud te ipse perpendes; si necessitas tollit arbitrium, scies te non accipere, sed parere. Nemo id accipiendo obligatur, quod illi repudiare non licuit; si vis scire, an velim, effice, ut possim nolle. «Vitam tamen tibi dedit». Non refert, quid sit, quod datur, nisi a volente, nisi volenti datur; si servasti me, non ideo servator es. Venenum aliquando pro remedio fuit; non ideo numeratur inter salubria. Quaedam prosunt nec obligant: tuber quidam tyranni gladio divisit, qui ad occidendum eum venerat; non ideo illi tyrannus gratias egit, quod rem, quam medicorum manus reformidaverant, nocendo sanavit. 19. Vides non esse magnum in ipsa re momentum, quoniam non videtur dedisse beneficium, qui a malo animo profuit; casus enim beneficium est, hominis iniuria. Leonem in amphitheatro spectavimus, qui unum e bestiariis agnitum, cum
quondam eius fuisset magister, protexit ab inpetu bestiarum; num ergo beneficium est ferae auxilium? Minime, quia nec voluit facere nec faciendi animo fecit. Quo loco feram posui, tyrannum pone: et hic vitam dedit et illa, nec hic nec illa beneficium. Quia non est beneficium accipere cogi, non est beneficium debere, cui nolis. Ante des oportet mihi arbitrium mei, deinde beneficium. 20. Disputari de M. Bruto solet, an debuerit accipere ab divo Iulio vitam, cum occidendum eum iudicaret. Quam rationem in occidendo secutus sit, alias tractabimus; mihi enim, cum vir magnus in aliis fuerit, in hac re videtur vehementer errasse nec ex institutione Stoica se egisse; qui aut regis nomen extimuit, cum optimus civitatis status sub rege iusto sit, aut ibi speravit libertatem futuram, ubi tam magnum praemium erat et imperandi et serviendi, aut existimavit civitatem in priorem formam posse revocari amissis pristinis moribus futuramque ibi aequalitatem civilis iuris et staturas suo loco leges, ubi viderat tot milia hominum pugnantia, non an servirent, sed utri. Quanta vero illum aut rerum naturae aut urbis suae tenuit oblivio, qui uno interempto defuturum credidit alium, qui idem vellet, cum Tarquinius esset inventus post tot reges ferro ac fulminibus occisos! Sed vitam accipere debuit, ob hoc tamen minus habere illum parentis loco, quia in ius dandi beneficii iniuria venerat; non enim servavit is, qui non interfecit, nec beneficium dedit, sed missionem. 21. Illud magis venire in aliquam disputationem potest, quid faciendum sit captivo, cui redemptionis pretium homo prostituti corporis et infamis ore promittit. Patiar me ab inpuro servari? Servatus deinde quam illi gratiam referam? Vivam cum obsceno? Non vivam cum redemptore? Quid ergo placeat, dicam: etiam a tali accipiam pecuniam, quam pro capite dependam, accipiam autem tamquam creditum, non tamquam beneficium; solvam illi pecuniam et, si occasio fuerit servandi periclitantem, servabo; in amicitiam, quae similes iungit, non descendam, nec servatoris illum loco numerabo sed feneratoris, cui sciam reddendum, quod accepi. Est aliquis dignus, a quo beneficium accipiam, sed danti nociturum est; ideo non accipiam, quia ille paratus est mihi cum incommodo aut etiam periculo suo prodesse. Defensurus est me reum, sed illo patrocinio regem sibi facturus inimicum; inimicus sum, si, cum ille pro me periclitari velit, ego, quod facilius est, non facio, ut sine illo pericliter. Ineptum et frivolum hoc Hecaton ponit exemplum Arcesilai, quem ait a filio familiae adlatam pecuniam non accepisse, ne ille patrem sordidum offenderet; quid fecit laude dignum, quod furtum non recepit, quod maluit non accipere quam reddere? Quae est enim alienam rem non accipere moderatio? Si exemplo magni animi opus est, utamur Graecini Iulii, viri egregii, quem C. Caesar occidit ob hoc unum, quod melior vir erat, quam esse quemquam tyranno expedit. Is cum ab amicis conferentibus ad inpensam ludorum pecunias acciperet, magnam pecuniam a Fabio Persico missam non accepit et obiurgantibus iis, qui non aestimant
mittentes, sed missa, quod repudiasset: «Ego» inquit «ab eo beneficium accipiam, a quo propinationem accepturus non sum?» Cum illi Rebilus consularis, homo eiusdem infamiae, maiorem summam misisset instaretque, ut accipi iuberet: «Rogo» inquit «ignoscas; et a Persico non accepi». Utrum hoc munera accipere est an senatum legere? 22. Cum accipiendum iudicaverimus, hilares accipiamus profitentes gaudium, et id danti manifestum sit, ut fructum praesentem capiat; iusta enim causa laetitiae est laetum amicum videre, iustior fecisse; quam grate ad nos pervenisse indicemus effusis adfectibus, quos non ipso tantum audiente sed ubique testemur. Qui grate beneficium accipit, primam eius pensionem solvit. 23. Sunt quidam, qui nolint nisi secreto accipere; testem beneficii et conscium vitant; quos scias licet male cogitare. Quomodo danti in tantum producenda notitia est muneris sui, in quantum delectatura est, cui datur, ita accipienti adhibenda contio est; quod pudet debere, ne acceperis. Quidam furtive gratias agunt et in angulo et ad aurem; non est ista verecundia, sed infitiandi genus; ingratus est, qui remotis arbitris agit gratias. Quidam nolunt nomina secum fieri nec interponi pararios nec signatores advocari, ‹vix› chirographum dare; idem faciunt, qui dant operam, ut beneficium in ipsos conlatum quam ignotissimum sit. Verentur palam ferre, ut sua potius virtute quam alieno adiutorio consecuti dicantur; rariores in eorum officiis sunt, quibus vitam aut dignitatem debent, et, dum opinionem clientium timent, graviorem subeunt ingratorum. 24. Alii pessime locuntur de optime meritis. Tutius est quosdam offendere quam demeruisse; argumentum enim nihil debentium odio quaerunt; atqui nihil magis praestandum est, quam ut memoria nobis meritorum haereat, quae subinde reficienda est, quia nec referre potest gratiam, nisi qui meminit, et, qui meminit, eam refert. Nec delicate accipiendum est nec submisse et humiliter; nam qui neglegens est in accipiendo, cum omne beneficium recens pateat, quid faciat, cum prima eius voluptas refrixit? Alius accipit fastidiose, tamquam qui dicat: «Non quidem mihi opus est, sed quia tam valde vis, faciam tibi mei potestatem»; alius supine, ut dubium praestanti relinquat, an senserit; alius vix labra diduxit et ingratior, quam si tacuisset, fuit. Loquendum est pro magnitudine rei inpensius et illa adicienda: «Plures, quam putas, obligasti» (nemo enim non gaudet beneficium suum latius patere); «nescis, quid mihi praestiteris, sed scire te oportet, quanto plus sit, quam existimas» (statim gratus est, qui se onerat); «numquam tibi referre gratiam potero; illud certe non desinam ubique confiteri me referre non posse». 25. Nullo magis Caesarem Augustum demeruit et ad alia inpetranda facilem sibi reddidit Furnius, quam quod, cum patri Antonianas partes secuto veniam
inpetrasset, dixit: «Hanc unam, Caesar, habeo iniuriam tuam: effecisti, ut et viverem et morerer ingratus». Quid est tam grati animi, quam nullo modo sibi satis facere, quam ne ad spem quidem exaequandi umquam beneficii accedere? His atque eiusmodi vocibus id agamus, ut voluntas nostra non lateat, sed aperiatur et luceat. Verba cessent licet: si, quemadmodum debemus, adfecti sumus, conscientia eminebit in voltu. Qui gratus futurus est, statim, dum accipit, de reddendo cogitet. Chrysippus quidem ait illum velut in certamen cursus conpositum et carceribus inclusum opperiri debere tempus suum, ad quod velut dato signo prosiliat; et quidem magna illi contentione opus est, magna celeritate, ut consequatur antecedentem. 26. Videndum est nunc, quid maxime faciat ingratos. Facit aut nimius sui suspectus et insitum mortalitati vitium se suaque mirandi aut aviditas aut invidia. Incipiamus a primo. Nemo non benignus est sui iudex; inde est, ut omnia meruisse se existimet et in solutum accipiat nec satis suo pretio se aestimatum putet. «Hoc mihi dedit, sed quam sero, sed post quot labores? Quanto consequi plura potuissem, si illum aut illum ita me colere maluissem? Non hoc speraveram; in turbam coniectus sum; tam exiguo dignum me iudicavit? Honestius praeteriri fuit». 27. Cn. Lentulus augur, divitiarum maximum exemplum, ante quam illum libertini pauperem facerent, hic, qui quater miliens sestertium suum vidit (proprie dixi; nihil enim amplius quam vidit), ingenii fuit sterilis, tam pusilli quam animi. Cum esset avarissimus, nummos citius emittebat quam verba: tanta illi inopia erat sermonis. Hic cum omnia incrementa sua divo Augusto deberet, ad quem adtulerat paupertatem sub onere nobilitatis laborantem, princeps iam civitatis et pecunia et gratia subinde ‹de› Augusto solebat queri dicens a studiis se abductum; nihil tantum in se congestum esse, quantum perdidisset relicta eloquentia. At illi inter alia hoc quoque divus Augustus praestiterat, quod illum derisu et labore inrito liberaverat. Non patitur aviditas quemquam esse gratum; numquam enim inprobae spei, quod datur, satis est, et maiora cupimus, quo maiora venerunt, multoque concitatior est avaritia in magnarum opum congestu conlocata, ut flammae infinito acrior vis est, quo ex maiore incendio emicuit. Aeque ambitio non patitur quemquam in ea mensura honorum conquiescere, quae quondam eius fuit inpudens votum: nemo agit de tribunatu gratias, sed queritur, quod non est ad praeturam usque perductus; nec haec grata est, si deest consulatus; ne hic quidem satiat, si unus est. Ultra se cupiditas porrigit et felicitatem suam non intellegit, quia non, unde venerit, respicit, sed quo tendat. 28. Omnibus his vehementius et inportunius malum est invidia, quae nos inquietat, dum conparat: «Hoc mihi praestitit, sed illi plus, sed illi maturius»; et deinde nullius causam agit, contra omnes sibi favet. Quanto est simplicius, quanto
prudentius beneficium acceptum augere, scire neminem tanti ab alio, quanti a se ipso aestimari! «Plus accipere debui, sed illi facile non fuit plus dare; in multos dividenda liberalitas erat; hoc initium est, boni consulamus et animum eius grate excipiendo evocemus; parum fecit, sed saepius faciet; illum mihi praetulit, et me multis; ille non est mihi par virtutibus nec officiis, sed habuit suam Venerem; querendo non efficiam, ut maioribus dignus sim, sed ut datis indignus. Plura illis hominibus turpissimis data sunt; quid ad rem? Quam raro fortuna iudicat? Cottidie querimur malos esse felices; saepe, quae agellos pessimi cuiusque transierat, optimorum virorum segetem grando percussit; fert sortem suam quisque ut in ceteris rebus ita in amicitiis». Nullum est tam plenum beneficium, quod non vellicare malignitas possit, nullum tam angustum, quod non bonus interpres extendat. Numquam deerunt causae querendi, si beneficia a deteriore parte spectaveris. 29. Vide, quam iniqui sint divinorum munerum aestimatores et quidem professi sapientiam: queruntur, quod non magnitudine corporum aequemus elephantos, velocitate cervos, levitate aves, inpetu tauros, quod solida sit cutis beluis, decentior dammis, densior ursis, mollior fibris, quod sagacitate nos narium canes vincant, quod acie luminum aquilae, spatio aetatis corvi, multa animalia nandi facilitate. Et cum quaedam ne coire quidem in idem natura patiatur, ut velocitatem corporum et vires, ex diversis ac dissidentibus bonis hominem non esse conpositum iniuriam vocant et neglegentes nostri deos, quod non bona valetudo etiam vitiis inexpugnabilis data sit, quod non futuri scientia. Vix sibi temperant, quin eo usque inpudentiae provehantur, ut naturam oderint, quod infra deos sumus, quod non in aequo illis stetimus. Quanto satius est ad contemplationem tot tantorumque beneficiorum reverti et agere gratias, quod nos in hoc pulcherrimo domicilio voluerunt secundas sortiri, quod terrenis praefecerunt! Aliquis ea animalia conparat nobis, quorum potestas penes nos est? Quidquid nobis negatum est, dari non potuit. Proinde, quisquis es iniquus aestimator sortis humanae, cogita, quanta nobis tribuerit parens noster, quanto valentiora animalia sub iugum miserimus, quanto velociora consequamur, quam nihil sit mortale non sub ictu nostro positum. Tot virtutes accepimus, tot artes, animum denique, cui nihil non eodem, quo intendit, momento pervium est, sideribus velociorem, quorum post multa saecula futuros cursus antecedit; tantum deinde frugum, tantum opum, tantum rerum aliarum super alias acervatarum. Circumeas licet cuncta et, quia nihil totum invenies, quod esse te malles, ex omnibus singula excerpas, quae tibi dari velles: bene aestimata naturae indulgentia confitearis necesse est in deliciis te illi fuisse. Ita est: carissimos nos habuerunt di inmortales habentque, et, qui maximus tribui honos potuit, ab ipsis proximos conlocaverunt. Magna accepimus, maiora non cepimus. 30. Haec, mi Liberalis, necessaria credidi, et quia loquendum aliquid de maximis beneficiis erat, cum de minutis loqueremur, et quia inde manat etiam in
cetera huius detestabilis vitii audacia. Cui enim respondebit grate, quod munus existimabit aut magnum aut reddendum, qui summa beneficia spernit? Cui salutem, cui spiritum debebit, qui vitam accepisse se a dis negat, quam cottidie ab illis petit? Quicumque ergo gratos esse docet, et hominum causam agit et deorum, quibus nullius rei indigentibus, positis extra desiderium, referre nihilo minus gratiam possumus. Non est, quod quisquam excusationem mentis ingratae ab infirmitate atque inopia petat et dicat: «Quid enim faciam et quomodo? Quando superioribus dominisque rerum omnium gratiam referam?». Referre facile est, si avarus es, sine inpendio, si iners, sine opera. Eodem quidem momento, quo obligatus es, si vis, cum quolibet paria fecisti, quoniam, qui libenter beneficium accipit, reddidit. 31. Hoc ex paradoxis Stoicae sectae minime mirabile, ut mea fert opinio, aut incredibile est eum, qui libenter accipit, beneficium reddidisse. Nam cum omnia ad animum referamus, fecit quisque, quantum voluit; et cum pietas, fides, iustitia, omnis denique virtus intra se perfecta sit, etiam si illi manum exerere non licuit, gratus quoque homo esse potest voluntate. Quotiens, quod proposuit, quisque consequitur, capit operis sui fructum. Qui beneficium dat, quid proponit? Prodesse ei, cui dat, et voluptati esse. Si, quod voluit, effecit pervenitque ad me animus eius ac mutuo gaudio adfecit, tulit, quod petit. Non enim in vicem aliquid sibi reddi voluit; aut non fuit beneficium, sed negotiatio. Bene navigavit, qui quem destinavit portum tenuit; teli iactus certae manus peregit officium, si petita percussit; beneficium qui dat, vult excipi grate: habet, quod voluit, si bene acceptum est. Sed speravit emolumenti aliquid: non fuit hoc beneficium, cuius proprium est nihil de reditu cogitare. Quod accipiebam, eo animo accepi, quo dabatur: reddidi. Alioqui pessima optimae rei condicio est: ut gratus sim, ad fortunam mittor. Si illa invita respondere non possum, sufficit animus animo. «Quid ergo? Non, quidquid potuero, et faciam, ut reddam, et temporum rerumque occasionem sequar et inplere eius sinum cupiam, a quo aliquid accepi?» Sed malo loco beneficium est, nisi et excussis manibus esse grato licet. 32. «Qui accepit» inquit «beneficium, licet animo benignissimo acceperit, nondum consummavit officium suum; restat enim pars reddendi; sicut in lusu est aliquid pilam scite ac diligenter excipere, sed non dicitur bonus lusor, nisi qui apte et expedite remisit, quam acceperat». Exemplum hoc dissimile est; quare? Quia huius rei laus in corporis motu est et in agilitate, non in animo; explicari itaque totum debet, de quo oculis iudicatur. Nec tamen ideo non bonum lusorem dicam, qui pilam, ut oportebat, excepit, si per ipsum mora, quo minus remitteret, non fuit. «Sed quamvis» inquit «arti ludentis nihil desit, quia partem quidem fecit, sed partem, quam non fecit, potest facere, lusus ipse inperfectus est, qui consummatur vicibus mittendi ac remittendi». Nolo diutius hoc refellere; existimemus ita esse, desit aliquid lusui, non lusori; sic et in hoc, de quo
disputamus, deest aliquid rei datae, cui par alia debetur, non animo, qui animum parem sibi nanctus est et, quantum in illo est, quod voluit, effecit. 33. Beneficium mihi dedit, accepi non aliter, quam ipse accipi voluit: iam habet, quod petit, et quod unum petit, ergo gratus sum. Post hoc usus mei restat et aliquod ex homine grato commodum; hoc non inperfecti officii reliqua pars est, sed perfecti accessio. Facit Phidias statuam; alius est fructus artis, alius artificii: artis est fecisse, quod voluit, artificii fecisse cum fructu; perfecit opus suum Phidias, etiam si non vendidit. Triplex illi fructus est operis sui: unus conscientiae; hunc absoluto opere percipit; alter famae; tertius utilitatis, quem adlatura est aut gratia aut venditio aut aliqua commoditas. Sic beneficii fructus primus ille est conscientiae: hunc percipit, qui, quo voluit, munus suum pertulit; secundus ‹et tertius› est et famae et eorum, quae praestari in vicem possunt. Itaque cum benigne acceptum est beneficium, qui dedit, gratiam quidem iam recepit, mercedem nondum; debeo itaque, quod extra beneficium est, ipsum quidem bene accipiendo persolvi. 34. «Quid ergo?» inquit «rettulit gratiam, qui nihil fecit?» Primum fecit: bono animo bonum optulit et, quod est amicitiae, ex aequo. Post deinde aliter beneficium, aliter creditum solvitur; non est, quod expectes, ut solutionem tibi ostendam; res inter animos geritur. Quod dico, non videbitur durum, quamvis primo contra opinionem tuam pugnet, si te commodaveris mihi et cogitaveris plures esse res quam verba. Ingens copia est rerum sine nomine, quas non propriis adpellationibus notamus, sed alienis commodatisque: pedem et nostrum dicimus et lecti et veli et carminis, canem et venaticum et marinum et sidus; quia non sufficimus, ut singulis singula adsignemus, quotiens opus est, mutuamur. Fortitudo est virtus pericula iusta contemnens aut scientia periculorum repellendorum, excipiendorum, provocandorum; dicimus tamen et gladiatorem fortem virum et servum nequam, quem in contemptum mortis temeritas inpulit. Parsimonia est scientia vitandi sumptus supervacuos aut ars re familiari moderate utendi; parcissimum tamen hominem vocamus pusilli animi et contracti, cum infinitum intersit inter modum et angustias. Haec alia sunt natura, sed efficit inopia sermonis, ut et hunc et illum parcum vocemus, ut et ille fortis dicatur cum ratione fortuita despiciens et hic sine ratione in pericula excurrens. Sic beneficium est et actio, ut diximus, benefica et ipsum, quod datur per illam actionem, ut pecunia, ut domus, ut praetexta; unum utrique nomen est, vis quidem ac potestas longe alia. 35. Itaque adtende, iam intellegis nihil me, quod opinio tua refugiat, dicere: illi beneficio, quod actio perficit, relata gratia est, si illud benevole excipimus; illud alterum, quod re continetur, nondum reddidimus, sed volemus reddere. Voluntati voluntate satis fecimus, rei rem debemus. Itaque, quamvis rettulisse illum gratiam dicamus, qui beneficium libenter accipit, iubemus tamen et simile
aliquid ei, quod accepit, reddere. A consuetudine quaedam, quae dicimus, abhorrent, deinde alia via ad consuetudinem redeunt: negamus iniuriam accipere sapientem, tamen, qui illum pugno percusserit, iniuriarum damnabitur; negamus stulti quidquam esse, et tamen eum, qui rem aliquam stulto subripuit, furti condemnabimus; insanire omnes dicimus, nec omnes curamus elleboro; his ipsis, quos vocamus insanos, et suffragium et iuris dictionem conmittimus. Sic dicimus eum, qui beneficium bono animo accipit, gratiam rettulisse, nihilo minus illum in aere alieno relinquimus gratiam relaturum, etiam cum rettulit. Exhortatio est illa, non infitiatio beneficii, ne beneficia timeamus, ne ut intolerabili sarcina pressi deficiamus animo. «Bona mihi donata sunt et fama defensa, detractae sordes, spiritus servatus et libertas spiritu potior: et quomodo referre gratiam potero? Quando ille veniet dies, quo illi animum meum ostendam?». Hic ipse est, quo ille suum ostendit. Excipe beneficium, amplexare, gaude, non quod accipias, sed quod reddas debiturusque sis; non adibis tam magnae rei periculum, ut casus ingratum facere te possit. Nullas tibi proponam difficultates, ne despondeas animum, ne laborum ac longae servitutis expectatione deficias; non differo te, de praesentibus fiat. Numquam eris gratus, nisi statim es. Quid ergo facies? Non arma sumenda sunt: fortasse erunt; non maria emetienda: fortasse etiam ventis minantibus solves. Vis reddere beneficium? Benigne accipe; rettulisti gratiam, non ut solvisse te putes, sed ut securior debeas.
Liber tertius 1. Non referre beneficiis gratiam et est turpe et apud omnes habetur, Aebuti Liberalis; ideo de ingratis etiam ingrati queruntur, cum interim hoc omnibus haeret, quod omnibus displicet, adeoque in contrarium itur, ut quosdam habeamus infestissimos non post beneficia tantum sed propter beneficia. Hoc pravitate naturae accidere quibusdam non negaverim, pluribus, quia memoriam tempus interpositum subducit. Nam quae recentia apud illos viguerunt, ea interiecto spatio obsolescunt; de quibus fuisse mihi tecum disputationem scio, cum tu illos non ingratos vocares sed oblitos, tamquam ea res ingratum excuset, quae facit, aut, quia hoc accidit alicui, non sit ingratus, cum hoc non accidat nisi ingrato. Multa sunt genera ingratorum, ut furum, ut homicidarum, quorum una culpa est, ceterum in partibus varietas magna; ingratus, qui beneficium accepisse se negat, quod accepit, ingratus est, qui dissimulat, ingratus, qui non reddit, ingratissimus omnium, qui oblitus est. Illi enim si non solvunt, tamen debent, et extat apud illos vestigium certe meritorum intra malam conscientiam inclusorum; aliquando ad referendam gratiam converti ex aliqua causa possunt, si illos pudor admonuerit, si subita honestae rei cupiditas, qualis solet ad tempus etiam in malis pectoribus exurgere, si invitaverit facilis occasio; hic numquam fieri gratus potest, cui beneficium totum elapsum est. Et utrum tu peiorem vocas, apud quem gratia beneficii intercidit, an apud quem etiam memoria? Vitiosi oculi sunt, qui lucem reformidant, caeci, qui non vident; et parentes suos non amare inpietas est, non adgnoscere insania. 2. Quis tam ingratus est, quam qui, quod in prima parte animi positum esse debuit et semper occurrere, ita seposuit et abiecit, ut in ignorantiam verteret? Adparet illum non saepe de reddendo cogitasse, cui obrepsit oblivio. Denique ad reddendam gratiam et virtute opus est et tempore et facultate et adspirante fortuna; qui meminit, sine inpendio gratus est. Hoc, quod non operam exigit, non opes, non felicitatem, qui non praestat, nullum habet, quo lateat, patrocinium; numquam enim voluit gratus esse, qui beneficium tam longe proiecit, ut extra conspectum suum poneret. Quemadmodum, quae in usu sunt et manum cottidie tactumque patiuntur, numquam periculum situs adeunt, illa, quae ad oculos non revocantur, sed extra conversationem ut supervacua iacuerunt, sordes ipsa colligunt vetustate, ita, quidquid frequens cogitatio exercet ac renovat, memoriae numquam subducitur, quae nihil perdit, nisi ad quod non saepe respexit. 3. Praeter hanc causam aliae quoque sunt, quae nobis merita non numquam maxima evellant. Prima omnium ac potentissima, quod novis semper cupiditatibus occupati non, quid habeamus, sed quid petamus, ‹spectamus;› in id, quod adpetitur, intentis, quidquid est domi, vile est. Sequitur autem, ut, ubi quod
acceperis leve novorum cupiditas fecit, auctor quoque eorum non sit in pretio. Amavimus aliquem et suspeximus et fundatum ab illo statum nostrum professi sumus, quamdiu nobis placebant ea, quae consecuti sumus; deinde inrumpit animum aliorum admiratio, et ad ea inpetus factus est, uti mortalibus mos est ex magnis maiora cupiendi: protinus excidit, quidquid ante apud nos beneficium vocabatur, nec ea intuemur, quae nos aliis praeposuere, sed ea sola, quae fortuna praecedentium ostentat. Non potest autem quisquam et invidere et gratias agere, quia invidere querentis et maesti est, gratias agere gaudentis. Deinde quia nemo nostrum novit nisi id tempus, quod cum maxime transit, ad praeterita rari animum retorquent; sic fit, ut praeceptores eorumque beneficia intercidant, quia totam pueritiam reliquimus; sic fit, ut in adulescentiam nostram conlata pereant, quia ipsa numquam retractatur. Nemo, quod fuit, tamquam in praeterito sed tamquam in perdito ponit, ideoque caduca memoria est futuro inminentium. 4. Hoc loco reddendum est Epicuro testimonium, qui adsidue queritur, quod adversus praeterita simus ingrati, quod, quaecumque percipimus bona, non reducamus nec inter voluptates numeremus, cum certior nulla sit voluptas, quam quae iam eripi non potest. Praesentia bona nondum tota in solido sunt, potest illa casus aliquis incidere; futura pendent et incerta sunt; quod praeteriit, inter tuta sepositum est. Quomodo gratus esse quisquam adversus beneficia potest, qui omnem vitam suam transilit praesentium totus ac futurorum? Memoria gratum facit; memoriae minimum tribuit, quisquis spei plurimum. 5. Quemadmodum, mi Liberalis, quaedam res semel perceptae haerent, quaedam, ut scias, non est satis didicisse (intercidit enim eorum scientia, nisi continuetur), geometriam dico et sublimium cursum et si qua alia propter suptilitatem lubrica sunt, ita beneficia quaedam magnitudo non patitur excidere, quaedam minora sed numero plurima et temporibus diversa effluunt, quia, ut dixi, non subinde illa tractamus nec libenter, quid cuique debeamus, recognoscimus. Audi voces petentium: nemo non victuram semper in animo suo memoriam dixit, nemo non deditum se et devotum professus est, et si quod aliud humilius verbum, quo se obpigneraret, invenit. Post exiguum tempus idem illi verba priora quasi sordida et parum libera evitant; perveniunt deinde eo, quo, ut ego existimo, pessimus quisque atque ingratissimus pervenit, ut obliviscantur. Adeo enim ingratus est, qui oblitus est, ut ingratus sit, cui beneficium in mentem venit. 6. Hoc tam invisum vitium an inpunitum esse debeat, quaeritur, et an haec lex, quae in scholis exercetur, etiam in civitate ponenda sit, qua ingrati datur actio; quae videtur aequa omnibus. «Quidni? Cum urbes quoque urbibus, quae praestitere, exprobrent et in maiores conlata a posteris exigant». Nostri maiores, maximi scilicet viri, ab hostibus tantum res repetierunt, beneficia magno animo dabant, magno perdebant; excepta Macedonum gente non est in ulla data adversus ingratum actio. Magnumque hoc argumentum est dandam non fuisse, quia
adversus maleficium omne consensimus, et homicidii, veneficii, parricidii, violatarum religionum aliubi atque aliubi diversa poena est, sed ubique aliqua, hoc frequentissimum crimen nusquam punitur, ubique inprobatur; neque absolvimus illud, sed cum difficilis esset incertae rei aestimatio, tantum odio damnavimus et inter ea reliquimus, quae ad iudices deos mittimus. 7. Rationes autem multae mihi occurrunt, propter quas crimen hoc in legem cadere non debeat. Primum omnium pars optima beneficii periit, si actio sicut certae pecuniae aut ex conducto et locato datur. Hoc enim in illo speciosissimum est, quod dedimus vel perdituri, quod totum permisimus accipientium arbitrio; si adpello, si ad iudicem voco, incipit non beneficium esse, sed creditum. Deinde cum res honestissima sit referre gratiam, desinit esse honesta, si necessaria est; non magis enim laudabit quisquam gratum hominem, quam eum, qui depositum reddidit aut, quod debebat, citra iudicem solvit. Ita duas res, quibus in vita humana nihil pulchrius est, corrumpimus, gratum hominem et beneficium; quid enim aut in hoc magnificum est, si beneficium non dat, sed commodat, aut in illo, qui reddit, non quia vult, sed quia necesse est? Non est gloriosa res gratum esse, nisi tutum est ingratum fuisse. Adice nunc, quod huic uni legi omnia fora vix sufficient. Quis erit, qui non agat? Quis, cum quo non agatur? Omnes sua extollunt, omnes etiam minima, quae in alios contulere, dilatant. Praeterea, quaecumque in cognitionem cadunt, conprendi possunt et non dare infinitam licentiam iudici; ideo melior videtur condicio causae bonae, si ad iudicem quam si ad arbitrum mittitur, quia illum formula includit et certos, quos non excedat, terminos ponit, huius libera et nullis adstricta vinculis religio et detrahere aliquid potest et adicere et sententiam suam, non prout lex aut iustitia suadet, sed prout humanitas aut misericordia inpulit, regere. Ingrati actio non erat iudicem adligatura sed ‹in› regno liberrimo positura. Quid sit enim beneficium, non constat, deinde, quantum sit; refert, quam benigne illud interpretetur iudex. Quid sit ingratus, nulla lex monstrat; saepe et qui reddidit, quod accepit, ingratus est, et qui non reddidit, gratus. De quibusdam et inperitus iudex demittere tabellam potest, ubi fecisse aut non fecisse pronuntiandum est, ubi prolatis cautionibus controversia tollitur, ubi inter disputantes ratio ius dicit; ubi vero animi coniectura capienda est, ubi id, de quo sola sapientia decernit, in controversiam incidit, non potest sumi ad haec iudex ex turba selectorum, quem census in album et equestris hereditas misit. 8. Itaque non haec parum idonea res visa est, quae deduceretur ad iudicem, sed nemo huic rei satis idoneus iudex inventus est; quod non admiraberis, si excusseris, quid habiturus fuerit difficultatis, quisquis in eiusmodi reum exisset. Donavit aliquis magnam pecuniam, sed dives, sed non sensurus inpendium; donavit alius, sed toto patrimonio cessurus; summa eadem est, beneficium idem non est. Etiamnunc adice: hic pecuniam pro addicto dependit, sed cum illam domo protulisset; ille dedit eandem, sed mutuam sumpsit aut rogavit et se
obligari ingenti merito passus est; eodem existimas loco esse illum, qui beneficium ex facili largitus est, et hunc, qui accepit, ut daret? Tempore quaedam magna fiunt, non summa: beneficium est donata possessio, cuius fertilitas laxare possit annonam, beneficium est unus in fame panis; beneficium est donare regiones, per quas magna flumina et navigabilia decurrant, beneficium est arentibus siti et vix spiritum per siccas fauces ducentibus monstrare fontem. Quis inter se ista conparabit? Quis expendet? Difficilis est sententia, quae non rem, sed vim rei quaerit; eadem licet sint, aliter data non idem pendent. Dedit hic mihi beneficium, sed non libenter, sed dedisse se questus est, sed superbius me, quam solebat, adspexit, sed tam tarde dedit, ut plus praestaturus fuerit, si cito negasset: horum quomodo iudex inibit aestimationem, cum sermo et dubitatio et voltus meriti gratiam destruant? 9. Quid, quod quaedam beneficia vocantur, quia nimis concupiscuntur, quaedam non sunt ex hac volgari nota sed maiora, etiam si minus adparent? Beneficium vocas dedisse potentis populi civitatem, in quattuordecim deduxisse et defendisse capitis reum; quid utilia suasisse? Quid retinuisse, ne in scelus rueret? Quid gladium excussisse morituro? Quid efficacibus remediis lugentem et, quos desiderabat, volentem sequi ad vitae consilium reduxisse? Quid adsedisse aegro et, cum valetudo eius ac salus momentis constaret, excepisse idonea cibo tempora et cadentes venas vino refecisse et medicum adduxisse morienti? Haec quis aestimabit? Quis dissimilibus beneficiis iubebit beneficia pensari? «Donavi tibi domum»; sed ego tuam supra te ruere praedixi. «Dedi tibi patrimonium»; sed ego naufrago tabulam. «Pugnavi pro te et volnera excepi»; at ego vitam tibi silentio dedi. Cum aliter beneficium detur, aliter reddatur, paria facere difficile est. 10. Dies praeterea beneficio reddendo non dicitur, sicut pecuniae creditae; itaque potest, qui nondum reddidit, reddere. Dic enim, intra quod tempus deprendatur ingratus. Maxima beneficia probationem non habent, saepe intra tacitam duorum conscientiam latent; an hoc inducimus, ut non demus beneficia sine teste? Quam deinde poenam ingratis constituimus? Unam omnibus, cum disparia sint? Inaequalem et pro cuiusque beneficio maiorem, minorem? Age, intra pecuniam versabitur taxatio: quid, quod quaedam vitae beneficia sunt et maiora vita? His quae pronuntiabitur poena? Minor beneficio? Iniqua est; par et capitalis? Quid inhumanius quam cruentos esse beneficiorum exitus? 11. «Quaedam» inquit «privilegia parentibus data sunt; quomodo horum extra ordinem habita ratio est, sic aliorum quoque beneficorum haberi debet». Parentium condicionem sacravimus, quia expediebat liberos tolli; sollicitandi ad hunc laborem erant incertam adituri fortunam. Non poterat illis dici, quod beneficia dantibus dicitur: «Cui des, elige; ipse tecum, si deceptus es, querere; dignum adiuva». In liberis tollendis nihil iudicio tollentium licet, tota res voti est;
itaque, ut aequiore animo adirent aleam, danda aliqua illis potestas fuit. Deinde alia condicio parentium est, qui beneficia, quibus dederunt, dant nihilo minus daturique sunt, nec est periculum, ne dedisse ipsos mentiantur; in ceteris quaeri debet, non tantum an receperint, sed an dederint, horum in confesso merita sunt, et, quia utile est iuventuti regi, inposuimus illi quasi domesticos magistratus, sub quorum custodia contineretur. Deinde omnium parentium unum erat beneficium, itaque aestimari semel potuit; alia diversa sunt, dissimilia, infinitis inter se intervallis distantia; itaque sub nullam regulam cadere potuerunt, cum aequius esset omnia relinqui quam omnia aequari. 12. Quaedam magno dantibus constant, quaedam accipientibus magna sunt, sed gratuita tribuentibus. Quaedam amicis data sunt, quaedam ignotis; plus est, quamvis idem detur, si ei datur, quem nosse a beneficio tuo incipis. Hic auxilia tribuit, ille ornamenta, ille solacia. Invenies, qui nihil putet esse iocundius, nihil maius quam habere, in quo calamitas adquiescat; invenies rursus, qui dignitati suae, quam securitati consuli malit; est, qui plus ei debere se iudicet, per quem tutior est, quam ei, per quem honestior. Proinde ista maiora aut minora erunt, prout fuerit iudex aut huc aut illo inclinatus animo. Praeterea creditorem mihi ipse eligo, beneficium saepe ab eo accipio, a quo nolo, et aliquando ignorans obligor: quid facies? Ingratum vocabis eum, cui beneficium inscio et, si scisset, non accepturo inpositum est? Non vocabis eum, qui utcumque acceptum non reddidit? Aliquis dedit mihi beneficium, sed idem postea fecit iniuriam: utrum uno munere ad patientiam iniuriarum omnium adstringor, an proinde erit, ac si gratiam rettulerim, quia beneficium suum ipse insequenti iniuria rescidit? Quomodo deinde aestimabis, utrum plus sit, quod accepit, an quo laesus est? Dies me deficiet omnes difficultates persequi temptantem. 13. «Tardiores» inquit «ad beneficia danda facimus non vindicando data nec infitiatores eorum adficiendo poena». Sed illud quoque tibi e contrario occurrat multo tardiores futuros ad accipienda beneficia, si periculum causae dicundae adituri erunt et innocentiam sollicitiore habituri loco. Deinde erimus per hoc ipsi quoque ad danda tardiores; nemo enim libenter dat invitis, sed quicumque ad bene faciendum bonitate invitatus est et ipsa pulchritudine rei, etiam libentius dabit nihil debituris nisi quod volent. Minuitur enim gloria eius officii, cui diligenter cautum est. 14. Deinde pauciora erunt beneficia, sed veriora; quid autem mali est inhiberi beneficiorum temeritatem? Hoc enim ipsum secuti sunt, qui nullam legem huic constituerunt, ut circumspectius donaremus, circumspectius eligeremus eos, in quos merita conferuntur. Etiam atque etiam, cui des, considera: nulla actio erit, nulla repetitio. Erras, si existimas succursurum tibi iudicem; nulla lex te in integrum restituet, solam accipientis fidem specta. Hoc modo beneficia
auctoritatem suam tenent et magnifica sunt; pollues illa, si materiam litium feceris. Aequissima vox est et ius gentium prae se ferens: «Redde, quod debes»; haec turpissima est in beneficio: «Redde!» Quid? Reddet vitam, quam debet? Dignitatem? Securitatem? Sanitatem? Reddi maxima quaeque non possunt. «At pro iis» inquit «aliquid, quod tanti sit». Hoc est, quod dicebam, interituram tantae rei dignitatem, si beneficium mercem facimus. Non est inritandus animus ad avaritiam, ad querellas, ad discordiam; sua sponte in ista fertur. Quantum possumus, resistamus et quaerenti occasiones amputemus. 15. Utinam quidem persuadere possemus, ut pecunias creditas tantum a volentibus acciperent! utinam nulla stipulatio emptorem venditori obligaret nec pacta conventaque inpressis signis custodirentur, fides potius illa servaret et aequum colens animus! Sed necessaria optimis praetulerunt et cogere fidem quam expectare malunt. Adhibentur ab utraque parte testes; ille per tabulas plurium nomina interpositis parariis facit; ille non est interrogatione contentus, nisi reum manu sua tenuit. O turpem humani generis fraudis ac nequitiae publicae confessionem! anulis nostris plus quam animis creditur. In quid isti ornati viri adhibiti sunt? In quid inprimunt signa? Nempe ne ille neget accepisse se, quod accepit. Hos incorruptos viros et vindices veritatis existimas? At his ipsis non aliter statim pecuniae conmittentur. Ita non honestius erat a quibusdam fidem falli, quam ab omnibus perfidiam timeri? Hoc unum deest avaritiae, ut beneficia sine sponsore non demus. Generosi animi est et magnifici iuvare, prodesse; qui dat beneficia, deos imitatur, qui repetit, feneratores. Quid illos, dum vindicamus, in turbam sordidissimam redigimus? 16. «Plures» inquit «ingrati erunt, si nulla adversus ingratum datur actio». Immo pauciores, quia maiore dilectu dabuntur beneficia. Deinde non expedit notum omnibus fieri, quam multi ingrati sint; pudorem enim rei tollet multitudo peccantium, et desinet esse probri loco commune maledictum. Numquid iam ulla repudio erubescit, postquam inlustres quaedam ac nobiles feminae non consulum numero sed maritorum annos suos conputant et exeunt matrimonii causa, nubunt repudii? Tamdiu istuc timebatur, quamdiu rarum erat; quia nulla sine divortio acta sunt, quod saepe audiebant, facere didicerunt. Numquid iam ullus adulterii pudor est, postquam eo ventum est, ut nulla virum habeat, nisi ut adulterum inritet? Argumentum est deformitatis pudicitia. Quam invenies tam miseram, tam sordidam, ut illi satis sit unum adulterorum par, nisi singulis divisit horas? Et non sufficit dies omnibus, nisi apud alium gestata est, apud alium mansit. Infrunita et antiqua est, quae nesciat matrimonium vocari unum adulterium. Quemadmodum horum delictorum iam evanuit pudor, postquam res latius evagata est, ita ingratos plures efficies et avidiores, si numerare se coeperint. 17. «Quid ergo? Inpunitus erit ingratus?» Quid ergo, inpunitus erit inpius?
Quid malignus? Quid avarus? Quid inpotens? Quid crudelis? Inpunita tu credis esse, quae invisa sunt, aut ullum supplicium gravius existimas publico odio? Poena est, quod non audet ab ullo beneficium accipere, quod non audet ulli dare, quod omnium designatur oculis aut designari se iudicat, quod intellectum rei optimae ac dulcissimae amisit. An tu infelicem vocas, qui caruit acie, cuius aures morbus obstruxit, non vocas miserum eum, qui sensum beneficiorum amisit? Testes ingratorum omnium deos metuit, urit illum et angit intercepti beneficii conscientia; denique satis haec ipsa poena magna est, quod rei, ut dicebam, iocundissimae fructum non percipit. At quem iuvat accepisse, aequali perpetuaque voluptate fruitur et animum eius, a quo accepit, non rem intuens gaudet. Gratum hominem semper beneficium delectat, ingratum semel. Conparari autem potest utriusque vita, cum alter tristis sit et sollicitus, qualis esse infitiator ac fraudulentus solet, apud quem non parentium, qui debet, honor est, non educatoris, non praeceptorum, alter laetus, hilaris, occasionem referendae gratiae expectans et ex hoc ipso adfectu gaudium grande percipiens nec quaerens, quomodo decoquat, sed quemadmodum plenius uberiusque respondeat non solum parentibus et amicis, sed humilioribus quoque personis? Nam etiam si a servo suo beneficium accepit, aestimat, non a quo, sed quid acceperit. 18. Quamquam quaeritur a quibusdam, sicut ab Hecatone, an beneficium dare servus domino possit. Sunt enim, qui ita distinguant, quaedam beneficia esse, quaedam officia, quaedam ministeria; beneficium esse, quod alienus det (alienus est, qui potuit sine reprehensione cessare); officium esse filii, uxoris, earum personarum, quas necessitudo suscitat et ferre opem iubet; ministerium esse servi, quem condicio sua eo loco posuit, ut nihil eorum, quae praestat, inputet superiori. Praeterea servum qui negat dare aliquando domino beneficium, ignarus est iuris humani; refert enim, cuius animi sit, qui praestat, non cuius status. Nulli praeclusa virtus est; omnibus patet, omnes admittit, omnes invitat, et ingenuos et libertinos et servos et reges et exules; non eligit domum nec censum, nudo homine contenta est. Quid enim erat tuti adversus repentina, quid animus magnum promitteret sibi, si certam virtutem fortuna amitteret? Si non dat beneficium servus domino, nec regi quisquam suo nec duci suo miles; quid enim interest, quali quis teneatur imperio, si summo tenetur? Nam si servo, quo minus in nomen meriti perveniat, necessitas obstat et patiendi ultima timor, idem istuc obstabit et ei, qui regem habet, et ei, qui ducem, quoniam sub dispari titulo paria in illos licent. Atqui dant regibus suis, dant imperatoribus beneficia: ergo et dominis. Potest servus iustus esse, potest fortis, potest magni animi: ergo et beneficium dare potest; nam et hoc virtutis est. Adeo quidem dominis servi beneficia possunt dare, ut ipsos saepe beneficii sui fecerint. 19. Non est dubium, quin servus beneficium dare possit cuilibet; quare ergo non et domino suo possit? «Quia non potest» inquit «creditor domini sui fieri, si pecuniam illi dederit. Alioqui cottidie dominum suum obligat: peregrinantem
sequitur, aegro ministrat, rus eius labore summo colit; omnia tamen ista, quae alio praestante beneficia dicerentur, praestante servo ministeria sunt. Beneficium enim id est, quod quis dedit, cum illi liceret et non dare; servus autem non habet negandi potestatem; ita non praestat, sed paret, nec id se fecisse iactat, quod non facere non potuit». Iam sub ista ipsa lege vincam et eo perducam servum, ut in multa liber sit; interim dic mihi, si tibi ostendero aliquem pro salute domini sui sine respectu sui dimicantem et confossum volneribus reliquias tamen sanguinis ab ipsis vitalibus fundentem et, ut ille effugiendi tempus habeat, moram sua morte quaerentem, hunc tu negabis beneficium dedisse, quia servus est? Si tibi ostendero aliquem, ut secreta domini prodat, nulla tyranni pollicitatione corruptum, nullis territum minis, nullis cruciatibus victum avertisse, quantum potuerit, suspiciones quaerentis et inpendisse spiritum fidei, hunc tu negabis beneficium domino dedisse, quia servus est? Vide, ne eo maius sit, quo rarius est exemplum virtutis in servis, eoque gratius, quod, cum fere invisa imperia sint et omnis necessitas gravis, commune servitutis odium in aliquo domini caritas vicit. Ita non ideo beneficium non est, quia a servo profectum est, sed ideo maius, quia deterrere ab illo ne servitus quidem potuit. 20. Errat, si quis existimat servitutem in totum hominem descendere. Pars melior eius excepta est: corpora obnoxia sunt et adscripta dominis, mens quidem sui iuris, quae adeo libera et vaga est, ut ne ab hoc quidem carcere, cui inclusa est, teneri queat, quo minus inpetu suo utatur et ingentia agat et in infinitum comes caelestibus exeat. Corpus itaque est, quod domino fortuna tradidit; hoc emit, hoc vendit; interior illa pars mancipio dari non potest. Ab hac quidquid venit, liberum est; nec enim aut nos omnia iubere possumus aut in omnia servi parere coguntur: contra rem publicam imperata non facient, nulli sceleri manus commodabunt. 21. Quaedam sunt, quae leges nec iubent nec vetant facere; in iis servus materiam beneficii habet. Quam diu praestatur, quod a servo exigi solet, ministerium est; ubi plus, quam quod servo necesse est, beneficium est; ubi in adfectum amici transit, desinit vocari ministerium. Est aliquid, quod dominus praestare servo debeat, ut cibaria, ut vestiarium; nemo hoc dixit beneficium; at indulsit, liberalius educavit, artes, quibus erudiuntur ingenui, tradidit: beneficium est. Idem e contrario fit in persona servi: quidquid est, quod servilis officii formulam excedit, quod non ex imperio, sed ex voluntate praestatur, beneficium est, si modo tantum est, ut hoc vocari potuerit quolibet alio praestante. 22. Servus, ut placet Chrysippo, perpetuus mercennarius est. Quemadmodum ille beneficium dat, ubi plus praestat, quam in quod operas locavit, sic servus, ubi benevolentia erga dominum fortunae suae modum transit et altius aliquid ausus, quod etiam felicius natis decori esset, spem domini antecessit, beneficium
est intra domum inventum. An aequum videtur tibi, quibus, si minus debito faciant, irascimur, non haberi gratiam, si plus debito solitoque fecerint? Vis scire, quando non sit beneficium? Ubi dici potest: «Quid, si nollet?». Ubi vero id praestitit, quod nolle licuit, voluisse laudandum est. Inter se contraria sunt beneficium et iniuria; potest dare beneficium domino, si a domino iniuriam accipere. Atqui de iniuriis dominorum in servos qui audiat positus est, qui et saevitiam et libidinem et in praebendis ad victum necessariis avaritiam conpescat. Quid ergo? Beneficium dominus a servo accipit? Immo homo ab homine. Denique, quod in illius potestate fuit, fecit: beneficium domino dedit; ne a servo acceperis, in tua potestate est. Quis autem tantus est, quem non fortuna indigere etiam infimis cogat? 23. Multa iam beneficiorum exempla referam et dissimilia et quaedam inter se contraria. Dedit aliquis domino suo vitam, dedit mortem, servavit periturum et, hoc si parum est, pereundo servavit; alius mortem domini adiuvit, alius decepit. Claudius Quadrigarius in duodevicensimo annalium tradit, cum obsideretur Grumentum et iam ad summam desperationem ventum esset, duos servos ad hostem transfugisse et operae pretium fecisse. Deinde urbe capta passim discurrente victore illos per nota itinera ad domum, in qua servierant, praecucurrisse et dominam suam ante egisse; quaerentibus, quaenam esset, dominam et quidem crudelissimam ad supplicium ab ipsis duci professos esse. Eductam deinde extra muros summa cura celasse, donec hostilis ira consideret; deinde, ut satiatus miles cito ad Romanos mores rediit, illos quoque ad suos redisse et dominam sibi ipsos dedisse. Manu misit utrumque e vestigio illa nec indignata est ab his se vitam accepisse, in quos vitae necisque potestatem habuisset. Potuit sibi hoc vel magis gratulari; aliter enim servata munus notae et volgaris clementiae habuisset, sic servata nobilis fabula et exemplum duarum urbium fuit. In tanta confusione captae civitatis cum sibi quisque consuleret, omnes ab illa praeter transfugas fugerunt; at hi, ut ostenderent, quo animo facta esset prior illa transitio, a victoribus ad captivam transfugerunt personam parricidarum ferentes; quod in illo beneficio maximum fuit, tanti iudicaverunt, ne domina occideretur, videri dominam occidisse. Non est, mihi crede, condicio servilis animi egregium factum fama sceleris emisse. Vettius, praetor Marsorum, ducebatur ad Romanum imperatorem; servus eius gladium militi illi ipsi, a quo trahebatur, eduxit et primum dominum occidit, deinde: «Tempus est» inquit «me et mihi consulere! iam dominum manu misi», atque ita traiecit se uno ictu. Da mihi quemquam, qui magnificentius dominum servaverit. 24. Corfinium Caesar obsidebat, tenebatur inclusus Domitius; imperavit medico eidemque servo suo, ut sibi venenum daret. Cum tergiversantem videret: «Quid cunctaris» inquit, «tamquam in tua potestate totum istud sit? Mortem rogo armatus». Tum ille promisit et medicamentum innoxium bibendum illi dedit; quo
cum sopitus esset, accessit ad filium eius et: «Iube» inquit «me adservari, dum ex eventu intellegas, an venenum patri tuo dederim». Vixit Domitius et servatus a Caesare est; prior tamen illum servus servaverat. 24. Bello civili proscriptum dominum servus abscondit et, cum anulos eius sibi aptasset ac vestem induisset, speculatoribus occurrit nihilque se deprecari, quo minus imperata peragerent, dixit et deinde cervicem porrexit. Quanti viri est pro domino eo tempore mori velle, quo rara erat fides dominum mori nolle! in publica crudelitate mitem inveniri, in publica perfidia fidelem! cum praemia proditionis ingentia ostendantur, praemium fidei mortem concupiscere! 26. Nostri saeculi exempla non praeteribo. Sub Tib. Caesare fuit accusandi frequens et paene publica rabies, quae omni civili bello gravius togatam civitatem confecit; excipiebatur ebriorum sermo, simplicitas iocantium; nihil erat tutum; omnis saeviendi placebat occasio, nec iam reorum expectabantur eventus, cum esset unus. Cenabat Paulus praetorius in convivio quodam imaginem Tib. Caesaris habens ectypa et eminente gemma. Rem ineptissimam fecero, si nunc verba quaesiero, quemadmodum dicam illum matellam sumpsisse; quod factum simul et Maro ex notis illius temporis vestigatoribus notavit et servus eius, quoi nectebantur insidiae. Is subsidians ei ebrio anulum extraxit et cum Maro convivas testaretur admotam esse imaginem obscenis et iam subscriptionem conponeret, ostendit in manu sua servus anulum. Si quis hunc servum vocat, et illum convivam vocabit. 27. Sub divo Augusto nondum hominibus verba sua periculosa erant, iam molesta. Rufus, vir ordinis senatorii, inter cenam optaverat, ne Caesar salvus rediret ex ea peregrinatione, quam parabat; et adiecerat idem omnes et tauros et vitulos optare. Fuerunt, qui illa diligenter audirent. Ut primum diluxit, servus, qui cenanti ad pedes steterat, narrat, quae inter cenam ebrius dixisset, et hortatur, ut Caesarem occupet atque ipse se deferat. Usus consilio descendenti Caesari occurrit et, cum malam mentem habuisse se pridie iurasset, id ut in se et in filios suos recideret, optavit et Caesarem, ut ignosceret sibi rediretque in gratiam secum, rogavit. Cum dixisset se Caesar facere: «Nemo» inquit «credet te mecum in gratiam redisse, nisi aliquid mihi donaveris», petitque non fastidiendam etiam a propitio summam et inpetravit. Caesar ait: «Mea causa dabo operam, ne umquam tibi irascar». Honeste fecit Caesar, quod ignovit, quod liberalitatem clementiae adiecit; quicumque hoc audierit exemplum, necesse est Caesarem laudet, sed cum servum ante laudaverit. Non expectas, ut tibi narrem manu missum, qui hoc fecerat; nec tamen gratis: pecuniam pro libertate eius Caesar numeraverat. 28. Post tot exempla num dubium est, quin beneficium aliquando a servo dominus accipiat? Quare potius persona rem minuat, quam personam res ipsa
cohonestet? Eadem omnibus principia eademque origo; nemo altero nobilior, nisi cui rectius ingenium et artibus bonis aptius. Qui imagines in atrio exponunt et nomina familiae suae longo ordine ac multis stemmatum inligata flexuris in parte prima aedium conlocant, non noti magis quam nobiles sunt? Unus omnium parens mundus est, sive per splendidos sive per sordidos gradus ad hunc prima cuiusque origo perducitur. Non est, quod te isti decipiant, qui, cum maiores suos recensent, ubicumque nomen inlustre defecit, illo deum infulciunt. Neminem despexeris, etiam si circa illum obsoleta sunt nomina et parum indulgente adiuta fortuna. Sive libertini ante vos habentur sive servi sive exterarum gentium homines, erigite audacter animos et, quidquid in medio sordidi iacet, transilite; expectat vos in summo magna nobilitas. Quid superbia in tantam vanitatem adtollimur, ut beneficia a servis indignemur accipere et sortem eorum spectemus obliti meritorum? Servum tu quemquam vocas, libidinis et gulae servus et adulterae, immo adulterarum commune mancipium? Servum vocas quemquam tu? Quo tandem ab istis gerulis raperis cubile istud tuum circumferentibus? Quo te penulati in militum quidem non volgarem cultum subornati, quo, inquam, te isti efferunt? Ad ostium alicuius ostiarii, ad hortos alicuius ne ordinarium quidem habentis officium; et deinde negas tibi a servo tuo beneficium dari posse, cui osculum alieni servi beneficium est? Quae est tanta animi discordia? Eodem tempore servos despicis et colis, imperiosus intra limen atque inpotens, humilis foris et tam contemptus quam contemnens; neque enim ulli magis abiciunt animos, quam qui inprobe tollunt, nullique ad calcandos alios paratiores, quam qui contumelias facere accipiendo didicerunt. 29. Dicenda haec fuerunt ad contundendam insolentiam hominum ex fortuna pendentium vindicandumque ius beneficii dandi servis, ut filiis quoque vindicaretur. Quaeritur enim, an aliquando liberi maiora beneficia dare parentibus suis possint, quam acceperint. Illud conceditur multos filios maiores potentioresque extitisse quam parentes suos; aeque et illud meliores fuisse. Quod si constat, potest fieri, ut meliora tribuerint, cum et fortuna illis maior esset et melior voluntas. «Quidquid» inquit «est, quod det patri filius, utique minus est, quia hanc ipsam dandi facultatem patri debet. Ita numquam beneficio vincitur, cuius beneficium est ipsum, quod vincitur». Primum quaedam initium ab aliis trahunt et tamen initiis suis maiora sunt; nec ideo aliquid non est maius eo, quo coepit, quia non potuisset in tantum procedere, nisi coepisset. Nulla non res principia sua magno gradu transit. Semina omnium rerum causae sunt et tamen minimae partes sunt eorum, quae gignunt. Adspice Rhenum, adspice Euphraten, omnes denique inclutos amnes: quid sunt, si illos illic, unde effluunt, aestimes? Quidquid est, quo timentur, quo nominantur, in processu paraverunt. Adspice trabes, sive proceritatem aestimes, altissimas, sive crassitudinem spatiumque ramorum, latissime fusas: quantulum est his conparatum illud, quod radix tenui fibra conplectitur? Tolle radicem:
nemora non surgent, nec tanti montes vestientur. Innituntur fundamentis suis templa excelsa urbis; tamen, quae in firmamentum totius operis iacta sunt, latent. Idem in ceteris evenit: principia sua semper sequens magnitudo obruet. Non potuissem quicquam consequi, nisi parentum beneficium antecessisset; sed non ideo, quidquid consecutus sum, minus est eo, sine quo consecutus non essem. Nisi me nutrix aluisset infantem, nihil eorum, quae consilio ac manu gero, facere potuissem nec in hanc emergere nominis claritatem, quam civili ac militari industria merui; numquid tamen ideo maximis operibus praeferes nutricis officium? Atqui quid interest, cum aeque sine patris beneficio quam sine nutricis non potuerim ad ulteriora procedere? Quod si initio meo, quidquid iam possum, debeo, cogita non esse initium mei patrem, ne avum quidem; semper enim erit ulterius aliquid, ex quo originis proximae origo descendat. Atqui nemo dicet me plus debere ignotis et ultra memoriam positis maioribus quam patri; plus autem debeo, si hoc ipsum, quod genuit me pater meus, maioribus debet. 30. «Quidquid praestiti patri, etiam si magnum est, infra aestimationem paterni muneris est, quia non esset, si non genuisset». Isto modo etiam, si quis patrem meum aegrum ac moriturum sanaverit, nihil praestare ei potero, quod non beneficio eius minus sit; non enim genuisset me pater, nisi sanatus esset. Sed vide, ne illud verius sit aestimari, an id, quod potui, et id, quod feci, meum sit, mearum virium, meae voluntatis. Illud, quod natus sum, per se intuere, quale sit: animadvertis exiguum et incertum et boni malique communem materiam, sine dubio primum ad omnia gradum, sed non ideo maiorem omnibus, quia primus est. Servavi patrem meum et ad summam provexi dignitatem et principem urbis suae feci nec tantum rebus a me gestis nobilitavi, sed ipsi quoque gerendarum ingentem ac facilem nec tutam minus quam gloriosam dedi materiam; honores, opes, quidquid humanos ad se animos rapit, congessi, et cum supra omnes starem, infra illum steti. Dic nunc: «Hoc ipsum, quod ista potuisti, patris munus est»; respondebo tibi: «Est prorsus, si ad ista facienda nasci satis est; sed si ad bene vivendum minima portio est vivere et id tribuisti, quod cum feris mihi et animalibus quibusdam minimis, quibusdam etiam foedissimis commune est, noli tibi adserere, quod non ex tuis beneficiis, etiam ‹si non› sine tuis, oritur». 31. Puta me vitam pro vita reddidisse: sic quoque munus tuum vici, cum ego dederim sentienti, cum sentiens me dare, cum vitam tibi non voluptatis meae causa aut certe per voluptatem dederim, cum tanto maius sit retinere spiritum quam accipere, quanto levius mori ante mortis metum. Ego vitam dedi statim illa usuro, tu nescituro, an viveret; ego vitam dedi mortem timenti, tu vitam dedisti, ut mori possem; ego tibi vitam dedi consummatam, perfectam, tu me expertem rationis genuisti, onus alienum. Vis scire, quam non sit magnum beneficium vitam sic dare? Exposuisses; nempe iniuria erat genuisse. Quo quid colligo? Minimum esse beneficium patris matrisque concubitum, nisi accesserunt alia, quae prosequerentur hoc initium muneris et aliis officiis ratum facerent. Non est bonum
vivere, sed bene vivere. At bene vivo. Sed potui et male; ita hoc tantum est tuum, quod vivo. Si vitam inputas mihi per se, nudam, egentem consilii, et id ut magnum bonum iactas, cogita te mihi inputare muscarum ac vermium bonum. Deinde, ut nihil aliud dicam, quam bonis artibus me studuisse et cursum ad rectum iter vitae derexisse, in ipso beneficio tuo maius, quam quod dederas, recepisti; tu enim me mihi rudem, inperitum dedisti, ego tibi filium, qualem genuisse gauderes. 32. Aluit me pater. Si idem praesto, plus reddo, quia non tantum ali se, sed a filio ali gaudet et maiorem ex animo meo quam ex ipsa re percipit voluptatem, illius alimenta ad corpus tantum meum pervenerunt. Quid? Si quis in tantum processit, ut aut eloquentia per gentes notesceret aut iustitia aut bellicis rebus et patri quoque ingentem circumfunderet famam tenebrasque natalium suorum clara luce discuteret, non inaestimabile in parentes suos beneficium contulit? An quisquam Aristonem et Gryllum nisi propter Xenophontem ac Platonem filios nosset? Sophroniscum Socrates expirare non patitur. Ceteros enumerare longum est, qui durant ob nullam aliam causam, quam quod illos liberorum eximia virtus tradidit posteris. Utrum maius beneficium dedit M. Agrippae pater ne post Agrippam quidem notus, an patri dedit Agrippa navali corona insignis, unicum adeptus inter dona militaria decus, qui tot in urbe maxima opera excitavit, quae et priorem magnificentiam vincerent et nulla postea vincerentur? Utrum Octavius maius beneficium dedit filio an patri divus Augustus, quamvis illum umbra adoptivi patris abscondit? Quantam cepisset voluptatem, si illum post debellata arma civilia vidisset securae paci praesidentem, non adgnoscens bonum suum nec satis credens, quotiens ad se respexisset, potuisse illum virum in domo sua nasci! Quid nunc ceteros persequar, quos iam consumpsisset oblivio, nisi illos filiorum gloria e tenebris eruisset et adhuc in luce retineret? Deinde, cum quaeramus, non quis filius patri maiora beneficia reddiderit, quam a patre acceperat, sed an aliquis possit maiora reddere, etiam si, quae rettuli, exempla nondum satis faciunt nec beneficia parentium suorum superiaciunt: capit tamen hoc natura, quod nondum ulla aetas tulit. Si singula paternorum meritorum magnitudinem exuperare non possunt, plura in unum congesta superabunt. 33. Servavit in proelio patrem Scipio et praetextatus in hostes ecum concitavit. Parum est, quod, ut perveniret ad patrem, tot pericula maximos duces cum maxime prementia contempsit, tot obpositas difficultates, quod ad primam pugnam exiturus tiro per veteranorum corpora cucurrit, quod annos suos transiluit? Adice, ut idem patrem reum defendat et conspirationi inimicorum potentium eripiat, ut alterum illi consulatum ac tertium aliosque honores etiam consularibus concupiscendos congerat, ut pauperi raptas belli iure opes tradat et, quod est militaribus viris speciosissimum, divitem illum spoliis etiam hostilibus faciat. Si adhuc parum est, adice, ut provincias et extraordinaria imperia continuet, adice, ut dirutis maximis urbibus Romani imperii sine aemulo ad ortus
occasusque venturi defensor et conditor maiorem nobilitatem nobili viro adiciat, dici Scipionis patrem: dubium est, quin generandi volgare beneficium vicerit eximia pietas et virtus ipsi urbi nescio utrum maius praesidium adferens an decus? Deinde, si hoc parum est, finge aliquem tormenta patris discussisse, finge in se transtulisse. Licet tibi, in quantum velis, extendere beneficia filii, cum paternum munus et simplex sit et facile et danti voluptarium, quod necesse est ille multis dederit, etiam quibus dedisse se nescit, in quo consortem habet, in quo spectavit legem, patriam, praemia patrum, domus ac familiae perpetuitatem, omnia potius quam eum, quoi dabat. Quid? Si quis sapientiam consecutus hanc patri tradiderit, etiamnunc disputabimus, an maius aliquid iam dederit, quam acceperat, cum vitam beatam patri reddiderit, acceperit tantum vitam? 34. «Sed patris» inquit «beneficium est, quidquid facis, quidquid praestare illi potes». Et praeceptoris mei, quod institutis liberalibus profeci; ipsos tamen, qui tradiderunt illa, transcendimus, utique eos, qui prima elementa docuerunt, et quamvis sine illis nemo quicquam adsequi posset, non tamen, quantumcumque quis adsecutus est, infra illos est. Multum inter prima ac maxima interest, nec ideo prima maximorum instar sunt, quia sine primis maxima esse non possunt. 35. Iam tempus est quaedam ex nostra, ut ita dicam, moneta proferre. Qui id beneficium dedit, quo est aliquid melius, potest vinci. Pater dedit filio vitam, est autem aliquid vita melius: ita pater vinci potest, quia dedit beneficium, quo est aliquid melius. Etiamnunc, qui dedit alicui vitam, si et semel et iterum liberatus est mortis periculo, maius accepit beneficium quam dedit; pater autem vitam dedit: potest ergo, si saepius periculo mortis liberatus a filio fuerit, maius beneficium accipere quam dedit. Qui beneficium accipit, maius accipit, quo magis eo indiget; magis autem indiget vita, qui vivit, quam qui natus non est, ut qui ne indigere quidem omnino possit: maius ergo beneficium accipit pater, si vitam a filio accipit, quam filius a patre, quod natus est. «Patris beneficia vinci a filii beneficiis non possunt. Quare? Quia vitam accepit a patre, quam nisi accepisset, nulla dare beneficia potuisset». Hoc commune est patri cum omnibus, qui vitam alicui dederunt; non potuissent enim referre gratiam, nisi vitam accepissent. Ergo nec medico gratia in maius referri potest (solet enim et medicus vitam dare), nec nautae, si naufragum sustulit. Atqui et horum et aliorum, qui aliquo modo nobis vitam dederunt, beneficia vinci possunt: ergo et patrum possunt. Si quis mihi beneficium dedit, quod multorum beneficiis adiuvandum esset, ego autem illi beneficium dedi id, quod nullius egeret adiutorio, maius dedi quam accepi; pater filio vitam dedit perituram, nisi multa accessissent, quae illam tuerentur; filius patri si dedit vitam, dedit eam, quae nullius desideraret auxilium in hoc, ut permaneret: ergo maius beneficium accepit a filio pater, qui vitam accepit, quam ipse illi dedit.
36. Haec non destruunt parentium venerationem nec deteriores illis liberos faciunt, immo etiam meliores; natura enim gloriosa virtus est et anteire priores cupit. Alacrior erit pietas, si ad reddenda beneficia cum vincendi spe venerit. Ipsis patribus id volentibus laetisque contigerit, quoniam pleraque sunt, in quibus nostro bono vincimur. Unde certamen tam optabile? Unde tantam felicitatem parentibus, ut fateantur ipsos liberorum beneficiis inpares? Nisi hoc ita iudicamus, excusationem damus liberis et illos segniores ad referendam gratiam facimus, quibus stimulos adicere debemus et dicere: «Hoc agite, optimi iuvenes! Proposita est inter parentes ac liberos honesta contentio, dederint maiora an receperint. Non ideo vicerunt, quia occupaverunt; sumite modo animum, qualem decet, et deficere nolite: vincetis optantes. Nec desunt tam pulchro certamini duces, qui ad similia vos cohortentur ac per vestigia sua ire ad victoriam saepe iam partam ex parentibus iubeant. 37. Vicit Aeneas patrem, ipse eius in infantia leve tutumque gestamen, gravem senio per media hostium agmina et per cadentis circa se urbis ruinas ferens, cum conplexus sacra ac penates deos religiosus senex non simplici vadentem sarcina premeret; tulit illum per ignes et (quid non pietas potest?) pertulit colendumque inter conditores Romani imperii posuit. Vicere Siculi iuvenes: cum Aetna maiore vi peragitata in urbes, in agros, in magnam insulae partem effudisset incendium, vexerunt parentes suos; discessisse creditum est ignes et utrimque flamma recedente limitem adapertum, per quem transcurrerent iuvenes dignissimi, qui magna tuto auderent. Vicit Antigonus, qui, cum ingenti proelio superasset hostem, praemium belli ad patrem transtulit et imperium illi Cypri tradidit; hoc est regnum nolle regnare, cum possis. Vicit patrem imperiosum quidem Manlius, qui, cum ante ad tempus relegatus esset a patre ob adulescentiam brutam et hebetem, ad tribunum plebis, qui patri suo diem dixerat, venit petitoque tempore, quod ille dederat sperans fore proditorem parentis invisi, (et bene meruisse se de iuvene credebat, cuius exilium pro gravissimo crimine inter alia Manlio obiciebat) nanctus adulescens secretum stringit occultatum sinu ferrum et: «Nisi iuras» inquit «te diem patri remissurum, hoc te gladio transfodiam. In tua potestate est, utro modo pater meus accusatorem non habeat». Iuravit tribunus nec fefellit et causam actionis omissae contioni reddidit. Nulli alii licuit inpune tribunum in ordinem redigere. 38. Alia ex aliis exempla sunt eorum, qui parentes suos periculis eripuerint, qui ex infimo ad summum protulerint et e plebe acervoque ignobili numquam tacendos saeculis dederint. Nulla vi verborum, nulla ingenii facultate exprimi potest, quantum opus sit, quam laudabile quamque numquam memoria hominum exiturum, posse hoc dicere: «Parentibus meis parui, cessi imperio eorum, sive aequum sive inicum ac durum fuit, obsequentem submissumque me praebui; ad hoc unum contumax fui, ne beneficiis vincerer». Certate, obsecro vos, et fessi quoque restituite aciem. Felices, qui vincent, felices, qui vincentur! Quid eo
adulescente praeclarius, qui sibi ipsi dicere poterit (neque enim est fas alteri dicere): «Patrem meum beneficiis vici»? Quid eo fortunatius sene, qui omnibus ubique praedicabit a filio se suo beneficiis victum? Quid autem est felicius quam ibi cedere?»
Liber quartus 1. Ex omnibus, quae tractavimus, Aebuti Liberalis, potest videri nihil tam necessarium aut magis, ut ait Sallustius, cum cura dicendum, quam quod in manibus est: an beneficium dare et in vicem gratiam referre per se res expetendae sint. Inveniuntur, qui honesta in mercedem colant quibusque non placeat virtus gratuita; quae nihil habet in se magnificum, si quicquam venale. Quid enim est turpius, quam aliquem conputare, quanti vir bonus sit, cum virtus nec lucro invitet nec absterreat damno adeoque neminem spe ac pollicitatione corrumpat, ut contra inpendere in se iubeat et saepius in ultro tributis sit? Calcatis ad illam utilitatibus eundum est; quocumque vocavit, quocumque misit, sine respectu rei familiaris, interdum etiam sine ulla sanguinis sui parsimonia vadendum nec umquam inperium eius detractandum. «Quid consequar» inquit, «si hoc fortiter, si hoc grate fecero?» Quod feceris; nihil tibi extra promittitur. Si quid commodi forte obvenerit, inter accessiones numerabis. Rerum honestarum pretium in ipsis est. Si honestum per se expetendum est, beneficium autem honestum est, non potest alia eius condicio esse, cum eadem natura sit. Per se autem expetendum esse honestum saepe et abunde probatum est. 2. In hac parte nobis pugna est cum Epicureis, delicata et umbratica turba in convivio suo philosophantium, apud quos virtus voluptatum ministra est, illis paret, illis deservit, illas supra se videt. «Non est» inquis «voluptas sine virtute». Sed quare ante virtutem est? De ordine putas disputationem esse? De re tota et de potestate eius ambigitur. Non est virtus, si sequi potest; primae partes eius sunt, ducere debet, imperare, summo loco stare; tu illam iubes signum petere. «Quid» inquit «tua refert? Et ego sine virtute nego beatam vitam posse constare. Ipsam voluptatem, quam sequor, cui me emancipavi, remota illa inprobo et damno. De hoc uno disputatur, utrum virtus summi boni causa sit an ipsa summum bonum». Ut hoc unum quaeratur, ordinis tantum existimas mutationem? Ista vero confusio est et manifesta caecitas primis postrema praeferre. Non indignor, quod post voluptatem ponitur virtus, sed quod omnino cum voluptate, contemptrix eius et hostis et longissime ab illa resiliens, labori ac dolori familiarior, virilibus incommodis, quam isti effeminato bono. 3. Inserenda haec, mi Liberalis, fuerunt, quia beneficium, de quo nunc agitur, dare virtutis est et turpissimum id causa ullius alterius rei dare, quam ut datum sit. Nam si recipiendi spe tribueremus, locupletissimo cuique, non dignissimo daremus; nunc vero diviti inportuno pauperem praeferimus. Non est beneficium, quod ad fortunam spectat. Praeterea, si, ut prodessemus, sola nos invitaret utilitas, minime beneficia distribuere deberent, qui facillime possent, locupletes
et potentes et reges aliena ope non indigentes; di vero tot munera, quae sine intermissione diebus ac noctibus fundunt, non darent; in omnia enim illis natura sua sufficit plenosque et tutos et inviolabiles praestat; nulli ergo beneficium dabunt, si una dandi causa est se intueri ac suum commodum. Istud non beneficium, sed fenus est circumspicere, non ubi optime ponas, sed ubi quaestuosissime habeas, unde facillime tollas. Quod cum longe a dis remotum sit, sequitur, ut inliberales sint; nam si una beneficii dandi causa sit dantis utilitas, nulla autem ex nobis utilitas deo speranda est, nulla deo dandi beneficii causa est. 4. Scio, quid hoc loco respondeatur: «Itaque non dat deus beneficia, sed securus et neglegens nostri, aversus a mundo aliud agit aut, quae maxima Epicuro felicitas videtur, nihil agit, nec magis illum beneficia quam iniuriae tangunt». Hoc qui dicit, non exaudit precantium voces et undique sublatis in caelum manibus vota facientium privata ac publica; quod profecto non fieret, nec in hunc furorem omnes profecto mortales consensissent adloquendi surda numina et inefficaces deos, nisi nossemus illorum beneficia nunc oblata ultro, nunc orantibus data, magna, tempestiva, ingentes minas interventu suo solventia. Quis est autem tam miser, tam neclectus, quis tam duro fato et in poenam genitus, ut non tantam deorum munificentiam senserit? Ipsos illos conplorantes sortem suam et querulos circumspice: invenies non ex toto beneficiorum caelestium expertes, neminem esse, ad quem non aliquid ex illo benignissimo fonte manaverit. Parum est autem id, quod nascentibus ex aequo distribuitur? Ut quae secuntur inaequali dispensata mensura transeamus, parum dedit natura, cum se dedit? 5. «Non dat deus beneficia». Unde ergo ista, quae possides, quae das, quae negas, quae servas, quae rapis? Unde haec innumerabilia oculos, aures, animum mulcentia? Unde illa luxuriam quoque instruens copia (neque enim necessitatibus tantummodo nostris provisum est; usque in delicias amamur)? Tot arbusta non uno modo frugifera, tot herbae salutares, tot varietates ciborum per totum annum digestae, ut inerti quoque fortuita terrae alimenta praeberent? Iam animalia omnis generis, alia in sicco solidoque, alia in umido nascentia, alia per sublime demissa, ut omnis rerum naturae pars tributum aliquod nobis conferret? Flumina haec amoenissimis flexibus campos cingentia, illa praebitura commercio viam vasto et navigabili cursu vadentia, ex quibus quaedam aestatis diebus mirabile incrementum trahunt, ut arida et ferventi subiecta caelo loca subita vis aestivi torrentis inriget? Quid medicatorum torrentium venae? Quid in ipsis litoribus aquarum calentium exundatio? te, Lari maxime, teque, fluctibus et fremitu adsurgens, Benace, marino? 6. Si pauca quis tibi donasset iugera, accepisse te diceres beneficium:
inmensa terrarum late patentium spatia negas esse beneficium? Si pecuniam tibi aliquis donaverit et arcam tuam, quoniam tibi id magnum videtur, inpleverit, beneficium vocabis; tot metalla ‹deus› defodit, tot flumina emisit terra, super quae decurrunt sola, aurum vehentia; argenti, aeris, ferri inmane pondus omnibus locis obrutum, cuius investigandi tibi facultatem dedit, ac latentium divitiarum in summa terra signa disposuit: negas te accepisse beneficium? Si domus tibi donetur, in qua marmoris aliquid resplendeat et tectum nitidius auro aut coloribus sparsum, non mediocre munus vocabis; ingens tibi domicilium sine ullo incendii aut ruinae metu struxit, in quo vides non tenues crustas et ipsa, qua secantur, lamna graciliores, sed integras lapidis pretiosissimi moles, sed totas variae distinctaeque materiae, cuius tu parvula frusta miraris, tectum vero aliter nocte, aliter interdiu fulgens: negas te ullum munus accepisse? Et cum ista, quae habes, magno aestimes, quod est ingrati hominis, nulli debere te iudicas? Unde tibi istum, quem trahis, spiritum? Unde istam, per quam actus vitae tuae disponis atque ordinas, lucem? Unde sanguinem, cuius cursu vitalis continetur calor? Unde ista palatum tuum saporibus exquisitis ultra satietatem lacessentia? Unde haec inritamenta iam lassae voluptatis? Unde ista quies, in qua putrescis ac marces? Nonne, si gratus es, dices: Deus nobis haec otia fecit. Namque erit ille mihi semper deus, illius aram saepe tener nostris ab ovilibus inbuet agnus. Ille meas errare boves, ut cernis, et ipsum ludere, quae vellem, calamo permisit agresti. Ille deus est, non qui paucas boves, sed qui per totum orbem armenta dimisit, qui gregibus ubique passim vagantibus pabulum praestat, qui pascua hibernis aestiva substituit, qui non calamo tantum cantare et agreste atque inconditum carmen ad aliquam tamen observationem modulari docuit, sed tot artes, tot vocum varietates, tot sonos alios spiritu nostro, alios externo cantus edituros conmentus est. Neque enim nostra ista, quae invenimus, dixeris, non magis, quam quod crescimus, quam quod ad constitutum temporum sua corpori officia respondent: nunc puerilium dentium lapsus, nunc ad surgentem iam aetatem et in robustiorem gradum transeuntem pubertas et ultimus ille dens surgenti iuventae terminum ponens. Insita sunt nobis omnium aetatum, omnium artium semina, magisterque ex occulto deus producit ingenia. 7. «Natura» inquit «haec mihi praestat». Non intellegis te, cum hoc dicis, mutare nomen deo? Quid enim aliud est natura quam deus et divina ratio toti mundo partibusque eius inserta? Quotiens voles, tibi licet aliter hunc auctorem rerum nostrarum conpellare; et Iovem illum Optimum ac Maximum rite dices et Tonantem et Statorem, qui non, ut historici tradiderunt, ex eo, quod post votum susceptum acies Romanorum fugientium stetit, sed quod stant beneficio eius
omnia, stator stabilitorque est. Hunc eundem et Fatum si dixeris, non mentieris; nam quom fatum nihil aliud sit, quam series inplexa causarum, ille est prima omnium causa, ex qua ceterae pendent. Quaecumque voles, illi nomina proprie aptabis vim aliquam effectumque caelestium rerum continentia: tot adpellationes eius possunt esse, quot munera. 8. Hunc et Liberum patrem et Herculem ac Mercurium nostri putant: Liberum patrem, quia omnium parens sit, quoi primum inventa seminum vis est consultura per voluptatem; Herculem, quia vis eius invicta sit quandoque lassata fuerit operibus editis, in ignem recessura; Mercurium, quia ratio penes illum est numerusque et ordo et scientia. Quocumque te flexeris, ibi illum videbis occurrentem tibi; nihil ab illo vacat, opus suum ipse inplet. Ergo nihil agis, ingratissime mortalium, qui te negas deo debere, sed naturae, quia nec natura sine deo est nec deus sine natura, sed idem est utrumque, distat officio. Si, quod a Seneca accepisses, Annaeo te debere diceres vel Lucio, non creditorem mutares, sed nomen, quoniam, sive praenomen eius sive nomen dixisses sive cognomen, idem tamen ille esset; sic nunc naturam voca, fatum, fortunam: omnia eiusdem dei nomina sunt varie utentis sua potestate. Et iustitia, probitas, prudentia, fortitudo, frugalitas unius animi bona sunt; quidquid horum tibi placuit, animus placet. 9. Sed ne aliam disputationem ex obliquo habeam, plurima beneficia ac maxima in nos deus defert sine spe recipiendi, quoniam nec ille conlato eget nec nos ei quidquam conferre possumus; ergo beneficium per se expetenda res est. Una spectatur in eo accipientis utilitas; ad hanc accedamus sepositis commodis nostris. «Dicitis» inquit «diligenter eligendos, quibus beneficia demus, quia ne agricolae quidem semina harenis conmittant; quod si verum est, nostram utilitatem in beneficiis dandis sequimur, quemadmodum in arando serendoque; neque enim serere per se res expetenda est. Praeterea quaeritis, ‹ubi et quomodo detis› beneficium, quod non esset faciendum, si per se beneficium dare expetenda res esset, quoniam, quocumque loco et quocumque modo daretur, beneficium erat». Honestum propter nullam aliam causam quam propter ipsum sequimur; tamen, etiam si nihil aliud sequendum est, quaerimus, cui faciamus et quando et quemadmodum; per haec enim constat. Itaque, cum eligo, cui dem beneficium, id ago, ut quandoque beneficium sit, quia, si turpi datur, nec honestum esse potest nec beneficium. 10. Depositum reddere per se res expetenda est; non tamen semper reddam nec quolibet loco nec quolibet tempore. Aliquando nihil interest, utrum infitier an palam reddam. Intuebor utilitatem eius, cui redditurus sum, et nociturum illi depositum negabo. Idem in beneficio faciam: videbo, quando dem, cui dem, quemadmodum, quare. Nihil enim sine ratione faciendum est; non est autem beneficium, nisi quod ratione datur, quoniam ratio omnis honesti comes est.
Quam saepe hominum donationem suam inconsultam obiurgantium hanc exaudimus vocem: «Mallem perdidisse quam illi dedisse»! Turpissimum genus damni est inconsulta donatio multoque gravius male dedisse beneficium, quam non recepisse; aliena enim culpa est, quod non recipimus; quod, cui daremus, non elegimus, nostra. In electione nihil minus quam hoc, quod tu existimas, spectabo, a quo recepturus sim; eligo enim eum, qui gratus, non qui redditurus sit, saepe autem et non redditurus gratus ‹est et ingratus,› qui reddidit. Ad animum tendit aestimatio mea; ideo locupletem sed indignum praeteribo, pauperi viro bono dabo; erit enim in summa inopia gratus et, cum omnia illi deerunt, supererit animus. 11. Non lucrum ex beneficio capto, non voluptatem, non gloriam; uni placere contentus in hoc dabo, ut quod oportet faciam. Quod oportet autem non est sine electione: quae qualis futura sit, interrogas? Eligam virum integrum, simplicem, memorem, gratum, alieni abstinentem, sui non avare tenacem, benevolum; hunc ego cum elegero, licet nihil illi fortuna tribuat, ex quo referre gratiam possit, ex sententia gesta res erit. Si utilitas me et sordida conputatio liberalem facit, si nulli prosum, nisi ut in vicem ille mihi prosit, non dabo beneficium proficiscenti in diversas longinquasque regiones, afuturo semper; non dabo sic adfecto, ut spes ei nulla sit convalescendi; non dabo ipse deficiens, non enim habeo recipiendi tempus. Atqui ut scias rem per se expetendam esse bene facere, advenis modo in nostrum delatis portum, statim abituris, succurrimus; ignoto naufrago navem, qua revehatur, et damus et struimus. Discedit ille vix satis noto salutis auctore et numquam amplius in conspectum nostrum reversurus debitores nobis deos delegat precaturque, illi pro se gratiam referant; interim nos iuvat sterilis beneficii conscientia. Quid? Cum in ipso vitae fine constitimus, cum testamentum ordinamus, non beneficia nihil nobis profutura dividimus? Quantum temporis consumitur, quam diu secreto agitur, quantum et quibus demus! Quid enim interest, quibus demus a nullo recepturi? Atqui numquam diligentius damus, numquam magis iudicia nostra torquemus, quam ubi remotis utilitatibus solum ante oculos honestum stetit, tam diu officiorum mali iudices, quam diu illa depravat spes ac metus et inertissimum vitium, voluptas; ubi mors interclusit omnia et ad ferendam sententiam incorruptum iudicem misit, quaerimus dignissimos, quibus nostra tradamus, nec quicquam cura sanctiore conponimus, quam quod ad nos non pertinet. At mehercules tunc magna voluptas subit cogitantem: «Hunc ego locupletiorem faciam, et huius dignitati adiectis opibus aliquid splendoris adfundam». Si non damus beneficia nisi recepturi, intestatis moriendum sit. 12. «Dicitis» inquit «beneficium creditum insolubile esse, creditum autem non est res per se expetenda». Cum creditum dicimus, imagine et translatione utimur; sic enim et legem dicimus iusti iniustique regulam esse, et regula non est
res per se expetenda. Ad haec verba demonstrandae rei causa descendimus; cum dico creditum, intellegitur tamquam creditum. Vis scire? Adicio insolubile, cum creditum nullum non solvi aut possit aut debeat. Adeo beneficium utilitatis causa dandum non est, ut saepe, quemadmodum dixi, cum damno ac periculo dandum sit. Sic latronibus circumventum defendo, ut tuto transire permittatur; reum gratia laborantem tueor et hominum potentium factionem in me converto, quas illi detraxero sordes, sub accusatoribus isdem fortasse sumpturus, cum abire in partem alteram possim et securus spectare aliena certamina; spondeo pro iudicato et suspensis amici bonis libellum deicio creditoribus eius me obligaturus; ut possim servare proscriptum, ipse proscriptionis periculum adeo. Nemo Tusculanum aut Tiburtinum paraturus salubritatis causa et aestivi secessus, quoto anno empturus sit, disputat; cui e re sit, tuendum est. Eadem in beneficio ratio est; nam quom interrogaveris, quid reddat, respondebo: bonam conscientiam. Quid reddat beneficium? Dic tu mihi, quid reddat iustitia, quid innocentia, quid magnitudo animi, quid pudicitia, quid temperantia; si quicquam praeter ipsas, ‹ipsas› non petis. In quid mundus vices suas solvit? In quid sol diem extendit et contrahit? Omnia ista beneficia sunt, fiunt enim nobis profutura. Quomodo mundi officium est circumagere rerum ordinem, quomodo solis loca mutare, ex quibus oriatur, in quae cadat, et haec salutaria nobis facere sine praemio, ita viri officium est inter alia et beneficium dare. Quare ergo dat? Ne non det, ne occasionem bene faciendi perdat. 13. Vobis voluptas est inertis otii facere corpusculum et securitatem sopitis simillimam adpetere et sub densa umbra latitare tenerrimisque cogitationibus, quas tranquillitatem vocatis, animi marcentis oblectare torporem et cibis potionibusque intra hortorum latebram corpora ignavia pallentia saginare; nobis voluptas est dare beneficia vel laboriosa, dum aliorum labores levent, vel periculosa, dum alios periculis extrahant, vel rationes nostras adgravatura, dum aliorum necessitates et angustias laxent. Quid mea interest, an recipiam beneficia? Etiam cum recepero, danda sunt. Beneficium eius commodum spectat, cui praestatur, non nostrum; alioquin nobis illud damus. Itaque multa, quae summam utilitatem aliis adferunt, pretio gratiam perdunt. Mercator urbibus prodest, medicus aegris, mango venalibus; sed omnes isti, quia ad alienum commodum pro suo veniunt, non obligant eos, quibus prosunt. Non est beneficium, quod in quaestum mittitur. «Hoc dabo et hoc recipiam» auctio est. 14. Non dicam pudicam, quae amatorem ut incenderet reppulit, quae aut legem aut virum timuit; ut ait Ovidius: Quae, quia non licuit, non dedit, illa dedit. Non inmerito in numerum peccantium refertur, quae pudicitiam timori
praestitit, non sibi. Eodem modo, qui beneficium ut reciperet dedit, non dedit. Ergo et nos beneficium damus animalibus, quae aut usui aut alimento futura nutrimus? Beneficium damus arbustis, quae colimus, ne siccitate aut inmoti et neclecti soli duritia laborent? Nemo ad agrum colendum ex aequo et bono venit nec ad ullam rem, cuius extra ipsam fructus est; ad beneficium dandum non adducit cogitatio avara nec sordida, sed humana, liberalis, cupiens dare, etiam cum dederit, et augere novis ac recentibus vetera, unum habens propositum, quanto ei, cui praestat, bono futura sit; alioqui humile est, sine laude, sine gloria, prodesse, quia expedit. Quid magnifici est se amare, sibi parcere, sibi adquirere? Ab omnibus istis vera beneficii dandi cupido avocat, ad detrimentum iniecta manu trahit et utilitates relinquit ipso bene faciendi opere laetissima. 15. Numquid dubium est, quin contraria sit beneficio iniuria? Quomodo iniuriam facere per se vitanda ac fugienda res est, sic beneficium dare per se expetenda. Illic turpitudo contra omnia praemia in scelus hortantia valet; ad hoc invitat honesti per se efficax species. Non mentiar, si dixero neminem non amare beneficia sua, neminem non ita conpositum animo, ut libentius eum videat, in quem multa congessit, cui non causa sit iterum dandi beneficii semel dedisse. Quod non accideret, nisi ipsa nos delectarent beneficia. Quam saepe dicentem audias: «Non sustineo illum deserere, cui dedi vitam, quem e periculo eripui. Rogat me, ut causam suam contra homines gratiosos agam; nolo, sed quid faciam? Iam illi semel, iterum adfui». Non vides inesse isti rei propriam quandam vim, quae nos dare beneficia cogit, primum quia oportet, deinde quia dedimus? Cui initio ratio non fuisset praestandi aliquid, ei praestamus ob hoc, quia praestitimus; adeoque ad beneficia nos non inpellit utilitas, ut inutilia tueri ac fovere perseveremus sola beneficii caritate, cui etiam infeliciter dato indulgere tam naturale est, quam liberis pravis. 16. Idem isti gratiam referre ipsos fatentur, non quia honestum est, sed quia utile; quod non esse ita minore opera probandum est, quia, quibus argumentis collegimus beneficium dare per se rem expetendam esse, isdem etiam hoc colligimus. Fixum illud est, a quo in cetera probationes nostrae exeunt, honestum ob nullam aliam causam, quam quia honestum sit, coli. Quis ergo controversiam facere audebit, an gratum esse honestum sit? Quis non ingratum detestetur, hominem sibi ipsum inutilem? Quid autem, cum tibi narratur «adversus summa beneficia amici sui ingratus est», quomodo adficeris? Utrum tamquam rem turpem fecerit, an tamquam rem utilem sibi et profuturam omiserit? Puto, nequam hominem existimas, cui poena, non cui curatore opus sit; quod non accideret, nisi gratum esse per se expetendum honestumque esset. Alia fortasse minus dignitatem suam praeferunt et, an sint honesta, interprete egent; hoc expositum est pulchriusque, quam ut splendor eius dubie ac parum luceat. Quid tam laudabile, quid tam aequaliter in omnium animos receptum, quam referre bene meritis
gratiam? 17. Ad hoc, dic mihi, quae causa nos perducit? Lucrum? Quod qui non contemnit, ingratus est. Ambitio? Et quae iactatio est solvisse, quod debeas? Metus? Nullus ingrato; huic enim uni rei non posuimus legem, tamquam satis natura cavisset. Quomodo nulla lex amare parentes, indulgere liberis iubet (supervacuum est enim, in quod imus, inpelli), quemadmodum nemo in amorem sui cohortandus est, quem adeo, dum nascitur, trahit, ita ne ad hoc quidem, ut honesta per se petat; placent suapte natura, adeoque gratiosa virtus est, ut insitum sit etiam malis probare meliora. Quis est, qui non beneficus videri velit, qui non inter scelera et iniurias opinionem bonitatis adfectet, qui non ipsis, quae inpotentissime fecit, speciem aliquam induat recti velitque etiam his videri beneficium dedisse, quos laesit? Gratias itaque agi sibi ab iis, quos adflixere, patiuntur bonosque se ac liberales fingunt, quia praestare non possunt; quod non facerent, nisi illos honesti et per se expetendi amor cogeret moribus suis opinionem contrariam quaerere et nequitiam abdere, cuius fructus concupiscitur, ipsa vero odio pudorique est; nec quisquam tantum a naturae lege descivit et hominem exuit, ut animi causa malus sit. Dic enim cuilibet ex istis, qui rapto vivunt, an ad illa, quae latrociniis et furtis consecuntur, malint ratione bona pervenire: optabit ille, cui grassari et transeuntes percutere quaestus est, potius illa invenire quam eripere; neminem reperies, qui non nequitiae praemiis sine nequitia frui malit. Maximum hoc habemus naturae meritum, quod virtus lumen suum in omnium animos permittit; etiam, qui non secuntur illam, vident. 18. Ut scias per se expetendam esse grati animi adfectionem, per se fugienda res est ingratum esse, quoniam nihil aeque concordiam humani generis dissociat ac distrahit quam hoc vitium. Nam quo alio tuti sumus, quam quod mutuis iuvamur officiis? Hoc uno instructior vita contraque incursiones subitas munitior est, beneficiorum commercio. Fac nos singulos, quid sumus? Praeda animalium et victimae ac bellissimus et facillimus sanguis; quoniam ceteris animalibus in tutelam sui satis virium est, quaecumque vaga nascebantur et actura vitam segregem, armata sunt, hominem inbecilla ‹cutis› cingit, non unguium vis, non dentium terribilem ceteris fecit, nudum et infirmum societas munit. Duas ‹deus› res dedit, quae illum obnoxium validissimum facerent, rationem et societatem; itaque, qui par esse nulli posset, si seduceretur, rerum potitur. Societas illi dominium omnium animalium dedit; societas terris genitum in alienae naturae transmisit imperium et dominari etiam in mari iussit; haec morborum inpetus arcuit, senectuti adminicula prospexit, solacia contra dolores dedit; haec fortes nos facit, quod licet contra fortunam advocare. Hanc societatem tolle, et unitatem generis humani, qua vita sustinetur, scindes; tolletur autem, si efficis, ut ingratus animus non per se vitandus sit, sed quia aliquid illi timendum est; quam multi enim sunt, quibus ingratis esse tuto licet! Denique ingratum voco, quisquis metu gratus est.
19. Deos nemo sanus timet; furor est enim metuere salutaria, nec quisquam amat, quos timet. Tu denique, Epicure, deum inermem facis, omnia illi tela, omnem detraxisti potentiam et, ne cuiquam metuendus esset, proiecisti illum extra metum. Hunc igitur insaeptum ingenti quidem et inexplicabili muro divisumque a contactu et a conspectu mortalium non habes quare verearis; nulla illi nec tribuendi nec nocendi materia est; in medio intervallo huius et alterius caeli desertus sine animali, sine homine, sine re ruinas mundorum supra se circaque se cadentium evitat non exaudiens vota nec nostri curiosus. Atqui hunc vis videri colere non aliter quam parentem grato, ut opinor, animo; aut, si non vis gratus videri, quia nullum habes illius beneficium, sed te atomi et istae micae tuae forte ac temere conglobaverunt, cur colis? «Propter maiestatem» inquis «eius eximiam ac singularem naturam». Ut concedam tibi, nempe hoc facis nullo pretio inductus, nulla spe; est ergo aliquid per se expetendum, cuius te ipsa dignitas ducit, id est honestum. Quid est autem honestius, quam gratum esse? Huius virtutis materia tam late patet quam vita. 20. «Sed inest» inquit «huic bono etiam utilitas aliqua». Cui enim virtuti non inest? Sed id propter se expeti dicitur, quod, quamvis habeat aliqua extra commoda, sepositis quoque illis ac remotis placet. Prodest gratum esse; ero tamen gratus, etiam si nocet. Gratus quid sequitur? Ut haec res illi alios amicos, alia beneficia conciliet? Quid ergo? Si quis sibi offensas concitaturus est, si quis intellegit adeo per hoc se nihil consecuturum, ut multa etiam ex reposito adquisitoque perdenda sint, non libens in detrimenta descendit? Ingratus est, qui in referenda gratia secundum datum videt, qui sperat, cum reddit; ingratum voco, qui aegro adsidit, quia testamentum facturus est, cui de hereditate aut de legato vacat cogitare. Faciat licet omnia, quae facere bonus amicus et memor officii debet: si animo eius obversatur spes lucri, captator est et hamum iacit; ut aves, quae laceratione corporum aluntur, lassa morbo pecora et casura ex proximo speculantur, ita hic inminet morti et circa cadaver volat. 21. Gratus animus ipsa virtute propositi sui capitur. Vis scire hoc ita esse nec illum utilitate corrumpi? Duo genera sunt grati hominis: dicitur gratus, qui aliquid pro eo, quod acceperat, reddit; hic fortasse ostentare se potest, habet, quod iactet, quod proferat; dicitur gratus, qui bono animo accepit beneficium, bono debet; hic intra conscientiam clusus est. Quae illi contingere potest utilitas ex adfectu latenti? Atqui hic, etiam si ultra facere nil potest, gratus est: amat, debet, referre gratiam cupit; quidquid ultra desideras, non ipse deest. Artifex est etiam, cui ad exercendam artem instrumenta non suppetunt, nec minus canendi peritus, cuius vocem exaudiri fremitus obstrepentium non sinit. Volo referre gratiam: post hoc aliquid superest mihi, non ut gratus, sed ut solutus sim; saepe enim et qui gratiam rettulit, ingratus est, et qui non rettulit, gratus. Nam ut omnium aliarum virtutum, ita huius ad animum tota aestimatio redit; hic si in
officio est, quidquid defuit, fortuna peccat. Quomodo est disertus etiam qui tacet, fortis etiam qui conpressis manibus vel etiam adligatis, quomodo gubernator etiam, qui in sicco est, quia consummatae scientiae nihil deest, etiam si quid obstat, quo minus se utatur, ita gratus est etiam, qui vult tantum nec habet huius voluntatis suae ullum alium quam se testem. Immo amplius adiciam: est aliquando gratus etiam, qui ingratus videtur, quem mala interpres opinio contrarium tradidit. Hic quid aliud sequitur quam ipsam conscientiam? Quae etiam obruta delectat, quae contioni ac famae reclamat et in se omnia reponit et, cum ingentem ex altera parte turbam contra sentientium adspexit, non numerat suffragia, sed una sententia vincit. Si vero bonam fidem perfidiae suppliciis adfici videt, non descendit e fastigio et supra poenam suam consistit: «Habeo» inquit, «quod volui, quod petii; nec paenitet nec paenitebit nec ulla iniquitate me eo fortuna perducet, ut hanc vocem audiat: quid mihi volui? Quid nunc mihi prodest bona voluntas?». Prodest et in eculeo, prodest et in igne; qui si singulis membris admoveatur et paulatim vivum corpus circumeat, licet ipsum cor plenum bona conscientia stillet: placebit illi ignis, per quem bona fides conlucebit. 22. Nunc illud quoque argumentum quamvis dictum iam reducatur: quid est, quare grati velimus esse, cum morimur, quare singulorum perpendamus officia, quare id agamus in omnem vitam nostram memoria decurrente, ne cuius officii videamur obliti? Nihil iam superest, quo spes porrigatur; in illo tamen cardine positi abire e rebus humanis quam gratissimi volumus. Est videlicet magna in ipso opere merces rei et ad adliciendas mentes hominum ingens honesti potentia, cuius pulchritudo animos circumfundit et delenitos admiratione luminis ac fulgoris sui rapit. At multa hoc commoda oriuntur, et tutior est vita melioribus amorque et secundum bonorum iudicium aetasque securior, quam innocentia, quam grata mens prosequitur. Fuisset enim iniquissima rerum natura, si hoc tantum bonum miserum et anceps et sterile fecisset. Sed illud intuere, an ad istam virtutem, quae saepe tuta ac facili aditur via, etiam per saxa et rupes et feris ac serpentibus obsessum iter fueris iturus. Non ideo per se non est expetendum, cui aliquid extra quoque emolumenti adhaeret; fere enim pulcherrima quaeque multis et adventiciis comitata sunt dotibus, sed illas trahunt, ipsa praecedunt. 23. Num dubium est, quin hoc humani generis domicilium circumitus solis ac lunae vicibus suis temperet? Quin alterius calore alantur corpora, terrae relaxentur, inmodici umores conprimantur, adligantis omnia hiemis tristitia frangatur, alterius tepore efficaci et penetrabili regatur maturitas frugum? Quin ad huius cursum fecunditas humana respondeat? Quin ille annum observabilem fecerit circumactu suo, haec mensem minoribus se spatiis flectens? Ut tamen detrahas ista, non erat ipse sol idoneum oculis spectaculum dignusque adorari, si tantum praeteriret? Non erat digna suspectu luna, etiam si otiosum sidus transcurreret? Ipse mundus, quotiens per noctem ignes suos fudit et
tantum stellarum innumerabilium refulsit, quem non intentum in se tenet? Quis sibi illa tunc, cum miratur, prodesse cogitat? Adspice ista tanto superne coetu labentia, quemadmodum velocitatem suam sub specie stantis atque inmoti operis abscondant. Quantum ista nocte, quam tu in numerum ac discrimen dierum observas, agitur! Quanta rerum turba sub hoc silentio evolvitur! quantam fatorum seriem certus limes educit! Ista, quae tu non aliter, quam in decorem sparsa consideras, singula in opere sunt. Nec enim est, quod existimes septem sola discurrere, cetera haerere; paucorum motus conprehendimus, innumerabiles vero longiusque a conspectu seducti di eunt redeuntque, et ex his, qui oculos nostros patiuntur, plerique obscuro gradu pergunt et per occultum aguntur. 24. Quid ergo? Non caperis tantae molis adspectu, etiam si te non tegat, non custodiat, non foveat generetque ac spiritu suo riget? Quemadmodum haec cum primum usum habeant et necessaria vitaliaque sint, maiestas tamen eorum totam mentem occupat, ita omnis illa virtus et in primis grati animi multum quidem praestat, sed non vult ob hoc diligi; amplius quiddam in se habet nec satis ab eo intellegitur, a quo inter utilia numeratur. Gratus est, quia expedit? Ergo et quantum expedit? Non recipit sordidum virtus amatorem; soluto ad illam sinu veniendum est. Ingratus hoc cogitat: «Volebam gratiam referre, sed timeo inpensam, timeo periculum, vereor offensam; faciam potius, quod expedit». Non potest eadem ratio et gratum facere et ingratum; ut diversa illorum opera, ita diversa inter se proposita sunt; ille ingratus est, quamvis non oporteat, quia expedit; hic gratus est, quamvis non expediat, quia oportet. 25. Propositum est nobis secundum rerum naturam vivere et deorum exemplum sequi; di autem, quodcumque faciunt, in eo quid praeter ipsam faciendi rationem secuntur? Nisi forte illos existimas fructum operum suorum ex fumo extorum et turis odore percipere. Vide, quanta cottidie moliantur, quanta distribuant, quantis terras fructibus inpleant, quam oportunis et in omnes oras ferentibus ventis maria permoveant, quantis imbribus repente deiectis solum molliant venasque fontium arentes redintegrent et infuso per occulta nutrimento novent. Omnia ista sine mercede, sine ullo ad ipsos perveniente commodo faciunt. Hoc nostra quoque ratio, si ab exemplari suo non aberrat, servet, ne ad res honestas conducta veniat. Pudeat ullum venale esse beneficium: gratuitos habemus deos. 26. «Si deos» inquit «imitaris, da et ingratis beneficia; nam et sceleratis sol oritur, et piratis patent maria». Hoc loco interrogant, an vir bonus daturus sit beneficium ingrato sciens ingratum esse. Permitte mihi aliquid interloqui, ne interrogatione insidiosa capiamur. Duos ex constitutione Stoica accipe ingratos. Alter est ingratus, quia stultus est; stultus etiam malus est; quia malus est, nullo vitio caret: ergo et ingratus est. Sic omnes malos intemperantes dicimus, avaros,
luxuriosos, malignos, non quia omnia ista singulis magna et nota vitia sunt, sed quia esse possunt; et sunt, etiam si latent. Alter est ingratus, qui volgo dicitur, in hoc vitium natura propensus. Illi ingrato, qui sic hac culpa non caret, quomodo nulla caret, dabit beneficium vir bonus; nulli enim dare poterit, si tales homines submoverit. Huic ingrato, qui beneficiorum fraudator est et in hanc partem procubuit animo, non magis dabit beneficium, quam decoctori pecuniam credet aut depositum conmittet ei, qui iam pluribus abnegavit. 27. Timidus dicitur aliquis, quia stultus est: et hoc malos sequitur, quos indiscreta et universa vitia circumstant; dicitur timidus proprie natura etiam ad inanes sonos pavidus. Stultus omnia vitia habet, sed non in omnia natura pronus est: alius in avaritiam, alius in luxuriam, alius in petulantiam inclinatur. Itaque errant illi, qui interrogant Stoicos: «Quid ergo? Achilles timidus est? Quid ergo? Aristides, cui iustitia nomen dedit, iniustus est? Quid ergo? Et Fabius, qui «cunctando restituit rem», temerarius est? Quid ergo? Decius mortem timet? Mucius proditor est? Camillus desertor?» Non hoc dicimus sic omnia vitia esse in omnibus, quomodo in quibusdam singula eminent, sed malum ac stultum nullo vitio vacare; ne audacem quidem timoris absolvimus, ne prodigum quidem avaritia liberamus. Quomodo homo omnes sensus habet, nec ideo tamen omnes homines aciem habent Lynceo similem, sic, qui stultus est, ‹non› tam acria et concitata habet omnia, quam quidam quaedam. Omnia in omnibus vitia sunt, sed non omnia in singulis extant: hunc natura ad avaritiam inpellit; hic vino, hic libidini deditus est aut, si nondum deditus, ita formatus, ut in hoc illum mores sui ferant. Itaque, ut ad propositum revertar, nemo non ingratus est, qui malus: habet enim omnia nequitiae semina; tamen proprie ingratus adpellatur, qui ad hoc vitium vergit: huic ergo beneficium non dabo. Quomodo male filiae suae consulet, qui illam contumelioso et saepe repudiato conlocavit, malus pater familiae habebitur, qui negotiorum gestorum damnato patrimonii sui curam mandaverit, quomodo dementissime testabitur, qui tutorem filio reliquerit pupillorum spoliatorem, sic pessime beneficia dare dicetur, quicumque ingratos eligit, in quos peritura conferat. 28. «Di quoque» inquit «multa ingratis tribuunt». Sed illa bonis paraverunt; contingunt autem etiam malis, quia separari non possunt. Satius est autem prodesse etiam malis propter bonos, quam bonis deesse propter malos. Ita, quae refers, diem, solem, hiemis aestatisque cursus et media veris autumnique temperamenta, imbres et fontium haustus, ventorum statos flatus pro universis invenerunt; excerpere singulos non potuerunt. Rex honores dignis dat, congiarium et indignis; frumentum publicum tam fur quam periurus et adulter accipiunt et sine dilectu morum, quisquis incisus est; quidquid aliud est, quod tamquam civi, non tamquam bono datur, ex aequo boni ac mali ferunt. Deus quoque quaedam munera universo humano generi dedit, a quibus excluditur nemo. Nec enim poterat fieri,
ut ventus bonis viris secundus esset, contrarius malis, communi autem bono erat patere commercium maris et regnum humani generis relaxari; nec poterat lex casuris imbribus dici, ne in malorum inproborumque rura defluerent. Quaedam in medio ponuntur: tam bonis quam malis conduntur urbes; monumenta ingeniorum et ad indignos perventura publicavit editio; medicina etiam sceleratis opem monstrat; conpositiones remediorum salutarium nemo subpressit, ne sanarentur indigni. In iis exige censuram et personarum aestimationem, quae separatim tamquam digno dantur, non in his, quae promiscue turbam admittunt. Multum enim refert, utrum aliquem non excludas an eligas. Ius et furi dicitur; pace et homicidae fruuntur; sua repetunt etiam, qui aliena rapuerunt; percussores et domi ferrum exercentes murus ab hoste defendit; legum praesidio, qui plurimum in illas peccaverunt, proteguntur. Quaedam non poterant ceteris contingere, nisi universis darentur; non est itaque, quod de istis disputes, ad quae publice invitati sumus. Illud, quod iudicio meo ad aliquem pervenire debebit, ei, quem esse ingratum sciam, non dabo. 29. «Ergo» inquit «nec consilium deliberanti dabis ingrato nec aquam haurire permittes nec viam monstrabis erranti? An haec quidem facies, sed nihil donabis?». Distinguam istud, certe temptabo distinguere. Beneficium est opera utilis, sed non omnis opera utilis beneficium est; quaedam enim tam exigua sunt, ut beneficii nomen non occupent. Duae res coire debent, quae beneficium efficiant. Primum rei magnitudo; quaedam enim sunt infra huius nominis mensuram. Quis beneficium dixit quadram panis aut stipem aeris abiecti aut ignis accendendi factam potestatem? Et interdum ista plus prosunt, quam maxima; sed tamen vilitas sua illis, etiam ubi temporis necessitate facta sunt necessaria, detrahit pretium. Deinde hoc, quod potentissimum est, oportet accedat, ut eius causa faciam, ad quem volam pervenire beneficium, dignumque eum iudicem et libens id tribuam percipiensque ex munere meo gaudium, quorum nihil est in istis, de quibus loquebamur; non enim tamquam dignis illa tribuimus, sed neglegenter tamquam parva, et non homini damus, sed humanitati. 30. Aliquando daturum me etiam indignis quaedam non negaverim in honorem aliorum, sicut in petendis honoribus quosdam turpissimos nobilitas industriis sed novis praetulit non sine ratione; sacra est magnarum virtutum memoria, et esse plures bonos iuvat, si gratia bonorum non cum ipsis cadit. Ciceronem filium quae res consulem fecit nisi pater? Cinnam nuper quae res ad consulatum recepit ex hostium castris, quae Sex. Pompeium aliosque Pompeios, nisi unius viri magnitudo tanta quondam, ut satis alte omnes suos etiam ruina eius adtolleret? Quid nuper Fabium Persicum, cuius osculum etiam inpudici denotabant, sacerdotem non in uno collegio fecit nisi Verrucosi et Allobrogici et illi trecenti, qui hostium incursioni pro re publica unam domum obiecerant? Hoc debemus virtutibus, ut non praesentes solum illas, sed etiam ablatas e conspectu colamus;
quomodo illae id egerunt, ut non in unam aetatem prodessent, sed beneficia sua etiam post ipsas relinquerent, ita nos non una aetate grati simus. Hic magnos viros genuit: dignus est beneficiis, qualiscumque est; dignos dedit. Hic egregiis maioribus ortus est: qualiscumque est, sub umbra suorum lateat. Ut loca sordida repercussu solis inlustrantur, ita inertes maiorum suorum luce resplendeant. 31. Excusare hoc loco tibi, mi Liberalis, deos volo. Interdum enim solemus dicere: «Quid sibi voluit providentia, quae Arrhidaeum regno inposuit?» Illi putas hoc datum? Patri eius datum est et fratri. «Quare C. Caesarem orbi terrarum praefecit, hominem sanguinis humani avidissimum, quem non aliter fluere in conspectu suo iubebat, quam si ore excepturus esset?» Quid ergo? Tu hoc illi datum existimas? Patri eius Germanico datum, avo proavoque et ante hos aliis non minus claris viris, etiam si privati paresque aliis vitam exegerunt. Quid? Tu, cum Mamercum Scaurum consulem faceres, ignorabas ancillarum illum suarum menstruum ore hiante exceptare? Numquid enim ipse dissimulabat? Numquid purus videri volebat? Referam tibi dictum eius in se, quod circumferri memini et ipso praesente laudari. Pollioni Annio iacenti obsceno verbo usus dixerat se facturum id, quod pati malebat; et cum Pollionis adtractiorem vidisset frontem: «Quidquid» inquit «mali dixi, mihi et capiti meo». Hoc dictum suum ipse narrabat. Hominem tam palam obscenum ad fasces et ad tribunal admisisti? Nempe dum veterem illum Scaurum senatus principem cogitas et indigne fers subolem eius iacere. 32. Idem facere deos veri simile est, ut alios indulgentius tractent propter parentes avosque, alios propter futuram nepotum pronepotumque ac longe sequentium posterorum indolem; nota enim illis est operis sui series, omniumque illis rerum per manus suas iturarum scientia in aperto semper est; nobis ex abdito subit, et, quae repentina putamus, illis provisa veniunt ac familiaria. «Sint hi reges, quia maiores eorum non fuerunt, quia pro summo imperio habuerunt iustitiam, abstinentiam, quia non rem publicam sibi, sed se rei publicae dicaverunt. Regnent hi, quia vir bonus quidam ante proavus eorum fuit, qui animum supra fortunam gessit, qui in dissensione civili, quoniam ita expediebat rei publicae, vinci quam vincere maluit; referri gratia illi tam longo spatio non potuit; in illius respectum iste populo praesideat, non quia scit aut potest, sed quia alius pro illo meruit. Hic corpore deformis est, adspectu foedus et ornamenta sua traducturus; iam me homines accusabunt, caecum ac temerarium dicent, nescientem, quo loco, quae summis atque excelsissimis debentur, ponam; at ego scio alii me istud dare, alii olim debitum solvere. Unde isti norunt illum quondam gloriae sequentis fugacissimum, eo voltu ad pericula euntem, quo alii e periculo redeunt, numquam bonum suum a publico distinguentem? «Ubi» inquis «iste aut quis est?» Unde vos scitis? Apud me istae expensorum acceptorumque rationes dispunguntur, ego, quid cui debeam, scio; aliis post longam diem repono, aliis in antecessum ac prout occasio et rei publicae meae facultas tulit». Ingrato
ergo aliquando quaedam, sed non propter ipsum dabo. 33. «Quid? Si» inquit «nescis, utrum ingratus sit an gratus, expectabis, donec scias, an dandi beneficii tempus non amittes? Expectare longum est (nam, ut ait Platon, difficilis humani animi coniectura est), non expectare temerarium est». Huic respondebimus numquam expectare nos certissimam rerum conprehensionem, quoniam in arduo est veri exploratio, sed ea ire, qua ducit veri similitudo. Omne hac via procedit officium: sic serimus, sic navigamus, sic militamus, sic uxores ducimus, sic liberos tollimus; cum omnium horum incertus sit eventus, ad ea accedimus, de quibus bene sperandum esse credidimus. Quis enim pollicetur serenti proventum, naviganti portum, militanti victoriam, marito pudicam uxorem, patri pios liberos? Sequimur, qua ratio, non qua veritas traxit. Expecta, ut nisi bene cessura non facias et nisi conperta veritate nil noveris: relicto omni actu vita consistit. Cum veri similia me in hoc aut in illud inpellant, non vera, ei beneficium dabo, quem veri simile erit gratum esse. 34. «Multa» inquit «intervenient, propter quae et malus pro bono subrepat et bonus pro malo displiceat; fallaces enim sunt rerum species, quibus credidimus». Quis negat? Sed nihil aliud invenio, per quod cogitationem regam. His veritas mihi vestigiis sequenda est, certiora non habeo; haec ut quam diligentissime aestimem, operam dabo nec cito illis adsentiar. Sic enim in proelio potest accidere, ut telum meum in conmilitonem manus dirigat aliquo errore decepta et hosti tamquam meo parcam; sed hoc et raro accidet et non vitio meo, cuius propositum est hostem ferire, civem defendere. Si sciam ingratum esse, non dabo beneficium; at obrepsit, at inposuit: nulla hic culpa tribuentis est, quia tamquam grato dedi. «Si promiseris» inquit «te daturum beneficium et postea ingratum esse scieris, dabis an non? Si facis sciens, peccas, das enim, cui non debes dare; si negas, et hoc modo peccas: non das ei, cui promisisti. Conscientia vestra hoc loco titubat et illud superbum promissum, numquam sapientem facti sui paenitere nec umquam emendare, quod fecerit, nec mutare consilium». Non mutat sapiens consilium omnibus his manentibus, quae erant, cum sumeret; ideo numquam illum paenitentia subit, quia nihil melius illo tempore fieri potuit, quam quod factum est, nihil melius constitui, quam constitutum est; ceterum ad omnia cum exceptione venit: «si nihil inciderit, quod inpediat». Ideo omnia illi succedere dicimus et nihil contra opinionem accidere, quia praesumit animo posse aliquid intervenire, quod destinata prohibeat. Inprudentium ista fiducia est fortunam sibi spondere; sapiens utramque partem eius cogitat; scit, quantum liceat errori, quam incerta sint humana, quam multa consiliis obstent; ancipitem rerum ac lubricam sortem suspensus sequitur, consiliis certis incertos eventus expendit. Exceptio autem, sine qua nihil destinat, nihil ingreditur, et hic illum tuetur. 35. Promisi beneficium, nisi si quid incidisset, quare non deberem dare. Quid
enim, si, quod illi pollicitus sum, patria sibi dare iusserit? Si lex lata erit, ne id quisquam faciat, quod ego me amico meo facturum promiseram? Promisi tibi in matrimonium filiam; postea peregrinus adparuisti; non est mihi cum externo conubium; eadem res me defendit, quae vetat. Tunc fidem fallam, tunc inconstantiae crimen audiam, si, cum eadem omnia sint, quae erant promittente me, non praestitero promissum; alioquin, quidquid mutatur, libertatem facit de integro consulendi et me fide liberat. Promisi advocationem: postea adparuit per illam causam praeiudicium in patrem meum quaeri; promisi me peregre exiturum: sed iter infestari latrociniis nuntiatur; in rem praesentem venturus fui: sed aeger filius, sed puerpera uxor tenet. Omnia esse debent eadem, quae fuerunt, cum promitterem, ut promittentis fidem teneas; quae autem maior fieri mutatio potest, quam si te malum virum et ingratum conperi? Quod tamquam digno dabam, indigno negabo et irascendi quoque causam habebo deceptus. 36. Inspiciam tamen et, quantum sit, de quo agitur; dabit mihi consilium promissae rei modus. Si exiguum est, dabo, non quia dignus es, sed quia promisi, nec tamquam munus dabo, sed verba mea redimam et aurem mihi pervellam. Damno castigabo promittentis temeritatem: «Ecce, ut doleat tibi, ut postea consideratius loquaris!» Quod dicere solemus, linguarium dabo. Si maius erit, non conmittam, quemadmodum Maecenas ait, ut sestertio centies obiurgatus sim. Inter se enim utrumque conparabo: est aliquid in eo, quod promiseris, perseverare; est rursus multum in eo, ne indigno beneficium des; hoc tamen quantum est? Si leve, coniveamus, si vero magno mihi aut detrimento aut rubori futurum, malo semel excusare, quare negaverim, quam semper, quare dederim. Totum, inquam, in eo est, quanti promissi mei verba taxentur. Non tantum, quod temere promisi, retinebo, sed, quod non recte dedi, repetam; demens est, qui fidem praestat errori. 37. Philippus Macedonum rex habebat militem manu fortem, cuius in multis expeditionibus utilem expertus operam subinde ex praeda aliquid illi virtutis causa donaverat et hominem venalis animae crebris auctoramentis accendebat. Hic naufragus in possessiones cuiusdam Macedonis expulsus est; quoi ut nuntiatum est, accucurrit, spiritum eius recollegit, in villam illum suam transtulit, lectulo suo cessit, adfectum semianimemque recreavit, diebus triginta sua inpensa curavit, refecit, viatico instruxit subinde dicentem: «Gratiam tibi referam, videre tantum mihi imperatorem meum contingat». Narravit Philippo naufragium suum, auxilium tacuit et protinus petit, ut sibi cuiusdam praedia donaret. Ille quidam erat hospes eius, is ipse, a quo receptus erat, a quo sanatus. Multa interim reges in bello praesertim opertis oculis donant. «Non sufficit homo iustus tot armatis cupiditatibus, non potest quisquam eodem tempore et bonum virum et bonum ducem agere. Quomodo tot milia hominum insatiabilia satiabuntur? Quid habebunt, si suum quisque habuerit?». Haec Philippus sibi dixit, cum illum induci in bona, quae petebat, iussit.
Expulsus bonis suis ille non ut rusticus iniuriam tacitus tulit contentus, quod non et ipse donatus esset, sed Philippo epistulam strictam ac liberam scripsit; qua accepta ita exarsit, ut statim Pausaniae mandaret, bona priori domino restitueret, ceterum inprobissimo militi, ingratissimo hospiti, avidissimo naufrago stigmata inscriberet ingratum hominem testantia. Dignus quidem fuit, cui non inscriberentur illae litterae, sed insculperentur, qui hospitem suum nudo et naufrago similem in id, ‹in› quo iacuerat ipse, litus expulerat; sed videbimus, quis modus poenae servandus fuerit: auferendum utique fuit, quod summo scelere invaserat. Quis autem poena eius moveretur? Id conmiserat, propter quod nemo misereri misericors posset. 38. Dabit tibi Philippus, quia promisit, etiam si non debet, etiam si iniuriam facturus est, etiam si scelus facturus est, etiam si uno facto praeclusurus est naufragis litora? Non est levitas a cognito et damnato errore discedere, et ingenue fatendum est: «Aliud putavi, deceptus sum». Haec vero superbae stultitiae perseverantia est: «Quod semel dixi, qualecumque est, fixum ratumque sit». Non est turpe cum re mutare consilium. Age, si Philippus possessorem illum eorum litorum reliquisset, quae naufragio ceperat, non omnibus miseris aqua et igni interdixerat? «Potius» inquit «intra fines regni mei tu litteras istas oculis inscribendas durissima fronte circumfer. I, ostende, quam sacra res sit mensa hospitalis; praebe in facie tua legendum istuc decretum, quo cavetur, ne miseros tecto iuvare capital sit. Magis ista constitutio sic rata erit, quam si illam in aes incidissem». 38. «Quare ergo» inquit «Zeno vester, cum quingentos denarios cuidam mutuos promisisset et ipse illum parum idoneum conperisset, amicis suadentibus, ne daret, perseveravit credere, quia promiserat?». Primum alia condicio est in credito, alia in beneficio. Pecuniae etiam male creditae exactio est; et adpellare debitorem ad diem possum et, si foro cesserit, portionem feram; beneficium et totum perit et statim. Praeterea hoc mali viri est, illud mali patris familiae. Deinde ne Zeno quidem, si maior fuisset summa, credere perseverasset. Quingenti denarii sunt: illud quod dici solet, «in morbo consumat»; fuit tanti non revocare promissum suum. Ad cenam, quia promisi, ibo, etiam si frigus erit; non quidem, si nives cadent. Surgam ad sponsalia, quia promisi, quamvis non concoxerim; sed non, si febricitavero. Sponsum descendam, quia promisi; sed non, si spondere me in incertum iubebis, si fisco obligabis. Subest, inquam, tacita exceptio: si potero, si debebo, si haec ita erunt. Effice, ut idem status sit, cum exigis, qui fuit, cum promitterem: destituere levitas erit. Si aliquid intervenit novi, quid miraris, cum condicio promittentis mutata sit, mutatum esse consilium? Eadem mihi omnia praesta, et idem sum. Vadimonium promittimus, tamen deserti non in omnes datur actio: deserentem vis maior excusat.
40. Idem etiam in illa quaestione responsum existima, an omni modo referenda sit gratia, et an beneficium utique reddendum sit. Animum praestare gratum debeo, ceterum aliquando me referre gratiam non patitur mea infelicitas, aliquando felicitas eius, cui debeo. Quid enim regi, quid pauper diviti reddam, utique cum quidam recipere beneficium iniuriam iudicent et beneficia subinde aliis beneficiis onerent? Quid amplius in horum persona possum quam velle? Nec enim ideo beneficium novum reicere debeo, quia nondum prius reddidi. Accipiam tam libenter, quam dabitur, et praebebo me amico meo exercendae bonitatis suae capacem materiam; qui nova accipere non vult, acceptis offenditur. Non refero gratiam: quid ad rem? Non est per me mora, si aut occasio mihi deest aut facultas. Ille praestitit mihi, nempe cum occasionem haberet, cum facultatem; utrum bonus vir est an malus? Apud bonum virum bonam causam habeo, apud malum non ago. Ne illud quidem existimo faciendum, ut referre gratiam etiam invitis his, quibus refertur, properemus et instemus recedentibus; non est referre gratiam, quod volens acceperis, nolenti reddere. Quidam, cum aliquod illis missum est munusculum, subinde aliud intempestive remittunt et nihil se debere testantur; reiciendi genus est protinus aliud in vicem mittere et munus munere expungere. Aliquando et non reddam beneficium, cum possim: quando? Si plus mihi detracturus ero, quam illi conlaturus, si ille non erit sensurus ullam accessionem recepto eo, quo reddito mihi multum abscessurum erit. Qui festinat utique reddere, non habet animum grati hominis, sed debitoris; et, ut breviter, qui nimis cupit solvere, invitus debet; qui invitus debet, ingratus est.
Liber quintus 1. In prioribus libris videbar consummasse propositum, cum tractassem, quemadmodum dandum esset beneficium, quemadmodum accipiendum. Hi enim sunt huius officii fines; quidquid ultra moror, non servio materiae, sed indulgeo, quae, quo ducit, sequenda est, non quo invitat; subinde enim nascetur, quo lacessat aliqua dulcedine animum, magis non supervacuum quam necessarium. Verum, quia ita vis, perseveremus peractis, quae rem continebant, scrutari etiam ea, quae, si vis verum, conexa sunt, non cohaerentia; quae quisquis diligenter inspicit, nec facit operae pretium nec tamen perdit operam. Tibi autem, homini natura optimo et ad beneficia propenso, Liberalis Aebuti, nulla eorum laudatio satis facit. Neminem umquam vidi tam benignum etiam levissimorum officiorum aestimatorem; iam bonitas tua eo usque prolapsa est, ut tibi dari putes beneficium, quod ulli datur; paratus es, ne quem beneficii paeniteat, pro ingratis dependere. Ipse usque eo abes ab omni iactatione, usque eo statim vis exonerare, quos obligas, ut, quidquid in aliquem confers, velis videri non praestare, sed reddere, ideoque plenius ad te sic data revertentur; nam fere secuntur beneficia non reposcentem et, ut gloria fugientes magis sequitur, ita fructus beneficiorum gratius respondet, per quos esse etiam ingratis licet. Per te vero non est mora, quo minus beneficia, qui acceperunt, ultro repetant, nec recusabis conferre alia et subpressis dissimulatisque plura ac maiora adicere: propositum optimi viri et ingentis animi tam diu ferre ingratum, donec feceris gratum. Nec te ista ratio decipiet; succumbunt vitia virtutibus, si illa non cito odisse properaveris. 2. Illud utique unice tibi placet velut magnifice dictum turpe esse beneficiis vinci. Quod an sit verum, non inmerito quaeri solet, longeque aliud est, quam mente concipis; numquam enim in rerum honestarum certamine superari turpe est, dummodo arma non proicias et victus quoque velis vincere. Non omnes ad bonum propositum easdem adferunt vires, easdem facultates, eandem fortunam, quae optimorum quoque consiliorum dumtaxat exitus temperat; voluntas ipsa rectum petens laudanda est, etiam si illam alius gradu velociori antecessit: non ut in certaminibus ad spectaculum editis meliorem palma declarat, quamquam in illis quoque saepe deteriorem praetulit casus. Ubi de officio agitur, quod uterque a sua parte esse quam plenissimum cupit, si alter plus potuit et ad manum habuit materiam sufficientem animo suo, si illi, quantum conatus est, fortuna permisit, alter autem voluntate par est, etiam si minora, quam accepit, reddidit aut omnino non reddidit, sed vult reddere et toto in hoc intentus est animo, non magis victus est, quam qui in armis moritur, quem occidere facilius hostis potuit quam avertere. Quod turpe existimas, id accidere viro bono non potest, ut vincatur. Numquam enim succumbet, numquam renuntiabit; ad ultimum usque vitae diem
stabit paratus et in hac statione morietur magna se accepisse prae se ferens, paria voluisse. 3. Lacedaemonii vetant suos pancratio aut caestu decernere, ubi inferiorem ostendit victi confessio. Cursor cretam prior contigit: velocitate illum, non animo antecessit; luctator ter abiectus perdidit palmam, non tradidit. Cum invictos esse Lacedaemonii cives suos magno aestimarent, ab iis certaminibus removerunt, in quibus victorem facit non iudex nec per se ipse exitus, sed vox cedentis et tradere iubentis. Hoc, quod illi in suis civibus custodiunt, virtus ac bona voluntas omnibus praestat, ne umquam vincantur, quoniam quidem etiam inter superantia animus invictus est. Ideo nemo trecentos Fabios victos dicit, sed occisos; et Regulus captus est a Poenis, non victus, et quisquis alius saevientis fortunae vi ac pondere obpressus non submittit animum. In beneficiis idem est: plura aliquis accepit, maiora, frequentiora; non tamen victus est. Beneficia fortasse beneficiis victa sunt, si inter se data et accepta conputes; si dantem et accipientem conparaveris, quorum animi et per se aestimandi sunt, penes neutrum erit palma. Solet enim fieri, ut, etiam cum alter multis volneribus confossus est, alter leviter quidem saucius, pares exisse dicantur, quamvis alter videatur inferior. 4. Ergo nemo vinci potest beneficiis, si scit debere, si vult referre, si, quem rebus non potest, animo aequat. Hic quam diu in hoc permanet, quam diu tenet voluntatem gratum animum signis adprobandi, quid interest, ab utra parte munuscula plura numerentur? Tu multa dare potes, et ego tantum accipere possum; tecum stat fortuna, mecum bona voluntas: tamen tam par tibi sum, quam multis armatissimis nudi aut leviter armati. Nemo itaque beneficiis vincitur, quia tam gratus est quisque, quam voluit. Nam si turpe est beneficiis vinci, non oportet a praepotentibus viris accipere beneficium, quibus gratiam referre non possis, a principibus dico, a regibus, quos eo loco fortuna posuit, ex quo largiri multa possent pauca admodum et inparia datis recepturi. Reges et principes dixi, quibus tamen potest opera navari et quorum illa excellens potentia per minorum consensum ministeriumque constat. At sunt quidam extra omnem subducti cupiditatem, qui vix ullis humanis desideriis continguntur; quibus nihil potest praestare ipsa fortuna. Necesse est a Socrate beneficiis vincar, necesse est a Diogene, qui per medias Macedonum gazas nudus incessit calcatis regiis opibus; o! ne ille tunc merito et sibi et ceteris, quibus ad dispiciendam veritatem non erat obfusa caligo, supra eum eminere visus est, infra quem omnia iacebant; multo potentior, multo locupletior fuit omnia tunc possidente Alexandro; plus enim erat, quod hic nollet accipere, quam quod ille posset dare. 5. Non est turpe ab his vinci; neque enim minus fortis sum, si cum involnerabili me hoste conmittis, nec ideo minus ignis urere potest, si in materiam incidit inviolabilem flammis, nec ideo ferrum secandi vim perdidit, si
non recipiens ictum lapis solidusque et invictae adversus dura naturae dividendus est. Idem tibi de homine grato respondeo: non turpiter vincitur beneficiis, si ab his obligatus est, ad quos aut fortunae magnitudo aut eximia virtus aditum redituris ad se beneficiis clusit. A parentibus fere vincimur. Nam tam diu illos habemus, quam diu iudicamus graves et quam diu beneficia illorum non intellegimus; cum iam aetas aliquid prudentiae collegit et adparere coepit propter illa ipsa eos amari a nobis debere, propter quae non amabantur, admonitiones, severitatem et inconsultae adulescentiae diligentem custodiam, rapiuntur nobis; paucos usque ad verum fructum a liberis percipiendum perduxit aetas, ceteri filios onere senserunt. Non est tamen turpe vinci beneficiis a parente; quidni non sit turpe, cum a nullo turpe sit? Quibusdam enim et pares et inpares sumus, pares animo, quem solum illi exigunt, quem nos solum promittimus, inpares fortuna, quae si cui obstitit, quo minus referret gratiam, non ideo illi tamquam victo erubescendum est; non est turpe non consequi, dummodo sequaris. Saepe necesse est ante alia beneficia petamus, quam priora reddidimus, nec ideo non petimus aut turpiter, quia non reddituri debebimus, quia non per nos erit mora, quo minus gratissimi simus, sed interveniet aliquid extrinsecus, quod prohibeat: nos tamen nec vincemur animo nec turpiter his rebus superabimur, quae non sunt in nostra potestate. 6. Alexander Macedonum rex gloriari solebat a nullo se beneficiis victum. Non est, quod nimius animi Macedonas et Graecos et Caras et Persas et nationes discriptas in exercitum suspiciat, nec hoc sibi praestitisse regnum ‹a› Thraciae angulo porrectum usque ad litus incogniti maris iudicet; eadem re gloriari Socrates potuit, eadem Diogenes, a quo utique victus est. Quidni victus sit illo die, quo homo super mensuram iam humanae superbiae tumens vidit aliquem, cui nec dare quicquam posset nec eripere? Archelaus rex Socratem rogavit, ut ad se veniret; dixisse Socrates traditur nolle se ad eum venire, a quo acciperet beneficia, cum reddere illi paria non posset. Primum in ipsius potestate erat non accipere; deinde ipse dare beneficium prior incipiebat, veniebat enim rogatus et id dabat, quod utique ille non erat Socrati redditurus; etiamnunc Archelaus daturus erat aurum et argentum recepturus contemptum auri et argenti: non poterat referre Archelao Socrates gratias? Et quid tantum erat accepturus, quantum dabat, si ostendisset hominem vitae ac mortis peritum utriusque fines tenentem? Si regem in luce media errantem ad rerum naturam admisisset usque eo eius ignarum, ut, quo die solis defectio fuit, regiam cluderet et filium, quod in luctu ac rebus adversis moris est, tonderet? Quantum fuisset beneficium, si timentem e latebris suis extraxisset et bonum animum habere iussisset dicens: «Non est ista solis defectio, sed duorum siderum coitus, cum luna humiliore currens via infra ipsum solem orbem suum posuit et illum obiectu sui abscondit; quae modo partes eius exiguas, si in transcursu strinxit, obducit, modo plus tegit, si maiorem partem sui obiecit, modo
excludit totius adspectum, si recto libramento inter solem terrasque media successit. Sed iam ista sidera hoc et illo diducet velocitas sua; iam recipient diem terrae, et hic ibit ordo per saecula dispositosque ac praedictos dies habet, quibus sol intercursu lunae vetetur omnes radios effundere. Paulum expecta; iam emerget, iam istam velut nubem relinquet, iam exolutus inpedimentis lucem suam libere mittet». Socrates parem gratiam Archelao referre non posset, si illum regnare vetuisset? Parum scilicet magnum beneficium a Socrate accipiebat, si ullum dare Socrati potuisset. Quare ergo hoc Socrates dixit? Vir facetus et cuius per figuras sermo procederet, derisor omnium, maxime potentium, maluit illi nasute negare quam contumaciter aut superbe; dixit se nolle beneficia ab eo accipere, cui non posset paria reddere. Timuit fortasse, ne cogeretur accipere, quae nollet, timuit, ne quid indignum Socrate accipere. Dicet aliquis: «negasset, si vellet». Sed instigasset in se regem insolentem et omnia sua magno aestimari volentem. Nihil ad rem pertinet, utrum dare aliquid regi nolis an accipere a rege; in aequo utramque ponit repulsam, et superbo fastidiri acerbius est quam non timeri. Vis scire, quid vere voluerit? Noluit ire ad voluntariam servitutem is, cuius libertatem civitas libera ferre non potuit. 7. Satis, ut existimo, hanc partem tractavimus, an turpe esset beneficiis vinci. Quod qui quaerit, scit non solere homines sibi ipsos dare beneficium; manifestum enim fuisset non esse turpe a se ipsum vinci. Atqui apud quosdam Stoicos et de hoc ambigitur, an possit aliquis sibi beneficium dare, an debeat referre sibi gratiam. Quod ut videretur quaerendum, illa fecerunt: solemus dicere: «gratias mihi ago» et «de nullo queri possum alio quam de me» et «ego mihi irascor» et «ego a me poenas exigam» et «odi me», multa praeterea eiusmodi, per quae unusquisque de se tamquam de altero loquitur. «Si nocere» inquit «mihi possum, quare non et beneficium mihi dare possim? Praeterea quae, si in alium contulissem, beneficia vocarentur, quare, si in me contuli, non sint? Quod, si ab altero accepissem, deberem, quare, si mihi ipse dedi, non debeam? Quare sim adversus me ingratus, quod non minus turpe est quam in se sordidum esse et in se durum ac saevum et sui neglegentem? Tam alieni corporis leno male audit quam sui. Nempe reprenditur adsentator et aliena subsequens verba, paratus ad falsa laudator; non minus placens sibi et se suspiciens, ut ita dicam, adsentator suus. Vitia non tantum, cum foris peccant, invisa sunt, sed cum in se retorquentur. Quem magis admiraberis, quam qui imperat sibi, quam qui se habet in potestate? Gentes facilius est barbaras inpatientesque arbitrii alieni regere, quam animum suum continere et tradere sibi. Platon, inquit, agit Socrati gratias, quod ab illo didicit; quare Socrates sibi non agat, quod ipse se docuit? M. Cato ait: «Quod tibi deerit, a te ipso mutuare»; quare donare mihi non possim, si commodare possum? Innumerabilia sunt, in quibus consuetudo nos dividit; dicere solemus: «sine, loquar mecum» et «ego mihi aurem pervellam»; quae si vera sunt, quemadmodum aliquis sibi irasci debet, sic et gratias agere, quomodo
obiurgare se, sic et laudare se, quomodo damno sibi esse, sic et lucro potest. Iniuria et beneficium contraria sunt; si de aliquo dicimus: «iniuriam sibi fecit», poterimus dicere et: «beneficium sibi dedit». 8. Natura prius est, ut quis debeat, deinde, ut gratiam referat; debitor non est sine creditore, non magis quam maritus sine uxore aut sine filio pater; aliquis dare debet, ut aliquis accipiat. Non est dare nec accipere in dexteram manum ex sinistra transferre. Quomodo nemo se portat, quamvis corpus suum moveat et transferat, quomodo nemo, quamvis pro se dixerit, adfuisse sibi dicitur nec statuam sibi tamquam patrono suo ponit, quomodo aeger, cum cura sua convaluit, mercedem a se non exigit, sic in omni negotio, etiam cum aliquid, ‹quod› prodesset sibi, fecerit, non tamen debebit referre gratiam sibi, quia non habebit, cui referat. Ut concedam aliquem dare sibi beneficium, dum dat, et recipit; ut concedam aliquem a se accipere beneficium, dum accipit, reddit. Domi, quod aiunt, versura fit et velut lusorium nomen statim transit; neque enim alius dat quam accipit, sed unus atque idem. Hoc verbum «debere» non habet nisi inter duos locum; quomodo ergo in uno consistet, qui se obligando liberat? Ut in orbe ac pila nihil imum est, nihil summum, nihil extremum, nihil primum, quia motu ordo mutatur et quae sequebantur praecedunt et quae occidebant oriuntur, omnia, quomodocumque ierunt, in idem revertuntur, ita in homine existima fieri; cum illum in multa mutaveris, unus est. Cecidit se: iniuriarum cum quo agat, non habet; adligavit et clusit: de vi non tenetur; beneficium sibi dedit: danti protinus reddidit. Rerum natura nihil dicitur perdere, quia, quidquid illi avellitur, ad illam redit, nec perire quicquam potest, quod, quo excidat, non habet, sed eodem revolvitur, unde discedit. «Quid simile» inquis «hoc exemplum habet huic propositae quaestioni?». Dicam. Puta te ingratum esse: non perit beneficium, habet illud, qui dedit; puta te recipere nolle: apud te est, antequam redditur. Non potes quicquam amittere, quia, quod detrahitur, nihilo minus tibi adquiritur. Intra te ipsum orbis agitur; accipiendo das, dando accipis. 9. «Beneficium» inquit «sibi dare oportet; ergo et referre gratiam oportet». Primum illud falsum est, ex quo pendent sequentia; nemo enim sibi beneficium dat, sed naturae suae paret, a qua ad caritatem sui conpositus est, unde summa illi cura est nocitura vitandi, profutura adpetendi. Itaque nec liberalis est, qui sibi donat, nec clemens, qui sibi ignoscit, nec misericors, qui malis suis tangitur; quod aliis praestare liberalitas est, clementia, misericordia, sibi praestare natura est. Beneficium res voluntaria est, at prodesse sibi necessarium est. Quo quis plura beneficia dedit, beneficentior est; quis umquam laudatus est, quod sibi ipse fuisset auxilio? Quod se eripuisset latronibus? Nemo sibi beneficium dat, non magis quam hospitium, nemo sibi donat, non magis quam credit. Si dat sibi quisque beneficium, semper dat, sine intermissione dat, inire beneficiorum suorum non potest numerum; quando ergo gratiam referet, cum per hoc ipsum, quo
gratiam refert, beneficium det? Quomodo enim discernere poteris, utrum det sibi beneficium an reddat, cum intra eundem hominem res geratur? Liberavi me periculo: beneficium mihi dedi; iterum me periculo libero: utrum do beneficium an reddo? Deinde, ut primum illud concedam dare nos nobis beneficium, quod sequitur, non concedam; nam etiam si damus, non debemus. Quare? Quia statim recipimus. Accipere beneficium me oportet, deinde debere, deinde referre; debendi locus non est, quia sine ulla mora recipimus. Dat nemo nisi alteri, debet nemo nisi alteri, reddit nemo nisi alteri; id intra unum non potest fieri, quod totiens duos exigit. 10. Beneficium est praestitisse aliquid utiliter; verbum autem «praestitisse» ad alios spectat. Numquid non demens videbitur, qui aliquid sibi vendidisse se dicet? Quia venditio alienatio est et rei suae iurisque in ea sui ad alium translatio. Atqui, quemadmodum vendere, sic dare aliquid a se dimittere est et id, quod tenueris, habendum alteri tradere; quod si est, beneficium nemo sibi dedit, quia nemo dat sibi; alioqui duo contraria in uno coeunt, ut sit idem dare et accipere. Etiamnunc multum interest inter dare et accipere; quidni? Cum ex diverso ista verba posita sint. Atqui si quis sibi beneficium dat, nihil interest inter dare et accipere. Paulo ante dicebam quaedam ad alios pertinere et sic esse formata, ut tota significatio illorum discedat a nobis: frater sum, ‹sed› alterius, nemo est enim suus frater; par sum, sed alicui, quis enim par est sibi? Quod conparatur, sine altero non intellegitur; quod iungitur, sine altero non est; sic et, quod datur, sine altero non est, et beneficium sine altero non est. Idem ipso vocabulo adparet, in quo hoc continetur, «bene fecisse»; nemo autem sibi bene facit, non magis quam sibi favet, quam suarum partium est. Diutius hoc et pluribus exemplis licet prosequi: quidni? Cum inter ea sit habendum beneficium, quae secundam personam desiderant. Quaedam, cum sint honesta, pulcherrima, summae virtutis, nisi in altero non habent locum. Laudatur et inter maxima humani generis bona fides colitur; num quis ergo dicitur sibi fidem praestitisse? 11. Venio nunc ad ultimam partem. Qui gratiam refert, aliquid debet inpendere, sicut, qui solvit, pecuniam; nihil autem inpendit, qui gratiam sibi refert, non magis quam consequitur, qui beneficium a se accepit. Beneficium et gratiae relatio ultro citro ire debent; intra unum hominem non est vicissitudo. Qui gratiam refert, in vicem prodest ei, a quo consecutus est aliquid; qui sibi gratiam refert, cui prodest? Sibi: et quis non alio loco relationem gratiae, alio beneficium cogitat? Qui gratiam refert sibi, ‹sibi› prodest: et quis umquam ingratus hoc noluit facere? Immo quis non ingratus fuit, ut hoc faceret? «Si gratias» inquit «nobis agere debemus, et gratiam referre debemus»; dicimus autem: «Ago gratias mihi, quod illam uxorem nolui ducere» et «quod cum illo non contraxi societatem». Cum hoc dicimus, laudamus nos et, ut factum
nostrum conprobemus, gratias agentium verbis abutimur. Beneficium est, quod potest, cum datum est, et non reddi; qui sibi beneficium dat, non potest non recipere, quod dedit; ergo non est beneficium. Alio tempore beneficium accipitur, alio redditur; In beneficio et hoc est probabile, hoc suspiciendum, quod aliquis, ut alteri prodesset, utilitatis interim suae oblitus est, quod alteri dedit ablaturus sibi; hoc non facit, qui beneficium sibi dat. Beneficium dare socialis res est, aliquem conciliat, aliquem obligat; sibi dare non est socialis res, neminem conciliat, neminem obligat, neminem in spem inducit, ut dicat: «Hic homo colendus est; illi beneficium dedit, dabit et mihi». Beneficium est, quod quis non sua causa dat, sed eius, cui dat; is autem, qui sibi beneficium dat, sua causa dat; non est ergo beneficium. 12. Videor tibi iam illud, quod in principio dixeram, mentitus; dicis me abesse ab eo, qui operae pretium facit, immo totam operam bona fide perdere. Expecta, et iam hoc verius dices, simul te ad has latebras perduxero, ex quibus cum evaseris, nihil amplius eris adsecutus, quam ut eas difficultates effugeris, in quas licuit non descendere. Quid enim boni est nodos operose solvere, quos ipse, ut solveres, feceris? Sed quemadmodum quaedam in oblectamentum ac iocum sic inligantur, ut eorum solutio inperito difficilis sit, quae illi, qui inplicuit, sine ullo negotio paret, quia conmissuras eorum et moras novit, nihilo minus illa habent aliquam voluptatem (temptant enim acumen animorum et intentionem excitant), ita haec, quae videntur callida et insidiosa, securitatem ac segnitiam ingeniis auferunt, quibus modo campus, in quo vagentur, sternendus est, modo creperi aliquid et confragosi obiciendum, per quod erepant et sollicite vestigium faciant. Dicitur nemo ingratus esse; id sic colligitur: «Beneficium est, quod prodest; prodesse autem nemo homini malo potest, ut dicitis Stoici; ergo beneficium non accipit malus, ingratus est. Etiamnunc beneficium honesta et probabilis res est; apud malum nulli honestae rei aut probabili locus est, ergo nec beneficio; quod si accipere non potest, ne reddere quidem debet, et ideo non fit ingratus. Etiamnunc, ut dicitis, bonus vir omnia recte facit; si omnia recte facit, ingratus esse non potest. Malo viro beneficium nemo dare potest. Bonus beneficium reddit, malus non accipit; quod si est, nec bonus quisquam ingratus est nec malus. Ita ingratus in rerum natura est nemo, et hoc inane ‹nomen›». Unum est apud nos bonum, honestum. Id pervenire ad malum non potest; desinet enim malus esse, si ad illum virtus intraverit; quam diu autem malus est, nemo illi dare beneficium potest, quia mala bonaque dissentiunt nec in unum eunt. Ideo nemo illi prodest, quia, quidquid ad illum pervenit, id pravo usu corrumpitur. Quemadmodum stomachus morbo vitiatus et colligens bilem, quoscumque accepit cibos, mutat et omne alimentum in causam doloris trahit, ita animus scaevus, quidquid illi conmiseris, id onus suum et perniciem et occasionem miseriae facit. Felicissimis itaque opulentissimisque plurimum aestus subest minusque sedem inveniunt, quo in maiorem materiam inciderunt, qua fluctuarentur. Ergo nihil potest ad malos pervenire, quod prosit, immo nihil, quod non
noceat; quaecumque enim illis contigerunt, in naturam suam vertunt et extra speciosa profuturaque, si meliori darentur, illis pestifera sunt. Ideo nec beneficium dare possunt, quoniam nemo potest, quod non habet, dare; hic bene faciendi voluntate caret. 13. Sed quamvis haec ita sint, accipere etiam malus tamen quaedam potest, quae beneficiis similia sint, quibus non redditis ingratus erit. Sunt animi bona, sunt corporis, sunt fortunae; illa animi bona a stulto ac malo submoventur; ad haec admittitur, quae et accipere potest et debet reddere, et, si non reddit, ingratus est. Nec hoc ex nostra tantum constitutione; Peripatetici quoque, qui felicitatis humanae longe lateque terminos ponunt, aiunt minuta beneficia perventura ad malos; haec qui non reddit, ingratus est. Nobis itaque beneficia esse non placet, quae non sunt animum factura meliorem; commoda tamen illa esse et expetenda non negamus. Haec et viro bono dare malus potest et accipere a bono, ut pecuniam et vestem et honores et vitam; quae si non reddit, in ingrati nomen incidet. «At quomodo ingratum vocas eo non reddito, quod negas esse beneficium?». Quaedam, etiam si vera non sunt, propter similitudinem eodem vocabulo conprehensa sunt: sic pyxidem et argenteam et auream dicimus; sic inlitteratum non ex toto rudem, sed ad litteras altiores non perductum; sic, qui male vestitum et pannosum vidit, nudum vidisse se dicit. Beneficia ista non sunt, habent tamen beneficii speciem. «Quomodo ista sunt tamquam beneficia, sic et ille tamquam ingratus est, non ingratus». Falsum est, quia illa beneficia et qui dat adpellat et qui accipit; ita, qui veri beneficii speciem fefellit, tam ingratus est quam veneficus, qui soporem, cum venenum esse crederet, miscuit. 14. Cleanthes vehementius agit. «Licet» inquit «beneficium non sit, quod accepit, ipse tamen ingratus est, quia non fuit redditurus, etiam si accepisset». Sic latro est, etiam antequam manus inquinet, quia ad occidendum iam armatus est et habet spoliandi atque interficiendi voluntatem; exercetur et aperitur opere nequitia, non incipit. Sacrilegi dant poenas, quamvis nemo usque ad deos manus porrigat. – «Quomodo» inquit «adversus malum ingratus est quisquam, cum ‹a› malo dari beneficium non possit?» Ea scilicet ratione, quia ipsum, quod accepit, beneficium non erat, sed vocabatur; ‹qui› accipiet ab illo aliquid ex his, quae apud inperitos sunt, quorum et malis copia est, ipse quoque in simili materia gratus esse debebit et illa, qualiacumque sunt, cum pro bonis acceperit, pro bonis reddere. Aes alienum habere dicitur et qui aureos debet et qui corium forma publica percussum, quale apud Lacedaemonios fuit, quod usum numeratae pecuniae praestat. Quo genere obligatus es, hoc fidem exsolve. Quid sint beneficia, an et in hanc sordidam humilemque materiam deduci magnitudo nominis clari debeat, ad vos non pertinet; in alios quaeritur verum: vos ad speciem veri conponite animum et, dum honestum discitis, quidquid est, in quo nomen honesti iactatur, id colite.
15. «Quomodo» inquit «nemo per vos ingratus est, sic rursus omnes ingrati sunt». Nam, ut dicimus, omnes stulti mali sunt; qui unum autem habet vitium, omnia habet; omnes autem stulti et mali sunt: omnes ergo ingrati sunt. Quid ergo? Non sunt? Non undique humano generi convicium fit? Non publica querella est perisse beneficia et paucissimos esse, qui de bene merentibus non in vicem pessime mereantur? Nec est, quod hanc nostram tantum murmurationem putes pro pessimo pravoque numerantium, quidquid citra recti formulam cecidit. Ecce nescioqui non ex philosophorum domo clamat, ex medio conventu populos gentesque damnatura vox mittitur: Non hospes ab hospite tutus, non socer a genero; fratrum quoque gratia rara est; inminet exitio vir coniugis, illa mariti. Hoc iam amplius est: beneficia in scelus versa sunt, et sanguini eorum non parcitur, pro quibus sanguis fundendus est; gladio ac venenis beneficia sequimur. Ipsi patriae manus adferre et fascibus illam suis premere potentia ac dignitas est; humili se ac depresso loco putat stare, quisquis non supra rem publicam stetit; accepti ab illa exercitus in ipsam convertuntur, et imperatoria contio est: «Pugnate contra coniuges, pugnate contra liberos! aras, focos, penates armis incessite!». Qui ne triumphaturi quidem inire urbem iniussu senatus deberetis quibusque victorem exercitum reducentibus curia extra muros praeberetur, nunc civibus caesis perfusi cruore cognato urbem subrectis intrate vexillis. Obmutescat inter militaria signa libertas, et ille victor pacatorque gentium populus remotis procul bellis, omni terrore conpresso, intra muros obsessus aquilas suas horreat. 16. Ingratus est Coriolanus, sero et post sceleris paenitentiam pius: posuit arma, sed in medio parricidio posuit. Ingratus Catilina: parum est illi capere patriam, nisi verterit, nisi Allobrogum in illam cohortes inmiserit et trans Alpes accitus hostis vetera et ingenita odia satiaverit ac diu debitas inferias Gallicis bustis duces Romanos persolverit. Ingratus C. Marius ad consulatus a caliga perductus, qui, nisi Cimbricis caedibus Romana funera aequaverit, nisi civilis exitii et trucidationis non tantum dederit signum, sed ipse signum fuerit, parum mutatam ac repositam in priorem locum fortunam suam sentiet. Ingratus L. Sulla, qui patriam durioribus remediis, quam pericula erant, sanavit, qui, cum a Praenestina arce usque ad Collinam portam per sanguinem humanum incessisset, alia edidit in urbe proelia, alias caedes: legiones duas, quod crudele est, post victoriam, quod nefas, post fidem in angulo congestas contrucidavit et proscriptionem conmentus est, di magni, ut, qui civem Romanum occidisset, inpunitatem, pecuniam, tantum non civicam acciperet! Ingratus Cn. Pompeius, qui pro tribus consulatibus, pro triumphis tribus, pro tot honoribus, quos ex maxima
parte inmaturus invaserat, hanc gratiam rei publicae reddidit, ut in possessionem eius alios quoque induceret quasi potentiae suae detracturus invidiam, si, quod nulli licere debebat, pluribus licuisset; dum extraordinaria concupiscit imperia, dum provincias, ut eligat, distribuit, dum ita cum tertio rem publicam dividit, ut tamen in sua domo duae partes essent, eo redegit populum Romanum, ut salvus esse non posset nisi beneficio servitutis. Ingratus ipse Pompei hostis ac victor: a Gallia Germaniaque bellum in urbem circumegit, et ille plebicola, ille popularis castra in circo Flaminio posuit propius, quam Porsinae fuerant. Temperavit quidem ius crudelitatemque victoriae; quod dicere solebat, praestitit: neminem occidit nisi armatum. Quid ergo est? Ceteri arma cruentius exercuerunt, satiata tamen aliquando abiecerunt; hic gladium cito condidit, numquam posuit. Ingratus Antonius in dictatorem suum, quem iure caesum pronuntiavit, interfectores eius in provincias et imperia dimisit, patriam vero proscriptionibus, incursionibus, bellis laceratam post tot mala destinavit ne Romanis quidem regibus, ut, quae Achaeis, Rhodiis, plerisque urbibus claris ius integrum libertatemque cum inmunitate reddiderat, ipsa tributum spadonibus penderet. 17. Deficiet dies enumerantem ingratos usque in ultima patriae exitia. Aeque inmensum erit, si percurrere coepero, ipsa res publica quam ingrata in optimos ac devotissimos sibi fuerit quamque non minus saepe peccaverit, quam in ipsam peccatum est. Camillum in exilium misit, Scipionem dimisit; exulavit post Catilinam Cicero, diruti eius penates, bona direpta, factum, quidquid victor Catilina fecisset; Rutilius innocentiae pretium tulit in Asia latere; Catoni populus Romanus praeturam negavit, consulatum pernegavit. Ingrati publice sumus; se quisque interroget: nemo non aliquem queritur ingratum. Atqui non potest fieri, ut omnes querantur, nisi querendum est de omnibus: omnes ergo ingrati sunt. Ingrati sunt tantum? Et cupidi omnes et maligni omnes et timidi omnes, illi in primis, qui videntur audaces; adice: et ambitiosi omnes sunt et inpii omnes. Sed non est, quod irascaris; ignosce illis, omnes insaniunt. Nolo te ad incerta revocare, ut dicam: «Vide, quam ingrata sit iuventus; quis non patris sui supremum diem, ut innocens sit, optat, ut moderatus sit, expectat, ut pius, cogitat? Quotus quisque uxoris optimae mortem timet, ut non et conputet? Cui, rogo, litigatori defenso tam magni beneficii ultra res proximas memoria duravit?». Illud in confesso est: quis sine querella moritur? Quis extremo die dicere audet: «Vixi et quem dederat cursum fortuna peregi»? Quis non recusans, quis non gemens exit? Atqui hoc ingrati est non esse contentum praeterito tempore. Semper pauci dies erunt, si illos numeraveris. Cogita non esse summum bonum in tempore; quantumcumque est, boni consules; ut prorogetur tibi dies mortis, nihil proficitur ad felicitatem, quoniam mora non fit beatior vita sed longior. Quanto satius est gratum adversus perceptas voluptates non aliorum annos conputare, sed suos benigne aestimare et in lucro ponere! «Hoc me dignum iudicavit deus, hoc satis est; potuit plus, sed hoc quoque beneficium est». Grati simus adversus deos, grati adversus homines, grati adversus eos, qui aliquid
nobis praestiterunt, grati etiam adversus eos, qui nostris praestiterunt. 18. «In infinitum ius» inquit «me obligas, cum dicis: «et nostris»; itaque pone aliquem finem. Qui filio beneficium dat, ut dicis, et patri eius dat: primum, de quo quaero. Deinde illud utique mihi determinari volo: si et patri beneficium datur, numquid et fratri? Numquid et patruo? Numquid et avo? Numquid et uxori et socero? Dic mihi, ubi debeam desinere, quousque personarum seriem sequar». Si agrum tuum coluero, tibi beneficium dedero; si domum tuam ardentem restinxero aut, ne concidat, excepero, tibi beneficium dabo; si servum tuum sanavero, tibi inputabo; si filium tuum servavero, non habebis beneficium meum? 19. «Dissimilia ponis exempla, quia, qui agrum meum colit, agro beneficium non dat sed mihi; et qui domum meam, quo minus ruat, fulcit, praestat mihi, ipsa enim domus sine sensu est; debitorem me habet, quia nullum habet; et qui agrum meum colit, non illum, sed me demereri vult. Idem de servo dicam: mei mancipii res est, mihi servatur; ideo ego pro illo debeo. Filius ipse beneficii capax est; itaque ille accipit, ego beneficio laetor et contingor, non obligor». Velim tamen, tu, qui debere te non putas, respondeas mihi: filii bona valetudo, felicitas, patrimonium pertinet ad patrem; felicior futurus est, si salvum filium habuerit, infelicior, si amiserit; quid ergo? Qui et felicior fit a me et infelicitatis maximae periculo liberatur, non accipit beneficium? «Non» inquit; «quaedam enim in alios conferuntur, sed ad nos usque permanant; ab eo autem exigi quidque debet, in quem confertur, sicut pecunia ab eo petitur, cui credita est, quamvis ad me illa aliquo modo venerit. Nullum beneficium est, cuius non commodum et proximos tangat, non numquam etiam longius positos; non quaeritur, quo beneficium ab eo, cui datum est, transierit, sed ubi primo conlocetur; a reo tibi ipso et a capite repetitio est». Quid ergo? Oro te, non dicis: «Filium mihi donasti, et, si hic perisset, victurus non fui»? Pro eius vita beneficium non debes, cuius vitam tuae praefers? Etiamnunc, cum filium tuum servavi, ad genua procumbis, dis vota solvis tamquam ipse servatus; illae voces exeunt tibi: «Nihil mea interest, an me servaveris; duos servasti, immo me magis». Quare ista dicis, si non accipis beneficium? «Quia et, si filius meus pecuniam mutuam sumpserit, creditori numerabo, non tamen ideo ego debuero; quia et, si filius meus in adulterio deprensus erit, erubescam, non ideo ego ero adulter. Dico me tibi obligatum pro filio, non quia sum, sed quia volo me offerre tibi debitorem voluntarium. At pervenit ad me summa ex incolumitate eius voluptas, summa utilitas, et orbitatis gravissimum volnus effugi. Non quaeritur nunc, an profueris mihi, sed an beneficium dederis; prodest enim et animal et lapis et herba, nec tamen beneficium dant, quod numquam datur nisi a volente». Tu autem non vis patri, sed filio dare, et interim ne nosti quidem patrem. Itaque cum dixeris: «Patri ergo beneficium non dedi filium eius servando?», contra obpone: «Patri ergo beneficium dedi, quem non novi, quem non cogitavi?». Et quid quod aliquando
eveniet, ut patrem oderis, filium serves? Beneficium ei videberis dedisse, cui tunc inimicissimus eras, cum dares?». Sed ut dialogorum altercatione seposita tamquam iuris consultus respondeam, mens spectanda est dantis; beneficium ei dedit, cui datum voluit. Si in patris honorem fecit, pater accepit beneficium; si filii in usum, pater beneficio in filium conlato non obligatur, etiam si fruitur. Si tamen occasionem habuerit, volet et ipse praestare aliquid, non tamquam solvendi necessitatem habeat, sed tamquam incipiendi causam. Repeti a patre beneficium non debet; si quid pro hoc benigne facit, iustus, non gratus est. Nam illud finiri non potest: si patri do beneficium, et matri et avo et avunculo et liberis et adfinibus et amicis et servis et patriae. Ubi ergo beneficium incipit stare? Sorites enim ille inexplicabilis subit, cui difficile est modum inponere, quia paulatim subrepit et non desinit serpere. 20. Illud solet quaeri: «Fratres duo dissident; si alterum servo, an dem beneficium ei, qui fratrem invisum non perisse moleste laturus est». Non est dubium, quin beneficium sit etiam invito prodesse, sicut non dedit beneficium, qui invitus profuit. «Beneficium» inquit «vocas, quo ille offenditur, quo torquetur?». Multa beneficia tristem frontem et asperam habent, quemadmodum secare et urere, ut sanes, et vinclis coercere. Non est spectandum, an doleat aliquis beneficio accepto, sed an gaudere debeat; non est malus denarius, quem barbarus et ignarus formae publicae reiecit. Beneficium et odit et accepit, si modo id prodest, si is, qui dabat, ut prodesset, dedit. Nihil refert, an bonam rem malo animo quis accipiat. Agedum, hoc in contrarium verte. Odit fratrem suum, quem illi habere expedit; hunc ego occidi: non est beneficium, quamvis ille dicat esse et gaudeat. Insidiosissime nocet, cui gratiae aguntur pro iniuria. «Video: prodest aliqua res et ideo beneficium est; nocet et ideo non est beneficium. Ecce, quod nec prosit nec noceat, dabo, et tamen beneficium erit. Patrem alicuius in solitudine exanimem inveni, corpus eius sepelivi: nec ipsi profui (quid enim illius intererat, quo genere dilaberetur?) nec filio (quid enim illi per hoc commodi accessit?)». Dicam, quid consecutus sit: officio sollemni et necessario per me functus est; praestiti patri eius, quod ipse praestare voluisset nec non et debuisset. Hoc tamen ita beneficium est, si non misericordiae et humanitati dedi, ut quodlibet cadaver absconderem, sed si corpus adgnovi, si filio tunc hoc praestare me cogitavi; at si terram ignoto mortuo inieci, nullum in hoc habeo huius officii debitorem in publicum humanus. Dicet aliquis: «Quid tanto opere quaeris, cui dederis beneficium, tamquam repetiturus aliquando? Sunt, qui numquam iudicent esse repetendum, et has causas adferunt: Indignus etiam repetenti non reddet, dignus ipse per se referet. Praeterea, si bono viro dedisti, expecta, ne iniuriam illi facias adpellando, tamquam sua sponte redditurus non fuisset; si malo viro dedisti, plectere; beneficium vero ne corruperis creditum faciendo. Praeterea lex, quod non iussit repeti, vetuit».
Verba sunt ista. Quam diu me nihil urguet, quam diu fortuna nihil cogit, perdam potius beneficium quam repetam; sed si de salute liberorum agitur, si in periculum uxor deducitur, si patriae salus ac libertas mittit me etiam, quo ire nollem, imperabo pudori meo et testabor omnia me fecisse, ne opus esset mihi auxilio hominis ingrati; novissime recipiendi beneficii necessitas repetendi verecundiam vincet. Deinde, cum bono viro beneficium do, sic do tamquam numquam repetiturus, nisi fuerit necesse. 21. «Sed lex» inquit «non permittendo exigere vetuit». Multa legem non habent nec actionem, ad quae consuetudo vitae humanae omni lege valentior dat aditum. Nulla lex iubet amicorum secreta non eloqui; nulla lex iubet fidem etiam inimico praestare; quae lex ad id praestandum nos, quod alicui promisimus, adligat? Nulla. Querar tamen cum eo, qui arcanum sermonem non continuerit, et fidem datam nec servatam indignabor. «Sed ex beneficio» inquit «creditum facis». Minime; non enim exigo, sed repeto, et ne repeto quidem, sed admoneo. Num ultima quoque me necessitas in hoc aget, ut ad eum veniam, cum quo mihi diu luctandum sit? ‹Si› quis tam ingratus est, ut illi non sit satis admoneri, eum transibo nec dignum iudicabo, qui gratus esse cogatur. Quomodo fenerator quosdam debitores non adpellat, quos scit decoxisse et in quorum pudorem nihil superest, nisi quod pereat, sic ego quosdam ingratos palam ac pertinaciter praeteribo nec ab ullo beneficium repetam, nisi a quo non ablaturus ero, sed recepturus. 22. Multi sunt, qui nec negare sciant, quod acceperunt, nec referre, qui nec tam boni sunt quam grati nec tam mali quam ingrati, segnes et tardi, lenta nomina, non mala; hos ego non adpellabo, sed conmonefaciam et ad officium aliud agentes reducam. Qui statim mihi sic respondebunt: «Ignosce; non mehercules scivi hoc te desiderare, alioqui ultro obtulissem; rogo, ne me ingratum existimes; memini, quid mihi praestiteris»; hos ego quare dubitem et sibi meliores et mihi facere? Quemcumque potuero, peccare prohibebo; multo magis amicum, et ne peccet et ne in me potissimum peccet. Alterum illi beneficium do, si illum ingratum esse non patior; nec dure illi exprobrabo, quod praestiti, sed quam potuero mollissime. Ut potestatem referendae gratiae faciam, renovabo memoriam eius et petam beneficium; ipse me intelleget repetere. Aliquando utar verbis durioribus, si emendari illum posse speravero; nam deploratum propter hoc quoque non exagitabo, ne ex ingrato inimicum faciam. Quod si admonitionis quoque sugillationem ingratis remittimus, segniores ad reddenda beneficia faciemus; quosdam vero sanabiles et qui fieri boni possint, si quid illos momorderit, perire patiemur admonitione sublata, qua et pater filium aliquando correxit et uxor maritum aberrantem ad se reduxit et amicus languentem amici fidem erexit. 23. Quidam, ut expergiscantur, non feriendi, sed conmovendi sunt; eodem
modo quorundam ad referendam gratiam fides non cessat, sed languet; hanc pervellamus. «Noli munus tuum in iniuriam vertere; iniuria est enim, si in hoc non repetis, ut ingratus sim. Quid, si ignoro, quid desideres? Quid, si occupationibus districtus et in alia vocatus occasionem non observavi? Ostende mihi, quid possim, quid velis. Quare desperes, antequam temptes? Quare properas et beneficium et amicum perdere? Unde scis, nolim an ignorem, animus an facultas desit mihi? Experire». Admonebo ergo, non amare, non palam, sine convicio, sic, ut se redisse in memoriam, non reduci putet. 24. Causam dicebat apud divum Iulium ex veteranis quidam paulo violentior adversus vicinos suos et causa premebatur. «Meministi» inquit, «imperator, in Hispania talum extorsisse te circa Sucronem?». Cum Caesar meminisse se dixisset: «Meministi quidem sub quadam arbore minimum umbrae spargente cum velles residere ferventissimo sole et esset asperrimus locus, in quo ex rupibus acutis unica illa arbor eruperat, quendam ex commilitonibus paenulam suam substravisse?» Cum dixisset Caesar: «Quidni meminerim? Et quidem siti confectus, quia inpeditus ire ad fontem proximum non poteram, repere manibus volebam, ni bonus commilito, homo fortis ac strenuus, aquam mihi in galea sua adtulisset» –, «Potes ergo» inquit, «imperator, adgnoscere illum hominem aut illam galeam?». Caesar ait se non posse galeam adgnoscere, hominem pulchre posse, et adiecit, puto obiratus, quod se a cognitione media ad veterem fabulam abduceret: «Tu utique ille non es». «Merito» inquit, «Caesar, me non adgnoscis; nam cum hoc factum est, integer eram; postea ad Mundam in acie oculus mihi effossus est et in capite lecta ossa. Nec galeam illam, si videris, adgnosces; machaera enim Hispana divisa est». Vetuit illi exhiberi negotium Caesar et agellos, in quibus vicinalis via causa rixae ac litium fuerat, militi suo donavit. 25. Quid ergo? Non repeteret beneficium ab imperatore, cuius memoriam multitudo rerum confuderat, quem fortuna ingentes exercitus disponentem non patiebatur singulis militibus occurrere? Non est hoc repetere beneficium, sed resumere bono loco positum et paratum, ad quod tamen, ut sumatur, manus porrigenda est. Repetam itaque, quia hoc aut ex magna necessitate facturus ero aut illius causa, a quo repetam. Ti. Caesar inter initia dicenti cuidam: «Meministi …» antequam plures notas familiaritatis veteris proferret: «Non memini» inquit, «quid fuerim». Ab hoc quidni non esset repetendum beneficium? Optanda erat oblivio; aversabatur omnium amicorum et aequalium notitiam et illam solam praesentem fortunam suam adspici, illam solam cogitari ac narrari volebat; inquisitorem habebat veterem amicum. Magis tempestive repetendum est beneficium quam petendum. Adhibenda verborum moderatio, ut nec ingratus dissimulare possit nec gratus offendi ulla re. Tacendum erat et expectandum, si inter sapientes viveremus; et tamen sapientibus quoque indicare melius fuisset, quid rerum nostrarum status posceret. Deos,
quorum notitiam nulla res effugit, rogamus, et illos vota non exorant, sed admonent; dis quoque, inquam, Homericus ille sacerdos adlegat officia et aras religiose cultas. Moneri velle ac posse secunda virtus est. Equus obsequens facile et parens huc illuc frenis leniter motis flectendus est. Paucis animus sui rector optimus; proximi sunt, qui admoniti in viam redeunt: his non est dux detrahendus. Opertis oculis inest acies, sed sine usu, quam lumen diei iis inmissum ad ministeria sua evocat; instrumenta cessant, nisi illa in opus suum artifex movit. Inest interim animis voluntas bona, sed torpet modo deliciis ac situ, modo officii inscitia; hanc utilem facere debemus nec irati relinquere in vitio, sed ut magistri patienter ferre offensationes puerorum discentium memoriae labentis; quae quemadmodum saepe subiecto uno aut altero verbo ad contextum reddendae orationis adducta est, sic ad referendam gratiam admonitione revocanda est.
Liber sextus 1. Quaedam, Liberalis, virorum optime, exercendi tantum ingenii causa quaeruntur et semper extra vitam iacent; quaedam et, dum quaeruntur, oblectamento sunt et quaesita usui. Omnium tibi copiam faciam; tu illa, utcumque tibi visum erit, aut peragi iubeto aut ad explicandum ludorum ordinem induci. Quin his quoque, si abire protinus iusseris, non nihil actum erit; nam etiam quae discere supervacuum est, prodest cognoscere. Ex voltu igitur tuo pendebo; prout ille suaserit mihi, alia detinebo diutius, alia expellam et capite agam. 2. An beneficium eripi posset, quaesitum est. Quidam negant posse; non enim res est, sed actio. Quomodo aliud est munus, aliud ipsa donatio, aliud qui navigat, aliud navigatio, et, quamvis in morbo aeger sit, non tamen idem est aeger et morbus, ita aliud est beneficium ipsum, aliud quod ad unumquemque nostrum beneficio pervenit. Illud incorporale est, inritum non fit; materia vero eius huc et illuc iactatur et dominum mutat. Itaque cum eripis, ipsa rerum natura revocare, quod dedit, non potest. Beneficia sua interrumpit, non rescindit: qui moritur, tamen vixit; qui amisit oculos, tamen vidit. Quae ad nos pervenerunt, ne sint, effici potest, ne fuerint, non potest; pars autem beneficii et quidem certissima est, quae fuit. Non numquam usu beneficii longiore prohibemur, beneficium quidem ipsum non eraditur. Licet omnes in hoc vires suas natura advocet, retro illi agere se non licet. Potest eripi domus et pecunia et mancipium et quidquid est, in quo haesit beneficii nomen; ipsum vero stabile et inmotum est; nulla vis efficiet, ne hic dederit, ne ille acceperit. 3. Egregie mihi videtur M. Antonius apud Rabirium poetam, cum fortunam suam transeuntem alio videat et sibi nihil relictum praeter ius mortis, id quoque, si cito occupaverit, exclamare: «Hoc habeo, quodcumque dedi». O! quantum habere potuit, si voluisset! Hae sunt divitiae certae in quacumque sortis humanae levitate uno loco permansurae; quae quo maiores fuerint, hoc minorem habebunt invidiam. Quid tamquam tuo parcis? Procurator es. Omnia ista, quae vos tumidos et supra humana elatos oblivisci cogunt vestrae fragilitatis, quae ferreis claustris custoditis armati, quae ex alieno sanguine rapta vestro defenditis, propter quae classes cruentaturas maria deducitis, propter quae quassatis urbes ignari, quantum telorum in aversos fortuna conparet, propter quae ruptis totiens adfinitatis, amicitiae, conlegii foederibus inter contendentes duos terrarum orbis elisus est, non sunt vestra; in depositi causa sunt iam iamque ad alium dominum spectantia; aut hostis illa aut hostilis animi successor invadet. Quaeris, quomodo illa tua facias? Dona dando. Consule igitur rebus tuis et certam tibi earum atque inexpugnabilem possessionem para honestiores illas, non solum tutiores facturus. Istud, quod suspicis, quo te divitem ac potentem putas, quam diu possides, sub
nomine sordido iacet: domus est, servus est, nummi sunt; cum donasti, beneficium est. 4. «Fateris» inquit «nos aliquando beneficium non debere ei, a quo accepimus; ergo ereptum est». Multa sunt, propter quae beneficium debere desinimus, non quia ablatum sed quia corruptum est. Aliquis reum me defendit, sed uxorem meam per vim stupro violavit: non abstulit beneficium, sed obponendo illi parem iniuriam solvit me debito, et, si plus laesit, quam ante profuerat, non tantum gratia extinguitur, sed ulciscendi querendique libertas fit, ubi in conparatione beneficii praeponderavit iniuria; ita non aufertur beneficium, sed vincitur. Quid? Non tam duri quidam et tam scelerati patres sunt, ut illos aversari et eiurare ius fasque sit? Numquid ergo illi abstulerunt, quae dederant? Minime, sed inpietas sequentium temporum conmendationem omnis prioris officii sustulit. Non beneficium tollitur, sed beneficii gratia, et efficitur, non ne habeam, sed ne debeam. Tamquam pecuniam aliquis mihi credidit, sed domum meam incendit: pensatum est creditum damno; nec reddidi illi, nec tamen debeo. Eodem modo et hic, qui aliquid benigne adversus me fecit, aliquid liberaliter, sed postea multa superbe, contumeliose, crudeliter, eo me loco posuit, ut proinde liber adversus eum essem, ac si nihil accepissem; vim beneficiis suis adtulit. Colonum suum non tenet quamvis tabellis manentibus, qui segetem eius proculcavit, qui succidit arbusta, non quia recepit, quod pepigerat, sed quia, ne reciperet, effecit. Sic debitori suo creditor saepe damnatur, ubi plus ex alia causa abstulit, quam ex crediti petit. Non tantum inter creditorem et debitorem iudex sedet, qui dicat: «Pecuniam credidisti. Quid ergo est? Pecus abegisti, servum eius occidisti, argentum, quod non emeras, possides; aestimatione facta debitor discede, qui creditor veneras»; inter beneficia quoque et iniurias ratio confertur. Saepe, inquam, beneficium manet nec debetur; si secuta est dantem paenitentia, si miserum se dixit, quod dedisset, si, cum daret, suspiravit, voltum adduxit, perdere se credidit, non donare, si sua causa aut certe non mea dedit, si non desiit insultare, gloriari, ubique iactare et acerbum munus suum facere, manet beneficium, quamvis non debeatur, sicuti quaedam pecuniae, de quibus ius creditori non dicitur, debentur, sed non exiguntur. 5. Dedisti beneficium, iniuriam postea fecisti; et beneficio gratia debebatur et iniuriae ultio: nec ego illi gratiam debeo nec ille mihi poenam: alter ab altero absolvitur. Cum dicimus: «Beneficium illi reddidi», non hoc dicimus illud nos, quod acceperamus, reddidisse, sed aliud pro illo. Reddere est enim rem pro re dare; quidni? Cum omnis solutio non idem reddat, sed tantundem. Nam et pecuniam dicimur reddidisse, quamvis numeraverimus pro argenteis aureos, quamvis non intervenerint nummi, sed delegatione et verbis perfecta solutio sit. Videris mihi dicere: «Perdis operam; quorsus enim pertinet scire me, an maneat, quod non debetur? Iuris consultorum istae acutae ineptiae sunt, qui hereditatem negant usu capi posse sed ea, quae in hereditate sunt, tamquam
quicquam aliud sit hereditas, quam ea, quae in hereditate sunt. Illud potius mihi distingue, quod potest ad rem pertinere, cum idem homo beneficium mihi dedit et postea fecit iniuriam, utrum et beneficium illi reddere debeam et me ab illo nihilo minus vindicare ac veluti duobus nominibus separatim respondere an alterum alteri contribuere et nihil negotii habere, ut beneficium iniuria tollatur, beneficio iniuria. Illud enim video in hoc foro fieri; quid in vestra schola iuris sit, vos sciatis. Separantur actiones nec de eo, quod agimus, et de eo, quod nobiscum agitur, confunditur formula: si quis apud me pecuniam deposuerit, idem postea furtum mihi fecerit, et ego cum illo furti agam et ille mecum depositi». 6. Quae proposuisti, mi Liberalis, exempla certis legibus continentur, quas necesse est sequi. Lex legi non miscetur, utraque sua via it; depositum habet actionem propriam, tam mehercules quam furtum. Beneficium nulli legi subiectum est, me arbitro utitur; licet mihi inter se conparare, quantum profuerit mihi quisque et quantum nocuerit, tum pronuntiare, utrum plus debeatur mihi an debeam. In illis nihil est nostrae potestatis, eundum est, qua ducimur; in beneficio tota potestas mea est, ego iudico. Itaque non separo illa nec diduco, sed iniurias et beneficia ad eundem iudicem mitto; alioqui iubes me eodem tempore et amare et odisse et queri et gratias agere, quod natura non recipit. Potius conparatione facta inter se beneficii et iniuriae videbo, an mihi etiam ultro debeatur. Quomodo, si quis scriptis nostris alios superne inprimit versus, priores litteras non tollit, sed abscondit, sic beneficium superveniens iniuria adparere non patitur. 7. Voltus tuus, quoi regendum me tradidi, colligit rugas et trahit frontem, quasi longius exeam; videris mihi dicere: Quo tantum mihi dexter abis? Huc derige cursum, litus ama. Non possum magis. Itaque, si huic satis factum existimas, illo transeamus, an ei debeatur aliquid, qui nobis invitus profuit. Hoc apertius potui dicere, nisi propositio deberet esse confusior, ut distinctio statim subsecuta ostenderet utrumque quaeri, et an ei deberemus, qui nobis, dum non vult, profuit, et an ei, qui, dum nescit. Nam si quis coactus aliquid boni fecit, quin nos non obliget, manifestius est, quam ut ulla in hoc verba inpendenda sint. Et haec quaestio facile expedietur et si qua similis huic moveri potest, si totiens illo cogitationem nostram converterimus beneficium nullum esse, nisi quod ad nos primum aliqua cogitatio defert, deinde amica et benigna. Itaque nec fluminibus gratias agimus, quamvis aut magna navigia patiantur et ad subvehendas copias largo ac perenni alveo currant aut piscosa et amoena pinguibus arvis interfluant; nec quisquam Nilo beneficium debere se iudicat, non magis quam odium, si inmodicus superfluxit tardeque decessit; nec ventus beneficium dat, licet lenis et secundus
adspiret, nec utilis et salubris cibus. Nam qui beneficium mihi daturus est, debet non tantum prodesse, sed velle. Ideo nec mutis animalibus quicquam debetur: et quam multos e periculo velocitas equi rapuit! nec arboribus: et quam multos aestu laborantes ramorum opacitas texit! Quid autem interest, utrum mihi, qui nescit, profuerit, an qui scire non potuit, cum utrique velle defuerit? Quid interest, utrum me iubeas navi aut vehiculo aut lanceae debere beneficium an ei, qui aeque quam ista propositum bene faciendi nullum habuit, sed profuit casu? 8. Beneficium aliquis nesciens accipit, nemo a nesciente. Quomodo multos fortuita sanant nec ideo remedia sunt, ut in flumen aliquoi cecidisse frigore magno causa sanitatis fuit, quomodo quorundam flagellis quartana discussa est et metus repentinus animum in aliam curam avertendo suspectas horas fefellit nec ideo quidquam horum, etiam si saluti fuit, salutare est, sic quidam nobis prosunt, dum nolunt, immo quia nolunt; non tamen ideo illis beneficium debemus, quod perniciosa illorum consilia fortuna deflexit in melius. An existimas me debere ei quicquam, cuius manus, cum me peteret, percussit hostem meum, qui nocuisset, nisi errasset? Saepe testis, dum aperte peierat, etiam veris testibus abrogavit fidem et reum velut factione circumventum miserabilem reddidit. Quosdam ipsa, quae premebat, potentia eripuit, et iudices, quem damnaturi erant causae, damnare gratiae noluerunt. Non tamen hi beneficium reo dederunt, quamvis profuerint, quia, quo missum sit telum, non quo pervenerit, quaeritur, et beneficium ab iniuria distinguit non eventus sed animus. Adversarius meus, dum contraria dicit et iudicem superbia offendit et in unum testem temere rem demittit, causam meam erexit; non quaero, an pro me erraverit: contra me voluit. 9. Nempe, ut gratus sim, velle debeo idem facere, quod ille, ut beneficium daret, debuit. Num quid est iniquius homine, qui eum odit, a quo in turba calcatus aut respersus aut, quo nollet, inpulsus est? Atqui quid est aliud, quod illum querellae eximat, cum in re sit iniuria, quam nescisse, quid faceret? Eadem res efficit, ne hic beneficium dederit, ne ille iniuriam fecerit; et amicum et inimicum voluntas facit. Quam multos militiae morbus eripuit! quosdam, ne ad ruinam domus suae occurrerent, inimicus vadimonio tenuit; ne in piratarum manus pervenirent, quidam naufragio consecuti sunt; nec his tamen beneficium debemus, quia extra sensum officii casus est, nec inimico, cuius nos lis servavit, dum vexat ac detinet. Non est beneficium, nisi quod a bona voluntate proficiscitur, nisi illud adcognoscit, qui dedit. Profuit aliquis mihi, dum nescit: nihil illi debeo; profuit, cum vellet nocere: imitabor ipsum. 10. Ad primum illum revertamur. Ut gratiam referam, aliquid facere me vis? Ipse, ut beneficium mihi daret, nihil fecit. Ut ad alterum transeamus, vis me huic gratiam referre, ut, quod a nolente accepi, volens reddam? Nam quid de tertio loquar, qui ab iniuria in beneficium delapsus est? Ut beneficium tibi debeam,
parum est voluisse te dare; ut non debeam, satis est noluisse. Beneficium enim voluntas nuda non efficit, sed, quod beneficium non esset, si optimae ac plenissimae voluntati fortuna defuisset, id aeque beneficium non est, nisi fortunam voluntas antecessit; non enim profuisse te mihi oportet, ut ob hoc tibi obliger, sed ex destinato profuisse. 11. Cleanthes exemplo eiusmodi utitur: «Ad quaerendum» inquit «et accersendum ex Academia Platonem duos pueros misi; alter totam porticum perscrutatus est, alia quoque loca, in quibus illum inveniri posse sperabat, percucurrit et domum non minus lassus quam inritus redit; alter apud proximum circulatorem resedit et, dum vagus atque erro vernaculis congregatur et ludit, transeuntem Platonem, quem non quaesierat, invenit. Illum, inquit, laudabimus puerum, qui, quantum in se erat, quod iussus est, fecit; hunc feliciter inertem castigabimus». Voluntas est, quae apud nos ponit officium; cuius vide quae condicio sit, ut me debito obstringat. Parum est illi velle, nisi profuit; parum est profuisse, nisi voluit. Puta enim aliquem donare voluisse nec donasse: animum quidem eius habeo, sed beneficium non habeo, quod consummat et res et animus. Quemadmodum ei, qui voluit mihi quidem pecuniam credere, sed non dedit, nihil debeo, ita ei, qui voluit mihi beneficium dare, sed non potuit, amicus quidem ero sed non obligatus; et volam illi aliquid praestare (nam et ille voluit mihi), ceterum, si benigniore usus fortuna praestitero, beneficium dedero, non gratiam rettulero. Ille mihi gratiam referre debebit; hinc initium fiet, a me numerabitur. 12. Intellego iam, quid velis quaerere; non opus est te dicere; voltus tuus loquitur. «Si quis sua nobis causa profuit, eine» inquis «debetur aliquid? Hoc enim saepe te conquerentem audio, quod quaedam homines sibi praestant, aliis inputant». Dicam, mi Liberalis; sed prius istam quaestiunculam dividam et rem aequam ab iniqua separabo. Multum enim interest, utrum aliquis beneficium nobis det sua causa an et sua. Ille, qui totus ad se spectat et nobis prodest, quia aliter prodesse sibi non potest, eo mihi loco est, quo, qui pecori suo hibernum et aestivum pabulum prospicit; eo loco est, quo, qui captivos suos, ut commodius veneant, pascit et ut opimos boves saginat ac defricat, quo lanista, qui familiam summa cura exercet atque ornat. Multum, ut ait Cleanthes, a beneficio distat negotiatio. 13. Rursus non sum tam iniquus, ut ei nihil debeam, qui, cum mihi utilis esset, fuit et sibi; non enim exigo, ut mihi sine respectu sui consulat, immo etiam opto, ut beneficium mihi datum vel magis danti profuerit, dum modo id, qui dabat, duos intuens dederit et inter me seque diviserit. Licet id ipse ex maiore parte possideat, si modo me in consortium admisit, si duos cogitavit, ingratus sum, non solum iniustus, nisi gaudeo hoc illi profuisse, quod proderat mihi. Summae malignitatis est non vocare beneficium, nisi quod dantem aliquo incommodo adfecit. Alteri illi, qui beneficium dat sua causa, respondebo: «Usus me quare
potius te mihi profuisse dicas quam me tibi?» «Puta» inquit «aliter fieri non posse me magistratum, quam si decem captos cives ex magno captivorum numero redemero: nihil debebis mihi, cum te servitute ac vinculis liberavero? Atqui mea id causa faciam». Adversus hoc respondeo: «Aliquid istic tua causa facis, aliquid mea: tua, quod redimis, mea, quod me redimis; tibi enim ad utilitatem tuam satis est quoslibet redemisse. Itaque debeo, non quod redimis me, sed quod eligis; poteras enim et alterius redemptione idem consequi, quod mea. Utilitatem rei partiris mecum et me in beneficium recipis duobus profuturum. Praefers me aliis; hoc totum mea causa facis. Itaque, si praetorem te factura esset decem captivorum redemptio, decem autem soli captivi essemus, nemo quicquam tibi deberet ex nobis, quia nihil haberes, quod cuiquam inputares, a tua utilitate seductum. Non sum invidus beneficii interpres nec desidero illud mihi tantum dari, sed et mihi». 14. «Quid ergo?» inquit; «si in sortem nomina vestra coici iussissem, et tuum nomen inter redimendos exisset, nihil deberes mihi?» Immo deberem, sed exiguum; quid sit hoc, dicam. Aliquid istic mea causa facis, quod me ad fortunam redemptionis admittis; quod nomen meum exit, sorti debeo, quod exire potuit, tibi. Aditum mihi ad beneficium tuum dedisti, cuius maiorem partem fortunae debeo, sed hoc ipsum tibi, quod fortunae debere potui. Illos ex toto praeteribo, quorum mercennarium beneficium est, quod qui dat, non conputat, quoi, sed quanti daturus sit, quod undique in se conversum est. Vendit mihi aliquis frumentum; vivere non possum, nisi emero; sed non debeo vitam, quia emi. Nec, quam necessarium fuerit, aestimo, sine quo victurus non fui, sed quam ingratum, quod non habuissem, nisi emissem, in quo invehendo mercator non cogitavit, quantum auxilii adlaturus esset mihi, sed quantum lucri sibi. Quod emi, non debeo. 15. «Isto modo» inquit «nec medico quicquam debere te nisi mercedulam dicis nec praeceptori, quia aliquid numeraveris; atqui omnium horum apud nos magna caritas, magna reverentia est». Adversus hoc respondetur quaedam pluris esse, quam emuntur. Emis a medico rem inaestimabilem, vitam ac bonam valetudinem, a bonarum artium praeceptore studia liberalia et animi cultum; itaque his non rei pretium, sed operae solvitur, quod deserviunt, quod a rebus suis avocati nobis vacant; mercedem non meriti, sed occupationis suae ferunt. Aliud tamen dici potest verius, quod statim ponam, si prius, quomodo istud refelli possit, ostendero. «Quaedam» inquit «pluris sunt, quam venierunt, et ob hoc aliquid mihi extra pro illis, quamvis empta sunt, debes». Primum quid interest, quanti sint, cum de pretio inter ementem vendentemque convenerit? Deinde non emi illud suo pretio, sed tuo. «Pluris est» inquis, «quam venit»; sed pluris venire non potuit. Pretium autem rei cuiusque pro tempore est; cum bene ista laudaveris, tanti sunt, quanto pluris venire non possunt; propterea nihil venditori debet, qui bene emit. Deinde, etiam si pluris ista sunt, non tamen ullum
istic tuum munus est, ut non ex usu effectuve, sed ex consuetudine et annona aestimetur. Quod tu pretium ponis traicienti maria et per medios fluctus, cum terra e conspectu recessit, certam secanti viam et prospicienti futuras tempestates et securis omnibus subito iubenti vela substringi, armamenta demitti, paratos ad incursum procellae et repentinum inpetum stare? Huic tamen tantae rei praemium vectura persolvit. Quanti aestimas in solitudine hospitium, in imbre tectum, in frigore balneum aut ignem? Scio tamen, quanti ista consecuturus deversorium subeam. Quantum nobis praestat, qui labentem domum suscipit et agentem ex imo rimas insulam incredibili arte suspendit! certo tamen et levi pretio fultura conducitur. Murus nos ab hostibus tutos et a subitis latronum incursionibus praestat; notum est tamen, illas turres pro securitate publica propugnacula habituras excitaturus faber quid in diem mereat. 16. Infinitum erit, si latius exempla conquiram, quibus adpareat parvo magna constare. Quid ergo? Quare et medico et praeceptori plus quiddam debeo nec adversus illos mercede defungor? Quia ex medico et praeceptore in amicum transeunt et nos non arte, quam vendunt, obligant, sed benigna et familiari voluntate. Itaque medico, si nihil amplius quam manum tangit et me inter eos, quos perambulat, ponit sine ullo adfectu facienda aut vitanda praecipiens, nihil amplius debeo, quia me non tamquam amicum videt, sed tamquam imperatorem. Ne praeceptorem quidem habeo cur venerer, si me in grege discipulorum habuit, si non putavit dignum propria et peculiari cura, si numquam in me derexit animum, et, cum in medium effunderet, quae sciebat, non didici, sed excepi. Quid ergo est, quare istis multum debeamus? Non quia pluris est, quod vendiderunt, quam emimus, sed quia nobis ipsis aliquid praestiterunt. Ille magis pependit, quam medico necesse est; pro me, non pro fama artis extimuit; non fuit contentus remedia monstrare: et admovit; inter sollicitos adsedit, ad suspecta tempora occurrit; nullum ministerium illi oneri, nullum fastidio fuit; gemitus meos non securus audivit; in turba multorum invocantium ego illi potissima curatio fui; tantum aliis vacavit, quantum mea valetudo permiserat: huic ego non tamquam medico sed tamquam amico obligatus sum. Alter rursus docendo et laborem et taedium tulit; praeter illa, quae a praecipientibus in commune dicuntur, aliqua instillavit ac tradidit, hortando bonam indolem erexit et modo laudibus fecit animum, modo admonitionibus discussit desidiam; tum ingenium latens et pigrum iniecta, ut ita dicam, manu extraxit; nec, quae sciebat, maligne dispensavit, quo diutius esset necessarius, sed cupit, si posset, universa transfundere: ingratus sum, nisi illum inter gratissimas necessitudines diligo. 17. Sordidissimorum quoque artificiorum institoribus supra constitutum aliquid adiecimus, si nobis illorum opera enixior visa est; et gubernatori et opifici vilissimae mercis et in diem locanti manus suas corollarium adspersimus. In optimis vero artibus, quae vitam aut conservant aut excolunt, qui nihil se plus existimat debere, quam pepigit, ingratus est. Adice, quod talium studiorum
traditio miscet animos; hoc cum factum est, tam medico quam praeceptori pretium operae solvitur, animi debetur. 18. Platon cum flumen nave transisset nec ab illo quicquam portitor exegisset, honori hoc suo datum credens dixit positum illi esse apud Platonem officium; deinde paulo post, cum alium atque alium gratis eadem sedulitate transveheret, negavit illi iam apud Platonem positum officium. Nam ut tibi debeam aliquid pro eo, quod praestas, debes non tantum mihi praestare, sed tamquam mihi; non potes ob id quemquam adpellare, quod spargis in populum. Quid ergo? Nihil tibi debebitur pro hoc? Tamquam ab uno nihil; cum omnibus solvam, quod cum omnibus debeo. 19. «Negas» inquit «ullum dare beneficium eum, qui me gratuita nave per flumen Padum tulit?». Nego. Aliquid boni facit, beneficium non dat; facit enim aut sua causa aut utique non mea; ad summam ne ipse quidem se mihi beneficium iudicat dare, sed aut rei publicae aut viciniae aut ambitioni suae praestat et pro hoc aliud quoddam commodum expectat, quam quod a singulis recepturus est. «Quid ergo?» inquit, «si princeps civitatem dederit omnibus Gallis, si inmunitatem Hispanis, nihil hoc nomine singuli debebunt?». Quidni debeant? Debebunt autem non tamquam proprium beneficium, sed tamquam publici partem. «Nullam» inquit «habuit cogitationem illo tempore mei, quo universis proderat; noluit mihi civitatem proprie dare nec in me direxit animum; ita quare ei debeam, qui me sibi non substituit, cum facturus esset, quod fecit?». Primum, cum cogitavit Gallis omnibus prodesse, et mihi cogitavit prodesse; eram enim Gallus et me, etiam si non mea, publica tamen nota conprendit. Deinde ego quoque illi non tamquam proprium debebo, sed tamquam commune munus; unus ex populo non tamquam pro me solvam, sed tamquam pro patria conferam. Si quis patriae meae pecuniam credat, non dicam me illius debitorem nec hoc aes alienum profitebor aut candidatus aut reus; ad exolvendum tamen hoc dabo portionem meam. Sic istius muneris, quod universis datur, debitorem me nego, quia mihi quidem dedit sed non propter me, et mihi quidem, sed nesciens, an mihi daret; nihilo minus aliquid mihi dependendum sciam, quia ad me quoque circumitu longo pervenit. Propter me debet factum esse, quod me obliget. 20. «Isto» inquit «modo nec lunae nec soli quicquam debes; non enim propter te moventur». Sed cum in hoc moveantur, ut universa conservent, et pro me moventur; universorum enim pars sum. Adice nunc, quod nostra et horum condicio dissimilis est; nam qui mihi prodest, ut per me prosit sibi, non dedit beneficium, quia me instrumentum utilitatis suae fecit; sol autem et luna, etiam si nobis prosunt sua causa, non in hoc tamen prosunt, ut per nos prosint sibi; quid enim nos conferre illis possumus? 21. «Sciam» inquit «solem ac lunam nobis velle prodesse, si nolle potuerint;
illis autem non licet non moveri. Ad summam consistant et opus suum intermittant». Hoc vide quot modis refellatur. Non ideo minus vult, qui non potest nolle; immo maximum argumentum est firmae voluntatis ne mutari quidem posse. Vir bonus non potest non facere, quod facit; non enim erit bonus, nisi fecerit; ergo nec bonus vir beneficium dat, quia facit, quod debet, non potest autem non facere, quod debet. Praeterea multum interest, utrum dicas: «Non potest hoc non facere», quia cogitur, an: «Non potest nolle». Nam si necesse est illi facere, non debeo ipsi beneficium, sed cogenti; si necesse est illi velle ob hoc, quia nihil habet melius, quod velit, ipse se cogit; ita, quod tamquam coacto non deberem, tamquam cogenti debeo. «Desinant» inquit «velle». Hoc loco tibi illud occurrat: Quis tam demens est, ut eam neget voluntatem esse, cui non est periculum desinendi vertendique se in contrarium, cum ex diverso nemo aeque videri debeat velle, quam cuius voluntas usque eo certa est, ut aeterna sit? An, si is quoque vult, qui potest statim nolle, is non videbitur velle, in cuius naturam non cadit nolle? 22. «Agedum» inquit, «si possunt, resistant». Hoc dicis: «Omnia ista ingentibus intervallis diducta et in custodiam universi disposita stationes suas deserant; subita confusione rerum sidera sideribus incurrant, et rupta rerum concordia in ruinam divina labantur, contextusque velocitatis citatissimae in tot saecula promissas vices in medio itinere destituat, et, quae nunc alternis eunt redeuntque oportunis libramentis mundum ex aequo temperantia, repentino concrementur incendio, et ex tanta varietate solvantur atque eant in unum omnia; ignis cuncta possideat, quem deinde pigra nox occupet, et profunda vorago tot deos sorbeat»; est tanti, ut tu coarguaris, ista concidere? Prosunt tibi etiam invito euntque ista tua causa, etiam si maior illis alia ac prior causa est. 23. Adice nunc, quod non externa cogunt deos, sed sua illis in lege aeterna voluntas est. Statuerunt, quae non mutarent; itaque non possunt videri facturi aliquid, quamvis nolint, quia, quidquid desinere non possunt, perseverare voluerunt, nec umquam primi consilii deos paenitet. Sine dubio stare illis et desciscere in contrarium non licet, sed non ob aliud, quam quia vis sua illos in proposito tenet; nec inbecillitate permanent, sed quia non libet ab optimis aberrare et sic ire decretum est. In prima autem illa constitutione, cum universa disponerent, etiam nostra viderunt rationemque hominis habuerunt; itaque non possunt videri sua tantum causa decurrere et explicare opus suum, quia pars operis et nos sumus. Debemus ergo et soli et lunae et ceteris caelestibus beneficium, quia, etiam si potiora illis sunt, in quae oriuntur, nos tamen in maiora ituri iuvant. Adice, quod ex destinato iuvant, ideoque obligati sumus, quia non in beneficium ignorantium incidimus, sed haec, quae accipimus, accepturos scierunt; et quamquam maius illis propositum sit maiorque actus sui fructus, quam servare mortalia, tamen in nostras quoque utilitates a principio rerum praemissa mens est et is ordo mundo datus, ut adpareat curam nostri non inter ultima
habitam. Debemus parentibus nostris pietatem, et multi non, ut gignerent, coierant; di non possunt videri nescisse, quid effecturi essent, cum omnibus alimenta protinus et auxilia providerint, nec eos per neglegentiam genuere, quibus tam multa generabant. Cogitavit nos ante natura, quam fecit, nec tam leve opus sumus, ut illi potuerimus excidere. Vide, quantum nobis permiserit, quam non intra homines humani imperii condicio sit; vide, in quantum corporibus vagari liceat, quae ‹non› coercuit fine terrarum, sed in omnem partem sui misit; vide, animi quantum audeant, quemadmodum soli aut noverint deos aut quaerant et mente in altum elata divina comitentur: scies non esse hominem tumultuarium et incogitatum opus. Inter maxima rerum suarum natura nihil habet, quo magis glorietur, aut certe, cui glorietur; quantus iste furor est controversiam dis muneris sui facere! quomodo adversus eos hic erit gratus, quibus gratia referri sine inpendio non potest, qui negat se ab iis accepisse, a quibus cum maxime accepit, qui et semper daturi sunt et numquam recepturi? Quanta autem perversitas ob hoc alicui non debere, quia etiam infitianti benignus est, et continuationem ipsam seriemque beneficiorum argumentum vocare necessario dantis! «Nolo! sibi habeat! quis illum rogat?» et omnes alias inpudentis animi voces his adstrue: non ideo de te minus meretur is, cuius liberalitas ad te etiam, dum negas, pervenit, cuiusque beneficiorum vel hoc maximum est, quod etiam querenti daturus est. 24. Non vides, quemadmodum teneram liberorum infantiam parentes ad salubrium rerum patientiam cogant? Flentium corpora ac repugnantium diligenti cura fovent et, ne membra libertas inmatura detorqueat, in rectum exitura constringunt et mox liberalia studia inculcant adhibito timore nolentibus; ad ultimum audacem iuventam frugalitati, pudori, moribus bonis, si parum sequitur, coactam adplicant. Adulescentibus quoque ac iam potentibus sui, si remedia metu aut intemperantia reiciunt, vis adhibetur ac severitas. Itaque beneficiorum maxima sunt, quae a parentibus accepimus, dum aut nescimus aut nolumus. 25. His ingratis et repudiantibus beneficia, non quia nolunt, sed ne debeant, similes sunt ex diverso nimis grati, qui aliquid incommodi precari solent iis, quibus obligati sunt, aliquid adversi, in quo adfectum memorem accepti beneficii adprobent. An hoc recte faciant et pia voluntate, quaeritur; quorum animus simillimus est pravo amore flagrantibus, qui amicae suae optant exilium, ut desertam fugientemque comitentur, optant inopiam, ut magis desideranti donent, optant morbum, ut adsideant, et, quidquid inimicus optaret, amantes vovent. Fere idem itaque exitus est odii et amoris insani. Tale quiddam et his accidit, qui amicis incommoda optant, quae detrahant, et ad beneficium iniuria veniunt, cum satius sit vel cessare, quam per scelus officio locum quaerere. Quid, si gubernator a dis tempestates infestissimas et procellas petat, ut gratior ars sua periculo fiat? Quid, si imperator deos oret, ut magna vis hostium circumfusa castris fossas subito inpetu conpleat et vallum trepidante
exercitu vellat et in ipsis portis infesta signa constituat, quo maiore cum gloria rebus lassis profligatisque succurrat? Omnes isti beneficia sua detestabili via ducunt, qui deos contra eum advocant, cui ipsi adfuturi sunt, et ante illos sterni quam erigi volunt; inhumana ista perverse grati animi natura est contra eum optare, cui honeste deesse non possis. 26. «Non nocet» inquit «illi votum meum, quia simul opto et periculum et remedium». Hoc dicis non nihil te peccare sed minus, quam si sine remedio periculum optares. Nequitia est ut extrahas mergere, evertere ut suscites, ut emittas includere; non est beneficium iniuriae finis, nec umquam id detraxisse meritum est, quod ipse, qui detraxit, intulerat. Non volneres me malo, quam sanes. Potes inire gratiam, si, quia volneratus sum, sanas, non, si volneras, ut sanandus sim; numquam cicatrix nisi conlata volneri placuit, quod ita coisse gaudemus, ut non fuisse mallemus. Si hoc ei optares, cuius nullum beneficium haberes, inhumanum erat votum; quanto inhumanius ei optas, cui beneficium debes! 27. «Simul» inquit, «ut possim ferre illi opem, precor». Primum, ut te in media parte voti tui occupem, iam ingratus es; nondum audio, quid illi velis praestare, scio, quid illum velis pati. Sollicitudinem illi et metum et maius aliquod inprecaris malum. Optas, ut ope indigeat: hoc contra illum est; optas, ut ope tua indigeat: hoc pro te est. Non succurrere vis illi, sed solvere; qui sic properat, solvi vult, non solvere. Ita, quod unum in voto tuo honestum videri poterat, ipsum turpe et ingratum est, nolle debere; optas enim, non ut tu facultatem habeas referendae gratiae, sed ut ille necessitatem inplorandae. Superiorem te facis et, quod nefas est, bene meritum ad pedes tuos mittis. Quanto satius est honesta voluntate debere, quam rationem per malam solvere! Si infitiareris, quod acceperas, minus peccares; nihil enim, nisi quod dederat, amitteret; nunc vis illum subici tibi, iactura rerum suarum et status mutatione in id devocari, ut infra beneficia sua iaceat. Gratum te putabo? Coram eo, cui prodesse vis, opta. Votum tu istud vocas, quod inter gratum et inimicum potest dividi, quod non dubites adversarium et hostem fecisse, si extrema taceantur? Hostes quoque optaverunt capere quasdam urbes, ut servarent, et vincere quosdam, ut ignoscerent, nec ideo non hostilia vota, in quibus, quod mitissimum est, post crudelitatem venit. Denique qualia esse iudicas vota, quae nemo minus tibi volet, quam is, pro quo fiunt, succedere? Pessime cum eo agis, cui vis a dis noceri, a te succurri, inique cum ipsis dis; illis enim durissimas partes inponis, tibi humanas; ut tu prosis, di nocebunt. Si accusatorem submitteres, quem deinde removeres, si aliqua illum lite inplicares, quam subinde discuteres, nemo de tuo scelere dubitaret; quid interest, utrum istuc fraude temptetur an voto, nisi quod potentiores illi adversarios quaeris? Non est, quod dicas: «Quam enim illi iniuriam facio?» votum tuum aut supervacuum est aut iniuriosum, immo
iniuriosum, etiam si inritum. Quidquid non efficis, dei munus est, iniuria vero, quidquid optas. Sat est; tibi non aliter debemus irasci, quam si profeceris. 28. «Si vota» inquit «valuissent, et in hoc valuissent, ut tutus esses». Primum certum mihi optas periculum sub incerto auxilio. Deinde utrumque certum puta: quod nocet, prius est. Praeterea tu condicionem voti tui nosti, me tempestas occupavit portus ac praesidii dubium. Quantum tormentum existimas, etiam si accepero, eguisse? Etiam si servatus fuero, trepidasse? Etiam si absolutus fuero, causam dixisse? Nullius metus tam gratus est finis, ut non gratior sit solida et inconcussa securitas. Opta, ut reddere mihi beneficium possis, cum opus erit, non, ut opus sit. Si esset in tua potestate, quod optas, ipse fecisses. 29. Quanto hoc honestius votum est: «Opto, in eo statu sit, quo semper beneficia distribuat, numquam desideret; sequatur illum materia, qua tam benigne utitur, largiendi iuvandique; numquam illi sit dandorum beneficiorum inopia, datorum paenitentia; naturam per se pronam ad misericordiam, humanitatem, clementiam inritet ac provocet turba gratorum, quos illi et habere contingat nec experiri necesse sit; ipse nulli inplacabilis sit, ipsi nemo placandus; tam aequali in eum fortuna indulgentia perseveret, ut nemo in illum possit esse nisi conscientia gratus». Quanto haec iustiora vota sunt, quae te in nullam occasionem differunt, sed gratum statim faciunt! Quid enim prohibet referre gratiam prosperis rebus? Quam multa sunt, per quae, quidquid debemus, reddere etiam felicibus possumus! fidele consilium, adsidua conversatio, sermo comis et sine adulatione iocundus, aures, si deliberari velit, diligentes, tutae, si credere, convictus familiaritas. Neminem tam alte secunda posuerunt, ut non illi eo magis amicus desit, quia nihil absit. 30. Ista tristis et omni voto submovenda occasio ac procul repellenda; ut gratus esse possis, iratis dis opus est? Ne ex hoc quidem peccare te intellegis, quod melius cum eo agitur, cui ingratus es? Propone animo tuo carcerem, vincula, sordes, servitutem, bellum, egestatem; haec sunt occasiones voti tui; si quis tecum contraxit, per ista dimittitur. Quin potius eum potentem esse vis, cui plurimum debes, ‹et› beatum? Quid enim, ut dixi, vetat te referre etiam summa felicitate praeditis gratiam? Cuius plena tibi occurret et varia materia. Quid? Tu nescis debitum etiam locupletibus solvi? Nec te invitum distringam; omnia sane excluserit opulenta felicitas, monstrabo tibi, cuius rei inopia laborent magna fastigia, quid omnia possidentibus desit: scilicet ille, qui verum dicat et hominem inter mentientes stupentem ipsaque consuetudine pro rectis blanda audiendi ad ignorantiam veri perductum vindicet a consensu concentuque falsorum. Non vides, quemadmodum illos in praeceps agat extincta libertas et fides in obsequium servile submissa? Dum nemo ex animi sui sententia suadet dissuadetque, sed adulandi certamen est et unum amicorum omnium officium, una contentio, quis blandissime fallat, ignoravere vires suas, et, dum se tam magnos,
quam audiunt, credunt, adtraxere supervacua et in discrimen rerum omnium perventura bella, utilem et necessariam rupere concordiam, secuti iram, quam nemo revocabat, multorum sanguinem hauserunt fusuri novissime suum; dum vindicant inexplorata pro certis flectique non minus existimant turpe quam vinci et perpetua credunt, quae in summum perducta maxime nutant, ingentia super se ac suos regna fregerunt; nec intellexerunt in illa scena vanis et cito diffluentibus bonis refulgente ex eo tempore ipsos nihil non adversi expectare debuisse, ex quo nihil veri audire potuerunt. 31. Cum bellum Graeciae indiceret Xerxes, animum tumentem oblitumque, quam caducis confideret, nemo non inpulit. Alius aiebat non laturos nuntium belli et ad primam adventus famam terga versuros; alius nihil esse dubii, quin illa mole non vinci solum Graecia, sed obrui posset; magis verendum, ne vacuas desertasque urbes invenirent et profugis hostibus vastae solitudines relinquerentur non habituris, ubi tantas vires exercere possent; alius vix illi rerum naturam sufficere, angusta esse classibus maria, militi castra, explicandis equestribus copiis campestria, vix patere caelum satis ad emittenda omni manu tela. Cum in hunc modum multa undique iactarentur, quae hominem nimia aestimatione sui furentem concitarent, Demaratus Lacedaemonius solus dixit ipsam illam, qua sibi placeret, multitudinem indigestam et gravem metuendam esse ducenti; non enim vires habere, sed pondus; inmodica numquam regi posse, nec diu durare, quidquid regi non potest. «In primo» inquit «statim monte Lacones obiecti dabunt sui experimentum. Tot ista gentium milia trecenti morabuntur; haerebunt in vestigio fixi et conmissas sibi angustias armis tuebuntur, corporibus obstruent; tota illos Asia non movebit loco; tantas minas belli et paene totius generis humani ruentis inpetum paucissimi sistent. Cum te mutatis legibus suis natura transmiserit, in semita haerebis et aestimabis futura damna, cum conputaveris, quanti Thermopylarum angusta constiterint; scies te fugari posse, cum scieris posse retineri. Cedent quidem tibi pluribus locis velut torrentis modo ablati, cuius cum magno terrore prima vis defluit; deinde hinc atque illinc coorientur et tuis te viribus prement. Verum est, quod dicitur, maiorem belli adparatum esse, quam qui recipi ab his regionibus possit, quas obpugnare constituis, sed haec res contra nos est; ob hoc ipsum te Graecia vincet, quia non capit: uti toto te non potes. Praeterea, quae una rebus salus est, occurrere ad primos rerum inpetus et inclinatis opem ferre non poteris nec fulcire ac firmare labentia; multo ante vinceris, quam victum esse te sentias. Ceterum non est, quod exercitum tuum ob hoc sustineri non putes posse, quia numerus eius duci quoque ignotus est; nihil tam magnum est, quod perire non possit, cui nascitur in perniciem, ut alia quiescant, ex ipsa magnitudine sua causa». Acciderunt, quae Demaratus praedixerat; divina atque humana inpellentem et mutantem, quidquid obstiterat, trecenti stare iusserunt, stratusque passim per totam Graeciam Perses intellexit, quantum ab exercitu turba distaret. Itaque
Xerxes pudore quam damno miserior Demarato gratias egit, quod solus sibi verum dixisset, et permisit petere, quod vellet. Petit ille, ut Sardis, maximam Asiae civitatem, curru vectus intraret rectam capite tiaram gerens; id solis datum regibus. Dignus fuerat praemio, ante quam peteret; sed quam miserabilis gens, in qua nemo fuit, qui verum diceret regi, nisi qui non dicebat sibi! 32. Divus Augustus filiam ultra inpudicitiae maledictum inpudicam relegavit et flagitia principalis domus in publicum emisit: admissos gregatim adulteros, pererratam nocturnis comissationibus civitatem, forum ipsum ac rostra, ex quibus pater legem de adulteriis tulerat, filiae in stupra placuisse, cottidianum ad Marsyam concursum, cum ex adultera in quaestuariam versa ius omnis licentiae sub ignoto adultero peteret. Haec tam vindicanda principi quam tacenda, quia quarundam rerum turpitudo etiam ad vindicantem redit, parum potens irae publicaverat. Deinde, cum interposito tempore in locum irae subisset verecundia, gemens, quod non illa silentio pressisset, quae tam diu nescierat, donec loqui turpe esset, saepe exclamavit: «Horum mihi nihil accidisset, si aut Agrippa aut Maecenas vixisset!». Adeo tot habenti milia hominum duos reparare difficile est. Caesae sunt legiones et protinus scriptae; fracta classis et intra paucos dies natavit nova; saevitum est in opera publica ignibus, surrexerunt meliora consumptis: tota vita Agrippae et Maecenatis vacavit locus. Quid? Putem defuisse similes, qui adsumerentur, an ipsius vitium fuisse, quia maluit queri quam quaerere? Non est, quod existimemus Agrippam et Maecenatem solitos illi vera dicere; qui si vixissent, inter dissimulantes fuissent. Regalis ingenii mos est in praesentium contumeliam amissa laudare et his virtutem dare vera dicendi, a quibus iam audiendi periculum non est. 33. Sed ut me ad propositum reducam, vides, quam facile sit gratiam referre felicibus et in summo humanarum opum positis. Dic illis, non quod volunt audire, sed quod audisse semper volent; plenas aures adulationibus aliquando vera vox intret; da consilium utile. Quaeris, quid felici praestare possis? Effice, ne felicitati suae credat, ut sciat illam multis et fidis manibus continendam. Parum in illum contuleris, si illi stultam fiduciam permansurae semper potentiae excusseris docuerisque mobilia esse, quae dedit casus, et maiore cursu fugere, quam veniunt, nec iis portionibus, quibus ad summa perventum est, retro iri, sed saepe inter maximam fortunam et ultimam nihil interesse? Nescis, quantum sit pretium amicitiae, si non intellegis multum te ei daturum, cui dederis amicum, rem non domibus tantum, sed saeculis raram, quae non aliubi magis deest, quam ubi creditur abundare. Quid? Istos tu libros, quos vix nomenclatorum conplectitur aut memoria aut manus, amicorum existimas esse? Non sunt isti amici, qui agmine magno ianuam pulsant, qui in primas et secundas admissiones digeruntur. 34. Consuetudo ista vetus est regibus regesque simulantibus populum
amicorum discribere, et proprium superbiae magno aestimare introitum ac tactum sui liminis et pro honore dare, ut ostio suo propius adsideas, ut gradum prior intra domum ponas, in qua deinceps multa sunt ostia, quae receptos quoque excludant. Apud nos primi omnium ‹C.› Gracchus et mox Livius Drusus instituerunt segregare turbam suam et alios in secretum recipere, alios cum pluribus, alios universos. Habuerunt itaque isti amicos primos, habuerunt secundos, numquam veros. Amicum vocas, cuius disponitur salutatio? Aut potest huius tibi fides patere, qui per fores maligne apertas non intrat, sed inlabitur? Huic pervenire usque ad libertatem destringendam licet, cuius volgare et publicum verbum et promiscuum ignotis «have!» non nisi suo ordine emittitur? Ad quemcumque itaque istorum veneris, quorum salutatio urbem concutit, scito, etiam si animadverteris obsessos ingenti frequentia vicos et conmeantium in utramque partem catervis itinera conpressa, tamen venire te in locum hominibus plenum, amicis vacuum. In pectore amicus, non in atrio quaeritur; illo recipiendus, illic retinendus est et in sensus recondendus. Hoc doce: gratus es. 35. Male de te existimas, si inutilis es nisi adflicto, si rebus bonis supervacuus es. Quemadmodum te et in dubiis et in adversis et in laetis sapienter geris, ut dubia prudenter tractes, adversa fortiter, laeta moderate, ita in omnia utilem te exhibere amico potes. Adversa eius nec deserueris nec optaveris; multa nihilo minus, ut non optes, in tanta varietate, quae tibi materiam exercendae fidei praebeant, incident. Quemadmodum, qui optat divitias alicui in hoc, ut illarum ipse partem ferat, quamvis pro illo videatur optare, sibi prospicit, sic, qui optat amico aliquam necessitatem, quam adiutorio suo fideque discutiat, quod est ingrati, se illi praefert et tanti existimat illum miserum esse, ut ipse gratus sit, ob hoc ipsum ingratus; exonerare enim se vult et gravi sarcina liberare. Multum interest, utrum properes referre gratiam, ut reddas beneficium, an ne debeas. Qui reddere vult, illius se commodo aptabit et idoneum illi venire tempus volet; qui nihil aliud quam ipse liberari vult, quo modo cumque ad hoc cupiet pervenire, quod est pessimae voluntatis. «Ista» inquit «festinatio nimium grati est!». Id apertius exprimere non possum, quam si repetivero, quod dixi: Non vis reddere acceptum beneficium, sed effugere. Hoc dicere videris: «Quando isto carebo? Quocumque modo mihi laborandum est, ne isti obligatus sim». Si optares, ut illi de suo solveres, multum abesse videreris a grato; hoc, quod optas, iniquius est: execraris enim illum et caput sanctum tibi dira precatione defigis. Nemo, ut existimo, de inmanitate animi tui dubitaret, si aperte illi paupertatem, si captivitatem, si famem ac metum inprecareris; at quid interest, utrum vox ista sit voti tui an vis? Aliquid enim horum optas. I nunc et hoc esse grati puta, quod ne ingratus quidem faceret, qui modo non usque in odium, sed tantum usque ad infitiationem beneficii perveniret! 36. Quis pium dicet Aenean, si patriam capi voluerit, ut captivitati patrem eripiat? Quis Siculos iuvenes ut bona liberis exempla monstrabit, si optaverint, ut
Aetna inmensam ignium vim super solitum ardens et incensa praecipitet datura ipsis occasionem exhibendae pietatis ex medio parentibus incendio raptis? Nihil debet Scipioni Roma, si Punicum bellum, ut finiret, aluit; nihil Deciis, quod morte patriam servaverunt, si prius optaverant, ut devotioni fortissimae locum ultima rerum necessitas faceret. Gravissima infamia est medici opus quaerere; multi, quos auxerant morbos et inritaverant, ut gloria maiore sanarent, non potuerunt discutere aut cum magna miserorum vexatione vicerunt. 37. Callistratum aiunt (ita certe Hecaton auctor est), cum in exilium iret, in quod multos cum illo simul seditiosa civitas et intemperanter libera expulerat, optante quodam, ut Atheniensibus necessitas restituendi exules esset, abominatum talem reditum. Rutilius noster animosius, cum quidam illum consolaretur et diceret instare arma civilia, brevi futurum, ut omnes exules reverterentur: «Quid tibi» inquit «mali feci, ut mihi peiorem reditum quam exitum optares? Ut malo, patria exilio meo erubescat, quam reditu maereat!». Non est istud exilium, cuius neminem non magis quam damnatum pudet. Quemadmodum illi servaverunt bonorum civium officium, qui reddi sibi penates suos noluerunt clade communi, quia satius erat duos iniquo malo adfici quam omnes publico, ita non servat grati hominis adfectum, qui bene de se merentem difficultatibus vult obprimi, quas ipse submoveat, quia, etiam si bene cogitat, male precatur. Ne in patrocinium quidem, nedum in gloriam est incendium extinxisse, quod feceris. 38. In quibusdam civitatibus inpium votum sceleris vicem tenuit. Demades certe Athenis eum, qui necessaria funeribus venditabat, damnavit, cum probasset magnum lucrum optasse, quod contingere illi sine multorum morte non poterat. Quaeri tamen solet, an merito damnatus sit. Fortasse optavit, non ut multis venderet, sed ut care, ut parvo sibi constarent, quae venditurus esset. Cum constet negotiatio eius ex empto et vendito, quare votum eius in unam partem trahis, cum lucrum ex utraque sit? Praeterea omnes licet, qui in ista negotiatione sunt, damnes; omnes enim idem volunt, id est, intra se optant. Magnam partem hominum damnabis; cui enim non ex alieno incommodo lucrum? Miles bellum optat, si gloriam; agricolam annonae caritas erigit; eloquentiae pretium excitat litium numerus; medicis gravis annus in quaestu est; institores delicatarum mercium iuventus corrupta locupletat; nulla tempestate tecta, nullo igne laedantur: iacebit opera fabrilis. Unius votum deprensum est, omnium simile est. An tu Arruntium et Haterium et ceteros, qui captandorum testamentorum artem professi sunt, non putas eadem habere quae dissignatores et libitinarios vota? Illi tamen, quorum mortes optent, nesciunt, hi familiarissimum quemque, ex quo propter amicitiam spei plurimum est, mori cupiunt; illorum damno nemo vivit, hos, quisquis differt, exhaurit; optant ergo non tantum, ut accipiant, quod turpi servitute meruerunt, sed etiam, ut tributo gravi liberentur. Non est itaque dubium, quin hi magis, quod damnatum est in uno, optent, quibus, quisquis morte
profuturus est, vita nocet; omnium tamen istorum tam nota sunt vota quam inpunita. Denique se quisque consulat et in secretum pectoris sui redeat et inspiciat, quid tacitus optaverit: quam multa sunt vota, quae etiam sibi fateri pudet! quam pauca, quae facere coram teste possimus! 39. Sed non, quidquid reprehendendum, etiam damnandum est, sicut hoc votum amici, quod in manibus est, male utentis bona voluntate et in id vitium incidentis, quod devitat; nam dum gratum animum festinat ostendere, ingratus est. Hoc ait: «In potestatem meam recidat, gratiam meam desideret, sine me salvus, honestus, tutus esse non possit, tam miser sit, ut illi beneficii loco sit, quidquid redditur». Haec dis audientibus: «Circumveniant illum domesticae insidiae, quas ego possim solus obprimere, instet potens inimicus et gravis, infesta turba nec inermis, creditor urgueat, accusator». 40. Vide, quam sis aequus: horum optares nihil, si tibi beneficium non dedisset. Ut alia taceam, quae graviora conmittis pessima pro optimis referendo, hoc certe delinquis, quod non expectas suum cuiusque rei tempus, quod aeque peccat, qui non sequitur, quam qui antecedit. Quomodo beneficium non semper recipiendum est, sic non utique reddendum. Si mihi non desideranti redderes, ingratus esses; quanto ingratior es, qui desiderare me cogis! Expecta! quare subsidere apud te munus meum non vis? Quare obligatum moleste ‹te› fers? Quare quasi cum acerbo feneratore signare rationem parem properas? Quid mihi negotium quaeris? Quid in me deos inmittis? Quomodo exigeres, qui sic reddis? 41. Ante omnia ergo, Liberalis, hoc discamus, beneficia debere secure et occasiones reddendorum observare, non manu facere. Ipsam hanc cupiditatem primo quoque tempore liberandi se meminerimus ingrati esse; nemo enim libenter reddit, quod invitus debet, et, quod apud se esse non vult, onus iudicat esse, non munus. Quanto melius ac iustius in promptu habere merita amicorum et offerre, non ingerere, nec obaeratum se iudicare, quoniam beneficium commune vinculum est et inter se duos adligat! Dic: «Nihil moror, quominus tuum revertatur; opto, hilaris accipias. Si necessitas alterutri nostrum inminet fatoque quodam datum est, ut aut tu cogaris beneficium recipere aut ego alterum accipere, det potius, qui solet. Ego paratus sum: nulla mora in Turno est; ostendam hunc animum, cum primum tempus advenerit; interim di testes sunt». 42. Soleo, mi Liberalis, notare hunc in te adfectum et quasi manu prendere verentis et aestuantis, ne in ullo officio sis tardior. Non decet gratum animum sollicitudo, contra summa fiducia sui et ex conscientia veri amoris dimissa omnis
anxietas. Tam convicium est: «Recipe» quam: «Debes». Hoc primum beneficii dati sit ius, ut recipiendi tempus eligat, qui dedit. «At vereor, ne homines de me sequius loquantur». Male agit, qui famae, non conscientiae gratus est. Duos istius rei iudices habes, illum, quem non debes timere, et te, quem non potes. «Quid ergo? Si nulla intervenerit occasio, semper debebo?». Debebis; sed palam debebis, sed libenter debebis, sed cum magna voluptate apud te depositum intueberis. Paenitet accepti beneficii, quem nondum redditi piget; quare, qui tibi dignus visus est, a quo acciperes, indignus videatur, cui diu debeas? 42. In magnis erroribus sunt, qui ingentis animi credunt proferre, donare, plurium sinum ac domum inplere, cum ista interdum non magnus animus faciat, sed magna fortuna; nesciunt, quanto interim maius ac difficilius sit capere, quam fundere. Nam, ut nihil alteri detraham, quoniam utrumque, ubi virtute fit, par est, non minoris est animi beneficium debere quam dare; eo quidem operosius hoc quam illud, quo maiore diligentia custodiuntur accepta, quam dantur. Itaque non est trepidandum, quam cito reponamus, nec procurrendum intempestive, quia aeque delinquit, qui ad referendam gratiam suo tempore cessat, quam qui alieno properat. Positum est illi apud me; nec illius nomine nec meo timeo. Bene illi cautum est; non potest hoc beneficium perdere nisi mecum, immo ne mecum quidem: egi illi gratias, id est, rettuli. Qui nimis de reddendo beneficio cogitat, nimis cogitare alterum de recipiendo putat. Praestet se in utrumque facilem: si vult recipere beneficium, referamus reddamusque laeti; si illud apud nos custodiri mavult, quid thensaurum eius eruimus? Quid custodiam recusamus? Dignus est, quoi, utrum volet, liceat. Opinionem quidem et famam eo loco habeamus, tamquam non ducere sed sequi debeat.
Liber septimus 1. Bonum, mi Liberalis, habeas animum volo: in manibus terrae; non hic te carmine longo atque per ambages et longa exorsa tenebo. Reliqua hic liber cogit, et exhausta materia circumspicio, non quid dicam, sed quid non dixerim; boni tamen consules, quidquid ibi superest, cum tibi superfuerit. Si voluissem lenocinari mihi, debuit paulatim opus crescere et ea pars in finem reservari, quam quilibet etiam satiatus adpeteret. Sed quidquid maxime necessarium erat, in primum congessi; nunc, si quid effugit, recolligo. Nec mehercules, si me interroges, nimis ad rem existimo pertinere, ubi dicta sunt, quae regunt mores, prosequi cetera non in remedium animi, sed in exercitationem ingenii inventa. Egregie enim hoc dicere Demetrius Cynicus, vir meo iudicio magnus, etiam si maximis conparetur, solet plus prodesse, si pauca praecepta sapientiae teneas, sed illa in promptu tibi et in usu sint, quam si multa quidem didiceris, sed illa non habeas ad manum. «Quemadmodum» inquit «magnus luctator est, non qui omnes numeros nexusque perdidicit, quorum usus sub adversario rarus est, sed qui in uno se aut altero bene ac diligenter exercuit et eorum occasiones intentus expectat (neque enim refert, quam multa sciat, si scit, quantum victoriae satis est), sic in hoc studio multa delectant, pauca vincunt. Licet nescias, quae ratio oceanum effundat ac revocet, quare septimus quisque annus aetati signum inprimat, quare latitudo porticus ex remoto spectantibus non servet portionem suam, sed ultima in angustius coeant et columnarum novissime intervalla iungantur, quid sit, quod geminorum conceptum separet, partum iungat, utrum unus concubitus spargatur in duos an totiens concepti sint, cur pariter natis fata diversa sint maximisque rerum spatiis distent, quorum inter ortus minimum interest: non multum tibi nocebit transisse, quae nec licet scire nec prodest. Involuta veritas in alto latet. Nec de malignitate naturae queri possumus, quia nullius rei difficilis inventio est, nisi cuius hic unus inventae fructus est, invenisse; quidquid nos meliores beatosque facturum est, aut in aperto aut in proximo posuit. Si animus fortuita contempsit, si se supra metus sustulit nec avida spe infinita conplectitur, sed didicit a se petere divitias; si deorum hominumque formidinem eiecit et scit non multum esse ab homine timendum, a deo nihil; si contemptor omnium, quibus torquetur vita, dum ornatur, eo perductus est, ut illi liqueat mortem nullius mali materiam esse, multorum finem; si animum virtuti consecravit et, quacumque vocat illa, planum putat; si sociale animal et in commune genitus mundum ut unam omnium domum spectat et conscientiam suam dis aperuit semperque tamquam in publico vivit se magis veritus quam alios: subductus ille tempestatibus in solido
ac sereno stetit consummavitque scientiam utilem ac necessariam. Reliqua oblectamenta otii sunt; licet enim iam in tutum retracto animo ad haec quoque excurrere cultum, non robur, ingeniis adferentia». 2. Haec Demetrius noster utraque manu tenere proficientem iubet, haec nusquam dimittere, immo adfigere et partem sui facere eoque cottidiana meditatione perduci, ut sua sponte occurrant salutaria et ubique ac statim desiderata praesto sint et sine ulla mora veniat illa turpis honestique distinctio. Sciat nec malum esse ullum nisi turpe nec bonum nisi honestum; hac regula vitae opera distribuat; ad hanc legem et agat cuncta et exigat miserrimosque mortalium iudicet, in quantiscumque opibus refulgebunt, ventri ac libidini deditos quorumque animus inerti otio torpet. Dicat sibi ipse: «Voluptas fragilis est, brevis, fastidio obiecta, quo avidius hausta est citius in contrarium recidens, cuius subinde necesse est aut paeniteat aut pudeat, in qua nihil est magnificum aut quod naturam hominis dis proximi deceat, res humilis, membrorum turpium aut vilium ministerio veniens, exitu foeda. Illa est voluptas et homine et viro digna non inplere corpus nec saginare nec cupiditates inritare, quarum tutissima est quies, sed perturbatione carere et ea, quam hominum inter se rixantium ambitus concutit, et ea, quae intolerabilis ex alto venit, ubi de dis famae creditum est vitiisque illos nostris aestimavimus». Hanc voluptatem aequalem, intrepidam, numquam sensuram sui taedium percipit hic, quem deformamus quom maxime, ut ita dicam, divini iuris atque humani peritus. Hic praesentibus gaudet, ex futuro non pendet; nihil enim firmi habet, qui in incerta propensus est. Magnis itaque curis exemptus et distorquentibus mentem nihil sperat aut cupit nec se mittit in dubium suo contentus. Et ne illum existimes parvo esse contentum, omnia illius sunt, non sic, quemadmodum Alexandri fuerunt, cui, quamquam in litore rubri maris steterat, plus deerat, quam qua venerat. Illius ne ea quidem erant, quae tenebat aut vicerat, cum in oceano Onesicritus praemissus explorator erraret et bella in ignoto mari quaereret. Non satis adparebat inopem esse, qui extra naturae terminos arma proferret, qui se in profundum inexploratum et inmensum aviditate caeca prosus inmitteret? Quid interest, quot eripuerit regna, quot dederit, quantum terrarum tributo premat? Tantum illi deest, quantum cupit. 3. Nec hoc Alexandri tantum vitium fuit, quem per Liberi Herculisque vestigia felix temeritas egit, sed omnium, quos fortuna inritavit inplendo. Cyrum et Cambysen et totum regni Persici stemma percense: quem invenies, cui modum imperii satietas fecerit, qui non vitam in aliqua ulterius procedendi cogitatione finierit? Nec id mirum est: quidquid cupiditati contingit, penitus hauritur et conditur, nec interest, quantum eo, quod inexplebile est, congeras. Unus est sapiens, cuius omnia sunt nec ex difficili tuenda; non habet mittendos trans maria legatos nec metanda in ripis hostilibus castra, non oportunis castellis disponenda praesidia; non opus est legione nec equestribus turmis.
Quemadmodum di inmortales regnum inermes regunt et illis rerum suarum ex edito tranquilloque tutela est, ita hic officia sua, quamvis latissime pateant, sine tumultu obit et omne humanum genus potentissimus eius optimusque infra se videt. Derideas licet: ingentis spiritus res est, cum Orientem Occidentemque lustraveris animo, quo etiam remota et solitudinibus interclusa penetrantur, cum tot animalia, tantam copiam rerum, quas natura beatissime fundit, adspexeris, emittere hanc dei vocem: «Haec omnia mea sunt!» Sic fit, ut nihil cupiat, quia nihil est extra omnia. 4. «Hoc ipsum» inquis «volui! teneo te! volo videre, quomodo ex his laqueis, in quos tua sponte decidisti, expliceris. Dic mihi: quemadmodum potest aliquis donare sapienti, si omnia sapientis sunt? Nam id quoque, quod illi donat, ipsius est. Itaque non potest beneficium dari sapienti, cui, quidquid datur, de suo datur; atqui dicitis sapienti posse donari. Idem autem me scito et de amicis interrogare: omnia dicitis illis esse communia; ergo nemo quicquam donare amico potest; donat enim illi communia». Nihil prohibet aliquid et sapientis esse ‹et› etiam eius, qui possidet, cui datum et adsignatum est. Iure civili omnia regis sunt, et tamen illa, quorum ad regem pertinet universa possessio, in singulos dominos discripta sunt, et unaquaeque res habet possessorem suum; itaque dare regi et domum et mancipium et pecuniam possumus nec donare illi de suo dicimur; ad regem enim potestas omnium pertinet, ad singulos proprietates. Fines Atheniensium aut Campanorum vocamus, quos deinde inter se vicini privata terminatione distinguunt; et totus ager utique ullius rei publicae est, pars deinde suo domino quaeque censetur; ideoque donare agros nostros rei publicae possumus, quamvis illius esse dicantur, quia aliter illius sunt, aliter mei. Numquid dubium est, quin servus cum peculio domini sit? Dat tamen domino suo munus. Non enim ideo nihil habet servus, quia non est habiturus, si dominus illum habere noluerit; nec ideo non est munus, cum volens dedit, quia potuit eripi, etiam si noluisset. Quemadmodum probemus hoc, mittam, nunc enim omnia sapientis esse inter duos convenit; illud, quod quaeritur, colligendum est, quomodo liberalitatis materia adversus eum supersit, cuius universa esse concessimus. Omnia patris sunt, quae in liberorum manu sunt; quis tamen nescit donare aliquid et filium patri? Omnia deorum sunt; tamen et dis donum posuimus et stipem iecimus. Non ideo, quod habeo, meum non est, si meum tuum est; potest enim idem meum esse et tuum. «Is» inquit, «cuius prostitutae sunt, leno est; omnia autem sapientis sunt; inter omnia et prostitutae sunt; ergo prostitutae sapientis sunt. Leno autem est, cuius prostitutae sunt; ergo sapiens leno est». Sic illum vetant emere, dicunt enim: «Nemo rem suam emit; omnia autem sapientis sunt; ergo sapiens nihil emit». Sic vetant mutuum sumere, quia nemo usuram pro pecunia sua pendat. Innumerabilia sunt, per quae cavillantur, cum pulcherrime, quid a nobis dicatur, intellegant.
5. Etenim sic omnia sapientis esse dico, ut nihilo minus proprium quisque in rebus suis dominium habeat, quemadmodum sub optimo rege omnia rex imperio possidet, singuli dominio. Tempus istius probandae rei veniet; interim hoc huic quaestioni sat est me id, quod aliter sapientis est, aliter meum est, posse donare sapienti. Nec mirum est aliquid ei, cuius est totum, posse donari. Conduxi domum a te; in hac aliquid tuum est, aliquid meum: res tua est, usus rei tuae meus est. Itaque nec fructus tanges colono tuo prohibente, quamvis in tua possessione nascantur, et, si annona carior fuerit aut fames, heu! frustra magnum alterius spectabis acervum in tuo natum, in tuo positum, in horrea iturum tua. Nec conductum meum, quamquam sis dominus, intrabis nec servum tuum, mercennarium meum, abduces et, cum a te raedam conduxero, beneficium accipies, si tibi in vehiculo tuo sedere permisero. Vides ergo posse fieri, ut aliquis accipiendo, quod suum est, munus accipiat. 6. In omnibus istis, quae modo rettuli, uterque eiusdem rei dominus est. Quo modo? Quia alter rei dominus est, alter usus. Libros dicimus esse Ciceronis; eosdem Dorus librarius suos vocat, et utrumque verum est: alter illos tamquam auctor sibi, alter tamquam emptor adserit; ac recte utriusque dicuntur esse, utriusque enim sunt, sed non eodem modo. Sic potest Titus Livius a Doro accipere aut emere libros suos. Possum donare sapienti, quod viritim meum est, licet illius sint omnia; nam cum regio more cuncta conscientia possideat, singularum autem rerum in unumquemque proprietas sit sparsa, et accipere munus et debere et emere et conducere potest. Caesar omnia habet, fiscus eius privata tantum ac sua; et universa in imperio eius sunt, in patrimonio propria. Quid eius sit, quid non sit, sine diminutione imperii quaeritur; nam id quoque, quod tamquam alienum abiudicatur, aliter illius est. Sic sapiens animo universa possidet, iure ac dominio sua. 7. Bion modo omnes sacrilegos esse argumentis colligit, modo neminem. Cum omnes de saxo deiecturus est, dicit: «Quisquis id, quod deorum est, sustulit et consumpsit atque in usum suum vertit, sacrilegus est; omnia autem deorum sunt; quod quisque ergo tollit, deorum tollit, quorum omnia sunt; ergo, quisquis tollit aliquid, sacrilegus est». Deinde, cum effringi templa et expilari inpune Capitolium iubet, dicit nullum sacrilegum esse, quia, quidquid sublatum est, ex eo loco, qui deorum erat, in eum transfertur locum, qui deorum est. Hic respondetur omnia quidem deorum esse, sed non omnia dis dedicata; in iis observari sacrilegium, quae religio numini adscripsit. Sic et totum mundum deorum esse inmortalium templum, solum quidem amplitudine illorum ac magnificentia dignum: tamen a sacris profana discerni; non omnia licere in angulo, cui fani nomen inpositum est, quae sub caelo et conspectu siderum licent. Iniuriam sacrilegus deo quidem non potest facere, quem extra ictum sua divinitas posuit, sed punitur, quia tamquam deo fecit: opinio illum nostra ac sua obligat
poenae. Quomodo ergo sacrilegus videtur, qui aliquid aufert sacri, etiam si, quocumque transtulit, quod subripuerat, intra terminos mundi est, sic et sapienti furtum potest fieri; auferetur enim illi non ex iis, quae universa habet, sed ex iis, quibus dominus inscriptus est, quae viritim ei serviunt. Illam alteram possessionem adgnoscet, hanc nolet habere, si poterit, emittetque illam vocem, quam Romanus imperator emisit, cum illi ob virtutem et bene gestam rem publicam tantum agri decerneretur, quantum arando uno die circumire potuisset: «Non opus est» inquit «vobis eo cive, cui plus opus sit quam uni civi». Quanto maioris viri putas respuisse hoc munus, quam meruisse! multi enim fines aliis abstulerunt, sibi nemo constituit. 8. Ergo cum animum sapientis intuemur potentem omnium et per universa dimissum, omnia illius esse dicimus, cum ad hoc ius cottidianum, si ita res tulerit, capite censebitur. Multum interest, possessio eius animo ac magnitudine aestimetur an censu. Haec universa habere, de quibus loqueris, abominabitur. Non referam tibi Socraten, Chrysippum, Zenonem et ceteros magnos quidem viros, maiores quidem, quia in laudem vetustorum invidia non obstat. Paulo ante Demetrium rettuli, quem mihi videtur rerum natura nostris tulisse temporibus, ut ostenderet nec illum a nobis corrumpi nec nos ab ullo corrigi posse, virum exactae, licet neget ipse, sapientiae firmaeque in iis, quae proposuit, constantiae, eloquentiae vero eius, quae res fortissimas deceat, non concinnatae nec in verba sollicitae, sed ingenti animo, prout inpetus tulit, res suas prosequentis. Huic non dubito quin providentia et talem vitam et talem dicendi facultatem dederit, ne aut exemplum saeculo nostro aut convicium deesset. Demetrio si res nostras aliquis deorum possidendas velit tradere sub lege certa, ne liceat donare, adfirmaverim repudiaturum dicturumque: 9. «Ego vero me ad istud inextricabile pondus non adligo nec in altam faecem rerum hunc expeditum hominem demitto. Quid ad me defers populorum omnium mala? Quae ne daturus quidem acciperem, quoniam multa video, quae me donare non deceat. Volo sub conspectu meo ponere, quae gentium oculos regumque praestringunt, volo intueri pretia sanguinis animarumque vestrarum. Prima mihi luxuriae spolia propone, sive illa vis per ordinem expandere sive, ut est melius, in unum acervum dare. Video elaboratam scrupulosa distinctione testudinem et foedissimorum pigerrimorumque animalium testas ingentibus pretiis emptas, in quibus ipsa illa, quae placet, varietas subditis medicamentis in similitudinem veri coloratur. Video istic mensas et aestimatum lignum senatorio censu, eo pretiosius, quo illud in plures nodos arboris infelicitas torsit. Video istic crystallina, quorum accendit fragilitas pretium; omnium enim rerum voluptas apud inperitos ipso, quo fugari debet, periculo crescit. Video murrea pocula; parum scilicet luxuria magno fuerit, nisi, quod vomant, capacibus gemmis inter se propinaverint. Video uniones non singulos singulis auribus conparatos; iam enim exercitatae aures oneri ferundo sunt; iunguntur inter se et insuper alii binis superponuntur; non satis muliebris insania viros superiecerat, nisi bina ac terna patrimonia auribus singulis pependissent.
Video sericas vestes, si vestes vocandae sunt, in quibus nihil est, quo defendi aut corpus aut denique pudor possit, quibus sumptis parum liquido nudam se non esse iurabit; hae ingenti summa ab ignotis etiam ad commercium gentibus accersuntur, ut matronae nostrae ne adulteris quidem plus sui in cubiculo, quam in publico ostendant. 10. Quid agis, avaritia? Quot rerum caritate aurum tuum victum est! omnia ista, quae rettuli, in maiore honore pretioque sunt. Nunc volo tuas opes recognoscere, lamnas utriusque materiae, ad quam cupiditas nostra caligat. At mehercules terra, quae, quidquid utile futurum nobis erat, protulit, ista defodit et mersit et ut noxiosis rebus ac malo gentium in medium prodituris toto pondere incubuit. Video ferrum ex isdem tenebris esse prolatum, quibus aurum et argentum, ne aut instrumentum in caedes mutuas deesset aut pretium. Et tamen adhuc ista aliquam materiam habent; est, in quo errorem animorum oculus subsequi possit. Video istic diplomata et syngraphas et cautiones, vacua habendi simulacra, umbracula avaritiae quaedam laborantis, per quae decipiat animum inanium opinione gaudentem; quid enim ista sunt, quid fenus et calendarium et usura, nisi humanae cupiditatis extra naturam quaesita nomina? Possum de rerum natura queri, quod aurum argentumque non interius absconderit, quod non illis maius, quam quod detrahi posset, pondus iniecerit: quid sunt istae tabellae, quid conputationes et venale tempus et sanguinulentae centesimae? Voluntaria mala ex constitutione nostra pendentia, in quibus nihil est, quod subici oculis, quod teneri manu possit, inanis avaritiae somnia. O miserum, si quem delectat patrimonii sui liber magnus et vasta spatia terrarum colenda per vinctos et inmensi greges pecorum per provincias ac regna pascendi et familia bellicosis nationibus maior et aedificia privata laxitatem urbium magnarum vincentia! Cum bene ista, per quae divitias suas disposuit ac fudit, circumspexerit superbumque se fecerit, quidquid habet, ei, quod cupit, conparet: pauper est. Dimitte me et illis divitiis meis redde; ego regnum sapientiae novi, magnum, securum; ego sic omnia habeo, ut omnium sint». 11. Itaque cum C. Caesar illi ducenta donaret, ridens reiecit ne dignam quidem summam iudicans, qua non accepta gloriaretur. Di deaeque, quam pusillo animo illum aut honorare voluit aut corrumpere! Reddendum egregio viro testimonium est; ingentem rem ab illo dici audivi, cum miraretur Gai dementiam, quod se putasset tanti posse mutari: «Si temptare» inquit «me constituerat, toto illi fui experiendus imperio». 12. Sapienti ergo donari aliquid potest, etiam si sapientis omnia sunt. Aeque nihil prohibet, cum omnia amicis dicamus esse communia, aliquid amico donari; non enim mihi sic cum amico communia omnia sunt, quomodo cum socio, ut pars mea sit, pars illius, sed quomodo patri matrique communes liberi sunt, quibus cum duo sunt, non singuli singulos habent, sed singuli binos. Primum omnium iam
efficiam, ut, quisquis est iste, qui me in societatem vocat, sciat se nihil mecum habere commune: quare? Quia hoc inter sapientes solum consortium est, inter quos amicitia est; ceteri non magis amici sunt quam socii. Deinde pluribus modis communia sunt. Equestria omnium equitum Romanorum sunt; in illis tamen meus fit proprius locus, quem occupavi; hoc si cui cessi, quamvis illi communi re cesserim, tamen aliquid dedisse videor. Quaedam quorundam sub certa condicione sunt. Habeo in equestribus locum, non ut vendam, non ut locem, non ut habitem, in hoc tantum, ut spectem; propterea non mentior, si dico habere me in equestribus locum. Sed cum in theatrum veni, si plena sunt equestria, et iure habeo locum illic, quia sedere mihi licet, et non habeo, quia ab his, cum quibus mihi ius loci commune est, occupatus est. Idem inter amicos puta fieri: quidquid habet amicus, commune est nobis, sed illius proprium est, qui tenet; uti iis illo nolente non possum. «Derides me» inquis; «si, quod amici est, meum est, liceat mihi vendere». Non licet; nam nec equestria, et tamen communia tibi cum ceteris equitibus sunt. Non est argumentum ideo aliquid tuum non esse, quia vendere non potes, quia consumere, quia mutare in deterius aut melius; tuum enim est etiam, quod sub lege certa tuum est. 13. […] accepi, sed certe non minus. Ne traham longius, beneficium maius esse non potest; ea, per quae beneficium datur, possunt esse maiora et plura, in quae se denique benevolentia effundat et sic sibi indulgeat, quemadmodum amantes solent, quorum plura oscula et conplexus artiores non augent amorem, sed exercent. 14. Haec quoque, quae venit, quaestio profligata est in prioribus; itaque breviter perstringetur; possunt enim in hanc, quae aliis data sunt, argumenta transferri. Quaeritur, an, qui omnia fecit, ut beneficium redderet, reddiderit. «Ut scias» inquit «illum non reddidisse, omnia fecit, ut redderet; adparet ergo non esse id factum, cuius faciendi occasionem non habuit. Et creditori suo pecuniam non solvit is, qui, ut solveret, ubique quaesivit nec invenit». Quaedam eius condicionis sunt, ut effectum praestare debeant; quibusdam pro effectu est omnia temptasse, ut efficerent. Si omnia fecit, ut sanaret, peregit partes suas medicus; etiam damnato reo oratori constat eloquentiae officium, si omni vi usus est; laus imperatoria etiam victo duci redditur, si et prudentia et industria et fortitudo muneribus suis functa est. Omnia fecit, ut beneficium redderet, obstitit illi felicitas tua; nihil incidit durius, quod veram amicitiam experiretur; locupleti donare non potuit, sano adsidere, felici succurrere: gratiam rettulit etiam si tu beneficium non recepisti. Praeterea huic intentus semper et huius rei tempus opperiens, qui in hoc multum curae, multum sedulitatis inpendit, plus laboravit, quam cui cito referre gratiam contigit. Debitoris exemplum dissimile est, cui parum est pecuniam quaesisse, nisi solvit; illic enim stat acerbus super caput creditor, qui nullum diem gratis occidere patiatur; hic benignissimus, qui, te cum viderit concursantem et sollicitum atque anxium, dicat: «Mitte hanc de pectore
curam; desine tibi molestus instare. Omnia a te habeo; iniuriam mihi facis, si me quicquam desiderare amplius iudicas; plenissime ad me pervenit animus tuus». «Dic» inquit «mihi: si reddidisset beneficium, diceres illum gratiam rettulisse; eodem ergo loco est, qui reddidit et qui non reddidit?» Contra nunc illud pone: si oblitus esset accepti beneficii, si ne temptasset quidem gratus esse, negares illum gratiam rettulisse; at hic se diebus noctibusque lassavit et omnibus aliis renuntiavit officiis huic uni inminens et operatus, ne qua se fugeret occasio; eodem ergo loco erunt ille, qui curam referendae gratiae abiecit, et hic, qui numquam ab illa recessit? Iniquus es, si rem a me exigis, cum videas animum non defuisse. 15. Ad summam puta, cum captus esses, me pecuniam mutuatum rebus meis in securitatem creditoris obpositis navigasse hieme tam saeva per infesta latrociniis litora, emensum, quidquid periculorum adferre potest etiam pacatum mare; peragratis omnibus solitudinibus, cum, quos nemo non fugiebat, ego quaererem, tandem ad piratas perveni; iam te alius redemerat: negabis me gratiam rettulisse? Etiamne, si in illa navigatione pecuniam, quam saluti tuae contraxeram, naufragus perdidi, etiamne, si in vincula, quae detrahere tibi volui, ipse incidi, negabis me rettulisse gratiam? At mehercules Athenienses Harmodium et Aristogitonem tyrannicidas vocant, et Mucio manus in hostili ara relicta instar occisi Porsinae fuit, et semper contra fortunam luctata virtus etiam citra effectum propositi operis enituit. Plus praestitit, qui fugientes occasiones secutus est et alia atque alia captavit, per quae referre gratiam posset, quam quem sine ullo sudore gratum prima fecit occasio. «Duas» inquit «res ille tibi praestitit, voluntatem et rem; tu quoque illi duas debes». Merito istud diceres ei, qui tibi reddidit voluntatem otiosam, huic vero, qui et vult et conatur et nihil intemptatum relinquit, id non potes dicere; utrumque enim praestat, quantum in se est. Deinde non semper numero numerus aequandus est, aliquando una res pro duabus valet; itaque in locum rei succedit tam propensa voluntas et cupida reddendi. Quod si animus sine re ad referendam gratiam non valet, nemo adversus deos gratus est, in quos voluntas sola confertur. «Dis» inquit «nihil aliud praestare possumus». Sed si huic quoque, cui referre gratiam debeo, nihil aliud praestare possum, quid est, quare non eo adversus hominem gratus sim, quo nihil amplius in deos confero? 16. Si tamen quaeris, quid sentiam, et vis signare responsum, hic beneficium recepisse se iudicet, ille se sciat non reddidisse; hic illum dimittat, ille se teneat; hic dicat: «habeo», ille respondeat: «debeo». In omni quaestione propositum sit nobis bonum publicum; praecludendae sunt excusationes ingratis, ad quas refugere non possint et sub quibus infitiationem suam tegere. «Omnia feci». Fac etiamnunc. Quid? Tu tam inprudentes iudicas maiores nostros fuisse, ut non intellegerent iniquissimum esse eodem loco haberi eum, qui pecuniam, quam a creditore acceperat, libidine aut alea absumpsit, et eum, qui incendio aut latrocinio aut aliquo casu tristiore aliena cum suis perdidit? Nullam
excusationem receperunt, ut homines scirent fidem utique praestandam; satius enim erat a paucis etiam iustam excusationem non accipi quam ab omnibus aliquam temptari. Omnia fecisti, ut redderes; hoc illi satis sit, tibi parum. Nam quemadmodum ille, si enixam et sedulam operam transire pro inrita patitur, cui gratia referatur, indignus est, ita tu ingratus es, nisi ei, qui voluntatem bonam in solutum accipit, eo libentius debes, quia dimitteris. Non rapias hoc nec testeris; occasiones reddendi nihilo minus quaeras. Redde illi, quia repetit, huic, quia remittit; huic, quia malus est, illi quia non malus. Ideoque hanc quaestionem non est quod ad te iudices pertinere, an, quod beneficium quis a sapiente accepit, reddere debeat, si ille desiit esse sapiens et in malum versus est. Redderes enim et depositum, quod a sapiente accepisses, etiam malo, redderes creditum: quid est, cur non et beneficium? Quia mutatus est, ille te mutet? Quid? Si quid a sano accepisses, aegro non redderes, cum plus semper inbecillo amico debeamus? Et hic aeger est animo: adiuvetur, feratur; stultitia morbus est animi. 17. Distinguendum hoc, quo magis intellegatur, existimo. Duo sunt beneficia: unum, quod dare nisi sapiens sapienti non potest; hoc est absolutum et verum beneficium; alterum volgare, plebeium, cuius inter nos inperitos commercium est. De hoc non est dubium, quin illi, qualiscumque est, debeam reddere, sive homicida sive fur sive adulter evasit. Habent scelera leges suas; melius istos iudex quam ingratus emendat; nemo te malum, quia est, faciat. Malo beneficium proiciam, bono reddam, huic, quia debeo, illi, ne debeam. 18. De altero beneficii genere dubitatur, quod si accipere non potui nisi sapiens, ne reddere quidem nisi sapienti possum. «Puta enim me reddere: ille non potest recipere, non est iam huius rei capax, scientiam utendi perdidit. Quid, si me remittere manco pilam iubeas? Stultum est dare alicui, quod accipere non possit». Ut respondere ab ultimo incipiam: non dabo ulli, quod accipere non poterit; reddam, etiam si recipere non poterit. Obligare enim non possum nisi accipientem; liberari tantum, si reddidi, possum. Ille uti illo non poterit? Viderit; penes illum erit culpa, non penes me. «Reddere est» inquit «accepturo tradidisse. Quid enim? Si cui vinum debeas et hoc ille te infundere reticulo iubeat aut cribro, reddidisse te dices? Aut reddere voles, quod, dum redditur, inter duos pereat?». 19. Reddere est id, quod debeas, ei, cuius est, volenti dare. Hoc unum mihi praestandum est; ut quidem habeat, quod a me accepit, iam ulterioris est curae; non tutelam illi, sed fidem debeo, multoque satius est illum non habere, quam me non reddere. Et creditori statim in macellum laturo, quod acceperit, reddam; etiam, si mihi adulteram, cui numerem, delegaverit, solvam; et, si nummos, quos accipiet, in sinum suum discinctus infundet, dabo. Reddendum enim mihi est, non servandum, cum reddidero, ac tuendum; beneficii accepti, non redditi, custodiam debeo. Dum apud me est, salvum sit; ceterum, licet accipientis manibus effluat,
dandum est reposcenti. Reddam bono, cum expediet, malo, cum petet. «Tale» inquit «illi beneficium, quale accepisti, non potes reddere; accepisti enim a sapiente, stulto reddis». Non; reddo illi, quale nunc potest recipere, nec per me fit, quod deterius id, quod accepi, reddam, sed per illum, cui, si ad sapientiam redierit, reddam, quale donavit, dum in malis est, reddam, quale ab illo potest accipi. «Quid? Si» inquit «non tantum malus factus est, sed ferus, sed inmanis, qualis Apollodorus aut Phalaris, et huic beneficium, quod acceperas, reddes?». Mutationem sapientis tantam natura non patitur. Non in pessima ab optimis lapsus necesse est etiam in malo vestigia boni teneat; numquam tantum virtus extinguitur, ut non certiores animo notas inprimat, quam ut illas eradat ulla mutatio. Ferae inter nos educatae si in silvas eruperunt, aliquid mansuetudinis pristinae retinent tantumque a placidissimis absunt, quantum a veris feris et numquam humanam manum passis. Nemo in summam nequitiam incidit, qui umquam haesit sapientiae; altius infectus est, quam ut ex toto elui et transire in colorem malum possit. Deinde interrogo, utrum iste ferus sit animo tantum, an et in perniciem publicam excurrat? Proposuisti enim mihi Phalarim et ‹alterum› tyrannum, quorum si naturam habet intra se malus, quidni ego isti beneficium suum reddam, ne quid mihi cum illo iuris sit amplius? Si vero sanguine humano non tantum gaudet, sed pascitur, sed et suppliciis omnium aetatium crudelitatem insatiabilem exercet nec ira sed aviditate quadam saeviendi furit, si in ore parentium liberos iugulat, si non contentus simplici morte distorquet nec urit solum perituros, sed excoquit, si arx eius cruore semper recenti madet, parum est huic beneficium non reddere. Quidquid erat, quo mihi cohaereret, intercisa iuris humani societas abscidit. Si praestitisset quidem aliquid mihi, sed arma patriae meae inferret, quidquid meruerat, perdidisset, et referre illi gratiam scelus haberetur; si non patriam meam inpugnat, sed suae gravis est et sepositus a mea gente suam exagitat, abscindit, nihilo minus illum tanta pravitas animi, etiam si non inimicum, invisum mihi efficit, priorque mihi ac potior eius officii ratio est, quod humano generi, quam quod uni homini debeo. 20. Sed quamvis hoc ita sit et ex eo tempore omnia mihi in illum libera sint, ex quo corrumpendo fas omne, ut nihil in eum nefas esset, effecerit, illum mihi servandum modum credam, ut, si beneficium illi meum neque vires maiores daturum est in exitium commune nec confirmaturum, quas habet, id autem erit, quod illi reddi sine pernicie publica possit, reddam. Servabo filium eius infantem; quid hoc beneficium obest cuiquam eorum, quos crudelitas eius lacerat? Pecuniam, quae satellitem stipendio teneat, non subministrabo. Si marmora et vestes desideraverit, nihil oberit cuiquam id, quo luxuria eius instruitur; militem et arma non suggeram. Si pro magno petet munere artifices scenae et scorta et quae feritatem eius emolliant, libens offeram. Cui triremes et aeratas non mitterem, lusorias et cubiculatas et alia ludibria regum in mari lascivientium mittam. Et si ex toto desperata eius sanitas fuerit, eadem manu beneficium omnibus dabo, illi reddam; quoniam ingeniis talibus exitus remedium
est optimumque est abire ei, qui ad se numquam rediturus est. Sed haec rara nequitia est semper portenti loco habita, sicut hiatus terrae et e cavernis maris ignium eruptio; itaque ab illa recedamus, de iis loquamur vitiis, quae detestamur sine horrore. Huic homini malo, quem invenire in quolibet foro possum, quem singuli timent, reddam beneficium, quod accepi. Non oportet mihi nequitiam eius prodesse; quod meum non est, redeat ad dominum. Bonus sit an malus, quid ‹differt›? Diligenter istud excuterem, si non redderem, sed darem. 21. Hic locus fabulam poscit. Pythagoricus quidam emerat a sutore phaecasia, rem magnam, non praesentibus nummis. Post aliquot dies venit ad tabernam redditurus et, cum clusam diu pulsaret, fuit, qui diceret: «Quid perdis operam? Sutor ille, quem quaeris, elatus, conbustus est; quod nobis fortasse molestum est, qui in aeternum nostros amittimus, tibi minime, qui scis futurum, ut renascatur», iocatus in Pythagoricum. At philosophus noster tres aut quattuor denarios non invita manu domum rettulit subinde concutiens; deinde, cum reprehendisset hanc suam non reddendi tacitam voluptatem, intellegens adrisisse illud lucellum sibi redit ad eandem tabernam et ait: «Ille tibi vivit; redde, quod debes». Deinde per clostrum, qua se conmissura laxaverat, quattuor denarios in tabernam inseruit ac misit poenas a se exigens inprobae cupiditatis, ne alieno adsuesceret. 22. Quod debes, quaere, cui reddas, et, si nemo poscet, ipse te adpella; malus an bonus sit, ad te non pertinet; redde et accusa. Oblitus es, quemadmodum inter vos officia divisa sint: illi oblivio imperata est, tibi meminisse mandavimus. Errat tamen, si quis existimat, cum dicimus eum, qui beneficium dedit, oblivisci oportere, excutere nos illi memoriam rei praesertim honestissimae; quaedam praecipimus ultra modum, ut ad verum et suum redeant. Cum dicimus: «meminisse non debet», hoc volumus intellegi: «praedicare non debet nec iactare nec gravis esse». Quidam enim beneficium, quod dederunt, omnibus circulis narrant; hoc sobrii locuntur, hoc ebrii non continent, hoc ignotis ingerunt, hoc amicis conmittunt; ut haec nimia et exprobratrix memoria subsideret, oblivisci eum, qui dedit, iussimus et plus imperando, quam praestari poterat, silentium suasimus. 23. Quotiens parum fiduciae est in iis, quibus imperes, amplius exigendum est, quam sat est, ut praestetur, quantum sat est. In hoc omnis hyperbole extenditur, ut ad verum mendacio veniat. Itaque ille, cum dixit: «Qui candore nives anteirent, cursibus auras», quod non poterat fieri, dixit, ut crederetur, quantum plurimum posset. Et qui dixit: «His inmobilior scopulis, violentior amne», ne hoc quidem se persuasurum putavit aliquem tam inmobilem esse quam scopulum. Numquam tantum sperat hyperbole, quantum audet, sed incredibilia adfirmat, ut ad credibilia perveniat. Cum dicimus: «Qui beneficium dedit, obliviscatur», hoc dicimus: «similis sit oblito; memoria eius non adpareat nec
incurrat». Cum dicimus beneficium repeti non oportere, non ex toto repetitionem tollimus; saepe enim opus est malis exactore, etiam bonis admonitione. Quid ergo? Occasionem ignoranti non ostendam? Necessitates illi meas non detegam? Quare nescisse se aut mentiatur aut doleat? Interveniat aliquando admonitio, sed verecunda, quae non poscat nec in ius vocet. 24. Socrates amicis audientibus: «Emissem» inquit «pallium, si nummos haberem». Neminem poposcit, omnes admonuit. A quo acciperet, ambitus fuit; quidni esset? Quantulum enim erat, quod Socrates accipiebat? At multum erat eum fuisse, a quo Socrates acciperet. Num illos castigare mollius potuit? «Emissem» inquit «pallium, si nummos haberem». Post hoc quisquis properaverit, sero dat; iam Socrati defuit. Propter acerbos exactores repetere prohibemus, non, ut numquam fiat, sed ut parce. 25. Aristippus aliquando delectatus unguento: «Male» inquit «istis effeminatis eveniat, qui rem tam bellam infamaverunt». Item dicendum est: «Male istis inprobis et inportunis beneficiorum suorum quadriplatoribus eveniat, qui tam bellam rem, admonitionem inter amicos, sustulerunt». Ego tamen utar hoc iure amicitiae et beneficium ab eo repetam, a quo petissem, qui alterius beneficii loco accepturus est potuisse reddere. Numquam ne querens quidem dicam: Eiectum litore, egentem excepi et regni demens in parte locavi. Non est ista admonitio, convicium est; hoc est in odium beneficia perducere, hoc est efficere, ut ingratum esse aut liceat aut iuvet. Satis abundeque est submissis et familiaribus verbis memoriam revocare: Si bene quid de te merui, fuit aut tibi quicquam dulce meum. Ille in vicem dicat: «Quidni merueris? Eiectum litore, egentem excepisti». 26. «Sed nihil» inquit «proficimus; dissimulat, oblitus est: quid facere debeam?» Quaeris rem maxime necessariam et in qua hanc materiam consummari decet, quemadmodum ingrati ferendi sint. Placido animo, mansueto, magno. Numquam te tam inhumanus et inmemor et ingratus offendat, ut non tamen dedisse delectet; numquam in has voces iniuria inpellat: «Vellem, non fecissem». Beneficii tui tibi etiam infelicitas placeat; semper illum paenitebit, si te ne nunc quidem paenitet. Non est, quod indigneris, tamquam aliquid novi acciderit; magis mirari deberes, si non accidisset. Alium labor, alium inpensa deterret, alium periculum, alium turpis verecundia, ne, dum reddit, fateatur accepisse, alium
ignorantia officii, alium pigritia, alium occupatio. Adspice, quemadmodum inmensae hominum cupiditates hient semper et poscant; non miraberis ibi neminem reddere, ubi nemo satis accipit. Quis est istorum tam firmae mentis ac solidae, ut tuto apud eum beneficia deponas? Alius libidine insanit, alius abdomini servit; alius lucri totus est, cuius summam, non vias, spectat; alius invidia laborat, alius caeca ambitione et in gladios inruente. Adice torporem mentis ac senium et contraria huic inquieti pectoris agitationem tumultusque perpetuos; adice aestimationem sui nimiam et tumorem, ob quae contemnendus est, insolentem. Quid contumaciam ‹dicam› in perversa nitentium, quid levitatem semper aliquo transilientem? Hoc accedat temeritas praeceps et numquam fidele consilium daturus timor et mille errores, quibus volvimur: audacia timidissimorum, discordia familiarissimorum et, publicum malum, incertissimis fidere, fastidire possessa, quae consequi posse spes non fuit. Inter adfectus inquietissimos rem quietissimam, fidem, quaeris? 27. Si tibi vitae nostrae vera imago succurret, ‹videre› videberis tibi captae cum maxime civitatis faciem, in qua omisso pudoris rectique respectu vires in concilio sunt velut signo ad permiscenda omnia dato. Non igni, non ferro abstinetur; soluta legibus scelera sunt; ne religio quidem, quae inter arma hostilia supplices texit, ullum inpedimentum est ruentium in praedam. Hic ex privato, hic ex publico, hic ex profano, hic ex sacro rapit; hic effringit, hic transilit; hic non contentus angusto itinere ipsa, quibus arcetur, evertit et in lucrum ruina venit; hic sine caede populatur, hic spolia cruenta manu gestat; nemo non fert aliquid ex altero. In hac aviditate generis humani o ne tu nimis fortunae communis oblitus es, qui quaeris inter rapientes referentem! Si indignaris ingratos esse, indignare luxuriosos, indignare avaros, indignare inpudicos, indignare aegros deformes, senes pallidos. Est istuc grave vitium, est intolerabile et quod dissociet homines, quod concordiam, qua inbecillitas nostra fulcitur, scindat ac dissupet, sed usque eo volgare est, ut illud ne qui queritur quidem effugerit. 28. Cogita tecum, an, quibuscumque debuisti, gratiam rettuleris, an nullum umquam apud te perierit officium, an omnium te beneficiorum memoria comitetur. Videbis, quae puero data sunt, ante adulescentiam elapsa, quae in iuvenem conlata sunt, non perdurasse in senectutem. Quaedam perdidimus, quaedam proiecimus, quaedam e conspectu nostro paulatim exierunt, a quibusdam oculos avertimus. Ut excusem tibi inbecillitatem, inprimis vas fragile est memoria et rerum turbae non sufficit; necesse est, quantum recipit, emittat et antiquissima recentissimis obruat. Sic factum est, ut minima apud te nutricis esset auctoritas, quia beneficium eius longius aetas sequens posuit; sic factum est, ut praeceptoris tibi non esset ulla veneratio; sic evenit, ut circa consularia occupato comitia aut sacerdotiorum candidato quaesturae suffragator excideret. Fortasse vitium, de quo quereris, si te diligenter excusseris, in sinu invenies. Inique publico crimini
irasceris, stulte tuo: ut absolvaris, ignosce. Meliorem illum facies ferendo, utique peiorem exprobrando. Non est, quod frontem eius indures; sine, si quid est pudoris residui, servet. Saepe dubiam verecundiam vox conviciantis clarior rupit. Nemo id esse, quod iam videtur, timet; deprenso pudor demitur. 29. «Perdidi beneficium». Numquid, quae consecravimus, perdidisse nos dicimus? Inter consecrata beneficium est, etiam si male respondit, bene conlatum. Non est ille, qualem speravimus; simus nos, quales fuimus, ei dissimiles. Damnum non tunc factum: adparuit; ingratus non sine nostro pudore protrahitur, quoniam quidem querella amissi beneficii ‹non› bene dati signum est. Quantum possumus, causam eius apud nos agamus: «Fortasse non potuit, fortasse ignoravit, fortasse facturus est». Quaedam nomina bona lentus et sapiens creditor fecit, qui sustinuit ac mora fovit. Idem nobis faciundum est; nutriamus fidem languidam. 30. «Perdidi beneficium». Stulte non nosti detrimenti tui tempora; perdidisti, sed cum dares; nunc palam factum est. Etiam in his, quae videntur in perdito, moderatio plurimum profuit; ut corporum ita animorum molliter vitia tractanda sunt. Saepe, quod explicari pertinacia ‹potuit, violentia› trahentis abruptum est. Quid opus est maledictis? Quid querellis? Quid insectatione? Quare illum liberas? Quare dimittis? Si ingratus est, iam nihil debet. Quae ratio est exacerbare eum, in quem magna contuleris, ut ex amico dubio fiat non dubius inimicus et patrocinium sibi nostra infamia quaerat, nec dicere: «Nescio quid est, quod eum, cui tantum debuit, ferre non potuit; subest aliquid»? Nemo non superioris dignitatem querendo, etiam si non inquinavit, adspersit: nec quisquam fingere contentus est levia, cum magnitudine mendacii fidem quaerat. 31. Quanto illa melior via, qua servatur illi species amicitiae et, si reverti ad sanitatem velit, etiam amicitia! Vincit malos pertinax bonitas, nec quisquam tam duri infestique adversus diligenda animi est, ut etiam ‹in› iniuria bonos non amet, quibus hoc quoque coepit debere, quod inpune non solvit. Ad illa itaque cogitationes tuas flecte: «Non est relata mihi gratia; quid faciam? Quod di, omnium rerum optimi auctores, qui beneficia ignoranti dare incipiunt, ingratis perseverant. Alius illis obicit neglegentiam nostri, alius iniquitatem; alius illos extra mundum suum proicit et ignavos hebetesque sine luce, sine ullo opere destituit; alius solem, cui debemus, quod inter laborem quietemque tempus divisimus, quod non tenebris mersi confusionem aeternae noctis effugimus, qui annum cursu suo temperat et corpora alit, sata evocat, percoquit fructus, saxum aliquod aut fortuitorum ignium globum et quidvis potius quam deum adpellat. Nihilo minus tamen more optimorum parentium, qui maledictis suorum infantium adrident, non cessant di beneficia congerere de beneficiorum auctore dubitantibus, sed aequali tenore bona sua per gentes populosque distribuunt; unam potentiam, prodesse, sortiti spargunt oportunis imbribus terras, maria flatu movent, siderum cursu notant tempora, hiemes aestatesque interventu lenioris
spiritus molliunt, errorem labentium animarum placidi ac propitii ferunt. Imitemur illos; demus, etiam si multa in inritum data sunt; demus nihilo minus aliis, demus ipsis, apud quos facta iactura est. Neminem ad excitandas domos ruina deterruit, et, cum penates ignis absumpsit, fundamenta tepente adhuc area ponimus et urbes haustas saepius eidem solo credimus; adeo ad bonas spes pertinax animus est. Terra marique humana opera cessarent, nisi male temptata retemptare libuisset. 32. Ingratus est: non mihi fecit iniuriam, sed sibi; ego beneficio meo, cum darem, usus sum. Nec ideo pigrius dabo, sed diligentius; quod in hoc perdidi, ab aliis recipiam. Sed huic ipsi beneficium dabo iterum et tamquam bonus agricola cura cultuque sterilitatem soli vincam; perit mihi beneficium, iste hominibus. Non est magni animi beneficium dare et perdere; hoc est magni animi perdere et dare».
I benefìci
Premessa Un riferimento a Claudio («Ma come, non bisognava accettare i doni di Claudio!», I 15, 6) testimonia che l’inizio dell’opera è posteriore alla sua morte e che risale presumibilmente intorno al 59 d. C., secondo alcuni al 62, quando Seneca poteva accennare ai benefìci avuti da Nerone e alla ingratitudine dell’imperatore per quelli ricevuti da lui nella sua veste di precettore e consigliere. La fine della stesura viene collocata fra il 63 e il 65, dopo il ritiro di Seneca dalla scena politica. Prima di Seneca già altri avevano trattato l’argomento, a partire da Omero, Esiodo e i poeti elegiaci, a cui seguirono Pitagora, Democrito, Platone, Aristotele, Epicuro e in particolare Crisippo, ma anche Cicerone (De officiis). Ma la fonte principale dei Benefici è Ecatone, discepolo di Panezio, della media Stoa, di cui ci sono pervenuti solo frammenti di un trattato Perì kathékontos (Sul dovere). Oltre a Ecatone sono nominati da Seneca altri filosofi, fra cui Crisippo (I 3, 8-9) e Demetrio Cinico, citato e ammirato nel libro VII. Spesso, però, si tratta di spunti che Seneca sviluppa in modo originale. Questi, nell’ordine, i principali argomenti del trattato, che consta di sette libri ed è dedicato a Ebuzio Liberale, il personaggio citato nelle Lettere a Lucilio a proposito dell’incendio di Lione, la sua città. Generalmente gli uomini non sanno né dare né ricevere benefìci, molti sono gl’ingrati, ma ciò non deve distogliere dal donare poiché il valore del beneficio consiste nel fatto stesso di dare. I benefìci possono essere: necessari, utili, piacevoli ma non necessari (I). È meglio darli spontaneamente e subito, magari prevenendo la richiesta per evitarne al destinatario l’umiliazione, e per questo a volte occorre agire in segreto. I benefìci non si devono rinfacciare, né bisogna vantarsene o farli pesare. Sono da rifiutarsi i benefìci che possono rivelarsi dannosi a chi li chiede o vergognosi per chi li dà. Bisogna dimostrare riconoscenza non soltanto con le parole ma anche con l’atteggiamento e contraccambiando il beneficio. L’ingratitudine nasce da un concetto troppo alto di sé, dall’avidità, dall’ambizione e dall’invidia (II). Essa, tuttavia, non deve essere punita dalla legge, perché le garanzie legali annullerebbero il valore morale del beneficio e della riconoscenza. Anche lo schiavo può beneficare il suo padrone, poiché ciò che conta è l’intenzione, non la condizione sociale. Il dono della vita è il beneficio più grande, ma un figlio può beneficare il padre e superarlo (III). Non si devono concedere benefìci a chi è particolarmente portato al vizio dell’ingratitudine, né si è tenuti a mantenere le promesse fatte a chi in seguito si rivela malvagio. Non si deve pretendere che si contraccambi subito il beneficio: chi non vuole essere debitore è praticamente un ingrato (IV). Nessuno può essere vinto da un altro in generosità perché ciò che conta è la buona disposizione d’animo, non l’entità del beneficio. Non si può essere benefattori di se stessi. Talvolta si deve ricordare al beneficato il suo debito, per impedirgli di essere ingrato (V). Ci sono casi in cui non si è tenuti a restituire il beneficio e in cui non si hanno debiti di gratitudine in quanto il beneficio non sussiste. Si deve essere riconoscenti anche alla divinità per gli innumerevoli benefìci che riceviamo da lei (praticamente tutti, se tutto proviene da lei) (VI). Anche il saggio può ricevere un beneficio, sebbene dentro di sé possieda già tutto, in quanto vive in comunione con la divinità (VII). Le questioni dibattute nei Benefici, come dice Seneca stesso, sono «sottili», piene di «tranelli» e di «cavilli», perché «ora bisogna spianare il campo in cui muoversi, ora affrontare un cammino tenebroso e accidentato, lungo il quale arrampicarsi faticosamente e avanzare passo dopo passo con estrema prudenza». E spesso infatti Seneca si arrampica faticosamente, introducendo a suo sostegno un interlocutore, che può essere Ebuzio Liberale, un semplice lettore, o Seneca stesso che si interroga, sviscera l’argomento, per far vedere che il suo è un ragionamento obiettivo, coerente, a tutto campo; ma quando muove l’obiezione ha già pronta la risposta che la cancella o che, gira e rigira, l’incanala nella strada che egli stesso le spiana. Il dibattito lo conduce lui. Alcuni sostengono che il trattato sia stato ispirato a Seneca dalla ingratitudine dimostratagli da Nerone per i benefìci ricevuti da lui, dal desiderio di liberarsi da ogni debito di riconoscenza verso l’imperatore. Chi ha ricevuto un maggior numero di benefìci, più frequenti e di maggior valore, osserva Seneca, non per questo è un vinto. «Se si mettono a confronto il bene che si fa e quello che si riceve forse i benefìci vengono superati dai benefìci; se invece si confrontano chi dà e chi riceve e si considera la
buona disposizione d’animo di entrambi nessuno dei due risulterà vincitore» (V 3). Per quel che mi riguarda, dice in sostanza Seneca, io non sono un ingrato: fra me e Nerone la partita si è chiusa alla pari. Il testo latino seguito è quello di F. Préchac, Parigi 1967, in cui talvolta le righe finali o iniziali dei vari capitoli hanno una collocazione diversa rispetto alle altre edizioni. M. S. A.
Libro primo 1. Credo di poter dire, mio ottimo Liberale1, che fra i diversi e numerosi errori di chi vive spensieratamente e senza un minimo di avvedutezza ce ne sono due, di cui non è possibile dire quale sia il peggiore: il non saper dare e il non saper ricevere benefìci. Né c’è da stupirsi che fra i molti e gravi vizi dell’uomo il più frequente sia l’ingratitudine, e ciò secondo me accade per vari motivi. Il primo risiede nel fatto che spesso le persone a cui elargiamo un beneficio non ne sono degne, mentre se dobbiamo concedere un prestito svolgiamo indagini sulla vita e sul patrimonio del contraente e quando dobbiamo seminare non gettiamo le sementi su un terreno sterile o troppo sfruttato. Così facciamo coi benefìci: più che darli, li buttiamo a caso. Mi sarebbe poi difficile dire se sia più vergognoso negare di aver ricevuto un beneficio o pretendere il contraccambio, visto che il beneficio è un genere di credito dal quale si recupera quel tanto che viene restituito spontaneamente; lamentarsene, poi, è cosa ignobilissima perché per liberarsi dall’obbligo non c’è bisogno di ricchezze, basta una particolare disposizione d’animo: riconoscere un debito, infatti, equivale a contraccambiare il beneficio. Ma come sono colpevoli coloro che non si dimostrano grati neppure riconoscendo il loro debito, così lo siamo anche noi, quando, vista l’ingratitudine di molti nei nostri confronti, li rendiamo ancora più ingrati perché ora rinfacciamo insistentemente il beneficio concesso e pretendiamo il contraccambio, ora, volubili come siamo, ci pentiamo subito del nostro dono, ora ci lamentiamo e recriminiamo su delle inezie. Così distruggiamo ogni senso di riconoscenza, e non solo dopo aver concesso il beneficio ma anche mentre lo concediamo. Non ci basta, infatti, farci pregare con discrezione e una volta sola. Quanti, al minimo sospetto che gli si chieda qualcosa, non corrugano la fronte, non distolgono lo sguardo e non fanno finta di essere occupati e con discorsi prolungati ad arte non impediscono all’interlocutore di parlare, eludendo così, con stratagemmi vari, una impellente necessità? Oppure, messi alle strette, non rimandano, negando timidamente il loro aiuto, o promettono ma avanzando difficoltà, aggrottando le sopracciglia, con parole asciutte che gli escono dalla bocca a fatica? Fra l’altro non fa piacere sentirsi debitori di ciò che si è ricevuto non come un dono spontaneo, bensì strappato a forza. Chi potrebbe provare gratitudine
verso uno che gli ha rifiutato sdegnosamente un beneficio o glielo ha gettato con stizza, o che, insofferente di esserne richiesto, glielo ha concesso solo per toglierselo dai piedi? Sbaglia chi spera che possa essergli riconoscente uno che coi suoi continui rinvii lo ha stancato e torturato facendolo aspettare. La disposizione d’animo del debitore dipende da quella del donatore e dunque non bisogna donare con negligenza: dobbiamo infatti a noi stessi ciò che abbiamo ricevuto da chi donava senza rendersene conto. Né bisogna donare con lentezza, perché in ogni favore conta molto la volontà di chi lo concede, e l’aver donato tardi significa non aver avuto per molto tempo la volontà di farlo. Ma, soprattutto, nel donare non bisogna umiliare, perché le offese subìte scottano più di quanto non siano gradite le buone azioni ricevute, e queste si dimenticano rapidamente, mentre quelle si conservano tenacemente nella memoria: quindi cosa può aspettarsi chi, pur beneficandoci, ci mortifica? Gli si deve già molto se gli si perdona il suo beneficio. Il fatto che ci siano parecchi ingrati non deve però renderci restii nel concedere i benefìci, prima di tutto perché noi stessi, come ho detto, contribuiamo ad aumentarne il numero, poi perché nemmeno gli dèi immortali, nella loro larga e continua generosità, si lasciano frenare dal fatto che ci sono uomini sacrileghi e indifferenti: essi esercitano la loro natura e aiutano tutti, compresi coloro che non sanno apprezzarne i doni. Seguiamo, dunque, gli dèi come nostre guide, per quanto è concesso alla debolezza umana:2 i nostri benefìci siano un dono, non un prestito a interesse. Merita di essere ingannato chi, mentre dà, pensa già al contraccambio. Ammettiamo che le cose vadano male: anche i figli e la moglie hanno deluso le nostre speranze e tuttavia si continua a educare i figli e ci si sposa, siamo talmente ostinati a dispetto delle esperienze fatte che riprendiamo la guerra dopo essere stati sconfitti e i viaggi per mare dopo aver fatto naufragio. Quanto più conviene persistere nel beneficare! E se qualcuno il bene non lo fa perché sa che in cambio non ne riceverà alcunché, vuol dire che se lo fa lo fa proprio per ricevere qualcosa in cambio, e così dà ragione agli ingrati, che noi biasimiamo perché non ricambiano un bene quando ne avrebbero la possibilità. Quanti sono indegni della luce del sole! Eppure, il giorno continua a sorgere. Quanti si lamentano di essere nati! Eppure, la natura continua a generare nuovi discendenti e a lasciar vivere coloro che avrebbero preferito non essere nati. È proprio di un animo grande e buono non ricercare un guadagno dai benefìci che fa, ma accontentarsi del beneficio in sé stesso, e continuare a cercare la bontà anche dopo aver ricevuto ingratitudine. Dove sarebbe la nostra magnanimità nel donare se nessuno ci avesse deluso? Il merito sta proprio nel concedere un beneficio senza avere la certezza di un contraccambio. L’uomo virtuoso ne coglie i frutti nel momento stesso in cui lo fa. Ciò non deve trattenerci, né renderci restii a compiere l’azione più bella che ci sia, tanto che io, pur senza avere la minima speranza di trovare una persona riconoscente, preferirei non ricevere il contraccambio di un beneficio piuttosto che non farlo,
perché chi, potendolo, non lo fa è più colpevole di un ingrato. Io la penso così: chi non ricambia un beneficio pecca di più, chi non lo concede pecca prima. 2. Se hai deciso di elargire benefìci al volgo, devi perderne molti, per piazzarne bene uno.3 Nel primo verso si potrebbero criticare entrambi i concetti, sia perché i benefìci non devono essere elargiti al volgo indiscriminatamente,4 sia perché in nessun caso, ma soprattutto in fatto di benefìci, è lodevole essere prodighi; se si fanno senza alcun discernimento, cessano di essere benefìci e prendono un altro nome. Il pensiero che segue è davvero ammirevole: un solo beneficio ben collocato compensa la perdita di molti. Bada, però, se non sia invece più vero e più consono alla magnanimità di un benefattore esortarlo a dare comunque, anche se il suo beneficio non sarà ben collocato. Non è infatti esatto dire “si devono perdere molti benefìci”, poiché non va perso nulla: perde chi aveva agito per calcolo. I benefìci non si misurano col dare e con l’avere, si distribuiscono e basta; se poi ci si ricava qualcosa è un guadagno, diversamente non c’è perdita alcuna. Ho donato solo per donare. Nessuno prende nota dei benefìci nel libro dei crediti, né reclama il dovuto, come un avido esattore al giorno e all’ora stabilita. L’uomo virtuoso non pensa mai ai benefìci fatti se non perché glieli ricorda chi li contraccambia, altrimenti si trasformano in crediti. È un’usura vergognosa mettere un beneficio in conto al beneficato. Perciò, qualunque sia stata la sorte di quelli precedenti, continua a concedere benefìci; meglio se resteranno infruttuosi presso gl’ingrati, la cui vergogna o le circostanze o l’occasione o l’emulazione potranno renderli riconoscenti. Non desistere, porta a termine la tua opera e interpreta il tuo ruolo di uomo virtuoso. Aiuta uno coi beni materiali, un altro garantendo per lui, un altro coi tuoi consigli, un altro con ammonimenti salutari. I doveri sono sentiti anche dalle fiere, e non c’è animale tanto feroce da non poter essere addomesticato e da non affezionarsi a chi si prende cura di lui. I domatori possono toccare impunemente la bocca dei leoni, il cibo dato agli elefanti placa la loro ferocia trasformandola in servile docilità, tanto un comportamento benevolo riesce a vincere anche quegli esseri che non sono in grado di comprendere e di apprezzare un beneficio. Uno si mostra ingrato di fronte a un primo beneficio? Non sarà così di fronte a un secondo. Ne ha dimenticati già due? Un terzo gli farà ricordare anche quelli che gli sono usciti dalla memoria. 3. Perderà i benefìci colui che crede troppo presto di averli perduti; ma chi insiste elargendone uno dietro l’altro riesce a suscitare riconoscenza anche nel cuore di un individuo immemore e insensibile. Questi, infatti, di fronte a molti benefìci non oserà alzare gli occhi: da qualunque parte si volti, cercando di sfuggire al ricordo, egli ti veda: circondalo con i tuoi benefìci.
Ora illustrerò la natura e le caratteristiche di questi benefìci, ma prima consentimi di accennare ad alcune questioni che non riguardano specificamente l’argomento, cioè per quale motivo le Grazie siano tre, perché sorelle, perché si tengano per mano e perché siano sorridenti, giovani e vergini e indossino una veste trasparente e senza cintura.5 Ebbene, secondo alcuni una di loro dà il beneficio, un’altra lo riceve e una terza lo ricambia; altri, invece, spiegano la cosa osservando che ci sono tre tipi di benefìci, quelli di chi si rende benemerito, quelli di chi ricambia, quelli di chi riceve e ricambia contemporaneamente. Scegli l’interpretazione che vuoi: a che ci serve questa conoscenza? Perché le Grazie danzano in cerchio tenendosi per mano? Perché un beneficio, passando di mano in mano, alla fine ritorna al suo autore, e se la catena s’interrompe perde la sua prerogativa di completezza, mentre è bellissimo se questo passare di mano in mano mantiene la sua connessione. In questa danza, però, la maggiore delle Grazie ha un’importanza particolare, come chi fa il beneficio per primo. Le Grazie in volto sono gioiose, come lo sono solitamente coloro che dànno o ricevono un beneficio; sono giovani, perché il ricordo dei benefìci non deve invecchiare; vergini, perché i benefìci sono puri e schietti e sacri per tutti, non devono aver nulla di forzato o di coercitivo, e per questo indossano tuniche senza cintura, le quali sono trasparenti perché i benefìci vogliono essere visibili. Ora magari ci sarà qualcuno così legato ai Greci da sostenere che tutte queste cose sono necessarie, ma mai a tal punto da ritenere che i nomi assegnati alle Grazie da Esiodo6 siano importanti per il nostro tema. Egli ha chiamato Aglaia la maggiore, Eufrosine la seconda, Talia la terza. Ebbene, ciascuno interpreta come gli pare il motivo di questi nomi e si sforza di trovare una spiegazione razionale, mentre Esiodo ha attribuito alle sue fanciulle quei nomi semplicemente perché gli sono piaciuti. Così Omero ha cambiato nome a una di loro, chiamandola Pasitea, e l’ha promessa in matrimonio, per far sapere che le Grazie non sono delle vergini vestali. Potrei trovare un altro poeta che fa loro indossare cinture e spesse vesti di lana crespa. Analogamente anche Mercurio è stato aggiunto al gruppo non perché un ragionamento o un discorso diano prestigio al beneficio, ma perché al pittore è piaciuto così. Crisippo,7 spirito acuto che va al fondo della verità e che parla a fini pratici usando solo le parole necessarie per farsi capire, riempie un libro intero di queste inezie, dicendo pochissimo sul beneficio e sul rapporto fra chi lo dà, chi lo riceve e chi lo ricambia: non tratta questi problemi limitandosi a inserirvi qualche aneddoto, ma inserisce qualche quesito fra questi aneddoti. Infatti, oltre a queste cose, trascritte da Ecatone, Crisippo dice che le Grazie sono figlie di Giove e di Eurinome, più giovani delle Ore, ma un po’ più belle e perciò assegnate a Venere come compagne. Secondo lui ha importanza anche il nome della madre, la quale sarebbe stata chiamata Eurinome perché è tipico di un grande patrimonio distribuire benefìci: come se solitamente si desse il nome alla madre dopo averlo dato alle figlie, o come se i poeti riferissero i nomi veri!
Come il nomenclatore8 supplisce con la sfrontatezza ai suoi vuoti di memoria e assegna un nome inventato a coloro dei quali non ricorda quello vero, così i poeti non ritengono importante attenersi alla verità, ma, o perché costretti dalla necessità, o perché sedotti dalla bellezza dell’effetto, chiamano le persone con quel nome che si conviene alle necessità del verso. E non commettono una frode se trascrivono un nome diverso sullo stato civile di una persona, visto che in seguito un altro poeta attribuisce alle Grazie un nome diverso a propria scelta, come dimostra Talìa, di cui stiamo appunto parlando, che Esiodo chiama Charis, Omero Musa. 4. Ma, non volendo fare proprio ciò che biasimo, lascerò da parte tutte codeste inezie, che sono così estranee al nostro argomento da non sfiorarlo neppure. Tu, però, difendimi se qualcuno mi rimprovererà di aver ridotto all’ordine Crisippo, un grand’uomo, perbacco, ma greco, la cui sottigliezza eccessiva il più delle volte si smussa e si ripiega su sé stessa; anche quando sembra smuovere le acque, punge, ma non va in profondità. E in verità dov’è tutto questo acume? Bisogna parlare dei benefìci e regolare una materia che provvede a tenere quanto mai unita l’umana società, stabilire delle leggi di comportamento per non abbandonarsi a una prodigalità esagerata che opera sotto l’apparenza della generosità, e al tempo stesso affinché il rispetto di questa legge non limiti, nel regolarla, la nostra liberalità, che non deve mancare ma nemmeno essere eccessiva. Occorre insegnare agli uomini a donare volentieri, a ricambiare di buon grado e a proporre a sé stessi questa grande gara, e chi ha degli obblighi di riconoscenza deve non solo eguagliare concretamente il benefattore per la sua disposizione d’animo, ma superarlo, perché chi deve ricambiare un beneficio vi riesce solo se restituisce più di quanto ha ricevuto; agli uni bisogna insegnare a non rinfacciare niente di quello che hanno dato, agli altri a considerarsi debitori per più di quanto hanno ricevuto. A questa gara nobilissima di superare i benefìci con i benefìci ci esorta appunto Crisippo, quando dice che essendo le Grazie figlie di Giove bisogna guardarsi dal commettere sacrilegio mostrandosi poco grati, e dall’offendere fanciulle così belle. Tu da parte tua insegnami qualcuna di quelle cose in virtù delle quali io possa diventare più attivo nel bene ed essere più riconoscente verso chi mi ha beneficato, mostrami come gareggino l’animo di chi fa il beneficio e di chi lo riceve, sicché chi ha dato dimentichi e chi è in debito se ne ricordi sempre. Le inezie lasciamole ai poeti, il cui scopo è quello di dilettare le orecchie e inventare dolci favole. Ma chi si propone di curare le anime rafforzando la lealtà nei rapporti umani e imprimendo negli animi il ricordo dei doveri parli seriamente e si impegni con tutte le sue forze. Sempre che tu non creda che con discorsi superficiali e mitologici e con cavilli da donnicciole si possa impedire una cosa terribilmente funesta: il ritenere estinti i propri debiti. 5. Ma come sorvolo sulle cose superflue così bisogna ch’io precisi che la
prima cosa da imparare è quale sia il nostro debito per un beneficio ricevuto, visto che c’è chi dice di essere debitore del denaro, chi della carica di console, chi del sacerdozio, chi del governo di una provincia, e così via. In realtà questi sono i segni esteriori dei benefìci, non i benefìci in sé. Il beneficio non si tocca materialmente, appartiene alla dimensione dello spirito: c’è una grande differenza fra il beneficio e la sostanza di cui è fatto, il beneficio non consiste né nell’oro né nell’argento né in alcuna di quelle cose a cui si attribuisce un valore estetico, ma risiede nella volontà stessa di chi lo concede. Gli ignoranti, invece, notano solo ciò che balza agli occhi, che si può possedere e trasferire, non badano al valore intrinseco e prezioso che è nel dono in sé. I beni che teniamo in mano, che guardiamo, a cui si volgono i nostri desideri, sono caduchi, possono esserci tolti dalla sorte o da un atto di violenza, mentre il beneficio rimane anche quando non c’è più l’oggetto materiale attraverso cui si è realizzato, poiché non c’è forza che possa annullare quella buona azione. Se ho riscattato un amico dai pirati e poi un nemico lo ha fatto prigioniero e lo ha messo in prigione, costui gli ha tolto non il mio beneficio, ma la possibilità di goderne. Ho restituito i figli al padre dopo averli strappati a un naufragio o a un incendio, e poi una malattia o qualche accidente glieli porta via: anche senza i figli resta sempre ciò che ho dato attraverso di loro. Dunque tutto ciò che esula dal beneficio in sé non è che un servizio materiale attraverso cui si esprime la volontà di fare il bene. Anche in altri casi accade che la forma visibile non si identifichi con la sostanza. Un generale insignisce un soldato della collana, della corona turrita, della corona civica: che cos’ha di prezioso una corona di per sé? E la pretesta? E i fasci? E il palco e il carro trionfale? L’onore non consiste in nessuna di queste cose, che dell’onore sono i segni materiali. Analogamente ciò che cade sotto i nostri occhi non è il beneficio, è l’orma, il segno del beneficio. 6. Il beneficio, insomma, è un’azione benevola che procura gioia e fa gioire nel procurarla, accompagnata da un’inclinazione e da una disposizione d’animo a compierla, perciò non importa ciò che si fa o si dà, importa l’intenzione, perché il beneficio, ripeto, consiste non nella materia concreta attraverso cui si realizza, ma nella disposizione d’animo di chi dà o di chi fa. Che ci sia una grande differenza fra queste cose lo si può capire anche dal fatto che il beneficio è in ogni caso un bene, mentre ciò che si fa o si dà non è né un bene né un male: è la disposizione d’animo che rende grandi le piccole cose, nobilita le cose meschine, rende misere le cose ritenute importanti e pregiate. Persino ciò che noi desideriamo è per natura indifferente, nel senso che non è classificabile né come bene né come male: quel che conta è dove l’indirizza colui che lo governa e gli dà forma. L’essenza del beneficio non consiste in ciò che si possiede materialmente o che passa da una mano all’altra, così come l’onore reso agli dèi risiede non nelle vittime offerte ma nella volontà onesta e religiosa di chi li venera. Perciò ai buoni bastano un po’ di farro e del vasellame di terracotta per mostrare la loro devozione; i malvagi, invece, per quanti altari bagnino di
sangue, non sfuggono all’empietà. 7. Se i benefìci consistessero nelle cose donate, non nella volontà stessa di fare il bene, il loro valore si misurerebbe in rapporto alla consistenza materiale del dono ricevuto, il che, invece, è falso, visto che spesso ci sentiamo maggiormente in debito con chi ci ha donato poco, ma con animo generoso, con chi eguagliava le ricchezze dei re con la disposizione d’animo,9 con chi ci ha reso un servizio minimo, ma di buon grado, con chi ha dimenticato la sua povertà guardando la mia, con chi ha avuto non soltanto la volontà, ma più che la voglia di aiutarmi, con chi ha ritenuto di ricevere egli stesso un beneficio facendolo a me, con chi ha ricevuto il contraccambio come se non avesse mai donato, con chi ha cercato e ha colto l’occasione per essermi utile. Per contro, come ho detto, non sono graditi, anche se di valore e molto belli a vedersi, quei doni che vengono quasi carpiti o che cadono di mano al donatore, poiché risulta molto più gradito un dono spontaneo che non uno elargito a piene mani. Ciò che costui mi ha dato è poco, ma non avrebbe potuto darmi di più; è molto, invece, ciò che mi ha dato quell’altro, ma me lo ha dato con esitazione, ha rinviato, se ne è lamentato, lo ha fatto con arroganza, ha sparso la voce e ha voluto riuscire gradito, ma non all’interessato; ha donato per la sua ambizione, non per me. 8. Visto che tutti offrivano a Socrate molti doni, ciascuno in proporzione alle sue possibilità, Eschine, un discepolo povero, gli disse: «Non trovo niente da offrirti che sia degno di te, e solo per questo mi rendo conto di essere povero. Ti dò quindi l’unica cosa che possiedo: me stesso. Ti prego di gradire questo dono e pensa che gli altri, pur avendoti donato tanto, hanno tenuto per sé stessi molto di più». Socrate gli rispose: «E perché il dono che mi hai fatto non dovrebbe essere prezioso? Hai forse poca stima di te?10 Avrò dunque cura di restituirti te stesso migliore di come ti ho ricevuto». Eschine con questo dono superò la generosità di Alcibiade, che era pari alla sua ricchezza, e quella di tutti i discepoli ricchi. 9. Vedi come l’animo anche nelle ristrettezze sappia trovare materia per esprimere la sua generosità? Per me Eschine è come se avesse detto: «O sorte, non hai ricavato nulla dalla povertà che mi hai imposto, perché nonostante ciò io riuscirò a trovare un dono degno di un tale uomo: non potendo infatti dargli del tuo, gli darò del mio». E non pensare che si sia tenuto in poco conto, perché si è dato un valore pari al suo debito. Non importano infatti la quantità e il valore dei doni che si ricevono, ciò che conta è sapere da quali persone ci giungano. Una persona astuta offre un facile accesso a coloro che nutrono desideri smisurati, e coi suoi discorsi alimenta le loro folli speranze, ma senza avere affatto l’intenzione di aiutarli; ed è peggiore di Opimio11, se con parole dure e aria severa fa sfoggio dei suoi beni materiali. Gli uomini, infatti, venerano ma al tempo stesso maledicono chi è fortunato e odiano le sue azioni, quelle stesse che
farebbero anche loro, se solo lo potessero. Dopo aver preso in giro le mogli altrui, e non di nascosto ma apertamente, hanno messo a disposizione degli altri le proprie. Chi proibisce alla moglie di farsi vedere in portantina o di uscire con abiti trasparenti, offrendosi agli sguardi di tutti, è considerato un uomo rozzo, incivile e maleducato, e addirittura detestabile fra le matrone. Chi non si fa notare perché non ha alcuna amante e non mantiene la moglie di un altro, è definito dalle matrone un sempliciotto, di piaceri grossolani e un amante da servette. Ne consegue che il genere più saldo di fidanzamento è l’adulterio, mentre la vedovanza e il celibato sono cose di ordinaria amministrazione: nessuno prende moglie se non la ruba a un altro. Costoro ormai gettano al vento le ricchezze, frutto di rapina, e poi, presi da una tardiva e acuta cupidigia, fanno a gara nel recuperare ciò che hanno sperperato, senza il minimo scrupolo, disprezzano la povertà altrui, temono la propria come se fosse il male più grande, turbano la pace coi soprusi, opprimono i più deboli con la forza o con la paura. Che si saccheggino le province e che giudici corrotti, ascoltate le offerte delle due parti, si vendano a una di esse non suscita meraviglia, visto che è diritto di tutti vendere ciò che si è comprato. 10. Ma l’impeto, visto che la materia è così stimolante, sta portandomi troppo lontano, perciò mi fermo per non far ricadere tutta la colpa sulla nostra generazione. E come noi ci lamentiamo del nostro tempo, così i nostri antenati si sono lamentati del loro, e del loro si lamenteranno i posteri: i costumi, infatti, si sono ribaltati, regna la malvagità, l’umanità precipita verso il peggio e verso ogni genere di nefandezze. Cose che restano ferme allo stesso punto e vi resteranno, oscillando leggermente in un senso o nell’altro, come le onde che l’alta marea spinge più lontano, mentre la bassa le riconduce dentro i limiti interni dei lidi. Ora l’adulterio sarà un vizio più frequente degli altri e la castità romperà i freni che la trattengono; ora sarà di moda la smania dei banchetti e l’arte culinaria, detestabile causa di rovina per i patrimoni; ora prevarranno la cura eccessiva del corpo e la preoccupazione per la bellezza esteriore, da cui traspare la bruttezza dell’animo; ora una libertà male regolata sfocerà in insolenza e impudenza; ora si andrà verso le efferatezze private e pubbliche e la pazzia delle guerre civili, che profanano tutto quanto c’è di santo e di sacro; talvolta si onorerà l’ubriachezza e si farà risiedere il valore nel bere più vino degli altri. I vizi non si fermano in un unico posto ma, mobili e in discordia fra loro, si agitano, scacciano o sono scacciati, e in definitiva il giudizio che diamo su di noi è sempre lo stesso: siamo malvagi, lo siamo stati e – lo dirò a denti stretti – lo saremo ancora. Ci saranno sempre omicidi, tiranni, ladri, adulteri, seduttori, sacrileghi, traditori; ma la peggiore delle colpe è l’ingratitudine, perché tutte le altre derivano da quella, senza la quale quasi nessun grande delitto ha mai assunto così vaste proporzioni. Tu guardati dal commettere questo crimine, considerandolo come il più grave di tutti, ma perdonalo come se fosse il più lieve se viene commesso nei tuoi confronti. Il torto subìto, infatti, si riduce a
questo: hai sprecato un beneficio. Ti resta intatto, però, il meglio di esso: l’aver donato. Ora, se è vero che bisogna curarsi di rivolgere i nostri benefìci soprattutto verso coloro che risponderanno con gratitudine, tuttavia ne faremo alcuni anche senza speranza che siano bene impiegati, e li accorderemo non solo se i destinatari saranno ingrati, ma anche se lo sono già stati. Per esempio, se potrò restituire a qualcuno i figli, dopo averli sottratti a un grave pericolo, senza correre alcun rischio, non esiterò a farlo. Se uno lo merita, lo difenderò anche a prezzo del mio sangue e condividerò i pericoli con lui; se uno non lo merita, ma potrò strapparlo ai banditi con un semplice grido, ebbene, io quel grido lo leverò se servirà a salvare la vita di un uomo. 11. Ora vediamo quali siano i benefìci da concedere e in che modo si debbano elargire. Prima di tutto diamo ciò che è necessario, poi ciò che è utile, poi ciò che è piacevole, e comunque in modo che duri. Bisogna cominciare da ciò che è necessario, poiché, per dire, un beneficio che conservi la vita ha un effetto ben diverso rispetto a uno che la abbellisca o la renda comoda. E poi qualche schizzinoso che volentieri ne farebbe a meno potrebbe rispondere: «Riprenditelo, non lo voglio, mi basta quel che ho». Per non dire che a volte si vorrebbe non solo restituire ciò che si è ricevuto, ma gettarlo lontano con disprezzo. Fra i benefìci necessari il primo posto spetta a quelli senza i quali non potremmo vivere, il secondo a quelli senza i quali non dovremmo vivere, il terzo a quelli senza i quali non vorremmo vivere. Fra i primi c’è, per esempio, l’essere strappati alle mani dei nemici o all’ira dei tiranni o alle proscrizioni o ad altri pericoli che in modi vari e imprevedibili insidiano la vita umana. Quanto più grave e terribile sarà stata la sventura a cui abbiamo sottratto il beneficato tanto più questo ci sarà riconoscente, dopo che avrà riflettuto sulla gravità del male evitato e la paura provata gli avrà reso più gradito il beneficio. Tuttavia non perché la paura dia maggior valore al beneficio dobbiamo intervenire più tardi per salvare qualcuno. Dopo questi ci sono i benefìci senza i quali potremmo sì continuare a vivere, ma in modo tale da preferire la morte: per esempio la libertà, la pudicizia, la moralità. Quindi viene ciò che ci è caro o per parentela o per legame di sangue o per un rapporto abituale e inveterato, come i figli, la moglie, la casa e le altre cose a cui ci siamo affezionati tanto che il distacco da esse ci sembra più grave di quello dalla vita. Dopo questi vengono i benefìci utili, un ambito piuttosto vario ed esteso, fra cui rientrano il denaro, in quantità non eccessiva ma procurato moderatamente, gli onori e i successi per chi aspira all’ascesa sociale, visto che non c’è niente di più utile che il rendersi utili ai cittadini. I restanti benefìci sono un sovrappiù e risvegliano la raffinatezza: dobbiamo perciò fare in modo che risultino graditi per la loro opportunità, che non siano grossolani, che siano pochi a goderne o pochi fra quelli del nostro tempo, o che, pur non
essendolo per loro natura, diventino preziosi per il momento o per il luogo in cui sono stati elargiti. Cerchiamo il dono che può piacere di più, che cadrà spesso sotto gli occhi del possessore suscitandogli così il nostro ricordo, ma in ogni caso evitiamo di elargire doni inutili, come armi da caccia a una donna o a un vecchio, libri a un contadino o reti a un uomo dedito agli studi. Per contro dovremo fare ugualmente attenzione, se vogliamo fare doni graditi, a non regalare cose che rinfaccino al destinatario un suo difetto, come vino a un ubriacone e medicine a una persona cagionevole di salute, perché a quel punto il dono diventa un’offesa, visto che mette in evidenza i difetti del destinatario. 12. Se siamo noi a scegliere il dono cercheremo soprattutto cose che possano durare, che siano il meno possibile caduche. Sono poche, infatti, le persone tanto riconoscenti da tenere a mente, anche quando non lo vedono, ciò che hanno ricevuto. Il ricordo del beneficio assale anche gli ingrati nel momento stesso in cui vedono davanti ai propri occhi l’immagine del dono, la quale non solo fa sì che non se ne dimentichino ma risveglia e imprime nell’animo il ricordo del suo donatore. Ma anche per un altro motivo dobbiamo fare doni destinati a durare, perché in una mente debole non dobbiamo essere noi a suscitarne il ricordo, dev’essere l’oggetto stesso. Donerò più volentieri dell’argenteria che delle monete d’argento, una statua piuttosto che un abito o qualcosa che si consuma rapidamente. Sono pochi quelli che continuano a essere riconoscenti anche dopo la scomparsa dell’oggetto, per i più il ricordo del dono dura solo il tempo in cui lo si è goduto. Io non voglio che il mio dono si consumi, voglio che resti, che resista all’usura del tempo, che si attacchi al mio amico e viva con lui. Nessuno è così stolto da dover essere consigliato di non inviare in dono gladiatori o animali feroci quando la stagione degli spettacoli è finita, o abiti estivi d’inverno o invernali in piena estate. Occorre buonsenso nel donare, bisogna fare attenzione al momento, al luogo, alla persona, perché certe cose risultano gradite o sgradite per un particolare insignificante. Quanto sarà più gradito se a qualcuno regaliamo ciò che non ha piuttosto che ciò che ha in abbondanza, ciò che cerca da molto tempo senza riuscire a trovarlo, piuttosto che ciò che potrà vedere dappertutto! I doni, più che preziosi, siano rari e ricercati, tali da poter trovare posto anche nella casa di un ricco: così, per esempio, se ci arriva come primizia, ci farà piacere anche della frutta comune che dopo pochi giorni ci verrà a nausea. Saranno prestigiosi anche quegli oggetti che il nostro beneficato non avrà mai ricevuto o che noi non abbiamo donato ad alcun altro. 13. Quando Alessandro il Macedone, dopo le sue vittorie in Oriente, meditava imprese al di sopra delle umane possibilità, gli abitanti di Corinto si congratularono con lui attraverso degli ambasciatori e gli offrirono la cittadinanza. Alessandro rise di un simile omaggio, al che uno degli ambasciatori gli disse: «Non abbiamo mai offerto la cittadinanza ad alcuno, tranne che a
Ercole e a te». A quel punto Alessandro accettò volentieri quell’onorificenza inconsueta e, invitati gli ambasciatori alla sua mensa e trattatili con ogni riguardo, soffermò la sua attenzione non su coloro che gli avevano offerto la cittadinanza, ma su colui a cui l’avevano data in precedenza, sicché quest’uomo bramoso di una gloria di cui non conosceva né il limite né la natura, seguendo le orme di Ercole e di Bacco, senza fermarsi neppure là dove esse sparivano, più che ai donatori pensò al compagno di quell’onorificenza, come se avesse conquistato il cielo (a cui ambiva con la sua mente piena di illusioni), poiché veniva accomunato a Ercole. Cosa aveva di simile a questo dio quel giovane pazzo che al posto del valore aveva una fortunata inconsideratezza? Ercole non vinse mai per sé stesso; attraversò tutto il globo terrestre non in preda alla brama, ma riflettendo su cosa dovesse trionfare, lui, nemico dei malvagi, difensore dei buoni, pacificatore di terre e di mari. L’altro, invece, fin da bambino fu un brigante, un devastatore di popoli, un flagello sia per i nemici sia per gli amici, poiché riteneva che il massimo bene consistesse nel terrorizzare tutti i mortali, dimenticando che non solo gli animali feroci, ma anche i più vili sono temuti per il loro veleno. 14. Ma torniamo al nostro argomento. Chi concede un beneficio a chiunque, senza alcuna discriminazione, non fa cosa gradita ad alcuno. Chi si reca in un albergo, in un’osteria o a un banchetto pubblico non si considera certo un ospite del proprietario. In questi casi potrebbe chiedersi: «Costui che cos’ha fatto realmente per me? La stessa cosa che ha fatto per chi conosceva appena e perfino per chi era suo nemico e uomo del tutto spregevole. Mi ha forse riconosciuto qualche merito particolare? No: ha soddisfatto la sua morbosa vanità». Se vuoi che un dono sia gradito, fallo raramente, perché allora chiunque si sentirà in debito con te. Questo, però, non si interpreti come un freno alla generosità, quasi ch’io volessi imbrigliarla in troppo stretti confini: la si esprima pure quanto si vuole ma in una direzione ben precisa, non errando a caso di qua e di là. Si possono distribuire doni in abbondanza, ma in modo che ciascuno, anche se ha ricevuto insieme con molti altri, non pensi di essere stato confuso nella massa. Ognuno trovi nel proprio dono qualche segno particolare di amicizia, in virtù del quale possa sperare di essere stato oggetto di un favore speciale e fare questa considerazione: «Ho ricevuto il medesimo dono che è stato dato a un altro, ma a me è stato offerto spontaneamente, o in un tempo più breve, mentre l’altro ci ha messo tanto per meritarlo. Altri hanno avuto il mio medesimo regalo, ma il donatore non gliel’ha dato con le stesse parole e con la stessa cortesia. Quello ha ricevuto dopo aver chiesto, mentre io non avevo chiesto. Quell’altro ha ricevuto, ma avrebbe dato volentieri un contraccambio, poiché, vecchio e senza figli, era pieno di promesse; a me, invece, pur avendo fatto lo stesso dono, ha dato di più, poiché me l’ha dato senza speranza di ricevere in cambio alcunché». Come una meretrice si divide fra molti, ma riesce a far sì che ciascuno porti con sé un segno particolare della sua tenerezza, così chi vuole che i suoi benefìci
siano graditi trova il modo per far sì che molti si sentano in debito, ma che ciascuno singolarmente abbia qualche motivo di considerarsi preferito rispetto agli altri. 15. Io in verità non frappongo ostacoli ai benefìci, perché quanto più numerosi e più grandi essi saranno, maggiore sarà la lode che ne deriverà. Ci sia, però, un criterio nella scelta, poiché non possono essere graditi i benefìci concessi a caso e sconsideratamente. Se poi qualcuno pensa che con questi precetti io restringa i confini della generosità destinandole un campo più limitato, non ha capito bene i miei insegnamenti. Quale virtù, infatti, venero di più? Quale stimolare maggiormente? A chi spetta di formulare queste esortazioni più che a me che cerco di stabilire tra gli uomini le regole della vita sociale? E che, dunque? Poiché uno sforzo morale è virtuoso solo quando la misura ne fa una virtù, pur nascendo già da una volontà rivolta al bene, io non voglio che la generosità si trasformi in prodigalità. Si riceve un beneficio con piacere e quasi religiosamente quando una scelta razionale lo elargisce a chi ne è degno, non quando lo getta il caso o un impulso indiscriminato; quel tipo di beneficio piace mostrarlo e ritenersene destinatari. Sono forse benefìci quelli di cui ci si vergogna di confessare il nome dell’autore? Quanto sono più graditi, invece, i veri benefìci, e come penetrano nel fondo dell’animo per non uscirne più, quando il piacere proviene, più che dal dono ricevuto, dal pensiero di chi ce lo ha fatto! Crispo Passieno12 soleva dire che di alcuni preferiva la stima ai benefìci, di altri i benefìci alla stima, adducendo degli esempi: «Del divo Augusto», diceva, «preferisco la stima, di Claudio il beneficio». Io però ritengo che non dovremmo desiderare i benefìci di una persona la cui stima per noi non conta nulla. Ma come? Non bisognava accettare i doni di Claudio? Sì, ma come si accettano i beni della fortuna, che si sa che può diventare avversa in un istante.13 Perché separiamo due elementi che sono fusi strettamente insieme? Non c’è beneficio se manca la parte migliore, se cioè è stato dato senza criterio, altrimenti un’ingente somma di denaro che sia stata elargita senza una scelta razionale e senza la volontà rivolta al bene più che un beneficio è un tesoro trovato. Ci sono molte cose che bisogna accettare, ma senza sentirsi in debito.
1. Forse è quello stesso Liberale, cavaliere e molto ricco, di cui Seneca parla nelle Lettere a Lucilio (91, 1) a proposito dell’incendio che ha distrutto la colonia di Lione, la sua città. 2. Seneca qui abbandona la concezione stoica e si avvicina a quella platonica (Teeteto, 176 A-B). 3. Versi di autore comico ignoto. 4. Si allude forse alle elargizioni fatte da Nerone al popolo (Svetonio, Nerone, 11.) 5. La digressione sulle Grazie è dovuta probabilmente al fatto che il loro nome deriva da charis, che al singolare significa grazia o beneficio. 6. Cfr. Esiodo, Teogonia, 907-909.
7. Crisippo è il secondo fondatore dello stoicismo. 8. Il nomenclator era lo schiavo incaricato di suggerire al padrone i nomi delle persone incontrate. 9. Virgilio, Georgiche, IV 132. 10. Cfr. Diogene Laerzio, Storia dei filosofi, XI 34. 11. Opimio è l’avaro di cui parla Orazio in Satire, II 3, 142 ss., che si lascia morire di fame ma non rinuncia ad accumulare denaro. 12. Gaio Passieno Crispo era un personaggio ricco e potente; oratore e console per due volte fu marito di una zia di Nerone, Domizia, e poi di Agrippina, madre di Nerone. 13. Probabilmente Seneca allude ai benefìci che ha accettato da Claudio.
Libro secondo 1. Esaminiamo, o Liberale, ottimo fra gli uomini, ciò che resta della prima parte, cioè come si debba concedere il beneficio, un quesito la cui soluzione più semplice credo che sia questa: doniamo così come vorremmo ricevere. Innanzitutto di buon animo, prontamente, senza esitare. Non è gradito, infatti, quel beneficio rimasto a lungo nelle mani del donatore, il quale sembrava staccarsene controvoglia, quasi gli venisse strappato. Anche se interviene qualche motivo di indugio, evitiamo in ogni modo di mostrarci indecisi, poiché chi esita è molto vicino a chi nega e non ispirerà riconoscenza alcuna nel beneficato, visto che nel beneficio ciò che fa più piacere è la volontà di chi dà e poiché l’esitazione testimonia la malavoglia del donatore, costui in realtà non ha dato, avendo inizialmente opposto resistenza agli sforzi di chi lo tirava verso di sé: molti, infatti, sono resi generosi o dal caso o dalla debolezza. I benefìci più graditi sono quelli dati prontamente, con naturalezza, che ti vengono quasi incontro, il cui unico indugio è il pudore di chi li riceve, per cui la cosa migliore è prevenire il desiderio del destinatario o soddisfarlo subito, meglio ancora se il dono lo si concede prima ancora di esserne pregati, perché a un uomo virtuoso, quando chiede, si serrano le labbra e il viso si cosparge di rossore, quindi chi gli risparmia questa sofferenza e questa umiliazione raddoppia il valore del suo dono. Chi ottiene dopo aver chiesto non riceve gratuitamente poiché – così la pensavano anche i nostri antenati, uomini molto seri – nulla1 costa più caro di ciò che si compra con le preghiere. In pubblico gli uomini esprimono i loro desideri con maggiore moderazione, e anche gli dèi – ai quali è onorevole rivolgere le nostre suppliche – preferiamo pregarli in silenzio e nell’intimità del nostro cuore. 2. “Chiedo” è una parola difficile, pesante, da dirsi con lo sguardo abbassato. Dobbiamo risparmiarla all’amico e a chiunque vogliamo farci amico, rendendocene benefattore: chi concede un beneficio in seguito a una richiesta, per quanto sia sollecito, lo concede sempre tardi, per questo bisogna indovinare i desideri di ciascuno e una volta che si siano compresi liberarlo dalla gravosa necessità di chiedere: sappi che il beneficio spontaneo e immediato è il più gradito e continua a vivere nell’animo di chi lo riceve. Se non ci è stato possibile prevenire la richiesta, tronchiamo almeno il lungo e penoso discorso di chi chiede e, mostrando di prendere la sua preghiera per una pura e semplice informazione, promettiamo e dimostriamo subito con la nostra sollecitudine, prima ancora che ci sia rivolta la domanda, che manteniamo le promesse. Come per gli ammalati il cibo è salutare se gli vien dato al momento opportuno, mentre l’acqua ha la funzione di una medicina, così un beneficio, anche se comune e di poco conto, se viene dato prontamente, senza la minima perdita di tempo,
accresce molto il suo valore e riesce più gradito di un dono prezioso ma concesso tardi e dopo lunghe esitazioni. È indubbio che chi agisce prontamente agisce spontaneamente, quindi gioisce di quel che fa e il suo volto riflette la sua disposizione d’animo. 3. Immensi benefìci sono stati vanificati dal silenzio che li ha accompagnati o da frasi stentate che hanno dato l’impressione di fastidio e di insensibilità: si è promesso ma col volto di chi rifiuta. Come sarebbe meglio, invece, aggiungere buone parole alle buone azioni e valorizzare ciò che si offre con frasi benevole e gentili! Affinché chi riceve si rammarichi di aver tardato a domandare, aggiungi pure qualche rimprovero amichevole del tipo: «Sono adirato con te perché, pur desiderando qualcosa, non me l’hai mai detto, perché me l’hai chiesto con tanta formalità, perché hai fatto ricorso a un intermediario. Comunque ti ringrazio per aver voluto mettere alla prova il mio animo; in futuro, però, qualunque cosa desidererai, pretendila come tuo diritto. Per questa volta perdono la tua rozzezza». Così farai in modo che quello stimi il tuo animo più del beneficio che era venuto a chiederti. La virtù e la benevolenza di chi dona saranno piene e complete quando colui che ha ricevuto il dono potrà dire a sé stesso: «Oggi ho fatto un grande guadagno: preferisco aver trovato un uomo del genere, piuttosto che essermi procurato quel bene, magari moltiplicato, in un altro modo. Non gli sarò mai abbastanza riconoscente per la sua magnanimità». 4. Ci sono molti che per l’atteggiamento severo e la durezza delle loro parole fanno odiare i benefìci, o il cui linguaggio e la cui aria arrogante fanno pentire di avergli strappato una promessa, alla quale, per di più, fa seguito una serie di ritardi; e non c’è cosa più penosa del dover tornare a chiedere a chi ti ha già dato una promessa. I benefìci vanno pagati subito, in contanti, perché c’è chi promette ma poi all’atto pratico stenta a concedere: bisogna pregare uno perché glielo ricordi, un altro perché lo costringa a metterlo in atto, e intanto il beneficio, passando per le mani di molti, si consuma, dunque verso il donatore non resta che una fievole gratitudine, perché il dover ricorrere a numerose altre persone diminuisce la riconoscenza verso chi ha dato. Perciò se vuoi che il dono riscuota riconoscenza fa’ sì che arrivi intatto e integro a chi l’hai promesso, senza che il suo valore diminuisca, senza che alcuno lo intercetti o lo trattenga. Nessuno può fare sua la riconoscenza per ciò che tu darai, sì che non sia ridotta quella dovuta a te. 5. Niente è così amaro come una lunga attesa, tanto che alcuni sopportano più serenamente una speranza troncata che non una tirata per le lunghe. Molti, invece, per una perversa ambizione, hanno il difetto di rinviare l’adempimento di ciò che hanno promesso, affinché non diminuisca la folla di quelli che li pregano, come fanno i ministri di un re che si compiacciono di protrarre lo spettacolo del loro altezzoso potere considerando una sua diminuzione il non mostrare a tutti e
continuamente quanto sono potenti. Non c’è cosa che facciano subito o tutta in una volta: le loro offese sono immediate, i loro benefìci lenti. Tieni dunque per vero ciò che ha detto quel famoso poeta comico: Come? Non capisci che quanto più indugi tanto più diminuirà la riconoscenza?2 Da qui quelle frasi che provengono da un sincero risentimento: «Se vuoi fare qualcosa, fallo», «Non val la pena faticare tanto: preferisco che tu mi dica subito di no». Quando l’animo, ormai disgustato per via dell’attesa, comincia a odiare il beneficio, si può essere veramente grati? Com’è una crudeltà terribile prolungare il supplizio, e una forma di pietà uccidere subito, perché il culmine della tortura porta con sé anche la sua fine, e come l’attesa della tortura ne costituisce una parte considerevole, così la riconoscenza per un dono è tanto maggiore quanto minore è stata l’attesa. Infatti, anche l’attesa di qualcosa di buono è angosciosa, e poiché moltissimi benefìci sanano qualche molesta situazione, chi lascia soffrire più a lungo qualcuno che potrebbe liberare immediatamente o ne ritarda la gioia rovina il beneficio stesso. La generosità è sempre sollecita e la prerogativa di chi dona volentieri è quella di donare subito: chi aiuta tardi e tirando per le lunghe non lo fa col cuore, e perde due cose importantissime, il tempo e l’occasione di dimostrare la sua intenzione amichevole. Un volere tardivo è proprio di chi non vuole. 6. In ogni faccenda, o Liberale, una parte non trascurabile è il modo in cui si dice o si fa qualcosa. Molto si ottiene con la prontezza, molto si perde con l’indugio. Come nelle frecce il ferro ha sempre la stessa potenza, ma c’è un’enorme differenza fra lo scagliarlo con tutta la forza del braccio e il lasciarlo cadere con la mano abbandonata, e una medesima spada ci sfiora o ci trapassa a seconda della presa di chi la impugna, così in un medesimo beneficio la differenza sta nel come lo si dà. Com’è gradito, com’è prezioso il dono quando colui che lo fa non lascia nemmeno che lo si ringrazi, e mentre dà dimentica di dare! Rimproverare infatti il destinatario del dono nel momento in cui glielo si dà è follia, è inserire un’offesa in un atto meritorio. Non bisogna dunque rendere aspri i benefìci, né mescolarvi qualcosa di sgradevole. Anche se ci sarà da aggiungervi qualche ammonimento scegli un’altra occasione. 7. Fabio Verrucoso 3 diceva che il beneficio concesso da un uomo rozzo è un pezzo di pane duro come la pietra, che chi è affamato è costretto ad accettare, anche se sgradito. Tiberio Cesare, pregato da Mario Nepote, 4 un ex-pretore, di aiutarlo perché era pieno di debiti, si fece portare la lista dei creditori, un gesto che non è un beneficio ma un convocare, appunto, dei creditori. Dopo averla ricevuta, scrisse a Nepote che aveva dato ordine di pagare quella somma, aggiungendo dei rimproveri offensivi. Fu un saldo, non un beneficio: liberò
Nepote dai creditori, ma non lo fece sentire in obbligo verso di lui. Tiberio seguì un’altra strada: secondo me, non voleva che molti ricorressero a lui per chiedergli la stessa cosa, così si servì di quell’espediente per reprimere con la vergogna la smodata cupidigia degli uomini. Ma chi vuol fare un beneficio deve seguire una via completamente diversa. Bisogna adornare in tutti i modi ciò che si dà, affinché sia più gradito: uno come quello di Tiberio non è un beneficio, è cogliere in fallo. 8. Neppure per un principe – per dire di passaggio ciò che penso a questo proposito – è decoroso fare un dono per umiliare. Si dirà: «Però Tiberio in quel modo non poté sfuggire a ciò che voleva evitare, visto che in seguito altri gli chiesero la stessa cosa, e lui ordinò che tutti esponessero al Senato i motivi dei loro debiti, così diede loro le somme corrispondenti». Ma questo non è essere generosi, è comportarsi da censori; è un aiuto, un dono del principe, non un beneficio, dato che non si può ricordarsene senza arrossire, appunto, per la vergogna. Sono stato mandato davanti a un giudice: per vincere la causa mi sono difeso. 9. È per questo che tutti i filosofi esortano a concedere alcuni benefìci pubblicamente, altri in segreto: pubblicamente quelli che è onorevole ottenere, come doni militari, onorificenze e qualunque altra cosa diventi più bella se conosciuta; al contrario, ciò che non innalza socialmente né dà maggior lustro, come il soccorso a una malattia, alla povertà o a una situazione disonorevole, deve essere dato in silenzio, affinché sia noto solo a coloro che ne traggono giovamento. 10. Talvolta bisogna che la persona a cui si porge aiuto venga ingannata, che cioè riceva ma senza sapere da chi. Si narra che Arcesilao 5 pensò di dover aiutare in segreto un suo amico povero che gli nascondeva la sua condizione e che, pur essendo malato, non gli confessava che non aveva il denaro per comprare l’indispensabile. Ebbene, a sua insaputa gli mise un borsellino sotto il cuscino, affinché quell’uomo tanto pudico da recar danno a sé stesso potesse trovare, piuttosto che dover accettare, ciò che desiderava. «Ma come?», si obietterà. «Uno non deve sapere da chi ha ricevuto il dono?». Inizialmente non lo sappia, se è necessario che questo sia un lato indispensabile del beneficio, in seguito si faranno per lui molte altre cose, gli si concederanno altri benefìci, dai quali capirà chi è stato l’autore del primo. «Ma alla fine non saprà di aver ricevuto». Io, però, saprò di aver donato. «È poco», ribatti. È poco se tu pensi di dare a interesse, ma se pensi solo di dare darai nel modo che gioverà maggiormente a chi riceve. Ti accontenterai di te stesso come unico testimone, altrimenti non è fare il bene, perché vuoi che si veda che l’hai fatto. «Comunque voglio che lui lo sappia». Allora cerchi un debitore. «Comunque voglio che lui lo sappia». Ma come? Se per lui è più utile, più onorevole e più gradito non
saperlo, non seguirai quest’altra via? «Voglio che lui lo sappia». Dunque non salverai un uomo nelle tenebre? Non dico che se le circostanze lo consentono non si debba pensare alla gioia che ci viene dalla benevolenza di chi riceve; ma se quello ha bisogno di essere aiutato e però se ne vergogna, se ciò che gli offro lo offende, quando non sia nascosto, allora non rendo pubblici i miei benefìci. E perché non dovrei nascondergli che sono stato io a donare, dato che una delle prime e più indispensabili regole è quella di non rinfacciare mai, anzi di non ricordare neppure il bene che si fa? Questa, infatti, è la legge del beneficio che riguarda entrambe le persone: l’una deve subito dimenticare di averlo dato, l’altra non deve mai dimenticare di averlo ricevuto. 11. Ricordare continuamente il bene ricevuto tormenta e opprime l’animo del beneficato. In quel caso è lecito comportarsi come quel tale che, salvato dalle proscrizioni dei triumviri da un amico di Cesare, non potendo più sopportare l’arroganza del suo benefattore, esclamò: «Restituiscimi a Cesare!». Fino a quando ripeterai: «Io ti ho salvato, io ti ho strappato alla morte»? Se sono io a volerlo ricordare è la vita, ma se lo ricordo perché lo vuoi tu è la morte: non ti devo nulla, se mi hai salvato per avere qualcuno da mettere in mostra. Fino a quando mi porterai in giro? Fino a quando non mi permetterai di dimenticare la mia sorte? In un corteo trionfale mi avrebbero fatto sfilare una volta sola. Non bisogna sbandierare ai quattro venti il bene che si è fatto: chi lo ricorda è come se chiedesse il contraccambio; non bisogna insistere, non bisogna risvegliarne il ricordo, a meno che tu non lo faccia con un altro dono. E non dobbiamo neppure raccontarlo ad altri: chi ha fatto un beneficio taccia, parli chi lo ha ricevuto. Altrimenti si dirà ciò che un tale disse a uno che si vantava con tutti dei suoi benefìci: «Non dirai di non aver ricevuto il contraccambio». «Quando?». «Spesso, e in molte occasioni, cioè tutte le volte e in tutte le circostanze in cui ne hai parlato». Che bisogno c’è di parlare, che bisogno c’è che tu faccia per primo ciò che spetta a un altro? C’è chi può farlo in modo più dignitoso, e se sarà lui a parlare, tu sarai lodato anche per aver taciuto. Mi giudichi un ingrato se pensi che, tacendo tu, nessuno verrà a sapere del bene che mi hai fatto. E bisogna evitare di pubblicizzare il bene fatto, a tal punto che, anche se qualcuno ne parlerà davanti a noi, gli si risponda: «Quell’uomo meriterebbe senz’altro maggiori benefìci, e io vorrei dargli più di quanto gli ho dato finora». Ciò va detto non servilmente e neppure con quell’atteggiamento con cui alcuni rifiutano le lodi che invece vorrebbero attirarsi. In più bisogna aggiungere al beneficio ogni gentilezza possibile. Come fa l’agricoltore, che non abbandona il suo lavoro subito dopo avere sparso i semi, per non perdere ciò che ha seminato: molte cure conducono le sementi a messe; non nasce frutto, se non c’è dall’inizio alla fine una coltivazione costante. Lo stesso vale per i benefìci. Ci sono forse benefìci maggiori di quello che un padre fa per i figli? Eppure, anche questo è vano se ci si ferma all’infanzia, se il dono non viene
alimentato da un affetto continuo. Così è pure per gli altri benefìci: se non li sosterrai, li perderai; averli dati è poco, bisogna curarli. Se vuoi che ti sia grato chi è in debito con te, oltre che fargli del bene, devi amarlo. Soprattutto, come ho detto, occorre risparmiargli le orecchie, nel senso che non si deve offenderlo, perché un richiamo produce fastidio, un rimprovero odio. La prima cosa che bisogna evitare nel concedere un beneficio è l’alterigia. Che bisogno c’è di un’aria arrogante, di parole enfatiche? L’atto stesso del donare ti rende grande. Bisogna eliminare ogni vanto inutile, parlano i fatti, non le parole. Un beneficio dato con arroganza è non solo sgradito, ma odioso. 12. Gaio Cesare6 diede la vita a Pompeo Peno, se non toglierla significa darla. Poi, mentre lui, liberato, lo ringraziava, gli tese il suo piede sinistro affinché lo baciasse. Chi cerca di scusarlo, dicendo che con quel gesto non intendeva offenderlo, sostiene che volle mostrargli il suo sandalo dorato, anzi, d’oro tempestato di perle. Proprio così: che affronto c’è se un ex console baciò l’oro e le perle, perché diversamente non avrebbe saputo scegliere nel corpo di Cesare nessuna parte più degna da baciare? Quest’uomo, nato per cambiare i costumi di una città libera in una servitù degna dei Persiani, non ritenne sufficiente che un senatore, un vecchio, uno che aveva ricoperto le cariche più alte, si fosse prostrato davanti a lui, in presenza dei notabili, in atteggiamento supplice, come i vinti di fronte al vincitore, ma trovò un modo per abbassare la libertà al di sotto delle sue ginocchia. Questo non è forse calpestare lo Stato, e per di più, anche se può sembrare un dettaglio da nulla, col piede sinistro? In realtà quella insolenza non sarebbe stata abbastanza sfacciata e vergognosa se l’imperatore, che aveva assistito in pantofole a un processo capitale a un ex console, non avesse ficcato in bocca a un senatore il legno dei suoi sandali. 13. O superbia, figlia di una grande fortuna! O stoltissimo male! Come è meglio non accettare niente da te! Come trasformi ogni beneficio in un’offesa! Come ti piace ogni eccesso! Come nulla ti si conviene! Quanto più ti innalzi, tanto più finisci in basso e mostri che non ti è dato di conoscere veramente questi beni per i quali ti gonfi tanto; tu guasti tutto ciò che dài. Mi piacerebbe dunque chiedere perché cammini con tanto sforzo a testa alta, perché alteri i lineamenti e l’espressione del volto a tal punto da preferire una maschera a una faccia. I doni che fanno piacere sono quelli che si offrono con un’espressione benevola, o quanto meno dolce e tranquilla, che, pur provenendo da una persona superiore, non le dànno alcun motivo per mettere arrogantemente sotto i piedi il beneficato, ma anzi dovrebbero indurla a essere quanto più possibile benevola, al punto da porsi allo stesso livello di lui, da togliere ogni ostentazione al suo gesto e cogliere il momento opportuno per donare, sì da soccorrerlo prima invece che in condizioni di estrema necessità. C’è un solo modo per persuadere costoro a non vanificare i loro benefìci per l’arroganza con cui li concedono: mostrargli che le cose non risultano più
importanti se sono date in modo più appariscente, che a nessuno sembrano tali per questo loro atteggiamento, che la grandezza tipica della superbia è inconsistente e tale da far odiare anche quelle azioni che dovrebbero essere amate. 14. Ci sono doni che nuocerebbero a chi li chiede, e in questo caso il beneficio consiste non nel darli, ma nel negarli; quindi bisogna tener conto della loro utilità più che del desiderio di chi ne fa richiesta. Spesso, infatti, bramiamo cose nocive e non riusciamo a capire quanto ci danneggerebbero, perché la passione disturba le nostre facoltà di giudizio; ma quando la brama si è placata, quando è venuta meno quella foga che impedisce di riflettere, malediciamo chi ci ha procurato del male con dei doni dannosi. Come non si dà l’acqua fredda agli ammalati e un’arma a chi è afflitto o adirato con sé stesso, come agli innamorati si nega tutto ciò che sono spinti a chiedere per via di una passione sfrenata, e che potrebbero usare contro sé stessi, così bisogna essere fermi e decisi nel non concedere cose che potrebbero arrecar danno, anche se vengono chieste con insistenza, con umiltà e talvolta in modo da destare compassione. Bisogna infatti badare non solo agli effetti immediati dei benefìci, ma anche alle loro ultime conseguenze, e concedere cose che siano gradite non solo nel momento in cui si ricevono ma anche dopo che si sono ricevute. Molti dicono: «So che questo non gli gioverà, ma cosa dovrei fare? Lui me lo chiede, e io non posso resistere alle sue preghiere: fatti suoi, si lamenterà di sé stesso, non di me». Ciò è sbagliato: si lamenterà proprio di te, e a ragione; quando sarà tornato in sé, quando si sarà placata quella febbre che gli infiammava l’animo, perché non dovrebbe odiare chi gli ha dato una mano a procurarsi danno e pericolo? Lasciarsi vincere dalle preghiere di chi chiede qualcosa che lo danneggerà è una bontà crudele. Come è un’azione bellissima salvare, loro malgrado, coloro che non vogliono essere salvati, così donare cose funeste a coloro che le chiedono significa odiarli, sotto una gentilezza e cortesia apparenti. Dobbiamo concedere benefìci che con l’uso piacciano sempre di più, che non diventino un danno. Non darò mai del denaro a chi so che con quello pagherà un’adultera, non mi farò suo complice in un’azione o in un piano disonesti; se potrò, lo dissuaderò, altrimenti non lo aiuterò nel suo misfatto. Sia che l’ira lo spinga dove non dovrebbe, sia che un’ardente brama lo allontani dalla retta via, non permetterò che altre forze oltre alle sue lo conducano al male e che un giorno possa dire: «Quell’uomo, pur volendomi bene, mi ha rovinato». Spesso non c’è alcuna differenza fra i doni degli amici e i voti dei nemici; questi ultimi desiderano che ti accada qualcosa di male, l’avventata bontà degli amici ti spinge verso il male, anzi, te lo procura. Cosa c’è di più turpe di un fatto così frequente qual è la confusione che nasce fra il beneficio e l’odio che esso può generare? 15. Non dobbiamo neppure concedere cose di cui poi potremmo vergognarci.
Il culmine dell’amicizia consiste nel rendere l’amico uguale a noi, sicché occorre badare contemporaneamente sia a noi che a lui, pensando: gli darò quando ne avrà bisogno, ma in modo da non aver bisogno io; lo soccorrerò se sta per morire, ma in modo da non morire io, a meno che questo non sia il prezzo da pagare per salvare un grand’uomo o un grande bene. Non concederò alcun beneficio di cui mi vergognerei se lo chiedessi io. Non aumenterò il valore di un dono di poco conto né permetterò che cose di valore vengano ricevute come cose da nulla, poiché come chi esagera il valore di ciò che ci dà distrugge tutta la bellezza del dono, così chi sottolinea il valore del suo dono non lo rinfaccia, lo fa solo apprezzare. Ciascuno deve valutare i propri mezzi e le proprie possibilità per non dare né più né meno di quanto può; va considerata anche la personalità di colui a cui il dono è destinato: alcuni doni, infatti, sono troppo piccoli per persone di alto rango, altri troppo grandi per chi li riceve. Fa’ dunque un confronto fra i due casi e analizza bene il dono, per stabilire se sia troppo oneroso o troppo piccolo per chi lo dà e se il ricevente potrà disprezzarlo o non capirlo. 16. Alessandro, un folle che concepiva solo idee esagerate, regalò a un tale una città. Poiché il destinatario, che conosceva il proprio valore, obiettò che quel dono non si addiceva alla sua condizione, sfuggendo così agli odi che un simile beneficio poteva generare, Alessandro gli rispose: «M’interessa non quale dono si convenga a te, ma cosa convenga a me che ti regali».7 Sembra un’espressione fiera e degna di un re, ed è invece stoltissima, poiché non esiste cosa che convenga a qualcuno di per sé stessa, ciò che importa è chi dà, a chi, quando, dove, perché e tutto ciò che serve a stabilire il valore del gesto. Che individuo gonfio d’orgoglio! Se a lui non si addice accettare quel dono, a te non si addice darlo. Bisogna infatti tener conto della personalità e della posizione sociale, e poiché la virtù è in ogni caso la giusta misura, pecca tanto chi sbaglia per eccesso quanto chi sbaglia per difetto. Ammettiamo pure che tu abbia una simile possibilità e che sia stato portato dalla fortuna così in alto da poter donare addirittura delle città (quanto sarebbe stato più nobile, però, non espugnarle piuttosto che distribuirle!), tuttavia c’è qualcuno che è troppo piccolo per mettergli fra le braccia una città. 17. Un Cinico chiese ad Antigono 8 un talento e lui rispose che era più di quanto un Cinico dovesse chiedere. Quello, allora, di rimbalzo, gli chiese un denaro, al che Antigono rispose che era meno di quanto a un re si addicesse concedere. Un cavillo del genere è vergognosissimo, visto che in quel modo ha trovato il pretesto per non dare né l’uno né l’altro. Nel caso del denaro ha guardato al re, nel caso del talento al Cinico, mentre avrebbe potuto dare sia un denaro, considerando quello come Cinico, sia un talento, considerando sé stesso come re. Se è vero che un dono è troppo grande perché un Cinico lo accetti, non ne esiste nessuno così piccolo che la bontà di un re non possa concedere senza
perdere il suo onore. Se vuoi saperlo ti dirò che io approvo quel gesto, perché è inammissibile chiedere del denaro e disprezzarlo. Hai dichiarato odio al denaro, vai proclamando questa tesi, hai assunto questa parte: devi recitarla. È decisamente ingiusto che tu ti vanti della tua povertà e al tempo stesso ti arricchisca. Dobbiamo dunque considerare sia la nostra personalità, sia quella di colui che intendiamo aiutare. Voglio servirmi di una similitudine del nostro Crisippo relativa al gioco della palla: se la palla cade la colpa è o di chi l’ha lanciata o di chi doveva riceverla; mantiene il suo ritmo quando, lanciata e ricevuta in modo corretto, passa dalle mani dell’uno a quelle dell’altro. Bisogna, però, che un buon giocatore la tiri diversamente a seconda che il compagno sia alto o basso. Ebbene, la stessa regola vale per il beneficio: se non si conforma alla personalità di colui che lo dà e di colui che lo riceve non uscirà dalle mani dell’uno e non giungerà nelle mani dell’altro come si deve. Se il nostro compagno è allenato ed esperto lanceremo la palla con minore precauzione, poiché sappiamo che in qualunque modo gli arriverà lui la rinvierà con mano agile e pronta; se invece giochiamo con un principiante inesperto la lanceremo non a tutta forza, tendendo il braccio energicamente, ma in modo più dolce, quasi indirizzandola nelle mani di lui come andandogli incontro benevolmente. La stessa cosa bisogna fare coi benefìci: educare gli altri e mostrarci soddisfatti se loro si sforzano, se osano, se hanno buona volontà. Siamo noi stessi a rendere ingrati i più e a far sì che lo siano, come se i nostri benefìci fossero grandi solo se è venuta a mancare la riconoscenza, comportandoci così come i giocatori in mala fede, il cui obiettivo è quello di far ridere alle spalle del compagno, rovinando il gioco stesso, che non può proseguire se non c’è intesa. Molti sono di natura così malvagia che preferiscono perdere il dono fatto piuttosto che apparire come chi ha ricevuto un contraccambio, superbi che considerano un credito i benefìci che hanno concesso. Com’è più nobile e più onesto agevolare chi ha ricevuto un beneficio nel suo tentativo di contraccambiare, ascoltando benevolmente le sue parole di gratitudine, come se la testimoniasse con azioni concrete, andandogli incontro a tal punto da aiutarlo a disobbligarsi dopo che col nostro dono lo abbiamo costretto a indebitarsi! Di solito si sente parlar male di un usuraio se si mostra aspro nel ricevere indietro la somma prestata, oppure se è lento e indugia nel contare il denaro, sollevando mille difficoltà. Accettare la restituzione di un beneficio è un dovere come il non pretenderla. Ottimo uomo è quello che dà con facilità, che non pretende mai il contraccambio, che gioisce, certo, quando lo riceve, ma che in buona fede ha dimenticato ciò che ha fatto per gli altri, che riceve il contraccambio con la stessa disposizione d’animo di colui che riceve il beneficio. 18. Alcuni non solo dànno i benefìci con arroganza, ma anche nel riceverli
mostrano lo stesso atteggiamento. Non bisogna agire così. Con ciò passiamo ad affrontare la seconda parte della questione: come comportarsi quando si riceve un beneficio. Ogni tipo di legame che coinvolge due persone impone a entrambe uguali doveri: se avrai indagato quale debba essere la condotta di un padre, ti renderai conto che non occorre minore fatica per stabilire come debba essere un figlio; così il marito ha alcuni doveri, ma non minori sono quelli della moglie. In questo genere di obbligazioni reciproche ciascuno ha tanti diritti quanti doveri e vige una regola di parità che, come dice Ecatone, è difficile: il bene, infatti, è sempre difficile, e così pure ciò che gli è vicino, perché il bene non deve solo essere fatto ma va compiuto secondo ragione. Questa dev’essere la guida della nostra vita, alla quale devono ispirarsi tutte le nostre azioni, dalle più banali alle più importanti: in base ai suoi consigli dobbiamo dare e ricevere. Ora, come prima cosa, essa stabilirà che non si deve accettare da tutti. Da chi, dunque, accetteremo? Ti rispondo in poche parole: da coloro ai quali avremmo donato. Vediamo perché. Non occorre maggior discernimento per trovare qualcuno degno della nostra riconoscenza che per trovare qualcuno degno del nostro aiuto? Infatti, supponendo che non ne conseguano altri inconvenienti (ma di fatto ne conseguono moltissimi), è un grave tormento essere in debito con chi non vorresti, mentre è piacevolissimo aver ricevuto un beneficio da chi potresti amare anche dopo che ti avesse offeso, soprattutto se qualche motivo ha reso anche giusta quell’amicizia che prima era solo piacevole. Per un uomo rispettabile e onesto è assai triste se deve amare qualcuno che non gli garba. Devo ricordare che parlo non dei saggi, per i quali ogni dovere è un piacere, che hanno il dominio sul loro animo, si impongono la legge che vogliono e coerentemente la rispettano, ma degli uomini imperfetti che vogliono seguire la via della virtù e le cui passioni obbediscono solo dopo continue lotte. Per questo bisogna sceglierla la persona da cui accettare un beneficio, e in verità occorre cercare con maggior cura chi ci elargisce un beneficio che non chi ci concede un prestito: a quest’ultimo, infatti, devo restituire solo quanto ho ricevuto, e una volta restituitolo sono libero e sciolto da ogni obbligo, mentre all’altro devo rendere di più e anche dopo aver contraccambiato resto sempre legato per via dell’amicizia, e devo ricominciare di nuovo, e come non accoglierei fra i miei amici chi ne fosse indegno, così sarà anche per il legame sacro che riguarda i benefìci, dal quale nasce appunto l’amicizia. «Non sempre posso dire “Non voglio”», si obietterà: «talvolta si deve accettare il beneficio anche contro voglia. Se me lo dà un tiranno crudele e collerico, per il quale è un oltraggio che si accolga malvolentieri il suo dono, che faccio, non lo accetto? Al posto suo metti un bandito, un pirata, un re che ha l’animo di un bandito e di un pirata: che farò? Un uomo simile è indegno che io sia in debito con lui?». Quando dico che bisogna scegliere la persona con cui essere in debito escludo i casi di forza maggiore e di intimidazione, di fronte ai quali la possibilità di scelta non esiste. Se sei libero, se dipende solo da te
volere o non volere, la decisione sarà tua, se invece sei costretto e non hai facoltà di scelta, penserai che non accetti, ma obbedisci. Non si assume un obbligo accettando una cosa che non si ha la possibilità di rifiutare; se vuoi sapere se voglio fa’ sì che io possa anche non volere. «E se ti ha donato la vita?». Non importa cos’è ciò che si dà, se non è dato da chi vuole dare a chi vuole ricevere: se mi hai salvato la vita non per questo sei il mio salvatore. Il veleno a volte serve come rimedio, tuttavia non lo si annovera fra le cose salutari. Alcune azioni ci tornano utili, ma non per questo siamo obbligati verso chi le compie: un tale che si era avvicinato a un tiranno per ucciderlo, gli tagliò un ascesso con la spada, ma il tiranno, visto che voleva ucciderlo, non lo ringraziò, anche se lo guarì da un male su cui i medici non avevano osato intervenire. 19. Come vedi, l’atto del donare in sé non ha grande importanza, poiché non ci concede un beneficio chi ci fa del bene con intenzioni cattive: il beneficio, nell’episodio su riportato, è da ascrivere al caso, l’offesa all’uomo. Nell’anfiteatro abbiamo visto un leone che avendo riconosciuto fra i bestiari9 colui che un tempo era stato il suo domatore lo ha difeso contro l’assalto delle belve: è un beneficio l’aiuto di una fiera? Per niente, poiché quello che ha fatto l’animale non nasceva da un atto di volontà, né lei ne era consapevole. Ora, metti il tiranno al posto della fiera: entrambi hanno donato la vita, ma nessuno dei due ha fatto un beneficio, perché non è un beneficio essere costretti ad accettare, come non lo è essere in debito verso chi non si vorrebbe. Insomma, prima del beneficio bisogna concedere la facoltà di scegliere liberamente. 20. A proposito di Marco Bruto 10 solitamente si dibatte la questione se avrebbe dovuto accettare la vita dal divo Giulio, quando invece pensava che si dovesse ucciderlo. Esamineremo un’altra volta i motivi che lo indussero a farlo fuori. A me sembra che, pur essendo stato un grand’uomo in altre occasioni, in quella abbia commesso un grave errore e non si sia comportato secondo i princìpi stoici. O ebbe paura del titolo di re, mentre la condizione migliore per lo Stato è sotto un re giusto, oppure sperò che potesse esserci libertà dove c’erano tanti vantaggi sia nel comandare sia nel servire, oppure ritenne che lo Stato, una volta scomparsi gli antichi costumi, potesse essere riportato alla costituzione precedente, che ci sarebbe stata uguaglianza di diritti fra i cittadini e che le leggi sarebbero state stabili là dove aveva visto tante migliaia di uomini combattere per decidere non se essere schiavi, ma chi servire fra i due contendenti. Aveva dimenticato le leggi della natura e la condizione della sua città per credere che, ucciso uno, non ce ne sarebbe stato un altro che volesse le stesse cose, quando era stato trovato un Tarquinio 11 dopo tanti re uccisi dalle spade o dai fulmini! Tuttavia dovette accettare la vita da Cesare, ma non per questo lo considerò come un padre, perché aveva acquisito il diritto di fare del bene attraverso un’ingiustizia. In realtà chi non lo uccise non lo salvò, e gli
concesse una grazia, non un beneficio. 21. Questo argomento potrebbe essere motivo di un qualche dibattito su che cosa debba fare un prigioniero, se la somma per il riscatto gli viene promessa da un uomo che ha prostituito il suo corpo e infamato la sua bocca. Permetterò che mi salvi un impuro? E una volta salvato, quale riconoscenza gli mostrerò? Dovrei vivere con un uomo immondo? Dovrei rifiutare di vivere con chi mi ha riscattato? Io penso che accetterei il denaro per il riscatto anche da un uomo simile, ma come un prestito, non come un beneficio; gli restituirò il denaro e se avrò l’occasione di salvarlo da un pericolo lo salverò; ma non mi abbasserò a prenderlo come amico, perché l’amicizia è un vincolo che unisce il simile col simile, né lo giudicherò mio salvatore ma lo terrò in conto di un usuraio, al quale so che devo restituire ciò che mi ha prestato. Se qualcuno è degno che io accetti il suo beneficio, ma questo lo danneggerà, io non lo accetterò, in quanto egli è pronto a giovarmi ma con suo danno e pericolo. Così pure se vorrà difendermi in un processo, ma attirandosi l’inimicizia del re. Possa io essergli nemico se, volendo lui rischiare per difendermi, non faccio la cosa più semplice, cioè rischiare senza coinvolgerlo. Questo esempio di Ecatone a proposito di Arcesilao è quanto mai sciocco e insulso: egli dice che rifiutò del denaro, portatogli da un figlio minorenne, per non offendere il padre, che era avaro. Che cosa fece di lodevole, se rifiutò ciò che era un furto, se preferì non accettare, piuttosto che dover poi restituire? E che saggezza c’è nel non accettare quel che appartiene ad altri? Un esempio di agire nobile è quello di Giulio Grecino,12 uomo straordinario, che Gaio Cesare uccise solo perché era migliore di quanto potesse far comodo a un tiranno. Egli accettò il denaro datogli dagli amici per contribuire alle spese dei giochi pubblici, ma non accettò una somma ingente inviatagli da Fabio Persico,13 e poiché alcuni di quelli che guardano solo ai doni, non al donatore, gli rimproveravano di aver rifiutato, rispose: «E io dovrei accettare un beneficio da colui dal quale non accetterei un brindisi?». E quando Rebilio,14 ex console altrettanto disonesto, gli mandò una somma ancora maggiore e insistette perché ordinasse di accettarla, disse: «Ti prego di perdonarmi, ma non ho accettato neppure da Persico». Questo è solo accettare o non accettare dei doni, o non è piuttosto giudicare dei senatori? 22. Quando abbiamo deciso di accettare un beneficio accogliamolo con gioia, mostrandoci contenti, sì che il donatore lo noti, ricavandone un frutto immediato: è un motivo legittimo di gioia vedere l’amico contento; mostriamo dunque di aver gradito quel dono esternando liberamente i nostri sentimenti, non solo davanti a lui ma in ogni circostanza. Chi prova gratitudine nel ricevere un beneficio ha già pagato la prima rata del suo debito. 23. Ci sono alcuni che vogliono accettare i doni solo in segreto, evitando che
siano presenti testimoni o vengano comunque a conoscenza del beneficio: sappi che queste persone sono malintenzionate. Come il donatore deve pubblicizzare il suo regalo nella misura in cui farà piacere al destinatario, così chi lo riceve deve chiamare il pubblico a testimone: se si vergogna di essere in debito, non avrebbe dovuto accettare. Alcuni ringraziano di nascosto, in un luogo appartato e avvicinandosi all’orecchio del donatore; questa non è riservatezza, è un modo di negare il proprio debito: è un ingrato chi ringrazia lontano da testimoni. C’è poi chi non vuole che il suo nome venga scritto, che ci siano intermediari o che vengano chiamati testimoni per firmare, si limita a rilasciare una dichiarazione, così come fanno quelli che cercano in ogni modo di tenere il più possibile segreto il dono ricevuto. Hanno paura di renderlo noto al pubblico in quanto vogliono far credere di averlo ottenuto per i loro meriti non per un aiuto esterno, e sono poco assidui nell’adempiere al loro dovere verso uno a cui magari devono la vita o la posizione sociale, così nel timore di passare per clienti passano per ingrati (il che è molto più grave). 24. C’è poi chi parla male proprio di quelle persone da cui ha ricevuto di più. Alcuni è meno rischioso offenderli che renderli obbligati, poiché per non far vedere di essere in debito ricorrono all’odio. Eppure la cosa di cui dobbiamo preoccuparci di più è custodire il ricordo dei nostri debiti, che va rinnovato continuamente, perché non si può mostrare la propria riconoscenza se non ricordando il beneficio ricevuto, e il solo fatto di ricordare ne è una testimonianza. Nell’accettare il dono non si deve essere né schizzinosi né servili. Chi è indifferente nel momento in cui lo riceve, quando il dono è gradito per la sua novità, cosa farà quando il piacere iniziale si sarà indebolito? C’è poi chi accetta il dono sdegnosamente, come se dicesse: «Non ne ho bisogno, ma, dato che insisti tanto, farò come vuoi tu». Un altro accetta passivamente, talché il donatore dubita persino che non se ne sia accorto, oppure borbotta qualche parola stentata, mostrandosi così più ingrato che se avesse taciuto. Le parole di ringraziamento devono essere in proporzione alla grandezza del dono che si riceve, e magari sarebbe bene aggiungere: «Più persone di quante credi sono in obbligo verso di te» (tutti infatti sono contenti che il valore del suo beneficio aumenti); «Mi hai fatto un gran favore, ma devo dirti che è superiore a quello che pensi» (chi aumenta il proprio debito si mostra subito riconoscente); «Non potrò mai dimostrarti abbastanza la mia riconoscenza, non smetterò di dichiararlo in ogni occasione, la mia gratitudine non sarà mai sufficiente». 25. Con nessun altro gesto Furnio15 si ingraziò maggiormente Augusto, rendendolo ben disposto a concedergli altri favori, che col dirgli, chiedendogli la grazia per suo padre, partigiano di Antonio: «Questa è l’unica offesa che ho ricevuto da te, Cesare: hai fatto sì ch’io vivessi e morissi da ingrato». Niente potrebbe testimoniare meglio la propria riconoscenza che l’essere sempre e in qualunque modo scontenti di sé, il non osare neppure sperare di uguagliare con
un proprio beneficio i benefìci ricevuti. Sull’esempio di queste e di altre espressioni del genere, adoperiamoci affinché la nostra disposizione d’animo non resti nascosta, ma sia chiaramente manifesta. Anche se mancano le parole, se i nostri sentimenti sono giusti si rifletteranno sul nostro volto. Chi vorrà essere riconoscente pensi subito, nel momento stesso in cui riceve, a restituire il beneficio. Crisippo dice che il beneficato deve fare come l’atleta, il quale, chiuso dietro le sbarre, è pronto per una gara di corsa e aspetta il momento opportuno per scattare, appena dato il segnale, e ha bisogno di una grande energia e di una grande agilità per raggiungere chi gli sta davanti. 26. Ora dobbiamo esaminare le cause principali dell’ingratitudine. Ciò che rende ingrati sono un troppo alto concetto di sé, il senso di ammirazione, insito nella natura umana, delle proprie cose e di sé stessi, l’avidità o l’invidia. Esaminiamo la prima causa. Ciascuno di noi è giudice benevolo di sé stesso, perciò ritiene di meritare tutto ciò che riceve come un pagamento dovuto, anzi, di non essere stimato abbastanza per quello che vale. «Sì, me lo ha dato, ma dopo molto tempo e tante fatiche! Quanto di più avrei potuto ottenere se mi fossi dedicato a questo o a quello, o a me stesso? Non era questo che avevo sperato: sono stato gettato nella massa, mi ha giudicato degno di così poco? Mi sarebbe stato più onorevole essere dimenticato». 27. Lentulo, l’augure,16 massimo esempio di ricchezza, prima che i liberti lo riducessero in povertà, uno che vide il proprio patrimonio di quattrocento milioni di sesterzi (ho detto giusto perché non faceva altro che guardarselo), fu di debole intelletto e di animo piccino. Pur essendo avarissimo, la sua conversazione era così povera che tirava fuori più soldi che parole, e benché dovesse tutti i suoi acquisti al divo Augusto, a cui aveva portato la sua povertà resa ancora più grave dal peso di un nome nobile, divenuto il primo cittadino per ricchezza e per prestigio, si lamentava spesso di lui dicendo che lo aveva distolto dagli studi e che tutti i beni di cui l’aveva colmato non compensavano quel che aveva perso lasciando l’oratoria. E sì che il divo Augusto gli aveva fatto anche il favore di sottrarlo alla derisione o a una fatica inutile. L’avidità non consente di essere riconoscenti, poiché chi nutre speranze eccessive non si accontenta mai di quel che ottiene: quanto più numerosi sono i doni che riceviamo, tanto più crescono i nostri desideri, e l’avidità è molto più grande in chi ha accumulato ingenti ricchezze, come la violenza della fiamma è tanto maggiore quanto più esteso è l’incendio da cui si è sprigionata. Analogamente l’ambizione non ci consente di accontentarci di aver raggiunto quella posizione sociale che un tempo era stata il nostro sogno più ardito: non c’è uno che ringrazi per aver ottenuto un tribunato, ma ci si lamenta perché a quella carica non è seguita la pretura; e neppure questa riesce gradita se non le si aggiunge il consolato, il quale pure non soddisfa se lo si ottiene una volta sola. L’avido pretende sempre di più, vuole andare sempre più in alto e non si rende
conto di quanto sia stato fortunato, perché guarda dove vuole arrivare, non da dove è partito. 28. Il più violento e molesto di questi mali è l’invidia, la quale ci mette in uno stato di ansia con i confronti che facciamo fra noi e gli altri: «A me ha dato questo, ma a quello ha dato di più e a quell’altro con maggiore sollecitudine. E poi persegue solo il proprio interesse, non appoggia la causa di alcuno». Quanto è più semplice e più saggio accrescere il valore del beneficio ricevuto, pensare che nessuno può avere per noi tanta stima quanta noi ne abbiamo per noi stessi! Dovremmo dire: «Avrei dovuto ricevere di più, ma lui non poteva, perché la sua generosità doveva dividersi fra molti. E poi questo è solo l’inizio, accontentiamoci e intanto facciamogli vedere la nostra gratitudine per quel che ci ha donato: ha dato poco, ma darà più spesso; ha anteposto quello a me, ma anche me a molti altri; quello non mi eguaglia in virtù né in servigi, ma è stato fortunato; se mi lamento, oltre che non rendermi degno di altri e più grandi doni, mi dimostro indegno di quelli che ho ricevuto. Uomini del tutto ignobili hanno avuto di più? Che cosa importa? Com’è raro il giudizio della sorte! Ogni giorno ci lamentiamo perché i malvagi sono felici: spesso la grandine risparmia i poderi dei più cattivi e danneggia le messi dei migliori. Come nelle altre cose, così anche nelle amicizie ognuno ha il suo destino». Nessun beneficio è così completo da non poter essere denigrato dalla malignità, nessuno è così piccolo che un’interpretazione benevola non ne possa accrescere il valore. Se guardiamo i benefìci dal lato peggiore troveremo sempre motivi per lamentarci. 29. Pensa quanto sono ingiusti nel valutare i doni degli dèi anche coloro che fanno professione di saggezza!17 Si lamentano che non eguagliamo per grandezza del corpo gli elefanti, in velocità i cervi, in leggerezza gli uccelli, per lo slancio i tori, che la pelle delle bestie feroci sia più spessa, quella dei daini più bella, quella dei castori più morbida, quella degli orsi più folta, che i cani ci superino quanto a olfatto, le aquile nell’acutezza della vista, i corvi nella durata della vita e molti animali nel nuoto. E benché la natura non consenta che in uno stesso animale si trovino riunite certe qualità, come l’agilità e la forza fisica, considerano un’ingiustizia il fatto che l’uomo non possieda qualità diverse e incompatibili e dicono che gli dèi non si curano di noi poiché non ci hanno dato né una salute che fosse inattaccabile persino dai vizi, né la conoscenza del futuro. Sono così sfrontati che a mala pena si trattengono dallo spingersi fino a odiare la natura per il fatto che siamo inferiori agli dèi e non al loro livello. Quanto meglio sarebbe, invece, volgersi a contemplare la quantità e l’entità dei benefìci ricevuti da loro e ringraziarli per averci dato, in questa bellissima dimora, il secondo posto e il comando di tutto ciò che c’è sulla terra! Si potrebbero forse paragonare a noi quegli animali sui quali abbiamo un potere quasi assoluto? Tutto ciò che ci è stato negato non poteva esserci dato.
Perciò, chiunque tu sia, giudice ingiusto della sorte degli uomini, pensa quante cose ci ha concesso il nostro creatore, quanto più forti siano gli animali che con tutta la loro forza abbiamo soggiogato, quanto più veloci siano quelli che catturiamo e come niente di ciò che è mortale riesca a sfuggire ai nostri colpi. Abbiamo ricevuto tante virtù, tanta abilità e soprattutto l’intelligenza, alla quale, se s’impegna, nulla è precluso e che è più veloce delle stelle, di cui prevede con secoli di anticipo i percorsi; e oltre a tutto questo tanti prodotti del suolo, tante ricchezze, e tante altre cose che si accumulano le une sulle altre. Conta tutte le specie degli esseri viventi e, poiché non troverai nessuno di essi con cui vorresti far cambio, considerandone ogni aspetto, prendi da ciascuno le qualità che vorresti avere. Ebbene, se consideri quanto sia stata generosa la natura non puoi non riconoscere di essere il suo favorito. È così: siamo sempre stati e siamo tuttora carissimi agli dèi, i quali, concedendoci il massimo onore possibile, ci hanno posto appena un gradino al di sotto di loro. Abbiamo ricevuto grandi doni: più di così sarebbero stati superiori alle nostre capacità. 30. Ho ritenuto di dover dire queste cose, mio caro Liberale, sia perché, parlando dei benefìci più piccoli, occorreva ch’io accennassi anche a quelli più grandi, sia perché è da lì che si estende a tutto il resto la sfrontatezza di questo detestabile vizio dell’ingratitudine. Con chi, infatti, si mostrerà riconoscente, quale dono giudicherà importante o degno di contraccambio colui che disprezza i benefìci più grandi? A chi si sentirà debitore della propria salvezza, della propria vita, chi nega di aver ricevuto la vita dagli dèi, quella vita che chiediamo loro ogni giorno? Ecco perché chi insegna a essere riconoscenti difende sia la causa degli uomini sia quella degli dèi, ai quali, anche se non hanno bisogno di nulla e sono al di sopra di ogni desiderio, possiamo tuttavia mostrare la nostra riconoscenza. Né si cerchi una scusa per la propria ingratitudine nella debolezza e nella povertà, dicendo: «Che potrei fare, e in quale modo? Come posso dimostrare la mia riconoscenza a coloro che stanno tanto al di sopra di me e sono i padroni di tutte le cose?». Non è difficile dimostrarla: se sei tirchio non c’è bisogno che tu spenda denaro, se sei pigro non devi fare alcuna fatica. Se vuoi puoi estinguere il tuo debito verso chiunque nel momento stesso in cui ricevi il beneficio: basta che lo accetti di buon grado. 31. Questo è uno dei paradossi della scuola stoica, a mio giudizio il meno sorprendente e il meno difficile da credere: chi riceve di buon animo ha già reso il contraccambio. Se infatti rapportiamo ogni azione all’intenzione, e ciascuno agisce in proporzione alla sua volontà, e poiché la pietà, la fedeltà, la giustizia e tutte le altre virtù sono già perfette in sé stesse anche se non si è avuta la possibilità di metterle in atto, ne consegue che un uomo può mostrarsi riconoscente anche solo volendo esserlo. Ogni volta che si raggiunge l’obiettivo prefisso si coglie il frutto della propria fatica. Ebbene, chi concede un beneficio cosa si prefigge? Di aiutare colui al quale dona e di fargli piacere. Se ha
realizzato ciò che voleva e la sua disposizione d’animo si è comunicata al beneficato, generando una gioia condivisa, ha raggiunto il suo scopo. La sua intenzione, infatti, non era quella di ricevere un contraccambio, altrimenti il suo non sarebbe stato un beneficio, si sarebbe trattato di un affare. Ha navigato bene chi ha raggiunto il porto stabilito; una freccia lanciata da una mano sicura adempie alla sua funzione se colpisce il bersaglio; così chi concede un beneficio desidera che sia accolto con piacere, e se è bene accetto ha raggiunto lo scopo. Se invece sperava anche in un guadagno il suo non è stato un beneficio, la cui peculiarità sta proprio nel non prevedere un contraccambio. Ho accettato ciò che mi è stato dato con la stessa disposizione d’animo con cui mi veniva elargito, dunque ho contraccambiato, diversamente la cosa migliore sta nella condizione peggiore, cioè, per mostrarmi riconoscente mi rimetto alla fortuna. Ma se non sono in grado di contraccambiare perché la sorte mi è avversa basterà la mia disposizione d’animo in risposta a quella del donatore. «Ma come?», si dirà. «Non devo fare tutto il possibile per contraccambiare, cercare il momento, le occasioni opportune, e non sarò impaziente di colmare di beni colui che mi ha donato qualcosa?». Ebbene, se non è possibile manifestare la propria riconoscenza anche a mani vuote il beneficio non esiste più. 32. Si dirà: «Chi ha ricevuto un beneficio, pur avendolo accolto con la migliore disposizione d’animo, non ha compiuto tutto il suo dovere, ne resta ancora una parte: la restituzione. Come nel gioco della palla, in cui è già un merito riceverla con destrezza e abilità, ma non può chiamarsi giocatore esperto se non chi la rimanda bene e prontamente». L’esempio non è pertinente. Perché? Perché in questo caso il merito consiste nel movimento e nell’agilità fisica, non nella disposizione d’animo: si devono compiere tutti quei gesti che si misurano con gli occhi. Tuttavia non definirei bravo quel giocatore che ha ricevuto la palla come si doveva se il ritardo nel rilanciarla non è dipeso da lui. «Ma pur non mancando nulla alla sua abilità di giocatore, perché ha fatto solo una parte ma è capace di fare anche la parte che non ha fatto, il gioco è imperfetto, perché si effettua compiutamente solo con l’alternanza di lancio e rilancio». Non voglio portare per le lunghe la confutazione di questa tesi, ma ammettiamo che sia come tu dici, che cioè manchi qualcosa al gioco, non al giocatore; e anche nel caso in questione manca qualcosa a ciò che si dà, e che richiede un contraccambio, ma non all’intenzione, che ne ha incontrata una pari a sé e, per quanto stava in essa, ha raggiunto il suo scopo. 33. Mi ha concesso un beneficio e io l’ho accettato come voleva lui, il quale in questo modo ha ottenuto l’unica cosa che desiderava: dunque gli ho dimostrato la mia riconoscenza. Ora gli restano la possibilità di servirsi di me e quei vantaggi che si traggono da un uomo riconoscente. Ebbene, questo non è il resto che si deve a un dovere incompleto, è un’aggiunta al suo compimento. Fidia fa
una statua: una cosa è il frutto della sua arte, un’altra quello del suo lavoro: il frutto dell’arte consiste nell’aver realizzato ciò che voleva, quello del lavoro nell’aver fatto qualcosa da cui trarre un profitto. Fidia, però, ha realizzato compiutamente la sua opera anche se non l’ha venduta. Il frutto della sua opera è triplice: il primo è la consapevolezza di averla fatta, di cui gode quando l’ha terminata, il secondo è la fama, il terzo è l’utilità che gli verrà o dalla riconoscenza o dalla vendita o da qualche circostanza favorevole. Analogamente il primo frutto del beneficio è la consapevolezza di averlo elargito, di cui gode colui che ha fatto arrivare il suo dono a chi voleva; il secondo e il terzo sono la fama e tutto ciò che può essere dato in contraccambio. Dunque, quando un beneficio è stato accolto benevolmente chi lo ha dato ha già ricevuto una dimostrazione di riconoscenza, ma non ancora una ricompensa concreta, perciò il debito riguarda qualcosa che è esterno al beneficio in sé, il quale è già stato pagato nel momento in cui lo si è ricevuto benevolmente. 34. Si potrà obiettare: «Ma come? Ha dimostrato la sua riconoscenza chi non ha fatto nulla?». Prima di tutto qualcosa l’ha fatta: ha contraccambiato una buona disposizione d’animo con una disposizione d’animo ugualmente buona e, come è proprio dell’amicizia, su un piano di parità. E poi, una cosa è pagare un debito, un’altra è pagare un beneficio: non si tratta di vederlo saldare materialmente, è una questione che riguarda l’animo. Ciò che dico non ti sembrerà così strano, anche se in apparenza è in contrasto con le tue idee, se ti affidi al mio ragionamento e pensi che le cose sono ben più numerose delle parole. Di cose ne esistono tante che noi designiamo con nomi presi in prestito da altre e adattati all’oggetto che vogliamo indicare: così, per esempio, chiamiamo piede sia l’estremità del nostro corpo, sia la parte di fondo del letto, sia la base della vela, sia la misura del verso; chiamiamo cane sia il cane da caccia, sia un tipo di pesce e una costellazione, e ciò perché non abbiamo un numero di nomi sufficiente per assegnarne uno a ogni cosa, sicché ogni volta che ci serve li prendiamo in prestito. Il coraggio è l’atteggiamento di chi disprezza i pericoli da dover affrontare, o anche la capacità di affrontarli, di sfidarli, tuttavia definiamo coraggioso sia un gladiatore, sia uno schiavo fannullone che l’audacia spinge a disprezzare la morte. La parsimonia è l’inclinazione a evitare spese inutili o l’arte di servirsi con misura dei propri beni, tuttavia, chiamiamo parsimonioso anche l’uomo di animo gretto e tutto chiuso in sé stesso, sebbene ci sia un’enorme differenza fra la giusta misura e le restrizioni dell’avarizia. Sono cose di natura diversa, ma la penuria del lessico fa sì che chiamiamo parsimonioso sia questo sia quello e che sia detto coraggioso sia chi disprezza consapevolmente i pericoli, sia chi si getta senza riflettere in mezzo ai pericoli. Così il beneficio, come abbiamo detto, è sia l’azione con cui si fa del bene, sia la cosa stessa che viene data con quell’azione, come il denaro, una casa, una pretesta: c’è un nome unico per le due cose, ma il loro significato e il loro valore sono di gran lunga diversi.
35. Io dunque, come vedi, non dico nulla che sia in contrasto con le tue idee: il beneficio inteso nel primo significato, cioè quello che si realizza con l’atto del donare in sé, ha già ricevuto il contraccambio se lo abbiamo accolto di buon animo; il beneficio inteso nel secondo senso, cioè quello che consiste nella cosa donata, non lo abbiamo ancora contraccambiato, ma vogliamo contraccambiarlo. Alla disposizione d’animo rispondiamo con la disposizione d’animo, alla cosa dobbiamo rispondere con la cosa. Perciò, anche se diciamo che chi riceve un beneficio di buon animo ha già dimostrato la sua riconoscenza, tuttavia pretendiamo che ricambi il dono ricevuto con qualcosa di analogo. A volte le nostre idee contrastano con quelle correnti, ma poi vi ritornano per un’altra via: diciamo che il saggio non può ricevere offesa, però chi lo colpisce con un pugno verrà condannato per avere offeso; diciamo che lo stolto non possiede neppure un soldo, però chi ruba qualcosa a uno stolto sarà condannato per furto; diciamo che tutti gli uomini sono pazzi, però non li curiamo tutti con l’elleboro:18 proprio a quelli che chiamiamo pazzi concediamo il diritto di voto e affidiamo l’amministrazione della giustizia. Così diciamo che chi ha ricevuto il beneficio con buona disposizione d’animo ha già dimostrato la sua riconoscenza, ma ciò nonostante lo consideriamo ancora in debito e anche quando ha pagato resta sempre un debitore. Ciò non vuol dire disconoscere i benefìci, significa esortare a non averne paura, a non perdersi d’animo anche se gravati da un peso difficile da sopportare. «Mi sono stati dati dei benefìci», dirà uno, «attraverso i quali è stata salvaguardata la mia reputazione, sono stato tolto dall’ignominia, mi è stata salvata la vita e donata la libertà, che è ancora più importante della vita: come dimostrare la mia gratitudine all’autore di tutto ciò? Verrà il giorno in cui potrò manifestargli i miei sentimenti?». Ebbene, quel giorno è proprio quello in cui tale persona si è posta quella domanda, con la quale ha ipso facto manifestato i suoi sentimenti. Accetta quel beneficio, accoglilo fra le tue braccia, gioisci, non perché lo ricevi, ma perché lo ricambi già e dovrai ricambiarlo in futuro; non correrai mai il rischio che un qualche motivo possa renderti ingrato. Non ti prospetto alcuna difficoltà, affinché tu non ti perda d’animo e non ti scoraggi di fronte alla pena e alla lunga servitù che ti attendono: non rinvio a più tardi, voglio che la cosa si risolva immediatamente. Non sarai mai riconoscente se non lo sei subito. Che farai, dunque? Non c’è bisogno di prendere le armi: forse ce ne sarà bisogno in futuro; non c’è bisogno di varcare i mari: forse in futuro salperai anche con venti che minacciano burrasca. Vuoi ricambiare il beneficio? Accoglilo di buon animo: hai già dimostrato la tua riconoscenza, non al punto da ritenere di aver estinto il tuo debito, ma tanto da pensarci con maggiore serenità.
1. Il concetto sarà ripreso da Dante nel Convivio (I 8): «Perché dice Seneca: che nulla cosa più cara si compera che quella dove i prieghi si spendono». 2. Frammento di autore incerto. 3. Quinto Fabio Massimo Verrucoso, detto il Temporeggiatore, politico, generale e console, fu nominato dittatore nel 219, durante la seconda guerra punica. 4. Di Mario Nepote sappiamo da Tacito (Annali, II 48) che nel 17 d.C. fu costretto ad abbandonare il Senato, forse perché si era ridotto in povertà a causa di debiti. 5. Arcesilao di Pitane, filosofo accademico scettico, visse tra il IV e il III sec. a.C. 6. Gaio Giulio Cesare Germanico, detto Caligola perché indossava le calzature militari (caliga), fu imperatore dal 37 al 41. Fu ucciso in una congiura. 7. Cfr. Plutarco, Apoftegmi di re e di capi, 179b 6. 8. Antigono Monoftalmo (381-301 a.C.), generale di Alessandro Magno, alla cui morte ebbe il governo della Frigia, della Licia e della Panfilia, sognava di riunire sotto di sé tutta l’eredità di Alessandro. 9.Bestiarius era il gladiatore che lottava contro le belve nel circo. 10. Marco Giunio Bruto, partecipò alla congiura del 44 contro Cesare. 11. Lucio Tarquinio il Superbo fu re di Roma dal 534 al 509 a. C. Governò in modo crudele trasformando la monarchia da costituzionale in assoluta. 12. Giulio Grecino, padre di Agricola, oratore e senatore, fu condannato a morte da Caligola perché si era rifiutato di sostenere l’accusa contro Marco Silano (cfr. Tacito, Agricola, 4, 2). 13. Fabio Persico, discendente di Quinto Fabio Massimo, console nel 34 d.C., fu uomo di costumi riprovevoli. 14. Canino Rebilio era un personaggio noto per la sua depravazione: si suicidò svenandosi. 15. C. Furnio, celebre oratore, fu legatus Augusti in Spagna e console nel l7 a.C. 16. Cn. Cornelio Lentulo, uomo ricchissimo, console nel 14 a.C., fu costretto da Tiberio a nominarlo suo unico erede (cfr. Svetonio, Tiberio, 49). 17. Allusione agli epicurei e alla loro polemica contro la natura matrigna (cfr. Lucrezio, De rerum natura, V 218-234). 18. L’elleboro era la pianta usata come rimedio contro la pazzia e l’epilessia.
Libro terzo 1. Tutti, o Ebuzio Liberale, sono d’accordo nel ritenere che sia vergognoso non ricambiare un beneficio con la riconoscenza e perciò anche gli ingrati si lamentano degli ingrati, mentre questo vizio criticato da tutti è innato in tutti noi, e tale è la contraddizione a cui si arriva che alcuni diventano i nostri peggiori nemici non solo dopo avere ricevuto da noi dei benefìci, ma proprio a causa di essi. Io non nego che ciò accada in alcuni per malvagità naturale, però succede, e a molti, perché col tempo il ricordo svanisce. Per quelli, infatti, ciò che conta sono i fatti recenti, ma questi, una volta che sia passato del tempo, perdono d’importanza. Ricordo di aver già parlato con te di questi individui e che tu li chiamavi smemorati, non ingrati, come se il motivo dell’ingratitudine possa giustificarla, o come se non fosse ingrato chi dimentica, quando ciò accade proprio a chi è irriconoscente. Ci sono molti tipi ingrati, così come di omicidi: la colpa è unica ma ne esistono diverse varietà: ingrato è chi nega di aver ricevuto un beneficio quando invece gli è stato dato, ingrato è chi finge di non averlo ricevuto, ingrato è chi non lo ricambia, ma il più ingrato di tutti è colui che l’ha dimenticato. I primi, infatti, anche se non lo ripagano, almeno si sentono in debito e in loro resta il segno dei favori ricevuti, pur se nascosto nella loro mala coscienza; può accadere che a un certo punto per un qualche motivo cambino atteggiamento e manifestino la loro riconoscenza, o per vergogna o per il desiderio improvviso di compiere anch’essi una buona azione, che può nascere al momento opportuno anche nei cuori dei malvagi, o da una circostanza favorevole, mentre chi si dimentica del tutto del beneficio non potrà mai essere riconoscente. E tu chi consideri peggiore, colui nel quale è morta la riconoscenza per il beneficio ricevuto o colui in cui ne è morto persino il ricordo? Come gli occhi che soffrono la luce sono ammalati e quelli che non ci vedono sono ciechi, così non amare i propri genitori è un’empietà, non riconoscerli come tali è follia. 2. Chi è più ingrato di colui che scaccia dal suo animo sino a ignorarlo completamente ciò che invece dovrebbe occupare il primo posto ed essere sempre presente nel suo pensiero? È evidente che non ha pensato quasi mai a ricambiare colui che ha finito col dimenticare. Infine occorre una buona disposizione per dimostrare la propria gratitudine, ci vogliono tempo, mezzi e il favore della fortuna, ma chi ricorda non ha bisogno di alcuna spesa per dimostrare la sua riconoscenza. Non può essere assolutamente giustificato chi non è disposto a fare ciò che non richiede né fatica, né ricchezza, né circostanze favorevoli: chi respinge così lontano un beneficio tanto da non vederlo più non ha mai voluto essere riconoscente. Come le cose che usiamo ogni giorno e che tocchiamo e maneggiamo non rischiano di arrugginire, mentre quelle che non
cadono sotto i nostri occhi e sono rimaste inutilizzate e fuori uso si rovinano solo per l’effetto del tempo, così tutto ciò che la nostra mente richiama alla memoria non le viene sottratto, poiché la memoria non perde se non ciò che non ha guardato spesso. 3. Ci sono anche altre cause, spesso di grande entità, che possono cancellare dalla memoria i favori ricevuti: la prima e la più potente consiste nel fatto che desiderando sempre cose nuove guardiamo non alle cose che possediamo ma a quelle a cui tendiamo, sicché tutto ciò che abbiamo a nostra disposizione ci sembra privo di valore. Di conseguenza se il desiderio di cose nuove diminuisce il valore del dono ricevuto anche il suo autore non è più apprezzato, cioè abbiamo amato e ammirato qualcuno, riconoscendogli di aver dato una base alla nostra posizione sociale, ma solo fino a quando godevamo delle cose ottenute, poi all’improvviso siamo stati presi dall’ammirazione per altre cose e siamo andati verso di esse, seguendo il costume degli uomini che quando hanno ottenuto cose grandi ne desiderano altre ancora più grandi: così ciò che prima consideravamo un beneficio finiamo col dimenticarlo, non guardiamo più a ciò che ci rendeva superiori agli altri ma solo alla fortuna che ha portato gli altri a stare al di sopra di noi.1 Ebbene, non si può invidiare e ringraziare contemporaneamente, perché l’invidia è tipica di chi si lamenta, mentre il ringraziare è proprio delle persone contente. Inoltre poiché noi generalmente non conosciamo altro tempo se non l’istante che passa e sono pochi coloro che si volgono al passato, così accade che i precettori e i benefìci che abbiamo ricevuto da loro cadano nell’oblio, in quanto il tempo dell’infanzia è completamente passato. Così pure viene meno in noi il ricordo dei benefìci ottenuti durante la giovinezza, perché quell’età non torna più. Ciò che è accaduto non viene più tenuto in conto perché è considerato come perduto, ed è per questo che chi guarda sempre e soltanto al futuro ha la memoria debole. 4. A questo punto non possiamo non dare ragione a Epicuro, quando si lamenta perché siamo ingrati verso i beni passati e non richiamiamo alla memoria, annoverandoli fra i piaceri, tutti i beni che abbiamo ricevuto, mentre non c’è piacere più sicuro di quello passato, che non può esserci tolto.2 I beni presenti, infatti, non sono ancora del tutto al sicuro, perché un evento fortuito può danneggiarli, d’altra parte i beni futuri sono incerti perché devono ancora venire; i beni passati, invece, si trovano in un luogo certo e ben preciso. Come dunque può dimostrare la propria riconoscenza per i benefìci ottenuti uno che passa tutta la sua vita guardando solo al presente e al futuro? È il ricordo che genera la riconoscenza, mentre quanto più ci spingiamo verso l’attesa e la speranza tanto più si riduce lo spazio per il ricordo. 5. Caro Liberale, come alcune cose, una volta comprese, si imprimono in noi profondamente, mentre altre per saperle non basta averle apprese, perché se non
ci pensiamo costantemente non ne siamo più padroni – parlo della geometria, dell’astronomia e di tutte quelle nozioni che per la loro sottigliezza ci sfuggono facilmente – così accade anche per i benefìci: alcuni non si possono dimenticare perché sono grandi, altri, più piccoli ma più numerosi e concessi a distanza di tempo, ci sfuggono di mente, perché, come ho detto, non vi pensiamo spesso né volentieri e perché non ci piace ricordare i nostri debiti. Ascolta le parole di quelli che chiedono un beneficio: tutti dicono che il ricordo resterà in loro sempre vivo, o che saranno obbligatissimi, quando non ricorrono a espressioni ancora più servili, se mai ce ne sono, per legarsi al donatore. Ebbene, poco tempo dopo quelle stesse persone si guardano bene dal ripetere le parole dette in precedenza, come se fossero umilianti e indegne di uomini liberi, e finiscono col dimenticare, cosa che a mio parere è il limite a cui giungono le persone peggiori e le più ingrate. Infatti è tanto ingrato chi si è dimenticato ma è già ingrato colui a cui il beneficio viene in mente solo per un istante. 6. Ci si chiede se questo vizio così odioso dell’ingratitudine debba restare impunito o se la legge che condanna legalmente le persone ingrate – e che si studia nelle scuole di retorica3 – debba essere applicata anche nei confronti delle città. A tutti sembra una legge giusta: «Perché no», dicono, «quando anche le città si rinfacciano fra loro i favori resi e pretendono che i discendenti paghino per i benefìci concessi ai loro antenati?». I nostri avi, grandi uomini, pretesero solo dai nemici un tale genere di pagamento, largivano i benefìci con magnanimità e con magnanimità li perdevano: tranne che i Macedoni, nessun altro popolo persegue legalmente gli ingrati.4 Tutti infatti riteniamo che si debba perseguire ogni azione criminale – come omicidio, avvelenamento, parricidio, sacrilegio, che hanno pene diverse nei diversi luoghi – mentre questo crimine che è il più frequente non viene punito in nessun luogo, nonostante ricorra dovunque. Noi non lo assolviamo, ma non essendo facile la stima di un’azione incerta, lo deprechiamo, relegandolo fra quelle cose che rimettiamo al giudizio degli dei. 7. D’altra parte vi sono molte ragioni per le quali l’ingratitudine non può essere perseguibile legalmente. La prima è che si verrebbe a perdere la parte migliore del beneficio se si permettesse di recuperarlo per vie legali, come avviene per una somma di denaro o per un contratto d’appalto o di locazione. La cosa più bella del beneficio, infatti, è l’averlo concesso, anche a costo di perdere ciò che può derivarne al donatore, l’averlo lasciato, cioè, interamente all’arbitrio di chi lo ha ricevuto: se lo cito in giudizio, se mi rivolgo al giudice, non è più un beneficio, è un mio credito. In secondo luogo, pur essendo motivo di onore dimostrare la propria riconoscenza, se quell’onore diventa obbligatorio non c’è più, visto che chi si dimostra riconoscente non sarà più lodato di chi ha restituito ciò che aveva in consegna o di chi ha pagato i suoi debiti senza l’intervento del giudice. Così si distruggono le due cose più belle della vita associata, la gratitudine e il beneficio: che c’è infatti di nobile in chi non
concede un beneficio, ma lo presta, o in chi lo contraccambia non perché lo voglia ma perché è obbligato? Non è onorevole dimostrarsi riconoscenti se non è anche possibile, al sicuro da ogni rivalsa, dimostrarsi ingrati. A ciò aggiungi che solo per applicare questa legge quasi non basterebbero tutti i tribunali del mondo. Chi non avrebbe da intentare un’azione legale? Quanti non sarebbero perseguiti legalmente? Tutti ingrandiscono i propri meriti, tutti amplificano anche i più piccoli favori che hanno reso agli altri. Per non dire che un’inchiesta giudiziaria si esprime attraverso formule precise, non lascia una libertà assoluta di giudizio, per questo una causa giusta è meglio metterla nelle mani di un giudice che non di un arbitro, perché il giudice è legato alla precisa formulazione della legge, che gli pone dei limiti da non superare, mentre l’arbitro segue la sua discrezionalità, slegata da qualsiasi vincolo, e può togliere o aggiungere e regolare il suo giudizio non sulla base di norme di legge o di giustizia, ma a seconda del suo senso di compassione o di umanità. L’azione contro ingrati dovrebbe non vincolare il giudice, ma dargli la più ampia facoltà di decisione, inquantoché non è chiaramente definito né cosa sia il beneficio, né quanto valga, dunque ciò che conta è l’atteggiamento più o meno benevolo con cui il giudice lo interpreta. Analogamente non v’è legge che definisca cosa s’intenda per ingrato, e spesso anche chi ricambia ciò che ha ricevuto è ingrato, e chi non ricambia è riconoscente. In certi casi anche un giudice inesperto può emettere la sentenza, quando occorre stabilire se il fatto sia stato commesso o no, quando la controversia si risolve con la presentazione dei garanti, quando un’analisi razionale stabilisce chi ha ragione fra le parti in causa; ma quando si tratta di congetture sulle intenzioni, quando la discussione verte su qualcosa che solo la saggezza è in grado di decidere, il giudice non si può prenderlo fra coloro che sono stati scelti dal pretore, non può essere un uomo che sia giunto a quella posizione per il suo censo e per l’appartenenza ereditaria all’ordine equestre. 8. Ecco perché questo reato ci è parso poco adatto a essere portato davanti a un giudice, e in effetti non si è trovato alcun giudice adatto a tale scopo, né c’è da meravigliarsene se si considerano attentamente le difficoltà che incontrerebbe chi fosse stato scelto per giudicare un simile reato. Mettiamo che un tale abbia donato un’ingente somma di denaro, ma che sia talmente ricco che quel gesto non gli è costato alcun sacrificio, mentre un altro ha donato ma quasi privandosi di tutto il suo patrimonio: la somma è la stessa in entrambi i casi ma i due benefìci sono diversi. Oppure: un tale ha speso del denaro per liberare un uomo schiavo per debiti attingendo dal proprio patrimonio; un altro ha speso la stessa somma, ma l’ha presa in prestito o l’ha chiesta assoggettandosi a condizioni gravose: pensi che stiano sullo stesso piano colui che ha donato con facilità e colui che per dare ha dovuto contrarre un prestito? Alcuni benefìci acquistano valore per le circostanze in cui vengono dati, non per l’entità della somma di denaro corrispondente: è un beneficio donare un
terreno la cui fertilità può far diminuire il prezzo del grano, così come lo è dare un pezzo di pane a chi ha fame, donare regioni attraversate da grandi fiumi navigabili o indicare una sorgente a chi muore di sete e fatica a respirare perché ha la gola secca. Chi può confrontare fra loro questi benefìci? Chi può soppesarli? È difficile fare una stima che riguardi non il dono in sé ma il suo valore. I benefìci possono pure essere uguali, ma se vengono dati in circostanze diverse non hanno lo stesso valore. E ancora: un tale mi ha concesso un beneficio, ma non spontaneamente, oppure si è lamentato di avermelo concesso, guardandomi con più arroganza del solito, o me lo ha dato con tale ritardo che se me lo avesse rifiutato subito mi avrebbe fatto un favore maggiore: come farà un giudice a valutare tutte queste cose, quando le parole, l’esitazione e l’espressione del volto possono distruggere la bellezza del favore che si è fatto? 9. Cosa dire poi di quei benefìci che sono chiamati così perché desiderati troppo ardentemente, mentre altri che non appartengono a questa volgare categoria hanno un valore ben più grande, anche se sono meno vistosi? È un beneficio l’aver concesso a uno il diritto di cittadinanza presso un popolo potente, l’averlo iscritto nell’ordine dei cavalieri, l’averlo difeso da un’accusa capitale, o l’aver dato dei consigli utili, distolto uno dall’intraprendere la via del delitto o l’aver tolto di mano la spada a chi stava per suicidarsi? E l’aver distolto tempestivamente dal togliersi la vita chi piangeva per la perdita dei propri cari e voleva seguirne la sorte? O l’aver assistito un malato, nutrendolo adeguatamente quando la sua vita era appesa a un filo, rianimando col vino le sue forze illanguidite e chiamando un medico quando stava per morire? Chi valuterà questi gesti? Chi stabilirà con quali altri benefìci compensare quelli ricevuti? «Ti ho regalato una casa». Ma io ti ho avvertito che la tua stava crollandoti addosso. «Ti ho salvato il patrimonio». Ma io ti ho offerto una tavola quando stavi per annegare. «Ho combattuto e sono stato ferito per difendere te». Ma io ti ho salvato la vita senza bisogno di tante parole. È difficile pareggiare i conti quando c’è differenza fra il contenuto di un beneficio ricevuto e il suo contraccambio. 10. Inoltre non si stabilisce una scadenza per ricambiare il beneficio, come si fa invece per la restituzione di un prestito, perciò chi non lo avesse ancora ricambiato può sempre farlo. Dunque dopo quanto tempo potrebbe essere perseguibile l’ingratitudine? I benefìci più grandi non possono essere provati, spesso restano nascosti nella coscienza delle due persone. O forse dovremmo introdurre l’usanza di non concedere benefìci senza testimoni? E la pena? Quale pena stabilire per gli ingrati? Una identica per tutti, nonostante la varietà dei benefìci? O una variabile a seconda del beneficio ricevuto da ciascuno? Mettiamo che si stabilisca una pena in denaro: come regolarsi quando alcuni benefìci hanno dato la vita o beni ancora più preziosi della vita? Per questo genere di benefìci quale pena si dovrebbe fissare? Una pena minore del
beneficio ricevuto? Sarebbe ingiusta. Una pena equivalente, cioè quella capitale? Che cosa c’è di più disumano di un beneficio che finisce in modo cruento? 11. «Ai genitori», si dice, «sono stati concessi alcuni privilegi. Ebbene, come con loro si sono seguite norme diverse da quelle comuni, così ci si deve comportare anche con chi concede dei benefìci». Abbiamo reso sacra la condizione di genitori perché era necessario che allevassero dei figli e dunque dovevano essere invogliati a un lavoro i cui risultati sono incerti. Non si poteva dir loro ciò che si dice a chi concede un beneficio: «Scegli bene la persona alla quale doni, e se vieni ingannato prenditela con te stesso: aiuta chi se lo merita». Nell’allevare i figli i genitori non hanno possibilità di scelta, tutto dipende dal desiderio, perciò affinché i genitori corressero il rischio bisognò dargli una certa autorità. Inoltre, la condizione dei genitori è diversa: ai figli a cui hanno fatto del bene continueranno sempre a farne, e non c’è il rischio che dicano di aver dato benefìci che non hanno concesso; per tutti gli altri, invece, bisogna vedere non solo se hanno ricevuto ma anche se hanno dato; i servigi dei genitori sono fuori d’ogni dubbio, e, poiché è utile ai giovani essere governati, abbiamo imposto loro, per così dire, dei magistrati domestici che, sorvegliandoli, li tenessero a freno. Per non dire che il beneficio dei genitori è sempre il medesimo, quindi si può valutarlo una volta per tutte, mentre gli altri sono diversi, disuguali, distinti da differenze che non sempre è facile calcolare, dunque non possono essere ricondotti a un criterio unico, sicché è più giusto rinunciare all’impresa piuttosto che mettere tutto sullo stesso piano. 12. Certi doni costano tanto a chi li fa, certi sono molto importanti per chi li riceve ma non costano nulla a chi li dà. Vi sono doni che si fanno ad amici, altri a persone sconosciute; fra due doni uguali ha maggior valore quello fatto a uno che si viene a conoscere proprio nel momento in cui glielo si dà. Uno elargisce aiuti, un altro onori, un altro consolazione. C’è chi pensa che non vi sia nulla di più piacevole e più importante che l’avere qualcuno in cui trovare conforto nelle disgrazie; c’è chi preferisce che il donatore badi più alla sua posizione sociale che alla sua sicurezza, e chi ritiene di essere maggiormente in debito verso chi contribuisce alla sua sicurezza piuttosto che verso chi contribuisce alla sua onorabilità. Tali benefìci, dunque, saranno più o meno importanti a seconda che il giudice inclini verso l’uno o l’altro genere. Inoltre se devo chiedere un prestito sono io stesso a scegliere il donatore, mentre spesso il beneficio lo ricevo da chi non vorrei, e talvolta mi ritrovo in debito senza neppure saperlo: che fare in questo caso? Definiremo ingrato colui al quale è stato imposto un beneficio a sua insaputa e che, sapendolo, non lo avrebbe accettato? Non definiremo ingrato chi non ha ricambiato ciò che, comunque, aveva accettato? Mettiamo che un tale mi abbia concesso un beneficio e che dopo mi abbia fatto un torto: ebbene, per quell’unico beneficio sono obbligato a sopportare tutte le offese, o sono autorizzato a considerare estinto il mio debito, visto che lui con
la sua offesa ha annullato il suo beneficio? E come giudicare, poi, se valga di più il dono ricevuto o l’offesa subìta? Non mi basterebbe un giorno se dovessi esaminare tutte le difficoltà. 13. Si obietterà: «Non difendendo chi li ha concessi e non punendo chi li nega rendiamo gli uomini restii a concedere benefìci». Tieni presente anche il caso contrario, cioè che gli uomini saranno restii ad accettare benefìci se temono di poter correre il rischio di un processo e, benché innocenti, dovranno vivere nell’ansia. Per lo stesso motivo anche noi saremo restii a fare il bene, poiché nessuno dà volentieri a chi non accetta volentieri; ma chi è indotto a fare il bene dalla bontà e dalla bellezza stessa dell’azione lo farà ancora più volentieri a coloro che gli dovranno solo quel che vorranno. Se una buona azione è tutelata da precise garanzie l’onore che ne deriva diminuisce. 14. I benefìci, dunque, saranno meno numerosi ma più autentici. D’altra parte, che male c’è a frenare l’impulso che spinge a concederli? Non si è fatta alcuna legge a questo proposito proprio per rendere più cauti nel donare e più prudenti nello scegliere a chi fare del bene. Se riflettiamo più volte sulla persona alla quale donare non potrà esserci alcun processo, alcun reclamo. Sbagli se pensi che il giudice possa venire in tuo aiuto, perché non v’è legge che ripristini lo stato di prima, si può far conto solo sulla buona fede del destinatario del dono. È così che i benefìci mantengono la loro importanza e la loro bellezza, se diventano oggetto di liti è una profanazione. Dire: «Rendi ciò che devi» è una richiesta del tutto legittima e garantita dal diritto delle genti, ma per quel che riguarda un beneficio è assolutamente vergognoso dire: «Restituisci!». Che cosa? La vita che gli devi? La sicurezza? La salute? Le cose di grandissimo valore non possono essere restituite. «Ma al loro posto si può rendere qualcosa che valga altrettanto». È appunto ciò che dicevo: che il merito di un’azione così importante va perduto se riduciamo il beneficio a una merce. Non occorre spingere l’animo all’avidità, alle lamentele, alla discordia, visto che è già incline per natura a queste cose. Per quanto possiamo, resistiamo e togliamogli le occasioni che va cercando. 15. Oh, se si potessero convincere i creditori ad accettare il denaro che gli si deve solo da quelli che vogliono darlo! Oh, se nessun contratto legasse il compratore al venditore, se i patti e gli accordi fossero garantiti senza bisogno di sigilli e bastassero la buona fede e il rispetto dell’onestà! Ma si è sostituito al meglio il necessario e si preferisce legare con una legge la buona fede piuttosto che farvi affidamento. Dall’una e dall’altra parte vengono prodotti testimoni: l’uno, dopo essere ricorso a intermediari, fa scrivere dei nomi su registri non suoi;5 l’altro non si accontenta di una promessa verbale ma vincola il debitore con una dichiarazione autografa. Vergognosa testimonianza della natura umana, della disonestà e della malvagità pubblica! Ci si fida di più dei sigilli dei nostri
anelli che delle nostre coscienze! Perché si convocano a testimoniare questi uomini rispettabili? Perché si imprimono questi sigilli? Solo perché chi ha ricevuto non possa negare di aver ricevuto. Consideri questi testimoni uomini incorruttibili e difensori della verità, ma con questi stessi uomini non si agisce allo stesso modo quando gli si versa il denaro? E allora non sarebbe più dignitoso che qualcuno tradisse la parola data piuttosto che temere tutti la slealtà? Solo questo manca alla nostra avidità, che non facciamo del bene senza la presenza di un garante, quando aiutare e rendersi utile è proprio di un animo liberale e generoso: chi concede benefìci imita gli dèi, chi pretende un contraccambio imita gli usurai. Perché proprio mentre difendiamo coloro che fanno del bene, li releghiamo nella massa più miserabile? 16. Si dice che gl’ingrati siano più numerosi perché non è permessa alcuna azione legale contro l’ingratitudine. Anzi, sarebbero di meno, perché i benefìci verrebbero concessi con maggiore discernimento. E poi non conviene che tutti sappiano quanti sono gl’ingrati, poiché essendo assai numerosi i peccatori, la cosa non sarà più giudicata vergognosa e il disonore cesserà di essere un’infamia quando coinvolgerà tutti. Ormai c’è forse qualche donna che arrossisce per essere stata ripudiata, quando donne nobili e famose calcolano la loro età in rapporto al numero dei loro mariti, non dei consoli, e lasciano la casa paterna per sposarsi e si sposano per divorziare? Finché ciò accadeva di rado era una vergogna; da quando non c’è giornale che non riporti la notizia di un divorzio si è imparato a fare ciò di cui si sente parlare così spesso. Non si prova alcun pudore per l’adulterio, quando si è arrivati al punto che ci si sposa per ingelosire l’amante. L’essere pudica è ritenuto indice di bruttezza. Non troverai una donna così meschina e spregevole da accontentarsi di un paio di amanti, e che non divida fra molti le sue ore, riservandone una a ciascuno. E non le basta una giornata intera, salvo che non si faccia portare in lettiga a casa di uno e non rimanga la notte a casa di un altro. Sciocca e retrograda è quella donna la quale ignora che un solo adulterio si chiama matrimonio. Come non c’è più vergogna per questi misfatti, essendosi estesi sempre di più, così si accrescerà il numero e il potere degli ingrati, se cominceranno a contarsi. 17. «E che? L’ingrato resterà dunque impunito?». E che? Resterà impunito l’empio? O il malvagio? O l’uomo incapace di dominarsi? O il crudele? Tu credi che rimangano impunite le colpe che sono invise a tutti o ritieni che ci sia qualche punizione più grave dell’odio popolare? Già è una punizione il non osar ricevere né concedere un beneficio, il vedersi segnato a vista da tutti, l’aver perso la capacità di comprendere il valore della cosa o dell’azione più bella e più dolce che ci sia. O forse chiami infelice chi è privo della vista, chi ha perso l’udito per una malattia, e non chiami infelice chi ha perso la capacità di sentire i benefìci? Costui ha paura degli dèi, testimoni di ogni atto di ingratitudine, è
bruciato e tormentato dalla coscienza di avere infranto un beneficio; in definitiva è già una pena abbastanza grande il non godere della più piacevole fra le cose. Chi invece gioisce di aver ricevuto gode di un piacere continuo, pensando non alla cosa ricevuta, ma alla benevolenza di colui che l’ha donata. A un uomo riconoscente un beneficio fa piacere sempre, a un ingrato solo una volta. Del resto confronta la vita dei due: l’uno è accigliato e preoccupato, come uno spergiuro e un truffatore che non prova il dovuto rispetto per i genitori, né per chi lo ha educato e istruito; l’altro, invece, è allegro e contento e non vede l’ora di poter dimostrare concretamente la sua riconoscenza, traendo da questo suo stato d’animo una grande gioia, e cerca il modo non per ridurre il suo debito ma per pagarlo più pienamente e abbondantemente possibile non solo ai parenti e agli amici, ma anche alle persone di rango inferiore, e se ha ricevuto un beneficio da un suo schiavo bada al dono, non alla persona. 18. Alcuni, fra i quali Ecatone, si chiedono se uno schiavo possa fare un beneficio al proprio padrone. C’è infatti chi distingue fra benefìci, doveri e servizi: beneficio è ciò che dà un estraneo (cioè chi avrebbe potuto astenersene senza per questo essere biasimato); il dovere è proprio del figlio, della moglie e di quelle persone che il legame di parentela spinge a intervenire e ad aiutarci; il servizio è proprio dello schiavo, la cui condizione non gli consente di farsi merito di alcuna cosa, come di un sovrappiù, con chi gli è superiore. Ma chi sostiene che uno schiavo non possa in nessun caso essere benefattore del suo padrone non conosce il diritto umano: ciò che conta, infatti, è la disposizione d’animo del benefattore, non la sua condizione sociale. La virtù non è preclusa a nessuno, è accessibile a tutti, invita e accoglie tutti, liberi e liberti, schiavi, re ed esuli, non sceglie in base al casato o alla ricchezza, guarda all’uomo e basta. Quale difesa potremmo avere contro gli imprevisti, cosa potrebbe promettersi di grande l’animo nostro se la fortuna potesse cambiare una virtù consolidata? Se uno schiavo non può beneficare il suo padrone, allora neppure un suddito può beneficare il suo re, né un soldato il suo comandante; che importa, infatti, a quale tipo di autorità si sia soggetti, se tale autorità è assoluta? Se lo stato di servitù e il timore delle più gravi punizioni impediscono allo schiavo di acquisire il titolo di benefattore, la stessa cosa accade a chi è soggetto a un re o a un comandante, inquantoché costoro, anche se a titolo diverso, hanno verso di lui la medesima libertà del padrone nei confronti dello schiavo. Con tutto ciò si può essere benefattori del proprio re o del proprio generale, dunque, anche del proprio padrone. Uno schiavo può essere giusto, può essere forte, magnanimo, quindi può concedere un beneficio, poiché anche questo è proprio della virtù. Anzi, gli schiavi possono beneficare i loro padroni a tal punto che spesso è proprio coi loro benefìci che li hanno resi tali. 19. Nessuno può dubitare che uno schiavo non possa fare del bene, e se può
perché non potrebbe farlo al suo padrone? Si obietterà: «Perché anche se gli dà del denaro non può diventare suo creditore, altrimenti ogni giorno il suo padrone gli sarebbe obbligato: lo schiavo segue il padrone quando è in viaggio, lo assiste quando è malato, gli coltiva con gran fatica la campagna. Ebbene, tutte queste cose se fatte da un altro sarebbero considerate benefìci, ma se le fa lo schiavo sono servizi. Il beneficio, infatti, si ha quando è concesso da qualcuno che avrebbe anche potuto non concederlo, mentre lo schiavo non ha la facoltà di rifiutarsi, quindi non offre ma obbedisce, né può vantarsi di un’azione che non avrebbe potuto evitare di compiere». Anche se la questione è impostata così la supererò, portando lo schiavo a un punto tale da renderlo libero in molte sue azioni. Intanto dimmi: se ti mostrerò uno che per salvare il suo padrone combatte senza alcun riguardo per sé stesso e, massacrato in tutte le parti del corpo, versa dai suoi organi vitali il sangue che gli resta cercando con la propria morte un indugio affinché quello abbia il tempo di fuggire, sosterrai che quell’uomo, essendo uno schiavo, non è stato un benefattore? Se ti mostrerò uno che, richiesto di svelare i segreti del suo padrone, non si è lasciato corrompere dalle promesse del tiranno né spaventare dalle minacce e vincere dalle torture, ma, per quanto ha potuto, ha stornato i sospetti degli investigatori e ha sacrificato la sua vita per restare fedele, dirai che costui, essendo uno schiavo, non è stato un benefattore? Rifletti, invece, se un’azione virtuosa compiuta da uno schiavo non abbia maggior valore proprio perché è più rara e se non sia per questo più apprezzata, perché, a dispetto degli ordini e del suo stato di servitù che lo costringe a obbedire, l’amore per il padrone riesce a vincere l’odio che è comune a tutti gli schiavi. Non si può dunque negare che si tratti di un beneficio solo perché è stato compiuto da uno schiavo, anzi, quel gesto ha tanto maggior valore proprio perché neppure la condizione di schiavo ha potuto impedirgli di compierlo. 20. Sbaglia chi crede che la schiavitù penetri in un uomo interamente. La sua parte migliore ne è esclusa: il corpo è sottomesso e assegnato al padrone, ma la mente è autonoma, libera e indipendente al punto che neppure la prigione in cui è rinchiusa può impedirle di seguire il suo impulso naturale, concepire grandi idee e lanciarsi nell’infinito, compagna degli spiriti celesti. Il corpo che la fortuna ha assoggettato a un padrone è ciò che questi compra e vende, l’altra parte, quella interiore, non può essere soggetta a compravendita: ciò che proviene da essa è libero, e come noi non possiamo comandare su tutto così gli schiavi non possono essere costretti a obbedire in tutto, non eseguiranno ordini contro lo Stato, non si presteranno a commettere un delitto. 21. Ci sono azioni che le leggi non comandano né proibiscono di fare: è in questo ambito che lo schiavo ha materiale per i suoi benefìci. Finché si limita a fare ciò che abitualmente si richiede a uno schiavo egli svolge un servizio, ma se fa più di ciò a cui è tenuto compie un beneficio: quando è spinto dal sentimento
dell’amicizia ciò che fa non si può chiamare servizio. Il padrone deve fornire allo schiavo alcune cose, come cibo e indumenti: ebbene, questo non è un beneficio; ma se il padrone tratta lo schiavo con benevolenza, lo educa liberalmente, lo istruisce in quelle arti che sono proprie dei cittadini liberi, questo è un beneficio. Lo stesso vale nel caso contrario, cioè per lo schiavo: tutto ciò che oltrepassa il limite dei doveri, che viene fatto volontariamente, non per un ordine, è un beneficio, a condizione che quell’atto, indipendentemente da chi lo compie, sia degno di quel nome. 22. Secondo Crisippo lo schiavo è un mercenario a vita. Ma come un mercenario compie un beneficio quando fa più di ciò per cui è stato arruolato, così, quando lo schiavo, benevolo verso il suo padrone, oltrepassa i limiti del suo stato servile e osa compiere un’azione che farebbe onore anche a chi fosse per nascita più fortunato e supera ogni speranza del padrone, ebbene, questo è un beneficio compiuto all’interno delle pareti domestiche. O ti sembra logico che ci si adiri con gli schiavi se fanno meno del loro dovere e non gli si debba riconoscenza se hanno fatto più di quanto devono fare o fanno abitualmente? Vuoi sapere quando non si tratta di un beneficio? Quando si può dire: «Anche se non avesse voluto, cosa avrebbe potuto fare?». Quando invece ha fatto qualcosa che avrebbe potuto rifiutarsi di fare, allora va lodato per la sua volontà. Il beneficio e l’offesa sono due cose contrapposte: uno schiavo può concedere un beneficio al suo padrone, visto che da lui può ricevere un’offesa. Nonostante ciò, c’è un magistrato apposito incaricato di ascoltare le offese fatte agli schiavi dai loro padroni, affinché ne reprima la crudeltà, la lascivia e l’avarizia nel fornire loro il necessario. Ma come? Un padrone può ricevere un beneficio da uno schiavo? No: è un uomo che lo riceve da un altro uomo. Del resto ha messo in atto ciò che era in suo potere: ha fatto del bene al padrone; il quale aveva il potere di rifiutare il beneficio di uno schiavo. Ma chi è così potente da non essere costretto dalla sorte ad aver bisogno anche dei più umili? 23. Ora citerò molti esempi di benefìci diversi, di cui alcuni addirittura opposti fra loro. C’è chi ha donato la vita al suo padrone, chi l’ha fatto morire, chi lo ha salvato dalla morte e, se questo è ancora poco, lo ha salvato morendo egli stesso; un altro ne ha favorito la morte, un altro gliene ha data l’illusione. Claudio Quadrigario6 nel diciottesimo libro degli Annali narra che durante l’assedio di Grumento,7 due schiavi, presi dalla disperazione, passarono al nemico e gli resero importanti servigi. Poi, come la città fu espugnata, mentre i vincitori la percorrevano di qua e di là, i due, attraverso strade che ben conoscevano, li precedettero alla casa in cui erano stati schiavi e, fatta uscire la padrona, si misero a camminare dietro di lei e a chi gli chiedeva chi fosse quella donna rispondevano che era la loro padrona e che stavano portandola al supplizio perché era stata molto crudele. Condottala fuori dalle mura, la nascosero con gran cura finché l’ira dei nemici non si placò, poi, quando i
soldati, sazi di bottino, tornarono alle abitudini romane, anch’essi tornarono alle loro e si misero nuovamente al servizio della loro padrona. La quale li affrancò entrambi e non si vergognò di aver ricevuto la vita proprio da coloro sui quali aveva avuto potere di vita e di morte. Ebbe motivo di rallegrarsi ancora di più per questo episodio, perché se fosse stata salvata diversamente avrebbe usufruito di un atto di clemenza comune e di poco valore, mentre, salvata in quel modo, divenne oggetto di nobili racconti ed esempio per le due città. Nell’enorme confusione seguita alla presa della città ciascuno pensava solo a sé stesso e tutti avevano abbandonato quella donna tranne i due disertori, i quali, per dimostrare con quale intenzione erano passati al nemico, dai vincitori tornarono alla padrona fingendosi dei giustizieri, giudicando che per salvarle la vita valesse la pena di passare per assassini, e ciò diede maggior valore al loro beneficio. Credimi, non è segno di un animo servile, anzi, di un animo vile, aver pagato un’azione nobile acquistandosi la reputazione di criminali. Vezio, pretore dei Marsi, veniva condotto al generale romano: 8 il suo schiavo sguainò la spada del soldato che lo trascinava e prima uccise il padrone, poi disse: «Ora tocca a me: il padrone ormai l’ho liberato!». E si trafisse con un solo colpo. Citami un solo uomo che abbia salvato il suo padrone più nobilmente. 24. Cesare assediava Corfinio: Domizio,9 intrappolato, ordinò al suo schiavo medico di portargli il veleno, e poiché quello esitava gli disse: «Perché indugi, come se fossi tu a dover decidere? Sono io che, armato, chiedo la morte». Allora quello annuì e gli portò da bere una medicina innocua. Quando il padrone si addormentò si avvicinò al figlio e gli disse: «Fammi la guardia, finché dall’esito capirai se ho dato del veleno a tuo padre». Ebbene, Domizio visse e Cesare gli lasciò la vita, ma il primo a salvarlo era stato il suo schiavo. 25. Durante la guerra civile uno schiavo nascose il padrone che era iscritto nelle liste di proscrizione e, infilatosi i suoi anelli e indossati i suoi abiti, si presentò alle guardie e dopo aver detto che non le avrebbe affatto pregate di non eseguire gli ordini ricevuti porse loro il collo. Che prova di carattere il voler morire per il proprio padrone quando era già una prova rara di fedeltà il non volerne la morte, l’essere un esempio di bontà nella generale efferatezza, di fedeltà nella generale slealtà; il desiderare la morte come premio della propria fedeltà, quando a chi tradiva si offrivano enormi ricompense! 26. Non tralascerò esempi della nostra epoca. Sotto Tiberio Cesare ci fu una mania continua e quasi generale di lanciare accuse, che rovinò Roma in piena pace più gravemente di qualsiasi guerra civile: si prestava orecchio ai discorsi degli ubriachi, alle battute scherzose, non si era mai al sicuro, ogni occasione era buona per incrudelire, e ormai non si aspettava neanche più l’esito dei processi, visto che la conclusione era sempre la stessa. L’ex-pretore Paolo partecipava a
un banchetto e aveva al dito un anello con un cammeo sul quale era raffigurato Tiberio Cesare. Per non cercare un eufemismo, che sarebbe un’enorme sciocchezza, dirò che prese un vaso da notte: il gesto fu notato sia da Marone, una famosa spia dell’epoca, sia dallo schiavo del padrone contro cui si stava tramando un’insidia, il quale, venendo in aiuto al padrone ubriaco, gli sfilò l’anello dal dito, e quando Marone chiamò i convitati a testimoni del fatto che l’immagine di Tiberio veniva accostata ai genitali e già stava per formulare l’atto d’accusa, lo schiavo fece vedere che l’anello era nella propria mano. Se si chiama schiavo quest’uomo, l’altro lo si chiamerà convitato! 27. Sotto il divo Augusto i discorsi che si facevano non erano ancora pericolosi, ma cominciavano a diventare compromettenti. Rufo, un membro dell’ordine senatorio, durante una cena aveva detto di sperare che Cesare non tornasse sano e salvo dal viaggio che si accingeva a fare, aggiungendo che anche i tori e i vitelli avevano la stessa speranza. Qualcuno ascoltò attentamente quelle parole. Il giorno dopo, appena fece chiaro, uno schiavo che era stato ai suoi piedi durante la cena riferì a Rufo ciò che aveva detto mentre era ubriaco e lo esortò a informare Cesare denunciandosi da sé, prima che lo facesse qualcun altro. Accolto il consiglio, Rufo andò incontro a Cesare sulla soglia di casa e dopo avergli giurato che il giorno prima aveva avuto la mente sconvolta, gli chiese che quelle sue parole ricadessero su di sé e sui propri figli e lo pregò di perdonarlo e di riaccoglierlo nelle sue grazie. Avuta l’assicurazione di Cesare, aggiunse: «Nessuno crederà che io sia tornato nelle tue grazie se non mi farai un dono», e chiese una somma che neppure un favorito di Cesare avrebbe disdegnato, al che Cesare disse: «Nel mio interesse, farò di tutto per non adirarmi mai con te». Ebbene, Cesare si comportò in un modo che gli fa onore, perdonandolo e aggiungendo alla clemenza la generosirà: non c’è persona che, ascoltato questo episodio, non senta di dover lodare Cesare, ma solo dopo aver lodato lo schiavo. È inutile aggiungere che lo schiavo di Rufo per quel suo comportamento fu poi affrancato, ma non gratis: fu Cesare a pagare la somma per la sua libertà. 28. Dopo tanti esempi si può ancora dubitare che a volte il padrone può ricevere un beneficio da uno schiavo? E perché la condizione sociale dovrebbe sminuire il valore di un’azione, quando è l’azione ad accrescere il valore della condizione di chi la compie? Abbiamo tutti il medesimo principio e la medesima origine; nessuno è più nobile di un altro, se non chi ha un’indole più retta e più incline al bene. Coloro che mettono in mostra nell’atrio i ritratti di famiglia e dispongono nell’ingresso i nomi dei loro antenati in lungo ordine e collegati fra loro dalle numerose ramificazioni dell’albero genealogico sono forse più noti, ma non più nobili degli altri. L’unico padre, comune a tutti, è il cielo: è lì che, attraverso strade oscure o luminose, risale la prima origine di ciascuno. Non farti ingannare da chi, mentre ti fa l’elenco dei suoi antenati, ogni volta che gli manca
un nome illustre v’inserisce un dio. Non disprezzare alcuno, anche se è circondato da nomi sconosciuti o dimenticati che non sono stati affatto favoriti dalla sorte. Non importa che tra i vostri antenati ci siano degli schiavi, dei liberti o degli stranieri: siate fieri, alzate la testa e passate oltre lo spazio oscuro che c’è in mezzo, perché in cima alla vetta vi attende una somma nobiltà. Perché l’orgoglio accresce la nostra vanità al punto che ci sembra indecoroso ricevere benefìci dagli schiavi e badiamo solo alla loro condizione sociale, dimentichi dei loro servigi? Dài dello schiavo a uno proprio tu che sei schiavo della libidine, della gola e della tua amante, anzi, delle tue amanti, che ti possiedono in comune? Chiami schiavo qualcuno: ma tu dove sei trascinato da questi portatori che fanno fare dei giri a questo tuo letto? Dove ti portano questi uomini in abiti da viaggio che imitano quelli militari? Alla porta di qualche portinaio, ai giardini di qualche schiavo, che per giunta non è neppure regolare? E poi dici che un tuo schiavo non può essere tuo benefattore, proprio tu che consideri un beneficio il bacio di uno schiavo che non è neppure tuo? Cos’è questa sfacciata contraddizione? Disprezzi gli schiavi e nello stesso tempo gli fai la corte, fra le pareti domestiche sei tirannico e prepotente, mentre fuori sei debole e tanto disprezzato quanto tu disprezzi te stesso: nessuno, infatti, scende tanto in basso come chi monta in superbia così altezzosamente, nessuno è più pronto a calpestare gli altri di chi ha imparato a offendere gli altri ricevendo offese continuamente. 29. Questo occorreva dire per abbattere l’insolenza di quegli uomini che devono tutto ciò che sono alla fortuna e per rivendicare agli schiavi il diritto di fare dei benefìci e affinché questo diritto sia rivendicato anche dai figli. Ci si domanda, infatti, se i figli talvolta possano fare ai loro genitori un bene maggiore di quello che hanno ricevuto. Si ammetterà che molti di essi sono diventati più importanti e più potenti dei loro genitori, e molti anche migliori. Se così è, può essere che abbiano dato loro di più perché hanno una condizione migliore e sentimenti più alti. Si dice: «Qualunque cosa un figlio dia al padre è sempre meno di quel che il padre dà al figlio non fosse altro perché il figlio deve al padre la facoltà stessa di dare. E così non si può superare nei benefìci colui che ci ha dato come beneficio proprio questa possibilità di superarlo». Innanzitutto certe cose, anche se derivano da altre, diventano più grandi di quelle a cui hanno dato origine, e il fatto che una cosa non avrebbe potuto svilupparsi se non avesse avuto un inizio non è una buona ragione perché non diventi maggiore di ciò da cui è nata. Non c’è cosa che non superi a grandi passi la sua origine. I semi sono le cause di tutte le cose, e tuttavia sono una parte piccolissima di ciò che generano. Guarda il Reno, guarda l’Eufrate e tutti gli altri fiumi famosi: che cosa sono, se valuti la loro importanza nel punto in cui nascono? Tutto ciò per cui sono temuti o famosi l’hanno acquisito strada facendo. Se togli le radici non vi saranno più boschi tanto elevati e spoglie resteranno le montagne pur così imponenti. Guarda gli alberi, considera la loro altezza: è immensa; considera lo
spessore e l’estensione dei rami: si allargano per ampio tratto. Quanto piccolo al confronto è lo spazio che occupa la radice coi suoi esili filamenti! Templi e città poggiano sulle proprie fondamenta, ma queste, che sono state gettate per sostenere l’opera intera, sono nascoste. Lo stesso avviene in tutte le altre cose: la grandezza che ne consegue nasconde le loro origini. Non avrei potuto ottenere nulla di ciò che possiedo se in precedenza non avessi goduto dei benefìci dei miei genitori, ma non per questo ciò che ho ottenuto vale meno di ciò che mi ha consentito di averlo. Se la nutrice non mi avesse allevato quand’ero appena nato non avrei potuto compiere alcuna azione intellettuale o fisica né raggiungere quella fama che mi sono meritato con la mia attività civile e militare, ma non per questo devo porre il lavoro della nutrice al di sopra delle grandi imprese che ho compiuto. Eppure, che differenza c’è fra le due cose, visto che senza il beneficio del padre come senza quello della nutrice non avrei potuto realizzare niente? E se io sono debitore alla mia origine di tutto ciò che diverrò, che dirò quando la mia origine non è né mio padre né mio nonno, perché ci sarà sempre qualcosa di ulteriore da cui quella, più prossima, proviene? Eppure, nessuno dirà che io più che a mio padre sono debitore a degli antenati sconosciuti e al di là della portata della mia memoria, e invece proprio a loro devo di più inquantoché mio padre deve ai suoi antenati il fatto stesso di avermi messo al mondo. 30. «Tutto ciò che ho fatto per mio padre, anche se molto, è meno di quello che mi ha donato lui, perché non ci sarebbe stato se lui non mi avesse generato». Analogamente se uno ha guarito mio padre, prima che mi mettesse al mondo, poiché era gravemente ammalato e stava per morire, non potrò mai ripagarlo per il bene che mi ha fatto, inquantoché mio padre non mi avrebbe generato se lui non lo avesse guarito. Guarda, piuttosto, se non sia più corretto considerare se ciò che ho potuto fare e ciò che ho fatto non sia invece opera mia, delle mie forze, della mia volontà. Pensa al valore che ha in sé e per sé il fatto che io sia nato e vedrai che è cosa di poco conto e indefinibile, materia di bene o di male: certo, è il primo passo per ogni sviluppo, ma non è il più importante, perché è il primo. Ho salvato mio padre e l’ho innalzato al culmine degli onori e l’ho fatto diventare il primo fra i suoi concittadini, e non solo l’ho reso famoso con le mie opere, ma gli ho anche dato la possibilità, immensa, facile, sicura e onorevole, di compierne anche lui; cariche, ricchezze, tutto ciò che esalta l’animo umano l’ho accumulato su di lui e pur trovandomi al di sopra di tutti mi sono sempre tenuto al di sotto di lui. Ora, se mi dici: «L’aver potuto fare tutto ciò è un dono di tuo padre» ti risponderò: «Certo, se per fare queste cose fosse sufficiente nascere; ma se per vivere moralmente ciò che conta meno è proprio la vita, e se tu, padre, mi hai donato ciò che l’uomo ha in comune con le bestie feroci e con gli animali più insignificanti o addirittura più immondi, non puoi attribuirti cose che non derivano dai tuoi benefìci, anche se non possono realizzarsi senza di essi». 31. Supponi che io abbia ricambiato con la mia vita il dono della vita che tu
mi hai fatto: anche così ho superato il tuo dono, perché ho donato a uno che aveva coscienza, perché io stesso donavo coscientemente, perché non ti ho dato la vita per un piacere o attraverso il piacere, perché è tanto più importante conservare la vita piuttosto che riceverla quanto è più lieve morire prima di cominciare a temere la morte. Io ho dato la vita a uno che ne avrebbe subito usufruito, mentre tu l’hai data a uno che non sapeva se sarebbe vissuto; io ho dato la vita a uno che aveva paura di morire, tu invece l’hai data a uno che, proprio ricevendola, diveniva soggetto alla morte; io ti ho dato una vita completa, tu mi hai generato come un essere privo di ragione, un peso per gli altri. Vuoi sapere perché il dare la vita così non sia un grande beneficio? Avresti potuto espormi, ma a quel punto l’avermi generato sarebbe stata un’offesa. Dove voglio arrivare? Il rapporto sessuale fra padre e madre non è affatto un beneficio se essi non vi aggiungono tutto ciò che segue a questo dono iniziale e che con altri servigi ne consacra il valore. Il bene non è vivere, è vivere bene. Ma io vivo bene. Però avrei anche potuto vivere male, quindi io devo a te soltanto la vita. Se mi addebiti la vita in sé e per sé, nuda, priva di discernimento e te ne vanti come di un grande bene, pensa che mi addebiti un bene che hanno anche le mosche e i vermi. Inoltre, per parlare solo dei miei studi liberali e della mia condotta indirizzata al bene, tu nel tuo beneficio stesso hai ricevuto più di quanto avevi dato, perché mi hai generato come un essere ignorante e senza esperienza, mentre io ti ho dato un figlio tale da goderne per averlo generato. 32. Mio padre mi ha nutrito. Se io faccio con lui la stessa cosa gli rendo di più, perché egli è lieto non solo perché viene nutrito ma perché a nutrirlo è il figlio e gode più per la mia benevolenza verso di lui che per il nutrimento in sé, mentre il nutrimento che mi dava lui toccava solo il mio corpo. Se poi un figlio ha fatto tanti progressi da diventare famoso presso tutti i popoli o per la sua eloquenza o per la sua giustizia o per le sue imprese militari, e ha riversato la sua fama anche sul padre, illuminando l’oscurità dei suoi natali, non ha fatto ai suoi genitori un beneficio ineguagliabile? O forse qualcuno avrebbe conosciuto Aristone e Grillo senza i loro figli Senofonte e Platone? Socrate ha impedito che Sofronisco venisse dimenticato. Sarebbe troppo lungo elencare tutte le persone di cui sopravvive il ricordo solo perché le qualità eccezionali dei figli lo hanno tramandato ai posteri. È più grande il beneficio fatto ad Agrippa dal padre, che è famoso solo per aver avuto un figlio come Agrippa, oppure quello che ha fatto al padre Agrippa, famoso per aver ottenuto la corona navale, 10 la più alta fra le onorificenze militari, e per aver fatto erigere a Roma grandissimi edifici che superavano la magnificenza di quelli precedenti e che non furono mai superati nelle epoche successive? È più grande il beneficio che Ottavio ha fatto a suo figlio o quello che il divo Augusto 11 ha fatto a suo padre (benché questi sia stato oscurato dal padre adottivo)? Quale gioia avrebbe provato quel padre, se avesse visto che il figlio, dopo aver sedato le guerre civili, vegliava sulla pace ormai assicurata! Avrebbe preso atto che quel bene proveniva da lui e pensando a sé
stesso avrebbe creduto a stento che un uomo simile potesse nascere in casa sua. Ma perché dovrei continuare a elencare i nomi di quanti sarebbero già dimenticati se la gloria dei loro figli non li avesse strappati alle tenebre mantenendoli ancora nella luce? E poiché ci chiediamo non quale figlio abbia reso al padre benefìci maggiori di quelli ricevuti da lui, ma se qualcuno possa renderne di più grandi, anche se gli esempi che ho fatto non ti soddisfano e non superano quelli dei genitori, in natura possono pure accadere cose che prima non sono mai accadute. Se è vero che un singolo beneficio non può superare in grandezza i meriti dei nostri genitori, vi riusciranno però più benefìci accumulati su un solo. 33. Scipione salva in battaglia la vita a suo padre12 e, pur indossando ancora la pretesta, sprona il cavallo contro il nemico. È cosa da poco, per arrivare fino al padre, aver disprezzato tanti ostacoli e tanti pericoli che in quel momento angustiavano i più grandi generali, essersi aperto una strada verso la prima linea passando sui corpi dei veterani, aver compiuto insomma un’azione superiore alle possibilità che gli consentivano i suoi anni giovanili? Immagina pure che quello stesso figlio difenda il padre in un processo e lo strappi alla congiura di nemici potenti,13 che gli faccia avere una seconda e una terza volta il consolato e altri onori ai quali aspiravano anche degli ex consoli, che ceda a lui, povero, il bottino ottenuto per diritto di guerra e, onore grandissimo per i militari, lo renda ricco di trofei strappati al nemico. E se non basta, immagina che il figlio gli protragga il governo delle province e i poteri straordinari; che dopo aver distrutto grandissime città, divenuto difensore e fondatore di un impero che si sarebbe esteso senza alcun rivale fino agli estremi confini a oriente e a occidente, aggiunga alla nobiltà del padre qualcosa di ancora più prestigioso, il titolo di padre di Scipione: ebbene, come dubitare che il banale beneficio di averlo messo al mondo sia stato superato da una straordinaria devozione e da un valore che non so se alla città dia più sicurezza o più onore? E se tutto ciò è ancora poco, immagina che un figlio abbia sottratto il padre alla tortura, prendendone il posto. Puoi estendere all’infinito i benefìci che un figlio può fare al padre, mentre il dono del padre è uno solo, è facile ed è anche piacevole per chi lo concede, forse ha dato la vita anche ad altri, magari senza saperlo, visto che quell’atto l’ha consumato con un’amante, e l’ha compiuto tenendo presente la legge, la patria, le prerogative del padre, la continuità della casa e della famiglia, tutto, tranne la persona alla quale concedeva quel dono. E che? Se uno, dopo aver conseguito la saggezza, la trasmette al padre, staremo ancora a discutere se è più quello che ha dato o quello che ha ricevuto, quando al padre ha dato come contraccambio una vita felice, mentre lui ha ricevuto dal padre solo la vita materiale? 34. Si obietterà: «Ma il beneficio della nascita datoti da tuo padre comprende tutto ciò che tu puoi fare e che gli puoi offrire». Anche quello del mio
precettore comprende tutti i progressi che ho fatto grazie agli studi liberali che mi ha impartito, noi, però, superiamo anche chi ci ha dato quella educazione e coloro che ci hanno insegnato le nozioni elementari; sebbene senza il loro aiuto nessuno potrebbe conseguire alcunché, non è però vero che, per quanto grande sia ciò che abbiamo conseguito, restiamo inferiori a loro. C’è una grande differenza fra ciò che è primo in ordine di tempo e ciò che è primo per importanza, né le due cose si equivalgono perché ciò che è primo per importanza non sarebbe stato possibile senza ciò che è primo cronologicamente. 35. A questo punto è ora di produrre qualcosa che abbia, per così dire, il marchio della nostra fabbrica. Chi ha dato un beneficio del quale ne esiste uno migliore può essere superato. Il padre ha dato al figlio la vita, ma c’è qualcosa che vale più della vita, quindi il padre può essere superato, perché ha dato un beneficio del quale ne esiste uno migliore. Ancora: se chi ha dato la vita a qualcuno è stato salvato più di una volta dalla morte ha ricevuto un beneficio maggiore di quello che ha dato; ora, il padre mi ha dato la vita: dunque, se viene liberato più volte da un pericolo di morte a opera di suo figlio, riceve un beneficio maggiore di quello che ha dato. Uno riceve un beneficio tanto maggiore quanto maggiore è il bisogno che ne ha; ora, chi vive ha bisogno della vita più di chi non è ancora nato, che non potrebbe neppure avvertire un bisogno; dunque, il padre, se riceve la vita dal figlio, riceve un beneficio maggiore di quello che riceve il figlio dal padre che lo ha fatto nascere. «I benefìci del padre non possono essere superati da quelli del figlio, perché questi ha ricevuto la vita dal padre e se non l’avesse ricevuta, non avrebbe potuto dargli alcun beneficio». Ma il beneficio della vita il padre l’ha in comune con tutti quelli che hanno dato la vita a qualcuno; bisogna ricevere la vita per poter dimostrare la propria riconoscenza, dunque non si potrebbe superare, pur dimostrandogli riconoscenza, neppure il beneficio del medico (il quale pure dà la vita), né quello del pilota che ci ha preso a bordo quando abbiamo fatto naufragio. E invece i benefìci di costoro e di altri che in un modo o nell’altro ci hanno dato la vita possono essere superati, quindi possono esserlo anche quelli di un padre. Se uno mi ha dato un beneficio che doveva essere sostenuto da benefìci di molti altri e io invece gliene ho dato uno che non aveva bisogno di alcun sostegno gli ho dato più di quanto ho ricevuto; il padre ha dato al figlio una vita che sarebbe andata perduta se non si fossero aggiunte molte cose a sua protezione; il figlio, invece, se ha dato la vita al padre, gliel’ha data tale che non aveva bisogno di alcun aiuto per sussistere, dunque, il padre che ha ricevuto la vita dal figlio ha ricevuto da questi un beneficio maggiore di quello che gli aveva fatto lui. 36. Queste considerazioni non cancellano la venerazione dei figli per i genitori e non rendono i figli meno riguardosi verso di loro, anzi li rendono migliori, poiché la virtù, per sua natura, ama la gloria e desidera ardentemente
superare chi la precede. L’affetto filiale sarà più vivo se per contraccambiare il bene ricevuto si farà avanti con la speranza di superarlo. Ciò provocherà l’approvazione e la gioia dei genitori, poiché generalmente l’essere superati va a nostro vantaggio. Dove mai può esserci una gara più desiderabile di questa? Dove trovare per i genitori una felicità così grande qual è quella di riconoscere che i loro beni sono inferiori a quelli dei figli? Se invece non la pensiamo così diamo ai nostri figli una scusa, li rendiamo più pigri nel dimostrare la loro riconoscenza: dobbiamo stimolarli e dir loro: «Su, ottimi giovani! È stata indetta una nobile gara tra genitori e figli per sapere chi ha dato o chi ha ricevuto di più. Non è detto che abbia già vinto chi è partito prima; prendete il coraggio necessario e non arrendetevi: vincerete degli avversari che non desiderano altro. E non mancano per una gara così bella delle guide che vi esortino a imitare le loro imprese e vi facciano seguire le loro orme verso una vittoria che spesso i figli hanno già riportato sui padri». 37. Enea, che da bambino era stato un peso leggero e tranquillo per lui, superò in benefìci suo padre, portandoselo sulle spalle, appesantito dalla vecchiaia, attraverso le schiere nemiche e in mezzo alle rovine della città che gli crollava intorno, mentre il devoto vecchio, stringendo fra le braccia gli oggetti sacri e gli dèi Penati, intralciava col suo peso il cammino del figlio. Lo portò in salvo attraverso le fiamme e (cosa non può fare l’affetto filiale!) lo pose così tra i fondatori dell’impero romano, che noi veneriamo. I giovani siciliani, Anapo e Anfìnomo, mentre l’Etna, agitato da scosse più violente, riversava il fuoco sulle città, sulle campagne e su gran parte dell’isola, condussero in salvo i loro genitori; la lava – così si credette – deviò e, ritraendosi le fiamme da entrambi i lati, si aprì un varco attraverso il quale passarono correndo questi giovani che meritavano di compiere indenni la loro grande impresa. Antigono, avendo sconfitto il nemico in una grande battaglia, portò al padre il frutto di quella guerra e gli diede la sovranità su Cipro. Questo è essere veramente re: privarsi di un regno che si potrebbe possedere. Anche Manlio14 superò il padre, un tiranno che lo aveva esiliato per la rozzezza e l’ottusità da lui dimostrate nell’adolescenza. In seguito, avendo il tribuno della plebe citato in giudizio il padre, si presentò in tribunale e chiese di poter parlare con lui. Il magistrato acconsentì, sperando che avrebbe tradito il padre tanto odiato (ma al tempo stesso, avendo in precedenza rimproverato all’uomo, come il più grave dei crimini, l’esilio di Manlio, pensava anche di essersi meritato la riconoscenza del figlio). Ma il giovane, ottenuto l’incontro privato, estrasse il pugnale che teneva nascosto sotto la veste e disse al tribuno: «Se non giuri di rinunciare al processo contro mio padre ti trafiggerò. A te non manca la possibilità di trovare il modo in cui mio padre possa liberarsi dal suo accusatore». Il magistrato giurò e mantenne la parola, riferendo all’assemblea il motivo per il quale rinunciava al processo. Nessun altro ebbe mai l’ardire di dare ordini a un tribuno rimanendo impunito.
38. Sono numerosi gli esempi di figli che hanno strappato dai pericoli i loro genitori, che dalla condizione più umile li hanno portati alla più elevata e che dalla plebe e dalla massa oscura li hanno offerti alla memoria perenne dei posteri. Non v’è abilità oratoria, non v’è ricchezza d’ingegno che possa esprimere quanto sia importante e lodevole, e quanto meriti di essere ricordato in eterno, il poter dire: «Ho obbedito ai miei genitori, giusta o ingiusta e dura che fosse la loro autorità, l’ho rispettata, mi sono comportato con umiltà e arrendevolezza: in una sola cosa ho opposto resistenza: non mi sono lasciato superare nei benefìci». Gareggiate, vi prego, e anche se stanchi tornate a lottare. Felici coloro che vinceranno, felici coloro che saranno vinti! Cosa c’è di più bello di quel giovane che possa dire a sé stesso (dirlo agli altri sarebbe un’empietà): «Ho superato in benefìci mio padre»? Cosa c’è di più fortunato di quel vecchio che andrà dicendo a tutti e in ogni luogo di essere stato superato in benefìci dal figlio? Quale maggiore fortuna che perdere in questa battaglia?
1.Lettere a Lucilio, 73, 3. 2.Lettere a Lucilio, 79, 15; 63, 5-7. 3. Le esercitazioni nelle scuole di eloquenza comprendevano le suasoriae, orazioni a favore di un progetto di legge o in difesa di qualcuno, e le controversiae, orazioni con lo scopo opposto. 4. Contro gli ingrati si poteva intentare azione legale ad Atene, a Marsiglia e in Persia. 5. Le tabulae plurium erano i registri in cui gli intermediari annotavano il debito, mentre il creditore lo annotava nel suo registro. 6. Claudio Quadrigario era un annalista contemporaneo di Silla. 7. È un episodio della guerra sociale (90-88 a. C), in cui i Romani domarono la rivolta degli Italici. Grumento era una piccola borgata dell’antica Lucania. 8. È un altro episodio della guerra sociale. Il generale romano era Cneo Pompeo Strabone. Vezio occupò la città sannita di Isernia e sconfisse un esercito romano, ma il giorno dopo (90 a.C.) fu battuto da Mario. 9. Corfinio in Abruzzo era l’antica capitale dei Peligni. Durante la guerra civile del 49 a.C. fu assediata ed espugnata da Cesare, che lasciò libero L. Domizio Enobarbo, il capo pompeiano. 10. Marco Vipsanio Agrippa, di umili natali, affiancò Ottavio nella guerra contro i Parti; fu pretore e governatore. La corona navale gli fu data per la vittoria su Sesto Pompeo nel 36 a.C. Sposò Giulia, figlia di Augusto, e diede grande impulso all’edilizia: le sue opere maggiori sono il Pantheon e le Terme. 11. Ottavio (63a.C.-14 d. C), discendente da famiglia equestre, nacque da Gaio e da Attia, nipote di Cesare, il quale lo adottò e alla sua morte gli lasciò in eredità tre quarti delle sue sostanze. Rientrato in patria dall’Epiro, intraprese la carriera politica assumendo il nome di Gaio Giulio Cesare Ottaviano. Divenuto imperatore nel 30 a.C., assunse il titolo di Augusto. 12. Publio Cornelio Scipione, detto l’Africano Maggiore (235-183 a.C.) nel 218, durante la battaglia del Ticino, salvò la vita al padre. 13. In realtà Scipione rese questo servizio non al padre, ma al fratello Lucio Cornelio Scipione Asiatico, a cui Publio fu inviato come consigliere nella guerra contro Antioco in Asia. Al loro ritorno i due fratelli furono chiamati dai tribuni a render conto di come avessero utilizzato le enormi ricchezze di Antioco: Publio cercò di opporsi alle accuse, ma Lucio fu condannato a una grossa multa. I benefìci citati vogliono dimostrare la possibilità che un figlio renda al padre più di quanto ha ricevuto. 14. F. Manlio Torquato, più volte console, combatté vittoriosamente contro i Latini e i Campani. Ne
parla Cicerone nel De officiis, III 112.
Libro quarto 1. Fra tutte le questioni che abbiamo affrontato, o Ebuzio Liberale, la più essenziale o più bisognosa di essere analizzata accuratamente, per dirla con Sallustio, è questa: se fare del bene e ricambiarlo mostrandosi riconoscenti siano cose desiderabili per sé stesse. Ci sono infatti persone che praticano il bene mirando a una ricompensa, le quali non gradiscono la virtù quando non si fa pagare. Ma che attrattiva ha la virtù se diventa in qualche misura venale? Non c’è cosa più meschina del misurare il guadagno di un uomo che agisce onestamente, quando invece la virtù ci invita ad agire senza la prospettiva di un guadagno, né ci trattiene con la paura di subire dei danni, ed è tanto lontana dal lusingarci con speranze e promesse che anzi ci impone dei sacrifici e molto spesso consiste in ciò che diamo spontaneamente. Bisogna andare verso la virtù calpestando i propri interessi: dovunque ci chiami, dovunque ci mandi, bisogna agire senza riguardo per il nostro patrimonio, talvolta addirittura senza risparmiare il nostro sangue e senza sottrarsi al suo comando. Mi dirai: «Ma che ci ricavo se farò tutto questo con coraggio e con riconoscenza?». Otterrai di averlo fatto: non ti si promette nient’altro che questo. Se poi ne conseguirai qualche vantaggio consideralo un sovrappiù. La ricompensa delle buone azioni consiste nelle azioni stesse. Se il bene è desiderabile per sé stesso, e il beneficio è un bene, è chiaro che, essendo della medesima natura, non può sottostare a una legge diversa, e che il bene sia desiderabile per sé stesso è stato dimostrato spesso e distesamente. 2. Su questo punto ci scontriamo con gli epicurei, una schiera di poltroni e di raffinati che filosofeggiano nei loro banchetti: per loro la virtù è serva dei piaceri, obbedisce a essi, vi si sottomette e li guarda al di sopra di sé. «Non c’è piacere senza virtù». Ma perché prima della virtù? Pensi che sia solo una questione di precedenza? In ballo è il principio intero e il valore stesso della virtù. Se la virtù può stare al secondo posto non è più tale: a lei spetta il primo, lei deve guidare, comandare, stare nel posto più alto; e tu invece pretendi che prenda degli ordini! «Non è questo il punto. Anch’io sostengo che senza virtù non può esserci vita felice. Il piacere stesso, che io seguo e di cui mi sono fatto schiavo, se privo di virtù, io lo disapprovo e lo condanno. Si tratta solo di vedere se la virtù sia causa del sommo bene o se sia essa stessa il sommo bene». Per limitare l’esame a questo solo punto, pensi che basti cambiare l’ordine di precedenza? Ma è segno di confusione e di palese cecità anteporre ciò che va all’ultimo posto a ciò che va al primo! Io m’indigno non perché la virtù sia posta dopo il piacere, ma perché viene fusa del tutto col piacere, quando invece lo disprezza, gli è ostile e ne fugge il più lontano possibile, quando ha maggiore familiarità con la fatica e col dolore, che sono disagi di uomini veri, piuttosto
che con questo bene effeminato. 3. Ho dovuto inserire qui, o Liberale, tutte queste considerazioni, perché il beneficio di cui stiamo parlando è proprio della virtù, e il concederlo per un motivo diverso da quello per cui deve essere dato è la cosa più meschina, poiché se lo elargissimo nella speranza di ricevere un contraccambio, daremmo ai più ricchi, non ai più degni, e io, invece, a un riccone prepotente preferisco un povero. Non è un beneficio quello che guarda alla fortuna del ricevente. Per di più, se dovessimo fare del bene spinti unicamente dall’utilità dovrebbero farne pochissimo proprio coloro che ne avrebbero maggiore possibilità, cioè i ricchi, i potenti, i re, persone che non hanno bisogno dell’aiuto altrui; da parte loro gli dèi non ci elargirebbero tutti quei doni che ci dànno ininterrottamente di giorno e di notte; loro, infatti, sono per natura autosufficienti e ciò gli garantisce tutte le risorse possibili, la sicurezza e l’inviolabilità, sicché se l’unico impulso che spinge a donare è il proprio egoismo, il proprio utile, essi non concederanno benefìci ad alcuno. Non è da benefattori, è da usurai pensare a ricavarne il massimo guadagno o a come poterlo recuperare più facilmente invece di trovare al beneficio la migliore destinazione.1 E poiché gli dèi sono ben lontani dal fare questi calcoli ne consegue che sono liberali; se infatti si concede un beneficio all’unico scopo di ricavarne un’utilità e se gli déi non possono sperare di trarre da noi alcuna utilità essi non hanno alcun motivo di farci del bene. 4. So cosa mi si potrebbe ribattere a questo punto: «È così: dio non concede benefìci, ma tranquillo e indifferente a noi, volta le spalle al mondo e si occupa di altro, oppure non fa nulla (cosa che a Epicuro sembra la massima felicità), e i benefìci non lo toccano più di quanto non lo tocchino le offese». Chi dice ciò non ode le voci di quelli che pregano e che dovunque, levate le mani al cielo, fanno dei voti in pubblico e in privato, né gli uomini sarebbero stati tutti così pazzi da rivolgersi a divinità sorde e a dèi impotenti se non avessero sperimentato i loro benefìci, i quali, offerti spontaneamente o concessi in seguito alle preghiere, sono grandi, opportuni e allontanano da noi gravi minacce. Non c’è persona tanto disgraziata, tanto derelitta o generata con un destino così duro e una tale sofferenza, che non abbia sperimentato l’immensa generosità degli dèi. Guarda intorno a te persino coloro che piangono la loro sorte e si lamentano: vedrai che neppure loro sono stati esclusi del tutto dai benefìci celesti e che non c’è nessuno a cui non sia arrivato qualcosa da quella fonte inesauribile. O ti sembra poco ciò che viene distribuito equamente a tutti coloro che nascono? Per non parlare di quei doni che vengono dispensati in misura diseguale, forse la natura ci ha fatto un dono troppo piccolo quando ci ha donato sé stessa? 5. «Dio non dà benefìci». Da dove viene allora tutto ciò che possiedi, che dài, che rifiuti, che conservi, che rubi? Da dove vengono quelle innumerevoli
cose che dilettano i tuoi occhi, le tue orecchie, il tuo spirito? Da dove viene quella profusione di beni che alimenta il tuo lusso (dio infatti non provvede solo alle nostre necessità, ma ci ama al punto da viziarci)? Da dove vengono tanti alberi che producono frutti di diverso genere, tante erbe salutari, tanta varietà di cibi distribuita nel corso di tutto l’anno, al punto che la terra offre anche all’ozioso il nutrimento, senza che egli si dia da fare per procurarselo? E gli animali di ogni specie, quali nascono all’asciutto e sulla terraferma, quali nell’acqua, quali scendono dal cielo, affinché ogni parte della natura ci porti un suo contributo? E questi fiumi che cingono i campi coi loro giri ameni, quelli che offrono una via per il commercio, con un corso ampio e navigabile, fra i quali alcuni che d’estate si accrescono mirabilmente affinché regioni aride e sottoposte a un clima torrido vengano irrigate dall’improvvisa violenza della corrente estiva? E che dire delle sorgenti d’acque medicinali? E dello zampillare di acque termali proprio in riva al mare? E tu, Lario immenso, e tu, Benaco, che ti sollevi con i flutti e il fragore del mare?2 6. Se qualcuno ti avesse donato pochi iugeri di terra tu diresti di aver ricevuto un beneficio: e non vorresti definire un beneficio le immense distese di terra che si aprono alla tua vista? Se qualcuno ti donerà del denaro e ti riempirà la cassaforte, che a te sembra una gran cosa, definirai questo un beneficio; dio ha interrato tanti metalli, ha fatto scaturire tanti fiumi che portano oro sulle terre su cui scorrono, un’enorme quantità d’argento, di rame, di ferro è seppellita in ogni luogo e dio ti ha dato la facoltà di andare a cercarla e ha sistemato in superficie dei segnali che indicano dove sono nascoste queste ricchezze: e tu dici di non aver ricevuto alcun beneficio? Se ti viene donata una casa nella quale risplendano i marmi e il tetto scintilli d’oro e di colori, non lo chiamerai un dono banale; ebbene, dio ti ha costruito una casa immensa che non temi possa incendiarsi o crollare, nella quale vedi non dei sottili intonaci, ancor più sottili delle lame che servono per tagliarli, ma blocchi interi di pietre preziosissime, di quel materiale vario e multiforme di cui ammiri i minuscoli frammenti, e un tetto che di notte risplende in un modo, di giorno in un altro: e tu dici di non aver ricevuto alcun beneficio? E, pur stimando molto queste cose che possiedi, ritieni, com’è tipico dell’ingrato, di non esserne debitore a nessuno? Da dove viene quest’aria che respiri? E questa luce in virtù della quale disponi e regoli le azioni della tua vita? E il sangue, nella cui circolazione risiede il calore vitale? E questi cibi che con sapori squisiti solleticano il tuo palato anche quando sei già sazio? E questi altri capaci di eccitare la tua già stanca voluttà? E questa quiete nella quale ti rammollisci e marcisci? Se sei riconoscente, dirai: È un dio che ci ha dato questa tranquillità; egli resterà sempre un dio per me, e spesso
un tenero agnellino dei miei ovili bagnerà il suo altare. Come vedi, egli ha permesso ai miei buoi di pascolare e a me di suonare liberamente il flauto agreste.3 È un dio che ha sparso per tutto il mondo non già pochi buoi, ma gli armenti, che a tutte le greggi sparse dovunque garantisce il foraggio, che alterna ai pascoli invernali quelli estivi, che non solo ci ha insegnato a suonare il flauto e a modulare un canto agreste e rustico, pur dotato di un certo ritmo, ma ha anche inventato tante arti, tante varietà di voci, tanti suoni, che, prodotti dalla nostra voce o da uno strumento, dànno origine a una melodia. E non potrai dire che le scoperte che noi abbiamo fatto siano opera nostra, non più di quanto lo sia la nostra crescita fisica o il fatto che in un tempo determinato certe funzioni siano conformi allo stato o alle necessità del nostro corpo: ora la caduta dei denti da latte, ora la pubertà, il crescere dell’età e il passaggio a una fase di maggior vigore, ora lo spuntare del dente del giudizio che segna la fine dello sviluppo giovanile. In noi sono insiti i germi di tutte le età della vita e di tutte le arti, e dio, nostro maestro, sviluppa dalle profondità del nostro essere le nostre possibilità. 7. Si obietterà: «È la natura che fa tutte queste cose per me». Ma non capisci che parlando così non fai che chiamare dio con un altro nome? Cos’è infatti la natura se non dio e la ragione divina che permea l’universo, nelle sue parti e nella sua totalità? Puoi dare tanti altri nomi quanti ne vuoi a questo autore di tutte le nostre cose, puoi chiamarlo, come siamo soliti, Giove Ottimo Massimo, oppure Tonante, o Statore, un nome che deriva non dal fatto, come dicono gli storici, che in seguito a una preghiera fece fermare l’esercito dei Romani in fuga, ma dal fatto che tutte le cose stanno grazie a lui, che ne è lo “statore”, cioè colui che dà stabilità. Se poi lo chiamerai anche Fato, non sbaglierai, perché il Fato non è altro che una serie concatenata di cause, di cui dio è la prima, da cui dipendono tutte le altre. Qualunque nome tu scelga si conviene perfettamente a lui, purché racchiuda l’idea di una potenza che produce tutte le realtà celesti, e i suoi nomi potrebbero essere tanti quanti sono i suoi doni. 8. I nostri antenati lo chiamano anche Padre Libero, Ercole e Mercurio: Padre Libero in quanto è padre di tutto, cioè l’inventore del potere seminale che perpetua la vita attraverso il piacere; Ercole in quanto la sua forza è invincibile e quando si sarà stancata di tutte le opere prodotte si trasformerà nuovamente in fuoco; Mercurio perché a lui appartengono la ragione, il numero, l’ordine e la scienza. Dovunque tu ti volga lo vedi venirti incontro;4 non c’è cosa in cui non ci sia lui, il quale con la sua presenza riempie la propria opera. Perciò sei il più ingrato dei mortali se dici di essere debitore non a dio ma alla natura, perché non c’è natura senza dio e dio senza natura ma sono entrambi una medesima cosa, diversi solo per funzione. Se tu dicessi di dovere ad Anneo o a Lucio ciò che hai
ricevuto da Seneca, cambieresti non il creditore ma il nome, perché, che tu lo chiami col prenome o col cognome, egli resta sempre la stessa persona. Dunque, che tu parli di natura, di Fato o di fortuna, sono tutti nomi del medesimo dio che si serve del suo potere in modi diversi. Anche giustizia, probità, prudenza, coraggio e sobrietà sono qualità di un medesimo animo, e qualunque di esse ti piaccia ti piace l’animo che le possiede. 9. Ma, per non divagare dall’argomento, dio ci concede numerosissimi e importantissimi benefìci senza contraccambio alcuno, visto che non ha bisogno di riceverne e senza di lui noi non avremmo la possibilità di dargliene; quindi il beneficio è desiderabile di per sé, ciò a cui bisogna pensare è solo l’utilità di colui che lo riceve: mettiamo quindi da parte i nostri interessi e miriamo solo a questo. Si obietterà: «Voi dite che bisogna scegliere accortamente le persone a cui far del bene, perché anche gli agricoltori non gettano le sementi nella sabbia; ma se così stanno le cose, nel concedere un beneficio noi perseguiamo il nostro utile, come nell’arare e nel seminare: infatti neppure il seminare è desiderabile di per sé. Inoltre vi chiedete quando e come si debba concedere un beneficio, una domanda che se il beneficio fosse desiderabile di per sé non si dovrebbe nemmeno porre, poiché in qualunque modo venisse fatto sarebbe comunque un beneficio». Ebbene, noi ricerchiamo l’onestà unicamente per sé stessa, tuttavia, anche se non si deve ricercarla per alcun altro motivo, ci chiediamo cosa fare, quando e in che modo: è attraverso queste cose che l’onestà si realizza. Così, quando scelgo la persona a cui fare del bene, quando cerco come e quando farlo, mi preoccupo che, per quanto sta nelle mie possibilità, sia un beneficio vero, perché se lo si concede a un uomo indegno non può esserci né beneficio né azione onesta. 10. Restituire una cosa che abbiamo avuto in deposito è desiderabile di per sé, ma non per questo si restituisce sempre e in qualunque circostanza. Certe volte non c’è differenza se non restituisco o se restituisco apertamente. Baderò all’utilità che ne ricava colui al quale voglio restituire, ma mi rifiuterò di restituirgli un deposito se ciò potrà nuocergli. Agirò nello stesso modo nel fare il bene: valuterò, cioè, quando dare, a chi dare, come e perché. Non bisogna infatti agire senza ragione, e d’altra parte solo ciò che viene dato in virtù di una scelta razionale è un beneficio, perché la ragione è la compagna di ogni azione virtuosa. Quante volte dalla bocca di uno che veniva rimproverato per la sua avventata generosità abbiamo udito queste parole: «Preferirei averlo perduto piuttosto che averlo dato a lui!». Un beneficio avventato è la perdita più vergognosa, ed è molto più grave avere sbagliato un beneficio che non averne ricevuto il contraccambio, perché se non riceviamo il contraccambio la colpa è degli altri, ma se non abbiamo scelto bene il destinatario del beneficio la colpa è nostra.
Nel fare la scelta ciò a cui baderò di meno è proprio quello che tu invece cerchi, cioè la possibilità di avere un contraccambio: scelgo, infatti, chi mi sarà riconoscente, non chi mi darà il contraccambio, e d’altra parte spesso accade che chi non dà il contraccambio sia comunque riconoscente mentre sia ingrato colui che lo dà. Io valuterò in base alla disposizione d’animo, quindi trascurerò un uomo ricco ma indegno e darò invece a un uomo povero ma virtuoso, perché costui anche nella più grande indigenza si mostrerà riconoscente e se non avrà nulla da dare in cambio gli resterà sempre la buona disposizione d’animo. 11. Dal beneficio io non cerco di ottenere né il guadagno né il piacere né la gloria, ma darò esclusivamente per fare ciò che si deve, pago di far piacere a uno solo. Tuttavia il dovere non esiste senza una scelta, e quale sarà la mia? Sceglierò un uomo onesto, sincero, che si ricordi del bene ricevuto e sia riconoscente, che rispetti i beni altrui e non sia sordidamente attaccato ai suoi, che sia generoso; e quando lo avrò scelto riterrò di avere agito in coscienza, anche se la fortuna non darà al beneficato la possibilità di dimostrare concretamente la sua riconoscenza. Se invece sono generoso per interesse o per un calcolo meschino, se faccio del bene solo a chi a sua volta ne fa a me, non concederò mai un beneficio a chi parte verso paesi lontani per non tornare più, oppure a chi è così gravemente malato da non aver alcuna speranza di guarigione, e non lo concederò ancora quando le mie forze mi verranno meno, perché non farò in tempo a ricevere il contraccambio. Eppure, se vuoi renderti conto che fare il bene sia desiderabile di per sé, pensa che noi aiutiamo gli stranieri, i quali non fanno in tempo a giungere nel nostro porto che ripartono immediatamente. Così a uno sconosciuto che ha fatto naufragio diamo una nave con tutto l’equipaggiamento affinché possa tornare in patria, e lui parte conoscendo appena chi lo ha salvato e dal momento che non ci rivedremo più trasferisce agli dèi il debito che ha nei nostri confronti pregandoli di darci il contraccambio per conto suo; e noi intanto proviamo piacere per aver concesso un beneficio che non ci darà alcun frutto. E quando siamo giunti al termine della nostra vita, quando facciamo testamento, non distribuiamo forse dei benefìci dai quali non ricaveremo alcun frutto? Quanto tempo si perde, quanto a lungo si esamina la propria coscienza prima di decidere quanto e a chi lasciare l’eredità! Ma che importa sapere a chi doniamo quando non riceveremo un contraccambio da alcuno? Tuttavia proprio quando, privi di ogni interesse, abbiamo davanti a noi solo l’idea del bene doniamo con maggiore accuratezza e controlliamo più rigorosamente i nostri giudizi. Abbiamo mal giudicato i nostri doveri fino a quando la speranza, il timore o il piacere, spregevole vizio, hanno distorto il nostro giudizio, ma quando la morte toglie di mezzo tutte queste cose e ci manda per le nostre decisioni un giudice incorruttibile, allora cerchiamo i più meritevoli a cui affidare i nostri beni e non c’è cosa che disponiamo con maggiore cura quanto ciò che non ci riguarda più. Ma, perbacco, un grande piacere prova nell’animo colui che pensa: «Renderò costui più ricco e
accrescendo il suo patrimonio nobiliterò la sua posizione sociale». Se facciamo del bene pensando solo al contraccambio dovremmo morire senza fare testamento. 12. Si obietterà: «Voi dite che il beneficio è un credito che non può essere riscosso; ma un credito non è desiderabile di per sé». “Credito” è un’immagine, una metafora, come quando diciamo che la legge è la riga che separa il giusto dall’ingiusto, e una riga non è una cosa desiderabile di per sé. Ci adattiamo a usare questi vocaboli per chiarire il concetto: quando dico “credito” questa parola va intesa nel senso di “una specie di credito”. E vuoi saperlo? Vi aggiungo “che non può essere riscosso”, perché un credito si può o si deve sempre riscuotere. È tanto vero che non bisogna concedere un beneficio per interesse che, come ho detto, bisogna concederlo anche a costo di dover affrontare perdite e rischi. Se uno è aggredito dai briganti io mi fermo e lo difendo, ma potrei anche proseguire tranquillamente per la mia strada; se un imputato si trova in difficoltà per le stringenti testimonianze contro di lui, io lo difendo, rivolgendo su di me l’ira dei notabili e magari rischiando di ritrovarmi, per opera degli accusatori stessi, nelle vesti di accusato, e ciò pur avendo la possibilità di starmene tranquillo a osservare una lite che non mi riguarda. Se un uomo è condannato, io rispondo per lui e se è già stato posto il sequestro sui beni di un amico lo faccio togliere, pronto ad assumermi in prima persona gli obblighi verso i suoi creditori. Così per poter salvare un proscritto mi espongo io stesso al rischio di essere proscritto. Chi ha intenzione di acquistare una villa a Tuscolo o a Tivoli, per la salubrità dell’aria o per passarvi le vacanze estive, non sta a contare in quale anno l’acquisterà, aspetterà il momento in cui cogliere l’occasione.5 Lo stesso vale per il beneficio. E se mi chiederai cosa mi frutti risponderò: «La consapevolezza di aver fatto del bene». Che frutti può portare un beneficio? Dimmi tu che frutti portano la giustizia, l’innocenza, la magnanimità, la pudicizia, la temperanza: se cerchi qualcosa al di là di esse non cerchi queste virtù per sé stesse. A quale scopo il cielo compie le sue rivoluzioni, o il sole allunga o accorcia la durata del giorno? Questi fenomeni sono dei benefìci, perché accadono per nostra utilità. Come il compito del cielo è far susseguire i fenomeni secondo il loro ordine naturale e quello del sole è cambiare il punto in cui sorge e in cui tramonta e compiere senza ricompensa alcuna tutti quei movimenti da cui noi traiamo giovamento, così il compito dell’uomo è, fra gli altri, quello di beneficare. Dunque, perché egli lo fa? Per non mancare al dovere di farlo e per non perdere l’occasione di fare del bene. 13. Per voi epicurei il piacere consiste nell’infiacchire il vostro corpiciattolo nell’ozio, nell’aspirare a una tranquillità molto simile al sonno, nel nascondervi sotto una fitta ombra, dilettare con meditazioni raffinate – che voi chiamate tranquillità – il torpore del vostro animo illanguidito e rimpinzare di
cibi e di bevande, nei vostri giardini appartati, i corpi impalliditi dall’inattività. Per noi, invece, il piacere consiste nel concedere benefìci, anche se ci costano fatica, purché allevino le pene degli altri, anche se sono pericolosi, purché liberino dai pericoli gli altri, anche se graveranno sul nostro bilancio, purché allevino i bisogni e le ristrettezze altrui. Che mi importa se riceverò un contraccambio per i miei benefìci? E quando lo avrò ricevuto dovrò donarlo di nuovo. Un beneficio guarda all’utile di colui al quale è destinato, non al nostro, altrimenti è come se lo facessimo a noi stessi. Per questo molte azioni, che arrecano grandissimi vantaggi agli altri, se sono pagate perdono il diritto alla gratitudine. Il commerciante è utile alle città, il medico agli ammalati, il mercante di schiavi a coloro che mette in vendita; ma tutti costoro, in quanto arrecano vantaggi agli altri ma muovendo dal proprio interesse, non obbligano alla riconoscenza coloro ai quali giovano. Non è un beneficio quello che viene dato con la prospettiva di un guadagno. Se dici: «Darò questo per riceve quello» il beneficio non c’è più. 14. Non chiamerò pudica quella donna che ha respinto un innamorato per eccitarlo maggiormente, o quella che ha avuto paura della legge o del marito: come dice Ovidio, colei che non si è data perché non ha potuto, di fatto si è data.6 Giustamente viene annoverata fra le peccatrici la donna che si è mantenuta casta per paura, non di per sé stessa. Analogamente chi ha fatto del bene per ricevere il contraccambio non ha fatto del bene. Facciamo del bene agli animali che nutriamo per servircene o per mangiarceli? Facciamo del bene agli alberi che coltiviamo perché non soffrano a causa della siccità o per la durezza di un suolo non smosso e trascurato? Non si coltivano i campi per spirito di giustizia e di bontà, né si compie un’azione che non abbia in sé stessa la sua ricompensa; a fare il bene ci spinge non un gretto calcolo o l’avarizia, ma un senso di umanità, di generosità, un desiderio di dare anche dopo avere già dato e di accrescere con nuovi doni, magari appena ricevuti, quelli precedenti, badando a una sola cosa: il bene che ne verrà alla persona a cui si dona; diversamente fare del bene solo per convenienza è cosa meschina, che non merita né lode né gloria. Cosa c’è di nobile nell’amare sé stessi, nel risparmiare per proprio tornaconto, nell’acquistare per sé? Il desiderio autentico di fare il bene distoglie da tutte queste cose e ci prende al punto da indurci ad agire persino a nostro svantaggio, facendoci mettere da parte la ricerca di un utile per noi, paghi solo di fare del bene. 15. Si può forse dubitare che l’offesa sia il contrario del beneficio? Mentre offendere è di per sé cosa da evitare e da cui rifuggire, fare il bene è cosa da ricercare di per sé. Nel primo caso a spingerci è la bassezza morale, più forte di
tutti gli allettamenti che invitano al delitto, nel secondo è il fascino del bene, che ci induce di per sé stesso a compiere l’azione. Sono sicuro di non sbagliare se dico che non c’è persona che non ami il bene compiuto, che abbia un animo tale da non provare piacere per colui al quale ha fatto molti benefìci e da non fare ancora una volta il bene dopo averlo già fatto. Ciò non accadrebbe se il concedere benefìci non fosse cosa piacevole per sé stessa. Quante volte si sente dire: «Non sono capace di abbandonare colui al quale ho salvato la vita, che ho strappato a un pericolo. Mi prega d’intervenire a suo favore contro persone influenti, io non vorrei, ma che altro dovrei fare? L’ho già aiutato in diverse occasioni». Non è evidente che in queste azioni c’è una forza che ci costringe a fare del bene, la prima volta perché si deve, poi perché l’abbiamo già fatto? Anche a chi inizialmente non avremmo avuto motivo di dare in seguito continuiamo a dare proprio perché abbiamo già dato, quindi non è il nostro interesse a spingerci a fare il bene, anzi, così continuiamo ad alimentare e ad accrescere benefìci inutili, unicamente per amore del bene, donando anche a coloro che non ci hanno dimostrato gratitudine ma che ci viene spontaneo perdonare, come si perdonano i figli cattivi. 16. Gli stessi filosofi epicurei confessano di dimostrare la loro riconoscenza non perché sia bene, ma perché è utile. Dimostrare quanto ciò sia falso ci torna ancora più facile, perché lo provano le argomentazioni con cui abbiamo spiegato che fare il bene è cosa desiderabile di per sé. Il punto di partenza dei nostri ragionamenti che riguardano altre questioni è che il bene viene praticato solo in quanto è bene. Chi dunque oserà dubitare che la riconoscenza sia un bene? Chi potrebbe non detestare l’ingrato, uomo dannoso perfino a sé stesso? E quando ti si dice che uno «si dimostra ingrato di fronte ai più grandi benefìci del suo amico», cosa ne pensi? Che abbia commesso un’azione vergognosa o che abbia trascurato di compiere un’azione che gli avrebbe arrecato utilità e giovamento? Suppongo che tu lo giudichi un uomo malvagio che merita di essere punito non di avere un difensore, il che non accadrebbe se l’essere riconoscenti non fosse una cosa buona e desiderabile di per sé. Altre doti sono forse meno splendide e appariscenti e necessitano di essere interpretate perché si possa stabilire se sono buone o no, mentre la gratitudine è manifesta ed è troppo bella perché la sua luce non risplenda certa e cospicua. Non c’è cosa così lodevole e così unanimemente accolta nei nostri cuori quanto la riconoscenza verso chi ci ha fatto del bene. 17. E cos’è che ci spinge a dimostrarci riconoscenti? L’interesse? Ma chi non lo disprezza è un ingrato. L’ambizione? Ma come si può vantarsi di aver pagato ciò che si doveva? La paura? L’ingrato non ne ha, visto che solo per questa colpa non abbiamo stabilito alcuna legge, quasi che in ciò la natura avesse voluto premunirsi. Come nessuna legge impone di amare i genitori o di trattare con benevolenza i figli (poiché è inutile essere spinti là dove siamo diretti per natura), come nessuno ha bisogno di essere sollecitato all’amore di sé stesso, che
prova fin dall’istante in cui nasce, così non c’è bisogno di essere spronati a ricercare il bene per sé stesso, il quale riesce gradito per la sua stessa natura, e la virtù è talmente affascinante che anche i malvagi approvano istintivamente ciò che è meglio sul piano morale. Chi non vorrebbe apparire benefico, chi persino in mezzo a delitti e violenze non pretenderebbe di passare per buono, chi non vorrebbe dare anche alle sue azioni più sfrontate un’apparenza di onestà e passare per benefattore di coloro ai quali invece ha fatto del male? Così costoro sopportano di essere ringraziati da quelli che hanno rovinato e si fingono buoni e generosi, visto che non possono esserlo davvero, perché l’amore di ciò che è bene e desiderabile di per sé li costringe a farsi una fama contraria alle loro abitudini e a nascondere la propria malvagità, di cui desiderano ardentemente i vantaggi, mentre ne provano odio e vergogna. Non c’è insomma individuo che rinunci alla sua natura di uomo al punto da fare il male per il piacere di farlo. Chiedi infatti a chi vive di rapina se non preferirebbe ottenere con mezzi onesti ciò che si procura col furto e col brigantaggio, e vedrai che chi si guadagna da vivere assalendo e derubando i passanti preferirà trovare piuttosto che rapire; non troverai persona che non preferisca godere dei vantaggi della disonestà conseguendoli onestamente. Questo è il più grande beneficio che dobbiamo alla natura, il fatto, cioè, che la virtù diffonde la sua luce nell’animo di tutti, una luce che anche i non virtuosi riescono a vedere. 18. Affinché tu ti convinca che il sentimento della gratitudine è desiderabile considera che l’essere ingrati è cosa da evitarsi di per sé, in quanto non c’è cosa che divida e distrugga la concordia fra gli uomini come questo vizio. Per quale motivo, infatti, ci sentiamo al sicuro se non perché troviamo un aiuto nello scambio di doveri? Solo per questo, per la reciprocità dei benefìci, la vita è difesa contro gli assalti imprevisti. Presi singolarmente che cosa siamo? Prede e vittime degli animali, sangue piacevolissimo e facilissimo da ottenere; gli altri animali, infatti, hanno forze sufficienti per difendersi, e quelli che conducono una vita errabonda o solitaria sono armati, mentre l’uomo ha come difesa una debole pelle che lo ricopre, né la forza delle unghie o dei denti lo rende temibile agli altri esseri: nudo e fragile com’è, trova la sua difesa solo nella vita associata, in virtù della quale, lui che sarebbe stato inferiore a tutte le altre creature se fosse rimasto isolato, è invece il padrone del mondo. La vita associata gli ha dato la sovranità su tutti gli altri esseri viventi, ha consentito a lui, nato per vivere sulla terraferma, di estendere il suo dominio su elementi estranei e dominare il mare, lo protegge contro la violenza delle malattie, gli procura sostegni per la vecchiaia, sollievi contro il dolore: la vita associata, insomma, ci rende forti, perché possiamo invocarla contro le avversità della fortuna. Se la elimini distruggi l’unità del genere umano, che è il sostegno della vita stessa: dimostrami che l’ingratitudine è da evitare non di per sé ma perché ha qualcosa da temere (quanti sono infatti coloro che possono essere ingrati senza alcun rischio!) e la vita associata scomparirà. Concludendo, per me è ingrato anche chi si mostra
riconoscente per paura. 19. Un uomo che ha senno non teme gli dèi: è follia, infatti, temere le cose che ci fanno del bene, e nessuno ama coloro che teme. Tu poi, Epicuro, togli a dio tutte le armi, tutta la potenza, e affinché non faccia paura lo releghi al di fuori delle cose che incutono timore. Circondato da un muro immenso e impenetrabile e fuori dal contatto e dalla vista dei mortali non spaventa nessuno, non ha la possibilità né di giovare né di nuocere; nello spazio che si estende fra questo cielo e l’altro, tutto solo, senza esseri animati e inanimati, senza uomini, sfugge al crollo dei mondi che gli rovinano sopra e intorno, non ascolta le nostre preghiere e non si cura di noi. Tuttavia vuoi passare per uno che l’onora come un padre, immagino per riconoscenza, o, se disdegni questo sentimento, perché i benefìci che ricevi ti vengono non da lui, ma dagli atomi e da queste tue minute particelle che, mescolandosi fra loro, ti hanno creato per caso. Ma allora perché l’onori?7 «Per la sua straordinaria maestà», mi rispondi, «e per la sua natura eccezionale». Sia pure, ma allora lo fai non perché te l’imponga la speranza di un qualche guadagno o di altro, quindi c’è qualcosa che è desiderabile di per sé, il cui valore stesso ti attira, e questo è il bene. Ora, cosa c’è che sia più conforme al bene se non la riconoscenza? Questa virtù, per esercitarsi, ha un campo tanto vasto quanto la vita. 20. Si obietterà: «Ma anche in questa virtù c’è qualcosa di utile». E in quale virtù non c’è? Però si dice che una cosa è desiderabile di per sé quando, pur offrendo dei vantaggi esterni, accantonati o eliminati questi, continua a piacere. Dimostrarsi riconoscenti giova, ma io resterò tale anche se ciò mi nuoce. A che si mira mostrandosi riconoscenti? A procurarsi altri amici e altri benefìci? E chi ne ricava dei danni e si accorge che con la sua riconoscenza non otterrà più nulla, anzi perderà molte delle cose già ottenute e messe in serbo, andrà volentieri incontro a quei danni? Ingrato è anche chi, pur manifestando la sua riconoscenza, mira già a un altro dono e chi vi spera nel contraccambiare. Ingrato è anche chi assiste un ammalato solo perché si accinge a fare testamento, chi pensa ai lasciti e all’eredità: anche se si comporta come un amico buono e memore dei favori ricevuti, se nella sua mente c’è sempre l’immagine del guadagno è un pescatore che ha gettato l’amo: come gli uccelli che si nutrono di carogne sorvegliano la pecora che già sfinita dalla malattia sta per morire, così quest’uomo ha lo sguardo fisso alla morte e vola attorno a un cadavere. 21. Un animo riconoscente è tutto preso dal valore in sé del suo proposito. Vuoi la prova che non si lascia corrompere dall’interesse e che le cose stanno proprio così? Ci sono due tipi di riconoscenza: quella di chi rende qualcosa per ricambiare ciò che ha ricevuto, forse per vantarsi, perché ha qualcosa di cui andare fiero e da mettere in mostra, e chi accetta un beneficio con buona disposizione d’animo e col medesimo atteggiamento si sente in debito: in questo
caso la riconoscenza è celata nell’intimo della coscienza. Che utilità può venirgli da un sentimento che rimane nascosto? Eppure, anche se non può esternarlo, egli è pur sempre riconoscente: ama, si sente in debito, desidera dimostrare concretamente la sua riconoscenza; se pur manca qualcosa di ciò che desidera, non manca l’intenzione. Artista è anche colui che non dispone degli strumenti per esercitare la sua arte, e non è un cantante meno bravo colui del quale non riusciamo a sentire la voce per lo strepito della folla. Voglio dimostrare la mia riconoscenza: oltre a ciò, mi resta da fare qualcosa non per essere riconoscente, ma per potermi considerare sciolto dall’obbligo; spesso, infatti, anche chi ha manifestato la propria riconoscenza può essere un ingrato, mentre è riconoscente pure chi non l’ha manifestata. Infatti, come la valutazione di tutte le altre virtù anche questa è esclusivamente interiore: se la disposizione d’animo è quella che deve essere, tutto ciò che manca è imputabile alla sorte. Come può essere un valido oratore anche chi non parla e un uomo forte anche chi sta senza far nulla o con le mani legate, come un timoniere rimane tale anche sulla terraferma, perché alla sua scienza perfetta non manca nulla anche se non la esercita, così è riconoscente anche chi ha solo la volontà di esserlo e di questa sua volontà non ha nessun altro testimone che sé stesso. Anzi, aggiungo: a volte è riconoscente pure chi sembra ingrato solo perché l’opinione pubblica, interprete non sempre benevola dei fatti, lo ha giudicato in modo contrario al vero. Cos’altro segue quest’uomo se non la propria coscienza? La quale, pur se nascosta, ci dà gioia, si oppone al giudizio della massa e all’opinione comune e ripone tutto in sé stessa, e quando ha davanti la folla di coloro che sono di parere contrario, non ne conta i voti, ma vince con uno solo. Se poi vede che agli onesti sono inflitte le pene riservate ai malvagi non scende dalla sua altezza e non cambia posizione neppure se punito, ma dice: «Io ho ciò che ho voluto e cercato. Non mi pento e non mi pentirò, e nessuna avversità della sorte mi indurrà a dire: “Cosa cercavo? A che mi giova la buona volontà?”». Giova, invece, anche sul cavalletto e tra le fiamme: e se questi strumenti di tortura vengono accostati alle mie membra sino a circondare tutto il corpo ancora in vita, e se il cuore stesso, consapevole di aver compiuto il proprio dovere, stilla sangue, amerò quel fuoco che farà risplendere l’onestà. 22. Chiediamoci ora – anche se l’argomento lo abbiamo già affrontato – perché mai quando stiamo per morire vogliamo essere riconoscenti, perché soppesiamo con cura i favori resi da ciascuno e ripercorriamo con la memoria tutta la nostra vita, sforzandoci di mostrare che non ci siamo dimenticati di nessun beneficio ricevuto? Ormai non ci resta più niente da sperare, eppure, arrivati a quel momento fatale, vogliamo andarcene dalla vita dimostrandoci quanto più possibile riconoscenti. È evidente che già nell’azione c’è la ricompensa, e l’enorme forza del bene attira gli animi, il suo splendore li circonda e l’ammirazione per quella luce e quel bagliore li seduce e li manda in estasi.
Obietterai: «Ma da ciò derivano molti vantaggi, e chi agisce più onestamente ha una vita più tranquilla, ha l’affetto e il plauso dei buoni, e un’esistenza improntata alla lealtà e alla gratitudine è più sicura». La natura sarebbe stata molto ingiusta se avesse reso misero, incerto e senza frutti un bene così grande. Ma il punto è se tu, che ti accosti spesso a questa virtù quando la via è facile e sicura, lo faresti anche lungo una strada infestata da serpenti, su pareti rocciose e precipizi. Una cosa non cessa di essere desiderabile di per sé anche se vi si unisce qualche vantaggio esteriore: quasi tutte le cose più belle sono accompagnate da molti vantaggi accessori, che sono conseguenti e perciò non hanno la precedenza sulle cose stesse. 23. Si può forse dubitare che il sole e la luna, coi loro movimenti periodici, svolgano un’azione regolatrice su questa dimora del genere umano? Che il calore del sole nutra i corpi, dilati le terre, riduca l’eccessiva umidità, spezzi il rigore dell’inverno che immobilizza ogni cosa, e il penetrante ed efficace tepore della luna porti a maturazione le messi? Si può dubitare che la fecondità dell’uomo sia in correlazione con le fasi lunari? Che il sole con la sua rivoluzione ci abbia consentito di calcolare l’anno e la luna il mese con le sue fasi, minori di quelle del sole? Ma, lasciando da parte queste cose, il sole stesso non sarebbe già uno spettacolo per i nostri occhi, degno di essere adorato anche se si limitasse ad attraversare il cielo? E la luna non sarebbe degna di ammirazione, anche se non facesse altro che percorrere il cielo come un astro inutile? E il cielo stesso quando di notte sparge i suoi fuochi e risplende di un’infinità di stelle, quale sguardo non tiene fisso su di sé? Chi, quando contempla queste cose, pensa alla loro utilità? Nota come questi corpi, che corrono in cielo così numerosi, nascondano la loro velocità sotto un’apparente immobilità. Quante cose avvengono durante la notte che noi consideriamo solo per distinguere e contare i giorni! Quale intreccio di destini deriva da quel corso sempre uguale! Questi astri, che si potrebbe credere siano stati sparsi nel cielo solo per ornamento, hanno ciascuno un proprio compito particolare. In realtà non c’è ragione per ritenere che siano solo sette quelli che si muovono e che gli altri stiano fermi;8 noi conosciamo i movimenti di pochi, ma innumerevoli dèi, sottratti alla nostra vista, vanno e vengono e fra quelli che sono accessibili al nostro sguardo la maggior parte si sposta con movimenti impercettibili nascondendo il proprio cammino. 24. E che, dunque? Non saresti affascinato da un così grande spettacolo se oltre a ciò non ti proteggesse, non ti custodisse, non contribuisse a generarti, a nutrirti e a darti l’aria in cui sei immerso? Come tutte queste cose, pur essendo assolutamente necessarie e indispensabili alla nostra vita, colpiscono con la loro maestà la nostra mente, così la gratitudine, fra tutte le altre virtù, procura senza dubbio numerosi vantaggi, ma non vuole essere amata per questo, poiché ha in sé
qualcosa che vale molto di più, e anche chi la considera utile non la comprende abbastanza. Chi si dimostra riconoscente solo perché gli conviene lo farà solo per quel tanto che gli serve. Ma la virtù non accetta un amante avaro: bisogna accostarsi a lei evitando che la toga formi delle tasche. L’ingrato, invece, pensa: «Volevo dimostrare la mia riconoscenza, ma mi trattiene la spesa, ho paura di rischiare, non vorrei offenderlo, farò come mi conviene». Non è possibile che uno stesso principio renda ingrati o riconoscenti a seconda dei casi: come il comportamento di chi è riconoscente è opposto a quello dell’ingrato, così sono opposte anche le intenzioni: l’uno è ingrato, benché ciò sia contrario al dovere, perché gli conviene, l’altro è riconoscente, pur se non gli conviene, perché ciò è conforme al dovere. 25. Il fine dell’uomo è vivere secondo natura e seguire l’esempio degli dèi. Ebbene, gli dèi, qualunque cosa facciano, seguono, necessariamente, la loro natura. A meno che tu non pensi che le loro azioni siano ricompensate dal fumo dei sacrifici e dal profumo dell’incenso. Guarda quante cose fanno ogni giorno, quante ne distribuiscono, con quanti frutti riempiono le terre, con quali venti propizi che spingono verso tutte le coste agitano i mari, con quante piogge improvvise ammorbidiscono il suolo e rinnovano le sorgenti inaridite rianimandole e alimentandole per vie misteriose. Tutte queste cose le fanno senza alcuna ricompensa, senza ricavarne alcuna utilità personale. Occorre dunque che anche la nostra ragione si conformi a questa regola, se non vogliamo discostarci dal modello, per non dover compiere le azioni virtuose come un mercenario. Vergogniamoci di stabilire un prezzo per ogni beneficio, visto che noi non paghiamo nulla per godere dei benefìci degli dèi. 26. Si dirà: «Se imiti gli dèi devi fare del bene anche agli ingrati: il sole, infatti, sorge pure per i malvagi e i mari sono aperti anche ai pirati». Dunque ci si chiede se un uomo virtuoso debba fare del bene a un ingrato, pur sapendolo tale. Facciamo prima una considerazione, per non incappare in una questione insidiosa. Secondo la dottrina stoica ci sono due tipi di ingratitudine: il primo è quello di chi è ingrato perché è stolto; ebbene, lo stolto è anche malvagio, ed essendo malvagio, ha in sé tutti i vizi senza alcuna eccezione, quindi è anche ingrato. Noi diciamo che tutti i malvagi sono sfrenati, avidi, dissoluti e cattivi non perché abbiano tutti questi vizi, numerosi ed evidenti, ma perché possono averli, e li hanno anche se non si vedono. Il secondo tipo di ingratitudine è quello comunemente attribuito a chi ha una tendenza naturale per questo vizio. All’ingrato del primo tipo, che non è esente da questa colpa così come da tutte le altre, l’uomo virtuoso farà del bene: se infatti respingesse uomini del genere non potrebbe fare del bene ad alcuno. All’ingrato del secondo tipo, che è un frodatore di benefìci e che per disposizione d’animo tende a un simile comportamento, non farà del bene più di quanto presterà denaro a uno scialacquatore o affiderà un deposito a uno che già molte volte ha negato di
averlo. 27. Noi chiamiamo uno pauroso perché è stolto: così è pure per i malvagi, che sono circondati da tutti i vizi senza eccezioni e senza distinzione alcuna. Chiamiamo pauroso chi per natura si spaventa anche per rumori inconsistenti. Lo stolto ha tutti i vizi, ma non è incline verso tutti per una disposizione d’ordine naturale: uno è portato all’avidità, un altro alla lussuria, un altro all’insolenza. Sbaglia, dunque, chi chiede agli stoici: «Ma come? Achille è pauroso? Ma come? Aristide, reso famoso dalla giustizia, è ingiusto? Ma come? Fabio, che temporeggiando salvò lo Stato9 è temerario? Ma come? Decio ha paura della morte? Muzio è un traditore? Camillo è un disertore?».10 Noi non diciamo che tutti i vizi sono presenti in tutti con l’intensità di ciascun singolo vizio, ma che chi è malvagio e stolto non è privo di vizi, così come riteniamo che nemmeno l’audace sia esente dalla paura, né il prodigo dall’avarizia. Un uomo ha tutti i sensi ma non per questo tutti gli uomini hanno una vista simile a quella di Linceo11. Analogamente chi è stolto non ha però tutti i vizi in modo così intenso e violento come uno che abbia un vizio particolarmente evidente. Tutti i vizi sono insiti in ogni uomo, ma non tutti emergono in ciascun singolo uomo: c’è chi è spinto dalla sua natura all’avidità, chi è dedito al bere, chi alla libidine, o se non lo è ancora è conformato in modo tale che il suo carattere lo condurrà a esserlo. Quindi, per tornare all’argomento, tutti i malvagi sono anche ingrati, perché hanno in sé tutti i germi della malvagità, ma noi chiamiamo propriamente ingrato colui che tende in modo particolare verso il vizio dell’ingratitudine, ergo, a costui io non farò del bene. Agisce male con sua figlia quel padre che la dà in sposa a un uomo insolente e già respinto più volte, così come è un cattivo capofamiglia chi affida l’amministrazione dei propri beni a uno che è stato condannato per aver male amministrato il suo patrimonio. Analogamente è un pazzo chi nel suo testamento lascia come tutore per suo figlio uno che ha sperperato il denaro dei suoi pupilli, ed è il peggiore dei benefattori chi sceglie degli ingrati come destinatari di benefìci che andranno perduti. 28. «Anche gli dèi», si dice, «fanno molti benefìci agli ingrati». Ma gli dèi li hanno disposti per gli uomini buoni, tuttavia capitano pure ai malvagi, perché non è possibile dividerli nettamente dai buoni, e poi è meglio giovare anche ai malvagi a causa dei buoni che trascurare i buoni a causa dei malvagi. Perciò, i beni sopra ricordati, il giorno, il sole, l’avvicendarsi di inverno ed estate, le stagioni intermedie e più miti della primavera e dell’autunno, le piogge e le sorgenti da cui attingiamo l’acqua, i venti che soffiano in periodi determinati, gli dèi li hanno creati per tutti gli uomini in quanto non potevano essere distribuiti singolarmente, individuo per individuo. Il re accorda le onorificenze solo a coloro che ne sono degni, le elargizioni anche a coloro che non le meritano: ricevono il frumento della pubblica distribuzione tanto il ladro quanto lo spergiuro e l’adultero indipendentemente dalla moralità di ciascuno, basta essere
iscritti nelle liste dei cittadini; quando un dono è destinato agli uomini in quanto cittadini e non in quanto virtuosi, virtuosi e malvagi si trovano sullo stesso piano. Anche dio ha dato in dono delle cose a tutti gli uomini senza escluderne alcuno: il vento non può essere favorevole ai buoni e contrario ai malvagi, il mare aperto alle comunicazioni è utile a tutta la comunità, come è utile che il genere umano prolifichi e si accresca, né le piogge possono sottostare a delle leggi sì che non si riversino sui campi dei malvagi. Alcuni beni sono destinati a tutti: le città vengono fondate tanto per i buoni quanto per i cattivi; le opere degli uomini d’ingegno vengono pubblicate anche se finiranno in mano a uomini che non ne sono degni; la medicina offre le sue risorse anche agli scellerati, non si elimina la produzione di medicine salutari per non far guarire coloro che non lo meritano. Un giudizio e una valutazione morale delle persone si richiedono solo quando si tratta di doni destinati al singolo, quando li merita, non di benefìci elargiti indiscriminatamente a una folla. C’è una grande differenza fra lo scegliere e il non escludere. Si rende giustizia anche a un ladro, della pace usufruiscono pure gli omicidi, anche chi ha rubato i beni altrui ha il diritto di reclamare i propri, le mura difendono dai nemici anche gli assassini e coloro che usano in patria le armi, e sono protetti dalle leggi pure quelli che le hanno violate ripetutamente. Certi beni non potrebbero toccare ad alcuni se non fossero concessi a tutti, perciò non serve discutere su quelle cose che sono destinate a tutti. Ma se tocca a me decidere a chi concedere un beneficio certamente non lo dò a chi si è rivelato ingrato. 29. «Dunque se un ingrato deve prendere una decisione tu non gli darai un consiglio, non gli lascerai bere un sorso d’acqua né, se si è smarrito, gli indicherai la strada giusta? Oppure queste cose le farai, ma non gli elargirai alcun dono?». Farò una distinzione, o per lo meno cercherò di farla. Un beneficio è un’opera utile, ma non ogni opera utile è un beneficio; ci sono, infatti, alcune cose così insignificanti da non poter essere definite benefìci. Perché ci sia un beneficio devono verificarsi insieme due condizioni: la prima è l’importanza della cosa, poiché alcune sono troppo piccole per potersi chiamare benefìci. Nessuno definisce beneficio un pezzo di pane, una moneta di poco valore o il permesso di accendere il fuoco. È vero, queste cose a volte giovano più di quelle grandi, ma la loro scarsa entità ne diminuisce o ne elimina il valore, anche se sono rese necessarie dal bisogno del momento. Inoltre, condizione particolarmente importante, occorre anche agire nell’interesse del destinatario del beneficio, giudicarlo degno di riceverlo, concederlo volentieri e provando gioia nel donare. Nei casi sopra accennati non c’è niente di tutto ciò, perché doniamo alle persone non in quanto ne sono degne ma senza farci su alcun ragionamento, in quanto sono cose di poco conto, destinate non al singolo, ma all’umanità.
30. Tuttavia non posso negare che talvolta concederò qualche beneficio anche a chi non lo meriterebbe, e ciò per rendere omaggio ad altri: per esempio nella gara per le cariche pubbliche la nobiltà di nascita fa preferire uomini disonesti a uomini attivi ma senza antenati illustri, questo perché la memoria delle grandi virtù è sacra, e la virtù piacerà a un numero maggiore di persone se il credito di cui godono gli uomini virtuosi non scompare con loro. Per quale motivo il figlio di Cicerone ottenne il consolato se non per via di suo padre? E recentemente che cosa fece passare Cinna dal campo dei nemici al consolato – cosa che accadde anche per Sesto Pompeo e per gli altri Pompei – se non la grandezza di un solo uomo che fu tale da tenere in alto i suoi discendenti anche dopo il proprio crollo? E cosa fece diventare sacerdote – e in più collegi – quel Fabio Persico il cui bacio, anche se indossava la veste talare, era un marchio d’infamia per tutti, se non il Verrucoso, l’Allobrogico e quei famosi trecento che da soli fermarono l’invasione dei nemici, sacrificando tutta la loro famiglia in difesa dello Stato?12 Questo è l’omaggio che dobbiamo agli uomini virtuosi: onorarli non solo finché sono davanti ai nostri occhi, ma anche quando non ci saranno più; come essi non solo giovarono alla loro età ma lasciarono i propri benefìci anche a quelle successive, così noi non dobbiamo limitare la nostra riconoscenza a una sola vita. Costui ha generato dei grandi uomini: è degno dei nostri benefìci, qualunque sia il suo valore, perché ci ha dato dei figli che ne sono degni. Quest’altro discende da antenati illustri: qualunque sia il suo valore, sia coperto dall’ombra dei suoi. Come i luoghi oscuri sono rischiarati dal riflesso del sole, così coloro che non hanno fatto nulla risplendono della luce dei loro antenati. 31. A questo punto, mio Liberale, voglio difendere gli dèi. Talvolta, infatti, ci accade di dire, per esempio: «Che cosa si è prefissa la provvidenza affidando il regno ad Arridèo?». Pensi che sia stato affidato a lui? Fu affidato a suo padre e a suo fratello. «Perché ha messo a capo del mondo Gaio Cesare, uomo avidissimo di sangue umano, che faceva scorrere davanti ai suoi occhi come se volesse berlo?». E che? Pensi che quel potere sia stato dato a lui? Fu dato a suo padre Germanico, a suo nonno, al suo bisavolo13 e prima che a loro ad altri uomini non meno illustri, anche se condussero una vita da privati cittadini uguale a quella degli altri. Ma come? Quando proprio tu nominavi console Mamerco Scauro14 non sapevi che beveva a bocca aperta il flusso mestruale delle sue schiave? Non lo diceva forse egli stesso? Voleva passare per un uomo casto e puro! Ti riferirò una sua battuta su sé stesso, che mi ricordo circolava e veniva citata anche in sua presenza. Ad Asinio Pollione, che era sdraiato, aveva detto, usando una parola oscena, che gli avrebbe fatto ciò che voleva si facesse a lui, e avendo visto che Pollione aggrottava la fronte, aggiunse: «Tutto ciò che ho detto di male ricada su di me e sulla mia testa». Lui stesso riportava le parole che aveva pronunciato. E tu hai ammesso ai fasci e all’amministrazione della giustizia un uomo così notoriamente lascivo? Evidentemente perché, pensando a
quel vecchio Scauro che presiedette il Senato, mal sopporti che i suoi discendenti restino oscuri. 32. È verisimile che gli dei trattino con maggiore indulgenza alcuni per via dei loro genitori e dei loro avi, altri per le qualità che avranno i nipoti, i pronipoti e i discendenti in un lontano futuro, perché gli dèi conoscono perfettamente l’evolversi della loro creazione e ogni cosa che passa per le loro mani gli è sempre chiara e manifesta, mentre noi procediamo dal buio alla luce, e quegli eventi che consideriamo imprevisti sono invece previsti e familiari per gli dèi. È come se dio dicesse: «Costoro siano re, perché i loro antenati non lo furono, perché nella loro somma autorità furono giusti e onesti e più che ai propri interessi badarono a quelli dello Stato, a cui diedero tutti sé stessi. Questi regnino perché prima di essi un loro bisavolo s’innalzò al di sopra della fortuna, perché nelle lotte civili piuttosto che vincere preferì essere vinto per il bene dello Stato. A costui per tanto tempo non ho dimostrato la mia riconoscenza: ebbene, in virtù del suo bisavolo diventi capo del popolo, non perché sia preparato e capace ma perché un altro lo ha meritato per lui. Questo qui ha il corpo deforme, è brutto di aspetto e le sue insegne saranno derise.15 Gli uomini mi accuseranno, mi chiameranno cieco e temerario, diranno che io non pongo al posto giusto i riconoscimenti dovuti agli uomini superiori che si distinguono dagli altri; ma io so che dando a uno pago un vecchio debito a un altro. Come possono costoro che mi criticano conoscere quell’uomo che un tempo sfuggiva con ostinazione a una gloria che lo seguiva, che affrontava il pericolo con l’atteggiamento che gli altri hanno dopo averlo scampato, che non ha mai separato il suo interesse da quello dello Stato? Mi chiedi: “Ma dove è quest’uomo? Chi è?”. Come potreste conoscere queste cose? Sono io che controllo le uscite e le entrate, io so quel che devo a ciascuno: alcuni li rimborso dopo molto tempo, altri in anticipo in base alle occasioni e alle risorse del mio Stato». Anch’io dunque ogni tanto potrò dare all’ingrato qualcosa, ma non per merito suo. 33. «Ma se non sai se hai a che fare con un ingrato o con uno che ti sarà riconoscente aspetterai di saperlo o lo farai perché l’occasione ti offre di fare del bene? Aspettare, infatti, sarebbe lungo (come dice Platone è difficile fare ipotesi sull’animo dell’uomo), ma non aspettare sarebbe azzardato». A questa obiezione rispondo che noi non ci aspettiamo mai una certezza assoluta, essendo difficile trovare la verità, ma seguiamo la via lungo la quale ci conduce la verisimiglianza, e per questa strada procediamo in ogni nostra attività: è così che seminiamo, che navighiamo, che facciamo spedizioni militari, che prendiamo moglie, che alleviamo figli. Pur essendo incerto l’esito di tutte le nostre attività, intraprendiamo quella strada che riteniamo ci offra buoni motivi di speranza. Chi infatti può garantire il raccolto a chi semina, il porto a chi naviga, la vittoria a chi combatte, l’onestà della moglie al marito, l’affetto dei figli al padre?
Andiamo dove ci conduce la ragione, non la verità. Non si può aspettare e fare solo ciò che avrà successo, non muoversi se non dopo aver conosciuto la verità, perché non compiendo più alcuna azione la vita si fermerebbe. Dunque, poiché è la verosimiglianza, non la verità, che mi spinge ad agire, farò del bene a chi “verosimilmente” me ne sarà grato. 34. Si obietterà: «Potrebbe anche capitare che un malvagio s’intrufoli furtivamente come un uomo virtuoso e che un uomo virtuoso ci sia sgradito come un malvagio, poiché le apparenze ci hanno ingannato». E chi lo nega? Ma io non trovo nessun’altra regola su cui basarmi, devo cercare la verità seguendo quel criterio, poiché non ne ho un altro più sicuro; farò un esame più rigoroso, mi sforzerò in tutti i modi per non convincermi troppo facilmente: anche in guerra può accadere che per sbaglio io tiri una freccia contro un mio commilitone, risparmiando così un nemico come se fosse uno dei miei. Ma ciò accade raramente e non per colpa: io volevo colpire il nemico e difendere il mio concittadino. Se saprò che uno è un ingrato non gli farò del bene. Ma quello si è intrufolato furtivamente, mi ha ingannato: il donatore non ha alcuna colpa, perché ha fatto il bene come se avesse avuto a che fare con un uomo riconoscente. Mi domandi: «Se prometti di concedere un beneficio e poi vieni a sapere che il destinatario è un ingrato, lo concederai ugualmente? Se lo fai, essendone consapevole, pecchi, perché lo dài a uno che non lo merita, se lo rifiuti pecchi lo stesso, perché non lo dài a uno a cui l’hai già promesso. E qui vacilla la vostra coscienza, che vi fa orgogliosamente dire che il saggio non si pente mai delle sue azioni, non corregge mai ciò che ha fatto e non cambia le sue decisioni». Il saggio non cambia le sue decisioni se restano immutate le circostanze che le hanno provocate. Perciò egli non si pente mai, perché in quelle determinate circostanze non era possibile fare niente di meglio di quel che si è fatto, non si poteva decidere niente di meglio di quel che si è deciso, e d’altra parte il saggio si accinge a compiere ogni cosa con questa riserva: «se non sopraggiungerà qualche impedimento». Ecco perché noi diciamo che al saggio ogni cosa riesce e non gli capita nulla di inatteso in quanto tiene sempre presente l’eventualità di qualche imprevisto che gl’impedisca di attuare i suoi propositi. Solo gli imprudenti confidano che la fortuna favorisca i loro progetti, mentre il saggio pensa a entrambe le possibilità: sa quanto sia grande quella di sbagliare, quanto siano incerte le cose umane, quanti eventi ostacolino le nostre decisioni, segue con l’animo sospeso l’ambiguità e la mutevolezza della sorte e in tutto ciò che decide mette sempre una riserva a causa dell’incertezza degli eventi, e anche in questo caso tale riserva, senza la quale egli non decide e non fa nulla, lo protegge. 35. Ho promesso a uno un beneficio a condizione che non intervenisse un qualche ostacolo che me lo impedisse. Ebbene, che succederà se la patria dovesse ordinarmi di dare a lei ciò che avevo promesso a quell’uomo o se
interverrà una legge che proibisce a tutti di fare ciò che io avevo promesso all’amico? Ti avevo promesso di darti in moglie mia figlia, ma poi si è scoperto che sei uno straniero e poiché non mi è concesso imparentarmi con uno straniero questo divieto giustifica il mio rifiuto. Mancherò alla parola data, sarò accusato di volubilità solo se, restando immutate tutte le circostanze che c’erano quando ho fatto la promessa, non la manterrò, diversamente qualunque cambiamento mi autorizza a prendere una nuova decisione e mi libera dall’impegno preso. Ho promesso di difenderti in un processo, poi però si è scoperto che attraverso quel processo si cercava di colpire mio padre; ho promesso che avrei fatto un viaggio all’estero ma poi ho saputo che la strada era infestata dai banditi; ho promesso che sarei venuto, ma la malattia di mio figlio o il parto di mia moglie mi hanno trattenuto. Affinché io mantenga la mia promessa bisogna che tutte le circostanze restino quali erano nel momento in cui ho dato la mia parola, e non c’è cambiamento maggiore della scoperta di avere a che fare con un uomo ingrato e malvagio. Ergo, ciò che io ti avrei dato perché ti consideravo degno, se ne sei indegno te lo rifiuterò, e avrò anche motivo di prendermela con te perché mi hai ingannato. 36. Va esaminato anche il valore del dono promesso, il quale ci suggerirà la decisione da prendere. Se è una cosa di poco conto te la darò, non perché tu ne sia degno, ma perché te l’ho promessa, e non te la darò come un dono, ma solo per liberarmi, tirandomi le orecchie, dall’impegno che ho preso. Con questa perdita punirò l’avventatezza che ho avuto nel promettere, dicendo a me stesso: «Ben ti sta! Così impari a parlare meno e a riflettere di più!». Pagherò la multa sulle chiacchiere, come si dice. Se invece l’oggetto del mio dono sarà di maggior valore, cercherò di evitare che la punizione, per dirla con Mecenate, mi costi dieci milioni di sesterzi. Confronterò cioè le due conseguenze possibili: da una parte è importante mantenere la promessa, dall’altra non concedere un beneficio che sia di danno a sé stessi. Ebbene, che valore ha questo beneficio? Se ne ha poco passiamoci sopra, se invece dovesse essere per me motivo di grande danno o di vergogna preferisco scusarmi una volta per aver rifiutato piuttosto che continuamente per aver dato. Insomma, ripeto, tutto sta nello stabilire il valore della mia promessa. Non solo mi terrò ciò che ho promesso avventatamente, ma chiederò indietro ciò che ho dato ingiustamente: è stolto chi tiene fede a una promessa sbagliata. 37. Filippo, re di Macedonia, aveva un soldato valoroso. Avendo sperimentato in molte spedizioni la sua abilità, gli aveva dato alcune cose del bottino di guerra per premiare il suo valore, accendendo così con continue ricompense quell’animo venale. Ebbene, questo soldato, avendo fatto naufragio, sbarcò sulle terre di un macedone, il quale, come ne fu informato, accorse, lo rianimò, lo curò a sue spese per trenta giorni, lo rimise in sesto e gli diede le provviste per il viaggio, mentre quello andava ripetendogli: «Ti dimostrerò la
mia riconoscenza, se avrò la fortuna di rivedere il mio generale». Dopodiché narrò a Filippo il suo naufragio, ma senza dire nulla dell’aiuto che aveva ricevuto, e gli chiese subito di dargli i poderi di un tale. Sennonché costui era proprio quello che lo aveva ospitato, accolto in casa sua e guarito. Ora, i re, specialmente in guerra, donano spesso a occhi chiusi. Filippo, dato al soldato ciò che chiedeva, disse a sé stesso: «Un uomo giusto non riesce a resistere a tanti desideri dei suoi soldati, non ci si può comportare contemporaneamente da uomo virtuoso e da buon generale. Come fare a saziare tante migliaia di uomini insaziabili? Cosa avranno alla fine se ciascuno manterrà quello che ha?». Il padrone di quei poderi, espropriato dei suoi beni, non sopportò in silenzio, come un contadino silenzioso e contento di non essere stato egli stesso parte del dono, ma scrisse una lettera schietta e concisa a Filippo. Il quale, dopo averla letta, si adirò a tal punto che incaricò subito Pausania di restituire i beni al loro precedente proprietario e di bollare col marchio dell’ingratitudine colui ch’era stato il più vile dei soldati e il più avido dei naufraghi. In verità egli meritava che quelle lettere invece che scritte gli fossero scolpite nella carne, poiché aveva scacciato dalla sua terra colui che lo aveva ospitato, lo aveva depredato e reso simile a un naufrago su quella spiaggia dove egli stesso era naufragato. Ma vedremo dopo in che modo sia stato punito: bisognava comunque toglierlo di mezzo perché aveva usurpato un bene col peggiore dei delitti. Chi si sarebbe potuto commuovere per la sua punizione? Nessun uomo pietoso avrebbe potuto provare compassione per un tale misfatto. 38. Dunque Filippo darà perché ha promesso, anche se non deve, anche se commetterà un’ingiustizia, un delitto, anche se con questo suo gesto precluderà ai naufraghi ogni spiaggia? Allontanarsi da un errore che si è riconosciuto e condannato non è leggerezza, anzi bisogna confessare con sincerità: «Pensavo che le cose stessero diversamente, mi sono ingannato». È invece segno di molto orgoglio perseverare: «Ciò che ho detto una volta, di qualunque cosa si tratti, è stabilito definitivamente». Non è vergognoso cambiare idea quando cambiano le circostanze. Se Filippo avesse lasciato a quel soldato le terre di cui si era impadronito in seguito al naufragio, tutti gli sventurati non avrebbero più avuto acqua per dissetarsi e fuoco per scaldarsi. «Porta in giro queste lettere impresse sulla tua faccia svergognata, fuori dai confini del mio regno fino alla costa: che si fissino bene negli occhi di tutti. Va’ e mostra quanto sia sacra la mensa di chi ci offre ospitalità; fa’ leggere sulla tua faccia questo decreto, il quale serve a evitare che l’offrire ospitalità agli sventurati sia un delitto capitale. Questa disposizione avrà maggiore garanzia che se l’avessi fatta incidere sul bronzo». 39. Si obietterà: «Perché dunque il vostro Zenone, che aveva promesso a uno un prestito di cinquecento danari, avendo scoperto che era una persona poco affidabile, benché gli amici gli consigliassero di non concederglielo, si ostinò a darglielo in quanto glielo aveva promesso?». Innanzitutto altro è il prestito, altro
il beneficio. Il denaro, anche se è stato prestato ingiustamente, è possibile riprenderlo con un’ingiunzione di pagamento, e nel caso in cui il donatario dovesse fallire si può recuperare almeno una parte del credito, mentre il beneficio va perduto tutto e subito. Nel primo caso il destinatario è un cattivo capofamiglia, nel secondo un malvagio. E poi se la somma fosse stata maggiore neppure Zenone avrebbe insistito nel prestarla: cinquecento denari è quanto si spende per curare una malattia, quindi mantenere la promessa non era poi una cosa sconveniente. Andrò a un banchetto, poiché l’ho promesso, anche se farà freddo, ma se nevica non ci andrò. Mi alzerò da tavola, anche se non ho ancora finito, per andare a un matrimonio, perché l’ho promesso, ma se avrò la febbre non ci andrò. Scenderò al Foro per farti da garante poiché l’ho promesso, ma se pretenderai che io mi impegni per una somma non precisata o nei confronti del fisco, non verrò. In questi casi, ripeto è sottintesa una tacita riserva: se potrò farlo, se dovrò, se le circostanze resteranno invariate. Fa’ sì che la situazione nel momento in cui mi chiedi di mantenere la promessa sia la stessa di quando l’ho fatta: in tal caso mancare alla parola data sarebbe un atto di leggerezza. Se invece sopraggiunge qualche novità, perché ti meravigli che essendo mutata la condizione di chi aveva promesso sia cambiata anche la sua decisione? Fa’ sì che tutto resti immutato e anch’io non cambierò idea. Abbiamo promesso di comparire in giudizio, d’accordo, ma non si può far causa a tutti perché non si sono presentati: una forza maggiore li giustifica. 40. La stessa risposta vale per quest’altra questione, se si debba manifestare la propria riconoscenza in qualunque circostanza e se il beneficio vada ricambiato in ogni caso. Io ho il dovere di mostrare la mia riconoscenza, tuttavia o la mia condizione infelice, o la felice condizione del donatore non mi permette di manifestarla. Cosa darò a un re come contraccambio? Se sono povero cosa darò a un ricco, tanto più quando alcuni considerano un’offesa la restituzione di un beneficio e aggiungono subito altri benefìci? Cosa posso fare di più se non voler ricambiare? Peraltro non sono obbligato a rifiutare un nuovo beneficio perché non ho ricambiato il precedente. Lo accetterò con la stessa buona disposizione d’animo con cui mi verrà dato e mi metterò nelle mani del donatore affinché per mio mezzo continui a esercitare la sua bontà. Chi non vuole accettare nuovi doni evidentemente si è offeso per quelli che ha ricevuto. Che importa poi se non ricambio? Se il ritardo non dipende da me, se mancano i mezzi o l’occasione? Se uno mi ha fatto del bene è segno che ne aveva i mezzi e l’occasione: è un uomo buono o malvagio? Se è buono, vinco la causa, se è malvagio, non mi dò nemmeno da fare. E non penso neppure che sia un dovere dare il contraccambio a chi non lo vuole, né insistere con coloro che lo rifiutano: non è un ricambiare il restituire a chi non vuole ciò che hai ricevuto con piacere. Alcuni, ricevuto un piccolo dono, ne mandano subito un altro come contraccambio: un gesto inopportuno con cui praticamente dichiarano di non
avere più alcun debito. Anche questo è un modo di rifiutare un dono inviandone immediatamente un altro, un annullarne uno con un altro. Talvolta non ricambierò un beneficio, pur avendone la possibilità. Quando? Nel caso in cui dovessi togliere a me più di quanto darò al donatore, quando costui nel ricevere ciò che a me costa molto dare, non ne trarrà alcun guadagno. Chi si affretta a ricambiare a ogni costo ha l’animo di un debitore non quello di un uomo riconoscente. In poche parole: chi è troppo impaziente di estinguere il suo debito trova fastidioso sentirsi in debito; chi trova fastidioso sentirsi in debito è un ingrato.
1. Cfr. Cicerone, Lelio o della amicizia, 31. 2. Virgilio, Georgiche, II 156-160. 3. Virgilio, Bucoliche, I 6-10. 4. Qui Seneca ha una visione immanentistica di Dio, il quale, secondo la dottrina stoica, coincide totalmente con la sua opera. 5. È un paragone oscuro che ha portato a correggere il testo in diversi modi. 6. Ovidio, L’arte di amare, III 4, 4. 7. Cfr. Cicerone, Sulla natura degli dèi, I 101; 121. 8. Gli antichi credevano che esistessero delle stelle fisse, attaccate alla volta della sfera celeste, e sette stelle erranti: il sole, la luna e i pianeti Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. 9. Frammento di Ennio: il personaggio è Quinto Fabio Massimo, il Temporeggiatore. 10. Publio Decio Mure è il nome del padre e del figlio che sacrificarono la propria vita per la salvezza della patria. Muzio Scevola è l’eroe che punì sé stesso bruciandosi la mano per non essere riuscito a uccidere Porsenna. Marco Furio Camillo, politico e dittatore, combatté contro i Volsci, gli Etruschi e i Galli. 11. Linceo, figlio di Afareo, era famoso per la sua vista straordinaria che gli consentiva di vedere anche attraverso i corpi. 12. Per Fabio Persico, cfr. I benefìci, II 21. Verrucoso era il soprannome di Quinto Fabio Massimo il Temporeggiatore, Allobrogico era il soprannome di un altro Quinto Fabio Massimo che sottomise la popolazione celtica degli Allobrogi. Per i trecento Fabi che nel 477 a.C. si sacrificarono in difesa di Roma nella battaglia del Cremera contro gli Etruschi, cfr. Tito Livio, Storie, II 50. 13. Germanico era il padre di Caligola, Druso Germanico, fratello di Tiberio, il nonno, e Tiberio Claudio Nerone il bisavolo. 14. Mamerco Emilio Scauro, discendente da antenati illustri, fu console suffecto nel 21 d.C. 15. Seneca allude probabilmente a Claudio, che ebbe antenati illustri, fra cui Appio Claudio Cieco.
Libro quinto 1. Nei libri precedenti credevo di aver spiegato esaurientemente come si debba dare e come si debba ricevere un beneficio: questi, infatti, ne sono i confini. Ora se m’intrattengo ancora un po’ non è perché mi senta in debito verso questo argomento, che bisognerebbe seguire dove ci porta non dove c’invita, ma per un certo compiacimento: potrà infatti nascerne qualcosa di utile, più che necessario, che solleciti il mio animo con qualche attrattiva. Tuttavia, visto che vuoi così, dopo aver sviscerato i problemi di fondo, continuiamo a esplorare le questioni che sono legate al tema, ma che non ne costituiscono parte integrante; chi le esamina accuratamente non fa qualcosa di molto importante, ma non spreca neppure il suo tempo. A te, o Ebuzio Liberale, uomo eccellente per natura e incline ai benefìci, nessuna lode di essi appare sufficiente. Non ho mai visto un uomo tanto benevolo da dar valore anche ai servigi più banali; la tua bontà è arrivata al punto che tu pensi di fare a te stesso quel bene che non fai a un altro e affinché nessuno si penta del bene fatto sei pronto a pagare di tasca tua al posto degli ingrati. Sei così lontano da qualunque ostentazione, vuoi liberare così presto dal loro obbligo coloro ai quali concedi un beneficio che, qualunque cosa tu gli dia, vorresti che sembrasse non un dono ma una restituzione. Perciò quel che hai donato ti ritorna in misura maggiore, perché i benefìci seguono chi non ne reclama il contraccambio e come la gloria insegue più spesso chi ne rifugge, così ricavano un maggior frutto dai benefìci coloro con i quali si può anche essere ingrati. Tu non impedisci a chi ha già ricevuto dei benefìci di chiederne altri, non rifiuti di aggiungerne di nuovi ai precedenti, che nascondi e dissimuli, numerosi e più grandi: un uomo eccellente e di nobile animo mira a sopportare l’ingrato tanto a lungo da farlo diventare riconoscente. Questa regola non ti deluderà, poiché i vizi soccombono di fronte alle virtù, a patto che non ci si avvii a odiarli troppo presto. 2. Comunque a te piace sommamente, come un motto magnifico, quella famosa massima: «È vergognoso essere vinto nei benefìci». Non a torto ci si chiede se sia vero, e la realtà è di gran lunga diversa da come te la immagini: infatti, non è mai vergognoso essere vinti in una gara di buone azioni, purché tu non getti le armi e, benché vinto, voglia ancora vincere. Non tutti ai fini di un buon proposito utilizzano le stesse forze, gli stessi mezzi, la stessa fortuna (che limita il successo anche delle migliori intenzioni); è solo la volontà di tendere al bene che si deve lodare, anche se è stata superata da un altro più veloce: non è come nelle gare teatrali, in cui la palma della vittoria va al migliore, benché spesso anche in esse il caso faccia vincere il peggiore. Per quanto riguarda il
dovere, che entrambi vogliono adempiere il più compiutamente possibile, se l’uno ha maggiori possibilità e dispone di mezzi adeguati alle sue intenzioni e la fortuna gli consente di portare a termine ciò che ha intrapreso, l’altro, però, lo eguaglia nella volontà: anche se ha dato un contraccambio inferiore a quanto ha ricevuto o non ha ricambiato affatto, ma vuole ricambiare, volto interamente a questo fine, non è vinto più di quanto non lo sia chi muore con le armi in pugno e che il nemico ha trovato più facile uccidere che respingere. A un uomo buono non può accadere ciò che tu consideri vergognoso, cioè di essere vinto, perché egli non cederà mai, non desisterà, sarà pronto fino all’ultimo giorno della sua vita, e in questo stato morirà, dichiarando di aver ricevuto grandi benefìci e di averli ricambiati con benefìci di uguale valore. 3. Gli Spartani proibiscono ai loro giovani di gareggiare nel pancrazio e nel cesto,1 dove l’essere vinti è segno di inferiorità. Un corridore che è giunto per primo al traguardo, ha superato l’altro in velocità, non in energia; un lottatore atterrato per tre volte ha perso la palma della vittoria, non l’ha ceduta. Poiché ritenevano molto importante che i loro cittadini non fossero mai vinti, gli Spartani esclusero i giovani da quelle gare in cui il vincitore è proclamato non da un giudice o dall’esito della competizione ma dalle dichiarazioni del concorrente che si arrende, lasciando così all’altro la palma della vittoria. Gli Spartani riconoscono e difendono nei loro cittadini il valore e la buona volontà, che sono una prerogativa fondamentale per essere invincibili, perché l’animo resta invitto anche in mezzo a difficoltà che superano le sue possibilità. I trecento Fabi non furono vinti, furono uccisi, Regolo fu catturato dai Cartaginesi, non vinto, e chiunque altro sia stato battuto dalla violenza e dall’influsso della sorte avversa non ha piegato il suo animo: così la pensano tutti gli Spartani. La stessa cosa accade nei benefìci: chi ne ha ricevuti di più, più frequenti e di maggior valore non per questo è un vinto. Se si mettono a confronto il bene che si fa e quello che si riceve forse i benefìci vengono superati dai benefìci; se invece si confrontano chi dà e chi riceve e si considera la buona disposizione d’animo di entrambi nessuno dei due risulterà vincitore, come accade di solito quando uno dei due avversari è ferito in più parti mentre l’altro lo è solo leggermente, nel cui caso si dice che ne sono usciti alla pari, sebbene uno dei due sembri inferiore. 4. Nei benefìci, dunque, nessuno può essere vinto, se chi riceve sa di essere in debito, se vuole ricambiare, perché per uscirne alla pari basta la buona disposizione d’animo. Fin quando chi riceve resta in questo stato di benevolenza, mantenendo la volontà di dimostrare la propria riconoscenza con delle prove concrete, che importa se da una parte o dall’altra si conta un numero maggiore di doni? Tu puoi dare molto e io posso solo ricevere; tu hai dalla tua parte la fortuna, io la buona volontà: ciò nonostante ti sono pari e rimango invitto, come uomini inermi o armati alla leggera lo sono di fronte a molti avversari armati di tutto punto. Nessuno, quindi, è vinto nei benefìci, perché ciascuno è riconoscente
in rapporto alla sua volontà e alla sua possibilità. Poiché, infatti, è vergognoso essere vinti nei benefìci, non bisogna accettarne da uomini molto potenti, ai quali non si potrebbe dare un contraccambio adeguato: parlo di principi e di re, che la fortuna ha collocato a un’altezza dalla quale possono elargire molti doni, ma riceverne pochi e non proporzionati ai loro. A essi, però, si possono sempre rendere dei servigi, visto che la loro grandissima potenza si fonda sul consenso e sull’aiuto dei loro subordinati. Ma alcuni sono del tutto estranei a ogni cupidigia, o appena appena sfiorati da qualche desiderio umano, e a questi neppure la fortuna può dare alcunché. È inevitabile che nei benefìci io sia vinto da Socrate, o da Diogene, che camminò nudo in mezzo ai tesori dei Macedoni, calpestando le ricchezze del re. Giustamente, dunque, egli parve a sé stesso e agli altri – che avevano la vista ben chiara per poter distinguere la verità – superiore a colui che aveva tutto ai suoi piedi: fu molto più potente e molto più ricco di Alessandro, che allora possedeva tutto, perché ciò che egli rifiutava era più di quello che Alessandro gli potesse dare. 5. Non è vergognoso essere vinti da uomini simili. Se infatti sono costretto a lottare con un nemico invulnerabile non per questo sono meno forte di lui; se il fuoco incontra un materiale non infiammabile non per questo ha perduto la sua capacità di bruciare, né il ferro quella di tagliare se deve spaccare una pietra che resiste ai colpi, compatta e inattaccabile dai corpi solidi. Lo stesso vale per l’uomo riconoscente: non è vergognoso per lui essere vinto nei benefìci, se è in debito verso uomini la cui straordinaria virtù o una più generosa fortuna rendono impossibili o vani quei benefìci con cui si vorrebbe ricambiare i loro. Nei benefìci, per esempio, noi siamo vinti dai genitori, coi quali viviamo per quel periodo in cui li giudichiamo fastidiosi e non comprendiamo il bene che ci fanno, e quando con l’età acquisiamo un po’ di assennatezza e cominciamo a capire che dobbiamo amarli proprio per quei motivi che detestavamo – rimproveri, severità, controllo assiduo della nostra giovinezza spensierata – ci vengono rapiti; pochi sono quei genitori che arrivano a un’età tale che gli consenta di cogliere dai figli una vera ricompensa ai benefìci elargiti, gli altri, dei figli, avvertono solo il peso. Con tutto ciò non è vergognoso essere vinti nei benefìci dal padre; e come potrebbe esserlo se non lo è l’essere vinti da altri? Con alcuni genitori, infatti, noi siamo al tempo stesso alla pari e non alla pari: alla pari per la disposizione d’animo, che è l’unica cosa che essi pretendono e che noi promettiamo; non alla pari nella fortuna; ma se questa c’impedisce di dimostrare concretamente la nostra riconoscenza, non per questo dobbiamo arrossire come per una sconfitta: non è vergognoso non raggiungere l’obiettivo, purché lo si sia tentato. Spesso prima di aver contraccambiato un beneficio ci sentiamo costretti a sollecitarne altri, ma non per questo dobbiamo astenerci dal chiederli o chiederli vergognandocene solo perché resteremo in debito senza poter ricambiare, in
quanto l’indugio nel manifestare concretamente la nostra viva riconoscenza dipenderà non da noi ma da un qualche motivo estraneo che ce l’ha impedito. Sul piano morale, dunque, noi non saremo vinti, né dovremo vergognarci di essere superati da loro quando ci sono cose che non dipendono da noi. 6. Alessandro, re di Macedonia, era solito vantarsi di non essere stato vinto nei benefìci da alcuno. Non c’era ragione perché egli guardasse con minore orgoglio Macedoni, Greci, Carii e Persiani e i popoli arruolati nel suo esercito, né perché credesse che ciò glielo consentiva un regno esteso da un angolo della Tracia fino a coste sconosciute. Lo stesso vanto di Alessandro valeva per Socrate, come per Diogene, dal quale il Macedone indubbiamente fu vinto. E non lo fu forse quel giorno in cui, gonfio di superbia oltre ogni limite umano, s’imbatté in uno al quale non poteva dare né togliere alcuna cosa? Il re Archelao pregò Socrate di andare da lui; stando alla tradizione, Socrate rispose che non intendeva recarsi da chi gli avrebbe fatto dei benefìci che lui non avrebbe potuto ricambiare adeguatamente. Innanzitutto era in suo potere non accettarli, e poi sarebbe stato lui il primo a concedere un beneficio andando dal re che lo aveva chiamato, dandogli così qualcosa che lui, comunque, non avrebbe potuto rendergli. Inoltre, Archelao avrebbe potuto offrirgli oro e argento, che il filosofo avrebbe rifiutato e disprezzato. Ebbene, Socrate avrebbe mai potuto dimostrare ad Archelao la sua riconoscenza? E che cosa avrebbe potuto ricevere che valesse tanto quanto ciò che gli dava lui con la sua esperienza della vita e della morte, di cui ben sapeva i limiti, introducendo alla conoscenza della natura un re che non ci vedeva neppure in pieno giorno ed era talmente ignorante in questo campo che quando ci fu un’eclissi di sole fece chiudere la reggia e tagliare i capelli al figlio come si usa in caso di lutti o di calamità? Quale immenso beneficio gli avrebbe fatto Socrate se lo avesse tirato fuori dai suoi nascondigli e gli avesse fatto coraggio, dicendogli: «Non è il venir meno del sole a produrre l’eclissi, è l’incontro di due astri, il quale si verifica quando la luna, che percorre un’orbita situata più in basso, si mette proprio al di sotto del sole e frapponendosi lo nasconde; e se lo sfiora di passaggio ne copre una porzione minima, se si interpone con una parte maggiore ne copre una più grande e se si trova fra la terra e il sole in linea retta lo sottrae completamente alla nostra vista. Ma la loro velocità allontana questi astri conducendoli in direzioni opposte, ed ecco che la terra torna a rivedere la luce, e questa serie di fenomeni continuerà nel corso dei secoli e ha i suoi giorni fissati e prestabiliti, nei quali il sole non può inviare tutti i suoi raggi per l’interporsi appunto della luna. Aspetta dunque un po’: ecco che il sole sta ricomparendo, presto riemergerà da questa specie di nube e liberatosi da ogni ostacolo c’invierà normalmente la sua luce». Socrate non avrebbe potuto dimostrare adeguatamente la propria riconoscenza se Archelao gli avesse proibito di rifiutare l’invito? Evidentemente il re avrebbe ricevuto un beneficio troppo piccolo da Socrate se questi avesse potuto ricambiarlo opportunamente. Perché allora Socrate disse così? Uomo di
spirito, che parlava per sottintesi e prendeva in giro tutti, specialmente i potenti, preferì rifiutare con una frase spiritosa piuttosto che in modo altero e superbo; disse che non voleva ricevere benefìci da colui al quale non avrebbe potuto offrire un contraccambio adeguato. Forse temeva di dover essere costretto ad accettare qualcosa che non voleva o che non era degna di lui. «Avrebbe sempre potuto rifiutare», obietterà qualcuno. Ma avrebbe provocato un re arrogante, il quale pretendeva che i suoi doni fossero tenuti in gran conto. Non fa alcuna differenza se tu non vuoi dare qualcosa a un re o non vuoi riceverla da lui: egli pone sullo stesso piano entrambi i rifiuti, e per un superbo è più duro essere oggetto di disprezzo che non di timore. Vuoi sapere cosa intendeva Socrate con quella battuta? Non voleva rendersi volontariamente schiavo, lui che per la sua schiettezza non fu tollerato neppure da una città libera. 7. Credo di aver trattato a sufficienza questo argomento, cioè se sia vergognoso essere vinti nei benefìci, una questione posta da chi pensa che gli uomini di solito non beneficano sé stessi, perché in caso contrario sarebbe evidente che non è vergognoso essere vinti da sé stessi. Eppure, alcuni stoici si chiedono se sia possibile beneficare sé stessi e se in questo caso ci si debba mostrare riconoscenti nei propri confronti. Essi giustificano questo problema osservando che noi siamo soliti dire: «Sono grato a me stesso», «Non posso lamentarmi che di me stesso», «Me la prendo con me stesso», «Punirò me stesso», «Mi odio», e tante altre frasi di questo genere, con le quali ciascuno parla di sé come se si riferisse a un altro. Se ne deduce che «se posso fare del male a me stesso, non potrei anche farmi del bene? Inoltre, se ciò che dò a un altro è un beneficio, perché non dovrebbe esserlo se le dò a me stesso? Perché se ho ricevuto qualcosa da uno sono in debito con lui e se ho dato qualcosa a me stesso non lo sono nei miei confronti? E perché non posso essere ingrato verso me stesso, cosa che non è meno vergognosa dell’essere avaro, duro, crudele e trascurato con sé stesso? Il lenone acquista una cattiva reputazione sia che prostituisca il corpo di altri sia che prostituisca il suo. Se l’adulatore, che approva con compiacimento ciò che dicono gli altri, che è sempre pronto a lodare ipocritamente, è oggetto di biasimo, lo è altrettanto chi si compiace di sé stesso: se così si può dire, un autocorteggiatore. I vizi sono odiosi non solo quando il male si riversa su altri ma anche quando si ritorcono contro noi stessi. Chi va ammirato di più se non colui che sa comandare a sé stesso e che a sé stesso s’impone? È più facile governare popolazioni barbare e insofferenti del dominio altrui che frenare il proprio animo e affidarlo a sé stessi. Platone, si dice, è grato a Socrate perché lo ha avuto come maestro. Ebbene, perché Socrate non dovrebbe essere grato a sé stesso per essere stato il proprio maestro? Catone dice: «Ciò che ti mancherà, prendilo da te stesso»; perché non dovrei poter donare a me stesso, se posso prestare a me stesso? Sono innumerevoli i casi in cui il linguaggio usuale ci divide in due, come quando diciamo: «Lasciami parlare con me stesso», o «Mi tirerò le orecchie». Ora, se questi modi di dire
sono corretti ne consegue che come ci si può adirare con sé stessi, così si può anche essere grati a sé stessi, come ci si può rimproverare, così ci si può anche lodare, come si può essere di danno a sé stessi, si può anche essere di vantaggio. Ancora: l’offesa e il beneficio sono contrari, ma se diciamo che uno «ha fatto un’offesa a sé stesso» possiamo dire anche che «ha fatto del bene a sé stesso». E far bene a sé stessi è cosa conforme a natura». 8. Deve a sé secondo natura? Prima, però, bisogna che ci sia il debitore, che successivamente dimostra la propria riconoscenza. E l’esistenza di un debitore presuppone quella di un creditore, come l’esistenza di un marito presuppone quella di una moglie o quella di un padre presuppone quella di un figlio o di una figlia; affinché qualcuno riceva è necessario che qualcuno dia. Non è invece dare né ricevere passare qualcosa dalla mano sinistra a quella destra. Come nessuno trasporta sé stesso, benché muova e trasferisca il suo corpo, come nessuno, benché abbia parlato in sua difesa, viene chiamato avvocato di sé stesso o innalza una statua a sé come al suo difensore, come l’ammalato, guarito grazie alle proprie cure, non esige l’onorario da sé stesso, così in ogni attività chi ha fatto qualcosa di utile a sé stesso non può dimostrare, a sé stesso, la propria riconoscenza, perché non c’è un’altra persona a cui possa dimostrarla. Anche ammettendo che uno conceda un beneficio a sé stesso, nell’istante in cui lo dà lo riceve. È un prestito che si fa in casa, come si suol dire, e si annulla subito in quanto non esiste un credito, poiché non c’è uno che dà e un altro che riceve, c’è un’unica persona. La parola “debito” non si può usare, non esiste se non nel caso in cui le persone siano due: a chi infatti si potrebbe attribuire quando la persona è una sola, che nel momento stesso in cui contrae un debito lo estingue? Come nella sfera e nella palla non c’è né basso né alto, né fine né principio, perché l’ordine cambia col movimento e quel che era dietro passa davanti e quel che scendeva sale e tutto, con qualunque movimento, ritorna al punto di prima, così – credimi – accade anche nel caso dell’uomo: puoi cambiarlo in mille modi, ma resterà sempre uno. Ha colpito sé stesso? Non ha nessuno che possa accusare di averlo offeso. Si è legato e imprigionato? Non c’è nessuno che possa accusarlo di violenza. Ha fatto del bene a sé stesso? Ha ricambiato subito insieme col donatore. Si dice che la natura non perde nulla perché tutto ciò che le viene portato via ritorna a lei, e nulla può scomparire perché non ha un posto dove andare a finire ma ogni cosa torna nel luogo da cui si era allontanata, cioè sempre alla natura. Dirai: «Che c’entra questo esempio con la questione in esame?». Ora te lo dico. Supponiamo che tu sia un ingrato: il beneficio non va perduto, ma resta nelle mani di chi lo ha concesso; supponiamo che tu non voglia accettare il contraccambio: è nelle tue mani prima ancora che ti sia dato. Non puoi perdere nulla, perché ciò che ti viene tolto si trasforma comunque in un guadagno per te. È un circolo chiuso: ricevendo dài e dando ricevi.
9. «Se si dice che bisogna beneficare sé stessi è evidente che bisogna anche mostrarsi riconoscenti nei propri confronti». Prima di tutto la premessa da cui si trae la conclusione è falsa: nessuno, infatti, dà un beneficio a sé stesso, quando uno con quel gesto obbedisce alla sua natura, che lo spinge all’amore di sé, per cui egli con molta cura evita ciò che può danneggiarlo e ricerca ciò che può giovargli. Non è dunque generoso chi dona a sé stesso, né è clemente chi perdona a sé stesso e misericordioso chi si commuove per le proprie sventure: ciò che se rivolto ad altri è generosità, clemenza e compassione, se rivolto a sé stessi non è che istinto naturale. Il beneficio è un atto della volontà, mentre giovare a sé stessi è una necessità. Quanti più benefìci si dànno, tanto più si è benefattori, ma chi è mai stato lodato per aver prestato aiuto a sé stesso o per essersi sottratto ai banditi? Nessuno dà a sé stesso un beneficio, oppure un prestito, oppure offre a sé stesso ospitalità. Se uno può dare un beneficio a sé stesso, allora lo dà sempre e continuamente, il numero dei suoi benefìci non si conta, e allora quando dimostrerà la propria riconoscenza, visto che nel momento in cui la dimostra si dà un beneficio? E come puoi distinguere se da o ricambia un beneficio a sé stesso quando tutto si svolge nell’ambito della medesima persona? Mi sono sottratto a un pericolo: mi sono dato un beneficio; mi sottraggo un’altra volta a un pericolo: mi dò un altro beneficio o ricambio il precedente? E poi, anche ammesso che io possa dare un beneficio a me stesso, non accetterò la conseguenza: infatti, anche se dò, non sono in debito. Perché? Perché ricevo subito il contraccambio. Bisogna che io prima riceva il beneficio, poi sia in debito e quindi ricambi: in questo caso, invece, non posso essere in debito, perché ricevo immediatamente il contraccambio. Non si dà se non a un altro, non si è in debito se non verso un altro, non si ricambia se non con un altro: ciò che richiede due persone non può verificarsi in una sola. 10. Il beneficio consiste nell’offerta di qualcosa di utile; ora, la parola “offerta” implica l’esistenza di altri. Non sembrerebbe insensato chi dicesse di aver venduto qualcosa a sé stesso? La vendita, infatti, è un trasferimento di proprietà, la cessione di una cosa che appartiene a uno e del suo diritto su di essa a un altro. E come il vendere anche il dare significa privarsi di una cosa che si possiede per darla a un altro: se è così, nessuno ha mai fatto un beneficio a sé stesso, perché non si può dare qualcosa a sé stessi, altrimenti coesisterebbero due cose opposte e dare e ricevere sarebbero la medesima cosa. C’è molta differenza fra dare e ricevere, e non potrebbe essere diversamente, dal momento che queste parole designano cose opposte. Ma se qualcuno dà un beneficio a sé stesso non c’è più differenza fra dare e ricevere. Poc’anzi ho detto che alcune parole si riferiscono agli altri e sono fatte in modo tale che tutto ciò che significano ci sfugge: io sono fratello di un altro, nessuno è fratello di sé stesso; sono pari a un altro, e chi può essere pari a sé stesso? L’elemento messo a confronto non si comprende senza l’altro, quel che viene congiunto non esiste senza l’altro elemento; così anche ciò che viene dato o
ricevuto non esiste senza l’altro rispettivo corrispondente. La stessa cosa risulta chiara dall’espressione stessa con cui lo si definisce: «Aver fatto del bene»: nessuno fa del bene a sé stesso, così come non favorisce sé stesso o parteggia per sé stesso. Si potrebbe continuare e trascinare a lungo questa discussione con molti esempi: e perché no, visto che il beneficio deve essere certamente annoverato fra quelle cose che richiedono una seconda persona? Alcune azioni, che pur sono onorevoli, bellissime, virtuosissime, non si possono compiere se non nei confronti di un altro. Si loda e si onora come uno dei beni più grandi la lealtà, ma si può dire che uno è leale con sé stesso? 11. Vengo ora all’ultima parte. Chi dimostra la propria riconoscenza deve spendere qualcosa, come chi estingue un debito spende del denaro. Ebbene, chi dimostra la propria riconoscenza a sé stesso non spende nulla, così come non guadagna nulla chi riceve un beneficio da sé stesso: il beneficio e la dimostrazione di riconoscenza avvengono fra due persone, non c’è uno scambio reciproco in una sola. Chi dimostra la propria riconoscenza giova a sua volta a colui dal quale ha ricevuto; chi dimostra la propria riconoscenza a sé stesso a chi giova? A sé stesso: ma chi non pensa che la riconoscenza abbia un destinatario e il beneficio un altro? Chi dimostra a sé stesso la propria riconoscenza giova a sé stesso, e chi è mai quell’ingrato che non vuole farlo? Anzi, chi non è stato ingrato proprio per fare ciò? Si dice: «Se noi dobbiamo ringraziare noi stessi, dobbiamo anche dimostrarci la nostra riconoscenza». Ebbene, noi diciamo: «Ringrazio me stesso di non aver voluto sposare quella donna» e «di non essermi messo in società con quell’uomo». Quando parliamo così, lodiamo noi stessi e usiamo in modo improprio le espressioni di chi ringrazia. Beneficio è ciò che una volta dato può anche non essere ricambiato; ora, chi dà un beneficio a sé stesso non può non ricevere ciò che ha dato; dunque, non si tratta di un beneficio. Il beneficio poi si riceve in un momento e si ricambia in un altro, mentre in questo caso si riceve e si ricambia contemporaneamente. Ancora: nel beneficio è degno di lode e di ammirazione anche il fatto che per giovare a un altro ci si dimentica del proprio utile e si è pronti a privarsi di ciò che si vuole dare, e questo non lo fa chi dà un beneficio a sé stesso. Concedere un beneficio è un’azione di portata sociale: fa nascere un rapporto di amicizia, un obbligo; concederlo a sé stessi non è un’azione di portata sociale, non genera alcuna amicizia, alcun obbligo, alcuna speranza, sì che si possa dire: «Devo onorare quest’uomo; ha fatto del bene a quello, lo farà anche a me». Il beneficio lo si dà non per sé stessi, ma per colui al quale lo si dà, mentre colui che dà un beneficio a sé stesso lo dà per sé stesso, dunque non è un beneficio. 12. Ti sembra ch’io abbia mentito in ciò che ho detto all’inizio, perché sono ben lungi, tu dici, dal fare cose di qualche valore e, sia pure in buona fede, spreco tutta la mia fatica. Aspetta e potrai sostenerlo con maggior fondatezza
quando ti avrò condotto in un tale labirinto che una volta venutone fuori potrai solo dire di essere sfuggito a difficoltà che avresti potuto benissimo evitare. Che bene c’è, infatti, nello sciogliere con fatica i nodi che tu stesso hai fatto proprio per scioglierli? Ma spesso i nodi si fanno per distrarsi e per passare il tempo, o affinché poi risulti difficile scioglierli per un inesperto, mentre colui che li ha fatti li scioglie senza fatica inquantoché conosce i nodi e gli ostacoli, e ciò, fra l’altro, dà un certo piacere, mette alla prova l’intelligenza e stimola l’attenzione. Analogamente questi problemi, che sembrano sottili e pieni di tranelli, distolgono dalla pigrizia e dall’inerzia, perché ora bisogna spianare il campo in cui muoversi, ora affrontare un cammino tenebroso e accidentato, lungo il quale arrampicarsi faticosamente e avanzare passo dopo passo con estrema prudenza. C’è chi dice che nessuno è ingrato, e lo dimostra così: «Il beneficio giova; ma nessuno può giovare al malvagio, come dite voi stoici, perciò il malvagio non può ricevere un beneficio e quindi non può essere ingrato. E poi il beneficio è una cosa onesta e lodevole, mentre l’onesto e il lodevole non trovano posto nel malvagio, dunque neppure il beneficio; ora, se il malvagio non può accettare un beneficio non ha nemmeno il dovere di ricambiarlo, quindi non può essere ingrato. Inoltre, come dite voi, l’uomo virtuoso fa tutto rettamente e se fa tutto rettamente non può essere ingrato. L’uomo virtuoso ricambia il beneficio, il malvagio non lo riceve; se le cose stanno così, né l’uomo virtuoso né il malvagio sono ingrati, ergo in natura l’ingrato non esiste». Anche questa argomentazione, però, è inconsistente. Il bene per noi è unico: è l’onestà. Questa non può toccare al malvagio, poiché egli cesserebbe di essere malvagio se la virtù penetrasse in lui; fino a quando resta malvagio, nessuno può fargli del bene, perché il male e il bene sono opposti e non possono coesistere. Perciò, nessuno gli giova, perché egli guasta, facendone cattivo uso, qualunque cosa gli giunga. Come uno stomaco ammalato e che accumula bile trasforma qualsiasi cibo che ingerisca e ne ricava dolore, così un animo malato fa diventare un peso, un danno e un’occasione di miseria tutto ciò che gli si dà. Perciò, gli uomini più fortunati e più ricchi sono tanto più esposti all’agitazione quanto più vasti sono i campi di oscillazione in cui si imbattono. Ai malvagi, dunque, non può toccare nulla che gli giovi, anzi nulla che non li danneggi: qualunque bene gli capiti, essi lo trasformano conformemente alla propria natura, e le cose belle, che date a un uomo buono gli gioverebbero, a loro sono dannose. Quindi non possono neppure fare del bene, perché uno non può dare ciò che non ha, e il malvagio non ha la volontà di fare il bene. 13. Nonostante tutto ciò, anche il malvagio può ricevere alcune cose che sono simili ai benefìci, e se non le ricambia è un ingrato. Ci sono infatti beni dell’anima, beni del corpo e beni della fortuna: i beni dell’anima sono preclusi a chi è stolto e malvagio, ammesso solo a quei beni che può ricevere e deve ricambiare, e se non li ricambia è un ingrato. Ciò non vale solo per il nostro sistema filosofico, anche i peripatetici, che allungano e allargano i confini della
felicità umana, affermano che ai malvagi possono toccare piccoli benefìci e che chi non li ricambia è un ingrato.2 Noi riteniamo che non rientrino fra i benefìci quelli che non rendono migliore l’animo, ma non neghiamo che siano dei vantaggi e delle cose desiderabili. Sono cose che anche un uomo malvagio può dare a un uomo buono, come il denaro, le vesti, gli onori, la vita, e chi non le ricambia passa per ingrato. «Ma come puoi chiamare ingrato chi non ricambia ciò che, come tu dici, non è un beneficio?». Alcune cose, anche se non sono veri benefìci, vengono comprese sotto il medesimo nome a causa della somiglianza: così noi chiameremo pisside sia quella d’argento sia quella d’oro, e illetterato non solo chi è completamente ignorante, ma anche chi non ha raggiunto un certo livello culturale, come chi ha visto un uomo vestito male e cencioso dice di averlo visto nudo. Quelli di cui stiamo parlando non sono benefìci, ma ne hanno l’aspetto. «Ma come queste cose hanno solo l’aspetto di benefìci, così anche uno che ha l’aspetto di un ingrato può non esserlo». No, perché queste cose sono chiamate benefìci sia da chi le dà sia da chi le riceve, quindi anche chi non ricambia una cosa che ha l’aspetto di un vero beneficio è un ingrato, come è un avvelenatore chi ha preparato un sonnifero credendo che fosse un veleno. 14. Cleante3 sostiene questa tesi con maggior forza, dicendo: «Anche se quello che uno ha ricevuto non è un beneficio, egli è ugualmente un ingrato, perché non avrebbe ricambiato neppure se avesse ricevuto un beneficio autentico. Allo stesso modo un bandito è tale anche prima di compiere il delitto, perché è già armato per uccidere o ha la volontà di derubare e di uccidere; la sua malvagità si esplica e si manifesta nell’azione, ma esiste prima di essa. «Però ciò che aveva ricevuto non era un beneficio». Ma era chiamato così! I sacrileghi vengono puniti, sebbene nessuno di loro riesca ad allungare le mani fino agli dèi. «Come si può essere ingrati nei confronti di un malvagio, visto che il malvagio non può fare del bene?». Evidentemente per questi motivi: chi riceve da un malvagio qualcuna di quelle cose che sono tenute in gran conto dagli ignoranti e che i malvagi hanno in abbondanza, in una circostanza analoga deve anch’egli mostrarsi riconoscente e ricambiare al pari di un bene ciò che ha ricevuto come tale, quale che sia la sua natura. Si dice che sia in debito tanto chi deve dell’oro quanto chi deve del cuoio su cui è impresso il sigillo di Stato, che esisteva presso gli Spartani e che sostituiva la moneta coniata. Ebbene, tu paga il tuo debito con cose dello stesso genere. Cosa siano i benefìci, se la grandezza di un nome così nobile debba scendere fino a una materia così vile e meschina, non vi riguarda; in questo caso si cerca la verità a danno degli altri: adeguatevi a ciò che ha l’apparenza del vero e se siete onesti onorate qualunque cosa a cui si attribuisca il nome di bene. 15. Si può obiettare: «In base al vostro ragionamento nessuno è ingrato: allora vale anche il contrario, cioè che tutti sono ingrati». Non diciamo che tutti
gli stolti sono malvagi? Ora, chi ha un vizio li ha tutti, e se tutti sono stolti e malvagi, tutti sono ingrati. E che, forse non lo sono? Non si leva da ogni parte un rimprovero per tutto il genere umano? Non è una lamentela generale che i benefìci vanno perduti e che sono pochissimi quelli che non ricambiano perché i loro benefattori si comportano malissimo? Non pensare che questo mormorio venga solo da noi, che consideriamo negativo e malvagio tutto ciò che non rientra nella nostra definizione del bene. Ecco un grido che non si leva dalla casa dei filosofi, ma proviene dalla folla a condanna di popoli e nazioni: Neppure l’ospite è sicuro dall’ospite, né il suocero dal genero; anche tra fratelli è rara l’armonia. Il marito aspetta solo di uccidere la moglie, la moglie il marito.4 E non è tutto: i benefìci si sono trasformati in delitti e non si risparmia il sangue di coloro per i quali invece si dovrebbe versarne; ai benefìci rispondiamo con la spada e col veleno, si considera segno di onore e di potenza aggredire la patria e opprimerla con i suoi fasci, chi non ha lo Stato sotto di sé si ritiene in una posizione infima e umiliante, i generali rivolgono contro lo Stato gli eserciti che hanno ricevuto da lui, gridando ai propri soldati: «Combattete contro le vostre mogli, contro i vostri figli! Attaccate con le armi le case, gli altari, i Penati!». Voi che non sareste dovuti entrare in città senza l’ordine del Senato neppure per celebrare il trionfo, voi che anche riconducendo un esercito vittorioso avreste ottenuto udienza fuori dalle mura, ora, dopo aver ucciso dei concittadini, tutti bagnati del sangue dei vostri fratelli, entrate in città a bandiere spiegate. Ammutolisca la libertà, in mezzo alle insegne militari, e quel popolo che aveva vinto e pacificato le nazioni, dopo aver allontanato le guerre ed eliminato ogni motivo di terrore, assediato dentro le sue stesse mura, tremi di fronte alle sue aquile! 16. È un ingrato Coriolano,5 che diventò onesto tardi e dopo aver provato il rimorso per il misfatto commesso: depose le armi, ma in piena guerra contro la patria. È un ingrato Catilina,6 a cui parve poca cosa impadronirsi della patria se non l’avesse anche distrutta, se non l’avesse consegnata alle coorti degli Allobrogi, se non avesse saziato gli antichi e congeniti odi e reso gli onori funebri da tempo dovuti immolando dei generali romani ai sepolcri dei Galli. È un ingrato Caio Mario,7 il quale, pervenuto da semplice soldato a console, affinché non sembrasse che la sua fortuna fosse cambiata di poco, anzi, ritornata quella di prima, volle eguagliare coi cadaveri romani quelli della strage dei Cimbri, dando il segnale della guerra civile e del massacro divenendone il simbolo. È un ingrato Lucio Silla,8 che volle guarire la patria con rimedi più crudeli dei pericoli che la minacciavano e che, essendo avanzato, in mezzo al sangue umano, dalla rocca Prenestina fino alla porta Collina, causò nella città
altri combattimenti e altre stragi, facendo trucidare contemporaneamente – dopo la vittoria, azione crudele, e dopo che aveva promesso di non farlo, azione empia – due legioni ammassate in un angolo, e inventò, grandi dèi, la proscrizione, sicché chiunque avesse ucciso un cittadino romano riceveva l’impunità e del denaro. Gli mancò solo la corona civica! È un ingrato Gneo Pompeo,9 che per i tre consolati, i tre trionfi e i tanti onori che per la maggior parte aveva conseguito senza averne ancora l’età, dimostrò la sua riconoscenza verso la patria consentendo ad altri di impadronirsi dello Stato, quasi per far odiare di meno il suo potere, permettendo a molti ciò che non doveva essere permesso ad alcuno. Mentre bramava poteri straordinari, mentre distribuiva le provincie per scegliersele, mentre divideva lo Stato in tre parti, ma in modo che a lui ne restassero due, ridusse il popolo romano a non avere altra possibilità di salvezza che la schiavitù. È un ingrato Giulio Cesare,10 nemico e vincitore di Pompeo, questo demagogo, questo adulatore della plebe, che dalla Gallia e dalla Germania portò la guerra fino a Roma e pose i suoi accampamenti al circo Flaminio, più vicino di quanto lo fossero stati quelli di Porsenna. Usò con moderazione il diritto di incrudelire che gli veniva dalla vittoria, mantenendo la promessa che aveva fatto spesso: non uccise nessuno che non fosse armato. E con ciò? Gli altri usarono le armi spargendo molto più sangue, ma una volta saziatisi le deposero: lui nascose subito la spada, ma non la depose mai. È un ingrato Antonio11 verso il suo dittatore, perché disse che avevano fatto bene a ucciderlo; distribuì provincie e comandi ai suoi assassini e dopo tante sventure destinò a re stranieri la patria, straziata da proscrizioni, guerre e incursioni, talché quella stessa Roma, che aveva ridato ad Achei, a Rodiesi e a molte altre città famose tutti i loro diritti nonché l’immunità da tributi e servizi, dovette pagare il tributo a degli eunuchi. 17. Non basterebbe un giorno per enumerare tutti coloro che hanno spinto la propria ingratitudine sino al punto da provocare la rovina della patria. Ma sarebbe un’impresa ugualmente infinita elencare le occasioni in cui la patria si è dimostrata ingrata nei confronti dei suoi uomini migliori e più devoti, nonché le sue colpe, che non sono meno numerose di quelle commesse contro di lei. Mandò in esilio Camillo, allontanò Scipione; dopo Catilina esiliò Cicerone, distrusse la sua casa, saccheggiò i suoi beni, comportandosi come si sarebbe comportato Catilina se avesse vinto. Rutilio,12 come premio per la sua onestà, ottenne di nascondersi in Asia, a Catone il popolo romano rifiutò una volta la pretura e ostinatamente il consolato. Siamo tutti, indistintamente, degli ingrati. Ciascuno interroghi sé stesso e vedrà che tutti, senza alcuna eccezione, ci lamentiamo di qualche ingrato. Eppure, visto che se ne lamentano tutti non ci sarebbe ragione di lamentarsene: dunque, tutti sono ingrati. Ma sono solo ingrati? Sono anche avidi, maligni e vili, primi fra tutti quelli che sembrano coraggiosi; aggiungi poi che tutti sono ambiziosi ed empi. Ma non arrabbiarti: perdona loro, perché sono tutti pazzi.
Non ti cito fatti indeterminati, non dico, per esempio: «Vedi come sono ingrati i giovani: chi, pur nella sua innocenza, non desidera la morte del padre, anche se moderato, chi non la aspetta, anche se affettuoso, o perlomeno non la immagina? Quanti sono coloro che temono la morte di un’ottima moglie tanto da non includerla mai nei loro pensieri delittuosi? Chi è, dimmi, l’accusato che dopo essere stato assolto ha conservato a lungo il ricordo di un beneficio così grande?». Una cosa è certa: nessuno muore senza lamentarsi. Chi nell’ultimo giorno ha il coraggio di dire: «Sono vissuto e ho compiuto tutto il cammino che la fortuna mi aveva assegnato»?13 Chi esce dalla vita senza protestare, senza lamentarsene? Eppure, è proprio dell’ingrato il non essere contento del tempo trascorso. Se li conti, i giorni ti risultano sempre pochi. Il sommo bene non è una questione di tempo: indipendentemente dalla sua durata si può sempre usarlo bene; ritardare la morte non giova per nulla alla felicità, perché con una proroga la vita non si fa più felice, diventa solo più lunga. Quanto sarebbe meglio, mostrandosi riconoscente per i piaceri goduti, non badare al numero degli anni altrui ma contare generosamente i propri e metterli fra i guadagni! «Dio mi ha giudicato degno di questo beneficio: mi accontento. Avrei potuto avere di più, ma questo è pur sempre un beneficio». Dobbiamo essere grati verso gli dèi, verso gli uomini e verso coloro che ci hanno fatto del bene, ma anche a quelli che hanno fatto del bene ai nostri cari. 18. Si obietterà: «Dicendo “ai nostri cari” estendi all’infinito il mio dovere di riconoscenza, gli poni un limite. Tu dici che chi fa del bene al figlio lo fa anche al padre: questo è il primo punto su cui ti chiedo una spiegazione. Ma voglio anche sapere: se si fa del bene al padre, lo si fa pure al fratello? E allo zio? E al nonno, al suocero, alla moglie? Dimmi dove devo fermarmi, fin dove devo portare il numero delle persone». Ascolta. Se coltivo il tuo campo faccio del bene a te; se spengo l’incendio che sta bruciando la tua casa o se la puntello affinché non cada, faccio del bene a te; se guarisco il tuo schiavo, metto in conto a te questo beneficio, se salvo tuo figlio, non ricevi da me un beneficio? 19. Gli esempi che tu hai addotto sono di genere diverso, nel senso che chi coltiva il mio campo non dà un beneficio al mio campo, dà un beneficio a me; e chi puntella la mia casa affinché non crolli rende un servigio a me, dato che la casa non ha sensibilità; sono io a essere in debito con lui, poiché nessun altro potrebbe esserlo; e anche chi coltiva il mio campo vuole ingraziarsi me, non il campo. La stessa cosa vale per lo schiavo: è una mia proprietà, è per me che lo salvi, perciò sono io a essere in debito per lui. Il figlio, invece, riceve egli stesso il beneficio: la cosa mi tocca e me ne rallegro, ma non sono io in debito. Tu, però, che non ritieni di essere in debito, rispondimi: la salute del figlio, la sua felicità e il suo patrimonio hanno una grande importanza per il padre, il quale gioirà di più se suo figlio sarà vivo e vegeto, infelice se lo perderà. E allora? Chi è reso più felice da me ed è liberato dal pericolo di una grandissima
infelicità non riceve un beneficio? Si può obiettare: «No, perché certe cose vengono date ad altri, anche se in seguito arrivano fino a noi: tutto, dunque, deve essere ricondotto a colui che ha ricevuto il beneficio, come il denaro si richiede a chi l’ha avuto in prestito, anche se in qualche modo è arrivato a me. Non c’è beneficio i cui vantaggi non tocchino anche coloro che sono più vicini al destinatario, talvolta anche quelli un po’ più lontani. Il problema non è dove sia andato a finire il beneficio partendo da chi lo ha ricevuto, il problema è dove sia stato collocato all’inizio: quindi il contraccambio va chiesto a chi è direttamente in obbligo e ha ricevuto per primo il beneficio». E allora? Tu non dici: «Mi hai ridato mio figlio, se lui fosse morto, io non sarei sopravvissuto»? Non sei in debito di un beneficio dal momento che la vita di tuo figlio è per te più importante della tua? Inoltre, dopo che ti ho salvato tuo figlio, tu ti prostri alle mie ginocchia, fai sacrifici agli dèi, come se fossi stato salvato tu stesso, dici frasi del genere: «Non m’interessa sapere se sono stato io a essere salvato: tu hai salvato tutti e due, anzi, me soprattutto». Perché parli così se tu personalmente non hai ricevuto un beneficio? «Perché anche se mio figlio, per dire, contrarrà un debito e io rimborserò il creditore, non sarò io a essere in debito; e anche se mio figlio sarà colto in flagrante adulterio, io ne arrossirò, ma non per questo sarò io l’adultero. Dico che sono in debito con te per via di mio figlio, non perché io lo sia realmente, ma perché voglio offrirmi a te come debitore volontario. Certo, per la sua salvezza ho provato una grandissima gioia, un grandissimo giovamento, e sono sfuggito al colpo più doloroso, quello della sua perdita. Ora la questione non è se tu mi abbia giovato, ma se tu mi abbia dato un beneficio; infatti, anche un animale, una pietra e dell’erba possono giovare, però non dànno un beneficio, perché un beneficio può essere dato solo da chi vuole darlo». Tu, però, vuoi dare non al padre, ma, al figlio, e talvolta il padre non lo conosci neppure. Perciò, invece di chiederti «Non ho dato, dunque, un beneficio al padre, salvando il figlio?», domandati: «Ho dato, dunque, un beneficio a quel padre che non conosco e al quale non pensavo neppure?». E che dire di quel che accade a volte, cioè di odiare il padre e salvare il figlio? Vuoi apparire come il benefattore di uno che mentre lo beneficavi consideravi un nemico? Ma, lasciando da parte questa disputa, ti rispondo da giureconsulto: bisogna guardare all’intenzione di chi dona; ha beneficato colui al quale ha voluto destinare il beneficio. Se ha voluto rendere omaggio al padre, è il padre che ha ricevuto il beneficio, se ha voluto favorire il figlio, il padre non è in debito per il beneficio concesso al figlio, anche se ne gode pure lui. Tuttavia, se ne avrà l’occasione e vorrà dare anch’egli qualcosa, lo faccia non perché obbligato a sdebitarsi, ma a titolo di iniziativa. Non si deve chiedere al padre il contraccambio del beneficio: se egli gentilmente fa qualcosa è giusto ma non riconoscente. Un tale obbligo, infatti, non può essere definito con precisione: se faccio del bene al padre, lo faccio anche alla madre, al nonno, allo zio, ai figli, ai parenti, agli amici, agli schiavi e alla patria. Dunque, dove comincerà a
fermarsi il beneficio? Ci si infila in quell’insolubile sorite14 a cui è difficile assegnare un limite, perché si insinua a poco a poco e non cessa di diffondersi. 20. Un’altra delle solite questioni che ci si pone è questa: «Due fratelli sono in discordia fra loro: se salvo uno dei due, sono il benefattore anche dell’altro, il quale magari si dispiacerà che l’odiato fratello non sia morto?». Certo è un beneficio anche rendere un servigio a chi non lo vuole, come non lo è rendere un servigio senza volerlo. «E lo chiami beneficio ciò che per qualcuno è un’offesa o una sofferenza?». Molti benefìci hanno un aspetto crudo e sgradevole, come amputazioni, cauterizzazioni e immobilizzazioni che hanno per fine la guarigione. Si deve guardare non se chi riceve il beneficio possa soffrirne ma se avrebbe motivo di rallegrarsene: una moneta rifiutata da un barbaro che non conosce il conio dello Stato non per questo è falsa. Un beneficio può essere odiato e al tempo stesso accettato in quanto giova, purché il donatore lo abbia elargito appunto per giovare. Non importa se si accoglie una cosa buona con una disposizione d’animo ostile. E ora ribaltiamo la situazione. Un tale odia il fratello, che però gli fa comodo, e io lo uccido: questo non è un beneficio, anche se quello lo considera tale e se ne rallegra. Nuoce nel modo più insidioso chi ci ringrazia per un’offesa. «Ho capito: ciò che giova è un beneficio, ciò che nuoce non lo è. E io allora ti darò qualcosa che senza nuocere o giovare è un beneficio. Uno trova il padre di un tale abbandonato e privo di vita e ne seppellisce il cadavere: non ha giovato né al morto (che vantaggio ne ricavava, infatti, da quella sepoltura quando il suo corpo si sarebbe comunque decomposto?), né al figlio, che da quella azione non ha tratto alcun giovamento personale». Ebbene ti dirò io che cosa ha ottenuto il figlio: ha compiuto, per mezzo mio, un suo dovere sacro e ineludibile, avendo io fatto a suo padre ciò che avrebbe voluto e dovuto fare lui stesso. Tuttavia, quell’azione è un beneficio se io l’ho compiuta non per quell’umano sentimento di pietà che mi avrebbe indotto a seppellire chiunque, ma perché ho riconosciuto il cadavere e ho pensato di compiere quell’atto nell’interesse del figlio; se invece ho gettato della terra su un morto a me sconosciuto, allora non ho alcun debitore, perché è stato un normale gesto di umanità. Qualcuno dirà: «Ti dài tanto da fare per cercare uno al quale hai dato un beneficio come se dovessi chiedergli un contraccambio? Alcuni pensano che il contraccambio non si debba chiedere mai, per questi due motivi: chi non meritava il beneficio non lo ricambierà nemmeno se glielo chiedi, chi lo meritava lo ricambierà spontaneamente. Inoltre, se hai fatto del bene a un uomo virtuoso, non sollecitarlo, per non offenderlo, come se non intendesse ricambiare spontaneamente, ma aspetta che sia lui a provvedere; se lo hai fatto a un malvagio, sopportane le conseguenze, ma non rovinare il beneficio trasformandolo in un credito. Peraltro la legge proibisce di chiedere il contraccambio, visto che non lo impone espressamente». Queste sono parole. Fino a quando niente mi angustierà, fino a quando la
sorte non mi costringerà, perderò un beneficio piuttosto che chiedere il contraccambio; ma se c’è di mezzo la vita dei miei figli, se mia moglie è in pericolo, se la salvezza e la libertà della patria mi mandano dove non volevo, farò violenza alla mia discrezione e dichiarerò di aver fatto di tutto per non aver bisogno dell’aiuto di un ingrato, però alla fine la necessità di recuperare il mio beneficio vincerà la vergogna. D’altra parte quando dò un beneficio a un uomo virtuoso lo dò con l’intenzione di non chiederne mai il contraccambio, tranne che in caso di necessità. 21. «Ma se la legge non consente di chiedere il contraccambio vuol dire che lo proibisce». Molte cose non hanno una legge specifica e non dànno il diritto di agire legalmente, ma sono permesse dalle consuetudini della società, che sono più forti di qualsiasi legge. Nessuna legge ordina di non divulgare i segreti degli amici, di mantenere la parola data anche con un nemico; quale legge ci obbliga a mantenere ciò che abbiamo promesso? Nessuna. Tuttavia, io mi lamenterò con chi non manterrà un segreto e con chi mancherà alla parola data. «Ma così trasformi il beneficio in un credito!». Niente affatto. Io non pretendo, ma chiedo, anzi, non chiedo neppure: avverto. Metti che un’estrema necessità mi spinga ad andare da uno con cui mi toccherà lottare a lungo. Se incontrerò un ingrato a cui non basteranno i miei richiami al dovere, passerò oltre e non lo giudicherò neppure degno di essere costretto a dimostrare la sua riconoscenza. Come l’usuraio non pretende la restituzione del denaro da quei debitori che hanno fatto bancarotta e che per la vergogna hanno perduto tutto, così io tralascerò coloro che sono manifestamente e ostinatamente ingrati, e chiederò il contraccambio di un beneficio solo a colui che me lo darà senza che io debba strapparglielo con la forza. 22. Molti non negano ciò che hanno ricevuto e tuttavia non lo ricambiano, non sono così buoni come quelli che si dimostrano riconoscenti, ma nemmeno così cattivi come gli ingrati: pigri e lenti, sono tardi, ma non cattivi pagatori. Ebbene, contro costoro io non intraprenderò un’azione legale, ma li ammonirò e li richiamerò al loro dovere, visto che sono in tutt’altre faccende affaccendati. Loro magari mi risponderanno: «Perbacco, perdonami: non sapevo che tu lo desiderassi, altrimenti te lo avrei offerto spontaneamente. Ti prego di non considerarmi un ingrato: io mi ricordo di ciò che hai fatto per me». Perché non dovrei provare a rendere migliori uomini simili, nell’interesse loro e nel mio? Se mi sarà possibile gli impedirò di peccare, di commettere una colpa e in particolare di commetterla contro di me, se si tratta di persone amiche. Darò a chi me lo chiede un altro beneficio, facendo in modo che non sia ingrato con me, e non gli rinfaccerò quello fattogli in precedenza ma glielo ricorderò con la massima delicatezza per dargli la possibilità di dimostrare la sua riconoscenza, e a mia volta gli chiederò un beneficio, così capirà da sé che gli chiedo un contraccambio. Oppure farò ricorso a parole un po’ più dure nella speranza che
egli possa correggersi, se invece è irrecuperabile proprio per questo motivo non lo esaspererò, per non mutarlo da ingrato in nemico. Se infatti togliamo agli ingrati anche la vergogna di un rimprovero li rendiamo ancora più pigri nel ricambiare i benefìci, e quelli che potrebbero guarire e diventare buoni dietro la spinta del rimorso si perderebbero solo perché noi non gli abbiamo mosso alcuna nota di biasimo, quando al rimprovero ricorrono anche il padre per correggere il figlio, la moglie per ricondurre a sé il marito e l’amico per rinsaldare un’amicizia che cominciava a languire. 23. Alcuni per svegliarsi non hanno bisogno di essere percossi, basta solo scuoterli; analogamente in certuni la volontà di ricambiare non scompare, si indebolisce: scuotiamola, dunque. Non trasformare il tuo dono in un’offesa, perché mi offendi se il contraccambio non lo chiedi col proposito di fare di me un ingrato. «E se io ignoro i tuoi desideri? E se, preso dalle mie occupazioni e sollecitato da altre cose, non ho potuto cogliere l’occasione? Dimmi cosa posso fare e ciò che vuoi. Perché disperi prima di tentare? Perché ti affretti a perdere sia il beneficio che l’amico? Come fai a sapere se non voglio o se non so, se mi manca l’intenzione o la possibilità? Prova!». Io dunque lo ammonirò, non pubblicamente, senza asprezza e senza biasimo, in modo che egli pensi di essersene ricordato lui stesso, senza la spinta di alcuno. 24. Uno dei veterani di Cesare, piuttosto violento nei confronti dei suoi vicini, si difendeva di fronte al divo Giulio in una situazione davvero imbarazzante. «Ricordi, generale», gli domandò, «che in Spagna ti slogasti una caviglia nei pressi di Sucrone?». Avendo Cesare risposto che si ricordava, quello aggiunse: «Ricordi che, volendo riposare sotto un albero che faceva pochissima ombra e che spuntava, unico, dalle rocce aguzze, sotto un sole cocente e in un terreno arido, uno dei tuoi commilitoni ti stese sopra il suo mantello?». «Perché non dovrei ricordarmene?», rispose Cesare. «Ricordo anche che, spossato dalla sete, perché non ce la facevo a camminare fino alla sorgente più vicina, mi sarei trascinato carponi se un buon commilitone, uomo forte e valoroso, non mi avesse portato un po’ d’acqua nel suo elmo». Al che il veterano: «Allora, generale, potresti riconoscere quell’uomo o quell’elmo?». Cesare rispose che non avrebbe saputo riconoscere l’elmo, ma l’uomo sicuramente, quindi, arrabbiato perché distratto in pieno processo da quella vecchia storia, aggiunse: «Comunque, quell’uomo non sei tu». E il veterano: «Hai ragione di non riconoscermi, perché quando ciò accadde il mio corpo era integro, poi a Munda persi un occhio e fui ferito alla testa. E non riconosceresti neppure l’elmo, se lo vedessi: una spada spagnola l’ha diviso a metà». Cesare allora ordinò di non creare difficoltà al suo veterano e gli donò quei campicelli attraverso i quali passava la strada comune che era stata il motivo della lite. 25. E che, dunque? Quell’uomo non avrebbe dovuto chiedere il
contraccambio del beneficio fatto al suo generale, che dopo tanti eventi si era dimenticato di lui e che allestendo a sua grande fortuna interi eserciti non poteva star dietro a ogni singolo soldato? Questo non è chiedere il contraccambio di un beneficio, è riprenderselo dal luogo in cui fu collocato sì che bastasse allungare la mano per recuperarlo. In questo caso, quindi, io lo pretenderò, o perché costretto da un’assoluta necessità o per il bene di colui al quale lo richiederò. Tiberio Cesare, agli inizi del suo regno, a un tale che gli aveva detto «Ti ricordi…», prima che quello finisse la domanda aggiungendo particolari della loro antica familiarità, replicò: «Non mi ricordo che cosa sono stato». Era forse il caso di chiedere il contraccambio di un beneficio a un uomo simile? Era piuttosto da desiderare che dimenticasse, visto che detestava qualunque rapporto con amici e coetanei e voleva che si guardasse solo la sua condizione presente, che si pensasse solo a quella e si parlasse soltanto di quella: ogni vecchio amico era per lui una spia. Bisogna stare più attenti a scegliere il momento opportuno per chiedere il contraccambio di un beneficio che non il beneficio stesso. Bisogna parlare con moderazione affinché l’ingrato non possa offendersi per alcun motivo. Se vivessimo fra persone sagge dovremmo tacere e aspettare; benché sia meglio rivelare anche ai saggi ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra situazione. Agli dèi, che sanno tutto, rivolgiamo delle richieste, ma le nostre preghiere, lungi dal convincerli a far cose che hanno già stabilito, servono a far sì che si ricordino di noi: anche quel famoso sacerdote di Omero rivolgendosi agli dèi dà importanza agli uffici da lui svolti e agli altari devotamente venerati. Voler essere consigliati e poterlo essere è virtù secondaria. A un cavallo docile e che ubbidisce facilmente basta un leggero movimento delle briglie per essere diretto. Solo pochi hanno come miglior guida il proprio animo; dopo di loro vengono quelli che tornano sulla retta via grazie a un avvertimento, e questi non possono mai restare senza una guida. Anche negli occhi chiusi c’è la facoltà visiva, ma non in atto: è la luce del giorno che penetrando in essi gli fa svolgere la loro funzione; gli strumenti restano inerti se l’artista non li utilizza per la sua opera. Negli animi talvolta c’è la buona volontà, ma questa si intorpidisce ora per i piaceri e l’inerzia, ora per l’ignoranza del dovere; noi dobbiamo renderla attiva, non lasciarla difettosa sotto la spinta dell’ira, e come i maestri di giovani discepoli dobbiamo sopportare con pazienza i colpi della memoria che vacilla; come, suggerendo una parola determinata, si fa tornare in mente il testo del discorso da pronunciare, così con un ammonimento si deve ricordare il dovere di essere riconoscenti.
1. Il pancrazio era una prova costituita da lotta e pugilato insieme, il cesto il pugilato con le mani e i polsi avvolti in strisce di cuoio appesantite con piombo.
2. Per gli stoici la felicità consiste nel vivere secondo natura, per i peripatetici nella attività dell’anima secondo ragione. 3. Cleante è il successore di Zenone alla guida della scuola stoica. 4. Ovidio, Metamorfosi, I 144-146. 5. Coriolano è un personaggio leggendario dell’antica Roma: patrizio e contrario alla libertà dei plebei, si rifugiò tra i Volsci, che convinse a muovere guerra contro i Romani, ma la madre e la moglie riuscirono a farlo desistere dal suo proposito. 6. Lucio Sergio Catilina, fautore di Silla, escluso dal consolato, occupato dai plebei, ordì una congiura coi patrizi e parte delle popolazioni italiche, sventata da Cicerone. 7. Gaio Mario era un plebeo: partecipò come semplice soldato all’assedio di Numanzia, distintosi in Spagna, fu eletto console e prese il posto di Metello al comando delle truppe africane. Nel 102 e nel 101 sconfisse i Teutoni e i Cimbri. Rivale di Silla, nella guerra civile che ne nacque, entrò in Roma, compiendo una strage. 8. Lucio Cornelio Silla (138-78 a.C.), capo della spedizione contro Mitridate, ricevuto l’ordine di abbandonare l’esercito, marciò su Roma con le sue legioni dando inizio alla prima guerra civile. Instaurata la dittatura, compilò le famose liste di proscrizione. 9. Gneo Pompeo Magno iniziò la vita militare a diciassette anni, seguendo il padre in varie campagne. Nel 70 fu eletto console con Crasso. Riportò tre trionfi, in Spagna su Sertorio, sui pirati e su Mitridate. 10. Giulio Cesare (102-44 a.C.), console nel 59, nel 58 assunse il comando delle truppe nelle Gallie, quindi compì una spedizione contro i Germani, una in Britannia e un’altra in Gallia per domare la rivolta di Vercingetorige. Nel 49 tornò in Italia entrando in Roma. Nel 48 sconfisse a Farsalo Pompeo. 11. Marco Antonio, eletto tribuno della plebe nel 50, fu uno dei più strenui difensori di Cesare, con cui fu eletto console nel 44. Nel 43 costituì con Ottaviano e Lepido il secondo triumvirato. 12. Publio Rutilio Rufo, politico, giurista e storico romano, fu legatus proconsulis in Asia. Accusato di concussione, nonostante fosse innocente, fu condannato all’esilio. 13. Virgilio, Eneide, IV 653. 14. Il sorite è il termine della logica formale che dà inizio al sofisma del “mucchio”, secondo cui nessuno dei granelli forma il mucchio. In seguito il termine passò a indicare il sillogismo con più di una premessa, cioè un “mucchio” di sillogismi.
Libro sesto 1. Mio Liberale, ottimo fra gli uomini, alcune cose si ricercano esclusivamente per esercitare l’ingegno, e restano sempre fuori della vita, altre sono per noi fonte di piacere mentre le ricerchiamo e utili dopo la loro soluzione. Di queste ti parlerò abbondantemente, tu dimmi, in base a quel che ti sembra opportuno, se vanno trattate estesamente o presentate come si fa col programma di uno spettacolo. Se mai riterrai che si debba passare subito oltre non avremo perso del tempo perché torna utile conoscere anche ciò che è superfluo studiare a fondo. Mi atterrò, dunque, all’espressione del tuo volto: a seconda di come mi consiglierà, mi soffermerò più a lungo su alcuni argomenti, altri li eliminerò o li porterò subito a termine. 2. Ci siamo chiesti se un beneficio possa esserci tolto. Alcuni sostengono che è impossibile, poiché si tratta di un’azione, non di una cosa: altro, infatti, è il dono, altro l’atto di donare, altro il navigante, altro la navigazione, e come ammalato e malattia non sono la stessa cosa, benché l’ammalato abbia una malattia, così una cosa è il beneficio in sé, un’altra è ciò che ci perviene in virtù del beneficio. Il quale, non ha un corpo in sé e non può essere annullato, mentre la sua materia si sposta di qua e di là e cambia padrone. Pertanto quando porti via la materia non porti via la cosa in sé. La natura stessa non può riprendersi ciò che ha dato, può interrompere i suoi benefìci ma non li annulla: però chi muore è vissuto, chi perde la vista l’ha avuta. Quando una cosa è arrivata in nostro possesso, può accadere che non lo sia più, ma non che non l’abbiamo posseduta: una parte dei benefìci, anzi, la parte più autentica, è quella che è stata. Talvolta ci viene impedito l’uso duraturo del beneficio, ma il beneficio in sé non viene distrutto. La natura anche se cercasse di eliminarlo con tutte le sue forze non potrebbe tornare indietro: si può cancellare la casa, il denaro, lo schiavo e tutto ciò a cui è legato il nome di beneficio, ma il beneficio in sé è stabile e senza mutamento: nessuna forza potrà far sì che l’uno non l’abbia dato e l’altro non l’abbia ricevuto. 3. A me sembrano parole bellissime quelle pronunciate da Marco Antonio in un verso del poeta Rabirio,1 quando vede che la fortuna passa da lui ad altri e che ormai gli resta solo la facoltà di morire, ma anche questa a condizione che la sfrutti immediatamente: «Ho quello che ho donato». Quante cose avrebbe potuto avere, se avesse voluto! Sono queste le ricchezze sicure, destinate a restare nelle alterne vicende della condizione umana; e quanto maggiori diventeranno, tanto minore sarà l’invidia che susciteranno. È inutile che cerchi di risparmiare, come se queste cose fossero tue: tu non ne sei che l’amministratore. Tutto ciò che vi gonfia d’orgoglio e vi innalza al di sopra dell’umanità, vi fa dimenticare la
vostra fragilità: queste cose che custodite armati dietro sbarre di ferro, queste cose che avete rubato spargendo sangue altrui e che difendete col vostro, queste cose che vi spingono ad allestire delle flotte che insanguineranno i mari, queste cose per le quali devastate le città, senza sapere con quanti colpi la fortuna vi assalirà alle spalle, queste cose per le quali, spezzati tante volte i vincoli di parentela, di amicizia, di società, tutto il pianeta fu diviso fra due contendenti, non sono vostre. Le avete in deposito e aspettano da un momento all’altro un nuovo padrone, o un nemico o un erede con un animo da nemico se ne impossesserà. Ebbene, chiedi come rendere tue queste cose? Donandole. Provvedi perciò alle cose tue e assicurati un possesso certo e inalienabile, così non solo le metterai più al sicuro, ma te ne verrà anche maggior onore. Le altre cose che ammiri, grazie alle quali pensi di essere ricco e potente, finché le possiedi hanno nomi volgari, si chiamano casa, schiavo, soldi: quando le hai donate diventano un beneficio. 4. Si obietterà: «Se tu riconosci che talvolta non siamo debitori di un beneficio nei confronti di chi ce lo ha dato vuol dire che ci è stato portato via». Numerosi sono i motivi per cui smettiamo di essere debitori di un beneficio, non perché ci sia stato portato via, ma perché è stato guastato. Un tale mi ha difeso in un processo, ma ha preso con la violenza mia moglie: non mi ha portato via il beneficio, ma con un’offesa altrettanto grande mi ha liberato dal debito, e se l’offesa supera il bene che mi aveva fatto non solo si annulla la mia riconoscenza, ma mi è anche consentito di vendicarmi e di denunciarlo, visto che l’offesa pesa di più del beneficio: questo dunque non mi viene sottratto, viene sopraffatto. E che? Non ci sono padri così severi e scellerati che le leggi divine e umane autorizzano ad abbandonare e a rinnegare? Hanno forse tolto quel che avevano dato? Assolutamente no, ma l’empietà dimostrata in seguito ha annullato il valore dei loro precedenti servigi. Non viene tolto il beneficio, viene tolta la riconoscenza per il beneficio, con la conseguenza non che io non abbia più il beneficio, ma che io non sia più in debito per esso. Come se un tale da una parte mi prestasse del denaro, dall’altra mi incendiasse la casa: il prestito è compensato dal danno e, pur non avendogli restituito nulla, io non ho più alcun debito con lui. Analogamente, anche chi prima è stato con me benevolo e generoso, ma poi superbo, offensivo e brutale, mi ha messo in condizione di ritenermi libero nei suoi confronti, come se non avessi ricevuto nulla da lui: ha tolto efficacia ai suoi benefìci. Uno, anche se ha stipulato un contratto con un contadino, non può continuare a pagarlo se gli calpesta le messi e gli taglia gli alberi, perché il contadino stesso si è comportato in modo da non meritare più il compenso pattuito. Così non di rado il creditore è condannato a vantaggio del debitore, quando gli ha portato via più di quanto gli ha chiesto per il prestito concessogli. Spesso un giudice, non soltanto fra creditori e debitori, esclama: «Gli hai prestato del denaro. E con ciò? Gli hai portato via il bestiame, gli hai ucciso uno schiavo, ti sei preso la sua argenteria senza averla acquistata: a conti
fatti, tu che eri venuto in qualità di creditore te ne vai in qualità di debitore». Anche tra benefìci e offese si ragiona così. Spesso, voglio dire, il beneficio rimane, ma non il debito: se chi lo ha dato poi se ne è pentito, se si considera infelice per averlo dato, se mentre lo dava sospirava, corrugava la fronte, credeva di perdere invece di donare, se ha dato per il proprio vantaggio o comunque non per il mio, se non smette di maltrattarmi, di gloriarsi, di vantarsi dovunque sì da rendere amaro il suo dono, il beneficio resta, ma il debito se ne va; come accade con certe somme di denaro: se la giustizia non si pronuncia a favore del creditore, esse sono dovute, ma non sono esigibili. 5. Uno mi ha dato un beneficio, poi mi ha fatto un torto: al beneficio si doveva riconoscenza, al torto vendetta, ma io non sono tenuto a dimostrargli riconoscenza, lui non è tenuto a riparare al torto: le due cose si compensano vicendevolmente. Quando diciamo «Gli ho restituito il beneficio» intendiamo dire non che gli abbiamo restituito ciò che avevamo ricevuto da lui, ma che gli abbiamo dato in cambio qualcos’altro. In questo caso, infatti, restituire significa dare una cosa in cambio di un’altra, così come un pagamento consiste non nel restituire la medesima cosa, ma l’equivalente: si dice che si è restituita una somma di denaro anche se il rimborso è avvenuto in monete d’oro mentre il prestito è stato effettuato in monete d’argento, o se non sono stati restituiti dei soldi, ma il debito è stato estinto in altro modo attraverso una delega. Mi sembra che tu dica: «Sprechi fatica: a cosa mi serve sapere se rimane un beneficio che non mi obbliga più alla riconoscenza? Queste sono sottigliezze e cavilli da giureconsulti, i quali sostengono che non si possono acquisire per usucapione i beni che fanno parte dell’eredità, come se l’eredità fosse qualcosa di diverso dai beni che la compongono! Spiegami piuttosto questo caso, che potrebbe avere a che fare con quello sopra accennato: quando una medesima persona mi ha fatto del bene e successivamente mi ha fatto un torto, devo ricambiare il beneficio e al tempo stesso vendicarmi, contraccambiare l’uno e l’altro separatamente come due cose distinte, oppure devo ritenere che l’uno compensi l’altro e non preoccuparmene più, dato che il beneficio è annullato dall’offesa e l’offesa dal beneficio? La prima interpretazione è quella che vedo adottata nei nostri tribunali (quale sia quella della vostra scuola lo sapete voi), cioè si separano i due processi, quello in cui accusiamo e quello in cui siamo accusati, senza fonderli in un’unica azione giudiziaria: se qualcuno mi ha lasciato in deposito del denaro e in seguito mi ha derubato, io lo querelerò per furto e lui querelerà me per mancata restituzione del deposito». 6. I casi che mi hai proposto, o Liberale, sono contemplati da leggi precise, che bisogna seguire. Una legge non si mescola a un’altra, ciascuna va per la sua strada; il deposito ha una propria azione legale, perbacco, così come il furto. Il beneficio, invece, non è soggetto ad alcuna legge, l’arbitro sono solo io, che ho il diritto di mettere a confronto l’entità del giovamento e del danno arrecatimi e di
giudicare se è più quello che mi è dovuto o quello che devo io. Nelle leggi non possiamo agire di testa nostra, dobbiamo andare dove esse ci conducono, mentre nel beneficio tutto è in potere del singolo, è lui a giudicare. Perciò io non separo e non distinguo le cose, ma rimetto a uno stesso giudice sia i torti che i benefìci, altrimenti è come se tu mi ordinassi di amare e di odiare nello stesso tempo, di lamentarmi e di ringraziare, cosa che la natura non consente. Piuttosto, una volta messi a confronto benefìci e torti, vedrò se mi si deve ancora qualcosa. Come nel sovrapporre altre righe a quelle già scritte non si toglie quel che c’era prima ma lo si nasconde, così un’offesa che si sovrappone a un beneficio lo rende invisibile. 7. Il tuo volto, che ho preso come guida, si aggrotta e corruga la fronte quasi che io mi allontanassi troppo dall’argomento. Sento che mi dici: Perché devii verso destra? Resta qui, vicino alla riva.2 Non posso far di più, quindi, se pensi che questo punto sia stato esaminato abbastanza, vediamo se siamo in debito anche verso chi ci ha fatto del bene involontariamente. Se la frase non fosse più complessa avrei potuto formulare questo argomento con maggiore precisione in modo da mostrare che le questioni sono due: se siamo in debito nei confronti di chi ci ha fatto del bene senza volerlo e se lo siamo anche verso chi ci ha fatto del bene senza saperlo. Ora, che non siamo in debito con chi ci ha fatto del bene perché costretto è così evidente che non vale la pena di spenderci delle parole. Sia questo caso, sia gli altri simili che possono essere addotti si risolvono facilmente se ogni volta teniamo presente questo principio: non esiste beneficio in primo luogo se non c’è l’intenzione di darlo, in secondo luogo se l’intenzione non è amichevole e benevola. Dunque non siamo riconoscenti ai fiumi, benché essi consentano la navigazione a grandi imbarcazioni e, scorrendo in un alveo largo e perenne, permettano di trasportare merci o scorrano, pescosi e ridenti, attraverso pingui campi: nessuno crede di essere in debito verso il Nilo se straripa, così come non lo odia se le sue inondazioni sono state eccessive e le acque hanno tardato a ritirarsi. Neppure il vento ci dà un beneficio, anche se soffia dolce e favorevole, né il cibo, anche se è utile e salutare, poiché, come accennato, per essere un benefattore bisogna non solo fare del bene ma anche volerlo. Di conseguenza non abbiamo alcun debito verso gli animali, anche se un cavallo correndo ha sottratto al pericolo molte persone, né verso gli alberi, anche se l’ombra delle fronde ha ristorato molti affaticati dal caldo. Ebbene, che differenza c’è se a giovarmi è qualcuno che non sa di giovarmi o qualcuno che non ha potuto saperlo, dato che a entrambi è mancata la volontà? Che differenza c’è fra il debito verso una nave, un carro o un giavellotto o verso una persona che non ha avuto l’intenzione di farmi del bene, ma mi ha giovato per caso?
8. Può accadere di ricevere un beneficio senza saperlo, ma non di riceverlo da qualcuno che non sa di farlo. Ci sono casi fortuiti che guariscono molte persone, ma non per questo sono considerati dei rimedi: per alcuni l’essere caduti in un fiume è stato, grazie al gran freddo, causa di guarigione; ad altri la fustigazione ha fatto passare la febbre quartana, a certi uno spavento improvviso, per il sopraggiungere di un altro pensiero, ha fatto passare il momento che temeva, ma non per questo qualcuna di queste cose è salutare in sé anche se ha ridato la salute. Allo stesso modo, alcuni ci fanno del bene pur senza volerlo, anzi proprio perché non vogliono, ma non per questo siamo in debito verso di loro, perché è stato il caso a volgere al meglio i loro propositi che avrebbero potuto nuocerci. O pensi che io sia in debito verso uno la cui mano, cercando di colpire me, ha colpito il mio nemico e quindi mi avrebbe fatto del male se non avesse sbagliato? Spesso un testimone, spergiurando in modo evidente, ha tolto credibilità anche a testimoni sinceri facendo apparire il colpevole degno di compassione, quale vittima di una congiura. Qualcuno ha tratto un vantaggio proprio dalla cerchia di potenti che lo accusava, quando i giudici, che l’avrebbero condannato se si fossero attenuti alla causa, non l’hanno fatto per non sembrare di aver ceduto alle pressioni di quelli. Non per questo essi sono i benefattori dell’accusato, anche se gli hanno fatto un favore, perché si deve badare al bersaglio a cui il dardo era diretto, non dove è andato a finire, e perché non l’esito ma l’intenzione è ciò che distingue un beneficio da un torto. Se un mio avversario, rilasciando dichiarazioni contraddittorie, offendendo il giudice con la sua superbia e fondando tutta la sua difesa su un unico testimone, ha contribuito alla mia vittoria nel processo, io non guardo se il suo errore mi ha giovato: egli voleva nuocermi. 9. È evidente che io, per dimostrarmi riconoscente, devo avere le stesse intenzioni che ha avuto chi mi ha fatto del bene. Quale ingiustizia maggiore di quella di un uomo che odia chi, pressato dalla folla, gli ha schiacciato un piede, lo ha infangato o gli ha dato involontariamente una spinta? Eppure, costui con quale scusa può sottrarsi alle lagnanze dell’altro, quando di fatto c’è stata l’offesa, se non dicendo che non sapeva quel che faceva? Un medesimo caso fa sì che da una parte non ci sia stato il beneficio e dall’altra l’offesa: è la volontà che rende amici o nemici. Quanti hanno evitato il servizio militare grazie a una malattia! Quanti sono sfuggiti al crollo della loro casa per un mandato di comparizione inviatogli da un avversario! Alcuni, grazie a un naufragio, non sono caduti nelle mani dei pirati. Tuttavia non siamo in debito di un beneficio a queste circostanze, perché al caso è estraneo il senso del dovere, e non siamo in debito neppure al nemico, anche se la controversia con lui ci ha salvato, provocandoci tribolazioni e perdita di tempo. Non c’è beneficio se non proviene dalla buona volontà e se il suo autore non lo riconosce per tale. Uno mi ha fatto del bene senza saperlo? Non gli devo nulla.
Mi ha fatto del bene senza volerlo? Non gli devo nulla. Mi ha fatto del bene, ma volendo farmi del male? Gli renderò pan per focaccia. 10. Torniamo al primo caso. Vuoi che io faccia qualcosa per dimostrare la mia riconoscenza a uno che non ha agito per farmi del bene? Passiamo al secondo caso. Vuoi che io dimostri la mia riconoscenza ricambiando volontariamente ciò che ho ricevuto da lui senza che lui lo volesse? E che dire del terzo caso, in cui dall’offesa si è passati al beneficio? A rendermi tuo debitore non basta che il beneficio tu abbia voluto darmelo; perché io non ti sia debitore di un beneficio è sufficiente che tu non abbia voluto darmelo. La nuda volontà, infatti, non dà origine al beneficio; ma, come non ci sarebbe beneficio se alla volontà migliore e più perfetta fosse poi mancata la fortuna, così non c’è beneficio se la volontà non precede la fortuna; perché io sia in debito nei tuoi confronti, infatti, non occorre semplicemente che tu mi abbia fatto del bene, bisogna che tu me lo abbia fatto di proposito. 11. Cleante si serve di un esempio di questo genere: «Ho mandato due ragazzi a cercare Platone per condurlo qui dall’Accademia; uno ha perlustrato accuratamente tutto il portico, è andato in tutti gli altri posti in cui sperava di poterlo trovare ed è tornato a casa stanco e senza alcun risultato; l’altro si è fermato davanti al primo ciarlatano che ha incontrato e mentre se ne andava in giro insieme ad altri schiavetti e giocava, ha visto passare Platone senza neppure averlo cercato. Ebbene», dice Cleante, «noi loderemo quel ragazzo che, per quanto gli è stato possibile, ha fatto ciò che gli era stato ordinato, e puniremo invece quell’altro, che è stato fortunato senza far nulla». È la volontà che ci rende debitori, questa è la condizione perché io contragga un debito di riconoscenza. Non basta che uno voglia farmi del bene, quando poi non me lo fa, non basta che uno mi faccia del bene, quando non voleva farmelo. Supponi che un tale voglia farmi un dono ma non me lo faccia: io ho sì la sua intenzione, ma non il beneficio, il quale è completo solo se all’intenzione si aggiunge l’azione. Come a uno che voleva prestarmi del denaro ma non me l’ha prestato io non devo nulla, così anche con chi voleva farmi del bene ma non ha potuto farmelo, pur se gli resto amico, non sono in debito. E se anch’io vorrò fare qualcosa per lui (come lui lo voleva per me), e però, essendo più fortunato di lui, glielo farò, questo sarà un beneficio, non un gesto di riconoscenza. Sarà lui a essere in debito nei miei confronti: questo sarà l’inizio, si comincerà a contare partendo da me. 12. Non c’è bisogno che parli, so già cosa vuoi chiedermi: me lo dice il tuo volto. «Se uno ci ha fatto del bene per il suo interesse gli dobbiamo lo stesso qualcosa?». Spesso, infatti, ti lamenti che gli uomini mettano in conto agli altri cose che invece giovano a loro stessi. Ti risponderò, caro Liberale, ma prima dividerò in due parti questa piccola questione, separando il giusto dall’ingiusto. C’è una grande differenza se qualcuno ci dà un beneficio per giovare solo a sé
stesso o anche a sé stesso. Chi bada esclusivamente a sé stesso, e ci fa del bene perché altrimenti non potrebbe giovare a sé stesso, lo considero uguale a colui che procura al bestiame il pascolo invernale e quello estivo, a colui che nutre i suoi prigionieri per venderli più facilmente e li ingrassa e li liscia come buoi ben pasciuti, o all’addestratore dei gladiatori che con gran cura esercita e adorna i suoi uomini. Come dice Cleante, c’è una bella differenza tra un beneficio e un affare. 13. Al contrario, non sono tanto ingiusto da non sentirmi in debito verso chi, rendendo un servigio a me, lo ha reso anche a sé stesso: non pretendo che egli si prenda cura di me senza alcuna considerazione per sé, anzi, desidero che il beneficio fatto a me giovi ancor più a chi me lo fa, purché egli lo faccia pensando a entrambi, dividendolo fra me e lui. Anche se avrà una parte maggiore della mia, se comunque me ne ha reso partecipe, se ha pensato a tutti e due, sarei ingrato, non solo ingiusto, se non mi rallegrassi perché ciò che ha giovato a me ha giovato anche a lui. È indizio di grandissima cattiveria non chiamare beneficio ciò che ha recato qualche svantaggio al suo autore. A quell’altro, invece, che mi fa del bene solo nel proprio interesse, risponderò: «Ti sei servito di me: perché dici che sei stato tu a farmi del bene e non che sono stato io a farlo a te?». Mettiamo che io non possa diventare magistrato se non dopo aver riscattato dieci cittadini dall’ingente numero dei prigionieri: tu non sarai per nulla in debito con me, dopo che io ti ho liberato dalla schiavitù e dalle catene? Eppure, io l’ho fatto nel mio interesse. Ebbene, a questa obiezione risponderò così: in questo caso tu fai un po’ il tuo interesse e un po’ il mio: fai il tuo perché riscatti dei cittadini, fai il mio perché riscatti me; infatti per il tuo interesse sarebbe stato sufficiente riscattare una persona qualsiasi, dunque io sono in debito con te non perché mi riscatti ma perché scegli me, dato che avresti potuto ottenere lo stesso risultato riscattando un altro al posto mio. Tu dividi con me l’utilità della tua azione e mi inserisci in un beneficio che gioverà a due persone. Preferisci me agli altri, e ciò lo fai esclusivamente per me. Quindi se il riscatto di dieci prigionieri avesse potuto farti diventare pretore, e però i prigionieri disponibili fossero stati in tutto soltanto dieci, nessuno di noi sarebbe in debito con te, perché tu non avresti da metterci in conto nient’altro che il tuo interesse. Non c’è invidia nella mia valutazione del beneficio, né desiderio che il beneficio venga dato solo a me, ma che venga dato “anche” a me. 14. «E che?», si obietterà. «Se io avessi fatto estrarre i nomi a sorte e il tuo fosse uscito tra quelli da riscattare, non mi saresti debitore di nulla?». Sì che lo sarei, ma di poco, e ti dirò di quanto. In questo caso tu hai agito anche nel mio interesse, perché mi hai fatto tentare la sorte di essere riscattato: che sia uscito il mio nome, lo devo alla sorte, che sia potuto uscire, lo devo a te. Mi hai permesso di partecipare al tuo beneficio, del quale per la maggior parte sono debitore alla fortuna, ma sono debitore a te della possibilità di essere debitore alla fortuna.
Non parlerò affatto di coloro il cui beneficio è mercenario, perché quando lo dànno pensano non al destinatario ma al prezzo che ne ricavano: è un beneficio diretto esclusivamente a loro stessi. Uno mi vende del frumento: se non lo compro non posso vivere, ma non gli sono debitore della vita per averlo comprato da lui. Io non bado a quanto mi sia stato necessario ciò senza cui non sarei potuto vivere, guardo a quanto poca gratitudine meriti ciò che non avrei potuto avere se non l’avessi comprato, perché il mercante, che ha richiesto quel frumento per venderlo, non ha pensato a quanto aiuto mi avrebbe dato, ma a quanto avrebbe guadagnato. Dunque non sono in debito per averlo comprato. 15. «Ma così tu affermi che al medico non si è debitori di nulla, o comunque che gli si deve poco, come al precettore, dal momento che gli si è dato del denaro, e tuttavia per questo genere di persone abbiamo grande amore e stima». A questa obiezione posso risponderti che certe cose hanno un prezzo superiore a quello che si paga. Dal medico si compra una cosa di valore inestimabile, la vita e la salute, dall’insegnante di arti liberali la cultura letteraria e la finezza d’animo; perciò a costoro tu non paghi il prezzo della cosa, paghi quello del loro lavoro, perché ci rendono un servigio, perché ci dedicano del tempo che sottraggono ai loro affari: essi ricevono la ricompensa non del loro merito, ma della loro attività. Ma si potrebbe dare una risposta più veritiera, che ti esporrò dopo aver mostrato come si possa confutare questa affermazione. Si dice: «Certe cose valgono più del prezzo pagato e proprio per questo, pur avendole comprate, si deve qualcosa in più». Prima di tutto che importanza ha quanto valgano in effetti, una volta che l’acquirente e il venditore si sono messi d’accordo sul prezzo? E poi, io ho comprato quella cosa in base non al suo valore, ma al prezzo stabilito da te. «Vale più del suo prezzo di vendita», tu dici. Ma non saresti riuscito a venderla a un prezzo maggiore. Il prezzo di una cosa dipende sempre dalle circostanze; per quanto tu l’abbia esaltata, c’è un prezzo al di sopra del quale non potrebbe essere venduta; inoltre, chi compra a buon mercato non deve nulla al venditore. E poi, anche se certe cose valgono di più, non per questo si tratta di un dono da parte del venditore, dato che il prezzo è stabilito non sulla sua effettiva utilità, ma in base alla consuetudine e all’andamento del mercato. Che prezzo dài a chi attraversa i mari e in mezzo ai flutti, quando la terra si è ormai allontanata dalla vista, sceglie una rotta sicura e, prevedendo il sopraggiungere delle tempeste, mentre tutti se ne stanno tranquilli, ordina improvvisamente di ammainare le vele, di calare le antenne e di tenersi pronti ad affrontare la tempesta e il suo violento assalto? Eppure, col solo prezzo del trasporto si paga un’opera così importante. Che prezzo dài a un rifugio nel deserto, a un tetto quando piove, a un bagno caldo o a un fuoco quando fa freddo? Eppure, io lo so a quale prezzo avrò queste cose, entrando in un albergo. Quale servizio ci rende colui che puntella la nostra casa cadente e con la sua straordinaria abilità riesce a mantenere in piedi un edificio che ha crepe profonde! Eppure, questi lavori di sostegno si fanno a un prezzo fisso e non alto.
Un muro ci difende dai nemici e dalle improvvise incursioni dei briganti; tuttavia si sa bene quanto guadagni al giorno un operaio che erige quelle torri che saranno il baluardo dell’incolumità pubblica. 16. Non si finirebbe mai se si volessero elencare altri esempi che testimonino come grandi servigi vengano pagati poco. E allora? Il motivo per cui al medico e al precettore siamo debitori di qualcosa in più e pagandoli non estinguiamo il nostro debito? Perché da medico e da precettore si trasformano in amici e noi siamo in debito verso di loro non per le loro prestazioni, ma per la loro disposizione d’animo benevola e affettuosa. Se il medico non fa nient’altro che tastarmi il polso e mi considera uno dei tanti pazienti che visita, prescrivendomi freddamente ciò che devo fare e ciò che devo evitare, non gli sono debitore di nulla, perché mi vede non come un amico, ma come un cliente. E non ho motivo per venerare neppure il mio precettore se mi considera uno fra i suoi numerosi discepoli, se non mostra per me un’attenzione specifica e particolare, se non si cura personalmente di me, né io posso dire di apprendere la scienza direttamente da lui, poiché la trasmette alla massa, sicché in definitiva è come se io l’afferrassi di passaggio. Perché, dunque, dobbiamo essere tanto debitori a costoro? Non perché ciò che ci hanno venduto vale più del prezzo che abbiamo pagato ma perché hanno fatto qualcosa per noi personalmente: il medico si è curato di noi più di quanto sia doveroso per un medico, ha avuto timore non per la sua reputazione in qualità di medico, ma per me, non si è accontentato di indicarmi i rimedi, ma me li ha anche applicati, è stato uno di coloro che mi hanno assistito, è accorso nei momenti critici, nessun servizio gli è pesato o gli ha dato fastidio, si è preoccupato nel sentire i miei lamenti, nella folla di persone che lo invocavano io sono stato oggetto particolare delle sue cure, si è dedicato agli altri solo nel tempo lasciatogli libero dalle mie condizioni di salute, dunque verso quest’uomo io sono in debito non come verso un medico, ma come verso un amico. La stessa cosa vale per il precettore, che ha sopportato la fatica e la noia di insegnare sempre le medesime nozioni e oltre a quelle che vengono insegnate a tutti me ne ha trasmesse e inculcate altre, e con le sue esortazioni ha stimolato la mia buona indole e ora mi ha incoraggiato con le sue lodi, ora mi ha scosso dall’inerzia con i suoi rimproveri; infine, ha tirato fuori, per così dire, con le sue mani, le mie qualità nascoste e impigrite; e quel che sapeva non me l’ha dispensato a poco a poco, con la cattiva intenzione di rendersi necessario più a lungo, ma ha desiderato versarlo in me tutto in una volta, se fosse stato possibile. Sarei dunque un ingrato se non annoverassi quest’uomo fra i miei più cari amici. 17. Anche a chi compie i mestieri più umili diamo qualcosa in più del prezzo stabilito, quando la sua prestazione ci sembra svolta con particolare zelo; anche al timoniere, al più modesto artigiano e a chi lavora a giornata elargiamo una mancia. Quando si tratta, invece, delle più nobili attività, che conservano o
migliorano la vita, chi pensa di essere in debito solo di quanto ha pattuito è un ingrato. Aggiungi poi che la comunità di conoscenze di questo tipo unisce gli animi. Dopo un simile risultato quel che si paga al medico e al precettore è sì il prezzo della loro prestazione, ma si resta in debito per la loro disposizione d’animo. 18. Platone attraversò un fiume in barca e il traghettatore non gli fece pagare nulla: pensando così di rendere un omaggio alla sua persona, gli disse che restava in debito con lui; subito dopo, però, visto che traghettava, uno dopo l’altro, molti passeggeri, con la stessa premura, gli disse che non era più in debito con lui. Infatti, affinché io sia in debito con te per il favore che mi fai bisogna che tu lo faccia a me in quanto singola persona, non puoi chiedermi conto di ciò che dispensi a una moltitudine indiscriminatamente. E che? Non ti si dovrà nulla per quello che fai? Da me come singolo nulla: estinguerò insieme a tutti gli altri il debito che ho contratto insieme a loro. 19. Si obietterà: «Tu dici dunque che non mi dà alcun beneficio chi mi fa attraversare il Po sulla sua barca senza farsi pagare?». Esatto. Compie una buona azione, ma non mi dà un beneficio perché lo fa o per il proprio interesse o comunque non per il mio; in fondo nemmeno lui pensa di darmi un beneficio, lo fa o per lo Stato o per il vicinato o per la sua ambizione, e dalla sua azione si aspetta qualche vantaggio diverso dal denaro che potrebbe ricevere dai singoli. «Ma come? Se l’imperatore accorda il diritto di cittadinanza a tutti i Galli o l’esenzione dalle imposte agli Spagnoli, essi non avranno alcun debito a titolo personale?». Avranno un debito, ma per la loro partecipazione a un beneficio collettivo, non per un beneficio personale. «L’imperatore», si dice, «non ha pensato affatto a me nel momento in cui giovava a tutti; non ha voluto dare il diritto di cittadinanza a me in particolare, dunque perché dovrei essere in debito verso uno che non pensava a me in particolare quando stava per fare ciò che ha fatto?». Prima di tutto, quando ha deciso di essere utile a tutti i Galli si è proposto di essere utile anche a me, poiché anch’io ero un Gallo e, anche senza un’indicazione speciale per me mi ha però incluso in una lista generale. Poi, io sono in debito verso di lui non per un dono personale, ma per un dono fatto a un popolo intero; essendo un membro del mio popolo, non mi sdebiterò come singolo, ma darò il mio contributo per la mia patria. Se uno fa un prestito alla mia patria non mi definirò suo debitore e non riconoscerò questo debito né come candidato né come accusato; però, darò la mia parte affinché il prestito venga estinto. In questo senso io sostengo di non essere debitore per questo dono che è stato dato a tutti, in quanto è stato dato sì a me, ma non specificatamente per me, e perché è stato dato sì a me, ma da qualcuno che non sapeva di darlo a me; ciò nonostante so di dover pagare anch’io qualcosa, perché dopo un lungo giro è arrivato fino a me. Perché io sia in debito personalmente, bisogna che il dono sia fatto proprio per me.
20. «Allora, in base a questo criterio tu non sei in debito né col sole né con la luna, poiché essi non si muovono per te». Ma dato che si muovono per la conservazione dell’universo si muovono anche per me, in quanto io sono parte dell’universo. Aggiungi poi che la nostra condizione e la loro sono diverse: chi infatti mi fa del bene, ma per giovare a sé stesso attraverso di me, non mi dà un beneficio, perché mi riduce a uno strumento della sua utilità; il sole e la luna, invece, anche se ci giovano per i loro fini, non lo fanno per giovare a sé stessi attraverso di noi, perché quale vantaggio ne hanno? 21. Si ribatte: «Potremmo sapere se il sole e la luna vogliono giovarci solo se avessero la possibilità di non farlo, ma loro devono muoversi per forza. Si fermino, una buona volta, e sospendano la loro attività!». Guarda in quanti modi si può confutare questa affermazione. Il fatto che qualcuno non possa rifiutare non comporta che egli non voglia; la prova migliore di una volontà ben legata ai suoi princìpi è il non poter mutare. L’uomo virtuoso non può non fare quello che fa, poiché se non lo fa non è virtuoso; dunque, neppure l’uomo virtuoso concede un beneficio, visto che fa ciò che deve e non può non fare ciò che deve. C’è poi una grande differenza fra il dire «non può non fare ciò» perché è costretto a farlo e «non può non volere», poiché se per lui è inevitabile farlo, io non sono in debito verso di lui, lo sono verso chi lo costringe a farlo; se, invece, per lui è inevitabile volerlo, perché non c’è niente di meglio che egli possa volere, allora è lui a costringere sé stesso, dunque io sono in debito verso di lui in quanto costringe sé stesso per una cosa per cui non sarei in debito se fosse costretto da un altro. «Smettano pure di volere!», si dirà. Ascolta: chi è così folle da non voler definire volontà quella che non corre il rischio né di venir meno né di volgersi al contrario, quando invece si dovrebbe ritenere autentica solo la volontà di chi l’ha così salda da mantenerla sempre? E se diciamo che c’è volontà anche quando uno potrebbe all’improvviso non volere più, perché non potremmo dirlo quando la natura del soggetto esclude la possibilità di non volere? 22. Si potrebbe dire: «Se possono, si fermino!». Sarebbe come dire: «Tutti questi corpi, separati da immensi spazi e sistemati a custodia dell’universo, abbandonino le loro postazioni; con un improvviso rivolgimento le stelle si scontrino con le stelle e, distrutta l’armonia universale, i corpi celesti crollino e questo apparato velocissimo abbandoni a metà le rivoluzioni che dovrebbero durare nei secoli, e quei corpi che ora vanno è vengono alternativamente e che garantiscono al mondo l’equilibrio attraverso dei contrappesi, siano bruciati da un incendio divampato all’improvviso e il tutto esca da una così grande varietà formando una massa unica; e il fuoco si impossessi di ogni cosa, quindi gli succeda una notte inerte e un abisso senza fondo inghiotta tanti dèi». Vale la pena che si verifichi questa immensa catastrofe solo perché tu sia confutato? Quei
corpi celesti ti giovano anche contro la tua volontà e si muovono per te, anche se hanno qualche altro motivo precedente e più importante. 23. A tutto ciò aggiungi che gli dèi agiscono non in virtù di forze esterne che li costringano a operare così, ma che è la loro stessa volontà eterna che si fa legge. Hanno stabilito un ordine immutabile, perciò non possiamo pensare che facciano qualcosa contro la loro volontà, perché essi hanno voluto continuare a fare tutto ciò che non possono smettere di fare, e gli dèi non si pentono mai delle decisioni che hanno preso. Non c’è dubbio che gli è impossibile fermarsi assumendo una posizione contraria, ma solo perché la loro forza li mantiene saldi in ciò che si sono proposti; non vi rimangono per debolezza, ma perché non gli va di deviare dalla strada migliore e perché è stato stabilito di percorrere quella. Ora, in quella loro prima organizzazione, quando sistemarono tutto, misero in conto anche le cose di noi uomini, dunque non possiamo pensare che essi vadano per la loro strada e operino esclusivamente per sé stessi, perché anche noi siamo parte del loro operato. Perciò siamo debitori di benefìci anche al sole e alla luna e agli altri corpi celesti, perché, anche se essi hanno dei motivi più importanti per sorgere, anche se mirano a fini superiori, tuttavia giovano pure a noi. Aggiungi che gli dèi ci giovano di proposito, e perciò siamo in debito verso di loro, perché abbiamo a che fare con un beneficio non di chi ignorava di darcelo, ma di chi sapeva che l’avremmo ricevuto. E, benché il loro fine sia più alto e il risultato della loro attività sia più importante della conservazione degli esseri mortali, tuttavia fin dall’inizio hanno pensato anche al nostro vantaggio e hanno dato al mondo un ordine tale da far apparire chiaramente che quella per noi non è stata la loro ultima preoccupazione. Noi dobbiamo affetto ai nostri genitori, anche se molti nell’accoppiarsi non hanno intenzione di procreare, ma quanto agli dèi non si può pensare che non sapessero cosa avrebbero prodotto, dal momento che procurarono subito per tutti il nutrimento e in seguito il resto, né possiamo credere che abbiano generato per distrazione degli esseri per i quali hanno prodotto tante cose. La natura, dunque, pensò a noi, prima di crearci, e noi non siamo un’opera di così poco conto da poter essere usciti dalle sue mani per caso. Guarda quante cose ci ha permesso, quanto poco i limiti dell’uomo condizionino il suo dominio, guarda quanto lontano possano avventurarsi dei corpi che la natura non ha rinchiuso entro i confini delle terre, ma ha posto in ogni sua parte; guarda quanto possa osare l’animo, come esso solo possa conoscere, o cercare di conoscere, gli dèi, e come la mente possa arrivare in alto a unirsi alle cose divine: ti renderai conto che l’uomo non è un’opera improvvisata e non meditata. Tra le sue opere più grandi la natura non ha nulla di cui gloriarsi o di cui si glori di più. Che follia è, quindi, contestare agli dèi i doni che ci hanno fatto! Come potrà mostrarsi riconoscente verso gli dèi, ai quali solo attraverso dei sacrifici si può esternare la propria gratitudine, chi dichiara di non aver ricevuto nulla da coloro che
invece gli hanno dato moltissimo, e che continueranno sempre a dare senza mai ricevere nulla in cambio? Che malvagità è il non sentirsi in debito verso qualcuno solo perché è benevolo anche con chi nega di aver ricevuto, e il considerare una lunga e ininterrotta serie di benefìci come la prova che il donatore dona per necessità! «Non lo voglio! Se lo tenga per sé! Chi glielo ha chiesto?». A queste frasi aggiungi tutte le altre che può pronunciare uno sfacciato: non per questo cesserà di essere tuo benefattore uno la cui generosità giunge fino a te anche se tu la neghi, e il cui beneficio è il più grande di tutti, proprio perché te lo concede nonostante le tue lagnanze. 24. Non vedi come i genitori costringano i figli ancora bambini a sopportare dei sacrifici che in seguito daranno i loro frutti? Si prendono cura scrupolosamente del loro corpo, anche se essi piangono o si dibattono, e affinché una libertà prematura non deformi le loro membra, le tengono strette in modo che si sviluppino diritte, gli fanno studiare le arti liberali, minacciando quelli che non vogliono saperne, e piegano con la forza i ribelli che seguono poco la frugalità, la pudicizia e i buoni costumi. Anche con gli adolescenti che sono già padroni di sé stessi, se respingono i rimedi per paura o per insofferenza, si usa la forza e la severità. I benefìci più grandi sono dunque quelli che riceviamo dai genitori, senza saperlo o senza volerlo. 25. Agli ingrati che ripudiano i benefìci non perché non li vogliano, ma per non sentirsi in debito, assomigliano, per l’opposto motivo, quelli che sono troppo riconoscenti, i quali generalmente si augurano che accada qualche disgrazia a coloro con cui sono in debito per potergli dimostrare in quell’occasione i loro sentimenti in ricordo del beneficio ricevuto. Si tratta di vedere se agiscano rettamente e con buone intenzioni. La disposizione d’animo di costoro è molto simile a quella di chi arde di un amore insano e augura alla sua amata l’esilio per poterla accompagnare, la povertà per poterle fare dei doni quando ne ha maggior bisogno, la malattia per poterla assistere, e, pur amandola, desidera per lei tutto ciò che potrebbe desiderare un nemico, talché il risultato dell’odio e dell’amore insano è il medesimo. Uguale è il caso di coloro che augurano ai loro amici delle disgrazie per poterli poi aiutare, che arrivano al beneficio attraverso un’ingiustizia, quando sarebbe meglio non fare nulla piuttosto che cercare l’occasione per fare il bene attraverso un misfatto. Che diresti di un timoniere che chieda agli dèi tempeste violente e burrasche affinché la sua abilità aumenti il suo prestigio grazie a gravissimi pericoli? E se un generale pregasse gli dèi che un esercito nemico grande e forte, circondando gli accampamenti, riempia con un attacco improvviso i fossati, abbatta la palizzata, mettendo in subbuglio tutto l’esercito, e pianti le sue insegne minacciose proprio sulle porte, per poter poi, respingendolo, conseguire una gloria maggiore, prestando soccorso in una situazione compromessa e disperata?
Chi invoca l’intervento degli dèi a danno di uno a cui pur desidera giovare, e vuole che prima sia abbattuto per poterlo poi risollevare, fa prendere al suo beneficio una via detestabile: è una caratteristica disumana, indice di un sentimento perverso di riconoscenza, augurare qualcosa di male alla persona che onestamente non si può non aiutare. 26. Si può obiettare: «Il mio voto non gli nuoce, perché io gli auguro nello stesso tempo un incidente e la guarigione». Con ciò non puoi dire di essere esente da colpe, ne hai di meno che se gli augurassi solo l’incidente. È cattiveria gettare uno in acqua per tirarlo fuori, abbatterlo per risollevarlo, imprigionarlo per liberarlo: non è fare il bene metter fine a un torto e non è un merito liberare da un male che è stato provocato allo scopo di farlo cessare. Preferisco che tu non mi ferisca, piuttosto che guarirmi. Puoi conquistarti la mia riconoscenza se mi guarisci dopo che sono stato ferito, ma non se mi ferisci per potermi poi guarire, anche perché una cicatrice non fa mai piacere, a meno che non la si confronti con una ferita, e benché ci rallegriamo che si sia rimarginata preferiremmo che non ci fosse stata. Se tu l’augurassi a uno da cui non hai ricevuto alcun bene sarebbe un desiderio disumano, ma lo è molto di più se l’auguri a uno col quale sei in debito per un beneficio! 27. «Ma io contemporaneamente prego di potergli prestare aiuto». Innanzitutto se ti colgo a metà del tuo augurio tu sei già un ingrato: io non ho ancora sentito che bene gli vuoi fare, so solo che male vuoi che gli accada. Tu gli auguri preoccupazioni, paure e anche peggio. Desideri che abbia bisogno di aiuto, e questo è a suo danno; desideri che abbia bisogno del tuo aiuto, è questo è a tuo vantaggio. Non vuoi soccorrerlo, insomma, vuoi sdebitarti: ma chi mostra fretta vuole essere già libero, non liberarsi dal suo debito. Così l’unico sentimento che nel tuo augurio sarebbe potuto sembrare onorevole è anch’esso ignobile e ingrato, perché non vuoi essere in debito. Tu, infatti, non vuoi manifestare la tua riconoscenza, ma vuoi che egli abbia bisogno di implorare la tua. Ti consideri superiore e con un gesto empio umili chi ti ha fatto del bene. Quanto sarebbe meglio rimanere in debito con onesta disposizione d’animo, invece di sdebitarsi in modo riprovevole! Se tu negassi di aver ricevuto un beneficio peccheresti di meno, perché il tuo benefattore perderebbe solo quello che ti aveva donato; ora, invece, vuoi mortificarlo, vuoi che per le sue perdite e i rivolgimenti di situazione sia ridotto in condizioni inferiori ai suoi benefìci. E io dovrei ritenerti un uomo riconoscente? Prova a fare questo augurio in presenza di colui al quale vuoi giovare! E lo chiami augurio un voto che può essere diviso fra la riconoscenza e l’odio e che tu attribuiresti senza esitare a un avversario o a un nemico, se si omettesse la seconda parte? Anche il nemico vuole conquistare una città per conservarla e vincere per poi perdonare, ma non per questo non sono ostili tali desideri, nei quali il sentimento più dolce viene dopo la crudeltà. Che razza di
voti sono questi, che chi li riceve desidera meno di qualunque altro che si realizzino? Ti comporti malissimo quando vuoi che uno sia perseguitato dagli dèi per poi essere soccorso da te; ti comporti in modo ingiusto con gli dèi stessi, imponendo loro un ruolo assolutamente crudele e riservando a te quello buono: affinché tu possa fare del bene, gli dèi dovranno fare del male. Se tu gli mandassi un accusatore per poi farlo andar via, se lo trascinassi in qualche lite e la troncassi subito nessuno avrebbe dubbi sulla tua scelleratezza: che differenza c’è se questo tentativo viene attuato con un inganno o con un voto? Solo nel fatto che col voto cerchi per lui avversari più potenti. È inutile che tu dica: «Ma che torto gli faccio?», quando il tuo augurio o è inutile o è dannoso, anzi è dannoso anche se va a vuoto. Tutto ciò che non consegui è un dono degli dèi, tutto ciò che desideri è un torto. Basta: dobbiamo adirarci con te come se il torto glielo avessi fatto. 28. Dici: «Se i voti fossero stati efficaci lo sarebbero stati anche nel garantirti la salvezza». Innanzitutto tu mi auguri un pericolo sicuro a fronte di un aiuto non sicuro. Ma anche ammesso che pericolo e aiuto siano entrambi certi, ciò che nuoce viene prima. E poi, tu conosci le condizioni del tuo augurio, io invece sono stato sorpreso dalla tempesta quando ancora non ero certo che avrei trovato un porto e una protezione. Sai che tormento ho provato nell’attesa di un aiuto, anche se poi l’ho ricevuto? E per aver sperimentato il terrore, anche se poi sono stato salvato? E per essermi dovuto difendere, anche se poi sono stato assolto? La fine di un timore non è mai tanto gradita da non far ritenere preferibile una sicurezza stabile e sicura. Tu puoi desiderare di ricambiare il mio beneficio quando ne avrò bisogno, ma non che io mi trovi ad averne bisogno. Se fosse dipeso da te il male che mi hai augurato, l’avresti fatto tu stesso! 29. Quanto sarebbe più onesto questo augurio: «Desidero che egli sia sempre in grado di elargire benefìci, mai di desiderarne; che disponga sempre dei mezzi materiali, di cui si serve così generosamente per donare e per beneficare; che non sperimenti mai l’impossibilità di fare il bene, né il pentimento per il bene fatto; che la sua indole già naturalmente incline alla compassione, all’umanità e alla clemenza sia stimolata da una folla di persone riconoscenti, che ha avuto la fortuna di incontrare ma che non debba mettere alla prova; che sia pietoso con tutti, ma che non abbia bisogno di muovere a pietà nessuno; che il favore della fortuna si mantenga costante in modo che nessuno possa dimostrargli la propria riconoscenza se non con la sua buona disposizione d’animo». Quanto sono più leali auguri di questo tipo, che non rinviano ad un’altra occasione ma dimostrano subito la riconoscenza! Cosa c’impedisce, infatti, di mostrarci riconoscenti nelle circostanze favorevoli? Quanti mezzi abbiamo per estinguere il nostro debito anche con chi è fortunato! Un consiglio sincero, incontri frequenti, una conversazione affabile e scevra di adulazione, orecchie attente se vuole suggerimenti per prendere una decisione, sicure se vuole
confidarsi, un rapporto amichevole. Il favore della sorte non ha posto nessuno così in alto che non senta la mancanza di un amico, tanto più se non gli manca nulla. 30. L’occasione che ti auguri è funesta, va eliminata dai tuoi voti e respinta ben lontano: c’è bisogno della collera degli dèi perché tu possa dimostrare la tua riconoscenza? E il fatto che ti comporti meglio con colui al quale non sei per nulla grato non ti dimostra che pecchi? Il carcere, le catene, la miseria: sono queste le occasioni che ti auguri; questo è il prezzo che paga chi ha a che fare con te. Perché invece non ti auguri che colui verso il quale sei tanto in debito sia potente e felice? Che cosa t’impedisce di manifestare la tua riconoscenza anche a chi è al culmine della fortuna? Ti si offrirebbero molte e varie occasioni. Non sai che ci si può sdebitare anche coi ricchi? Non ti tratterrò con un gran numero di esempi; ammesso che la ricchezza e la prosperità precludano ogni strada al beneficio, ti farò vedere da quale povertà spirituale siano afflitte le persone di alto rango, che cosa manchi a quelli che possiedono tutto: che qualcuno dica loro la verità, come uno che vedendo un uomo stordito in mezzo alle menzogne che lo circondano e portato a ignorare la verità dall’abitudine di ascoltare cose piacevoli invece che giuste, lo liberi dal complotto e dalla cospirazione degli impostori. Non vedi come la mancanza di libertà e la lealtà trasformatasi in ossequio servile li spingano verso la rovina, quando non v’è chi li consigli o li sconsigli ascoltando la voce della propria coscienza? Si fa a gara nell’adulare e l’unico dovere, l’unica contesa che impegna tutti è quella di ingannare nel modo più affabile. Hanno ignorato le loro vere forze, e, credendosi tanto grandi quanto sentono dire, hanno attirato su di sé guerre inutili con pericolo per tutti, hanno distrutto la concordia, utile e necessaria, hanno ceduto all’ira che nessuno cercava di contrastare, hanno sparso il sangue di molti per versare alla fine anche il loro. Punendo colpe ipotetiche come fossero certe, considerando il lasciarsi commuovere non meno vergognoso che l’essere vinti e credendo perpetuo quel potere che giunto al suo culmine è più precario che mai, hanno fatto crollare immensi regni, e non si sono resi conto che da quando non hanno potuto più ascoltare nulla di vero, su quella scena risplendente di beni vani che si dissolvono rapidamente non devono aspettarsi altro che sventure. 31. Quando Serse3 dichiarò guerra alla Grecia non ci fu una sola persona che non eccitasse l’animo di lui gonfio di superbia e dimentico della caducità di ciò in cui confidava. C’era chi diceva che i Greci non avrebbero retto all’annuncio della guerra e che si sarebbero dati alla fuga alle prime voci del suo arrivo; chi sosteneva che senza alcun dubbio la Grecia sarebbe stata non solo vinta ma distrutta da quella massa di soldati, quando invece si doveva temere che si trovassero città vuote e abbandonate e che non ci sarebbe stato modo di mettere all’opera forze tanto imponenti in quei vasti territori che il nemico, fuggendo, aveva lasciato sgombri e indifesi; altri dicevano che a stento gli sarebbe bastata
la terra intera, che i mari erano troppo stretti per la sua flotta, esigui gli accampamenti per i suoi soldati e poco estese le pianure perché potesse dispiegarvi la sua cavalleria, e che il cielo sarebbe stato appena sufficiente perché tutti potessero scagliare i loro dardi. Ebbene, mentre da ogni parte si levavano simili affermazioni per eccitare un uomo che aveva già una folle stima di sé stesso, lo spartano Demarato4 fu il solo a dire che proprio quella moltitudine confusa e pesante, di cui Serse si compiaceva, costituiva un pericolo per il suo capo, perché era un peso, non una forza: ciò che è smisurato non si può governare, e ciò che è ingovernabile non può durare a lungo. «Alla prima montagna», disse, «gli Spartani ti si opporranno, dando prova del loro valore. Trecento uomini fermeranno tutte queste migliaia di soldati, restando fermi al loro posto e difendendo con le armi i valichi affidatigli e sbarrandone il passaggio coi loro corpi: l’Asia intera non riuscirà a smuoverli. Basteranno un pugno di uomini per arrestare tutto questo minaccioso apparato bellico e l’avanzata impetuosa di quasi tutto il genere umano. Quando la natura, cambiando le sue leggi, ti avrà fatto arrivare al di là del mare, ti fermerai in un sentiero e allora potrai prevedere quali danni ti attendono, calcolando quanto ti costerà il passo delle Termopili; 5 quando ti sarai accorto che è possibile fermarti, ti renderai conto che è possibile metterti in fuga. Certo, i Greci cederanno di fronte a te in molti luoghi, come trascinati da un torrente che col suo primo impeto suscita grande spavento, ma poi si leveranno qua e là e ti schiacceranno con le tue stesse forze. È vero che l’apparato bellico è troppo grande per poter essere sistemato in quelle regioni che hai deciso di attaccare, e ciò va a nostro svantaggio, ma proprio per questo la Grecia ti vincerà, perché quello spazio non può contenere tutta quella massa di soldati e di mezzi: tu, dunque, non potrai servirti di tutte le tue forze. Per di più, e questa sarebbe la tua unica possibilità di salvezza, non potrai fronteggiare il primo impeto e portare rinforzi a chi cede, né sostenere o rafforzare le parti che vacillano, perché sarai vinto molto prima che tu possa rendertene conto. Del resto non ci sono motivi per credere che non si possa resistere al tuo esercito, perché il numero dei suoi soldati è sconosciuto persino a te che ne sei il capo. E poi non vi è cosa tanto grande che non possa perire: la causa della sua rovina, se non ne intervengono altre, proviene dalla sua stessa grandezza». Accadde ciò che Demarato aveva previsto: trecento uomini costrinsero a fermarsi colui che aveva violato le leggi divine e umane e che aveva abbattuto ogni ostacolo, sicché, piegato in tutta la Grecia, il Persiano capì la differenza tra un esercito e una massa informe di uomini. Così Serse, più infelice per la vergogna che per il danno subito, ringraziò Demarato, che era stato l’unico a dirgli la verità, e gli permise di chiedergli ciò che voleva. Quello chiese di entrare a Sardi, la più grande città dell’Asia, su un carro e portando in capo la tiara diritta, che era una prerogativa dei re. Sarebbe stato degno di quel premio senza neppure doverlo chiedere, ma quanto fu meschino quel popolo in cui non ci fu alcuno capace di dire al re la verità se non colui che non poteva dirla a sé
stesso! 32. Il divo Augusto relegò in esilio sua figlia, 6 la cui impudicizia aveva superato quanto di vergognoso è implicito in questa parola, rendendo così pubblici gli scandali della casa imperiale: amanti ricevuti in massa, gente che faceva baldoria in giro per la città, il Foro e quei rostri dai quali il padre aveva promulgato la legge sull’adulterio scelti dalla figlia come scenario per le sue sconcezze, il suo accorrere ogni giorno alla statua di Marsia,7 quando, trasformatasi da adultera in prostituta, chiedeva al suo amante sconosciuto il diritto di abbandonarsi a ogni dissolutezza. Queste cose che un imperatore avrebbe dovuto punire e allo stesso tempo tacere, perché la vergogna di certe cose ricade anche su chi le punisce, non riuscendo a dominare la propria ira, le aveva rese pubbliche. Quando poi, col passare del tempo, all’ira subentrò la vergogna, dolendosi di non aver taciuto quei fatti che per tanto tempo aveva ignorato, spesso esclamava: «Non mi sarebbe accaduto nulla di tutto ciò se Agrippa o Mecenate8 fossero stati ancora vivi!». A tal punto è difficile per chi ha tante migliaia di uomini sostituirne due! Delle legioni furono massacrate e subito ricomposte, una flotta fu distrutta e nel giro di pochi giorni ne fu messa in mare una nuova, si infierì contro le opere pubbliche incendiandole e se ne innalzarono altre, migliori di quelle distrutte: ma finché Augusto fu in vita il posto di Agrippa e di Mecenate rimase vuoto. Cosa pensare? Gli mancarono uomini di quello stampo da poter assumere come consiglieri, o fu colpa sua, visto che preferì lamentarsi invece di andare a cercarli? Comunque non c’è motivo di credere che Agrippa e Mecenate avessero l’abitudine di dire la verità: se fossero stati ancora vivi avrebbero finto anche loro. È abitudine dei re lodare il passato per sminuire il presente e attribuire la virtù di dire la verità a coloro dai quali non c’è più pericolo di ascoltarla. 33. Ma per tornare all’argomento, vedi come sia facile dimostrare la propria riconoscenza a coloro che sono fortunati e che si trovano al culmine della potenza umana? Di’ loro non ciò che vogliono ascoltare, ma ciò che vorrebbero aver sempre ascoltato: entri ogni tanto una parola sincera nelle loro orecchie piene di adulazioni, dagli un consiglio utile. Chiedi cosa puoi fare per un uomo fortunato? Digli che non confidi nella sua fortuna, che sappia che occorrono molte e fedeli mani per mantenerla. Non sarà poco ciò che gli darai se gli leverai la sciocca fiducia che la sua potenza durerà per sempre e gli insegnerai che le cose dateci dal caso sono mutevoli e se ne vanno più rapidamente di quanto arrivino, e che indietro non si va gradualmente come si è giunti al culmine della potenza, ma spesso tra il grado più alto e quello più basso della fortuna la differenza è minima. Non conosci il valore dell’amicizia, se non capisci che darai molto a colui al quale darai un amico, cosa rara non solo nelle singole famiglie, ma nelle generazioni, e che manca soprattutto là dove si crede che abbondi. E che? Pensi
che questi libri, che la memoria o la mano del nomenclatore abbracciano a stento, siano delle liste di amici? Non sono amici questi che a frotte bussano alla tua porta e che vengono divisi in quelli che entrano per primi e quelli che entrano per secondi. 34. È una vecchia abitudine dei re e di coloro che li imitano dividere in classi la folla degli amici ed è una caratteristica della loro arroganza far pagare caro il privilegio di entrare in casa loro o di toccarne la soglia e di concedere come un’onorificenza il permesso di stare seduti più vicino alla loro porta per entrare per primi in casa loro, dove però ci sono molte porte che non possono varcare neanche coloro che hanno varcato la prima. Presso di noi Gaio Gracco e poi Livio Druso9 istituirono la consuetudine di suddividere in gruppi il loro seguito e di ricevere alcuni in privato, altri in piccole schiere, altri in massa. Così si ebbero amici di prima e di seconda categoria, ma mai amici veri. Puoi chiamare amico uno che ha un ordine da rispettare per poterti salutare? Come potrebbe aprirti lealmente il suo cuore uno che non entra, ma si infila fra i battenti appena appena aperti? Può mai parlare liberamente chi, quando è il suo turno, non pronuncia neppure un «buongiorno!», parola banale e comune, che si rivolge anche agli sconosciuti? Se giungi in casa di uno di questi uomini al momento del saluto mattutino, che mette in subbuglio la città, anche se vedi le strade invase da una folla immensa e il traffico bloccato dalla massa di gente che va e che viene, sappi che arrivi in un luogo pieno di uomini, ma vuoto di amici. Un amico si cerca nel cuore, non nell’atrio della casa: è lì che bisogna accoglierlo, trattenerlo e trovargli un posto segreto, nei nostri sentimenti. Insegna loro queste cose: dimostrerai la tua riconoscenza. 35. Ti giudichi male se consideri di essere utile solo a chi è sfortunato e inutile nelle circostanze propizie. Come ti comporti saggiamente sia nelle situazioni avverse sia in quelle favorevoli, agendo con prudenza in quelle critiche, con coraggio in quelle avverse, con moderazione in quelle propizie, così puoi dimostrarti utile all’amico in qualunque circostanza. Nelle avversità non lo abbandonerai e tanto meno gliele augurerai: nell’immensa varietà delle vicende umane se ne presenteranno molte, senza che tu le desideri, che ti offriranno l’occasione di esprimere la tua lealtà. Chi augura la ricchezza a un altro, per riceverne anch’egli una parte, benché sembri desiderarla per lui, in realtà pensa a sé stesso; analogamente chi augura all’amico qualche bisogno da cui poi tirarlo fuori col suo aiuto e la sua assistenza – comportandosi come un ingrato – antepone sé stesso all’altro e ritiene che valga la pena che quello sia infelice per potergli manifestare la propria riconoscenza, e appunto per questo è un ingrato: vuole sdebitarsi e liberarsi da un grave peso. C’è una grande differenza tra chi si affretta a dimostrare la propria riconoscenza per contraccambiare e chi si affretta per non essere più in debito. Chi vuole ricambiare si adatterà all’interesse dell’altro e desidererà che si
presenti l’occasione giusta; chi invece vuole esclusivamente liberarsi dal debito desidererà raggiungere il suo scopo in qualsiasi modo, e ciò è indizio di una pessima disposizione d’animo. Ci si chiede: «Ma questa fretta eccessiva è propria di un ingrato?». Non potrei rispondere più chiaramente che ripetendo ciò che ho già detto: tu non vuoi ricambiare il beneficio ricevuto, vuoi sottrarti a esso. Sembra che tu dica: «Quando potrò sbarazzarmi di costui? Devo fare di tutto per non essere più in debito nei suoi confronti». Se tu desideri sdebitarti con lui a sue spese sei ben lontano dalla gratitudine, poiché ciò che desideri è ancora più iniquo: tu, infatti, lo maledici e voti alla morte con un sinistro augurio chi dovresti invece venerare. Secondo me nessuno dubiterebbe della disumanità del tuo animo, se tu augurassi apertamente al tuo benefattore la povertà, la prigionia, la fame e la paura: che queste siano le parole o l’essenza del tuo augurio non c’è differenza, tu gli hai augurato proprio uno di questi mali. Continua pure a giudicare questo come un segno di gratitudine: non lo farebbe neppure un ingrato, che non arriverebbe fino all’odio ma si limiterebbe a negare il beneficio! 36. Chi potrebbe definire pio Enea se avesse desiderato che la sua patria fosse presa dai nemici per poter poi strappare il padre alla schiavitù? Chi considererebbe dei figli esemplari i giovani Siciliani se per poter dimostrare il proprio affetto filiale, sottraendo alle fiamme i genitori, si fossero augurati che l’Etna buttasse fuori un’immensa massa di fuoco? Roma non ha alcun debito nei confronti di Scipione10 se ha alimentato la guerra punica allo scopo di mettervi fine; non ha alcun debito nei confronti dei Deci, che pur salvarono la patria con la loro morte, quando prima ne avevano desiderato l’estrema rovina per avere l’occasione di dimostrare la loro eroica devozione. È il massimo dell’infamia per un medico provocare di proposito il suo intervento: molti che deliberatamente aggravarono o acutizzarono le malattie per potersi procurare maggior gloria guarendole non sono poi stati in grado di curarle, o vi sono riusciti ma a prezzo di grandi sofferenze dei loro pazienti sfortunati. 37. A quanto si dice (e a quanto riporta Ecatone), mentre Callistrato 11 si accingeva a partire per l’esilio, insieme con molti altri espulsi da quella città sediziosa in cui vigeva una libertà sfrenata, qualcuno si augurò che gli Ateniesi si trovassero nella necessità di richiamare gli esuli. Ebbene, Callistrato respinse inorridito un simile modo di tornare in patria. Il nostro Rutilio fu ancora più fiero: poiché qualcuno cercava di consolarlo dicendogli che la guerra civile era imminente e che entro breve termine sarebbero ritornati tutti gli esuli, rispose: «Che cosa ti ho fatto di male, perché tu mi auguri un ritorno peggiore della partenza? Preferisco che la mia patria si vergogni del mio esilio, piuttosto che debba soffrire per il mio ritorno!». Non è esilio quello del quale non c’è chi si vergogni meno del condannato. Come hanno fatto il proprio dovere di buoni cittadini quelli che non hanno
voluto rivedere i loro Penati a prezzo di una rovina generale, perché era meglio che due soli fossero colpiti da un male ingiusto piuttosto che tutti da una sventura collettiva, così viene meno al sentimento della riconoscenza chi vuole che il suo benefattore si trovi in difficoltà per potere poi trarlo fuori: anche se la sua intenzione è buona, i suoi auguri sono malvagi. E non è una scusa, né tanto meno un motivo di gloria, spegnere un incendio dopo averlo provocato. 38. Presso alcuni popoli un augurio funesto era considerato un delitto. Ad Atene Demade12 condannò uno che commerciava in corredi funerari, dopo aver dimostrato che si era augurato un ingente guadagno che non avrebbe potuto conseguire se non con la morte di molte persone. Tanti, però, si chiedono se meritasse di essere condannato: forse si augurò non di vendere a molti, ma di vendere a caro prezzo e di comprare a buon mercato ciò che avrebbe rivenduto. Visto infatti che il commercio consiste nel comprare e nel vendere, perché interpretare solo in un senso quel desiderio quando il guadagno proviene da entrambe le cose, cioè dal comprare e dal rivendere? E poi bisognerebbe condannare tutti quelli che partecipano al commercio, poiché tutti in cuor loro si augurano la stessa cosa. Si condannerebbe la maggior parte degli uomini, perché chi non deve il suo guadagno agli svantaggi di un altro? Il soldato desidera la guerra, perché pensa alla gloria che gliene potrà venire; l’aumento del prezzo dei generi alimentari rallegra l’agricoltore; il numero dei processi fa aumentare l’onorario degli avvocati; un periodo di epidemie è una fonte di guadagno per i medici; la corruzione della gioventù fa arricchire i venditori di oggetti di lusso; se le case non vengono danneggiate dal maltempo né dal fuoco, ristagnerà l’attività degli artigiani. E così via. O forse credi che Arrunzio e Aterio e gli altri che fanno professione di cacciatori di testamenti non si augurino le stesse cose degli ordinatori e degli impresari di pompe funebri? Questi ultimi, però, non sanno a chi augurano di morire, mentre gli altri desiderano e aspettano con ansia la morte dei loro amici più cari, in cui ripongono grandi speranze proprio a causa dell’amicizia; agli uni chi continua a vivere non arreca nessun danno, mentre gli altri si logorano per chiunque tardi a morire; essi, dunque, desiderano non solo ricevere ciò che hanno meritato col loro vergognoso servilismo, ma anche essere liberati da un gravoso tributo, quindi il loro desiderio è più grave di quello unico che si condanna, dato che chi morendo gioverebbe, continuando a vivere nuoce. Eppure, benché noti, i desideri di costoro restano impuniti. Ciascuno dunque interroghi sé stesso, si faccia l’esame di coscienza esaminando ciò che ha desiderato in cuor suo e vedrà quanto sono numerosi i desideri che ci si vergogna di confessare persino a sé stessi! Quanto sono pochi i desideri che potremmo esprimere in presenza di un testimone! 39. Ma non tutto ciò che è criticabile va condannato, come per esempio il desiderio di un amico che ha buone intenzioni ma ne fa un cattivo uso, cadendo in una colpa che cercava di evitare, perché per la fretta di dimostrare la propria
riconoscenza finisce col diventare un ingrato. Dice: «Che quello cada in mio potere, che abbia bisogno della mia autorità, che non possa essere né salvo, né onorato, né sicuro senza di me, che sia colpito da una sventura tale da accogliere come beneficio qualunque cosa gli si restituisca». E agli dèi che lo ascoltano rivolge questa preghiera: «Che sia circondato in casa sua da intrighi che solo io possa sventare, che un nemico potente e terribile e una folla ostile e armata lo perseguitino, che un creditore e un accusatore lo tormentino». 40. Guarda che ingiustizia: non gli augureresti nulla di tutto ciò, se non ti avesse fatto del bene. Tralasciando le altre colpe più gravi che commetti ricambiando un gran bene con un gran male, certamente sbagli quando non aspetti il momento opportuno per ogni cosa: si sbaglia in egual misura a lasciarsi sfuggire l’occasione e ad anticiparla. Come non sempre si deve accettare il beneficio, così non si deve in ogni caso ricambiare. Se ricambiassi senza che io lo desideri saresti un ingrato, e quanto più ingrato sei tu che mi costringi a desiderarlo! Aspetta! Perché non vuoi che il mio dono rimanga da te? Perché sopporti di malanimo di essere in debito nei miei confronti? Perché ti affretti a estinguere il debito come faresti con un spietato usuraio? Perché vuoi procurarmi delle difficoltà? Perché inciti gli dèi contro di me? Se ti comporti così per ricambiare, come ti comporteresti se dovessi riscuotere del denaro? 41. Prima di tutto, dunque, o Liberale, impariamo a essere debitori di benefìci serenamente e a osservare le occasioni di ricambiarli, senza provocarle artificiosamente. Ricordiamoci che la smania di sdebitarsi appena possibile è già un segno di ingratitudine, poiché non si restituisce volentieri ciò di cui si diventa debitori controvoglia e se non si vuole tenere una cosa perché la si considera un peso, non un dono. Come sarebbe meglio e più giusto tenere a disposizione degli amici i benefìci che ci hanno fatto e offrirli loro, invece di rinfacciarglieli, e non sentirsi gravati da un debito, visto che il beneficio è un legame reciproco che unisce fra loro due persone! Diciamo così: «Io non ho alcuna difficoltà a restituirti il beneficio e desidero che tu lo riceva con gioia. Se l’uno o l’altro di noi due dovesse essere afflitto da un bisogno e per una fatalità tu sei stato costretto a riprendere il tuo beneficio o io ad accettarne un altro, chi è solito dare continui pure a farlo. Io sono pronto: nessun indugio da parte di Turno:13 mostrerò la mia buona disposizione d’animo alla prima occasione; nel frattempo, chiamo a testimoni gli dèi». 42. Di solito, o mio Liberale, noto e quasi tocco con mano in te l’atteggiamento di chi è inquieto e teme sempre di essere in ritardo nell’adempiere i suoi doveri. A un animo riconoscente non si addice l’ansietà, si
conviene invece una grande fiducia in sé e, se si è coscienti del vero amore, il superamento di ogni ansietà. È un’offesa sia il dire: «Eccoti il contraccambio» che il dire: «Sei in debito con me». Quando si concede un beneficio la prima legge dev’essere questa: che sia il donatore a scegliere il momento per il contraccambio. «Ma io ho paura che la gente parli male di me». Chi si dimostra riconoscente pensando alla propria reputazione invece che alla propria coscienza si comporta male. In questo caso hai due giudici: il donatore, che non devi temere, e te stesso, che non puoi temere. «E allora? Se non si presenterà l’occasione, resterò sempre in debito?». Rimarrai sì in debito, ma apertamente e di buon animo, e guarderai con molto piacere a ciò che ti è stato lasciato. Si pente di aver accettato un beneficio colui al quale dà fastidio non averlo ancora ricambiato; perché se ti è sembrato degno di accettare da uno un beneficio ora ti sembra indegno restare a lungo in debito con lui? 43. Commette un grave errore chi pensa che sia segno di grandezza d’animo offrire, donare, riempire borse e case di molti, quando a volte chi fa ciò non è un animo grande, è una grande fortuna; è più importante e difficile ricevere che elargire. Infatti – senza con ciò voler sminuire alcuna delle due azioni, poiché entrambe sono sullo stesso piano quando sono ispirate dalla virtù – l’essere in debito per il bene ricevuto non è moralmente da meno che il fare il bene; anzi, l’essere in debito è tanto più faticoso che il fare il bene quanto l’impegno per custodire ciò che si è ricevuto è maggiore di quello necessario per darlo. Perciò non dobbiamo essere ansiosi di ricambiare al più presto, né precipitarci intempestivamente, perché chi non manifesta la propria riconoscenza al momento opportuno commette lo stesso errore di chi si affretta nel momento sbagliato. Ha posto il suo dono nelle mie mani: non temo né per lui né per me. Ha preso le sue garanzie: non può perdere questo beneficio se non con me, anzi neppure con me, dato che io l’ho ringraziato, cioè mi sono sdebitato. Chi pensa troppo a restituire il beneficio immagina che l’altro pensi troppo a ricevere il contraccambio. Ci si mostri ben disposti verso entrambe le alternative: se vuole che il beneficio gli venga ricambiato, ricambiamolo e restituiamolo con gioia; preferisce che sia custodito presso di noi? Perché dissotterrare il suo tesoro? Perché rifiutarci di custodirlo? Egli merita di poter fare ciò che vuole. Consideriamo le opinioni e i giudizi degli altri non come se dovessero guidarci, ma come se dovessero seguirci.
1. Rabirio, poeta epico latino, fu autore di un poema sulla battaglia di Azio e sulla morte di Cleopatra. 2. Virgilio, Eneide, VI 62. 3. Serse, re persiano, tentò di sottomettere la Grecia e nel 481 iniziò là guerra che si concluse con la sua
sconfitta per mare a Salamina, per terra a Platea. 4. Demarato, re spartano: deposto, riparò presso Dario e accompagnò Serse nella spedizione contro la Grecia. 5. Le Termopili: passo strategico al centro della Grecia, difeso eroicamente, nel 480 a.C., da Leonida e i suoi trecento Spartani per ritardare l’invasione persiana. 6. Giulia fu sposa di Marcello, poi di Agrippa, quindi di Tiberio. Per la licenziosità dei suoi costumi fu relegata dal padre dapprima nell’isola di Pandataria, poi a Reggio Calabria, dove morì nel 14 d.C. 7. Marsia è il satiro che col suo flauto sfidò Apollo e, vinto, fu da lui scorticato (l’episodio è ricordato da Dante). Presso la sua statua, situata nel Foro, si davano appuntamento le coppie. 8. Per Agrippa cfr. I benefìci, III 32. Mecenate, politico romano del I sec. a. C., ebbe un grandissimo peso negli affari di Stato. La sua fama è legata alla protezione data ai maggiori letterati del tempo, fra i quali Virgilio, Orazio e Properzio. 9. Gaio Sempronio Gracco era il minore dei due famosi fratelli, vanto della madre Cornelia. Tribuno della plebe nel 124, affrontò la questione agraria, la democratizzazione della struttura politica e l’estensione dei diritti di cittadinanza agli Italici. Livio Druso, zio di Catone Uticense, eletto tribuno della plebe, tentò di attuare una riforma che ristabilisse forme più democratiche di governo, proseguendo la politica dei Gracchi. 10. Publio Cornelio Scipione, detto l’Africano Maggiore, console nel 205, sbarcò in Africa nel 204 (seconda guerra punica) e sconfisse i Cartaginesi nella battaglia di Zama nel 202. 11. Callistrato, oratore e politico ateniese, partecipò alle lotte contro Sparta, poi si alleò con gli Spartani contro Tebe. Dopo la conquista di Oropo da parte dei Tebani, fu incolpato per la sua politica ed esiliato. 12. Demade, oratore e uno dei principali uomini politici di Atene. Fu mediatore di pace con Filippo e poi con Alessandro. Nel 319, accusato di complotto contro Antipatro, fu fatto uccidere insieme col figlio. 13. Virgilio, Eneide, XII 2.
Libro settimo 1. Sta’ di buon animo, mio caro Liberale, la terra è vicina; non ti tratterrò con un poema, con giri di parole e lunghi preamboli.1 Questo libro contiene i resti di una materia ormai esaurita e io mi guardo intorno per vedere non che cosa dire, ma cosa non ho detto; tuttavia, puoi dichiararti soddisfatto di ciò che rimane, visto che è rimasto per te. Se avessi voluto seguire il mio gusto, avrei accresciuto quest’opera a poco a poco, riservando per la conclusione quella parte che potesse interessare anche chi ne aveva già abbastanza. Invece, ho ammassato all’inizio tutto ciò che era essenziale; ora vado a recuperare quel che mi è sfuggito, e non credo che sia molto importante, dopo avere illustrato le leggi morali, esaminare questioni che sono state affrontate non per migliorare l’animo, ma per esercitare l’intelligenza. Come dice giustamente Demetrio Cinico,2 grand’uomo, a mio parere, anche se confrontato con i sommi, di solito conoscere pochi precetti filosofici e servirsene è più utile che averne imparati molti ma non averli a portata di mano. Egli dice: «Come il grande lottatore non è quello che ha imparato alla perfezione tutte le mosse e le prese che si usano con l’avversario, ma è quello che si è esercitato con impegno e zelo in una o due di esse e aspetta attentamente l’occasione per servirsene (non importa, infatti, quante ne conosce, basta che sappia quelle che sono sufficienti per vincere), così nei nostri studi vi sono molte conoscenze interessanti, ma poche decisive. Puoi anche ignorare il motivo che determina il flusso e il riflusso dell’oceano, perché uno ogni sette anni lasci un segno nella nostra vita; perché la larghezza di un portico a chi lo guarda da lontano non appaia uniforme ma in fondo si restringa e all’estremità l’intervallo fra una colonna e l’altra scompaia; per quale ragione dei gemelli concepiti separatamente nascano assieme, e se un unico rapporto sessuale dia origine a due esseri distinti o se siano concepiti in due momenti differenti; perché due persone nate contemporaneamente abbiano destini diversi e ci sia tanta differenza fra coloro che alla nascita sono separati da un intervallo minimo: se tralasci cose di questo genere, che non è possibile né utile conoscere, non te ne verrà danno alcuno. La verità, avvolta nel mistero, giace nell’abisso. E non possiamo lamentarci accusando la natura di essere cattiva, perché è difficile solo la scoperta di quelle cose il cui frutto consiste esclusivamente nell’averle scoperte, mentre tutto ciò che è destinato a renderci migliori e più felici la natura lo ha messo bene in vista o a portata di mano. Se il nostro animo è arrivato a disprezzare tutto ciò che dipende dal caso, se ha debellato la paura, se non abbraccia con avide speranze cose smisurate, ma trova in sé stesso la ricchezza,
se ha scacciato da sé il timore degli dèi e quello degli uomini e sa che dagli uomini non c’è molto da temere e nulla da parte di dio; se l’uomo, disprezzando tutto ciò che al tempo stesso abbellisce e tormenta la vita, è arrivato a rendersi conto che la morte non dà origine ad alcun male ma pone fine a molti; se ha consacrato tutto sé stesso alla virtù e, per qualunque via lo esorti a passare, la trova agevole; se, in quanto animale sociale e generato per la vita associata, guarda al mondo come alla casa comune di tutti e ha aperto la sua coscienza agli dèi e si comporta sempre come se fosse in pubblico, temendo più sé stesso che gli altri, allora, scampato alle tempeste, si è fermato sulla terraferma sotto un cielo sereno ed è arrivato alla perfetta conoscenza di ciò che è utile e necessario. Tutte le altre cose non sono che svaghi per il nostro tempo libero: ci si può dedicare quando l’animo è già al sicuro, ma esse si limitano ad affinare l’animo, non lo fortificano». 2. Questi sono i princìpi che il nostro Demetrio ordina all’aspirante saggio di tenere ben stretti e di non abbandonare mai, anzi di imprimere in sé e di far diventare parte di sé, sì da ottenere, con la meditazione quotidiana, che essi gli vengano incontro spontaneamente, che gli giovino e siano dovunque e subito a sua disposizione e senza indugio gli facciano vedere la distinzione fondamentale tra il bene e il male. Non c’è altro male che la disonestà, né altro bene che l’onestà: egli dunque regoli la vita sulla base di questo principio, agisca sempre ispirandosi a questa legge e, per grande che sia lo splendore delle loro ricchezze, giudichi i più meschini fra tutti i mortali coloro che sono schiavi del ventre e del piacere e lasciano giacere il loro animo in uno sterile ozio. Dica a sé stesso: «Il piacere è fragile, breve, porta alla sazietà, quanto più avidamente lo si gusta tanto più rapidamente si trasforma nel suo contrario ed è inevitabile poi pentirsene o vergognarsene, in esso non c’è niente di bello o che si addica alla natura dell’uomo, che è vicinissima a quella divina; è meschino, è procurato da organi sconci e indecenti e il suo risultato è ignobile. Il piacere vero, degno dell’uomo, non consiste nel rimpinzare e nell’ingrassare il corpo, né nello stimolare le passioni, la cui assenza è la cosa più sicura, consiste nell’essere privo di turbamenti, sia di quelli causati dall’ambizione degli uomini che litigano fra di loro, sia di quelli insopportabili provenienti dall’alto, quando, credendo alle dicerie popolari sugli dèi, li giudichiamo in base ai nostri vizi». Questo piacere, sempre uguale, imperturbabile, che non viene mai a noia a sé stesso, lo prova quell’uomo che qui descriviamo per sommi tratti, esperto, diciamo così, delle leggi umane e divine. Egli gode del presente, non è tutto proteso verso il futuro, poiché non ha nulla di stabile chi tende verso ciò che è incerto. È dunque libero da quelle grandi preoccupazioni che angosciano la mente, e non ha alcuna speranza né alcuna brama e, contento di ciò che ha, non mette in pericolo sé stesso. E, affinché tu non pensi che si accontenti di poco, ti dirò che egli possiede tutto, non come lo possedeva Alessandro, al quale anche dopo essere arrivato fino alle rive del Mar Rosso mancava più terra di quella
che aveva occupato per arrivare fin lì. Non era infatti nemmeno sua la terra che possedeva o che aveva conquistato, visto che Onesicrito,3 mandato avanti in esplorazione, andava errando in cerca di guerre in un mare sconosciuto. Non era abbastanza evidente che era un povero chi portava le sue armi oltre i confini della natura e si spingeva verso abissi inesplorati e immensi per la sua cieca avidità? Che importa quanti regni ha sottratto, quanti ne ha concessi, quante nazioni ha oppresso con l’imposizione dei suoi tributi, quando gli manca sempre tanto quanto desidera? 3. Questo vizio non fu solo di Alessandro, la cui fortunata audacia lo spinse sulle orme di Bacco e di Ercole, lo ebbero tutti coloro che la fortuna, riempiendoli di beni, ha esaltato. Passa in rassegna Ciro,4 Cambise e tutta la genealogia dei re di Persia, non ne troverai uno che si sia fermato per la sazietà di potere o che non abbia finito di vivere pensando di andare oltre. E non c’è da meravigliarsi, perché tutto ciò che riguarda la nostra cupidigia viene subito inghiottito e scompare, e non importa la quantità di cose che si gettano le une sulle altre quando manca il fondo. Il saggio è l’unica persona che possiede tutto e non fa fatica a conservarlo: non deve inviare ambasciatori al di là dei mari, non deve disporre accampamenti sulle rive nemiche, sistemare guarnigioni nei posti più rischiosi, non gli servono legioni o squadroni di cavalleria. Come gli dèi immortali governano senza armi il proprio regno e difendono le loro proprietà da un luogo alto e tranquillo, così il saggio adempie ai suoi doveri, quali e quanti essi siano, senza agitazione, e poiché è il migliore e il più potente di tutti vede sotto di sé l’intera umanità. Ridi pure di lui. È un grande animo, quello di colui che – dopo aver percorso con la mente tutto l’Oriente e tutto l’Occidente, penetrando anche nei luoghi remoti e inaccessibili a causa dei deserti, dopo aver contemplato tanti animali, tutta la varietà di beni che la natura dispensa in abbondanza – può pronunciare queste parole che sono proprie di un dio: «Tutto questo è mio!». Di conseguenza egli non desidera nulla, perché non c’è nulla al di fuori del tutto. 4. «Qui ti volevo!», esclamerai a questo punto. «Non mi scappi! Voglio vedere come ti liberi dal guaio in cui ti sei cacciato da solo. Dimmi: come si può donare qualcosa al saggio, se tutto è suo, e quindi anche ciò che gli si dona è già suo? Quindi non si può concedere un beneficio al saggio, dato che, qualunque cosa gli si doni, gli si dona del suo». Ebbene, nulla impedisce che una cosa sia del saggio e anche di colui che la possiede in quanto gli è stata data e assegnata. Secondo il diritto civile tutto appartiene al re, ma quelle cose che egli possiede nell’insieme sono ripartite fra singoli proprietari, e ciascuna ha un suo proprietario particolare; dunque possiamo donare al re una casa, uno schiavo, del denaro, senza per questo dire che gli diamo del suo, posto che al re spetta la potestà su tutto, ai singoli la proprietà. Noi chiamiamo territorio degli Ateniesi e dei Campani quelle terre che poi vengono divise fra vicini con dei confini
privati; il territorio nel suo insieme non è di nessuno, è dello Stato; ciascuna parte è poi registrata come proprietà del suo padrone; perciò possiamo donare i nostri campi allo Stato, benché si dica che sono suoi, perché il modo in cui sono suoi è diverso dal modo in cui sono miei. Si può forse mettere in dubbio che uno schiavo coi suoi beni personali appartenga al padrone? Eppure, può fare un dono al suo padrone. Non si può dire che lo schiavo non possieda nulla perché non avrà nulla se il padrone non lo vorrà. Analogamente non si può dire che non abbia fatto un dono quando ha dato volontariamente qualcosa che gli si sarebbe potuto strappare contro la sua volontà. Ora, visto che siamo d’accordo sul fatto che il saggio possiede tutto non starò a dimostrarlo; bisogna invece risolvere la questione che tutti pongono: come, cioè, sia possibile essere generosi nei confronti di colui che, come abbiamo ammesso, possiede tutto. Ebbene, tutte le cose di cui i figli possono disporre sono del padre, però tutti sanno che anche un figlio può donare qualcosa al padre. Tutte le cose sono degli dèi, eppure noi anche agli dèi facciamo doni e offerte in denaro. Ciò che io ho non cessa di essere mio, se è anche tuo, perché una medesima cosa può essere sia mia sia tua. Si dirà: «Colui che possiede delle prostitute è un lenone; ora, il saggio possiede tutto, nel tutto sono comprese le prostitute, dunque, il saggio possiede delle prostitute. E poiché chi possiede delle prostitute è un lenone, il saggio è un lenone». Così pure si dice che il saggio non può comprare, poiché «nessuno compra ciò che è suo, e se tutte le cose sono del saggio, il saggio non compra nulla». Analogamente si dice che non può prendere in prestito del denaro, perché nessuno può pagare gli interessi sul proprio denaro. Sono innumerevoli i cavilli che la gente inventa, mentre capisce benissimo ciò che noi intendiamo dire. 5. Io infatti sostengo che tutto è del saggio, ma in modo che, ciò nonostante, ciascuno abbia il diritto di proprietà sulle sue cose, così come un re possiede tutto in quanto detentore del potere supremo, i singoli individui in quanto proprietari. Vedremo in seguito come dimostrare questa affermazione, ora, per risolvere la nostra questione, è sufficiente che io possa donare al saggio ciò che in un senso appartiene al saggio e in un altro senso appartiene a me. Nessuna meraviglia che si possa donare qualcosa a chi possiede tutto. Ho preso in affitto da te una casa; in essa qualcosa è tuo, qualcosa è mio: l’edificio è tuo, l’uso del tuo edificio è mio. Perciò tu non toccherai i frutti, se il colono, che è tuo, te lo proibirà, benché essi nascano nella tua proprietà, e se aumenteranno i prezzi dei generi alimentari o ci sarà carestia, ohimé!, guarderai invano il ricco raccolto altrui nato dal tuo terreno, posto nel tuo terreno, destinato a finire nei granai, che sono tuoi; e non entrerai nella casa che mi hai dato in affitto, pur essendone il padrone, e non mi porterai via il tuo schiavo, che ora è un mio salariato, e se mi avrai noleggiato una carrozza, dovrai considerare come un beneficio il fatto che io ti permetta di sedere nel tuo veicolo. Vedi, dunque, che è possibile, ricevendo qualcosa di nostro, ricevere un dono.
6. In tutti questi casi che ho citato una medesima cosa ha due padroni. Come? Uno possiede la cosa, l’altro ne possiede l’uso. Diciamo che i libri sono di Cicerone: il libraio Doro definisce quegli stessi libri suoi, ed entrambe le affermazioni sono corrette: l’uno li rivendica a sé come autore, l’altro come compratore; e giustamente si dice che sono di entrambi, perché lo sono realmente, ma non nello stesso modo. E così Tito Livio può ricevere da Doro i propri libri. Posso dunque donare al saggio ciò che appartiene a me in particolare, anche se egli possiede tutto; infatti, egli possiede tutto come lo possiede un re, nel suo animo, ma la proprietà delle singole cose è suddivisa fra molti, quindi egli può ricevere un dono ed essere in debito, può comprare e può prendere in affitto. Cesare possiede tutto, ma il suo patrimonio comprende solo i suoi beni privati e personali, i beni nel loro complesso rientrano nel suo potere supremo, i suoi beni privati nel suo patrimonio personale. Possiamo chiederci che cosa gli appartenga e che cosa no senza sminuire il suo potere; infatti, anche ciò che gli si toglie in quanto appartenente ad altri, in un altro senso appartiene a lui. Analogamente il saggio possiede nell’animo tutto, ma sul piano legale possiede solo i suoi beni personali. 7. Bione dimostra a volte che tutti sono sacrileghi, a volte che nessuno lo è. Quando vuole buttare giù tutti dalla rupe Tarpea, dice: «Chiunque prende, consuma o sfrutta per la sua utilità ciò che appartiene agli dèi è sacrilego. Ora, poiché tutto appartiene agli dèi, qualunque cosa si prenda la si toglie agli dèi, ai quali appartiene tutto, dunque, chiunque prenda qualcosa è sacrilego». Poi, quando vuole che si profanino i templi e si saccheggi il Campidoglio, dice che nessuno è sacrilego, perché tutto ciò che si prende viene trasferito da un luogo che appartiene agli dèi a un altro luogo che pure appartiene agli dèi. Ebbene, a questo ragionamento si obietta che tutto appartiene sì agli dèi, ma non tutto è consacrato agli dèi: siamo infatti in presenza di un sacrilegio quando si tratta di cose che la religione ha assegnato alla divinità. Così il mondo intero è il tempio degli dèi immortali, l’unico degno della loro grandezza e della loro magnificenza, e però le cose profane si distinguono da quelle sacre, e in quell’angolo a cui è stato dato il nome di sacrario non sono permesse tutte quelle cose che sono invece permesse sotto il cielo e le stelle. Il sacrilego in realtà non può offendere dio, che per la sua natura divina è intoccabile da ogni misfatto, però viene punito perché si è comportato come se volesse colpire dio: il nostro giudizio e il suo stesso lo costringono a subire una punizione. Perciò, come ci sembra sacrilego chi ruba qualcosa di sacro, anche se, dovunque porti ciò che ha sottratto, resta sempre entro i confini del mondo, così anche il saggio può subire un furto: gli viene tolta, infatti, non una delle cose che possiede nel loro insieme, ma una di quelle che sono registrate come sua proprietà personale e che sono a suo esclusivo servizio. Egli riconoscerà il primo tipo di proprietà, mentre, pur
potendolo, non vorrà avere il secondo, e leverà quel grido che levò quel generale romano,5 a cui per il suo valore e per aver ben gestito lo Stato, era stato assegnato tanto terreno quanto poteva solcarne in giro con l’aratro in un giorno: «Voi», disse ai suoi compatrioti, «non avete bisogno di un cittadino che abbia bisogni maggiori di un singolo cittadino». Quanta maggior grandezza ci vuole, secondo te, per rifiutare questo dono piuttosto che per meritarlo? Molti uomini, infatti, hanno violato i confini altrui, ma nessuno ha fissato dei confini a sé stesso. 8. Dunque, se consideriamo l’anima del saggio, che ha il dominio su tutto e spazia per l’intero universo, diciamo che ogni cosa gli appartiene, se invece ci riferiamo al diritto che regola la vita quotidiana, se ciò dovesse capitare, il possesso sarà personale. È ben diversa la valutazione di ciò che egli possiede a seconda che sia riferito alla grandezza del suo animo o al suo censo. Egli pregherà di non avere tutte queste cose di cui parli. Non ti citerò come esempi Socrate, Crisippo, Zenone e gli altri grandi uomini, in verità ancora più grandi, dato che l’invidia non ci impedisce di lodare gli antichi. Poco fa ho ricordato Demetrio, che mi sembra la natura abbia fatto nascere nella nostra epoca per mostrare che né lui può essere corrotto da noi, né noi possiamo essere corretti da lui, uomo di saggezza perfetta, anche se egli lo nega, e costante nei suoi propositi, di un’eloquenza adatta ai tempi più seri, non ricercata né legata alle parole, ma volta alla comunicazione di un contenuto con passione, in base alla foga che la trasporta. Io non dubito minimamente che la provvidenza gli abbia dato una tale vita e una tale capacità oratoria perché alla nostra epoca non mancasse né un esempio né un rimprovero. Se qualcuno degli dèi volesse affidare a Demetrio il possesso dei nostri beni, con la condizione di non poter donare nulla, io dico che egli rifiuterebbe e direbbe: 9. «Io non mi lego a questo peso, dal quale non saprei liberarmi, e non scendo, perché sono un uomo libero, in questa feccia profonda della ricchezza. Perché porti a me i mali di tutti i popoli? Non accetterei queste cose neppure per donarle, perché ce ne sono molte che per me non sarebbe decoroso donare. Mettetemi davanti quelle cose che abbagliano popoli e re: voglio proprio vedere ciò che vi procurate a prezzo del vostro sangue e della vostra vita. Prima di tutto i trofei del lusso, spiegati ordinatamente o tutti ammucchiati insieme, che sarebbe ancora meglio. Ecco un guscio di tartaruga, lavorato in scaglie finissime, e conchiglie, comprate a caro prezzo, di animali quanto mai pigri e ripugnanti, nelle quali quella screziatura che ne costituisce il fascino viene colorata con tinte artificiali a imitazione del vero. Ecco dei tavoli e un legno valutato quanto il patrimonio di un senatore e ancor più prezioso per i tanti nodi provocati dalla sua crescita tormentata. Ecco dei cristalli, fragili e perciò più preziosi, visto che agli ignoranti ogni cosa piace di più proprio per il rischio, che invece dovrebbe diminuirne il valore. Ecco delle tazze di murra: non ci sarebbe abbastanza lusso se non si ingurgitasse a bocca spalancata da tazze preziose capaci di contenere fino a tre sestari6 ciò che
poi si vomiterà! Ecco delle perle, non comprate per ciascun orecchio, ma, visto che ormai le orecchie sono esercitate a portare pesi, le perle sono unite fra loro e a ciascuna coppia se ne sovrappongono altre: la follia femminile non supererebbe abbastanza quella maschile se a ciascun orecchio non fossero appesi due o tre patrimoni. Ecco delle vesti di seta (se si possono chiamare vesti dei tessuti in cui non c’è nulla che possa proteggere il corpo o per lo meno il pudore), che una donna, indossatele, stenterebbe a giurare di non essere nuda. Le si fanno arrivare, pagandole somme spropositate, da paesi sconosciuti persino ai nostri mercanti, affinché le nostre spose non mostrino ai loro amanti nella camera da letto più di quanto mostrano in pubblico. 10. E tu, avarizia? Quante cose col loro alto prezzo hanno superato il tuo oro! Tutti questi oggetti che ho elencato sono tenuti in maggior conto e costano di più. Ora passerò in rassegna le tue ricchezze, cumuli di monete d’oro e d’argento, la cui cupidigia ci acceca. Ma, perbacco, la terra, che ha messo bene in vista tutto ciò che ci sarebbe stato utile, ha sepolto e nascosto queste cose e vi si è posta sopra con tutto il suo peso, come su cose nocive capaci di rovinare popoli interi. Ecco il ferro estratto dalle stesse tenebre dalle quali sono stati estratti l’oro e l’argento, perché per scannarci a vicenda non ci mancassero né lo strumento né la ricompensa. Tuttavia queste cose hanno almeno una qualche realtà materiale, mentre altre ingannano la mente che segue facilmente l’errore degli occhi. Ecco attestati, cambiali e cauzioni: vuoti simulacri della proprietà, che accompagnano come un’ombra l’avarizia, la quale cerca di trovare un modo per ingannare l’animo felice di credere alle sue chimere. Che sono, infatti, queste cose, le rendite, il libro dei crediti e gli interessi, se non nomi inventati per la cupidigia umana, andata ben oltre i limiti naturali? Posso lagnarmi della natura perché non ha nascosto ancora più nel profondo l’oro e l’argento, perché non vi ha gettato sopra un peso così grande da non poter essere tolto: cosa sono questi registri, cosa sono questi calcoli, il tempo speso per farli e lo spietato interesse del dodici per cento? Sono mali che dipendono dalla nostra struttura mentale, che ci procuriamo noi deliberatamente, in cui non c’è nulla che possa essere percepito con gli occhi o tenuto in mano: segni di un’avarizia sterile e vana. Infelice colui che gode del grosso registro del suo patrimonio, delle vaste distese di terre coltivate dai suoi schiavi, delle immense mandrie di bestiame, che per pascolare hanno bisogno di province e regni, delle schiere di schiavi più numerose degli eserciti di nazioni bellicose, degli edifici privati che superano in estensione grandi città! Dopo aver bene esaminato tutte queste cose, nelle quali ha speso e riversato le sue ricchezze insuperbendone, confronti tutto ciò che ha con quello che desidera e vedrà quanto è povero. Lasciami andare e restituiscimi a quelle ricchezze che mi sono proprie; il mio regno è la saggezza, regno immenso e sicuro: come lo possiedo io possono possederlo gli uomini tutti».
11. E così quando Gaio Cesare voleva donargli duecentomila sesterzi Demetrio rifiutò ridendo, poiché riteneva che quella somma non meritasse neppure che ci si vantasse di averla rifiutata. O dèi, con quale meschinità d’animo Cesare volle onorarlo o corromperlo! Bisogna rendere testimonianza a questo grand’uomo: ho sentito dire che, stupito della follia di Gaio, che con quella somma pensava di potergli far cambiare atteggiamento, diede questa grande risposta: «Se voleva indurmi in tentazione avrebbe dovuto provarci offrendomi tutto l’impero». 12. Dunque, al saggio si può donare qualcosa anche se possiede già tutto. Allo stesso modo niente impedisce di donare qualcosa a un amico, per quanto si dica che fra gli amici tutto è in comune, ma non come avviene con un socio, cioè in modo che una parte sia mia e una parte sua, ma come i figli sono in comune fra padre e madre, e quando sono due non ne hanno uno ciascuno, ma ciascuno ne ha due. Prima di tutto farò sì che chiunque mi inviti ad associarmi con lui sappia che non abbiamo nulla in comune, perché la comunanza esiste solo fra saggi, che sono amici fra loro, mentre gli altri sono amici solo in quanto sono soci. E poi ci sono diversi modi di possedere in comune qualcosa: i seggi dei cavalieri a teatro, per esempio, appartengono a tutti i cavalieri romani, però fra questi posti diventa mio quello che ho occupato per primo; se l’ho ceduto a qualcuno, pur avendogli dato una cosa che abbiamo in comune, io vengo considerato come uno che ha fatto un dono. Vi sono cose che appartengono a certe condizioni, come appunto i seggi dei cavalieri: io ho il mio ma non per venderlo, non per darlo in affitto, non per viverci, ma soltanto per assistere agli spettacoli; poste queste restrizioni, non dico il falso se affermo di possedere un seggio tra i cavalieri. Ma se quando arrivo a teatro i seggi dei cavalieri sono tutti occupati io, legalmente, ho il mio posto lì, in quanto ho il diritto di sedermi, però lì non ho il mio posto, in quanto ogni posto è occupato da chi ha in comune con me il diritto a quel posto. La stessa cosa avviene fra gli amici: ciò che ha un amico è in comune con noi, ma è proprietà personale di chi lo possiede e, se egli non vuole, io non posso farne uso. «Mi prendi in giro», dici: «se ciò che appartiene al mio amico è mio, dovrebbe essermi consentito anche di venderlo». No, visto che non puoi vendere neppure i seggi dei cavalieri, che pure hai in comune con gli altri. Il fatto che tu non possa vendere, consumare o peggiorare una cosa non prova che essa non sia tua, in quanto è tuo anche ciò che lo è a determinate condizioni. 13. […] ho ricevuto, ma certo non meno. Per non tirarla per le lunghe, un beneficio non può essere maggiore di un altro; possono essere maggiori e più numerosi i mezzi attraverso i quali viene concesso, affinché la benevolenza si faccia sentire di più e si compiaccia di sé, come fanno di solito gli amanti, che dandosi più baci e abbracciandosi più stretti non aumentano il loro amore, lo sperimentano meglio.
14. Anche la questione che pongo ora è stata risolta nei libri precedenti, perciò la sfiorerò brevemente, dato che per essa valgono le argomentazioni fatte per le altre. Si chiede, cioè, se chi ha fatto di tutto per ricambiare un beneficio lo abbia ricambiato. La risposta è: «Affinché tu ti renda conto che non lo ha ricambiato pensa appunto che ha fatto di tutto per ricambiarlo: è, dunque, evidente che non ha ricambiato, perché non ne ha avuto l’occasione. Analogamente, non ha estinto il suo debito col creditore chi ha cercato dappertutto il denaro per pagare, ma non l’ha trovato». Certe azioni sono di natura tale che devono giungere alla realizzazione concreta, per altre invece l’aver fatto di tutto per realizzarle equivale all’averle realizzate. Se un medico ha fatto di tutto per guarire un paziente, ha svolto perfettamente il suo compito, se un avvocato ha messo tutto il suo impegno nel difendere il suo cliente, ha compiuto il suo dovere anche se il cliente è stato condannato; la lode riservata ai generali viene tributata anche al comandante sconfitto, se la sua assennatezza, il suo impegno e il suo coraggio sono stati come dovevano essere. Ha fatto di tutto per ricambiare il beneficio, ma la tua fortunata condizione gliel’ha impedito; non è accaduto alcun incidente che mettesse alla prova l’autenticità della tua amicizia; non ha potuto farti un dono perché eri ricco, non ha potuto assisterti perché stavi bene, non ha potuto recarti aiuto perché eri fortunato: ti ha dimostrato insomma la sua riconoscenza anche se tu non hai ricevuto il contraccambio del tuo beneficio. Peraltro chi, avendo sempre in mente di compiere questo dovere e attendendo il momento opportuno vi si è dedicato con molta cura e sollecitudine, ha fatto più fatica di colui al quale si è presentata subito l’occasione di dimostrare la sua riconoscenza. Diverso è il caso del debitore, per il quale, se alla fine non ha pagato, l’aver cercato il denaro non conta quasi nulla, visto che il creditore incombe sul suo capo implacabilmente, e non lascia passare un giorno senza calcolargli gli interessi; il benefattore, invece, è benevolissimo e vedendoti correre di qua e di là, angosciato e ansioso, ti dirà: «Scaccia dal tuo cuore questa preoccupazione, smetti di tormentarti. Ho ricevuto tutto da te; mi offendi, se pensi che io desideri ancora qualcosa; la tua buona disposizione d’animo mi si è manifestata pienamente». «Ma se contraccambiando il beneficio si dimostra la propria riconoscenza, allora chi ha ricambiato e chi no si trovano nella medesima situazione?». Immagina, invece, quest’altro caso: se uno si fosse dimenticato del beneficio ricevuto, se non avesse neppure tentato di dimostrarsi riconoscente, diresti che non ha manifestato la propria riconoscenza. L’altro, invece, si è dato da fare giorno e notte e ha rinunciato a tutti i suoi altri doveri, dedicandosi esclusivamente a questo e preoccupato di non lasciarsi sfuggire l’occasione; dunque, come possono trovarsi nella stessa situazione chi ha rimosso da sé la preoccupazione di dimostrare la sua riconoscenza e chi non l’ha mai abbandonata? Non è giusto che tu esiga da me una manifestazione concreta, quando vedi che l’intenzione non è mai venuta meno.
15. Insomma, fa’ conto che tu sia stato catturato dai pirati e che io, per riscattarti, mi sia fatto prestare del denaro, impegnando i miei beni come garanzia per il creditore, che io abbia navigato durante un inverno già rigido lungo coste infestate dai briganti e attraversato tutti i pericoli che può presentare il mare anche se calmo; che, dopo aver percorso tutti i deserti, dopo aver cercato i pirati, che tutti evitavano, sia giunto infine da loro ma che ormai qualcun altro ti avesse già riscattato: dirai che non ti ho dimostrato la mia riconoscenza? E se in quella navigazione, avendo fatto naufragio, ho perso il denaro che avevo messo insieme per salvarti, se sono caduto io stesso in quella prigionia da cui volevo liberarti, dirai che non ti ho dimostrato la mia riconoscenza? Ma, perbacco, gli Ateniesi chiamano tirannicidi Armodio e Aristogitone, 7 e Muzio lasciando la mano sull’ara nemica è come se avesse ucciso Porsenna: la virtù che ha combattuto con la fortuna ha sempre mostrato il suo splendore anche senza aver raggiunto l’obiettivo. Chi ha inseguito le occasioni che gli sfuggivano e ha colto uno dopo l’altro i mezzi per dimostrare la sua riconoscenza ha fatto più di chi l’ha dimostrata senza alcuna fatica alla prima occasione. «Quello ti ha offerto due cose, la buona volontà e il dono, dunque anche tu gliene devi due», si dice. Avresti ragione di dirlo a chi ti ricambia con pigrizia e svogliataggine, ma a chi, in debito, vuole e si sforza e non lascia nulla di intentato per ricambiare non puoi parlare così, poiché, per quanto dipende da lui, ti dà entrambe le cose. E poi non sempre si deve realizzare una parità quantitativa, a volte una sola cosa ne vale due, per questo un dono materiale può essere sostituito da una volontà ben disposta e desiderosa di ricambiare. Ché se la disposizione d’animo per dimostrare la riconoscenza ha valore solo se è unita a un dono materiale, allora nessuno è riconoscente verso gli dèi, ai quali si offre soltanto la volontà. Si dirà: «Agli dèi non possiamo offrire altro». Ma se anche a colui al quale devo dimostrare la mia riconoscenza non posso offrire niente di concreto perché non dovrei manifestargli la mia gratitudine offrendogli nulla di più di quel che offro agli dèi? 16. Tuttavia se mi chiedi cosa ne pensi esattamente io e vuoi una risposta ufficiale, ti dirò: l’uno pensi di aver ricevuto un beneficio, l’altro sappia di non aver ricambiato; l’uno sciolga l’altro dall’obbligo, l’altro si ritenga in debito; l’uno dica: «Ho ricevuto», l’altro risponda: «Sono in debito». In ogni questione occorre aver di mira il bene comune, bisogna chiudere agli ingrati ogni scappatoia, in modo che non possano cercarvi rifugio e proteggersi quando negano di aver ricevuto un beneficio. «Ho fatto tutto». Fa’ ancora. Che cosa? Tu ritieni che i nostri antenati siano stati così sciocchi da non accorgersi che era un’enorme ingiustizia mettere sullo stesso piano chi ha sprecato nei piaceri e nel gioco d’azzardo il denaro che si era fatto prestare e chi ha perso in un incendio o in un furto o in qualche disgrazia maggiore i beni altrui insieme con i suoi? Non ammisero alcuna giustificazione, affinché si sapesse che in ogni caso bisogna mantenere la parola data: era infatti meglio non accettare le valide giustificazioni
di pochi, piuttosto che tutti tentassero di trovarne. Hai fatto di tutto per ricambiare, ma anche se questo è sufficiente per il tuo benefattore, per te è poco. Infatti, come se, lasciando cadere i tuoi sforzi e il tuo impegno, non merita che tu gli dimostri la tua riconoscenza, così se accetta la tua buona volontà come pagamento, tu sei un ingrato se non ti consideri in debito, e tanto più in quanto lui ti ha sciolto da ogni obbligo. Tu, però, non approfittarne, e non prenderla come una giustificazione da parte tua, ma continua ugualmente a cercare occasioni per ricambiare. All’uno ricambia perché te lo ha chiesto, all’altro perché te ne ha esonerato, all’uno perché è malvagio, all’altro perché non lo è. Non devi dunque pensare che questa questione non ti riguardi, cioè se chi ha ricevuto un beneficio da un saggio debba ricambiarlo nell’eventualità che questi smetta di essere saggio e diventi malvagio. Tu gli restituiresti un deposito ricevuto da un saggio, oppure un prestito, anche se fosse un malvagio, quindi perché non dovresti restituirgli un beneficio? Perché è cambiato lui, dovresti cambiare anche tu? E che? Se tu avessi ricevuto qualcosa da un uomo sano non glielo restituiresti se si fosse ammalato, dato che abbiamo sempre maggiori doveri nei confronti di un amico debole? Anche quello è ammalato, nell’animo: sia dunque aiutato e sopportato. La stoltezza è una malattia dell’animo. 17. A questo punto ritengo che si debba fare una distinzione, se vogliamo essere più comprensibili. Ci sono due generi di benefìci: l’uno non può essere dato che da un saggio a un altro saggio, e questo è il beneficio assoluto e autentico; l’altro è quello comune e popolare che ci scambiamo noi uomini ignoranti. Non c’è dubbio che io debba ricambiare questo beneficio a colui che me l’ha fatto, anche se è diventato un omicida, un ladro o un adultero. I delitti hanno delle loro leggi particolari e un giudice può punirli meglio che un ingrato; nessuno ti faccia diventare malvagio perché lo è lui. Al malvagio getterò il beneficio, al buono lo restituirò: a quest’ultimo perché sono in debito con lui, al primo per non essergli più debitore di nulla. 18. Sul primo genere di benefìci si possono avere dei dubbi: se io non ho potuto riceverlo se non in quanto saggio non posso renderlo se non a un saggio. «E infatti supponiamo che io lo renda: quello non può riceverlo, non ne è più capace, ha perso la facoltà di servirsene. Sarebbe come se tu mi dicessi di rinviare la palla a un monco. È stolto dare a qualcuno ciò che non può ricevere». Cominciamo a rispondere dalla fine: io non darò a nessuno che non possa ricevere, però gli renderò anche se non potrà ricevere. Infatti, non posso mettere in obbligo se non chi riceve, ma posso sdebitarmi solo restituendo. Quell’uomo non potrà servirsene? Sono affari suoi: la colpa è sua, non mia. 19. Si dice: «Rendere significa dare a chi accetterà. Ma come? Se tu devi del vino a qualcuno e questi te lo fa versare in una reticella o in un crivello, dirai di averglielo restituito? O vorrai rendere ciò che mentre viene reso va perduto
passando di mano?». Rendere significa dare quello che devi al proprietario che lo vuole indietro. Solo questo io devo fare; che poi egli conservi quello che ha ricevuto da me è un’altra questione; io non sono tenuto a fargli da custode, devo solo tener fede all’impegno ed è molto meglio che sia lui a non conservare piuttosto che io a non rendere. Anche a un creditore che porterà subito al macello ciò che riceverà da me io restituirò; anche se farà cadere il denaro che riceverà dalle pieghe della toga indossata senza cintura io glielo darò. Io ho il dovere di restituire, non di conservare o di sorvegliare dopo aver restituito; io ho il dovere di custodire un beneficio quando l’ho ricevuto, non quando l’ho reso. Finché resta presso di me sia intatto, per il resto, anche se sfugge dalle mani di chi lo riceve, quando ce lo chiede bisogna darglielo comunque. All’uomo virtuoso restituirò quando gli converrà, al malvagio quando me lo chiederà. «Non puoi rendergli un beneficio dello stesso genere di quello che hai ricevuto: l’hai ricevuto da un saggio, lo rendi a uno stolto», si obietta. No: io lo restituisco a lui nello stato in cui può riceverlo ora, non dipende da me se è peggiorato, dipende da lui: se egli ritorna alla saggezza, gli restituirò il beneficio nello stato in cui me l’ha dato, mentre è nella malvagità glielo restituirò nello stato in cui può riceverlo un malvagio. «E se egli è diventato non solo malvagio, ma anche feroce, bestiale, come Apollodoro o Falaride,8 gli renderai il beneficio che hai ricevuto?». La natura non permette un cambiamento così radicale nel saggio. È inevitabile che chi cade dal massimo bene al massimo male conservi anche nel male qualche traccia del bene, non credi? La virtù non si spegne mai a tal punto da non imprimere nell’animo dei segni troppo precisi perché possano essere cancellati da un cambiamento. Le bestie feroci che abbiamo domato se forzano le gabbie e fuggono nei boschi conservano qualcosa della mansuetudine che hanno acquisito e si differenziano sia dagli animali più miti sia dalle fiere vere e proprie che non hanno mai sentito la mano dell’uomo. Nessuno che abbia raggiunto la saggezza diventa malvagio al massimo grado, poiché se ne è impregnato troppo profondamente per poterla cancellare completamente e trasformarla nel colore della malvagità. E poi mi chiedo se quest’uomo è feroce solo nell’intimo o se lo manifesta anche all’esterno, provocando dei danni generali. Tu mi hai citato il tiranno Falaride e Apollodoro: ora, se il malvagio dentro di sé ha la natura di costoro, perché non dovrei restituirgli il beneficio per non avere più niente a che fare con lui? Se invece non solo gode del sangue umano ma se ne pasce ed esercita la sua crudeltà insaziabile torturando persone di ogni età e infierisce non solo con rabbia, ma con una smania di accanimento, se sgozza i figli sotto gli occhi dei genitori, se non contento della morte pura e semplice tortura e non solo brucia ma arrostisce coloro che vuol far morire, se la sua bocca gronda sempre di sangue fresco, allora non rendergli il beneficio è ancora poca cosa. Qualunque fosse il legame che mi univa a lui, la violazione di ogni legge sociale compiuta da lui lo ha spezzato. Se egli mi avesse fatto del bene, ma combattesse contro la mia patria, perderebbe qualunque riconoscenza si fosse meritato, e dimostrargliela sarebbe considerato un delitto; se non assale la
mia patria, ma lontano da essa opprime e perseguita la sua, una tale malvagità d’animo rescinde ugualmente ogni mio legame con lui e, anche se non me lo rende nemico, me lo rende odioso, perché il mio dovere verso il genere umano viene prima ed è più importante del mio dovere verso una singola persona. 20. Ma sebbene le cose stiano così e io abbia la libertà di agire come mi pare nei suoi confronti, dal momento in cui egli, violando ogni legge, ha reso tutto lecito verso di lui, io crederei di dovermi comportare così: se il mio beneficio non gli darà maggiori forze per provocare una totale rovina, né rinsalderà quelle che ha, e ci sarà qualcosa che gli si possa restituire senza provocare un danno generale, glielo restituirò. Salverò, per esempio, il suo bambino piccolo, un beneficio che non potrà nuocere a chi è straziato dalla sua crudeltà. Non gli fornirò però il denaro per stipendiare i suoi sgherri. Se desidererà marmi e vesti, questo suo lusso non danneggerà nessuno, ma non gli fornirò armi e soldati. Se chiederà come un gran dono attori e meretrici e cose che mitighino la sua ferocia, glieli offrirò volentieri. Invece di triremi e navi rivestite di lamine di bronzo gli manderò navi da diporto, cabinate e altri oggetti per il divertimento dei re che giocano spensierati sul mare. E se non ci sarà più alcuna speranza che egli rinsavisca con la medesima mano con cui darò un beneficio a tutti lo restituirò a lui, perché per uomini simili non c’è altro rimedio che la morte, e la cosa migliore per chi non potrà più ritornare in sé è andarsene. Ma una tale malvagità è rara ed è sempre considerata una cosa mostruosa, come le voragini che si aprono nel terreno o l’eruzione del fuoco dalle profondità del mare; mettiamola dunque da parte e parliamo di quei vizi detestabili che però non incutono orrore. A un uomo malvagio che posso trovare in qualunque piazza e di cui i singoli hanno paura renderò il beneficio che ho ricevuto: bisogna infatti ch’io non tragga alcun vantaggio dalla sua malvagità. Ciò che non è mio ritorni al suo padrone! Che egli sia buono o cattivo non ha importanza. Se dovessi dare invece di restituire farei maggiore attenzione. 21. Qui ci vuole un aneddoto. Un pitagorico aveva comprato da un calzolaio un paio di sandali di cuoio bianchi, che costavano parecchio, senza pagare in contanti. Alcuni giorni dopo ritornò alla bottega per saldare il conto e, dopo che ebbe bussato ripetutamente alla porta, gli si presentò uno che gli disse: «Perdi il tuo tempo: il calzolaio che cerchi è stato sepolto ed è già cenere; ciò che è forse doloroso per noi che riteniamo morti per sempre i nostri cari non lo è per te, convinto come sei che rinascerà».9 E lo prendeva in giro. Il nostro filosofo tornò a casa, riportandosi indietro compiaciuto quei tre o quattro denari che faceva tintinnare. Poi però, vergognatosi di aver provato piacere per non aver pagato, rendendosi conto di essersi lasciato tentare da quel piccolo guadagno, ritornò alla bottega dicendo a sé stesso: «Per te quell’uomo vive; rendigli ciò che gli devi». E attraverso una fessura della porta infilò i quattro denari e si punì da solo per la sua cupidigia disonesta affinché non prendesse l’abitudine di tenere
per sé ciò che apparteneva ad altri. 22. Cerca il creditore per rendergli ciò che gli devi, e se nessuno lo richiede imponi a te stesso di pagare: che il creditore sia buono o cattivo non ti riguarda, prima rendi, poi accusa. Ricorda come sono stati divisi fra di voi i compiti: a lui è stato ordinato di dimenticare, a te abbiamo raccomandato di ricordare. Sbaglia, però, chi pensa che noi, dicendo che chi ha fatto del bene deve dimenticarlo, gli togliamo il ricordo delle sue azioni, che sono le più nobili in assoluto: talvolta formuliamo i nostri precetti in modo esagerato, per ricondurli poi alla loro giusta e naturale dimensione. Così per: «Non deve ricordare» intendiamo «Non deve farlo sapere a tutti, né vantarsene, né diventare fastidioso». Certi, infatti, raccontano a ogni gruppo di persone il bene che hanno fatto; ne parlano quando sono sobri, quando sono ubriachi non sanno trattenersi, ne riempiono le orecchie a gente che non conoscono neppure, lo confidano agli amici. Ebbene, per far cessare questo modo esagerato di ricordare, che è come un rinfacciare, abbiamo ordinato al donatore di dimenticare e chiedendogli più di quanto gli era possibile lo abbiamo convinto a tacere. 23. Quando si ha poca fiducia in uno a cui si ordina una cosa bisogna pretendere più di quanto è necessario per ottenere quanto è necessario. L’iperbole è un’esagerazione che tende a far raggiungere la verità attraverso la menzogna. Così quando il poeta scrive che in velocità superano l’aria e la neve10 dice una cosa impossibile, per farci credere il massimo possibile. E chi dice «più fermo di questi scogli, più violento di un fiume»,11 non pensa certo di convincerci che qualcuno possa stare così fermo come uno scoglio. L’iperbole non presume di raggiungere quanto osa affermare, ma afferma cose incredibili per giungere a cose credibili. Così quando diciamo «Chi ha fatto del bene lo dimentichi», intendiamo dire «sia simile a colui che l’ha dimenticato: il suo ricordo non sia evidente e aggressivo». Quando diciamo che non bisogna reclamare il contraccambio del beneficio non escludiamo completamente questa richiesta: spesso, infatti, per i malvagi c’è bisogno di un esattore, e anche per i buoni di un avvertimento. E che? Non indicherò a chi non se ne accorge l’occasione di ricambiare? Non gli rivelerò i miei bisogni affinché egli finga o soffra per aver ignorato come stavano le cose? Di tanto in tanto diamo pure un avvertimento, ma con discrezione, sì che non appaia come un reclamo, né come un’ingiunzione legale. 24. Socrate disse agli amici che lo ascoltavano: «Avrei comprato un mantello, se avessi avuto il denaro». Non chiese a nessuno, ma avvertì tutti. Si fece a gara per darglielo: e come sarebbe potuto essere altrimenti? Com’era poco ciò che Socrate riceveva! Ma com’era importante essere colui dal quale Socrate riceveva! Avrebbe potuto rimproverarli più delicatamente? «Avrei comprato un mantello, se avessi avuto il denaro». A quel punto chi si affretta
arriva troppo tardi: a Socrate è già mancato qualcosa. Proibiamo di reclamare bruscamente il contraccambio, non per eliminarlo, ma per limitarlo. 25. Una volta Aristippo,12 mentre annusava con piacere un profumo, esclamò: «Maledetti questi effeminati che hanno screditato una cosa tanto bella!». Così dobbiamo dire noi: «Maledetti questi malvagi e insopportabili quadruplicatori dei loro benefìci, che hanno eliminato una cosa così bella, cioè l’ammonimento fra amici». Io, però, mi servirò di questo diritto che deriva dall’amicizia, e chiederò il contraccambio del mio beneficio a uno a cui ne avrei chiesto un altro, il quale accetterà come un nuovo beneficio la possibilità di ricambiare che gli offro. Non dirò mai, neppure fra i lamenti, gettato sulla riva, ti ho accolto bisognoso e fuori di me ti ho reso partecipe del regno.13 Questo è un rimprovero, non un avvertimento, significa far odiare i benefìci, rendere l’ingratitudine lecita o conveniente. È più che sufficiente risvegliare il ricordo con parole discrete e affettuose: se ho qualche merito nei tuoi confronti o se qualcosa di me ti è stato caro.14 E l’altro a sua volta dica: «Certo che hai dei meriti. Gettato sulla riva mi hai accolto bisognoso». 26. «Ma così», si obietta, «non abbiamo ottenuto alcun vantaggio: quello finge, ha dimenticato: ti chiedo che devo fare». Poni una questione fondamentale con cui conviene concludere l’esame di questo tema, cioè come ci si debba comportare con gli ingrati. Con animo tranquillo, mansueto e magnanimo. Un uomo tanto insensibile, immemore e ingrato non ti offenda mai a tal punto da non farti provare gioia per aver donato; un’offesa ricevuta non ti spinga mai a pronunciare frasi come: «Vorrei non averlo fatto». Accetta anche l’esito sfortunato del tuo beneficio: se tu non ti penti nemmeno ora, l’ingrato si pentirà continuamente. Non hai motivo di indignarti, come se fosse accaduto qualcosa di strano; dovresti meravigliarti di più se non fosse accaduto. C’è chi è trattenuto dalla fatica, chi dalla spesa, chi dal rischio, chi da una falsa vergogna di confessare, ricambiando, di aver ricevuto, chi dall’ignoranza del suo dovere, chi dalla pigrizia, chi dalle sue occupazioni. Se guardi come la smisurata fame degli uomini li tenga sempre a bocca aperta, sempre pronti a chiedere continuamente, non ti meraviglierai che nessuno contraccambi, visto che a nessuno sembra abbastanza quello che ha ricevuto. Chi fra costoro ha un carattere così fermo e saldo che tu possa affidargli, in tutta sicurezza, dei benefìci? Uno impazzisce per la libidine, un altro è schiavo del ventre; un altro è tutto dedito al guadagno e
guarda non ai mezzi ma al risultato; un altro è tormentato dall’invidia, un altro da una cieca ambizione che lo getta fra le spade. Aggiungi il torpore della mente e la vecchiaia o, al contrario, l’agitazione e il tumulto continuo di un animo inquieto, l’eccessiva stima di sé e l’orgoglio insolente che si gonfia proprio per quei motivi per i quali è invece da disprezzare. E che dire di coloro che perseverano nel male e dei superficiali che passano continuamente da una cosa all’altra? Aggiungi ancora la temerarietà sconsiderata e la codardia, che non darà mai un consiglio di cui fidarsi, e i mille errori in cui ci rivoltiamo: l’audacia dei più timorosi, la discordia dei più intimi e, male comune, la fiducia nelle cose più incerte, la nausea per quei beni che prima non speravamo neppure di poter ottenere. Tra queste passioni agitatissime tu cerchi la buona fede, la cosa quieta per eccellenza? 27. Se ti si presenta alla mente la vera immagine della nostra vita, ti sembrerà di vedere una città interamente espugnata, nella quale, svanito ogni rispetto per il pudore e la giustizia, è la forza a decidere tutto. Come se fosse stato dato il segnale per sovvertire ogni cosa, non ci si astiene né dal ferro né dal fuoco; i delitti sono sottratti alle punizioni legali; neppure la religione, che di solito fra le armi nemiche protegge i supplici, costituisce un freno per coloro che si avventano sulla preda. Chi saccheggia beni privati, chi beni pubblici, chi cose profane, chi cose sacre; uno sfonda, un altro scavalca; un altro, non contento di uno stretto passaggio, ribalta ciò che lo ostacola e trae guadagno dalla rovina; questo saccheggia senza fare stragi, quello si riempie di bottino sporcandosi le mani di sangue; non c’è individuo che non si porti via qualcosa di un altro. Di fronte a questa avidità del genere umano, ti dimentichi del destino comune, tu che, in mezzo a gente che pensa solo a depredare, vai cercando qualcuno che ti restituisca ciò che gli hai dato! Se disdegni gli ingrati, disdegna anche i lussuriosi, gli avari, i disonesti, gli ammalati deformi, i vecchi pallidi. L’ingratitudine è un vizio funesto, insopportabile, che divide gli uomini, che mina e distrugge la concordia, sostegno della nostra debolezza, ma è talmente comune che non vi sfuggono neppure coloro che se ne lamentano. 28. Pensa fra te se hai dimostrato la tua riconoscenza a tutti coloro coi quali eri in debito, se non sia andato perduto nessuno dei benefìci che hai ricevuto, se il ricordo del bene che ti è stato fatto ti accompagni sempre. Scoprirai che i benefìci ricevuti quando eri bambino li hai dimenticati prima ancora dell’adolescenza, quelli che ti sono stati concessi nella giovinezza non sono durati nella memoria fino alla vecchiaia; alcuni li abbiamo persi, altri li abbiamo rimossi, altri sono usciti a poco a poco dalla nostra vista, da altri abbiamo distolto deliberatamente lo sguardo. Per giustificare la tua debolezza ti dirò che prima di tutto la memoria è un vaso fragile e non basta per contenere una grande quantità di cose; è inevitabile che lasci sfuggire ciò che riceve e che cancelli con ricordi più recenti quelli più antichi. Perciò la tua nutrice ormai ha un’autorità
minima su di te, perché il molto tempo trascorso ha distanziato troppo il suo beneficio; perciò, essendo impegnato nei comizi per essere eletto console o candidato al sacerdozio, ti è uscito dalla memoria chi ha appoggiato la tua nomina a questore. Forse, se ti esaminassi a fondo, troveresti in te proprio quel vizio di cui ti lamenti. È ingiusto che ti arrabbi per una colpa comune a tutti, ma per una colpa tua è da stolti: se vuoi essere assolto, perdona. Sopportando un ingrato lo renderai migliore, rimproverandolo lo renderai peggiore. Non c’è motivo di fargli perdere la capacità di arrossire: se gli resta ancora un po’ di pudore, lascia che lo conservi. Spesso un rimprovero troppo forte annienta un sentimento di vergogna ancora incerto. Nessuno ha paura di diventare realmente ciò che sembra già: chi è colto in flagrante perde ogni senso di vergogna. 29. «Ho perso il beneficio». Ma diciamo forse di aver perso le offerte fatte agli dèi? Ebbene, fra le offerte c’è il beneficio: anche se non ha dato buoni frutti, è stato giusto concederlo. Il destinatario non è quale speravamo: siamo noi, dunque, quali siamo sempre stati, diversi da lui. Allora la nostra perdita non si è verificata, si è fatta evidente. L’ingrato quando viene smascherato getta vergogna anche su di noi, perché lamentarsi di aver perso un beneficio è come dimostrare che non è stato dato bene. Per quanto ci è possibile, difendiamo presso noi stessi la causa dell’ingrato: «Forse non ha potuto, forse non lo sapeva, forse ha intenzione di ricambiare». Come un creditore paziente e saggio può far diventare alcuni buoni pagatori, sostenendoli e favorendoli con dilazioni, così dobbiamo fare noi: aiutiamo la buona fede a vivere quando sta per venir meno. 30. «Ho perso un beneficio». Come uno stolto, tu ignori il momento della tua perdita: il beneficio l’hai perso quando l’hai dato, ora la perdita è solo diventata evidente. Anche nelle cose che ci sembrano disperate giova moltissimo la moderazione: come i mali del corpo, così quelli dell’anima vanno trattati con delicatezza. Spesso ciò che si potrebbe risolvere con la perseveranza viene rotto da uno strappo brusco. Che maledici a fare? Che ti lamenti a fare? Che bisogno c’è di attaccare duramente? Perché lo sciogli dal suo obbligo? Perché lo lasci andare? Se è un ingrato, già non ti deve nulla. Perché esasperare uno a cui hai fatto tanto bene, trasformandolo da amico incerto in nemico sicuro, e tale che cerchi di giustificarsi di fronte al nostro biasimo? Non mancherà qualcuno che dica: «Non capisco perché non possa sopportare colui al quale è debitore di tanto: c’è sotto qualcosa». Ognuno, lamentandosi, anche se non la corrompe, macchia l’onorabilità di chi gli è superiore; e non c’è chi si appaghi di calunnie di poco conto, quando cerca di procurarsi credito proprio con l’enormità delle sue menzogne. 31. Quanto è preferibile il metodo di conservare un’apparente amicizia e, se lui vuole rinsavire, un’amicizia autentica! La perseveranza nella bontà vince i malvagi, né c’è persona dall’animo così insensibile e così ostile di fronte a ciò
che merita amore che non ami chi resta buono anche se offeso, a cui deve già il primo favore di aver potuto impunemente non pagare il suo debito. Volgi le tue riflessioni in questa direzione: «Non mi è stato dato alcun contraccambio; cosa devo fare? Ciò che fanno gli dèi, ottimi creatori di tutte le cose, che fanno del bene anche a chi non se ne accorge e continuano a farlo anche agli ingrati. Chi li accusa di negligenza nei nostri confronti, chi di ingiustizia; chi li butta fuori dal nostro mondo e li lascia nell’ignavia e nell’inerzia, senza luce e senza alcuna attività. Il sole, al quale dobbiamo la possibilità di dividere il nostro tempo tra fatica e riposo e di sfuggire alla confusione di una notte eterna che ci inghiottirebbe nelle tenebre, il sole, che regola l’anno col suo corso e nutre i corpi, fa germogliare le sementi e maturare i frutti, c’è chi lo chiama “un pezzo di roccia”15 o “un globo di fuochi ammassati dal caso”16 o in qualunque altro modo tranne che dio. Ciò nonostante, come quegli ottimi genitori, che sorridono alle parole offensive dei loro bambini, gli dèi non smettono di accumulare benefìci su coloro che mettono in dubbio l’esistenza del benefattore, ma distribuiscono in egual misura i loro benefìci tra i popoli, avendo avuto in sorte l’unica facoltà di essere utili: bagnano le terre con piogge al momento opportuno, muovono i mari col vento, distinguono le stagioni col corso degli astri, mitigano l’inverno e l’estate inviando un vento leggero, sopportano, sereni e benevoli, gli errori degli animi incerti. Imitiamoli! Diamo, anche se molto di ciò che abbiamo dato è andato sprecato; ciò nonostante, diamo ad altri e diamo a quegli stessi che ci hanno causato delle perdite. Il crollo di una casa non ha mai dissuaso nessuno dal costruirne altre e quando il fuoco ha distrutto un’abitazione, gettiamo le fondamenta sul terreno ancora tiepido e spesso affidiamo intere città allo stesso suolo su cui sono bruciate, tanto l’animo continua ostinatamente a essere ottimista! L’attività umana sulla terra e sul mare cesserebbe se non avessimo voglia di ritentare ciò che la prima volta è andato male. 32. È un ingrato: ha fatto un torto non a me, ma a sé stesso; io ho tratto giovamento dal bene che ho fatto nel momento stesso in cui l’ho fatto. Non per questo sarò più pigro nel dare, starò solo più attento. Ciò che ho perso dando a costui lo riceverò da altri. Ma anche a costui farò ancora del bene e come un buon agricoltore vincerò, come lui vince con la coltivazione e le cure la sterilità del suolo. Io ho perduto un beneficio, costui è perduto per tutti. Non c’è grandezza d’animo nel fare del bene e perderlo; c’è invece nel perderlo e continuare a farlo».
1. Virgilio, Georgiche, II 45. 2. Demetrio Cinico, filosofo molto ammirato da Seneca, che da lui riprende spunti di riflessione (sul piacere, sulla morte, sul lusso dei potenti).
3. Onesicrito di Astipalea, storico greco, seguì Alessandro Magno nella sua campagna d’Asia. 4. Ciro il Grande, fondatore dell’impero persiano, estese il suo dominio verso Occidente fino all’Egeo, assoggettando il regno di Lidia, la Palestina, la Fenicia e tutte le colonie greche dell’Asia Minore, guadagnandosi l’appellativo di «re del mondo». Cambise, figlio di Ciro il Grande, sottomise l’Egitto, poi passò nella Nubia e nella Libia. 5. Mario Curio Dentato, politico romano, quattro volte console, sottomise i Sanniti, i Sabini e i Lucani e respinse l’attacco di Pirro presso Benevento. 6. Un sestario equivaleva a circa mezzo litro. 7. Armodio e Aristogitone sono due giovani ateniesi che nel 514 a.C. congiurarono contro i tiranni Ippia e Ipparco, figli di Pisistrato. Ippia, scampato alla morte, li fece giustiziare. 8. Apollodoro fu tiranno di Cassandria (l’antica Potidea) in Macedonia; Falaride è il crudele tiranno di Agrigento che ideò il famoso “toro di Falaride”, simulacro taurino di bronzo cavo che veniva arroventato dopo avervi rinchiuso i condannati a morte. 9. I pitagorici erano i sostenitori della metempsicosi, secondo cui l’anima è costretta a reincarnarsi più volte per espiare una colpa originaria. 10. Virgilio, Eneide, XII 84. 11. Ovidio, Metamorfosi, XIII 801. 12. Aristippo di Cirene, discepolo di Socrate, da cui in seguito si discostò assumendo un atteggiamento di indipendenza, di pensiero e di vita. 13. Virgilio, Eneide, IV 373. 14. Virgilio, Eneide, IV 317. 15. Definizione di Anassagora. 16. Definizione di Epicuro.
Naturales quaestiones
Liber primus Prooemium Quantum inter philosophiam interest, Lucili virorum optime, et ceteras artes, tantum interesse existimo in ipsa philosophia inter illam partem quae ad homines et hanc quae ad deos pertinet. Altior est haec et animosior; multum permisit sibi; non fuit oculis contenta; maius esse quiddam suspicata est ac pulchrius quod extra conspectum natura posuisset. Denique inter duas interest quantum inter deum et hominem. Altera docet quid in terris agendum sit, altera quid agatur in caelo. Altera errores nostros discutit et lumen admovet quo discernantur ambigua vitae; altera multum supra hanc in qua volutamur caliginem excedit et e tenebris ereptos perducit illo unde lucet. Equidem tunc rerum naturae gratias ago cum illam non ab hac parte video qua publica est, sed cum secretiora eius intravi, cum disco quae universi materia sit, quis auctor aut custos, quid sit deus, totus in se tendat an et ad nos aliquando respiciat, faciat cotidie aliquid an semel fecerit, pars mundi sit an mundus, liceat illi hodieque decernere et ex lege fatorum aliquid derogare an maiestatis deminutio sit et confessio erroris mutanda fecisse … necesse est eadem placere ei cui nisi optima placere non possunt. Nec ob hoc minus liber est ac potens; ipse est enim necessitas sua. Nisi ad haec admitterer, non tanti fuerat nasci. Quid enim erat cur in numero viventium me positum esse gauderem? An ut cibos et potiones percolarem? Ut hoc corpus causarium ac fluidum, periturumque nisi subinde impletur, farcirem et viverem aegri minister? Ut mortem timerem, cui uni nascimur? Detrahe hoc inaestimabile bonum, non est vita tanti ut sudem, ut aestuem. O quam contempta res est homo, nisi supra humana surrexerit! Quamdiu cum affectibus colluctamur, quid magnifici facimus? Etiamsi superiores sumus, portenta vincimus. Quid est cur suspiciamus nosmet ipsi quia dissimiles deterrimis sumus? Non video quare sibi placeat qui robustior est in valetudinario. Multum interest inter vires et bonam valetudinem. Effugisti vitia animi; non est tibi frons ficta, nec in alienam voluntatem sermo compositus, nec cor involutum, nec avaritia quae, quicquid omnibus abstulit, sibi ipsi neget, nec luxuria pecuniam turpiter perdens quam turpius reparet, nec ambitio quae te ad dignitatem nisi per indigna non ducet: nihil adhuc consecutus es; multa effugisti, te nondum. Virtus enim ista quam affectamus magnifica est, non quia per se beatum est malo caruisse, sed quia animum laxat et praeparat ad cognitionem caelestium dignumque efficit qui in consortium deo veniat. Tunc consummatum
habet plenumque bonum sortis humanae cum calcato omni malo petit altum et in interiorem naturae sinum venit. Tunc iuvat inter ipsa sidera vagantem divitum pavimenta ridere et totam cum auro suo terram, non illo tantum dico quod egessit et signandum monetae dedit, sed et illo quod in occulto servat posterorum avaritiae. Non potest ante contemnere porticus et lacunaria ebore fulgentia et tonsiles silvas et derivata in domos flumina quam totum circumit mundum et, terrarum orbem superne despiciens angustum et magna ex parte opertum mari, etiam ea qua extat late squalidum et aut ustum aut rigentem, sibi ipse dixit: «Hoc est illud punctum quod inter tot gentes ferro et igne dividitur? O quam ridiculi sunt mortalium termini! Ultra Istrum Dacos nostrum arceat imperium, Haemo Thraces includat; Parthis obstet Euphrates; Danuvius Sarmatica ac Romana disterminet; Rhenus Germaniae modum faciat; Pyrenaeus medium inter Gallias et Hispanias iugum extollat; inter Aegyptum et Aethiopas harenarum inculta vastitas iaceat. Si quis formicis det intellectum hominis, nonne et illae unam aream in multas provincias divident? Cum te in illa vere magna sustuleris, quotiens videbis exercitus subrectis ire vexillis et, quasi magnum aliquid agatur, equitem modo ulteriora explorantem, modo a lateribus affusum, libebit dicere: it nigrum campis agmen. Formicarum iste discursus est in angusto laborantium. Quid illis et nobis interest nisi exigui mensura corpusculi?». Punctum est istud in quo navigatis, in quo bellatis, in quo regnatis. †Ponitis minima, etiam cum illis utrimque oceanus occurrit. Sursum ingentia spatia sunt, in quorum possessionem animus admittitur, et ita si secum minimum ex corpore tulit, si sordidum omne detersit et expeditus levisque ac contentus modico emicuit. Cum illa tetigit, alitur, crescit ac velut vinculis liberatus in originem redit et hoc habet argumentum divinitatis suae quod illum divina delectant, nec ut alienis, sed ut suis interest. Secure spectat occasus siderum atque ortus et tam diversas concordantium vias; observat ubi quaeque stella primum terris lumen ostendat, ubi columen eius summumque cursus sit, quousque descendat; curiosus spectator excutit singula et quaerit. Quidni quaerat? Scit illa ad se pertinere. Tunc contemnit domicilii prioris angustias. Quantum est enim quod ab ultimis litoribus Hispaniae usque ad Indos iacet? Paucissimorum dierum spatium, si navem suus ferat ventus. At illa regio caelestis per triginta annos velocissimo sideri viam praestat nusquam resistenti sed aequaliter cito. Illic demum discit quod diu quaesiit; illic incipit deum nosse. Quid est deus? Mens universi. Quid est deus? Quod vides totum et quod non vides totum. Sic demum magnitudo illi sua redditur, qua nihil maius cogitari potest, si solus est omnia, si opus suum et intra et extra tenet. Quid ergo interest inter naturam dei et nostram? Nostri melior pars animus est; in illo nulla pars extra animum est. Totus est ratio, cum interim tantus error mortalia tenet ut hoc, quo neque formosius est quicquam nec dispositius nec in
proposito constantius, existiment homines fortuitum et casu volubile ideoque tumultuosum inter fulmina nubes tempestates et cetera quibus terrae ac terris vicina pulsantur. Nec haec intra vulgum dementia est sed sapientiam quoque professos contigit. Sunt qui putent ipsis animum esse, et quidem providum, dispensantem singula et sua et aliena, hoc autem universum, in quo nos quoque sumus, expers consilii aut ferri temeritate quadam aut natura nesciente quid faciat. Quanti aestimas ista cognoscere et rebus terminos ponere, quantum deus possit; materiam ipse sibi formet an data utatur; utrum utro sit prius, materiae supervenerit ratio an materia rationi; deus quicquid vult efficiat an in multis rebus illum tractanda destituant et a magno artifice prave multa formentur, non quia cessat ars, sed quia id in quo exercetur saepe inobsequens arti est? Haec inspicere, haec discere, his incubare, nonne transilire est mortalitatem suam et in meliorem transcribi sortem? – Quid tibi, inquis, ista proderunt? – Si nil aliud, hoc certe: sciam omnia angusta esse mensus deum. 1. Nunc, ut ad propositum opus veniam, audi quid de ignibus sentiam quos aer transversos agit. Magna illos vi excuti argumentum est quod obliqui feruntur et praerapida celeritate; apparet illos non ire, sed proici. Ignium multae variaeque facies sunt. Aristoteles quoddam genus horum capram vocat. Si me interrogaveris quare, prior mihi rationem reddas oportet quare haedi vocentur. Si autem, quod commodissimum est, convenerit inter nos ne alter alterum interroget quod scit illum respondere non posse, satius erit de re ipsa quaerere quam mirari quid ita Aristoteles globum ignis appellaverit capram. Talis enim fuit forma eius qui bellum adversus Persen Paulo gerente lunari magnitudine apparuit. Vidimus nos quoque non semel flammam ingentis pilae specie, quae tamen in ipso cursu suo dissipata est. Vidimus circa divi Augusti excessum simile prodigium. Vidimus eo tempore quo de Seiano actum est, nec Germanici mors sine denuntiatione tali fuit. Dices mihi: «Ergo tu in tantis erroribus es ut existimes deos mortium signa praemittere et quicquam in terris esse tam magnum quod perire mundus sciat?». Erit aliud istius rei tempus. Videbimus an rerum omnium certus ordo ducatur et alia aliis ita implexa sint ut quod antecedit aut causa sit sequentium aut signum. Videbimus an diis humana curae sint; an series ipsa, quid factura sit, certis rerum notis nuntiet. Interim illud existimo eiusmodi ignes existere aere vehementius trito, cum inclinatio eius in alteram partem facta est et non cessit, sed inter se pugnavit; ex hac vexatione nascuntur trabes et globi et faces et ardores. At cum levius collisus et, ut ita dicam, frictus est, minora lumina excutiuntur, crinemque volantia sidera ducunt. Tunc ignes tenuissimi iter exile designant et caelo producunt. Ideo nulla sine eiusmodi spectaculis nox est; non enim opus est ad efficienda ista magno aeris motu. Denique, ut breviter dicam, eadem ratione fiunt ista qua fulmina, sed vi
minore: quemadmodum nubes collisae mediocriter fulgurationes efficient, maiore impetu impulsae fulmina, sic quanto illas minus presseris minoresve, tanto leviora lumina emittent. Aristoteles rationem eiusmodi reddit. Varia et multa terrarum orbis expirat, quaedam umida, quaedam sicca, quaedam calentia, quaedam concipiendis ignibus idonea. Nec mirum est si terrae omnis generis et varia evaporatio est, cum in caelo quoque non unus appareat color rerum, sed acrior sit Caniculae rubor, Martis remissior, Iovis nullus in lucem puram nitore perducto. Necesse est ergo, in magna copia corpusculorum quae terrae eiectant et in superiorem agunt partem, aliqua in nubes pervenire alimenta ignium, quae non tantum collisa possint ardere sed etiam afflata radiis solis; nam apud nos quoque ramenta sulphure aspersa ignem ex intervallo trahunt. Veri ergo simile est talem materiam inter nubes congregatam facile succendi et minores maioresve ignes existere, prout plus illis fuit aut minus virium. Illud enim stultissimum, existimare aut decidere stellas, aut transilire, aut aliquid illis auferri et abradi. Nam si hoc fuisset, etiam defuissent; nulla enim nox est qua non plurimae ire et in diversum videantur abduci. Atqui, quo solet, quaeque invenitur loco et magnitudo sua singulis constat; sequitur ergo ut infra illas ista nascantur et cito intercidant quia sine fundamento et sede certa sunt. – Quare ergo non etiam interdiu transferuntur? – Quid, si dicas stellas interdiu non esse, quia non apparent? Quemadmodum illae latent et solis fulgore obumbrantur, sic faces quoque transcurrunt et interdiu, sed abscondit illas diurni luminis claritas. Si quando tamen tanta vis emicuit ut etiam adversus diem vindicare sibi fulgorem suum possint, apparent. Nostra certe aetas non semel vidit diurnas faces, alias ab oriente in occidentem versas, alias ab occasu in ortum. Argumentum tempestatis nautae putant, cum multae transvolant stellae. Quod si ventorum signum est, ibi est unde venti sunt, id est in aere, qui medius inter lunam terrasque est. In magna tempestate apparere quasi stellae solent velo insidentes; adiuvari se tunc periclitantes aestimant Pollucis et Castoris numine. Causa autem melioris spei est quod iam apparet frangi tempestatem et desinere ventos; alioquin ferrentur ignes, non sederent. Gylippo Syracusas petenti visa est stella super ipsam lanceam constitisse. In Romanorum castris ardere visa sunt pila, ignibus scilicet in illa delapsis. Qui saepe fulminum modo ferire solent et animalia et arbusta; sed si minore vi utuntur, defluunt tantum et insidunt, non feriunt nec vulnerant. Alii autem inter nubes eliduntur; alii sereno, si aer ad exprimendos ignes aptus fuit. Nam sereno quoque aliquando caelo tonat ex eadem causa qua nubilo, aere inter se colliso, qui, etiamsi est lucidior ac siccior, coire tamen et facere corpora quaedam similia nubibus potest, quae percussa reddant sonum. Quando ergo fiunt trabes? Quando clipei et vastorum imagines ignium? Ubi in talem materiam similis incidit causa, sed maior. 2. Videamus nunc quemadmodum fiat is fulgor qui sidera circumvenit. Memoriae proditum est, quo die Urbem divus Augustus Apollonia reversus
intravit, circa solem visum coloris varii circulum, qualis esse in arcu solet. Hunc Graeci halo vocant, nos dicere coronam aptissime possumus. Quae quemadmodum fieri dicatur, exponam. Cum in piscinam lapis missus est, videmus in multos orbes aquam discedere et fieri primum angustissimum orbem, deinde laxiorem ac deinde alios maiores, donec evanescat impetus et in planitiem immotarum aquarum solvatur. Tale quiddam cogitemus fieri etiam in aere. Cum spissior factus est, sentire plagam potest; lux solis aut lunae vel cuiuslibet sideris incurrens recedere illum in circulos cogit. Nam umor et aer et omne quod ex ictu formam accipit in talem habitum impellitur qualis est eius quod impellit; omne autem lumen rotundum est; ergo et aer in hunc modum lumine percussus exibit. Ob hoc tales splendores Graeci areas vocaverunt quia fere terendis frugibus destinata loca rotunda sunt. Non est autem quod existimemus istas, sive areae sive coronae sunt, in vicinia siderum fieri. Plurimum enim ab his absunt, quamvis cingere ea et coronare videantur; non longe a terra fit talis effigies, quam visus noster solita imbecillitate deceptus circa ipsum sidus putat positam. In vicinia autem stellarum et solis nihil tale fieri potest, quia illic tenuis aether est. Nam formae crassis demum spissisque corporibus imprimi solent; in subtilibus non habent ubi consistant aut haereant. In balneis quoque circa lucernam tale quiddam aspici solet ob aeris densi obscuritatem; frequentissime autem austro, cum caelum maxime grave et spissum est. Nonnumquam paulatim diluuntur et desinunt. Nonnumquam ab aliqua parte rumpuntur et inde ventum nautici expectant unde contextus coronae perit: si a septemtrione discessit, aquilo erit; si ab occidente, favonius. Quod argumentum est intra eam partem caeli has fieri coronas intra quam venti quoque esse solent; superiora non habent coronas, quia ne ventos quidem. His argumentis et illud adice numquam coronam colligi nisi stabili aere et pigro vento; aliter non solet aspici. Nam qui stat aer impelli et diduci et in aliquam faciem fingi potest. Is autem qui fluit ne feritur quidem lumine; non enim resistit nec formatur, quia prima quaeque pars eius dissipatur. Numquam ergo ullum sidus talem sibi effigiem circumdabit, nisi cum aer erit densus atque immotus et ob hoc custodiens incidentem in se rotundi lineam luminis. Nec sine causa. Repete enim exemplum quod paulo ante proposui. Lapillus in piscinam aut lacum et alligatam aquam missus circulos facit innumerabiles; at hoc idem non faciet in flumine. Quare? Quia omnem figuram fugiens aqua disturbat. Idem ergo in aere evenit, ut ille qui manet possit figurari, at ille qui rapitur et currit non det sui potestatem et omnem ictum venientemque formam ex eo turbet. Hae de quibus dixi coronae, cum dilapsae sunt aequaliter et in semet ipsae evanuerunt, significatur quies aeris et otium et tranquillitas; cum ad unam partem cesserunt, illinc ventus est unde finduntur; si ruptae pluribus locis sunt, tempestas fit. Quare id accidat, ex his quae iam exposui intellegi potest. Nam si facies universa subsedit, apparet temperatum esse aera, et sic placidum. Si ab una parte intercisa est, apparet inde aera incumbere, et ideo illa regio ventum dabit. At cum
undique lacerata et concerpta est, manifestum est a pluribus partibus in illam impetum fieri et inquietum aera hinc atque illinc assilire; itaque ex hac inconstantia caeli tam multa temptantis et undique laborantis apparet futura tempestas ventorum plurium. Hae coronae noctibus fere circa lunam et alias stellas notantur; interdiu raro, adeo ut quidam ex Graecis negaverint omnino eas fieri, cum illos historiae coarguant. Causa autem raritatis haec est quod solis fortius lumen est et aer ipse agitatus ab illo calefactusque solutior. Lunae inertior vis est ideoque facilius a circumposito aere sustinetur. Aeque cetera sidera infirma sunt nec perrumpere aera vi sua possunt; excipitur itaque illorum imago et in materia solidiore ac minus cedente servatur. Debet enim aer nec tam spissus esse ut excludat ac summoveat a se lumen immissum, nec tam tenuis aut solutus ut nullam venientibus radiis moram praebeat. Haec noctibus temperatura contingit, cum sidera circumiectum aera luce leni non pugnaciter nec aspere feriunt spissioremque quam solet esse interdiu inficiunt. 3. At contra arcus nocte non fit aut admodum raro, quia luna non habet tantum virium ut nubes transeat et illis colorem suffundat, qualem accipiunt sole perstrictae. Sic enim formam arcus discoloris efficiunt. Quia aliae partes in nubibus tumidiores sunt, aliae summissiores, quaedam crassiores quam ut solem transmittant, aliae imbecilliores quam ut excludant, haec inaequalitas alternis lucem umbramque permiscet et exprimit illam mirabilem arcus varietatem. Altera causa arcus eiusmodi redditur. Videmus, cum fistula aliquo loco rupta est, aquam per tenue foramen elidi, quae sparsa contra solem oblique positum faciem arcus repraesentat. Idem videbis accidere, si quando volueris observare fullonem; cum os aqua implevit et vestimenta tendiculis diducta leviter aspergit, apparet varios edi colores in illo aere asperso, quales fulgere in arcu solent. Huius rei causam in umore esse ne dubitaveris; non fit enim umquam arcus nisi nubilo. Sed quaeramus quemadmodum fiat. Quidam aiunt esse aliqua stillicidia quae solem transmittant, quaedam magis coacta quam ut transluceant; itaque ab illis fulgorem reddi, ab his umbram, et sic utriusque intercursu effici arcum in quo pars fulgeat, quae solem recipit, pars obscurior sit, quae exclusit et ex se umbram proximis fecit. Hoc ita esse quidam negant. Poterat enim verum videri, si arcus duos tantum haberet colores, si ex lumine umbraque constaret. Nunc diversi niteant cum mille colores, transitus ipse tamen spectantia lumina fallit: usque adeo quod tangit idem est, tamen ultima distant. Videmus in eo aliquid flammei, aliquid lutei, aliquid caerulei et alia in picturae modum subtilibus lineis ducta. Ut ait poeta, an dissimiles colores sint, scire non possis, nisi cum primis extrema contuleris. Nam commissura decipit,
usque eo mira arte naturae: quod a simillimo coepit, in dissimillimo desinit. Quid ergo istic duo colores faciunt lucis atque umbrae, cum innumerabilium ratio reddenda sit? Quidam ita existimant arcum fieri: in ea parte in qua iam pluit singula stillicidia pluviae cadentis singula esse specula, a singulis ergo reddi imaginem solis; deinde multas imagines, immo innumerabiles, et devexas et in praeceps euntes confundi; itaque arcum esse multarum solis imaginum confusionem. Hoc sic colligunt. Pelves, inquiunt, mille sereno die pone, omnes habebunt imagines solis; in singulis foliis dispone guttas, singulae habebunt imaginem solis. At contra ingens stagnum non amplius habebit quam unam imaginem. Quare? Quia omnis circumscripta levitas et circumdata suis finibus speculum est. Itaque piscinam ingentis magnitudinis insertis parietibus divide, totidem illa habebit imagines solis quot lacus habuerit; relinque illam sic ut est diffusa, semel tibi imaginem reddet. Nihil refert quam exiguus sit umor aut lacus; si determinatus est, speculum est. Ergo stillicidia illa infinita quae imber cadens defert, totidem specula sunt, totidem solis facies habent. Hae contra intuenti perturbatae apparent, nec dispiciuntur intervalla quibus singulae distant, spatio prohibente discerni; deinde pro singulis apparet una facies turbida ex omnibus. Aristoteles idem iudicat. Ab omni, inquit, levitate acies radios suos replicat; nihil autem est levius aqua et aere; ergo etiam ab aere spisso visus noster in nos redit. Ubi vero acies hebes et infirma est, qualislibet aeris ictu deficiet. Quidam itaque hoc genere valetudinis laborant ut ipsi sibi videantur occurrere, ut ubique imaginem suam cernant. Quare? Quia infirma vis oculorum non potest perrumpere ne sibi quidem proximum aera, sed resilit. Itaque, quod in aliis efficit densus aer, in his facit omnis; satis enim valet qualiscumque ad imbecillam aciem repellendam. Longe autem magis visum nobis nostrum remittit aqua, quia crassior est et pervinci non potest, sed radios luminum nostrorum moratur et eo unde exierunt reflectit. Ergo, cum multa stillicidia sint, totidem specula sunt; sed, quia parva sunt, solis colorem sine figura exprimunt. Deinde, cum in stillicidiis innumerabilibus et sine intervallo cadentibus reddatur idem color, incipit facies esse non multarum imaginum et intermissarum, sed unius longae atque continuae. – Quomodo, inquis, tu mihi multa milia imaginum istic esse dicis ubi ego nullam video? Et quare, cum solis color unus sit, imaginum diversus est? – Ut et haec quae proposuisti refellam et alia quae non minus refellenda sunt, illud dicam oportet, nihil esse acie nostra fallacius non tantum in his a quibus subtiliter pervidendis illam locorum diversitas submovet, sed etiam in his quoque quae ad manum cernit. Remus tenui aqua tegitur et fracti speciem reddit; poma per vitrum aspicientibus multo maiora sunt; columnarum intervalla porticus longior iungit.Ad ipsum solem revertere. Hunc, quem toto terrarum orbe maiorem probat ratio, acies nostra sic contraxit ut sapientes viri pedalem esse contenderent; quem velocissimum omnium scimus, nemo nostrum moveri videt, nec ire crederemus, nisi appareret isse. Mundum ipsum praecipiti velocitate labentem et ortus occasusque intra momentum temporis revolventem nemo nostrum sentit
procedere. Quid ergo miraris, si oculi nostri imbrium stillicidia non separant et ex ingenti spatio intuentibus minutarum imaginum discrimen interit? Illud dubium esse nulli potest quin arcus imago solis sit roscida et cava nube concepta. Quod ex hoc tibi appareat: numquam non adversa soli est; sublimis aut humilis, prout ille se submisit aut sustulit; in contrarium mota, illo enim descendente altior est, alto depressior. Saepe talis nubes a latere solis est nec arcum efficit, quia non ex recto imaginem trahit. Varietas autem non ob aliam causam fit quam quia pars coloris a sole est, pars a nube illa; umor modo caeruleas lineas, modo virides, modo purpurae similes et luteas aut igneas ducit, duobus coloribus hanc varietatem efficientibus, remisso et intento. Sic enim et purpura eodem conchylio non in unum modum exit; interest quamdiu macerata sit, crassius medicamentum an aquatius traxerit, saepius mersa sit et excocta an semel tincta. Non est ergo mirum si, cum duae res sint, sol et nubes, id est corpus et speculum, tam multa genera colorum exprimuntur quam multis generibus possunt ista incitari aut relanguescere; alius est enim color ex igneo lumine, alius ex obtunso et leniore. In aliis rebus vaga inquisitio est, ubi non habemus quod manu tenere possimus et late coniectura mittenda est; hic apparet duas causas esse arcus, solem nubemque, quia nec sereno umquam fit, nec nubilo ita ut sol lateat; ergo utique ex his est quorum sine altero non est. 4. Iam nunc illud accedit quod aeque manifestum est speculi ratione imaginem reddi, quia numquam nisi e contrario redditur, id est nisi ex altera parte stetit quod appareret, ex altera quod ostenderet. Rationes, quae non persuadent sed cogunt, a geometris afferuntur nec dubium cuiquam relinquitur quin arcus imago solis sit male expressi ob vitium figuramque speculi. Nos interim temptemus alias probationes quae de plano legi possint. Inter argumenta sic nascentis arcus pono quod celerrime nascitur. Ingens enim variumque corpus intra momentum subtexitur caelo et aeque celeriter aboletur. Nihil autem tam cito redditur quam a speculo imago; non enim facit quicquam sed ostendit. Parianus Artemidorus adicit etiam quale genus nubis esse debeat quod talem soli imaginem reddit. Si speculum, inquit, concavum feceris, quod sit sectae pilae pars, si extra medium constiteris, quicumque iuxta te steterint inversi tibi videbuntur et propiores a te quam a speculo. Idem, inquit, evenit, cum rotundam et cavam nubem intuemur a latere, ut solis imago a nube discedat propiorque nobis sit et in nos magis conversa. Color illi igneus a sole est, caeruleus a nube, ceteri utriusque mixturae. 5. Contra haec illa dicuntur. De speculis duae opiniones sunt. Alii enim in illis simulacra cerni putant, id est corporum nostrorum figuras a nostris corporibus emissas ac separatas; alii non imagines in speculo sed ipsa aspici corpora retorta oculorum acie et in se rursus reflexa. Nunc nihil ad rem pertinet quomodo videamus quodcumque videmus; sed, quae modo est imago, similis
reddi debet e speculo. Quid autem est tam dissimile quam sol et arcus, in quo neque figura solis neque color neque magnitudo apparet? Arcus longe amplior est longeque ea parte qua fulget rubicundior quam sol, ceteris vero coloribus diversus. Deinde, cum velis speculum inesse aeri, des oportet mihi eandem levitatem corporis, eandem aequalitatem, eundem nitorem. Atqui nullae nubes habent similitudinem speculi; per medias saepe transimus nec in illis nos cernimus; qui montium summa conscendunt, despectant nubem nec tamen imaginem in illa suam aspiciunt. – Singula stillicidia singula specula sunt. – Concedo, sed illud nego ex stillicidiis constare nubem. Habent enim quaedam ex quibus fieri stillicidia possint, non ipsa. Ne aquam quidem habet nubes sed materiam futurae aquae. Concedamus tibi et guttas innumerabiles nubibus inesse et illas faciem reddere, non tamen unam omnes reddunt, sed singulae singulas. Deinde inter se specula coniunge, in unam imaginem non coibunt, sed unumquodque in se similitudinem visae rei claudet. Sunt quaedam specula ex multis minutisque composita, quibus si unum ostenderis hominem, populus apparet, unaquaque particula faciem suam exprimente. Haec, cum sint coniuncta et simul collocata, nihilominus seducunt imagines suas et ex uno quidem turbam efficiunt, ceterum catervam illam non confundunt, sed diremptam in facies singulas distrahunt. Arcus autem uno circumscriptus est ductu, una totius est facies. – Quid ergo? Inquit. Non et aqua rupta fistula sparsa et remo excussa habere quiddam simile his quos videmus in arcu coloribus solet? Verum est, sed non ex hac causa ex qua tu videri vis, quia unaquaeque stilla recipiat imaginem solis. Citius enim cadunt stillae quam ut concipere imagines possint. Standum est, ut id quod imitantur excipiant. Quid ergo fit? Colorem, non imaginem ducunt. Alioquin, ut ait Nero Caesar disertissime, Colla Cytheriacae splendent agitata columbae et variis coloribus pavonum cervix, quotiens aliquo deflectitur, nitet. Numquid ergo dicemus specula eiusmodi plumas, quarum omnis inclinatio in colores novos transit? Non minus nubes diversam naturam speculis habent quam aves quas rettuli, et chamaeleontes, et reliqua animalia quorum color aut ex ipsis mutatur, cum ira vel cupidine incensa cutem suam variant umore suffuso, aut positione lucis, quam prout rectam vel obliquam receperunt, ita colorantur. Quid enim simile speculis habent nubes, cum illa non perluceant, hae transmittant lucem; illa densa et coacta, hae rarae sint; illa eiusdem materiae tota, hae e diversis temere compositae et ob hoc discordes nec diu cohaesurae? Praeterea videmus ortu solis partem quandam caeli rubere, videmus nubes aliquando ignei coloris; quid ergo prohibet, quomodo hunc unum colorem accipiunt solis occursu, sic multos ab illis trahi, quamvis non habeant speculi potentiam? Modo, inquit, inter argumenta ponebas semper arcum contra solem excitari,
quia ne a speculo quidem imago redderetur nisi adverso. Hoc, inquit, commune nobis est; nam, quemadmodum opponendum est speculo id cuius in se imaginem transferat, sic, ut nubes infici possint, ita sol ad hoc apte ponendus est. Non enim idem facit, undecumque effulsit, et ad hoc opus est radiorum idoneus ictus. Haec dicuntur ab his qui videri volunt nubem colorari. Posidonius et hi qui speculari ratione talem effici iudicant visum hoc respondent: «Si ullus esset in arcu color, permaneret et viseretur eo manifestius quo propius; nunc imago arcus, ex longinquo clara, interit, cum ex vicino ventum est». Huic contradictioni non consentio, cum ipsam sententiam probem. Quare? Dicam: quia coloratur quidem nubes, sed ita ut color eius non undique appareat. Nam ne ipsa quidem undique apparet; nubem enim nemo qui in ipsa est videt. Quid ergo mirum, si color eius non videtur ab eo a quo ipsa non visitur? Atqui ipsa, quamvis non videatur, est; ergo et color. Ita non est argumentum falsi coloris quod apparere accedentibus desinit. Idem enim in ipsis evenit nubibus, nec ideo falsae sunt quia non videntur. – «Praeterea, cum dicitur tibi nubem sole suffectam, non dicitur tibi colorem illum inustum esse velut duro corpori et stabili ac manenti, sed ut fluido et vago et nihil amplius quam brevem speciem recipienti. Sunt etiam quidam colores qui ex intervallo vim suam ostendunt: purpuram Tyriam, quo melior est saturiorque, eo altius oportet teneas ut fulgorem suum teneat. Non tamen ideo non habet colorem illa, quia, quae optimum habet, non quomodocumque explicatur ostendit». In eadem sententia sum qua Posidonius ut arcum iudicem fieri nube formata in modum concavi speculi et rotundi, cui forma sit partis e pila secta. Hoc probari, nisi geometrae adiuverint, non potest, qui argumentis nihil dubii relinquentibus docent solis illam esse effigiem non similem. Neque enim omnia ad verum specula respondent. Sunt quae videre extimescas, tantam deformitatem corrupta facie visentium reddunt, servata similitudine in peius; sunt quae cum videris placere tibi vires tuae possint, in tantum lacerti crescunt et totius corporis super humanam magnitudinem habitus augetur; sunt quae dextras facies ostendant; sunt quae sinistras; sunt quae detorqueant et vertant. Quid ergo mirum est eiusmodi speculum in nube quoque fieri quo solis species vitiosa reddatur? 6. Inter cetera argumenta et hoc erit quod numquam maior arcus dimidio circulo apparet et quod eo minor est quo altior sol […] Quare tamen, si imago solis est arcus, longe ipso sole maior apparet? Quia est alicuius speculi natura talis ut maiora multo quae vidit ostendat et in portentuosam magnitudinem augeat formas, alicuius invicem talis ut minuat. Illud mihi dic quare in orbem eat facies, nisi orbi redditur? Dices enim fortasse unde sit illi color varius; unde talis figura sit, non dices, nisi aliquod exemplar ad quod formetur ostenderis. Nullum autem quam solis est, a quo cum tu quoque fatearis illi colorem dari, sequitur ut et detur forma. Denique inter me teque convenit colores illos quibus caeli regio depingitur a sole esse; illud unum inter nos non convenit: tu dicis illum colorem
esse, ego videri. Qui sive est, sive videtur, a sole est. Tu non expedies quare color ille subito desinat, cum omnes fulgores paulatim discutiantur. Pro me est et repentina eius facies et repentinus interitus. Proprium enim hoc speculi est, in quo non per partes struitur quod apparet, sed statim totum fit. Aeque cito omnis imago aboletur in illo quam ponitur; nihil enim aliud ad ista efficienda vel removenda opus est quam ostendi et abduci. Non est ergo propria in ista nube substantia, nec corpus est sed mendacium, sine re similitudo. Vis scire hoc ita esse? Desinet arcus, si obtexeris solem. Oppone, inquam, soli alteram nubem, huius varietas interibit. At maior aliquanto est arcus quam sol. Dixi modo fieri specula quae multiplicent omne corpus quod imitantur. Illud adiciam omnia per aquam videntibus longe esse maiora. Litterae quamvis minutae et obscurae per vitream pilam aqua plenam maiores clarioresque cernuntur. Poma formosiora quam sunt videntur, si innatant vitro. Sidera ampliora per nubem aspicienti videntur, quia acies nostra in umido labitur nec apprehendere quod vult fideliter potest. Quod manifestum fiet, si poculum impleveris aqua et in id conieceris anulum; nam, cum in ipso fundo anulus iaceat, facies eius in summa aqua redditur. Quicquid videtur per umorem. Longe amplius vero est: quid mirum maiorem reddi imaginem solis, quae in nube umida visitur, cum ex duabus causis hoc accidat? Quia in nube est aliquid vitro simile quod potest perlucere; est aliquid et aquae, quam, etiamsi nondum habet, iam parat, id est iam eius natura est in quam ex sua vertatur. 7. – Quoniam, inquit, vitri fecisti mentionem, ex hoc ipso argumentum contra te sumam. Virgula solet fieri vitrea, striata vel pluribus angulis in modum clavae torosa. Haec, si in transversum solem accipit, colorem talem qualis in arcu videri solet reddit, ut scias non imaginem hic solis esse, sed coloris imitationem ex repercussu –. Primum in hoc argumento multa pro me sunt: quod apparet a sole fieri; quod apparet leve quiddam esse debere et simile speculo quod solem repercutiat; deinde quod apparet non fieri ullum colorem sed speciem falsi coloris, qualem, ut dixi, columbarum cervix et sumit et ponit, utcumque deflectitur. Hoc autem et in speculo est, cui nullus inditur color, sed simulatio quaedam coloris alieni. Unum hoc tantum mihi solvendum est quod non visitur in ista virgula solis imago. Cuius bene exprimendae capax non est; ita conatur quidem reddere imaginem, quia levis est materia et ad hoc habilis, sed non potest, quia enormiter facta est. Si apta fabricata foret, totidem redderet soles quot habuisset †inspectores. Quae quia discernuntur inter se nec satis in vicem speculi nitent, incohant tantum imagines, nec exprimunt, et ob ipsam viciniam turbant et in speciem coloris unius abducunt. 8. At quare arcus non implet orbem, sed pars dimidia eius videtur, cum plurimum porrigitur incurvaturque? Quidam ita opinantur: «Sol, cum sit multo altior nubibus, a superiore illas tantum percutit parte; sequitur ut inferior pars earum non tingatur lumine; ergo, cum ab una parte solem accipiant, unam eius
partem imitantur, quae numquam dimidia maior est». Hoc argumentum parum potens est. Quare? Quia, quamvis sol ex superiore parte sit, totam tamen percutit nubem; ergo et tingit. Quidni? Cum radios transmittere soleat et omnem densitatem perrumpere. Deinde contrariam rem proposito suo dicunt. Nam, si superior est sol et ideo superiori tantum parti nubium affunditur, numquam terra tenus descendet arcus; atqui usque in humum demittitur. Praeterea numquam non contra solem arcus est. Nihil autem ad rem pertinet supra infrave sit, quia totum quod contra est latus verberatur. Deinde aliquando arcum et occidens facit. Tum certe ex inferiore parte nubes ferit terris propinquus; atqui et tunc dimidia pars est, quamvis solem nubes ex humili et sordido accipiant. Nostri, qui sic in nube quomodo in speculo lumen volunt reddi, nubem cavam faciunt et sectae pilae partem, quae non potest totum orbem reddere, quia ipsa pars orbis est. Proposito accedo, argumento non consentio. Nam, si in concavo speculo tota facies oppositi orbis exprimitur, et in semiorbe nihil prohibet totam aspici pilam. Etiamnunc diximus circulos apparere soli lunaeque in similitudinem arcus circumdatos; quare ille circulus iungitur, in arcu numquam? Deinde quare semper concavae nubes solem accipiunt, non aliquando planae et tumentes? Aristoteles ait post autumnale aequinoctium qualibet hora diei arcum fieri; aestate non fieri, nisi aut incipiente aut inclinato die. Cuius rei causa manifesta est. Primum, quia media diei parte sol calidissimus nubes evincit nec potest imaginem suam ab his recipere quas scindit. At matutino tempore aut vergens in occasum minus habet virium; ideo a nubibus sustineri et repercuti potest. Deinde, cum arcum facere non soleat nisi adversus his in quibus facit nubibus, cum breviores dies sunt, semper obliquus est; itaque qualibet diei parte, etiam cum altissimus est, habet aliquas nubes quas ex adverso ferire possit. At temporibus aestivis super nostrum verticem fertur; itaque medio die excelsissimus terras rectiore aspicit linea quam ut ullis nubibus possit occurri; omnes enim sub se tunc habet. Ut ait Vergilius noster, et bibit ingens arcus, cum adventat imber. Sed non easdem, undecumque apparuit, minas affert. A meridie ortus magnam vim aquarum vehet; vinci enim non potuerunt valentissimo sole, tantum illis est virium. Si circa occasum refulsit, rorabit et leviter impluet. Si ab ortu circave surrexit, serena promittit. 9. Nunc de virgis dicendum est, quas non minus pictas variasque aeque pluviarum signa solemus accipere. In quibus non multum operae consumendum est, quia virgae nihil aliud sunt quam imperfecti arcus. Nam facies illis est quidem picta sed nihil curvati habens; in rectum iacent. Fiunt autem iuxta solem fere in nube umida et iam se spargente. Itaque idem est in illis qui in arcu color; tantum figura mutatur, quia nubium quoque in quibus extenduntur alia est.
10. Similis varietas in coronis est; sed hoc differunt quod coronae ubique fiunt ubicumque sidus est, arcus non nisi contra solem, virgae non nisi in vicinia solis. Possum et hoc modo differentiam omnium reddere: coronam si diviseris, arcus erit; si direxeris, virga. In omnibus color multiplex, ex caeruleo fulvoque varius. Virgae soli tantum adiacent; arcus solares lunaresque sunt; coronae omnium siderum. 11. Aliud quoque virgarum genus apparet, cum radii per angusta foramina nubium tenues et intenti distantesque inter se diriguntur. Et ipsi signa imbrium sunt. Quomodo nunc me hoc loco geram? Quid vocem? Imagines solis? Historici soles vocant et binos ternosque apparuisse memoriae tradunt. Graec parhelia appellant, quia in propinquo fere a sole visuntur aut quia accedunt ad aliquam similitudinem solis. Non enim totum imitantur, sed magnitudinem eius figuramque; ceterum nihil habent ardoris hebetes et languidi. His quod nomen imponimus? An facio quod Vergilius, qui dubitavit de nomine, deinde id de quo dubitaverat posuit? Et quo te nomine dicam, Rhaetica? Nec cellis ideo contende Falernis. Nihil ergo prohibet illas parhelia vocari. Sunt autem imagines solis in nube spissa et vicina in modum speculi. Quidam parhelion ita definiunt: nubes rotunda et splendida similisque soli. Sequitur enim illum nec umquam longius relinquitur quam fuit, cum apparuit. Num quis nostrum miratur, si solis effigiem in aliquo fonte aut placido lacu vidit? Non, ut puto. Atqui tam in sublimi facies eius quam inter nos potest reddi, si modo idonea est materia quae reddat. 12. Quotiens defectionem solis volumus deprehendere, ponimus pelves quas aut oleo aut pice implemus, quia pinguis umor minus facile turbatur et ideo quas recipit imagines servat; apparere autem imagines non possunt nisi in liquido et immoto. Tunc solemus notare quemadmodum luna soli se opponat et illum tanto maiorem subiecto corpore abscondat, modo ex parte, si ita competit ut in latus eius incurreret, modo totum. Haec dicitur perfecta defectio, quae stellas quoque ostendit et intercipit lucem, tunc scilicet cum uterque orbis sub eodem libramento stetit. Quemadmodum ergo utriusque imago in terris aspici potest, ita in aere, cum sic coactus aer et limpidus constitit ut faciem solis acciperet. Quam et aliae nubes accipiunt, sed transmittunt, si aut mobiles sunt aut rarae aut sordidae. Mobiles enim spargunt illam; rarae emittunt; sordidae turpesque non sentiunt, sicut apud nos imaginem maculosa non reddunt. 13. Solent et bina fieri parhelia eadem ratione. Quid enim impedit quominus
tot sint quot nubes fuerint aptae ad exhibendam solis effigiem? Quidam in illa sententia sunt, quotiens duo simulacra talia existunt, ut iudicent in illis alteram solis imaginem esse, alteram imaginis. Nam apud nos quoque, cum plura specula disposita sunt ita ut alteri sit conspectus alterius, omnia implentur, et una imago a vero est, ceterae imaginum effigies sunt. Nihil enim refert quid sit quod speculo ostendatur; quicquid videt, reddit. Ita illic quoque in sublimi, si sic nubes fors aliqua disposuit ut inter se conspiciant, altera nubes solis imaginem, altera imaginis reddit. Debent autem hae nubes quae hoc praestant densae esse, leves, splendidae, planae, vice functurae solis. Ob hoc omnia eiusmodi simulacra candida sunt et similia lunaribus circulis, quia ex percussu oblique accepto sole respondent. Nam, si infra solem nubes fuerit et propior, ab eo dissipatur. Longe autem posita radios non remittet nec imaginem efficiet; sic apud nos quoque specula, cum procul a nobis abducta sunt, faciem non reddunt, quia acies nostra non habet usque ad nos recursum. Pluviarum autem et hi soles, – utar enim historica lingua, – indicia sunt, utique si a parte austri constiterunt, unde maxime nubes ingravescunt. Cum utrimque solem cinxit talis effigies, tempestas, si Arato credimus, surgit. 14. Tempus est alios quoque ignes percurrere, quorum diversae figurae sunt. Aliquando emicat stella, aliquando ardores sunt, hi nonnumquam fixi et haerentes, nonnumquam volubiles. Horum plura genera conspiciuntur. Sunt bothyni, cum velut corona cingente introrsus ingens caeli recessus est similis effossae in orbem specu; sunt pithiae, cum magnitudo vasti rotundique ignis dolio similis vel fertur vel uno loco flagrat; sunt chasmata, cum aliquod spatium caeli desedit et flammam velut dehiscens in abdito ostentat. Colores quoque horum omnium plurimi sunt: quidam ruboris acerrimi, quidam evanidae ac levis flammae, quidam candidae lucis, quidam micantes, quidam aequaliter et sine eruptionibus aut radiis fulvi. Videmus ergo Flammarum longos a tergo albescere tractus. Hae velut stellae exiliunt et transvolant videnturque longum ignem porrigere propter immensam celeritatem, cum acies nostra non discernat transitum earum, sed, quacumque cucurrerunt, id totum igneum credat. Tanta est enim velocitas motus ut partes eius non dispiciantur, summa prendatur; intellegimus magis qua ierit stella quam qua eat. Itaque velut igne continuo totum iter signat, quia visus nostri tarditas non subsequitur momenta currentis, sed videt simul et unde exiluerit et quo pervenerit. Quod fit in fulmine. Longus nobis videtur ignis eius, quia cito spatium suum transilit et oculis nostris occurrit universum per quod deiectus est. At ille non est extenti corporis per omne qua venit; neque enim tam longa et extenuata in impetum valent. Quomodo ergo prosiliunt? Attritu aeris ignis incensus vento praeceps
impellitur. Non semper tamen vento attrituve fit; nonnumquam et aliqua opportunitate aeris nascitur. Multa enim sunt in sublimi sicca calida terrena, inter quae oritur et pabulum suum subsequens defluit ideoque velociter rapitur. At quare color diversus est? Quia refert quale sit id quod incenditur, quantum et quam vehemens quo incenditur. Ventum autem significant eiusmodi lapsus, et quidem ab ea parte qua erumpunt. 15. Fulgores, inquis, quomodo fiunt quos Graeci sevla appellant? – Multis, ut aiunt, modis. Potest illos ventorum vis edere; potest superioris caeli fervor, nam, cum late fusus sit ignis, inferiora aliquando, si sunt idonea accendi, corripit; potest stellarum motus cursu suo excitare ignem et in subiecta transmittere. Quid porro? Non potest fieri ut aer vim igneam usque in aethera elidat, ex qua fulgor ardorve sit vel stellae similis excursus? Ex his fulgoribus quaedam praeceps eunt similia prosilientibus stellis, quaedam certo loco permanent et tantum lucis emittunt ut fugent tenebras ac diem repraesentent, donec consumpto alimento primum obscuriora sint, deinde flammae modo quae in se cadit per assiduam deminutionem redigantur ad nihilum. Ex his quaedam in nubibus apparent, quaedam supra nubes, cum aer spissus ignem quem propior terris diu paverat usque in sidera expressit. Horum aliqua non patiuntur moram sed transcurrunt aut extinguntur subinde quam reluxerant. Haec fulgura dicuntur, quia brevis illorum facies et caduca est nec sine iniuria decidens; saepe enim fulminum noxas ediderunt. Ab his tacta nos dicimus siderata, id est icta sine fulmine, quae ajsterovplhkta Graeci vocant. At quibus longior mora est et ignis fortior motumque caeli sequens aut etiam proprios cursus agunt, cometas nostri putant, de quibus dictum est. Horum genera sunt pogoniae et cyparissiae et lampades et alia omnia quorum ignis in exitu sparsus est. Dubium an inter hos ponantur trabes et pithiae raro visi; multa enim conglobatione ignium indigent, cum ingens illorum orbis aliquantum matutini amplitudinem solis exuperet. Inter haec licet ponas et quod frequenter in historiis legimus caelum ardere visum, cuius nonnumquam tam sublimis ardor est ut inter sidera ipsa videatur, nonnumquam tam humilis ut speciem longinqui incendii praebeat. Sub Tiberio Caesare cohortes in auxilium Ostiensis coloniae cucurrerunt tamquam conflagrantis, cum caeli ardor fuisset per magnam partem noctis parum lucidus crassi fumidique ignis. De his nemo dubitat quin habeant flammam quam ostendunt; certa illis substantia est. De prioribus quaeritur, – de arcu dico et coronis, – decipiant aciem et mendacio constent, an in illis quoque verum sit quod apparet. Nobis non placet in arcu aut corona subesse aliquid corporis certi, sed illam iudicamus speculi esse fallaciam alienum corpus nihil aliud quam mentientis. Non est enim in speculo quod ostenditur. Alioquin non exiret nec alia protinus imagine obduceretur, nec innumerabiles modo interirent modo exciperentur formae. Quid ergo? Simulacra ista sunt et inanis verorum corporum imitatio, quae ipsa a quibusdam ita compositis ut hoc possint detorquentur in pravum. Nam, ut dixi, sunt specula quae faciem prospicientium obliquent; sunt
quae in infinitum augeant, ita ut humanum habitum modumque excedant nostrorum corporum. 16. Hoc loco volo tibi narrare fabellam, ut intellegas quam nullum instrumentum irritandae voluptatis libido contemnat et


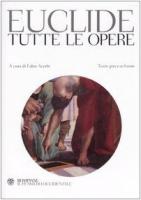
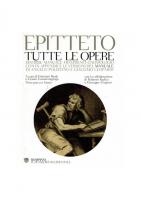

![Tutte le opere. Le commedie. Testo inglese a fronte [Vol. 2]
8845280594, 9788845280597](https://dokumen.pub/img/200x200/tutte-le-opere-le-commedie-testo-inglese-a-fronte-vol-2-8845280594-9788845280597.jpg)
![Tutte le opere. Le tragedie. Testo inglese a fronte. Ediz. illustrata [Vol. 1]
8845277526, 9788845277528](https://dokumen.pub/img/200x200/tutte-le-opere-le-tragedie-testo-inglese-a-fronte-ediz-illustrata-vol-1-8845277526-9788845277528.jpg)

![Opere mnemotecniche. Testo latino a fronte [Vol. 1]
8845919242, 9788845919244](https://dokumen.pub/img/200x200/opere-mnemotecniche-testo-latino-a-fronte-vol-1-8845919242-9788845919244.jpg)
![Tutte le opere. I drammi storici. Testo inglese a fronte [Vol. 3]
8845294536, 9788845294532](https://dokumen.pub/img/200x200/tutte-le-opere-i-drammi-storici-testo-inglese-a-fronte-vol-3-8845294536-9788845294532.jpg)
