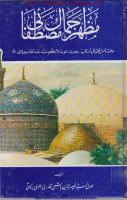Società e classi popolari nell'Italia dell'800 8846462904
190 46 16MB
Italian Pages 260 Year 2005
Polecaj historie
Citation preview
Franco Della Peruta
FrancoAngeli Storia
Studi e ricerche storiche Collana fondata da Marino Berengo e Franco Della Peruta diretta da Carlo Capra e Franco Della Peruta Come dichiara nel suo titolo, la Collana è aperta alla “ricerca storica” nella varietà e ricchez-
za dei suoi temi: politici, culturali, religiosi, economici e sociali; e spazia nel lungo arco dei secoli dalle origini dell’età moderna ai nostri giorni. La Collana non si propone di riesumare “classici” della storiografia, o di tradurre opere straniere; suo specifico intento è raccogliere le nuove voci della cultura storica italiana. Contributi originali, dunque; in prevalenza dovuti a giovani studiosi, di vario orientamento e provenienza. La forma del saggio critico non andrà a detrimento di un sempre necessario corredo di riferimenti, di note e di appendici; ma eviterà anche che il testo sia appesantito da apparati eruditi. Un impianto, dunque, agile ed essenziale che entra nel vivo del lavoro storiografico in atto nel nostro paese.
I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo a: “FrancoAngeli, viale Monza
106, 20127 Milano”
Franco Della Peruta Pt
FrancoAngeli Storia
Franco Della Peruta, nato a Roma il 6 maggio 1924, già professore di Storia del Risorgimento nella Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli studi di Milano, è attualmente presidente dell’Istituto lombardo di storia contemporanea, presidente del Centro internazionale di studi risorgimentali e garibaldini di Marsala e membro del consiglio di Presidenza dell’Istituto nazionale per la Storia del Risorgimento. Già condirettore delle riviste «Movimento operaio» e «Studi storici», è nel comitato direttivo della rivista «Società e storia» e direttore di «Storia in Lombardia». Tra le sue opere principali: / democratici e la rivoluzione italiana. Dibattiti ideali e contrasti politici all’indomani del 1848 (Milano, FrancoAngeli); Democrazia e socialismo nel Risorgimento (Roma, Editori Riuniti); Scrittori politici dell’Ottocento. Tomo I, Giuseppe Mazzini e i democratici (MilanoNapoli, Ricciardi), Il giornalismo italiano dal 1847 all’Unità (Bari, Laterza); Società e
classi popolari nell’Italia dell’Ottocento (la ed. 1986, Palermo, Epos); Esercito e società nell’Italia napoleonica (Milano, FrancoAngeli); Storia dell'Ottocento (Firenze, Le Monnier); Storia del Novecento (Firenze, Le Monnier); Momenti di storia d’Italia fra ‘800 e 900 (Firenze, Le Monnier); Conservatori, liberali e democratici nel Risorgimento (Milano, FrancoAngeli); Realtà e mito nell’Italia dell’800 (Milano, FrancoAngeli); Politica e società nell’Italia dell’800 (Milano, FrancoAngeli); Carlo Cattaneo politico (Milano,
FrancoAngeli); Uomini e idee dell’Ottocento italiano (Milano, FrancoAngeli), Sapere e organizzazione della cultura in Lombardia dagli anni napoleonici all’Unità (Milano, Istituto lombardo di scienze e lettere).
Prima edizione: Epos, Palermo 1985
In copertina: Attilio Postera, Alle Cucine Economiche di Porta Nuova a Milano, Milano, Civica Galleria d’ Arte Moderna (particolare)
Copyright © 2005 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy Ristampa
0284506,
Anno
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
È vietata la riproduzione, anche parziale, effettuata a qualsiasi titolo, eccetto quella ad uso personale. Quest'ultima è consentita nel limite massimo del 15% delle pagine dell’opera, anche se effettuata in più volte, e alla condizione che vengano pagati i compensi stabiliti dall’art. 2 della legge vigente. Ogni fotocopia che eviti l'acquisto di un libro è illecita ed è severamente punita. Chiunque fotocopia un libro, chi mette a disposizione i mezzi per farlo, chi comunque favorisce questa pratica commette un reato e opera ai danni della cultura. Stampa: Tipomonza, via Merano 18, Milano.
Indice
. Democrazia risorgimentale, rivoluzione francese e giacobinismo . Aspetti sociali dell’età della Restaurazione
. Le «interdizioni» israelitiche e la questione dell’emancipazione degli ebrei nel Risorgimento
»
. Le origini risorgimentali dell’assistenza alla prima infanzia
»
. Il giornalismo del 1848 e la società italiana
»
. La società lombarda
tra il 1815
e l'Unità:
l’alimentazione
e
l’abitazione
»
161
. Caratteri generali della società lombarda tra l'Unità e la fine dell'Ottocento
185
8. Salute pubblica e legislazione sanitaria dall’ Unità a Crispi
199
Indice dei nomi
249
Digitized by the Internet Archive in 2028 with funding from Kahle/Austin Foundation
https://archive.org/details/societaeclassipo0000dell
I saggi che formano il presente volume sono apparsi nelle seguenti sedi: Aspetti sociali dell’età della Restaurazione, in «Studi storici», 1976, n. 2 (con il tito-
lo: Aspetti della società italiana nell’età della Restaurazione). Le «interdizioni» israelitiche e la questione dell’emancipazione degli ebrei nel Risorgimento, in «Società e storia», 1983, n. 19.
Le origini risorgimentali dell’assistenza alla prima infanzia, in «Studi storici», 1979, n. 3 (con il titolo: Infanzia e famiglia nella prima metà dell’ottocento). Il giornalismo del 1848 e la società italiana, in Saggi di storia del giornalismo in memoria di Leonida Balestreri, Genova, 1982 (con il titolo: Echi sociali nel giornalismo del 1848). La società lombarda tra il 1815 e l’Unità: l’alimentazione e l’abitazione, in «Studi storici», 1975, n. 2 (con il titolo: Per la storia della società lombarda nell’età della Restaurazione).
Caratteri generali della società lombarda tra l’Unità e il 1900, in Aspetti religiosi e culturali della società lombarda negli anni della crisi modernista: 1898-1914, Como, 1979 (con il titolo: La società lombarda). Sanità pubblica e legislazione sanitaria dall’Unità a Crispi, in «Studi storici», 1980,
n.4.
PA
arde =
si
«i iirnntà
Je
ero
1°
—_
TS e
Ù
Poeti
\\b
i è
- 3
vbb
(I
Gs
ta
il
suit
out sof SUE Lifapietimezio nie
‘seme
nta
Laces :
ss
-iA ton ce
iegionit
magpg=© Lan radioig i n
Ù
i
È
i
se
pe
ed ri
A N tabs
re O)
si
Ne De
paz
sinsin
rei ioitose ibi» ai sisi seria
Rigcgnsg gdoEui SES
ni antitnirialg
ton
MLA
ibui2» mi sagininticy) & sitoì Ò sb fio' Han nirndonol fsi peg s ingigiio i. teri trinigiosegò te POTRO
ceeligresiori caio nali i
0801 .«doitota ibui2» mi gl) » $
ia
svelo bo
una
ian: vos: à Au
I. Democrazia risorgimentale, rivoluzione francese e giacobinismo
L'avvio del Risorgimento italiano è strettamente collegato con la grande rivoluzione francese, nel senso che — come ha osservato Gramsci — le ripercussioni dell’ 89 e dei successivi avvenimenti rafforzarono nella penisola le condizioni favorevoli al consolidarsi del movimento nazionale che avevano cominciato a delinearsi nel corso del ‘700, accelerando la trasformazione di una tradizione ancora essenzialmente retorico-letteraria in un coerente atteggiamento politico e stimolando l’aggregazione di gruppi specificamente operanti per la modificazione della realtà storica esistente!. E la coscienza di questo intimo nesso, già chiara in molti uomini del triennio «giacobino» e poi dell’età napoleonica, fu più volte esplicitamente riaffermata nei decenni della Restaurazione, come dimostra un largo arco di testimonianze tra le quali basterà trascegliere alcune delle più significative. Così nel 1821 Francesco Saverio Salfi, un vecchio «patriota» esule in terra di Francia, nello scritto L’/talie au dix-neuvième siècle dato alle stampe a Pa-
rigi con l’intento di riproporre all’opinione pubblica la questione italiana, affermava che alla rivoluzione francese, riproduzione su scala allargata di quella americana, andava il merito — al di là dei suoi errori e delle sue deviazioni
— di avere comunicato uno slancio vitale all’ Europa e all’Italia e di avere rianimato lo spirito della libertà tra i popoli2. A sua volta un altro patriarca dell’emigrazione, Luigi Angeloni, scriveva in polemica col Botta in un’opera del 1826, Della forza nelle cose politiche, che l'operato dei francesi in Italia era stato largamente positivo e che avrebbe sempre costituito titolo di gloria per quel popolo «l’aver essi dato il primo fatal cozzo al servaggio pressoché universale ch’era saldamente fondato in quasi che tutta la terra ferma
1. A. Gramsci, // Risorgimento, Torino, 1952, pp. 50-51. 2. F.S. Salfi, L’Italie au dix-neuvième siècle; ou de la nécessité d’accorder,
pouvoir avec la liberté, Paris, 1821, pp. 12-13.
9
en Italie, le
europea»3. Alcuni anni più tardi un personaggio minore, ma la cui voce esprimeva pur sempre un’opinione largamente diffusa tra i liberali del tempo, il romagnolo Decio Valentini, in un opuscolo apparso a Forlì nel 1831 durante la breve stagione della libertà faceva anch'egli discendere dalla rivoluzione dell’89 il primo impulso dell’Italia verso la propria emancipazione, anche se poi i francesi avevano finito col fare della vicina penisola una loro tributaria*. E una menzione meritano pure le riflessioni stese in carcere nell’ottobre 1833 dallo studente milanese Fedele Bono, uno dei responsabili della Giovine Italia nella capitale lombarda il quale, pur militando nell’organizzazione mazziniana, non era insensibile alle suggestioni delle idee buonarrotiane. In queste sue pagine il cospiratore metteva in rilievo le modificazioni indotte dall’età rivoluzionaria e napoleonica nei vari strati della società italiana e più particolarmente lombarda, tentando una sorta di elementare analisi storico-sociologica. A suo avviso, dunque, mentre il vecchio ceto dominante — «nobili, cle-
ro, dotti e ricchi in genere» — aveva subìto una secca perdita di potere e di prestigio, la classe media, «formata da tutto ciò che non appartiene alla prima, e non si accomuna coi proletari», era divenuta «preponderante». Ma nell’ottica di Bono il fenomeno di maggior rilievo prodottosi negli anni della rivoluzione e dell’impero era costituito dalle modificazioni che si erano verificate nella mentalità dei «proletari»: questa classe, prima «totalmente inerte ed incapace d’intelligenza» e che ancora nel 1797 aveva prestato la sua forza materiale ai «potenti d’in allora che se ne servivano come stromento», aveva appreso dalla «caduta di ciò che essa riguardava come inviolabile e divinamente legittimo» a ragionare con la propria mente e a maturare una «coscienza della propria dignità e del proprio onore», sia pure ancora confusa e indistinta?. Di lì a poco, infine, l'anonimo autore dell’opuscolo Della morale del cittadino affermava che l’Italia era stata ridestata dalla rivoluzione francese e da Napoleone dal suo sonno secolare, e che i nuovi ordinamenti politici stabiliti nella penisola, le discussioni che vi erano state avviate e la conseguente educazione degli intelletti, le prove militari compiute avevano rappresentato l’inizio di una nuova era nella storia del paese®. Nella prospettiva di questa consapevolezza del rapporto che univa le lotte risorgimentali alle esperienze della rivoluzione francese può riuscire utile, con l’intento di definire più nettamente i contorni della democrazia risorgi3. L. Angeloni, Della forza nelle cose politiche, Londra, 1826, vol. 2°, p. 101. 4. D. Valentini, Osservazioni sull’avvenire d’Italia; Forlì, 1831, pp. 7 sgg. S. Tredicesimo esame giudiziale di Fedele Bono, 31 ottobre 1833, in Archivio di Stato di Milano (da ora ASM), processo contro la Giovine Italia, n. 599.
6. Della morale del cittadino. Considerazioni di un italiano per uso degli italiani, Italia, 1834, pp. 5-7.
10
mentale, delineare un quadro sommario delle valutazioni storico-politiche — che è poi in qualche misura un quadro di derivazioni ideologiche — che della grande rivoluzione di Francia diedero uomini per vari versi rappresentativi del movimento democratico. Nella scomposizione della troppo semplicistica rappresentazione della democrazia risorgimentale italiana come un blocco unitario precocemente consolidatosi intorno alla prepotente personalità di Mazzini hanno svolto una funzione rilevante — come è noto — le ricerche sul pensiero e sull’attività di Filippo Buonarroti sviluppate da Saitta e da Galante Garrone, uno dei cui apporti principali è stata la ricostruzione dell’azione italiana del comunista toscano nel periodo immediatamente successivo alla rivoluzione parigina del luglio 1830, ricostruzione che ha fatto emergere Buonarroti come l’antagonista di Mazzini e della sua Giovine Italia nella lotta per l'egemonia all’interno della democrazia risorgimentale. Qui quel che importa è ricordare l'atteggiamento politico-storiografico di fronte alla rivoluzione francese che emerge nella Congiura per l’eguaglianza o di Babeuf, l’opera del 1827 con la quale Buonarroti voleva non soltanto «vendicare la memoria» dei suoi compagni condannati 30 anni prima a VendOme, ma anche divulgare al di là di una ristretta cerchia di iniziati i temi
centrali della sua ideologia egualitaria, quale concreto programma da proporre alla frazione più avanzata del movimento democratico europeo. Nella visione del rivoluzionario toscano non trovava posto una questione che avrebbe poi sollecitato a lungo la riflessione di comunisti e socialisti delle più varie tendenze, quella del deperimento e della dissoluzione finale dello Stato, perché per Buonarroti anche nella futura società degli eguali lo Stato — e sia pure uno Stato per sua natura intimamente democratico — avrebbe continuato ad esistere; e così pure a giudizio di Buonarroti per avviare l’edificazione del nuovo ordine era indispensabile la presa del potere politico; e anzi una rigorosa dittatura era vista come un momento transitorio ma necessario per il consolidamento della rivoluzione. Ebbene, proprio questa dottrina della dittatura aveva le sue radici nel ripensamento delle esperienze della rivoluzione francese, dal quale Buonarroti aveva ricavato la convinzione che un popolo diseducato da un lungo regime di dispotismo corruttore e di diseguaglianza non sarebbe stato in grado, nei primordi di una rivoluzione rinnovatrice, di
scegliere gli uomini adatti a dirigerla e a condurla a termine; donde la necessità di introdurre un’autorità straordinaria che fosse capace di sottrarre le masse popolari, anche con misure coercitive, all’influenza dei sostenitori del
vecchio sistema. D'altra parte il carattere di manifesto politico che il suo autore aveva inteso dare alla Conspiration aiuta anche a chiarire il nesso che connette le pagine in cui viene abbozzato il quadro della società futura allo schizzo storico 11
sulla grande rivoluzione con cui si apre l’opera. La maturazione del comunismo buonarrotiano avvenne infatti in intimo rapporto con gli sviluppi della situazione francese dall’89 in avanti, come presa di coscienza del fatto che ogni rivoluzione la quale non avesse posto la questione della «riforma integrale della società a favore delle masse del popolo» non avrebbe potuto dispiegarsi sino alle sue estreme conseguenze rinnovatrici e sarebbe stata bloccata dal ritorno delle forze conservatrici; e parallelamente l’attuazione del programma proposto nella Conspiration era presentato come la logica ripresa del corso rivoluzionario bruscamente interrotto dalla reazione termidoriana e il coerente approfondimento e coronamento dell’opera iniziata da Robespierre e Saint-Just. Alla luce di queste correlazioni si intendono anche meglio da un lato la rivalutazione della fase giacobina e robespierrista, della costituzione del ’93 e del Terrore che anima la ricostruzione buonarrotiana, e dall’altro
la forzatura interpretativa che induceva lo scrittore a vedere nei provvedimenti sociali presi dal governo rivoluzionario tra l'estate del ‘93 e Termidoro «i preliminari di un ordine nuovo», il consapevole avvio di un piano generale di riforma della società: «Ancora un giorno, — questa la conclusione — e la felicità e la libertà di tutti sarebbero state assicurate dalle istituzioni che non si era mai cessato di chiedere!»?. E val la pena, sempre in tema di Conspiration, aggiungere qualche notazione sull’atteggiamento più propriamente storiografico che emerge dalle pagine dell’opera. Il criterio interpretativo generale di Buonarroti è quello della «discordia sempre esistente tra i partigiani dell’opulenza e delle distinzioni da una parte, e gli amici dell’eguaglianza o della numerosa classe dei lavoratori dall’altra», discordia che aveva conosciuto uno dei suoi momenti di massima tensione nella Francia del ‘92-94. All’interno di questa impostazione, in
cui assumono valore di canoni storiografici anche i concetti di «virtù», nell’accezione di Rousseau, e di «égalité», permeata di contenuto etico-emotivo, sono presenti però spunti interpretativi nettamente caratterizzati in senso classista. È questo il caso del giudizio sulla Gironda, considerata come l’arti-
colazione a livello politico di quella «classe» di «avvocati, procuratori, medici, banchieri, ricchi mercanti, opulenti borghesi e uomini di lettere», collocata tra la nobiltà e «la classe immensa dei lavoratori», che aveva dato inizialmente la sua adesione alla rivoluzione e aveva contribuito a spingere al movimento anche le masse, «poste alla sua dipendenza dal bisogno e dal difetto d'istruzione». E, riflettendo sul problema dei limiti della «fazione» girondina, Buonarroti li individuava nella volontà politica dei girondini — i quali pure 7. F. Buonarroti, Congiura per l’eguaglianza o di Babeuf, a cura di G. Manacorda, Torino, 1946, passim.
re
erano contrari alla conservazione dell’antico regime — di impedire che «il nuovo regime giungesse fino a confonderli con quel che essi chiamavano il basso popolo e li spogliasse di quel prestigio per loro tanto vantaggioso», perché ad essi poco importava che la Francia si reggesse a repubblica o a monarchia, purché il potere restasse nelle loro mani e purché «la sovranità del popolo non fosse in realtà che un’espressione felicemente inventata, per meglio assicurare la sottomissione e l'obbedienza del pubblico alle leggi da loro immaginate ed eseguite». L’azione italiana di Buonarroti introdusse e fece circolare nel paese tra il 1831 e il 1834 gli elementi essenziali della sua concezione politica — di cui era parte integrante la tipica valutazione della rivoluzione francese di cui è detto — in alcuni circoli dell’emigrazione e in alcuni gruppi cospirativi nell’interno. Del che è traccia nella scarsa documentazione rimastaci della propaganda buonarrotiana, come è il caso, per portare un esempio, di una circolare diffusa in Piemonte nei primi mesi del 1833 nella quale l’accento batteva sulla distinzione tra rivoluzione politica e rivoluzione sociale. «Cambiare la forma di governo è fare una rivoluzione politica», si diceva, mentre l’es-
senza di una rivoluzione
sociale stava nella modificazione
radicale della
«condizione economica e civile delle masse»; e tutte le rivoluzioni del passa-
to, compresa quella francese, avevano lasciato dietro di sé rimpianti e amari ricordi proprio perché non avevano affondato con incisività la propria azione sul terreno sociale e si erano limitate a dislocare il potere, permettendo che sussistesse la contrapposizione tra un ristretto ceto di privilegiati e la massa degli infelici, «consacrati alla pena e alla fame e costretti a maledire in silen-
zio una società barbara che essi non conoscono che per le privazioni alle quali quella li sottopone»8. Testimonianza di questo processo di assimilazione di motivi ideologici di derivazione buonarrotiana è la esemplare vicenda politico-intellettuale di Carlo Bianco di Saint-Jorioz, il rivoluzionario piemontese del ‘21 che nel 1830 diede alle stampe una approfondita sistemazione della teoria della guerra partigiana nel trattato Della guerra nazionale d’insurrezione per bande, applicata all’Italia. Tipicamente buonarrotiana appare infatti l’asserzione del Bianco sulla funzione essenziale delle organizzazioni settarie nella preparazione rivoluzionaria, funzione ribadita proprio nei riferimenti alla rivoluzione dell’89
contenuti nel trattato. I francesi infatti, scriveva nella sua prosa dall’ andamento puristico Bianco, «sotto la regola di franchi muratori con ben custodito segreto accozzati, quella rivoluzione, pei principi messi in chiaro lume, sublime, energica, e tremenda pei mezzi adoperati, biasimevole nel suo fine, per la 8. F. Della Peruta, Nel mondo buonarrotiano, estratto da «Critica storica», settembre 1965, p. 3.
13
facilità con che fu da Bonaparte calpestata, mossero e diressero. La quale, come che aborto possa denominarsi, non v’ha dubbio, stata non sia di un gran bene dalla nazione attualmente sentito, e goduto, produttrice»9. Ma dove la corrispondenza tra le tesi buonarrotiane e le idee di Bianco appare più immediata è nelle posizioni da questo sostenute in materia di struttura del potere rivoluzionario. Anche per il piemontese infatti, sebbene fonte di ogni potere fosse pur sempre il popolo, sarebbe stato un errore imperdonabile mettere in vigore la nuova costituzione democratica prima di aver completato la liberazione della penisola e prima di aver compiuto, con un «generale sistema di depurazione», necessariamente violento e spietato, lo sterminio di tutti gli elementi ostili al movimento nazionale. E coerentemente a questa propensione terroristica gli organi rivoluzionari investiti delle funzioni civili erano collocati in una posizione nettamente subordinata di fronte al supremo condottiero militare (uomo «d’un cuore duro, ed inaccessibile a qualunque grido di pietà»), cui erano attribuiti poteri dittatoriali!0. Questa infiltrazione di motivi terroristico-giacobini di radice buonarrotiana ha lasciato altri tenui indizi di sé. Così quel Fedele Bono di cui si è già parlato, nell’abbozzo di un lavoro manoscritto sulla rivoluzione italiana sequestratogli dalla polizia nel 1833 affermava: «1°. Se non troncate il capo, tutto ripulula [sic]. 2°. Se, troncato il capo, vi soffermate avrete il juste milieu. 3°. Se non troncate il potere dispotico e i troppi ricchi avrete l’aristocrazia»; e ancora:
«Se il dispotismo del re è spaventevole
non lo è meno
quello dei militari. Napoleone... Se quello dei re e dei militari è spaventoso lo è più quello dei borghesi... Che fare? Repubblica intera. Libertà-Eguaglianza»!!. Nello stesso torno di tempo un’altra nobile figura di cospiratore, il capitano di mare genovese Giovan Battista Serra, anch’egli animato da convinzioni egualitarie estreme di matrice buonarrotiana, in una serie di lettere che intendeva dare alle stampe individuava negli umili, nei «disperati», schiacciati sotto il peso dell’ingiustizia, la principale forza motrice della rivoluzione, e sosteneva che i veri rivoluzionari, anziché limitarsi ai meri cambiamenti
politici, avrebbero
invece dovuto
mirare
alla distruzione
del
privilegio e alla realizzazione della giustizia sociale su base egualitaria; e anche il Serra si rifaceva agli ammaestramenti della rivoluzione francese che, rilevava, «dopo fiumi di sangue sparso per la libertà si è veduta retrocedere, e dar luogo nuovamente al dispotismo per avere in essa dato adito al 9. C. Bianco di Saint-Jorioz, Della guerra nazionale d’insurrezione per bande, applicata all’Italia, Marsiglia, 1830, vol. 1°, p. 48.
10. Ibidem, vol. 1°, pp. 54 sgg.; vol. 2°, pp. 207 sgg. 11. F. Della Peruta, Per la storia dei rapporti tra Giovine Italia e buonarrotismo,
da «Critica storica», 31 maggio 1964, pp. 344-345.
14
estratto
fasto, alle colossali ricchezze, alle decorazioni e distinzioni orgogliose, dalle
quali cose n’è nato un imperatore»!2. Nel rapido esame che si sta qui compiendo il discorso deve ora portarsi su Mazzini — l’uomo che tra il ’31 e il ’33 costruì con la Giovine Italia il primo partito politico moderno della storia italiana e si conquistò la funzione di leader della democrazia risorgimentale —, anche perché l’esame delle valutazioni e delle opinioni da lui espresse sulla rivoluzione francese, per quanto sparse e occasionali, permettono di cogliere alcuni elementi non secondari nella genesi del suo pensiero. Se è infatti vero che il Mazzini che a mezzo il 1831 iniziò il lavoro di organizzazione della Giovine Italia era un uomo già passato attraverso esperienze politico-culturali che avevano lasciato in lui sedimenti ineliminabili, resta però il fatto che il genovese, consapevole delle difficoltà che nell’impianto di un autonomo lavoro organizzativo e ideologico avrebbe incontrato chi — e questo era il suo caso — appariva ancora come un «uomo nuovo», non si pose affatto su di un piano di rigida contrapposizione nei confronti del preesistente mondo cospirativo e dei nuclei più avanzati della precedente generazione di esuli. Ché anzi in questa fase non furono senza influenza nel processo di formazione della personalità di Mazzini e nell’elaborazione delle linee programmatiche della sua nuova associazione i rapporti che egli stabilì con gli uomini di quell’ala dell'emigrazione — Bianco, Nicolai, e anche Buonarroti — che avevano già costruito una piattaforma programmatica democratico-repubblicana, e dai quali il genovese ricavò motivi ideali, temi propagandistici, argomentazioni polemiche, spunti interpretativi della realtà che lo circondava. In questo Mazzini che cercava ancora la sua strada il giudizio sulla rivoluzione francese suonava assai diverso da quello degli anni a venire, quando la questione dell’iniziativa sarebbe stata risolta con l’attribuzione del primato rivoluzionario ai paesi che ancora lottavano per conquistare la propria indipendenza, e in primo luogo all’Italia: attribuzione che venne inoltre concepita sempre più nettamente in chiave antifrancese dato che — affermerà — la Francia era ormai «diseredata» d’iniziativa, poiché continuava a seguire le vecchie e superate parole d’ordine della rivoluzione dell’89, testamento e «ultima formola» di un’epoca già conclusa, che aveva esaltato il momento del «diritto» e dell’individuo, e non già «iniziazione di una epoca nuova» incentrata sui principî del dovere, della missione, dell’associazione. Così nel luglio 1831 Mazzini si augurava come prossime la caduta della monarchia borghese e «giusto mezzo» di Luigi Filippo e la distruzione delle logore istituzioni vi12. F. Della Peruta, Un buonarrotiano
genovese:
storia ligure», 1958, p. 457.
15
G.B. Serra, estratto da «Miscellanea
di
genti per opera della «Giovine Francia», attraverso una linea di sviluppo che avrebbe dovuto riprodurre le fasi dell’ «antica rivoluzione», inclusa quella terroristica, perché così voleva la «dura necessità delle cose». Poco più tardi, agli inizi del 1832, il giovane esule attribuiva alla rivoluzione dell’ 89 il merito di aver elaborato il programma di quella «grande rivoluzione sociale» che si annunciava ormai all’orizzonte. In altri suoi scritti di quegli stessi mesi era poi ricorrente la giustificazione del Terrore, giudicato un rimedio estremo ma necessario per «salvare l’indipendenza del territorio, e liberarsi dalle interne congiure, dalle insidie coperte, che preti, e nobili ordivano coll’oro inglese, ... dagli eserciti stranieri impossessati di piazze forti, e inoltrati sul suolo di Francia». E così pure agli occhi di Mazzini assumeva un valore paradigmatico per i patrioti italiani l’energica determinazione con cui la Montagna e Robespierre avevano realizzato il «concentramento a un intento d’elementi omogenei», ottenendo così quella coesione che nelle cose politiche contava assai più del numero. «La Montagna — suona un brano assai significativo — dominò la Francia convulsa, e contrastò all’ Europa ribelle, perché tutti i membri che la componevano, rappresentavano un principio solo, perché s’era incarnata in Robespierre che riassumeva in sé le dottrine di quegli uomini decisi a vincere, immemori di tutte l’altre cose»!3. Nei mesi immediatamente successivi, tra il ‘33 e il ’34, si assistè però in Mazzini, parallelamente al consolidarsi di una concezione della rivoluzione
di impronta volontarista e spiritualista, a un graduale stemperamento del suo iniziale radicalismo sociale, con l’approdo a un interclassismo che respingeva non soltanto ogni soluzione di tipo comunistico ma anche qualsiasi mutamento profondo dell’assetto della proprietà e dei diritti «legittimamente acquistati». Nell’ambito di questa rettifica, motivata al fondo dalla convinzione che le prospettive di vittoria del movimento nazionale dipendevano in massima parte dall’appoggio delle «classi medie», alle quali veniva delegata la direzione delle masse popolari, si intendono anche le sistematiche condanne del Terrore che Mazzini cominciò a pronunciare da quella data. «Aborriamo dal sangue fraterno; non vogliamo il terrore eretto a sistema», dirà nel 1833; e dieci anni dopo: «Da più anni, i popoli avrebbero accettato il partito repubblicano... se la rivoluzione francese col suo ’93 e col suo terrore, non tenesse ancora spaventati gli animi». «Io detesto il terrore e la ghigliottina applicati sistematicamente; — si legge ancora in una lettera a G. Sand dell’inizio del 1848 — e credo che abbiano perduto la vostra rivoluzione»; motivo ricorrente che proprio verso il chiudersi della sua esistenza avrebbe così riaffermato an13. G. Mazzini, Scritti editi ed inediti (SEI), vol. 5°, pp. 15-16; vol. 2°, pp. 89, 138, 206, 211; vol. 3°, p. 40.
16
cora una volta in polemica con le correnti di simpatia per la Comune di Parigi affioranti all’interno della democrazia italiana: «Non sanno i nostri che in Francia il nemico più potente della Repubblica è tuttora, nella popolazione rurale, il ricordo del settembre 1792 e dei patiboli del 1793?»; ed anche:
Non è vero che il terrore eretto a sistema possa mai impiantare o difendere libertà repubblicana o progresso: il Terrore esercitato in Francia nel 1793 non impedì il ritorno della dinastia proscritta né il riordinarsi dell’elemento cattolico: stancò la Francia, agevolò l'Impero, pose la paura a servigio d’ogni forte potere dispotico e contaminò la repubblica d’una macchia che tre generazioni non valsero a cancellare!4.
In linea con queste posizioni di Mazzini la nota antiterroristica e l'insistenza sull’affermazione che la diversità della situazione italiana rispetto a quella della Francia rivoluzionaria escludeva nella penisola l’impiego di misure di tipo robespierristico caratterizzano buona parte della letteratura di propaganda della prima Giovine Italia. Basterà così ricordare che Elia Benza, il fraterno amico di gioventù di Mazzini, nelle Considerazioni sulla rivoluzione apparse in un fascicolo della «Giovine Italia» lamentava la mala fede di quanti, «per impaurir gli animi e distorli dalla rivoluzione», continuavano a intonare «la mai vieta nenia
sugli errori del ’93» presentando «quel tremendo spettacolo, come pronto a rinnovarsi, e inseparabile da ogni rivoluzione»!5. E in un anonimo opuscolo pubblicato dalla società mazziniana nel 1833 e indirizzato Ai sacerdoti italiani si legge un’esortazione di questo tenore: «Discacciate... dall’animo vostro il timore, che nella generale rivoluzione italiana possano mai rinnovarsi le infande scene della prima rivoluzione francese. Quell’abisso è chiuso per sempre. La presente civiltà europea rifugge da quella idea desolante e terribile»!9. Non tutti però, all’interno del campo mazziniano, condividevano appieno l’intransigente linea antiterroristica e antigiacobina fatta propria da Mazzini dalla fine del 1832. E valga il caso di Gustavo Modena, l’attore-patriota affiliato alla Federazione, il quale in un Insegnamento popolare edito in quei mesi per conto della Giovine Italia dall’ispirazione accentuatamente egualitaria (la felicità degli uomini, si diceva, consiste «nel godimento uguale per tutti i viventi di tutti i beni terreni», e la libertà «dee tendere a migliorare la condizione della classe più numerosa e più povera»: il che tornava a dire, nel caso di un paese agricolo come l’Italia, dare la massima diffusione possibile alla proprietà contadina) ricalcava fedelmente la dichiarazione dei diritti 14. Ibidem, vol. 2°, p. 210; vol. 24°, p. 207; vol. 33°, p. 269; vol. 92°, pp. 275 e 335. 15. «La
Giovine
Italia», nuova
edizione
a cura di M. Menghini,
Roma-Milano-Napoli,
1912, fasc. 4°, p. 66. 16. Ai sacerdoti italiani, Marsiglia, 1833, p. 38. Autore dello scritto fu quasi certamente il sacerdote toscano Pietro Contrucci.
d7
dell’uomo di Robespierre e soprattutto difendeva la politica dei giacobini con toni più caldi e convinti di quelli analoghi che si trovano nel primo Mazzini: Robespierre, Saint Just, e gli altri terroristi non sorsero nella repubblica francese, [se]
non quando dieci armate nemiche invasero la Francia, e i nobili, e i preti, e l’oro inglese accesero una atroce guerra .civile. Robespierre e gli altri, detti montagnardi, videro l’estremo pericolo, vollero opporvi estremi rimedi, ed essendo in ciò attraversati dalla debolezza dei liberali moderati dovettero sacrificare questi stessi per avere le mani libere a distruggere gli interni nemici. Operarono disperatamente, perché la disperazione sola potea salvare la repubblica... Del resto le stragi di Robespierre compariscono gigantesche, perché i re, i preti, e tutte le loro creature le hanno cantate con trombe e timballi, ma il re Carlo IX, il re Luigi XI, il vivente Carlo X, e mille al-
tri hanno fatto per puro capriccio scorrere più sangue innocente di Robespierre. Appunto perché le violenze e le morti accadute in una repubblica si magnificano tanto, dì che in quella sono straordinarie: nelle monarchie l’occhio si avvezza al sangue e la pelle si indura agli strapazzi, perché le sono cose di tutti i giorni!7.
Modena ribadì poi le sue idee in tema di eguaglianza in un dialoghetto di poco successivo, nel quale veniva posta in maniera esplicita la questione del rapporto delle masse con il movimento nazionale. Se si voleva trascinare il popolo nella lotta contro l’ Austria — vi si affermava — era indispensabile tenere nel debito conto i suoi bisogni quotidiani e le sue aspirazioni a più umane condizioni di vita: Il popolo vuole dalla rivoluzione miglioramento materiale del suo essere: per questo scopo mette in giuoco il sangue e gli averi: ma se la rivoluzione non gli dà immediati vantaggi, si stringe nelle spalle e sta a guardare. E se il popolo non aiuta di braccia, gli Austriaci non si cacciano. Conchiudo: o servire e soffrire, o gettarsi in quella piena rivoluzione sociale che dia al popolo un vantaggio materiale, palpabile, sollecito.
I rivoluzionari dovevano cioè fare leva sull’eguaglianza, definita non soltanto come «uguale considerazione d’ogni cittadino in faccia alla legge», ma anche come «il giusto riparto dei beni terreni fra tutti gli uomini in misura delle loro fatiche, e dell’utile che recano alla società». Anche se poi, nel ten-
tativo di definire i contorni di questa eguaglianza, il Modena oscillava tra l’ideale estremo di una ripartizione livellatrice delle ricchezze, con richiami al comunismo evangelico, e la più temperata visione di un assetto sociale che avrebbe lasciato sussistere una certa diversità di condizioni materiali, pur eliminando le sperequazioni più stridenti figlie del «privilegio»!8. 17. G. Modena, Scritti e discorsi (1831-1860), a cura di T. Grandi, Roma, anche A. Saitta, Filippo Buonarroti, Roma, 1950, vol. 1°, pp. 221 sgg.
1957, pie2S Cir.
18. Sul pensiero del Modena v. la «nota introduttiva» in Scrittori politici dell’Ottocento, tomo 1°, Giuseppe Mazzini e i democratici, a cura di F. Della Peruta, Milano-Napoli, 1969, pp. 843 sgg.
18
Singolare appare anche il caso di un altro militante della Giovine Italia, il compositore tipografo romagnolo Giuseppe Budini, che nel 1843 pubblicava a Londra un opuscolo, Alcune idee sull’Italia, per discutere il problema dell’avvio e della condotta di una guerra partigiana popolare nella penisola. Per il Budini il nerbo delle formazioni partigiane avrebbe dovuto essere costituito dal «basso popolo delle campagne e delle città», e in particolare dai braccianti agricoli, il ceto che aveva in sé «tutte le qualità che abbisognano a guerra siffatta, cioè sobrietà, agilità, conoscenza del paese e obbedienza passiva a quegli che crede più esperto di sé». Ma per interessare le «masse popolari» ad agire contro lo straniero i rivoluzionari italiani avrebbero dovuto persuadere il popolo che, a differenza di quanto era avvenuto nel recente passato, la vittoria della causa nazionale gli avrebbe dato «vantaggi materiali così palpabili da non potersi mettere in dubbio». E a sostegno del suo assunto il romagnolo recava l’esempio della rivoluzione francese della quale — distaccandosi dalle valutazioni di Mazzini, che pure aveva firmato la prefazione dello scritto — sottolineava il momento giacobino, che aveva portato alla liquidazione definitiva della feudalità, base su cui si era costruita l’alleanza tra contadini e borghesia rivoluzionaria: I rivoluzionari del 1793 conobbero i bisogni del loro paese, abolirono i feudi, aboli-
rono le decime e chiamarono il popolo a sostenerli, non per farsi essi capi e amministratori della nazione, ma bensì per potergli conservare gli immensi vantaggi che i decreti loro gli accordavano. Il popolo, che manca raramente, o piuttosto non manca mai di buon senso, fu pronto a quella voce e insorse con furia contro i suoi antichi oppressori quando vollero nuovamente togliergli il frutto che già aveva gustato e che avea deciso serbarsi a prezzo di tutto il suo sangue. Ognuno sa quanto eroismo mo-
strò la Francia in quell’epoca!9.
La persistenza di un filone di pensiero democratico che continuava a fare riferimento ai principî dell’89 e all’esperienza giacobina è testimoniato anche da alcune delle voci che si espressero nella pubblicistica politica fiorita nei mesi precedenti lo scoppio rivoluzionario del 1848. Il più rappresentativo tra questi scritti è forse il Dialogo di alcuni italiani sulle odierne cose patrie, il cui nucleo è costituito da un violento attacco al costituzionalismo liberal-moderato, riportato alla sua essenza di classe in quanto giudicato programma dei ceti di più ricca borghesia. La raccomandazione generale posta all'esordio era infatti: — «Non riponete mai alcuna fiducia nelle persone troppo ricche, nei grossi mercanti,
banchieri,
avvocati,
sedicenti
dotti, scienziati
e letterati»;
mentre più avanti si affermava che la «borghesia» è la casta «la più esiziale 19. G. Budini, Alcune idee sull’Italia, Londra, 1843, pp. 12-13.
20. L’opuscolo reca la sola indicazione: Italia, 1847.
19
alla umanità per la quale soltanto sembra creato il mondo, ed alla quale esclusivamente è dato godere e fruire di tutti i beni, e miglioramenti fisici e morali che mai introdurre si possano su questa terra», quando invece il resto dell’umanità doveva adattarsi «a gemere eternamente sotto il peso della prepotenza fondiaria, del mancodi lavoro, della miseria, della fame»?!. Ai ricchi borghesi e agli intellettuali liberali moderati venivano così contrapposti i sinceri rivoluzionari, gli amici del popolo, dipinti con tratti che richiamano alla memoria motivi tipici del buonarrotismo: la virtù, la moralità, la purezza dei costumi («sobrii, nemici della crapula, del lusso, dell’ozio, non curanti di fal-
si amici, sprezzatori dell’aura popolare, ... dileggiatori delle riforme ingannatrici dei tiranni, coi quali non ammettono transazione alcuna possibile»)?2. Di
contro alla pratica delle costituzioni censitarie care ai moderati veniva così posto l’obiettivo di una costituzione realmente popolare, fondata sul suffragio universale, che desse vita a uno Stato nazionale unitario e repubblicano, vale a dire uno Stato retto da «leggi sagge, giuste, universali, fabbricate e consentite da tutti, nell’interesse di tutti, non da una classe e per una classe soltanto della società, minima frazione privilegiata, che la modella a seconda dei suoi capricci, dei suoi esclusivi interessi, del suo sentire diametralmente opposto all’immensa maggioranza degli uomini componenti una nazione, colla quale non ha eguaglianza di bisogni, né di appetiti»?3. E per indicare il cammino da percorrere per creare la nuova Italia il Dialogo come conclusione giudicava che la cosa più opportuna fosse riprodurre la «famosa dichiarazione dei diritti dell’uomo» di Robespierre, «che di per se sola vale la più sublime, anzi divina costituzione, che mai possa felicitare una nazione»?4, A questo punto riesce opportuno richiamare brevemente le tesi di Gramsci sulla questione della direzione politica nel corso del Risorgimento. Per spiegare la vittoria dei moderati sui democratici Gramsci — che utilizza nella sua analisi le categorie di «egemonia» e di «intellettuale» organico e tradizionale — sostiene che i liberal-moderati costituivano un gruppo sociale relativamente cinogeneo, il quale si poneva come l’espressione organica, l’avanguardia reale delle classi alte (alle quali appartenevano per la loro funzione economica), e che proprio per l’alto grado della loro «organicità» riuscirono a realizzare una direzione egemonica priva di grandi oscillazioni, esercitando così una forte attrazione sugli intellettuali di vario livello esistenti nel paese. I democratici invece non erano espressione organica di nessuna delle classi storiche esistenti; di qui la scarsa linearità della loro direzione po21. Ibidem, pp. 5 e 56. 22. Ibidem, p. 9.
23. Ibidem, pp. 27 e 28. 24. Ibidem, p. 42. La dichiarazione è pubblicata a pp. 45-49.
20
litica e la subordinazione di fatto ai moderati. Il Partito d’azione, aggiunge a questo riguardo Gramsci, avrebbe potuto porsi come forza autonoma e spingere il processo risorgimentale in direzione più accentuatamente democratica e popolare, spezzando la tendenza al compromesso dei moderati con le vecchie forze conservatrici, se avesse saputo elaborare «un programma organico di governo» nel quale si fossero rispecchiate «le rivendicazioni essenziali delle masse popolari, in primo luogo dei contadini». Il Partito d'azione avrebbe dovuto cioè configurarsi e comportarsi come un partito «giacobino» per il suo rapporto con le masse e per i contenuti economico-sociali del suo programma che avrebbero dovuto legarlo, con l’insistenza sulla questione della terra, alle popolazioni rurali (in specie quelle meridionali); in tal modo si sarebbe potuto mirare a mettere in crisi il tradizionale blocco reazionario formatosi nelle campagne operando una duplice sollecitazione, da una parte quella sui «contadini di base», che avrebbero visto così accolte le loro aspira-
zioni di fondo, dall’altra quella sugli «intellettuali degli strati medi e inferiori», che avrebbero potuto essere anch’essi interessati dalle prospettive aperte dal processo di costruzione di uno Stato nazionale, unitario e democratico. Come è noto questa interpretazione fu criticata a suo tempo da Federico Chabod (e poi da Rosario Romeo), il quale le mosse l’appunto di avere «falsato la prospettiva storica» perché Gramsci, cedendo alla suggestione di esigenze politico-pratiche, avrebbe indebitamente trasferito nel periodo risorgimentale una problematica — quella della questione agraria e del ruolo dei contadini — che si sarebbe invece posta come questione corposamente concreta soltanto all’indomani della prima guerra mondiale. Ma in realtà il problema del rapporto tra movimento rivoluzionario e masse, comprese quelle contadine, fu già nella stagione rivoluzionaria del 1848 uno dei nodi di fondo della vicenda politico-sociale italiana, e questo non soltanto perché il corso degli avvenimenti e il suo esito finale vennero in larga misura condizionati dall’atteggiamento delle classi popolari, ma anche perché proprio nel corso del ’48 la coscienza dell’esigenza di coinvolgere attivamente nel movimento le masse — urbane o rurali che fossero — facendosi carico programmaticamente del miglioramento delle loro condizioni materiali di esistenza cominciò a maturare in uomini e gruppi di tendenze democratiche, come dimostra tra l’altro l'esame del libero giornalismo di quei mesi?5.
All’indomani del ‘48, dopo la sconfitta della rivoluzione, all’interno della riflessione autocritica sulle ragioni del fallimento sviluppatasi in campo democratico presero a circolare una serie di motivi che testimoniavano l’esigenza di ricercare nuovi programmi e nuove prospettive d'azione. Ed emergeva25. Cfr., in questo volume, lo scritto // giornalismo del 1848 e la società italiana.
22
no tra questi motivi il riconoscimento della necessità del concorso delle «masse» per conseguire la vittoria, la coscienza dell’opportunità di individuare le parole d’ordine capaci di ottenere l’apporto popolare alla lotta, l’ammissione che nelle moltitudini esisteva e si manifestava un «desiderio di migliorare» su cui si sarebbe dovuto far leva, la consapevolezza che nel ’48 era mancato il «concetto» motore, la formula rivoluzionaria che il popolo potesse fare sua e levare in alto come bandiera. Mentre Mazzini rimaneva fermo alla sua impostazione fondamentalmente «politica» del moto italiano, che ai suoi occhi aveva mantenuto in tutto il corso del 1848-49 un carattere quasi esclusivamente «nazionale» (nel senso che se altrove — come in Francia — le masse si erano agitate anche per chiedere un nuovo assetto sociale che ponesse fine alla miseria e all’ineguaglianza, i popoli della penisola avevano avuto di mira soltanto o soprattutto l’indipendenza della patria), in diretta opposizione con le tesi mazziniane si andò così faticosamente enucleando una diversa visione strategica del processo risorgimentale, che indicava come unica soluzione concreta del problema italiano la rivoluzione sociale, il «socialismo». E questo socialismo era cosa ben diversa dalle aspirazioni a una riforma sociale ondeggianti tra sentimento e utopia, venate di sansimonismo e fourierismo, che si erano manifestate in Italia nel periodo precedente il ‘48 e che avevano avuto un legame assai tenue con i dati concreti della realtà italiana e con i suoi problemi di fondo. Si stava insomma delineando negli anni 1848-1852 una germinale corrente socialista, un «partito sociale» italiano, come lo chiamavano
alcuni sostenitori dei nuovi indirizzi; e si delineava,
quel che
più conta, sul terreno della questione nazionale, alimentandosi delle esperienze del ‘48 e della critica serrata al mazzinianesimo, accusato di insufficienza rivoluzionaria. Il distacco critico dal mazzinianesimo che accomunava i principali rappresentanti di questo «socialismo risorgimentale» investiva una serie di nodi essenziali della strategia rivoluzionaria. Anzitutto, per quel che riguarda la diade indipendenza-libertà, il fondatore della Giovine Italia era accusato di mostrarsi troppo spesso incline a posporre il secondo termine al primo. Mazzini e i suoi seguaci — questa la sostanza dell’argomentazione critica — riducevano il nucleo del problema italiano alla lotta contro 1’ Austria, e finivano perciò con il sottovalutare le forze controrivoluzionarie annidate all’interno dei singoli Stati sotto la protezione dell’impero asburgico e del papato, vale a dire le vecchie caste nobiliari, gli uomini del «monopolio» commerciale e manifatturiero, i grandi proprietari fondiari. Il dissenso era anche netto sulla questione del futuro assetto istituzionale del paese, perché la repubblica unitaria prospettata da Mazzini, che appariva poco rispettosa delle differenziazioni tra le varie regioni e scarsamente curante delle autonomie locali, si sarebbe potuta tradurre in un vistoso indebolimento della libertà. 22
Ma l’elemento di maggiore spicco politico e ideale nelle posizioni di questi oppositori di Mazzini era la denuncia del «formalismo» del genovese, cioè della sua predicazione di una rivoluzione essenzialmente politica, con il rifiuto dell’appello agli interessi materiali delle masse e il ripudio del socialismo. Questi [i mazziniani] — scriveva Carlo Pisacane nell’aprile 1851 in un brano
che va-
le a dare un’idea dell’altezza di toni raggiunta dalla polemica — dicono di non accettare il formalismo, ma combattono il comunismo, temono dichiararsi socialisti, propugnano il vangelo, in una parola negano la rivoluzione, e vogliono la rivoluzione. Quali sono le riforme da essi desiderate? S’ignora, l’ignorano essi medesimi, e pretendono che il popolo, per conquistare questo futuro incognito, compia la rivoluzione, ed attenda che Iddio comunichi le tavole della legge ad un nuovo Mosè?6.
La rivoluzione alla quale pensavano i democratici della dissidenza antimazziniana era invece una rivoluzione in cui l’accento batteva su una riforma radicale della società che eliminasse il privilegio e che veniva concepita non tanto in maniera strumentale, come un incentivo per suscitare ed alimentare lo slancio delle masse, quanto come la realizzazione di una società più giusta, di liberi e di eguali (di fatto, e non soltanto davanti alla legge), la società che la grande rivoluzione francese aveva presentito ma non aveva attuato. E in questa embrionale democrazia sociale, che affermava esplicitamente la necessità del «socialismo» anche a costo di spaventare i timidi, prendevano corpo il tentativo di creare un’alternativa radicale, in un certo senso «giacobina», al
mazzinianesimo e lo sforzo di superare le deficienze e le incertezze che avevano fino ad allora impedito al partito nazionale italiano di porsi decisamente alla testa di una rivoluzione che, evitando i patteggiamenti con le forze ancora legate al passato, potesse svilupparsi in modo coraggioso e conseguente e rompere — specie nelle campagne — gli arretrati rapporti sociali. Nel panorama del socialismo risorgimentale postquarattottesco, che ebbe il suo momento di più intensa fioritura intellettuale nella fase che precedette il colpo di Stato di Luigi Bonaparte del 2 dicembre 1851, le elaborazioni di maggiore impegno politico e concettuale furono quelle di Giuseppe Ferrari, Giuseppe Montanelli e Pisacane. Il socialismo ferrariano si compendiava nei due termini della formula «irreligione» e «legge agraria», la cui realizzazione sarebbe stata possibile soltanto mediante una stretta alleanza tra i democratici italiani e la Francia, il paese più inoltrato sulla strada del socialismo. Per «irreligione» Ferrari intendeva il trionfo della ragione e della scienza positiva, non metafisica, sul mito religioso, la vittoria della piena libertà dell’uomo sulle costrizioni del dogma. 26. Lettera di Pisacane a C. Cattaneo del 17 aprile 1851, in C. Pisacane, Epistolario, a cura di A. Romano, Milano-Genova, 1937, p. 118.
29)
La «legge agraria», dal canto suo, implicava una critica della concezione della proprietà intesa come diritto di disporre nella maniera più assoluta delle cose, ma non contemplava la sua distruzione radicale, poiché l’obiettivo di-
chiarato era invece quello del ristabilimento di una eguaglianza di posizioni, raggiungibile attraverso misure limitative del diritto proprietario, prima tra tutte l’abolizione dell’eredità. Quanto a Montanelli, per lui il nodo del problema stava in un drastico riordinamento del sistema economico europeo, tale da frantumare la potenza cre-
scente del capitalismo «monopolistico». In questa ottica per Montanelli, come già per Ferrari, era necessario che la rivoluzione italiana procedesse d’intesa con quella francese e si indirizzasse sulla via dell’attuazione del «socialismo», cioè di una serie di «riforme sociali» atte a far passare l'eguaglianza dal piano formale a quello sostanziale; e questo attraverso un associazionismo dei lavoratori libero e spontaneo nel quale «i contratti sociali, stipulati fra gli uomini per conseguire tale o tale altro fine mostrato utile e necessario dall’esperienza», avrebbero dovuto costituire i soli limiti all’inviolabilità della persona. Venendo infine a Pisacane, l’elemento che caratterizzava più nettamente la
sua prima riflessione organica sul movimento nazionale italiano (La guerra combattuta
in Italia negli anni 1848-49,
1851) era la vigorosa affermazione
della natura popolare della rivoluzione, la dichiarata fiducia nelle masse come forza motrice essenziale della trasformazione della realtà italiana: fiducia che poggiava sulla convinzione che nel ’48 le classi popolari avevano manifestato energie e capacità tali da permettere, se opportunamente utilizzate e dirette, la vittoria sulle forze della conservazione interna e dell’ Austria. Quello
che lo scrittore napoletano dunque lamentava era l'assenza di una elaborazione teorica sulla natura e sui fini della rivoluzione che fosse in grado di elevare al livello della consapevolezza le spinte e i fermenti che si agitavano negli strati inferiori della società: la mancanza cioè di un «concetto unificatore», di
un «germe rivoluzionario», senza i quali anche gli sforzi più generosi sarebbero risultati vani. E il concetto, l’idea guida che avrebbe portato alla vittoria altro non era che la rivoluzione sociale, il socialismo, la meta verso cui tendeva il progresso europeo: un socialismo che Pisacane concepiva in termini risolutamente rivoluzionari e classisti, con una coerenza e una decisione che lo distinguono dagli altri rappresentanti del «socialismo risorgimentale». Per Pisacane i mali di cui soffrivano i popoli erano conseguenza delle cattive «costituzioni sociali», condannabili non soltanto per la concentrazione della ricchezza e della povertà in due poli estremi, ma anche per l’esistenza di una oppressiva impalcatura statale, sempre in contrasto con gli interessi della collettività. Se alla radice delle piaghe che travagliavano la società europea stava dunque il fatto che i mezzi di produzione, l’educazione, l’esercito 24
erano nelle mani di pochi privilegiati o dei governi, e funzionavano come strumenti di sfruttamento e di repressione, la meta finale della rivoluzione appariva perciò quella di «democratizzare» e mettere al servizio della collettività i fattori produttivi, la milizia e l'educazione: «L'arte della guerra non dovrà più essere il monopolio di pochi, ma la nazione tutta dovrà essere guerriera; gl’istrumenti del lavoro, in comune;
l’educazione, universale, comune,
gratuita, obbligatoria... Le numerose legioni del popolo non potranno avere altra bandiera se non questa. La pratica di questo concetto, sortirà dai vortici della rivoluzione stessa»?7. Il programma così delineato da Pisacane si compendiava dunque in un comunismo anarchico, da realizzare per via rivoluzionaria, attraverso la creazio-
ne di un movimento socialista che fosse in grado di mobilitare le masse con un appello risoluto ai loro interessi materiali. Lo scrittore napoletano era ben consapevole delle difficoltà che si opponevano in Italia alla formazione di un partito socialista; e tuttavia la situazione italiana era da lui giudicata — con ottimismo volontaristico e in polemica con la tesi ferrariana dell’iniziativa rivoluzionaria francese — più vicina che non quella del paese confinante al punto di rottura, e questo soprattutto per l’ancora debole sviluppo della borghesia della penisola rispetto a quella francese. Ferrari, Montanelli, Pisacane non furono però isolati e solitari precursori; e questo perché la discussione da essi iniziata sulle connessioni tra rivoluzione italiana e socialismo e sulla questione del coinvolgimento delle masse popolari nel moto risorgimentale investì a fondo tutta la democrazia italiana in quel particolare momento storico in cui era generale la convinzione dell’imminenza di una ripresa rivoluzionaria. E basterà accennare all’influenza di Proudhon sulle idee di molti democratici che, mossi dall’esigenza di caratterizzare in senso sociale la rivoluzione nazionale, facevano pro-
pri in tutto o in parte i progetti di riforma del francese, imperniati sul «credito gratuito», sull’organizzazione mutualistica dello scambio e sulla sostituzione dello Stato con l’«anarchia», mezzi giudicati idonei a eliminare ogni forma di «monopolio» e di potere tradizionalmente autoritario e a far sorgere «dalle viscere del popolo, dalle profondità del lavoro» una società fondata sulla giustizia e sull’eguaglianza. Filone, questo del proudhonismo risorgimentale, nel quale si collocano, oltre a Pietro Maestri, Carlo Rusconi, Francesco Milo Guggino e Pasquale Calvi, Carlo De Cristoforis, che nella sua opera del 1851 // credito bancario e i contadini indicava nella libertà delle banche e nella gratuità del credito gli strumenti più efficaci per sollevare le popolazioni rurali lombarde dalla loro condizione di degradante miseria. 27. C. Pisacane, Guerra combattuta in Italia negli anni 1848-49, Genova, 1851, pp. 357-358.
29
In questi anni la necessità di confrontarsi immediatamente con la vicina esperienza del ‘48 rese meno attuale e sfumò negli uomini della democrazia italiana l’esigenza di rifarsi come a un termine di riferimento obbligato alla grande rivoluzione francese. La rivoluzione dell’89 assunse così in questa fase un valore metaforico e quasi di mito in alcuni esponenti dell’ala radicale della democrazia risorgimentale di cui si è ora fatto cenno. Così per Ferrari la Francia era l'incarnazione delle vere idee rivoluzionarie, le idee del razionalismo, della democrazia avanzata e del socialismo, e la portatrice dei principî della scienza e dell’eguaglianza, che aveva cercato di realizzare nell’89. La Francia sola... sostiene, dopo il 1789, — così il milanese riaffermava proprio all’indomani del colpo di Stato del 2 dicembre 1851 la sua fede nella missione francese — la guerra contro la santa alleanza; sola combatte la cristianità, e non potrà li-
berare se stessa senza liberare colle idee e colle armi la terra del pontefice e dell’imperatore... Collegare l’Italia alla Francia, radicare in Italia la rivoluzione francese, applicarla in ogni Stato nella misura determinata dalla Francia, trasformare l’Italia pontificia e imperiale in una federazione di Stati republicani, tale fu il mio voto?8.
A queste posizioni, sulle quali concordavano altri democratici della «dissidenza» antimazziniana come Montanelli? e Ausonio Franchi39, reagì con risentiti accenti misogallici, che lo avvicinavano per questo aspetto a Mazzini, il più avanzato dei rivoluzionari italiani, Pisacane, con la cui voce chiudere-
mo la nostra analisi. In polemica con quanti facevano della Francia la nazione iniziatrice Pisacane sosteneva infatti — come si è accennato — che le probabilità di uno sconvolgimento sociale globale capace di atterrare i pilastri dell’ordine costituito, la proprietà e l'autorità, stavano molto più nettamente dalla parte dell’Italia che da quella della Francia, non soltanto perché nella penisola i mali che opprimevano il popolo erano più gravi e maggiore il potenziale di energia delle masse, ma anche perché le forze della conservazione erano meno coese, più arretrati erano lo sviluppo industriale e la concentrazione del capitale, e più vigorose e suscettibili di sviluppo le tradizioni di autonoma vita comunale. E nel contesto della complessiva ideologia pisacaniana, che insisteva sulla necessità della distruzione del «governo» e della creazione di una società di eguali liberamente articolata dal basso verso l’alto, si spiegano anche la valutazione
sostanzialmente riduttiva della rivoluzione francese,
vista come un'esperienza fallita il cui merito precipuo era stato quello di aver 28. G. Ferrari, L'Italia dopo il colpo di Stato del 2 dicembre 1851, Capolago, 1852, pp. 2-3. 29. G. Montanelli, Introduzione ad alcuni appunti storici sulla rivoluzione d’Italia, edizione
a cura di A. Alberti, Torino, 1945, pp. 199 sgg. (La prima edizione dello scritto è del 1851). 30. A. Franchi, Saggi di critica e polemica, parte 3a, Milano, 1872, pp. 177 sgg. (art. L'Italia e la Francia, pubblicato per la prima volta in «La Ragione», Torino, 25 aprile e 2 maggio 1857).
26
contribuito alla presa di coscienza della preminenza della questione sociale su quella delle forme politiche, e il giudizio negativo sui gruppi dirigenti della rivoluzione stessa: La rivoluzione francese del 1789 fu una grandiosa esperienza che mise a nudo la poca importanza delle varie forme di governo relativamente ai mali che la società ammiseriscono. Coloro che governarono quella rivoluzione cercarono garantire la libertà, proponendosi a modello Grecia e Roma, e mostrarono ignorare affatto quelle storie. Se con maggiore oculatezza avessero cercato le cagioni di quello splendore le avrebbero scorte ne’ rapporti sociali, nello stato economico di que’ popoli... Se avessero fatto studio sui tanti esperimenti che fecero que’ popoli, e tutti invano, per impedire l’usurpazione di chi reggevali... si sarebbero convinti facilmente come sia impossibile limitare l’abuso ed evitare il despotismo, allorché delegasi a pochi la sovranità ed il potere che risiede in tutti, e solleciti delle forme lasciansi sfuggire la
sostanza delle cose3!.
31. C. Pisacane, La rivoluzione, a cura di A. Romano, Milano-Roma,
n
1957, pp. 137 sgg.
2. Aspetti sociali dell’età della Restaurazione
Le pagine che seguono si propongono di richiamare l’attenzione su alcuni problemi sociali che caratterizzavano la vita italiana nell’età della Restaurazione esaminandoli da una prospettiva che intende mettere l’accento più in particolare sulle concrete condizioni di esistenza delle masse popolari in quei decenni; e la scelta di questa angolatura spiega perché siano state tenute sullo sfondo le vicende più propriamente economiche, le situazioni strutturali, le trasformazioni del tessuto connettivo agricolo e manifatturiero, operando soltanto i collegamenti resi necessari dal filo del discorso. Motivo conduttore dell’esposizione è quello della estrema crudezza della situazione materiale delle classi «le più numerose e le più povere» (per usare la terminologia sansimoniana, mutuata dal Mazzini giovane), che porta a concludere per un aggravamento delle loro condizioni di vita e di lavoro le cui conseguenze si sarebbero proiettate fino ai primi decenni dello Stato unitario: quadro oscuro nel quale si cercherà di individuare, accanto alle persistenze del passato, le spinte alla modificazione e i fattori innovatori. Alcuni elementi di valutazione emergono già dalla cornice generale, ben nota, dell’economia italiana del periodo, quella di un paese essenzialmente agricolo, la cui variegata struttura era riconducibile ad alcune tipologie essenziali, e cioè quelle della montagna e della collina, della Valle padana, della fascia mezzadrile (Toscana, Umbria, Marche, Emilia-Romagna),
del Mezzo-
giorno. In ciascuna di queste grandi circoscrizioni, a parte gli effetti generali dell’espansione dei rapporti capitalistici, nei decenni della Restaurazione operarono in maniera più o meno profonda impulsi al cambiamento dei rapporti sociali delle campagne che basterà richiamare sommariamente. Così nelle regioni collinose del Piemonte l'agricoltura contadina delle zone viticole andò assumendo un aspetto per alcuni versi patologico (messa a cultura di 28
terre marginali a scapito di vecchi equilibri colturali, frammentazione delle proprietà, scarsa disponibilità di capitali). Nelle montagne e nelle vallate alpine della Lombardia e del Veneto una sovrana risoluzione del 16 aprile 1839 impose la vendita dei beni comunali incolti, che fino ad allora avevano rappresentato — con gli usi civici che su di essi venivano esercitati — «la scorta del fondo privato» del proprietario particellare; e i modi con cui fu condotta l’operazione avvantaggiarono quasi esclusivamente i proprietari più facoltosi e gli speculatori sul legname, deteriorando così la condizione del piccolo contadino: «Nelle circostanze attuali — constatava Stefano Jacini, che pure era in linea di principio favorevole all’alienazione — ... il bosco ed il pascolo del Comune rimarranno oggetti di prima necessità per il montanaro, e ciò che non gli verrà accordato per tolleranza, egli sarà costretto a rubarlo»!. Sempre in Lombardia, nella fascia collinare e della pianura asciutta un altro processo che provocò un peggioramento delle sorti dei contadini fu quello del passaggio dalla forma contrattuale della «masseria» a quella del contratto misto di fitto in grano e mezzadria. Tale contratto, che spezzava la grande unità lavorativa formata da quattro o cinque famiglie coloniche spesso imparentate tra loro, indebolendone
la capacità di resistenza all’introduzione
clausole più gravose, obbligava il nobile o un borghese) una quota soltanto coltivando a quel cereale alla metà, con il che veniva meno
di
colono a corrispondere al proprietario (un di grano fissa, che poteva essere ottenuta una porzione del fondo sempre superiore quella ripartizione a metà dei prodotti del
suolo che aveva invece contraddistinto la masseria, mentre il tendenziale ac-
crescimento della misura del canone in grano rendeva sempre più dure le condizioni di esistenza dei contadini. Nella «bassa» padana, intanto, dalle zone risicole del Vercellese e del Nova-
rese fino al delta del gran fiume si accentuava la penetrazione di elementi capitalistici, con la conseguente espropriazione di mezzadri e coloni e l’accelerazione della formazione di quel bracciantato di massa che negli anni ‘70-80 avrebbe fatto il suo drammatico ingresso nella vita politica e sindacale del paese. Quanto alle regioni mezzadrili
dell’Italia centrale, ai vecchi connotati
di
quell’agricoltura generalmente stagnante (staticità produttiva e tecnica, dipendenza personale della famiglia colonica dal padrone in forme che raggiungevano gli estremi umilianti codificati nelle «Istruzioni» di Bettino Ricasoli, 1. S. Jacini, La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia, Milano e Verona, 18573, p. 171.
2. Si vedano ad es. le «Massime imprescrittibili ed essenziali ad ogni colono dell’ Amministrazione», nelle quali si legge tra l’altro: «Saran prese di mira [dall Amministrazione] quelle famiglie dove i capocci non si dieno premura di fare istruire i loro figliuoli nei
29
isolamento e «solitudine» del colono determinati dall’insediamento poderale, suo indebitamento diffuso) si aggiunsero gli effetti di una situazione demografica caratterizzata da una sovrapopolazione relativa, primi tra tutti la disoccupazione e la sottooccupazione diffuse e la creazione di un ceto di «pigionali»: fenomeno, quest’ultimo, che non mancava di allarmare gli osservatori toscani, preoccupati che la comparsa di questo nuovo soggetto sociale potesse turbare gli equilibri del mondo mezzadrile. Il ceto dei pigionali — 0sservava nel 1832 Leonida Landucci, una delle voci principali del celebre di-
battito sulla mezzadria avviato in quegli anni in Toscana — «riempie queste campagne di miserabili, che vanno accattando di porta in porta, e rubando dai campi i prodotti di pronta consumazione»; e aggiungeva: «Questa classe di pigionali, che ogn’anno viene aumentata da quella parte di mezzaioli, che non trova, chi loro affidi un podere, se presto non diviene eccedente attribuir devesi alla stessa miseria, che ne distrugge tanto numero»3. E di lì a non molti anni, subito dopo le esperienze del ‘47-48, Marco Tabarrini avrebbe scritto a sua volta che quel ceto rappresentava in Toscana «il pauperismo agricola, fra noi che grazie al Cielo non dobbiamo deplorare, altro che in piccola proporzione, il pauperismo manifatturiero»; ed era il pigionale che «al primo flagello del bisogno... si gettò sui campi dai quali era uscito, non più come cultore, ma come ladro; tumultuò sui mercati per avere il grano a vil prezzo; chiese elemosina
e lavoro colla violenza;
e vittima di qualche ciurmatore
d’osteria partecipò, forse senza saperlo, a’ commuovimenti politici»*. Venendo infine al Mezzogiorno, storici e studiosi della questione meridionale hanno fatto luce piena sulla durezza delle condizioni di esistenza di quelle popolazioni, formate in larga parte di contadini (piccoli proprietari, coloni, braccianti, figure i cui tratti spesso sfumavano e si fondevano) al limite della sussistenza, il cui disagio era stato accentuato dall’eversione della feudalità e dalla vendita dei beni demaniali. L'abolizione del regime feudale portò infatti al rafforzamento della proprietà terriera borghese, senza che però questo processo comportasse una modificazione sostanziale delle arretrate doveri della cristiana religione, ove i padri e le madri invece di educare i loro figliuoli al bene ed al lavoro, non li conducono di buon ora al campo... Saran prese di mira quelle famiglie ove sia il vizio del bestemmiare,
ed anche quello di parlare disonestamente
e senza educazione,
oppure vi sia il vizio e l’uso del giuoco... Saran prese di mira quelle famiglie i di cui individui non vadano vestiti con quella semplicità e risparmio, qual si conviene al contadino» (A. Gotti, Vita di Bettino Ricasoli, Firenze,
1894, p. 38; e ivi cfr. anche l’«Istruzione»
agli «ufficiali»
della fattoria di Brolio del 1843, pp. 30 sgg.). 3. L. Landucci, Considerazioni sulla povertà del contado toscano, in «Giornale agrario toscano», Firenze, 1832, pp. 510-511. 4. M. Tabarrini, Sui pigionali di campagna, in «Atti» dell’ Accademia economico-agraria dei Georgofili, Firenze, 1849, pp. 59 e 61.
30
strutture agrarie e un rinnovamento dei metodi produttivi, che continuarono invece a incentrarsi sulla cerealicoltura estensiva praticata nel latifondo; quanto all’alienazione dei demani, di essa profittarono prevalentemente o quasi esclusivamente i ricchi proprietari borghesi e nobili, mentre i contadini non soltanto non poterono aumentare in misura sostanziale la loro partecipazione al possesso fondiario, ma dovettero subire le conseguenze negative della rottura del precario equilibrio della loro piccola azienda, nella quale una componente non secondaria era stata costituita fino ad allora dagli usi civici sulle terre demaniali. Si apriva così quella secolare questione demaniale che, come dirà nel 1879 Giustino Fortunato, avrebbe avvelenato i rapporti sociali nelle campagne meridionali acuendo le tensioni e provocando massicce e subitanee esplosioni: «Ogni moto politico — scriveva il meridionalista lucano — non fu distinto se non dal desiderio della borghesia di aver libere, una buona
volta, le mani; e que’ moti, immancabilmente, finirono uno per uno, specialmente nel 1848, tra le grida selvagge delle reazioni sociali de’ contadini»!. Un altro elemento che contribuì poi ad aggravare la pressione sui contadini di alcune regioni del Mezzogiorno fu la generalizzazione dei contratti di miglioria e di godimento che, se favorirono la piantagione di agrumeti in Calabria e di oliveti, vigneti e mandorleti in Puglia, spesso costringevano però il colono a lasciare la terra sulla quale aveva lavorato rendendola produttiva dopo otto, dieci, quindici anni, e lo condannavano alla disoccupazione e alla miseria. Alla scadenza del rapporto, questa l’amara conclusione di una acuta analisi del contratto di godimento pugliese fatta da Carlo De Cesare nel 1859, l’infelice [colono] diventa più misero di prima; perché ei non ha più gli anni freschi della giovinezza, non più la vigoria d’un tempo, distrutta da dieci o quindici anni di lavoro assiduo, non più il desiderio ardente di lavorare, non più le speranze dell’avvenire. La spossatezza, il disinganno, la miseria s’impossessano di lui, ed ei non è più buono a nulla; è un infelice cui manca il desiderio e la forza di lavorare!9.
Un altro fenomeno nuovo che nell’ultima fase dell’età della Restaurazione cominciò a interessare plaghe più o meno vaste dell’Italia settentrionale (ma non solo di quella), introducendovi i fermenti di modificazioni che si sareb-
bero fatte via via più rapide e tumultuose dopo l’Unità, fu quello dell’ «industrialismo»: termine con il quale i contemporanei intendevano l'avanzare di più moderni rapporti di produzione di tipo capitalistico nei settori manifatturieri e industriali e l’insorgere di quei problemi di natura sociale su alcuni dei quali si soffermerà più avanti il nostro discorso. 5. G. Fortunato, // Mezzogiorno e lo Stato italiano. Discorsi politici, Bari, 1911, vol. 1°, p. 84. 6. C. De Cesare, Delle condizioni economiche e morali delle classi agricole nelle tre pro-
vincie di Puglia, Napoli, 1859, p. 70.
Si
Fatti questi rapidi riferimenti di ordine generale si cercherà ora di definire nei loro contorni essenziali alcuni dei processi e delle questioni che nel periodo considerato assunsero un rilievo particolare nel tessuto della società italiana e che interessarono più da vicino la vita delle classi popolari. Si tratta di fenomeni a volte vecchi, a volte nuovi, altre volte ancora risultanti da uno stretto intreccio tra vischiosità del passato e anticipazioni dell’avvenire, ma tutti comunque rivelatori di quello stato di profondo malessere delle classi lavoratrici e popolari dal quale si sono prese le mosse. Ai quadri di una vecchia struttura economico-sociale in corso di erosione appartengono le due carestie del 1815-17 e del 1846-47 che marcano l’inizio e la fine dell’arco di tempo qui preso in esame. Nei primissimi anni della Restaurazione una successione di cattivi raccolti portò con sé in tutto il paese il consueto corteggio di mali tradizionali: il rialzo del prezzo del grano e degli altri generi, le manovre speculative, l’aumento della disoccupazione, i tumulti popolari e il saccheggio di mercati e forni, l’esasperazione del pauperismo con la conseguente impennata del tasso di mortalità, la fame fisiologica. La documentazione sul fenomeno è larghissima, e basterà ascoltare qualcuna soltanto tra le tante voci. «La classe poi degli indigenti, che è il numero maggiore di questa popolazione, — scriveva l’ispettore di polizia al confine di Chiavenna in data 7 luglio 1815 — non sapendo più in qual modo alimentarsi, si ciba di erbe selvatiche le quali non possono a meno di produrre delle forti malattie»?; mentre una relazione di un parroco dell’ Udinese del 6 giugno dello stesso anno informava che la popolazione si cibava di fusti di pannocchie macinati e conditi con erba senza sale e in alcuni casi perfino di sterco8; e un anno più tardi un osservatore annotava da Ancona che «i poveri, che sono la massima parte della popolazione, si nutriscono malamente di ghiande, che pur per disgrazia poche se ne trovano»9. In questo quadro di fame generalizzata appare comprensibile la pubblicazione di testi di taglio catechistico-esortatorio che invitavano i contadini a dedicarsi alla coltura delle patate, di cui si magnificavano i pregi, o impartivano consigli di dubbia praticabilità sugli accorgimenti da seguire per calmare i morsi della farne: pubblicistica il cui documento più rappresentativo è forse il Manuale di carità del medico marchigiano Giuseppe Casagrande che suggeriva, oltre al consumo delle ghiande, delle bucce di agrumi e di meloni seccate, di erbe secche, anche quello delle carni di cani e gatti, di vipere e
serpi, e che mostrava qualche esitazione soltanto di fronte ai lombrichi e al7. ASM, Annona, p.m., cart. 16. 8. G. Monteleone, La carestia del 1816-1817 nelle province venete, estr. da «Archivio veneto», 1969, p. 42.
9. M. Petrocchi, La Restaurazione romana (1815-1823), Firenze, 1943, p. 20.
se
le cicale!0. E al flagello ricorrente della carestia e della fame le autorità centrali e locali si affannavano a porre qualche aleatorio riparo con i palliativi praticati da secoli: divieti di estrazione dei grani, lavori pubblici, potenziamento della beneficenza legale, appello alla carità privata. Gli stessi tratti presentò la replica del 1846-47, l’ultima grande carestia della storia italiana, nella quale fu però presente una novità di ordine politico, cioè il tentativo di utilizzare strumentalmente la crisi annonaria in funzione liberal-nazionale condotto da gruppi di oppositori ai regimi esistenti in Lombardia, in Romagna e in altre parti del paese!!: tentativo che fu abbozzato anche in Toscana, dove prevalse però tra i liberali la preoccupazione per le dimensioni assunte dai movimenti popolari in reazione al caroviveri!?. L’accenno alle carestie offre lo spunto per portare il discorso sull’alimentazione delle classi popolari, un tema questo al quale gli studi storici hanno finora dedicato una attenzione insufficiente e che costringe a ricorrere ancora a lavori vecchi di più di un secolo come quelli relativi al «popolo minuto» di Milano e Napoli. L'analisi, che non è possibile fare qui per la carenza delle ricerche locali, dovrebbe
essere
assai articolata, e questo non
soltanto per l’ovvia distinzione tra città e campagna, ma anche per la differenziazione di tipi sociali esistente all’interno del mondo rurale. Assai diverse erano infatti le possibilità alimentari di un bracciante della Valle padana, privo di terra e compensato con un salario in natura e in denaro in generale al disotto delle sue esigenze vitali, rispetto a quelle più elevate di un obbligato della zona della «cascina» della bassa lombarda, al quale spettava il «diritto di zappa» su un piccolo appezzamento che gli permetteva di inte10. G. Casagrande, Manuale di carità e di pubbliche istruzioni ai poveri famelici opportuno sempre, ma specialmente nelle circostanze di carestia, Verona, 1816. 11. Per la Lombardia v. F. Della Peruta, Democrazia e socialismo nel Risorgimento, Roma,
19732, pp. 67 sgg. Quanto alla Romagna cfr. L.C. Farini, Epistolario, vol. 1°, Bologna, 1911, pp. 629, 634, 653. 12. Si vedano ad es. le stampe clandestine intitolate «Toscani!» (22 gennaio 1847) e «I liberali al popolo italiano» edite in G. Montanelli, Memorie sull’Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al 1850, Torino, 18532, vol. 1°, pp. 335-340 e 344-345. Un’altra stampa clandestina, datata Borgo a Buggiano, 6 gennaio 1847 e indirizzata «Al popolo», alludendo all’armamento della guardia civica per reprimere i tumulti annonari così scriveva: «Gli uomini che tu vedi con le armi, vogliono impedire che si rinnovino le ruberie, e i saccheggi che a tuo nome si sono operati fin qui (mentendo il pretesto di darti del pane) da pochi individui oziosi e ladri: vogliono unicamente tutelare le proprietà dei cittadini ingiustamente manomesse nei fatti accaduti... Che giustizia è la tua? Credi forse o popolo che dallo spoglio della casa del ricco, del magazzino del negoziante, della taberna del venditore, ne venga la tua opulenza? T’inganni, la ricchezza viene dal solo lavoro, se di questo tu manchi, o popolo, chiedilo legalmente al governo costituito che deve dartelo, ed ha solo i mezzi per dartelo, non spogliare i tuoi concittadini che non possono darti di più di quello che ti danno. Chiedi lavoro, e gli uomini che tu vedi in armi si uniranno alle tue dimande»; Archivio di Stato di Firenze (da ora ASF), Buon
Governo segreto, anno 1847, fascio 48, aff. 303, parte II.
33
grare il salario con un certo quantitativo supplementare di derrate; e differenze quantitative e qualitative di un qualche rilievo potevano verificarsi tra i mezzi di sussistenza di un mezzadro dell’Italia centrale, che l'aspirazione a ricavare dal podere tutto il necessario alla vita spingeva alla promiscuità produttiva, e il colono meridionale vincolato ad un contratto miglioratario, costretto a vivere del ricavato delle stentate culture fra i filari di piante e viti e a fare assai spesso ricorso alle anticipazioni usurarie del proprietario. In linea generale si può comunque affermare che il bilancio nutritivo degli appartenenti alle classi popolari fosse più o meno carente dal punto di vista dell’apporto proteico, vitaminico e calorico, donde una condizione di sottoalimentazione endemica e costante. Per dare un’idea di qualcuno dei regimi alimentari del tempo si può ricordare quello delle popolazioni rurali dell’alto Milanese e del Comasco come ce lo descrivono gli osservatori coevi. La nota fondamentale era il ruolo del mais, che dominava nei pasti quotidiani del lavoratore rurale. A colazione il contadino consumava un pane misto di granturco, segale e miglio (panificato rudimentalmente in grosse forme che dopo pochi giorni inacidivano e ammuffivano), mangiato da solo o bagnato in acqua salata e condito con olio di ravizzone o lino. Il pranzo consisteva in una polenta di mais arricchita con fagioli o cavoli e insaporita con olio di semi o lardo, accompagnata da una piccola porzione di formaggio; e alla cena si replicava la polenta con un magro companatico. Assolutamente marginale era il consumo delle carni fresche; la maggior parte dei contadini della zona, si legge in una testimonianza immediatamente postunitaria, valida nella sostanza anche per gli anni della Restaurazione, «non conoscerebbero il sapore delle carni se al Natale non comperassero alcune ossa di porco o di vacca, non spoglie al tutto di muscoli, con cui preparano tanta copia di brodo per le zuppe e minestre che il brodo stesso non si differenzia dall’acqua»!3. Quanto all’alimentazione dei ceti popolari nelle città lombarde essa somigliava nei suoi tratti essenziali a quella delle campagne, caratterizzata com'era dalla prevalenza di cereali e legumi e dalla scarsità di carne, anche se va detto che nei maggiori centri urbani diminuiva nell’apporto nutritivo la parte spettante al mais a vantaggio di altri grani, non escluso il frumento. Ed ecco il pasto-tipo di una famiglia popolare romana nella descrizione che ce ne ha lasciata lo studioso della carità nella capitale pontificia di quel periodo, Carlo Luigi Morichini:
«La colazione è un poco di pane, con qual-
che frutto o formaggio o carne salata. Il pranzo nei giorni ordinarii è minestra 13. E. Ferrario, Intorno allo stato materiale, intellettuale e morale de’contadini di una parte della Lombardia, estratto da «Memorie» no, 1867, passim.
del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, Mila-
34
col lardo, pane, frutta e formaggio, e per bevanda per lo più l’acqua; la cena un poco d’insalata, pane e vino»!4. Passando poi ad un altro caso tipico di alimentazione, quella del «popolo minuto» di Napoli, le testimonianze coeve sono concordi nel sottolinearne le carenze. Se le paste alimentari comparivano sei giorni su sette nella mensa delle famiglie della borghesia, per il lavoratore e l’artigiano quello dei «maccheroni» era un desiderio soddisfatto soltanto nelle festività; lo scarso consu-
mo delle carni si limitava generalmente a quello dei suini in inverno (nella caratteristica forma del «soffritto») e degli ovini in primavera-estate, mentre dei bovini il livello dei prezzi rendeva accessibili soltanto le parti di scarso pregio (la trippa o «capezzale»); così pure erano esclusi dal desco dei poveri i pesci, eccezion fatta per il baccalà e le alici salate, mentre invece era largo il ricorso alla frutta e alla verdura!5. Quanto alla razione-standard del contadi-
no pugliese essa consisteva, a detta del De Samuele Cagnazzi, in un rotolo e 1/3 di pane, condito con sale e olio e bagnato nell’acqua, accompagnato da verdure cotte o crude, «alimento minore di quello, che aveano gli antichi servi da catena, addetti all’agricoltura»!6.
E a queste sommarie indicazioni sono infine da aggiungere due notazioni: la prima sulla funzione tradizionalmente svolta dalla castagna nell’alimentazione delle popolazioni di montagna; e la seconda sul ruolo sempre più rilevante che andò assumendo una coltura nuova, quella della patata, che guadagnò progressivamente terreno nei primi decenni dell’ 800. In un panorama complessivo delle condizioni di esistenza delle classi popolari un adeguato risalto dovrebbe essere dato ai problemi igienico-sanitari, per tanti versi legati a precedenti di un passato più o meno lontano; ma la carenza di lavori preparatori consiglia anche a questo riguardo di tenere l’esposizione entro i limiti di rapidi accenni tematici. I caratteri delle strutture urbane e la tipologia delle dimore dei ceti subalterni nelle città e nelle campagne tingono il quadro di colori scuri. E si prenda uno dei tanti casi, scelto nel relativamente più ricco Settentrione, quello di Brescia: qui si sommavano gli effetti funesti di una serie di elementi quali l’altissima densità di abitanti all’interno della cinta muraria, l’elevato indice di agglomeramento per vano, la strettezza delle strade e la mancanza di spazi liberi, l’umidità e la sporcizia delle vie e delle abitazioni, le disastrose condi-
14. C.L. Morichini, Degli istituti per la sussistenza e l’educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma, Roma, 1870, p. 86. 15. Sull’alimentazione del popolo minuto in Napoli, Napoli, 1863, passim. 16. L. De Samuele Cagnazzi, Saggio sulla popolazione del Regno di Napoli ne’passati tempi e nel presente, Napoli, 1839, parte 22, pp. 36-38, cit. in D. Demarco, /! crollo del Regno delle Due Sicilie. I. La struttura sociale, Napoli, 1960, p. 129.
35
zioni della rete dei canali nei quali si convogliavano le acque luride che contaminavano pozzi e fontane; donde le punte assai alte della mortalità!?. Quanto alla vicina Milano ancora alla vigilia dell’ Unità in numerosi borghi e contrade le case erano «catapecchie... indegne di accogliere gente viva», mentre anche il riassetto delle zone più popolose aveva una contropartita negativa, perché il «martello demolitore» costringeva le famiglie più disagiate ad abbandonare le loro vecchie abitazioni alla ricerca di un tetto più caro!8. Venendo a Genova la degradazione igienica della città ligure fu oggetto di insistenti deplorazioni di osservatori e studiosi; una testimonianza del 1819 parla della sua «aria umida, tiepida e sopraccarica di emanazioni escrementizie di ogni specie»; e a sua volta un testo del 1855 lamentava la «stragrande quantità di popolo minuto ridotto ad abitare in ristrettissimi spazii», l’insalubrità delle dimore, «addossate le une alle altre, umide, mancanti di aria, di luce, di acqua», la sporcizia dei carruggi e dei «piccoli cortiletti che a guisa di pozzi si trovano d’ordinario al centro di quelle altissime case a cui non forniscono che un’aria viziata», le «esalazioni pestilenziali delle fogne che innumerevoli scorrono sotto il suolo stradale non tutte ben conosciute dalla edilità, neglette od imperfettamente e raramente pulite»!?. Una situazione limite era poi quella di Napoli, la città dei «fondachi» e dei «bassi», nelle cui abitazioni «la cucina, il pozzo, il luogo immondo e il letto» erano in una stessa stanza; la città in cui, nella metà dell’ 800, i canali di raccolta delle acque luride (spesso sco-
perti) si immettevano in mare attraverso 54 sbocchi tra il porto della Maddalena e Mergellina e in cui circa 5.000 pozzi neri dalla manutenzione primordiale costituivano un perenne tramite di inquinamento. Sempre nella capitale del Regno una delle principali fonti di approvvigionamento idrico, il canale di Carmignano, scorreva a cielo aperto nel tratto da Maddaloni a Casalnuovo, ricevendo lungo il percorso le acque di vari torrenti melmosi e servendo tra l’altro ai contadini per la macerazione della canapa?0. Per quel che riguarda i contadi, la situazione desolante della pur fertile Lombardia — dove i limitati ammodernamenti delle abitazioni rurali furono dovuti soprattutto alle premure dei proprietari per l'allevamento dei bachi da seta e dove i contadini continuarono a utilizzare le stalle come principale locale di ritrovo nelle lunghe serate delle stagioni fredde —! non si differenzia17. Cfr. più avanti il saggio La società lombarda tra il 1815 e l’Unità. 18. Ibidem. 19. G.B. Montaldo, La teoria della dissenteria, cit., in «Biblioteca italiana», Milano, 1819,
vol. 15; p. 409 e A.M,, Società ligure per la costruzione di case pei poveri in Genova, in «Annali universali di statistica», Milano, 1855, vol. 123; p. 289. 20. O. Caro, L'evoluzione
igienica di Napoli, Napoli,
1914, pp. 101-102, e S. De Renzi,
Topografa e statistica medica della città di Napoli, Napoli, 18454, pp. 306-307. 21. Si veda più avanti.
36
va da quella dei centri rurali del Mezzogiorno e delle isole, la cui promiscua degradazione fu rivelata al paese da pagine incisive dei primi meridionalisti?2. Stando così le cose, nel quadro sanitario dell’Italia della Restaurazione predominano le tinte fosche: componenti di quel quadro erano malattie come il tifo nelle sue varie forme (e basti pensare all’epidemia di tifo petecchiale che infierì in tutta la penisola tra il 1815 e il 1817, e le cui conseguenze furono drasticamente aggravate dalla carestia?3), il vaiolo, la difterite, la grippe, la tubercolosi, la scrofola, il gozzo e il cretinismo (nelle vallate alpine). Tra i vecchi morbi endemici faceva poi spicco la malaria, la cui diffusione — determinata dalla presenza di vaste plaghe impaludate — fu favorita dai progressi della risicoltura?4. La malaria, al di là della sua impressionante incidenza (ancora alla fine dell’800 circa 19 milioni di italiani erano esposti al rischio del contagio; mentre, per quel che riguarda uno dei casi limite, quello della Maremma toscana, il Salvagnoli-Marchetti in un lavoro del 1844 stimò la percentuale dei malarici nel 54% a Orbetello, nel 59% a Grosseto, nel 66% a Gavorrano, nel 70% a S. Fiora?5), continuò ad agire — come è stato scritto da Franco Bonelli — quale «fattore cumulativo di sottosviluppo» nel Mezzogiorno; essa infatti, respingendo le popolazioni dalla pianura verso le colline e le zone più elevate, provocò il loro sfruttamento irrazionale in funzione di un’economia di autoconsumo, con il conseguente aggravamento del diboschimento e del dissesto idrogeologico. In questi decenni assunse un rilievo drammatico un fenomeno relativamente nuovo nel triste panorama sanitario italiano, quello della pellagra, il morbo che insinuatosi nel Veneto e in Lombardia tra la fine del ‘600 e gli inizi del 7700 prese a propagarsi più rapidamente nella seconda metà del ‘700 ed infierì poi endemicamente per tutto il corso dell’800 tra le popolazioni rurali dell’Italia settentrionale. I primi medici che dalla fine del ’700 presero a studiare il male formularono l’ipotesi che alla base della pellagra stessero le carenze e le caratteristiche del regime alimentare. Già nel 1779 il medico milanese Gherardini prendeva in considerazione l’alimentazione dei contadini 22. Cfr. ad es., per la Sicilia, S. Sonnino, I contadini in Sicilia, Firenze, 1877, pp. 87-88. 23. L’epidemia di tifo petecchiale del 1816-18, che si diffuse pressocché in tutta l’Italia, colpì in Lombardia — secondo le statistiche del tempo che sottostimavano il fenomeno — circa 38.000 individui (1° 1,7% della popolazione, con punte del 3,09% nella provincia di Cremona); nel Veneto si toccò la percentuale dell’ 11,8% dei colpiti rispetto alla popolazione nella provincia di Udine; a Livorno ci furono circa 2.000 casi; a Vasto pare rimanessero contagiati i 4/5 della popolazione (v. A. Corradi, Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850, vol. 3°, Bologna, 1973, ristampa fotomeccanica, pp. 150 sgg.). 24. Si veda sul problema L. Faccini, Uomini e lavoro in risaia. Il dibattito sulla risicoltura nel ’700 e nell’800, Milano, 1976. 25. A. Salvagnoli-Marchetti, Saggio illustrativo le tavole della statistica medica della Maremma Toscana, Firenze, 1844, passim.
37
lombardi notando che essi si cibavano quasi esclusivamente di un pane che era il più delle volte fatto con un «impasto di formentone, o grano turco, con segala, o con miglio»?6 e che sulle loro mense non compariva quasi mai la carne. Pochi anni dopo, era la volta di Gaetano Strambio (l’ispiratore del pellagrosario di Legnano che individuò per primo la triplice sintomatologia — cutanea, gastro-intestinale e nervosa — del male) a chiamare in causa in modo più articolato il tipo di alimentazione prevalente nell’alta pianura e nella collina del Milanese, le cui popolazioni consumavano solo eccezionalmente cibi animali??. E che alla base del male fossero l’indigenza e l’alimentazione inadeguata che quella comportava era anche la convinzione largamente dominante nelle risposte fornite da un gruppo di medici condotti della Lombardia a un’inchiesta avviata nel 1819: «Dove ha famiglie che si nutrono di buoni, variati e salubri cibi e specialmente carne e in convenevol copia, colà è sconosciuta la pellagra. Essa non segue un andamento topografico, ma lo stato economico dei popoli e delle famiglie: vibra i suoi strali là dove regna la povertà»28. Non è qui il caso di attardarsi sui dati statistici del tempo, infidi e in
generale largamente inferiori alla realtà per l’imperfezione delle rilevazioni inficiate dalla ostinata ritrosia dei contadini colpiti dal male a denunciare il loro stato (per cui le statistiche finivano con il tener conto dei soli pellagrosi «conclamati», trascurando i malati nel primo stadio) e anche dalla difficoltà
di distinguere i pazzi pellagrosi dagli altri. Basterà ricordare che secondo le stime dei delegati nel 1816 i pellagrosi sarebbero stati il 10% della popolazione della terraferma della provincia di Venezia, il 4,5% della popolazione del Vicentino e circa 40.000 nel Trevisano29. E in Lombardia, stando a un’inchiesta del 1830, nei 1.253 comuni colpiti i pellagrosi erano 20.282, pari all’ 1,4% della popolazione, con un massimo del 2,9% nella provincia di Brescia e del 2,8% in quella di Bergamo (qui la statistica dava percentuali dell’11,6 nel distretto di Trescore, dell’8,6 in quello di Clusone e del 7,7 in quello di Martinengo)30. Val piuttosto la pena di insistere sulla localizzazione del morbo. Esso colpiva infatti con larghissima prevalenza i contadini delle zone collinari e della pianura asciutta della Lombardia e del Veneto, e cioè le zone dove regnava l’alimentazione maidica, alla quale quelle popolazioni rurali erano costrette dalla miseria e, nel caso della Lombardia, da un regime 26. M. Gherardini, Della pellagra, Milano, 1779, pp. 53-54. 27. G. Strambio, De pellagra annus secundus, Milano, 1787, p. 82. 28. Come introduzione alla storia del morbo cfr. G. Strambio jr., La pellagra, i pellagrologi e le amministrazioni pubbliche, Milano, 1890. 29. M. Berengo, L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all’Unità, Milano, 1963, pp. 89-92. 30. L. Balardini, Della pellagra, del granoturco quale causa precipua di questa malattia e dei mezzi per arrestarla, Milano, 1845, pp. 132 sgg.
38
contrattuale che riservava ai proprietari la produzione del grano, lasciando ai coloni il granturco; e a questi contadini non si poneva se non in piccola misura
l’alternativa
del
riso,
ricco
di vitamina
PP
(la miacina,
Pellagra
Preventing), che limitava invece i danni della pellagra tra i lavoratori della pianura irrigua, consumatori di quel cereale. Alla metà degli anni ’30 fece poi la sua comparsa in Italia una epidemia fino ad allora sconosciuta, il colera, che con i suoi effetti devastatori prese il
posto della peste, ormai scomparsa3!. Il morbo, del quale si ignoravano allora l'agente e il meccanismo diffusivo, dopo aver raggiunto nel 1835 gli Stati sardi di terraferma si propagò nel Lombardo-Veneto e proseguì poi la sua lenta marcia verso il sud, toccando Roma alla metà del 36 e la Sicilia un anno più tardi. Il terribile male fece sentire la sua presa soprattutto sugli strati più miseri della popolazione, che pagarono il tributo di vite proporzionalmente più alto, in conseguenza dei depressi livelli delle loro condizioni igienico-sanitarie e delle difficoltà che incontravano a riparare in località meno esposte ai rischi del contagio. E valgano a dare un’idea sommaria dell’entità del male alcuni dati indicativi, iniziando dagli Stati sardi. Qui la provin-
cia più colpita fu quella di Bobbio, dove su circa 28.000 abitanti si ebbero 1.463 casi, di cui 978 mortali (e cioè un caso ogni 19 abitanti, con le punte più elevate a Pietra Gravina, 1 caso ogni 5 abitanti). A spiegazione dell’incidenza dell’epidemia i documenti ufficiali chiamarono giustamente in causa le «pessime» condizioni dell’igiene e dell’alimentazione della popolazione agricola, che favorirono 1’«inferocire del morbo» e l’elevato tasso di mortalità.
Le abitazioni campestri, come quelle ancora de’ contadini abitanti nei paesi, — si legge in una relazione medica coeva — sono infelicissime, mal costruite e non difese dall’intemperie, umide, a cagione delle stalle, a pian terreno, sucide e fumicanti,
spesso d’un solo piano ed anguste; sicché sono costretti a giacere molti in luoghi ristretti e bassi, non raro sulle scranne dei focolari, negli ovili, ed anche sullo strame. I contadini, costretti ad alimentarsi di ciò che producono i terreni ove dimorano, vi-
vono di polenta di melica, o di castagne; di pane composto con melica, legumi ed altri cereali ordinari; di minestra per la maggior parte di patate o di rape. Questi cibi si rendono anche più insalubri per essere spesso immaturi, non condizionati a dovere, mal conditi; anche le frutta concorrono ad alimentarli, e per essere selvati-
che, e spesso acerbissime formano una sorgente d’innumerevoli incomodi, special-
mente per i fanciulli32.
31. L’ultima epidemia di peste in Italia sembra sia stata quella di Noia (l’odierna Noicattaro), sulla quale v. Corradi, op. cit., vol. 3°, pp. 125 sgg. 32. Informazioni statistiche raccolte dalla R. Commissione superiore per gli Stati di S.M. in Terraferma. Statistica medica, parte 22, Torino, 1849-1852, p. 635 e passim.
39
Nella triste graduatoria seguiva la città di Genova, che su circa 98.000 abitanti noverò più di 4.000 casi, con 2.163 decessi33.
Quanto alla Lombardia, che fu una delle regioni nelle quali il colera venne meglio tenuto sotto controllo, su una popolazione di circa due milioni e mezzo di abitanti ci furono 57.000 casi (1 su 43 abitanti). A Milano, dove una più rigorosa osservanza delle misure sanitarie prescritte dalle autorità favorì
un decorso relativamente mite dell’epidemia, la proporzione dei colpiti fu di 1 per 103 abitanti, mentre nel comune
dei Corpi Santi (che abbracciava una
fascia di territorio suburbano concentrica alla città e dove vivevano lavoratori a basso reddito) la proporzione si elevò a 1 su 40. Nella provincia di Brescia, particolarmente provata, la proporzione fu di 1 a 15, ma nella città (al cui dissesto igienico si è già accennato) si ebbe un coleroso ogni 7,5 abitanti; e anche qui, constatava un medico, «i miserabili correvano più rischi dei ricchi,
massimamente quelli che abitavano luoghi sporchi e poco ventilati». Anche nelle province venete l’incidenza dell’epidemia fu elevata (1 caso ogni 48 abitanti), con punte più alte in quella di Verona (1 caso ogni 23 abitanti circa) e di Venezia e Vicenza (1 caso ogni 33 abitanti)34.
Alcune cifre assolute aiutano infine a dare un’idea delle proporzioni assunte dal contagio nel Mezzogiorno, dove l’estrema degradazione delle condizioni igieniche e le carenze delle strutture sanitarie offrivano un terreno particolarmente favorevole alla propagazione dell’epidemia. A Napoli i colpiti dal male nel corso delle due invasioni coleriche del 1836-37 furono circa 30.000, con più di 17.500 morti; e dimensioni altrettanto catastrofiche assunse il morbo nei centri urbani della Sicilia, dove nella sola Palermo ci sarebbero stati
più di 26.000 casi55. E ai lutti tenevan dietro i fenomeni economici tradizionalmente legati alle grosse epidemie: l’avvilimento del commercio, la disoccupazione di artigiani e operai, il rincaro del costo della vita; a tutto questo si aggiungevano infine le istintive e incontrollate reazioni delle popolazioni urbane e rurali, inclini ad attribuire l’insorgere e il propagarsi del contagio all’azione perversa dei medici e più ancora delle autorità vissute generalmente come proprie nemiche. Si è già accennato in precedenza a un altro fattore di profonde modificazioni del tessuto economico-sociale, il nascente e progrediente industriali33. Ibidem, p. 644.
34. G. Ferrario, Riassunto statistico comparativo dei casi del contagioso cholera-morbus asiatico notificati nelle provincie lombarde, durante le epidemie delle quattro importazioni avvenute negli anni 1836, 1849, 1854 e 1855..., in «Atti» dell’ Accademia fisio-medico-statistica
di Milano, 1855-1856, pp. 448-449. 35. A. Sansone, Gli avvenimenti del 1837 in Sicilia, Palermo, 1890, passim, e Corradi, op. cit., vol. 3°, pp. 520-521. Per Napoli cfr. A.L. Forti Messina, Società ed epidemia. Il colera a Napoli nel 1836, Milano, 1979.
40
smo, che verso gli anni ‘40 cominciò ad attrarre su di sé l’attenzione di studiosi e pubblicisti. Senza entrare nel merito di problemi che sono di pertinenza della storia economica, va però qui affermata — per una appropriata valutazione del fenomeno di contro a tesi che hanno circolato in anni recenti e che attribuiscono il deludente sviluppo industriale del Mezzogiorno soprattutto alla politica delle classi dirigenti dello Stato unitario — l’esistenza di radici secolari della diversificazione dei processi economici del Nord e del Sud: diversificazione che nella fase finale del periodo della Restaurazione trova un riscontro oggettivo nella concentrazione nelle regioni settentrionali di alcuni dei principali settori trainanti dello sviluppo industriale, come quello serico e quello cotoniero. Manifattura e industria tessili implicavano, come è noto, l’utilizzazione su
larga scala delle donne e dei fanciulli, serbatoio di una forza-lavoro che era possibile impiegare con salari assai tenui. E le dimensioni del fenomeno presero alla vigilia del 48 aspetti così preoccupanti da sollecitare gli interventi di un Ilarione Petitti di Roreto, di un Lorenzo Valerio, di un Giuseppe Sacchi e da divenire oggetto di dibattito nei congressi degli scienziati. E anche a questo proposito siano consentite alcune cifre indicative. Negli Stati sardi di terraferma agli inizi degli anni ‘40 su circa 40.000 lavoratori delle filande di seta si contavano 36.000 donne, e tra esse 18.000 erano fanciulle al di sotto dei 14 anni; su 15.000 addetti alla tessitura serica 10.000 erano di sesso femminile, con 2.600 fanciulli e fanciulle di meno di 15 anni; nell’industria del
cotone su 17.000 adulti la metà erano donne, cui si aggiungevano circa 3.300 fanciulli. Quanto alla Lombardia, secondo calcoli prudenziali gli addetti agli opifici di età tra i 6 e 1 14 anni erano più di 54.00089. L’avanzata sulla via dell’industrialismo fu accompagnata da quella serie di conseguenze negative sulle condizioni del lavoro e sulla salute degli operai che erano state lumeggiate da un’ampia letteratura in Inghilterra e in Francia, letteratura che ebbe un significativo riscontro — e sia pure più tardo e meno nutrito — anche in Italia. Una attenzione particolare fu portata (com’era naturale date le dimensioni che il settore andava assumendo) all’«igiene e moralità degli operaj di seterie», come suona il titolo del noto scritto del Valerio, il quale nel 1840 sotto-
lineava l’incidenza che sulla salute delle «trattrici» avevano la mancanza di riposo derivante dagli orari lavorativi di 15-16 ore giornaliere, l’azione del 36. Cfr. Voto della Commissione nominata nel V Congresso degli scienziati italiani per riferire sul lavoro dei fanciulli negli opifici italiani, in «Annali universali di statistica», 1844, vol. 82°, pp. 301 sgg. V. anche G. Sacchi, Sullo stato dei fanciulli occupati nelle manifatture, ibidem, 1842, vol. 73°, pp. 9 sgg. e 233 sgg., e 1843, vol. 75°, pp. 237 sgg.; C. Correnti, Su/ lavoro dei fanciulli negli opifici italiani, in «Rivista europea», Milano, 1844, vol. 2°, pp. 577 sgg.
41
calore sprigionato dalle bacinelle, l'immersione continua delle mani in un’ac-
qua quasi bollente (che provocava le dolorose infiammazioni chiamate «mal della caldajuola»), le esalazioni dei bachi macerati nell’acqua e ivi imputriditi, l’abuso di cibi scadenti37. Quanto ai lavoratori dei filatoi lo stesso autore metteva in rilievo i guasti che al loro fisico arrecavano la scarsità della luce («perché la luce spessisce l’olio impiegato a rendere più lieve ed uguale il moto dei meccanismo nelle varie parti de’ filatoi e perché spoglia la seta della lucidità e del colore»), la mancanza d’aria («siccome l’aria troppo viva nuocerebbe alla seta disseccandola di soverchio e ne romperebbe 1 fili»), l’attività sedentaria38. Tutti mali che erano destinati ad aggravarsi con il passaggio dalle piccole filande annesse alle case coloniche o alle dimore padronali di campagna — attive nei soli mesi estivi e nelle quali le lavoratrici godevano ancora di una relativa libertà e le «maestre» erano aiutate dalle «aspiere» — agli opifici che utilizzavano la forza del vapore: Grandi edifici a tale scopo furono eretti in prossimità e nel mezzo di borghi e di città, — così uno studioso della condizione di fabbrica sintetizzava acutamente nel 1861 gli effetti di quel processo iniziatosi appunto negli anni della Restaurazione — onde avere la sufficiente mano d’opera, contenenti un proporzionato numero d’operai, ristretti nelle loggie nel minore spazio possibile; il lavoro, oltre l'estate, si protrasse alle altre stagioni; la durata giornaliera ne fu prolungata; le soste diminuite; la
fatica della maestra accresciuta per la voluta esattezza dei titoli dei fili, per aggiunta di congegni, pel governo del naspo, non avendo più aspiera che la coadiuvi39.
I primi studiosi italiani dei problemi dell’«industrialismo» misero presto in rilievo anche l’alto grado di nocività degli opifici per la filatura del cotone e le dolorose conseguenze che ne derivavano alla salute dei fanciulli, chiusi per
12-15 ore al giorno in ambienti malsani con mercedi che andavano dai 24 ai 50 centesimi: Anche su questi sgraziati — aveva modo di osservare nel 1842 Giuseppe Sacchi — i medici tutti ne assicurarono che il polverio del cotone esercita sulla vita organica 37. L. Valerio, Igiene e moralità degli operai di seterie, in «Annali universali di statistica», 1840, vol. 66°, pp. 333 sgg. V. anche G. Melchiori, Le malattie delle mani delle trattore di seta, osservate in Novi (Liguria), in «Annali universali di medicina», 1857, vol. 160°, pp. 5 sgg. e il precedente C. Castiglioni-G. Melchiori, Osservazioni igieniche sulla trattura della seta in Novi, in «Spettatore industriale», Milano, 1845, vol. 3°, pp. 213 sgg. Cfr. anche Relazione del socio Girola sulle memorie presentate al concorso intorno all’influenza delle filande dei bozzoli sulla salute pubblica, stabilito con Premio dal r. governo. Letta nella seduta del 17 maggio, tenuta dalla r. Accademia medico-chirurgica di Torino, in «Giornale della r. Accademia medico chirurgica di Torino», 15 luglio 1859, pp. 241-273. 38. Valerio, Igiene e moralità degli operai di seterie, cit., passim. 39. G. Melchiori, Sulla insalubrità delle filature da seta, in «Annali universali di medicina», 1861, vol. 175°, p. 58.
42
un’azione deleteria, massimamente sugli organi della respirazione, per cui i fanciulli vanno spesse volte soggetti a infiammazione polmonare, a tossi, e spesso finiscono la vita per emottisi cronica. Il soverchio lavoro protratto anche a notte inoltrata, la poca ventilazione dei locali, il disagio continuo del corpo, costretto a pochissimi movimenti, il pericolo del vicino contatto colle macchine, l’assordare che queste fanno, la stessa monotonia del lavoro, stanca, intristisce, logora la vita dei poveri fanciulli, che en-
trano nella filatura a sette od otto anni vispi ed allegri e ne escono larve d’uomini?0.
Egualmente sconsolanti erano i dati che gli studiosi ricavavano dall’osservazione delle condizioni di lavoro nelle industrie minori, che impiegavano anch’ esse elevate aliquote di fanciulli. Tra le varie testimonianze disponibili ci si consenta di ricorrere a quella di Ferdinando Tonini, medico della delegazione di Como,
di poco successiva a quella del Sacchi. Nelle fabbriche di
maiolica e terraglia i giovinetti impiegati, notava il Tonini, «pel costume che hanno i rispettivi proprietari di far levare i vari pezzi dai ragazzi dal forno, ancora caldo, debbono entrare nel forno stesso e quindi facilmente riportano scottature e patiscono cefalee per le facili congestioni sanguigne e coliche saturnine»; in quelle di vetro gli addetti erano soggetti ad «oftalmie più o meno gravi» che erano spesso causa di cecità; nelle cartiere «i ragazzi adoperati... oltre alle malattie proprie a coloro che vivono continuamente in luoghi umidi, vanno soggetti alla tisi polmonare che respirano durante la scernita degli stracci, alla convergenza delle tibie e delle fibule per l’obbligo che hanno di tenersi costantemente in questi luoghi umidi onde rivoltare di frequente 1 fogli posti sopra i telaretti per essere asciugati»; e quanto alle miniere «è cosa veramente compassionevole e che fa agghiacciare il cuore il vedere fanciulletti di sei, sette anni o poco più farsi del pallore di morte, destinati a fungere le veci del giumento e nel disimpegno delle loro incombenze grondanti di copioso sudore»4!. Gli osservatori coevi furono colpiti anche dalle conseguenze di ordine psicologico che derivavano dal carattere ripetitivo e parcellare delle mansioni nel nuovo sistema di fabbrica; a tale riguardo la Commissione permanente nominata nel quinto Congresso degli scienziati italiani per riferire sulle condizioni dei fanciulli negli opifici osservava in una relazione che «le minuzie e la monotona
invariabilità dei lavori» producevano
«un’attonitagine
morale,
un impicciolimento di pensieri, una specie d’ebetismo», e che quindi tra gli
40. Sacchi, Sullo stato dei fanciulli, cit., 1842, vol. 73°, pp. 244-245.
41. F. Tonini, Relazione sullo stato degli stabilimenti manifatturieri e di industria esistenti nella provincia di Como e sulla condizione fisica, morale ed intellettuale degli operai e specialmente dei ragazzi di ambo i sessi che vi vengono impiegati, in ASM, Commercio, p.m., cart. 177.
43
operai adolescenti non erano infrequenti «la tristezza, l’ipocondria, il disamore della vita». Il tema richiederebbe altre specificazioni, che non sono possibili in questa sede, sulla struttura del salario, sugli orari, sulla disciplina, sulle prime elementari forme previdenziali (dalla «collette» alle società di mutuo soccorso); ci limiteremo quindi a dare un’idea complessiva del «clima» di fabbrica avvalendoci ancora di un testimone qualificato come il Tonini che vergò sulla base della sua esperienza questa realistica descrizione: Gli intraprenditori richiedono che i loro giornalieri abbiano a trovarsi allo stabilimento nel prefisso ed invariabile orario, il quale è sempre di buonissimo mattino, onde porre in azione ed attendere al meccanismo, occupazione che si mantiene fino a sera avanzata. La cattiva stagione, un certo mal essere dell’individuo od altra plausibile scusa non valgono a giustificare il più piccolo ritardo di taluno. Tutti debbono, sotto comminatoria della perdita della giornaliera mercede, trovarsi all’orario prestabilito, epperciò sì i vecchi che i novelli operai innanzi tempo abbandonano il proprio letto per sollecitamente andare allo stabilimento. I giovani poi tengono l’obbligo di recarvisi prima per dare ordine e pulizia ai locali e a taluno degli ordigni del meccanismo, né all’idea del pericolo di perdere il giornaliero meschinissimo provento prevalgono i sentimenti di figliale affetto nel cuore di sconsigliati genitori. Appena giunti all’opificio ciascuno deve porsi al proprio posto ed accingersi al travaglio, né viene ad alcuno accordato il tempo di asciugarsi e di riscaldarsi nei giorni piovosi o di maggior freddo... Si ponga mente... che l’operajo arriva allo stabilimento non ancora compiutamente rifocillato dalla stanchezza del lavoro sostenuto nei giorni precedenti, coi piedi inumiditi e coi panni zuppi di acqua, e spesso intirizzito dal freddo, e che in tale stato deve tosto darsi al lavoro e continuarlo per tutta la giornata; e si giudi-
chi dello stato suo miserando*3. Un collegamento diretto, per lo meno in alcune zone dell’Italia settentrionale, pare si possa istituire tra i progressi dell’industrialismo e la crescita quantitativa di una altro fenomeno che, sebbene ripetesse le sue origini da secoli remoti, assunse tuttavia connotati patologici proprio nell’ultimo periodo della Restaurazione. Si intende qui parlare dell’infanzia abbandonata e soprattutto della pratica dell’esposizione infantile attraverso il sistema della «ruota» o «torno», che permetteva di lasciare in modo
anonimo bambini
in
tenera età — illegittimi e legittimi — agli ospizi dei trovatelli. Al di là delle differenze nelle norme e negli usi locali il sistema dell’esposizione si articolava secondo questo schema: i piccoli esposti, in generale di pochi giorni o poche settimane di vita, erano allevati nell’interno dell’istituto da balie appositamente pagate; a questo baliatico interno seguiva quello esterno, cioè l’affida42. In «Annali universali di statistica», 1844, vol. 82°, p. 309. 43. F. Tonini, Sugli stabilimenti manifatturieri e d’industria della provincia di Como, in «Gazzetta medica lombarda», Milano, 31 gennaio 1848, p. 54.
44
mento degli infanti a nutrici contadine, allettate da un tenue compenso, che si riduceva progressivamente con il crescere dell’età del bambino; questi, una volta svezzato, o rimaneva presso la famiglia della sua nutrice, che dai 5 anni in su poteva utilizzarne la capacità lavorativa, oppure tornava all’ospizio, che cercava di riaffidarlo subito a un’altra famiglia artigiana o contadina. L'aumento numerico dell’esposizione risulta più elevato nella regione maggiormente toccata dal processo di incipiente industrializzazione, la Lombardia. Così a Brescia sino al 1799 gli esposti non superarono mai i 400 all’anno, ma la media annua toccò i 551 (con un massimo annuale di 601)
nel decennio 1830-394; a Pavia la media annua degli entrati nella Pia Casa degli esposti fu di circa 95 nel 1778-97, per salire a 210 nel ventennio 1798-1817 e a 259 nel ventennio successivo45; venendo al brefotrofio di Cremona, esso accolse nella seconda metà del ‘700 circa 6.000 esposti, mentre i trovatelli raccolti nei primi 50 anni del secolo XIX furono più di 22.000, il che significa che il loro numero si quadruplicò*6. I dati più sconvolgenti sono però quelli di Milano, dove la media annua passò dai 790 del 1785-89 ai 3.300 del 1841-50 e infine ai 4.384 del 1851-60, cifre che conservano la lo-
ro drammaticità anche dopo che si sia avvertito che il brefotrofio di S. Caterina alla Ruota raccoglieva oltre agli esposti della città quelli del circostante contado”. Una tendenza ascendente è dato osservare anche nei domini sabaudi, come
risulta non tanto dai dati della Statistica medica degli Stati sardi, che coprono un periodo troppo breve (in 16 dei 32 ospizi speciali esistenti nelle province di terraferma tra il 1828 e il 1837 il numero dei trovatelli passò da 1.385 a 1.606)#8, quanto da quelli delle serie secolari, come quella dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara; in questo istituto si passò infatti dai 489 esposti ricoverati nel quinquennio 1766-1770 ai 716 del quinquennio 1821-1825, con una progressione che si accentuò nei quinquenni successivi (861, 994, 1.068, 1.147, 1.225, 1.419 ecc.) E l’incremento del fenomeno si
ripete nel Granducato di Toscana: qui gli esposti in carico al brefotrofio di 44. A. Buffini, Ragionamenti intorno alla casa dei trovatelli in Brescia, Brescia, 1841, p. 17. 45. P. Magenta, Sui publici stabilimenti di beneficenza della città di Pavia, Pavia, 1838, allegato 1. 46. F. Robolotti, Storia e statistica economico-medica dell’Ospitale maggiore di Cremona, Cremona, 1851, p. 60. V. anche A.F. Tassani, Saggio di topografia statistico-medica della provincia di Cremona, Milano, 1847, p. 307.
47. A. Buffini, Ragionamenti storici economico-statistici trovatelli in Milano, Milano,
1844-1845, passim,
e morali intorno all’Ospizio dei
e M. Gorni-L.
Pellegrini,
Un problema
storia sociale. L’infanzia abbandonata in Italia nel secolo XIX, Firenze, 1974, passim. 48. Informazioni statistiche..., cit., vol. 2°, p. 573.
49. A. Martinengo, La Ruota di Novara, Novara, 1978, pp. 146 sgg.
45
di
Firenze salirono infatti dai 3.809 del 1818 ai 6.032 del 1832, mentre in tutto il territorio dello Stato la «famiglia gettatella» passò dalla media di 15.767 degli anni 1831-1840 ai 21.486 del 1852 (1 esposto sopra 83 abitanti). Un andamento più statico sembrerebbe invece ipotizzabile nel Mezzogiorno, dove pure il fenomeno appare rilevante in cifre assolute, soprattutto nella capitale (i «proietti» immessi nella ruota dell’ Annunciata furono 2.290 nel 1816, 1.998 nel 1825, 2.167 nel 1831)5!. La diversità che pare di poter riscontrare tra Nord e Sud induce a credere — come si è accennato — che nel ritmo più serrato assunto dal fenomeno nelle regioni settentrionali giocassero una parte, oltre al pauperismo generico, le conseguenze dell’ingresso delle donne nel lavoro della manifattura e della fabbrica, che rendeva assai difficile alle madri lavoratrici poter accudire alla propria prole: ipotesi che trova conferma nell’aumento numerico dell’esposizione dei figli legittimi e, correlativamente, in quello dei ritiri degli esposti legittimi arrivati a 5 e più anni di età. La piaga dell’esposizione infantile si sfaccettava poi in una serie di aspetti dolorosi che andrebbero studiati analiticamente e dei quali si darà qui solo qualche cenno, primo tra tutti quello dell’altissima mortalità dei fanciulli ricoverati negli ospizi, che toccava punte dell’ 80-90% nel primo anno di vita. E il dato non meraviglia più qualora si abbiano presenti le tristissime condizioni igienico-sanitarie dei brefotrofi che documenti ufficiali toscani definirono «sepolcri», condizioni delle quali ci si può fare un’idea da qualche citazione tratta dalle fonti del tempo. È necessario condensare persino cinquanta bambini in tre sole non molto grandi stanze [dell'Ospedale Maggiore di Milano] — scriveva nel maggio 1772 il medico Bernardino Moscati al Kaunitz in una lettera che, sebbene di qualche decennio anteriore al periodo qui preso in esame, riteniamo opportuno utilizzare perché la situazione in essa descritta continuò a caratterizzare molti ospizi di trovatelli anche nel periodo della Restaurazione — e tenerli quattro per letto..., ristrettezza che è sempre funesta e che poi maggiormente si rende tale allora quando qualche contagiosa malattia si sparge sopra questi troppo condensati corpi; s’aggiunge che non essendo comodo di prato o giardino... essi sono costretti a rimanersene quasi tutto il giorno conficcati sopra una piccola seggiola ed a respirare la medesima non rinnovata aria corrotta e dalla lunga abitazione di tanta gente e dalla permanenza degli escrementi di tutti questi bambini i quali sono costretti a soddisfare a tutti i bisogni della vita entro alle me-
desime stanze??.
50. O. Andreucci, Della carità ospitaliera in Toscana.
Studi documentati, Firenze,
1864,
pp. 314-315. SI. C. Della Valle, Della miseria pubblica, sue cause ed indizi. Considerazioni applicate allo stato attuale del Regno citeriore di Napoli, Napoli, 1833, p. 58. 52. ASM, Luoghi pii, p.a., cart. 389.
46
Ed ecco del resto come nel 1851 descriveva le sue esperienze nell’ospedale di Cremona il medico Francesco Robolotti: Mi ricorda, e ne raccapriccio, quando posi i primi passi entro il brefotrofio; la lugubre scena, che mi si offerse allo sguardo e mi strinse il cuore. Imperocché quegli infelici stipati in vere mude erano condannati a respirare tutto il giorno un’aria contaminata dalle sozzure sì frequenti in quell’età, a sedere sopra incomodi scanni... I più grandicelli, cioè dai 5 ai 10 anni, si abbandonavano di giorno a sé stessi ne’ cortili e
nelle stanze dell’Ospizio, spesso mal vestiti e puliti, con capegli, unghie, occhi e pelle indecenti, ignari delle prime pratiche del cristiano, e sino del nome e cognome loro imposto e insegnato, e privi d’ogni sentimento morale??.
Lo stato di degradazione fisica degli esposti era poi aggravato da altri elementi, come gli stenti cui erano sottoposti nei viaggi che li portavano all’ospizio e dall’ospizio alle famiglie presso le quali venivano collocati, la facilità dei contagi, le carenze dell’alimentazione sia nella fase dell’allattamento che in quella successiva («Il vitto deve essere... magro, — prescriveva l’intendente generale del brefotrofio di Novara — poiché qualunque ne sia il sesso, sono queste creature più di ogni altra specie umana miserabili e gioverà perciò accostumarli dall’adolescenza ad un vitto frugale, frugalissimo»54), la condizione di abbandono in cui erano generalmente tenuti dalle famiglie alle quali erano affidati durante il baliatico esterno («Abbandonate quelle misere creature alla discrezione di coteste donne [le nutrici esterne] — si legge in una testimonianza relativa a Napoli — ... o finivano in breve la vita, o tale vivean-
la, che sarebbe stato meglio non averla»55). A tutto questo si aggiungeva poi la loro emarginazione sociale, messa in evidenza fino al periodo napoleonico dall’uso di imporre ai trovatelli cognomi fissi che risultavano di per sé infamanti (Colombo a Milano, Esposito a Napoli, ecc.): altro aspetto doloroso del fenomeno che trovò un riflesso letterario nei romanzi di un Ranieri e di un Mastriani. Si tratta, come si vede, di un importante capitolo di storia sociale che attende ancora una adeguata ricostruzione storica, la quale dovrebbe essere attenta anche a un altro aspetto del problema, e cioè il nesso tra esposizione e fondazione e sviluppo degli asili per l’infanzia9. La manifestazione più appariscente delle tensioni e degli squilibri che nei decenni della Restaurazione marcarono la società italiana con il loro sviluppo di vecchio e di nuovo e nella quale si assommarono molti degli 53. 54. 55. 56.
Robolotti, op. cit., pp. 49-50. Martinengo, op. cit., p. 104. G. Petroni, Della casa santa dell’Annunziata in Napoli. Cenno storico, Napoli, 1863, p. 47. Cfr. il già cit. lavoro di Gorni e Pellegrini, passim.
47
elementi ai quali si è già accennato fu il «pauperismo». Questa presenza dalle secolari radici preoccupò governi, amministratori, intellettuali, opinione pubblica in misura inconsueta nel passato: preoccupazione che ha lasciato corposo documento in una ricchissima pubblicistica che soltanto di recente si è cominciato a utilizzare5? e la cui fioritura non è soltanto un riflesso dei dibattiti che già da tempo si erano aperti nei paesi più avanzati d’Europa. Molte pagine di questa letteratura, insieme a quelle dei documenti governativi, ci pongono sotto gli occhi la visione non nuova, ma egualmente conturbante, di folle di mendicanti e di vagabondi che battevano le strade dei centri urbani e sciamavano nelle campagne, nelle regioni settentrionali come in quelle meridionali: tanto che la scelta delle citazioni riesce assai agevole. Così per i domini sabaudi l’anonimo estensore dell’opuscolo Qualche cenno x
sulla mendicità e sui mezzi di estirparla (1834) descriveva le torme di accat-
toni che funestavano «col loro cinico e ributtante aspetto le vie delle più ricche e popolose città dello Stato», mentre più in particolare per Genova F. Isnardi insisteva nel 1838 sui «tanti accattoni girovaghi» che gremivano «le piazze, le strade, le passeggiate, le chiese stesse»58. E il quadro non cambiava nei centri lombardi e in Milano, dove un osservatore nel 1845 notava, accan-
to alla presenza di un vasto strato di accattoni professionisti che «inondavano le contrade», quella di tutta una frangia di postulanti avventizi presso le botteghe che limitavano la loro questua a uno o due giorni la settimana: «questi domandano l’usato centesimo, se lo pigliano d’in sul banco, dove se lo trovano bell’e preparato, e se ne vanno con Dio»59. Ed ecco una delle tante esemplificazioni possibili per il Veneto, anch’essa del 1845: «V’hanno gli abitatori montani della Carnia, dell’alto e basso Cadore, de’ sette Comuni, e d’altre vallate del Tirolo italiano, del Veronese e dei Vicentino che nella stagione in-
vernale massimamente si rovesciano sopra i paesi e le città soggette, e fanno del vagabondar mendicando un mestiere»90. Quanto allo Stato pontificio basterà rimandare alle pagine relative al pauperismo del Dal Pane e del Demarco8!; e lo stesso discorso vale per il Regno delle Due Sicilie, per il quale ci si
57. Cfr. ad es. R. Pozzi, Un filantropo cattolico di Lucca: Luigi Fornaciari (1798-1858), estr. da «Critica storica», settembre 1969. 58. F. Isnardi, Le cagioni dell’accattoneria in Genova, in «Annali universali di statistica», 1839, vol. 59°, p. 218 (la prima edizione dello scritto è quella genovese del 1838, in opuscolo). 59. L. Ambrosoli, Della pubblica e privata beneficenza, Milano, 1845, pp. 5-6. 60. J. Bernardi, La pubblica beneficenza ed i suoi soccorsi alla prosperità fisico-morale del popolo, Venezia, 1845, p. 143.
61. L. Dal Pane, Economia e società a Bologna nell’età del Risorgimento. Introduzione alla ricerca, Bologna, 1969, pp. 484 sgg. e D. Demarco, // tramonto dello Stato pontificio, Il papato di Gregorio XVI, Torino, 1949, pp. 95 sgg.
48
limiterà a qualche testo rappresentativo. Così nel 1816 Saverio Scrofani in uno scritto dedicato a La mendicità a Napoli si soffermava sulle migliaia di accattoni che «scorrono la città intera giorno e notte, e fino nei luoghi più appartati di essa» e sulle questue istituzionalizzate: Infine, chi non vede girare giornalmente per Napoli uno sciame di persone uomini e donne con le lor borse aperte e chiedere il lunedì per le anime del Purgatorio, il martedì per l’arcangelo Raffaello, il mercoledì per la Vergine Santissima del Carmine... e così di seguito! ed oltre a questi, lunghe processioni di donzelle conducenti una statua e precedute da un crocefisso, fermarsi nelle strade, alle porte dei caffè e delle bettole, nei cortili dei signori ed elemosinare cantando®2.
Studiando il pauperismo nella sua terra, 1’Abruzzo citra, il De Novelli rilevava in un lavoro del 1846 lo straordinario accrescersi del male, fattosi tanto diverso da quello di un tempo®; mentre per quel che concerne la Basilicata il duca della Verdura in un discorso al consiglio provinciale (1844) lamentava che ogni raccolto fallito costringeva a vedere «una numerosa classe del popolo ridotta senza mezzi di sussistenza pitoccare, intristirsi ed assuefarsi a vivere una Vita di onta a sé e di peso alla società»*4. E quanto alla Sicilia, le fonti pubblicistiche parlano della «numerosa famiglia de’ mendicanti» che «va sempre più popolando tutti i comuni» o della «classe miserabile» dei quartieri malsani di Palermo, «la quale ora riempie le pubbliche vie importunando i passeggeri, ora assedia il domicilio dei cittadini accattando, ora formicola affamata in quei luoghi ove distribuisconsi soccorsi in alimenti»95. Il fatto sta che in Italia, pur se in forme spesso dissimili da quelle proprie ai paesi europei già entrati nel cammino della rivoluzione industriale, operavano fattori che contribuivano a un abbassamento del tenore di vita di larghi strati delle classi popolari incancrenendo la piaga del pauperismo. Realtà, quella del pauperismo, di cui si può affermare la presenza massiccia ma che si sottrae ai tentativi di una precisa definizione quantitativa per la mancanza di moderne ricerche criticamente condotte sulle fonti (liste amministrative di
poveri, registri ospedalieri, archivi di case di ricovero e d’industria, di alberghi di poveri, di ospizi per vecchi e invalidi, di ritiri per «zitelle pericolanti», di monti di pegno e di monti frumentari ecc.; elenchi di somme distribuite in
62. S. Scrofani, La mendicità a Napoli, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», 1967,
pp. 146 sgg. 63. R. De Novelli, Sul pauperismo e le cagioni del suo rapido accrescimento nella provincia di Abruzzo citra, Chieti, 1846, passim.
64. T. Pedio, Note ed appunti per la storia economica e sociale del Mezzogiorno d'Italia. La Basilicata durante la dominazione borbonica, Matera, 1962, pp. 101-102. 65. Testi citati in Demarco, // crollo del Regno delle Due Sicilie, cit., pp. 130 e 150.
49
elemosina; bilanci di istituti di carità e di luoghi pii)9. Ma, a parte le carenze degli studi, un’altra difficoltà più intrinseca è costituita dalla natura non nettamente determinabile della nozione di povertà e dal carattere sfuggente dei suoi contorni, intorno alla cui definizione si affaticarono del resto gli stessi contemporanei, come dimostrano i loro insistenti tentativi di arrivare a distinguere, quasi in via amministrativa, i bisognosi reali da quelli camuffati, la povertà ostentata oltremisura da quella «vergognosa». Gli «sforzi degli uomini di carità intelligente» — ammoniva C.L. Morichini già nella prima edizione del suo lavoro sugli istituti di carità romani — andavano indirizzati «a sceverare il vero dal falso povero» e a non confondere i vagabondi con i veri «pauperes», «essere infelici, ma sacri», e immagini viventi del Cristo9?. «Niuno ignora — faceva rilevare a. sua volta nel 1838 l’accademico labronico B.P. Sanguinetti in un suo discorso — come spesso la carità mal diretta valga ad incoraggiare l’infingardaggine, ad alimentare il vizio, a promuovere la colpa, anziché a sollevare la vera indigenza»98. E il già menzionato abate Bernardi ribadiva di lì a poco la necessità di «sbandire quella scioperata, falsa, insolente indigenza che sotto il manto della reale nascondesi, e ne usurpa 1 diritti»99.
Della difficoltà di giungere a individuare con precisione l’insieme dei fatti e delle situazioni genericamente inclusi nel termine «pauperismo» danno prova anche gli sforzi di arrivare a classificazioni empiriche, del tipo di quella del Massei. Lo scrittore bolognese nella sua Scienza medica della povertà, definito il pauperismo come il «nome moderno col quale vuolsi significare l’indigenza che invase classi intiere, ed in ispecialità le classi operaie in quelle nazioni che sono le più avanzate nel progresso materiale», distingueva infatti tra proletari (quanti possiedono solo «le proprie forze e i profitti del giornaliero lavoro»), poveri (gli afflitti da «ogni ordine e condizione di miseria»), indigenti (coloro che sono privi in modo permanente e totale «del necessario alla vita, e de” mezzi di procacciarselo») e mendici elemosinanti?0. 66. Ricerche di questo tipo dovrebbero sempre tener conto del suggerimento di metodo che si può ricavare da questa osservazione di Carlo Cattaneo: «Non dobbiamo atterrirci del pauperismo, ossia d’un aumento continuo ed irresistibile della miseria, perché anche ove è aumento
di povertà apparente, non ne consegue certezza che si aumenti la povertà. Nei paesi, ove si fondano stabilimenti per i sordomuti, i ciechi, i pazzi, si manifestano a tratti centinaia di questi infelici, a cui prima non si badava. La publicità raccoglie i fatti, non li crea, né li moltiplica» (C. Cattaneo, Della beneficenza publica, scritto del 1839 ristampato in C. Cattaneo, Scritti economici, vol. 2°, Firenze, 1956, pp. 254-255). 67. C.L. Morichini, Degli istituti di pubblica carità e d’istruzione primaria in Roma, Roma, 1835, pp. XL-XLI. 68. B.P. Sanguinetti, Sulla carità. Discorso letto il 6 maggio 1838 all’Accademia labronica, Livorno, 1838, pp. 4-5. 69. Bernardi, op. cit., p. 5. 70. G. Massei, La scienza medica della povertà ossia la beneficenza illuminata, Firenze, 1845, vol. 2°, pp. 4-8.
50
Agli ostacoli che si oppongono al conseguimento di risultati quantitativi validi e probanti si deve aggiungere quello costituito dalla differenziazione tra coloro che con terminologia moderna sono stati chiamati rispettivamente poveri «strutturali» e poveri «congiunturali», ossia tra malati, inabili al lavoro, disoccupati più o meno permanenti, vecchi, vedove da una parte, e lavoratori costretti a varcare la soglia della povertà dalla congiuntura economica avversa (cattivi raccolti, crisi di sovraproduzione manifatturiera e industriale, epidemie ecc.)?!. Sulla base di queste considerazioni non si può attribuire altro valore che quello di una indicazione di massima alle cifre fornite dalle fonti generali: il più che mezzo milione di indigenti su una popolazione di 2 milioni e mezzo di abitanti riportato dal Sacchi per la Lombardia nel 184872; i 19.000 mendicanti della Statistica degli Stati estensi del Roncaglia?3; i 5.000 poveri censiti dal Fornaciari sui 24.000 abitanti di Lucca?4; i 13.000 mendici e sussidiati contati nel 1844 dalla magistratura comunale di Bologna sui 75.000 abitanti della città”5; infine i 237.000 e passa mendicanti attribuiti per il 1832 al Mezzogiorno continentale (esclusa Napoli) dal Rotondo?9. La linea delle ricerche sul pauperismo, senza rinunciare ovviamente agli sforzi per giungere anche a determinazioni quantitative a livello locale o generale, dovrebbe quindi muoversi in direzione di un approfondimento articolato del corso di quei processi che portavano all’immiserimento e delle forme in cui essi si manifestavano e incidevano; vale a dire, come si è sparsamente accennato: la proletarizzazione di frange di mezzadri e coloni in conseguenza dell’avanzata di rapporti di produzione capitalistici nell’area dell’agricoltura padana e, in minor misura, nella fascia mezzadrile dell’Italia centrale; la rottura del vecchio equilibrio economico della piccola azienda contadina che si reggeva sull’integrazione dei frutti del piccolo possesso fondiario con l’esercizio degli usi civici sulle terre demaniali, rottura che interessò larga parte delle popolazioni rurali non soltanto del Mezzogiorno ma anche delle vallate e delle montagne dell’arco alpino; l’appesantimento della pressione esercitata dai proprietari sui lavoratori agricoli attraverso l’introduzione di nuove vessatorie forme contrattuali e l’aggravamento di quelle esistenti, possibili anche 71.J.-P. Gutton, La société et les pauvres en Europe (XVIe-XVIIIE siècles), Paris, 1974, pp.
72-73. 72. «Annali universali di statistica», 1849, serie 22, vol. 21°, p. 217. 73. C. Roncaglia, Statistica generale degli Stati estensi, Modena, 1849-1850, vol. 2°, pp.
88 sgg. 74. L. Fornaciari, Dei poveri e delle figlie della carità, Lucca, 1842, p. 5. 75. Demarco, Il tramonto dello Stato pontificio, cit., p. 96. 76. M.L. Rotondo, Saggio politico su la popolazione, e le publiche contribuzioni, Napoli, 1834, cit. in «Annali universali di statistica», 1834, vol. 41°, pp. 259-260.
5]
per l’indebolita capacità di resistenza di una controparte costretta a fare i conti con l’eccesso di mano d’opera formatosi sul mercato del lavoro in seguito alla presenza di una sovrapopolazione relativa; l'avanzata dell’industrialismo in alcune zone del paese, soprattutto nel Nord, e l’intensificazione
dello sfruttamento di una forza-lavoro costituita in gran parte da donne e da fanciulli e retribuita con salari bassissimi; il venir meno di quel livello mini-
mo di garanzie assistenziali che il vecchio sistema corporativo aveva in qualche misura fornito a determinati strati dei lavoratori dei centri urbani e che non furono sostituite che lentamente dall’associazionismo mutualistico; e via dicendo. In questo contesto si intendono meglio il senso e la portata del dibattito sui problemi del pauperismo e dell’assistenza ai poveri e agli indigenti che si intrecciò in quegli anni e che ebbe il suo nodo principale nella questione della carità «pubblica» o «legale», vale a dire del ruolo e della funzione dello Stato e delle amministrazioni locali nel campo della previdenza e dell’assistenza. La pratica assistenziale nella tendenza di lungo periodo si muoveva nel senso di un allargamento crescente della sfera dell’intervento pubblico, ma l’assegnazione di una funzione primaria all’azione dello Stato e alla definizione legislativa dei suoi compiti appariva nel periodo di cui ci stiamo occupando tutt'altro che scontata tanto in sede di discussione dottrinale che al livello delle attuazioni pratiche. E basterà ricordare, a proposito del dibattito teorico, le drastiche posizioni antiinterventiste di Melchiorre Gioia in un suo
scritto del 1817 occasionato dalla carestia di quei mesi. Il Gioia, che si inseriva in un filone settecentesco nel quale spicca il nome di Ludovico Ricci («Il soccorso de’ poveri, — questi aveva detto — che in mano alle sodalità private era opportunamente intermesso e sottilmente bilanciato all’uopo di ciascun mendico e infermo, in mano alla podestà pubblica divenne continuo, capriccioso, inopportuno»?), metteva al centro del suo argomentare i tristi effetti che secondo lui derivavano dal «sistema de’soccorsi promessi da’ pubblici stabilimenti» (aumento delle pretese della «plebaglia sfaccendata», diffusione dei sentimenti ostili ai ricchi e dell’impulso alla sedizione, proliferazione dei postulanti),
e fondava
la condanna
della carità legale sulla considerazione
psicologica dell’esistenza nell’uomo di una «fortissima antipatia contro il travaglio continuo» che avrebbe fatto preferire nella generalità dei casi la sovvenzione al lavoro. In questa ottica fredda e distaccata il Gioia per spiegare
l’innegabile miseria dei contadini e dei lavoratori delle città chiamava in causa la loro imprevidenza e la loro incontinenza, il che lo portava ad avanzare 77.L. Ricci, Riforma degli istituti pii della città di Modena, in Scrittori classici italiani di economia politica, p.m., t. 41°, Milano, 1805, p. 28.
52
come rimedio la proposta di timbro malthusiano di «porre ostacoli agl’imprudenti matrimoni», congiuntamente a quella di obbligare i proprietari fondiari ad assorbire la disoccupazione con una serie di lavori certamente utili ma che era poco realistico considerare realizzabili nel momento dato (pavimentare le aie con mattoni, scavare pozzi e cisterne, costruire lavatoi pubblici, mettere vetri alle finestre delle case coloniche)?8.
Sulla sponda opposta si collocava, in quello stesso 1817, l’estensore dei Ragionamenti di un pitocco, che si configurano come una pungente replica al Gioia. L’anonimo scrittore infatti respingeva anzitutto le tesi del piacentino in materia di popolazione, e affermava recisamente al riguardo: «Ammetto la carestia: ma non conviene attribuirla in parte alla cresciuta popolazione fino a tanto che non siasi verificato che la terra non può dare di più di quello che suol dare comunemente, né impiegare un maggior numero di lavoratori di quello che impiega in effetto»; a questa polemica presa di posizione seguiva l’auspicio che a sollievo della miseria si facessero avanti i governi i quali, pur senza escludere il concorso del clero e dei privati, avrebbero dovuto individuare, stimolare e promuovere un complesso di misure capaci di sanare in qualche maniera le piaghe del pauperismo??. Questa polemica del 1817 anticipava sostanzialmente le linee lungo le quali negli anni successivi si sarebbe svolta una discussione che meriterebbe di essere ricostruita quale contributo allo studio degli atteggiamenti mentali e politici degli intellettuali e dei gruppi dirigenti di fronte ai problemi sociali del paese. Basterà qui ricordare che nel senso dell’intervento pubblico si orientò negli ultimi anni della sua vita il prestigioso Romagnosi, il quale dopo esitazioni e oscillazioni prese nettamente posizione sul problema nel 1835 quando, affermata la necessità di distinguere «la incolpabile e la inevitabile indigenza dalla colpevole ed evitabile», metteva in bocca ai poveri questo discorso: Dalle finestre del vostro palazzo voi [ricchi] dispensate sopra di noi... il nome di proletarj: ma noi siamo (quando le forze ci servono) proletarj produttori, e voi siete proletarj consumatori. La possidenza di cui andate orgogliosi non è né punto né poco assoluta; ma è legata alla condizione di soccorrere alle incolpabili nostre necessità, in
conseguenza dell’opera associata della convivenza. Questa condizione forma il correspettivo del partaggio introdotto e mantenuto dalle leggi e dalla nostra tolleranza. Il salario delle giornate non entra per nulla in questo correspettivo. Il salario è la mercede dell’opera transitoria, e non il soccorso dovuto in forza della socialità. Voi
mi direte che la limosina non è un debito. Distinguo. Non è un debito privato, concedo; non è un debito pubblico, nego. Solidale e comune è il dover civile del soccorso 78. M. Gioia, Problema: quali sono i mezzi più spediti, più efficaci, più economici per alleviare l’attuale miseria del popolo in Europa, Milano, 18172, passim. 79. Ragionamenti di un pitocco, Milano, 1817, passim.
53
alla incolpabile indigenza, e ciò tanto più, quanto meno il privato può giudicare della
causa della indigenza®80.
Le tesi interventiste ebbero poi altri sostenitori, maggiori e minori. Tra i primi figura, anche se con affermazioni temperate da cautela, uno dei classici del-
la letteratura pauperistica della prima metà dell’800, il piemontese I. Petitti di Roreto, che nel Saggio sul buon governo della mendicità sosteneva per l’appunto il diritto-dovere del governo civile «d’intervenire qual tutore comune in queste parti del pubblico reggimento» e di prestare il suo concorso al sollievo della miseria incolpevole8!. Tra i secondi arrivava a una formulazione assai esplicita il già ricordato L. Ambrosoli, un discepolo di Andrea Zambelli, il quale così concludeva il suo scritto: È chiaro pertanto che esiste la povertà, che questa ha diritto al soccorso verso tutti i cittadini; che, essendo questi nella loro sociale esistenza rappresentati dal governo, a lui spetta il dovere di soccorrerla; che questo dovere si identifica col diritto, giacché la
classe povera può cagionare nello Stato molti delitti; che essendo la privata beneficenza, tanto individuale che associata, improvida, precaria e pericolosa, devesi togliere di mezzo onde non alimentare la classe soverchiante e perniciosa dei poveri; che final-
mente alla privata beneficenza vuolsi surrogare la publica bene organizzata8?.
Di contro, i difensori di una beneficenza ispirata puramente dal sentimento religioso e dispensata essenzialmente attraverso i canali delle organizzazioni della Chiesa cattolica (i «cavalieri dello spegnitoio», come ebbe a definirli Giuseppe Sacchi) scagliavano i loro anatemi contro le «illusioni della pubblica carità» (era questo il titolo del noto libello attribuito a Monaldo Leopardi, il padre del poeta) e i suoi ritrovati scristianizzatori — primi tra tutti gli asili d’infanzia laici — arrivando a questa drastica conclusione: «Dovunque la pubblica beneficenza abbandonerà il candore della carità per abbellirsi coi fuchi della filantropia; dovunque la pubblica misericordia si allontanerà dall’altare, e sarà levata di mano ai sacerdoti per consegnarla ai filosofi, ivi si vedrà rinnovato l'esempio dell'Inghilterra», del paese cioè che allevava il popolo «il più cencioso, il più brutale, e il più infelice»83. Dopo aver così accennato ad alcuni degli aspetti e delle manifestazioni del disagio e della deteriorata «qualità» della vita di tanta parte dei ceti subalterni e dopo aver sommariamente delineato i motivi di fondo della discussione su 80. G.D. Romagnosi, Osservazioni all’articolo «Delle cause del nostro malessere sociale», del sig. Dumolard, in «Annali universali di statistica», 1835, vol. 44°, pp. 20-21. 81. C.I. Petitti di Roreto, Saggio sul buon governo della mendicità, degli istituti di beneficenza e delle carceri, Torino, 1839, vol. 1°, pp. XXVII-XXVII. 82. Ambrosoli, op. cit., pp. 29-30. 83. Le illusioni della pubblica carità, Lugano, 1837, p. 187.
54
poveri e carità è opportuno accennare ora alla variegata tipologia degli interventi — pubblici e privati — che miravano a contenere in qualche modo le manifestazioni più evidenti del pauperismo, avvalendosi di quella complessa struttura caritativo-assistenziale che era concresciuta nei secoli e che l’urgere di problemi vecchi e nuovi minacciava di mettere in crisi e sollecitava nel senso del cambiamento e dell’innovazione. Per quel che attiene all’atteggiamento e alle misure delle autorità pubbliche, va anzitutto ricordata la radicale modificazione delle idee sulla povertà che si era verificata a partire dal XV-XVI secolo. Alla concezione dominante nel Medio Evo che vedeva nei poveri i «vicari» di Cristo, i suoi rappresentanti in terra, le sue «membra sofferenti», si era venuta gradatamente sostituendo un’altra immagine nella quale il povero (il mendicante, il vagabondo, l’indigente) era Visto come un ozioso impenitente e infingardo, un elemento di tensione sociale e un motivo di disonore per il prestigio dello Stato, un portatore di contagi epidemici, insomma una presenza ostile e minacciosa alla quale si doveva fare fronte con la repressione e la segregazione. Di qui quella che Marx chiamò la «legislazione sanguinaria» contro i poveri, che celebrò i suoi trionfi soprattutto in Francia e in Inghilterra ma che ebbe una sua lunga storia anche in Italia. A tale proposito basterà ricordare, a titolo esemplificativo, il bando dato alla mendicità in Torino nel 1628 e rinnovato da Vittorio Amedeo Il nel 1716, in
occasione dell’apertura della nuova sede dello Spedale di Carità, destinato al ricovero coatto dei poveri inabili al lavoro e dei malati indigenti: Difendiamo ad ogni, e qualsivoglia persona valida, ed invalida — intimava l’editto — ... di mendicare...
tanto di giorno come
di notte, publicamente,
o in segreto, con
qualunque specie, o pretesto, sotto le medesime pene, che si vedono lodevolmente imposte in altri paesi... cioè della carcere per la prima volta, ed altra più grave, eziandio corporale ad arbitrio del Senato nostro in caso di recidiva84.
Quanto alla Lombardia, spagnola prima e austriaca dopo, ci si trova di fronte a un vero fuoco di fila legislativo che minacciava a poveri e vagabondi i tratti di corda, il marchio a fuoco, la frusta, la galera sino a cinque anni, la
deportazione ai lavori forzati nelle lontane terre d’ Ungheria, in un accavallarsi di norme tra le quali basterà citare, per dare un’idea del loro spirito informatore, un editto del 22 agosto 1744: «Ordiniamo a tutte le comunità dello
Stato che capitando li suddetti vagabondi, oziosi, sospetti malviventi o ladri... debbano immediatamente con previo suono di campana a martello unirsi, prendere le armi, inseguirli e fermarli, consegnandoli alle carceri del luo84. A. Guevarre, La mendicità sbandita col sovvenimento de’ poveri..., Torino, 1717, pp.
26 sgg.
55:
go... con far fuoco sopra li medesimi in caso di resistenza, ovvero di fuga»8>. E disposizioni di analogo tenore furono emanate anche negli altri Stati italiani, nella linea di una tradizione che, dopo la ribadita condanna della mendicità del periodo napoleonico, fu codificata negli anni della Restaurazione. La questua fu infatti proibita e punita con il carcere fino a tre mesi (aggravato con il digiuno e le «percosse» per gli incorreggibili) nel Regno lombardo-veneto; anche il codice penale di Parma del 1820 vietava la mendicità; e così pure faceva quello napoletano (art. 300-304): ma erano tutte disposizioni la cui attuazione aveva scarso successo, come dimostra il fatto stesso della continua iterazione di una normativa tanto afflittiva nell’enunciazione quanto poco efficace nella pratica. L'ispirazione repressiva che muoveva l’azione delle autorità appare evidente in uno degli obiettivi che quelle si posero a partire dal ‘600 e che caratterizzò ancora la loro politica «sociale» nella prima metà dell’800, cioè la segregazione e l’internamento dei poveri e dei miserabili, il «grand renfermement» (la definizione è del Foucault), che ebbe nelle «workhouses» inglesi il suo simbolo tipico. Tale politica, che mirava a depurare città e borghi da mendicanti e indigenti dei due sessi e di tutte le età attraverso la loro concentrazione volontaria o coatta in appositi edifici, trovò più o meno larga applicazione anche in Italia, specie nel corso del ‘700, del periodo napoleonico e della Restaurazione. Spiccano in queste vicende per le loro dimensioni i casi del genovese Albergo dei Poveri alla Carbonara (istituito nel 1539 e allargato poi a più riprese, che tra il 1830 e il 1840 arrivò a contenere circa 2.000 ricoverati giornalieri), del già menzionato Spedale di Carità di Torino e dell’ Albergo dei Poveri di Napoli che, iniziato per volere di Carlo II nel 1751 per riunire, come scrisse L. Bianchini, «in istraordinario e grandioso edifizio quanti più si potessero mendichi e vagabondi, fornendoli di cibo e vestimenta, e rendendoli utili in cose d’arti e d’industria e sani e robusti»86,
raccolse tra il 1830 e il 1850 fino a 6.000 ospiti al giorno. Più capillare e decentrata appare durante la Restaurazione la trama di questo tipo di istituzioni nella Lombardia e nel Veneto, dove il loro mantenimento era in parte a carico dell’erario statale e in parte a carico delle finanze comunali. Più in particolare le «case d’industria» lombarde avevano il loro precedente nell’attivazione voluta da Giuseppe II nel 1784 di una «casa di lavoro» volontario in Milano e di «una casa di lavoro» coatto per questuanti recidivi o inabili in Pizzighettone. L'intenzione del sovrano austriaco di dotare di istituti che si ispiravano alle workhouses i principali centri della regione fu ri85. ASM, Giustizia punitiva, p.a., cart. 16. 86. L. Bianchini, Della storia delle finanze del Regno di Napoli, Napoli, 18593, p. 355.
56
presa dopo il 1800 dalle amministrazioni del periodo napoleonico (nel 1812 risultano esistenti case di lavoro anche a Cremona,
Crema, Casalmaggiore,
Lodi, Bergamo, Brescia) e fu poi sviluppata nei primi anni della Restaurazione, anche sotto la pressione della carestia (1817 a Pavia, 1819 a Mantova, 1823 a Como, 1831 a Monza); ed organismi analoghi sorsero anche nel Veneto e a Trento (dal 1817). Negli Stati sardi «case di ricovero» furono invece create negli anni ‘30 per iniziativa di privati e di singole amministrazioni comunali (Chambéry, Vigevano, Novara, «ricovero di mendicità» di Torino, che
si affiancò allo Spedale di Carità); e la materia trovò una regolamentazione sul piano legislativo con le lettere patenti del 29 novembre 1836: queste, espresso il risoluto diniego sovrano che i provvedimenti per l'eliminazione della mendicità potessero mai avere nulla in comune con il sistema della «legge dei poveri» inglese (perché la tassa avrebbe pesato sulla «classe la più numerosa e la più vicina all’indigenza», identificata in quella dei piccoli proprietari), subordinavano la creazione delle case di lavoro all’approvazione reale e minacciavano a ogni individuo sorpreso a mendicare in una provincia in cui fosse aperto un ricovero l’arresto e l’internamento in quella istituzione87. In quello stesso torno di tempo Maria Luisa fece aprire a Borgo S. Donnino (Fidenza) una «deposito di mendicità» che ospitò presto più di 300 persone; mentre in Toscana tra il 1815 e il 1833 furono impiantati, con il prevalente concorso finanziario di privati, la Pia Casa di lavoro di Firenze, lo Stabilimento di mendicità di Siena, la Pia Casa di lavoro di Arezzo, e via dicendo.
La tipologia di questi istituti quale risulta dalle loro tavole di fondazione era quella di un organismo ibrido, che teneva contemporaneamente del reclusorio, dell’ospizio e dell’opificio. Là dove, come in Lombardia, i criteri di gestione furono più umani e l’amministrazione più oculata, le «case di lavoro» ebbero un certo ruolo nel contenimento della disoccupazione e della sottooccupazione, come si può rilevare dall’esame del loro funzionamento. Così a Milano nelle due case di S. Vincenzo e di S. Marco, che oltre ad accogliere i «ricoverati» stabili (una media quotidiana di più di 500 nel 1835) davano lavoro in loco o a domicilio ai cosidetti «intervenienti giornalieri», l’incidenza di questo tipo di assistenza fondata sull’assegnazione di lavori è dimostrata dal fatto che nel 1817, anno di carestia, si ebbero punte medie giornaliere di 1.263 lavoratori nell’interno e di 1.077 lavoratori a domicilio, assai elevate
per una città di 150.000 abitanti; dati analoghi si ebbero in altri momenti critici (il colera del 1836 e la carestia del 1846-47), senza che però le cifre superassero mai in misura patologica le medie degli anni «normali». Questo giudizio sulla relativa funzionalità delle «case di lavoro» milanesi e più in ge87. Petitti di Roreto, Saggio sul buon governo della mendicità..., cit., vol. 1°, p. 443.
57
nerale lombarde (le cui attività ricalcavano in generale le linee degli istituti della capitale) trova conferma nel fatto che della loro assistenza usufruivano in percentuali elevate disoccupati stagionali come muratori, legnaioli, spazzacamini, materassai, e disoccupati congiunturali, in specie tessitori. Va anche
tenuto presente che in queste «case» si cercò di non avvilire al di là di certi limiti la personalità dell’assistito, tanto è vero che la denominazione di «casa
d’industria» che finì coll’essere preferita a quella di «casa di lavoro» fu scelta, come si esprimeva nel 1815 un esperto di quei problemi, «per allontanare qualunque idea di turpitudine e di umiliazione, per promuovere il maggior concorso a simili stabilimenti»88. Elementi negativi erano invece gli orari assai lunghi della giornata lavorativa (impiegata nel tessere tela ordita, filare il lino, preparare fasce, cucire camicie, fare calze e scarpe, ecc.) e l'esiguità degli emolumenti (un assegno di beneficenza variante da 21 a 35 centesimi al giorno a seconda del sesso e della stagione, cui si aggiungeva la retribuzione del lavoro commissionato, le cui tariffe erano però così basse che di rado per-
mettevano di raddoppiare l’entità dell’assegno)89. Assai più scuro è il quadro, e più negativo il giudizio su quegli «Alberghi dei poveri» che la pratica prevalente dell’internamento stabile dei ricoverati rendeva simili a reclusori, producendo tutti quei guasti che sono conseguenza di una segregazione protratta. E valgano in proposito le impressioni esternate nel 1830 da G. Sacchi dopo una visita all’ Albergo dei poveri di Genova, che era sì «la più grandiosa e popolare casa d’industria dî tutta Italia», ma che gli appariva bisognosa di una radicale riforma: «Gioverebbe — osservava il filantropo lombardo — che i benefattori della pia casa si trovassero un po’ più a contatto co’ poverelli ivi ricoverati», perché «ricoverare de’ miserabili per segregarli in tutto e per tutto dall’umano consorzio» non era un atto di carità confacente agli scopi che ci si prefiggeva9. E ancora 16 anni dopo l’istituto genovese (che aveva la singolarità di ospitare un numero di femmine doppio di quello dei maschi, sproporzione dovuta essenzialmente a «due quasi costanti migrazioni di maschj, l’una per la navigazione, l’altra per le industrie di viticoltura, di facchinaggio, di spaccalegne, ecc., che in molti paesi d’Italia vengono pressoché esclusivamente esercitate dalle robuste braccia genovesi») appariva bisognoso di tutta una serie di miglioramenti a una speciale Com88. Sommariva, Memorie sull’istituzione di Case di industria e di ricovero negli Stati d’Italia amministrati dalla R. Cesarea Reggenza di governo, ms. del 1815 in copia in ASM, Luoghi pii, p.m., cart. 75. 89. Cfr. P. Testori, Origini e funzionamento delle Case di lavoro in Lombardia, tesi di lau-
rea discussa nella Facoltà di Lettere e filosofia dell’ Università degli studi di Milano nell’anno accademico 1970-1971. 90. «Annali universali di statistica», 1830, vol. 26°, p. 130.
58
missione visitatrice le cui osservazioni è opportuno riprodurre con ampiezza come testimonianza diretta della vita all’interno dell’ Albergo: A chi si recasse a visitare quell’interessante e vario istituto... potrebbe per avventura nascere il desiderio di vedere aggiungersi alle molte e savie provvidenze che lo reggono, qualche lieve tocco; che, cioè, allo stato prospero del materiale benessere non fosse disuguale l’istruzione del leggere, scrivere, conteggiare e degli elementi del disegno, onde quei molti operaj riuscissero operaj intelligenti ed istrutti: che i molti telaj destinati al lavoro delle donne e specialmente delle fanciulle fossero riformati in modo da non costringere quasi in uno strettojo... per lo spazio di circa nove ore al giorno quei preziosi abdomi che sono la prima cuna dell’uomo...: che le pie suore... avvisassero a quei petti curvi ed appoggiati l’intero giorno sui telai da ricamo: che i mezzi pecuniarj bastassero a procacciare a quella vasta e numerosa famiglia quasi tutta composta di adolescenza uno spazio sufficiente ove ricrearsi...: che il lavoro, specialmente quello della gioventù, venisse più spesso alternato coll’esercizio libero del corpo: ... che ai canti religiosi si affratellassero delle altre cantilene, purché savie e ispiratrici di morale, affinché la religione troppo spesso e lungamente adoperata non riesca a noja e non perda in riverenza quel che guadagna in tempo ed in parole: ... che finalmente si variassero maggiormente i generi di industria, e così agli artefici che usciranno di là a popolare gli opificj si preparassero
più facili il lavoro ed il pane?!.
In questo genere di istituzioni il limite della degradazione estrema era raggiunto dall’ Albergo dei poveri di Napoli, nel quale ai difetti strutturali propri a quel tipo di stabilimenti si aggiungevano le conseguenze di un disordine e di un malgoverno amministrativi sui quali avrebbero fatto luce le inchieste postunitarie. In un «parere» redatto all’inizio del 1861 da Luigi Settembrini per una «Consulta» voluta da Luigi Carlo Farini si legge infatti che un quarto delle entrate dell’ Albergo era assorbito dalle spese per gli impiegati e un numero imponente di medici, notai, avvocati e architetti, «tanta gente che son
quasi un migliaio, che non sono poveri e mangiano coi poveri»; e lo stesso «parere» aggiungeva: «Come si entra nell’ Albergo si vede chiaro che l’amministrazione opprime la carità... In camere spaziose, pulite ed esposte al sole stanno agiatamente gli impiegati con le loro famiglie e famiglie di impiegati già morti; ed un centinaio di poveri vecchi sono come sepolti in una specie di carcere sotterraneo detta la correzione»?. Nello spazio che si faceva sempre più ristretto di quello che era stato presto soprannominato il «serraglio» convivevano a migliaia nella promiscuità più completa e in generale nell’ozio impotente i mendicanti spediti dalla polizia di tutte le province del 91. Rapporto della Commissione incaricata della visita agli istituti di beneficenza della città di Genova... presieduta dal canonico A. Ambrosoli, Milano, 1846, pp. 5-6. 92. Regia Commissione d’inchiesta per Napoli, Relazione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza di Napoli, Roma, 1903, vol. 5°, pp. 23-25.
59
Mezzogiorno per dare attuazione al bando agli accattoni (un decreto del 1840 riservò l’ Albergo ai soli poveri di Napoli, ma la misura restò sulla carta perché non furono mai costruiti i quattro istituti previsti per i poveri delle altre parti dello Stato), i «proietti» di età superiore ai 7 anni, ciechi, sordomuti, infermi va-
ri, donne «pericolanti», «discoli», oblate. E pienamente meritati apparivano il «tetro nome popolare» e la fama sinistra dell’immenso edificio, che i documenti ci descrivono concordi come un immondo deposito di «famelici reclusi, in preda a mali scrofolosi e miasmatici di ogni maniera», alimentati talvolta solamente con pane e fave, giacenti spesso in due per letto, «scalzi, nudi, ... e tra le continuate infermità cagionate dalla lordezza ed umidità di quelle mura», e come una sentina di vizi sulla quale allungava le sue mani la camorra?3. Un'altra questione di fondo che permette di studiare in modo determinato l’atteggiamento dei governi della Restaurazione, dei gruppi dirigenti e degli intellettuali nei confronti delle classi subalterne e delle loro condizioni di esistenza è quello della politica scolastica nel settore dell’istruzione primaria. E anche qui i modi di comportamento e di intervento presentano due estremi tipici, quello del Lombardo-Veneto e quello del Regno delle Due Sicilie. Sul piano delle posizioni di principio già negli ultimi decenni del ‘700 si era ormai fatta strada non soltanto nelle élites intellettuali penetrate dalle idee illuministiche ma anche tra i pubblici amministratori l'esigenza dell’intervento pubblico nell’insegnamento primario, motivata volta a volta con la necessità di togliere l'istruzione da «mani interessate e mercenarie» per diffonderla tra «la gente più povera... e più negletta», i lavoratori delle campagne e delle città (come si legge nel Metodo di insegnamento pubblicato a Napoli da quel Vuoli che nel 1784 era stato inviato da Ferdinando IV a Rovereto per studiarvi il metodo «normale»)?, o con l’opportunità di impartire a tutti i membri della comunità statale «la cognizione dei doveri di buon cristiano, cittadino e suddito» (come si esprimeva il Regolamento generale del 1774 per le scuole elementari lombarde). Nell’ambito di questi orientamenti si collocano i tentativi riformatori avviati nella Lombardia austriaca da Maria Teresa (creazione
delle scuole normali) e da Giuseppe Il e più timidamente nel Regno di Napoli da Ferdinando IV, che sortirono però nel loro complesso risultati modesti: 93. Cfr. tra l’altro P. Turiello, Degli stabilimenti di beneficenza nella città di Napoli, e de’modi di renderli veramente giovevoli alle classi bisognose, in «Atti» del R. Istituto di incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche, Napoli, serie II, t. 3°, pp. 210 sgg.; T. Filangieri Ravaschieri Fieschi, Storia della carità napoletana, Napoli, 1875-1879, vol. 2°, pp. 225 sgg.; G. De Simone, Sul riordinamento delle opere pie della città di Napoli, Napoli, 1880, pp. 446 sgg. 94. A. Broccoli, Educazione e politica nel Mezzogiorno d’Italia (1767-1860), Firenze, 1968, p. 11. V. anche G. Carignani, Le scuole in Napoli nel sec. XVIII. Studi su documenti dell’ Archivio centrale della città di Napoli, Napoli, 1875, passim.
60
tentativi ai quali si sovrapposero poi gli impulsi innovatori dei governi del periodo rivoluzionario e napoleonico, che neppur essi riuscirono tuttavia a incidere in profondità sul contesto educativo nonostante la proclamazione dell’obbligo dell’istruzione elementare. Dopo il 1815, mentre in generale i governi restaurati adottarono di fronte al problema dell’istruzione popolare un comportamento ispirato a chiusa indifferenza o a manifesta diffidenza — il che tra l’altro consentì al clero di recuperare buona parte delle posizioni perdute su quel terreno — nel Lombardo-Veneto invece l’Austria sviluppò con una sua coerenza l’azione avviata nello scorcio del ‘700. Una sovrana risoluzione del 1818 imponeva infatti nella larghissima maggioranza delle circoscrizioni parrocchiali l’istituzione e il mantenimento a spese dei Comuni di scuole elementari «minori» di due classi «per la prima necessaria istruzione di tutti i fanciulli di qualunque condizione»; oltre ai principî della pubblicità e della gratuità era stabilito anche quello della frequenza obbligatoria per i fanciulli tra i sei e i dodici anni, sancito attraverso il pagamento un'ammenda mensile di mezza lira a carico dei genitori inadempienti. A Milano, Venezia e nei capoluoghi di provincia era inoltre prevista la creazione (poi estendibile agli altri centri più importanti) di scuole elementari «maggiori» di tre o quattro classi con corsi della durata di cinque-sei anni per «l’istruzione della gioventù che intende di applicarsi allo studio delle scienze e delle arti». E al dettato legislativo seguì una larga attuazione pratica. In Lombardia le scuole elementari minori, già 2.600 nel 1822, erano diventate 4.203 nel 1847, e nello stesso arco di tempo i mae-
stri delle elementari pubbliche passarono da 2.738 a 4.729 e gli alunni dei due sessi da 107.765 a 216. 2539. Ritmi di incremento più bassi si ebbero nel Veneto; secondo una fonte statistica ancora nel 1852 le scuole elementari venete erano 1.792, con un totale di 94.713 alunni, il che voleva dire che mentre in Lombardia in quell’anno il rapporto tra utenti delle elementari pubbliche e popolazione complessiva era di 1 a 14, nel Veneto il rapporto era di Ja: 26%. Questa rilevanza quantitativa delle cifre della scolarizzazione non deve certamente far dimenticare i gravi limiti che dietro quelle si avvertono: consistenti aliquote di fanciulli e soprattutto di fanciulle in età scolare non frequentavano le scuole pubbliche (in Lombardia rispettivamente 1/3 e 2/5 nel 1846, mentre nel Veneto nel 1852 di contro a 86.587 scolari si avevano soltanto 8.126 alunne), dalle quali li teneva lontani la necessità di contribuire al
95. G. Sacchi, Studj statistici sull’istruzione del popolo in Lombardia, in «Annali universali di statistica», 1858, vol. 133°, pp. 12-13.
96. Ibid.
61
bilancio familiare con il lavoro nei campi, nelle filande di seta e negli altri
opifici; nei comuni rurali le elementari erano spesso «scheletri» di scuole, e in esse la frequenza si diradava drasticamente all’epoca dei lavori agricoli stagionali; le aule erano spesso troppo affollate, vere pluriclassi nelle quali si stipavano a volte più di cento alunni, molti dei quali privi di libri di testo e di materiale didattico; la preparazione e le capacità pedagogiche degli insegnanti, pagati avaramente dai Comuni e quindi spesso costretti a un secondo lavoro e strettamente sorvegliati dalla polizia e dal clero (che forniva i quadri superiori dell’amministrazione scolastica) erano generalmente inadeguate, anche perché per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nelle elementari minori bastava aver frequentato la terza classe e un corso di metodica trimestrale; il carattere mnemonico dell’insegnamento, mirante a un apprendimento meccanico dei rudimenti della lettura e della scrittura, e la lentezza dei risultati conseguibili con i metodi in vigore lasciavano aperti larghi spazi al semianalfabetismo e all’analfabetismo di ritorno??. Ma le mende e le carenze non possono non far riconoscere, in sede di giudizio storico, la sostanziale superiorità rispetto al resto del paese dell’istruzione primaria della Lombardia e in minor misura del Veneto, che permise tra l’altro a queste regioni — grazie anche alle dimensioni assunte complessivamente dall’istruzione privata — di arrivare all’ Unità con percentuali di analfabetismo nettamente inferiori a quelle delle altre grandi circoscrizioni geografiche, elemento non indifferente nella diversificata dinamica dello sviluppo civile e sociale delle varie zone della penisola. Un andamento di segno opposto ebbero le vicende dell’impianto e della diffusione delle strutture dell’istruzione primaria nel Regno delle Due Sicilie. Qui la politica scolastica dei restaurati Borboni fu caratterizzata, come è stato scritto di recente, da una profonda avversione all'istruzione, che determinò la
liquidazione dell’eredità del decennio francese e l'accettazione di un pesante controllo del clero nel settore?8. Non mancarono, è vero, dichiarazioni di in-
tenzione, come il regolamento per le scuole primarie del 1° maggio 1816, che stabiliva l’apertura di scuole elementari in tutte le parrocchie di Napoli e l’obbligo di presentare un certificato di frequenza alle scuole primarie per i giovani che avessero voluto intraprendere un’arte o mestiere; o l’altro regolamento del 1819, che prevedeva la graduale sostituzione del metodo normale con quello lancasteriano del mutuo insegnamento e ribadiva l’obbligo dell’alfabeto per chi si fosse messo a esercitare un nuovo mestiere. Ma le affermazioni di principio stentarono a sostanziarsi nella pratica sia per la carente vo97. Sulla scuola elementare in Lombardia v. le periodiche rassegne di G. Sacchi negli «Annali universali di statistica». Cfr. anche Problemi scolastici ed educativi nella Lombardia del primo ottocento, vol. 1°, L'istruzione elementare, Milano, 1977.
98. Broccoli, op. cit., p. 118.
62
lontà politica delle autorità centrali, sia per le resistenze di moltissime amministrazioni comunali, dovute in parte a effettive difficoltà di bilancio, ma anche in buona misura a una chiusura misoneistica di fronte alla prospettiva di un sia pur limitato innalzamento del livello di istruzione delle classi subalterne. Il che spiega come mai nel 1859, alla vigilia del crollo del Regno, nelle province napoletane su 3.094 comuni e borgate soltanto 999 fossero provvisti dell’insegnamento primario maschile e femminile mentre 1.084 mancavano ancora di qualsiasi scuola elementare, e gli alunni frequentanti fossero solamente 67.431. Dati globali che al di là della loro attendibilità trovano un puntuale riscontro nell’esame di alcune situazioni locali, come ad esempio quella del Salernitano, dove nel 1835 su una popolazione intorno ai 450.000 abitanti gli alunni delle scuole pubbliche erano soltanto 5.000 circa!0, A prescindere dai dati quantitativi anche la qualità dell’insegnamento era poi estremamente scadente, sia per le deficienze di una parte del corpo insegnante reclutato senza alcuna seria garanzia di una preparazione adeguata, sia per i difetti e la promiscuità dei metodi pedagogici (l’affiancamento del sistema lancasteriano a quello normale spesso non fu infatti una innovazione didattica ma soltanto un espediente cui si ricorse per cercare di alfabetizzare in maniera rudimentale classi troppo numerose). E specchio fedele di questo stato di cose può essere considerata la relazione stesa nel 1859 dal presidente degli studi Emilio Capomazza, inconsapevole suggello a 45 anni di malgoverno scolastico, nella quale si legge tra l’altro: Molte delle scuole primarie hanno stanze male adatte o eccentriche. Moltissime si esercitano nell’abitazione de’ maestri con danno della morale e del costume, dovendo i fanciulli e le fanciulle esser sempre in mezzo ai famigliari, ai servi, ai lavoratori di campagna ed alle altre meno educate persone. Da per ogni dove, e forse esclusa la sola capitale, mancano di oggetti scolastici; non un libro, non un foglio di carta, non un lapis, non un quadretto si dà agli alunni, che
quasi tutti sono sforniti di mezzi per provvedersene. Non poche scuole poi mancano fino degli scanni e delle tabelle per l'insegnamento del leggere e dello scrivere... Che si direbbe poi se si sapesse che moltissimi maestri sono rimunerati peggio di una fantesca, ricevendo soldi meschinissimi, che in taluni luoghi non oltrepassano i ducati dieci o dodici all’anno?... E se a tutto ciò si aggiungesse che il soldo del maestro e della maestra è per il primo ad invertirsi ad altro uso, ad ogni più lieve bisogno del Comune, anteponendosi il bene materiale al morale, chi non vedrebbe essere ben altra che la poca vigilanza o il niuno incoraggiamento, la cagion vera dello scarso frutto delle scuole primarie?
99. G. Nisio, Della istruzione pubblica e privata in Napoli dal 1806 sino al 1871, Napoli,
187 pasile 100. D. Cosimato, Note e ricerche archivistiche su l’istruzione pubblica nella provincia di Salerno (dal 1767), Salerno, 1967, p. 105.
63
E tutto questo senza tener conto delle intrusioni da parte de’ maestri, e talvolta dei sindaci, di sostituti abusivi, per lo meno ignoranti e mai sempre non curanti dello insegnamento... In altri Comuni poi non esclusa la capitale, i maestri municipali disimpegnano il loro ufficio con raro abbandono, ed i genitori amano meglio a mandare i loro figli ai maestri privati, pagandone una mensile mercede, piuttosto che mandarli alle scuole pubbliche
che sono gratuite; e da tal ragione ne deriva la quantità immensa delle scuole private!0!,
Situazioni intermedie tra quelle del Lombardo-Veneto e del Mezzogiorno si ebbero negli altri Stati italiani. Così nei domini sabaudi l'istruzione primaria fu sostanzialmente trascurata fino all’inizio degli anni ’40, nel corso dei
quali prese l’avvio un vasto movimento rinnovatore. Prima di quella data l’istruzione elementare, affidata prevalentemente al clero, improntata a spiriti confessionali e finalizzata allo studio del latino, riguardò solo superficialmen-
te le classi popolari; e sebbene un regolamento del 23 luglio 1822 avesse previsto l’istituzione di classi elementari nelle città, nei capoluoghi di mandamento e possibilmente in tutti i borghi e le terre, la scarsità di docenti, la mancanza di sanzioni a carico di quei Comuni che non avessero proceduto all’attivazione delle scuole, la resistenza dei genitori (che preferivano inviare i figli al lavoro piuttosto che nelle aule) impedirono una realizzazione su vasta scala delle disposizioni governative. E a documento delle tristi condizioni della scuola elementare negli Stati sardi ci sembra che possano essere opportunamente riportate queste notazioni dal vivo del pedagogista piemontese Vincenzo Troya: Entrando in queste scuole zeppe di vispi fanciulletti, voi vedevate d’ordinario regnarvi un’orribile confusione, un chiasso spaventevole... Quivi per primo libro la così detta charta latina, il catechismo della diocesi, libro ottimo e necessario, ma il meno
confacente per materia di prima lettura ai fanciulli. E dopo parecchi anni di frequenza a queste scuole, quale ne era il profitto? Cercate nella classe del popolo, e soprattutto nei villaggi, quanti sappiano leggere, scrivere, conteggiare...: troveremo l’istru-
zione primaria non lontana da una generale ignoranza!02.
Quanto al Granducato di Toscana, ai lenti progressi che si avvertivano nelle città faceva riscontro la stagnante arretratezza dei contadi («Lagnansi là molto — osservava il Mittermaier nel suo scritto Delle condizioni d’Italia — che i parrochi di campagna non abbiano per le scuole interesse alcuno, le comuni alcuna voglia di fondarle; e quindi così spesso crescono i figli in campagna senza istruzione di sorta»!03), tanto che negli anni ’40 su circa 280.000 101. Nisio, op. cit., p. 30.
102. Sulle scuole elementari in Piemonte v. tra l’altro G. Griseri, L'istruzione primaria in Piemonte (1831-1856), Torino, 1973. 103. C. Mittermaier, Delle condizioni d’Italia, Lipsia-Milano-Vienna,
64
1845, p. 207.
fanciulli in età scolare i frequentanti erano poco più di 21.000!04, E il quadro volgeva al peggio nello Stato pontificio, dove le scarse scuole primarie, nelle mani del clero e imperniate sull’insegnamento religioso e su quello dei rudimenti del latino, riguardavano soltanto marginalmente gli strati popolari, sui quali continuava a gravare la coltre di una secolare ignoranza. Né il tono medio era di certo elevato dalle scuole private, chiamate «scuole regionarie», per le quali può bastare questa descrizione del Morichini: «L'aspetto di molti di questi luoghi è piuttosto sconfortante. Imperocché vedi ammassati alle volte in una sola stanza a pianterreno più fanciulletti tenuti con pochissima nettezza: chi piange, chi strepita, questi è penzolone al muro, cui è raccomandato da un nastro, quegli giace nel lezzo»!05. Più limitati di quelli relativi al pauperismo e all’istruzione primaria appaiono gli altri interventi dei governi della Restaurazione di fronte alle grandi questioni sociali alle quali si applicava il dibattito culturale; ma in questa sede, in cui non è possibile scendere ad una analisi approfondita delle misure pratiche, della strumentazione amministrativa e degli orientamenti ideali, ci limiteremo ad accennare ad alcune direzioni di ricerca. Sarebbero anzitutto desiderabili lavori sulla struttura sanitaria (medici, chi-
rurghi, levatrici, farmacie) e ospedaliera e sulle condizioni dell’«igiene pubblica»!06 delle città maggiori e minori e sul multiforme mondo dei contadi, sia in tempi normali che nelle stagioni di tensione straordinaria (epidemie, carestie, ecc.)!0, Lavori che ovviamente
non dovrebbero restare sul terreno
della storia delle istituzioni e di quella amministrativa o di una storia della medicina puramente «interna» e specialistica, ma dovrebbero investire tutti gli aspetti più rilevanti ai fini di una comprensione intima dei modi di essere materiali e mentali di una società così varia come quella italiana della prima metà dell’800: quali ad esempio le forme d’impatto delle epidemie nella coscienza popolare (la credenza negli avvelenatori; la diffidenza verso i medici, temuti come agenti di governi interessati a decimare popolazioni esuberanti; l’ostilità per i ricchi, che la condizione economica metteva in grado di sottrarsi più facilmente al contagio); le manifestazioni della «medicina popolare» (fiducia nei cerretani e nei conciaossa, abuso dei salassi e dei purganti, e così via)!08; la ripugnanza dei contadini e dei popolani in genere nei confronti 104. Ibidem, p. 207. 105. Morichini, Degl'’istituti di pubblica carità, cit., pp. 245 sgg. 106. Una bibliografia introduttiva sull'argomento è A. Corradi, Dell’igiene pubblica in Italia e degli studi degli italiani in questi ultimi tempi, Milano, 1868. 107. Per la cronaca delle epidemie v. Corradi, Annali delle epidemie, cit. 108. V. tra l’altro G. Mora, Di alcuni vegetabili in uso medico presso il popolo della provincia di Bergamo, Pavia, 1850, e C.L., Sull’abuso dello spaccio dei purganti, in «L’Igea», Milano, 16 luglio 1863.
65
degli ospedali, considerati anticamere della morte Egli è certo — scriveva nel 1834 il lombardo Folchino Schizzi, un esperto di questioni assistenziali — che negli spedali l’aria è affetta da morbifere evaporazioni, che il prospetto tristissimo di tanti infelici straziati da tanti e diversi malori, che l'aspetto di morte signoreggiante costantemente in questi asili della miseria umana, che i sonni interrotti dal pianto dell’infermo, dal lamento dell’agonizzante, dalla pia voce de’ sacerdoti che fanno corona al moribondo... e che pregano pace a’trapassati, sono cause più che bastanti a rendere ragionevole l’avversione che il popolo sente nel recarsi
a’pubblici spedali!09,
E, di nuovo, anche nel settore dell’ordinamento sanitario la Lombardia appariva relativamente privilegiata, con la sua rete di ospedali così vantata dai pubblicisti del periodo, con il suo servizio di distribuzione gratuita di medicinali ai poveri, con la sua fitta trama di medici, chirurghi, chirurghi minori, ostetriche, farmacisti e veterinari (nel 1842 si contavano
nella regione 284
medici in impieghi pubblici, 1.048 nelle condotte, 812 al servizio dei privati, oltre a 1.408 levatrici e 1.011 speziali)!!0. Anche se poi un’analisi minuta di questa situazione, che faceva pur sempre spicco in Italia, dovrebbe porre in evidenza pecche e carenze gravi, come le disfunzioni e il collasso amministrativo di molti ospedali e le limitazioni che a un più efficace disimpegno delle mansioni dei medici condotti ponevano la tenuità dei loro stipendi, il carattere elettivo della carica (1 medici condotti erano eletti dai «convocati» 0
dai consigli comunali, donde «i brogli, la prepotenza, le parentele, l'interesse, la seduzione, il fanatismo che creano partiti nei casi di scrutini...; per cui fra’ concorrenti bene spesso l’ignoranza trionfa prescegliendosi l’incapace»!!!), e la precarietà del rapporto, che scadeva ogni tre anni!!?, In questo contesto andrebbero studiate tra l’altro le vicende della vaiolizzazione e soprattutto della vaccinazione, una pratica che avrebbe alla lunga inciso in misura rilevante sulla struttura demografica del paese contribuendo ad 109. F. Schizzi, cenni premessi al Visitatore del povero del De Gérando, Milano, 1834. 110. G. Canziani, Ordinamento sanitario delle nove provincie di Lombardia, in «Il Politec-
nico», Milano, 1844, fasc. 39, pp. 223 sgg. 111. Sulla condizione dei medici condotti, in «Gazzetta medica italiana - Lombardia», 6 maggio 1850, p. 89. 112. V. tra l’altro: G. Comolli, Delle condotte mediche, chirurgiche ed ostetriche, in «Gazzetta medica lombarda», 11 settembre 1848; A. Marziali, Sui medici condotti, ibidem, 8 luglio 1850; Avviso di un medico condutto a’giovani che vogliono attendere allo studio della medicina e della chirurgia, in «Gazzetta medica italiana federativa. Lombardia»,
14 ottobre 1850; G.
Strambio, Intorno alle condutte, ai medici condutti, ed alla opportunità di alcune fra le riforme che si invocano, ibidem, 6 gennaio 1851; L. Balardini, Intorno alle condizioni de’ medici condutti ed alle riforme delle condutte mediche, in «Gazzetta medica italiana. Lombardia», 2 luglio 1855; ecc.
66
abbassare il quoziente di mortalità: del che si mostravano pienamente coscienti gli studiosi contemporanei, come il De Samuele Cagnazzi, il quale nel 1831 osservava che mentre nelle province del Mezzogiorno, dove la vaccinazione era scarsamente praticata, «di tutti quelli che nascono la metà ne resta all’età di sette in otto anni», nella città di Napoli, dove la vaccinazione era più diffusa, «di tutti fanciulli che nascono, la metà ne resta all’età di ventuno in ventidue anni»!!3; e come Giovanni Strambio il quale, studiando le epide-
mie di vaiolo verificatesi in Milano da metà novembre 1829 al 31 marzo 1834 (con un totale di 10.357 casi) metteva in rilievo la bassa percentuale di morti tra i vaccinati «con effetto»!!4. Dalla constatazione dell’efficacia della vaccinazione i medici più impegnati traevano poi conforto per proseguire e intensificare la lotta contro i pregiudizi e le diffidenze che avrebbero ancora a lungo ostacolato la generalizzazione di quella pratica, specie nelle campagne. E sempre in tema di vaiolo e delle sue connessioni con la storia del pensiero sociale è doveroso ricordare la sdegnata replica del Romagnosi — proprio in alcune osservazioni allo scritto del De Samuele Cagnazzi appena citato — a quanti sulle orme di Malthus si mostravano timorosi che l’uso del vaccino portasse a un ulteriore aumento della popolazione: «Coi principî, co’ quali taluni chiudono gli ospizi degli esposti, e fanno guerra ad una temuta, crescente popolazione, si dovrebbe giungere all’orrenda e tifonica conseguenza di porre in disparte tanto la vaccinazione, quanto i cordoni sanitari, lasciando solamente sussistere le precauzioni contro le epizoozie»!!5. Continuando a esemplificare in materia di sanità e politica sanitaria, un’altra questione sulla quale si esercitarono a lungo le discussioni di medici, igienisti, filantropi e uomini di governo tra metà ‘700 e metà ‘800 è quella dell’allargamento della cultura del riso e dei suoi effetti sulla salute dei risicultori e degli abitanti delle zone risate, divenute assai estese nella Val padana; questione di cui andrebbero seguiti anche i risvolti legislativi, concretatisi in una serie di interventi che si mossero nel senso di una limitazione della risicultura che rifletteva la preoccupazione delle popolazioni di quelle plaghe per l’insidia delle febbri malariche (divieto delle risaie sui terreni posti all’interno di un certo raggio intorno ai centri abitati variabile da qualche centinaio di metri per i villaggi rurali a vari chilometri per le città), ma che si rivelarono pressoché impotenti di fronte alla logica del profitto cui obbedivano grandi proprietari e affittuari!!6. 113. L. De Samuele Cagnazzi, La vaccinazione giova o no all’aumento della popolazione?, in «Annali universali di statistica», 1831, vol. 27°, p. 159.
114. G. Strambio, Della necessità di praticare l’innesto della vaccina in ogni umano individuo..., in «Il Politecnico», 1839, vol. 1°, pp. 341-342. 115. In «Annali universali di statistica», 1831, vol. 27°, p. 165. 116. Faccini, op. cit., passim.
67
Così pure un fecondo terreno di ricerca potrebbe essere quello dell’atteggiamento dei pubblici poteri, dei medici e degli studiosi di fronte al problema dell’esposizione infantile: e anche qui lo studio delle strutture amministrative e delle vicende patrimoniali dei brefotrofi (il cui finanziamento pesò in misura cospicua sui bilanci erariali e su quelli locali, costretti a colmare i deficit aperti nelle amministrazioni degli ospedali e dei luoghi pii dal mantenimento degli esposti) andrebbe raccordato a quello degli aspetti sociali del fenomeno e del lungo dibattito che si intrecciò in Italia, sulla falsariga della discussione francese, tra oppositori e fautori dei brefotrofi e della «ruota» (e val la pena di ricordare qui che fra i primi fu anche Francesco Ferrara, il quale in un saggio del 1838 asseriva che gli ospizi dei trovatelli erano inutili in quanto facevano morire un numero di fanciulli non inferiore a quello che sarebbe perito senza di essi, dannosi perché corrompevano la morale domestica, ingiusti perché richiedevano il concorso di una spesa pubblica come se fossero stati utili!!?).
Un posto adeguato in questo tipo di indagini andrebbe infine assegnato allo studio delle vicende della «istituzione manicomiale», un settore nel quale in questi decenni si andarono allargando gli interventi della «carità legale». Varie le cause di questo progrediente interesse pubblico: l'allarme suscitato un po’ in tutta Europa dalla presunta crescita del numero dei pazzi (il Morichini parlava di un aumento «progressivo e spaventevole» del quale faceva responsabili l’indebolimento del sentimento religioso e gli sconvolgimenti politici!!8); la scoperta che i pazzi erano malati curabili come gli altri (e basti pensare a un precursore a cavallo tra ‘700 e ’800, il fiorentino Chiarugi) e non più coloro «qui perpetuo more laborant»; la diuturna battaglia condotta da filantropi e intellettuali illuminati per un più umano trattamento dei malati mentali. Di conseguenza non soltanto i folli furono sottratti alla malsana curiosità di visitatori in cerca di emozioni, ma si avviò anche una profonda trasformazione dei sistemi usati nel trattamento di quei malati, spesso ancora confusi con i carcerati; si ebbero così l'abbandono delle segrete, delle catene, della sferza (nelle regole dettate nel 1635 e rimaste a lungo in uso per l’ospedale dei pazzi della Pietà in Roma si prescriveva al «maestro dei pazzi» di tener sempre con sé il «solito nervo», con l’avvertenza di esercitare l’ufficio della battitura «con carità e con discretezza»' per evitare «errori gravissimi» nel somministrare le percosse!!9) e l’introduzione, accanto a pratiche che non si sarebbero rivelate producenti (le sedie ruotanti e via dicendo), di metodi
117. F. Ferrara, Dei fanciulli abbandonati,
in «Giornale
di statistica di Sicilia», Palermo,
1838, s. I, vol. 3° (ripubblicato in «Annali di statistica», Roma, 1890, s. IV, vol. 39°, pp. 46 sgg.). 118. Morichini, Degl'’istituti di pubblica carità, cit., p. 57. 119. Q. Querini, La beneficenza romana dagli antichi tempi fino ad oggi, Roma, 1892, p. 255.
68
che testimoniavano di una crescente sensibilità dei medici per i problemi psichici dei loro pazienti, primo tra tutti la terapia del lavoro. E in questa prospettiva, pur tra esitazioni, errori e insufficienze, si rinnovarono o si crearono ex novo un buon numero di manicomi — le cui vicende andrebbero anch’esse studiate dall’interno — come quelli di Genova e del Bonifazio a Firenze, la Senavra di Milano, il «morotrofio» di Aversa e l’ospizio dei Pazza-
relli di Palermo. Questo elenco di questioni aperte e di temi di ricerca potrebbe essere ancora arricchito con altre indicazioni tematiche (le migrazioni interne, le prigioni e il dibattito sul problema carcerario, l’alcoolismo, la prostituzione, e via dicendo), ma quanto si è fin qui detto potrà forse apparire sufficiente dal momento che non ci si proponeva altro intento che quello di invitare all’approfondimento di vicende e di aspetti della storia sociale del nostro paese sui quali si deve ancora esercitare il comune impegno degli studiosi.
69
3. Le «interdizioni» israelitiche e la questione dell’emancipazione degli ebrei nel Risorgimento
La Restaurazione del 1814-15 eliminò gli effetti della prima parificazione degli ebrei in Italia, introdotta dopo l’arrivo delle armate della Francia rivoluzionaria nella penisola, e ristabilì la situazione esistente nel 1796. Lo stato giuridico degli israeliti italiani tornò quindi a farsi assai differenziato, dalla condizione di estremo sfavore propria degli Stati sardi, dello Stato pontificio e del Ducato di Modena a quella tollerante o relativamente favorevole vigente nel Granducato di Toscana, nel Lombardo-Veneto e nel Ducato di Parma.
Nei domini sabaudi l’editto reale del 21 maggio 1814 richiamò in vigore le costituzioni del 1770 e le successive disposizioni via via emanate negli anni seguenti: tornavano così per gli ebrei l’obbligo di dimorare nei ghetti e di portare il «segno», il divieto di costruire nuove sinagoghe, la proibizione di acquistare immobili e di avere servi cristiani. Poco più tardi la regia patente del 1° marzo 1816 dispensò gli israeliti dall’obbligo del «segno», permise loro l'esercizio della mercatura, delle arti e dei mestieri e rese possibile l’uscita
dai ghetti anche di notte per motivi di lavoro, ma impose la vendita entro cinque anni degli immobili acquistati durante il periodo francese. Inoltre si vietava agli ebrei l’accesso alle professioni liberali che richiedessero una laurea, si sanciva la loro esclusione da tutti gli impieghi governativi e dall’esercito e si negavano agli israeliti nullatenenti le varie forme di assistenza erogate dalle opere pie. Analoghe ed altrettanto discriminatorie furono le interdizioni cui vennero sottoposti gli ebrei nei domini pontifici, dove si tornò alla situazione sanzionata da Pio VI nel 1755, con un ulteriore rincrudimento durante il pontificato
di Leone XII (1823-29)!. 1. Un'idea delle restrizioni imposte agli ebrei nello Stato pontificio la si può avere da un editto dell’inquisitore generale del S. Officio in Ancona del 24 giugno 1843 (riprodotto in Degli israeliti nei dominii della Chiesa innanzi la pubblicazione dello Statuto fondamentale e
70
Quanto a Modena,
furono ribadite le misure contenute nel Codice civile
del 1771, aggravate da una legge del 23 marzo 1831. In particolare, oltre al ripristino del ghetto e del «segno» (un nastro rosso sul cappello), si proibiva il possesso di stabili fuori del ghetto, si limitavano drasticamente i diritti civili (esclusione dai gradi accademici, dagli impieghi pubblici e dall’esercito) e si imponeva alla comunità israelitica un contributo speciale di 20.000 lire annue come contropartita per la tolleranza. All’estremo opposto, nel Granducato di Toscana una legge del 17 dicembre 1814, confermando i relativi privilegi di cui gli israeliti godevano da tempo nello Stato, realizzava una parificazione pressoché integrale dei diritti civili della «nazione ebrea», i cui individui avrebbero dovuto «indistintamente
come gli altri sudditi esser soggetti alle leggi ed ordini del Granducato e ricorrere ai tribunali ordinari». Vestigio dell’antica inferiorità restavano l’esclusione dall’esercito e quella dalle professioni forensi, fatto tanto più strano in quanto gli ebrei potevano addottorarsi nelle università toscane anche nelle scienze legali ed erano ammessi all’esercizio delle altre professioni liberali che più da vicino potevano interessare l’ordine pubblico. Circa i «diritti pubblici» gli ebrei potevano accedere a tutte le magistrature delle comunità toscane, tranne che in Livorno: eccezione che venne soppressa da una risoluzione del 24 giugno 18452. Nel Lombardo-Veneto, come in Toscana, l’equiparazione poteva dirsi quasi completa: il più corposo residuo delle interdizioni stava nel fatto che gli ebrei, ammessi ai convocati comunali, non potevano invece far parte delle congregazioni municipali (organi incaricati dell’amministrazione dei capoluoghi di provincia e delle città regie) e delle congregazioni provinciali; inoltre era loro interdetto l’ufficio tutelare e (dal 1829) l’esercizio della
farmacia. della utilità e convenienza di emanciparli. Discorsi cinque per un religioso, Bologna, 1848, pp. 141-144). In esso si stabiliva tra l’altro il licenziamento di tutti i servitori e le balie cristiane che prestavano la loro opera nel ghetto, l'alienazione dei fondi rustici o urbani di proprietà di ebrei situati fuori del recinto a essi riservato, la proibizione agli israeliti di «mangiare unitamente ai cristiani nelle locande, e trattorie fuori di ghetto» e di «frequentare case cristiane, o tenere amicizie con donne, o uomini cristiani». Gli studi più recenti e documentati sul problema ebraico nel Risorgimento sono quelli di A. Canepa, L'atteggiamento degli ebrei italiani davanti alla loro seconda emancipazione: premesse e analisi, in «La Rassegna mensile di Israel» (da ora «R.m.I.»), settembre 1977, pp. 419 sgg., e Considerazioni sulla seconda emancipazione e le sue conseguenze, ibidem, gennaio-giugno 1981, pp. 45 sgg. Ancora utile la classica Storia degli ebrei in Italia di A. Milano (Torino, 1963). Cfr. anche N. Samaia, La situazione degli ebrei nel periodo del Risorgimento, in «R.m.I.», luglio
1957, pp. 298 sgg. e S. Foà, Gli ebrei nel Risorgimento italiano, Assisi-Roma, 1978. 2.LE. Rignano, Sulla attuale posizione giuridica degli israeliti in Toscana. Brevi cenni, Firenze, 1847, pp. 28 sgg.
71
Ancora più favorevole, infine, era la condizione degli israeliti nel Ducato di Parma, dove la sola restrizione rimasta in vigore fu il divieto di risiedere
nella capitale. Certo, anche là dove la normativa nei confronti degli ebrei (circa 37.000 nel 1840)3 fu più accentuatamente discriminatoria, non sempre le singole disposizioni — come accadde per l’obbligo di vendita degli immobili in Piemonte — furono attuate con rigore. E neppure prevalsero totalmente, nello Stato pontificio, gli orientamenti drasticamente antiebraici propri di molti esponenti dell’alto clero, come il delegato a Ferrara Tommaso Bernetti che all’aprirsi della Restaurazione,
nel dicembre
1815, aveva
scritto al segretario di Stato
cardinal Consalvi: «Se fosse permesso a me di dir qualche cosa sul timore che si ha di perdere questa genia [gli ebrei] disgustandola con la rimettere ov’era, io rispettosamente direi che per Ferrara sarebbe — e per lo Stato — una fortuna vera che ne sloggiasse, perché quanto v’è d’usura, di frode, di monopolio, di disordine nelle monete, tutto in questa provincia viene da quella parte»*. Ma in ogni modo, al di là della menomazione giuridica e della minorazione civile, vanno messe in conto alla legislazione restrittiva dei principi cristiani anche le conseguenze negative che sulle condizioni materiali di esistenza degli ebrei produceva l’ammassamento di un gran numero di persone in spazi ristretti, come accadeva nei ghetti di Ferrara o di Roma, che la penna di Massimo d’ Azeglio così descriveva nel 1846: Che cosa sia il ghetto di Roma, lo sanno i romani, e coloro che l’hanno veduto. Ma
chi non l’ha visitato, sappia che presso il ponte a Quattro Capi s’estende lungo il Tevere un quartiere, o piuttosto ammasso informe di case e tugurj mal tenuti, peggio riparati e mezzo cadenti... nei quali si stipa una popolazione di 3.900 persone, dove invece ve ne potrebbe capire una metà malvolentieri.
Le strade strette, immonde,
la
mancanza d’aria, il sudiciume che è conseguenza inevitabile dell’agglomerazione sforzata di troppa popolazione quasi tutta miserabile, rende quel soggiorno tristo, puzzolente e malsano. Famiglie di que’ disgraziati vivono, e più d’una per locale, ammucchiate senza distinzione di sessi, d’età, di condizioni, di salute, a ogni piano, nelle sof-
fitte e perfino nelle buche sotterranee, che in più felici abitazioni servono di cantine9.
La perpetuazione di discriminazioni così vessatorie, e che apparivano ormai decisamente in contrasto con le acquisizioni del più avanzato pensiero 3. Si veda soprattutto Roberto Bachi, Lo sviluppo demografico degli ebrei italiani dal 1600 di Sally Mayer. Saggi sull’ebraismo italiano, Gerusalemme, 1956, pp. 52 sgg. 4. E. Loevinson, Gli israeliti dello Stato pontificio e la loro evoluzione politico sociale nel periodo del Risorgimento italiano fino al 1849, in «Rassegna storica del Risorgimento», 1929, p. 780. al 1937, in Scritti in memoria
S. M. d’Azeglio, Dell’emancipazione civile degl’israeliti, Firenze, 1848, pp. 24-25.
72
europeo (a far data almeno dall’illuminismo), non si spiega soltanto con il carattere particolarmente retrivo assunto dalla Restaurazione a Torino, Roma e Modena, con la forza inerziale di consuetudini e pratiche secolari, con l’insegnamento tradizionale della Chiesa cattolica, con il radicamento di mentalità
collettive, ma chiama in causa anche tendenze profonde e tenaci della cultura conservatrice o reazionaria che, riemerse con nuovo vigore nella stagione della Restaurazione, si riallacciavano al filone antisemita proprio di alcuni gruppi intellettuali italiani del ’700. E basterà ricordare, a tale proposito, i nomi di Paolo Medici, che nel suo scritto Riti e costumi degli ebrei confutati
(Venezia, 1740) parlava di «cecità» degli ebrei e proponeva la loro conversione più o meno forzata, o quello di Giuseppe Sessa, vice conservatore generale dell’università israelitica di Torino, che nel Tractatus de judaeis del 1717, partendo da premesse teologiche tradizionaliste, si era dilungato nella condanna del Talmud (il quale a suo avviso avrebbe raccomandato l’odio e il disprezzo nei confronti dei non correligionari) e nella deprecazione dei caratteri della vita economica degli ebrei (commercio, usura, ecc.): «L’orribile medusa è l’empia usura, / che ti rende insensato ai mali estremi, — così Sessa si rivolgeva verseggiando agli ebrei — e fa, che in pena il Punitor non temi, / fatta in te la perfidia omai natura. Deh adora il Redentor, che già uccidesti, / e sia la
tua fortuna il tuo peccato». E nel filone antiebraico a sfondo conservatore si inserisce, proprio in apertura di Restaurazione, il piemontese Francesco Gambini, che nel periodo napoleonico fu membro della Consulta legislativa in Piemonte e poi del corpo legislativo a Parigi, e che coltivò in seguito gli studi economici’. Il primo intervento di Gambini sulla questione ebraica, l’opuscolo Dell’ebreo possidente (1815), mirava a escludere recisamente la possibilità che si concedesse agli israeliti il diritto di possedere immobili, soprattutto terre. L’argomentazione di fondo, appoggiata su motivazioni ricavate dal vecchio armamentario antisemita, si fondava sull’asserzione che gli ebrei erano
una «nazione» esclusiva, intollerante e non assimilabile, che aveva voluto la propria «segregazione» con l’osservanza esasperata del Talmud (la quale aveva spinto «le massime segregative sino al delirio») e che in seguito a questo suo orgoglioso isolamento aveva anche sviluppato la sua forte propensione per le pratiche usuraie e commerciali spesso fraudolente. [Il giudeo] nemico, per istituto, di tutti gli stranieri, — così suona un passo che dà la
misura dell’acrimonia da cui era pervaso lo scritto — ravvolto fra loro per necessità, e 6. Tra i suoi scritti: Delle leggi frumentarie in Italia, s.n.t., 1819 e Osservazioni sulla proibita esportazione della seta greggia dal Piemonte, Torino, 1833 (già apparso anonimo nel 1820 nella Raccolta di opere di economia politica di autori piemontesi, Torino, 1820).
73
con essi ogni nodo di convivenza e di sangue abborrente per legge; nelle sue propensioni represso, e ad atti contrarii violentato; odiatore finalmente per attual situazione, e per abitual dovere, fu altrettanto odiato per retribuzione, ma coll’inevitabil sorte del
debole a fronte del forte. Non cessando però mai di considerarsi come un popolo privilegiato da Dio, e destinato a dominar col tempo, e a riformar sul proprio modello tutti gli altri, si mantenne sempre internamente orgoglioso, benché esternamente avvilito, e per la sua nullità politica necessariamente disprezzatissimo. I suoi riti, già per sé singolari, rimasti senza reale oggetto, divennero superstizioni per lui moleste, e per gli altri ridicole. Usurajo ad arbitrio cogli stranieri, si credè lecita ogni frode con quelli, con cui crede-
va a sé lecita l’usura. Stretto co’ suoi, come dagli altri disgiunto, considerò la fortuna privata d’ogni giudeo come patrimonio comune della nazione, e non riconobbe alcun moral ritegno nelle vie d’acquistarla a danno de’ non giudei; perché imputando ad essi gli effetti d’una causa ch’egli porta con sé, riguardossi sempre come in uno stato di guerra, che lecita gli rende ogni rappresaglia”.
Dato questo loro «carattere» nazionale, che li poneva in contrasto con tutti gli altri popoli, — argomentava Gambini a chiusura del suo ragionamento — gli ebrei non potevano essere considerati «cittadini» del paese che li accoglieva, e quindi non potevano neppure essere titolari del diritto di proprietà fondiaria. L’ostilità dello scrittore piemontese per gli ebrei aveva però — e questo è un suo tratto distintivo — un fondo laico, nel senso che egli evitava i riferimenti alle prese di posizione dei papi e all’autorità teologica, per mettere invece in primo piano preoccupazioni di natura politica ed economica. Anzitutto, a suo giudizio, importava conservare la saldezza, la compattezza del mondo contadino (piccoli proprietari, coloni, affittuari), perché quella dei contadini era «la più preziosa di tutte le classi» e «la vera stirpe indigena d’ogni paese», come quella che «sostiene la milizia, e le arti laboriose, e che ristabilisce
continuamente la popolazione delle città, cui il lusso, la mollezza e le arti sedentarie corrompono, e consumano sempre». Per questo la proprietà di terre assumeva agli occhi di Gambini un'importanza economica e sociale assai superiore a quella delle proprietà mobili e delle ricchezze mercantili, tanto che il legislatore sarebbe dovuto intervenire per impedire la sua «snazionalizzazione». Agli ebrei, esclusi dalle attività agricole, si potevano lasciare invece quelle commerciali e industriali, concessione che non avrebbe fatto correre rischi gravi alla «nazione» ospitante. Il mercante giudeo, ricco di fondi commerciali, — così argomentava Gambini — può colla sua industria e parsimonia renderli più produttivi, ch’altri non farebbe; e può con essi aumentar il numerario circolante, con pubblico vantaggio, senza privato 7. F. Gambini, Dell’ebreo possidente, Torino, 1815, pp. 24-25.
74
danno d’alcuno. Il regno dell’industria non è circonscritto da verun limite; e son d’al-
tra parte sempre utili l'emulazione e la concorrenza. Che se le ricchezze mobili e mercantili aumentassero in qualche modo la popolazione giudaica, non potrà tuttavia mai nascerne alcuna pubblica sensibil conseguenza. Finché la popolazione nazionale avrà la sua solida base ne’ proprietari e coltivatori del suolo, la nazione sarà sempre la stessa perché il genio dominante, e gli strumenti della pubblica forza saranno sempre gli stessi8.
All’interno di questa impostazione, imperniata sulla visione tradizionalista della superiorità dell’agricoltura sulle altre forme di attività economica, trovavano poi ampio spazio i luoghi comuni più diffusi e consolidati nella secolare pubblicistica antiebraica: l’arricchimento «prodigioso» dovuto al «mercimonio» e all’«usura», la proliferazione demografica, e via dicendo. E non deve
sorprendere se all’interno di un quadro mentale che lasciava ancora tanto spazio al pregiudizio e all’intolleranza Gambini giustificasse le interdizioni più odiose, dal ghetto al «segno» (imposto, arrivava a dire, per gli «atroci atti clandestini» degli ebrei contro i cristiani) e consigliasse il governo sabaudo a imporre ai «giudei» la vendita dei beni stabili di cui erano possessori, a reprimere le loro attività usurarie e a non restituire loro i banchi feneratizi, così da
facilitare l'inserimento degli israeliti nell’ «esercizio delle arti». In questo modo, aggiungeva, «si potrebbe sperare di renderli col tempo, se non cittadini, quali non potrebbero essere, almeno abitanti utili più che non sono». Gambini sarebbe poi tornato a insistere sulle sue opinioni venti anni più tardi con il volumetto Della cittadinanza giudaica, nel quale la confutazione delle idee emancipazioniste — che si erano fatta strada dalla Francia all’Inghilterra e ad altri paesi europei — assumeva toni parossistici e quasi ossessivi. Il nucleo del discorso era che il popolo ebreo era un popolo «d’eccezione», e andava perciò sottoposto a «leggi d'eccezione» per frenare la sua capacità di espansione economica e civile, impedendogli in primo luogo — e tornava qui la tesi centrale dell’Ebreo possidente — l’accesso alla proprietà della terra: «La non men disastrosa, che umiliante importanza politica, civile ed economica
de’ giudei, non metterà mai profonde radici in veruno
Stato,
finché la legge non permetterà loro d’invadere la proprietà del suolo». Quindi erano giustificati le «condotte» e i ghetti; non solo, ma diveniva sempre più necessario introdurre ulteriori misure restrittive a difesa dei contadini, come
la proibizione dei traffici vaganti dei contratti tra ebrei e abitanti mento»: provvedimenti ai quali israeliti delle città di tenervi un
degli ebrei nelle campagne e la limitazione del contado a quelli di «immediato eseguisi dovevano aggiungere l’obbligo per gli «negozio stabile ed aperto» o di esercitarvi
8. Ibidem, p. 9.
15,
un mestiere, pena l’internamento in una casa di lavoro, e il controllo dello Stato sull’insegnamento dei rabbini. Il «giudaismo», in questa concezione dominata da una paura aberrante della capacità espansiva degli ebrei nel tessuto della società, poteva così essere paragonato al «morbo asiatico», il colera, l’epidemia nuova e misteriosa che aveva aggredito negli ultimi anni l'Europa, di cui non era dato spegnere il germe e che poteva al massimo essere frenata nel suo percorso. E di qui una chiusa che non esitava a sostenere in maniera esplicita l'opportunità dell’intolleranza: Frattanto i moderni giudei non debbono dimenticar mai... che le esorbitanti ricchezze de’ giudei moderni, con tutte le perniciose ed odiose lor conseguenze, potrebbero, oltre il pubblico risentimento, eccitar anche il buon senso politico a rigettar i sofismi che le promuovono e proteggono; ed a conchiuder finalmente che se il frenare i giudei non è possibile il tollerarli non è necessario?.
Assai diversi gli orientamenti ideologici entro cui si muovevano i rappresentanti del filone antiebraico di segno cattolico-reazionario, nel senso che le
motivazioni addotte per riaffermare l’inferiorità giuridica e civile degli ebrei facevano riferimento alla pratica della Chiesa e si ammantavano di preoccupazioni religiose. Esemplare appare, da questo punto di vista, lo scritto del canonico piemontese Vincenzo Rossi, già segretario del cardinale Gerdil, pubblicato nel 1817 con il titolo Gli ebrei. Anche Rossi sosteneva che l’accettazione degli ebrei in uno Stato cristiano era pura «grazia del principe», semplice «tolleranza», che non includeva per nulla il diritto di cittadinanza, la
cui concessione era in contrasto con le «troppo venerande sanzioni della Chiesa». Ma la ragione principale per cui erano da respingere le tesi emancipazioniste stava nel fatto che esse, oltre a nuocere alla sicurezza dei principi cristiani, considerati ostilmente dagli israeliti, avrebbero danneggiato «tutti i seguaci della religione di Cristo, i quali rimanendo così vieppiù vincolati colla popolazione ebrea», si sarebbero trovati più «esposti ai pericoli di quell’odio mortale, che gli ebrei potranno talora nascondere, ma non potranno cancellar giammai». E in questa chiave veniva elargito ai cristiani il consiglio di non familiarizzare con i discendenti di Giuda «senza usare le debite precauzioni dalla cristiana prudenza suggerite», perché altrimenti avrebbero dimostrato di non avere sufficientemente a cuore la loro religione!0. Ancora più rozze, nel segno di un antisemitismo virulento, le argomentazioni esposte dal padre Ferdinando Jabalot in un intervento sul problema ebraico 9. F. Gambini, Della cittadinanza giudaica, Torino,
1834, passim. Sulla situazione degli
ebrei in Piemonte nel periodo in cui fu pubblicato il libro di Gambini v. A.C. Jemolo, Gli ebrei piemontesi ed il ghetto intorno al 1835-40, in «Memorie» dell’ Accademia delle scienze di Torino, classe di scienze morali, serie III, t. 1°, parte II, 1952, pp. 1 sgg. 10. V. Rossi, Gli ebrei, Cuneo,
1817, passim.
76
pubblicato nel 1825 dal «Giornale ecclesiastico di Roma». Il domenicano (Jabalot era pro-procuratore generale dell’ordine dei frati predicatori) polemizzava con quanti negli ultimi tempi si erano dati a professare un «amore svisceratissimo» per gli ebrei, dai filosofi che invocavano a favore degli israeliti i diritti dell’uomo, le leggi della natura, i principî di una sana politica, a quei rari teologi che osavano chiedere la parificazione. Tornavano in Jabalot, grezzi e inconditi, i più logori luoghi comuni dell’antiebraismo: la brama di arricchire, e di procurarsi così potere; la proliferazione demografica (segno — diceva il domenicano — di un buon trattamento da parte dei cristiani); e addi-
rittura l’infanticidio rituale o l’immoralità radicata («Il pudore ci divieta di parlare di certe nefandità. È incredibile il guasto che recano costoro alla morale, e l’insulto continuo che fanno alla santità del nome cristiano, abusando delle ricchezze per corrompere la fedeltà delle consorti, e la innocenza delle vergini battezzate»). Pienamente giustificate erano quindi interdizioni e leggi restrittive, di cui anzi poco caritatevolmente Jabalot chiedeva un inasprimento, con il ripristino di una serie di misure ormai cadute in desuetudine («Noi, il confessiamo con tutta sincerità, noi vorremmo a dì nostri rimesse ovunque in attività codeste
savissime ed antichissime
discipline che, a parer nostro,
sono altamente reclamate dal bisogno della società, e dal bene medesimo degli ebrei»). E l'eventuale, remota possibilità di aprire un discorso sulla parificazione era rimandata al giorno in cui i «deicidi» avessero abbandonato la loro religione per abbracciare la fede di Cristo!!. Ma anche ecclesiastici di ben superiore livello intellettuale, come il tosca-
no Luigi Chiarini — continuatore di una corrente di studi che aveva espresso alla fine del ’700 un ebraista come Giovanni Bernardo De Rossi —, pagavano il loro contributo alla coltre di preconcetti, chiusure e intolleranze che pesava sull’atteggiamento dottrinario della Chiesa cattolica nei confronti degli ebrei. Chiarini, che fu a lungo professore di lingua ebraica e di ermeneutica biblica nell’ Università di Varsavia, non esitava a sostenere nelle Théorie du judaisme
— un testo il quale ebbe una vasta diffusione dal 1830 in avanti — che il giudaismo era una dottrina perniciosa e antisociale perché il Talmud, «caos informe, ricettacolo di errori e di pregiudizi», predicava «il dispotismo religioso più oppressivo, la frode più raffinata, l’intolleranza più sfrontata», insegnava il sospetto, l’inganno, il sofisma, il «dispotismo religioso». La riforma degli ebrei doveva quindi partire da quella della loro religione; una riforma cioè che li liberasse dai loro errori religiosi e avviasse così la loro conversione, grazie anche a uno stretto controllo dello Stato sulla loro educazione. Pro11. F. Jabalot, Degli ebrei nel suo [sic] rapporto colle nazioni cristiane, estratto dal «Giornale ecclesiastico di Roma», t. III, 1825.
77
spettiva che comportava, sul piano giuridico, l’inammissibilità della attribuzione dei diritti civili agli ebrei, perché «questa massa, che non è oggi per nulla preparata a ricevere tali benefici, non potrebbe che abusarne a suo proprio svantaggio, e a svantaggio di coloro che glieli avessero accordati»2. Posizioni del genere non restavano però confinate nei giornali ecclesiastici o nelle trattazioni erudite, ma circolavano e penetravano nella società civile e tendevano a farsi «senso comune» attraverso le prediche, l’insegnamento religioso, la pubblicistica popolareggiante o — a un livello superiore — le allegazioni giuridiche. E a quest’ultimo proposito basterà ricordare il giurista bolognese Berni degli Antonj, il più anziano tra i docenti di diritto nell’ Ateneo della città petroniana, il quale in una dissertazione del 1827 — intesa a provare che gli ebrei non potevano succedere insieme ai cristiani nell’eredità di un congiunto cristiano — difendeva le tesi di Jabalot: egli dichiarava infatti che nello Stato pontificio gli ebrei erano soltanto «schiavi tollerati» i quali a loro volta, «per adempiere ai nefandi obblighi di una religione, dettata dall’odio implacabile contro i cristiani», avrebbero voluto ridurre questi ultimi in schiavitù, e che le condizioni e i vincoli in virtù dei quali era stato loro con-
cesso asilo erano pienamente giustificati perché miravano a evitare «gli effetti di una micidiale religione»!3. E della vera e propria «giudeofobia» alimentata nei domini papali si fece portavoce anche Monaldo Leopardi, uomo di punta della cultura clerico-reazionaria, che nel 1829 contrastò un progetto di colonizzazione dell’ Agro romano nel quale sospettava la presenza di capitali di ebrei: «Sarà possibile, — si chiedeva il padre del poeta — che andando una sera al riposo sudditi onorati e lieti del Papa, dobbiamo risvegliarci degradati a vili mancipj di Giuda?... Sarebbe possibile che il patrimonio della sposa di Gesù Cristo debba vendersi per danaro contante alla progenie de’ suoi crocifissori?»!4. E in un altro opuscolo coevo Monaldo giungeva a proporre l’espulsione dallo Stato degli israeliti, definiti «una birbaglia la quale non può fargli altro che male»!5.
12. L.A. Chiarini, Théorie du judaisme, appliquée à la réforme des israélites de tous les pays de l’Europe et servant en méme temps d’ouvrage préparatoire à la version du Tahlmud de BabyIone, Paris, 1830, 2 voll. 13. V. Berni degli Antonj, Osservazioni al voto consultivo del sig. avv. G. Vicini nelle cause di simultanea successione di cristiani ed ebrei alla eredità di un loro congiunto, Bologna,
1827. 14. M. Leopardi, Sul progetto di colonizzare l’Agro romano e di rendere abbondante la moneta nello Stato della Chiesa, Recanati, 1829, p. 15 (citato in La questione ebraica in un secolo di cultura italiana, con uno studio introduttivo di R. Mazzetti, Modena, 1938, pp. 14-15. Del Mazzetti v. anche Orientamenti antiebraici della vita e della cultura italiana, Modena, 1939).
15. La questione ebraica..., cit., p. 15.
78
Del resto la penetrazione di motivi antisemiti in frange abbastanza ampie degli intellettuali italiani anche nei decenni risorgimentali trova una conferma nell’atteggiamento verso gli ebrei di uomini che pure furono tra i protagonisti del movimento democratico, come è il caso di Francesco Domenico Guerrazzi. Questi, nelle Note autobiografiche composte nella prigione di Portoferraio (dove restò rinchiuso tra il settembre e il novembre 1833 per la sua partecipazione alle trame settarie mazziniane) mostrava di condividere in pieno l’insieme dei pregiudizi antiebraici largamente diffusi nella sua Livorno, città che contava una comunità di quasi 5.000 israeliti. «Partecipi della natura dei gatti mai li ammansisci; — questi alcuni dei tratti del quadro degli ebrei tracciato da Guerrazzi — né lunga servitù, né amorevolezza, né nulla con essi giova; l’amicizia non sentono; ogni loro affetto non oltrepassa la circonferenza dello scudo»; e ancora: «Gli ebrei con Moisè, e dopo presentano una vasta compagnia di Masnadieri più trista assai di quella del conte Lando; quando furono dispersi mutarono pelo, non vizio; di leoni si fecero volpi, e la guerra di sangue convertirono in guerra di frodi». Visione negativa che metteva capo a una richiesta di assimilazione forzosa diretta dallo Stato: «Ma dacché gli ebrei esistono, — questo il suggerimento finale di Guerrazzi — che farne? Applicare a loro le proprie regole dell’interdetto? No; ma quelli a cui fortuna pose in mano il freno delle nostre contrade volgano la mente a questa erba parassita, le contendano di tutto inviluppare, la costringano come conviene ad uomini tolleranti e filosofi a mutare natura, a mescolarsi»!9. Di contro a questo antisemitismo rivolto al passato, ostile o estraneo in molti di quanti gli diedero voce ai valori ideali liberali e progressisti del nuovo secolo, che trovava l’appoggio di buona parte del clero e di rilevanti settori del personale politico del Regno di Sardegna e dello Stato pontificio, si andò delineando e rafforzando — specie a partire dagli anni a cavallo del 1830 — una corrente intellettuale e ideale pienamente concorde sull’opportunità di una totale emancipazione degli israeliti; corrente che vedeva nella fine delle interdizioni e nella garanzia dei pieni diritti civili e politici degli ebrei uno degli obiettivi del Risorgimento, se questo doveva essere realmente un moto 16. F.D. Guerrazzi, Note autobiografiche e poema, con prefazione di R. Guastalla, Firenze,
1899, pp. 85, 87, 89. Sempre nell’ambito della democrazia risorgimentale livornese va ricordato l’antisemitismo che ispira la produzione poetica di Giovanni Guarducci (sul quale v. E. Toaff, Giovanni Guarducci: un poeta livornese antisemita, in «R.m.I.», luglio-settembre 1970, pp. 453 sgg.). E per restare nei confini toscani vanno segnalate l’avversione per gli ebrei e le critiche alla loro «intolleranza» di un liberale moderato come Capponi (cfr. B. Di Porto, Gino Capponi e gli ebrei: un’antipatia non meditata, ibidem, febbraio 1968, pp. 104 sgg.). Fuori della Toscana va rilevata la vena antisemita del romanzo Sibilla Odoleta di Carlo Varese (1827), sul quale v. A. Colombo,
Un romanzo antisemita del secolo scorso, in «R.m.I.», luglio
1967.
79
progressivo e liberatore, realizzatore dei fini umani propri del liberalismo o della democrazia. Corrente, va ancora aggiunto, la quale aveva avuto un suo precorrimento, negli ultimi decenni del ’700, in quanti — nel clima dell’illu-
minismo, del dispotismo riformatore e dell’età rivoluzionaria e napoleonica — si erano venuti distaccando dagli stereotipi sin lì predominanti nella visione della questione ebraica. Nel ristretto novero dei precursori delle idee emancipazioniste si può far rientrare in qualche misura Giovanni Battista Gherardo d’Arco con il suo scritto Dell’influenza del ghetto nello Stato (1782), pur se le sue posizioni oscillavano ancora tra il vecchio e il nuovo. La faccia che guardava indietro era costituita dal giudizio negativo sull’attività economica degli ebrei (commercio, affitto di fondi rustici, usura, cambio di valute, ecc.), ritenuta danno-
sa per lo Stato che li ospitava. Valutazione critica che, al di là delle ragioni di carattere materiale, poggiava in realtà sull’opinione comune corrente sulla mentalità e sull’indole degli ebrei, resi dalla loro religione — diceva d’ Arco — intolleranti e insocievoli, per cui il ghetto. restava «un corpo essenzialmente e per natura della cosa staccata dallo Stato, in mezzo a cui esiste; ed anzi pur
contro di esso lottante e per principî, e per sentimenti, e per doveri». Nuovi e progressivi, coerentemente al temperato illuminismo del futuro intendente della provincia di Mantova, erano invece l’asserzione che la separazione dei ghetti era stata determinata non soltanto dal «carattere» ebraico, ma anche dalle
leggi che avevano costretto gli ebrei a rinchiudersi tra loro, e l'apprezzamento per le recenti misure prese in Boemia, in virtù delle quali gli israeliti erano stati ammessi all’esercizio dell’agricoltura e delle attività manifatturiere e artigianali: con il che ci si era incamminati per la strada di «fratellanza» e «unione» che avrebbe consentito di avvicinare nazione a nazione e uomo a uomo!7. A favore di un temperato miglioramento della condizione giuridica degli ebrei si pronunciava qualche anno dopo Pietro Regis, professore di teologia nell’ Università di Torino, nel suo De judaeo cive (1795). Pur negando la possibilità della concessione a tempi brevi della cittadinanza piena agli ebrei (che avrebbe provocato una «grande jattura»), e pur proponendo un loro allontanamento dai vecchi costumi (peraltro libero e spontaneo), Regis sosteneva l’opportunità di concedere agli israeliti più ampi diritti civili, come l’accesso a determinate cariche e l’esercizio delle arti belle. Ma accenti di una simpatia assai più calda per il popolo ebraico erano risuonati poco prima nel Saggio sugli ebrei, e sui greci di Giuseppe Compa17. G.B.G. d'Arco, Della influenza del ghetto nello Stato, Venezia, 1782, passim. Su questo scritto cfr. R. Bachi, L'attività economica degli ebrei in Italia alla fine del sec. XIX (sic, per XVIII), in Studi in onore di Gino Luzzatto, Padova, 1950, vol. 3°, pp. 266-277; v. anche la voce su G.B.G. d’ Arco redatta da C. Vivanti in Dizionario biografico degli italiani, vol. 3°.
80
gnoni. Il futuro «giacobino» romagnolo apprezzava infatti caldamente l’amore per la libertà dimostrato dagli ebrei nel corso della loro storia (essi caddero, però «nessuno può loro rimproverare di essere stati vili») e respingeva i luoghi comuni correnti sul loro conto (così, ad esempio, magnificava la funzione culturale che avevano svolto con l’invenzione delle lettere di cambio o con il contributo dato alla civiltà europea da uomini quali Spinoza e Mendelssohn e definiva il Talmud una «insigne raccolta» che i cristiani avrebbero dovuto conoscere anziché disprezzare). E questa difesa, condotta in nome della «giustizia naturale»
e dei «diritti inerenti all'uomo»,
assumeva
i toni
della commossa apologia là dove Compagnoni scriveva: Senza terreno, che gli sostenga, esecrati, maledetti da tutti, divisi a torme più dal caso, che da umano intendimento, senza cittadinanza, senza proprietà, rigettati per fino dalla condizione miserabile della schiavitù, attraverso di mille infortunii ardiscono di
conservarsi, e divenendo gli agenti stessi de’ loro persecutori, ... più d’ogni altro contribuiscono a far risorgere in Europa, ov’eran trattati peggio che altrove, e le arti, e il commercio. E ancora:
L’uomo, che legge con riflessione la Storia, si sente a un tempo stesso gelare di raccapriccio al racconto delle disgrazie sofferte dagli ebrei in ogni secolo; e rapire da altissima meraviglia, vedendo questo avanzo di popolo sciagurato non solo scampare alla intera sua distruzione,
ma
unito tuttora sotto l’antica disciplina, costante
ne’
principj, negli usi, nella religione paterna, unico esempio sulla terra di fermezza, e d’immutabilità, senza mai attentare in nessun modo alla tranquillità de’ governi, sotto cui vive, tendere tacitamente a ricuperare il suo primo splendore!8.
Alla voce di Compagnoni, così intimamente pervasa di passione civile e tensione morale, altre voci che si muovevano nello stesso senso tennero dietro nei tempi più favorevoli della prima, breve emancipazione del periodo rivoluzionario e napoleonico. E basterà richiamare i nomi di Giambattista Formentini e Giuseppe Maria Pujati. Il primo, in un suo intervento del 1807, bollava il fanatismo e la superstizione antiebraici così duri a morire, attribuiva la responsabilità della condizione di avvilimento degli israeliti e dei loro eventuali difetti alle persecuzioni e alle interdizioni di cui erano stati fatti oggetto e auspicava il «vero risorgimento» della nazione ebraica, realizzabile appieno soltanto con la scomparsa delle prevenzioni antiebraiche. Ma quando mai avrà fine — questa la conclusione dello scritto — un’avversione che tanto disonora l’umanità celebrata del nostro secolo quanto è dessa irragionevole ed 18. G. Compagnoni, Saggio sugli ebrei e sui greci. Lettera a s.e. il sig. marchese Francesco Albergati Capacelli, Venezia, 1792, passim.
81
ingiusta? Quando mai vorranno persuadersi i mal prevenuti, che tutti i viventi sono eguali per la natura, ed hanno diritto al medesimo bene? Quando mai si desisterà di perseguitare un popolo, che lungi dal meritarsi inimicizie, ed odiosità, vanta ogni titolo all’altrui estimazione, e che dovunque trovò nella protezione delle leggi e de” sovrani meno difficoltà che attraversassero i di lui civili progressi seppe promuovere, e rinvigorire arti, commercio, agricoltura, popolazione? La ragion lo consiglia, l’umanità lo persuade, la carità lo comanda!9.
Diversa, religiosa e teologica più che civile, la matrice delle espressioni di apprezzamento per gli ebrei presenti nelle opere del giansenista veneto Pujati, impegnato a dibattere i temi del millennio e dell’avvento di una patria celeste, comune a cristiani e a ebrei, dentro un quadro ideale che implicava una interpretazione spirituale della riedificazione del Tabernacolo di Gerusalemme e del ristabilimento del Regno di Dio. I giudei — sosteneva tra l’altro Pujati — fra tutti i popoli del mondo sono da Dio singolarmente benedetti nella loro radice; ... essi... sono già da tanti secoli prodigiosamente conservati, secondo i disegni profondi di misericordia che veglia di continuo sopra di loro in particolar guisa; perché, siccome l’incredulità de’ lor antenati deicidi il luogo diede alla vocazione di noi gentili, così la incredulità nostra vicendevolmen-
te... cederà il luogo al richiamo loro?0. E, sempre negli anni napoleonici, si possono ricordare le pagine percorse da comprensione umana e da simpatia per gli ebrei del patrizio comasco Giambattista Giovio che, pur tra le concessioni a moduli tradizionali (decadenza degli ebrei come risultato della «punizione profetata», dottrine «ridevoli» dei rabbini, vanità dell’attesa del Messia), lamentava la durezza e la crudeltà con cui spesso «quegli infelici» erano trattati dai cristiani, tanto più ingiuste in quanto proprio Cristo si era sacrificato per tutti gli uomini?!. La manifestazione dei sentimenti e delle opinioni favorevoli alla causa dell’emancipazione ebraica da parte degli intellettuali di orientamento liberale e nazionale — che, come si è detto, cominciò ad avere le sue espressioni più concrete nel periodo intorno al 1830 — trovò ovviamente un ostacolo difficile da superare nei severi vincoli della censura laica ed ecclesiastica dei vari Stati italiani e nei loro apparati repressivi. E sarà sufficiente ricordare a questo riguardo l’episodio che nel 1827 ebbe come protagonista a Bologna Giovanni Vicini, un uomo formatosi nelle esperienze degli anni napoleonici e 19. C. Formentini, Tributo alla verità nella soluzione del dubbio se la nazione ebrea sia suscettibile di per sé sola d’un perpetuo civile risorgimento, Venezia, 1807, passim (e specie pp. 34 e 40). 20. La questione ebraica in un secolo di cultura italiana, cit., pp. 18 sgg. 21. G. Giovio, Sublimità e decadenza degli ebrei somma,
s.n.t., 1808, passim.
82
inesplicabile. Memoria
inedita,
che durante la rivoluzione del 1831 sarebbe stato presidente del Governo delle province unite dell’Italia centrale. Intervenendo nella questione — solo apparentemente giuridica — prima richiamata a proposito di Berni degli Antonj, Vicini in un suo Voto di verità non soltanto aveva sostenuto che i fratelli ebrei avevano diritto di concorrere in parti eguali insieme a quelli cristiani all'eredità del fratello fattosi cristiano e morto intestato (e questo perché a suo avviso le leggi dello Stato pontificio davano agli ebrei gli stessi diritti civili degli altri cittadini), ma aveva anche biasimato come «orrenda sanguino-
sa diatriba contro gli ebrei» una predica recentemente tenuta in S. Petronio da quel Jabalot le cui idee ci sono già note. Perché mai, — ci si chiedeva nel Voto — mentre noi tutti abbiamo sott'occhio il Codice di Giustiniano, havvi per avventura un qualche oratore, che non ponga ogni suo studio nel divino Codice del Vangelo? Che là non troverebbe né le funi, né li ceppi, né le atroci invettive ma solo vedrebbe un re mansueto starsi fra le turbe specialmente degli ebrei, e dispiegare con dolci parole e con semplici parabole la nuova dottrina, e non impugnare mai il flagello, che per discacciare fuori del Tempio gli indegni profanatori??. Ma la reazione delle autorità pontificie non si fece attendere, e l'intervento
di Vicini gli costò una pena pecuniaria e un periodo di clausura in un convento. Proprio alla relativa mitezza della censura del Granducato di Toscana si deve invece la presenza nelle pagine della fiorentina Antologia di aperture ispirate a comprensione per gli ebrei. Così nel 1828 un anonimo collaboratore della rivista, nel parlare delle Pie Case d’industria e ricovero degli israeliti aperte a Mantova, faceva carico ai retrogradi ignoranti, superstiziosi e «detrattori» della specie umana delle sofferenze sopportate dagli ebrei, il miglioramento della cui condizione veniva posto nella larghezza delle leggi, che avrebbero dovuto ispirarsi a «più miti sentimenti» e «più sani principj»23. E poco più tardi l’esule meridionale Gabriele Pepe invitava i lettori del periodico a guardare con ammirazione «la prole d’ Abramo» come quella che, nonostante una «ecumenica interdizione», si era radicata nelle istituzio-
ni patrie, benché priva di patria, testimonianza di «immensa gagliardia» di quelle istituzioni?4, Ma nei primi due decenni della Restaurazione gli ebrei non furono soltanto oggetto di misure legislative o amministrative da parte dei governi o proble22. Citato in Gioacchino Vicini, Giovanni Vicini, Bologna, 1897, p. 191. 23. Considerazioni sulla morale della storia. Case pie israelitiche di Mantova, in «Antolo-
gia», Firenze, ottobre 1828, pp. 26 sgg. (L'articolo è siglato Th., ed è forse dell’allora giovanissimo Pietro Thouar).
24. «Antologia», gennaio 1830, pp. 101-102.
83
ma di discussione per teologi, giuristi, economisti; essi infatti si inserirono, con alcune avanguardie politicizzate, nel movimento risorgimentale, dando il loro contributo al lavoro cospirativo delle organizzazioni che lottavano contro i regimi dispotici: dalla Carboneria ai Veri Italiani alla Giovine Italia (e basti ricordare i modenesi fratelli Usiglio, stretti collaboratori di Mazzini). E a tale
proposito vale la pena di riprodurre integralmente uno sconosciuto foglio volante a stampa diffuso clandestinamente negli Stati sardi all’inizio del 1831, nel quale gli ebrei italiani erano invitati a sollevarsi e a combattere per la causa dell’Italia «una», perché il Risorgimento italiano era intimamente collegato a quello degli ebrei e l’Italia libera sarebbe potuta divenire anche la patria degli ebrei: Israeliti italiani! E giunto il tempo, in cui l’Italiano s'alza a riprendere la sua dignità perduta. Un sì dolce momento, chi deve sospirarlo più di noi li quali fummo e siamo ancora la vittima del dispotismo collegato coi pregiudizj, col fanatismo e coll’intolleranza? Doppie catene ci aggravano e chi le può spezzare, se non il braccio della libertà? Guardate i nostri correligionarj di Francia, quelli di Polonia. Essi sono uomini. Ma chi li rese degni del bel onore? Un braccio intrepido, un cuore disinteressato, che oprarono per la Patria. No che gli Israeliti d’Italia non sono da meno da quelli degli altri paesi: quel fuoco che scalda gli altri Italiani, scalda pure il nostro petto, ché l’Italia è nostra Patria e non già la sterile Palestina. Non pugneremo noi dunque? Non allargheremo la mano a doni in questo momento sì necessari? Alziamoci, pugniamo, adopriamoci; l’Italia sarà libera, e con Lei sarà libero ogni Italiano.
Viva la Patria! Viva l’Italia una e indivisibile!?5. Nella vicenda che si sta qui ripercorrendo un momento di scansione può essere costituito dal 1835, perché in quell’anno vennero elaborati, da uomini
di assai diverso orientamento ideale e politico e di varia formazione culturale e intellettuale, tre scritti che prendevano posizione per la totale abolizione delle interdizioni e la più completa equiparazione civile, economica e politica degli ebrei; e questo con una vastità di argomenti e una ricchezza di analisi cui poco avrebbero aggiunto gli interventi degli anni successivi, fino al 1848. Di questi difensori della causa ebraica due sono dei protagonisti di parte democratica del risorgimento, Mazzini e Cattaneo, i quali furono entrambi stimolati a manifestare le loro opinioni da un episodio contingente, la controversia tra il governo francese e il cantone svizzero di Basilea campagna circa l’acquisto fatto dai fratelli Wahl, ebrei cittadini francesi, di una proprietà fondiaria in quel cantone (acquisto regolare in base agli accordi tra Francia e Confederazione, ma annullato dal governo di Basilea campagna le cui leggi avevano interdetto il possesso fondiario agli ebrei). Assai meno noto è invece 25. Un esemplare dello stampato è in mio possesso.
84
l’autore del terzo scritto, Luigi Maffoni, un avvocato liberale di Saluzzo che aveva appunto redatto sullo scorcio del 1835 delle Considerazioni politico-legali circa la depressione, e segregazione degli ebrei; opuscolo che per le pressioni delle autorità piemontesi non potè per allora essere pubblicato né negli Stati sardi, né a Milano, né presso la Tipografia Elvetica di Capolago, e riuscì a vedere la luce soltanto alla fine del 1847 con il nuovo titolo Origine delle interdizioni civili israelitiche e dannosi effetti dalle medesime derivanti. La pagine di Maffoni, tenendo conto del momento in cui vennero redatte e quindi delle cautele adottate dall’autore per cercar di ottenerne la stampa, appaiono coraggiose e avanzate, perché l’avvocato piemontese — in implicita polemica con lo scritto di Gambini sulla Cittadinanza giudaica — rigettava sulle «leggi repressive» la responsabilità dei difetti e dei torti — assai più presunti che reali - comunemente attribuiti agli ebrei (intolleranza; avversione all’agricoltura e alla milizia; dedizione ai traffici mercantili e alle usure; man-
canza di umanità verso i non correligionari; estraneità nei confronti dello Stato ospitante). Così pure era respinto qualsiasi addebito agli israeliti che avesse chiamato in causa la religione ebraica; ché anzi Maffoni, appoggiandosi all’autorità di G.B. De Rossi, presentava sotto una luce estremamente favorevole il Talmud e le dottrine dei moderni rabbini, predicatori di amore tra tutti gli uomini (e a tal fine venivano utilizzati scritti e prediche di Lelio Cantoni,
Lelio Della Torre e altri israeliti italiani e il testo Figli di Sion, un libro d'istruzione morale e religiosa per gli israeliti del Lombardo-Veneto). Così pure Maffoni giudicava assurda la preoccupazione che la fine delle interdizioni potesse accrescere a dismisura il numero degli ebrei, respingeva come erronea la tesi della «accumulazione
delle ricchezze» fra gli israeliti, conte-
stava la mancanza di amore degli ebrei per la terra che li accoglieva ed esemplificava con un’ampia messe di dati (relativi a Livorno, Mantova, Verona, Padova, Firenze, ecc.) la liberalità degli ebrei verso istituzioni benefiche cri-
stiane. La segregazione e le interdizioni, quindi, non solo erano contrarie ai principî cristiani, ma danneggiavano lo stesso interesse dello Stato, alienandogli una minoranza di potenziali sudditi e cittadini fedeli: di qui l'epilogo della necessità di una emancipazione, di una libertà assolute, che dessero il diritto
di salire a tutte le cariche amministrative e politiche come avveniva in Francia, e non di una libertà soltanto civile, come quella stabilita nell’impero d’Austria, che escludeva gli israeliti da una serie di impieghi e funzioni pubblici?9. Quanto a Mazzini, il fondatore della Giovine Europa in due articoli apparsi sulla Jeune Suisse del novembre 1835 liquidava sdegnosamente quel tipo di 26. Torino, 1847, passim. Per le vicende dello scritto cfr. i documenti in Archivio di Stato di Torino, Gabinetto di Polizia, Cuneo, 1836, cart. 2 (dove sono anche le bozze dei primi due
fogli di stampa della tentata edizione del 1836 e una copia del manoscritto).
85
motivazioni che pretendevano di giustificare le interdizioni con le «abitudini di cupidigia, d’incetta» attribuite agli ebrei, inclinazioni che quand’anche fossero state reali provavano soltanto le cattive conseguenze provocate dall’ineguaglianza («è lo stesso errore che fa negare la libertà ai popoli, sol perché essi lasciano scorgere le abitudini di schiavitù»). Il rivoluzionario genovese, coerentemente alla sua tipica maniera di impostare i problemi politici mettendo in primo piano le grandi idee, i principî generali, i valori assoluti, parlava appunto in nome della libertà, della tolleranza, della causa progressiva della civiltà, anche se nella contingenza specifica questi valori erano occasionalmente sostenuti da un governo illiberale come quello di Luigi Filippo: Ma ciò di cui sentiamo il bisogno, ... è di alzare anche la nostra voce contro un’ec-
cezione tanto ingiusta quanto retrograda, qual è quella con cui si perseguitano ancor oggi i seguaci della legge di Mosè; di protestare, in nome del progresso e delle nostre sante credenze umanitarie, contro ogni legge eccezionale, che viola il gran principio di tolleranza, assimilando, col fatto, una credenza religiosa a un delitto, o ad un
errore di cui colui che se ne trova colpevole deve sopportare le tristi conseguenze. La nostra è un’epoca di emancipazione, di riabilitazione universale. Ogni atto, ogni disposizione
che statuisca un’esclusione,
un’interdizione,
una
separazione
assoluta,
dalla società europea, contro un’intera classe d’uomini, per ciò solo che fanno fede della loro credenza in Dio e nella sua onnipotenza in una maniera determinata, è arretrata di non so quanti secoli: risale alle due nature degli antichi: è un’applicazione del principio che ha fatto tutte le aristocrazie??.
Assai più organico, meditato e articolato della pur incisiva polemica giornalistica di Mazzini si presenta il pressoché contemporaneo studio di Cattaneo il quale — ispirandosi anch’egli al principio di tolleranza e altrettanto deciso nel sostenere la tesi della piena equiparazione degli ebrei — sviluppava la sua argomentazione in una chiave essenzialmente economica, che mirava a dimostrare non soltanto l’iniquità ma anche la dannosità delle interdizioni. Per il lombardo dovere essenziale del «pubblicista» era infatti quello di avvalorare le dottrine del diritto con quelle dell'economia; dalla congiunzione delle due scienze sarebbe derivato il trionfo della sana morale, perché «l’equilibrio degli interessi produce l’equilibrio delle passioni», per cui il mezzo più diretto e sicuro per modificare i costumi di «una stirpe d’uomini» era la riforma del loro «stato economico», dal momento che «gli uomini cedono più docilmente i loro interessi che le loro opinioni»?8. 27. G. Mazzini, Différend entre Bàle-campagne et la France, in «La Jeune Suisse», 4 e 11 novembre 1835 (e in G. Mazzini, SEI, 6°, pp. 401 sgg.). 28. C. Cattaneo, Ricerche sulle interdizioni imposte dalla legge civile agli israeliti, in C. Cattaneo, Scritti economici, a cura di A. Bertolino, vol. 1°, Firenze, 1956, pp. 313-315 e 337. (Lo scritto apparve per la prima volta negli «Annali di giurisprudenza pratica», Milano, 1836, VOR2Sm)i
86
Il nucleo centrale del ragionamento cattaneano poggiava sulla considerazione che l’agricoltura, a parità di capitali investiti, dava un reddito molto inferiore a quello ricavabile dalle intraprese commerciali, finanziarie o usurarie, anche perché la proprietà fondiaria non permetteva una divisione del lavoro spinta al di là di un certo limite, stimolava il lusso (e «la pompa è la lima della opulenza») e non poteva sottrarsi alle tasse e alle spese militari (mentre «i capitali volanti, non impiombati al suolo come le ricchezze prediali, fuggono davanti agli eserciti, o li seguono alle spalle per ingrassarsi nei magazzini e negli ospitali»). Quindi la proibizione della possidenza non solo impediva l'afflusso nell’agricoltura di capitali utili per elevare il suo livello tecnico e produttivo, ma spingendo gli ebrei verso il commercio provocava effetti contrari a quelli sperati dai fautori delle restrizioni, vale a dire l’«opulenza» e l'arricchimento sempre crescenti degli israeliti. E conseguenze dello stesso tipo generavano le altre interdizioni: quella dal libero e socievole «consorzio», radice dello «spirito di secreto» e della «fidatezza» degli ebrei divenuti proverbiali, componente essenziale delle transazioni commerciali e condizione della diffusione della cambiale (e gli italiani e gli ebrei, i quali avevano adottato in tempi bui il «mirabile ripiego» di quel titolo di credito, erano paragonati a «uno stuolo di giganti che giocasse alla palla in mezzo a una generazione di nani, i quali vedessero la palla balzare per di sopra il loro capo da un punto all’altro dell’orizzonte, senza poterla raggiungere»); quella dagli studi letterari e cavallereschi, anch’essa rivelatasi «fomento» alla ricchezza degli interdetti, indotti a «rivolger monete» e non libri; quella infine dalla libera abitazione che, costringendo gli ebrei a vivere nei ghetti, li aveva preservati dal dispendioso «mal della pietra». Nello svolgere il filo del suo discorso Cattaneo respingeva altresì con grande decisione il razzismo circolante nelle opinioni che attribuivano fissità di comportamento e di caratteri fisici e morali ai singoli popoli; e polemizzava quindi con gli «scrittori oltremontani» che avevano accusato i popoli meridionali di «fisica degenerazione... da emendarsi con un crocicchio di razze» (aggiungendo sprezzantemente che «costoro avevano genio di scrivere l’istoria dei cavalli e dei cani») e con quanti sostenevano l’opinione popolare che gli ebrei si distinguessero razzialmente per avidità di guadagno, astuzia e insensibilità («l’arte usuraia non è un affare di sangue ma di educazione e di posizione; e gli ebrei sono capaci d’altri generi di bene e d’altri generi di male»). Considerazioni di ordine economico oltre che di ordine morale avrebbero perciò dovuto spingere legislatori e governi a realizzare il «generale pareggiamento degli israeliti», come avevano già fatto Francia e Inghilterra, senza porsi l’obiettivo della distruzione o dell’assimilazione del «giudaismo», ma seguen-
do unicamente la voce della tolleranza e dell'umanità: «Dacché dunque una potenza prevalente ha disposto che il genere umano, vita nostra durante, appar87
tenga a diverse credenze: cerchiamo almeno di comporci in modo che questo dissidio perturbi men che si possa quella pace che per noi può godersi»??. Dopo il 1835 la discussione sulla questione della parificazione degli ebrei non offre testimonianze significative fino al 1843, quando in Italia si aprì la nuova stagione politica del neoguelfismo e del moderatismo liberale, che miravano a una soluzione del Risorgimento incentrata sull’accordo fra principi e popoli, da realizzare attraverso una illuminata attività riformatrice dei primi e la rinuncia dei secondi al metodo insurrezionale. Questa fase del moto nazionale è strettamente legata al nome di Vincenzo Gioberti; e proprio nel suo Primato il filosofo torinese, tra le lodi di circo-
stanza elargite ai governi italiani per la tolleranza che a suo avviso mostravano nei confronti delle minoranze religiose, esprimeva l’augurio che fosse vicino il giorno in cui, con il pieno compimento dei voti dell'umanità e della religione, gli israeliti italiani avrebbero potuto essere accomunati agli altri cittadini nel godimento dei diritti civili. Imperocché — scriveva Gioberti — passato è il tempo, in cui sultava quegl’infelici, predicandoli incapaci ed indegni di mentre una bieca teologia... voleva punire in essi la colpa che nelle cose toccanti alla religione sia lecito ai Cristiani il na giustizia, invece d’imitare quella misericordia, che mosse donare, morendo, e a pregare pe’ suoi percussori.
una brutale filosofia ingodere i beni comuni, dei loro antenati; quasi farsi ministri della diviil nostro modello a per-
Il teorico del neoguelfismo — che per motivi di cautela non faceva in quel momento parola dei diritti politici — ricorreva dunque a una argomentazione di ordine religioso, la carità cristiana; e, collegando il tema dell’emancipazione a quello della conversione (ma il nesso appare strumentale), soggiungeva che il metodo caritativo proprio del Cristianesimo sarebbe alla lunga risultato «il modo più efficace per ricondurre all’ovile lo smarrito Israele»30. Dopo l’apparizione del Primato l’orientamento favorevole alla parificazione largamente prevalente nell’opinione pubblica liberale potè manifestarsi vivace e articolato attraverso la stampa nella seconda metà del 1847 e nelle prime settimane del 1848, grazie ai larghi varchi apertisi nelle maglie della censura3!,
29. Ibidem, passim.
30. V. Gioberti, Del primato morale e civile degli italiani, a cura di U. Redanò, vol. 1°, Milano, 1938, pp. 259-260. 31. Tra la pubblicazione del Primato e il 1847 il solo documento di qualche rilievo che in-
teressi la questione dell’emancipazione è la prefazione di Aurelio Bianchi Giovini alla sua Storia degli ebrei e delle loro sette e dottrine religiose dal ritorno di Babilonia sino al presente (Milano, 1844-1845). Il pubblicista comasco, dopo aver manifestato la sua ammirazione verso
gli ebrei per essere riusciti a mantenere l’unità religiosa nonostante «tante persecuzioni» e do-
88
Consentaneo ai tempi appariva in alcuni di questi scritti l’esplicito inserimento dell’emancipazione degli ebrei nel più generale problema dell’emancipazione italiana. Inserimento che veniva volta a volta motivato o con il richiamo alle alte ragioni ideali, come l’essenza unitaria della giustizia, cui si
appellava Massimo d’ Azeglio nel più noto dei testi emancipazionisti di quella stagione, là dove notava: «La causa della rigenerazione israelitica è strettamente unita con quella della rigenerazione italiana; perché la giustizia è una sola, ed è la medesima per tutti; ed è forte ed invincibile soltanto quando è imparzialmente domandata a chi ci sta sopra ed è più potente di noi, come imparzialmente fatta a chi si trova nella nostra dipendenza»3?; oppure con il superiore interesse dello Stato perché, sosteneva il toscano Giovanni Battista Giorgini, «la più solida garanzia dell’ordine sociale sta nella sua piena ed unanime accettazione da parte di tutti i membri del civile consorzio; e tale accettazione non potrebbe essere unanime e sincera quando gli oneri ed i vantaggi sociali non fossero egualmente distribuiti fra tutti i cittadini»33; considerazione che si ritrova in un opuscolo del piemontese Giovanni Tournon, che alla fine del 1847 insisteva sulla necessità dell’unione del principe con il popolo, la quale sarebbe rimasta imperfetta finché gli ebrei fossero stati considerati alla stregua di iloti, di sudditi degradati e indegni dei pubblici uffici34. Ma soprattutto ricorrevano frequenti nella letteratura emancipazionista i riferimenti ai principî generali: la «ragione»35; i «dettami imprescrittibili» della natura e della morale, che postulavano l’eguaglianza di tutti gli esseri umani al cospetto di Dio36; la fratellanza umana, che veniva invocata da un
uomo del ‘31 reduce dall’esilio, Tommaso Zauli Sajani, in un discorso a un «pranzo popolare» di affratellamento con gli ebrei romani del luglio 184737; o di nuovo la «ragione» congiunta all’utile civile, cui si appellavano gli anonimi discorsi pronunciati nel febbraio 1848 da un religioso «assai conosciuto in Bologna, e nella Toscana»38. E vi era anche chi, come il ferpo aver elogiato la loro «indole dolce, industriosa e tranquilla», si augurava — richiamandosi alle posizioni di Cattaneo e alla legislazione dell’ Austria e della Francia — una maggiore «giustizia» dei governi nei confronti degli israeliti, che a loro volta venivano invitati ad assimilarsi nella società in cui vivevano rinunciando al «particolarismo». 32. D'Azeglio, Dell’emancipazione..., cit., p. 56. (Lo scritto fu redatto alla fine del 1847).
33. Gli interventi di Giorgini (che, come M. d’ Azeglio, era genero di Manzoni) apparvero nell’«Italia» di Pisa del 24 luglio e 21 agosto 1847 (sono riprodotti, con il titolo Sulla emancipazione degli ebrei, in «R.m.I.», settembre 1933, pp. 204 sgg.). 34. G. Tournon, Dell’emancipazione delle credenze religiose, Torino, 1847, p. 14.
35. Giorgini, Sulla emancipazione degli ebrei, cit., p. 206. 36. Tournon, Dell'emancipazione..., cit., pp. 6-7.
37. T. Zauli Sajani, Discorso detto al pranzo popolare diretto da Ciceruacchio nella campagna di Tor di Quinto, Livorno, 1847. 38. Degli israeliti nei dominii della Chiesa..., cit., pp. 25 e 5.
89
rarese Luigi Borsari, affrontava la questione dell’abolizione delle interdizioni sotto un profilo giuridico, con il proposito dichiarato di integrare il ragionamento di M. d’Azeglio; rifacendosi alle polemiche bolognesi del 1827 sulla capacità degli ebrei di succedere al congiunto cristiano morto intestato Borsari intendeva infatti dimostrare che la condizione degradata degli israeliti pontifici era illegale, perché «la legge stessa che poneva quel popolo al bando di ogni prerogativa morale e civile... riconosceva in lui la qualità e i diritti di cittadino e di suddito» e che quindi Pio IX, assecondando il mutato spirito dei tempi, avrebbe dovuto ristabilire la legalità nei suoi domini temporali accomunando israeliti e cattolici nel godimento dei pieni diritti civili e politici39. Né poteva essere assente nelle prese di posizione dei cattolici liberali, rese pubbliche in una fase in cui il mito di Pio IX non era ancora in crisi e la prospettiva neoguelfa pareva conservare la sua validità, l'insistenza sul nesso tra l'emancipazione e l’essenza intima del vero cristianesimo, la carità evangelica. Così per Raffaello Lambruschini l’equiparazione degli ebrei ai cattolici, imposta dalla «legge eterna del Vangelo», costituiva il «vero trionfo del Cristianesimo»49; e ai principî dell’amore e della fratellanza cristiani si rifaceva Roberto d’Azeglio nella supplica indirizzata a Carlo Alberto il 23 dicembre 1847 «a pro degli infelici fratelli per cui durano ancora inesorabili i rigori e le interdizioni a cui dannavali la barbarie della trascorsa età, per la deplorevole inosservanza in cui rimase sino a questo giorno il più sublime fra i precetti che la carità di Dio impose all’umana famiglia»4!. Anche i discorsi dell’anonimo religioso già ricordati, dopo aver analizzato le Sacre scritture per dimostrare che in esse non si poteva rinvenire niente che approvasse o consigliasse «vessazioni speciali di sorta alcuna sopra l’infelice progenie ebraica», si appoggiavano alla tradizione ecclesiastica per sostenere che in essa era comandata la «carità generosa» e condannata «quella specie di schiavitù che opprime gl’israeliti nello Stato papale»4; mentre a sua volta un altro sacerdote, Ambrogio Ambrosoli, in una predica tenuta a Roma il 26 marzo 1848 e subito stampata dal Labaro (un foglio della capitale pontificia di tendenza neo-
39. L. Borsari, Una quistione israelitica, Ferrara, 1848, p. 5 e passim. 40. Cfr. gli articoli sulla questione dell’emancipazione in R. Lambruschini, Scritti politici e di istruzione pubblica, raccolti e illustrati da A. Gambaro, Firenze, 1937, pp. 98 e 105. (Questi scritti apparvero per la prima volta nel giornale «La Patria» di Firenze, 22 settembre, 12 ottobre e 22 novembre
41. liti in caèa 42.
1847).
Cfr. A.M. Ghisalberti, Massimo e Roberto d’Azeglio per l'emancipazione degli israePiemonte, in «R.m.I.», agosto-settembre 1979, pp. 289 sgg. (la citazione dalla supplip. 297). Degli israeliti nei dominii della Chiesa..., cit., pp. 53-55.
90
guelfa) chiedeva la simbolo di perdono Ma era in Nicolò totale equiparazione
parificazione degli ebrei in nome della Croce di Cristo, e non di vendetta#3, Tommaseo che la perorazione del diritto degli israeliti alla si accendeva di una simpatia e di una partecipazione in-
condizionate che facevano vibrare di toni commossi la sua prosa. Il dalmata, in
uno scritto del gennaio 1848 di cui la censura austriaca impedì la pubblicazione, dichiarava infatti che a Israele erano state affidate «le più sincere primigenie tradizioni del genere umano», e che quella piccola nazione aveva dato vita nel corso della sua storia a molte istituzioni salutari che il mondo moderno avrebbe potuto far sue e la cui eccellenza si fondava su quell’intreccio di poesia e religione e di religione e civiltà che Tommaseo considerava tipico del popolo ebraico. E proprio alla fedeltà tradizionale alle loro antiche istituzioni gli ebrei dovevano la propria conservazione, «perché la tradizione è condizione della vita dei popoli, così come la memoria è condizione della umana coscienza»44. Ragione, tolleranza, giustizia, carità, fratellanza erano tutti valori sinceramente sentiti dai sostenitori dell’emancipazione, laici o religiosi che fossero,
anche se questa sincerità di convinzioni non escludeva, in quanti intendevano pur sempre rifarsi agli insegnamenti della Chiesa cattolica, la persuasione della superiorità del cristianesimo rispetto al «giudaismo», cui si accompagnava la speranza che la fine delle interdizioni potesse in ultima analisi favorire le conversioni al cattolicesimo. Così per Giorgini se la persecuzione aveva spinto il giudaismo a resistere all’azione unificatrice del cristianesimo e a riaffermare la sua separatezza, l’equiparazione civile e politica avrebbe invece facilitato l’integrazione degli ebrei e il loro graduale assorbimento «nel seno della religione dominante»*5. E sulla stessa linea si poneva Raffaello Lambruschini in una replica a Salvatore Anau, un ebreo di Ferrara il quale aveva
sostenuto la sufficienza dei soli principî ricavati «idealmente» dalla ragione a rendere l’uomo buono e socievole; per il «solitario di San Cerbone» i principî ideali invece non bastavano, ed essi andavano quindi fortificati e ampliati con la «rivelazione» del Vecchio e soprattutto del Nuovo Testamento, le cui
verità si augurava attirassero a sé da allora in avanti «gli sguardi del popolo israelitico» emancipato”. 43. Gl’israeliti in Roma.
Parole dette nella basilica di S. Maria in Trastevere nel dì 26
marzo, Roma, 1848, pp. 7-8.
44. N. Tommaseo, Diritti degli israeliti alla civile eguaglianza. Discorso, in «R.m.I.», agosto-settembre 1935, pp. 163 sgg. (Il discorso fu pubblicato dal «Telegrafo della sera» di Trieste del 25 novembre 1848). V. anche A. Ottolenghi, L’azione di Tommaseo a Venezia per l’emancipazione civile degli israeliti, Venezia, 1933. 45. Giorgini, Sulla emancipazione degli ebrei, cit., p. 211. 46. Lettera del 14 luglio 1847, in «La Patria», Firenze, 10 ottobre 1847. 47. «La Patria», Firenze, 12 ottobre 1847 (riprodotta in Lambruschini, Scritti politici..., cit.,
pp. 101 sgg.).
9]
Ma mentre nei rappresentanti di un cattolicesimo liberale aperto, tollerante e impegnato con determinazione nel movimento nazionale quale era quello di un Lambruschini, di un Giorgini o di un Tommaseo la fede religiosa che li portava ad affermare il primato del cattolicesimo non impacciava il riconoscimento
della necessità di una parificazione incondizionata,
in altri cattolici,
che pure si collocavano nell’ambito del neoguelfismo, la religione finiva con il costituire una remora all'affermazione di una equiparazione generale e generalizzata di ebrei e cattolici. Che era quanto accadeva ad Antonio Rosmini il quale in una lettera intorno alla questione ebraica, riprendendo argomentazioni della sua Filosofia del diritto, riconosceva che un governo che avesse
tolto agli ebrei o agli appartenenti ad altre minoranze religiose 1 «diritti privati comuni» operava contro i suvi fini istituzionali, ma per soggiungere subito dopo che diversamente stavano le cose in fatto di diritti politici, «essendo convenevole, che quelli che, attesa l’indole della loro religione, non sono ido-
nei a certe cariche pubbliche, ne rimangano esclusi»48. Tra questi fautori di una parificazione dimidiata dagli scrupoli religiosi va inserito il canonico casalese Giuseppe Gatti, che nel corso del 1848 sostenne nel suo periodico «Fede e patria» il programma giobertiano di armonizzazione tra cattolicesimo e «progresso civile». Il religioso, autore di un trattatello sulla «rigenerazione politica» degli ebrei italiani redatto poco prima della concessione dello Statuto albertino, si distingueva infatti nella pubblicistica emancipazionista per una prospettiva gradualista, fondata sul convincimento che la «generalità israelitica» non fosse ancora pienamente preparata per la «redenzione civile»; il che lo induceva a dire che bisognava «ricorrere prima a quelle concessioni parziali, che concorrono a formare l'educazione del popolo iniziando a’ dritti di cittadinanza». Sì dunque all’abolizione dei ghetti e all'ammissione degli ebrei a tutte le attività economiche, alla proprietà fondiaria, alla milizia, a tutti i gradi dell’istruzione e all’insegnamento; ma no all'esercizio del notariato («cautela... consigliata o dal timore di certe formole capziose ne’ testamenti per fornire all’avvocato correligionario il boccone d’una pingue lite, o di certi dolosi istrumenti per cuoprire le male arti degli usurai e truffatori della sua comunione») e all’insegnamento della «filosofia razionale» (per i suoi legami con la teologia dogmatica e morale) e delle letterature italiana e moderna (e questo perché molti capolavori di quelle — dalla Divina Commedia ai Lusiadi alla Messiade — avevano strette implicazioni con la teologia cristiana). E soprattutto niente accesso alle alte cariche: Quanto agli altri pubblici offizi — questo il punto di vista di Gatti — non disdirebbero punto all’israelita i più bassi offizi, finanzieri, amministrativi, edilizi e fors’anco giu-
48. La lettera (della fine del ’47 o dell’inizio del ‘48) apparve in appendice a Degli israeliti nei dominii della Chiesa..., cit., pp. 158-160.
92
diziari, come né pur male gli starebbe un seggio ne’ consigli municipali. Dico più bassi, perocché gli alti offizi, massime amministrativi e giudiziari, gli sconverrebbero, sia perché lo merrebbero [sic] talora a diffinire in materie ecclesiastiche, od anche sul conto di persone ecclesiastiche immischiate in opere pie o cause civili. E certo non parrebbe decoroso che i pastori, massime primari, dovessero accettare la legge
da un infedele9.
All’interno di un'impostazione nella quale la tendenza emancipazionistica appariva condizionata dalla preoccupazione confessionale anche i riferimenti al tema della «conversione» risultavano più rozzi e scoperti rispetto a quelli sfumati di Lambruschini e Giorgini50; mentre, in un’appendice stesa dopo la promulgazione dello Statuto, Gatti invitava esplicitamente gli ebrei a starsi paghi dell’abolizione delle interdizioni civili e a non chiedere la fine delle discriminazioni religiose, giudicata «pretesa indiscreta e non comportabile» soprattutto in Italia, paese in cui doveva durar costante «la nota caratteristica di cattolicità insieme alla prevalenza del culto cattolico»5!. Certamente la posizione di Gatti può apparire timida e ambigua, come quella che con le sue distinzioni lasciava aperti varchi pericolosi alla pratica dell’intolleranza. Ma non va neppure sottovalutato il significato di rottura che uno scritto come quello del casalese finiva per assumere all’interno dell’ambiente del clero cattolico piemontese, sostanzialmente retrivo e ancora atteg-
giato nelle sue alte gerarchie a ostilità nei confronti dell’emancipazione, come dimostra la protesta contro la parificazionne inviata dall’episcopato a Carlo Alberto alla fine del gennaio 184852. Degli orientamenti dominanti in ampi settori del clero piemontese è documento significativo uno scritto sul «giudaismo» del sacerdote Giuseppe Maria Bertetti venuto alla luce intorno al febbraio 1848. Per Bertetti, che attingeva a piene mani ai più vieti e logori pregiudizi antiebraici (dal deicidio alla scarsa «mondezza» della persona, dall’usura all’orgoglio nazionale), con un riallacciamento ideale al filone Sessa-Gambini, era in sommo grado allarmante la minaccia di «giudeizzazione» che l’emancipazione avrebbe a suo parere reso presto incombente sul Piemonte. Nella visionaria previsione del religioso gli ebrei, una volta parificati legalmente ai cristiani, si sarebbero infatti impadroniti del suolo e dell’amministrazione del paese «schiantandone la classe cristiana ed indigena»; mentre la libertà del culto avrebbe promosso 49. G. Gatti, La rigenerazione politica degli israeliti in Italia. Discorso religioso, pedagogico e sociale, Casale, 1848, pp. 64-71 e passim. (Sul Gatti v. G. Manacorda, L’abate Giuseppe Gatti, dantista, e le sue relazioni col Rosmini, in «Rassegna nazionale», 1° marzo 1913, pp. 61 sgg.). 50. Gatti, La rigenerazione politica..., cit., p. 85, e inoltre pp. 23 e 25. 51. Ibidem, pp. 92-93. 52. Ghisalberti, Massimo e Roberto d’Azeglio..., cit., pp. 322 sg8g.
93
il proselitismo e la «dommatizzazione» degli israeliti tra i cristiani mettendo così in pericolo l’identità religiosa degli Stati sabaudi. Per allontanare questi rischi occorreva perciò negare i diritti politici agli ebrei, interdire loro la proprietà fondiaria ed escluderli dai gradi accademici «superiori al magistero di filosofia, almeno per ciò che riguarda gli studi legali, i medico-chirurgici, e
loro attinenti»53.
|
A rendere ancora difficile e tribolata la strada della seconda affrancazione contribuivano poi le resistenze e le diffidenze dei governi e delle autorità periferiche, testimoniate tra l’altro dalla riluttanza con cui in alcuni centri dello Stato pontificio, come
Ferrara e Ancona,
si procedette ad ammettere
nella
Guardia civica gli ebrei, sebbene il decreto della sua istituzione non facesse
questione di confessione religiosa>4. All’ostilità degli ambienti clericali e alle sospettose esitazioni dei governi si aggiungevano anche gli inveterati pregiudizi radicatisi in strati più o meno larghi dei ceti popolari dei centri in cui esistevano ghetti o comunità ebraiche, pregiudizi che in alcuni casi vennero stimolati proprio dalle misure di
53. G.M. Bertetti, De/ giudaismo considerato nelle sue dottrine, nella sua storia, e nelle conseguenze della sua emancipazione, Torino, 1848, passim. Cfr. anche la Risposta di alcuni israeliti allo stesso Bertetti (Torino, 1848). 54. Sull’ammissione degli ebrei alla Guardia civica come concessione che avrebbe dovuto preludere alla loro emancipazione prendeva posizione favorevolmente il canonico Luigi Crescioli sull’«Italiano» di Bologna del 31 agosto 1847 (Un prete agli israeliti tutti). Nell’articolo Crescioli scriveva: «Quando vi si permetterà coltivare ogni scienza, esercitare ogni professione, quando vi si apriranno onorate carriere, vi si ammetterà ad ogni impiego, eccettuati sol quelli che si collegano colle credenze della religion dominante, voi pareggerete gli altri non solo, ma facilmente gli avanzerete, in virtù dello slancio che vi darà la naturale energia, sempre nuova, eccitata dalla brama di smentire l’ingiuriosa opinione. Si lamentano in voi vizi morali? Colpa del nostro disprezzo. Avvilite l’uomo e l’avrete corrotto. E noi non abbiam vizi? E non ne siamo assai meno scusabili? Eppoi mancano a voi uomini di virtù egregie? No certo. Dell’amor patrio non è difetto fra voi: a molti di voi manca solo una patria: perché la nostra tirannide ha loro interdetto la cittadinanza, ma ne’ loro petti arde l’aspirazione ad averla; e ciò ne garantisce che, ottenutala, l’amor vostro per essa tutto vergine ed intero della natural vigoria, all’uopo farà meraviglie. E mirate non lontano il momento
che il nome
di concittadini, e
con esso l’esercizio de’ relativi diritti, a voi pure legalmente si volgerà: ricognizione dovuta ai diritti naturali, aggravi giuridici che avete verso il paese in cui dimorate». Riconoscenza per l’intervento di Crescioli fu espressa a nome degli ebrei da Abramo Anau in un breve scritto pubblicato dall’ «Italiano» del 20 settembre 1847. Una denuncia delle resistenze all’attuazione dell'ammissione degli ebrei nella Guardia civica degli Stati romani fu fatta, con riferimento a Ferrara, da Leone Carpi in un opuscolo datato 10 novembre 1847 (Alcune parole sugli israeliti in occasione dell’organizzazione della Guardia civica nello Stato pontificio, Torino, 1848, II ediz.). Quanto ad Ancona, cfr. una lettera da quella città apparsa sul «Felsineo» di Bologna del 9 dicembre 1847 in cui si diceva che un’«ignota influenza» tendeva ad escludere dal servizio nei corpi civici gli ebrei, che erano per questo esposti ai «dispregi del volgo».
94
emancipazione. Fenomeno che si verificò a Roma all’inizio del luglio 1847, quando le prime concessioni di Pio IX provocarono il risentimento dei popolani dei quartieri di Regola e Trastevere e i correlativi timori degli abitanti del ghetto, tanto che dovette intervenire lo stesso Ciceruacchio il quale, impegnando tutto il suo prestigio, si fece promotore di una manifestazione di riconciliazione tra ebrei, «regolanti» e trasteverini culminata nello scambio del «bacio di pace»59. E stati d’animo popolari di ostilità verso gli ebrei dovettero essere abbastanza diffusi nel corso del ‘48, come stanno a provare il tumulto antiebraico verificatosi ad Acqui il 23 aprile57, l’ostilità dei contadini di alcune zone del Mantovano all’ammissione degli israeliti nella Guardia civica esplosa apertamente a mezzo il luglio58, e l’attacco al ghetto romano avvenuto verso la fine dell’ottobre59. I fatti e le circostanze qui richiamati contribuiscono a spiegare perché in alcuni degli Stati italiani divenuti da assoluti costituzionali nei primi mesi del 1848 non fu subito realizzata la piena equiparazione tra ebrei e cattolici. A parte Napoli, dove la Costituzione del 19 febbraio non eliminò la discriminazione religiosa (poiché permetteva ai soli cattolici l’esercizio del culto), l'eguaglianza dei diritti civili e politici degli ebrei venne infatti inizialmente 55. Come esempio delle argomentazioni usate dai liberali per combattere i pregiudizi antiebraici diffusi tra i ceti popolari in Toscana cfr. l’opuscoletto Parole al popolo, pubblicato a Pistoia alla fine del 1847 o all’inizio del 1848. 56. Si veda la vivace narrazione dell’episodio fatta nel foglio volante / popolani di Roma e l’università israelitica (s.n.t.), dove si legge: «Una schiera di conciapelli della Regola, guidati da un bravo giovinetto, Luigi Caravaccioli, per antonomasia, il Micoccetta, entrava allegra nel Ghetto. I poveri ebrei spaventati si chiedevano tremando: che sarà? daranno il fuoco? e guardavano senza dir motto. Allora il Micoccetta: allegri, che siam venuti per farvi vedere che vi siamo amici, che vi rispettiamo, e che non diamo retta a chi vi vuol male, e via coll’abbracciarli, e chiamarli coi più cari nomi del mondo. A quel generoso atto gli ebrei lagrimavano di contentezza, e baciavano i popolani, e li ringraziavano pur anco in ginocchio. Frattanto il ceto più elevato della gioventù israelitica... s'era unito a quella moltitudine ed accettava l’invito fattogli dai Regolanti d’andare in quella sera istessa nel loro rione a mangiare il piatto favorito dei conciapelli. Gli ebrei v’andarono, e vi rinvennero il celebre Angelo Brunetti, e molti cittadini, [i] quali secondarono l’incominciato pacificamento». 57. S. Foà, Il ‘48 e gli ebrei di Acqui, in «Vessillo israelitico», 30 aprile 1913, pp. 243 sgg. 58. Scriveva a questo riguardo l’«Eco del Po», un foglio di Casalmaggiore, nel n. del 20 luglio 1848: «[Nei comuni del Mantovano] l’opposizione viva, ostinata, dei contadini specialmente, contro i religionarj israeliti che sono la ricchezza del paese, non si è mostrata mai tanto forte ed evidente come in questi tempi a proposito dell’elezione dei capi della guardia nazionale. Con minacce sorde, con violenti apostrofi si costrinsero gli israeliti a tenersi fuori dai luoghi di convegno, ove facevansi le nomine, e non uno di essi ottenne il grado di uffiziale... Gli ebrei — dicono i contadini — si fanno ricchi col sangue nostro: un po’ per volta ci divorano le nostre piccole proprietà, ci riducono a nudi coltivatori, a bifolchi e peggio». 59. Si vedano le deplorazioni dei giornali romani «La Pallade» (26 ottobre 1848) e «La Speranza» (25 ottobre 1848). Già il 18 aprile la «Pallade» aveva lamentato i sentimenti antiebraici nell’articolo Anche gli israeliti sono cittadini.
95
riconosciuta soltanto dagli statuti del Granducato di Toscana (15 febbraio) e del Ducato di Parma (28 marzo): testi che, sebbene mantenessero alla religione cattolica il ruolo di religione di Stato, attribuivano pienezza di diritti a tutti
i cittadini indipendentemente dal culto professato90. Negli Stati sardi, invece, lo Statuto del 4 marzo — pur sanzionando l’eguaglianza dei regnicoli davanti alla legge — richiamava le «eccezioni determinate dalle leggi», dizione nella quale sarebbero potute rientrare anche le interdizioni o le incapacità relative agli israeliti. Il 29 marzo una sovrana risoluzione riconosceva però agli ebrei la capacità di godere tutti i diritti civili e di conseguire i gradi accademici; il 15 aprile un decreto luogotenenziale li ammetteva alla leva militare; e infine 18 luglio una legge declaratoria toglieva ogni dubbio residuo sulla loro capacità di essere eleggibili e di conseguire cariche e impieghi pubblici stabilendo espressamente che la differenza di culto non formava eccezione «al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari»9!. Quanto agli Stati romani, infine, lo Statuto del 14 marzo negava i diritti politici agli ebrei perché l’articolo 25 stabiliva espressamente che «la professione della religione cattolica» era condizione necessaria per il godimento di quei diritti2, discriminazione che venne sanata soltanto dalla Repubblica romana del 1849. Con gli avvenimenti del 1848 tuttavia si era ormai decisamente imboccata la strada della parificazione completa degli ebrei, che di lì a pochi anni avrebbe avuto il suo definitivo riconoscimento in tutto il territorio nazionale libero con la formazione dello Stato unitario italiano.
60. La concessione della Costituzione da parte di Leopoldo II fu salutata da Abramo Pesaro nel Tempio maggiore israelitico di Ferrara la sera del 21 febbraio 1848. Il Pesaro prendeva lo spunto dallo Statuto toscano per augurare che anche Pio IX si mettesse sulla stessa strada e arrivasse a realizzare la piena parificazione degli ebrei («Il Felsineo», Bologna, 4 marzo 1848). 61. Cfr. I. Rignano, Della uguaglianza civile e della libertà dei culti secondo il diritto pubblico del Regno d’Italia, Livorno, 1861, pp. 4-13; B. Terracini, L’emancipazione degli ebrei piemontesi, in «R.m.I.», febbraio 1949, pp. 61 sgg.; G. Fubini, La condizione giuridica dell’ebraismo italiano dal periodo napoleonico alla Repubblica, Firenze, 1974, pp. 18 sgg. V. anche il rilievo critico mosso da G. Dina alla costituzione sarda per aver fatto del cattolicesimo la religione «ufficiale» nella sua introduzione (datata 15 febbraio 1848) alla traduzione dello scritto del barone Eòtvòs Sull’emancipazione degli israeliti (Torino, 1848, p. 26 nota). 62. Cfr. R. Elia, Gli ebrei e lo Statuto pontificio del ‘48. Vicende di una deputazione delle Comunità israelitiche pontificie, in «R.m.I.», agosto-settembre 1935, pp. 197 sgg.
96
4. Le origini risorgimentali dell’assistenza alla prima infanzia
I problemi connessi alla maternità e alla situazione infantile cominciarono ad attrarre in maniera duratura l’attenzione degli intellettuali italiani più sensibili alle tematiche sociali nel periodo della Restaurazione, nell’ambito del più accentuato e diffuso interesse per i modi di vita e le reali condizioni di esistenza delle classi popolari che caratterizzò in quei decenni larga parte della cultura europea. La presa di coscienza — fattasi via via più approfondita e impegnata in larghi strati dell’opinione pubblica illuminata — dell’esistenza di specifiche e spesso drammatiche questioni proprie del mondo dell’infanzia si colloca all’interno del più generale dibattito sul pauperismo che si intrecciò con nuovo vigore tra il 1815 e le rivoluzioni del 1848 e che ebbe — come si è accennato — uno dei suoi nodi principali nel problema della carità «pubblica» o «legale» e dei suoi rapporti con la carità «privata». E proprio sotto il segno della carità «privata» prese l’avvio l’esperienza degli «asili», la prima in ordine cronologico delle strutture in cui si esplicò l’intervento a favore dell’infanzia di quei «filantropi» che dalla fine degli anni "20 del XIX secolo si impegnarono nella realizzazione di una rete di strutture assistenziali destinata ai bambini delle fasce di età più basse. Gli «asili di carità per l’infanzia» furono infatti concepiti da Ferrante Aporti!, da Giuseppe Sacchi e da quanti li coadiuvarono in Lombardia e nelle altre regioni italiane come istituzioni che, sovvenzionate da singoli «benefattori», erano deputate a
raccogliere e custodire nel corso della giornata fanciulli di famiglie indigenti tra i 2 anni e mezzo e i 6 anni e nelle quali — dal momento che esse erano viste come una sorta di preparazione propedeutica alle scuole elementari — i piccoli ospiti, oltre a sviluppare «idee e sentimenti conformi ai doveri del vi1. Per un inquadramento generale sugli asili aportiani v. T. Tomasi, L’educazione infantile tra Chiesa e Stato, Firenze, 1978.
97
vere domestico, sociale e cristiano»?, avrebbero anche dovuto apprendere «i primordiali rudimenti del leggere, scrivere e conteggiare». Stimolo potente alla creazione degli asili fu la consapevolezza sempre più diffusa, all’interno dei gruppi intellettuali impegnati nell’azione volta a mitigare la durezza dell’esistenza delle «classi le più numerose e le più povere», delle difficoltà che le madri delle famiglie dei ceti popolari — nelle città ma anche nelle campagne — incontravano nella cura e nell’allevamento dei figli più piccoli: difficoltà che erano destinate a ingigantire nelle regioni in cui, come la Lombardia e il Piemonte, lo sviluppo delle attività manifatturiere e industriali (specie nel settore tessile) e il peso crescente del lavoro a domicilio impegnavano quote crescenti di mano d’opera femminile. Consapevolezza di cui fornisce efficace testimonianza una pagina vergata nel 1839 da Luigi Alessandro Parravicini (il pedagogista milanese autore del Giannetto, uno dei più diffusi libri di lettura per ragazzi dell’800) nella quale veniva fatto realistico riferimento a Como, un centro urbano caratterizzato sul piano economico dalle larghe dimensioni della tessitura serica a domicilio: Nascono dunque a furia i bambini popolari! e i genitori di questa numerosa prole non hanno libre di gallette, non sacchi di grano, non botte di vino,... la loro ricchezza so-
no le braccia. Dunque al subbio, al naspo, al martello, alle cesoje, alla lesina. Lavorano, lavorano la giornata intera per buscarsi tanto da mangiare pan bigio tutta la settimana — e far una baccanella al lunedì. E intanto, ch’ei sono assidui al lavoro, che
avviene de’ bambini? Chi non visto dagli affaccendati genitori sbalza da una sedia e si ammacca la testa o si rompe un braccio; chi accostatosi al bracero o al focolare per iscaldarsi ben bene, brucia il gonnellino, poi la pelle... Sopravviene una malattia all’operaio? — la seta è a troppo buon mercato? — la seta è troppo cara? Così nell’uno come nell’altro di questi estremi i mercanti non fanno più lavorar la pezza, allora chi tesse, chi tinge, chi dissaca, chi ammanisce l’ordito, e son migliaia di mani, tutti son digiuni o poco meno. In tanta miseria, che n’è degli innocentissimi bambini? Penuria, strapazzi, fame, botte, cenci, ... ecco se nessuno gli ajuta, la misera sorte di quei
piccoli infelici?.
In situazioni di questo tipo, nei freddi, disadorni, «miseri abituri» in cui nei centri urbani si ammassavano le prolifiche famiglie degli strati popolari, assai spesso non rimaneva soverchio spazio — come notavano frequentemente i pubblicisti del tempo — per il dispiegarsi del senso materno. Nelle dimore dei «poveri» — il che torna a dire della grande maggioranza delle popolazioni urbane, oltre che di quelle rurali — in assenza del padre impegnato dalla mat2. F. Aporti, Relazioni sugli asili d’infanzia ed altri istituti elementari visitati nell’autunno dell’anno 1843, in «Annali universali di statistica», Milano, 1845, vol. 85°, pp. 380-381.
3. L.A. Parravicini, Gli asili di carità per l’infanzia, in «Almanacco della provincia di Como per l’anno 1839», Como, 1839, pp. V-VI.
98
tina alla sera nel tentativo di «guadagnare una meschina mercede», era spettacolo usuale, osservava sempre nel 1839 il medico lombardo Andrea Buffini, uno
dei più acuti indagatori della realtà infantile della prima metà dell’800, quello di una madre che, «occupata a filare, od a rattoppare cenciose vesti» e circondata da numerosi figli «sporchi, mal coperti, scalzi, colla faccia lividastra dal freddo, colle mani parimenti livide e gonfie, piagnenti di fame e di freddo», era indotta dalle strette della miseria a soffocare o dimenticare la tenerezza materna: La stessa madre sgrida quelle tenere creature, se pure non le maltratta coi fatti, e stanca del loro pianto, or getta il lavoro, che deve procurare il pane a tutti, ed adagia in grembo il più piccolo dei figli, ora lo affida al più grandicello, e lo fa uscire per togliersi l’importunità di quel pianto, ora indispettita di tutto abbandona a sé stessi que” poveri bamboli per trovare un momento di quiete presso una sua vicina, che forse non è a miglior condizione*.
E un rimedio poco efficace contro il male di una situazione di incuria generalizzata dell’infanzia dei ceti popolari era costituito dalle cosidette «scuole» o «scuolette» per i fanciulli in età prescolare, contro le quali indirizzava dure parole proprio l’ Aporti, perché esse erano rette da «donnicciole ignoranti» che si limitavano a prendere in consegna per il corso della giornata i bambini e reputavano «buona educazione fisica il tenerli... seduti sopra seggiole perforate, utile erudizione intellettuale apprender loro le più sciocche cantilene delle quali non poche son laide, ed apice di educazione morale l’insegnar loro le preci solite a recitarsi nelle pubbliche liturgie in uno storpiato latino»5. Per non dire poi del deplorevole stato igienico-sanitario di questi depositi di bambini in cui essi «anneghittivano nel lezzo e nell’ozio»® e dei quali può dare un’idea appropriata una realistica rappresentazione del medico lombardo Federico Castiglioni: Ed ella è cosa che muove veramente lo sdegno e la compassione il vedere in una di queste pessime stanze raccolti una trentina di fanciulli, ove devono e divertirsi e leggere l’abbiccì, e mangiare e deporre gli escrementi, vivere insomma buona parte delle 24 ore del giorno. Quivi le esalazioni cutanee dei bimbi, le mefitiche esalazioni
del piccolo cesso, dell’orina sparsa talora per casa, e fors’anche dell’acido carbonico che si svolge dal braciere in tempo d’inverno, alterano di maniera l'atmosfera dell’ambiente, che non può che nuocere grandemente al fisico delicato di tanti poveri 4. [A. Buffini], Gli asili dell’infanzia considerati sotto l’aspetto della polizia sanitaria, ovvero effetti che devonsi aspettare dagli asili dell’infanzia sulla salute pubblica e sul benessere delle future generazioni, Brescia, 1839, pp. 15-16.
5. Lettera di F. Aporti a Joseph Werthaimer del 29 gennaio 1829, in F. Aporti, Scritti pedagogici editi ed inediti, a cura di A. Gambaro, vol. 1°, Torino, 1944, p. 194.
6. G. Sacchi, Gti asili infantili e la «Civiltà cattolica», Milano, 1855, p. 4 (estr. da «Annali universali di statistica»).
99
fanciulli, tra’? quali sono pure di quelli che per essere un po’ malaticci, vengono appositamente mandati alla scuola, affine (come si esprime il volgo) che la comunanza
cogli altri li risani?.
Che la funzione degli asili rispondesse a un’esigenza largamente sentita fu dimostrato dalla loro rapida diffusione, la quale si limitò peraltro alle più progredite regioni dell’Italia centro-settentrionale, dal Piemonte all’Emilia, dalla
Lombardia alla Toscana, lambendo marginalmente il Mezzogiorno e le isole, avviati già da quegli anni a un ruolo di inferiorità nelle vicende della scuola e delle istituzioni prescolastiche8. A sollecitare un più puntuale e ravvicinato inquadramento degli specifici problemi del mondo infantile da parte di intellettuali, filantropi e operatori medici contribuì in larga misura la dimensione massiccia presa nei decenni della Restaurazione dalla piaga dell’esposizione, fenomeno di origini lontane che assunse tuttavia proprio in questo periodo connotati patologici e sul quale ci si è soffermati in precedenza. L’aumento numerico dell’esposizione e del ricovero dei lattanti negli istituti ospedalieri fu più sostenuto nelle zone della penisola nelle quali andavano facendo passi più rapidi l’incipiente industrializzazione e la manifattura domestica. Così a Brescia — e utilizzando dati lombardi in parte già richiamati — mentre sino al 1799 i ricoveri nella casa dei trovatelli non avevano mai superato i 400 l’anno, la media annua toccò i 551 nel decennio 1830-18399; nell’Ospedale del-
la vicina Bergamo la media ventennale passò dalle 755 unità del 1771-1790 alle 1.978 del 1811-1830!9, e in quello di Como il numero annuale degli ingressi si portò dai 100 circa della fine del ‘700 ai 198 del 1837 e ai 379 del 1859!!. E analoga fu la tendenza riscontrata nelle province della bassa: a Pavia la media annua degli entrati nella Pia casa degli esposti salì dai 95 del 1778-1797 ai 210 del 1798-1817 ai 259 del ventennio successivo!2; il brefotrofio di Cremona accolse nel secondo cinquantennio del XVIII secolo circa 6.000 bambini, che crebbero a più di 22.000 nei primi 50 anni del secolo successivo!3; quanto poi 7. F. Castiglioni, Della fisica educazione dei fanciulli, Milano, 1834, pp. 14-15. 8. Si veda, per le linee di tendenza della diffusione degli asili negli anni immediatamente precedenti il 1848, F. Aporti, Prospetto statistico degli asili infantili esistenti in Italia nel 1846, in «Annali universali di statistica», 1847, vol. 91°, p. 292. 9. A. Buffini, Ragionamenti intorno alla casa dei trovatelli in Brescia, Brescia, 1841, p. 17.
10. G. Capsoni, Materiali per servire alla storia degli esposti, in «Giornale della provincia di Bergamo», Bergamo, 22 maggio 1840. 11. A.F. Tassani, Intorno all’Ospizio provinciale degli esposti in Como, in «Annali universali di medicina», 1873, vol. 223°, pp. 61-62. 12. P. Magenta, Sui pubblici stabilimenti di beneficenza della città di Pavia, Pavia, 1838, allegato |. 13. F. Robolotti, Storia e statistica economico-medica dell’Ospitale Maggiore di Cremona, Cremona,
1851, p. 60.
100
all'Ospedale di Mantova si passò dai 181 esposti del 1816 ai 343 del 1830 ai 520 del 1842!4, I dati più impressionanti sono però quelli di Milano, dove la media annuale si impennò dalla cifra di 790 del quinquennio 1785-1789 a quella di 3.300 del decennio 1841-1850 e infine a quella di 4.384 del decennio successivo!5, dati che acquistano maggior risalto se posti accanto a quello delle nascite nella città, che fu di circa 6.600 nel 1843 e di 6.800 nel 185116.
È bensì vero che l’analisi del dato globale annuo!” e l’avvertenza che il brefotrofio milanese di S. Caterina alla ruota serviva un bacino territoriale più ampio di quello della sola città ridimensionano parzialmente le cifre, ma resta pur sempre il fatto che, come notava nel 1853 (e sia pure con qualche amplificazione) una commissione incaricata di studiare il fenomeno, «sceve-
randosi dalla somma complessiva delle nascite quelle appartenenti ai ceti più agiati, risulta che quasi la metà dei bambini nella popolazione povera della città sono gettati alla ruota»!8. La stessa tendenza ascendente è rilevabile anche negli Stati sardi di terraferma, come risulta tra l’altro dalle già ricordate serie dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara!?. E un incremento sensibile si verificò anche nel Granducato di Toscana, dove — come si è detto — la «famiglia gettatella» aumentò dalla media annua di 15.767 unità del periodo 1831-1840 alle 21.486 14. G. Tinelli, Prospetto degli esposti dello Spedale civico di Mantova nel corso dell’anno 1830, in «Annali universali di medicina»,
1831, vol. 53°, p. 301, e L. Preti, Notizie statistiche
della città e provincia mantovana, Mantova, 1842, pp. 168-169. 15. A. Buffini, Ragionamenti storici economico-statistici e morali intorno all’Ospizio dei trovatelli in Milano, Milano, 1844-1845, passim.
16. Relazione stata compilata per cura di una Commissione stata eletta dalla Società d’incoraggiamento delle scienze, lettere ed arti intorno alla Pia casa degli esposti, ai ricoveri dei bambini lattanti, agli asili di carità per l’infanzia ed ai conservatori per la puerizia di Milano, Milano, 1853, p. 40.
17. Ibidem, p. 32. L’analisi del prospetto degli esposti per l’anno 1851 dava i seguenti risultati: bambini deposti nel torno di Milano bambini deposti nel torno di Varese bambini abbandonati davanti al ricovero di Legnano bambini abbandonati nei comuni di campagna totale dei bambini esposti e derelitti
15935 38 92 73 2.138
bambini ammessi con fedi di povertà per impotenza delle madri ad allattare in Milano idem dalla campagna bambini appartenenti a madri inferme ricoverate all'ospedale bambini provenienti dal Pio ricovero delle partorienti bambini appartenenti a madri accolte come nutrici nell’ospizio totale dei bambini ammessi fuori del torno e non abbandonati
161 968 138 210 15 1.492
18. Ibidem, p. 40.
19. Ibidem, p. 35.
101
unità del 185220, mentre gli esposti introdotti nell'ospedale di S. Maria degli Innocenti di Firenze salirono dai 10.000 circa del 1781-1790 ai più di 16.000 del 1831-184021. Un andamento
meno
dinamico
(e anche questo fatto è stato richiamato)
sembra invece ipotizzabile nel Mezzogiorno, dove pure l’esposizione assume rilievo nelle cifre assolute della capitale, poiché i «proietti» introdotti nella ruota dell’ Annunciata furono a partire dal 1816 circa 2.000 l’anno?2. La pratica dell’esposizione portava dunque alla formazione di una fascia sempre più larga di potenziali condannati all’emarginazione sociale: destino che attendeva soprattutto i maschi, perché in generale le femmine che fossero riuscite a raggiungere l’età matrimoniale dimostravano in generale una forte propensione al matrimonio, che era loro facilitato dalle doti abbastanza allet-
tanti concesse dagli istituti23. Va inoltre sottolineato che al progressivo estendersi di questa fascia contribuivano in larga proporzione bambini legittimi, i quali fornivano a volte — specialmente negli istituti maggiori — più della metà degli affidati, come testimoniano le analisi degli studiosi coevi?4. Il contingente globale degli esposti veniva tuttavia drasticamente falcidiato dall’altissimo tasso di mortalità della categoria, superiore a quello già elevatissimo della mortalità infantile presa in generale, perché la morte colpiva molto duramente i piccoli abbandonati. E basterà richiamare poche cifre per dare conto dell’ampiezza di una pratica che fu volta a volta chiamata «strage degli innocenti» o «infanticidio legale»25. Così i calcoli relativi a S. Caterina alla ruota danno per gli anni 1800-1809 a fronte di 15.418 entrati 11.960 deceduti (una parte dei quali relativa a entrati negli anni precedenti), per gli anni 1810-1819 21.158 entrati e 14.964 morti, per gli anni 1820-1829 20.976 entrati e 11.064 morti, per gli anni 1830-1839 27.637 entrati e 14.644 morti,
e via dicendo°9; a Firenze percentualmente su 1.000 bambini introdotti nel 20. O. Andreucci, Della carità ospitaliera in Toscana.
Studi documentati,
Firenze,
1864,
pp. 314-315. 21. C.A. Corsini, Materiali per lo studio della famiglia in Toscana nei secoli XV11-XIX: gli esposti, in «Quaderni storici», settembre-dicembre
1977, n. 33, p. 1039.
22. C. Della Valle, Della miseria pubblica, sue cause ed indizi. Considerazioni applicate allo stato attuale del Regno citeriore di Napoli, Napoli, 1833, p. 58. 23. Corsini, Materiali..., cit., p. 1000.
24. Secondo i calcoli del Buffini in Santa Caterina alla ruota la percentuale degli esposti legittimi sul totale variò negli anni 1830-1843 tra il 62,6% e il 71,37% (Buffini, Ragionamenti storici..., cit., vol. 1°, tav. XXIII); quanto al brefotrofio di Cremona il Robolotti rilevava che
dei 10. 720 bambini raccolti nei 24 anni tra il 1823 e il 1847 «5.751 spettano ai legittimi, e 4.969 ai vari esposti o bastardi» (Robolotti, Storia e statistica economico-medica..., cit., p. 61). Cfr. anche Corsini, Materiali..., cit., pp. 1006 sgg., che stima tra il 40 e il 70% DApercentuale degli esposti legittimi a Firenze nei primi decenni dell’ 800. 25. C. Frua, Sulla questione del torno, Milano, 1866, p. 10. 26. Buffini, Ragionamenti storici..., cit., tavv. XII-XVII.
102
1841 come figli di ignoti in S. Maria degli Innocenti al compimento del decimo anno soltanto 238 erano ancora vivi e a carico dell'Ospedale, mentre la parte di gran lunga maggiore degli altri (esclusi cioè quelli restituiti ai genitori legittimi, il cui numero era basso) era morta??; venendo poi a una realtà minore, quella dell’Ospizio di Piacenza, negli anni 1809-1811 i bambini morti all’interno di quell’istituto prima dell’affidamento a balie esterne furono il 57,6% (212 su 368), percentuale scesa al 32,8% (126 su 384) nel 1823-1825
e risalita al 37,4% nel 1831-183228. Il tributo più alto alla morte era pagato dagli infanti «da latte», e quindi nel primo anno di vita, con punte più elevate nel primo mese: fenomeno che non meraviglia quando si ponga mente alle degradate condizioni igieniche e sanitarie dei brefotrofi (definiti «sepolcri» da documenti ufficiali toscani) e che
conservò la sua vischiosità nei primi decenni dello Stato unitario, quando la mortalità dei neonati che restavano negli ospizi sfiorò in qualche caso il 90%?9. Alle impressionanti testimonianze già ricordate:0 si può così affiancare quella più tarda che nel 1884 il delegato di Modica (Ragusa) tracciava al prefetto in una relazione sul brefotrofio locale: Una sola stanza molto angusta, priva di aria e di luce, è destinata a ricevere in media da 11 a 15 infanti, affidati alla cura di una direttrice inetta, ed a tre sole balie, pallide,
sparute e vecchie, che tutte insieme non sono atte a nutrire un solo bambino. Otto 0 dieci luride culle, coperte dei più luridi stracci e ripiene di insetti, raccolgono e coprono quelle creature destinate a morire in breve ora, ... miste ai cadaveri ed ai moribondi3!.
Questo tragico stato di cose aveva origini lontane se — come si ricorderà — Bernardino Moscati aveva scritto il 1° maggio 1772 al Kaunitz che nell’Ospedale Maggiore di Milano fino a 50 bambini erano stipati in tre piccole stanze, in quattro per letto e «costretti a rimanersene quasi tutto il giorno conficcati sopra una piccola seggiola»32; e se l’anonimo autore di un «discorso» sull’ospedale torinese di S. Giovanni lamentava nel 1778 che gli esposti giacevano «a quattro, a sei per letto», coperti da panni «immondi», e uscivano dall’ospizio «quasi tutti storpi, scrofolosi, gibbosi, rachitici»33. 27. Corsini, Materiali..., cit., p. 1002. 28. D. Zini, Un aspetto di storia demografica piacentina: l’infanzia abbandonata a Piacenza nei secoli XVIII e XIX, tesi di laurea discussa nella Facoltà di lettere e filosofia dell’ Univer-
sità degli studi di Milano nell’anno accademico 1977-1978, p. 74. 29. M. Gorni-L. Pellegrini, Un problema di storia sociale..., cit., pp. 54-55. 30. Ibidem, pp. 34 sgg. 31. A. Bonomi, voce Brefotrofio, in Il Digesto italiano, Torino, 1890-1899, vol. 5°, p. 964.
32. ASM, Luoghi pii, p. a., cart. 389. 33. T.M. Caffaratto, Storia dell’assistenza agli esposti a Torino, estratto dal «Giornale di batteriologia, virologia ed immunologia ed Annali dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino», Torino, 1963, n. 5-8, p. 24.
103
Il deperimento fisico e il rischio di morte dei bambini raccolti nei brefotrofi erano poi aggravati da tutto un insieme di fattori negativi concomitanti: le difficoltà della gestazione e del parto delle madri di illegittimi, le quali spesso cercavano inutilmente di «distruggere ne’ suoi primordi il frutto del concepimento» e tentavano poi di celare con la «conciatura» della persona «il crescente volume del ventre»34; gli stenti cui gli infanti andavano incontro nei viaggi che li portavano all’ospizio e in quelli dall’ospizio alle famiglie cui venivano affidati; le emorragie dovute al fatto che «i genitori più malvagi» non allacciavano loro il cordone ombelicale35; la scarsità di buone nutrici, che diventavano rare specie nei mesi estivi, quando più pressanti si facevano i lavori campestri, il che rendeva necessario assegnare a ogni balia quattro o anche cinque bambini39; il conseguente pericoloso ricorso all’allattamento artificiale con latte di vacca o di capra, che stroncava «siccome peste crudele quelle tenere vite»37; le carenze
dell’alimentazione
successiva
allo svezza-
mento, che non erano soltanto qualitative ma anche quantitative33. A questo complesso di elementi si accompagnava poi nei brefotrofi la triste, consueta presenza di un largo ventaglio di malattie endemiche e contagiose, dalla sifilide alla scrofola, dalle gastroenteriti alle oftalmie, dallo scleroma edematoso
(l’ «indurimento cellulare») ai morbi polmonari. E se migliori si facevano le aspettative di vita degli esposti affidati al baliatico esterno e dei fanciulli «da pane» consegnati a contadini o artigiani, la loro sorte si svolgeva pur sempre all’interno di una condizione di dolorosa durezza in fatto di rapporti umani, rare volte temperata dal sorgere di legami affettivi tra «allevatori» e fanciulli. Nel ventaglio delle spiegazioni addotte dagli osservatori del tempo posti di fronte al dilatarsi dell’esposizione e riconducibili all’interno di una situazione di diffusa povertà urbana e rurale (dai matrimoni precoci contratti nel Lombardo- Veneto per sfuggire alla leva all’abbondanza di «personale di servizio» di estrazione rurale) vennero individuati con consapevolezza maggiore o minore anche i due fattori che più contribuivano alla crescita del fenomeno: da una parte il peso che nel bilancio economico di una famiglia delle classi popolari — e nella quale anche la donna era chiamata sempre più spesso a erogare forza-lavoro a domicilio o in fabbrica — era costituito dall’allevamento di un infante; dall’altro l’assuefazione, nel quadro della mentalità popolare, 34. Buffini, Ragionamenti... Brescia, cit., p. 20.
35. A. Martinengo, La Ruota di Novara, cit., p. 144. 36. W. Menis, Saggio di topografia statistico-medica della provincia di Brescia aggiuntevi le notizie storico-statistiche sul colera epidemico che la desolò nell’anno 1836, Brescia, 1837,
Vol.
pà202! 37. Buffini, Ragionamenti storici, cit., vol. 1°, p. 145.
38. Cfr., i già ricordati suggerimenti che sul vitto degli esposti dava l’intendente del brefotrofio di Novara.
104
all’uso del brefotrofio come strumento di impiego legittimo per limitare il numero di «bocche» presenti all’interno della famiglia. Il primo aspetto era colto con grande lucidità da Buffini quando — forte delle sue esperienze bresciane e milanesi — annotava: Se il giornaliero guadagno del marito non basta a mantenere la moglie ed i figli già svezzati; se la moglie deve anch’essa ogni giorno lavorare per provvedere ai bisogni della famiglia; se fornita di buona fisica costituzione ed attitudine ad allattare non può ottenere i documenti necessari per affidare regolarmente il suo neonato all’ospizio; se allattandolo essa medesima si toglie ogni ora al lavoro, che le è indispensabile, voi comprendete che l’esporlo al torno è necessità presso che senza legge39.
Quanto poi all’«immagine» che del brefotrofio si veniva consolidando presso gli strati popolari dei centri urbani dell’Italia centro-settentrionale, tutte le testimonianze s’accordano — si legge nella relazione stesa nel 1853 dalla commissione milanese incaricata di studiare i problemi della beneficenza e le cui considerazioni hanno un valore generale — nell’affermare che nella opinione del povero, la pia casa è uno stabilimento pubblico destinato a fornire indistintamente il baliatico e la prima educazione ai suoi figli, che, valendosene, egli usa d’un diritto, e prende la parte a lui spettante d’un patrimonio comune, fa opera non che legittima ed onesta, grandemente utile alla sua famiglia ed alla prole stessa che espone al torno49.
E di questa mentalità che tendeva a divenire dominante, e il cui risvolto era una «fredda indifferenza» nei confronti della prole da parte dei genitori che affidavano alla ruota i loro nati legittimi, danno conferma sia la parte che
spesso avevano le levatrici nel consigliare alle loro assistite l’esposizione e nel mandarla ad effetto4!, sia i casi frequenti di esposizioni plurime — fino a cinque, sei figli — praticate da una stessa coppia di genitori”. La facilità del ricorso al torno — che era alimentata dagli effetti imitativi4 e che rinvia alla fecondità delle madri di famiglie popolari, la quale era paradossalmente incentivata dalla stessa pratica dell’abbandono4 — si radicava d’altra parte anche nel modo poco benevolo — un ulteriore motivo di complicazione all’interno di una situazione già di per sé difficile — in cui la gesta39. Buffini, Ragionamenti storici..., cit., vol. 1°, pp. 147-148.
40. Relazione stata compilata..., cit., p. 45. 41. Ibidem, p. 43. 42. Buffini, Ragionamenti storici..., cit., vol. 1°, p. 151.
43. Menis, Saggio di topografia..., cit., vol. 1°, p. 197. 44. «L'esposizione stessa da sé si feconda: le donne che non allattano, subito sciolte dal puerperio, sono, in generale, atte al concepimento, e per conseguenza pronte si trovano ad una nuova esposizione» (A. Triberti, Della necessità di limitare ai soli figli illegittimi l'esposizione dell’Ospizio di S. Caterina e di chiudervi il demoralizzante torno, Milano, 1850, p. 8).
105
zione e il parto erano spesso vissuti dentro i nuclei familiari poveri, e che era così caratterizzato con efficacia nel 1857 da Giovanni Capsoni, un altro me-
dico lombardo che si dedicò a lungo e con passione all’analisi delle condizioni sociali dei ceti subalterni: La classe bisognosa della popolazione non solo poco desidera un aumento di prole, ma questo le riesce di peso e di molestia. Da ciò la indifferenza o, dicasi pure, la durezza con cui da alcuni membri di una famiglia contadina e industriale si procede verso una donna incinta o partoriente; da ciò la mancanza per parte dei genitori stessi a prestare ai propri bambini quell’assistenza che vale a mantenerli in vita e a dare loro quella fisica educazione che ne assicura un vigoroso prosperamento#5.
L’aspetto di pesante passività che all’interno delle famiglie dei lavoratori urbani assumeva l’allevamento dei bambini, soprattutto nella fase dell’allattamento, ha la sua migliore riprova in un altro fenomeno tipico della condizione infantile in alcune delle città maggiori dell’Italia settentrionale nei decenni qui considerati, vale a dire l'affidamento della prole a balie «mercenarie». L’allattamento mercenario — sia nella forma della consegna dell’infante a una nutrice di campagna nella sua casa che in quella dell’impiego di una balia alloggiata nella dimora della madre del neonato — era una pratica generalizzata ormai da molto tempo presso le famiglie facoltose; e contro quella consuetudine aveva preso posizione dalla metà del ‘700, in Europa e in Italia, una nutrita pubblicistica che sosteneva — con argomenti medici, igienici e morali — la superiorità dell’allattamento materno e largheggiava di esortazioni alle madri perché nutrissero i figli con il proprio seno. In questi scritti si insisteva soprattutto sugli inconvenienti dell’allevamento presso le balie di campagna le quali, fiaccate da un duro lavoro, non potevano porgere che «un seno inaridito», dal quale usciva un latte «inacidito ed infiammato»47 e per di più scarso, dal momento che in generale erano costrette a «sfamarsi di rozzo ammuffito pane, di vecchi legumi conditi a molto sale, a lardo ed olio»48; inoltre quelle nutrici, si diceva, non erano in grado di prestare cure adeguate al bambino non soltanto perché erano impegnate per molte ore nei campi, ma 45. G. Capsoni, Sulle varie provvidenze a vantaggio delle classi povere. Cenni, in «Annali universali di statistica», 1857, vol. 129°, p. 7. 46. Oltre agli scritti che saranno citati più avanti cfr. ad es. A. Bianchi, Dell’allattamento. Memoria fisiologico-medico-politica, Milano, 1833. 47. J. Ballexserd (di Ginevra), Dissertazione sopra il quesito quali siano le cause principali, per cui una gran parte d’uomini muore nell’infanzia, e quali i rimedi più semplici, ed efficaci per conservar loro la vita presentata... al concorso dell’anno 1772 e coronata dalla reale Accademia di scienze e belle lettere di Mantova, Mantova, 1773, p. 29. 48. V. Cerri, Se più convenga al cittadino far allattare i propri bambini in casa, ovvero in campagna. Lettere ad una dama, Milano, 1788, p. 6.
106
anche perché, quando tornavano dal lavoro, o si fermavano con il lattante nella stalla dove si respirava «un’aria... fetida, corrotta dal continuo soggiorno di bestie insieme, e di persone malsane talvolta, sempre sudice e fetenti», o si chiudevano in un alloggio formato da una sola stanza «bassa, ristretta, mal ri-
parata, e zeppa delle eterogenee perniciose esalazioni di molti corpi insieme, e di molte immondezze»9. Ma proprio l’utilizzazione di balie che vivevano nelle condizioni ambientali sopra descritte fu il dato che caratterizzò durante 1’800 quel ricorso a nutrici di campagna da parte di famiglie di lavoratori urbani al quale si è accennato e che in una città come Milano assunse dimensioni di particolare rilievo. Nella capitale lombarda,
infatti, un’indagine
condotta
alla metà del secolo
con serietà di intenti e i cui risultati, al di là del loro margine di incertezza, possono essere assunti come rivelatori di una tendenza, appurò che dei bambini nati in città nel semestre 1° ottobre 1846-31 marzo 1847 un quinto, ... ossia il venti per cento, veniva consegnato all’ospizio degli esposti; ... gli altri due quinti dei bambini nati da famiglie povere, o sia il quaranta per cento fra i nati, veniva allattato dalle medesime madri con gravissimo loro sagrificio; e che gli ultimi due quinti, o sia il residuo 40 per cento, veniva per una parte corrispondente al 10 per cento allattato in città da madri agiate, ed il resto, corrispondente al 25%, era stato affidato a nutrici mercenarie dimoranti in campagna:
risultati statistici che pur nella loro gravità furono accolti con un senso di relativa soddisfazione, come quelli che smentivano l’opinione generale che soltanto il 10% delle madri povere di Milano allattasse direttamente i propri figli50. E a queste madri indigenti, sulle quali potevano fare scarsa presa le esortazioni dei medici e dei moralisti, non riuscivano del pari gran che utili le indicazioni fornite dalla manualistica corrente sull’allevamento dei bambini circa la scelta delle balie, e nelle quali ci si imbatte in consigli di questo tenore: [La buona nutrice] sia perfettamente sana del corpo: giovane da venticinque a trent'anni, non primipara, e possibilmente del parto secondo: di buon colore tra ‘1 rosso, e bruno, con carni non flaccide; non troppo grassa, né macilenta; mezzane di grossezza le sue mammelle tra dure e molli, con capezzoli né troppo piccoli o ritirati in dentro, né troppo grossi o sporgenti. Non sia di pelo rosso o biondo, come troppo impressionabile da passioni, offra bell'aspetto, non losca, non balbuziente, non feten-
te di bocca, 0 con denti cariosi5!. 49. Ibidem, pp. 7-8. 50. G. Sacchi, Sulla fondazione di speciali ricoveri per bambini lattanti, in «Annali universali di statistica», 1848, vol. 98°, pp. 134-135.
51. D. Boccali, Della educazione fisica dell’uomo bambino dalla nascita allo spoppamento. Saggio inaugurale, Pavia, 1836, p. 21.
107
Oppure: Sarà... la nutrice sana discretamente grassa, robusta, senza manifeste deformità. La
testa sarà coperta di capelli bruni, anziché biondi...: quelle poi la cui capigliatura è rossa dovranno essere rigettate costantemente per la loro traspirazione che è molto fetente... Le mammelle dovranno essere collocate su di un petto ben conformato, di un volume ordinario, di figura imbutiforme, gonfie del latte, un po’ volte all’infuori, separate tra loro da un ben marcato solco5?.
Nella generalità dei casi invece il tipo di «balia campagnola» cui consegnavano i propri figli le famiglie lavoratrici si avvicinava a quello così descritto nel 1881 con brutale franchezza da un giornale medico milanese: La nutrice è nulla più che una impietosa e pigra donnaccia che nel bimbo affidatole scorge solamente un mezzo per lucrar denaro: e allora, dopo aver rinnovato mille menzognere promesse ai genitori, appena giunta a casa gli lascia incuocere e recidere la tenera cute dalle orine e dallo sterco; lo rimpinza di pappa, di polenta, di grossolane minestre; lo lascia strillare lunghe ore oppur lo concede alle braccia troppo gracili di una ragazzetta di pochi anni che s’el conduce dietro i maiali, fra le oche, nel sozzume del cortile, o lo lascia tombolar a terra, o stizzita gli usa mille sgarbi e sguaia-
tezze59.
Un'altra componente delle condizioni dell’infanzia sulla quale deve richiamare l’attenzione un discorso volto a delineare la genesi delle iniziative assistenziali indirizzate ai bambini dei primissimi anni di vita è quella della loro mortalità. Le dimensioni quantitative del fenomeno apparvero in tutta la loro evidenza soprattutto da quando i servizi statistici dello Stato unitario permisero di misurare, a partire dal 1863, 1 morti nei primi 5 anni di età distinti analiticamente per classi annuali, mettendo tra l’altro in evidenza il peso del-
la vera e propria mortalità infantile, che fu del 228,7%o nel 1863-1865 e che era ancora del 168,3%o nel 1896-190054. Ma già prima di queste rilevazioni l’opinione pubblica più sensibile aveva preso coscienza dell’acutezza del problema, come dimostrano non tanto 1 tentativi di analisi specifica della questione?5 quanto l’attenzione rivolta ad individuarne le cause, e che si indirizzò in particolare a quelle esogene. Oltre ai guasti prodotti dalle malattie infantili dominanti nel periodo — dalle forme intestinali e tifoidee alla difterite — ven52. M. Carrara, Dell’educazione fisica e morale dell’infante. Dissertazione inaugurale, Milano, 1836, p. 17. 53. G. Brambilla, Le balie campagnuole, in «Gazzetta medica italiana-Lombardia», Milano, 29 gennaio 1881, p. 32. 54. S. Somogyi, La mortalità nei primi cinque anni di vita in Italia. 1863-1962, Palermo,
1967, p. 42. 55. Come ad es. F. Trevisan, Della preservazione dei bambini, Treviso, 1823.
108
nero così chiamati in causa anche gli effetti derivanti da un insieme di pratiche tradizionali tra le classi popolari. Per quel che concerne le malattie polmonari, pertanto, mentre si rilevava la pericolosità dell’usanza di tenere nella stagione rigida le culle degli infanti nelle stalle, a causa della «repentina sensazione di freddo» cui quelli venivano esposti quando erano ricondotti nelle case, d’ordinario gelide56, a partire dagli ultimi decenni del ‘700 fu posta sotto accusa anche la pratica di battezzare in chiesa nei mesi autunnali e invernali neonati di pochissimi giorni di vita: Il male che può risultarne è grave: — deplorava ad esempio nel 1786 Giovanni Rigoni, deputato di sanità del comune di Valdagno — il pericolo è però molto minore nelle città, e ne’ grossi borghi ove la chiesa non è lontana, e comode sono le strade. Ma nella campagna ove sovente conviene far delle miglia pria di giungere alla parrocchia, e specialmente nelle parti montuose, ove la distanza suol essere grandissima, e le strade vi sono pericolose e incomode, oltre il freddo che prende il bambino... evvi il pericolo della caduta?”?.
E le voci critiche mettevano poi in rilievo altri aspetti negativi della consuetudine, come le pressioni delle «mammane» sui genitori perché recassero il più presto possibile i neonati in chiesa «per timore di perdere una vile moneta, che nelle solennità del battesimo sogliono ricevere in dono» e il costu-
me di concludere il rito «in una qualche bettola dove il padre con quelli che hanno preso parte alla sacra cerimonia si abbandonano ad una festiva allegrezza, ... intantoché l’innocente creaturina tormentata dal disagio delle fascie, dai
rigori del freddo, e forse anche dalla fame manda i più dolorosi strilli»58. Una polemica serrata investì poi un tema divenuto classico nella letteratura sull’allevamento dell’infanzia a partire dalle prese di posizione di Rousseau, quello delle fasce strettamente avvolte intorno al corpo del bambino così da impedirne ogni movimento: sistema ormai pressoché unanimemente condannato dall’opinione medica come «avanzo di un’antica barbarie»5?, ma che continuava ad essere adottato su larghissima scala da madri e balie perché le fasce erano giudicate «convenienti, com’esse dicono, alle loro occupazioni 0 domestiche o rurali, duranti le quali, possono del tutto abbandonare il bambi-
no nella culla»90. 56. Castiglioni, Della fisica educazione dei fanciulli, cit., pp. 11-12. 57. Transunto d’una memoria del sig. Giovanni Rigoni sull’utilità d’amministrare il battesimo a’ bambini nella casa paterna, almeno nell’inverno, in «Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti», Milano, 1786, t. 9°, p. 339.
58. Da un articolo dell’arciprete di Breganze in «L’Educatore del contadino», Vicenza, gennaio-febbraio 1848, pp. 125-129. V. anche, tra l’altro. G. Valente, Su! battesimo dei bambini, in «L’Igea», Milano, 1863, pp. 9 sgg. 59. Carrara, Dell’educazione fisica..., cit., p. 9.
60. Castiglioni, Della fisica educazione deifanciulli, cit., p. 27.
109
Al tempo stesso si infittirono le condanne di consuetudini popolari, corroborate spesso da «mammane» e levatrici, come quelle che contribuivano ad accrescere i rischi di morte dell’infanzia. Nel quadro di queste pratiche entrava ad esempio la somministrazione di oppiacei e di alcoolici agli infanti per facilitarne e prolungarne il sonno. Così il medico bresciano Menis tra le cause dell’«eccessiva mortalità.de’ bambini» annoverava nel 1837 proprio l’ «uso di addormentarli colla triaca e cogli oppiati» e di «porgere ad essi nei primi mesi di vita del vino coll’idea di renderli più robusti»9!. A loro volta dieci anni più tardi i membri della sezione medica della milanese Società di incoraggiamento delle scienze, lettere ed arti, in una loro indagine sulle conseguenze del lavoro delle donne sulla condizione infantile, sottolineavano che
anche da noi si è introdotto quel sistema avvelenatore di Francia e d’Inghilterra di far trangugiare ai bambini bevande narcotiche per assopire in un letargico sonno quelle povere vite nelle lunghe ore diurne in cui le madri lascian la casa per l’opificio, e nelle non brevi ore notturne in cui l’operaio vuol trovare una quiete ne’ suoi dolori, foss’anche la quiete del sepolcro®?.
E così pure veniva deprecato l’impiego incontrollato di purganti violenti e di «vermifughi» ai danni della prima infanzia, età — constatavano nel 1830 gli editori della traduzione italiana di un noto «trattato» francese sulle malattie dei bambini — «malmenata dall’ignoranza di alcune mammane, dalla folle pretesa di molte vecchiarelle, o dalla ingorda cupidigia di non pochi dispensatori di segreti». Quanto poi ai vermifughi, i medici chiamavano in causa la credenza popolare «che i vermi esistano in noi naturalmente, in certi particolari ricettacoli, donde se escono, producono malanni», soprattutto per la 61. Menis, Saggio di topografia..., cit., vol. 1°, pp. 118-119. Anche il Boccali (Della educazione fisica..., cit., p. 18) lamentava che «alcune empiriche levatrici sogliono usare tuttavia, dar tosto nato al bambino qualche cucchiaio di vino puro, o inacquato, dalla falsa persuasione condotte, aver egli bisogno d’esser corroborato». 62. Sacchi, Sulla fondazione di speciali ricoveri..., cit., p. 133. Sull’uso della teriaca cfr. anche quanto scriveva Lorenzo Ercoliani nella sua /giene delle spose, ossia ragionamenti popolari intorno alla gravidanza, al parto, alla allattazione (Milano, 18442, p. 262; la prima edizione era apparsa a Brescia nel 1840): «Maledetta la madre intollerante, la nutrice crudele, che, insofferente della veglia del suo bambino, cerca assopirlo con un veleno...
I molti attivi
ingredienti irritanti, ond’è composta la teriaca, tra’ quali primeggia l’oppio, assopiscono il bambino, e sono causa d’infiammazioni intestinali, cerebrali, di convulsioni». E si veda anche
quel che alla fine degli anni ’60 scriveva il medico Luigi Seguini: «Invero questo [il poppante] debole, infermiccio, non ha fiato di far sentire i suoi vagiti, oppure facilmente lo si fa zittire addormentandolo con diascordio o triaca, dopo averlo satollato di polenta stemperata e bollita nel latte» (testimonianza riportata in C. Zucchi, L'istituzione dei ricoveri per bambini lattanti e slattati, in «Annali universali di medicina»,
1869, vol. 210°, p. 272).
63. C.-M. Billard, Trattato delle malattie de’ bambini neonati e poppanti, Milano, 1830, p. iniziale non numerata.
110
«speciale tendenza a portarsi alla gola onde soffocare gl’infanti»: credenza che induceva i genitori ad attribuire alla vermificazione malesseri che avevano tutt'altra origine e che li faceva affannare «a dare medicine, ad ungere, con olii od altre empiriche sostanze, il ventre de’ lattanti, attaccando loro al
collo canfora, aglio o che altro di peggio». Sempre nelle opinioni tradizionalmente accettate all’interno delle classi popolari - come ad esempio quella che i pidocchi servissero «come di purga al fanciullo» o che le «croste al capo» valessero a conservare bene il cervello66 — aveva uno dei suoi motivi la scarsa o nulla cura igienica della testa dei bambini, che spingeva il già ricordato Castiglioni a vergare una pagina in cui questo aspetto è richiamato con toni di un crudo realismo: La massima parte delle balie, per un principio falsissimo invalso nella popolare opinione.... evitano... con ogni scrupolo di lavargli [all’infante] la testa e conservarla pulita, opinando che questa, in parte ancora cartilaginosa e delicata, abbia bisogno di venire ad arte fortificata e difesa. Avviene per siffatta omissione che la molta materia perspirata dalla cute del capo, vi si raccoglie e si condensa, formando specie di scaglie che aderiscono tenacemente ai capelli, finché questi in una colla indicata lordura costituiscono un solo tutto fetente, che fa allontanare le persone anche da un vispo e
grazioso fanciullino®?.
A completare il quadro fin qui delineato vanno infine menzionate altre costumanze popolari largamente attestate dalla pubblicistica medica del tempo: quali il taglio generalizzato del frenulo linguale ad opera delle mammane (le quali, «quasi in ogni neonato, veggono il bisogno di tagliare il frenolo, e lo tagliano il più delle volte quando non va tagliato»); o la confricazione delle mammelle del bambino fin quando da esse non usciva un umore lattiginoso («il volgo gli si pone d’attorno, schiaccia colle dita e confrica le piccole mammelle, e crede e pretende cotal pratica necessaria; e così produce irritazioni della pelle e del tessuto sottocutaneo»)9. Elementi che si inserivano poi in una condizione diffusa di insufficiente attenzione per l’infanzia che aveva le sue radici anche nel profondo disagio economico e sociale dei ceti popolari, il quale proiettava i suoi riflessi negativi su alcuni aspetti della nutrizione: come la pratica di somministrare a forza al bambino a ore fisse quantità ec64. Ercoliani, Igiene delle spose..., cit., pp. 264-265. 65. Castiglioni, Della fisica educazione deifanciulli, cit., p. 43. 66. Da un modello di convenzione per baliatico ideato dal medico Scipione Giordano e messo in vendita negli anni ‘70 dell’800 nelle farmacie di Milano (/! medico di casa, Milano,
11873 pra99)) 67. Castiglioni, Della fisica educazione dei fanciulli, cit., p. 46. 68. Ercoliani, Igiene delle spose..., cit., p. 263.
69. Ibidem, p. 262.
11]
cessive
di latte, «consuetudine
non
meno
riprovevole
che frequentissima
presso le nutrici, alle quali importa di trovarsi in libertà per quello spazio di tempo ch’esse hanno destinato od al riposo o alle rurali occupazioni»?0; o la breve durata dell’allattamento materno (non oltre il terzo mese) da parte di
molte madri lavoratrici, con il conseguente ricorso all’allattamento misto, con un largo impiego di pappe di latte e pane grattugiato o di latte e di farina di mais per bambini poco più che neonati?! e più in generale di cibi poco adatti ad infanti («Le nutrici campagnuole tengono opinione che il latte non basti a impinguare i neonati anche di poche settimane e però li rimpinzano di pappe mal cucinate. Quando i poverini hanno cinque o sei mesi di vita, e talor anche prima, li tengono secoloro ai grossolani pasti, e di tratto in tratto lor pongono in bocca polenta e formaggio, e merluzzo»)?2. Nel doloroso contesto così delineato furono messi in atto, attorno agli anni °40, i primi tentativi della carità «privata» di organizzare strutture che valessero ad alleviare in qualche misura il carico che per le famiglie povere delle città era costituito dall’allevamento degli infanti e che potessero contribuire a lenire la piaga dell’esposizione: tentativi che si inserivano certamente nei moduli tipici di quel filantropismo paternalistico ottocentesco nel quale l’attenzione per le condizioni di esistenza delle classi subalterne andava sovente congiunta con le preoccupazioni per il profitto imprenditoriale e del quale sono risaputi caratteri e limiti, ma di cui va tuttavia riconosciuta la carica innovativa nella storia dell’assistenza, poiché essi fornirono una prima — anche se ristretta — base di sperimentazione che avrebbe poi permesso il passaggio ad altre più mature ed estese forme di intervento a favore dell’infanzia. L'occasione per una prima discussione a livello nazionale si presentò nell’ottava
«riunione»
degli scienziati
italiani
(Genova,
settembre
1846),
quando una comunicazione del francese Marc Antoine Jullien sulle crèches parigine fornì lo spunto per tentare un primo bilancio delle scarse istituzioni indirizzate ai lattanti e ai bambini da poco svezzati. Nel corso dei lavori congressuali si accennò così ad alcune provvidenze di baliatico praticate a spese pubbliche a Parma e nel Granducato di Toscana, mentre Lorenzo Valerio diede notizia del «presepio» organizzato dall’industriale Michele Bravo per i figli delle 300 operaie addette al suo filatoio di seta ubicato presso Pinerolo (nel quale le culle erano fatte dondolare dal motore idraulico dell’opificio), di 70. Castiglioni, Della fisica educazione deifanciulli, cit., p. 20. 71. Sull’abuso del «bollito» cfr. le considerazioni, valide anche per l’Italia, del Ballexserd
(Dissertazione..., cit., pp. 65 sgg.), che lo descrive come «una mucilagine attaccaticcia, e terrea, composta d’un latte condensato da una farina, che non è stata preparata né dalla natura, né dal fuoco»). Cfr. anche, per una testimonianza relativa a Bergamo, Zucchi, L'istituzione dei ricoveri..., cit., p. 276.
72. Brambilla, Le balie campagnuole, cit., p. 33.
1
quello in funzione dal 1842 per le mogli degli operai delle cartiere Cini a San Marcello in Toscana, e dell’ospizio per lattanti aperto in una grande azienda agraria della Lomellina, e sottolineò infine l’utilità che i ricoveri di quel tipo avrebbero potuto avere nelle campagne, «dove le case rurali sono assai distanti da’ poderi che si lavorano, sicché le madri debbono abbandonare per lunghe ore al giorno i loro bamboli»?3. E in quella stessa sede i congressisti furono informati da Giuseppe Sacchi dei progetti avviati a Milano per l’apertura di quel «ricovero per bambini lattanti» che avrebbe presto assunto un rilievo centrale nelle esperienze assistenziali dell’Italia preunitaria. Il primo «ricovero» milanese fu aperto nel giugno 1850 in contrada di Santa Cristina, nella popolosa e povera parrocchia di San Simpliciano, dopo una fase di studi i quali conclusero che, stante anche la misura assolutamente inadeguata dei sussidi caritativi elargiti alle madri povere durante il puerperio e l'allattamento, nella capitale lombarda «le cure prestate in famiglia ai bambini poveri... procedevano in modo del tutto anormale, e meritavano perciò tutta l’attezione dei buoni per far cessare uno stato di miseria che ancora ci richiama al pensiero tempi di deplorata né più comportabile barbarie»?4. L'istituzione, animata da G. Sacchi e Laura Solera Mantegazza e finanziata con il solo concorso dei privati, si proponeva statutariamente di «agevolare alle madri oneste e povere» che lavoravano fuori di casa l’allattamento e l’allevamento dei loro bambini; a tal fine il «ricovero», aperto ai soli legittimi, era
articolato in due sezioni, quella dei lattanti e quella degli slattati, nella seconda delle quali erano ammessi di preferenza gli infanti allattati dalle proprie madri o ritirati dal brefotrofio dai loro legittimi genitori. I bambini erano accolti tutti i giorni non festivi dalla mattina alla sera, e le madri — salvo i casi di «estrema povertà» — dovevano portarli nella casa di custodia con un corredo di pannilini e pagare un soldo al giorno per contribuire alle spese del mantenimento; le madri che allattavano erano poi tenute a recarsi al ricovero quattro volte al giorno nei primi quattro mesi di vita del loro figlio, e tre volte nel periodo successivo, quando il ricovero cominciava a fornire come alimento sussidiario latte fresco e pappe. Nell’istituzione, dotata del necessario personale femminile di custodia e di un servizio di assistenza sanitaria disimpegnato da tre medici, i lattanti erano 73. Atti della ottava riunione degli scienziati tenuta in Genova dal 14 al 29 settembre 1846, Genova, 1847, pp. 130 sgg. È possibile che le iniziative ricordate dal Valerio non fossero però né le sole né le prime. La successiva ricerca dello Zucchi (L'istituzione dei ricoveri...,
cit., p. 281) ricordava infatti che nel 1837 in una filanda di Trescore i bambini delle operaie «venivano consegnati alla mattina ad apposite custodi in prossimità della filanda per poterli nutrire nelle ore di riposo e riportarli poi a casa alla sera» e che una istituzione dello stesso tipo era stata attivata in una filanda di Zandobbio, dove le madri pagavano 16 o 17 centesimi al giorno per ogni bambino. 74. Sacchi, Sulla fondazione di speciali ricoveri..., cit., pp. 133-134.
113
sistemati in culle di ferro poste in camere attrezzate anche con «una specie di lettiera assai grande» che serviva a governare i bambini, ai quali erano tolte le «improvvide fasciature», sostituite da «capezzali muniti degli opportuni pannilini». Gli svezzati avevano a disposizione giochi di vario tipo e un giardino, dove si abituavano a camminare con il sussidio di «stradicciuole a sostegno», utilizzate per consiglio dei medici al posto di quelle «gabbie di legno, dette volgarmente coregh o guardinfanti» il cui uso era giudicato altrettanto «improvvido» di quello delle fasce; a questi bambini erano fornite tre refezioni giornaliere, a base di minestre di riso, di pappe di latte e di zuppe”. I risultati dell’iniziativa, almeno nella fase di avvio, non appagarono però appieno le attese dei promotori, nonostante il numero relativamente elevato dei bambini ammessi al ricovero di Santa Cristina e a quello, aperto nel gennaio 1852, di borgo Santa Croce (quartiere di Porta Ticinese), che nel 1853
ospitarono complessivamente 148 lattanti e 336 slattati?©. Il principale motivo di insoddisfazione era dovuto alla constatazione che mentre il Sacchi e i suoi collaboratori avevano concepito i ricoveri come strutture destinate al servizio soprattutto delle operaie impiegate stabilmente in manifatture e fabbriche, tanto che la loro ubicazione era stata decisa sulla base della vicinanza a opifici medi o grandi a prevalente impiego di mano d’opera femminile, l’esperienza dimostrò che invece dei «presepi» si erano avvalse in prevalenza lavoratrici a domicilio (filatrici in seta, serventi, cucitrici, sarte) o salariate giornaliere
occupate in maniera saltuaria”: fatto questo che si spiega con le difficoltà che le operaie di fabbrica incontravano ad assentarsi tre o quattro volte al giorno dal posto di lavoro per recarsi all’ospizio. Un altro aspetto negativo fu la discontinuità del ricorso al ricovero, riscontrata soprattutto nella categoria dei lattanti, che nel primo periodo di vita dell’istituzione abbassò la media annua della frequenza a undici giorni al mese per bambino: aspetto questo che aveva le sue cause principali nelle indisposizioni delle madri, nell’invio di molti fanciulli slattati in campagna presso parenti durante l’autunno, nelle malattie infantili e infine nel fatto che spesso le lavoratrici con una occupazione precaria tenevano il figlio presso di sé quando restavano senza lavoro?8. Alle critiche, a volte anche poco benevole, che sulla base di questi elementi e dell’alto costo della «giornata-ricovero» si appuntarono contro l’istituzione, i suoi promotori poterono però rispondere adducendo una contropartita positiva: 75. G. Sacchi, Sulla fondazione del primo ricovero per bambini lattanti in Milano, in «Annali universali di statistica», 1850, vol. 104°, pp. 66 sgg. 76. G. Sacchi, Intorno allo stato morale ed economico del Pio istituto della maternità e dei ricoveri pei bambini
lattanti in Milano durante
130-132. 77. Relazione stata compilata..., cit., p. 85. 78. Ibidem, pp. 86 sgg.
114
l’anno
1853, ibidem,
1854, vol.
118°, pp.
anzitutto la larga utilizzazione che ne facevano le famiglie bisognose; la più bassa mortalità dei bambini ospitati rispetto a quella generale della stessa classe di età?9; il mancato sviluppo di epidemie (eccezion fatta per quella di blefarite ciliare verificatasi nell'autunno del 1850), che smentiva le previsioni pessimistiche circolanti alla vigilia dell’apertura; i numerosi ritiri di legittimi dal brefotrofio di Santa Caterina alla ruota, facilitati dall’entrata in funzione dei «presepi»; e soprattutto gli effetti «morali», che il Sacchi preferiva mettere in primo piano come quelli che gli apparivano più congruenti con lo spirito dell’iniziativa: Il presepio per noi, se non è aperto a quanti bisognosi reclamerebbe la povertà delle nostre operaie, è, per così dire, il focolaio d’onde partono i raggi a germoglio di amore, a morale educazione,
a beneficio e sostegno della maternità; esso è scuola
di affetti, è nucleo di savie dottrine igieniche, è casa di misericordia alle povere famiglie, dove ripara bene spesso col bimbo l’affanno e l’accoramento della madre
desolata80, E del resto va anche tenuto presente che — come Sacchi e i suoi amici non mancavano di replicare a quanti non avevano solidarizzato in pieno con la loro istituzione — il «presepio» nella concezione dei suoi fondatori non era visto come una struttura isolata, ma come uno degli elementi, e sia pure quello centrale, di un più articolato sistema che veniva a configurarsi come un vero e proprio «istituto di maternità» che contemplava nel suo raggio d’azione anche il soccorso alle madri allattanti a domicilio, alle partorienti e alle fami-
glie disposte a ritirare i propri figli dal brefotrofio. La validità dell’idea ispiratrice dei «ricoveri» fu d’altra parte confermata da iniziative analoghe che sull’esempio di Milano vennero presto sorgendo in altre città dell’Italia settentrionale, da Varese, dove nel giugno 1851 si aprì un «Asilo di carità per i bambini lattanti»8!, a Venezia, a Verona, a Trieste82: il
che consente di concludere, in sede di valutazione storica, che l’esperienza pionieristica stimolata dal Sacchi, dalla Solera Mantegazza, da F. Castiglioni e dai loro collaboratori va considerata un primo, fecondo e stimolante punto di partenza dal quale poterono prendere le mosse le altre più numerose e complesse realizzazioni a sollievo della maternità e dell’infanzia che cominciarono, sia pure faticosamente, a essere costruite nei primi decenni dell’Italia unita. 79. F. Castiglioni, Rapporto annuale della direzione medica del Pio ricovero per bambini poveri lattanti di Milano..., in «Gazzetta medica italiana-Lombardia»,
15 settembre
1851, p.
319; idem, Su lo stato morale e igienico della Pia istituzione dei ricoveri dei bambini lattanti in
Milano, Milano, 1852, p. 12; cfr. anche i successivi rapporti annuali dello stesso Castiglioni e del Sacchi. 80. Sacchi, Intorno allo stato morale... durante l’anno 1853, cit., p. 123. 81. Capsoni, Sulle varie provvidenze..., cit., p. 40 n. 82. G. Sacchi, Intorno allo stato morale ed economico del Pio Istituto della maternità e dei ri-
coveri pei bambini lattanti in Milano durante l’anno 1854. Memoria sesta, Milano, 1855, p. 14.
115
5. Il giornalismo del 1848 e la società italiana
Nella rivoluzione liberale e nazionale italiana del 1848 si innestarono tensioni sociali a volte episodiche e momentanee, a volte diffuse e durature: agitazioni dei lavoratori urbani dei mestieri artigiani e delle manifatture, fermenti e movimenti di massa delle popolazioni rurali, manifestazioni di disoccupati, rivendicazioni degli strati più poveri; tutti fatti che richiamarono su di sé, in maniera più o meno larga, l’attenzione di circoli politici, di intellettuali e di giornalisti. E questa attenzione per l’affiorare di quell'insieme di problemi che si cominciava a comprendere nella generica espressione «questione sociale» venne stimolata anche dagli avvenimenti della vicina Francia, dove la seconda Repubblica si trovò presto a dover fare i conti con la diffusione delle idee socialiste, con la questione dell’ «organisation du travail», con il malcontento del proletariato culminato nella sanguinosa esplosione parigina del giugno. In Italia la componente sociale ebbe certamente un ruolo secondario rispetto a quella più propriamente politica nelle vicende quarantottesche; eppure un'analisi volta a ricercare gli echi e i riflessi dei problemi sociali nel giornalismo fiorito in tutto il paese durante il periodo rivoluzionario offre più di un motivo di interesse. Da una parte essa può infatti contribuire a meglio delineare gli orientamenti culturali e ideali di uomini e circoli della parte liberal-moderata e dei loro antagonisti della sinistra democratica; e consente anche di individuare alcuni momenti della lenta presa di coscienza all’interno dei gruppi dominanti delle questioni relative al mondo del lavoro, di seguire gli atteggiamenti dell’opinione pubblica che si esprimeva nella stampa di fronte ai vari aspetti della «questione contadina» là dove questa si manifestò con maggior rilievo, di mettere infine in evidenza alcuni dei fili che formarono la complessa trama del «socialismo risorgimentale». Le brecce apertesi durante il 1847 nel sistema della censura nello Stato pontificio e nel Granducato di Toscana prima che nelle altre parti d’Italia permisero un precoce delinearsi dell’attenzione della stampa periodica di Firen116
ze, Roma e Bologna per i temi di carattere sociale. La fiorentina «Alba» di Giuseppe La Farina, il quale in quei mesi militava in campo democratico, fu infatti il primo giornale italiano di risonanza nazionale del biennio rivoluzionario a prendere in considerazione i problemi che più angustiavano le classi popolari, pauperismo e disoccupazione, e a prospettarne una soluzione ricalcata sulle idee esposte alcuni anni prima da Louis Blanc nella sua Organisation du travail. E Organizzate il lavoro — non a caso — era il titolo programmatico di un articolo del 16 giugno 1847 nel quale si contestava la validità assoluta della libertà economica e si proponeva la creazione di «grandi stabilimenti di manifatture» con il concorso dello Stato: «Fate che il povero operaio possa sempre guadagnarsi un pane col sudore della sua fronte; non sciupate somme enormi in quelle vaste prigioni che decoriamo col nome di pubblica beneficenza, dove il marito è diviso dalla moglie, le madri dai figli, e condannati al carcere perpetuo pel delitto di essere poveri». A distanza di alcune settimane il foglio avanzava poi esplicitamente la tesi del «diritto al lavoro», confermando così di muoversi nell’ambito delle teorie di Blanc: «La Toscana avrà in breve un codice: — si leggeva nel numero del 26 luglio — scrivete sulla prima pagina e legalizzate il diritto naturale di ogni creatura umana, quello di vivere del lavoro delle sua braccia». Che se il riconoscimento dell’esigenza di realizzare legalmente quel diritto imprescrittibile fosse stata negata si sarebbe aperta la strada alla minaccia del comunismo, «questo mostro che bisognerebbe, anziché combattere quando si rivela con un ruggito, prevenire quando serpeggia come aspirazione disperata nella base dell’edificio sociale». Quanto ai mezzi concreti per attuare il diritto al lavoro si suggeriva l’apertura, al posto di quei veri e propri «reclusori de’ poveri» che erano le pie Case di lavoro e d’industria, di «case di lavori pubblici» e di «grandi stabilimenti agricoli», dove i lavoratori e le loro famiglie avrebbero conservato libertà e dignità e sarebbero stati retribuiti «non nella sola ragione diretta del lavoro, ma avendo anche riguardo a’ bisogni del lavorante» (e anche in questa affermazione si può cogliere un’eco del motto di Blanc: «Da ciascuno secondo le sue capacità; a ciascuno secondo i suoi bisogni»). E poco montava se queste istituzioni avrebbero rovinato alcuni grandi imprenditori, perché «che importa alla società se venti o trenta case che rigurgitano di danaro risentano de’ danni, quando i milioni han pane, vestito e tetto; quando la società è salvata dal più terribile de’ pericoli, dal conflitto de’ poveri contro i ricchi?». Le posizioni così espresse nell’«Alba» avevano per altro avuto due anni prima un’anticipazione in un periodico minore fiorentino, la «Rivista», prose-
guimento della «Rivista musicale di Firenze», fondata nel 1840 e inizialmente diretta dall’utopista sociale di formazione hegeliana Luigi Andrea Mazzini e più tardi da Enrico Montazio, una delle figure centrali e più discusse del
giornalismo toscano dell’epoca. E proprio Montazio in uno scritto dell’11 no117
vembre 1845 aveva infatti affrontato la questione del mutuo soccorso, sostenendo l’opportunità che le società mutue si diffondessero anche a Firenze, «una città in cui se le miserie dell’artigiano non sono sì gravi da spingerlo agli eccessi che contristano le più popolose contrade europee, non sono per questo né meno reali, né meno dolorose, né meno permanenti». Ma al pubblicista toscano il solo mutualismo sembrava un mezzo insufficiente a sciogliere il nodo centrale della società moderna, quello della «concorrenza», che a suo
avviso generava non soltanto il contrasto tra grandi e piccoli industriali ma anche quella lotta fra l’operaio e il capitale nella quale «a quello è forza soccombere sotto la protezione di questo». La soluzione definitiva — così suonava la conclusione — stava invece nella «organizzazione del lavoro», «l’unico rimedio che i socialisti contemporanei sappian vedere ai soprastanti malanni» ed al quale anche i più contrari sarebbero stati alla fine costretti a ricorrere «per salvare i pubblici e privati interessi». E sempre a Firenze sul chiudersi del 1847 il «Sabatino», un foglietto popolare redatto dal geografo Francesco Costantino Marmocchi (uno degli organizzatori della prima Giovine Italia in Toscana), nel rilevare l’ingiustizia della divisione della società tra «speculatori» e «produttori» («l’uno... il re della terra, l’altro... lo schiavo attaccato a perpetua e non frangibil catena») accennava a quello che sarebbe diventato durante e dopo il ’48 uno dei motivi di fondo del dibattito ideale all’interno della democrazia, vale a dire il rapporto tra momento politico e momento sociale nella rivoluzione nazionale: «E poi, demagoghi parolai, partigiani delle emancipazioni e delle franchigie, venite a parlare d’indipendenza e d’uguaglianza finché v’è una classe generosa che stenta e lavora per una classe che gode e s’avvantaggia speculando su quei lavori e quelli stenti» (24 dicembre 1847). Per quel che riguarda lo Stato pontificio, va ricordata anzitutto la singolare vicenda del «Povero», il settimanale «popolare» bolognese che era sorto nel gennaio 1846 e che si caratterizzò subito per la sensibilità dimostrata verso la durezza delle condizioni di vita e di lavoro delle classi popolari. Difatti all’interno dell’iniziale impostazione di taglio moralistico, filantropico e sostanzialmente interclassista andò prendendo corpo, dagli ultimi mesi del 1846, un discorso più radicale, che attribuiva esplicitamente la responsabilità
della miseria dei lavoratori ai «ricchi», incolpati di occuparsi soltanto a parole delle sorti delle classi popolari. E questi spunti di radicalismo sociale toccarono il culmine alla metà del 1847 con la pubblicazione di alcuni pensieri Sulla fame ricavati da una pagina di San Basilio e nei quali, dopo l’accusa ai ricchi di essersi appropriati delle cose «che sono comuni» escludendo tutti gli altri dal loro possesso, si leggeva: «Perché se ciascuno non prendesse che ciò, che gli è necessario per la sua sussistenza, e donasse il restante agli indigenti, non vi sarebbero né ricchi, né poveri... Non siete voi dunque avari e ladri, 118
voi che appropriate a voi soli ciò che avete ricevuto per accomunarlo e distribuirlo a’ molti?» (5 giugno). Tali asserzioni, interpretate come una professione di fede socialista o comunista, suscitarono scandalo negli ambienti mode-
rati e conservatori della città e costrinsero i redattori a ripiegare su una meno esposta posizione a sfondo più vagamente umanitario: Io so quali sono i diritti e i doveri de’ricchi e de’poveri; e se si vuol tenere per comunista colui, che vorrebbe non vi fossero poveri in società; che vorrebbe che dai ricchi tutti e con cuore fraterno si pigliasse la più grande sollecitudine di cavare dalla miseria, dalla fame, dai dolori e da ogni pena la maggior parte de’ loro fratelli; che vorrebbe che inspirassero loro forza e coraggio; che li educassero all’amor santo della vera religione, della patria, della società, oh allora io sia pur tenuto un comunista, che me ne vanto (19 giugno 1847).
Più tenue, in confronto con l’esperienza dell’«Alba» e del «Povero», appare l’interesse per la tematica sociale nella stampa periodica romana durante il 1847, con l’eccezione della «Pallade», il quotidiano che si era procurato un buon successo di pubblico per la violenza dei suoi attacchi ai reazionari. Il foglio scese in campo verso la fine dell’anno per sostenere la necessità dell’«intervento dello Stato» per lenire la piaga della disoccupazione, aggravata dall’introduzione
|
delle macchine;
lo Stato avrebbe dovuto, in sostanza,
creare delle «officine nazionali d’industrie manifatturiere ed intraprese» per accogliervi i lavoratori disoccupati in conseguenza del macchinismo e «quei ancora che per mancanza di lavoro affliggono la società con un pauperismo disperato, e colla mendicità cangrenosa». Ma queste strutture, come aveva già sostenuto l’«Alba», non avrebbero dovuto riprendere il modello delle avvilenti pie Case d’industria, strumento di «esilio e schiavitù sociale» degli operai, per qualificarsi invece come istituzioni «di libertà, di moralità, e di garanzia al merito dei lavoratori». In tal modo le officine nazionali, sorte con capitali versati dallo Stato o da questo garantiti, avrebbero potuto funzionare «quasi mezzo di concorrenza e quindi di moderazione alla sfrenata ingordigia della bancocrazia degli aristocratici finanzieri dei lavori industriali che s’infeudano speculando sul merito intellettuale, e sulle fatiche dei lavoranti, ... e
si fanno asiaticamente ricchi col sudore lagrimevole del basso popolo» (16 e 17 dicembre 1847).
Gli sparsi interventi di cui si è fin qui data notizia furono il prodromo di quell’interesse per la «questione sociale» che si fece via via più diffuso dall’inizio del 1848 e che trovò uno dei principali canali di espressione nel giornalismo, reso libero in una misura che non aveva precedenti dalle leggi sulla stampa e dalle Costituzioni. Si è già accennato alla funzione di stimolo svolta in questa direzione dagli avvenimenti francesi. Ed è significativo che sul «Risorgimento», il quotidiano PI9
liberal-moderato di Cavour, fosse lo stesso direttore ad assumersi in prima persona il compito di commentare l’avvento della seconda Repubblica a Parigi. Cavour cercava anzitutto di tranquillizzare l’opinione pubblica circa i possibili sviluppi radicali della situazione francese e i suoi eventuali riflessi in Italia; egli respingeva quindi l’ipotesi che la Francia potesse avviarsi verso una riproduzione della «democrazia tirannica del ’93» ed invitava i suoi connazionali a proseguire nella strada intrapresa senza tentennamenti: «Guai a noi, se, intimoriti dai casi di Francia, vacilliamo un solo istante nella santa impresa della rigenerazione italiana. Guai a noi, se, spaventati dai precipizi che circondano la via che percorriamo, volgiamo incerti lo sguardo indietro verso un passato, da cui siam separati da un abisso insuperabile». Al tempo stesso Cavour coglieva però con grande penetrazione la novità essenziale dei fatti parigini quando rilevava che la rivoluzione di febbraio si prefiggeva non soltanto di stabilire un nuovo regime politico ma anche e soprattutto di «operare sostanziali cambiamenti negli ordini sociali», e che quindi non era l’idea della repubblica o quella della democrazia a spaventare gli animi, ma «lo spettro del comunismo». Spostando il suo discorso sul piano delle teorie economiche il direttore del «Risorgimento» prendeva pertanto a confutare «le dottrine socialiste e comuniste, nate nei cupi cervelli di alcuni filosofi della Germania», e contestava la possibilità di una modificazione dei processi distributivi della ricchezza tra le varie classi della società attraverso la limitazione o l’attacco al diritto di proprietà. Il nucleo dell’argomentazione cavouriana era ricavato dalla dottrina liberista classica sul risparmio e sulla proprietà. Posto cioè che la prosperità dei popoli poggiava sull’accumulazione continua dei capitali e che questi erano una creazione del sacrificio e del risparmio, ogni mutamento che avesse leso il principio di proprietà avrebbe bloccato «l’impulso della forza che spinge tutte le classi della società a risparmiare» e si sarebbe risolto in un danno generalizzato sia per i ricchi che per i poveri. Che se invece i novatori pensavano
a un intervento sulla produzione, come
sembrava orientato a fare il Governo provvisorio di Parigi, si sarebbe arrivati ad accogliere la tesi della «organizzazione del lavoro», la parte «meno assurda» ina «più speciosa» delle dottrine socialiste. Per non parlare dell’imprudenza «temeraria» di attribuire allo Stato compiti di intervento in materie quali la durata del lavoro o la misura dei salari, l' «organizzazione del lavoro» interpretata come pretesa di assicurare il lavoro a tutti gli operai rispettando le loro competenze professionali appariva a Cavour un’«assurdità», perché così facendo la produzione delle merci avrebbe dovuto essere regolata non sulla base della loro domanda ma su quella del numero degli individui addetti ai vari settori. La conclusione era che la questione della «garanzia del lavoro» andava piuttosto risolta — e qui Cavour era consapevole di esprimere un'opinione non condivisa dalla maggioranza degli economisti europei — at120
traverso lo strumento della «carità legale», così da «raffermare l’edifizio so-
ciale, senza far cadere sullo Stato gravi ed insopportabili pesi»: una carità legale da realizzare quindi sulla base del presupposto che i soccorsi pubblici avrebbero dovuto mantenere i loro destinatari «in una condizione peggiore dell’operaio indipendente». In tal modo si sarebbero tolti al «comunismo» i suoi argomenti più temibili e si sarebbero migliorate le sorti delle classi popolari «senza mettere a repentaglio l’esistenza stessa dell’ordine sociale» (6, 11 e 17 marzo 1848).
La crisi politica francese e le sue possibili ripercussioni sulla situazione italiana furono giudicate in quegli stessi giorni in maniera più aperta dall’altro quotidiano torinese, la democratico-costituzionale «Concordia». Il foglio di Lorenzo Valerio il 4 marzo negava che la Francia si fosse incamminata verso la «legge agraria» o il «comunismo industriale», perché il fallimento dei tentativi fino ad allora effettuati e le carenze delle teorie avanzate avevano dimostrato l'impossibilità di raggiungere la riorganizzazione della società seguendo i modelli proposti dalle varie scuole socialiste; ma si augurava al tempo stesso che la Repubblica francese prendesse l’iniziativa delle «riforme sociali» a favore delle classi lavoratrici, mentre l'Europa e l’Italia — che, impegnata nel problema della nazionalità, non avrebbe dovuto lasciarsi distogliere dal suo compito per seguire le esperienze straniere — avrebbero atteso l’esito dell’esperimento. «Noi siamo d’avviso — terminava la “Concordia” — che oltre le riforme politiche altre riforme verranno in campo... Finora si considerò il popolo nei suoi rapporti colla sovranità nazionale, ora si considera in relazione al suo benessere, e alla maggiore o minore partecipazione a’ prodotti de’ suoi lavori». Quali poi dovessero essere i contenuti di queste riforme veniva precisato dal giornale in un articolo dell’11 marzo, dovuto probabilmente allo stesso Valerio. La Francia era ormai entrata — si diceva — «in una serie di esperienze sociali difficili e pericolose», dominate dalla presenza del «proletarismo»; e quindi il suo avvenire dipendeva dall’«applicazione dei principii sociali», fra cui essenziale era quello dell’ «organizzazione del lavoro», che avrebbe dovuto garantire all’operaio un minimum salariale tale da bastare alla sua esistenza quotidiana e da permettergli un accantonamento di risparmi per «provvedere ai cattivi giorni dell’industria, a quelli dell’infermità e della vecchiaia». E a questo punto la «Concordia» collegava i problemi della società francese con le prospettive politiche italiane poiché — questo il tenore dell’argomentazione — la Francia non avrebbe potuto tentare da sola l’ «organizzazione del lavoro» e sarebbe quindi stata costretta a cercar di uscire dalle difficoltà «per via di guerra»: una guerra all’ Austria che avrebbe necessariamente coinvolto anche l’Italia e alla quale si sarebbero dovuti preparare i governi della penisola, che invece si mostravano ancora esitanti e incerti di fronte alla potenza asburgica. Questo scritto provocò un intervento polemico nello stesso foglio di Giuseppe Bertinatti, discepolo e amico di Gioberti, che cercava di ricondurre il 121
problema dell’organizzazione del lavoro all’interno dei principî della carità e della fratellanza cristiane. Bertinatti sottolineava la difficoltà di conciliare l’«organizzazione del lavoro» (che doveva a suo avviso tener presente non soltanto la produzione, ma anche la distribuzione della ricchezza, «e non già
come venne finor considerata, astrazion fatta dal maggiore o minor benessere morale e fisico degli operai medesimi») con il rispetto della libertà individuale e della proprietà privata; ma finiva con il concludere che il governo repubblicano francese sarebbe stato in grado di risolvere la questione, e senza ricorrere alla guerra, se avesse adottato l’«idea cristiana»: «Esso può mostrarsi sinceramente e francamente cristiano, ed abbattere così d’un colpo tutte le reli-
quie del paganesimo governativo, del materialismo pratico, e dell’egoismo tradizionale di chi sopravvigliò [sic] finora alla cosa publica» (28 marzo 1848).
Anche fuori del Piemonte il tema dell’«organizzazione del lavoro» e del connesso «diritto al lavoro» fu uno dei punti centrali al quale si rannodarono le prese di posizione della stampa periodica in materia di problemi sociali. La linea di demarcazione tra chi si mostrava favorevole a quelle tesi e chi le osteggiava non coincideva però con la distinzione di campo tra moderati e democratici. E quindi ai giudizi del foglio moderato milanese «Pio IX», vicino al Governo provvisorio, che il 20 aprile tacciava di «dannosa utopia» 1’ «organizzazione del travaglio di Blanc e compagni» (perché «il travaglio dovrà avere il fondamento sulla libertà, e la libertà maritata all’industria procreerà la concorrenza, e la concorrenza lo smercio, principio d’ogni ricchezza e d’ogni vita sociale»), cui contrapponeva la pratica del risparmio e del mutuo soccorso (che avrebbe dovuto essere favorita dai datori di lavoro, esortati a «largheggiare coi dipendenti meglio che pel passato»)!, si possono accostare quelli di Francesco Domenico Guerrazzi, che sul democratico «Corriere livornese» del 4 aprile condannava il «diritto al lavoro», che avrebbe soffocato lo spirito di iniziativa e convertito il mondo in una «confraternita di Fratelli Moravi».
1. Già prima dell’introduzione della libertà di stampa, dell’«organizzazione del lavoro» si era occupata a Milano nel dicembre 1847 la «Rivista europea» con la recensione di Giuseppe Levi a un lavoro francese (pp. 640 sgg.). Va anche ricordato che nella Milano liberata dalle Cinque giornate il tessitore Bortolo Negri (0, secondo altre fonti, Bartolomeo Negro) espose il 1° maggio nel circolo «Palestra parlamentaria» un suo progetto di «organizzazione del lavoro tendente alla maggiore educazione, moralità e sicurezza degli operaj» («Il Nazionale», Milano, 2 maggio 1848; «Il Repubblicano», Milano, 4 maggio 1848; «L’Emancipazione», Milano, 8 maggio 1848). Poco benevolmente la «Gazzetta di Milano» (supplemento del 2 maggio 1848) così presentava l'intervento del Negri: «Parlò per ultimo il cittadino Negro, e questi non lesse ma parlò veramente e fece piacere per l’ilarità con la quale esponeva le sue chiarissime idee, e per qualche profondità ne” suoi principj sull’organizzazione del lavoro... Egli aveva cominciato coll’organizzazione di una bottega di quattro operaj, e con certi suoi lepidi di più ci aveva condotti fino ad un opificio in cui ve ne fossero quattro mila, e diceva di non aver ancora finito. Misericordia!».
122
L’idea dell’«organizzazione del lavoro» era invece accolta a Roma dal «Labaro», un foglio «religioso-politico» pubblicato da una società di ecclesiastici ed inizialmente orientato in senso neoguelfo. In un fondo del 10 maggio E. Fabiani, pur negando per l’Italia l’esistenza di un «pericolo del comunismo», la «terribile piaga» che si andava aprendo nella società moderna, si mostrava consapevole della necessità di provvedere alle «miserie del popolo minuto», ben note a «noi sacerdoti costretti dalla vocazione del ministero a trovarci ad ogni istante al letto, e presso alla mensa, fra i dolori, e i lamenti
del povero». E lo strumento per mitigare queste sofferenze, dato che l’elemosina non faceva che accrescere il male, doveva essere l’ «organizzazione del
lavoro», sia pure accompagnata dai conforti e dall’ispirazione della religione; anche se poi la sua attuazione era affidata non all’intervento dello Stato ma alla benevola disposizione d’animo dei ricchi, invitati a sacrificare una parte dei loro averi per consentire la formazione del «capitale della organizzazione del lavoro», così da garantire ai lavoratori «un’onesta retribuzione delle loro fatiche». Pochi giorni dopo su un foglio provinciale dello Stato pontificio, il ravennate «Romagnolo» del 24 maggio, si poteva invece leggere che l’ «organizzazione del travaglio» era un’utopia diffusa dagli eventi francesi e che il solo sistema per dare lavoro agli operai era «quello d’inculcar loro di lasciare le piazze e le strade e rientrare negli stabilimenti d’industria e nelle officine» a lavorare «per l’usata mercede e per l’usato tempo». A Napoli una temperata propensione verso la parola d’ordine coniata da L. Blanc manifestarono giornali che pure esprimevano gli orientamenti di gruppi diversificati tra di loro all’interno del movimento liberale e nazionale. Alla domanda di lavoro dei «proletari», fattasi ormai «imperiosa» nella capitale meridionale, il giornale di Ferdinando Petruccelli della Gattina — quel «Mondo vecchio e mondo nuovo» che si era collocato all’estrema sinistra dell’arco politico — sosteneva che bisognasse rispondere con l’istituzione di «case di lavoro», concepite come una via di mezzo tra gli «ateliers nationaux» e le pie Case d’industria, i cui capitali d'impianto avrebbero potuto essere forniti dalle rendite dei monasteri e dei vescovadi (25 aprile). In sale bene aerate — questo il quadro tratteggiato dal foglio — si allogherebbero delle officine, differenti secondo le arti; e, se si può, separando i sessi, e gl’infanti dagli adulti. Ciascun’arte debbe avere un capo dei più probi e più istruiti...: ciascuna officina un sotto capo, o maestro diretto... Questo maestro sceglierà tra i suoi alunni i più provetti ed i meglio addestrati, e li addirà ad istruttori degli altri, formando in un certo modo una scuola di mutuo insegnamento.
Il «Mondo vecchio e mondo nuovo» era stato però preceduto dal liberalmoderato «Riscatto italiano»; il giornale di Pasquale S. Mancini, allarmato dai sintomi di malcontento della «plebe» napoletana, già il 16 marzo aveva affer123
mato — in uno scritto del suo redattore più assiduo, Achille de Lauzières — che per le classi popolari la questione di fondo non era quella del mutamento delle istituzioni politiche, che riguardava soltanto i «signori», ma quella del pane e del lavoro: questione che andava affrontata prendendo esempio dai provvedimenti proposti da L. Blanc alla Commissione del Lussemburgo, senza peraltro trascurare la «forza» per «tenere la plebe a dovere». E a difesa della concreta «ragionevolezza» dell’organizzazione del lavoro» si espresse infine il «Nazionale» di Silvio Spaventa, con una argomentazione permeata di quella hegeliana concezione del divenire della società come storia della libertà e della ragione circolante nel giornale: La forza delle idee — scriveva infatti il «Nazionale» in data 12 maggio — si fa via 0ggidì non tanto per rimbalzo nelle passioni, quanto per la loro intrinseca ragionevolezza: onde conseguita che il loro processo di attuazione è più continuo e concreto che non sarebbe, se fosse mosso da scomposti effetti e sollevamenti di fantasia. Si citi un sol caso nella storia più recente dove non veggasi l’impronta di questa concretezza, che noi riconosciamo come propria dello spirito generale del nostro tempo: la stessa «utopia», come piace a molti dire, della organizzazione del lavoro, accettata in principio dal nuovo Governo repubblicano in Francia, e creduta generalmente come cosa impossibile a mettersi in pratica, non si valuta altrimenti dagli stessi francesi che meno hanno fede in essa, se non come necessità ineluttabile della presente società loro.
Il quale carattere di necessità, ond’essa si riveste agli occhi de’ più increduli, è una prova della parte concreta che essa ha in sé, la quale non può mancare di farsi valere, sia qualunque la forma che dovrà assumere?.
Il dibattito sull’«organisation du travail» e più in generale sulle dottrine socialiste e comuniste in Francia tornò ad animare il panorama giornalistico italiano subito dopo l’insurrezione degli operai parigini del giugno 1848 provocata dalla decisione del governo di abolire gli «ateliers nationaux». L'orientamento largamente prevalente fu quello della condanna degli insorti, con la correlativa chiamata in causa del «socialismo» e del «comunismo».
Si era trattato, questo il giudizio di Cavour sul «Risorgimento» (30 giugno), «di salvare l’ordine sociale da una distruzione assoluta, di serbare intatti i sacrosanti principii della famiglia e della proprietà, minacciati dal socialismo e dall’anarchia»; bisognava quindi gioire anche in Italia per la vittoria degli amici dell’ordine, «giacché se il comunismo
vinceva a Parigi, difficilmente
2. A conferma dell’attenzione della stampa italiana per il tema dell’organizzazione del lavoro si può accennare, oltre che ai commenti occasionati dalle giornate parigine del giugno di cui si dirà più avanti, a due articoli apparsi all’inizio del 1849 ed entrambi risolutamente contrari a qualsiasi concessione a progetti di quel tipo: il primo nella «Gazzetta di Milano» (supplemento del 12 gennaio, Cenni intorno ad alcune teorie sul lavoro divulgate in Francia dai moderni riformatori. Organizzazione del lavoro), il secondo nel «Positivo» di Roma (25 gennaio, Il diritto al lavoro).
124
l’Italia e la Germania sarebbero giunte a tenerlo per lungo tempo lontano». E sullo stesso foglio il giorno prima Giorgio Briano aveva attribuito la causa della «rivoluzione sociale» parigina alla «diffusione delle idee socialistiche e comunistiche tra le classi degli operai» ed aveva invitato i lavoratori italiani a trar frutto dai rovinosi avvenimenti francesi e a moderare le loro aspirazioni al cambiamento. Anche la democratica «Concordia» il 1° luglio si rallegrava del trionfo del governo repubblicano di Parigi e subito dopo, proclamata la necessità di rispettare «tutti i diritti, tutti gli interessi», asseriva che la Francia porgeva all’intera Europa «un esempio tremendo del male che si fa col voler attaccare di fronte le basi sociali e distruggere in un giorno l’opera accumulata dei secoli»; aggiungendo però, quasi a bilanciare questa difesa dell’ordine costituito, che i diritti e gli interessi dei ceti abbienti andavano conciliati con quelli degli operai, «la classe più benemerita e finora pur troppo la più mal ricompensata della Francia». D’altra parte questa linea di cautela critica verso le agitazioni del proletariato francese era stata anticipata dal giornale il 14 giugno in uno scritto che, dopo aver approvato la legge sugli «assembramenti», così proseguiva: La mala prova delle officine nazionali, e i vani sforzi della Commissione presieduta da Luigi Blanc al Luxemburgo hanno pienamente dimostrato che... non s’intaccano impunemente le fonti stabilite dalla pubblica ricchezza. Per voler sostituire bruscamente l’industria dello Stato all’industria privata, si rovinò questa, e quella non riuscì, né poteva riuscire. Imperocché, cosa può mai lo Stato, se il concorso de’ privati gli manca?
Tra i commenti della stampa milanese ai fatti parigini spicca quello di Mazzini sull’«Italia del popolo». Il genovese, preoccupato che si potesse addossare all’avvento della Repubblica in Francia la colpa di un terribile scontro che era stato «sociale» e non «politico», e che la condanna dei repubblicani d’oltralpe potesse coinvolgere quelli italiani, negava anzitutto che nel nostro paese, privo di «grandi centri manifatturieri» e senza rilevanti squilibri tra le classi, esistessero condizioni simili a quelle che in Parigi avevano spinto all’insurrezione i più che centomila disoccupati, avanguardia di quei «milioni d’operai, uomini, donne, fanciulli, invalidi per vecchiaia e miseria», che
erano sparsi per tutta la Francia, pagati con un salario «inferiore ai bisogni» e incerti dell’avvenire. E svolgendo il filo del suo ragionamento Mazzini finiva con l’imputare — come Cavour — l’esito drammatico degli avvenimenti francesi al comunismo, nella specie del neobabuvismo diffusosi e ordinatosi a setta sotto Luigi Filippo; una setta «non solamente distinta dai repubblicani, ma armeggiante contr’essi», setta che, aggiungeva per ribadire l’assoluta estraneità dei veri repubblicani ai luttuosi eventi di Parigi, aveva potuto mettere radici nel proletariato francese perché nel 1830 al posto di una repubbli125
ca decisa ad aprire alle masse «una via di miglioramento pacifico, ... una valvola di sicurezza alla loro foga di attività, una speranza non menzognera ai loro bisogni», così da sciogliere la «questione sociale» con la «libera associazione promossa dal Governo», si era impiantata una monarchia basata sul culto degli interessi e dei privilegi: «Gli operai trovarono la proprietà ordinata, privilegiata a danno dell’utile loro e intesero col Comunismo a distruggere la proprietà; trovarono lo Stato chiuso per ogni dove alle loro domande, e intesero a rovesciare lo Stato»3. Mentre dunque Mazzini operava una netta distinzione tra repubblica da una parte e socialismo e organizzazione del lavoro dall’altra, nei fogli moderati milanesi l’insurrezione di giugno veniva presentata come la necessaria conseguenza
dell’instaurazione
della repubblica;
come
faceva
1’ «Avvenire
d’Italia», per il quale il logico sbocco del febbraio era l’utopistica «organizzazione del lavoro» di Blanc che «fe’ nascere nel popolo una calda speranza di miglior avvenire, la quale, quando fu dall’esperienza dimostrata impossibile a conseguirsi, si convertì in ira cieca, accresciuta dalla miseria, fomentata dai tristi, scaldata da un socialismo sovvertitore» (3 luglio). Né da questi schemi interpretativi si discostò la generalità degli altri giorna-
li italiani, dal «Vessillo italiano» di Modena, dove Francesco Carbonieri scriveva il 7 luglio che non bisognava lusingare la «plebe» con teorie assurde come
quella dell’«organizzazione
del lavoro», alla «Patria» di Firenze, che si
compiaceva il 3 luglio con Celestino Bianchi per il trionfo della causa dell’ordine, aggiungendo che gli operai parigini, «usciti testè dalla dura tirannia degli opificj, tirannia ignota fra noi, si assisero pieni di speranza sugli scanni del Lussemburgo, dov’ebbero in pastura de’ cupidi e incerti intelletti il vaniloquio di Luigi Blanc». Voci cui si possono affiancare quella del «Cittadino italiano» di Livorno, che vedeva nell’insurrezione di Parigi l’opera del comunismo ed esortava a far tesoro di quelle esperienze per «inculcare nel popolo» la convinzione che all’esercizio dei suoi diritti doveva unire l'adempimento dei doveri verso Dio e la società (6 luglio); e quella della romana «Epoca» che, pur riconoscendo in Francia l’esistenza del «pauperismo», sosteneva che il problema sociale poteva arrivare a soluzione soltanto con la libertà, e non con esperi3. «L'Italia del popolo», Milano, 2 e 3 luglio 1848 (e in G. Mazzini, SEI, vol. 38°, pp. 130 sgg.). Già prima, in un articolo del 24 maggio, l’«Italia del popolo» aveva condannato congiuntamente la violenza borbonica del 15 maggio a Napoli e quella dei «sedicenti» repubblicani a Parigi sostenendo che «le riforme politiche e sociali non sono legittime quando il popolo non le accetta» e polemizzando con Barbès, il quale «voleva impoverire i ricchi per arricchire 1 poveri».
4. Cfr. anche l’ «Operaio galantuomo» del luglio che, parlando dei «demagoghi», scriveva: «E sapete poi qual sia l’effetto delle costoro dottrine? Domandatene la Francia, ed ella per risposta vi mostrerà migliaja de’ suoi figliuoli scannati da altri figliuoli».
126
menti di socialismo alla Blanc, che davano nelle mani dello Stato «tutta la forza, tutta la possanza, tutti i capitali, tutta la direzione della società» (10 luglio). Unica nota discorde appare perciò quella della milanese «Voce del popolo», che in un fondo del 19 luglio dedicato alle giornate di giugno così esprimeva la sua simpatia per gli operai parigini: Il proletario inglese vive nobilmente colla tassa dei poveri, il compagnone allemanno carco di denaro e di ninnoli non arrossisce d’andar mendicando di officina in officina la passata; il lazzariglio spagnolo fa di meglio, domanda la carità appuntando lo schioppo; l’operaio francese dimanda del lavoro; e se invece del lavoro voi gli offrite l’elemosina, egli si rivolta e vi risponde a colpi di fucile. Io amo meglio l’operaio francese ed io vo superbo d’appartenere a questa razza fiera, inaccessibile al disonore.
A una presa di coscienza più immediata e determinata dei gravi problemi sollevati anche nel nostro paese dalla struttura dei rapporti di produzione e dalla concreta articolazione del tessuto sociale fece velo nel corso del ’48-°49 la convinzione diffusa che il largo prevalere nell’economia italiana dell’agricoltura — e un’agricoltura alla quale si attribuiva in generale una funzione equilibratrice per le caratteristiche del regime proprietario e la natura dei contratti — avrebbe preservato la penisola dai mali che avevano colpito le nazioni coinvolte dal processo di industrializzazione. Ed abbonda la documentazione di un topos tanto diffuso quanto poco fondato su una conoscenza realistica del mondo contadino. Fortunata l’Italia che non conosceva i mali che affliggevano «le classi artiere nelle contrade manufattrici dell'Occidente», si rallegrava sul «22 marzo» Tullo Massarani, che così proseguiva: Nella nostra società... l’uguaglianza di diritto ha già messe immarcescibili radici. La nostra magnifica terra rimerita largamente le fatiche del colono, e lo alletta alla vita salubre e tranquilla dei campi, alle gioje serene e moralizzatrici della famiglia. Non x avvilito da pesi degradanti, non isvigorito da spostamenti ripetuti, egli è e si sente consociato più presto che servo agli interessi del proprietario... Paese il nostro essenzialmente agricola, non ruppe mai il prezioso equilibrio fra la produzione e la consumazione (20 aprile 1848).
Quasi di rincalzo dalla vicina Brescia l’«Unione» di Gabriele Rosa il 27
aprile esortava gli italiani, fortunati abitatori di un paese eminentemente rurale, a non invidiare e anzi a compiangere «la sorte di quelle nazioni che sono costrette a stivare nelle grandi officine, in ambienti corrotti, lungi dall’almo conforto del cielo aperto e degli effluvi della vegetazione, una grande parte della popolazione, condannata a lavoro incessante, monotono, che non lascia tempo a distrazione, e che impedisce lo sviluppo delle più soavi affezioni morali». E questo perché quelle nazioni, nonostante le loro ricchezze e la grande concentrazione di capitali industriali
127
e commerciali, non soltanto era-
no esposte alle fluttuazioni delle crisi ricorrenti, ma erano anche «flagellate dal pauperismo», e quindi dal «conflitto delle associazioni delle plebi contro i possidenti ed i capitalisti». Poco dopo era un altro giornale milanese, la repubblicana «Emancipazione», a escludere che in Italia fosse da temere una crisi come quella che affliggeva la Francia e minacciava gli altri paesi «industriosi», dal momento che «la questione sociale fra noi è ancora intempestiva perché il pauperismo non ci ha stretti per anco colla sua mano di ferro» (29 aprile e 3 maggio). E un ragionamento analogo era svolto dalla romana «Pallade» in uno scritto del 10 maggio già richiamato: «Per noi l’ubertà del suolo, la moltiplicazione delle manifatture non solo non spinte ad eccesso, ma anzi assai minori del bisogno, e l’abbondanza dei soccorsi d’ogni fatta han sempre reso men duro lo stato dei non proprietari, e allontanato perciò il pericolo del comunismo». Ideologia ruralista che era poi la stessa che ispirava — con maggiore consapevolezza e più elevata dignità culturale — le posizioni degli intellettuali «campagnoli» toscani in quella difesa della mezzadria che esaltava, come faceva Luigi Guglielmo di Cambray-Digny all’inizio del 1849, le «virtù domestiche» della «classe vergine» dei coloni, argine saldissimo contro i sommovimenti delle masse provocati dal fermentare delle questioni sociali: «Il colono mezzaiolo ha col padrone comune l’interesse al buon fruttato della terra... Questa comunità d’interessi delle due più grandi classi del nostro popolo costituisce una solidarietà di tendenze e di affetti che nessuno potrà mai diminuire, non che distruggere, e che è la maggior garanzia, la più salda base della solidità del nostro ordinamento sociale»S. E proprio nella «Patria», l’organo di Bettino Ricasoli e degli altri moderati «campagnoli», era apparsa verso la metà del 1848 una lirica esaltazione delle virtù taumaturgiche della mezzadria (indebitamente
assunta come
contratto prevalente in tutta la penisola),
quella mezzadria che a detta dell’articolista aveva impedito in Italia il permanere di un’aristocrazia feudale e aveva eliminato la disuguaglianza e l’oppressione sociale: «In un paese ove i privilegi sparirono cancellati dalla sapienza de’ legislatori, non dalla scure delle rivoluzioni, ove la tirannide industriale è ignota, ove il lavoro è libero, ove l’agricoltore si asside col padrone del fondo,
e secolui divide alla pari i frutti della terra, ove sono generalmente lontani gli estremi dell’opulenza e della miseria... il popolo è tutto» (8 luglio). Ma la realtà di una struttura sociale connotata da squilibri e contrasti e nella quale andavano emergendo i sintomi di un profondo malessere avrebbe presto incrinato questo quadro ottimistico e manierato, anche se la maggior parte del giornalismo quarantottesco continuò a caratterizzarsi per il suo taS. G. di Cambray-Digny, Cenni sui pericoli sociali in Toscana, memoria letta alla R. Accade-
mia dei Georgofili di Firenze nell'adunanza del 7 gennaio 1849, estr. dagli Atti, t. 27°, pp. 3-6.
128
glio essenzialmente politico, all’interno del quale la corda sociale veniva in generale toccata per deprecare gli eccessi di Francia, per invocare la concordia e l’affratellamento in vista del riscatto nazionale6, per esorcizzare lo spettro del comunismo? o per dissipare — come stava a cuore ai democratici — le confusioni più o meno interessate tra comunismo e repubblica8, e per riaffer6. Un esempio tipico di questo genere esortatorio è lo scritto Fratello operajo di Costanzo Giani nella milanese «Italia rigenerata» del 12 luglio 1848, dove si legge tra l’altro: «Io so che popolo sono anche i ricchi, che in loro soli non stanno i vizj, né le virtù nei soli poveri, e che quindi non si otterrà mai un popolo collo staccarli, col rendere l’una classe odiosa all’altra; ma bensì col mostrar loro il bisogno d’intendersi reciprocamente ed i particolari doveri non solo di giustizia, ma anche di convenienza, amendue elementi indispensabili ad ottenere la maggiore felicità possibile degli uomini, così pure la pensa l’illustre Mazzini». (Lo scritto fu riprodotto in «L’Operajo», Milano, 3 giugno 1848). Altre testimonianze di questo atteggiamento mentale sono nel «Brianteo» di Monza e nel milanese «Servitore di piazza». Il primo nel suo Programma così si indirizzava ai ceti abbienti (6 aprile 1848): «A voi pure ci rivolgiamo o conduttori di fabbriche, a voi ricchi padroni di beni e di case! deh! prestate anche voi mano pietosa alla santa opera della rigenerazione morale e materiale di questo nostro popolo, se pur non volete che mirando con bieco ed invido occhio ai vostri industriali stabilimenti, alle vostre case magnifiche, ai vostri sterminati poderi, maledica all’egoismo di chi s’innalza a prezzo de’ suoi sudori, della sua vita; ma sì invece benedica l’ora del risorgimento in cui vide i proprj padroni prestarsi quali fratelli amorevoli ad illuminarlo». Quanto al secondo, scriveva il 27 maggio 1848 in un articolo intitolato Gli operai: «Gli operai sono l’elemento principale della vita sociale, e noi dovremmo amarli, stimarli, elevarli da quell’abbrutimento in cui furono finora gettati... Se noi ricambiassimo con un po” d’amore tutti i loro martirj, vedremmo insieme abbracciati capitalista ed operajo, lavoratore e ricco, e non ci toccherebbe di vedere quel brutto spettacolo d’una fatale disarmonia fra le classi... Riteniamo che la beneficenza è un dovere sacrosanto, non uno slancio di sentimento, e che
è maledetto chi non presta il suo obolo al mendico e all’operaio, sia esso sano od infermo». 7. Valga per tutti uno scritto apparso sul veneziano «Indipendente» del 17, 19 e 20 aprile 1848 ed incentrato sulla necessità di istruire la «plebe» sul significato vero dei termini libertà,
repubblica, eguaglianza: parola, quest’ultima, alla quale «l’uomo ignorante o traviato dalle suggestioni di alcuni male intenzionati, e nemici del bene pubblico» avrebbe potuto dare «una latitudine che non comporta, e spingere l’idea fino al comunismo». Un esempio del tipo di critica alle ideologie comuniste più largamente corrente nella pubblicistica quarantottesca la si può avere da questo brano di un opuscolo di Luigi Coddè (Pensieri sull’ordine sociale da servire d’istruzione al pubblico e di professione di fede politica, Milano, 1848): «Quel comunismo che distrugge il possesso e la famiglia è immorale e colpevole come la tirannia dei re sedicenti padroni della vita e delle sostanze dei popoli. Senza famiglia e senza possesso non si può svolgere né il sentimento di amore, vincolo della famiglia come della società, né il sentimento del giusto e dell’onesto, origine e base di prosperità della famiglia e della società. Tale comunismo tocca quindi l’estremo del vizio dell’assolutismo, e distruggono tutti e due l’individuo e la società». 8. La questione era così toccata dal milanese «Repubblicano» del 27 aprile 1848 nel corso di un’analisi delle modificazioni intervenute nell’opinione pubblica dopo le Cinque giornate: «Suscitaronsi inoltre nel popolo altre allarmanti idee. Il Comunismo fu dimostrato essere necessaria conseguenza della repubblica; si propose l’esempio della Francia; si dipinsero con tetri colori gli ultimi avvenimenti di quell’eroico paese. Cominciarono i ricchi a tremare sulle loro proprietà, e mentre dapprima (anche per private invidiuzze) sarebbero stati repubblicani, unironsi con un solo voto agli aristocratici... Gli allarmi del Comunismo influirono adunque fortemente sull’opinione de’ ricchi, che disertando dalla bandiera repubblicana, alla cui ombra
si credeano malsicuri, sotto l’altra rifugiaronsi, che prometteva tutelarli dai tumulti popolari».
129
mare infine — e in questo si distinguevano i fogli moderati — la provvidenzialità dell’esistenza dei ricchi e dei poveri, come faceva la «Gazzetta di Brescia» del 9 luglio 1848 in uno scritto che val la pena di riportare ampiamente come testimonianza esemplare, nella sua franchezza a volte brutale, di una mentalità assai diffusa tra i ceti dominanti: Certo se per aristocratici vogliansi intendere i ricchi o agiati, — così si esprimeva l’articolista, che si proponeva di negare l’esistenza di una aristocrazia regolatrice della vita politica bresciana — o se vogliansi con tal nome divisare quelli qualunque che hanno il potere, la famiglia umana sarà in eterno partita in due classi, e non sappiamo in vero immaginarci quando sia mai per prendere effetto il sogno di alcuni che hanno ne’ voti, e quasi sotto gli occhi una tale uguaglianza che tolga affatto questa distinzione. Non è bisogno che si dica per noi, che sempre comanderanno i meno e obbediranno i più, sempre i meno passeggeranno in carrozza e i più a piedi, i più andranno nel campo o nell’officina e i meno vivranno alle lautezze e in ogni abbondanza di cose. Ma chi non sa e vede che questo è ordine della Provvidenza, ed è appunto un beneficio di tutti, e che, siccome una società tutta composta di poveri sarebbe un
abisso di miseria, una società tutta composta di ricchi è un assurdo ancora più grande?... Quelli pertanto che s’adoprano a risuscitare questa parola [aristocrazia], invece che muovere il popolo a libertà, gettano in esso il mal seme di inique invidie; lo dividono in due parti ...; ne incitano la porzione più numerosa contro i decreti della Provvidenza; lungi dal rialzare le plebi alla dignità di popolo vieppiù le abbrutiscono in empi delirii, allontanandole dal santo sentiero del lavoro, per perderle nel furore del sangue.
Fuori di questi stereotipi una preoccupazione sincera per le condizioni delle classi popolari e l'aspirazione a una riforma di un assetto sociale eccessivamente sperequato si fecero largo in alcuni giornali di più o meno manifesta ispirazione democratica pubblicati nelle città maggiori, e anche in qualche centro provinciale. È questo il caso, nella capitale lombarda, della «Voce del popolo», il quotidiano di Romolo Griffini e Pietro Maestri che si contraddistinse per l’insistente trattazione dei temi economici. Il giornale si soffermava sulle prospettive di «emancipazione delle classi popolari» il 31 marzo, a pochi giorni di distanza da quella liberazione della città che era stata in gran parte opera per l’appunto di popolani, di lavoratori manuali, tanto che, come avrebbe detto Carlo Cattaneo a commento del suo «registro mortuario» degli oltre trecento caduti delle Cinque giornate, «le barricate e li operai vanno insieme oramai come il cavallo e il cavaliere»?. Gli uomini del popolo, diceva il giornale milanese, avevano fino ad allora tratto poco frutto dai grandi rivolgimenti politi9. C. Cattaneo, Registro mortuario delle barricate in Milano, in «L’Italia del popolo», Milano, 3 luglio 1848 (e in C. Cattaneo, Tutte le opere, a cura di L. Ambrosoli, vol. 4°, Milano,
1967, pp. 145-148).
130
ci, dopo i quali erano tornati «alla... fatica improba e sprezzata, al... pane bagnato di servo sudore». Ma questo destino, suonava l’augurio della «Voce del popolo», non si sarebbe dovuto più ripetere: La patria redenta, penserà agli stenti della vostra esistenza, all’asprezza de’ vostri travagli, alla vita che voi sfiorate precocemente nell’eccessivo e brutale lavoro dell’officine; alla scarsa porzione che vi tocca nella ricchezza sociale; ai vostri figli che l’ignoranza abbandona alle tentazioni della colpa; all’onore delle vostre figlie che la fame getta talvolta vittime all’ignobili voglie del ricco. La patria redenta cancellerà le ineguaglianze che finora vi hanno divisi dagli altri fratelli; vi chiamerà all'esercizio di tutti i diritti sociali ridonandovi alla dignità cittadina; ... darà a tutti quell’istruzione che è il pane dello spirito, ed assicurerà al vostro lavoro un pane meno scarso ed ingrato; farà che tutti insieme progressivamente realizziamo sulla terra il regno di Dio, il regno dell’eguaglianza e della giustizia.
Sulla questione del pauperismo, «cancro delle moderne società», si incentrava a sua volta l’analisi dell’«Emancipazione», un altro foglio milanese che
si richiamava al mazzinianesimo. L’«Emancipazione», la quale tuttavia riteneva che quel male fosse ancora poco progredito in Italia, ne individuava la radice nel «sopravvento» preso dal capitale sul lavoro in virtù di fenomeni quali «la divisione del lavoro, il perfezionamento della meccanica e l’applicazione a questa della forza del vapore» e, in linea con la dottrina sociale mazziniana, indicava come cura specifica l’«associazione»:
«Il solo rimedio con-
tro tanto male è l’associazione; essa ridona all’opera dell’uomo la propria dignità, riduce il capitale a non essere che uno strumento produttivo. Con tale sistema in ogni opificio, pagate le materie prime ed un equo interesse de’ capitali, il di più dovrebbe compartirsi tra gli operai» (29 aprile 1848). E, sempre a Milano, un associazionismo di stampo cooperativo fu propugnato dall’«Operajo» di Pietro Perego ed Enrico Cernuschi, un giornaletto il cui populismo antiaristocratico e vagamente classista non ne fa certo un foglio filocomunista, come invece all’inizio del luglio 1848 lo presentarono i suoi avversari in un libello che qualificava i redattori quali «sovvertitori della morale, comunisti, instigatori contro i ricchi». L’«Operajo» precisò invece a più riprese che la sua rivendicazione di una maggiore eguaglianza sociale escludeva il metodo della violenza, della guerra civile, e che era inutile e dannoso gridare «Morte ai ricchi! Abbasso i ricchi! ed altre simili giullerie». La via da battere per «avvicinarsi allo scopo dell’eguaglianza» era piuttosto quella della formazione di società cooperative e di produzione, la cui fisionomia e la cui funzione venivano così sommariamente delineate: Queste società servirebbero ad impedire che i più furbi abbiano ad accaparrarsi per loro tutti i lavori, che i più poveri abbiano a rovinare i loro confratelli o col minimo prezzo che esigessero dai loro lavori, o colle viltà che molte volte si commettono in (31
un momento d’estremo bisogno. Queste società non sarebbero in principio, che accademie di mutuo soccorso, quindi crescendo i mezzi avressimo in breve un fondo, onde poter intraprendere in comune i lavori tutti spettanti alla tal arte a cui la società appartiene (19 giugno 1848).
A Venezia l’interesse per i temi di natura sociale si manifestò soprattutto nelle pagine del «San Marco» e del «Precursore», due fogli pubblicati tra la fine del 1848 e l’inizio del 1849, quando il declino della parabola rivoluzionaria permetteva ormai di tracciare un primo bilancio delle più recenti esperienze. E proprio uno sforzo sincero di riflessione sulla questione del rapporto tra masse popolari e movimento nazionale nel corso del ‘48 animava lo scritto La rivoluzione e il popolo apparso sul «San Marco» del 21 dicembre 1848. Il giornale — diretto da due giovani democratici, Giovanni Piermartini e Bernardo Canal, che avrebbe finito i suoi giorni a Belfiore — metteva a ragione l’accento sull’indifferenza popolare per le rivoluzioni esclusivamente politiche, attribuendo a un «povero artiere» queste considerazioni: «Se in esse noi abbiamo poco da perdere, nulla troviamo da guadagnare: il lavoro, la fatica, le privazioni saranno, in qualunque condizione il nostro paese si trovi, nostro esclusivo retaggio, ed i signori che avranno invocato pei loro fini ambiziosi il soccorso delle nostre braccia, ottenuto un giorno mercè nostra l’intento, ci lasceranno ultimo rifugio un letto nell’ospedale, una fossa nel cimitero». Dopo questa amara constatazione il foglio deplorava il distacco, prodottosi nel secolare corso storico, tra intellettuali e popolo: distacco al quale veniva attribuita la responsabilità dell’atteggiamento delle masse, «dacché nessuno presso di noi o quasi nessuno fra coloro cui la fortuna aveva sortito ricchezze od ingegno si era accomunato col povero, e si era mai degnato di sentire le sue dolorose querele, e dividere con esso la tristezza delle sue grandi sventure». E la severa autocritica culminava in queste affermazioni: Se noi fossimo stati daddovero compresi dal sentimento di amore per la umanità e dal grande scopo di un politico rivolgimento che dev'essere sempre scala ad un miglioramento sociale, avremmo tenuto colla classe povera un ben diverso contegno. Associandoci alle sue sofferenze, rassicurando i suoi dubbii, sviluppando la sua intelligenza, provvedendo alle sue necessità, conciliando i suoi interessi coi nostri e con questi identificandoli in un solo e grande interesse comune
per tutti, noi avremmo
trovato un eco alle nostre grida di libertà, un ajuto nei nostri sforzi, un sostegno nei nostri pericoli. Così come
si è fatto sin ora, il popolo ammaestrato da una serie di rivoluzioni, che
queste non riescono quasi mai ad uno scopo di comune utilità, ma solo ad esclusivo vantaggio di pochi, che le sue fatiche rimangono sempre le stesse né meglio vengono rimeritate, che le sue sventure non scemano per cangiar di governi della loro intensità, che a lui non resta che soffrire e morire, disprezzato ne’ suoi giusti desiderj, conculcato ne’ suoi santi diritti, non si scosse in tutto il suo onnipotente furore, e,
cessato il primo entusiasmo che le grandi parole riferite e ripetute avevano pure in
132
lui risvegliato un istante, si allontanò dal movimento, e, freddo spettatore delle varie vicende, per poco non ritornò nella sua fatale apatia.
L'analisi si concludeva con il riconoscimento della necessità di una «grande riforma sociale», i cui termini restavano però nebulosi perché non venivano definiti i mezzi con cui realizzare i fini assegnati a quella riforma, che si
sostanziavano nel compiere l’educazione del popolo e nel rendere «assicurato, garantito, rimunerato
debitamente
il lavoro». E tuttavia enunciazioni
di
questo tipo, che probabilmente risentivano dell’assimilazione di motivi mazziniani, bastarono perché gli avversari politici accusassero il giornale di favorire la propagazione del comunismo e del socialismo; accuse alle quali il «San Marco» replicava con un invito a distinguere tra le due dottrine, la prima da respingere, la seconda da valutare positivamente qualora essa fosse stata intesa, in maniera riduttiva, come «l’idea progressiva del perfezionamento sociale, idea che abbraccia l’intelligenza e la prosperità, il bene dell’individuo e quello delle famiglie, della patria e di tutti i popoli, e che anela bramosamente di rannodare i vincoli della fiducia e dell’amore spezzati indegnamente da tanto tempo dalle cupidigie sfrenate dei pochi e dall’influsso malefico della prepotenza e della tirannide» (29 gennaio 1849). Sul tema del comunismo e del socialismo intervenne anche il «Precursore», diretto da quel Pacifico Valussi che già nel 1847 aveva dimostrato nel suo «Osservatore triestino» una acuta sensibilità per la «questione sociale», documentata anche dall’attenzione con cui aveva seguito le idee sostenute dalla fourierista «Démocratie pacifique». Pur respingendo il «comunismo», perché comportava «un livellamento, una rivoluzione, una violenza, un rovesciamento d’ogni ordine attuale», Valussi mostrava di non condividere le condanne sommarie pronunciate nei suoi confronti dai ricchi e dai potenti. «Colui è comunista, — dicono; — scriveva in un articolo intitolato appunto Comunismo,
socialismo (11 febbraio 1849) — ed è come
se dicessero un /adro,
quando il più delle volte significa un affamato. Ora agli affamati vostri fratelli darete voi pietre, o pane? I gaudenti della terra dicono alla povera plebe affamata: orde di barbari della civiltà. Disgraziati, se civiltà vera fosse la loro,
non sarebbero minacciati da questa nuova invasione barbarica». E quindi le idee comuniste gli sembravano non un’aberrazione ma il «sintomo di una malattia sociale», la conseguenza
necessaria dell’assetto profondamente
in-
giusto delle società moderne, che rendeva comprensibili le aspirazioni dei comunisti a un loro capovolgimento violento: «I comunisti somigliano in tutto agli schiavi pagani, i quali stanchi di portare le loro catene, si provarono di quando in quando di spezzarle sulla testa dei loro padroni. Questi si tenevano ed erano per certa guisa più inciviliti dei loro schiavi; ma quest'ultimi agivano secondo un naturale istinto che li portava a liberarsi». 133
Quanto al «socialismo», esso era interpretato da Valussi come «un mezzo pacifico di riordinamento sociale, un trovato della scienza da applicarsi colla persuasione, e per gradi successivi, alla società presente», così da ristabilirvi
l’«armonia» (e si noti il termine, di probabile derivazione fourierista). Per il giornalista friulano il socialismo, al di là delle peculiarità delle singole scuole, era quindi dominato dal «principio cristiano». E questo fatto avrebbe dovuto indurre «gli uomini saggi, spregiudicati e desiderosi del bene della società a studiare il socialismo, ed investigare i motivi che gli avevano dato origine, a cercare quanto di opportuno ai tempi e di salutare veramente vi può essere in quelle dottrine». Si trattava in sostanza di arginare la «libera concorrenza», generatrice del «monopolio» e del «pauperismo», con la «libera associazione», che nel pensiero di Valussi avrebbe dovuto riallacciarsi alla tradizione nazionale delle corporazioni di arti e mestieri, con le quali gli italiani avevano anticipato l’«organisation du travail». E quanto ai contenuti concreti di questa «associazione», essi andavano desunti non da un particolare sistema socialista, ma dai suggerimenti di quegli studiosi e filantropi che avevano individuato un vasto arco di istituzioni benefiche e previdenziali la cui realizzazione avrebbe dovuto concorrere a un rapido miglioramento delle condizioni di esistenza delle classi popolari: Perché a Parigi lo scorso giugno vi fu una rivoluzione, nella quale soffiarono dentro molti partiti per pescare nel torbido, vorremo noi rinuziare ai presepi per i lattanti, alle sale d’asilo per l’infanzia, agli scaldatoi pubblici, alle cucine, ai forni, ai lavatoi
comuni, alle associazioni di mutuo soccorso, alle associazioni di operai partecipanti ai frutti del loro lavoro, ed a tutte quelle altre associazioni infinite, iniziate e da farsi,
e dai socialisti quotidianamente promosse e proclamate, associazioni tendenti tutte ad ispirare al povero, all’operaio, come al ricco ed all'uomo colto, lo stesso amore dell’ordine e della conservazione?
Spostando ora l’analisi a Firenze, va messa anzitutto in evidenza la singolare esperienza del «Popolano», lo «scarlatto» foglio di E. Montazio!0 che, fino a quando questi ne tenne la direzione (8 gennaio-5 maggio 1848), fece del pauperismo e dell’organizzazione del lavoro due degli argomenti più dibattuti nelle sue pagine. Motivo dominante di questi interventi fu l’asserzione della necessità di porre fine all’oppressione che «l’aristocrazia del sangue e l’aristocrazia del danaro» esercitavano a danno della «classe proletaria» (8 gennaio). Questo obiettivo andava perseguito non con l’abolizione del diritto di proprietà ma
10. La definizione è di Montanelli (Memorie sull'Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al 1850, vol. 2°, Torino, 1853, pp. 435-436).
134
con una sua regolamentazione mirante a ostacolare «ogni sordido accumulamento di poderi e di case» nelle mani dei ricchi. Impedite che una mostruosa opulenza, — così si esprimeva Montazio nell’articolo Del reparto dei beni apparso nei numeri del 15 e 22 gennaio — nel trasformare in lussureggianti passeggiate le fertili nostre campagne, condanni alla sterilità questa terra feconda data all’uomo da Dio per nutrirlo. Raffrenate l’insaziabile passione d’acquistar incessantemente nuovi beni: diminuite le grandi ricchezze, diminuite le grandi eredità.
Nella prospettiva di una necessaria saldatura tra rivoluzione politica e mutamento sociale veniva poi formulato l’invito a non ripetere gli errori commessi dai rivoluzionari francesi dell’89 che, pur avendo a disposizione i due terzi del suolo del paese, anziché «farne un fondo comune inalienabile» e «dividerlo in poderi da darsi in affitto a cittadini non possidenti» così da diminuire il numero dei proletari, avevano venduto la terra ai «nuovi ricchi», perpetuando così «la razza dei diseredati, dei paria: razza sventurata, razza maledetta la quale coltiva la vite e beve acqua solamente, semina e raccoglie il grano e mangia soltanto pan nero e patate». E la conclusione suonava che tutti gli sforzi degli amici sinceri del popolo — in uno spirito di abnegazione solidale di tutte le classi — si sarebbero dovuti indirizzare ad «ottenere la politica eguaglianza e la formazione d’un fondo comune mediante il quale fosse concesso ad uno Stato l’assicurare a tutti i sudditi il dritto che essi hanno di vivere». Il carattere sociale della rivoluzione europea, che metteva all’ordine del giorno il problema dell’organizzazione del lavoro inteso come problema dell’equilibrio tra capitale e lavoro, era ribadito dal «Popolano» in un articolo del 4 aprile dedicato per l’appunto all’Ordinamento del lavoro. A poco serviva — si sosteneva nello scritto — attribuire al socialismo e al comunismo, come faceva-
no i conservatori e i gruppi dirigenti, la colpa del fermento che pareva minacciare l'ordine sociale dei paesi europei, perché se pure le teorie socialiste e comuniste avevano probabilmente accelerato la crisi, una rivoluzione sociale non poteva essere originata «fuorché dalla coscienza delle moltitudini troppo lungamente conculcate ed oppresse dal dispotismo di caste inventate dall’arbitrio e dai mali istinti degli uomini, non dal volere di Dio». A queste affermazioni così recise faceva però seguito, ad attenuarne la portata, un rifiuto altrettanto deciso dei modelli di organizzazione del lavoro elaborati dalle varie scuole francesi, che avrebbero dato al governo «il monopolio dell’industria e del commercio» e avrebbero trasformato la civiltà europea in una civiltà «orientale». Assai aperto alle istanze di riforma della società si dimostrò nel corso della sua breve esistenza (17 dicembre 1848-13 gennaio 1849) il piccolo quotidiano fiorentino «Il Tribuno della plebe», che si qualificava «organo dell’opinione radicale-democratica» e che fu redatto da Roberto Berlinghieri, un senese che per le sue riflessioni politico-sociali traeva ispirazione dal cristianesimo 185
sociale di Lamennais. Nello scritto di maggior rilievo apparso sul foglio, i Lavori di un prigioniero politico fatti in carcere (19 dicembre), Berlinghieri sosteneva che il diritto di proprietà sugli immobili, e quindi sulla terra, era «relativo» e non assoluto, perché poteva essere giustificato soltanto dal lavoro: «Proprietaria assoluta del suolo che occupa è la nazione. Proprietario relativo per titolo di pubblica utilità è l'individuo che ha reso questo suolo fruttifero. Ciò che egli paga annualmente allo Stato, non è veramente una tassa, ma più tosto un canone, per il godimento che di quel terreno gli accorda la nazione». E la conseguenza che discendeva da queste premesse era che i «veri proprietari» della terra avrebbero dovuto essere considerati i contadini, pochi dei quali erano invece in Italia «lavoranti sul suo, cioè quelli che colle loro mani lavorano i propri possedimenti». Ma il corso delle idee di Berlinghieri — che per le sue teorie venne accusato di «comunismo» dai moderati toscani!! — risulta molto più chiaro in alcuni suoi manoscritti sequestratigli dalla polizia granducale alla fine del 184612. In uno di questi (la prefazione a una traduzione della Roma sotterranea di Charles Didier) Berlinghieri aveva indicato con precisione gli strumenti fiscali utilizzabili per realizzare una maggiore giustizia sociale: Però vogliamo funzionante il diritto che ha ogni individuo della società di vivere, lavorando a seconda delle sue forze e dei suoi mezzi; che non sia gettata al povero l’elemosina che lo avvilisce, ma che la società venga in di lui soccorso,... con la giustizia che non comporta mancar 1 mille del necessario, perché nuotino i cinque e i dieci nel superfluo. Che sia perciò abolita ogni imposta la quale direttamente o indirettamente colpisca i generi di prima e di seconda necessità. Che tutti i monopoli, balzelli, pedaggi, regalie vengan soppressi come vecchia bigiotteria monarchica, e reso all’uomo di godersi liberamente i frutti della terra e dei suoi sudori. Che si provveda alle pubbliche spese con una tassa diretta e invariabile su i beni fondi, considerata qual canone che l’individuo usufruttuario paga alla nazione proprietaria; con una tassa proporzionale e progressiva sopra il superfluo delle famiglie; con una tassa essa pure proporzionale e progressiva sul trapasso delle proprietà.
In alcune note apposte a una traduzione del Libro del popolo di Lamennais si poteva poi leggere che la «servitù» nella quale vivevano quasi dovunque le 11. «Il Tribuno della plebe», Firenze, 20 dicembre 1848, articolo Il comunismo. Nello scrit-
to, in risposta a questa accusa, si diceva che «il comunismo fu fondato da Gesù Cristo», e che comunisti erano stati i primi apostoli e i primi cristiani. Il 18 dicembre il giornale aveva affermato che se l’eguaglianza assoluta delle fortune era una «chimera» e il comunismo un’ «utopia», una maggiore eguaglianza era però un diritto del popolo, e che bisognava favorirla con un sistema di tassazione che colpisse i ceti abbienti. 12. ASF, Buon governo segreto, anno 1847, fascio 20.
136
classi popolari era originata dalle «arbitrarie, mostruose diseguaglianze sociali», le quali avrebbero potuto essere eliminate soltanto dal «trionfo della eguaglianza cristiana» e dalla «applicazione del Vangelo alle istituzioni sociali»; e che non poteva durare a lungo un «disordine sociale» a causa del quale conquiste della scienza come il vapore e le macchine recavano profitto agli speculatori e agli industriali, mentre i lavoratori sostenevano «una fatica eguale o maggiore con guadagno forse più scarso» o languivano «privi di pane». In questo stesso manoscritto Berlinghieri, infine, aveva così argomentato dettagliatamente la sua tesi della «nazione proprietaria» del suolo: A chi concesse Iddio la proprietà di questo globo che abitiamo? Alla specie umana. Dispersa questa per l’ampia superficie, ciascuna nazione, ciascuna tribù occupò e fruttifera rese la porzione di cui trovossi abitatrice. Così avvenne per le famiglie: il possesso fu conseguenza del lavoro. Ravvicinati, poco a poco, i limiti dei respettivi possessi dalla moltiplicazione dei figli d’ Adamo, chi mai avrebbe potuto impor legge che quei limiti fossero rispettati? Questa legge la impose la Società, la Società sola proprietaria del suolo nazionale, e la impose nell’interesse di tutti; e tutti se ne acquietarono, perché tutti avevano di che vivere: che se fosse stato altrimenti giammai chi da tal legge si fosse trovato spogliato dei mezzi di sussistere, giammai voluto avrebbe sanzionare colla sua acquiescenza l’altrui possesso; e volendolo, potuto non lo avrebbe, poiché il diritto alla propria esistenza, e molto più a quella dei figli e dei discendenti, è sacro ed inalienabile. Dunque, al dover sociale, che impone rispettare l'altrui proprietà, vi è implicitamente annessa la condizione, che il cittadino non proprietario trovi nel proprio lavoro mezzo di sussistenza sufficiente. Dunque al padre di famiglia, che non ricusa lavoro, se di ciò ad onta la sussistenza manca, è debito della società
venire in suo aiuto; e ciò che pei singoli è dovere di carità, è per la Società intera dovere di giustizia, poiché, come dissi, la condizione d’avere di che sussistere è necessariamente implicita nell’abbandono che quel padre di famiglia, o i di lui autori, espressamente o tacitamente fecero dei loro diritti al territorio originariamente comune... Non deve dunque giammai darsi, tra i cristiani, la possibilità che una popolazione famelica, impugnate le armi della disperazione, sia tratta a scrivere sulle sue bandiere... «Vivere lavorando, o perire combattendo».
Ragionamento dal quale venivano infine ricavate queste conclusioni: Che i singoli non sono che possessori, ma che proprietaria del suolo... è la sola nazione. Che il suolo non è patrimonio dell’individuo se non in quanto è da lui reso fruttifero, prima per sé, poi per tutti. Che l’imposta territoriale altro non è, se non il canone livellare che il dominio utile (il possessore) paga al dominio diretto (la nazione). Che il possessore dispor non può se non se della superficie che utilizza coll’agricoltura e colla pastorizia... Che della superficie stessa il proprietario non può disporre, che ad utilità permanente, non mai a distruzione. Le foreste, per es., restano proprietà nazionale, non avendo il singolo possessore altro diritto che quello del pascolo, e d’un taglio regolare e moderato, salvo che convenga dissodare il terreno per ridurlo a più utile cultura.
137,
Che la trasmissione della proprietà d’uno in altro possessore non può avvenire se non se col consenso
tacito o espresso della nazione, la quale ha diritto di sottomettere
questo trapasso a delle regole, vincolarlo a delle condizioni, renderlo passibile di qualche proporzionata e progressiva retribuzione, a tenore della pubblica utilità. Che sopra il superfluo dei singoli ha la Società dritto imprescrittibile per ottenere il fine fondamentale che veruno manchi del necessario.
Nel giornalismo «questione sociale» logna tra il marzo Achille Serpieri, la
dello Stato pontificio la voce più avanzata in tema di continuò ad essere quella del «Povero». Il foglio di Boe l’aprile 1848 cercò di definire, con alcuni articoli di concezione di un «socialismo» che traeva ispirazione dal
Vangelo («il socialismo è... la carità, la cura, l’amore del povero») e la cui
carica si esauriva all’interno di un generico riformismo umanitario, come risulta chiaro da questo brano (16 marzo
1848, articolo // socialismo):
Oggi il socialismo si è posto a base del governo democratico, onde il popolo abbia lavoro continuo e compenso adeguato; onde entro i limiti dell’onesto la fatica dell’operaio sia la minima, massimo il guadagno; onde l’assoluta mancanza di travaglio non getti alcuno nella corruzione, nel vizio, nel delitto; onde l'elemosina sia interdetta...; onde l’artigiano giunto all’età dell’impotenza meccanica trovi un soccorso vitalizio; onde i soli invalidi al lavoro siano mantenuti dallo Stato; onde all’ope-
raio rimanga mezzo e tempo d'’istruirsi conforme alla sua condizione ed alla sua capacità; onde finalmente quelle tante rivoluzioni sociali che si son fatte dal popolo, ridondino veramente a vantaggio del popolo.
Ma l’indeterminatezza di questa visione del «socialismo» non deve far trascurare il fatto che proprio nel «Povero» di quelle settimane si possono leggere alcune tra le più energiche affermazioni sulla necessità di dare alla rivoluzione politica in atto contenuti sociali di immediato interesse per le masse popolari, le quali non avrebbero potuto essere coinvolte nel movimento dalla sola concessione della libertà e del diritto di eguaglianza giuridica: A che cosa ci servirebbe infatti l'acquisto di tali diritti, — si diceva in un articolo del 7 aprile intitolato A quelli che temono il socialismo — se non facessimo sortire alcun risultato serio, alcun miglioramento fondamentale per l’umanità le cui speranze si rivolgono verso di noi? Che cosa servirebbe a quelli che soffrono, a quelli che sono continuamente inquieti del pane dell’indomani, l’aver cangiato di forma di governo, se le tristi ansietà del passato continuassero a serrare loro il core; se il popolo, vale a
dire la gran massa degli uomini, continuasse a schiacciare le loro facoltà intellettuali sotto un lavoro da schiavi, i cui frutti sono appena sufficienti per sostentar loro la vita del corpo?... Qualunque sia la forma di un governo installato dalla politica, questo governo non sarà mai che un colosso di rame coi piedi d’argilla, se il socialismo non gli viene in aiuto pel miglioramento materiale e morale delle sorti di tutti.
138
L'esame che si sta compiendo approda ora a Napoli, dove quella stessa esigenza di stabilire un collegamento tra i ceti popolari e il movimento liberal-nazionale che era stata sottolineata dal «Povero» fu ripetutamente avanzata, prima che la giornata dal 15 maggio 1848 restituisse l’iniziativa alla monarchia borbonica e ai gruppi reazionari, da «Critica e verità» e dal «Mondo vecchio e mondo nuovo», del quale si è già messa in rilievo l’attenzione per l’ «ordinamento del lavoro». «Critica e verità», un foglio di orientamento giobertiano redatto dal giovane studioso di filosofia Angelo Santilli (poi ucciso nella repressione del 15 maggio), invitò ripetutamente e con energia il governo costituzionale di Napoli a combattere il dilagante pauperismo (14 marzo) e ad accompagnare la «riforma liberale» con misure di riforma economica tendenti all’accrescimento «delle industrie agricola, manifatturiera e commerciale» (17 marzo). E con tono particolarmente incalzante, dettato dal timore che il popolo «basso» della grande città potesse diventare una massa di manovra della reazione, Santilli tornava a battere sul tema in un fondo dal titolo La nazione vuol pane (20 marzo). La nazione vuol pane e lo dimanda incessantemente: lo chiede nel pianto della indigenza, tra le sciagure della desolazione: lo chiede non a titolo di preghiera, ma di dritto necessario, assoluto... Il popolo non capisce la speculativa astrazione di talune verità: egli non sa i titoli di libertà, di costituzione, di uguaglianza: egli sa solamente di languire nella miseria e chiede pane... Non puossi concepir dalla plebe l'altezza dei sentimenti liberali, dunque non si può pretendere di appagarla con la forma del governo, e quand’anche si potesse comprendere, quando un popolo non ha di che mangiare non può gioire di alcuna riforma... Governo e ministri all’opere, via; alle opere: non perdete tempo. Qui a Napoli è miseria infame e la miseria impone: nelle pubbliche piazze il popolo duolsi dei tempi, il popolo freme, vuol pane... La Nazione vuol pane: dovreste,
o governo, o ministri, lasciar tutto e pensare alla sa-
via distribuzione delle ricchezze.
Anche il «Mondo vecchio e mondo nuovo» constatava addolorato che «la plebe napoletana, ... pieghevole, ignorante, ghiotta, chiacchierona, piena di curiosità e goffamente religiosa», si dimostrava poco amica della Costituzione e degli ordinamenti liberali; e nel sollecitare una politica di lavori pubblici ricercava la radice di questo stato d’animo nel disinteresse dimostrato da borghesia e governo per le condizioni di vita degli strati popolari (27 marzo 1848): La plebe... è abituata a veder le cose in pratica e non in teoria, a guardare il presente e non il futuro; laonde, argomentando dallo stato attuale di cose, ha poco motivo di contentarsi del novello regime, poiché essa vede respingersi con la forza dalle classi civili il giorno dopo di essere stata abbracciata e soccorsa;
... si vede, ciò che
forma più peso, trascurata dal Ministero, che non si briga affatto di rianimare le opere pubbliche...; si vede, infine, mancare il lavoro dei privati, i quali, o preoccu189
pati, o perplessi, o timidi si astengono dal fare qualsivoglia spesa che non sia di prima necessità.
Con il la stampa compreso avanzata
clima repressivo stabilitosi a Napoli dopo il 15 maggio gli spazi per libera vennero drasticamente ridotti; e tuttavia nel difficile periodo tra il dicembre 1848 e il marzo 1849 si colloca la voce forse più del giornalismo meridionale sul piano delle idee sociali, quella
dell’«Indipendente»,
un quotidiano di tendenza democratica
diretto da Mi-
chele Pironti. Il foglio sosteneva nell’articolo programmatico (4 dicembre 1848) di essere scritto «per quella parte della società che mangia il pane del dolore, che indura nelle asprezze de’ lavori e delle fatiche, che soffre e spera e che si chiama popolo». Se, in realtà, 1’ «Indipendente» non fu affatto — né per i contenuti, né per il taglio del linguaggio, né per il grande formato e la severa impostazione grafica — un giornale «popolare», adatto cioè a una circolazione tra i ceti popolari, pure tenne fede al proposito iniziale di avere ben presenti i problemi sociali, legati alle dure condizioni di esistenza delle classi lavoratri-
ci. E questo gli procurò presto le consuete ed inevitabili accuse di «comunismo» messe in circolazione dagli avversari politici: accuse dalle quali il giornale si difese con un’analisi della società meridionale che, se metteva giustamente in rilievo la mancanza di grandi concentrazioni di capitale industriale, presentava però in modo distorto la realtà delle campagne, dal momento che negava l’esistenza di quella grande proprietà fondiaria nobile o borghese che invece caratterizzava l'agricoltura del Mezzogiorno (13 dicembre 1848):
E poi il nostro popolo, come l’ha mostrato coi fatti, non vuole il comunismo; perché non ha ragioni per volerlo. Ciò ch’esso desidera... è il pacifico godimento del suo buon diritto... D'altra parte il comunismo più che altrove è impossibile appo noi. La terra è qui divisa e suddivisa in modo che ad ognuno n’è toccata una parte per occuparla e coltivarla, ed i grandi proprietari di fondi si contan sulle dita, ed il popolo vive con essi in buona e perfetta amicizia. Manca dunque l’aristocrazia fondiaria, comunque sopravviva quella miserabilissima de’ titoli...: manca pure l’aristocrazia dell’industria manifatturiera, ed i capitali non sono veramente concentrati nelle mani di alcuno, ma circolano e si diffondono nelle mani di tutti... Come mai dunque può esservi il sospetto del comunismo tra noi?
Ma anche in un contesto così chiaramente dettato da esigenze difensive, in cui si affermava di aborrire «l’anarchia e il disordine» e di respingere le «concezioni ultra-democratiche di Owen» e le «teoriche ultra-dispotiche di Saint-Simon» e si proclamava il «rispetto alla proprietà de’ cittadini», veniva tuttavia riconosciuto «il dritto nello Stato di organarla e ricomporla secondo i principii immutabili della scienza» (13 dicembre 1848). E proprio all’intervento dello Stato — uno Stato costituzionale e democratico — era assegnato il 140
compito di provvedere alla piaga del pauperismo con una serie di misure che contemplavano la fondazione di casse di risparmio e di banche di piccolo credito, la riforma delle assicurazioni (che, «trattate finora commercialmente», sarebbero dovute divenire «istituzion civile» così da porre fine alla «iniqua guerra» tra «mercanti e braccianti»), l’alleggerimento delle ipoteche, la creazione di ospedali e monti di pietà, l’istituzione di «colonie di artigiani» per dare vita a nuove industrie, e soprattutto l’agevolazione al «povero» dei «modi di acquistare la proprietà d’una particella di quella terra ch’egli inaffia di sudori e di concime» (10 febbraio 1849)!3,
Lungo questa linea, ispirata alla convinzione che il vertiginoso movimento dei tempi moderni aveva «piuttosto un carattere sociale anziché politico» (24
febbraio 1849), l’ «Indipendente» sostenne recisamente la necessità di studiare il socialismo nelle sue varie tendenze e non di esorcizzarlo come facevano i «ricchi», criticati con durezza per la loro pavida inerzia intellettuale: Essi si spaventano, s’impauriscono e tremano a verghe come fanno i bimbi, sol che loro s’intuoni all’orecchio questa parola scomunicata di socialismo! Ledru Rollin! Felix Pyat! Louis Blanc! Proudhon! Dio ce ne liberi! E si segnano con la croce, e s’imbacuccano, s’appiattano sotto le coltri come se fosse apparso l’orco o la befana. Ce ne dispiace, ce ne duole proprio nell’animo! povere bestioline! meritano ogni riguardo; ma, lo ripetiamo, si diano alla lettura o vadano a scuola, ed anziché sospirare
che la spada di Radetzky, ch’è il primo brigante del mondo, scenda a tutelare le loro proprietà e le loro ricchezze, non ambite, né toccate o manomesse da chicchessia, troveranno invece più salda e potente guarentigia, più ferma e solida difesa nell’onnipotenza della ragione... E senza pronunziarci né in favore, né contra taluni avvenimenti che si verificano poco lungi da noi.... non possiamo però tenerci dal plaudire quegli spiriti inquieti che presi da una forte agitazione, per afferrare la felicità, che è il desiderio di tutta la nostra esistenza, coraggiosamente s’immolano nel ricercarla!4.
Nello stesso scritto veniva poi esaltato il ruolo svolto da quanti si erano occupati con passione della «scoperta del nostro meglio sociale» e avevano 13. Su alcuni di questi temi il giornale tornò gli articoli Condizioni degli ospedali e mezzi di sulla beneficenza pubblica in Napoli (21 marzo 14. A questa esigenza di studio del pensiero tire dal numero
del 10 marzo
nei numeri successivi; si vedano in particolare migliorarli (19 febbraio 1849 sgg.) e Pensieri 1849 sgg.). socialista va collegata la pubblicazione, a par-
1849, dello scritto di L. Blanc // socialismo.
Diritto al lavoro.
Risposta al sign. Thiers. Questo scritto venne stampato anche in opuscolo, sempre nel 1849, dal tipografo napoletano Gaetano Nobile. Il traduttore, Vincenzo Caprara, mostrava una chiara simpatia per le idee di Blanc, la cui formula del «diritto al lavoro» giudicava preferibile a quella del «diritto all’assistenza» sostenuta da Thiers (p. 60). In un altro passo Caprara scriveva che scopo della sua traduzione era «presentare ai dotti e ai potenti il triste quadro delle condizioni altrui, affinché specchiandovisi dentro prendano motivo di studiare le piaghe della nostra società e cercare di apportarvi opportuno rimedio» (pp. 9-10).
141
criticato la civiltà moderna «sia col mezzo di finzioni più acerbe dello stesso biasimo diretto, sia appoggiandosi a progetti di riforme studiate e metodiche, sia in fine mescolando la pratica alla teorica, l’azione alla speculazione». Tra-
dizione di pensiero radicale nella quale venivano accomunati Moro e Bruno, Campanella e W. Penn, Bernardin de Saint-Pierre e Rousseau, considerati precursori delle più recenti formulazioni del socialismo moderno, il quale aveva il suo fondamento nell’«agitarsi continuo ed incessante dell’umanità verso uno scopo finale d’immegliamento e di prosperità ferma e durevole». Tra i fogli minori provinciali quello che sottolineò nel modo più incisivo la questione del rapporto tra masse popolari e rivoluzione denunciando senza mezzi termini l’insufficienza di un mutamento soltanto formale, che non assicurasse la sussistenza ai lavoratori, fu il democratico «Tribuno del popolo» di
Piacenza. Qui il 1° giugno 1848 il parroco Antonio Civetta, affermati l’equivalenza del «diritto al pane» al «diritto all’esistenza» e l’obbligo dei governi — assoluti o democratici che fossero — di farsi carico dell’indigenza che colpiva artigiani e contadini, constatava che anche gli avvenimenti del ‘48 non avevano portato ad alcun miglioramento nella condizione dei ceti popolari: Ma pur troppo, non so per quale destino, il popolo che opera sempre le grandi rivoluzioni, e che proclamando la libertà, non fa che rivendicare i suoi proprii diritti, è sempre l’ultimo a sentirne gli effetti, se pure ne sente mai nessuno. Dichiarandosi sovrano non fa che cambiare padrone, e sembra condannato
zimbello alla tirannia dei maligni, che non gridano solo i vantaggi di quella! camente: niente, o quasi
a servire eternamente
di
despoti, al fasto oltraggioso dei grandi, alla scaltrezza dei libertà, e popolo se non per abusarsi di questo, e sfruttare Che cosa si è fatto fino adesso pel popolo? diciamolo franniente: qual vantaggio ha esso ricavato dalla rivoluzione,
dallo sfratto dei tedeschi, dal cambiamento
di governo? Nessuno, o quasi nessuno.
Sempre le medesime gravezze, i viveri allo stesso prezzo, le case aumentano d’affitto; sempre le stesse avanie dei ricchi inverso dei poveri villici, che chiamano loro famigli, e direbbero meglio giumenti. Un poco di lavoro conceduto a stento, dato con privilegio, diminuito, tolto finalmente; non una cassa di mutuo risparmio, o di mutuo soccorso; neppure un pensiero a migliorare e proteggere la propria industria del paese, che darebbe pane a tante famiglie, somministrando
loro sete da filare, e lane da
tessere; l’agricoltura, ed i villici che saranno pur sempre i veri fabbricatori della nostra prosperità nazionale, sembrano fino adesso indegni al governo di occupare per un momento gli alti suoi consigli. E intanto feste nazionali, grandi luminarie, e fuochi d’artifizio, gran pranzi, corso, cuccagne, e il popolo chiamato a prendervi parte a stomaco digiuno.
Stando così le cose, concludeva Civetta, il «popolo» non sarebbe mai accorso a dare il sostegno del proprio braccio alla causa nazionale, perché intimamente persuaso che «Italia, patria, libertà» esistevano soltanto pei «ricchi». Di qui la preoccupante prospettiva che «il popolo, stanco alla perfine de’ nomi», si potesse lasciar andare a una rivoluzione sociale violenta e san-
142
guinosa, quando pure non fosse divenuto cieco strumento della reazione antiliberale e antinazionale. L'analisi sin qui condotta ha messo in luce che nei giornali presi in esame la sensibilità per i problemi sociali, l'affermazione ricorrente della necessità di tener conto dei bisogni materiali dei ceti popolari, l'aspirazione a una riforma della società, anche quando si accompagnavano a una più o meno manifesta simpatia per il «socialismo», non si concretavano però in una scelta di campo nettamente socialista, nella definizione articolata di un «sistema»
o nell’accettazione esplicita dei principî di una delle varie scuole europee. L'unica eccezione significativa è costituita da quei fogli e da quei pubblicisti le cui prese di posizione dimostravano una accettazione più o meno completa delle idee di Fourier, o quanto meno una evidente derivazione da quelle. Tra i seguaci quarantotteschi del fourierismo, al quale nei precedenti decenni non era toccato in Italia quel seguito di interesse e di discussioni che aveva invece avuto il sansimonismo, un posto a sé spetta al piacentino Giuseppe Bucellati, che a partire dal 1834 aveva dato alle stampe a Milano e a Venezia una serie di scritti di chiara ispirazione fourierista!5. E alla scuola «societaria» si rifacevano anche gli articoli che Bucellati consegnò alla milanese «Italia rigenerata» tra il giugno e il luglio 1848!6 e nei quali venivano riproposti alcuni dei temi tipici di Fourier: l’esigenza di assegnare ad ognuno la «mansione» corrispondente alle sue tendenze e attitudini «naturali», così da evitare la «noia» nello svolgimento dei lavoro; la denuncia del
disordine di una società «caduta in balìa dei vampiri dell’usura, dell’agiotagio e del mercantilismo», e nella quale l’industria, «co’ suoi monopoli e per i suoi eccessi», era diventata «un orrendo castigo pel popolo», condannato a «morire affamato sulla terra medesima che fecondò co’ suoi sudori»; la sterilità dei mutamenti limitati alla forma di governo e l’urgenza di un riordinamento della società che corrispondesse alle richieste di «sussistenza e sicurezza» delle classi popolari e garantisse il giusto equilibrio nella remunerazione del capitale, del lavoro e dell’intelligenza (il fourierista «talento»).
E con un riferimento più specifico alla situazione italiana Bucellati proponeva infine la creazione di grandi stabilimenti destinati a raccogliere i lavoratori urbani e le loro famiglie secondo un progetto che appare modellato sul falansterio: 15. Sul Bucellati v. F. Della Peruta, Note e documenti per la storia delle idee sociali in Italia.
1830-1849, in «Annali» dell’Istituto G. Feltrinelli, 1960, p. 547, e 1962, pp. 387-392.
16. Alcune riflessioni intorno ai reali bisogni e doveri de’popoli e de’governanti (24 giugno 1848); Primo tentativo per minorare le sciagure dei popoli e contribuire per il miglior essere dell’intiera società (12 luglio 1848); Le tre parole della giornata discusse nel loro retto
senso (19 luglio 1848). I primi due articoli erano firmati Alessandro Bucellati, il terzo recava invece la firma Giuseppe Buccellati; ma l’autore era probabilmente una stessa persona.
143
A dissipare perciò il turbine che in questi tempi calamitosi va addensandosi sotto il bel cielo d’Italia, ed anche prontamente porre un argine ai più urgenti bisogni dei popoli, gioverebbe moltissimo che presso le principali nostre città vi si aprisse un grandioso stabilimento, in cui si ricoverassero tutti quelli artisti nazionali, che non altro
chieggono che di mantenere se stessi e le loro famiglie, e che il medesimo fosse provveduto: i 1. Di materiali idonei per somministrare a questi ricoverati un equabile e continuo lavoro. 2. Di locali sani e compatibilmente comodi per poterli alloggiare colle rispettive famiglie. 3. Di luoghi spaziosi, e di maestri e maestre, non superficialmente istruiti per l’allevamento ed educazione, dopo la prima infanzia, dei loro figli. 4. Di una o più cucine, dalle quali gli artisti ricoverati potessero ritrarne gli acconci e salubri alimenti, e ciò per un prezzo determinato e modico. 5. Di abiti decenti ed uniformi da distribuirsi ai medesimi per il loro abbigliamento esteriore, e da pagarsi in massa e in più riprese da essi. 6. Di discipline severe ed inesorabili per i ladri e per gl’incorreggibili. 7. In fine, che una Commissione apposita (costituita dagli impiegati onorifici, dal rappresentante il detto stabilimento, non che dai principali artisti in esso esistenti) determinasse il positivo valore di tutti i lavori condotti a termine, per indi porli a disposizione delle vigili protettrici di questa pia istituzione, le quali due volte per settimana, in uno o più locali, li smercerebbero coram populo al miglior offerente,
ma non mai per un prezzo minore dell’assegnato dalla suddetta Commissione. Ai singoli artisti poi dar si potrebbe il denaro ritratto da tali vendite, meno quella porzione fissata per assicurare ad essi un’annua pensione nella tarda età, e per sorreggerli nelle malattie; ed ai figli loro l'allevamento e l'educazione.
A Venezia seguace dichiarato del fourierismo fu l’ancora giovane Marco Antonio Canini, che nella città lagunare aveva fondato con altri democratici
oppositori di Manin il Circolo di Cannaregio. Canini già nel 1847 aveva pubblicato uno scritto, Pio IX e l’Italia, nel quale si diceva tra l’altro che per ar-
restare la decadenza economica di Venezia sarebbe stato necessario «congiungere 1 capitalisti co” braccianti in comune associazione di opera e di utili, con equa ripartizione a’ ministri di un prodotto di lavoro»!7. Questo generico associazionismo si andò precisando nel corso del ’48 in senso fourierista, come lo stesso Canini avrebbe poi ricordato in uno scritto autobiografico: «Io ero un discepolo della Démocratie pacifique... Ero socialista, un socialista moderato, per così dire... Tuttavia credevo, e credo ancora, che il più importante dei problemi sociali è il miglioramento dello stato delle classi popolari e la ricerca di una nuova organizzazione del lavoro»!8. E per diffondere le idee fourieriste all’inizio del 49 Canini decise di pubblicare un giornale, il «Tribuno del popolo», che apparve 1’ 11 gennaio recando nella testata motti di 17. M.A. Canini, Pio IX e l’Italia, Lucca, 1847, p. XXXIV.
18. M.A. Canini, Vingt ans d’exil, Paris, 1868, pp. 38 e 52.
144
matrice societaria: «Ogni uomo deve lavorare: il prodotto del lavoro sia ripartito fra i socii in proporzione del capitale, dell’opera di ingegno e dell’opera meccanica che hanno contribuito». Ma il tentativo non potè avere seguito perché il 12 gennaio Manin prese a pretesto l’apparizione del foglio per fare arrestare e poi espellere Canini, giustificando la misura con l’affermazione che la propaganda delle «teorie socialistiche» costituiva un «pericolo vero e la parte sana della popolazione ne era gravemente allarmata»!9. Mentre si chiudeva così la fugace esistenza del «Tribuno del popolo», a Firenze stava per concludersi l’esperienza della Democrazia progressiva, un piccolo foglio democratico (22 novembre 1848-25 gennaio 1849) che si dimostrò assai aperto alle suggestioni fourieriste. Già nel primo numero il giornale, che dichiarava di volere il trionfo del principio democratico e l’«effettuamento del progresso sociale» per via pacifica, insisteva sull’ingiustizia di una struttura economica che rendeva il popolo «schiavo dell’ignoranza e della miseria» e indicava come rimedio la prospettiva dell’alleanza, dell’associazione tra padroni e operai, tra ricchi proprietari e popolo («Ma non pensino — questo il discorso tenuto ai ricchi — di aver più oltre un servo in lui, riconoscano in lui il loro eguale; l’associno alle industrie; ne fecondino il lavoro; lo
inizino allo stato migliore, ov’essi già sono pervenuti»). E due giorni dopo un altro scritto su L'economia e il socialismo sosteneva che quest’ultimo nei suoi programmi doveva utilizzare gli studi empirici degli economisti elevandosi alla «vera teoria della felicità pubblica» e sostituendo ad «una scienza fredda e senza viscere... la scienza vera, umana, religiosa».
Che questa aspirazione a una riforma della società derivasse da una assimilazione di motivi fourieristi è dimostrato dalla frequenza con cui il giornale riprodusse scritti societari, come il programma della «scuola sociale» (14 dicembre 1848 sgg.), la Teoria del diritto di proprietà e del diritto al lavoro di Considérant (5 gennaio 1849) o gli estratti dell’ultima opera dello stesso Considérant, // socialismo in presenza del vecchio mondo (29 dicembre 1848
sgg.): quel Considérant che era presentato come «il vero discepolo di Fourier» e una delle voci più rappresentative del socialismo che i «miopi politici» francesi pensavano a torto fosse stato ucciso dall’elezione a presidente di Luigi Bonaparte?0. 19. Sull’attività di Canini a Venezia nel 1848-49 cfr. A. Bernardello, La paura del comuni-
smo e dei tumulti popolari a Venezia e nelle provincie venete nel 1848-49, estr. da «Nuova Rivista storica», 1970, fasc. I-II, pp. 42 sgg. 20. Si veda anche, nel numero dell’8 gennaio 1849, l’articolo Il «Conciliatore» e i socialisti, nel quale si affermava che il giornale moderato fiorentino nei suoi attacchi al socialismo criticava mezzo milione di socialisti francesi, e che inoltre sbagliava quando riteneva che il socialismo si incarnasse in Proudhon, il quale era soltanto uno dei suoi rami, «e della scuola negativa piuttosto che della scuola organica».
145
Resta ora da accennare ai riflessi che nella stampa periodica ebbero le tensioni sociali emerse nelle città e nelle campagne italiane durante il ‘48, tensioni il cui manifestarsi venne favorito dall’allentamento del controllo politico e sociale verificatosi soprattutto nella prima parte dell’anno. Nei centri urbani agitazioni e scioperi coinvolsero i lavoratori dei vecchi mestieri artigianali, dai tipografi ai sarti, dai cappellai ai vetturali. Particolarmente attivi si dimostrarono i tipografi i quali, oltre a chiedere un miglioramento delle basse retribuzioni e una riduzione della lunga giornata lavorativa (come fecero a Palermo nel marzo e a Genova nell’aprile), contrastarono vi-
vacemente l’introduzione dei torchi meccanici per il timore di possibili ripercussioni negative sull’occupazione. Infatti, dopo che già alla metà del 1847 gli stampatori dell’azienda fiorentina di F. Le Monnier avevano contestato l’utilizzazione delle macchine, nell’aprile 1848 furono i compositori e i torcolieri di Napoli a prendere posizione contro i torchi meccanici, seguiti nei primi giorni di maggio dai tipografi milanesi2!. Nei commenti e negli interventi dei giornali occasionati da questi primi sintomi di moderna conflittualità sociale, sulla condanna esplicita prevalsero largamente le esortazioni alla conciliazione tra i ceti, gli appelli al patriottismo e al buon senso, i richiami agli effetti benefici della libertà economica e politica; e questo perché l'orientamento più diffuso era quello di cercare di placare i fermenti evitando i toni accusatori e polemici che avrebbero potuto esasperare i contrasti e turbare il clima di relativa concordia che pareva essersi stabilito nelle prime settimane di riacquistata libertà. Così la fiorentina «Alba» il 12 marzo riconosceva giuste le lagnanze dei torcolieri e «battitori» a proposito della disoccupazione, e chiedeva al governo di adottare qualche «temperamento»; sempre a Firenze il 9 aprile la «Patria», occupandosi dell’agitazione dei tipografi genovesi, invitava con Raffaele Lambruschini i lavoratori a non coalizzarsi contro chi dava loro lavoro e pane perché il bene degli operai poteva discendere soltanto da una «alleanza di amici» con i proprietari. Pochi giorni dopo a Milano il «Pio IX», nell’esortare alla calma e al rispetto delle leggi i lavoranti sarti scesi in agitazione contro padroni e «maestri», indicava loro la strada del «risparmio» e del mutuo soccorso?2; mentre l’ufficiale «22 marzo», dopo aver negato che l’introduzione delle macchine potesse portare a una contrazione dell’occupazione nell’arte tipografica, si augurava che «gli operai nostri, dotati di tanto buon senso e patriottismo, e consapevoli del loro vero interesse», sapessero respingere ogni sollecitazione continuando a riporre piena fiducia in coloro che si erano consacrati al «trionfo della santa 21. Cfr. A. Galante Garrone-F. Della Peruta, La stampa italiana del Risorgimento, Bari, 1979, pp. 313-314. 22. G. Quadrio, Monte Tabor, in «Pio IX», Milano, 20 aprile 1848.
146
causa dell’indipendenza italiana» (6 maggio 1848)?3. Quanto a Napoli il «Nazionale», nel deplorare lo scontro avvenuto il 26 aprile al Campo di Marte tra guardie nazionali e stampatori, sosteneva la piena legittimità delle manifestazioni e delle «assemblee» di operai mossi solo dal desiderio di «trarre un profitto maggiore dalle loro oneste fatiche» (26 aprile 1848); seguito due giorni dopo dall’ «Inferno», il quale si doleva che le legittime richieste dei lavoratori fossero state strumentalizzate da chi tramava nell’ombra contro la libertà. Ma il documento più illuminante sulla mentalità dei gruppi dirigenti in tema di rapporto lavoratori-proprietari è il discorso popolaresco e sentenzioso indirizzato agli operai di Milano da Cesare Cantù nei panni di quella incarnazione del buon senso che voleva essere il personaggio immaginario Carlambrogio di Montevecchia?4. In questo vero e proprio trattatello della conciliazione interclassista Carlambrogio dava fondo alle sue doti di accattivante bonarietà per convincere gli interlocutori — quei «buoni operai» che rischiavano di cadere in balia dei «principj esagerati» dei demagoghi — che anche nel clima della libertà non era il caso di avanzare pretese eccessive. E le apparenti concessioni alle ragioni dei lavoratori si rivelavano subito dopo un espediente verbale che mascherava una posizione di sostanziale chiusura, come appare chiaro nel passo in cui Cantù veniva a parlare delle lamentele dei lavoranti sarti per il lavoro festivo e dello «sciopero del lunedì»: Avete detto: «Noi sartori siam pagati troppo poco; siam obbligati a lavorar alla festa: adesso c’è la libertà: si raddrizzano i torti; e noi vogliamo cambiare; altrimenti diremo che si è mutata la frasca, non il vino».
Avete ragione e avete torto. Sul lavorar alla domenica, sono con voi. Nel Decalogo c’è «Santificar la festa», il signor curato ripete: «Astenersi alla festa dalle opere servili» e perciò è non solo diritto, ma dovere in voi il non lavorar quel giorno. Avete sei giorni nella settimana; al settimo anche il Creatore riposò. Ma ho detto sei giorni: mi capite? Cos'è dunque cotesto vizio del lunedì? Alla domenica sera n’avete bevuto un bicchierin di più; la mattina state a letto più tardi, poi vi sentite svogliati; avete a risolvere degli intrighi non belli cominciati la domenica; e intanto la giornata si consuma, e la sera si torna all’osteria perché ci si andò la domenica. Ohibò! riposar la
domenica, ma lavorare il lunedì; e ricordarsi che son più i pasti che i giorni.
23. L’articolista respingeva inoltre come «socialistica» la proposta dei tipografi volta ad ottenere che, qualora la ditta editrice del «22 marzo» avesse acquistato un torchio meccanico, questo venisse ceduto agli operai uniti in associazione. «Si può ben comprendere — si legge nello scritto — come abbiano ad aver origine simili idee di socialismo in Francia, ma non lo si può in Italia che trovasi in condizioni affatto diverse, non senza pur notare che anche in Francia sia bastato soltanto il discutere sul serio una tesi socialistica per far sparire il credito pubblico, e gettare lo scoraggiamento nella società». 24. Agli operai. Così parla Carlambrogio di Montevecchia, in «Il Repubblicano», Milano, 17 aprile 1848.
147
Altrettanto illuminante appare l’argomentazione relativa all’impossibilità di ottenere aumenti salariali: Quanto ai salarj, è una questione come quella se nacque prima l’ovo o la gallina: gran dottoroni l’agitano da lunghissimo tempo e senza venirne a una risoluzione buona. Io non son in grado di farvi qui un trattato; ma mi concederete senza troppa fatica che il salario deve essere in proporzione della fatica. Se voi lavorate 6 ore, vi pagherò per 6 ore; se 8 per otto: se bravi e di voglia, vi compenserò meglio. Chi intraprende una manifattura non lo fa per divertimento, bensì colla fiducia di onesto guadagno... Noi operai non n’abbiam abbastanza, e vogliamo ci si cresca la giornata, si cresca il prezzo dell’opera. Cosa succede? il capo-fabbrica non ci trova più la convenienza, e dismette, e noi ci troviamo in piazza.
Dunque niente dimostrazioni o tumulti («lasciam urlare i ciarlatani e gli spazzacamini»), anche perché erano stati soprattutto i «poveri» a trarre beneficio dalla recente rivoluzione, a «far diciotto con tre dadi», come dimostrava
— a detta di Carlambrogio — l’eguaglianza che aveva parificato artigiani e operai ai nobili titolati («non vedete con che confidenza, noi cittadini ciabattini o legnajuoli o maniscalchi, parliamo al cittadino marchese, presidente, consigliere?»). Anche se questa eguaglianza, come Cantù si premurava di specificare, doveva restare esclusivamente sul piano formale, dal momento che poveri e ricchi c'erano sempre stati e avrebbero continuato ad esserci: Del resto, ricchi e poveri vi furono sempre e vi saranno di necessità anche nella repubblica. Non venite a imaginare che quando si parla d’Eguaglianza vogliasi intendere di posseder tutti altrettanto. Bello! Tu che lavori giorno e notte dovresti avere quanto quello che tutto il dì sta a grattarsi la pancia! E quel che tu hai acquistato col tuo sudore non potresti trasmetterlo a’ tuoi figli? Il mio e il tuo son parole sacre; e come voi dareste due bravi pugni a chi volesse levarvi la giacchetta ch’è vostra, al modo stesso il ricco avrebbe diritto di respingere chi volesse torgli il danaro ch’è suo?5.
25. Nella stampa è possibile cogliere altri echi del disagio sociale provocato nei centri urbani dall’aumento della disoccupazione congiunturale o dalla questione delle pigioni. Per la disoccupazione cfr. ad es. la «petizione» di Felice Turri al Governo provvisorio di Milano pubblicata dalla «Voce del popolo» di Milano (25 aprile 1848) e dal «Lario» di Como (10 maggio 1848). In essa lo scrivente, dopo aver chiesto l’intervento delle autorità per tamponare la crisi della tessitura serica a Como, città dove battevano più di due mila telai a domicilio, così proseguiva: «SI tratta di sette od otto mila persone minacciate di trovarsi fra un mese senza lavoro e senza pane. Quando un sacro dovere non ci imponesse di recar loro soccorso, ce lo comanderebbe l’interesse della nostra stessa conservazione. Se anche la moralità del nostro popolo resistesse alle funeste tentazioni della fame, e potessimo superare la crisi col concorso della carità cittadina e nazionale, non sarebbe perciò men deplorabile, che un così gran numero di uomini, laboriosi, ordinati, conscii della propria dignità, si trasmutasse in una moltitudine di mendici squallidi ed abietti, e spargesse tra noi i primi germi di quel pauperismo che corrode tante nobili e possenti nazioni. Non è pure lecito obliare, che il nobile e coraggioso contegno del no-
148
Venendo ora alle campagne, è noto che durante il ’48, e soprattutto nella prima metà dell’anno, chiari sintomi della crescente insofferenza delle popolazioni rurali per le loro condizioni di esistenza si manifestarono sia nel Mezzogiorno che in alcune regioni del Nord, come il Veneto e la Lombardia (dove si susseguirono le rivendicazioni delle popolazioni montane sui beni comunali alienati a partire dal 1839, il rifiuto di pagare dazi e imposte, i tumulti contro i grossi fittavoli, la renitenza alla leva, ecc.). E proprio in Lombardia più che altrove il malcontento e il rancore antipadronale di larghi strati di lavoratori agricoli indussero la stampa periodica a soffermarsi a lungo sulla situazione dei contadi e sugli stati d'animo dei loro abitanti. Il primo segno di preoccupazione per la situazione delle zone rurali venne dal «22 marzo», che il 4 maggio inseriva nelle sue colonne un appello ai «fratelli contadini» di Carlo Visconti, il quale mirava a controbattere l’opinione diffusa tra coloni e piccoli affittuari che essi non avrebbero guadagnato nulla dalla rivoluzione perché «i padroni del terreno che lavoriamo vorranno sempre riscuotere i fitti, o dividere i prodotti che col nostro sudore caviamo
dalla terra». E dopo aver elencato i presunti vantaggi che ai contadini sarebbero derivati dal nuovo ordine di cose (riduzione della ferma, minor carico
d’imposte, ecc.) il manifesto si chiudeva con un esplicito invito al rispetto della «roba» dei padroni: «Intanto non credete a quei perfidi che tentano di sovvertirvi col dire che adesso è repubblica, che siamo tutti egualmente padroni, che possiamo non pagare 1 debiti e andare a prendere danari e la roba dove c’è... Che direste se venissero dei manigoldi nella vostra casa, e portassero via le vostre robe, e ai vostri lamenti rispondessero: adesso è repubblica, e la roba è di chi la prende?». Ma questo appello si rivelò inefficace e tardivo, perché all’indomani della sua pubblicazione in molte plaghe della Brianza aveva inizio un rabbioso moto di protesta contro fittabili e proprietari, moto che era dovuto alla estrema durezza dei patti e che si sarebbe protratto sin oltre la metà del mese. Messi di fronte ai fatti di Brianza i giornali milanesi oscillarono tra la deprecazione da una parte e la consapevolezza dall’altra che a prevenire l’allargamento del distacco tra città e campagna occorresse prendere misure atte ad alleggerire stro popolo nei giorni del combattimento, ed il disinteresse con cui sagrificò senza esitazione il proprio ben essere alla causa italiana, lo fanno più degno ancora, se è possibile, di commiserazione e di soccorso. Non sarebbe giustizia, che chi ebbe tanta parte nel conseguimento della vittoria ne fosse rimeritato colla miseria». Altre prese di posizione in occasione di agitazioni di giornalieri e braccianti senza lavoro a Firenze e Parma si trovano rispettivamente in «L’Inflessibile», Firenze, 20 luglio 1848 e in «L’ Amico del popolo», Parma, 18 e 23 gennaio 1849. Quanto al problema delle pigioni, che fu particolarmente vivo a Firenze, cfr. il fiorentino «Giornaletto pei popolani» del 25 febbraio 1848.
149
la sorte dei contadini. Così la «Voce del popolo», dopo aver rimproverato i «buoni campagnoli... passati a trascorsi infiniti» e inebriati nell’«opera orrenda di depredazione e di distruzione», invocava la «politica dell’amore e del dovere» e «Ia carità e la generosità» dei proprietari, che avrebbero dovuto guardarsi «dal caricare, dall’offendere e soprattutto dallo scagliare a mezzo il corso sulla nuda strada le derelitte famiglie» (11 maggio). Il 17 maggio era la volta dell’«Italia rigenerata», la quale condannava decisamente gli avvenimenti brianzoli
(«ammutinamenti,
invasioni, ruba di danaro,...
minacce
di
morte, ferimenti») per consigliare subito dopo possidenti, fittabili e fattori a «non sovverchiare di pesi e sacrifizi i laboriosi agricoltori incompatibili coll’onesto e congruo mantenimento delle numerose loro famiglie»; mentre tre giorni dopo il «22 marzo», pur cercando di minimizzare la portata dei disordini, sosteneva che il Governo provvisorio doveva cercar di migliorare la condizione dei contadini con provvedimenti che determinassero «secondo giustizia ed equità i rapporti fra i possidenti e i coloni». E comprensione per il «popolo di campagna» era chiesta ai cittadini dalla «Politica per il popolo» (17 giugno), la quale indicava nello stridente contrasto dei rispettivi livelli di vita la ragione del rancore contro i padroni diffuso tra i contadini: Fra i paesani ce ne sono molti che hanno un certo astio contro i signori...; ma e non
pensate voi mai a quello che a lui tocca soffrire dai signori? non riflettete mai a qual terribile tentazione lo pone il confronto della propria miseria coll’abbondanza de’ suoi padroni, mentre questi da una parte gli fanno balenare sugli occhi l’immagine del lusso e dello sfarzo, e lui all’incontro che li mantiene co’ suoi sudori soffre la fame, e tante volte le angherie e l’insulto?
Tra la fine di giugno e l’inizio di agosto si moltiplicarono nelle campagne lombarde gli episodi che avevano alla loro radice l’odio contro i «signori» e nei quali risuonarono con frequenza le grida di evviva a Radetzky e ai suoi soldati. Ora... in taluni si va svolgendo una specie di simpatia per l’ Austriaco, — si legge in una relazione del 22 luglio che coglie dal vivo gli atteggiamenti mentali diffusi in quelle settimane nel Varesotto, ma la cui descrizione è valida per molte altre zone rurali della Lombardia — e ciò che è peggio si è che la parola da costoro proclamata nelle piazze, nei convegni, nelle bettole trova facile accoglienza nelle turbe ignoranti e mal disposte. Non è nuovo udire «viva i tedeschi», né straordinario «porci di signori, potevano lasciare le cose come erano senza tribolare tanto il mondo», oppure li ammazzasse tutti questi signori il Radetzky, che ci darebbe in
dono le loro terre?0. 26. Lettera di B. Brunazzi ad Angelo Fava, presidente del Comitato di pubblica sicurezza di Milano
(ASM,
Carte restituite dall’ Austria, cart. 368). Il documento
pendice.
150
è riprodotto in ap-
Di fronte a una situazione del genere la linea seguita dai fogli democratici od ostili al Governo provvisorio fu quella di una risoluta critica alle autorità centrali, che non solo avevano trascurato lo stato delle campagne, ma avevano troppo spesso lasciato al loro posto nei centri rurali amministratori e funzionari ligi all’ Austria. Or nulla si fece, — questa la denuncia della «Voce del popolo» (11 luglio) — per nulla si adoperò fino a quest'ultimi giorni, in cui le necessarie ma frazionate e mal condotte misure di coscrizione, e mille altre gravezze pubbliche, hanno... fomentato il mal umore nelle menti dei campagnuoli e strappate qua e là grida nefande che noi arrossiamo di ripetere, cosicché la grande azione governativa è intralciata, l'entusiasmo
generale del paese è svanito, minacciata una guerra sociale.
Attacco cui l’indomani faceva eco l’«Operajo», a giudizio del quale il disordine delle campagne («tumulti e sedizioni; ... evviva codardi e... voti traditori») andava imputato al Governo «ozioso e pigro» e solo preoccupato di ottenere la «fusione» col Piemonte; e che trovava sostanzialmente d’accordo
il «Crociato», dove Cristina Belgioioso, anche lei convinta che nelle campagne si fosse lasciato troppo potere ai «commissari» austriaci, scriveva che non ci si doveva meravigliare che si udisse dovunque «il canto cupo e funesto di viva Radetzky, viva i tedeschi, viva l’imperatore, morte ai signori», canto che serviva da stendardo alla «sconnessa insurrezione» (15 luglio)?7, In questo quadro, dominato dall’allarme per le ripercussioni negative che
l’atteggiamento delle popolazioni rurali avrebbe potuto avere sulle sorti di una guerra che vedeva ormai il ritorno offensivo dell’ Austria, fa spicco l’analisi dell’«Italia del popolo». Il giornale il 20 luglio poneva infatti con estrema chiarezza il problema del rapporto città-campagna nel movimento nazionale, e nel far questo impiegava toni e considerazioni così inconsueti nella stampa mazziniana,
spesso incline a sottovalutare il peso della questione contadina,
che è opportuno riprodurre con qualche ampiezza lo scritto: Qual meraviglia che la gente delle campagne non intenda come noi, dottissima gente, le cose civili, o non si commuova come noi del comune pericolo? E chi diè mai il nutrimento dell’intelletto a que’ poverelli? Chi disse loro: Voi siete italiani?...
27. Tra i giornali provinciali, anche l’«Unione» di Bergamo, ispirata da Gabriele Rosa, fa-
ceva risalire il deterioramento della situazione nei contadi alla mancanza di energia del Governo provvisorio, che aveva permesso ai «retrogadi» di seminare lo scontento nelle campagne. «Costoro — scriveva il giornale il 29 giugno — dipingono come normale, e figlio indispensabile della libertà lo stato attuale di sospensione di industria e commercio, ... insinuano essere i presenti sacrifizii di uomini e di denaro sostenuti per soddisfare ai capricci ed agli interessi di alcuni ricchi e di giovinastri facinorosi e turbolenti... Con queste insinuazioni irritano i più miserabili contadini, ed i proletari più inerti, i quali memori dei balzelli soverchii donde li gravavano alcuni padroni e della durezza colla quale li governavano, vanno buccinando vendette e saccheggi». Si veda l’articolo Educhiamo il popolo (13 luglio 1848).
151
Loro patria è il loro casolare, e il tratto di terra che fendono col vomere e non più. Vissero sempre tra il cielo e la gleba, pensosi solamente al nutrimento dell’indomani, pensosi della famigliuola, della ricolta, della vendemmia... Il suo signore, il possidente, il fittaiuolo gli parlò d’opera e di mercede; visse sospettoso della sua onestà; e gli mostrò sempre un viso cruccioso. E quando i signori della città passavano per le campagne, guardavano beffando gli affaticati agricoltori: Sono bestie costoro; nulla intendono, guai se non li freni con la paura. E qual comunanza d’affetto è dunque tra campagna e città?... Il popolo dei proprietari e dei fittaiuoli non si curò della educazione, della civiltà del popolo dei giornalieri; la città dimenticò la sua sorella, la faticosa sorella, la campagna; ed oggi è punita.
Orientamento, questo dell’«Italia del popolo», al quale non fu estranea la presenza tra i collaboratori dell’agronomo Giovanni Cantoni, che in quegli stessi giorni pubblicò sul foglio un’analisi di eccezionale rigore e profondità dei rapporti di produzione vigenti nelle campagne della Lombardia e delle condizioni di sfruttamento e miseria che ne derivavano per coloni e braccianti: analisi che si concludeva con un energico richiamo all’esigenza che un eventuale governo repubblicano prendesse misure radicali a sollievo delle popolazioni rurali per ottenere la loro adesione alla causa nazionale: Mentre in Francia, dove l’industria raggiunse un'alta importanza nella pubblica economia, la quistione sociale fra ricco e povero sorse prima e più imponente nelle città sotto aspetto di quistione del lavoro e delle mercedi ne’ rapporti dell’operaio col capitalista, in Lombardia all’incontro, dove l’agricoltura è precipua fonte di ricchezza,
la controversia sociale potrebbe più presto pronunziarsi di mezzo al popolo di contado sotto aspetto di quistione delle affittanze ne’ rapporti del colono col proprietario. E d’altra parte siccome in Francia a raggiungere uno stabile miglioramento della classe artigiana si vorrebbero provvedimenti e leggi che soltanto potranno escire da una repubblica democraticamente atteggiata, come certo non è l’attuale, così anche in Italia solo un governo vivificato da uno schietto spirito di evangelica fratellanza potrà concedere alla classe agricola un progressivo beneficio... Si consideri la loro [dei contadini] ignoranza, il loro idiotismo, la loro vita tutta mec-
canica, od al più animale, senza che alcuno si occupi della loro istruzione, sotto la sferza d’un orgoglioso fittaiuolo presto a battere il bue come il contadino, e si vedrà chiaro, in tanto avvilimento e senza speranza di risorgere, come noi siamo ingiusti quando chiediamo ad essi sacrifici per la patria che conoscono tanto matrigna?8.
In presenza di uno sforzo di comprensione come quello dell’«Italia del popolo», che chiamava in causa le responsabilità dei proprietari e dei fittabili e arrivava a prospettare la necessità di una riforma dei patti colonici, appaiono 28. L’«Italia del popolo», 20, 21 e 25 luglio 1848. (Gli scritti sono ristampati in G. Cantoni, Campagne e contadini in Lombardia durante il Risorgimento, a cura di C.G. Lacaita, Milano, 1976, pp. 3-22). Un tentativo di confutazione in chiave conservatrice delle analisi di Cantoni si può leggere nell’«Avvenire d’Italia» del 25 e 30 luglio 1848.
152
miopi e impacciati i tentativi fatti dai giornali moderati di ridurre il significato politico e sociale degli avvenimenti delle campagne. Così sull’«Avvenire d’Italia» A. Zoncada negava validità alla descrizione allarmante fatta dalla «Voce del popolo» e cercava di sostenere che gli incresciosi episodi verificatisi nei contadi rientravano nella normalità e che non ci si doveva stupire se in un anno di guerra, e quindi «d’incaglio per le industrie, pel commercio, per la mano d'opera» i contadini, «non sapendo con chi pigliarsela pel magro profitto dei bozzoli che, poco richiesti, dovevano di necessità invilire», se la prendevano «colle cascine e coi caseggiati per cieco e brutale istinto di vendetta» (20 luglio). Quanto al «22 marzo», nella sua difesa d’ufficio dell’operato del Governo provvisorio arrivava a negare l’evidente disaffezione delle campagne e i fermenti sociali che agitavano quelle popolazioni, tanto da tracciare questo quadro che rispecchiava più i desideri dei redattori che non la realtà: Del rimanente — scriveva dunque il «22 marzo» in data 20 luglio polemizzando con il «Crociato» — noi siamo lieti di questa occasione che ci è porta di rendere il dovuto merito alla nostra popolazione del contado. Non che dar prova d’essere propensa a lasciarsi aggirare da malvagie suggestioni, essa mostrasi dappertutto piena d’ardore per la causa nazionale, docile a portare il fascio della legge, pronta ad ogni sagrificio, ubbidiente alle istruzioni e ai conforti de’ suoi parrochi e di quanti si mostrano sinceramente rivolti a procurare i suoi veraci interessi. Né di ciò è da far le meraviglie; la
famiglia non è, grazie al cielo, nella campagna così disfatta com'è nelle case di molti giornalisti: gli affetti degli uomini son meno disgregati sull’aja del mietitore che nei gabinetti degli scrivacchianti. Meno si lagnano quelli che di più lagnarsi avrebber materia: meno ambiscono quelli a cui di maggiori compensi si apparterrebbe il diritto.
Tutt'al più il foglio riconosceva la durezza della condizione contadina e ammetteva che nelle campagne esisteva una certa indifferenza per il bene generale; ma si trattava a suo avviso di inconvenienti ai quali si sarebbe potuto porre rimedio con l’educazione e con l’esempio dei proprietari e degli intellettuali, invitati ad occuparsi delle plebi rurali così da renderle più contente del proprio stato: Intanto a far che il contado veracemente profitti della nuova libertà e sia reso inaccessibile ad ogni arte maligna, ad ogni perfida congiura, molto possono i preti, i ricchi, i saputi. S’uniscano insieme ad educare le famiglie rusticane con la parola fraterna, con l’esempio di miti virtù, con istituzioni che insegnino la parsimonia, la previdenza, con novità sempre innocenti e sempre evidentemente proficue: le educhino alla conoscenza delle patrie leggi, al sentimento de?’ civili diritti, all’arte di scernere il vero dal falso, i doveri che impongono Dio, la natura e la legge dai doveri che infliggono i capricci degli uomini. Facciano di vincere nel contadino quella sua deplorabile incuria degli utili comuni, e a quest’uopo lo iniziino alla Guardia nazionale, gliene procaccino i mezzi: eccitino gradualmente in lui lo smarrito sentimento dei bisogni della intelligenza, e cerchino di soddisfarli: ne migliorino le sorti dure antivenendo le
leggi: proveggano di tenerlo lontano dai cittadineschi contagi e di rendergli accetto 153
lo stato suo: gli facciano sentire come il miglior diporto sia la varietà dei lavori, come la rendita migliore sia la parsimonia del vivere, come l’amor de? fratelli sia il beneficio più vero e ricambiato di più certa gratitudine. Sovratutto, preti, ricchi, saputi, addomesticatevi con le genti di contado: ascoltate le loro querele, informatevi dei mali che di sanare intendete: fate che non vi sieno ignoti coloro che chiamate fratelli?9.
Contrasta con la ricchezza e l’articolazione del dibattito sulla situazione delle campagne che contraddistinsero il giornalismo lombardo la scarsità di riferimenti ai problemi contadini nella stampa periodica politica del resto dell’Italia centro-settentrionale. Tanto che nell’ambito veneto appare isolato un intervento come quello che si legge nel veneziano «Precursore» dell’11 febbraio 1849 nel quale, dopo l’esortazione ai «possidenti» a «guadagnarsi l'affetto dei contadini», veniva sottolineato il peggioramento delle condizioni di vita delle popolazioni alpine in seguito alla vendita dei beni comunali decisa nel 1839 e risoltasi a vantaggio quasi esclusivo di affaristi e di coltivatori agiati: Le terre demaniali poste in vendita passarono in mano di speculatori, i quali, non risguardarono le terre come i loro antichi proprietari, un mezzo di comune campamento per essi ed i contadini, ma bensì come una macchina che deve dare il massimo prodotto possibile. Le terre per i nuovi speculatori furono come la bottega, dove altro non si richiede che di vendere al più alto prezzo la merce. I contadini non ebbero molto di che lodarsi di questo sistema adottato da molti speculatori e da non pochi fattori di campagna.
Così pure pochi sono gli spunti relativi alle campagne e ai contadini rinvenibili nei giornali toscani e romani. Per la Toscana si può ricordare — a parte le notazioni sulla mezzadria già richiamate — uno scritto del «Corriere livornese» dell’11 aprile 1849 il quale, tardivamente, invitava a predicare la causa
nazionale nelle campagne che, «tuttora nella maggior parte neglette», vivevano «nella apatia, nel torpore, nella confusione, in una varietà d’incerte opi29. I sentimenti e le aspirazioni più diffusi in quelle settimane tra le popolazioni rurali della Lombardia erano colti in modo più realistico e penetrante da C. Cantù in uno dei suoi «trattenimenti»
di Carlambrogio
da Montevecchia
(il XII, intitolato 7! comunismo;
dove il villico Carlambrogio così replicava al «compare»
Milano,
1848),
che aveva cercato di spiegare le
«teorie» comuniste:
«Quel che ora debbo dirle è che il comunismo de’ suoi pensatori non è quel che intendo io, quel che mette dei grilli in capo ad alcuni contadini, e paura a tutti i signori. Non si tratta di concentrar nel governo tutte le forze, tutta l’industria, tutti i capitali; bensì di far senza governo, di sostituir le grida di piazza alle deliberazioni di gabinetti, l’impeto al consiglio; di essere tutti eguali, cioè comandar tutti del pari; togliere al ricco per dare al povero; nel palazzo del conte Archinti alloggiarci noi... Quest’è il comunismo che noi intendiamo in campagna; e, a quel che vedo, non ha a far nulla col comunismo suo di libri e di scuola. Il nostro sarebbe piuttosto la manifestazione dell’irremediabile rancore de’ poveri contro i ricchi».
154
nioni». E quanto a Roma, uno dei pochissimi accenni al mondo rurale lo si trova in un articolo del democratico 7ribuno (23 gennaio 1849) in cui Filippo De Boni si soffermava sulla povertà del popolo romano e sosteneva l’opportunità di allivellare tutti i beni ecclesiastici. Infine nello stesso Mezzogiorno, che pure nei primi mesi del 1848 conobbe un’ondata massiccia di occupazioni di terre e di agitazioni contadine per il recupero dei demani usurpati, debole fu la risonanza di questi avvenimenti nella stampa periodica napoletana. Al di là di alcuni rari accenni (come quello contenuto nell’«Amico del popolo» dell’11 maggio, che alludeva a «qualche scandalo di comunismo datosi nelle provincie») e delle vignette dell’umoristico «Arlecchino»3° le sole prese di posizioni argomentate furono quelle del «Nazionale» e del «Mondo vecchio e mondo nuovo». Il giornale di Spaventa, mosso dalla preoccupazione di togliere dalle mani del governo il pericolo del «comunismo» come pretesto per isolare i liberali, cercava di sostenere con una dimostrazione ideologizzata che non poteva darsi comunismo là dove, come era il caso delle popolazioni del Cilento e della Sila, mancava la coscienza di quello:
Lo stesso Ministero — così scriveva il giornale il 27 aprile prendendo lo spunto dal movimento di occupazione delle terre nel Cilento — ne avverte essere questa una levata di gente, concitata dalla fame e dalla oppressione di poche famiglie di cittadini usurpatori, nella quale egli si fa a riconoscere pieno diritto alle maltolte terre, e solo condanna i modi violenti e illegali col che lo fanno valere. Dispiacciono al Ministero questi modi perché si potrebbe credere che si volesse attuare fra noi il comunismo. Ma Dio buono! dove abbiamo la testa che non distinguiamo più il nero dal bianco? Si parla di comunismo in Napoli, e non si pensa che il comunismo è una piaga delle società nelle quali i non possidenti hanno la coscienza del diritto al possesso, come condizione materiale della vera concreta personalità umana, che questa coscienza manca assolutamente nelle popolazioni del Regno, e i modi violenti e illegali delle invasioni della proprietà non hanno origine dal principio del comunismo, il quale aspira ad un’attuazione organica e tranquilla, ma da cagioni accidentali e arbitrarie, senza alcun sentimento di diritto. 30. Si veda per es. il numero dell’8 giugno 1848, dove a un contadino venivano messe in bocca queste parole: «O per bacco! Come va questa faccenda? Dicono viva la libertà, viva la legge e si dividono le terre altrui?... Non me ne lasciano nemmeno un palmo». In precedenza il «Lume a gas» aveva accennato all’occupazione delle terre scrivendo che in alcune località del Regno gli abitanti avevano messo in pratica le teorie di Saint-Simon senza conoscerle, dividendosi «pacificamente i terreni e le possessioni de’ signori» (12 maggio). Scarse sono nella stampa periodica napoletana le notizie di cronaca sui moti contadini. Tra le poche eccezioni l’«Inferno» del 1° maggio, che riferisce sugli avvenimenti di Orsogna, dove il giorno di Pasqua «molti ribaldi... trascorsero il paese, armati di coltelli, ronche, scuri, mazze ecc. ecc. gridando: Morte alle giamberghe - Noi comandiamo» e imposero al sindaco un loro capitano della Guardia nazionale. L'indomani l’agitazione si ripetè, e culminò nella riscossione di «un’arbitraria tassa dai proprietari».
453
Dal canto suo il «Mondo vecchio e mondo nuovo» credeva di scorgere nelle agitazioni contadine la mano del re e della sua camarilla, che sobillavano
le popolazioni rurali per promuovere «l’anarchia madre del despotismo». Gli esempi dei fatti anarchici si vanno moltiplicando nelle province... — si legge in un fondo del 12 maggio che riprendeva in forma divulgativa l’argomentazione del «Nazionale» — Ora non si tratta neppure di comunisti: almeno costoro hanno per pretesto un principio, un’idea trattata da qualche penna; ma i nostri invasori provinciali vogliono ad ogni costo il mio e il tuo, con più sicurezza e baldanza del brigante della Sila.
E l’accusa alla monarchia sarebbe stata rinnovata, dopo la svolta del 15 maggio, in un articolo del 28 luglio che insisteva sulla strumentalizzazione reazionaria dei moti demaniali da parte del governo borbonico: Oh benedetto comunismo, tu sei l’ancora di speranza dell’abbattuto assolutismo...; e
in te si affida pure qualche volta il Ministero di Napoli. E ciò diciamo in quanto lascia vivere a propria discrezione in ogni provincia un’orda di predatori delle altrui sostanze, di comunisti i quali, facendosi scudo di una bandiera bianca impunemente devastano le proprietà, la fanno da padroni, né v’è paura che vengano contrariati, perché il magico vessillo li garentisce3!.
A conclusione di questa sommaria ricostruzione delle forme in cui la questione sociale» nelle sue varie sfaccettature si rispecchiò nel giornalismo quarantottesco italiano si può affermare che quel complesso di esperienze cultu31. A riprova che il sospetto che Ferdinando II pensasse a strumentalizzare i moti demaniali in senso antiliberale potesse avere qualche fondamento si può riportare un aneddoto relativo al viaggio fatto dal re in Calabria nel 1852. Ferdinando, ricevendo a Marcellinara il barbuto barone Saverio Sanseverino, che era in fama di liberale, ma anche di usurpatore di demani, gli
avrebbe detto: «Voi grandi proprietari calabresi spingete con gli atti e le maniere le popolazioni al comunismo, il quale porterà il vostro danno, non quello della Corona. Va subito a tagliarti questa barba» (R. De Cesare, La fine di un regno, Roma, 1909, vol. 1°, p. 29). Per quel che riguarda la Sicilia, una viva sensibilità per le condizioni dei contadini siciliani si coglie nella catanese «Unione italiana», dove il 14 agosto 1848 Mario Rizzari scriveva: «Più deplorabile [delle classi lavoratrici urbane] poi la nostra classe operaja agricola la quale a guisa di tribù nomade è costretta ad esulare ora in un luogo ora in un altro, andando in cerca di un lavoro non sempre facile, ma sempre scarsamente retribuito, e ritornare alla famiglia quando sospesi i lavori agricoli non resta loro niuno scampo di onorata esistenza. Fa pena, il vedere il siciliano colono costretto nella più gran parte dell’anno di cibarsi di pane di segala mischiato al grano turco o altre sostanze farinacee in quella terra medesima nella quale soprabondano i frumenti; e vederlo spesso nutrirsi di semplici erbe selvatiche, e di frutta. Tale condizione non
è serbata al solo bracciale dei campi, anche spesso al fittajuolo, all’inquilino... Però più delle città marittime è l’interno dell’isola che offre più luttuose scene; sono i paesi delle montagne coi loro stretti quartieri, coi loro umidi tuguri, con le loro popolazioni inselvatichite che fa mestieri visitare, per conoscere quale stato angustoso di miseria sia quello in cui giace vittima incolpabile il maggior numero della classe operosa siciliana».
156
rali, di discussioni e di polemiche, stimolate dall’intenso fervore della lotta politica, non andò disperso. Infatti problemi come l’organizzazione del lavoro, l’«associazione» operaia, la cooperazione, il mutualismo, il socialismo, il
comunismo, la questione contadina nelle sue specificazioni regionali, il rapporto tra masse popolari e rivoluzione nazionale — tutti toccati dalla stampa del ‘48 e sui quali si cominciò a formare una più attenta «opinione pubblica» — non sarebbero più usciti dall’ambito della riflessione degli intellettuali italiani politicamente impegnati; ed anche su quei problemi si sarebbe in definitiva giocata negli anni a venire tra le varie forze politiche la partita decisiva dell’«egemonia» sul movimento risorgimentale.
107
Appendice B. Brunazzi ad Angelo Fava, presidente del Comitato di Pubblica sicurezza di Milano. Dai colli varesini, li 22 luglio 1848 Egregio cittadino Presidente, Penetrato dal dovere che incombe ad ogni cittadino di conoscere per quanto è da lui e portare a notizia di chi dirige la cosa pubblica per supremo mandato del popolo tutte quelle circostanze di fatto che alla medesima si riferiscono in codesti supremi momenti della nostra vita nazionale, mi permetto nella mia nullità di farle alcune osservazioni su le presenti circostanze e condizioni di una parte di codesta popolazione varesina desunte dalla dimora in codesti paesi, e dall’abituale contatto col popolo minuto. Da circa un mese e mezzo ho riscontrato un notevole cambiamento nella opinione, nel morale, e nelle disposizioni della nostra popolazione agricola. Scossa in su le prime dalla sublimità dei fatti milanesi, e dal vedere passare pei propri villaggi cattivi pel valor cittadino quei ceffi feroci che per 34 anni erano stati l'oggetto del suo terrore, e illusa dalla presenza di una facile compita vittoria (dimenticando il formidabile quadrato delle quattro fortezze, e le parallele dei fiumi) plaudiva al nuovo ordine di cose, e ripeteva, dirò così festosa, il cantico nazionale che partiva dalla città. Egli è ben vero che tosto sorse qualche voce (come a Vedano e a Castiglione) a gridare fanaticamente: «Ora 1 signori hanno cacciato i Tedeschi, ora noi uccideremo e cacceremo i signori», ma quelle voci infernali furono quasi oppresse dal senso morale della moltitudine, la quale, educata alla parola sublime del Vangelo, sentiva tutto l’orro-
re di quella proposta. Ora però, oserei dire, in taluni si va svolgendo una specie di simpatia per l’ Austriaco, e ciò che è peggio si è che la parola da costoro proclamata nelle piazze, nei convegni, nelle bettole trova facile accoglienza nelle turbe ignoranti e mal disposte. Non è nuovo udire «viva i Tedeschi», né straordinario «porci di signori, potevano lasciare le cose come erano senza tribolare tanto il mondo», oppure «li ammazzasse tutti questi signori il Radetzky, che ci darebbe in dono le loro terre», ed altri «ci fanno ammazzare codesti signori dai Tedeschi per comandare essi», ed ancora «siamo ben stolti a farci ammazzare pei signori che sono carbonari, ed hanno fatto abbassare il prezzo della galletta». Codeste espressioni, che io volli esporre nella loro naturale, nativa grettezza, sono della più alta significanza perché accennano a principî comunistici, antisociali, innazionali, dissolventi. Guai se prevalessero in modo nelle moltitudini da armarne il braccio in questi decisivi momenti. Non illudiamoci, le cose sono incipienti, ma non mancano di essere della maggior possibile gravità. All’autorità informata spetta di coscienza l’avvisarne il rimedio. A Vedano Varesino erasi già passato a qualche atto reattivo. Si era suonata la campana, radunato il popolo, dichiarato di non pagar decime, livelli, fitti ecc. Si era scritto «morte al primo che paga»; si era intimidito qualche onest’uomo che opponeva le parole della giustizia, e dell’ordine. Ora però non so in qual stato stiano colà le cose. Lo ripeto, non illudiamoci intorno al veleno che si va propagando. Funesto, funestissimo errore sarebbe il giudicare dello stato delle condizioni morali del popolo agricolo da quello delle città, dove tutto è spirito d’ordine, di patria, di nazionalità.
Io parlo del distretto che conosco perché da anni lo abito, non mi estendo ad altri che mi sono ignoti: ma lo ripeto, quivi lo spirito pubblico si va tuttodì corrompendo. 158
Anche il venerabile clero ha rimesso alquanto del suo primitivo zelo, ora è muto, o debole è la sua parola; sia che più non lo riscaldi lo spirito del grande Pio, sia che si spaventi all’aspetto della tendenza che prende il popolo. La causa di questo regresso popolare io non la saprei ben cogliere, ma parmi poterlo acclarare come un effetto solidale, complessivo di più concause. La influenza di vari periodici, specialmente dell’«Operajo», lo spirito di inerzia che rifugge da ogni sacrificio, la avarizia che respinge ogni momentaneo ingorgo nella fonte delle ricchezze, lo stato di perplessità sul futuro, l'allontanamento dei figli chiamati a difendere la patria, il peso del servizio nella guardia nazionale di cui il nostro popolo non conosce né la dignità, né la sublimità della missione, la mancanza di ogni civile, e politica educazione, il malefi-
co influsso dello scetticismo civile dello «Spirito folletto» (che pure non è affatto sconosciuto), e certo più ch’altro mai il secreto lavoro di occulti agenti austriaci, che fanno ogni opera a corrompere, a traviare il popolo nella speranza di spingerlo agli eccessi delli iloti di Gallizia, ove il risorgimento nazionale è ormai impossibile: tali mi sembrano presso a poco le cause del degradamento che si va rendendo manifesto. L’identità delle idee, e dirò anche delle frasi in punti svariati accennano bene identità di origine: d’altronde l'indole delle massime è tutta di conio austriaco. Cieca obedienza al sovrano, supremazia dei beni materiali, esterminio degli agiati, dei pensanti, ecco le idee supreme che fondano l’essenza della propaganda retrograda che ci viene da oltre monte. Mi si permetta che io lo ripeta ancora, la cosa merita tutta l’attenzione dell’autorità: non si illuda codesta. Colle compassate frasi, cogli idilli, coi
gorgorismi [sic] del foglio ufficiale non si dirige l'opinione del popolo. Non è col vagare fra le idealità, né fra le illusioni della fantasia, né col rigirarsi fra uomini creati nel gabinetto fra li slanci dei soavi sentimenti del cuore, né dalle emozioni del bello
che si dirige la vita pratica; ciò sarà argomento di preparazione, sarà seme di frutto futuro: ma ora, ora conviene agire, conviene stare nella via de’ fatti, dell’ineluttabile
i realtà, quale pur siasi. Egli è ben vero che la Provvidenza del Signore, la quale pare operi ogni dì prodigi nuovi per compiere la politica e civile risurrezione di questa nostra carissima patria, fa sorgere dal seno del male il bene, e porge nuove armi nelle mani dei buoni qualora ne sappiano profittare. Fra questi mezzi vi è la cecità brutale del nemico. Rimedio precipuo al male si è illuminare le cieche menti, le rozze volontà, li corrotti cuori. Ciò che mi è veramente inconcepibile si è il vedere associarsi ai perversi nel maledire il nuovo sistema, e nel bramare lo straniero atroce, crudele, inesorabile,
si è dico il vedere associarsi in questo assaissimi i quali non hanno nel nuovo sistema avuti che vantaggi. Contadini che non diedero un obolo per la causa comune, che non diedero figli, che non pagano più il testatico, che sentono il bene dell’abbassamento del sale, che provano inusitate indulgenze da’ proprietari, che non servono nella guardia, sono tra i più caldi declamatori contro la patria, ed il nuovo sistema. Ma come dissi il Signore si serve degli errori, delle atrocità de’ nostri nemici pel nostro bene. Appena l’ Austriaco scatenò da Mantova la masnada di assassini che inaugurò la propria liberazione cogli incendi sorse un senso di letizia nel popolo credendo fosse un moto comunista. Ma appena si udì che i cascinali del povero erano di preferenza presi di mira, i saggi, i buoni cittadini proclamarono come quella fosse opera austriaca avversante specialmente il povero, ed il contadino. Quell’idea, sebbene a stento, entrò alcun poco nelle scosse menti, e non è rado udire chi si persuada essere opera austriaca appunto quella che minaccia il loro casolare, ed il loro vitto. Un'altra idea che i buoni cittadini vanno divulgando, e che è di un effetto mirabile è questa, che l’ Austria abbia promesso ai Croati di far uccidere tutti i contadini lom-
159
bardi, e far stanziare quei sozzi colle loro famiglie nelle nostre terre. A_ consolidare questa voce si sparse la nuova trovarsi fra i Croati donne, e fanciulli, colle masserizie per quivi stabilirsi, uccisi e sterminati prima i contadini. A queste novelle udii i contadini quasi per ispirazione proclamare la «leva in massa». Non perda adunque la autorità questa molla potente che pur potrebbe avere alcun di vero. Si diffonda, si propaghi questa voce, oppure per stare nella linea del fatto si parli delle leve forzate, degli eccidi, dei saccheggi, si faccia conoscere al popolo agreste che ove tornasse |’ Austriaco per essi è finita, si narrino i fatti di Castelnuovo, e di Bardolino, le leve del
Veneto, le tasse di Mantova, i saccheggi di Mantova, Curtatone, delle Grazie, della Montagna. Si ingeneri terrore per la ricomparsa, si persuadano che sono nell’alternativa, o di sostenere il nostro Governo, o di perire sotto la bajonetta del Croato. Si tolgano le illusioni popolari su la clemenza, su la dolcezza, su la predilezione popolare dell’ Austriaco. Gran che, un nemico che si difende, che stermina e distrugge troverà apostoli della propria causa, ed il Governo Provvisorio se ne starà inerte, silenzioso riposando sopra un buon senso, un buon volere che non ovunque si trova? Lascerà in balia dei raggiratori il corrompere il popolo, il renderlo avverso al sistema eletto dal popolo di cui il Governo stesso deve essere tutore, custode e sostenitore? Si stampino narrazio-
ni, si illumini con istile facile, semplice, intelligibile, si svelino in foglietti le mene austriache, si diffondano gratis nelle ville, su i mercati, nelle bettole, e si vedranno
effetti salutari. Ma, ciò che interessa, non si perda tempo ora, sì ora e tosto mentre ardono ancora i nostri villaggi...
160
6. La società lombarda tra il 1815 e l’Unità: l’alimentazione e l’abitazione
Tra il 1815 e il 1859 in Lombardia l’attività economica fondamentale rimase quella agricola, e i tre quinti della sua popolazione (che dai 2.176.000 abitanti del 1814 passò ai 2.843.000 del 1857) erano formati di proprietari particellari, mezzadri, coloni, salariati e di altre categorie la cui attività era le-
gata in modo immediato all’agricoltura. Nella fascia montuosa, là dove al disotto delle zone boschive era possibile una qualche coltura, su fasce di terra costruite e ricostruite con diuturna fatica, prodigava senza risparmio la sua forza-lavoro un ceto di piccolissimi proprietari, ai quali assai spesso le poche pertiche possedute non fornivano un prodotto sufficiente per saldare un’annata agraria all’altra. A questi si aggiungeva, nei fondivalle e nelle vicinanze dei centri abitati, dove gradatamente proprietari borghesi si erano andati sostituendo nel possesso fondiario ai contadini poveri, uno strato di agricoltori legati alla terra da contratti di affitto in grano, di mezzadria, di locazione ereditaria perpetua. Il precario equilibrio delle piccole aziende contadine fu poi gravemente turbato dal provvedimento legislativo del 1839 che imponeva l’alienazione dei beni comunali incolti i quali avevano costituito fin allora, con il godimento degli usi civici, l’indispensabile complemento del fondo del piccolo proprietario o del colono; le modalità con cui vennero condotte le operazioni di vendita tornarono infatti a vantaggio quasi esclusivo dei proprietari maggiori e degli speculatori sul legname e deteriorarono il livello di vita di buona parte di quelle popolazioni, che cercarono a lungo ma inutilmente di opporsi a una misura che esse vivevano come una vera e propria spoliazione. Nelle colline e nell’alta pianura asciutta la proprietà terriera, relativamente frazionata rispetto alla Bassa ma con una cospicua presenza di grandi e medi proprietari, apparteneva in buona parte alla nobiltà o agli strati più ricchi della borghesia cittadina i quali, sensibili agli «onori della possidenza» e interessati a un investimento che offriva risultati redditizi e sicuri, nell’arco di tem161
po qui considerato accrebbero in misura rilevante la loro presenza nel ceto proprietario. In queste plaghe, nelle campagne del Bergamasco o del Bresciano si addensava una popolazione di piccoli possessori, di mezzadri e di coloni immiseriti e tenuti in una condizione umiliante di dipendenza personale dai padroni. Quanto alla parte meridionale della provincia di Como, all’alto Milanese e alla Brianza, il patto contrattuale tipico del ‘700, quello della «masseria», contraddistinto dalla presenza su un fondo adeguatamente ampio di un nucleo di quattro o cinque famiglie coloniche fornite di scorte dirette da un «reggitore» e da una ripartizione dei prodotti relativamente favorevole ai coloni, venne gradualmente soppiantato (come si è accennato in precedenza) dal cosidetto contratto misto di fitto in grano e mezzadria;
e questo nuovo
rapporto non soltanto frantumava le masserie in più unità coloniche di dimensioni minori, indebolendo così le capacità di resistenza dei contadini alla sua introduzione, ma con il tendenziale accrescimento della misura del canone fisso in grano provocò il peggioramento delle condizioni di esistenza dei coloni, sempre più indebitati e denutriti. La pianura digradante verso il Po, infine, era la parte della Lombardia nella quale l’agricoltura, come risultato di un lungo processo storico, aveva con più decisione imboccato la strada dello sviluppo capitalistico. Qui tra i grandi proprietari — generalmente nobili assenteisti — e la terra si era inserito un ceto di affittuari capitalisti che, soprattutto nella zona irrigua, esercitavano l’ «alta coltura» (incentrata su una rotazione che includeva le piante foraggere e permetteva quindi la specializzazione in direzione delle attività lattiero-casearie) e che, giusta la penetrante caratterizzazione di C. Cattaneo, «piuttostoché agricultori, sono intraprendenti di industria agraria; poiché, sciolti d’ogni manuale fatica e d’ogni cura servile, dirigono sopra vasti spazi il lavoro dei mercenari, anticipando grandi valori riproduttivi al terreno»!. La forza-lavoro necessaria era fornita da salariati nei quali, accanto ai giornalieri fissi e avventizi che avevano con l’azienda un rapporto precario, era presente anche un ben differenziato strato di «obbligati», tipico dell’area della «cascina», i quali erano legati ai fittabili da contratti annuali, risiedevano stabilmente sul fondo ed erano retribuiti con una quota in moneta e una in generi integrata dalla compartecipazione ad alcuni prodotti (mais, lino, ecc.). Se in tempi normali la retribuzione complessiva degli obbligati, ai quali il fittabile concedeva l’uso gratuito della dimora, assicurava loro il livello minimo di sussistenza, assai più difficile era il confronto con le esigenze primarie quotidiane per i giornalieri fissi e per quelli avventizi. I primi, impegnati an1. C. Cattaneo, Dell’agricoltura inglese paragonata alla nostra, in «Il Crepuscolo», Milano, 13 dicembre 1857, p. 794.
162
ch’essi contrattualmente per tutto l’anno con gli affittuari, erano però pagati soltanto per le giornate di lavoro effettivamente prestate (in genere non più di 240) e dovevano una pigione per l'abitazione, per cui — variando la loro mercede giornaliera dai 10 ai 12 soldi — restavano loro al massimo 100 lire: «Quando si pensa — scriveva Giovanni Cantoni, il già menzionato penetrante conoscitore della realtà delle campagne lombarde — che con questo guadagno [il giornaliero] deve fare le spese del raccolto, vestir sé e la famiglia, non si penerà a credere troppo poco retribuita la fatica del contadino»?; e questo soprattutto nell’ultimo decennio preunitario, quando il rincaro del costo della vita abbassò sensibilmente i salari reali: di conseguenza, doveva constatare S. Jacini, «questi giornalieri portano dipinta la povertà sui volti sparuti e fanno raccapricciare ogni anima bennata»3. 1 giornalieri «di piazza» offrivano invece giorno per giorno la loro forza-lavoro per un salario che variava secondo la stagione e la domanda e che tendeva ad abbassarsi proprio quando la scarsità dei raccolti provocava il rialzo dei generi alimentari; di qui un’esistenza insicura e un livello di vita inferiore a quello dei giornalieri fissi. Prova evidente della miseranda condizione della generalità dei contadini lombardi era la difficoltà che essi incontravano nel riuscire a saldare i propri consumi alimentari da un San Martino all’altro, con la conseguente minaccia dell’espulsione dal fondo e la generalizzazione dell’indebitamento con proprietari e affittuari. Havvi altra specie di questi proprietari — si legge in una testimonianza del 1843 relativa all’alta Lombardia — i quali meno feroci, più ragionevoli [di quelli che ricorrevano alle disdette], ma egualmente avari, forniscono ai bisognosi coloni il necessario sostentamento, marcando scrupolosamente l’importo di questo alla partita dei crediti verso gli stessi; di questa maniera le famiglie coloniche diventano meschine di giorno in giorno, e si trovano di essere gravate da un forte debito verso il padrone, debito contratto per un’annata, per due e più annate di vitto.
E per quel che riguarda la Bassa 1 fittabili, rilevava ancora Cantoni, per aver salariati bisogna che al bel primo giorno di servizio anticipino una metà del salario d’un anno per pagare i debiti fatti presso l’affittaiuolo antecedente: che li sovvengano in grani, sovvenzione che finisce a precipitarli nell’abisso, giacché quasi 2. G. Cantoni, Sulle condizioni economiche e morali della bassa Lombardia (lo scritto, ap-
parso anonimo nel «Crepuscolo» del 1851, n. 11-14, è ripubblicato in G. Cantoni, Campagne e contadini in Lombardia..., cit. pp. 89 ssg. La citazione è a pp. 101-102). 3. S. Jacini, La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia, Milano, 18573, 43.02: P 4. F. Dossena, Alcune note economico-agricole in riguardo ai coloni mezzadri dell’alta Lombardia, in «L’Economista», Milano, 1843, vol. 2°, fasc. 1, p. 12.
163
sempre al tempo del raccolto, che è quello della restituzione, il grano è all’infimo prezzo dell’anno, e il salariato per compensare il diverso prezzo restituirà quattro moggia invece di tre, e talvolta anche di più. Nel periodo qui considerato, e soprattutto nella sua fase iniziale, le campa-
gne lombarde (anche nelle zone in cui si erano affermati il capitalismo agrario e la produzione per il mercato) si presentavano, per quel che concerne abitudini di vita e modi di pensare delle classi popolari, come il mondo della tradizione vischiosa, della pratica consuetudinaria, della gerarchia patriarcale, della dipendenza personale del contadino dal proprietario e dal fittabile: un mondo nel quale vi erano pochi spazi per l’introduzione e la circolazione delle idee nuove, l’analfabetismo era dominante, e depositario pressoché esclusivo della vita culturale e intellettuale appariva il clero, capillarmente irradiato nella trama delle parrocchie. In quello stesso arco di tempo, e con cadenze più sostenute a partire dagli anni ‘40, una dinamica economico-sociale più vivace prese invece ad animare quelle città che Cattaneo nel suo celebre scritto del 1858 avrebbe definito l’unico «principio ideale» della storia italiana e di quella della Lombardia in particolare. Alla crescita demografica, che prese ritmi più o meno intensi, si accompagnò l'avanzamento delle intraprese commerciali e di quelle manifatturiere, che se in parte conservarono uno stretto rapporto di interdipendenza con l’agricoltura (come nel caso del setificio), con una prevalente localizzazione nelle campagne e un larghissimo impiego di maestranze rurali, in parte invece ebbero la loro sede nei centri urbani maggiori e minori (meccanica, edilizia, tipografia, confezioni, articoli di lusso, ecc.); alle tradizionali funzioni di nuclei amministrativi e culturali e di luoghi di spesa della rendita fondiaria le città vennero così aggiungendo, lungo una linea di sviluppo lenta ma costante, quella di centri di un’attività industriale e di una dilatata operosità del settore terziario che preludeva al processo espansivo dei decenni postunitari, acquistando così un crescente peso specifico e un più elevato potere di attrazione nei confronti delle campagne, come «mercati e officine di più vasto contado». Per penetrare più all’interno del mondo popolare il discorso deve ora portarsi su alcuni di quei modi e di quelle forme del vivere quotidiano che in maniera più immediata condizionavano l’esistenza delle classi lavoratrici della Lombardia, forme e modi che appaiono come il risultato di uno stretto intreccio tra residui del passato e anticipazioni dell’avvenire. Gli anni iniziali della Restaurazione si aprirono anche in Lombardia sotto il segno della carestia, un fenomeno tradizionale ancora ricorrente, pur con S. Cantoni, op. cit., p. 107.
164
frequenza e intensità minori, in una struttura che opponeva tenaci resistenze alla diffusione del modo di produzione capitalistico e che era contrassegnata dalla rigidità e ristrettezza del mercato dei grani e dalla presenza — specie nelle zone superiori della regione — di piccole aziende contadine che si reggevano su un precario autoconsumo. I cattivi raccolti del 1815-17 portarono infatti con sé le conseguenze in parte già richiamate in precedenza: il rialzo del prezzo dei grani e degli altri generi di prima necessità, le manovre speculative degli incettatori, l'aumento della disoccupazione (aggravato dallo scioglimento dell’ex armata italiana), l'espulsione dai fondi dei piccoli proprietari marginali, l’impennata dei furti campestri e degli altri reati contro il patrimonio, l’incancrenirsi del pauperismo, la fame fisiologica. «Oltre ad essere ad un eccessivo prezzo i viveri in giornata, — si legge in uno dei tanti allarmati rapporti inviati dalle autorità periferiche (un dispaccio dell’ispettore di polizia al confine di Chiavenna del 7 luglio 1815) — la povera gente neppure col contante alla mano trova farina di grano turco»; e un uomo al vertice del potere come il governatore Saurau scriveva il 25 agosto: Già per la seconda nuazione di forza esempio che nella morire della gente possidenti, che non
volta vengo informato che siano morti degli individui per esteprodotta dalla mancanza di nutrimento... Sarebbe cosa senza Lombardia rinomata per la sua fertilità ed abbondanza avesse da per inedia, e per mal intesa e troppo estesa parsimonia di alcuni vogliono dar loro lavoro e con ciò della sussistenza®:
constatazioni preoccupate che erano destinate a infittirsi nei mesi seguenti. La drastica compressione del livello dei consumi alimentari portò con sé la consueta reazione dei tumulti popolari spontanei e non coordinati tra loro, che miravano a ottenere una riduzione del prezzo delle granaglie e culminavano spesso nel saccheggio dei forni e dei mercati. Pur nella mancanza di ricerche che permettano di seguire con esattezza l’andamento cronologico e la diffusione geografica del movimento, si può affermare che le agitazioni, nelle quali sovente ebbero un ruolo centrale le donne, toccarono il momento di massima concentrazione tra il maggio e il luglio 1815, con una ripresa endemica lungo il corso del 1816, e interessarono dal più al meno tutta la regione. Nel maggio 1815 (ma quella che segue è soltanto una rapida esemplificazione) disordini annonari si susseguirono nei distretti di Clusone e di Breno e nella Valle Imagna; alla fine di giugno gli abitanti dei borghi contermini si posero in marcia alla volta di Lumezzane per ottenere con le buone o con le cattive del frumentone; e nelle settimane successive l’agitazione si estese nella Valtellina, con epicentro Chiavenna. Nello stesso torno di tempo il fermento investì anche i centri maggiori della fascia centrale della regione, da Como 6. ASM, Annona, p.m., cart. 16 e 17.
165
(dove le autorità temevano
una sommossa
dei tessitori in seta, colpiti dalla
mancanza di lavoro) a Varese e alla stessa Milano. A Varese il 16 maggio ebbe luogo, informa una relazione, un tumulto «imponente», poiché «per essere giorno di mercato, una gran quantità di foresi e montanari si associarono ai reclamanti non già per la penuria delle granaglie, di cui era ben fornito il mercato, ma bensì per ribasso del prezzo, declamando per la mancanza di travaglio di non avere i mezzi di guadagnarsi con che acquistarsi il grano»; mentre a Milano, dove secondo un cronista i poveri erano «in molto pericolo di soccumbere per la scarsezza e il caro dei viveri», si ebbero a più riprese grossi assembramenti popolari con conseguenti assalti ai forni. Quanto alla Bassa, tumulti della «classe più indigente» con razzie nei mercati e incendi delle case dei maggiorenti erano segnalati nel maggio in numerosissime località grandi e piccole, come Chignolo Po, Lodi, Torricella, Crema, Cremona, Acquanegra, Viadana”.
In una situazione del genere, che le autorità cercavano di fronteggiare con i palliativi d’uso, si spiega quella particolare produzione pubblicistica di taglio esortativo che voleva convincere gli agricoltori a estendere l’ancora trascurata coltivazione delle patate, dimostrata utilissima dalle «crudeli circostanze
in
cui ci ha posti la trista raccolta delle biade»8 (e basti pensare a Vincenzo Dandolo, che nel 1815 diede alla stampe il suo Grido della ragione per la più estesa coltivazione dei pomi di terra?). Gli stessi tratti presentò, a circa trenta anni di distanza, la carestia del 1846-47, che colpì anche il resto della penisola e buona parte dell’Europa e che accelerò l’esplosione del malcontento generale e il «passaggio dal disagio alla rivolta» del 1848 (Marx); un importante elemento di novità fu però, in questa replica del fenomeno — l’ultimo di grandi dimensioni nella storia della Lombardia — il tentativo di utilizzare strumentalmente la contingenza in funzione antiaustriaca condotto con parziale successo dai gruppi liberalmoderati. Il tema delle carestie è direttamente collegato a quello dell’alimentazione, per il quale — in attesa delle necessarie ricerche quantitative — ci si deve appoggiare alle testimonianze coeve, che permettono di delineare soltanto un impressionistico quadro d’insieme. Come giudizio generale si può in ogni modo affermare che il bilancio nutritivo della grande maggioranza delle popolazioni lombarde — come di quelle del resto del paese — fosse in maggiore 7. Una documentazione assai ricca è ibidem, Annona, p.m., cart. 11, 16, 17, 18, 19, 22, ecc.
8. 9. terra, farne
F. Re, Saggio sulla coltivazione e su gli usi del pomo di terra, Milano, 1817, p. 1. Cfr. anche: [L. Passi], Istruzione per la gente di campagna sulla coltivazione dei pomi di Bergamo, 1815; N.C. Onorati, Delle patate, loro coltura, uso economico e maniera di il pane, Milano, 1816; Istruzioni sulla coltivazione e sull’uso delle patate, Brescia, 1817.
166
o minore misura deficiente di proteine e vitamine, con conseguenze che si ripercuotevano drammaticamente sulla mortalità e sulla morbilità e che avrebbero proiettato i loro effetti nei decenni postunitari, come sarebbe stato dimostrato tra l’altro dalle indagini di statistica medica miranti ad accertare le cause delle elevatissime percentuali dei non idonei al servizio di leva!0, Il regime alimentare dei ceti popolari delle campagne appariva definito da due costanti: il largo predominio dei cereali (e in subordine dei legumi) e il bassissimo consumo di carni fresche. Per la fascia alpina valga il caso della Valtellina. La mensa dei valtellinesi era concordemente giudicata misera e insufficiente dagli osservatori: «Legumi, castagne, pomi di terra conditi il più delle volte a solo sale, e pane inferigno, è il vitto di molti», ci informa una testimonianza del 1844!!, nella quale
si rilevava che anche la polenta di grano saraceno o di mais parcamente condita era un cibo che denotava già una relativa agiatezza. I cereali inferiori, spesso consumati nelle forme tradizionali della polenta «taragna», dei «pizzoccheri» e del «pesto» (una miscela di panico e miglio pestati e mescolati con un poco di farina di segale e cotti nell’acqua o nel brodo), le patate e le castagne (bollite o ridotte in farina) erano integrati da verze e rape e, nel caso delle piccole aziende contadine fornite di scorte vive, da modesti quantitativi di latte e di formaggi freschi. L'uso della carne fresca era quasi sconosciuto al contadino e nel 1880 l'Almanacco agrario valtellinese era ancora costretto a scrivere: «Le poche volte che ne può bollire un pezzetto l’ebbe in dono da qualche vicino, al quale la sventura faceva morire accidentalmente il porco o la giovenca». Le colline e la pianura asciutta erano il regno dell’alimentazione maidica,
generalizzatasi già nel ‘700 in correlazione con la costante avanzata della coltura del granturco nella gamma delle sue varietà tardive e precoci, che si rispecchiava nella «babele» della nomenclatura in uso rilevata nel 1846 dal vocabolarista Francesco Cherubini («formenton», «melgott», «melgon», «carlon», «melgon magengh», «melgon invernengh», «melgon gros», «melgon fusér», «melgon vestàn», «melgonìn», «quarantìn», «cinquantìn», «formenton de la famm» e via dicendo)!?.
La struttura del regime alimentare dominante tra i contadini della zona in questione era acutamente individuata già negli anni ‘80 del secolo XVIII dal 10. Cfr. per es. A. Trezzi, Sulle cause delle crescenti riforme dei giovani chiamati alla leva nel circondario e provincia di Milano, nati nell’undicennio 1842-1852, Milano, 1875.
11. F. Visconti Venosta, Notizie statistiche intorno alla Valtellina, in «Annali universali di
statistica», Milano, 1844, vol. 81°, pp. 34-35. 12. F. Cherubini, Considerazioni agrario-statistiche sulle cause rimote probabili della pellagra, in «Rivista europea», Milano, 1846, 2° semestre, pp. 441-442.
167
medico Gaetano Strambio che — come si è in precedenza accennato — la metteva in relazione con il preoccupante progredire della pellagra: Fere numquam cibis animalibus vescuntur, sed totus eorum victus in pultibus et pane plerumque consistit. Pultes fiunt ex farina turcici frumenti, cui et brassica, et rapa, et cucurbita, et sicca legumina, prout fert anni tempestas, miscentur, plurimo sale, et lardi, aut olei, aut lactis tantillo pro condimento adjectis ex qua, acerrimo addito fermento, amplas massas aegre coquendas efformant!3.
Quadro che non aveva conosciuto modifiche di rilievo 60, 70, anni più tar-
di, a giudicare dall’unanimità con la quale le fonti del tempo insistevano sul ruolo centrale del mais nei pasti quotidiani del lavoratore rurale. A colazione il contadino consumava pane misto di granturco, segale e miglio, da solo o bagnato in acqua calda salata condita con olio di ravizzone o lino, mescolata «qualche volta» con ricotta o latte; il pranzo consisteva in una polenta di mais arricchita con fagioli o cavoli e insaporita con olio di semi o lardo, alla quale seguiva una «tenue porzione» di formaggio fresco con pane (a volte la polenta era sostituita da una minestra di riso); alla cena si replicava la polenta con un magro companatico!4. In alcuni distretti la miseria toccava estremi tali che i contadini preferivano utilizzare il mais sotto forma di pane anziché di polenta, dal momento che di questa, «perché dolce, se ne farebbe consumo troppo largo, non compatibile con l’ordinaria penuria che essi hanno del grano turco»!5. Quanto ai contadi del Bergamasco e del Bresciano, «immoderato» era l’uso della polenta, «da passarne in proverbio fra gli altri popoli d’Italia», constatava nel 1845 un altro studioso della pellagra, il medico bresciano Lodovico Balardini, il quale aggiungeva che il mais, nella specie di pane o di polenta, costituiva i «nove decimi della massa alimentare giornalmente ingollata dall’affamato colono»!6. Marginali erano altre forme di utilizzazione del mais, come quella dei «gnocchett», impastati con una miscela di farina di granturco e di farina di frumento e conditi con formaggio e burro in uso nel Bresciano: «è un cibo che piace assai, — annotava nel 1847 ancora un medico della zona, Pietro Mottini — ma che non è quotidiano, perché richiede maggiore spesa, e il frumento è secondario nei prodotti agricoli di questi paesi»!7. 13. Cfr. le «osservazioni» De pellagra effettuate da G. Strambio nel pellagrosario di Legnano negli anni 1784 e seguenti e da lui pubblicate a Milano. 14. Cfr. tra l’altro, nella letteratura abbastanza ricca, G. Capsoni, Ancora sui coloni dell’alta Lombardia, in «Giornale agrario lombardo-veneto», Milano, gennaio 1842, vol. 16°, p. 62 e G. Assandri, Sulla pellagra, in «Gazzetta medica di Milano», Milano, 29 novembre 1845, pp. 431 sgg. 15. Milano e il suo territorio, Milano, 1844, tomo 1°, p. 266. 16. L. Balardini, Della pellagra, del grano turco quale causa precipua di questa malattia e dei mezzi per arrestarla, Milano, 1845, p. 40.
17. P. Mottini, Della pellagra. Studi teorico-pratici, in «Gazzetta medica di Milano», 20 ottobre 1847, p. 369.
168
Una più completa definizione della realtà dell’alimentazione maidica richiede però un accenno ad altri due suoi aspetti: la qualità del mais e la sua panificazione. Per quel che riguarda la qualità, è frequentissima nelle fonti coeve (a partire da Michele Gherardini nel 1779!8) l'osservazione che il mais consumato dalle popolazioni rurali era assai spesso alterato e attaccato dalla muffa, a causa della raccolta prematura e dei difetti della stagionatura e della conservazione. Raccolto infatti il grano, tal fiata anco immaturo, — questa la realistica descrizione
tracciata nel 1845 dal medico Giuseppe Assandri — stretti i contadini dalla fame, e dopo averlo per tre o quattro giorni esposto al sole, lo dividono col padrone, e collocano la propria metà nei luoghi i più mal adatti alla di lui conservazione. Come potrà infatti conservarsi incorrotto anche ben secco il grano presso i contadini, ammonticchiato nelle camere stesse ove sono ammucchiati i letti e coloro che vi dormono? Non vi ha famiglia, direi quasi, fra di essi, ed i medici che li assistono ben lo sanno,
nelle stanze delle quali entrando non si vegga in un angolo parte del frumentone destinato al vitto per tutto l’anno degli individui che la compongono, e parte sotto i letti sgranato od in pannocchie, in mezzo ad un’atmosfera viziata, ravvolto nella polvere di abituri ben di rado puliti, misto alle immondizie dei bambini, dei sorci, ecc.
Inoltre, poiché le scorte in genere venivano esaurite prima del nuovo raccolto, si rendeva necessario ricorrere alle anticipazioni usurarie del padrone,
che dava in prestito i grani più scadenti, o approvvigionarsi presso le botteghe («e quella farina che dai venditori d’ordinario si acquista dai mendicanti è sempre di grama qualità»!9). Venendo alla panificazione (operazione che ovviamente comportava il precedente ricorso al mulino), sia la confezione delle pagnotte di farina di mais,
mista assai spesso a farina di miglio, di segale e anche di veccia (il «pan ben vescionent e muff» del poeta dialettale Carlalfonso Pellizzone?°), sia la loro cottura erano per lo più opera delle stesse famiglie contadine, che soltanto di rado si servivano dei fornai. Le forme di pane, impastate con poco lievito e sale e molta acqua e confezionate in dimensioni «rilevantissime» per economizzare tempo e legna, erano poi introdotte nel forno, la cui bocca era tenuta accuratamente chiusa. «Ne viene da questo modo di procedere — rilevava il già menzionato Assandri — che il calore forte del forno rapidamente svincola dalla pasta gran parte dell’acqua che capisce, la quale innalzandosi in vapore diminuisce... la temperatura del forno, a segno che dopo poco tempo l’ambiente ne è tiepido, incapace a perfezionare la cottura del contenuto»; uscivano così pani con la crosta spessa, dura e screpolata, e con la mollica mal cot18. M. Gherardini, Della pellagra, Milano, 1779, passim. 19. Assandtri, op. cit., 6 dicembre 1845, p. 440. 20. Citato dal Cherubini, op. cit., p. 440.
169
ta e umidiccia. Difetti che risultavano ancora più gravi in quei «non pochi» comuni dove si usava cuocere il pane in fosse quadrilatere ricavate nel focolare del camino, alle quali si sovrapponeva un coperchio di ferro ricoperto di brace e cenere; e che erano presenti anche nella confezione delle «brusade»,
stiacciate arricchite «le più volte con porri e cipolle, e talora anche con noci, uva, finocchi, semi di pesche, spicchi di mele, fichi immaturi» e poste per pochi minuti nel forno prima dell’introduzione del vero pane?!. È quindi comprensibile come dopo due o tre giorni il pane ammuffisse acquistando un sapore acido e amarognolo, il che non ne impediva l’utilizzazione; i contadini infatti, come
si è accennato,
lo bollivano in acqua mal condita ricavandone
«una zuppa da penitenti che essi chiamavano brodo (‘“broeud”), e che dovrebbero invece nominare acqua bollita non si potendo pur dire acqua tinta»; varianti di questa zuppa erano ottenute bollendo il pane muffo sbriciolato nel latte sieroso o nel «vinello», e ad esse si dava la denominazione di «pappascianscia», «pappasal», «irletta», «burletta» e così via?2. L'impiego massiccio del mais si spiega anche con il fatto che ai contadini sembrava che quel tipo di alimentazione meglio valesse a placare gli stimoli di una fame a volte cronica; essi provavano cioè la sensazione illusoria che la
polenta «riempiva assai» e che «il grano turco rimane[va] con essi», come riscontrava nel 1809 Antonio Sabatti?3; motivazione analoga a quella che, a circa quaranta anni di distanza, adducevano i coloni di Cristina Belgioioso quando alla principessa, che li consigliava di sostituire al pane in grosse forme delle pezzature più piccole e meglio cotte, replicavano che conoscevano i vantaggi del pane ben cotto, ma che, «ponendosi un pezzo» del loro pane tradizionale «sullo stomaco alla mattina, non avevano più bisogno d’altro per molte ore, mentre un pane ben cotto non li avrebbe così gonfi e ripieni»?4. Anche nella Bassa il mais era una delle strutture portanti dell’alimentazione di salariati e braccianti, grandi consumatori di pane di granturco e di polenta. Così nel Cremonese — ma la notazione, che è del 1847, può essere estesa a tutto il territorio caratterizzato dal grande affitto — la minestra tipica era confezionata con una pasta, la «fogliata», ottenuta mescolando molta farina di granturco e poca farina di frumento di cattiva qualità; tagliata a pezzi, la «fogliata» veniva bollita «per soli pochi minuti nell’acqua, e così commista a fagiuoli, fave, verze od altra verdura, e condito il tutto con lardo od olio», 21. Assandri, op. cit., p. 432, e Cherubini, op. cit., p. 446. 22. Cherubini, op. cit., p. 445. 23. A. Sabatti, Appendice al «Quadro statistico del dipartimento del Mella», Milano, 1809, pp. 62-63. 24. C. Trivulzio Belgioioso, Stato attuale dell’Italia, art. IV: Condizione del basso popolo dell’Italia superiore, in «L’ Ausonio», Parigi, 1° semestre 1846, pp. 250-251.
170
formava il piatto «di cui le due e fin le quattro volte la settimana sogliono cibarsi a mezzogiorno i contadini, quando non siano per maggior miseria costretti a non far uso che della polenta»?25. E in due minestre e due libbre di pane veniva indicato nel 1851 lo «scarso e gramo trattamento» giornaliero dei salariati, al quale molti fittabili sostituivano 4 staia di melgone al mese?6. Accanto al mais nel regime alimentare delle popolazioni della bassa pianura figurava però in misura maggiore o minore — ma sufficiente comunque a limitare i guasti della pellagra — anche il riso; questo cereale (non tanto nella specie di riso bianco quanto in quella di «pistino» o «risino», ossia il riso mal pilato spaccatosi nel corso della pilatura) era utilizzato in generale per la preparazione di minestre nelle quali veniva mescolato a legumi o erbaggi, con l’aggiunta eventuale — specie nel Cremonese — di una certa quantità di vino per renderle più saporite e corroboranti??. Si è già accennato al ruolo estremamente marginale delle carni fresche nell’alimentazione delle popolazioni contadine, motivato dal loro prezzo elevato e attestato da una serie univoca di testimonianze relative a tutte le aree. «Ne” paesi più poveri» del Bresciano quelle carni erano consumate «appena qualche giorno dell’anno»?8; in Brianza la carne era riservata «per le occasioni di nozze e di malattie, e presso molte famiglie anche per la festa del paese»29; mentre riferendosi all’alto Milanese il medico Ercole Ferrario constatava — e siamo già in anni postunitari — che la maggior parte dei contadini «non conoscerebbero il sapore delle carni se al Natale non comperassero alcune ossa di porco o di vacca, non spoglie al tutto di muscoli, con cui preparano tanta copia di brodo per le zuppe e minestre che il brodo stesso non si differenzia dall’acqua»3°. Di qui l’invito ricorrente a proprietari e affittuari affinché facessero mostra di maggior comprensione verso coloni e braccianti, così da permettere — come si augurava uno scritto del 1848 — un cambiamento del 25. A.F. Tassani, Saggio di topografia statistico-medica della provincia di Cremona, in «Gazzetta medica di Milano», 5 giugno 1847, p. 206. 26. Cantoni, op. cit., p. 158. 27. Tassani, Saggio di topografia..., cit., p. 206. Per l'alimentazione dei lavoratori delle z0ne risate v. L. Faccini, / lavoratori della risaia fra 700 e ’800. Condizioni di vita, alimentazione, malattie, in «Studi storici», luglio-settembre 1974, pp. 556 sgg. 28. W. Menis, Saggio di topografia statistico-medica della provincia di Brescia, Brescia,
1837, vol. 1°, pp. 106-107. Sempre per l’area bresciana già il Sabatti aveva osservato che la maggior parte delle famiglie contadine «rare volte si cibano di carni fresche» (Quadro statistico del dipartimento del Mella, Brescia, 1807, p. 64).
29. F. Spreafico, Alcune notizie intorno all’agricoltura e allo stato degli agricoltori nella Brianza, in «Il Politecnico», Milano, 1844, vol. 7°, pp. 166-167.
30. E. Ferrario, Intorno allo stato materiale, intellettuale e morale de’contadini di una parte della Lombardia, estratto da «Memorie» del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, Milano, 1867, passim.
171
loro misero regime dietetico e la comparsa «alla mensa troppo parca dei villici, specialmente della pianura», di una quantità anche piccola di cibo animale almeno una volta la settimana3!. Né questa situazione così depressa era modificata gran fatto dalla presenza di eccezioni come quella segnalata, sempre dal Ferrario, nella zona di Busto Arsizio e dintorni, dove probabilmente grazie alla massa salariale percepita dagli addetti all’industria cotoniera si era esteso l’uso di carni vaccine e suine, «onde... si può dire, che qui da’ conta-
dini si mangia più e meglio che altrove; di che anzi i bustesi sono dagli estranei, forse per invidia, proverbiati»32.
Le carenze nell’apporto di proteine e lipidi all'organismo derivanti da questo tipo di nutrizione erano soltanto in parte attenuate dalle risorse che i contadini riuscivano a ricavare dalle loro piccole aziende e dall’economia di cortile o dalle opportunità di acquisto più economiche presentate dal mercato. Gli animali da cortile e le uova venivano prevalentemente venduti; e le uova riservate all’uso familiare erano generalmente destinate al capo di casa e agli uomini.
Servivano
invece prevalentemente
al consumo
domestico
i maiali,
che si uccidevano tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno e le cui carni venivano utilizzate soprattutto nella forma di insaccati. Ma poiché si trattava per lo più di suini allevati con parsimonia, ai quali il contadino poteva destinare unicamente «un po’ di polenta senza sale e di grano turco avariato» e che soltanto nelle settimane precedenti la macellazione erano nutriti con qualche maggior cura («un po’ di melica rossa, un po’ di crusca di frumento, qualche stajo di miglio, qualche tortello di semi di lino»), i risultati erano magri e i salami che si ricavavano — nei quali entrava spesso «qualche peso di magrissima vacca (e molte volte ammorbata)» — divenivano dopo pochi giorni «neri, affumicati, ossei»33. Una espansione si verificò nel consumo delle carni equine, nonostante la riluttanza verso quel tipo di alimento. La macellazione dei cavalli, dei muli e degli asini non più utilizzabili per le attività lavorative a causa dell’età o delle malattie era spesso clandestina; e le carni così ricavate, quando non erano spacciate per bovine, venivano tritate e mescolate con parti di maiale per farne salami e salsicce. Un’area specializzata in questo tipo di lavorazione era quella sulle sponde del Ticino tra Sesto Calende e Golasecca; qui affluivano dal Comasco e dal Milanese equini vecchi e giovani, sani e malati (compresi 31. G. Comolli, Delle malattie più frequenti e più gravi nella provincia di Como, e dei mezzi opportuni a diminuirle ed a curarle, in «Gazzetta medica lombarda», Milano, 28 agosto 1848. 32. E. Ferrario, Alcune considerazioni intorno alla pellagra, in «Gazzetta medica italianaLombardia», Milano, 30 maggio 1853, p. 197. 33. La pellagra in Lombardia ed i Consigli di sanità, a firma B... C..., ibidem, 30 luglio 1860, p. 254.
T72:
quelli non più in grado di servire ai «paroni» che attendevano al rimorchio delle barche da Tornavento a Sesto Calende) i quali venivano macellati senza alcuna garanzia sanitaria e le cui carni, tranne quelle consumate con una cer-
ta abbondanza sul posto, erano esportate in varie province della Lombardia e nel Novarese34. Un posto del tutto secondario avevano i prodotti della caccia, anche perché la selvaggina acquatica andava sempre più diminuendo in seguito al prosciugamento di paludi e acquitrini; e del resto i volatili più pregiati erano destinati alle mense degli agiati, mentre sul desco dei contadini alla stagione del passo figuravano allodole, tordi, merli, cardellini catturati con le reti e i lacci. La monotonia dei pasti che si succedevano sempre eguali a se stessi era rotta a volte dal pesce fresco, specie nelle aree vicine a laghi e a corsi d’acqua, dalle rane, dai gamberi e dal pesce salato o seccato (merluzzo o baccalà in prima fila, e poi aringhe, sardelle, tonno e avole del Garda). Per quel che riguarda il latte e i suoi derivati, se le popolazioni delle montagne e delle valli potevano fare affidamento sulle capre, «le amiche del povero», nella regione mediana i contadini proprietari di qualche mucca utilizzavano il latte per farne panetti di burro da vendere nel più vicino mercato; al più, come nell’alto Milanese, veniva usata come
«manicaretto estivo» la cosidetta
«caggiada», cioè il residuo inacidito o sieroso del latte scremato. Nella bassa pianura il grande carico di bestiame vaccino induce a credere che l’impiego del latte per fini alimentari fosse relativamente più diffuso; inoltre molti fittabili usavano «dare ogni dì la ricotta (mascarpa) alle opere (ai giornadee)», men-
tre il venerdì dispensavano il rimasuglio sieroso risultante dalla fabbricazione delle forme di formaggio lodigiano35. Frequente era anche l’uso come companatico dei formaggi, ma soltanto di quelli di qualità inferiore. Tra i condimenti più diffusi, utilizzati però sempre con parca misura, accanto all’olio di semi figuravano il burro acidognolo di scarso pregio (chiamato nel Milanese «butter de tocch» o «de montagna») e il lardo. In questo quadro alimentare per tanti versi tradizionale, povero di apporti proteici, lipidici e vitaminici e nel quale i più importanti elementi di variazione erano l’accresciuto peso del mais e, ma in misura molto minore, quello del
riso, merita un accenno anche la patata. Il cammino dei «pomi di terra» fu lento e contrastato, dopo l’effimera diffusione dell’età napoleonica e quella indotta dalla carestia del 1815-16. Tra le cause che ne frenavano il progresso Filippo Re additava nel 1817 «l’avversione che gli agricoltori hanno contro 34. V. in particolare F. Dell’ Acqua, Sull’alimentazione carnea e sull’uso alimentare delle carni cavalline, Milano, 1868, pp. 59 sgg. e 120 sgg., e G.B. Milanese, /ppofagia, in «L’Igea», Milano, pp. 82 sgg. 35. Cherubini, op. cit., pp. 434-436.
FIA
tuttociò che si presenta con aria di novità, il dubbio nato in loro che queste
radici si vogliano dai loro padroni sostituire al grano, l’ignoranza dei proprietarj intorno alla rustica economia»36; cause che in parte erano ancora operanti negli anni ’40, se le fonti del tempo parlano di una coltivazione tuttora scarsa del tubero nel Mantovano, nel Milanese («i pomi di terra non sono abbastanza coltivati dai nostri contadini, ed i pochi si danno ai fanciulli») e nelle altre province di pianura37, mentre la sua coltura si era ormai dal più al meno affermata nelle terre dell’alta Lombardia88. Il contadino trovava un illusorio conforto alla sua dura fatica nel vino, questo almeno finché alla metà del secolo l’oidio non cominciò a devastare i vigneti lombardi. Il vino era consumato durante il lavoro o in casa (ma allora era un prodotto di bassa gradazione alcolica, il «vino di stretta», il «torciade-
gh» che ad esempio i proprietari dell’alto Milanese e del Comasco lasciavano ai mezzadri e ai coloni), oppure nelle osterie e nelle bettole, il cui numero andava rapidamente salendo??. Più difficile riesce, allo stato attuale delle ricerche, delineare l’alimentazione
del «popolo minuto» delle città lombarde, che tuttavia rassomigliava nei suoi tratti essenziali (prevalenza di cereali e legumi e scarsità di carne) a quella delle campagne. Si può però avanzare fondatamente l’ipotesi che a Milano e nei centri urbani maggiori diminuisse nell’apporto nutritivo la parte spettante al mais a vantaggio di altri grani, non escluso il frumento. Nei forni milanesi, infatti, ac-
canto al pane «ad arbitrio» di puro fiore di farina di frumento o di semola per le mense dei ceti abbienti e a quello di «roggiolo» di infima qualità si confezionavano pani intermedi destinati al più largo smercio nei quali il mais non figurava in modo esclusivo (come quello composto di farina di frumento e di granturco in egual misura o quello fatto con farina di segale, miglio e mais in parti eguali) o non figurava affatto (il «pane bianco a meta»); e abbastanza elevato doveva essere, specie a Milano e nelle città della Bassa, l’uso delle paste di frumento e del riso. Così pure è probabile un maggior consumo di carni bo36. Re, op. cit., p. 8. 37. Milano e il suo territorio, cit., vol. 1°, p. 266.
38. V. la tabella in Jacini, op. cit., p. 78. 39. In alcune zone si usava far bere vino anche ai fanciulli di tenera età. Così nel Casalasco, riferisce un medico, si cominciava «fino dalla culla... a fare libazioni a Bacco; il fanciulletto di 4 a 6 anni non va alla scuola, alla campagna, se non vede far parte della piccola sua provvigione il fiaschetto di vino» (Tassani, Saggio di topografia..., cit., p. 206). 40. Si vedano i vari «capitoli» che i prestinai erano tenuti a osservare in Grida e regolamenti, tasse e tariffe diverse tuttora in vigore alla Congregazione municipale della R. Città di Milano, Milano, 1850, passim. 41. Da dati relativi al 1843, validi come indicatori di tendenza, risulterebbe che per 1 q. di
farine non di frumento se ne utilizzavano 6 di farina di frumento (Milano e il suo territorio, Gltgvol..l6p.2131).
174
vine nei centri urbani, anche se uno dei primi studiosi postunitari del problema dell’alimentazione affermava che nella Milano del tempo, «forse la più ricca delle città italiane», più di un decimo dei suoi abitanti ben di rado gustavano carne, e aggiungeva che la razione media giornaliera si era andata riducendo tra il 1810 e il 1862 in seguito al rialzo dei prezzi??. Un'altra costante che si può ricavare dalle testimonianze è l’incidenza relativa che in questi consumi già limitati avevano le frattaglie43 e le carni dei vitelli immaturi4, dei castrati, degli ovini e dei suini (insaccati e no). Queste
ultime lasciavano spesso a desiderare sotto l’aspetto igienico-sanitario, e gravi in particolare potevano essere le conseguenze dell’impiego diffuso delle carni di maiale durante l’estate; e non soltanto perché nei mesi estivi la loro qualità peggiorava giacché gli allevatori risparmiavano sul tipo di nutrimento dal momento che potevano attribuire la colpa della cattiva riuscita del prodotto alla stagione calda, ma anche perché carni fresche e «lardoni» venivano smerciati dai salumieri dopo una cattiva preparazione o addirittura in stato di «decomposizione più o meno inoltrata». Ma su un piano più generale era la mancanza di accurate visite sanitarie sulle carni, in violazione alla normativa vigente (come le circolari del 9 giugno 1828 e 18 settembre 1848), a costituire un grave problema di igiene sociale: Or come sta che appo di noi — chiedeva in un discorso del 1860 il fisiologo Filippo Lussana facendo riferimento anche alla situazione dei precedenti decenni — si trascorra sì ciecamente... a permettere che qualsiasi zotico, qualsiasi maniscalco possa coprir di fedi di sanità le carni da macello e da vendersi, e per tale sconsigliatissima guisa gettare all’azzardo la salute e la vita delle genti mal affidate alla tradita
legge?40 42. G. Bazzoni, L'alimentazione e le risorse economiche del popolo minuto di Milano, Milano, 1868, pp. 29, 8 e 43.
43. Si veda ad es. il seguente passo del Sabatti relativo a Brescia: «I macellaj delle bestie grasse e magre devono per patto assunto verso il Comune vendere per un prezzo convenuto le così dette giunte, cioè i piedi, il fegato, il polmone, il cuore, la milza, e la testa. Oltreché questa disciplina porta un vantaggio al basso popolo per le giunte, che si vendono a un prezzo tenue per conto della Comune, i compratori delle carni alle macellerie non possono con esse essere sopraccaricati» (Sabatti, Quadro statistico..., cit., p. 196).
44. Sulla vendita di carni di vitelli macellati pochi giorni dopo la nascita per permettere l’utilizzazione nel caseificio del latte materno v. F. Lussana, Sulla pubblica igiene, in «Gazzetta medica
italiana-Lombardia»,
12 novembre
1860, p. 383. Il Lussana
scriveva che questa
consuetudine, alla quale avevano cercato inutilmente di porre un limite alcune disposizioni della Cisalpina e poi del governo lombardo, era «un cinico calappio alla fede pubblica ed all’obolo del povero e del malato» perché i compratori acquistavano invece di carne nutriente un ammasso di «sostanze gelatinose» povere di valori nutritivi. 45. Cardone e Gorini, Sulla convenienza di proibire la macellazione dei suini durante l’estate, in «L’Igea», Milano, 1° settembre 1863, pp. 353-354. 46. Lussana, op. cit., p. 384.
D75
La situazione era inoltre aggravata dalla macellazione clandestina e dal contrabbando di equini destinati all’alimentazione degli abitanti delle città, pratiche divenute più estese nel periodo immediatamente preunitario, come sta a dimostrare l’aumento di prezzo dei cavalli divenuti inservibili4”. Analoghi a quelli già notati nelle campagne erano poi altri tratti tipici dell’alimentazione dei ceti popolari urbani: limitato impiego di latte, uova, formaggi di qualità superiore e burro; prevalenza del lardo come condimento; presenza di fagioli, fave, patate e cavoli; abbondante ricorso ai pesci seccati e
salati; di contro assai più adulterazioni quando era birra (la cui diffusione fu A proposito del vino,
largo era l’uso del caffè (che acquistato già macinato), favorita quando l’oidio colpì uno dei pilastri del regime
si prestava però a facili dello zucchero e della la produzione di vino). alimentare del «popolo
minuto», di esso si faceva un consumo di massa anche nelle città, specie nel-
le osterie e in particolare nei giorni di festa, come prova la diffusione del cosidetto «sciopero del lunedì», cioè l’assenteismo che si verificava nei luoghi di lavoro nelle giornate successive alle feste. Il fenomeno dell’ubriachezza era visto con preoccupazione dagli osservatori, che in genere si limitavano a una condanna generica e moralistica, come faceva il medico di Brescia Guglielmo Menis il quale deplorava che operai e artigiani passassero gran parte del loro tempo libero nelle bettole e nei «ridotti grandemente moltiplicati in tutte le contrade e nei più riposti vicoli» scialacquando così i loro risparmi?9. Ma vi era anche chi cercava di guardare più a fondo nel fenomeno per coglierne le ragioni di natura sociale; è questo il caso di Faustino Sanseverino che attribuiva, sia pure in forma dubitativa, le dimensioni prese dall’ubriachezza in Crema alla durezza delle condizioni lavorative nella pettinatura del lino, una delle attività prevalenti nella città, «giacché la polvere che si innalza... eccita continuamente la sete negli operai, i quali non si accontentano di soddisfarla con acqua, ma vogliono bere vino, ed abituandosi essi a frequentar le osterie vi attirano i loro amici ed in tal modo si è forse tanto propagato questo vizio nel nostro paese»50. E per concludere sul consumo delle bevande alcoliche si deve anche ricordare che quando negli anni ’50 il rialzo del prezzo dei vini ridusse il loro consumo tra i ceti meno abbienti non mancò chi seppe mettere a profitto la contingenza: infatti «l’industrial si mise a fabbri47. V. gli scritti citati alla n. 34. 48. V. nell’«Igea» del 1864 (pp. 250 sgg.) una nota di C. Pavesi, il quale osservava che da qualche tempo era stato posto in commercio caffè torrefatto a un prezzo basso, reso possibile dal fatto che al caffè si mescolavano semi di cereali, polvere di carbone e anche sali di rame e piombo. 49. Menis, op. cit., vol. 1°, p. 119 e vol. 2°, pp. 64 sgg. 50. F. Sanseverino, Notizie statistiche e agronomiche intorno alla città di Crema e suo territorio, Milano, 1843, p. 42.
176
care acquavite di patate, di barbabietole, di segale, di frumento» offrendo «questo liquore di fuoco al popolo a basso prezzo», con conseguenze certamente più dannose di quelle dello spaccio dei vini5!. Chiuso il tema dell’alimentazione con queste note sul vitto delle famiglie delle classi popolari cittadine (che, val la pena aggiungere, erano costrette a spendere per questa voce intorno al 65% del loro bilancio5?), rivolgiamo ora l’attenzione al problema delle abitazioni. La condizione delle dimore delle popolazioni rurali, dalle quali iniziamo l’esame, appariva estremamente degradata. Borghi e villaggi delle montagne e delle valli, le cui case erano edificate in pietra, o in pietra e mattoni, e più raramente in legno, erano in generale «labirinti di stradicciuole tortuose ed ingombre d’imondizie»53 a causa degli «ammassi di letame stipati sulla porta delle case, e negli atrii strettissimi delle contrade» e del «perfido abuso di adagiare stramaglie sulle vie e negli atrii stessi dei domicilii affine di imbeverli di escrementi umani e bovini per avere concimi senza il concorso di bestie legate alla stalla», consuetudini che inquinavano con un «fetido colaticcio» strade e cortili. Quanto alle case e ai loro interni le dimore dell’uomo, anguste e mal ventilate, erano spesso comuni anche alle bestie55. Ma un’idea più precisa la si può ricavare dalla dettagliata descrizione tracciata nel 1844 per la Valtellina da F. Visconti Venosta: Il contadino se vive male, alloggia peggio. Il comperarsi, o fabbricarsi una casa, è dispendio troppo superiore alle sue fortune; quindi appuntella, il meglio che può, le antiche catapecchie ereditate dagli avi, le quali, divise ne’ figliuoli e suddivise nei pronipoti, subiscono uno stranissimo trituramento di proprietà fino ad essere l’istessa camera, l’istessa cucina, l’istessa corte divisa per quarti, e per sesti.
Queste abitazioni tramandate di generazione in generazione (la povertà generale non incentivava infatti la costruzione di case da dare in affitto) erano
umide, sporche, con «le muraglie sconnesse, solo intonacate dal fumo che stanzia in quelle nere cucine, ed esce dagli usci, mancando
di fumajolo, e
molte per fin di finestre, se non si ha per finestra un foro praticato nella muraglia da qualche sasso mancato, o tolto»56. Nell’unico locale di queste dimore si svolgeva l’intera vita familiare, in uno stato di rozza primitività che colpiva nel 1858 Diego Guicciardi, il consigliere di Luogotenenza incaricato 51. «Eco della borsa», Milano, 6 novembre 1854, p. 3. 52. A. De Maddalena, Prezzi e mercedi a Milano dal 1701 al 1860, Milano, 1974, p. 330.
53. Jacini, op. cit., p. 196. 54. B. Besta, Sulla Valtellina, in «La Medicina comunale», Seregno, 1864, p. 234.
55. Menis, op. cit., vol. 1°, pp. 114-115. 56. Visconti Venosta, op. cit., pp. 55-56.
I7%
dall’arciduca Massimiliano Ferdinando di compiere un’inchiesta sulle condizioni economiche e civili della Valtellina: Non parlo di mobili, — scriveva il Guicciardi — mentre tranne un meschino letto e gli utensili più che indispensabili per cuocere il cibo usitato. nulla si vede in quei miseri tuguri, ed anche di questi molte famiglie sono prive, per le quali un giaciglio di paglia o strame come quello delle bestie, è l’unico oggetto su cui riposare le stanche membra. Poche sono le famiglie che abbiano buone coperte per riposarsi dal freddo, al qual uopo sogliono usare gli stessi cenci che indossano il giorno, e meno poi anco-
ra quelle che usino biancheria da letto?7.
Né di livello superiore, se si prescinde da una maggiore abbondanza di spazio, appariva agli inizi della Restaurazione il livello delle dimore rurali, sparse nella campagna o accentrate, della zona mediana della Lombardia. Circondate spesso da letamai, esse avevano in generale una stanza inferiore
(con il pavimento di terra battuta) e una superiore piccole e basse, con finestre di dimensioni ridotte prive di imposte e tappate alla meglio con legno o carta98. In queste zone la gelsibachicoltura si era dilatata al punto da condizionare tutto l’assetto agrario e sociale; e il baco da seta era un ospite esigente, che costringeva la famiglia colonica a cedergli non solo la camera superiore ma anche la cucina, perché essendo i contadini restii ad addossarsi il costo della legna necessaria per ottenere il fuoco continuo e il calore costante che più si confaceva alla maturazione dei filugelli preferivano spesso tenere i «bigatti» nelle cucine, dove la temperatura variava però a seconda che il camino fosse acceso o spento5?; di conseguenza uomini, donne e bambini erano costretti a cercarsi una sistemazione di fortuna, ammassando molti letti in spazii esigui, mentre gli ambienti si facevano irrespirabili per «il trasudamento delle foglie, la fermentazione dei così chiamati letti dei bachi pieni zeppi dei loro escrementi, il fumo altresì o non bene raccolto nei camini troppo spaziosi 0 tramandato dai piccoli fuochi accesi qua e là per intiepidire la camera»90, Nel corso dei decenni
la spinta a razionalizzare l'allevamento
dei bachi,
che da un lato portò alla sperimentazione di bigattiere padronali, spinse dall’altro i proprietari più accorti ad apportare alle case rurali migliorie (come l’apertura di nuove finestre e la costruzione di camini) delle quali profit57. Rapporto all’arciduca del 10 giugno 1858, in ASM, Cancelleria riservata del governatore, b. 457. 58. Oltre al Sabatti, Quadro statistico..., cit., p. 65, cfr. C. De Capitani, Sull’agricoltura particolarmente nei paesi di collina, Milano, 1815, vol. 3°, pp. 272-273. 59. V. una delle prime testimonianze al riguardo in Regola pratica e compiuta di allevare i bigatti felicemente, Milano, 1784, pp. 15-17. 60. B. Del Bene, Fornello per le stanze dei filugelli, in «Opuscoli scelti», Milano, 1795, VOM Pra ore
178
tarono anche i contadini, sempre però nell’ambito di una situazione degradata e sostanzialmente stazionaria. Il baco da seta è animale molto delicato che facilmente si ammala e muore; — osser-
vava a questo proposito la Belgioioso — siccome gli abbisogna appunto un asciutto ed un’aria pura, così i padroni timorosi di perdere qualcuno di quelli letti, fecero e fanno ogni giorno rifabbricare le case de’ loro coloni, ripararne SIADA ina fresche correnti d’aria, e di questi miglioramenti trae profitto l’uomo0!.
locale animai solai, anche
Quanto poi ai contadini della Bassa può essere accolta questa valutazione complessiva del Cantoni: A persuadersi della miseria e delle privazioni a cui sono condannati, basterebbe accompagnare la vita del contadino in una giornata di lavoro: basterebbe visitare la sua abitazione cupa, disagiata, senza luce, spesso sotto il fetore delle cloache, nella quale sono ammucchiati in una stanza sola genitori, figli, e talvolta i figli dei figli, chi su povero letto, chi su immondo strame gettato sul terreno. Eppure non tutti giungono a ripararsi in questo squallido abituro, giacché una gran parte di contadini passano tutto l’anno la notte sulle cascine, sotto i portici, nelle stalle, sotto quell’aria umida e pesante, a grave scapito della salute®2.
Nel paesaggio della bassa pianura irrigua, disseminate nell’aperta campagna o ai margini dei centri abitati, sorgevano le cascine, il cuore dell’azienda agraria capitalistica. Complesso di forma quadrilatera, spesso chiuso di notte dai proprietari e dagli affittuari, quasi a rimarcare la subordinazione personale dei contadini, la cascina comprendeva, accanto alle stalle, ai fienili e alle costruzioni necessarie allo svolgimento delle attività agricole, anche la casa padronale e le abitazioni dei lavoratori. Ma mentre le dimore dei padroni e talora quelle dei fittabili avevano una loro dignità architettonica, quelle dei coloni riflettevano tutto lo stento della vita contadina. Gli abituri dei salariati e degli obbligati si articolavano in generale, indipendentemente dal numero dei membri della famiglia, in due stanze sovrapposte, comunicanti tra loro attraverso una scala esterna (per economizzare gli spazi interni) o una rudimentale scala interna a una sola andata. In quella inferiore, utilizzata come cucina e stanza da pranzo, l’abitabilità era compromessa dal tipo di pavimentazione prevalente; per incuria o per spirito di economia dei proprietari il pavimento infatti non era ammattonato ma costruito in «terrazzo» 0 «gerone» (terra bat-
tuta con calcina e ghiaia o con calce, sabbia, ghiaietto e mattoni pestati), oppure era addirittura di nuda terra. Questa pratica offriva poche difese contro
61. Trivulzio Belgioioso, op. cit., p. 254. 62. Cantoni, op. cit., pp. 103-104.
d79
l’umidità, tanto più che, data la superficialità della falda acquifera, era quasi inesistente la consuetudine di costruire cantine. Il locale superiore, occupato da uno o due letti capaci di più persone, a volte era privo di soffitto e quindi risultava coperto direttamente dal tetto con le sue impalcature di legno a nudo; in altri casi invece era separato dal tetto da un soffitto formato da un sottile strato di malta (la cosidetta «caldana»), che non riusciva però a proteggere l’ambiente né dal caldo né dal freddo. Anche nelle cascine, come nelle al-
tre abitazioni rurali, le finestre erano piccole e scarse, e quando cominciarono ad ampliarsi questo avvenne per le esigenze dell’allevamento del baco da seta; esse erano generalmente chiuse da serramenti di legno, mentre assai lenta fu, a partire dagli inizi del secolo, la diffusione dei telai vetrati98.
Se questo era in generale lo stato delle abitazioni rurali, disadorne, arredate con poche e vecchie suppellettili (oltre ai letti un tavolo, alcune sedie, qualche cassapanca), rischiarate nelle ore serali da lucerne alimentate con olio di semi, umide e fredde nella cattiva stagione, si intende la funzione centrale che
durante i mesi invernali assumeva la stalla nella vita dei contadini della collina e della pianura. Le stalle, più o meno ampie a seconda del numero dei bovini ospitati, erano tenute chiuse con grande cura per non lasciar disperdere il calore, ed anche per la credenza che gli animali tenuti in locali ben caldi avessero bisogno di una minore quantità di cibo; tanto che a una temperatura esterna di qualche grado sotto lo zero ne corrispondeva una interna di 12°-16°. In queste stalle — informava una vivace testimonianza del tempo — stan raccolti dalla mattina fino a notte avanzatissima, massime in que’ giorni in cui non si ponno far lavori nei campi, uomini e donne dello stesso casolare ed anche de’ vicini, talvolta in numero di 30, di 40 e più; occupandosi le donne in filare e cucire, e gli uomini in qualche leggier lavoro, od anche, il che accade più spesso, nel non far nulla. Qui pure recano le culle ove tengono i bambini per aver maggior agio di sorvegliarli, e spesso i giovani e i ragazzi vi passano la notte stesi su un po’ di paglia. Né ciò solo: ma invitati e lusingati dal tepore che entro vi regna, qui pure moltissime famiglie soglion fare il bucato, e stendere ad asciugare le biancherie.
La coabitazione promiscua di uomini e animali in spazi spesso angusti rendeva l’atmosfera viziata e quasi irrespirabile per chi non vi fosse abituato: Or qual debba essere — notava criticamente un medico condotto — la purezza dell’aria in un sito caldo, sempre chiuso, ove all’alito e alla traspirazione de’ bovini s’uniscono l’alito e la traspirazione di tante persone ivi affollate e le emanazioni degli escre63. Per la caratterizzazione delle dimore nella cascina mi sono servito di un lavoro inedito
di M.T. Mereu sulle tecniche di costruzione nelle abitazioni rurali della bassa pianura lombarda tra 700 e ’800.
180
menti delle bestie, e gli effluvi di chi si ciba unicamente di farinacei conditi d’aglio e cipolla, ... ognuno potrà di leggieri per sé immaginarselo®4.
Sono facilmente intuibili le conseguenze negative di questa consuetudine sul piano igienico-sanitario, alle quali le autorità cercarono di opporre un qualche argine emanando «discipline» che imponevano ai proprietari di prendersi maggior cura della pulizia delle stalle55. Questi interventi amministrativi erano però generalmente elusi per il generale disinteresse di padroni e affittuari; e del tutto eccezionale restò l’iniziativa presa nel 1845 da Cristina Belgioioso nelle sue tenute di Locate con l’apertura di uno «scaldatoio» (un locale capace di 500 persone, riscaldato con una stufa, cui tutti gli abitanti potevano accedere dalle prime ore del mattino alle 11 di sera sottraendosi così «al fetore ed all’aria malsana delle stalle»)66. Ma nella secolare usanza della vita invernale nella stalla accanto all’esigenza
di difendersi dal freddo senza consumare legna entrava anche un’altra componente: la funzione di luogo di incontro e quasi di ritrovo che la stalla svolgeva nella monotona esistenza del contadino; i «filocci» (come i convegni nelle stalle erano chiamati nel Bresciano perché l’occupazione principale delle donne era quella di filare) erano infatti l'occasione per stare insieme in tanti, conversando o ascoltando un narratore che raccontava favole o le storie avventurose di Guerino il Meschino o dei Reali di Francia9?. Per questo, come annotava con stupore un osservatore, «i contadini chiamano queste fogne le loro sale ...; e tanto vi si deliziano che appena nell’autunno si accorciano i giorni, alla sera v’accorron con quella gioja e trasporto, con cui l’artigiano cittadino al teatro»98. Passando ora a Milano e ai centri urbani, si deve rilevare in primo luogo la carenza di ricerche sulle varie componenti che definiscono l'habitat urbano: evoluzione edilizia e urbanistica di città o di singoli loro quartieri; variazioni nell’insediamento dei gruppi sociali in relazione all'emigrazione e all’immigrazione e alla ristrutturazione delle vecchie aree centrali; rapporti tra comune urbano e comuni o comune rurali (Corpi Santi); articolazione della proprietà immobiliare; dinamica della rendita fondiaria, del prezzo delle aree e degli affitti; strutturazione interna degli edifici adibiti ad abitazione, loro età e 64. E. Ferrario, Del passare l’inverno nelle stalle, considerato come cagione di molte malattie, in «Gazzetta medica di Milano», 19 dicembre
1846, p. 437.
65. Si v. ad es. il documento riprodotto in /8/5-1898... Quando il popolo cominciò a leggere. Mostra dell’alfabetizzazione e diffusione della lettura in Lombardia, Milano, 1974, tav. 10. 66. F. Aporti, Istituzioni di comune educazione e soccorso fondate in Locate (provincia di Milano) dalla contessa Cristina Trivulzio principessa Belgiojoso, in «Annali universali di statistica», 1846, vol. 89°, pp. 173-174. 67. Si vedano tra l’altro le descrizioni, ambientate nel Mantovano, nelle novelle del Nievo Il milione del bifolco, L’avvocatino, La viola di San Bastiano (in I. Nievo, Novelliere campagnolo e altri racconti, Torino, 1956).
68. Ferrario, Del passare l’inverno..., cit., p. 438.
181
stato di conservazione; distribuzione degli abitanti negli spazi abitabili e indici di affollamento; tecniche dell’edificazione; stagnazione e innovazione negli impianti relativi all’igiene urbana e a quella domestica; localizzazioni industriali e dei servizi e loro effetti sulla compagine cittadina; problema delle «case operaie» e via dicendo. Tutte questioni la cui conoscenza potrebbe progredire con indagini sistematiche condotte sulle fonti le più varie, da quelle fiscali e catastali a quelle notarili99. Lo stato degli studi impedisce quindi di andare al di là di alcune notazioni episodiche, che non lasciano tuttavia molto spazio a una valutazione ottimistica. È certamente vero che la realtà edilizia e igienica delle città lombarde nella prima metà dell’800 era nel suo complesso lontana dagli estremi di disgregazione e degradamento di alcuni centri del Mezzogiorno, come Napoli o Palermo. E così pure si devono tenere nel debito conto i miglioramenti apportati dalle amministrazioni locali in materia di sistemazione, livellamento e pavimentazione delle strade, costruzione di canali sotterranei per smaltire le acque piovane, pulizia delle piazze e delle vie?0, per cui a mezzo il secolo Milano non era più quella che il Parini descriveva come ammorbata dal «fimo alto» stagnante tra «le sublimi case» e che nel 1809 appariva al Foscolo «una cloaca maligna». E accanto a quelle misure sono da porre le limitate operazioni di risanamento effettuate — dopo le invasioni del colera nel 1836 e negli anni seguenti — in contrade e case malsane, come avvenne in alcuni quartieri milanesi (dove al posto dei vecchi agglomerati si costruirono edifici a più piani, nei quali i corridoi e le caratteristiche «loggie a ringhiera» garantivano il disimpegno dei locali e migliori condizioni sanitarie?!) o nel «circondario» israelitico di Mantova??. E tuttavia si trattò sempre di interventi episodici, che non modificarono nella sostanza un tessuto urbano nel quale le eredità strutturali del passato che operavano negativamente sulle condizioni quotidiane di esistenza di artigiani, operai e lavoratori dipendenti erano aggravate dai problemi emergenti, quali la insufficienza di abitazioni accentuata dall’aumento della popolazione e il «caro alloggi», che veniva a incidere più marcatamente sul bilancio fami69. In particolare potrebbero risultare assai utili le indicazioni relative ai cosidetti beni «di seconda stazione» ricavabili dal catasto teresiano nell’ Archivio di Stato milanese, sui quali sono ora in corso dei lavori. 70. Si vedano, a titolo esemplificativo, Milano e il suo territorio, cit., vol. 1°, p. 248, e per Mantova L. Preti, Notizie statistiche..., cit, Mantova, 1842, p. 236, e G. B. Soresina, Cenni di topografia medico-igienica sulla città di Mantova, Mantova, 1857, p. 19. Cfr. anche G. Capsoni, Sul clima della bassa Lombardia. Ricerche politico-mediche-statistiche, Milano, 1839, pp. 4243. 71. G. Sacchi, Intorno alla fondazione di nuove abitazioni per la classe operaia a Milano, in «Atti dell’ Accademia
fisio-medico-statistica di Milano», anno acc. 1858-1859, p. 107.
72. Preti, op. cit., pp. 236-237.
182
liare?3. E valga il caso di Brescia, dove nelle contrade in cui alloggiavano i gruppi sociali a reddito più basso (parrocchie di S. Giovanni, S. Faustino e S. Alessandro) secondo una descrizione del tempo «le abitazioni sono agglomerate in mal ordinate serie e formate a molti scomparti sovrastanti l’uno all’altro, dei quali ognuno per l’ordinario serve al ricetto d’un’intera famiglia costretta a trascinare una stentata esistenza fra lo squallore ed i cenci, e mancano più sovente di spazio per dare sfogo alle immondezze»?4. Né la situazione era gran fatto mutata trenta anni più tardi, perché la città continuò a risentire gli effetti negativi di un’alta densità di abitanti all’interno della cerchia muraria, di un elevato tasso di affollamento per vano, della rudimentalità delle strutture igieniche, con i conseguenti riflessi sulla mortalità che si attestò a lungo, nei decenni post-unitari, su livelli più sostenuti di quelli della generalità degli altri capoluoghi di provincia?5. Quanto a Milano gli interventi risanatori avevano avuto un carattere assai parziale, tanto che alla vigilia del ’59 in numerosi borghi e contrade (Porta Comasina, Porta Vittoria, Porta Romana, Porta Lodovica, Porta Ticinese, S. Pietro in Campo Lodigiano, borgo della Cittadella) le case erano «catapecchie... indegne di accogliere gente viva»7, e ancora alcuni anni più tardi in quegli stessi quartieri la popolazione appariva al ricercatore «sciaguratamente addensata in orribili tugurii»??. Un ultimo aspetto che aiuta a meglio intendere le concrete condizioni di vita delle popolazioni lombarde è quello dell’approvvigionamento idrico per 1 bisogni domestici, problema al quale si davano risposte diverse in relazione alle peculiarità dell’insediamento e ai caratteri geofisici del terreno. Le popolazioni montane e valligiane utilizzavano prevalentemente le acque di torrenti e ruscelli (dalle quali in alcuni centri si derivavano fontane), dei pozzi e dei laghi; nelle campagne della zona collinare, dove in estate l’acqua si faceva scarsa, erano frequenti le fonti, ma si ricorreva anche ai fiumi, mentre nell’alta pianura ci si serviva delle sorgenti, più frequenti ai margini inferiori delle alture, e dei pozzi, peraltro non molto numerosi; nella bassa pianura infine prevalevano le acque di pozzo, ma era anche frequente il ricorso a quelle dei fiumi e dei canali irrigatori?8. In questo quadro, di fronte al vantaggio (almeno in certe aree) della relativa abbondanza d’acqua, stavano i disagi originati dalla lontananza delle fonti di approvvigionamento dalle abitazioni, e soprattutto i rischi dell’inquinamento. 73. De Maddalena, op. cit., pp. 327 sgg. 74. Menis, op. cit., vol. 2°, p. 45.
75. B. Zanetti, Le condizioni igienico-sanitarie del comune di Brescia dal 1860 al 1900, tesi di laurea discussa nella Facoltà di lettere e filosofia dell’ Università degli studi di Milano nell’anno acc. 1972-1973. 76. Sacchi, op. cit., p. 107.
77. Bazzoni, op. cit., p. 91. 78. Notizie naturali e civili sulla Lombardia, Milano, 1844, vol. 1°, pp. 247 sgg.
183
La potabilità delle acque utilizzate dalle popolazioni rurali era infatti in vario grado insidiata da una serie di fattori negativi: fiumi e ruscelli erano esposti a molteplici pericoli di contaminazione (attraversamento di mandrie di bestiame, scarichi di rifiuti, scoli di centri abitati); i pozzi lasciavano generalmente a de-
siderare per quel che riguardava il rivestimento murario, il rinnovo dello strato di ghiaia impiegato per filtrare l’acqua pullulante dalla falda, la pulizia dei tini di legno aperti sul fondo collocati nella parte terminale dello scavo, e per di più spesso a gola aperta?9; inoltre nella bassa pianura, dove erano frequenti le infiltrazioni di sostanze inquinanti nei pozzi80, i contadini usavano dissetarsi,
«più per incuria che per necessità», con l’«acqua colaticcia di prati e risaje»8!. In via di miglioramento appariva il rifornimento idrico delle città (assicurato con i pozzi pubblici e privati e talora con acquedotti e condutture collegati a sorgenti e corsi d’acqua) grazie a innovazioni come lo scavo, a partire dagli anni ‘40, di pozzi trivellati, sistema che permetteva di arrivare a profondità assai maggiori di quelle dei pozzi comuni e di ottenere cosi acque più pure82. Si generalizzò inoltre l’impiego di pompe per l’innalzamento dell’acqua dai pozzi alle abitazioni, e questo rese possibile portarla sino ai piani elevati e diramarla negli appartamenti attraverso tubature di ferro. Ma ancora una volta i progressi erano condizionati da pesanti limiti. Le acque derivate dai fiumi o dalle sorgenti andavano soggette, come si è accennato, alla possibilità di gravi inquinamenti; ad esempio gli abitanti di Sondrio si dissetavano con le acque del Mallero, nel quale si lasciavano però «scolare acquajoli e latrine»83; e l’acquedotto che portava le acque dalla sorgente di Mompiano a Brescia, alimentante la miriade delle sue fontane pubbliche e private, correva in molti punti «aperto e traforato» per comodità delle famiglie che abitavano lungo il suo percorso, mentre le sconnesse lastre della copertura lasciavano libero l’accesso alle acque pluviali e alle impurità84. In generale poi non veniva curato il rispetto di distanze minime tra i pozzi dell’acqua potabile e i pozzi neri (il sistema di fognatura statica prevalente nelle città) o gli altri rudimentali servizi igienici: di qui le frequenti infiltrazioni delle acque luride in quelle potabili, con i gravi danni igienici che medici e igienisti denunciavano con sempre maggiore insistenza85 e con conseguenze sul piano sanitario che si sarebbero protratte a lungo, ben oltre 1’ Unità. 79. L. Ripa, Idrologia medica, circondario amministrativo di Monza. Relazione diretta al Consiglio sanitario di Monza, in «La Medicina comunale», Seregno, novembre 1865, pp. 244 sgg. 80. Trezzi, op. cit., p. 25. 81. Notizie naturali e civili..., cit., vol. 1°, p. 248. 82. E. Rotondi-A. Pavesi, Sull’acqua dei pozzi trivellati della città di Milano in confronto di
quella dei pozzi comuni, Milano, s.d. (ma 1880 circa), pp. 31 sgg. V. anche Grande illustrazione
del Lombardo-Veneto, Milano, 1857, vol. 1° (Storia di Milano, di C. Cantù), pp. 415 sgg. 83. Notizie naturali e civili..., cit., vol. 1°, p. 250. 84. Menis, op. cit., vol. 2°, p. 24. 85. Cfr. Soresina, op. cit., p. 36, e Bazzoni, op. cit., p. 69.
184
7. Caratteri generali della società lombarda tra l'Unità e la fine dell’Ottocento
Al momento della formazione dello Stato unitario italiano la Lombardia si presentava ancora come una regione a struttura economica essenzialmente agricola, nella quale le attività industriali continuavano a rivestire un’importanza soltanto complementare. La sua popolazione era quindi ancora composta per più della metà di «contadini» (piccoli proprietari, coloni, mezzadri, obbligati, salariati, ecc.), le cui condizioni di vita e di lavoro erano sostan-
zialmente quelle delineate nelle pagine precedenti. La Lombardia rurale della fase immediatamente postunitaria confermava dunque con la durezza delle sorti delle sue plebi rurali, che per tanta parte non avevano ancora varcato le soglie della civiltà moderna, la lucida analisi delle prospettive della rivoluzione nazionale che Ippolito Nievo, attento osservatore delle realtà umane dei contadi della bassa Lombardia, aveva tracciato nella seconda metà del 1859 incentrandola sulla constatazione dell’esistenza di due Italie in contrasto tra loro. Lo scrittore rilevava infatti nel paese — e la sua analisi sarebbe rimasta valida per molti decenni avvenire — la profonda frattura che op-
poneva alla «gente letterata» la «nazione illetterata», il «volgo campagnolo», nel quale fermentava una sorda ostilità contro le città, foriera di aspre tensioni. «Si, il popolo illetterato delle campagne abborre da noi, popolo addottrinato delle città italiane, — questo l’accorato giudizio del Nievo — perché la nostra storia... gli vietò quell’assetto economico che risponde presso molte altre nazioni ai suoi più stretti bisogni. Esso diffida di noi perché ci vede solo vestiti coll’autorità del padrone, armati di diritti eccedenti, irragionevoli... Non crede a noi perché avvezzo ad udire dalle nostre bocche accuse di malizia, di rapacia che la sua coscienza sa esser false ed ingiuste... Vergogna per la nazione più esclusivamente agricola di tutta Europa ch’ella abbia formulato contro la parte più vitale di se stessa il codice più ingiusto, la satira più violenta che si possa immaginare dal malvagio talento d’un nemico!. 1. I. Nievo, Frammento sulla rivoluzione nazionale, in I. Nievo, Le più belle pagine scelte da R. Bacchelli, Milano, 1929, pp. 284-285.
185
Eppure nei decenni immediatamente successivi all’ Unità, mentre la «ruralità» appariva ancora la realtà dominante nel quadro della Lombardia, era possibile scorgere nella regione i sintomi di quello sviluppo dei rapporti produttivi in direzione del capitalismo industriale che si sarebbe fatto strada successivamente, specie tra la fine del secolo e la prima guerra mondiale, e che avrebbe determinato profonde modificazioni nel suo tessuto sociale. Il processo di industrializzazione, acceleratosi nonostante le fasi recessive nell’ultimo trentennio dell’ottocento, interessò le attività meccaniche e metallurgiche (localizzate di preferenza nel Milanese, nel Lecchese e nel Bresciano), quelle
edilizie, quelle tipografiche e via dicendo, ma ebbe i suoi punti di forza nel settore tessile, soprattutto nella filatura e tessitura del cotone (la filatura del cotone fu il primo settore a conoscere un’industrializzazione nel senso moderno del termine), che si irradiarono a preferenza nell’alta pianura nord-occidentale, tra Varese e Milano, e nella filatura della seta (concentrata nel Comasco, nel Varesotto e nel Lecchese), che fu affiancata complementarmente
dalla tessitura: si ebbero così progressi più o meno ampi nella meccanizzazione e razionalizzazione degli impianti, crescenti investimenti di capitale locale e straniero, una tendenza alla concentrazione delle imprese, un sempre più rilevante ricorso al sistema della «fabbrica», un graduale declino del lavoro domestico su commissione. L’avanzamento sulla via dello sviluppo industriale portò tra i suoi effetti quello della trasformazione della configurazione delle città e della loro funzione, percorso che assunse un rilievo tutto particolare a Milano. Da un lato, infatti, l’addensarsi di opifici e di impianti relativi ai servizi di pubblica utilità (stazioni ferroviarie, officine del gas, ecc.) nelle periferie e nei sobborghi dei più dinamici centri urbani, le sollecitazioni che ne derivavano alle attività terziarie e 1 conseguenti spostamenti di popolazione dalle campagne provocarono una più o meno rapida crescita demografica di molte città, accompagnata a volte da una loro espansione sul territorio circostante (così Milano si aggregò nel 1873 il comune concentrico dei Corpi Santi, mentre Brescia nel 1880 si estese al di là della cerchia delle antiche mura annettendosi cinque comuni della fascia periurbana) e da una profonda modificazione della loro stratificazione sociale, all’interno della quale andò crescendo il peso specifico del proletariato di fabbrica, degli addetti ai servizi e della mano d’opera impiegata in quell’ «appendice» della fabbrica che era la lavorazione a domicilio in settori emergenti come l’industria delle confezioni; e questo mentre si riduceva il ruolo dei mestieri artigianali di più vecchia tradizione (e valga per tutti il caso di Monza, dove la sostituzione della lavorazione meccanica a quella manuale nel settore del cappellificio, avviata dal 1868, portò nel giro di qualche decennio a una vorticosa espansione produttiva, con la conseguente crescita del numero degli operai da poche centinaia a varie migliaia, con186
centrati per lo più in grandi opifici). D’altro lato la tendenza al decentramento nelle campagne di alcuni rami, come
il tessile, tendenza che era contrad-
dittoria — ma in modo in qualche misura funzionale allo sviluppo del capitalismo industriale — rispetto alla spinta all’urbanesimo e che era motivata sia da ragioni economiche (quali il minor costo delle aree, la disponibilità della forza motrice idraulica, il basso costo della mano d’opera infantile e femminile),
che da ragioni sociali (come la docilità di maestranze di estrazione rurale e prive di consuetudini di organizzazione e di lotta), determinò specie nell’area dell’alta pianura e della collina l'espansione di una costellazione di centri manifatturieri di piccole dimensioni, che traevano dallo sviluppo delle fabbriche l’impulso alla loro crescita. Lo slancio del settore industriale trova conferma nei dati quantitativi, sia complessivi che settoriali, per i quali basteranno alcuni cenni sommari. Una rilevazione del 1876 relativa alle imprese esercitate in appositi locali numerava 161.000 addetti, mentre una statistica del 1903 faceva salire gli addetti alle aziende industriali a 354.000. Ma se assai spesso gli operai censiti nel 1876 lavoravano in piccoli opifici e per pochi mesi l’anno, la maggior parte di quelli rilevati nel 1903 lavoravano per tutto l’anno in officine medie e grandi. Nel settore tessile, nella provincia di Como il setificio vide salire gli addetti alla trattura dagli 11.605 del 1876 ai 16.298 del 1890; gli addetti alla tessitura si triplicarono tra il 1860 e il 1890 (circa 13.000), parallelamente al-
la crescita del numero dei telai. Più appariscenti i progressi del cotonificio (concentrato tra Olona e Ticino), un settore che approfittò in larga misura delle condizioni favorevoli create dalle tariffe protezionistiche del 1878 e del 1887, e che alla meccanizzazione
della filatura, già largamente attuata, af-
fiancò quella della tessitura, che fino al 1887 era stata prevalentemente domestica. Il carattere capitalisticamente pronunciato dell’industria cotoniera si accentuò poi nei primi anni dei secolo XX, correlativamente ai maggiori investimenti — sia nelle aziende che continuarono a preferire la vecchia struttura individuale che in quelle che si diedero la forma della società anonima (5 nel 1897, 11 nel 1902, 30 nel 1908) — e all’utilizzazione dell’elettricità come
forza motrice. Passando ora a un altro dei rami che esercitarono una funzione trainante nell’industrializzazione lombarda, quello metallurgico e meccanico, se le condizioni di partenza degli anni °60 erano quelle di un'attività ancora primordiale (piccole officine con scarsa dotazione tecnica e pochi addetti per unità), all’inizio del nuovo secolo la situazione si presentava profondamente mutata. La siderurgia e la metallurgia, favorite dal protezionismo, erano passate dalla conduzione «patriarcale» della piccola officina a quello capitalistico-industriale, toccando nel 1903 i 6.500 addetti, concentrati soprattutto nelle
province di Milano, Brescia e Como, e ritagliandosi una quota del 30% nella 187
produzione nazionale del ferro (mentre quasi insignificanti erano invece le percentuali della ghisa e dell’acciaio). Un ritmo più rapido, e foriero dei successivi sviluppi, assunse poi tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 la meccanica, stimolata da una serie di fattori favorevoli (l’incremento del tessile, l’ampliamento del sistema ferroviario nazionale e l’attrezzatura della rete di
comunicazioni su binario della regione, l’avvio della meccanizzazione agricola, gli sviluppi dell’industria tipografica, ecc.); nel 1903 il ramo annoverava infatti più di 16.000 addetti, impiegati essenzialmente nell’area milanese (12.490) e bresciana (1.692), con imprese di notevole consistenza, quali le Officine Meccaniche, la Ernesto Breda, la Franco Tosi, la Suffert, il Tecno-
masio, la Ercole Marelli. E a questi lavoratori erano da aggiungere alcune migliaia di unità utilizzate in piccole fucine e laboratori domestici per la produzione di chiodi, coltellerie, molle, ecc.
Il primato industriale acquistato dalla Lombardia sulle altre regioni italiane è del resto confermato dai dati relativi alla forza motrice idraulica e termica. Nel 1878, su 54.321 HP ottenuti in Italia con macchine a vapore per gli impieghi industriali la Lombardia ne utilizzava 13.629; nel 1897, su circa 100.000 HP ne utilizzava circa 55.000, cui erano da aggiungere i 51.000 ottenuti dai motori idraulici. E questa posizione egemonica dell’industria lombarda si sarebbe rafforzata nei primi anni del nuovo secolo, grazie anche al rapido moltiplicarsi degli impianti idroelettrici e al trasporto dell’energia a distanza, con il conseguente sviluppo dell’industria elettrica, e poi anche di quella chimica. L'espansione delle forze produttive collegata all’industrializzazione e alla penetrazione più larga di rapporti capitalistici nell’agricoltura introdusse il germe di cambiamenti rilevanti, pur se graduali, anche nelle campagne. È vero infatti che il progredire delle attività industriali in Lombardia non provocò, per le forme in cui si svolse, una rottura brusca tra lavoro contadino e lavoro manifatturiero; è vero che i contadini e le contadine impiegati nelle fabbriche non recisero in generale i loro legami con la terra e che forme da tempo consuete di lavoro a domicilio continuarono a coesistere, pur declinando, con l’opificio accentrato (come nel caso della tessitura del cotone e specialmente di quella della seta). E pur tuttavia i più larghi e assidui contatti tra i lavoratori resi possibili dal regime di fabbrica, l’accresciuta mobilità, attestata dalle dimensioni del fenomeno migratorio (e non si trattò soltanto di emigrazioni interne, ma anche di emigrazioni al di là dei confini e al di là dell'Oceano),
la sostituzione dei rapporti propri di un’economia monetaria a quelli di un'economia seminaturale, l’articolarsi delle comunicazioni e la formazione di più vasti mercati, l'attrazione dei centri maggiori, le possibilità di guadagno che si presentavano fuori del podere e della cascina, il più accelerato fluire insomma della vita sociale, furono tutti elementi che innescarono un 188
graduale processo di disgregazione delle arcaiche strutture della vita rurale. Momento centrale di questa vicenda fu lo sgretolamento dell’impianto patriarcale della famiglia contadina, che conobbe una manifestazione particolar-
mente evidente nella sempre più frequente contestazione dell’autorità prima indiscussa del «reggitore», il padre dei figli conviventi con le loro famiglie sotto lo stesso tetto che esercitava il suo potere attraverso una consolidata varietà di funzioni (dalla distribuzione delle porzioni del cibo a tavola all’amministrazione dei guadagni di tutti imembri del gruppo familiare). Tra il 1860 e il 1882 il popolo della Lombardia, i lavoratori delle città e delle campagne furono esclusi, come accadde del resto in tutto il paese, dalla possibilità di contribuire a determinare in modo attivo il corso della politica nazionale; e questo anche in virtù della legge elettorale del 17 dicembre 1860 che, ponendo come condizione per l’elettorato politico il «saper leggere e scrivere» e il pagamento di una abbastanza elevata somma di imposte dirette, aveva limitato l’esercizio del diritto di voto al 2% circa della popolazione italiana. Ma per alcuni strati — anche se ancora relativamente ristretti — dei ceti popolari cittadini l'esclusione dal voto non volle dire assenza dalla vita politica, ché anzi la presa di coscienza delle classi lavoratrici urbane si andò sviluppando e consolidando proprio in questi decenni, prima a livello di avanguardie, poi con dimensioni più ampie. Questo cammino sulla via della politicizzazione, che fu in ultima analisi un processo di crescita culturale e civile,
si realizzò in parte in forme spontanee, ma in parte fu stimolato e guidato dai gruppi dell’opposizione democratica e repubblicana che, nella ricerca di più ampie basi di consenso alla loro battaglia antigovernativa, svolsero un’assidua opera di propaganda tra i ceti popolari che si servì tra l’altro di giornali destinati esplicitamente ai lavoratori e all’«educazione morale e politica delle classi popolari» (come nel caso dei fogli milanesi «Fede e Avvenire» e «Libertà e Associazione»), nei quali si divulgavano i principî dell’associazionismo operaio mazziniano e si sosteneva la linea politica della sinistra estrema (suffragio universale, Costituente, nazione armata, ecc.). Nella loro attività in direzione
dei lavoratori i repubblicani e i democratici cercarono di utilizzare come principale strumento organizzativo le società di mutuo soccorso. Queste associazioni, di cui anche in Lombardia si erano avuti numerosi esempi già prima dell'Unità e che in seguito crebbero rapidamente di numero (su scala nazionale si passò
dalle 443
società
del
1862
alle 6772
del
1894,
con
una
folta
rappresentanza lombarda), non erano però in generale un’espressione autonoma delle classi lavoratrici, perché esse sorgevano assai spesso per l’iniziativa «filantropica», e quindi paternalistica, di uomini appartenenti ai ceti dirigenti, di orientamento moderato o anche conservatore, che volevano limitarne l’azione ai ristretti scopi previdenziali previsti dai primi statuti, tenendole lontane dalla politica e cercando di evitare la loro partecipazione ai conflitti del lavoro. 189
E fu proprio quello della politicizzazione il terreno di scontro scelto dai democratici, che si batterono all’interno di molte associazioni e nei loro congressi generali per farvi passare la linea dell’impegno politico: i successi conseguiti furono parziali, ma pur nei loro limiti essi rivelano quel desiderio di partecipazione, di far sentire il proprio peso che sempre più chiaramente si andava manifestando in strati sociali tenuti per l’innanzi in condizione subalterna. Il processo di accostamento alla partecipazione politica dei ceti popolari urbani, che ebbe tra l’altro un riflesso nelle fortune della democrazia radicale cavallottiana
(una formazione
essenzialmente
lombarda
che trovava
i suoi
consensi soprattutto tra i ceti medi, ma che ebbe a lungo anche una base popolare, come provano le altissime tirature raggiunte dal suo giornale quotidiano «Il Secolo»), ebbe una sorta di sanzione con la riforma elettorale del set-
tembre 1882; la nuova legge infatti, stabilendo come condizione per il conferimento del diritto di voto politico la capacità di leggere e scrivere, indipendentemente dal censo, portava il numero degli elettori lombardi a 320.000, il che voleva dire — data la relativamente scarsa incidenza dell’analfabetismo nei centri urbani della regione — l’estensione del suffragio a una buona parte dei lavoratori dipendenti delle città. Parallelamente alla maturazione della coscienza associativa e politica progredì nel proletariato urbano la crescita della coscienza sindacale e di classe, che si concretò nell’affiancamento della «resistenza» alle pratiche del mutualismo, il cui momento iniziale può essere collocato alla metà degli anni ’80. Accanto all’associazionismo mutualistico-previdenziale e in polemica con quello, accusato di essere uno degli strumenti con cui i ceti dirigenti borghesi perpetuavano la loro egemonia tra i lavoratori, presero così a sorgere, attraverso la tappa intermedia delle società di «miglioramento», le società e le leghe di «resistenza», che erano organizzate localmente sulla base dell’arte e del mestiere (a differenza delle società di mutuo soccorso, che spesso erano «miste», poiché comprendevano lavoratori di varie categorie) e si ponevano come fine la lotta sindacale a vari livelli, incluso quello dello sciopero, per i miglioramenti salariali e normativi e la difesa degli associati nello stesso posto di lavoro. Ma la lega, sebbene fosse sorta sul terreno della difesa economica, riuscì spesso a superare i limiti corporativi connessi alla sua genesi attraverso una tensione etico-politica che prospettava le mete del superamento di una condizione di miseria e degradazione e della realizzazione di una più giusta società di uomini emancipati dal bisogno e dall’ignoranza. Noi siamo poveri — si legge nel programma di uno di questi organismi, ma il motivo ispiratore era comune alla generalità dei documenti programmatici delle leghe — perché non possediamo nessuna proprietà. Noi siamo ignoranti perché le nostre braccia, la nostra intelligenza, la nostra attività, unico nostro retaggio, fin da fanciulli, per 190
campare la vita, fummo costretti a vendere per un misero salario. Noi vogliamo essere considerati uomini, aventi, come qualunque altro, il diritto di sedere al banchetto
della vita sociale. Noi vogliamo essere economicamente emancipati, politicamente liberi, moralmente istruiti, perché, sebben poveri ed ignoranti, abbiamo dall’esperienza e dall’osservazione imparato che uno stato di cose sociali come quello in cui viviamo e sr costretti a subire, pieno di iniquità e di palesi ingiustizie, non può durare a lungo?.
E certamente iniqua appare la condizione dei lavoratori delle manifatture, degli opifici, delle fabbriche, fatta di orari estenuanti (10, 11, 12, ore giorna-
liere), di basse mercedì (intorno ai 50 cent. al giorno i fanciulli, intorno a 1 lira le donne: un salario con il quale si potevano acquistare all’incirca 3 kg di pane di farina mista), di regolamenti vessatori, di ambienti di lavoro malsani che predisponevano alle malattie, professionali e non. E si deve inoltre osservare che si trattava di una forza-lavoro erogata, specie nell’industria tessile, essenzialmente da donne e fanciulli, assolutamente indifesi questi ultimi sino al 1886 (quando una legge scarsamente rispettata vietò il lavoro ai fanciulli di età inferiore ai 9 anni compiuti), e poco difesi sino al 1902, quando un’altra legge elevò a 15 anni il limite di età per il lavoro in fabbrica. L'esperienza della resistenza e la rivendicazione dell’autonomia, cui si è precedentemente accennato, trovarono il loro primo momento di coagulo nel Partito operaio italiano, un’organizzazione che negli anni ‘80 ebbe la sua base di massa in Lombardia e attraverso la quale si concretò il distacco delle frange più avanzate del movimento operaio della regione dalla democrazia radical-borghese ispirata da Cavallotti. Il Partito operaio si configurò infatti come una confederazione non tanto politica quanto sindacale di associazioni di mutuo soccorso, di miglioramento, di resistenza, di cooperazione, che dovevano essere composte da «puri e semplici operai manuali... salariati e alla diretta dipendenza dei padroni, imprenditori o capitalisti» e che si impegnavano ad accettare la resistenza, la lotta di classe, come metodo d’azione per
arrivare all’ «emancipazione completa dei lavoratori dall’oppressione capitalistica». Documento essenziale di questa progrediente autocoscienza, certo ancora elementare e unilaterale (come quella che, con il rifiuto della «maledetta politica» e il suo intransigente esclusivismo operaista coglieva soltanto l’aspetto più immediato delle contraddizioni della società «capitalista», senza inquadrarlo in una visione generale delle complesse articolazioni e dei molteplici rapporti politici, sociali, ideologici di quella), ma pur sempre tale da scandire un momento periodizzante nella storia del movimento operaio lombardo — e più in generale italiano — fu il «Fascio operaio», il giornale del Parti2. Citato in S. Merli, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale, Firenze, 1972, vol. 1°, pp. 614-615.
191
to: questo foglio può essere considerato la prima voce in Italia di una cultura autenticamente proletaria, dal momento che esso fu sostanzialmente scritto e
ispirato da operai i quali non intendevano limitarsi all’agitazione, alla propaganda e alla denuncia, ma cercavano di elevarsi a una concezione complessiva, di ispirazione positivistica, della società e della «scienza»,
che potesse
metterli in grado di «intendere le cose di questo mondo nel loro complesso, cioè nell’intima relazione che esse hanno fra di loro e nello scopo universale a cui mirano»3. Meno rapidi furono i cambiamenti che si delinearono nel più torpido scenario delle campagne, dove peraltro avevano cominciato ad operare in profondità fattori innovativi. Più in particolare nell’ hinterland contadino della pianura asciutta e della fascia collinare agivano le sollecitazioni disgregatrici del vecchio assetto trasmesse dalla progrediente industrializzazione. E basti ricordare in proposito la classica indagine del Serpieri4 relativa all’alto Milanese, nella quale sono messi in luce fenomeni quali il calo degli addetti all’agricoltura a vantaggio degli addetti all’industria, la tendenza all’agglomeramento della popolazione nei centri più grandi, lo spezzettamento delle famiglie in unità meno numerose, il rimpicciolimento delle colonie nelle aree in cui la famiglia lavoratrice spostava la propria attività verso altre fonti di reddito diverse dall’agricoltura, la trasformazione del contratto misto in affitto a danaro. Nella pianura, invece, l'elemento dinamico era rappresentato dall’ulteriore evoluzione in senso capitalistico dell’agricoltura (bonifica, ampliamento della rete di irrigazione, specializzazione delle colture, avanzata del prato a spese di altre coltivazioni e razionalizzazione dell’attività lattiero-casearia), accele-
rata negli anni ‘80 dalle ripercussioni della grande crisi agraria. Tra gli effetti di queste trasformazioni furono particolarmente incisivi sul piano sociale il rafforzamento delle grandi aziende a danno di piccoli proprietari, coloni e mezzadri, l’immiserimento di braccianti e obbligati, colpiti dalla decadenza della manifattura domestica e dalla tendenza alla riduzione delle compartecipazioni, l'aumento della disoccupazione e della sottooccupazione, in parte connesso con la crescita della popolazione. E sono proprio queste trasformazioni e il correlativo deterioramento delle condizioni materiali di esistenza delle popolazioni rurali, insieme alla modificazione della loro stessa «fisionomia psicologica» (incrinamento della remissiva soggezione nei confronti di padroni e affittuari, presa di coscienza delle contraddizioni sociali e dell’ingiustizia delle proprie sorti, ricerca di nuove forme di associazione, progressi 3. Articolo Gli operai e la scienza, in «Il Fascio operaio», Milano, 12 agosto 1883.
4. A. Serpieri, Il contratto agrario e le condizioni dei contadini nell’Alto Milanese, Milano, 1910.
192
dell’alfabetizzazione, ecc.) che spiegano la drammatica protesta dei contadini, di questi «paria della civiltà», esplosa agli inizi degli anni 80. Primi a muoversi furono, nell’avvio del decennio, i lavoratori della Bassa, che diedero vita a una prolungata serie di agitazioni che ebbe il suo epicentro nel Mantovano
e, in minor misura, nel Cremonese, e lambì il Bresciano e il
Pavese e nella quale il ruolo propulsivo fu svolto dai braccianti, lavoratori proletarizzati che stavano ormai uscendo dai quadri della mentalità contadina e allentavano sempre più il loro legame con la terra. Inizialmente il movimento ebbe un caratterre spontaneo; non però nel senso che la lotta di braccianti, salariati e obbligati fosse una ripresa dei ricorrenti tumulti rurali e delle forme tradizionali di protesta tipiche delle campagne (incendi dolosi, tagli di viti e di alberi, distruzioni di cascinotti, ecc.), ché essa invece assunse ca-
ratteri qualitativamente nuovi, come l’adozione su larga scala dello sciopero e la chiarezza delle rivendicazioni centrali (miglioramento dei patti colonici e assicurazione del lavoro ai giornalieri), ma in quello che le iniziative delle singole località scaturirono dal basso senza poi riuscire a collegarsi tra loro (e questo specialmente nel Cremonese). E la stessa durata dell’azione rivendicativa, che prima di esaurirsi ebbe momenti di caduta e di ripresa, non però cesure nette, favorì il tentativo di ricerca di più mature strutture organizzative, che permettessero di superare il localismo e la frammentazione attraverso la creazione di rapporti stabili a livello comunale e provinciale. Il passaggio a questa fase superiore fu favorito dall’inizio di un fenomeno che negli anni seguenti avrebbe largamente improntato di sé la vicenda politico-sociale della bassa Lombardia e della Val padana: vale a dire l’incontro tra il movimento dei braccianti, dei salariati e degli obbligati e l’azione di propaganda e di organizzazione dei primi nuclei socialisti che, quali che fosse la loro estrazione ideologica (e basti pensare alla matrice proudhoniana di Francesco Siliprandi, fondatore in quegli anni della mantovana Associazione generale dei lavoratori italiani), contribuirono a dischiudere ai lavoratori di quelle terre nuovi oriz-
zonti morali e politici, e facilitarono il loro passaggio dalla protesta episodica, spontanea e incoerente all’organizzazione permanente e consapevole. Qualche anno più tardi, prima nel 1885 e poi nel 1889, si manifestò invece in forme dirompenti il profondo malessere dei contadini della Brianza, dell’alto Milanese, del basso Comasco, del quale già in precedenza erano emersi sintomi sporadici. In queste agitazioni ebbero ancora spazio le manifestazioni di un odio antipadronale alimentato di generazione in generazione da un sistema contrattuale particolarmente oppressivo e che si espresse in una serie di moti che culminavano nell’attacco ai municipi e alle case dei proprietari più invisi. I contadini — questa la descrizione di un osservatore — si radunano sui sagrati delle chiese: quando le funzioni religiose son terminate, si dirigono in massa verso le case
193
dei proprietari che non sono umani e verso la sede del Comune: si rompono le lampade: si mandano avanti i ragazzi e i giovanotti e comincia la grandine di sassi contro i vetri e le imposte.
E in questi tumulti si levavano canti nei quali si sposavano il rancore contro i proprietari e il risentimento contro le autorità municipali, ritenute il braccio secolare di quelle: «Evviva nun, evviva quij d’Arlun — Abbasso i sciori e i guardi del Comun»5. Eppure anche qui, seppure in minor misura che nella Bassa, sono da rilevare il carattere generalizzato del movimento e la sua sia pur rudimentale organizzazione, il largo impiego dell’arma dello sciopero e l’individuazione di obiettivi abbastanza chiaramente definiti: 1’ aumento della retribuzione delle «giornate coloniche» (le giornate lavorative annue che i contadini dovevano prestare al padrone fuori del podere per un salario assai inferiore a quello di mercato e che erano mediamente più di 50 per famiglia colonica), un equo canone per le abitazioni, la riduzione degli «appendizi»; il che induce ad affermare che anche tra le popolazioni rurali di queste zone della Lombardia era ormai in atto un processo evolutivo che si sarebbe concluso con il loro definitivo distacco dai quadri mentali e di comportamento propri di una società arcaica. La fiammata parve esaurirsi senza residui; ma al di là degli esiti immediati la vicenda ebbe un valore che andò al di là dell’episodio in quanto contribuì a stimolare e meglio definire l'impegno sociale del movimento cattolico nella media e alta Lombardia, nel quadro di quella intensificazione dell’azione economica dei cattolici intransigenti che si era profilata a cavaliere degli anni 790, anche sotto la spinta di impulsi di ordine più generale, e che si era concretata tra l’altro nella creazione dell’Unione cattolica per gli studi sociali (1889) e nella pubblicazione della Rerum novarum (1891). Non si dovette in-
fatti a una mera coincidenza il fatto che proprio nelle campagne di queste zone (per non parlare di quelle del Veneto) diede i suoi frutti più rilevanti l’attività dispiegata dai cattolici per congiungere alle tradizionali iniziative assistenziali e caritative gestite direttamente o indirettamente dall’organizzazione parrocchiale una nuova e articolata gamma di strumenti di intervento nella vita delle popolazioni rurali; strumenti che, pur continuando a far riferimento alla parrocchia e pur nella compenetrazione del piano sociale con quello religioso, avevano pur sempre una propria individualità e una autonoma sfera d’azione. Fu così che nell’alta e nella media Lombardia si concretò quella ricca fioritura di organizzazioni economiche — società di mutuo soccorso, casse rurali (109 erano quelle in funzione nel 1897 in tutta la regione, delle quali 64 concentrate nella diocesi di Bergamo), società di assicurazione del bestiame, latterie sociali, forni cooperativi, cucine economiche - e di iniziatiS. «Il Secolo», Milano, 21-22 maggio 1889.
194
ve educative — giornali popolari, scuole popolari gratuite per adulti, biblioteche circolanti — che si tradusse in un rafforzamento della presenza cattolica in territori dove aveva già profonde radici. Questa azione, che fece sentire i suoi effetti anche in quelle parti delle campagne della Bassa dove predominavano la cascina e gli obbligati e che si allargò ad alcuni strati dei ceti popolari delle città, concorse inoltre all’innalzamento del livello educativo delle popolazioni, e fu quindi un rilevante fattore di crescita civile. La Lombardia si rivelò quindi un terreno propizio all’azione sociale dei cattolici, sia all’interno che all’esterno delle strutture dell’Opera dei congressi, come attesta anche lo sviluppo preso dalle società di mutuo soccorso di ispirazione cattolica (circa 250 verso la fine del secolo). È vero che in queste organizzazioni, che si moltiplicarono soprattutto nell’ultimo ventennio del secolo, gli intenti religiosi, formativi e morali parvero a volte prevalere sulle finalità più propriamente economiche, ma di fronte alla pressione della realtà economico-sociale, al di là del dettato statutario le esigenze di tutela previdenziale finirono con l'affermarsi più o meno rapidamente. Va però anche detto che nelle mutue cattoliche, dati il loro carattere «misto», la loro impostazione interclassista e il loro orientamento confessionale, non si verificò in
generale quel passaggio dal mutualismo alla resistenza che si attuò invece in molte delle società di mutuo soccorso laiche o democratiche organate sull’arte o mestiere. Sempre nell’ultimo decennio del secolo si collocano infine la nascita e i primi sviluppi del Partito socialista, che ebbe proprio in Lombardia uno dei suoi punti di forza. Nella seconda metà degli anni ‘80, mentre il Partito operaio raggruppava i nuclei più avanzati del proletariato lombardo intorno al suo programma anticapitalistico, e mentre le campagne della regione erano scosse da un movimento di massa che poneva in primo piano tra i problemi del paese la questione agraria, si compiva infatti l'evoluzione dalla democrazia radicale al socialismo di un gruppo di intellettuali (da Filippo Turati a Leonida Bissolati) che, assimilati — e sia pure in chiave positivistica — alcuni motivi del marxismo, avrebbero poi contribuito alla diffusione dei primi elementi di una coscienza socialista all’interno del movimento operaio lombardo, che si andava sempre più decisamente collocando sul terreno della resi-
stenza. Tra il ’92 e il ’98 la predicazione socialista andò così aumentando la sua presa non soltanto tra gli organismi economici e di resistenza dei lavoratori urbani (leghe, camere del lavoro, federazioni di mestiere) ma anche tra i
braccianti della Bassa, contribuendo a porre le premesse di quell’ondata di lotte rivendicative operaie e contadine senza precedenti nella storia italiana che avrebbero caratterizzato gli inizi del periodo giolittiano. E anche l’intervento socialista risultò in ultima analisi un elemento propulsivo essenziale
per l'avanzamento dell’istruzione dei lavoratori, nelle città e nelle campagne, 195
e per la nascita di una diversa cultura, scaturente dal basso, dalle esperienze
della nuova e moderna vita associativa e marcata dall’impegno politico, che ebbe le sue principali manifestazioni nella moltiplicazione dei giornali sindacali e politici, degli opuscoli di propaganda elementare, delle canzoni di lotta e di protesta. Non rientra nei limiti che qui ci si è posti seguire da vicino l’azione sociale di matrice socialista e cattolica agli inizi del nuovo secolo nelle sue connessioni con le modificazioni strutturali e con il quadro politico complessivo e analizzare l’impetuoso sviluppo delle lotte sindacali nelle città e nelle campagne lombarde tra il 1901 e il 1904; per cui sarà sufficiente accennare ad alcuni degli elementi caratterizzanti di questa nuova fase, che aprì un periodo innovativo nella storia del movimento operaio e contadino della regione. Nell'ambito del sindacalismo che si ispirava ai principî della lotta di classe e che si collegava in maniera più o meno diretta al Partito socialista (nel quale in questo periodo si acuirono i contrasti tra le due anime, quella riformista e quella intransigente, che proprio a Milano si espresse nell’esperienza del gruppo di «Avanguardia socialista» di Arturo Labriola), va sottolineato il processo di crescita delle federazioni di mestiere, che ebbero generalmente in Lombardia la loro principale base di massa. Organismi verticali a base professionale abbraccianti tutto un ramo della produzione le federazioni, che si ponevano come compiti fondamentali la contrattazione sindacale e la direzione delle agitazioni rivendicative, ebbero fin dagli inizi chiari connotati classisti e misero radici particolarmente solide tra quelle categorie che avevano una più accentuata qualificazione professionale (tipografi, ferrovieri, metalmeccanici).
Nel quadro delle organizzazioni federali un rilievo particolare assunse la Federazione nazionale lavoratori delle terra, costituitasi nel 1901, che ebbe il nerbo dei suoi aderenti nel proletariato agricolo della Padania. L’orientamento socialista della Federterra si concretò — come è noto — nel programma della socializzazione della terra, che se corrispondeva alle aspirazioni di larghi strati di salariati agricoli, limitava invece la penetrazione dell’organizzazione nelle aree dove prevalevano la colonìa o la piccola proprietà coltivatrice: ragione non ultima, questa, dell’egemonia conservata a lungo dai cattolici sulle popolazioni rurali lombarde della pianura asciutta, della collina e della montagna. In quegli stessi anni si accelerò — dopo lo scompaginamento del 1898-99 — la crescita delle camere del lavoro, che superarono la fase dell’iniziale agnosticismo politico e del mero collocamento per caratterizzarsi in senso socialista e porsi sul terreno della lotta di classe; esse inoltre affiancarono ai compiti di tutela dei lavoratori nelle vertenze economiche un impegno in vari settori d'intervento — educativo, ricreativo, assistenziale, politico — che ne fecero
196
degli originali organi di democrazia popolare e di autogoverno cittadino©. Anche in campo cattolico le modificazioni del quadro economico e politico, la crisi di fine secolo e l’acuirsi della conflittualità sociale produssero sensibili mutamenti negli indirizzi tradizionali dell’azione tra le masse lavoratrici. Grazie anche all’operosità di quanti nello scorcio del secolo XIX avevano cominciato a discutere di «democrazia cristiana» e di «preparazione nell’astensione», l’attività dei cattolici all’interno del mondo del lavoro andò gradatamente perdendo il carattere dell’intervento assistenziale episodico per configurarsi come lo strumento promozionale per la costruzione di un partito destinato a misurarsi direttamente sul piano della politica con gli avversari liberali e socialisti. In tale quadro, e attraverso un processo che esaltò la funzione di guida di Milano rispetto ad altri centri tradizionali del movimento sociale cattolico come Bergamo e Brescia, grazie all’opera di uomini quali Portaluppi, Minoretti, Mauri, gli innovatori fecero maturare il passaggio dalla pratica caritativo-assistenziale all’organizzazione professionale e sindacale: anche se si deve tener sempre presente che questi organizzatori in generale si muovevano pur sempre all’interno di una concezione interclassista della società ed erano sostenitori di un metodo gradualista, accettavano la divisione gerarchica tra le classi come un fatto provvidenziale, e affermavano la neces-
sità di una battaglia a fondo contro il socialismo. Di conseguenza quelle «unioni professionali» di arti e mestieri che sul piano dei principî erano state viste fin allora come incarnazioni dell’ideale corporativo e quindi come organismi «misti» di lavoratori e di padroni, di fronte alle resistenze dell’una e dell’altra parte presero a configurarsi più concretamente come organismi sindacali di soli lavoratori e non necessariamente confessionali, impegnati nella difesa degli associati quando si aprivano conflitti tra quelli e i proprietari (o gli affittuari, nel caso dei salariati agricoli), disposti in occasioni eccezionali a ricorrere anche allo sciopero. Significativo al riguardo il documento approvato nel primo Congresso lombardo della Democrazia cristiana tenuto nel maggio del 1901, un testo nel quale i convenuti si impegnavano a promuovere «organizzazioni semplici di lavoratori, uffici e leghe per la protezione del lavoro, collegi arbitrali» e accettavano «come mezzo estremo della tutela degli interessi degli umili, la resistenza legale e lo sciopero». E fu proprio grazie a queste modificazioni negli orientamenti di fondo che
l’azione sindacale dei cattolici di Lombardia — al di là delle successive contrastate vicende della Democrazia cristiana — potè proseguire il suo cammino in direzione della formazione di un moderno movimento operaio e contadino 6. G. Procacci, La lotta di classe in Italia agli inizi del secolo XX, Roma, 1970, pp. 53 sgg.
197
che ebbe le sue linee di forza nei lavoratori del tessile e tra i coloni, gli obbligati e i piccoli proprietari. Il movimento sociale cattolico si affiancò così a quello di orientamento socialista come una delle componenti essenziali della trama associativa regionale — politica e sindacale —, sulla quale l’uno e l’altro avrebbero lasciato il segno della loro essenziale presenza.
198
8. Salute pubblica e legislazione sanitaria dall'Unità a Crispi
All’interno della varia e complessa realtà sociale dell’Italia nei decenni immediatamente successivi all’unità alcuni aspetti salienti dell’esistenza materiale delle classi popolari possono essere messi a fuoco con chiarezza da un esame che parta dall’angolo visuale della sanità; esame che permette al tempo stesso di delineare la risposta che all’insieme dei problemi della «salute pubblica» cercarono di dare i gruppi dirigenti. La consapevolezza di un radicato e diffuso malessere sanitario, che condannava l’Italia ad una avvilente posizione di inferiorità rispetto ai più evoluti paesi europei, era presto divenuta — subito dopo la formazione del Regno — senso comune della parte più impegnata della classe medica, che continuava la tradizione di partecipe attenzione al destino dei ceti «subalterni» sostanziatasi già prima delle rivoluzioni quarantottesche nelle pagine di riviste come i milanesi «Annali universali di medicina», la «Gazzetta medica lombarda» di Agostino Bertani, o il napoletano «Filiatre sebezio». Lungo questa via, che voleva affiancare ai settori tradizionali e specialistici della scienza medica uno studio della malattia — specie se con connotati epidemici e di massa — calato all’interno delle strutture sociali e ambientali quali le aveva concretamente modellate il corso storico, e che attribuiva un rilievo centrale a quella «statistica medica» che aveva avuto in Giuseppe Ferrario il suo apologeta nei risorgimentali congressi degli scienziati, si erano così mossi i primi decisi passi avanti nella conoscenza del doloroso panorama igienico-sanitario di un paese reale che, anche sotto questo aspetto, si andava rivelando assai difforme da quello che si era creduto o sperato. Questo sforzo conoscitivo si materializzò in una ricca produzione di «quadri nosologici» e di relazioni e memorie «medico-storico-statistiche», che appare tanto più apprezzabile in quanto si realizzò grazie all'impegno privato di una schiera di medici — condotti e ospedalieri — che lavoravano al di fuori dei servizi statistici dello Stato, riorganizzati proprio in quegli anni — e non a caso — da un medico milanese, Pietro Mae199
stri, passato dagli entusiasmi giovanili per il socialismo utopistico e il «credito gratuito» di P.-J. Proudhon agli uffici ministeriali del giovane Stato italiano. E questa consapevolezza di una allarmante degradazione della «sanità pubblica» che, minando la «pianta uomo», proiettava l'ombra di pesanti riflessi negativi sul potenziale economico e sull’efficienza militare della nazione si allargò gradatamente — e sia pure a fatica — ad alcune frazioni dei gruppi dirigenti e si estrinsecò nella tormentata vicenda, protrattasi per più di vent'anni, dei tentativi miranti a dotare il paese di un insieme organico di leggi sanitarie: quel «codice», come lo si chiamò, che nelle intenzioni dei suoi più conseguenti fautori avrebbe dovuto rappresentare non soltanto la razionalizzazione e l’unificazione della normativa vigente ma lo strumento decisivo del «risorgimento» sanitario italiano. «Lo stato sanitario degli italiani non è prospero», così esordiva il 12 marzo 1873 Carlo Maggiorani all’avvio della discussione in Senato sul primo progetto di «codice» arrivato alle aule parlamentari, quello Lanza. E a suffragare la sua affermazione il medico romano tracciava un quadro che, al di là delle sue coloriture stilistiche, delineava con efficacia e sulla base di una cinquan-
tennale pratica professionale l’ampia gamma di fenomeni morbosi che caratterizzavano il quadro nosologico del paese. Si era in presenza di un vero e proprio «scadimento della razza», documentato dalla prevalenza nelle famiglie dei ceti popolari di «cere pallide, tempre di carne morbidamente impastate, macchine gracili e frolle costituzioni», risultato della «caterva di mali»
che avevano eletto dimora nelle terre del Regno: La tisi, la scrofola, la rachitide, tengono il campo più di prima; la pellagra va estendendo i suoi confini; la mal’aria co’ suoi tristi effetti ammorba gran parte della penisola; ... la sifilide serpeggia indisciplinata fra i cittadini ed in ispecie fra le milizie; la mortalità dei bambini, dei soldati e dei contadini supera i termini comportati dalla debolezza della età per i primi, e dal genere di vita dei secondi e dei terzi; i contagi esotici han facile adito e attecchiscono facilmente; il vaiuolo rialza il capo...; la dif-
terite si allarga ogni giorno più...; il numero degli epilettici e dei pazzi aumenta progressivamente, quanto più si diffonde l’abuso dei liquori spiritosi!.
Le fonti statistiche complessive che è possibile utilizzare per tentare di precisare le dimensioni quantitative di questo insieme di fenomeni confermano la gravità della situazione. Partendo dal dato generale forse più significativo, quello della mortalità, essa rimase su livelli assai elevati (indipendentemente dalle punte registrate negli anni caratterizzati da epidemie coleriche o da depressioni economiche) fino al 1886, quando prese a farsi gradatamente più netto il lentissimo decli1. Atti parlamentari (da ora A. p.), Senato, Discussioni, tornata del 12 marzo
200
1873, p. 1404.
no percettibile nei decenni risorgimentali. Se nel 1851 si erano infatti avuti 30,5 morti per ogni 1.000 abitanti, il quoziente fu di 31,06 nel 1862, di 29,84 nel 1870, di 30,57 nel 1880, per scendere poi a 26,32 nel 1890, e a 22,25 nel 1903: valori assai alti, con i massimi concentrati soprattutto nel
Mezzogiorno?, che collocavano l’Italia in una delle posizioni più critiche nella scala dei paesi europei. Sul bilancio così pesantemente negativo della mortalità generale incideva in maniera rilevante il contingente della mortalità nelle prime classi di età, che è possibile calcolare dal 1863, quando la statistica del movimento natura-
le della popolazione cominciò a rilevare i morti per i primi 5 anni distinguendoli in singole classi annuali. I bambini morti in quella fascia di età furono infatti il 48,8% dei morti complessivi nel triennio 1863-65; percentuale che restò pressoché stabile sino al 1890 (44,7% nel 1886-90), quando cominciò la contrazione che portò lentamente la proporzione a dimezzarsi nel quinquennio 1936-40 (25,1), con una ulteriore riduzione nei 15 anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale (10,5% nel 1956-60)3. Cifre che vanno in-
tegrate con quelle dei quozienti di mortalità infantile (morti per 1.000 nati vivi nel primo anno di età), che fino al 1890 si abbassarono soltanto con estrema lentezza (228,7 nel 1863-65, 220,6 nel 1871-75, 195 nel 1896-90)A.
Per spiegare le ragioni dell’ampiezza di questo vero e proprio genocidio sarebbe necessario poter compiere una analisi particolareggiata dell’aggregato numerico complessivo, che però per il periodo qui considerato non è possibile perché, come
è noto, la rilevazione
delle cause
di morte,
iniziata nel
1881 limitatamente ai comuni capoluogo di provincia o di circondario, fu estesa soltanto nel 1887 all’intero territorio nazionale; e per di più essa non ci fornisce serie complete per le cause delle morti infantili prima del 1895. È certo comunque che bisogna richiamare anzitutto — accanto al depresso tono generale delle condizioni igieniche, alle carenze dell’apparato assistenziale, al ritardo delle scienze mediche — il carico eccessivo di lavoro spesso gravante sulle donne anche nei giorni della gravidanza, del puerperio e dell’allattamentoi, e soprattutto l’incidenza delle malattie infantili dominanti nel perio2. E. Raseri, Atlante di demografia e geografia medica d’Italia, Roma, 1906, p. 46. Cfr. anche Istituto centrale di statistica, Sommario di statistiche storiche dell’Italia. 1861-1975, Roma, 1976, p. 19. 3. S. Somogy], La mortalità nei primi cinque anni di età in Italia..., cit., pp. 14-16. 4. Ibidem, p. 42.
5. V. le osservazioni relative al Cremonese, ma generalizzabili, in R. Griffini, Della mortalità dei bambini; della profilassi della sifilide infantile e da allattamento; della istituzione dei presepii in Italia, in Associazione medica italiana, Atti del quarto congresso tenuto in Venezia nei giorni 11 a 18 ottobre 1868, Venezia, 1869, p. 174 (e in «Annali universali di medicina»,
Milano, 1868, vol. 206°, p. 274). Il Griffini riportava una relazione del Comitato medico cre-
201
do: dalle infezioni gastro-intestinali (cui si doveva intorno al 1887 circa il 18% delle morti nel primo anno di età) e dell’apparato respiratorio alla meningite, al morbillo, alla scarlattina e alle altre malattie infettive sino alle epidemie difteriche©, responsabili di impennate
nella mortalità fino a quando,
dalla fine del secolo, non cominciò a diffondersi l’uso del siero antidifterico. Sull’incombente presenza della malattia e della morte nel mondo dell’infanzia influivano poi largamente anche morbi di natura sociale, più direttamente connessi con le condizioni di esistenza, quali la scrofola (la «lebbra dell’occi-
dente» che, come scriveva alla metà del secolo un medico mantovano assai attento al nesso malattia-miseria, compendiava in sé «buona parte delle malattie dell’infanzia, della fanciullezza e della adolescenza»?), o come il rachitismo (che trovava il terreno favorevole alla sua ampia presa nelle carenze
alimentari e nella mancanza della luce del sole, un bene scarso specie per gli abitanti dei quartieri più popolari dei centri urbani). Cui erano da aggiungere manifestazioni morbose che, sebbene più limitate, contribuivano anch'esse a deprimere lo status sanitario di infanti e bambini, tra le quali la sifilide da allattamento, l’edema del tessuto cellulare (la così detta «bruttura» di alcune zone rurali del Nord), le infezioni cutanee.
Ma a questi fattori, operanti nel lunghissimo periodo, se ne affiancavano altri, come l’esposizione e il baliatico mercenario, che avevano preso ad agire
con allargata incidenza nell’arco di tempo più breve, in stretta connessione con le modificazioni del tessuto economico-sociale avvertibili nel paese nel corso dell’800. Dopo l’unificazione, i criteri seguiti fino a tutto il 1883 dalla Direzione generale della statistica nel fornire i dati del movimento dello stato civile non consentono valutazioni quantitative sicure sul fenomeno dell’esposizione. Infatti in quegli anni, in cui ci si limitò a distinguere i nati in legittimi, illegittimi ed esposti, in molte località nella categoria degli esposti furono compresi non soltanto i veri e propri «gettatelli», ma anche gli illegittimi non riconosciuti presentati dalla levatrice o da altra persona all’ufficio dello stato civile monese, dove si rilevava che una delle cause della mortalità infantile stava «nella vita laborio-
sissima delle povere donne campagnuole, incaricate, oltre al governo della casa e famiglia, della speciale educazione dei bachi da seta, e delle lunghe e svariate operazioni del grano turco e del lino; vita laboriosa che continuasi anche nei venerati giorni della gravidanza, del puerperio, dell’allattamento, e che non è compensata da sufficiente riposo e alimento azotato, da abitazioni e bevande salubri e ristoratrici». 6. Tendenze evolutive della mortalità infantile in Italia, in «Annali di statistica», Roma, a. 104°, serie 82, vol. 29, pp. 107 sgg. V. anche, tra gli scritti coevi, G. Sormani, Sulla mortalità dei bambini in Italia, in «Giornale della reale Società italiana d’igiene», Milano, 1881, pp. 481 Sgg. 7. G.B. Soresina, Cenni di topografia medico-igienica sulla città di Mantova, cit., p. 197.
202
e poi ricoverati negli istituti per l’infanzia abbandonata; e va anche ricordato che le cifre degli illegittimi si gonfiarono dopo il 1866 per l’entrata in vigore della legge sul matrimonio civile, la quale considerava illegittimi i figli nati dalle unioni contratte con il solo rito religioso. La percentuale totale degli illegittimi più gli esposti sul totale dei nati passò come che sia dal 4,92 del 1863 al 7,75 del 1883, con un aumento degli illegittimi (dall’1,12 al 5,32) e
una diminuzione degli esposti (dal 3,80 al 2,43), dovuta in larga parte alla progressiva chiusura delle ruote, che tra il 1867 e il 1881 interessò la metà circa dei 1.209 comuni (appartenenti specialmente al Mezzogiorno continentale e alla Sicilia) in cui quelle risultavano aperte nel 1867. Una valutazione più chiara è permessa dalle cifre elaborate da un’inchiesta ministeriale relativa al 1879-81, che nella categoria «esposti» incluse soltanto gli abbandonati alla ruota o in luogo pubblico: nel triennio in questione furono trovati 40.296 esposti vivi (una media annua di 13.432) e 620 morti (207 l’anno), dei quali 32.093 nelle ruote e 8.823 sulla pubblica via o in chiesa8. A partire dal 1884 un nuovo tipo di classificazione dei nati, che li divideva nelle tre categorie dei legittimi, degli illegittimi riconosciuti e degli illegittimi non riconosciuti ed esposti globalmente presi, consente di individuare con sufficiente approssimazione il numero dei neonati abbandonati alla carità pubblica, quelli appunto della terza categoria, perché certamente quasi tutti gli illegittimi riconosciuti erano allevati in famiglia. I nati illegittimi non riconosciuti ed espo-
sti oscillarono tra i 35.527 del 1884 e i 32.744 del 1890 (dal 3,14 al 3,03% del totale dei nati), con una lievissima riduzione che si fece più rapida soltanto nell’ultimo decennio del secolo, in virtù sia di una ulteriore diminuzione del numero delle ruote (che nel 1895 esistevano solamente in 419 comuni),
sia di un maggior rigore nell’accettazione da parte dei brefotrofi?. Ma la faccia del problema dell’esposizione che più commosse l’opinione pubblica fu quella dell’elevata mortalità dei trovatelli. E a tale proposito basterà qualche accenno ai quozienti relativi al primo anno di vita, disponibili dal 1883. Nel 1887 su 1.000 bambini «da latte» ammessi nei brefotrofi o affidati a baliatico esterno ne morirono 381, con punte alte distribuite in tutti i compartimenti, anche se la loro localizzazione era più addensata nel Mezzo-
giorno e in Sicilia, dove nel 1887 il tasso di mortalità fu del 50%. La moria
8. «Annali di statistica», Roma, s. 32, vol. 12°, 1884; cfr. anche E. Raseri, Dei provvedi-
menti a favore dell’infanzia abbandonata, in «Rivista della beneficenza pubblica», Milano, 1885, pp. 193 sgg. 9. M. Gorni-L. Pellegrini, Un problema di storia sociale..., cit., p. 39 e 44-45. V. anche A. Tassani, Hospices d’enfants trouvés (Brephotrophia), in Les institutions sanitaires en Italie, Milan, 1885, pp. 192 sgg., e P. Bertolini, Gli esposti, in «Nuova Antologia», Roma, 1° dicembre 1893, pp. 434 sgg. e 15 dicembre 1893, pp. 653 sgg.
208
era poi generalizzata tra i neonati che restavano negli istituti (gli infanti malati e più deboli), la quale toccava il 90%!0 e che provocava sussulti di indignazione nell’opinione pubblica quando venivano divulgate situazioni come quella della napoletana Casa dell’ Annunciata, dove degli 856 bambini accolti nel 1895 alla fine del 1896 ne restavano in vita soltanto 3!!. Ma più rappresentative appaiono, nella loro medietà, le statistiche del brefotrofio di Bologna relative al periodo 1877-92. Degli 8.974 esposti entrati nell’istituto in quegli anni, i morti, dentro e fuori l’ospizio, furono 4.485, circa la metà; e se alla cifra si aggiungevano quanti erano deceduti dopo il riconoscimento e il ritiro da parte dei parenti o erano morti dopo il 1892 prima di aver compiuto i 15 anni la percentuale saliva al 60%, un quoziente allora raggiunto in Italia da una generazione soltanto a 40 anni!?. Questa «strage degli innocenti», come venne giustamente definita, era radicata nella condizione di miseria delle famiglie di origine, causa spesso dell’immaturità, delle malformazioni congenite e delle malattie ereditarie (tra cui la sifilide) proprie di una buona parte degli esposti; ma essa era poi allargata dai difetti connessi a un sistema assistenziale ancora primitivo, caratterizzato dall’insufficienza di balie sedentarie, dall’imperfezione dell’allattamento artificiale, responsabile di malattie gastro-enteriche spesso mortali, e dalle carenze igieniche di tanti brefotrofi, grandi e piccoli (e valga l'esempio di quello di Modica, ricordato nelle pagine precedenti!3). Di fronte a una situazione di tale gravità mancò un adeguato intervento dello Stato. Infatti sino al 1900 ed oltre, caduti via via i progetti di legge (come quello Nicotera del 1877) volti a disciplinare in maniera uniforme la questione dell’infanzia abbandonata, nella disordinata diversità delle situazioni locali le sole norme in materia furono quelle dell’articolo 237 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 che, nell’annunciare la promulgazione — mai avvenuta per allora — di una legge speciale sugli esposti, poneva il loro mantenimento a carico di province e comuni; cui si possono aggiungere gli articoli del codice civile relativi al ritrovamento di neonati in luogo pubblico e alla ricerca della paternità (esclusa tranne che nei casi di ratto e stupro violento) e della maternità (ammessa solo se promossa dal figlio), e quelli del codice penale che stabilivano le pene relative ali’abbandono. E dalla scarsa sensibilità dimostrata di fronte a un problema sociale così acuto dalla classe 10. Gorni-Pellegrini, op. cit., pp. 51 sgg. 11. U. Imperatori, Brefotrofi ed esposti in Italia, in «Giornale degli economisti», 1898, vol. 18; pi80. 12. G. Berti, Contributo allo studio della mortalità degli esposti, in «Rivista della beneficenza pubblica», 1897, pp. 79 sgg. 13. Ibid., p. 96.
204
dirigente — di Destra o di Sinistra che fosse — discese la conseguenza che l’Italia fu, sino agli inizi del ’900, l’unico Stato europeo che mancasse di una
regolamentazione organica sull’infanzia abbandonata e che lasciasse sussistere la vergogna della «ruota»!4. Quanto al «baliatico mercenario»,
la novità sostanziale emersa
nel corso
dell’800 fu che il baliatico «a distanza» venne adottato da ampi strati delle famiglie di lavoratori urbani, soprattutto nelle zone investite dal progresso della manifattura e dell’industria, che conoscevano
un crescente impiego del
lavoro femminile. La pratica — di cui nel Parlamento italiano si chiese più volte inutilmente la regolamentazione e la sorveglianza!5 — assunse dimensioni particolarmente massicce in centri come Milano, dove intorno alla metà del secolo XIX quasi la metà dei bambini nati in famiglie povere era affidata a balie del contado o al brefotrofio, e dove ancora agli inizi del 900 un’indagine della Società umanitaria rilevava che il 43% dei bambini nati vivi nella città erano consegnati a nutrici mercenarie!°. E i riflessi che tale consuetudine aveva sulla morbilità e sulla mortalità degli infanti appariranno chiari sol che si rifletta sul primitivismo igienico e sulle deficienze del regime alimentare propri di tanta parte del mondo rurale. Appena è nato — scriveva nel 1908 una delle apostole dell’igiene infantile e femminile, la dottoressa Emma Modena (e si utilizza di proposito una citazione tarda, a sottolineare la permanenza del fenomeno) — il bimbo dell’operaia viene mandato a balia in campagna, [e] non si tiene conto delle condizioni di salute, di famiglia della balia, perché non si può... O il figlio muore a balia, e questi casi di morte per bruttura, per i denti, per i vermi, esse dicono, per la cattiva alimentazione in realtà, si ripetono con
una frequenza terribile... Nei casi meno disgraziati dopo 10 o 12 mesi l’operaia riprende a casa suo figlio in tristissime condizioni fisiche, ed allora cominciano il giro degli ambulatori per curare il bambino, le ansie, le spese, i giorni di lavoro perduti!7.
Il tema del baliatico conduce il discorso a quello più generale dell’allattamento e dell’alimentazione infantile. Anche se spesso l’allattamento materno era protratto eccessivamente a lungo, là dove si addensavano le sedi delle at14. Per il periodo giolittiano cfr., tra l’altro, E. Raseri, Su/ governo degli esposti, in «Gior-
nale degli economisti», 1900, vol. 2°, pp. 368 sgg., e Infanzia indigente abbandonata e traviata. Relazione del Ministero dell’interno al Congresso nazionale dell’Unione italiana dell’educazione popolare tenutosi in Roma dal 7 al 10 dicembre 1912, in «Rivista della beneficenza pubblica», 1913, pp. 525 sgg. 15. Si veda l’intervento del Maggiorani (12 marzo 1873) durante la discussione al Senato sul codice sanitario Lanza (A. p., Senato, Discussioni, p. 1407). 16. Società umanitaria (Ufficio del lavoro), La mortalità infantile in Milano, Milano, 1908,
.4. i 17. E. Modena, L'insegnamento dell’igiene alle ragazze ed alle donne nella scuola e fuori, in «Igiene della donna e del bambino», Milano, 15 giugno 1908, p. 1.
205
tività manifatturiere e industriali a largo impiego di manodopera femminile si delineò la tendenza ad accorciare i tempi dell’allattamento esclusivamente materno
ed a passare a tre, quattro mesi all’allattamento misto, fondato
in
molte zone del paese sul cosidetto «bollito», una pappa mucillaginosa fatta di latte e pane grattugiato o di latte e farina di mais, concordemente giudicata dalla nascente pediatria scientifica poco adatta ai bambini di tenera età. E questa tendenza, che si rifletteva anch'essa negativamente sulla salute dell’infanzia, era diffusa anche nelle plaghe rurali dove, come
rilevava nel 1890
l’inchiesta Bertani sulle condizioni sanitarie dei lavoratori della terra, nelle frequenti evenienze di insufficienza o di povertà del latte materno si ricorreva a poltiglie di latte, acqua, cereali e grassi, inzuccherate soltanto dove vi era «maggiore agiatezza», 0 si somministravano ai bambini «alimenti più grossolani, pane, polenta, minestre casalinghe, masticati dalla madre»!8. Quanto all’allattamento artificiale, anch'esso in fase di espansione, sino alla fine del
secolo venne impiegato latte di mucca o di capra: e ancora una volta con larghi margini di rischio, date le difficoltà di conservazione del latte animale. I pericoli erano poi aggravati dalle strutture antiigieniche dei biberon in uso, tra i quali il cosidetto «biberon a tubo», che non permetteva una pulizia accurata delle sue componenti di vetro e di gomma e delle loro congiuzioni e di cui pediatri e igienisti chiesero a lungo e invano la proibizione per legge, come si era fatto in Francia. Per penetrare meglio nella «qualità della vita» dell’infanzia comune alle famiglie dei ceti popolari va anche tenuta presente la situazione di estremo degrado di larga parte delle dimore, sia urbane che rurali: il che spiega il costume, generalizzato nelle campagne dell’Italia settentrionale e vanamente deplorato da medici e igienisti, di utilizzare come riparo nei mesi freddi la stalla, nella quale si trovavano così a convivere con le bestie adulti, fanciulli e
anche neonati (e «tanto è invalso simile costume, o dirò meglio necessità, — osservava nel 1870 il medico condotto di Belgioioso, un piccolo centro del Pavese — che nella costruzione delle grandi stalle si ha riguardo a lasciare uno spazio difeso dal bestiame, ove si ricoverano nel giorno le donne e i bambini»!9). Vanno infine menzionate alcune nocive consuetudini tradizionali, sovente perpetuate dai consigli di levatrici e «mammane», quali l’uso di fasce stretta18. M. Panizza, Risultati dell’inchiesta istituita da Agostino Bertani sulle condizioni sanitarie dei lavoratori della terra in Italia. Riassunto e considerazioni, Roma, 1890, p. 234. 19. G. Casali, Resoconto di un triennio di condotta a Belgioioso, in «Annali universali di medicina», 1870, vol. 212°, p. 67. Secondo la Direzione generale della statistica (Risultati
dell’inchiesta sulle condizioni igieniche e sanitarie nei comuni del Regno. Relazione generale, Roma,
1886, p. CXIII) i contadini passavano
le serate d’inverno nelle stalle in 966 comuni,
mentre in 4.701 vi passavano non solo le serate ma anche le notti.
206
mente avvolte intorno al corpo del bambino (condannato dall’opinione medica come «avanzo di un’antica barbarie» ma largamente adottato da mamme e balie perché permetteva di attendere più liberamente alle loro occupazioni) o la somministrazione
del battesimo, anche nei mesi freddi, a pochi giorni di
vita. E tra le pratiche pericolose si possono ricordare ancora le manipolazioni delle ossa del cranio per regolarne la forma, la confricazione delle mammelle delle bambine per farle riuscire buone balie, la somministrazione di oppiacei ed alcolici agli infanti per facilitarne e prolungarne il sonno, l’impiego incontrollato di purganti violenti e di «vermifughi», il taglio generalizzato del frenulo linguale, il pregiudizio che la «crosta lattea» valesse a conservare il cervello, che l’eczema non andasse curata perché la sua guarigione poteva portare alla morte del bambino, che gli orecchini tenessero lontane le malattie degli occhi, e via dicendo. Tornando ora agli aspetti generali della morbilità e della mortalità, una loro conoscenza più differenziata fu possibile soltanto dal 1881, quando i competenti uffici centrali dello Stato iniziarono la rilevazione statistica delle cause di morte (sulla base dei certificati dei medici curanti o dei medici necro-
scopici) per i 284 comuni capoluoghi di provincia o di circondario, rilevazione estesa dal 1887 a tutto il Regno. E sulla base di questi dati, integrati da quelli delle inchieste e degli studi compiuti in quello stesso torno di tempo, si cercherà di mettere in rilievo le componenti salienti del quadro nosologico del paese nella fase che si chiuse con l’approvazione della legge sanitaria Crispi del 22 dicembre 1888, con la quale l’Italia si dotava di un nuovo strumento legislativo per affrontare più efficacemente i problemi della sanità e dell’igiene pubblici. Il fine che qui ci si propone è quindi essenzialmente descrittivo, senza la pretesa di tracciare un capitolo di quella storia della sanità modernamente intesa che dovrebbe tener presenti una serie diversificata ma intrecciata di piani, a partire da quello della storia «interna» o «tecnica» della medicina, volta a interpretare sulla base delle conoscenze attuali i fenomeni morbosi descritti dagli osservatori del passato e a ricostruire le terapie adottate20, fino ai piani propri della storia urbana, della storia istituzionale, della demografia storica e dell’antropologia culturale. Ma anche all’interno di un proposito così limitato occorre rendere espliciti i limiti e i rischi di imprecisione connessi alle fonti statistico-mediche,
nella cui utilizzazione sarà bene aver
sempre presente la questione della cosidetta «traduzione» di una terminologia che, poiché indicava soprattutto i sintomi, lasciava nell'ombra la diagnosi delle malattie (e basterà accennare alle difficoltà che presentano 1 dati relativi 20. L. Belloni, Evoluzione e stato attuale della storia della medicina in Italia, in Storia della sanità in Italia. Metodo e indicazioni di ricerca, a cura del Centro italiano di storia ospita-
liera, Roma, 1978, pp. 22-23.
207
alle «convulsioni», o alle malattie gastroenteriche, ancora definite a ’800 inoltrato da dizioni generiche come colera indigeno, colerina, diarree, ecc.).
Al primo posto nella graduatoria delle cause di morte stava la tubercolosi, cui le statistiche ufficiali (che pur computando tra le affezioni tubercolari anche la scrofola, la meningite tubercolare e la «tabe mesenterica» sottostima-
vano l’incidenza del male) attribuivano nel quadriennio 1881-84, nei capoluoghi di provincia o di circondario,
una media annuale di 860 decessi su
10.000 morti per qualsiasi causa (mentre la «polmonite acuta» si ritagliava una quota di 685 unità); un calcolo successivo, esteso a tutti i comuni per approssimazione e quindi largamente indicativo, imputava a quel male per il 1883 24,28 decessi per 10.000 abitanti?!. La tubercolosi, che colpiva soprattutto nelle grandi città?2 — con una maggiore incidenza sul sesso femminile e nel Settentrione — richiamò anche per questi suoi aspetti l’attenzione degli studiosi sulla sua connotazione di malattia sociale, specie dopo che Koch riuscì a isolare nel 1882 il suo agente eziologico, dimostrando il carattere contagioso e non ereditario del male. Da una parte infatti si mise in rilievo l’influenza di cause predisponenti come le insufficienze alimentari o l’insalubrità delle abitazioni, aggravate nelle città dagli effetti delle ondate immigratorie prodotte dalla industrializzazione. Dall'altra vennero sottolineate le responsabilità del lavoro femminile, sia quello di fabbrica, dove le operaie erano esposte all’azione irritante del pulviscolo di cotone e al pericolo di contagio costituito dal cosidetto
«bacio
della morte»?3,
sia quello
a domicilio,
tipico
21. Le cifre del 1881-84 sono quelle riportate in Direzione generale della statistica, Risultati dell’inchiesta sulle condizioni... Relazione generale, cit., p. CLXXII. Cfr. anche G. Sormani, Geografia nosologica dell’Italia, in «Annali di statistica», serie 28, vol. 6°, 1881, pp. 149 sgg., che collocava in testa alla graduatoria della mortalità per tubercolosi e tisi negli anni 1875-78 le città di Bologna (3,84 per mille abitanti), Milano (3,82), Venezia (3,73). Per Milano si veda anche Lo stato civile, la beneficenza comunale, la sanità in Milano nell’anno 1872. Saggio statistico (Milano, 1873) che numerava tra il 1861 e il 1870 7.307 morti per tubercolosi e tisi, con una media annuale di 3,69 decessi per 1.000 abitanti.
I dati relativi al 1883, sia per la tubercolosi che per le altre malattie di cui si parlerà in seguito, sono quelli elaborati dal Raseri sulla base della supposizione che negli anni 1883-85 il numero dei morti nei comuni non capoluogo stesse al numero (noto) dei morti nei capoluoghi nello stesso rapporto constatato per gli anni 1887-89 (Raseri, Atlante..., cit., p. 59 n.). Tra i motivi che portavano a sottostimare l’incidenza della tubercolosi stava il fatto che molti casi di forme tubercolari erano denunciati dai medici curanti sotto altre denominazioni per un «riguardo pietoso» verso le famiglie (G. Arcangeli, Diffusione della tubercolosi ed azione del Comune di Milano, 1896-1914, in «Storia urbana», gennaio-aprile 1978, pp. 82-83). 22. Sulla diffusione del male v. anche A. Raddi, Cenni statistici ed economici sulla riparti-
zione della tubercolosi in Italia, con speciale riguardo alle grandi città, in «Rivista della beneficenza pubblica», 1894, pp. 613 sgg.
23. Nei cotonifici la tessitrice, ad ogni operazione di cambio della spola riempita di trama (operazione ripetuta circa 800 volte al giorno) doveva portare le labbra alla navetta contenente la spola per succhiare il capo del filo dalla cruna; di conseguenza, oltre ad inspirare il pulvi-
208
dell’industria dell’abbigliamento, il quale si svolgeva in locali che l’uso promiscuo di abitazione e ambiente di lavoro collocava troppo spesso al di sotto della soglia richiesta dalle più elementari norme igieniche. Ma la tubercolosi era una presenza diffusa anche nelle campagne, e in quel male le considerazioni finali dell’inchiesta Bertani scorgevano una delle cause che provocavano il «deperimento» generalizzato delle classi rurali di tutto il Regno?4. In una situazione complessiva della «salute pubblica» ancora di vecchio modello, in cui la morbosità a carattere acuto e infettivo prevaleva largamente — per le ragioni cui si accennerà più avanti — sulle odierne patologie «degenerative», con etiologia multifattoriale ed andamento cronico?5, non deve meravigliare il peso delle affezioni, già richiamate a proposito della mortalità nei primi anni di vita, quali il morbillo, la scarlattina, e soprattutto la difterite (più di 6.500 morti annue nei soli capoluoghi di provincia e di circondario nel 1881-8426). Rilevante era anche l’incidenza del vaiolo, che continuò a serpeggiare endemicamente sin oltre la soglia del nuovo secolo e che ebbe manifestazioni epidemiche gravi nel 1870-72 (esemplificando, a Pavia i colpiti dal male furono
1.844, con 329 decessi; a Roma 3.149, con 1.219 morti??) e nel 1886-
90, con l’acme nel 1888 (600 morti per milione di abitanti)28. Né alla propagazione della malattia faceva valido argine l’intervento dello Stato, che soltanto nel 1888 rese obbligatorie la vaccinazione di tutti i bambini entro il semestre successivo a quello della loro nascita e la rivaccinazione al decimo anno dei fanciulli che frequentavano una scuola o lavoravano in un’officina: disposizione che pose termine al disordine creato dal ventaglio di normative sin allora vigenti nelle varie parti del paese, in nessuna delle quali era comunque previsto l’obbligo generalizzato della vaccinazione, perché il relativo certificato era richiesto soltanto per quanti dovevano essere ammessi alle scuole pubbliche, agli istituti di educazione dipendenti, sussidiati e autorizzati dallo Stato o dovevano sostenere pubblici esami??. scolo di cotone depositato nella navetta, rischiava il contagio diretto quando sostituiva una compagna malata di tubercolosi (G. Bardo, Le malattie professionali e l’igiene negli stabilimenti di tessitura, in «Le Arti tessili», Milano, 1° febbraio 1903). 24. Panizza, op. cit., p. 229. 25. C. Cislaghi, Statistica sanitaria e storia della salute, in Storia della sanità in Italia..., CILSp./5I
26,Direzione generale della statistica, Risultati generali dell’inchiesta sulle condizioni... Relazione generale, cit., p. CLXXII. 27. Sormani, Geografia nosologica..., cit., p. 179. 28. Raseri, Atlante..., cit., p. 59 e tav. 50. 29. E. Martino, Commento alla legge del 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato C), e del relativo regolamento sulla sanità pubblica, Milano, 1878, p. 172.
209
Ma la manifestazione forse più evidente dei ritardi del paese in fatto di infrastrutture igieniche e di azione preventiva nei confronti delle malattie infettive è la vicenda delle malattie gastro-enteriche. L’insieme di queste affezioni, dal tifo e paratifo a quelle che gli studi coevi e le statistiche ufficiali accomunavano — come si è accennato — sotto le denominazioni spesso generiche di enterite, gastro-enterite, diarrea, dissenteria, colera indigeno, colerina, ecc.,
costituì infatti sino all’inizio del ’900 la seconda grande causa di morte insieme alla tubercolosi (intorno al 16% di tutti i decessi al momento dell’approvazione della legge sanitaria Crispi), ma con riflessi demografici ancora più cospicui perché quelle malattie colpivano con esiti letali soprattutto i bambini. All’interno di questa categoria di affezioni un posto a sé va riservato al tifo addominale, ben distinto da quel tifo petecchiale che dopo la grande ondata dei primi anni della Restaurazione si era limitato a manifestazioni sporadiche e isolate. L’ileotifo, che in conseguenza di una letalità relativamente bassa (dovuta alla parziale immunizzazione)
aveva una diffusione assai più
larga di quella che lascerebbe supporre il puro dato della mortalità (10,62 morti per 10.000 abitanti nel 1883, scesi a 3,53 nel 190339) e che intorno al
1880 doveva tradursi in una cifra di circa 100 mila malati l’anno, rivela a un’analisi più appropriata una distribuzione geografica diversa da quella risultante dalle statistiche ufficiali. Queste attribuivano infatti alla malattia un
peso più elevato nei grandi e medi centri urbani e nell’area settentrionale; ma si trattava in sostanza del frutto di una distorsione derivante dalla concentrazione dell’assistenza medico-ospedaliera nelle città e nelle regioni del Nord, che rendeva possibile una rilevazione più accurata dei casi di tifo, e che sot-
tovalutava invece la critica realtà di tanti borghi rurali e dei compartimenti meridionali3!. Nello spaccato delle endemie ed epidemie gastro-enteriche risalta per i suoi effetti devastanti il colera. Dopo le due prime, grandi invasioni del periodo preunitario, quella del 1835-3732 e quella del 1854-56, che interessò più di
2.000 comuni provocando secondo alcune stime dai 200.000 ai 300.000 morti, l’Italia unita fu ancora attaccata dal morbo «asiatico» nel 1865-68; e que-
30. L. Faccini, Sviluppo urbano e condizioni sanitarie dei ceti subalterni. Le malattie gastroenteriche in Italia fra il 1887 e il 1914, in «Classe», Milano, n. 15, giugno 1978, pp. 165 Sgg. 31. Per la questione del tifo nei centri minori v. A. Di Vestea, Appunti statistici sulle condizioni sanitarie dei piccoli comuni, in «Giornale della reale Società d’igiene», 1894, pp. 393 seg. 32. Per il colera del 1835-37 cfr. A. Corradi, Annali delle epidemie occorse in Italia... vol.
3°, pp. 466 sgg. Un serio studio moderno di un importante caso locale è quello di A.L. Forti Messina, Società ed epidemia..., cit.
210
sta volta, stando ai dati abbastanza sicuri della Direzione di statistica, il vibrione, comparso in circa 2.900 comuni, fece 160.000 vittime (6,3 per 1.000 abitanti), infierendo soprattutto in alcune aree del Mezzogiorno (16,7 nelle Puglie e 24,1 in Sicilia, con punte del 26,9 a Catania, 29,6 a Palermo e 44,8
ad Agrigento33). Una nuova aggressione colerica, meno grave sul piano nazionale (poco più di 14.000 morti) perché concentrata in alcune aree, ma con effetti pesanti nelle zone colpite, si verificò nel 1884 e 1885, con epicentri rispettivamente nelle province di Napoli (circa 8.000 decessi, di cui 7.000 nel solo capoluogo) e di Cuneo, e poi di Palermo (circa 3.000 morti)34. E proprio questa epidemia, che sullo slancio di un’ondata di solidarietà verso Napoli (dove affluirono squadre di volontari guidate tra gli altri da Felice Cavallotti e Antonio Maffi) fece convergere le preoccupazioni di politici, amministratori, medici ed igienisti sulla questione della salute pubblica e dei suoi risvolti legislativi, induce a fermare brevemente l’attenzione sulla mentalità collettiva delle folle esposte al contagio colerico. Sono noti gli avvenimenti siciliani del 1837, che presero l’avvio dalla comparsa del male nell’isola. La propagazione dell’epidemia da Palermo al resto della Sicilia generò tra gli strati popolari il sospetto, alimentato dagli oppositori liberali dei Borboni, che il morbo fosse «opera di veleni» sparsi da agenti del governo; e l’ostilità e il rancore nei confronti dell’apparato statale, esasperati dal comportamento dei funzionari borbonici, che abbandonarono in massa i loro posti di responsabilità per paura del contagio, provocarono un rapido collasso dei poteri costituiti, di cui approfittarono i gruppi antiborbonici di Siracusa e di Catania per dichiarare la decadenza del governo e l’indipendenza da Napoli. Ma la crisi dell’amministrazione statale facilitò anche l'esplosione dell’odio popolare sia contro i rappresentanti del potere sia contro i grandi e medi proprietari terrieri, come si verificò a Bagheria, Corleone, Misilmeri, Prizzi, Villabate, ecc., dove nel corso di una serie di sommosse e
di tumulti contadini furono uccisi più di 80 «cappeddi»35. Ma questi stati d’animo impregnati di sospetto e diffidenza verso gli organi del potere centrale e periferico e quanti a quelli potevano in qualche modo essere assimilati (come era il caso dei medici condotti) caratterizzarono la
psicologia collettiva anche nella più evoluta Lombardia, pur se qui non si ebbero esplosioni di massa. Così a Milano era opinione largamente circolante 33. Statistica del Regno d’Italia (Sanità pubblica), /{ cholera-morbus 1867 e Il cholera morbus nel 1866-67, Firenze, 1870.
nel 1865, Firenze,
34. G.B. Morana, /! colera in Italia negli anni 1884 e 1885. Relazione a S.E. il cav. Agostino Depretis, presidente del Consiglio..., Roma,
1885, passim, ed E. Fazio, Il colera del 1884
in Napoli, in «Giornale della reale Società d’igiene», 1885, pp. 461-462. 35. F. Della Peruta, Mazzini e i rivoluzionari italiani. Il «partito d’azione» (1830-1845), Milano, 1974, pp. 273 sgg.
2
che il colera fosse il prodotto di una congiura ordita dai ricchi contro i poveri, e che medici e agenti del governo volessero avvelenare i poveri: opinione che tornò a diffondersi durante l’epidemia del 1855, come testimoniava un medico illuminato e impegnato come Gaetano Strambio, che tracciava questo quadro amaramente ironico degli atteggiamenti largamente presenti nei ceti popolari: È una polvere misteriosa che il medico depone sul polso o su la lingua del malato, quando ne esplora i battiti e la temperatura, o mescola alla pasta de’ senapismi; sono sanguisughe avvelenate! Ma siccome molti medici, ormai persuasi dell’impotenza dell’arte, si limitano a prescrivere fregagioni, bagnature ed acqua fresca, così v’è chi crede ad una boccetta di tanta maligna potenza, che valga a svolgere la morte sotto forma di profumi ingannevoli e sottilissimi!! I più furbi però od i meno tristi ridono di queste infime superstizioni, perché sanno di certa fonte non essere vero che i medici sono pagati dal governo per ammazzare la povera gente. Il colera, credono essi, c’è infatti, ed è contagioso: non sono i medici che lo inventano; essi non fanno che avvelenare i colpiti, perché non propaghino la malattia?9.
Che siffatte disposizioni mentali di fronte a una calamità che sembrava indirizzare i suoi strali prevalentemente contro i ceti più poveri della collettività si perpetuassero in virtù di una vischiosità frutto di tenaci, secolari permanenze è confermato proprio dall’ondata epidemica del 1884-85 dalla quale si sono prese le mosse. Nei centri del Mezzogiorno colpiti o minacciati dal contagio la reazione di fronte al pericolo culminò in una serie di gravi, reiterati disordini che richiesero in molte circostanze l’intervento delle truppe. E le popolazioni non si limitarono ad imporre con la forza alle autorità comunali l’introduzione illegale di quarantene e cordoni sanitari e ad impedire il servizio di treni, navi e corriere, ma come cinquanta anni prima, esacerbate dalla fuga dei ricchi, si levarono a tumulto contro i presunti «avvelenatori», spesso identificati negli agenti della forza pubblica. Così in Calabria — dove, a detta della relazione ufficiale, «più che altrove» era radicata nelle masse l’opinione che il colera fosse sparso ad arte — a Longobucco «i popolani assunsero un atteggiamento ostile e minaccioso» contro il delegato di pubblica sicurezza e i carabinieri «ritenuti spargitori di colera», che furono liberati da reparti di truppa inviati a circondare il paese; ed episodi analoghi avvennero a S. Biase e in altri centri della regione. Anche a Palermo, informa la stessa fonte, nelle masse fece breccia il sospetto che il colera fosse propagato «ad arte»; di qui «una resistenza dei popolani contro le autorità, contro i medici e contro i benemeriti cittadini che accorrevano nei luoghi infetti per provvedere, per cura36. «Gazzetta medica italiana. Lombardia», Milano, 24 settembre 1855, pp. 335-336.
212
re e per aiutare»; mentre tumulti del tipo di quelli calabresi si verificarono in alcuni centri minori, come ad esempio a Resuttano, dove «una banda di popolani armati per il cordone [sanitario] si ribellò contro due carabinieri sotto pretesto che venissero a spargere il veleno, e gli investì ferendoli entrambi»37. Il carattere endemico delle affezioni gastro-intestinali e le irruzioni del colera — malattie originate dall’ingestione di cibi e bevande inquinate (dagli ortaggi concimati con i liquami dei pozzi neri all’acqua e al latte contaminati da materie fecali) — rimandano in primo luogo alla situazione primitiva del paese in fatto di approvvigionamento idrico e di infrastrutture igieniche, e poi a quella che si potrebbe chiamare la «questione delle abitazioni». Come indicatori generali del dissesto dell’Italia igienica quale si presentava agli osservatori al tempo degli ultimi ministeri Depretis possono essere utilizzati i risultati dell’inchiesta sulle condizioni dell’igiene e della sanità nei comuni del Regno effettuata nel 1885-86. Questo il quadro fornito da sindaci e segretari comunali, e quindi in molti casi delineato con tinte inclini all’ottimismo.
Degli 8.258 comuni italiani 6.404, con una popolazione complessiva di più di 14 milioni e mezzo di abitanti, erano privi di qualsiasi sistema di fognatura, e in 1.313, con circa 8 milioni di abitanti, i condotti sotterranei erano utilizza-
ti soltanto per lo smaltimento delle acque meteoriche o provenienti da fontane e usi domestici, e non per quello delle acque luride; dei restanti 541 che risultavano in possesso di una rete fognaria soltanto 97 (con poco più di 1 milione e mezzo di abitanti) dichiaravano che questa rete era estesa a tutte o alla massima parte delle vie, mentre negli altri la canalizzazione era parziale. Quanto agli acquai, ne erano privi più di 5.000 comuni, e in altri 1.277 gli acquai sboccavano direttamente sulle vie o in cortili interni. I comuni con le abitazioni fornite in tutto o in buona parte di latrine erano 3.335 (16 milioni di abitanti); quanto ai restanti 4.923 la maggioranza della popolazione non disponeva di questo servizio; per quel che riguarda la rimozione delle materie luride dal centro dell’abitato questa era effettuata in 5.780 comuni per mezzo di mastelli, cesti e altri recipienti scoperti, e in altri 797, sono parole della relazione accompagnatoria dell’inchiesta, gli escrementi venivano deposti sulle vie, la-
sciando «ai venti, alle piogge ed ai maiali la cura di sgombrarle da questi fomiti continui d’infezione». Se in poco più della metà dei comuni le amministrazioni provvedevano alla nettezza urbana direttamente o appaltandola, in 2.766 l’incombenza era affidata alle cure verosimilmente poco assidue dei proprietari frontisti, e in 1.142 nessuno si prendeva cura del servizio. Più infidi appaiono i risultati dell’indagine ministeriale concernenti le acque potabili, perché se 355 comuni fondarono le loro risposte su analisi chi37. Morana, op. cit., pp. 27, 29-30, 133 e 151. V. anche E. Cimbali, Colera e pregiudizi sul colera in Sicilia, in «Rassegna nazionale», Firenze, 16 giugno 1888, pp. 603 sgg.
213
miche e microscopiche relativamente accurate, la quasi totalità delle ammini-
strazioni locali basò le sue dichiarazioni su accertamenti grossolani relativi alle qualità organolettiche. In ogni modo, quale che sia il valore di queste statistiche, dei 6.763 comuni
che affermarono
di avere acqua sufficiente per i
propri 22 milioni e mezzo di abitanti, 1.228 (con 6 milioni e mezzo di amministrati) disponevano di acqua potabile mediocre o cattiva, mentre i 1.495 comuni residui non potevano contare su acqua potabile sufficiente, e per di più questa era spesso cattiva. E ancora, rispetto alla provenienza, quasi 22 milioni di italiani bevevano acqua di pozzo, di sorgente, di cisterna, o attinta ai corsi d’acqua e ai laghi; in 2.720 comuni, infine, l’acqua potabile era portata ai centri abitati da distanze verie per mezzo di tubi metallici o di legno, e in altri 447 per mezzo di condotti a cielo aperto88. Scarne le informazioni fornite sulle abitazioni dall’inchiesta, alla quale ri-
sultava che 3.185.568 stanze (numero che includeva anche le cucine) di 1.750.000 appartamenti posti al solo pianterreno davano asilo a più di 7.200.000 persone; 183.000 persone vivevano nelle circa 100.000 stanze ricavate nelle soffitte e altre 100.000 alloggiavano in abitazioni sotterranee5?. Ma, per quel che riguarda le dimore rurali, i ragguagli forniti dall’inchiesta Jacini e dalle coeve monografie agrarie non lasciano dubbi sulla condizione insalubre, degradata e degradante degli alloggi delle popolazioni contadine — la maggioranza degli italiani — al Nord e al Sud, in montagna e in collina come in pianura, popolazioni che si affollavano in una promiscua convivenza, spesso estesa agli animali piccoli e grandi, in abitazioni di uno o due locali, umi-
di, sporchi e dotati delle sole suppellettili più indispensabili. Quadro che faceva scrivere al medico Mario Panizza, estensore della relazione sui risultati dell’inchiesta Bertani, che in tutte le abitazioni dei lavoratori della terra concorrevano i fattori negativi perché, «al verificarsi di una infezione, questa potesse inquinare tutto quanto circonda[va]
l’infermo, stabilire un focolaio di
grande intensità e pertinacia, e rapidamente propagarsi». Anche perché la situazione era poi aggravata dalla scarsa cura delle popolazioni rurali per l’igiene personale — resa difficile dalla miseria —, testimoniata dal fatto che sovente le famiglie contadine giudicavano un lusso cambiare la biancheria personale una volta alla settimana e quella del letto una volta al mese, Per quanto concerne poi il «patrimonio residenziale» dei centri urbani, una serie di studi di casi locali (da Brescia e Cremona a Napoli) ha documentato
in maniera analitica l’insieme degli aspetti crudamente negativi propri degli 38. Direzione generale della statistica, Risultati dell’inchiesta sulle condizioni... Relazione generale, cit., pp. XCIV-XCVI e XLI-XLII. 39. Ibidem, p. XCVII. 40. Panizza, op. cit., pp. 128-129.
214
alloggi delle classi popolari: alti tassi di affollamento, carenza di aria e di luce, rudimentalità o mancanza dei servizi igienici, livello elevato degli affitti, aggravato dalla insufficiente risposta del mercato alla pressione di una domanda in crescita per l’aumento naturale della popolazione e per l’inurbamento*!. E una recente indagine basata sulle risultanze del censimento del 1881 concentrata su 53 dei 69 capoluoghi di provincia (con esclusione delle città maggiori e dei piccoli capoluoghi, suggerita dall’intento di far riferimento a una realtà il più possibile omogenea) ha portato concludere che il taglio medio dell’alloggio nel complesso dei centri esaminati era di 3,44 stanze (sempre inclusa la cucina), che si abbassava però a 2,85 nelle città meridionali, dove tra l’altro era più grande la dimensione della famiglia, con valori minimi a Cosenza (2,24), Caserta (2,20), Agrigento (2,16), Sassari (2,11), Calta-
nissetta (1,92), Foggia (1,63). Cifre che non lasciano dubbi sulla tipologia degli alloggi in cui si addensavano gli strati urbani a basso livello di reddito; tanto più che esse non tengono conto di città quali Milano, Roma, Napoli e Palermo, dove la qualità della vita tra le pareti domestiche risultava ancora più scadente, così da sollecitare le curiosità di osservatori inclini alla minuziosa osservazione di stampo positivistico e di romanzieri spinti dal verismo sociale a scrutare il «ventre» dei grandi agglomerati urbani (e val la pena notare che proprio dalla narrativa sociale derivò il termine «sventramento» passato a designare i «risanamenti» edilizi degli ultimi lustri del secolo). Spostando ora il discorso sui due flagelli endemici che più logoravano la fibra di tanta parte delle masse contadine, la malaria e la pellagra, nell’un caso e nell’altro appaiono chiare le strette connessioni con la realtà economico-sociale del paese quale si era venuta formando nel corso storico di lungo periodo. L'infezione anofelica aveva infatti il suo terreno di coltura nelle distese di acque stagnanti, prodotto in larga misura di un dissesto idrogeologico provocato ed aggravato da un insieme di cause operanti nel lungo periodo (dal di41. Cfr. tra l’altro una serie di saggi apparsi in «Storia urbana», e in particolare: G. Dardano, Epidemie, contesto urbano e interventi di risanamento a Genova, 1830-1880 (luglio 1977, n. 3, pp. 33-69); M.L. Betri, La questione sanitaria a Cremona: problemi e provvedimenti,
1830-1880 (ibidem, pp. 71-89); C. Petraccone, Condizioni di vita delle classi popolari a Napoli dall’unità al «risanamento», 1861-1885 (gennaio-aprile 1978, n. 4, pp. 185-220); M.A. Teti, La città di Catanzaro dal 1860 al 1920: evoluzione urbanistica e condizioni di vita della popolazione (settembre-dicembre 1978, n. 6, pp. 55-83). Nella ricca letteratura coeva
sul nesso
abitazione-salute
v. A. Armanni,
Beneficenza
ed
igiene, in «Rivista della beneficenza pubblica», 1884, pp. 401 sgg. e La riforma sanitaria in Italia nei suoi rapporti colla beneficenza pubblica, ibidem, 1887, pp. 549 sgg. 42. C. Carozzi, Le abitazioni nei capoluoghi di provincia italiani intorno al 1880: alla ricerca di alcune differenze tra Nord e Sud, in «Storia urbana», luglio 1977, n. 3, pp. 147-148. 43. V. il discorso di N. Badaloni alla Camera dei deputati in data 12 dicembre 1888 (A. p., Camera, Discussioni, Legislatura 162, 22 sessione, p. 5961).
215
boscamento alla scarsità mento dei corsi d’acqua), 170.000 ettari localizzati ancora sino a quella data
degli interventi pubblici per la bonifica e l’inalveadistese che alla metà degli anni ‘80 coprivano circa in più di 1.300 comuni*. Ma la malaria, attribuita ai miasmi palustri, trovava un ambiente di elezione
anche nelle ampie distese della Valle padana a marcita e a risaia; ed aveva un
altro fornite, pur se più circoscritto, nelle pozze di acqua stagnante che accompagnavano i lavori di costruzione delle ferrovie e alle quali era da imputare l’alta incidenza della malattia tra il personale ferroviario. Sempre alla metà degli anni ‘80 i comuni a rischio malarico erano più di 4.800, con circa 20 milioni di abitanti, anche se quelli che denunciavano casi
frequenti si riducevano a 2.813 (con più di 11 milioni e mezzo di abitanti); questa classe di comuni era però concentrata essenzialmente nel Mezzogiorno continentale (specie in Puglia, in Basilicata e nella Calabria ionica) e nelle isole, oltre che nelle aree delle Maremme, della Campagna romana e del del-
ta del Po45. E sebbene la malaria non figurasse ai primissimi posti tra le cause di morte su scala nazionale (negli anni a cavallo tra ‘800 e ’900, quando si era però già delineata la tendenza alla caduta della mortalità per quella causa specifica, ai 600.000 individui colpiti annualmente corrispondevano fra i 9.000 e i 10.000 decessi), purtuttavia le statistiche a livello comunale mettono in evidenza che in certe zone, specie del Mezzogiorno e sempre in quegli anni, a quel male erano da attribuire sino al 20% e oltre dei decessi totali. La
localizzazione prevalentemente meridionale della malattia, considerata a ragione un «fattore cumulativo» del sottosviluppo delle regioni del Sud (l’endemia infatti, respingendo le popolazioni dalla pianura verso le aree collinose e più elevate, provocò lo sfruttamento irrazionale di queste in funzione di un’economia di autoconsumo, con l’aggravamento del diboscamento e del dissesto idrogeologico), non deve però far trascurare i riflessi negativi che nel corso dell’800 l’espansione di una coltura tipicamente capitalistica come quella del riso (fomite, come si è detto, di infezione anofelica) ebbe sulla sa-
lute delle popolazioni delle zone risate, e non solo di quelle. Alla malaria pagarono infatti un pesante tributo anche le decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici che ogni anno emigravano stagionalmente, spesso da lontani comuni di collina e di montagna, per le operazioni della monda e della trebbiatura in risaia dopo essere stati ingaggiati con il sistema del «caporalato»: pratica di sfruttamento dalle radici secolari e contro le quali erano state inefficaci sia le 44. Direzione generale della statistica, Risultati dell’inchiesta sulle condizioni... Relazione generale, cit., pp. XXXIX-XL. 45. Ibidem, pp. CLXXVI-CLXXVIII. 46. F. Bonelli, La malaria nella storia demografica ed economica d’Italia. Primi lineamen-
ti di una ricerca, in «Studi storici», 1966, pp. 675-678.
216
«grida» dei governatori spagnoli di Milano” che i tentativi di intervento dei successivi governi succedutisi in Lombardia e quelli delle autorità sabaude, proprio come non aveva sortito effetti di rilievo la lunga serie di provvedimenti e di regolamenti emanati per limitare la risicoltura e non farla avvicinare troppo ai centri abitati*8. All’insediamento della malaria nei compartimenti meridionali faceva riscontro quello della pellagra nelle campagne dei compartimenti settentrionali e, in minor misura, centrali. Negli anni dal 1881 al 1900 l’endemia pellagrosa fu responsabile di un numero annuo di decessi oscillanti tra le 2.800 e le 4.300 unità, mentre i dati registrati in due rilevazioni ravvicinate del 1879 e del 1881 parlavano di circa 100.000 persone colpite dal male; e la virulenza del fenomeno morboso, anche se in via di attenuazione a partire dagli anni 790, restò ancora forte sino al chiudersi del secolo (circa 73.000 colpiti nel 1899), per andare invece incontro a un rapido declino nel periodo giolittiano e durante la prima guerra mondiale. Le cifre assolute possono sembrare relativamente basse, ma esse acquistano ben altro rilievo se si tiene presente che i dati si riferivano, per 1'’80% dei casi, agli strati più miseri delle popolazioni rurali di tre soli compartimenti — la Lombardia, il Veneto e l'Emilia — e che il rapporto tra pellagrosi e popolazione agricola in quelle regioni nel 1881 era valutato rispettivamente nella misura del 53,67, 27,36 e 7,79 per mille. Inol-
47. Si veda ad es. l’editto pubblicato a Milano da Juan Fernandez de Velasco il 24 febbraio 1597, in cui si legge fra l’altro: «Et perché al tempo che si mondano li risi, o si fanno intorno ad essi altre opere, alcuni chiamati capi de risaroli procurano in più modi unire quantità de figliuoli, et garzoni, con quali usano barbare crudeltà, perché ridotti con promesse, et lusinghe al luogo destinato, li trattano male non pagando, o non provedendo a queste meschine creature del vivere necessario, facendole faticare come schiavi, con battiture, et con asprezza maggiore di quella, che si usa con li condennati al remo, di modo che molti anco ben nati, sedutti come sopra, se ne moiono miseramente nelle cassine, o nelli campi circonvicini, senz’aiuto, non solo
corporale, ma né anco spirituale; però non vuole Sua Eccellenza che nell’avvenire si facciano nel modo sin qui usato i detti capi de risaroli, né che si conduchino i figliuoli al macello con questo mezzo; ma comanda, che sia del tutto spento il nome, et traffico de capi de risaroli, et
che per tali opere gli istessi patroni de campi, o almeno li loro fittabili conduchino gli operari a lavorare come si usa nelli campi, et nelle vigne, per quella mercede, che sarà voluntariamente da ciascuno convenuta, né si usi loro alcuna violenza, né si astringano a faticarsi quando saranno infermi, o altrimenti non possano, perché in questo caso basta il licentiarli, pagandoli per quel tempo, che hanno servito» (Biblioteca di Brera, Milano, miscellanea di «regolamenti, tariffe, progetti, leggi, decreti: 1575-1700»). 48. L. Faccini, Uomini e lavoro in risaia..., cit., passim; e anche, dello stesso, / lavoratori
della risaia fra °700 e ’800..., cit., pp. 545 sgg. 49. Una analisi accurata dei dati quantitativi è in G. Porisini, Agricoltura, alimentazione e
condizioni sanitarie. Prime ricerche sulla pellegra in Italia dal 1880 al 1940, Genève, 1974 (con Appendice statistica, Bologna, s.d.). Per la situazione alla fine dell’800 cfr. anche P. Sitta, La diffusione della pellagra in Italia, in «Giornale degli economisti», 1899, vol. 2°, specie pp. 571 sgg.
217
tre, al di là degli scarti macroscopici tra i risultati dell’inchiesta del 1879 e di quella del 1881 (i malati censiti nel Veneto salivano da circa 30.000 a circa 56.000, mentre scendevano in Emilia da circa 19.000 a circa 8.000), dovuti alla diversità dei criteri seguiti nelle due rilevazioni e al disaccordo ancora re-
gnante tra i medici sulla sintomatologia e l’eziologia del male, va anche tenuto presente che le cifre sottostimavano in larga misura l'incidenza della pellagra. Infatti, oltre alla circostanza che non tutti i comuni davano risposte scrupolose, si deve ricordare
che le inchieste, affidate generalmente
ai medici
condotti, erano spesso eseguite nei mesi estivi, quando nelle case delle campagne padane restavano soltanto i fanciulli, i vecchi e poche donne; che molti contadini cercavano in tutti i modi di sottrarsi all’indagine medica, sia per un comprensibile senso di vergogna, sia per il timore che quella potesse preludere al ricovero in ospedale o in ospizio; e che infine si teneva conto soltanto
dei casi in cui il male appariva ormai evidente, trascurando invece quelli nella fase incipiente, che erano poi probabilmente la maggioranza®0, La pellagra, fenomeno relativamente recente nel panorama sanitario italiano (aveva fatto la sua comparsa tra la fine del °600 e l’aprirsi del ‘700), era diventata oggetto di studio più o meno sistematico nel tardo ‘700; e dai primi decenni del XIX secolo, dopo che intorno alla sua origine avevano avuto cor-
so molte teorie fantasiose (l’esposizione ai raggi solari, il clima, i venti, la sporcizia) nell’opinione medica si consolidò progressivamente l’ipotesi che andava nella direzione giusta, quella delle carenze alimentari, anche se nel corso dell’800 la intuizione del nesso tra la malattia e l'alimentazione quasi esclusivamente maidica dei contadini della Lombardia e in generale dell’Italia settentrionale venne offuscata e deviata dall’erronea teoria lombrosiana dell’intossicazione da mais guasto. In realtà la pellagra, come l’epidemiologia accertò dal 1914, era un’affezione carenziale, derivante da avitaminosi, e soprattutto dalla mancanza nei regimi alimentari a prevalente monofagismo maidico della vitamina PP (pellagra preventing), assente nelle farine di granturco. Il che spiega l’espansione ottocentesca del male nelle sue zone di elezione, dove la iniseria contadina e la penuria alimentare cronicizzata costringevano alcuni milioni di lavoratori della terra a cibarsi quasi esclusivamente di polenta e di pane fatto con il mais, con l’esclusione quasi assoluta della carne. E in questa luce, per comprendere l’inversione di tendenza nella capacità di presa dell’endemia verificatasi intorno al 1890, l’accento va posto non sui limitati e disorganici provvedimenti antipellagrosi, ma su fattori di natura economica e sociale: da una parte la depressione del mercato dei cereali provoca50. E. Gonzales, Della pellagra nella provincia di Milano. Relazione in nome della Commissione nominata dal r. prefetto di Milano, in «Giornale della reale Società italiana d’igiene», 1882, p. 177.
218
ta dalla crisi agraria degli anni ’80 che interruppe — nonostante la svolta protezionistica del 1887 — un aumento di lunga durata dei prezzi dei più diffusi generi alimentari al quale non era seguito un corrispondente rialzo dei salari di braccianti e di obbligati; dall’altra la spinta impressa alla rivalutazione delle retribuzioni dalle agitazioni contadine della Valle padana, che proprio negli anni ‘80 cominciarono a passare dalla spontaneità all’organizzazione, e che esplosero in forme più moderne nell’ondata di lotte del 1901-190251. Questi rapidi richiami all’endemia pellagrosa fanno ritenere opportuno accennare ora al rapporto causale che nei primi decenni dell’Italia unita si stabilì tra pellagra, malattia mentale e istituzione manicomiale. La pellagra nel suo ultimo stadio dava infatti luogo a manifestazioni psicotiche — la cosidetta «frenosi pellagrosa» — che portavano al ricovero dei malati nei manicomi; e quindi anche a questa malattia va in parte ricondotto l'ampliamento delle dimensioni quantitative dell’internamento psichiatrico verificatosi nei decenni successivi all’ Unità e attestato dalle statistiche. La prima di queste rilevazioni estesa a tutto il territorio nazionale, approssimativa per difetto, censiva infatti al 1° gennaio 1866 8.262 malati di mente ricoverati nei 27 manicomi pubblici, nei 5Smanicomi privati e nei 4 «comparti deliranti» degli ospedali civili. Successive indagini effettuate a partire dal 1874 mettevano in luce una tendenza all’aumento
costante dei ricoverati, sia in cifre assolute (12.210 nel
1874, 14.471 nel 1880, 20.282 nel 1885, 24.118 nel 1891, 34.802 nel 1898) che relative (da 50,5 per 100.000 abitanti nel 1874 a 108,6 nel 1898)52.
Sarebbe semplicistico legare in modo meccanico la crescita dei ricoveri manicomiali alla diffusione della pellagra, o attribuire esclusivamente a questa e all’alcoolismo (altro fenomeno — come si vedrà — largamente prevalente nelle regioni del Nord) la localizzazione essenzialmente settentrionale delle istituzioni di carattere psichiatrico: localizzazione che è invece da mettere in relazione anche con una tradizionale inferiorità delle regioni meridionali in fatto di strutture ospedaliere che contribuiva a tenere bassa la cifra dei ricoverati rispetto al totale dei malati53. E non si può negare che a incrementare gli 51. Cfr. A. De Bernardi, Pellagra e alcolismo: sviluppo capitalistico e trasformazioni nella configurazione sociale del ricovero psichiatrico (1780-1915), in A. De Bernardi-F. De Peri-L. Panzeri, Tempo e catene. Manicomi, psichiatria e classi subalterne. Il caso milanese, Milano,
1980, pp. 258 sgg. 52. M. Gorni, Malattia mentale e sistema. L’istituzione manicomiale italiana dalla fine del settecento agli inizi del novecento, in «Classe», giugno 1978, n. 15, pp. 200-201. 53. Una relazione della Deputazione provinciale di Siena presentata nel 1886 al congresso freniatrico svoltosi in quella stessa città faceva notare che, sulla base dei risultati del censi-
mento del 1871, nelle province del Mezzogiorno esistevano a quella data circa 8.000 mentecatti, dei quali soltanto 1.280 reclusi, mentre in Toscana, su un totale di 3.900 mentecatti, i reclusi erano 1.638 (Sul trattamento dei mentecatti ed in specie di quelli innocui ed incurabili,
in «Rivista della beneficenza pubblica», 1886, p. 807).
219
internamenti nei manicomi influivano ragioni di ordine generale: il più largo intervento pubblico per la custodia dei «mentecatti poveri», gli ospiti quasi esclusivi dei manicomi gratuiti, posti dalla legge comunale e provinciale del 1865 a carico delle province; il disgregamento delle famiglie patriarcali contadine e il passaggio alla famiglia nucleare, che rendeva più difficile il mantenimento dei membri non autosufficienti e provocava la loro espulsione dalle mura domestiche; la lenta modificazione dell’immagine del manicomio da luogo di pura detenzione, poco dissimile dal carcere, a istituto in cui ci si proponeva di curare il malato e possibilmente di guarirlo. Ma resta pur sempre il fatto che nelle regioni della pellagra la percentuale dei pazzi pellagrosi ricoverati nelle istituzioni manicomiali era assai consistente (al 1880 34,92% del totale degli internati nel Veneto, 15,40 in Lombardia, 11,04 in Emilia), e si faceva più cospicua negli istituti posti al centro di bacini di utenza largamente infestati dalla pellagra54.
La questione del rapporto tra follia e miseria aveva l’altra sua faccia principale nell’alcoolismo, che se nell’arco cronologico qui considerato non raggiunse livelli di gravità pari a quelli toccati in Inghilterra al tempo della gin mania o in altri paesi europei e negli Stati Uniti durante 1’ 800, pure aveva cominciato ad allarmare medici, sociologi, criminologi e politici per la sua natura di spia di un disagio e di un malessere sociali diffusi tra le classi subalterne e in qualche misura almeno collegabili ai mutamenti economici in atto nel paese. Il vino era in Italia un consumo dalle tradizioni millenarie al quale partecipavano in misura più o meno larga i ceti popolari, tra i quali era generale la convinzione che quella bevanda nutrisse, consentendo un minor ricorso ad altri alimenti, e che avesse effetti corroboranti,
come
del resto molti medici
continuarono a sostenere per tutto il XIX secolo. Così nel 1840 Andrea Bianchi, un medico lombardo sinceramente interessato agli aspetti sociali delle malattie delle classi lavoratrici, poteva affermare in un suo studio sull’ubriachezza che l’indole di alcuni lavori particolarmente pesanti costringeva l’operaio ad un regime per l’appunto «corroborante» il quale, non potendo consistere in un «nutrimento sostanzioso», doveva utilizzare il vino, oggetto di prima necessità per il lavoratore, dal momento che lo aiutava a «riposare le forze consunte dal lavoro»55; quasi trent'anni più tardi in un opuscolo divulgativo Carlo Livi sosteneva che «con un buon bicchiere di vino nello stomaco l’operaio può far a meno anche di qualche libbra di pane»56; e ancora nel 54. Gorni, op. cit., p. 205. 55. A. Bianchi, Della ubriachezza considerata negli operaj, e del modo di porvi riparo, in «Politecnico», Milano,
1840, vol. 3°, p. 143.
56. C. Livi, La vite, l’acquavite e la vita dell’operaio, Milano, 1868, p. 18.
220
1906, in un congresso scientifico sulle malattie professionali, Pietro Lussana
giustificava l’uso degli alcoolici nelle classi popolari perché un loro impiego moderato poteva fornire senza danno buona parte delle calorie necessarie all'organismo non ricavabili dalla dieta abituale, per concludere che l’esperienza popolare insegnava che «bevendo vino si mangia meno», considerazione che gli pareva tutt'altro che irrilevante in sede di bilancio delle famiglie operaie”. Ma il fatto nuovo che nell’800 caratterizzò, almeno nelle regioni del Nord, il consumo delle bevande alcooliche presso le classi popolari fu il massiccio incremento nell’uso dei distillati (specie l’acquavite), ben più pericolosi del vino dal punto di vista sanitario. Un momento di svolta nell’ uso delle acquaviti, relativamente poco diffuso sino agli inizi dell’80058, può essere collocato intorno alla metà del secolo, come conseguenza dell’invasione della crittogama che distrusse tanta parte dei vigneti dell’Italia settentrionale. La brusca impennata del prezzo del vino che ne seguì lo rese infatti una merce cara e spinse «le classi lavoratrici e povere» di quelle aree a rivolgersi alle acquaviti di patate, barbabietole, segale, frumento messe in circolazione a prezzi relativamente bassi da fabbricanti spesso di pochi scrupoli che non esitavano a ricorrere ad adulterazioni e all’impiego di sostanze nocive5?. L’acquavite insomma, come si legge in una realistica pagina del 1858, stava diventando un consumo di massa, attestato dal proliferare delle rivendite90 e delle rivendugliole girovaghe, che scambiavano la loro merce con «un pizzico di frumento, una scodella di grano-turco, un grembiale di patate o di farina, una matassa, un gomitolo di filo, un pajo d’uova, una libbra di lenticchie o di piselli» perché, proseguiva l’osservatore, «il contadino non va al campo, se non ha 57. P. Lussana, Alcool e lavoro muscolare, in «Atti» del 1° Congresso internazionale per le malattie del lavoro, 9-14 giugno 1906, Milano, 1906, p. 193. 58. Nel 1810 uno dei primi studiosi italiani dell’alcolismo, nel collegare l’aumento delle malattie all’uso dei «liquori spiritosi», osservava che «alcuni anni fa erano nomi ignoti alla più parte degli italiani il rum, il punch, il Kirschenwasser né la stessa acquavite era sì generalmente bevuta da ogni classe di persone» (P. Riccobelli, Quanto dannevole sia alla salute l’uso di be-
vande spiritose, e specialmente dell’acquavite, in «Commentari» della Accademia di scienze, lettere, agricoltura ed arti del dipartimento del Mella per l’anno 1810, Brescia, 1811, p. 55). 59. Tra le testimonianze al riguardo v. quella dell’«Eco della borsa», Milano, 6 novembre 1854. Lo stesso giornale, nel n. del 27 settembre 1856, tornava a lamentare che «il popolo, massime quello dei lavoratori», avesse preso l’abitudine «funesta» di consumare liquori alcoolici «estratti da materie di infimo valore», come le patate, la cui cultura si era per questo assai
estesa. 60. «Ci duole nell’animo — scriveva la mantovana “Lucciola” il 29 gennaio 1856 — lo scorgere come ogni giorno si moltiplicano nella città nostra, e nei paesi della provincia, bottegucce di liquori, e questi nuovi pseudo templi di Bacco vengono frequentati ogni dì più, aumentando così il numero degli ebbri di questa micidiale ebbrezza alcoolica» (art. di A.B., Nuova bevanda economica).
924 |
prima assaggiato l’acquavite...; non ha prima esilarato lo spirito l’asciolvere dei suoi ragazzini, d’acquavite»6!. Questa tendenza sai più pronunciata al Nord che
l’artigiano non apre la sua botteguccia, se coll’acquavite; la donnicciuola non allestisce se non ha prima bevuto di soppiatto un po’ alla sostituzione del vino con l’acquavite, asal Sud? e confermata da una nutrita serie di
testimonianze relative ai tre primi decenni postunitari, rallentò dopo il 1888,
quando in seguito alla guerra commerciale con la Francia, che bloccò le esportazioni vinicole italiane verso quel paese, i prezzi al minuto del vino presero a scendere (da L. 0,66 al litro, media nazionale del quinquennio 1871-75, a L. 0,51, media del quinquennio 1891-95), permettendo così una sua più larga utilizzazione, pur in presenza di un consumo di distillati sempre sostenuto93. La dislocazione prevalentemente settentrionale attribuibile all’alcoolismo sulla base della distribuzione regionale del consumo dei distillati parrebbe confermata dalle cifre relative ai ricoveri per psicosi alcooliche nei manicomi del Regno, cifre che indicavano — a partire dalle prime rilevazioni del 1874 e nella decisa progressione attestata dalle successive statistiche — una netta prevalenza del fenomeno nelle regioni del Nord. Ma siamo di fronte a un dato troppo limitato, relativo ai soli casi di alcoolismo acuto e cronico, e troppo grezzo, dal momento che esso è da mettere in relazione — anche questa volta
— soprattutto con la densità delle istituzioni ospedaliere e psichiatriche, e dal quale non si possono quindi far discendere facili generalizzazioni, che diventeranno attendibili soltanto quando si disporrà di una più ampia serie di ricerche locali basate sulla documentazione archivistica degli ospedali, dei manicomi e delle province95. E lo stesso discorso vale per la correlazione, spesso affermata,
tra alcoolismo
da una
parte e urbanesimo
e industrializzazione
dall’altra, che resta per il momento un’ipotesi: un’ipotesi però suggestiva e confortata da vari elementi. 61. «Regolatore amministrativo», Milano, 11 gennaio 1858 (art. L’acquavite). 62. Secondo E. Raseri (Materiali per l’etnologia italiana raccolti per cura della Società italiana di antropologia ed etnologia, in «Annali di statistica», s. 28, vol. 8°, 1879, p. 75) il consumo medio individuale annuo di alcool e liquori era di litri 4,1 nelle città della Lombardia e di litri 3,4 in quelle del Veneto, mentre era di litri 1,7 nelle città del Mezzogiorno continen-
tale e di litri 0,55 in quelle siciliane. 63. M. Figurelli, L’alcool e la classe. Cenni per una storia dell’alcoolismo in Italia, in «Classe», giugno 1978, n. 15, pp. 97 sgg. 64. Alla media annua dei 280 ricoveri nei manicomi di Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto registrata nel quinquennio 1883-87 facevano riscontro i 12 ricoveri del Mezzogiorno continentale e i 3 della Sicilia (ibidem, p. 115).
65. Si veda, per il Veneto, L'Archivio della follia. Il manicomio di S. Servolo e la nascita di una Fondazione. Antologia di testi
e documenti a cura di M. Galzigna e H. Terzian, Vene-
zia, 1980, e per Milano e il Milanese De Bernardi, Pellagra e alcoolismo..., cit., pp. 273 sgg.
222
Anzitutto — tra questi — la spinta ad allargare l’area di una lenta intossicazione «voluttuaria» che poteva venire agli operai di fabbrica dai ritmi e dalla disciplina imposti dalla progrediente organizzazione capitalistica del lavoro; poi le modificazioni introdotte dagli orari e dalle modalità del regime di fabbrica nelle forme di consumo del pasto diurno, che avveniva sempre più spesso fuori di casa e quindi anche all’osteria; e infine il bisogno di luoghi di socializzazione diversi dalle stanze anguste e disadorne dell’abitazione tipica dell’operaio, dove si facevano spesso difficili gli stessi rapporti di convivenza domestica: bisogno che stimolava la moltiplicazione di bettole, cantine, osterie, fiaschetterie, mescite, «trani», scena di un consumo di alcoolici che si dispiegava per tutti i giorni della settimana e che quindi presentava margini di rischio sociale più elevati che non l’alcoolismo essenzialmente «domenicale» dei contadini. Nel profilo depresso della sanità pubblica italiana trovano il loro posto anche due morbi endemici associati tra loro, il cretinismo e il gozzo, fatti 0ggetto dall’inizio dell’800 di ricerche sistematiche da parte di medici e di autorità di governo per il loro pronunciato addensamento in zone circoscritte (soprattutto dell’arco alpino) che li rendeva particolarmente evidenti. Nelle vallate e nelle montagne del Piemonte e della Lombardia agivano infatti, con
effetti moltiplicati dalla loro concomitanza, quei fattori eziologici che le ricerche moderne hanno individuato con sufficiente sicurezza nell’insorgere delle due endemie: vale a dire, per il gozzo, la carenza di apporto iodico (imputabile alla qualità delle acque potabili) e l'eccessiva assunzione di sostanze gozzigene dovuta a un’alimentazione nella quale avevano grande parte vegetali come i cavoli e le rape, ricchi per l’appunto di quelle sostanze; e per il cretinismo la carenza iodotironimica correlata al gozzo endemico e alla carenza di iodio, insieme ai fattori di degenerazione ereditaria la cui trasmissione era favorita dall’isolamento tipico delle comunità alpine99. Circa i dati quantitativi (che, ancora una volta, non possono che suggerire una dimensione approssimata dei fenomeni), dopo che l’inchiesta governativa piemontese del 1848 aveva individuato negli Stati sardi la presenza di circa 7.000 affetti da cretinismo e 22.000 gozzuti (localizzati quasi tutti nella Valle d’ Aosta, nelle valli della Dora Baltea, dell'Isère, dell’ Arvo e dell’Orco, nelle
zone più elevate dei circondari di Cuneo, Saluzzo, Pinerolo, e nell’alta Savoia, nella Moriana e nella Tarantasia), la prima indagine effettuata dopo l'Unità, quella promossa dall’Istituto lombardo di scienze e lettere, accertò la
presenza in Lombardia al 1861 di più di 3.000 cretini, addensati nella fascia 66. Cfr. E. Melossi, Gozzo e cretinismo nelle vallate alpine, in Timore e carità. I poveri nell’Italia moderna. Atti del convegno «Pauperismo e assistenza negli antichi Stati italiani» (Cremona, 28-30 marzo 1980), Cremona,
1982, pp. 391-397.
223
alpina. Una successiva inchiesta ministeriale, i cui dati si riferivano al 1883, individuò circa 13.000 affetti da cretinismo (7.506 in Lombardia, 4.718 in
Piemonte e 658 nel Veneto), correggendo i dati del censimento del 1881, che aveva sottostimato il fenomeno; mentre per il gozzo vennero rilevati circa 129.000 casi, concentrati in grande prevalenza in Lombardia (106.000)97. E della rilevanza di questa endemia nella fascia alpina davano conferma le cifre degli inabili al servizio militare per gozzo e «gola grossa» del periodo 1863-76: su circa 2 milioni di coscritti visitati gli scartati erano stati circa 43.000, il 20,9 per mille, ma con percentuali del 317 per mille nel circondario di Aosta e del 263 per mille nella Valtellina®8. Alla fine di questo sguardo generale sulle condizioni sanitarie del Regno è opportuno un richiamo alla materia delle malattie professionali, le affezioni derivanti cioè dalle modalità tecnico-produttive in cui si svolgevano le mansioni, dalla nocività degli ambienti di lavoro o delle sostanze lavorate, dall’eccessiva erogazione di forza-lavoro richiesta specialmente alle categorie più deboli e indifese come le donne e i fanciulli. È questo un tema sul quale un settore della ricerca consapevole della molteplicità dei piani di una storia del movimento operaio globalmente considerata ha preso a lavorare con utili risultati99. Si è così insistito, tra l’altro, sul deterioramento delle condizioni di
vita degli strati di lavoratori coinvolti dall’avanzare dell’industrialismo manifestatosi con più vigore a partire dagli anni ‘40 dell’800 nelle regioni settentrionali, e sulla riflessione portata su questi aspetti del mondo del lavoro già prima del ’60 (e in alcuni casi anche prima del ’48) da studiosi di problemi sociali e da medici sensibilizzati dalla dura realtà delle concrete situazioni specifiche. E basterà ricordare, tra i primi, un Lorenzo Valerio o un Giuseppe Sacchi, i quali misero rispettivamente l’accento
sulla allarmante
situazione
dei lavoratori delle «seterie» e sulle conseguenze negative che per la salute dei fanciulli occupati nelle manifatture avevano gli orari protratti sino a notte inoltrata, l’insalubrità dei locali e la «monotonia» del lavoro; e tra i secondi,
Giovanni Melchiori, Ferdinando Tonini e Serafino Bonomi, pionieri di quelle igiene e medicina del lavoro che si sarebbero consolidate come discipline autonome alla fine del secolo. Le proporzioni di quello che, impiegando un’espressione di Marx, è stato chiamato anche in Italia il «genocidio pacifico», sono state studiate a fondo proprio per il periodo che qui ci interessa?0; e non vale la pena di insistere sui 67. Studio sulle endemie del gozzo e del cretinismo, in Ministero di agricoltura, industria e commercio, «Annali di agricoltura», vol. 100°, 1887, pp. 19-20. 68. Sormani, op. cit., pp. 161-162.
69. Cfr. L. Dodi, / medici e la fabbrica. Prime linee di ricerca, in «Classe», giugno 1978, n. 15, pp. 21 sgg. 70. S. Merli, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano. 1880-1900, Firenze, vol. 1°, pp. 277 sgg.
224
dati e sulle testimonianze, assai ricchi per i settori trainanti dello sviluppo industriale del tempo, quello tessile e quello metalmeccanico, più legati all’avanzare del modo di produzione capitalistico. Nel filo di un discorso che cerchi di non trascurare i motivi della continuità e della permanenza basteranno invece pochi richiami esemplificativi a situazioni marcate piuttosto dal primitivismo imprenditoriale e dall’arcaismo tecnologico. Così alla nocività delle lavorazioni effettuate nelle ferriere del Lecchese si dovevano, secondo una relazione del 1861 del medico Luigi Sacchi, il deperimento fisico e mentale di quegli operai, descritti «quali torti nelle gambe, tal’altri aventi gozzi voluminosi e poco sviluppati nelle facoltà mentali, ... quasi tutti... presentanti tracce di fisico decadimento»”!. All’estremo opposto della penisola, le conseguenze della durezza sfibrante del lavoro nelle zolfare siciliane, gravante essenzialmente su «carusi» e «catastonara», assai spesso fanciulli impiegati per 10 ore negli anditi oscuri e nelle scale tortuose delle miniere del Nisseno e dell’ Agrigentino, facevano sì che uno degli intervenuti nella discussione del 1877 al Senato su uno dei progetti di «codice sanitario» parlasse, riferendosi al comune di Lercara, di una «generazione contorta, nana e bislacca e dalla breve vita media»?2; valutazione che poteva essere estesa a tutte le zone minerarie dell’isola, come basta a dimostrare un solo dato, quello relativo agli
zolfatai della provincia di Caltanissetta dichiarati abili nelle visite di leva degli anni 1881-84, che furono soltanto 253 su 3.67273. E venendo ai minatori dell’Iglesiente (circa 15.000 alla fine del secolo), la loro fatica per un insieme di fattori — polveri di minerali, gas tossici, umidità e variabilità della temperatura, uso estensivo del cottimo, ecc. — era segnata da un tasso assai elevato di
nocività che determinava l’insorgenza di malattie circolatorie e respiratorie e di anemia, saturnismo, anchilostomiasi, con drastiche ripercussioni sulla du-
rata della vita media?4. 71. L. Sacchi, Relazione sulla causa delle malattie più frequenti nei lavoratori delle ferriefisio-medico-statistica di Milano», 1860-61, 2A ° 72. Intervento di C. Maggiorani al Senato (A. p., Senato, Discussioni, sessione 1876-77, tornata del 6 dicembre 1877, p. 1924; il Maggiorani si servì di dati comunicatigli da Alfonso Giordano, il medico di Lercara che combattè una lunga battaglia per denunciare l’inumanità delle condizioni di vita dei lavoratori delle zolfare). Secondo i prospetti allegati al progetto di legge sul lavoro dei fanciulli presentato dal ministro Berti al Senato il 31 gennaio 1884, sui circa 19.000 operai che lavoravano nelle miniere di zolfo siciliane 5.655 avevano meno di 14 anni; in base ad altri dati, relativi al 1885, su circa 29.000 solfatai i fanciulli di meno di 14 anni sarebbero stati 8.500. (I. Santangelo Spoto, Gli operai solfatari in Sicilia, in «Rassegna nazionale», 1° dicembre 1888, vol. 44°, p. 385). 73. A. Mosso, La fatica, Milano, 1891, pp. 193 sgg. 74. B. Murgia, Industria mineraria e minatori in Sardegna, tesi di laurea discussa nella Facoltà di lettere e filosofia dell’ Università degli studi di Milano nell’anno accademico 1974-75. re nel territorio di Lecco, in «Atti dell’ Accademia
225
L’insieme degli elementi negativamente connotati sui quali si è sin qui insistito ha una sorta di riprova complessiva nelle informazioni ricavabili dalla cosidetta «antropometria militare», cioè dall’insieme di dati sulla condizione
fisica e lo stato di salute della popolazione maschile al ventesimo anno di età
che veniva sottoposta alla misurazione della statura e alla visita medica di leva, dati forniti dalle relazioni annuali del Ministero della guerra?5. Colpisce anzitutto in queste informazioni (sufficientemente attendibili perché fondate su un campione largamente rappresentativo e su valutazioni di un personale medico che si ispirava a criteri abbastanza omogenei) l'alto numero dei riformati per difetto di statura: il 12,13% dei coscritti «misurati» nelle leve eseguite dal 1863 al 1876 e relative ai nati dal 1843 al 185679, e 1 11,8% dei
«misurati» nelle leve del 1880 e del 1881. Una percentuale così elevata indusse nel 1882 le autorità militari a ridurre il minimum della statura richiesta ai coscritti per essere dichiarati abili da m 1,56 a m 1,54, decisione che negli
anni seguenti fece abbassare la proporzione dei riformati per quella causa a valori al di sotto del 10%77. Altrettanto impressionante appare poi il numero dei giovani dichiarati inabili per malattia o imperfezione, a prescindere dalla statura: il 36,1%
dei coscritti nati nel 1846-50,
il 29,7%
di quelli nati nel
1851-55, il 20,3% e il 19,5% di quelli nati rispettivamente nel quinquennio 1856-60 e nel quadriennio
1861-64; con una diminuzione dei valori percen-
tuali attribuibile soltanto in minima parte a un miglioramento delle condizioni sanitarie della popolazione, perché essa dipendeva invece dai mutamenti introdotti nelle disposizioni relative all'esenzione dal servizio militare per infermità con l’intento di rendere più difficile la riforma?8. Una valutazione esauriente della risposta, sostanzialmente inadeguata ed elusiva, che l’insieme di problemi e situazioni fin qui descritti poteva trovare sul piano delle strutture assistenziali e sanitarie richiederebbe un esame approfondito della trama di opere pie, istituzioni benefiche, ospedali, ricoveri che, costruita e alimentata nel corso dei secoli dalla carità «privata» e incrementata dall’intervento via via più largo di quella pubblica, copriva il paese con la sua variegata tipologia, esame che non può essere condotto in questa sede??. Qui ci si propone invece, più limitatamente, di enucleare gli orienta75. Ministero della guerra, Della leva sui giovani nati nell’anno
1843, e delle vicende
dell’esercito dal 10 ottobre 1863 al 30 settembre 1864 (e anni sgg.), Torino, Firenze, Roma,
1865 (e anni sgg.). 76. In cifre assolute 282.993 su 2.233.288 (cfr. Sormani, op. cit., p. 58). 77. Direzione generale della statistica, Risultati dell’inchiesta sulle condizioni... Relazione generale, cit., p. LXKXVII. 78. Ibidem, pp. LKXXII-LXXXIV. Per un caso di studio locale v. B. Farolfi, Una critica antropometrica dell’industrialismo: i riformati alla leva a Bologna (1862-1886), Bologna, 1979. 79. Sul tema delle «opere pie» mi riprometto di tornare in un saggio di prossima pubblicazione.
226
menti e le caratteristiche di fondo della politica sanitaria del giovane Stato italiano, tenendo soprattutto presenti l’assetto normativo realizzato con l’unità e i propositi e i tentativi di modifica e di riforma di quell’assetto succedutisi sino all'approvazione della legge Crispi del 22 dicembre 1888. L’amministrazione sanitaria e la sanità pubblica del Regno d’Italia furono regolate per quasi tre decenni dalla legge Rattazzi del 20 novembre 1859, entrata inizialmente in vigore negli Stati sardi e nell’annessa Lombardia, e dalla legge del 20 marzo 1865 (n. 2248, allegato C), che riprendeva pressocché testualmente la legge Rattazzi. Si può applicare anche alla legge del 1859 l’osservazione sulla strettissima continuità che attraverso quella si venne a stabilire con le preesistenti istituzioni politico-amministrative dello Stato sardo valida per la legge Rattazzi sull’ordinamento comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, perché le disposizioni emanate il 20 novembre (proprio l’ultimo giorno dei poteri straordinari) erano a loro volta ricalcate sulla normativa che in materia sanitaria il Piemonte si era dato con il r. editto del 30 ottobre 1847 e con la legge 12 maggio 1851. La tutela della sanità pubblica continuava così ad essere de-
mandata all’esecutivo, nelle persone del ministro dell’interno e dei suoi rappresentanti periferici (governatori, intendenti, sindaci). L’accentramento che ne derivava avrebbe potuto essere temperato dalla catena di consigli che erano stati previsti: il Consiglio superiore di sanità, e quelli provinciali e circondariali, chiamati ad «assistere» rispettivamente il ministro, i governatori e gli intendenti; ma il carattere non elettivo di questi organismi (i cui membri era-
no nominati dal re per quel che riguarda il Consiglio superiore e quelli provinciali, e dal ministro dell’interno per quanto concerne quelli circondariali) e la loro funzione rigidamente consultiva ne riducevano in maniera drastica l’autonomia, mentre la loro operatività era limitata da un lato dalla ristrettez-
za e dall’altro dall’imprecisione delle competenze assegnate. I consigli, composti in varia misura di medici e di esperti in materie giuridiche e amministrative e non collegati per via gerarchica tra di loro, erano infatti genericamente chiamati a sorvegliare la «conservazione della sanità pubblica», attendendo in particolare alla vigilanza sulle convivenze (ospedali, carceri, scuole) e sulle professioni ed attività attinenti al campo sanitario (dal medico al fabbricante di acque minerali o di birra). La scelta accentratrice del sistema piemontese era stata del resto affermata esplicitamente durante la discussione svoltasi al Parlamento subalpino nel 1857 sul progetto, rimasto tale, di riforma sanitaria di Rattazzi; in quell’occasione la relazione della Commissione senatoriale, dopo essersi posta la domanda se non sarebbe stato più proficuo che il governo rinunciasse a interessarsi direttamente degli atti dell’amministrazione sanitaria per assegnare invece «arbitrio e facoltà larghissime» ai comuni, rispondeva negativamente, perché la somma di quella amministrazione 227:
doveva raccogliersi e incentrarsi nella persona del ministro, «a cui, secondo si conviene a regime costituzionale, è dato il governo e l’indirizzo principale di tutte le provvidenze»80. Il sistema delineato alla fine del 1859 trascurava inoltre i punti terminali dai quali avrebbe dovuto proiettarsi a livello locale l’azione igienico-sanitaria pubblica, vale a dire i comuni (e specie quelli grandi e medi), perché la legge non prevedeva né un medico né un consiglio sanitario comunali, che avrebbero potuto affiancare il sindaco nell’incarico a lui affidato di vegliare all’ «osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria» nel proprio comune; e del resto anche i poteri di intervento dei sindaci apparivano piuttosto ristretti, perché ad essi spettavano limitate attribuzioni di vigilanza igienica in materia di alimenti e bevande e di abitazioni e luoghi pubblici. Questo ultimo limite, che accentuava l'inadeguatezza dell’assetto così stabilito dinnanzi ai problemi che sarebbe stato chiamato a fronteggiare, era infine aggravato dal fatto che la legge Rattazzi sull’ordinamento amministrativo non aveva incluso tra le spese obbligatorie dei comuni quelle relative al servizio sanitario gratuito per i poveri, e in particolare al medico condotto. I pericoli derivanti da tale omissione furono rilevati con prontezza soprattutto in Lombardia, dove nei precedenti decenni era stata creata una capillare struttura assistenziale a favore dei malati poveri, imperniata sulla condotta medica. Questa secolare istituzione, che sebbene conosciuta in tutto il paese aveva avuto la sua più larga diffusione nel Granducato di Toscana e soprattutto nel Ducato di Milano nella seconda metà del °700 e che il napoleonico Regno d’Italia aveva cercato di estendere in tutte le sue province, durante la Restaurazione venne posta dall’ Austria alla base dell’ordinamento sanitario del Lombardo-Veneto. La materia aveva trovato una prima sistemazione legislativa complessiva nei «capitoli normali» del 30 aprile 1834, una sorta di testo unico che mirava a dare uniformità all’assistenza medica imponendo ai singoli comuni (0 ai consorzi di più piccoli comuni) l’obbligo di stipendiare, con il gettito della sovrimposta fondiaria, uno o più medici o medici-chirurghi. La forma adottata era quella della condotta «di servizio caritativa» che prevedeva, a differenza di quella «piena», le cure del medico per i soli poveri iscritti nel «ruolo» apposito compilato annualmente dalle amministrazioni locali con la collaborazione dei parroci; la nomina del condotto spettava, sulla base di un concorso, ai consigli o ai convocati comunali, che avevano con il sanitario un rapporto contrattuale della durata di un triennio, rinnovabile via via per successivi trienni. I capitoli definivano poi in maniera più organica la figura professionale del medico condotto, al quale venivano attribuiti — rac80. A. p., Documenti, 5° Legislatura, sessione del 1857, p. 708.
228
cordandoli con quelli dei medici distrettuali e provinciali - anche compiti di sorveglianza e di intervento sulla sanità pubblica (effettuazione della vaccinazione antivaiolosa, attivazione di misure preventive e curative in caso di epidemie, vigilanza contro gli abusi nell’esercizio della medicina). L’ordinamento sanzionato nel 1834 aveva un difetto centrale, la posizione subalterna e precaria in cui il medico condotto era lasciato di fronte all’amministrazione comunale, soprattutto nei comuni rurali, dove nomina e conferma erano competenza del «convocato», l'assemblea degli «estimati». E proprio su questo nodo si appuntò una lunga serie di interventi polemici resi pubblici dalla stampa periodica, nei quali la condizione dei medici condotti era paragonata a quella dei servitori, dal momento che alla scadenza del triennio potevano essere licenziati o per «capriccio» dei loro giudici, o per il gioco al ribasso dei sanitari più giovani disposti a offrire i loro servigi per uno stipendio minore8!. Le modalità delle nomine costringevano infatti in molti casi 1 concorrenti a una avvilente «caccia al voto», che specie nei comuni rurali, dove a decidere erano i possidenti riuniti in assemblea, assumeva i connotati così descritti a tinte forti da una delle tante testimonianze: Taccio le frequenti e numerose visite di dovere, e il doversi ingojare in esse tante scempiaggini e filastrocche, che muovono a stomaco, e che que” villici, a cui non par vero d’essere complimentati e pregati e supplicati da un signore in abito nero, vi sciorinano largamente: taccio ancora tant’altre noje, non posso tacere i premj o voluti o estorti e spesso anche offerti in gozzoviglie o in denari agli integerrimi patres conscripti, gli obblighi che parecchi s’assumono di non cercar compensi da chi per legge vi è tenuto, di provvedersi da loro il mezzo di trasporto in onta della tenuità dello stipendio, e altrettali gravosi oneri che molti s’addossano per trovar pur modo di sca-
valcare i competitori82. Inoltre la concorrenza, dovuta al numero crescente dei laureati che usciva-
no dalle facoltà mediche di Pavia e Padova, contribuiva a tenere relativamente bassi gli onorari annui, la cui fascia mediana (la più ampia) oscillava tra le 1.000 e le 2.000 lire, con poche punte al disopra (e in questo caso il medico doveva provvedere al mantenimento di un «celere mezzo di trasporto») e molte al disotto83. Né, come si è visto, riusciva sempre agevole ai titolari del-
81. G. Comolli, Delle condotte mediche, chirurgiche ed ostetriche..., cit., p. 320. 82. A. Marziali, Sui medici condotti..., cit., pp. 165-166. 83. A. Tassani, medico provinciale di Como, dava per il 1851 questi dati relativi alle 123 condotte «foresi» della sua provincia: in 15 gli stipendi superavano le 2.000 lire annue, senza arrivare alle 3.000; 39 comuni assegnavano onorari compresi tra 1.500 e 2.000 lire; in 38 gli emolumenti andavano dalle 1.000 alle 1.500 lire, mentre nelle restanti 31 gli stipendi erano inferiori alle 1.000 lire (Osservazioni su l’esercizio sanitario nella provincia comense, in «Gaz-
zetta medica italiana. Lombardia», 24 maggio 1852, p. 181).
229
le condotte integrare le proprie entrate con le parcelle delle cure prestate ai malati non poveri, perché in molti comuni era opinione generale che il condotto fosse tenuto a dare la sua opera gratuitamente a tutti gli abitanti, e quindi, come riferiva un altro osservatore, «o apertamente gli viene negato l’elenco dei poveri o ad arte la compilazione sua si prolunga fino alle calende greche, ovvero gli si dà un illusorio elenco, dove... figurano come miserabili gente che vive comodamente»84. E in questa situazione economica che poteva farsi a volte difficile ed era aggravata della mancanza della prospettiva di una pensione (situazione che Arnaldo Fusinato sintetizzò efficacemente nel ritornello di una sua famosa poesia: «Arte più misera, arte più rotta / non c’è del medico che va in condotta») non era strano che molti medici si dessero ad altre attività, facendosi volta a volta commercianti di legnami, di uve, di bozzo-
li o conduttori di qualche piccola azienda agricola, presa in affitto o acquistata con la dote della moglie85. Le crescenti proteste della categoria alla fine indussero però le autorità austriache a cercare un seppur tardivo rimedio, e così il 31 dicembre 1858 l'arciduca Massimiliano Ferdinando emanò per i medici-chirurghi condotti del Regno lombardo-veneto uno «statuto» che, pur non conferendo loro lo status di impiegati comunali a pieno titolo, concedeva la tanto sospirata stabilità al termine di sei anni di prova, introduceva il diritto
a una pensione commisurata al periodo di servizio prestato, e fissava uno stipendio minimo annuo di 400 fiorini. Ma, al di là degli inconvenienti cui si è appena accennato, resta comunque fermo che alla vigilia dell’annessione la Lombardia (con il Veneto) poteva contare su un servizio di medicina gratuita che la poneva all’avanguardia del paese. A parte il fitto intreccio nelle città e nei centri maggiori di istituti ospedalieri e di luoghi pii per l'assistenza a domicilio dei malati poveri la regione disponeva nel 1857, a fronte di 649 liberi professionisti, di 1.278 tra medici,
medici-chirurghi, dottori in chirurgia, maestri di chirurgia e chirurghi minori (ma queste tre ultime categorie, le meno qualificate, contavano soltanto 268 unità) al servizio delle condotte comunali e di altri 468 sanitari posti alle dirette dipendenze dello Stato od operanti nelle istituzioni caritative pubbliche o addetti al servizio promiscuo di luoghi pii e di condotte comunali; mentre delle 1.913 levatrici patentate ben 1.278 svolgevano le loro mansioni con un patto di condotta86. Cifre che acquistano un significato più chiaro qualora le si 84. In «L’Abduano», Lodi, 15 novembre 1855. 85. Cfr., tra l’altro, gli articoli Sulla condizione dei medici condotti (di anonimo), in «Gaz-
zetta medica italiana. Lombardia», 6 maggio 1850, p. 90, e Delle risorse dei medici chirurghi condotti di campagna (a firma B.C.), ibidem, 9 aprile 1860, pp. 123-124. 86. G.L. Gianelli, Gli infermi poveri dei comuni lombardi e la nuova legge 23 ottobre 1859 sull’amministrazione comunale, in «Atti dell’i.r. Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti», Milano, 1860, vol. 2°, pp. 232-233.
230
metta a confronto con quelle degli Stati sardi, le quali pongono in evidenza l’arretratezza di un ordinamento sanitario cui pure nei primi anni dell’unificazione la classe politica si richiamò per estenderlo al resto del paese. La carenza principale del sistema piemontese non stava nell’insufficienza del personale sanitario ma nella sua cattiva distribuzione, dovuta alla scarsità delle condotte, specie rurali, la cui istituzione era lasciata alla discrezione delle amministrazioni locali e non veniva incoraggiata dalle autorità centrali. La conseguenza era il concentramento del personale sanitario nelle città messo in luce dai dati statistici relativi al 1849 (ma nel decennio successivo non si ebbero modificazioni di fondo): dei 2.836 laureati in medicina e chirurgia della terraferma 884 esercitavano infatti nei 42 centri maggiori (giustificando così l’adagio, di origine evidentemente cittadina, «ci son più medici che ammalati»); gli altri 1.952 erano invece sparsi in 2.647 comuni rurali o minori,
ma anche qui con forti sperequazioni, perché in 1.682 di quelle comunità non esistevano laureati in medicina. Quanto alla Sardegna, al 1° gennaio 1857 dei suoi 361 comuni (con 550.000 abitanti) soltanto 64 disponevano di un servi-
zio medico «compiuto» (cioè medico o medico-chirurgico), mentre i quasi 200.000 abitanti di altri 234 comuni non avevano alcun servizio medico o soltanto quello dei flebotomi e dei barbieri, e venivano perciò curati con salassi indiscriminati o con dosi massicce di purganti, di emetici (il tartaro stibiato) e di rivulsivi (le cantaridi)8?. L'applicazione della legge amministrativa del 23 ottobre 1859, che come si è ricordato non imponeva alle amministrazioni comunali l’obbligo della spesa per il personale sanitario (e che in Lombardia era stata preceduta da una circolare del governatore Vigliani del 3 agosto con la quale era stato abolito lo statuto dell’arciduca Massimiliano, ponendo nell’incertezza la disciplina del servizio medico gratuito e rendendo possibile in prospettiva una sua contrazione88), ritardò per alcuni anni la diffusione generalizzata del sistema delle condotte, soprattutto là dove — come nelle province dell’ex Stato pontificio e in quelle meridionali8° — la loro rete era ancora a maglie larghe. Fu infatti solo con la legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 che venne imposto 87. P. Castiglioni, Dell’ordinamento del servizio sanitario in Piemonte. Cenni storici e statistici e proposte, Torino, 1857, pp. 52 sgg. 88. Per le prese di posizione dei medici lombardi contro la circolare Vigliani v. (oltre a Gianelli, op. cit.) G. Strambio, Sull’organizzazione sanitaria in Italia, in «Il Politecnico», Mi-
lano, 1862, vol. 14°, pp. 248-249, che definiva il provvedimento «deplorabile» e «portato della più arcadica ignoranza». 89. Per cenni sommari sulla storia del servizio sanitario nelle varie regioni prima dell’unità cfr. il rapporto di P. Castiglioni al Congresso dell’ Associazione medica italiana del 1862 (Atti del secondo Congresso dell’Associazione medica italiana tenutosi in Napoli nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 7,8 e 9 settembre 1863, Napoli, 1863, pp. 89 sgg.).
231
ai comuni l’onere finanziario del servizio sanitario; e sia pure tra ritardi e resistenze fu così possibile muovere decisi passi avanti sulla strada della generalizzazione delle condotte mediche, presenti nel 1882 in quasi 7.600 comu-
ni, per cui nel 1885 dei circa 17.600 sanitari che esercitavano la professione quasi la metà (8.585) prestavano servizio in qualità di medici condotti. La struttura portante dell’edificio della legislazione sanitaria italiana venne completata con la pubblicazione del regolamento esecutivo dell’8 giugno 1865, poi sostituito da quello del 6 settembre 1874, che ne ricalcava con alcune modifiche le linee di fondo. L'innovazione di maggior rilievo era l’istituzione delle commissioni municipali di sanità, elette dal consiglio comunale e presiedute dal sindaco; tali commissioni, «corpi meramente consultivi», dovevano avere per segretario un medico condotto, ed erano chiamate ad assistere il sindaco nel disimpegno del servizio sanitario, curando in particolare la sorveglianza sull’«esatto adempimento dei regolamenti locali di igiene pubblica e di polizia igienica dei cimiteri» e vigilando sulla sanità di scuole, ospedali e istituti di carità. Dopo aver specificato più dettagliatamente le attribuzioni
delle varie autorità amministrative,
con
un ampio
«titolo»
sulla
pubblica igiene il testo demandava al sindaco la cura dell’esatta osservanza del regolamento comunale d’igiene (indicando le prescrizioni essenziali che quello doveva contenere relativamente alla salubrità delle abitazioni e dei luoghi abitati) e dettava una serie di norme i cui oggetti andavano dagli alimenti posti in commercio, alle sepolture e ai cimiteri, alle malattie endemiche ed epidemiche, agli ospedali e all’esercizio delle professioni sanitarie. Ma nonostante il tentativo del regolamento di dare contenuti più determinati alla legge del 1865, molti furono gli aspetti negativi e le carenze di quella normativa che vennero via via emergendo nel corso degli anni. Anzitutto l’intervento pubblico era contenuto in limiti assai ristretti, giusta quell’ispirazione — comune a tanta parte della Destra storica — che nel settembre 1866 faceva dire al presidente del consiglio Ricasoli (in una relazione per la nomina di una commissione incaricata di elaborare un nuovo disegno di legge sulla sanità pubblica) che l’ingerenza del governo e delle autorità locali negli atti amministrativi sanitari doveva rispettare il più possibile la «libertà privata» e non ledere od ostacolare «il libero esercizio delle proprietà e delle forze individuali»?!, 90. E. Raseri, Le condotte mediche in Italia, in «Rivista della beneficenza pubblica», 1882,
pp. 823 sgg.; id., Des médecins communaux en Italie, in Les institutions sanitaires en Italie, cit., pp. 132 sgg.; Direzione generale della statistica, Risultati dell’inchiesta sulle condizioni... Relazione generale, cit., pp. CXKLIX-CL. 91. Il testo della relazione è riprodotto in «Annali di medicina pubblica», Firenze, 30 novembre-10 dicembre 1866, p. 162.
232
E a proposito di questa ottica «liberale» una rapida esemplificazione può anzitutto ricordare le motivazioni con cui nel 1870 veniva di fatto resa facoltativa la vaccinazione antivaiolosa. Lo schema ministeriale per i regolamenti comunali di igiene pubblica del 6 settembre 1870 aveva bensì esteso l’obbligo della vaccinazione a quanti dovevano essere ammessi nelle fabbriche o manifatture esistenti nel comune, ma subito dopo la disposizione venne soppressa perché, sostennero le autorità ministeriali, essa dava luogo a una inframmettenza nelle azioni dei privati che «urtava naturalmente con la libertà individuale». In tema di abitazioni private, poi, la legge del 1865 non andava oltre l’autorizzazione ai sindaci di «dare gli ordini opportuni... al fine di rimuovere le cause d’insalubrità al vicinato»; e anche il regolamento — che conteneva prescrizioni relative alle sole case da costruire93 — continuava a tacere sulle situazioni antiigieniche che potevano toccare da presso, oltre al vicinato, gli stessi inquilini. Per quanto concerne poi l’igiene dell’alimentazione la vigilanza affidata ai sindaci era circoscritta ai cibi e alle bevande «posti in commercio»
in stato di alterazione e di corruzione; formula riduttiva, che
escludeva da ogni controllo la vasta area di pagamenti di forza-lavoro effettuati in natura nelle campagne, come la così detta «spesa» nella pianura irrigua lombarda, o le anticipazioni in generi fatte dai proprietari ai contadini, o gli approvvigionamenti di grani presso mugnai ben determinati ai quali molti contadini erano obbligati da conduttori di fondi disonesti che con quei mugnai avevano stipulato accordi vantaggiosi: tutti casi in cui il frumento e il granturco erano della qualità peggiore e spesso avariati. Per non parlare delle pratiche imparentate con il truck-system, diffuse con una relativa ampiezza, come accadeva nelle piccole fabbriche per la produzione di chiodi sparse nelle valli bergamasche e bresciane, nelle quali i padroni davano lavoro soltanto agli operai disposti a rifornirsi presso il magazzino del proprietario di «farine alterate, caci e salumi marci e vini guasti»9; o come
si verificava in alcune
zone risate, dove i contadini erano obbligati dai padroni a comperare al prezzo di mercato del pane di buona qualità un «pane muffaticcio composto di grani avariati e guasti, e mescolati coi semi del miglio palustre, o con altri 92. Martino, op. cit., p. 172.
93. L’art. 46 del regolamento stabiliva che i regolamenti comunali dovevano curare l’osservanza delle seguenti disposizioni: «a) che le case siano edificate in guisa che non siavi difetto di aria e di luce; b) che siano provviste di latrine ...; c) che gli acquai e gli scaricatoi delle acque immonde e residue degli usi domestici siano costruiti e situati in maniera da non pregiudicare e guastare i pozzi; d) che le case, o parte di esse, costrutte o restaurate, non possano essere abitate prima che siano dichiarate abitabili dalla Giunta comunale, sentita la Commissione municipale di sanità» (ibidem, p. 10). 94. A. Armanni, Beneficenza ed igiene, cit., pp. 419-420.
289
cereali corrotti e stati rifiutati dai pubblici mercati». Tra gli altri limiti di fondo del sistema di amministrazione sanitaria impiantato tra 59 e ’65 vanno poi segnalate le difficoltà per realizzare un funzionamento agile e produttivo dei consigli provinciali e circondariali, che dovevano fare assegnamento sulla collaborazione a titolo gratuito di persone già impegnate nelle loro attività professionali, e quindi non sempre facilmente disponibili per un lavoro collegiale spesso poco gratificante, come quello di fornire pareri non vincolanti su pratiche — e non sempre di grande rilievo — istruite dagli uffici ministeriali o dalle prefetture e sottoprefetture9. Questi consigli, che già negli Stati sardi non avevano fatto buona prova perché privi di poteri reali, tanto da essere giudicati «capi senza braccia, ... inetti allo scopo per cui vennero istituiti»97, discussero molto ma operarono poco, anche perché mancavano degli strumenti necessari per esercitare quella sorveglianza sulle condizioni sanitarie della propria circoscrizione che pure era stata loro affidata. Anche le commissioni municipali di sanità condussero una vita stentata. A parte la circostanza che in Italia al momento della loro istituzione vi erano circa 4.800 comuni con meno di 1.000 abitanti, nei quali non doveva riuscire facile trovare i quattro membri da eleggere, quelle commissioni non ebbero un terreno favorevole
nei comuni
minori, riluttanti ad accrescere
le
spese e poco favorevoli alle innovazioni, mentre in quelli maggiori dovettero fare i conti con i preesistenti medici municipali, già inseriti nell’apparato amministrativo con funzioni analoghe a quelle delle commissioni. E bisogna anche tener conto delle indulgenze dei sindaci, non sempre disposti all’esercizio severo delle funzioni loro attribuite per timore di possibili ripercussioni elettorali negative, e dei condizionamenti politici dei prefetti (dai quali dipendeva l’attività dei consigli provinciali) perché, come rilevava nel 1888 il medico Mario
Panizza,
l’amico
di Bertani,
in un discorso
alla Camera
sulla
riforma sanitaria, «non è lecito immaginare un prefetto che, sopra una questione di giustizia locale, rompa un intrigo, metta un freno, obblighi al proprio dovere le stesse persone o consorterie con cui deve poi intendersi e co95. Questa consuetudine,
attestata per i decenni
preunitari in uno scritto di S. Ruva (/In-
fluenza delle risaie sulla umana salute e regole igieniche le più efficaci per conciliare tale coltivazione colle persone soggette al suo mefitismo, Novara, 1845, p. 55) continuò a restare in vigore per tutto 1’800. 96. Cfr. G.L. Gianelli, Fondamenti di una amministrazione di sanità conveniente nel nostro Regno esposti nella seduta del 15 dicembre 1859 del r. Istituto nazionale di scienze, lettere ed
arti in Milano, Milano, 1859, pp. 10 e 14 (e, dello stesso, Fondamenti e piani di legislazione ed amministrazione della igiene pubblica nel Regno d’Italia, Napoli, 1863, pp. 14-15). V. anche le critiche al funzionamento dei consigli in A. Maraglio, L'organizzazione sanitaria e lo Stato, in «Gazzetta medica italiana. Lombardia», 8 settembre 1862, p. 329).
97. Castiglioni, Dell’ordinamento..., cit., p. 52. 98. C. Zucchi, La riforma sanitaria in Italia, Milano, 1888, p. 123.
234
spirare al momento delle elezioni». Quanto poi al Consiglio superiore, privo com'era di possibilità di autonoma iniziativa e pienamente subordinato al ministro degli interni, anche la sua esistenza si era dimostrata timida e poco efficace. Alla luce di queste considerazioni può quindi essere accettato il giudizio complessivo che sull’attività dei consigli formulava Stanislao Cannizzaro presentando il 22 novembre 1887 la relazione senatoriale sul progetto di legge sanitaria Crispi. I consigli avevano cioè operato soprattutto come consigli disciplinari di medici e di farmacisti, soddisfacendo così le «giornaliere esigenze di polizia medica», e avevano anche, in occasione di epidemie straordi-
narie, aiutato il governo a fare «fare sfoggio di inconsueta operosità»; ma non avevano certamente «esercitato con preveggenza ed efficacia quella continua vigilanza sulla salute delle popolazioni e quella costante e coordinata azione nel promuovere e dirigere il risanamento progressivo dei nostri comuni» che era stata loro richiesta!00, Le leggi del 1859 e del 1865 e i relativi regolamenti erano inadeguatamente integrati da alcune altre poche disposizioni legislative che riguardavano aspetti particolari della sanità e dell’igiene pubbliche. Tra queste realtà venne sentita con particolare intensità dalla parte più attenta dell’opinione pubblica — per gli aspetti morali e sociali ad essa connessi — la questione della prostituzione, che rimase disciplinata a lungo da un regolamento del 15 febbraio 1860 (a firma di Cavour e modellato su quello francese), emanato quale complemento per l’esecuzione della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza. Le disposizioni del 1860 introducevano nei capoluoghi di provincia e di circondario «uffici sanitari» per la «sorveglianza delle prostitute», diretti da delegati di pubblica sicurezza e formati da guardie («scelte — si specificava — fra le più distinte per attività, per regolare condotta, e per onestà») e da medici incaricati della visita periodica e della cura coercitiva delle meretrici iscritte, volontariamente o d’ufficio, negli appositi registri. Alcuni articoli del regolamento limitavano drasticamente i diritti civili delle prostitute, che non potevano cambiare l'alloggio o il domicilio senza il permesso delle autorità di polizia e alle quali era «assolutamente» vietato, tra l’altro, «d’af-
facciarsi alle finestre o di stazionare sulle porte anche della propria abitazione; ... di fermarsi, e frequentare le vie principali, le piazze o le pubbliche passeggiate; ... di rimanere fuori di casa senza giusta causa dopo le ore otto di sera dal mese di ottobre al marzo inclusivamente, e dopo le ore dieci negli altri mesi», e di frequentare i teatri. Questo complesso di norme fu sottopo99. Discorso alla Camera dei deputati del 12 aprile 1888, in M. Panizza, La riforma sanitaria in Italia. Discorsi e relazioni, Roma, 1889, p. 15.
100. A. p., Senato, Documenti, Legislatura 162, 22 sessione 1887-88, pp. 2-3.
235
sto ad attacchi serrati da parte dei cosidetti «abolizionisti» — tra cui A. Bertani — i quali denunciavano la situazione di inferiorità e di degradazione giuridica e morale riservata a tutta una categoria di donne, deploravano le conse-
guenze del potere incontrollato attribuito alla polizia (accusata di aver «dato sempre mano alla sequestrazione forzata delle donne nei postriboli, ed alla conversione di queste donne ‘artificiosamente indebitate in cambiali girabili, che i tenutari commerciavano, come pacchi di merce con porto assegnato»!0!), ed esprimevano il loro disgusto per «la condizione fatta a tanta povere infelici di vivere in uno stato di opprimente libertinaggio, fra gl’ingranaggi del lenocinio ed i vincoli insopportabili della sorveglianza»! La nutrita campagna di critiche che investì il regolamento del 1860 riscosse qualche parziale successo, anche se il problema rimase lontano da una soluzione soddisfacente. Si verificò infatti dapprima una attenuazione del rigore delle autorità di polizia nella registrazione delle prostitute schedate, il cui numero scese così tra il 1881 e il 1885 da 10.422 a 8.388 (ma queste cifre non includevano la larghissima fascia del meretricio clandestino)!9; e tra il 1881 e il 1891 la vecchia normativa fu sostituita da disposizioni meno vessatorie che eliminavano le limitazioni più gravi della libertà personale delle prostitute, rendevano responsabili i tenutari della salute delle donne raccolte nelle loro case — poste comunque sotto la doppia sorveglianza delle autorità sanitarie e di quelle di pubblica sicurezza —, e invece di restringere l’individuazione e la cura delle malattie veneree alle sole prostitute (per le quali, se malate, un decreto del 25 settembre 1862 aveva reso obbligatorio il ricovero in appositi sifilicomi governativi) estendevano il soccorso medico ai malati di ogni età e sesso, con la prevista istituzione di sezioni dermosifilopatiche negli ospedali e di dispensari celtici gratuiti!04, Duramente e lungamente avversata da igienisti e studiosi del mondo rurale per la sua permissività e le sue manchevolezze fu anche la legge del 12 giugno 1866 sulla risicoltura che, oltre a prescrivere a proprietari e conduttori di fondi le procedure da seguire per attivare le risaie, demandava ai consigli provinciali la pubblicazione dei regolamenti relativi alle questioni igieniche connesse con la coltura del riso, e in primo luogo a quella della distanza delle risaie dagli abitati. Ma sebbene il primo di questi regolamenti — quello della 101. Discorso di C. Tommasi-Crudeli alla Camera dei deputati in data 13 dicembre (A. p., Camera, Legislatura 162, 22 sessione, p. 6006).
1888
102. Zucchi, La riforma sanitaria..., cit., p. 131.
103. Direzione generale della statistica, Risultati dell’inchiesta sulle condizioni... Relazione generale, cit., p. CXCV. 104. Cfr. G.B. Cereseto, La legislazione sanitaria in Italia, Torino, 1903, vol. 2°, pp. 654
Sgg.
236
provincia di Pavia (25 aprile 1867), sul quale vennero via via esemplati tutti gli altri — contenesse due disposizioni, introdotte d’ufficio dal ministro degli interni Cantelli, che vennero giudicate dagli agrari lesive dei loro diritti (esse stabilivano che i lavori nelle risaie dovevano cominciare un’ora dopo il levar del sole ed essere sospesi un’ora prima del suo tramonto e che le erbe sarchiate andavano trasportate in terreno asciutto e disposte in modo da evitare la loro putrefazione), la legge lasciava ai risicoltori ampi margini di arbitrio. Nei consigli provinciali, cui era affidata la stesura dei regolamenti, e nelle giunte municipali, giudici dell’ osservanza delle distanze e delle condizioni volute dai regolamenti stessi, assai spesso sedevano infatti o proprietari di risaie o affittuari o loro dipendenti, e quindi le decisioni finivano per essere attribuite a persone che erano al tempo stesso giudici e parti in causa!05, Ispirate a grande cautela, in nome dei rispetto della libertà d’intrapresa, furono anche le due sole misure di legislazione sociale con attinenza alla sanità pubblica varate prima della riforma crispina, vale a dire la legge dell’8 luglio 1883, istitutiva della Cassa nazionale di assicurazioni contro gli infortuni del lavoro, e la legge dell’11 febbraio 1886 sul lavoro dei fanciulli nelle fabbriche, provvedimenti che confermavano l’arretratezza della politica sociale dello Stato italiano rispetto a quella degli altri paesi europei. Il carattere volontario dell’assicurazione contro gli infortuni istituita nel 1883 e l’onere finanziario che essa rappresentava per i lavoratori ridussero infatti fortemente l’area della sua applicazione, tanto che dopo sette anni di esercizio la Cassa assicurava soltanto 120.000 persone! Quanto poi alla legge del 1886, votata dopo una serie di precedenti tentativi andati a vuoto per l'opposizione degli industriali, il suo testo risultò assai accondiscendente nei confronti degli imprenditori, come ammetteva lo stesso ministro relatore del progetto, il quale dichiarò che in un paese come l’Italia, dove la fatica delle donne e dei fanciulli era utilizzata su larga scala nelle attività industriali grazie alla modestia dei salari, «una legge severa, la quale anziché colpire gli abusi» avesse mirato ad «ideali troppo alti» avrebbe arrecato «un turbamento non soltanto economico, ma sociale». Di conseguenza la legge non faceva parola delle donne perché, come argomentava sempre il ministro, dato il loro impiego di massa nelle industrie tessili l’imposizione di norme restrittive all’esercizio del lavoro femmi105. Cfr. l’intervento di Luigi Griffini durante la discussione al Senato della legge sanitaria Crispi (A. p., Senato, Discussioni, tornata del 30 aprile 1888, pp. 1432-1433). Si veda anche C. Livi, Della coltivazione del riso in Italia, in «Nuova Antologia», 1871, vol. 17°, pp. 559 sgg. (riprodotto in Faccini, Uomini e lavoro in risaia..., cit., in particolare le pp. 248-255). 106. Relazione sul disegno di legge sugli infortuni del lavoro presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio Chimirri al Senato nella tornata del 13 aprile 1891 (anche in «Rivista della beneficenza pubblica», 1891, p. 398).
237
nile avrebbe costituito un motivo di grave sconcerto!7. E per quel che concerne i fanciulli, essa vietava l’utilizzazione dei minori di 9 anni negli opifici industriali, nelle cave o nelle miniere (limite elevato a 10 anni per il lavoro in ambienti sotterranei), condizionava l'ammissione al lavoro dei minori di 15 anni a un certificato di idoneità, proibiva — ma con eccezioni — la loro occu-
pazione in mansioni insalubri e pericolose e stabiliva un massimo di 8 ore giornaliere per i fanciulli tra i 9 e i 12 anni. Come si vede — a parte il fatto che le norme si riferivano al solo lavoro svolto nelle aziende industriali — i limiti di età stabiliti erano troppo bassi, non veniva proibito il lavoro notturno, non era disciplinato il riposo settimanale, e mentre in Inghilterra e negli Stati Uniti il movimento operaio si stava battendo per le 8 ore degli adulti, proprio in 8 ore era fissata la giornata lavorativa dei fanciulli. Del lavoro notturno si occupò soltanto il regolamento allegato, vietandolo ai minori di 12 anni; ma questa norma, e le altre della legge, furono largamente eluse dagli industriali, che approfittarono della inesistenza di specifici organismi di controllo. Le deficienze dell’amministrazione sanitaria italiana erano poi aggravate dalla mancanza di una organica risposta legislativa a problemi di crescente gravità, come
quello dell’infanzia
abbandonata
e, più in generale,
della
condizione infantile (cui si è già fatto cenno) o quello della follia e dei manicomi. A quest’ultimo proposito, fino alla legge del 14 febbraio 1904 — nonostante il succedersi di una serie di disegni di legge mai giunti all’approvazione del Parlamento!9 — non si andò oltre l'obbligo della spesa per la cura degli alienati mentali imposto alle province dalla legge comunale e provinciale del 1865, e non si fece quindi nulla per creare un quadro di garanzie giuridiche in fatto di ammissione, permanenza e uscita dei malati di mente dai manicomi. Portando poi l’esame sulle misure per la prevenzione delle malattie sociali delle campagne, si dovette anche qui attendere il nuovo secolo per una legge (2 novembre 1901) che assicurasse la somministrazione gratuita del chinino e la cura medica gratuita del male nelle zone dichiarate malariche. E così pure fu del periodo giolittiano la prima legge organica per la prevenzione e la 107. Relazione del ministro di agricoltura, industria e commercio B. Grimaldi in A. p., Camera, Documenti, n. 393, Legislatura 152, 1 sessione 1882-86, e discorso dello stesso Grimaldi
alla Camera in data 2 febbraio 1886. 108. Per questi progetti cfr. tra l’altro i numerosi studi e commenti apparsi nella «Rivista della beneficenza pubblica», tra cui: S. Biffi, Del progetto di regolamento per il servizio dei manicomi e dei mentacatti, 1875, pp. 473 sgg.; F. Bini, I! progetto di legge sugli alienati e sui manicomi pubblici, privati e criminali presentato dal ministro dell’interno nella tornata del 15 marzo 1881, 1881, pp. 941 sgg.; A. Raggi, /! progetto di legge Nicotera sugli alienati e sui manicomi e la relazione della Commissione senatoriale, 1892, pp. 112 sgg.; ecc. Per un rapido excursus sulla storia della legislazione manicomiale italiana v. R. Canosa, Storia del manicomio in Italia dall’ unità ad oggi, Milano, 1979, pp. 100 sgg.
238
cura della pellagra (21 luglio 1902): compiti che fino a quella data vennero lasciati sostanzialmente all’iniziativa privata (forni Anelli, locande sanitarie, cucine economiche, ecc.), poiché l’unico intervento dello Stato fu un decreto
del 23 marzo 1884 che stabiliva un tenue concorso finanziario per l’impianto di essiccatoi per il mais e di forni economici!09, I gruppi politici dirigenti e larga parte dell’opinione pubblica tardarono ad acquistare consapevolezza della gravità e complessità dei problemi sanitari e dell’insufficienza delle norme emanate nel 1859 e 1865. L'esigenza di una profonda ristrutturazione dell’amministrazione sanitaria e di una razionalizzazione della relativa disciplina legislativa fu avanzata quindi, nei primi anni dello Stato unitario, quasi esclusivamente dai periodici medici e dall’organizzazione di categoria dei sanitari, 1’ Associazione medica italiana, costituitasi
nel settembre 1862. E fu proprio per le pressioni degli «uomini dell’arte» che con decreto del 12 settembre 1866 venne nominata una commissione, compo-
sta in prevalenza di medici, con l’incarico di preparare un progetto di legge che «abbracciasse tutti li argomenti di pubblica igiene, e risolvesse, coordinasse e riducesse in articoli dispositivi tutte le disposizioni attinenti alla pubblica sanità». Prendeva così l’avvio la tormentata vicenda del «codice sanitario», che ebbe il suo primo momento saliente nella presentazione al Senato (15 novembre 1872) e nell’approvazione da parte di quel ramo del Parlamento (1° maggio 1873) del cosidetto «codice Lanza», il progetto elaborato dalla Commissione ministeriale e modificato dal ministro stesso. Il codice Lanza, diviso in 14 titoli, era molto più articolato delle leggi del
1859 e del 1865, ma non presentava rispetto a quelle grandi modificazioni, anche perché in molte sue parti non era che una versione riveduta del primo regolamento di applicazione. Gli elementi di novità erano infatti — a parte l’istituzione dei consigli sanitari municipali (già previsti dal regolamento) e l’obbligo fatto ai comuni delle spese per il servizio medico e ostetrico (introdotto nel 1865) — l’attribuzione al medico condotto della qualifica di «ufficiale governativo», senza che a ciò corrispondesse la stabilità dell’impiego, e la presenza di un titolo sul lavoro dei fanciulli che contemplava l’esclusione dei minori di 9 anni dalle fabbriche e dalle miniere. Nonostante queste ultime norme il progetto si muoveva però sempre all’interno di una logica ispirata al principio di limitare il più possibile l’intervento dello Stato a fini sociali, logica che preferiva la raccomandazione all’imposizione e che appariva evidente nella domanda retorica con cui il relatore Carlo Burci replicava a chi nella discussione aveva posto la questione dell’affollamento delle abitazioni delle classi popolari: «Ma possiamo poi noi entrare nelle case dei privati? Possia109. I limiti dell’intervento dello Stato trovano conferma nei dati relativi alla spesa pubblica. Cfr. al riguardo i calcoli del Panizza, La riforma sanitaria..., cit., pp. 106 sgg.
209
mo noi ordinare che [in] una stanza che sarebbe capace per esempio di quattro individui non ve ne dovessero propriamente stare che quattro? E se al proprietario piacesse di metterne otto, si dovrebbe andare a verificare? e come
verificare? e chi ne dà il diritto?»!!0, E contro questo progetto, così poco soddisfacente, si levarono giustamente le critiche radicali di singoli medici e dei sodalizi di categoria, che al di là di un’ottica a volte corporativa indicavano
una serie di nodi irrisolti: la concentrazione di un potere eccessivo nelle mani del ministro a detrimento delle funzioni dei consigli e della loro rappresentatività; l’insufficiente ricorso all’elemento
tecnico, alla «competenza»,
negli
organismi sanitari; la mancanza di strumenti di controllo (gli «ispettori sanitari») sull’esecuzione
delle disposizioni; l'assenza di una regolamentazione
del baliatico e di norme per la prevenzione della malaria; la mancata introduzione dell’obbligo della vaccinazione; e così via!!!. Il codice Lanza non arrivò mai alla Camera, e al posto di una legge organica venne invece promulgato (6 settembre 1874) il regolamento sul quale ci si è già soffermati. Né sorte migliore ebbe il progetto presentato al Senato da Nicotera il 22 dicembre 1876 e discusso nel dicembre
1877, che si fermò an-
ch’esso al Senato. Poche le novità del codice Nicotera, una riproposizione pressoché testuale del progetto Lanza (e per di più contenute non tanto nel testo ministeriale quanto in quello della Commissione senatoriale): l’attribuzione di un peso maggiore ai tecnici con la costituzione di uffici sanitari composti di medici presso il Ministero dell’interno e le prefetture: l’omissione del titolo sul lavoro dei fanciulli, per ii quale si prevedeva una legge apposita; il riconoscimento ai sindaci del potere di far chiudere le case dichiarate inabitabili; la soppressione dell’affidamento degli esposti sifilitici a balie anch’esse sifilitiche!!2. Una fase nuova nella storia della riforma degli ordinamenti sanitari si aprì con l’incarico affidato nel 1880 da Depretis a Bertani di elaborare un nuovo schema di codice!!3. L'uomo politico radicale si avvalse nel suo lavoro della massa di conoscenze fornitagli dalla coeva inchiesta sulle condizioni sanitarie dei lavoratori della terra, da lui diretta, e trasse l’ispirazione di fondo dalla sua partecipe sensibilità per la dolorosa esistenza di tanta parte delle masse popolari («Ho teso avido l’orecchio — avrebbe scritto nella relazione che accompagnava il progetto — al rumoreggiare del proletariato; dal 110. A. p., Senato, Discussioni, tornata del 13 marzo
1873, p. 1412.
111. Cfr. per es. il discorso del Maggiorani al Senato, in A. p., Senato, Discussioni, seduta del 12 marzo 1873, pp. 1404 sgg. 112. Si veda la relazione della Commissione senatoriale (relatore Burci) in A. p., Documen-
ti, sessione del 1876-77, n. 17 A.
113. Lettera di Depretis a Bertani del 25 giugno 1880, in Civiche raccolte storiche del Comune di Milano, Arch. Bertani, cart. 17, plico XXVII bis, n. 243/2.
240
cui confuso tumulto escono, quando a quando, voci distinte e lampi di luce, che rischiarano a breve distanza un avvenire, che è dovere dei savi governi
di prevedere»114), Il cardine della codificazione proposta da Bertani era l’affermazione del «dovere» dello Stato di tutelare la «pubblica igiene»!!5, e in particolare quella dei «poveri», con un’azione preventiva che avrebbe dovuto integrare e anche sostituire l’azione dei privati: «L’igiene pubblica deve essere comandata — argomentava il medico milanese —. I fatti non ci consentono di affidarci alla iniziativa privata non sempre provvida, né illuminata, né disinteressata in ogni luogo; ... deve adunque la suprema e ordinata azione dello Stato procurare l'adempimento delle indeclinabili prescrizioni»!!6. Coerentemente con questa impostazione era contemplato un accertamento funzionale, fino al livello del circondario, degli strumenti operativi dell’azione sanitaria pubblica, vale a dire il magistrato superiore della pubblica igiene, i medici provinciali e gli ispettori circondariali. Al vertice della scala gerarchica stava dunque, a fianco del ministro dell’interno e da questi nominato, il magistrato superiore, una sorta di sottosegretario di Stato organizzatore e promotore di tutte le misure relative alla sanità; e a questo alto funzionario era assegnata una sfera di competenze assai ampia, perché tra l’altro avrebbe dovuto decretare e revocare le norme per evitare la propagazione delle malattie infettive, sorvegliare le istituzioni sanitarie ed educative e i luoghi di reclusione, stabilire «le discipline speciali per le industrie insalubri nei rapporti sanitari», fissare la durata del lavoro giornaliero nei rami di industria particolari e disporre «le cautele igieniche da imporsi ai capi industriali, proprietari, cottimisti, fittabili, imprenditori di miniere e di lavori pubblici in genere». Nell’ambito della provincia l’autorità sanitaria era impersonata dal medico provinciale, con compiti di sorveglianza sul servizio e sul personale della circoscrizione e con il potere di ordinare i provvedimenti d’urgenza richiesti dall’incolumità pubblica e di intraprendere di propria iniziativa «le pratiche dirette ad opere, riforme e miglioramenti interessanti la pubblica igiene nel territorio provinciale»; e analoghi poteri di sorveglianza e di intervento d’urgenza erano assegnati nel territorio della sua circoscrizione all’ispettore circondariale, anch’egli medi-
co. Bertani conservava, come organismi consultivi, il Consiglio superiore e i consigli provinciali, che avrebbero dovuto essere composti in larga prevalenza di medici e per la cui formazione era prevista l’introduzione del principio 114. A. Bertani, Sullo schema del Codice per la pubblica igiene. Relazione all’onorevole ministro dell’interno A. Depretis, Milano, 1886.
115. Art. 1 del Codice. (Il testo del progetto è riprodotto in «Giornale della reale Società italiana d’igiene», 1886, pp. 486 sgg.). 116. Bertani, op. cit., p. 10.
241
elettivo, con la concessione del diritto di voto alle facoltà mediche e, per i consigli provinciali, alle stesse facoltà o, nelle province che ne fossero prive, ai medici esercenti da più di 5 anni presso gli ospedali delle relative province. In questa parte del suo progetto Bertani aveva fatto propri gli orientamenti ripetutamente espressi dalla stampa e dai congressi medici circa l'opportunità di far poggiare la riforma sulle «competenze»; e questa via venne percorsa risolutamente anche nella definizione delle articolazioni e delle funzioni delle strutture sanitarie di base, quel «servizio igienico sanitario comunale» che avrebbe dovuto essere espletato gratuitamente dal medico-chirurgo, dal dottore veterinario e dalla levatrice per i soli poveri, con la conseguente abolizione delle condotte piene. L'innovazione più radicale proposta a tale riguardo era l’attribuzione al medico condotto della qualifica non soltanto di «ufficiale sanitario dello Stato» (come nel codice Lanza), ma di «autorità sanitaria del co-
mune», inamovibile dopo tre anni di prova: con il che il condotto avrebbe cumulato alla funzione di medico curante dei poveri quella di funzionario periferico della pubblica amministrazione sanitaria, investito di compiti ispettivi e propositivi in tutta la gamma di materie attinenti alla salute pubblica nella sua circoscrizione. L’allargamento delle attribuzioni amministrative del medico aveva come corrispettivo la restrizione di quelle del sindaco e delle giunte comunali e l’eliminazione delle commissioni municipali per la sanità, che Bertani si premurava di presentare non come una limitazione delle autonomie locali, ma come un’esigenza dettata dall’esperienza, la quale aveva dimostrato le responsabilità che nel dissesto sanitario del paese ricadevano su «uffici comunali guidati da ragioni locali, ... non dappertutto illuminati, talora sopraffatti da smodati timori, talora indifferenti e imprevidenti davanti a pericoli reali, quando larghi e fastosi nelle spese e quando cauti e parsimoniosi anche nel necessario»!!7. La consapevolezza propria al Bertani dello stretto nesso tra i problemi igienico-sanitari e le condizioni materiali di esistenza delle classi popolari ispirava tutto il titolo III, dedicato alla salubrità delle abitazioni e degli alimenti e al lavoro agricolo e industriale, e si traduceva in una minuziosità di disposizioni a volte dispersiva. Così, in tema di edilizia, oltre alle prescrizioni relative ai requisiti igienici indispensabili per le abitazioni (abbondanza di aria e di luce, presenza dei servizi essenziali, separazione delle camere d’abitazione dagli ambienti destinati agli animali), alla dichiarazione di abitabilità delle case restaurate o di nuova costruzione da parte del medico comunale e ai poteri d’intervento dell’autorità sanitaria comunale nel caso di abitazioni malsane, alla distanza dagli abitati delle fabbriche che spandevano esalazioni
117. Ibidem, pp. 14-15. 242
nocive, il codice vietava l’impiego di «ricci da falegname» come ripieno dei tavolati interni delle case e l’utilizzazione di mattoni crudi per i muri «destinati a formare botteghe, officine, camere da letto». Quanto agli alimenti, nel progetto giustamente era prevista la punizione con pene pecuniarie e detentive non soltanto di coloro che vendevano o detenevano per la vendita materie destinate a cibo o a bevanda «guaste, corrotte, infette, adulterate», ma anche
dei proprietari e fittabili che avessero somministrato ai contadini a titolo di sovvenzione o di salario granturco o altre sostanze alimentari avariate. Nella perdurante assenza di una legislazione a protezione del lavoro Bertani si era infine preoccupato di inserire una serie di norme che vietavano l’impiego in un lavoro stabile, sia industriale che agricolo, di fanciulli minori di 15 anni che non avessero superato i corsi d’istruzione elementare (o minori di 16 in caso di lavoro notturno o sotterraneo) e di provvedere a una regolamentazione generale della risicoltura, sia per quel che riguardava la distanza dagli abitati!!8, sia per quanto concerneva la durata della giornata lavorativa (non superiore a 10 ore, intervallate da due riposi, con esclusione del lavoro notturno
all’aperto, estesa anche ai luoghi malarici). E in questa stessa ottica lo schema di legge arrivava a formulare norme per prevenire gli infortuni («i meccanismi pericolosi dovranno avere uno spazio sgombro all’ingiro, e le ruote giranti, i cilindri, li ingranaggi ed ogni ordigno pericoloso deve essere munito di ripari») e per limitare il disagio fisico dell’operaio («nelle industrie nelle quali l’operaio deve starsene immobile allo stesso posto, dev'essere munito di un sedile alto con appoggio»). All’interno di queste linee di fondo il progetto era completato dalla risoluta affermazione del libero esercizio farmaceutico, con la quale Bertani intendeva risolvere un problema ormai annoso liquidando le resistenze corporative della categoria, e dal recupero delle disposizioni dei codici Lanza e Nicotera sulla vaccinazione obbligatoria e di quelle sulle malattie veneree, la cui applicazione — con la cura demandata a tutti i pubblici ospedali — avrebbe dovuto portare al superamento dell’istituzione segregante dei sifilocomi. Lo schema approntato da Bertani servì di base al progetto di codice presentato al Senato nella tornata del 13 aprile 1886 da Depretis, salutato da più parti come capo di quel «partito dell’igiene» che dopo il colera del 1884 aveva cominciato a premere più energicamente per la realizzazione della riforma sanitaria!!9. Poche le modificazioni introdotte nel disegno ministeriale: l’eli118. La misura della distanza minima dagli abitati (1 km per le risaie a deflusso perenne e 2 km per quelle senza deflusso) doveva essere presa «in linea retta dalla periferia esterna delle città, borghi e casali, tenimenti, poderi, cascine, a partire dall'ultima casa che si troverà far
parte delle abitazioni aggregate, nella direzione delle località da coltivarsi a riso» (art. 98). 119. G.B. Benvenuti, La nostra legislazione sanitaria, in «Rassegna di scienze sociali e politiche», 1° marzo 1885, p. 22.
243
minazione del richiamo al «dovere dello Stato» di tutelare la pubblica igiene; la sostituzione del magistrato superiore («un quasi ministro con tutti gli inconvenienti del quasi»!29) con una Direzione generale; la limitazione dei poteri di questa Direzione in materia di cautele igieniche all’interno delle fabbriche; l'assenza delle disposizioni sul lavoro dei fanciulli, regolamentato con la legge del 1886; l’abolizione del principio elettivo nella formazione del Consiglio superiore e dei consigli provinciali, i cui membri avrebbero dovuto essere nominati rispettivamente dal re, su proposta delle facoltà mediche, e dal prefetto, su proposta dei medici esercenti nella provincia da più di dieci anni!2!, Ma anche il progetto Depretis — il quarto della lunga serie, e al quale vennero mosse critiche di vario segno, come quelle che lamentavano la limitazione della libertà nelle amministrazioni locali o la dilatazione delle funzioni burocratiche dell’ufficiale sanitario (la quale, si diceva, avrebbe potuto uccidere il medico condotto)!22 o le difficoltà di funzionamento del Consiglio superiore (un «morto» che secondo Angelo Celli «sarebbe stato meglio non risuscitare»!23) — non riuscì ad andare in porto, e anzi non venne neppure discusso in Parlamento per la sopravvenuta scomparsa di Depretis. Toccò quindi a Crispi nel corso del suo primo ministero, caratterizzato dall’attenzione per i problemi amministrativi e istituzionali, portare a compimento la riforma sanitaria. La determinazione dello statista siciliano di risolvere una questione che si trascinava ormai da tanto tempo era del resto apparsa chiara già prima della sua ascesa alla presidenza del Consiglio, nelle settimane che precedettero la morte di Depretis, nel cui gabinetto Crispi era ministro dell’interno. Contestualmente ad alcune misure di minor rilievo (ricostru-
zione dei consigli sanitari su nuove basi, con l'aggiunta di membri ingegneri, 7 giugno 1887; prestiti di favore al 3% per opere di risanamento ai comuni di popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, 5 luglio 1887), il 3 luglio venne istituita la Direzione generale della sanità pubblica, ridando così autonomia all’amministrazione sanitaria presso il Ministero dell’interno, prima concentrata (tranne gli anni 1863-69 e 1874-78) con quella delle opere pie, e mettendo per la prima volta a capo di essa un direttore sanitario professionalmente qualificato, nella persona dell’igienista Luigi Pagliani!24, 120. A. Armanni, La riforma sanitaria in Italia nei suoi rapporti colla beneficenza pubblica, in «Rivista della beneficenza pubblica», 1887, p. 472. 121. Il testo del codice Depretis è riprodotto in /! progetto di codice sanitario presentato al Senato del Regno dal presidente del Consiglio e ministro dell’interno A. Depretis. Relazione [di C. Zucchi] alla reale Società italiana d’igiene, Milano, 1887, pp. 48 sgg. 122. Armanni, La riforma sanitaria..., cit., pp. 475 sgg. 123. A. Celli, L'amministrazione sanitaria in Italia e lo schema di codice per la pubblica
igiene, in «Giornale della reale Società italiana d’igiene», 1887, pp. 7-8. 124. L. Pagliani, Relazione intorno alla Direzione della sanità pubblica ed agli atti da essa compiuti dal 1° luglio 1887 al 31 dicembre 1889, ibidem, 1890, pp. 73 sgg.
244
Divenuto presidente del Consiglio, Crispi presentò il 22 novembre 1887 al Senato e il 15 maggio 1888 alla Camera il suo disegno di legge sulla tutela dell’igiene e della salute pubblica. Il progetto faceva propria l’intelaiatura del codice Depretis, anche se Crispi nella discussione alla Camera ci tenne a insistere soprattutto sulla dipendenza della nuova normativa dalle proposte di Bertani, affermando di essersi limitato a sfrondarle «di tutte quelle materie che erano regolamentari, lasciandovi tutto quello che era precettivo, e che doveva esser materia di una legge»!25. Come Depretis, anche Crispi si preoccupò dunque di restringere le aperture sociali presenti nello schema Bertani, accogliendo la limitazione delle facoltà di intervento della Direzione generale all’interno del settore industriale; e rafforzò inoltre l’accentramento del servizio sanitario subordinando ancora più strettamente all’esecutivo i consigli (i cui membri erano nominati dall’alto senza chiedere più il parere delle facoltà mediche o dei sanitari più anziani), attribuendo la presidenza dei consigli provinciali ai prefetti anziché a un membro eletto dai componenti del consiglio stesso, rendendo il medico provinciale «organo speciale» del prefetto!26 ed eliminando, oltre alle commissioni municipali, anche l’anello intermedio tra comune e provincia costituito da quell’ispettore circondariale che era stato previsto nei codici Bertani e Depretis. La legge fu approvata il 22 dicembre 1888, e su di essa si può dare un giudizio complessivamente positivo. La legge infatti — come rilevava giustamente alla Camera Nicola Badaloni, il medico condotto organizzatore dei braccianti del Polesine, che pure non ne nascondeva 1 limiti!?? — creava nel paese
il complesso delle istituzioni necessarie all’applicazione delle disposizioni di legge, e attribuiva il peso e la responsabilità dovuti alle «reali competenze» sottraendo l’amministrazione sanitaria alla «burocrazia invadente»!28. All’in125. Intervento alla Camera dei deputati in data 13 dicembre 1888 (A. p., Camera, Discussioni, Legislatura 168, 22 sessione, p. 6020). 126. Relazione della Commissione senatoriale sul progetto Crispi (relatore Cannizzaro), in A. p., Senato, Documenti, Legislatura 162, sessione 22, 1887-88, p. 9. La scelta accentratrice fu difesa esplicitamente dallo stesso presidente del Consiglio nelle sue repliche ai critici della legge nei due rami del Parlamento. Parlando del Consiglio superiore Crispi affermò infatti che esso non stava «al disopra del ministro», ma «accanto, o per dir meglio... sotto» (ibidem, Senato, Discussioni, tornata del 26 aprile 1888, p. 1356); e nel suo intervento alla Camera si espresse così: «Si è accusato il disegno di accentramento. Coloro che mossero quest’accusa non hanno riflettuto che, se vi è servizio nel quale abbisogna l’accentramento, è quello della sanità» (ibidem, Camera, Discussioni, Legislatura 162, 2 sessione, tornata del 13 dicembre
1888, p. 6020). 127. Badaloni denunciava tra l’altro il criterio eccessivamente accentratore che ispirava la legge e la timidità di questa in materia di igiene del suolo e dell’abitato (ibidem, tornata del 12 dicembre 1888, pp. 5960 sgg.). 128. Ibidem, p. 5958.
245
terno di questa prospettiva era poi definito e potenziato il ruolo del medico condotto («apostolo di igiene, di carità, di civiltà e di libertà», e in molti casi rappresentante nei comuni della «bandiera liberale e nazionale, contro il partito retrivo»!29), con l’attribuzione
della qualifica di ufficiale sanitario e la
concessione della stabilità dopo un triennio di prova. Ma al di là di questa valutazione di fondo restavano nell’ordinamento sanitario così introdotto alla fine del 1888 lacune e squilibri. Tra gli squilibri anzitutto quello del carico di spesa gravante sui comuni nei confronti degli oneri finanziari dello Stato e delle province. Mentre infatti la spesa del Ministero per la sanità nell’esercizio finanziario 1890-91 risultava di poco superiore a 1.700.000 lire, e assai esigua era quella delle amministrazioni provinciali, sulle spalle dei comuni gravavano nello stesso esercizio circa 70 milioni di lire (senza tener conto delle erogazioni delle opere pie); e sempre sui comuni sarebbe ricaduto il maggiore onere dell’assistenza ostetrica e veterinaria (resa obbligatoria in tutti i comuni la prima, e imposta la seconda dal prefetto ai comuni singoli o consorziati nei quali fossero state giudicate necessarie la vigilanza e l’assistenza zooiatrica)!30, dell’ampliamento di attribuzioni di quei medici condotti che sarebbero diventati ufficiali sanitari, e dei nuovi più ampi compiti di vigilanza igienico-sanitaria!3!. Quanto alle lacune, particolarmente grave appariva la mancata estensione dell’obbligo dell’assistenza sanitaria gratuita anche all’assistenza farmaceutica (deplorata durante la discussione al Senato
da Jakob
Moleschott
perché,
osservava
lo scienziato,
«l'assistenza
medica chirurgica il più delle volte non ha nessun esaurimento se non è accompagnata dalla somministrazione dei medicamenti»!32): lacuna che aveva ripercussioni negative soprattutto per le popolazioni rurali, a cui favore non era nemmeno previsto alcun intervento specifico che valesse a migliorare le condizioni di abitabilità delle loro dimore dal punto di vista igienico. La legge Crispi, poi completata dai regolamenti di esecuzione, iniziava così il cammino della sua applicazione, che venne a cadere proprio in una fase della vita nazionale perturbata da una grave crisi economica, sociale e istitu-
zionale che avrebbe impegnato in modo prevalente l’attività dei gruppi politi129. Le definizioni sono rispettivamente di Badaloni (ibidem, p. 5963) e del senatore Riccardo Secondi (ibidem, Senato, Discussioni, Legislatura 16, sessione 22, tornata del 28 aprile
1888, p. 1404). 130. È da rilevare che al 31 dicembre
1889 3.320 comuni mancavano
ancora del servizio
ostetrico, mentre 3.965 vi provvedevano da soli e 972 in consorzio. 131. U. Imperatori, La nuova politica sanitaria in Italia, in «Giornale degli economisti», 1891, vol. 1°, pp. 374-383. 132. A. p., Senato, Discussioni, Legislatura 162, sessione 22, tornata del 26 aprile 1888, p.
1343.
246
ci e dei ceti dirigenti. Ma i problemi ancora aperti dello stato sanitario del paese e dei suoi nessi con le più generali questioni che toccavano da vicino le masse popolari nei loro ambienti di vita e di lavoro erano ben lungi dalla loro soluzione definitiva, e sarebbero tornati alla ribalta all’aprirsi del nuovo seco-
lo, nel mutato clima politico e nella cornice dei nuovi rapporti di forza che avrebbero caratterizzato l’esperienza governativa di Giolitti.
247
Sb aris Age nsio ai ia
FOA
avotide siromsmisodi «iis
Sile
e
acarorene lib noigi tit bietole
sì
vii
UAN
sto ai di fà di quissiinià itssinendi limo vusi introdeto alla fine dei 1888 lacune e equità; Tra gii squilibri’ an Mitutto quello del carico di spesa gravante sui. comuni net confevati degli one-
n finanze dello Stato e delle province. Mentre ialfattà laspes chel
per ia sanità nell'evercizio finanziario 189051 rfisdiadà di poco
pid
170.000 lire, e. assai esigra. era quella delle acmminiensztoni
initiz spalle dei comuni gravavano nello stesso esercizio cita copioni di fe (senza lener comin delle erogazioni delle opere file);* pece vl: ona satebbe ncaduro il maggiore onere dell' assistenza ostetrica €
obligatoria 4) tutti i comuni la primta,.€ iapouia ta accostata da
comuni singoli a sonsorziati pei quali fossero state giudicate amcessarie Lug» gilanza.e l'assistenza zooiation)!%, sell'amplisoento di
medici condotti che sarebbero diventati ficrali sanitari. e der novi piùampi |
compiti di viglanza igienico-sandtaria!® Iuanto alte lacune, particolamento
grave appariva la mancata estensione dell'obbligo dell'assictenza’penitearia

![Lessico. Classi di parole, strutture, combinazioni [2 ed.]
9788815232991](https://dokumen.pub/img/200x200/lessico-classi-di-parole-strutture-combinazioni-2nbsped-9788815232991.jpg)