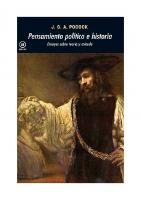Shoah, modernità e male politico 9788857520230
467 90 3MB
Italian Pages 352 Year 2014
Polecaj historie

- Author / Uploaded
- Dimitri D'Andrea
- Renata Badii (a cura di)
- Categories
- Other Social Sciences
- Philosophy
Citation preview
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
PIANI DI VOLO Saggi di critica sociale Collana diretta da Dimitri D’Andrea e Enrico Donaggio n.1 Comitato scientifico Laura Bazzicalupo (Università di Salerno) Dimitri D’Andrea (Università di Firenze) Enrico Donaggio (Università di Torino) Stéphane Haber (Université de Paris Ouest) Edith Hanke (Bayerische Akademie der Wissenschaften) Andrea Inglese (Université de Paris III) Daniel Innerarity (Universidad de Saragozza) Elena Pulcini (Università di Firenze) Adriano Zamperini (Università di Padova)
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
SHOAH, MODERNITÀ E MALE POLITICO a cura di Renata Badii e Dimitri D’Andrea
MIMESIS Piani di volo
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
La pubblicazione del presente volume è stata realizzata con il contributo della Regione Toscana.
© 2014 – MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine) Collana Piani di volo n. 1 Isbn 9788857520230 www.mimesisedizioni.it Via Risorgimento, 33 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Telefono +39 02 24861657 / 24416383 Fax: +39 02 89403935 E-mail: [email protected]
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
INDICE
Enrico Rossi PREMESSA
9
Ugo Caffaz PREFAZIONE
15
Renata Badii, Dimitri D’Andrea INTRODUZIONE Confrontarsi con il male: interpretare e ricordare la Shoah
19
I. IL DIBATTITO STORIOGRAFICO SULLA SHOAH Enzo Collotti LA SHOAH OGGI, TRA STORIOGRAFIA E DIVULGAZIONE
49
Christopher R. Browning CONTESTUALIZZARE LA SHOAH
55
Omer Bartov RIPENSARE L’OLOCAUSTO Obiettivo di guerra od ostacolo alla vittoria?
69
Christoph U. Schminck-Gustavus INDULGENZA TOGATA La mancata punizione di alcuni esecutori dell’Olocausto nella Germania Federale degli anni Sessanta
85
Simone Duranti A SCUOLA DI RAZZISMO Il Gruppo universitario fascista e le sue strutture per l’antisemitismo nell’ateneo fiorentino
119
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
II. LA CONDIZIONE UMANA DOPO IL MALE RADICALE Zygmunt Bauman MALE E MODERNITÀ: TRE PARADIGMI
141
Alberto Burgio IL CONFLITTO TRA MORALI NELLA GERMANIA NAZISTA
159
Fabio Dei TRA STORIA E SCIENZE SOCIALI: LE GRAMMATICHE DELLA VIOLENZA
181
Roberto Esposito NAZISMO E SHOAH
193
Massimo Giuliani LA MISURA DELLA RESPONSABILITÀ DOPO AUSCHWITZ
203
Susan Neiman SENZA CATTIVE INTENZIONI Ripensare il male dopo Auschwitz
215
III. AUSCHWITZ COME “FRATTURA DI CIVILTÀ”: LA COSCIENZA CONTEMPORANEA DI FRONTE ALLA SHOAH Annette Wieviorka DI CHE COSA AUSCHWITZ È IL NOME?
233
Diego Guzzi SE QUESTO È UN LUOGO Auschwitz e le memorie europee
245
Stefano Raimondi NONOSTANTE TUTTO, NONOSTANTE IL TUTTO La poesia nel tempo di Auschwitz
261
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Andrea Minuz TRAUMA, MELODRAMMA, MEMORIA Percorsi nel cinema della Shoah Tullio Seppilli RAZZISMO E “COSTRUZIONE SOCIALE DEL MALE”:
281
UNA RIFLESSIONE ANTROPOLOGICA
295
Enrico Donaggio SPREMERE I CERVELLI, ACCAREZZARE I CUORI La Shoah a scuola
303
OPERE CITATE
311
GLI AUTORI
INDICE DEI NOMI
343
345
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
9
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
ENRICO ROSSI
PREMESSA
Occorre dunque essere diffidenti con chi cerca di convincerci con strumenti diversi dalla ragione, ossia con i capi carismatici: dobbiamo essere cauti nel delegare ad altri il nostro giudizio e la nostra volontà. Poiché è difficile distinguere i profeti veri dai falsi, è bene avere in sospetto tutti i profeti; è meglio rinunciare alle verità rivelate, anche se ci esaltano per la loro semplicità e il loro splendore, anche se le troviamo comode perché si acquistano gratis. È meglio accontentarsi di altre verità più modeste e meno entusiasmanti, quelle che si conquistano faticosamente, a poco a poco e senza scorciatoie, con lo studio, la discussione e il ragionamento, e che possono essere verificate e dimostrate. (Levi 1976: 348)
Le parole di Primo Levi, contenute nell’appendice del 1976 all’edizione scolastica di Se questo è un uomo, e che così bene sintetizzano l’idea stessa di modernità, hanno segnato per l’Occidente un nuovo inizio, dopo la tragica parentesi dei totalitarismi del Novecento; la ripresa di un discorso drammaticamente interrotto e che, non a caso, ci riconnette alle basi del metodo scientifico. In realtà, lungo tutto il percorso accidentato della civiltà europea troviamo una costante che, come un fiume carsico, in diversi momenti emerge impetuosa dal sottosuolo: la persecuzione degli ebrei, fino alle forme del male assoluto raggiunte appunto con l’Olocausto sotto la guida di un capo carismatico. L’ebreo è stato concepito per secoli come lo stereotipo dell’Altro. Nell’Europa medievale e cristianizzata, gli unici non-cristiani (cioè diversi) sono gli ebrei; non c’è altro “Altro” che l’ebreo, per cui tutto quello che si manifesta come dissociazione dal “noi” si identifica con l’ebreo. Nelle dispute teologiche medievali ciò che ai cardinali cattolici risulta incomprensibile, per loro così abituati all’ordine, è come ogni rabbino potesse dare definizioni diverse del Messia: per loro l’ebreo è un perturbatore dell’ordine perché rompe la mentalità gerarchica dell’ortodossia cattolica. E non si tratta neppure di un pregiudizio originato da una posizione di potere che si intende tutelare: a metà del II secolo il cristianesimo è una religione perseguitata, eppure essa ha già elaborato un’immagine negativa, una definizione stereotipata dell’ebreo. Ed ecco il
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
10
Shoah, modernità e male politico
tema dell’identità: lo stereotipo su cui si fonda il pregiudizio antisemita sta tutto dentro una definizione dell’identità. Deriva dall’esasperazione del tema dell’identità come tendenza a guardare solo a se stessi. Eppure, la cultura ebraica ha dato un contributo decisivo alla modernità: il mondo moderno ha avuto un contributo fondamentale da intellettuali ebrei che si sono battuti non per il loro ebraismo, ma per una cultura universalistica. La citazione di Primo Levi, tuttavia, mette in campo la responsabilità individuale di compiere degli atti, di assumere degli orientamenti che – per quanto nei regimi totalitari siano drasticamente condizionati – costituiscono la base di ogni libertà: l’atto di disobbedienza è l’inizio della ragione, scriveva Erich Fromm nel suo Fuga dalla libertà (1941). L’avvento del capo carismatico può anche essere un evento improvviso, ma la costruzione del consenso alla rinuncia alla propria libertà, accettando come dati di fatto indiscutibili locuzioni e pensieri anche molto pericolosi, avviene per accumulazioni successive, talvolta impercettibili, apparentemente innocue. Sta tutta qui l’attualità del tema che oggi affrontiamo in una prospettiva storica sulla Shoah. Progressivamente, impercettibilmente siamo portati ad assumere, sottovalutando l’importanza dei dettagli, l’idea che la diversità culturale è portatrice di disordine e quindi da neutralizzare; che “noi non siamo razzisti, però...” e in quel “però” si rivela quello che la negazione iniziale tenta di nascondere. Il razzismo moderno si afferma sempre per questa via, giacché il razzismo biologico ci appare ormai inconcepibile, ma quello culturale o “differenzialista” lo assumiamo talvolta senza accorgercene. Così, nell’Italia degli anni Trenta, si passò progressivamente dal giuramento accademico di fedeltà al fascismo (che solo 21 docenti italiani ebbero la forza di rifiutare) alle leggi razziali. Così accettiamo oggi di attribuire caratteristiche comportamentali ad interi gruppi di immigrati (“i nordafricani sono indolenti, ma ci tolgono il lavoro”, “i cinesi sono industriosi, ma non si integrano”, “i rom rubano e non si lavano”) e ingoiamo senza accorgercene stereotipi indimostrabili, separati dal razzismo solo da impercettibili linee di demarcazione. Poi, una mattina ci risvegliamo improvvisamente con un omicidio razzista come quello di cui sono state vittime due cittadini senegalesi a Firenze nel dicembre 2011 e non sappiamo spiegarci il perché – e, di nuovo, accettiamo la soluzione più semplice, ma anche la più errata, della follia individuale. Talvolta anche le più alte affermazioni di principi universalistici contengono in sé aporie che forse sarebbe bene sciogliere: l’articolo 3 della nostra davvero splendida Costituzione recita che «Tutti i cittadini [...] sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Il testo,
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
E. Rossi - Premessa
11
che pure rappresenta il principio di uguaglianza come pochi testi costituzionali hanno saputo fare, contiene un errore perché, come è noto, le razze non esistono, dal momento che ne esiste una sola, quella umana. E poi forse il testo sarebbe più corretto, senza ambiguità e più completo se, semplicemente, affermasse che tutte le persone (anche a prescindere dal proprio status giuridico in relazione alla cittadinanza) sono uguali davanti alla legge. Perché è l’umanità che è comune a tutti ed è da questo che discende il principio di uguaglianza che sta alla base della democrazia moderna. E la politica, nella sua più vera ed alta espressione, è lì per inverare questo principio, cioè occuparsi del bene comune, assumerlo come fine della propria azione. Purtroppo lungo il corso del Novecento fino ai giorni nostri abbiamo assistito a momenti in cui la politica si è ridotta al perseguimento di interessi particolari, di gruppi circoscritti rappresentativi di interessi particolari. Questo svilimento della politica ha assunto anche le forme rabbiose ed odiose dell’egoismo del gruppo di volta in volta etnico, nazionale, religioso, familiare, degenerando nelle violenze peggiori, dalla Shoah fino ai più recenti conflitti nella ex Iugoslavia, la cui lezione abbiamo relegato all’oblio. È sempre la pretesa di rappresentare l’assoluto, la purezza del proprio cerchio ristretto da difendere contro l’Altro (la diversità, ciò che sta fuori dal cerchio, incomprensibile e apportatore di disordine), che produce il morbo del razzismo. Ma questa pretesa di purezza, scrive Claudio Magris nel suo Microcosmi (1997), si realizza solo per progressive elisioni, riduzioni, espulsioni, fino al nulla, al nichilismo. Mentre è solo dall’incontro, dal meticciato culturale, dall’accoglienza della diversità come condizione condivisa (non come qualcosa da tollerare e ricondurre alla legge dell’integrazione) che le società si sviluppano e le democrazie si rivitalizzano. Il grande scrittore israeliano Amos Oz ha giustamente a questo proposito (e con particolare riferimento al conflitto israelo-palestinese) richiamato il valore positivo del compromesso. Un termine poco di moda perché, dice Oz, è considerato come una mancanza di integrità, di dirittura morale, di consistenza, di onestà. Il compromesso puzza, è disonesto. Non nel mio vocabolario. Nel mio mondo, la parola compromesso è sinonimo di vita. E dove c’è vita ci sono compromessi. Il contrario di compromesso non è integrità e nemmeno idealismo e nemmeno determinazione o devozione. Il contrario di compromesso è fanatismo, morte. (Oz 2002: 25-6)
Accogliere il compromesso come valore e metodo su cui costruire la convivenza umana vuol dire assumere la diversità come ricchezza e l’incontro come il terreno su cui erigere l’edificio democratico. È da questa
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
12
Shoah, modernità e male politico
attitudine che è nato il processo unitario del nostro paese, di cui abbiamo da poco celebrato il 150° anniversario. Ed è sempre da questa attitudine che è nato il processo di unificazione politica dell’Europa. Un processo che, nonostante le più recenti deviazioni monetaristiche, è un processo politico, e scaturisce direttamente dall’esperienza della lotta contro il fascismo e il nazismo e dalla consapevolezza che, per evitare che quella storia nata dall’esasperazione del particolarismo nazionalista tornasse sulla scena europea, occorreva unire i diversi Stati e popoli europei in una prospettiva di sviluppo e di convivenza pacifici. Per questo motivo il “sogno” europeo è oggi più attuale che mai e la politica dovrebbe perseguirlo con la consapevolezza e l’impegno che meritano le cose fondamentali, soprattutto in questa situazione di crisi che sconvolge l’Occidente. L’Olocausto, dunque, non può essere un evento consegnato alla storia che ha riguardato solo l’ebraismo, né può essere concepito come uno dei tanti fenomeni sociali – per quanto estremi – di violenza che si ripetono nella storia con una certa frequenza: la sua unicità e specificità non ci mette al riparo dalla sua ripetibilità, seppure con forme diverse. Comprenderne la specificità, i meccanismi interni di funzionamento, le condizioni che lo hanno reso possibile, significa avere presente che cosa sarebbe stato il mondo nel quale oggi viviamo se l’ideologia hitleriana si fosse trasformata nell’ideologia vincente, se il razzismo e non l’egualitarismo democratico fosse diventato il cardine attorno al quale costruire gli assetti mondiali e le forme della convivenza fra i popoli e le persone. Forse, diversamente dalla Germania, l’Italia non ha fatto i conti fino in fondo con questo problema. Le dinamiche del razzismo, i suoi fondamenti ideologici, le forme anche edulcorate che esso assume, i meccanismi sociali e culturali che lo fanno scattare, sono problemi che la società italiana non ha voluto o saputo elaborare fino in fondo. Eppure questa sarebbe la condizione principale (anche se di per sé non sufficiente) per impedire che ciò che è avvenuto possa occorrere di nuovo. Perché è possibile. Certo in forme e probabilmente in dimensioni diverse, ma è possibile che si ripresenti un vasto consenso a opzioni sociali e politiche di tipo razzista o che facciano capo al “fascismo eterno”, cioè quegli atteggiamenti, quelle convinzioni culturali, quelle basi ideologiche che si ritrovano come minimo comune denominatore nelle diverse forme di fascismo storiche e attuali. Non avrei molti dubbi a sostenere che diverse di queste caratteristiche si ritrovano oggi nei tratti del regime politico che viene consolidandosi e trasformandosi nel tempo in Ungheria. Così come molte delle parole d’ordine di movimenti politici come la Lega Nord in Italia e altri gruppi “confratelli” in Europa hanno chiaramente questa impostazione e non dobbiamo
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
E. Rossi - Premessa
13
assolutamente sottovalutarli: l’odio per gli stranieri, la secessione come forma di isolazionismo da storie nazionali ma anche dal processo di unificazione europeo, la solidarietà circoscritta alla “piccola patria” e l’ideologia dell’espulsione della diversità, fino alle piccole ma significative iniziative nei singoli comuni e valli per mettere in pratica queste idee di egoismo sociale, sono pericolosi segnali di un fuoco che ancora arde sotto la cenere. In questo senso il male riesce ad insinuarsi nelle nostre vite e nella nostra società con normalità, attraverso strade e forme sempre nuove, che ci appaiono innocue, tollerabili, frutto della follia di qualcuno o della stranezza di altri; fatti isolati, circoscrivibili; eventi deprecabili, spiacevoli, ma sempre all’interno di un corpo sano che avrebbe in sé gli anticorpi per espellerlo. È il modo in cui molti hanno giudicato fatti come quello avvenuto a Firenze il 13 dicembre 2011: l’uccisione di Samb Modou e Diop Mor per motivi espressamente e consapevolmente razzisti. Ma è sbagliato, pericolosamente sbagliato. Noi dobbiamo saper riconoscere i fili che legano il linguaggio. Non solo quello violento e dichiaratamente razzista, ma anche quello più faceto o popolare che incorpora significati razzisti – pensiamo a parole come clandestino, vu cumprà, badante –, gli atteggiamenti, i messaggi politici, il discorso pubblico, finanche le nostre inconsce convinzioni che costituiscono l’humus su cui prolifera il germe razzista. Dobbiamo saper riconoscere il Mr. Hyde, cioè la versione riprovevole e anche abominevole, del dottor Jekyll che vive ordinariamente fra noi e dentro di noi. Se non comprendiamo il legame indissolubile ancorché recondito che c’è fra il gesto estremo e violento di razzismo e la quotidiana acquiescenza verso il discorso protorazzista dello stigma e della paura per la diversità che sta dominando le nostre esistenze, rischiamo di assistere inermi alla sempre più frequente trasformazione di Jekyll in Hyde. Hitler ne è stato il campione, avendo incarnato le paure e i sentimenti di un intero popolo, che ha strutturato nella macchina della distruzione e della Soluzione finale l’organizzazione sociale tedesca nel suo complesso. Ed è per questo che la Shoah è passata inosservata nella società tedesca: è apparsa normale, banale, appunto. Quando ci si accorge che la società è diventata così, è già troppo tardi: il tarlo del razzismo, dell’esclusione, del sospetto dell’uno verso l’altro si è già insediato nel profondo. Capire, discutere, approfondire i meccanismi riproduttivi del male politico, come abbiamo fatto nel Convegno fiorentino del 2012 e in questo volume collettaneo, non è un esercizio accademico, meramente teorico; è invece la più importante delle riflessioni su noi stessi, sulla nostra esistenza e sul modello di società che vogliamo per i nostri figli.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
15
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
UGO CAFFAZ
PREFAZIONE
Questo volume collettaneo esce in un momento in cui riflettere sulla natura e sui meccanismi di costruzione del male politico è, purtroppo, quanto mai necessario e doveroso. Del resto, malauguratamente, la storia ci parla dell’inesauribile attualità di questo tema che è stato al centro del Convegno internazionale organizzato dalla Regione Toscana in occasione del Giorno della Memoria 2012, e del quale sono qui raccolti alcuni interventi. È sufficiente una rapida lettura del contributo di Tullio Seppilli sul pregiudizio e sugli stereotipi per capire quanto i meccanismi che producono o comunque incentivano il “male” siano sempre dietro e, qualche volta, persino davanti l’angolo. Tanto più in una fase storica come quella che stiamo vivendo, caratterizzata da un pericoloso intreccio fra crisi economica, crisi sociale, crisi delle istituzioni tradizionali: uno scenario che genera un insidioso e temibile grembo fertile per il diffondersi del male, in un perverso rapporto di causa-effetto con le scelte del potere politico. Basterebbe questo a spiegare perché la Regione Toscana, ormai da oltre dieci anni, coglie l’occasione del dettato legislativo non solo per rivolgere un omaggio, mai sufficiente, alle vittime della Shoah e più in generale dello sterminio nazista, ma anche per riproporre continuamente, attraverso l’analisi di quei fatti terribili, una riflessione su come costruire una società tendenzialmente più giusta e rispettosa dei diritti. Una seria politica della memoria deve rivolgersi ai cittadini non con il vuoto ritualismo che lascia indifferenti le coscienze, ma con analisi complesse in grado di fornire loro gli strumenti per capire come e perché tutto ciò è potuto accadere. Soprattutto è necessario combattere quell’analfabetismo culturale, così tanto diffuso nel nostro paese, che si manifesta nell’incapacità di leggere e comprendere la realtà, nell’assenza di quella consapevolezza critica che sola può consentire ai cittadini, e soprattutto ai giovani, di fare scelte responsabili e di stare in guardia dai germi dell’intolleranza e dagli anelli di quella catena che può portare ai peggiori crimini. Saper valutare e sapersi difendere da stereotipi e pregiudizi, imparare a comprendere e controllare i meccanismi reali della degradazione e della violenza per disinnescarli
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
16
Shoah, modernità e male politico
prima che sia troppo tardi: è questo l’obiettivo di una politica culturale che abbia a cuore l’elevamento dei livelli di conoscenza e di civiltà di un paese. È di questi mesi la vicenda della sepoltura di Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine, che ha riproposto il solito, stanco interrogativo su quali siano i tempi giusti per processare i responsabili di indescrivibili atrocità. Ed è stata anche l’occasione per il riproporsi di uno sterile e spiacevole dibattito sul negazionismo, che instancabilmente riemerge a scadenze quasi regolari, e per contrastare il quale, con buona pace di intellettuali e giuristi che cercano notorietà con dichiarazioni blasfeme, solo un impegno educativo forte può essere incisivo e fruttuoso. Cosa rispondere a quanti sostengono che, trascorsi ormai settanta anni da quei tragici eventi, non avrebbero più alcun senso le iniziative per il Giorno della Memoria, e soprattutto che sarebbero fuori luogo i processi, le condanne e le pene comminate nei confronti dei criminali nazisti? Lo scenario contemporaneo rivela, da un lato, l’insufficienza, o addirittura la natura controproducente, di ogni condanna legislativa del negazionismo: quella contro i negazionisti è una battaglia da vincere sul piano culturale, non con una messa fuori legge di quelle opinioni, che può anzi paradossalmente servire ad ammantare chi ne fa propaganda di un’aura di minoranza perseguitata. Dall’altro lato, con una crescente insistenza dettata dal tempo, si pone la questione di come gestire e tramandare una memoria senza testimoni: se fino a qualche anno fa sarebbe bastata la testimonianza dei reduci dei Lager per neutralizzare i negazionisti, l’intera politica della memoria va oggi ripensata alla luce della progressiva scomparsa delle ultime persone che hanno recato impressi nella carne e nella mente i segni delle atrocità naziste. Più in generale, credo vada fatta una riflessione sul fattore tempo. La velocizzazione imposta oggi dai ritmi della contemporaneità, ivi comprese le prestazioni comunicative legate alle nuove tecnologie, ci fanno spesso consumare il tempo senza avere la possibilità di cogliere l’evolversi degli eventi. La stessa memoria individuale va in crisi, non solo negli anziani: figuriamoci quella collettiva. Nella fattispecie degli eventi legati direttamente o indirettamente alla Seconda guerra mondiale, se esaminiamo le opinioni su quale comportamento sia giusto tenere oggi come ieri, ci troviamo di fronte a posizioni schizofreniche. Nell’immediato dopoguerra, e per almeno venti anni, si disse che era troppo presto per rievocare situazioni, nomi e responsabilità, perché erano ancora vivi i testimoni e le persone che avevano preso parte a quel periodo storico. Naturalmente questa opinione andava a braccetto con il concetto dell’amnistia per tutti, che infatti fu rapidamente approvata. Un processo come quello di Norimberga viene oggi sempre più spesso liquidato e derubricato a evento rappresentativo
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Ugo Caffaz - Prefazione
17
ed espressivo del giudizio dei “vincitori”, con il risultato di svilirne il più complessivo significato storico, giuridico e simbolico. Gli anni successivi sono stati poi utilizzati, salvo lodevoli eccezioni, per digerire e far digerire responsabilità individuali e collettive. Perciò si pensava che fosse ancora presto per aprire archivi e “armadi della vergogna”. Nel frattempo sono passati settanta anni, e a questo punto la “vulgata” sostiene che ormai si è fatto troppo tardi, tentando di cancellare quella richiesta di “giustizia storica” che i testimoni non hanno rivendicato in primo luogo per sé, ma per i milioni di esseri umani che non hanno potuto raccontare. A cominciare dai trecentomila tedeschi vittime dell’eutanasia di Stato. Analizzare il male politico, come si configura, cosa è in grado di provocare, come cercare di prevenirlo: sono alcuni dei temi che ogni anno, durante tutto l’anno, affrontiamo nella nostra regione, senza retoriche celebrative, ma convinti che le politiche della memoria, se ben attuate, sono un contributo fondamentale non solo per il futuro, ma anche per il presente.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
19
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
RENATA BADII, DIMITRI D’ANDREA
INTRODUZIONE Confrontarsi con il male: interpretare e ricordare la Shoah
Il volume che presentiamo nasce dall’intento di offrire una panoramica quanto più esaustiva possibile sulle principali interpretazioni della Shoah che sono state elaborate nel dibattito internazionale dal dopoguerra ad oggi, invitando studiosi di nazionalità e ambiti disciplinari diversi a confrontarsi sulla storia di questo evento e sulla rilevanza – culturale, politica, morale – che esso è venuto ad acquisire per il mondo contemporaneo. In linea generale, le analisi e le riflessioni sullo sterminio nazista e sul contesto storico in cui questo si è realizzato possono disporsi su due piani chiaramente distinti1, anche se intrecciati e interconnessi tra loro in molti modi. Il primo è quello della ricostruzione della genesi, dei caratteri e della dinamica di uno specifico avvenimento. Si tratta della dimensione più strettamente storiografica della conoscenza di un evento storico complesso: lo sterminio delle comunità ebraiche europee perpetrato dal governo tedesco nazionalsocialista, dai suoi alleati e collaboratori, in relazione ad uno specifico contesto storico – la stagione dei fascismi, il progetto imperialista di un Nuovo ordine europeo e le dinamiche della Seconda guerra mondiale. Muoversi su questo piano impone, quindi, un confronto serrato con le più recenti interpretazioni storiografiche e con le nuove acquisizioni conoscitive in relazione ai fenomeni del nazionalsocialismo e dei fascismi europei, alle vicende della Seconda guerra mondiale, ai caratteri e alle forme dell’imperialismo e della violenza coloniale2. Una seconda dimensione possibile della riflessione sulla Shoah è quella che si interroga, invece, sul suo significato. Questa interrogazione può, a sua volta, essere declinata in due direzioni decisamente diverse. La prima punta ad individuare il posto di Auschwitz nell’ambito della storia umana e della civiltà moderna. È questa la direzione in cui si incontrano le questioni, sempre attuali, della unicità della Shoah e della sua comparazione con altre forme di sterminio di massa, e del rapporto fra la barbarie di Auschwitz e 1 2
Su questa duplice dimensione della riflessione sulla Shoah cfr. ad esempio Bauer 2000. Con questa dimensione si misurano in primo luogo, ma non esclusivamente, i contributi della prima sezione di questo volume.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
20
Shoah, modernità e male politico
la civiltà occidentale moderna che l’ha prodotta. In questa prospettiva, la domanda “Come è stato possibile?” si muove nella dimensione squisitamente filosofica della comprensione dell’origine e delle forme del male politico e morale, ma anche della ricognizione psicologica, sociologica e antropologica sulla genesi e il ruolo della violenza nelle vicende umane3. La seconda direzione tematizza, invece, il ruolo che la Shoah ha svolto – e continua ad esercitare – nei processi di formazione dell’identità politica e delle memorie nazionali, dapprima nello scenario delineatosi con la conclusione del secondo conflitto mondiale, poi in quello apertosi con la fine della Guerra fredda e il collasso del blocco sovietico4. In questa prospettiva, uno dei nuclei problematici principali è costituito dalla ricognizione di quel lento processo di simbolizzazione che in Occidente (ma non solo) ha portato a interpretare lo sterminio degli ebrei d’Europa come la “Shoah” o l’“Olocausto”: un «evento traumatico per l’intero genere umano» in quanto «simbolo generalizzato di sofferenza umana e di male morale» (Alexander 2003: 27-8). Un approdo per nulla scontato, se consideriamo che nell’immediato dopoguerra, quando i resoconti e le immagini dei Lager nazisti erano comunque già disponibili sui media, lo sterminio delle comunità ebraiche era percepito dalla maggioranza del pubblico che leggeva quei resoconti solo come una delle “molte atrocità” della Seconda guerra mondiale. Se questo atteggiamento comincerà a mutare già nei primi anni Sessanta, in conseguenza dell’impatto mediatico del processo tenutosi a Gerusalemme contro Adolf Eichmann, soltanto a partire dai primi anni Ottanta le politiche sterministiche adottate contro gli ebrei europei e gli altri “nemici” della Volksgemeinschaft nazionalsocialista sono divenute la Shoah, trasformandosi, da accadimento marginale, nell’evento chiave della nostra rappresentazione del cosiddetto Secolo breve, e imponendosi come un tema assolutamente centrale per l’agenda politica internazionale e per la cultura, sia accademica, sia popolare. 1. Malgrado una conoscenza sempre più accurata e dettagliata delle forme in cui lo sterminio nazista è stato condotto, nonostante le acquisizioni della ricerca storiografica in merito ai fenomeni e ai processi, anche di lunga durata, che ne hanno dischiuso le condizioni di possibilità, Auschwitz continua a sottrarsi a qualunque tentativo di comprensione. Se la conoscenza della Shoah progredisce, non altrettanto si può dire della sua intelligibilità. Le ragioni sono molte. Non ultima, il fatto che Auschwitz continua a sollevare interrogativi intorno 3 4
Questo plesso di questioni è oggetto della seconda sezione del volume. Si confrontano con questi temi i contributi della terza sezione.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
R. Badii, D. D’Andrea - Introduzione
21
a questioni verso le quali la temperie post-metafisica in cui siamo immersi ci indurrebbe ad un certo disincantato scetticismo, se non ad una aperta diffidenza: il male politico, la storia, l’uomo, la civiltà. Nella risposta alla domanda “Come è stato possibile?” continua, in particolare, a sfuggirci il versante soggettivo, quello delle forme di soggettività che hanno contribuito a realizzare, condiviso, permesso lo sterminio nazista. La questione che rimane ancora senza una risposta soddisfacente – anche perché de nobis fabula narratur – è quella relativa ai moventi e agli atteggiamenti soggettivi che hanno reso possibile la barbarie nel cuore della civiltà e con le risorse della civiltà. A costituire scandalo per il pensiero è, soprattutto, l’intreccio unico fra la radicalità estrema del progetto politico – l’eliminazione fisica di interi gruppi umani, concepita come parte integrante del fine e perseguita con i migliori strumenti tecnici ed organizzativi disponibili nell’arsenale della modernità – e il coinvolgimento di massa necessario a realizzarlo. Detto altrimenti, lo scandalo della cooperazione di massa ad un progetto che avrebbe dovuto registrare, tutt’al più, la partecipazione, magari entusiastica, di ristrettissimi gruppi di fanatici. La domanda su come è stato possibile riguarda così non tanto il concepimento di un progetto di restyling biologico razziale dell’umanità che prevedeva una drastica riduzione della biodiversità, non tanto il consenso meramente politico concretizzatosi nelle procedure della democrazia liberale, quanto piuttosto il prodursi di uno sforzo organizzato, condiviso o semplicemente non ostacolato, per la sua realizzazione. È l’intreccio fra il male estremo e il male in grandi numeri ciò che resiste alla nostra comprensione. Ovvero il fatto che alla realizzazione del progetto nazista abbiano collaborato milioni di persone – in forme che vanno dalla perpetrazione attiva del carnefice alla passività dello spettatore, passando per la complessa fenomenologia della complicità. Molte delle risposte alla domanda Unde malum?, ripercorse da Zygmunt Bauman nel suo contributo in questo volume, sono appunto tentativi di risolvere uno specifico problema: non come il male sia stato concepito, ma come abbia potuto contare sulla collaborazione più o meno attiva di molti. La questione centrale è, dunque, come sia potuto accadere che una grande massa di persone sia stata disposta a farsi coinvolgere, nelle forme più diverse, in un’impresa politica genocidiaria. Al di là della diversità delle interpretazioni proposte, gli studi pionieristici di Theodor W. Adorno sulla personalità autoritaria, le ricerche sperimentali di Stanley Milgram o di Philip Zimbardo, fino alla tesi del male senza cattive intenzioni avanzata qui da Susan Neiman si propongono di rendere ragione dei grandi numeri di coloro che, a vario titolo e in modi più o meno diretti, hanno cooperato allo sterminio di massa nazista.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
22
Shoah, modernità e male politico
2. Il paradigma più noto, influente e discusso per la comprensione della partecipazione di massa al male è quello arendtiano della banalità del male. Spesso fraintesa, altrettanto spesso declinata in direzioni anche molto lontane da quelle dell’autrice, la tesi della banalità del male è probabilmente il tentativo filosofico più attrezzato di comprendere il variegato fenomeno della complicità di milioni di uomini e donne nella realizzazione dello sterminio: dal coinvolgimento attivo nelle pratiche genocidiarie all’esecuzione dei compiti organizzativi ad esse funzionali; dal consenso passivo alla mancanza di resistenza. Al di là della persuasività della sua applicazione alla persona concreta di Adolf Eichmann, il paradigma della banalità del male ha il merito di evidenziare come la collaborazione di massa al male non possa essere compresa a partire dalla generalizzazione di profonde motivazioni malvagie o di radicate convinzioni ideologiche. Quando l’impresa della produzione politica della sofferenza umana e del dolore avviene nella forma della predisposizione di una organizzazione di massa, di un apparato burocratico di Stato, occorre che i demoni del male possano avvalersi del contributo di attori e complici che non necessariamente, anzi quasi mai, hanno la profondità adeguata al male che contribuiscono a realizzare. Il male come sofferenza indotta da uomini ad altri uomini è così il risultato non tanto e non soltanto dell’attiva e convinta opera degli entusiasti o dei sadici, quanto piuttosto di una cooperazione, anche attiva, nella forma della indifferenza. In Eichmann, Arendt vede squadernata la verità che «è possibile fare il male (le colpe di omissione alla stregua di quelle commesse) in mancanza non solo di “moventi abietti” (come li chiama la legge), ma di moventi tout court, di uno stimolo particolare dell’interesse o della volizione» (Arendt 1978: 85). È l’indifferenza come assenza di preferenze, come grado zero della motivazione – come «non essere incline a nulla se non al non essere incline», per usare la definizione che ne fornisce Littell in riferimento al gesuita Girolamo Nadal (Littell 2006: 13-4) – la tipologia dell’attore del male a cui è necessario ricorrere per comprendere Auschwitz: Eichmann non si iscrisse al partito per convinzione, né acquistò mai una fede ideologica […]. Non ebbe il tempo, e nemmeno il desiderio, d’informarsi bene; non conosceva il programma del partito, non aveva mai letto il Mein Kampf. Kaltenbrunner gli disse: “Perché non entri nelle SS?”, e lui rispose: “Già, perché no?”. (Arendt 1963a: 41)
L’indifferenza che rese possibile lo sterminio nazista non fu soltanto quella degli spettatori passivi, ma anche quella di coloro «che consideravano gli ebrei degli animali e li uccidevano come un macellaio sgozza
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
R. Badii, D. D’Andrea - Introduzione
23
una vacca, lavoro divertente o faticoso a seconda dell’umore o dello stato d’animo» (Littell 2006: 105). Assai raramente, tuttavia, l’indifferenza si dà nella forma perfetta della mancanza assoluta di preferenze, motivazioni, inclinazioni verso qualcosa piuttosto che verso qualcos’altro. L’indifferenza in questa accezione pura è una condizione limite. Quasi sempre l’indifferenza sociologicamente rilevante coincide non con l’assoluta contingenza e infondatezza della scelta, non con l’assenza di motivi, ma con la loro futilità. L’indifferenza finisce, cioè, per coincidere ordinariamente con la superficialità, con il conformismo. È questa declinazione che Arendt intravede in Eichmann: «Restai colpita dalla evidente superficialità del colpevole, superficialità che rendeva impossibile ricondurre l’incontestabile malvagità dei suoi atti ad un livello più profondo di cause o di motivazioni» (Arendt 1978: 84). L’indifferenza si esprime così nella superficialità di scelte compiute per futili motivi, senza un rapporto adeguato fra l’importanza dell’azione e delle sue conseguenze e la consistenza delle motivazioni. La superficialità si dispone, infatti, sul versante opposto non soltanto dell’adesione convinta, del fanatismo ideologico, o della malvagità individuale, ma anche di una combattuta o tormentata partecipazione. La banalità del male costituisce la scoperta che all’enormità dei crimini può essere congiunta l’“aggravante” dei futili motivi, della superficialità delle convinzioni, dell’assenza di “ragioni” adeguate. Questa superficialità viene interpretata da Arendt come la manifestazione di un’assenza di pensiero, dell’interruzione di quel dialogo interiore con noi stessi, di quel «due-in-uno» che ci costituisce come persone (Belliti 2012: 163-69): Socrate pensava che gli uomini fossero due-in-uno, non nel senso che avessero tutti una coscienza e un’autocoscienza (per cui qualunque cosa io faccia, sono sempre consapevole di farla), ma nel senso più attivo e peculiare di quel dialogo silenzioso, di quel rapporto intimo e costante che tutti intrattengono con se stessi. […] In questo silenzioso dialogo tra me e me risiede la mia stessa umanità. (Arendt 1965-66: 52)
Il male senza radici è il risultato della rimozione della riflessività, del venire meno della capacità di interrogarci sul senso e sulla giustificabilità di quello che stiamo per fare. Non un tecnicismo da filosofi, ma l’attività più propriamente umana che presuppone “soltanto”, per dirla con un autore per altri versi molto lontano da Arendt, che la vita per essere autenticamente umana non debba «procedere da sé come un evento naturale, bensì essere condotta consapevolmente» (Weber 1917: 332).
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
24
Shoah, modernità e male politico
Insomma: in questo paradigma la nuova figura del male che debutta con Auschwitz sarebbe dunque il male per futili motivi, un male in e per assenza di pensiero, di riflessione. Si tratta di una forma del male storicamente non del tutto inedita, ma che diventa decisiva quando l’impresa del male diviene un’impresa di massa. L’immensità dell’orrore organizzato deve essere pensata anche come prodotto di comportamenti caratterizzati da bassa intensità di motivazione. È il coinvolgimento di massa nello sterminio, sia pure in forme estremamente diversificate, a rendere necessario un paradigma in cui sia possibile pensare ciò che sta in mezzo fra i demoni malvagi e le vittime assolute. Non si tratta di un’alternativa secca: demoni assoluti e demoni mediocri possono convivere (Forti 2012: XIX). Tuttavia, quando il male diviene fenomeno di massa, le spiegazioni incentrate sulla “grandezza” della malvagità degli attori risultano implausibili. Il grado zero della motivazione sembrerebbe, così, costituire il tassello mancante per colmare la distanza fra il male come prodotto di un’idea aberrante, di un progetto al limite della follia – qualcosa di impossibile da pensare come condiviso da milioni di persone – e il coinvolgimento di massa necessario a realizzarlo. 3. Si tratta indubbiamente di un paradigma ermeneutico di grande potenza e dall’indubbia efficacia descrittiva. Che tuttavia non è immune da difficoltà. La prima è legata proprio alla proposta di imputare la disponibilità al male ad una superficialità che viene interpretata come assenza di pensiero. A costituire un problema in questo caso è l’idea che la riflessività, il pensiero non come tecnica intellettuale, ma come atteggiamento dialogico con se stessi, possa offrire una garanzia di riconoscimento e di perseguimento del bene. Come se il bene fosse unico, o come se il pluralismo etico – le differenze fra le idee di bene – fosse destinato a risolversi per via riflessiva. Come se non potessero darsi rappresentazioni condivise e consapevoli di un’idea di bene che risultino per qualcun altro l’incarnazione stessa del male. La percezione di questo problema sembra farsi strada laddove Arendt riconosce che il regime nazista, «in effetti, annunciò l’avvento di nuovi valori e introdusse un sistema giuridico coerente con tali valori» (Arendt 1965-66: 8). Nonostante questa “apertura”, l’impostazione arendtiana ci sembra, tuttavia, rimanere interna ad una visione che troppo ottimisticamente attribuisce al pensiero la funzione di antidoto al male (Donaggio 2005: 77-8), trascurando le ragioni e la natura conflittuale del pluralismo dei valori. Se l’assenza di pensiero – come origine di un atteggiamento indifferente e superficiale – contribuisce efficacemente alla comprensione delle dimensioni di massa della partecipazione al male, molto meno per-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
R. Badii, D. D’Andrea - Introduzione
25
suasiva risulta l’idea che l’attivazione di risorse riflessive avrebbe costituito un argine solido contro una convinta adesione alle politiche e all’idea di bene comune del nazionalsocialismo. Difficoltà analoghe emergono anche da una prospettiva diversa. Se è difficile pensare ad un’indifferenza come perfetta assenza di preferenze, è ancora più difficile pensare all’indifferenza come atteggiamento assoluto nei confronti del mondo. L’indifferenza è sempre posizionata, è sempre relativa a qualcosa ed esclude qualcos’altro. Del resto, Arendt stessa ricorda la valutazione di uno dei periti psichiatrici ascoltati durante il processo, che definiva l’atteggiamento di Eichmann verso la propria famiglia e gli amici “non solo normale, ma ideale”. L’indifferenza verso gli ebrei o altre “tipologie” di esseri umani può essere congiunta nello stesso individuo ad una premurosa sollecitudine, o addirittura all’amore per gli animali, o alla disponibilità al sacrificio per i propri familiari o per i compagni. L’indifferenza è sempre selettiva, distribuita in modo non uniforme sugli enti e sugli eventi del mondo in base a sistemi di rilevanza che dipendono, in ultima istanza, dalle immagini del mondo (Weltbilder): quell’insieme di assunti cognitivi relativi a totalità che eccedono ogni esperienza possibile – il mondo, la storia, l’uomo, la società –, ma che possiedono una fondamentale funzione di orientamento pratico (Weber 1920; Blumenberg 1960, 1961; D’Andrea 2009; Badii – Fabbri 2011). È l’immagine del mondo il dispositivo che decide quali cose possano essere considerate adiaphora, e che consente di distinguere ciò che è dotato di valore da ciò che non lo è, ciò che abbisogna di motivi – di un esame attento – da ciò che invece viene dato per scontato. Il paradigma dell’orrore a bassa intensità di motivazioni e, più in generale, tutte le impostazioni che insistono sulla normalità/facilità del male rischiano di restituire un’idea della Shoah polarizzata fra pochi attori criminali fanatici e una moltitudine di complici per indifferenza, debolezza, incapacità. Un’impostazione che può facilmente tradursi nell’indicazione di costanti antropologiche o antropologizzabili che sottostimano il ruolo della condivisione di due elementi: da una parte, delle immagini del mondo – l’insieme delle credenze relative alla natura e al funzionamento del mondo – e del loro ruolo nella perimetrazione dell’indifferenza possibile; dall’altra, del profilo generale dell’idea di bene, con il suo variegato corredo di indicazioni normative, che a quell’immagine del mondo rimanda. Detto altrimenti: la partecipazione nelle forme dell’indifferenza non soltanto non esclude, ma addirittura richiede e presuppone la condivisione di un’immagine del mondo e della relativa idea di bene. In direzione di una valorizzazione del ruolo delle idee di bene e delle immagini del mondo nella genesi della Shoah, sembrano andare, sia pure
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
26
Shoah, modernità e male politico
con percorsi e obiettivi diversi, quei contributi che, anche in questo volume (Omer Bartov, Roberto Esposito, Alberto Burgio), sottolineano il carattere utopico del nazionalsocialismo, la pretesa del regime di perseguire uno scopo eticamente giustificato. Sulla base di un’immagine del mondo che dispone le “razze” come entità unitarie di carattere biologico-etico-culturale non soltanto in un conflitto mortale, ma anche su una scala gerarchica che ne differenzia il valore, il nazionalsocialismo ha costruito un’idea di bene per il popolo tedesco che, al tempo stesso, avrebbe significato l’avvento di una migliore e più piena umanità. L’eliminazione degli agenti patogeni e della contaminazione corruttrice delle razze inferiori avrebbe consentito non solo la rigenerazione fisica e morale della Volksgemeinschaft tedesca, ma anche una perfetta rispondenza fra politica e natura. La bonifica razziale avrebbe cioè finalmente portato a realizzare nella storia la definitiva adeguatezza dell’ordine politico all’ordine naturale. Il rimodellamento biologico dell’umanità (Traverso 2002: 10), l’estirpazione dell’ebreo-parassita, l’eliminazione di tutte le forme di vita “prive di valore” rimandano ad una idea di sommo bene, ad una iper-morale (Forti 2012: 170-71) a fondamento biologico-razziale. È questo lo sfondo a partire dal quale la violenza nazista pretese e vide in gran parte riconosciuta (non senza conflitti o rimozioni, come efficacemente ricostruisce Burgio nel suo contributo) la propria legittimità. Ma è questo lo sfondo indispensabile anche per comprendere la disponibilità individuale alla partecipazione indifferente. L’immagine del mondo non spiega soltanto il concepimento dello scopo, ma anche l’indifferente partecipazione dei molti che forse non ne condividevano consapevolmente gli argomenti, magari neanche i mezzi o gli entusiasmi, ma che, comunque, erano immersi in quel senso comune e nel relativo sistema di rilevanza. Il fenomeno dell’indifferenza rimanda, cioè, alla condivisione dell’immagine del mondo e dell’idea di bene che essa sostiene: una condivisione generica, non pienamente consapevole, magari intrecciata con altre credenze che rispetto ad essa risultano non perfettamente coerenti o talvolta perfino contraddittorie. L’immagine del mondo come “campo di battaglia fra razze” e una concezione del bene come eliminazione degli agenti patogeni che minano la salute del popolo tedesco costituivano due condizioni di possibilità decisive per il progetto di sterminare milioni di persone in funzione della costruzione di un ordine europeo-mondiale finalmente fondato sulla gerarchia naturale delle razze. Un’immagine del mondo e una concezione del bene che erano condivise o date per scontate anche da coloro che non avrebbero promosso o che non si sarebbero spinti a teorizzare la Soluzione finale, e che rendevano esigue, se non inesistenti, le possibilità soggettive di opposizione o resistenza alle pratiche sterministiche del regime.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
R. Badii, D. D’Andrea - Introduzione
27
4. Se il tentativo di comprendere il male in grandi numeri rimanda al fenomeno della partecipazione indifferente, coglierne fino in fondo le condizioni di possibilità significa confrontarsi con la questione forse più scandalosa: come è stato possibile che milioni di uomini e di donne abbiano condiviso un’idea di bene che consisteva nella eliminazione – non dettata da fattori contingenti – di altri milioni di uomini e donne? Si tratta di una domanda che incrocia la questione, già ricordata sopra, sul posto di Aushwitz nell’orizzonte della modernità. Molte, e non tutte perfettamente convergenti, sono, anche in questo volume, le proposte interpretative relative a questo tema. Tuttavia, un punto ci sembra ormai ampiamente condiviso: l’internità della Shoah agli scenari e ai paradigmi della modernità. Interrogarsi sul rapporto fra modernità e barbarie significa, in realtà, porsi il problema della barbarie nella modernità. I campi di sterminio sono, cioè, figli delle istituzioni, della razionalità politica, delle forme economiche, dell’idea di scienza e di tecnica tipiche della modernità europea occidentale. Auschwitz è un prodotto della modernità, anche se non un prodotto inevitabile o l’unico esito possibile. Un esito certamente perverso, ma che, tuttavia, si è potuto produrre soltanto all’interno della modernità: una possibilità integralmente figlia della grammatica e dei dispositivi della civiltà moderna. Più controverso è, invece, definire che cosa nella modernità o della modernità dischiuda lo spazio di possibilità di Auschwitz. Differenziata, e in qualche misura contraddittoria, è, infatti, in primo luogo, la modernità stessa e non soltanto la messe delle sue interpretazioni. Coglie sicuramente un aspetto decisivo del paradigma della modernità chi insiste sull’avvento di un’immagine del mondo come totalità priva di ordine e di senso, come esito di quella scomparsa del cosmo che addossa agli uomini il compito dell’autoconservazione, ma gli assicura anche l’illimitata disponibilità del mondo e della natura in particolare (Blumenberg 1966). È, tuttavia, altrettanto vero che la modernità ha ospitato fino alla fine del Novecento forme di gigantismo del bene che si appoggiavano sull’idea che il mondo avesse un senso oggettivo e che esistesse un fondamento, una direzione del divenire storico che offrisse, se non garanzie, almeno chances ai progetti politici di realizzazione di un ordine politico e sociale perfetto. La modernità è stata, così, segnata dall’idea dell’illimitata manipolabilità di un mondo e, segnatamente, di una natura privi di scopo e di direzione, ma, al tempo stesso, anche dall’aspirazione ad un ordine politico e sociale perfetto per la cui realizzazione potevano, al contrario, essere mobilitati fondamenti oggettivi, tendenze di sviluppo, forze immanenti. È su questa idea dell’accessibilità della perfezione nel tempo storico del mondo che Bauman punta, anche nel suo contributo in questo volume, per
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
28
Shoah, modernità e male politico
spiegare gli esercizi di “distruzione creativa” del XX secolo e non solo. Gli esempi estremi più evidenti di questo delirio di onnipotenza della ragione sono costituiti ovviamente dal nazionalsocialismo e dal comunismo. Entrambi condividevano in forma pura l’idea che fosse possibile realizzare in terra un ordine sociale e politico perfettamente conforme alle rispettive idee di bene. Se il gigantismo del bene li accomuna, altrettanto significativa è però la distanza che li separa – e che rende ragione delle differenze che separano le logiche delle rispettive pratiche sterministiche. Lungo una linea di ragionamento che era stata già formulata da Primo Levi, Bartov insiste, infatti, sull’internità dello sterminio nazionalsocialista alle finalità perseguite. L’eliminazione fisica di interi gruppi umani era parte integrante della realizzazione del fine, non un semplice mezzo esterno allo scopo e quindi contingente. Insomma, soltanto il comunismo sarebbe un esempio della tragedia della giustificazione dei mezzi in base ai fini: il caso esemplare di un tentativo di realizzazione di quel fine ultimo che in quanto tale possiede illimitate capacità giustificative. Il paradosso di una ricerca del sommo bene che, in quanto accetta di servirsi di mezzi terribili, è legittimata a non indietreggiare di fronte a niente: neppure a milioni di morti. Nel comunismo possiamo quindi vedere all’opera un dispositivo di produzione e di giustificazione della sofferenza e della morte inflitte per via politica che possiede una validità più generale e che, se funziona in forma esemplare laddove è possibile far balenare fini ultimi, iscritti e giustificati all’interno di una filosofia della storia, pure conserva una propria efficienza anche con fini privi di ambizione, slegati da qualsiasi idea di compimento storico, ma che possono tuttavia venire “assolutizzati”. Ha ragione Roberto Esposito a segnalare come la biopolitica delle democrazie liberali abbia nella filosofia della vita un punto di tangenza fondamentale con la tanatopolitica nazionalsocialista. È, tuttavia, vero anche che il comunismo (pur nella sua profonda e irredimibile estraneità alla nostra percezione della storia) esemplifica una via di accesso alla produzione di sofferenza con strumenti politici tutt’altro che ostruita dopo la fine del Novecento. Una via che conduce ad un male che non uguaglia in “dimensioni” i “fasti” del Secolo breve, ma che non perde la sua natura e la sua fisionomia di produzione in massa di vittime innocenti. Lo stesso “razzismo” di massa nelle democrazie occidentali contemporanee non possiede i tratti identitariobiologici di quello nazista. Se le finalità di natura biopolitica delle democrazie liberali sono tutt’altro che incapaci di produrre sofferenza e dolore per gli innocenti, la legittimazione – l’accettazione magari indifferente – di queste pratiche passa esclusivamente per la loro pretesa inevitabilità dal punto di vista del benessere di un “noi”, rimangono semplici mezzi e non sono parte integrante di un fine. La via sempre aperta al male politico non passa oggi per
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
R. Badii, D. D’Andrea - Introduzione
29
fini estremi, ma per la disponibilità a mezzi anche radicali per fini semplicemente non negoziabili (magari di natura biopolitica). L’eclissi del gigantismo del bene non ci mette al riparo dalla produzione del male. Non la definitività del fine, non la sua perfezione, ma la semplice accettazione della logica della giustificabilità dei mezzi a partire dall’importanza dei fini ci espone al rischio di quella sempre possibile assolutizzazione del fine che dischiude la porta al male della violenza su larga scala. Non soltanto i fini ultimi, ma anche quelli più semplicemente non negoziabili possono richiedere mezzi estremi e violenza di massa. È questa la lezione che in Politica come professione (1919) Max Weber ricava dalla figura del Grande Inquisitore. Il vecchio Cardinale di Siviglia incarna, infatti, per Weber la tragedia del realismo dei mezzi, gli effetti perversi e incontrollabili del ricorso, privo di limiti, alla logica del fine che giustifica i mezzi: una tragedia che accomuna millenaristi e conservatori, comunisti e antiutopisti radicali, lasciandoli in balia di una valutazione dell’importanza del fine troppo soggettiva e contingente (Weber 1919: 112; D’Andrea 2013). La disponibilità ad usare mezzi terribili è ciò che accomuna sia le politiche del fine ultimo, sia il realismo dei fini ordinari. Non l’ambiziosità del fine conta, ma la sua assolutizzazione. Se i mezzi rimangono soltanto una variabile dei fini, niente impedisce che fini anche mediocri – magari la tutela del nostro benessere materiale – vengano assolutizzati al punto di consentire pratiche che conducono alla morte per annegamento di migliaia di innocenti. Anche gli “ultimi uomini” della tarda modernità (D’Andrea 2005) possono fare cose terribili. In questa prospettiva, un possibile argine alla deriva dei mezzi – ancorché sempre fragile e precario – può essere individuato nella rinuncia incondizionata e definitiva alla utilizzabilità di certi strumenti, nella delegittimazione del ricorso a certe pratiche indipendentemente dal fine che queste dovrebbero servire. La strategia più promettente sembra cioè consistere nel sottrarre all’importanza del fine l’ultima parola sui mezzi, nel concepire la politica anche come testimonianza del rigoroso rifiuto di certi mezzi oltre che come perseguimento di fini nobili. Al di là della retorica un po’ stucchevole che spesso li circonda, i diritti umani fondamentali o il diritto internazionale umanitario sono appunto tentativi di bloccare la disponibilità dei mezzi a partire dalla bontà del fine, e sembrano ammonirci sul fatto che in politica la vera “rivoluzione” passa più per la rinuncia a certi mezzi che per l’immaginazione di nuovi fini. 5. Passando adesso a esaminare il significato che la Shoah è venuta assumendo rispetto ai processi di formazione delle identità politiche e delle memorie nazionali, merita innanzitutto segnalare due tendenze “riduzionisti-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
30
Shoah, modernità e male politico
che” che si riscontrano spesso nel dibattito pubblico relativo a questo tema. La prima, segnalata da molti storici – da Dan Diner a Peter Novick –, si è palesata quando l’impulso verso una “universalizzazione” del significato politico della memoria pubblica della Shoah si è fatto più forte, anche grazie a iniziative istituzionali di carattere regionale o internazionale come il Forum di Stoccolma del 2000, la risoluzione sull’Olocausto dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2005 e quella emanata nello stesso anno dal Parlamento Europeo. Paradossalmente, nel momento in cui il “dovere di memoria” verso le vittime del nazionalsocialismo sembrava raggiungere un riconoscimento internazionale, ha cominciato a profilarsi una crescente discrasia: all’onnipresenza della Shoah – nelle commemorazioni pubbliche, nel lessico politico, nell’immaginario plasmato dal cinema e dalla letteratura – sembra corrispondere, infatti, una sempre minore consapevolezza storica di quell’evento. Il rischio è insomma quello di una memoria della Shoah che eclissa progressivamente la conoscenza di quello specifico sterminio in quanto fenomeno storico. O meglio: che Auschwitz come simbolo universale del male e icona della memoria si autonomizzi sempre più dalla distruzione degli ebrei d’Europa; e che questa simbolizzazione, dal punto di vista della nostra coscienza storica, promuova una visione in bianco e nero del passato. Una tendenza che testimonia forse la nostalgia dell’Occidente per quelle narrazioni teleologiche della storia che proprio l’evento Auschwitz ha mandato in frantumi (Benjamin 1940: 79; Diner 2005: 32, 39), ma che di certo impedisce di rendere conto della complessità dell’avvenimento stesso. Memoria contro conoscenza storica, dunque. Il dibattito pubblico sulla Shoah rischia però di scivolare anche lungo una china opposta: ritenere che la conoscenza dell’evento esaurisca di per sé la questione della Shoah nello scenario contemporaneo. Senza dubbio, sarebbe assurdo pensare di poter comprendere l’evento che chiamiamo “Shoah” prescindendo dai risultati delle ricerche storiografiche sulla Soluzione finale e sulle altre politiche sterministiche del Terzo Reich e dei suoi alleati, che a partire dagli anni Ottanta sono cresciute esponenzialmente. La divulgazione delle nuove acquisizioni della ricerca archivistica, la creazione di istituti specializzati nel reperimento e nella catalogazione delle fonti e delle testimonianze, da ultimo i progetti come l’EHRI (European Holocaust Research Infrastructure)5 rappresentano, al tempo stesso, altrettante tappe rilevanti di quel lento processo che ha radicalmente trasformato la percezione che le “persone comuni” hanno oggi di 5
Infrastruttura creata, grazie al finanziamento del Programma Quadro della Commissione Europea, dai principali centri di ricerca europei sulla Shoah insieme allo Yad Vashem di Gerusalemme con la finalità di integrare in un unico database i moltissimi archivi, grandi e piccoli, disseminati sul continente europeo.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
R. Badii, D. D’Andrea - Introduzione
31
questo evento rispetto a quella che se ne aveva nell’immediato dopoguerra. Un processo che, peraltro, ha visto convergere attori diversissimi tra loro – i sopravvissuti, i loro discendenti, la comunità accademica, le istituzioni politiche e le agenzie educative, gli esponenti del mondo dei media e dell’arte – nel tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla “frattura di civiltà” (Zivilisationsbruch)6 rappresentata da Auschwitz. Possiamo, tuttavia, affermare che la migliore e maggiore conoscenza storica della Soluzione finale raggiunta in questi ultimi decenni sia, di per sé, in grado di spiegare perché questo evento viene interpretato come il massimo esempio di male politico da parte di persone che non l’hanno vissuto, o che addirittura non erano nate all’epoca dei fatti? È solo la conoscenza dell’evento che spiega la rilevanza che lo sterminio degli ebrei d’Europa ha acquisito per la riflessione morale, la sensibilità politica e l’immaginario culturale dei contemporanei? O forse, per poter rispondere a queste domande, è necessario che la conoscenza storica interagisca con altri saperi? La questione che traluce da questo plesso di problemi è, dunque, se la storia, in quanto disciplina, sia l’unico sapere, o quello più epistemologicamente attrezzato, per comprendere le ragioni e il senso del processo di ricezione culturale che ha caratterizzato la Shoah negli ultimi trent’anni. Se una memoria senza conoscenza storica porta indubbiamente con sé il rischio di sacralizzare Auschwitz ai fini di una nuova grande narrazione storica, un approccio esclusivamente storiografico rischia di rendere superflua la domanda sul perché i contemporanei vedono nella Shoah un male che parla ancora di noi e del nostro mondo, nonostante la crescente distanza temporale dai fatti. Il rischio, insomma, è di “naturalizzare” Auschwitz, soprattutto agli occhi delle nuove generazioni, trasformando la riflessione e la memoria pubblica di questo evento in un qualcosa di “normale”, ovvio ed eterno. Oltre a voler evidenziare 6
Categoria, quest’ultima, proposta dallo storico Dan Diner proprio per riconciliare le due prospettive, prima facie contrastanti, da cui possiamo guardare all’evento della Soluzione finale: da un lato una prospettiva particolare, relativa all’esperienza concreta vissuta dalle vittime di questo sterminio (gli ebrei europei), e fondata su argomentazioni propriamente storiche; dall’altro lato, una prospettiva universale, che si appoggia piuttosto su argomentazioni che Diner definisce “antropologiche”, e vede in questo particolare caso di sterminio «un orrore che si situa al di là del male tradizionalmente inteso», perché si tratta di un atto che ha infranto i fondamenti stessi di ciò che siamo soliti chiamare civiltà: «un caso singolare di eliminazione di persone da parte di altre persone che va al di là del limite, fino allora valido e universalmente riconosciuto come indiscutibile, di ciò che non può e non deve accadere in nessun caso» (Diner 2005: 27, 20). Sulla Shoah come Zivilisationsbruch cfr. anche Diner 1988 e 2000.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
32
Shoah, modernità e male politico
l’importanza di considerare congiuntamente i due aspetti costitutivi della Shoah, richiamati all’inizio di questa Introduzione, l’impianto del volume risponde dunque anche alla necessità di creare occasioni di dialogo tra discipline diverse, nella convinzione che soltanto attraverso una prospettiva interdisciplinare si può sperare, da un lato, di comprendere un evento complesso come la Shoah, e, dall’altro, di tener viva la domanda sul suo significato per i contemporanei. 6. L’impostazione del volume risponde, inoltre, anche ad una finalità divulgativa. Nel mondo contemporaneo, la conoscenza e la percezione che gli individui hanno della “storia” è sempre più interconnessa alla memoria pubblica e istituzionale di certi eventi, ed è quindi ancora più importante rendere avvertito il pubblico (segnatamente i lettori più giovani) che la storia è sempre soggetta anche a usi e abusi politici7, che la memoria si declina necessariamente al plurale, e che, oltre ai conflitti storiografici sulle interpretazioni del passato, esistono anche conflitti di memorie che perdurano nel presente. Ricordare quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante per comprendere come il lento processo culturale che ha trasformato lo sterminio nazista nel massimo esempio di male politico della storia non abbia affatto seguito un percorso lineare, né a livello internazionale né all’interno dei singoli contesti nazionali. A tale riguardo, la prima questione che si pone è quella del significato universale, o piuttosto soltanto occidentale, della Shoah. In relazione alla valenza universale della Shoah, studiosi come Daniel Levy e Natan Sznaider (2001) hanno parlato di “cosmopolitizzazione della memoria”, interpretando il ricordo dello sterminio degli ebrei europei come un primo esempio di memoria collettiva nell’epoca della globalizzazione, capace di trascendere i confini nazionali così come le differenze etniche e religiose8. Questa tesi, sviluppata poi da molte altre ricerche, ha l’indubbio merito di evidenziare due processi che hanno riguardato la memoria della Shoah negli ultimi decenni. In primo luogo, la riflessione pubblica sulla Shoah ha profondamente plasmato le “politiche della memoria”, riattivando un interesse internazionale per le ricerche sulla “memoria collettiva” e le sue trasformazioni, così come per il ruolo che il “fare i conti con il passato” riveste nei processi di riconciliazione e, più in generale, per la giustizia di
7 8
Per una problematizzazione del concetto di uso politico della storia cfr. Gallerano 1999. Sul carattere transnazionale della memoria della Shoah cfr. anche Huyssen 2000.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
R. Badii, D. D’Andrea - Introduzione
33
transizione9. In secondo luogo, la Shoah si è progressivamente affermata come un tema centrale nell’agenda della politica internazionale: basti ricordare la già menzionata conferenza sulla Holocaust Education, Remembrance and Research promossa dall’International Forum di Stoccolma nel 200010 e l’Holocaust Outreach Programme creato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in seguito alla risoluzione sulla Holocaust Remembrance del 2005. Ma tutto questo è sufficiente per affermare che ci troviamo al cospetto di processi legittimamente interpretabili come un esempio di cosmopolitizzazione della memoria? A nostro parere, il “mondo” di cui si parla in relazione al significato della Shoah è in primo luogo l’Occidente, o più esattamente l’Europa occidentale, il Nord America e Israele: sono questi gli ambiti geografici e politici in cui la Shoah si è affermata, nel corso della seconda metà del Novecento, come una componente essenziale dell’identità nazionale, della cultura politica e della memoria collettiva – peraltro secondo traiettorie e tempistiche profondamente diverse. Ed è solo all’interno di questo specifico quadro culturale che si è posta la questione del significato universale e dell’unicità di questo caso di sterminio11. D’altro canto, sarebbe riduttivo pensare che il significato della Shoah sia sconosciuto, o addirittura incomprensibile, al di fuori dell’Occidente. Come ricorda Christopher Browning all’inizio del suo contributo, citando il caso di una vignetta satirica su Hitler e un leader vietnamita apparsa nella stampa della Repubblica Popolare Cinese all’epoca dei boat people, il valore simbolico dello sterminio nazista come massimo esempio di male politico è comunque riconosciuto anche in contesti culturali e politici profondamente diversi da quelli occidentali. Ma ciò non equivale ad affermare che la Shoah sia divenuta eo ipso l’unità di misura del male politico in tutto il mondo: per la storia culturale e politica dei paesi dell’America Latina, e soprattutto di quelli asiatici, mediorientali e africani, sono altri i traumi, legati principalmente al passato coloniale o a casi nazionali di violenza politica di massa, che plasmano i processi di costruzione dell’identità nazionale e/o regionale e della memoria collettiva. 9 10
11
Cfr. Portinaro 2011: 202-10, anche per un quadro d’insieme della letteratura su questi temi. La Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (ITF), creata nel 1998 dall’allora primo ministro svedese Göran Persson per l’organizzazione della conferenza sull’Olocausto, si è poi istituzionalizzata in una organizzazione intergovernativa (l’IHRA – International Holocaust Remembrance Alliance) che conta trentuno Stati membri, quattro paesi osservatori, e sei osservatori permanenti. Per un inquadramento del tema dell’unicità della Shoah e le sue molteplici accezioni ci permettiamo di rinviare a D’Andrea – Badii 2010: 26-37.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
34
Shoah, modernità e male politico
7. Come cittadini europei, tuttavia, la questione che forse più ci riguarda non è l’universalizzazione, quanto piuttosto l’“europeizzazione” della Shoah e della sua memoria, come segnalano Enzo Collotti e Diego Guzzi nei loro contributi. Alla luce delle trasformazioni che hanno investito le diverse narrazioni nazionali della storia e della memoria nel corso della seconda metà del Novecento, l’Europa si presenta infatti ancora oggi come uno scenario profondamente differenziato, per non dire apertamente diviso secondo una linea Est-Ovest. Paradossalmente, nonostante i milioni di pagine dedicate allo sterminio nazista e alla sua memoria dalla letteratura internazionale, oggi sono proprio i paesi dell’Europa orientale, vale a dire le aree geografiche in cui viveva la maggioranza della popolazione ebraica europea prima dell’inizio della Seconda guerra mondiale e dove lo sterminio è stato materialmente commesso, quelli in cui stenta maggiormente ad affermarsi un’attenzione ai luoghi della sua esecuzione, sia dal punto di vista della ricerca storiografica, sia da quello della memoria collettiva12. Le ragioni di questa disattenzione sono molteplici e variano da paese a paese; tuttavia, cercando un elemento comune tra le diverse politiche della memoria che hanno caratterizzato i paesi dell’Europa centro-orientale negli ultimi trent’anni, questo è sicuramente rappresentato dalla rielaborazione, in forma di trauma, dell’esperienza socialista. Con le trasformazioni politiche del biennio 1989-1991 non è arrivata soltanto la volontà di cambiare il proprio futuro, abbracciando i valori della liberaldemocrazia e riconquistando un’autonomia nazionale a lungo repressa dall’egemonia sovietica; la necessità di costruire una nuova identità politica ha implicato anche, com’è comprensibile, una profonda rilettura del passato recente e, segnatamente, di quell’evento spartiacque del XX secolo che è stata la Seconda guerra mondiale. Così, se la memoria istituzionale dell’epoca socialista leggeva l’8 maggio 1945 come la liberazione dall’incubo del nazifascismo, dopo la caduta del muro di Berlino quella data è stata reinterpretata dalle nuove istituzioni democratiche dell’Europa orientale come l’inizio di un nuovo incubo, durato quarant’anni13. A partire dai primi anni Novanta, 12
13
Si vedano ad esempio i contributi di Bartov (2007, 2008) sul caso della Galizia Orientale, oggi Ucraina, dove la ricostituzione di un’identità nazionale ucraina in epoca post-sovietica ha finora completamente rimosso dalla narrazione storica collettiva e dalla memoria pubblica non soltanto lo sterminio ebraico, ma anche la storia delle comunità ebraiche che, prima dello sterminio, avevano vissuto per secoli nella regione insieme alle comunità cristiane. In realtà, il quadro si complica molto qualora si consideri il rapporto tra la nuova memoria istituzionale e la memoria collettiva del passato socialista nelle diverse società dell’Europa orientale. La questione eccede l’oggetto di questo contributo,
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
R. Badii, D. D’Andrea - Introduzione
35
dunque, nell’Est europeo fare i conti con il proprio passato ha voluto essenzialmente dire confrontarsi con la questione dei crimini sovietici e dei governi socialisti, non con le politiche sterministiche del nazionalsocialismo e dei suoi collaboratori14. In questo processo di ridefinizione dell’identità politica e di reinterpretazione del passato nazionale, la questione della Shoah – peraltro già marginale per la memorializzazione dell’epoca socialista, perché adombrata dalla retorica della resistenza armata e della vittoria sul nazionalsocialismo – è stata per lo più dimenticata. Anzi, in alcune delle nuove nazioni nate dalla dissoluzione del blocco sovietico, il processo di smantellamento dell’identità e della memoria pubblica dell’epoca socialista si è spinto fino al punto di reinterpretare la collaborazione con la Germania di Hitler durante la guerra come un atto di patriottismo, oscurando completamente la questione della responsabilità nazionale rispetto alla partecipazione attiva allo sterminio delle comunità ebraiche e dei civili dell’allora Unione Sovietica. Emblematico, al riguardo, il caso della Lettonia, dove da vent’anni ogni 16 marzo i reduci della Legione lettone delle Waffen-SS sfilano per le strade di Riga, accompagnati da centinaia di persone, fino al Monumento alla Libertà (l’obelisco che ricorda l’indipendenza lettone), per commemorare quelli che, dopo il 1991, vengono chiamati “i difensori della patria
14
ma vorremmo almeno segnalare il caso dell’ex Repubblica Democratica Tedesca e del fenomeno dell’Ostalgie, noto anche al di fuori del contesto tedesco per i romanzi di Thomas Brussig o il successo internazionale di un film come Good Bye, Lenin! di Wolfgang Becker (2003). Questo neologismo (crasi di Ost – est – e Nostalgie – nostalgia), diffusosi fin dai primi anni Novanta, segnala quantomeno un rimpianto, da parte degli ex tedeschi orientali, per alcuni elementi dell’esperienza socialista e dello stile di vita tipico della DDR, nonché una critica al trionfalismo con cui è stato accolto l’ingresso nel mondo del libero mercato da parte di altre società degli ex paesi socialisti. Su questo tema segnaliamo le eccellenti mostre promosse dal Deutsches Historisches Museum di Berlino per il cinquantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale: 1945. Der Krieg und seine Folgen. Kriegsende und Erinnerungspolitik in Deutschland (1945: la Guerra e le sue conseguenze. Fine del conflitto e politica della memoria in Germania, aprile-agosto 2005), incentrata sul caso tedesco e l’impatto della riunificazione sulla nuova memoria nazionale tedesca, e Mythen der Nationen. 1945 – Arena der Erinnerungen (I miti delle nazioni. 1945: l’arena delle memorie, ottobre 2004-febbraio 2005), dedicata invece ad un confronto tra le trasformazioni della memoria della Seconda guerra mondiale occorse rispettivamente nell’Europa occidentale e in quella centro-orientale. Per una recensione delle due esposizioni cfr. Duranti 2006.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
36
Shoah, modernità e male politico
contro la seconda invasione sovietica”15. Questo nonostante le proteste dei movimenti antifascisti lettoni e delle associazioni ebraiche di tutto il mondo; e malgrado il fatto che il paese, contemporaneamente al suo ingresso nell’Unione Europea, sia divenuto membro permanente anche dell’International Holocaust Research Alliance, l’organizzazione intergovernativa nata dal Forum Internazionale sull’Olocausto con la missione di promuoverne la memoria così come la ricerca e la divulgazione scientifica, soprattutto all’interno dei diversi curricula scolastici. Se consideriamo i paesi dell’Europa occidentale, invece, in questi stessi anni lo sterminio degli ebrei europei diveniva lentamente l’evento centrale della nostra autorappresentazione. Dal punto di vista della narrazione storica e della memoria collettiva, a partire dagli anni Ottanta la Shoah è infatti divenuta l’elemento cardine della nostra interpretazione della stagione dei fascismi e della Seconda guerra mondiale, mentre dal punto di vista della nostra identità in quanto europei lo sterminio delle comunità ebraiche è stato certamente l’evento che ci ha costretto, più di ogni altro accadimento della nostra storia, a ripensare la forma di civiltà nata dalla modernità europea e a prendere coscienza delle sue patologie e dei suoi fallimenti. Inoltre, la Shoah come simbolo del male politico, segnalatore d’incendi rispetto ai pericoli dell’intolleranza, del razzismo e della xenofobia, è stata incorporata nella cultura dei diritti umani che informa le identità politiche dei diversi paesi dell’Europa occidentale, soprattutto in seguito al riemergere di casi di violenza di massa e odio etnico all’interno dello spazio europeo con la guerra nella ex Iugoslavia e l’intervento NATO in Kosovo. Più complessa invece, anche rispetto a questa area dell’Europa, è la questione della presa di coscienza, da parte delle diverse società, circa le responsabilità che il proprio paese ha avuto nel processo di schedatura, deportazione e uccisione della popolazione ebraica – sia in relazione ai propri concittadini, sia rispetto a quanti, in fuga dalla Germania nazista, avevano trovato un rifugio temporaneo in altre nazioni europee. Riguardo a tale questione non possiamo non considerare il caso dell’Italia, dove gli stereotipi del “cattivo tedesco” e del “bravo italiano” hanno profondamente condizionato la memoria nazionale dal dopoguerra a oggi, esimendoci dal fare i conti sia con il carattere genocidiario del colonialismo italiano e i crimini di guerra perpetrati dall’Italia monarchico15
Così recita la targa del monumento ai Legionari lettoni delle Waffen-SS, costruito nella piazza principale della cittadina di Bauska grazie a donazioni private e inaugurato nel settembre 2012 alla presenza delle autorità locali. La vicenda ha sollevato le proteste non solo delle associazioni antifasciste ed ebraiche, ma anche della comunità russofona residente in Lettonia, dell’Ambasciata russa a Riga, e dei ministri degli Esteri di Bielorussia e Israele.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
R. Badii, D. D’Andrea - Introduzione
37
fascista nella guerra combattuta accanto al Terzo Reich16, sia con la questione della partecipazione attiva di vastissimi strati della popolazione alla campagna antisemita organizzata dal regime. Il mito degli “italiani brava gente”, in base al quale gli italiani sarebbero stati sì fascisti, però mai razzisti e tantomeno antisemiti, e le violenze contro gli ebrei sarebbero da imputarsi soltanto ai barbari occupanti tedeschi, è, infatti, ancora profondamente radicato nell’immaginario nazionale, e sarebbe interessante valutare quanto questo mito sia stato rinvigorito da un film come l’acclamatissimo La vita è bella di Roberto Benigni. A differenza di quanto è successo in Germania dal dopoguerra a oggi, dove la questione della “colpa collettiva” è stata un elemento centrale dell’identità democratica tedesca, la società italiana e le sue istituzioni stentano ancora a prendere coscienza del carattere sterministico del regime fascista e dell’ampio consenso popolare riscontrato dalle sue politiche razziali – rivolte dapprima contro le popolazioni africane dell’Impero, poi contro gli ebrei italiani e stranieri. Per non dire del tentativo di utilizzare proprio il riferimento all’antisemitismo per difendere un’immagine edulcorata del fascismo come dittatura “dal volto umano”, indicando nelle Leggi razziali del 1938 l’“unico errore” di cui il regime si sarebbe macchiato. Paradossalmente, la difficoltà ad includere nella memoria nazionale anche le pagine più buie della nostra storia recente ha trovato una sponda inintenzionale persino nel paradigma memorialistico incentrato sulla Resistenza antifascista, evento fondativo della Repubblica e della sua cultura politica democratica. Si tratta di un punto delicato. In questione qui non è l’interpretazione della Resistenza come evento fondativo della democrazia italiana, né si intende mettere in dubbio la doverosità del riconoscimento tributato dalle istituzioni repubblicane ai meriti conquistati da una parte della popolazione nel corso della guerra di Liberazione. L’aspetto problematico è costituito, invece, dal fatto che, in molti casi, la memoria della Resistenza è stata usata come alibi per rimuovere dal dibattito pubblico il dato di fatto del consenso di massa degli italiani al fascismo, in generale, e alle sue politiche persecutorie e sterministiche, in particolare. Un dato ormai documentato da molte ricerche storiografiche, ma che continua ad essere volutamente taciuto da quanti – nel settore dell’informazione, ma anche nelle stesse istituzioni politiche – insistono nel raccontare al paese una lettura auto-assolutoria dell’esperienza fascista, seguitando ad addossare soltanto sui “cattivi tedeschi” tutte le responsabilità della persecuzione antiebraica e dei crimini di guerra17. 16 17
Sull’imperitura influenza di questi due stereotipi rispetto alla memoria pubblica italiana si veda Focardi 2013. Sul silenzio delle istituzioni e dei media italiani rispetto ai crimini del nostro colonialismo cfr. Collotti et al. 2000.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
38
Shoah, modernità e male politico
8. Di fronte a questa arena europea delle memorie è opportuno riflettere anche sulle politiche della memoria che l’Unione Europea ha adottato negli ultimi decenni nel suo tentativo di promuovere una comune “coscienza europea” tra le società dei diversi Stati membri, analizzando in particolare la funzione attribuita al ricordo della Shoah18. Indubbiamente l’Unione si è impegnata molto, anche a livello di finanziamenti alla ricerca e ai programmi educativi, per mantenere vivo il ricordo dello sterminio nazifascista delle comunità ebraiche, e da tali politiche emerge chiaramente come la memoria della Shoah rappresenti per l’Unione una scommessa politica sul futuro delle società europee. Se consideriamo infatti i documenti ufficiali relativi a questo tema, promossi soprattutto dal Parlamento Europeo, possiamo notare che le istituzioni europee guardano alla Shoah non tanto come a un evento storico che può sostanziare l’idea di un passato comune degli europei; il ricordo della Shoah e l’insistenza sull’unicità di questo specifico caso di violenza di massa hanno piuttosto una funzione proattiva, orientata al futuro e preventiva. In altri termini, nelle intenzioni delle istituzioni europee l’evento Shoah non dice tanto chi siamo e da dove veniamo, ma chi vorremmo essere in quanto europei, indicando i pericoli che minacciano tuttora le istituzioni democratiche e la convivenza pacifica dei popoli europei. Più che una memoria condivisa, secondo alcuni analisti l’Unione Europea avrebbe infatti trovato nel monito “Mai più Auschwitz!” il fondamento di una nascente moralità politica europea, incentrata sull’imperativo di contrastare il diffondersi di forme di intolleranza, discriminazione razziale e xenofobia all’interno delle società democratiche dello spazio comunitario19. La stessa Risoluzione del Parlamento Europeo sul ricordo dell’Olocausto lo collega subito, già nel nome del documento, a due fenomeni come l’antisemitismo e il razzismo, di cui il testo segnala la drammatica attualità (Parlamento Europeo 2005a). In effetti, la Risoluzione può considerarsi il punto di arrivo di un processo di sensibilizzazione degli Stati membri, guidato dal Parlamento Europeo, che è iniziato nei primi anni Ottanta e ha riguardato congiuntamente due fenomeni: l’ascesa di nuovi movimenti neofascisti e xenofobi nell’arena politica europea e il ripresentarsi di casi gravi di antisemitismo e razzismo che, soprattutto dopo il 1991, interessano sia i paesi dell’Europa occidentale sia quelli dell’Europa centrale e orientale. Anche il documento in cui si incontra un primo riferimento alla memoria dell’Olocausto e all’importanza di contrastare il negazionismo storico, cioè la Risoluzione su razzismo, xenofobia e antisemitismo del 1994, vuol essere una risposta alla crescita allarmante di episodi di xe18 19
Per un inquadramento di questo tema cfr. il volume collettaneo RI.LE.S. 2009. Cfr. ad esempio Dubiel 2003, Probst 2003.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
R. Badii, D. D’Andrea - Introduzione
39
nofobia denunciata dai rapporti prodotti nel 1985 e nel 1991 dal Comitato di inchiesta sull’ascesa del razzismo e del fascismo in Europa, istituito dal Parlamento20. Al tempo stesso, questa risoluzione inaugura una nuova attenzione dell’Unione rispetto alla memoria della Shoah, a cominciare dalla questione della conservazione del campo di sterminio di Auschwitz21, che porterà poi, all’inizio del nuovo millennio, a istituzionalizzare la data del 27 gennaio come Giorno europeo della Memoria non solo per ricordare le vittime della violenza nazista, ma anche per contrastare qualsiasi atto di odio razziale e di discriminazione nel presente, e impedire in futuro il riproporsi di forme di razzismo e di violenza genocidiaria22. Conoscenza e ricordo della Shoah come prevenzione del male, dunque. Tuttavia, la domanda che si pone nell’attuale scenario europeo riguarda la reale condivisione, da parte di tutti gli Stati membri, di questo significato politico assegnato alla Shoah e alla sua memoria. È noto che l’Unione europea ha imposto de facto il riconoscimento del significato civico della memoria istituzionale della Shoah ai nuovi Stati membri dell’Est come una specie di attestato di democraticità e di rispetto della cultura politica dell’Unione. Al tempo stesso, però, le istituzioni europee sembrano essere ben consapevoli del fatto che, per rafforzare realmente il senso di appartenenza dei cittadini e dei governi di tutti gli Stati membri, le politiche europee della memoria e dell’identità dovranno includere anche altre “lezioni dal passato” oltre a quella simboleggiata dalla Shoah. Rispetto a tale questione, la strategia adottata dall’Unione nei documenti più recenti relativi alla promozione di una comune coscienza europea, più che proporre un paradigma memorialistico nuovo, sembra piuttosto ricalcare la politica della memoria incentrata sull’idea di antitotalitarismo sperimentata dalla Germania, lo Stato membro che più di ogni altro si è trovato a confrontarsi con la questione delle diverse memorie del Novecento in seguito alla storica riunificazione del 1990. 20
21 22
Cfr. Parlamento Europeo 1985, 1994 e Ford 1992. A partire dal 1987, il monitoraggio sui fenomeni di razzismo e xenofobia nello spazio comunitario sarà il principale compito dell’agenzia EUMC (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia), cui è succeduta nel 2007 la European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Si vedano la Risoluzione del 1995 relativa all’instaurazione di una data per commemorare l’Olocausto in tutti gli Stati membri, e la Risoluzione del 1996 sul campo di stermino di Auschwitz. Rispetto a questo processo di istituzionalizzazione, alcuni Stati membri dell’Unione, tra cui l’Italia, anticipano com’è noto la stessa Risoluzione del Parlamento Europeo. Per una ricostruzione del dibattito politico italiano e dell’iter parlamentare che ha portato alla Legge 211 del luglio 2000 sulla “Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti” cfr. Cruzzolin 2009.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
40
Shoah, modernità e male politico
Nel contesto tedesco post-riunificazione, infatti, il concetto di antitotalitarismo ha costituito il quadro ideologico che ha consentito l’integrazione delle istituzioni dell’ex Germania orientale all’interno dell’infrastruttura politica della nuova Repubblica Federale Tedesca; al tempo stesso, questa lettura antitotalitaria della svolta del novembre 1989 ha permesso alle istituzioni di includere la storia dell’ex DDR all’interno della nuova memoria nazionale tedesca (Kansteiner 2006: 265 ss.). Ciò ha implicato una rappresentazione della Repubblica Democratica Tedesca come regime totalitario che è apparsa a molti analisti una prosecuzione dell’immagine della DDR tipica della Germania occidentale all’epoca della Guerra fredda, e che è stata criticata, nel contesto tedesco e altrove, come una ricostruzione limitata e distorcente23. Tale rappresentazione, tuttavia, è divenuta parte integrante di un «consenso istituzionale incentrato sull’antitotalitarismo», ritenuto assolutamente necessario dall’élite politica per il raggiungimento dell’unità nazionale all’interno del nuovo Stato tedesco (Beattie 2008: 38 ss.)24. Un processo simile sembra essere in atto anche all’interno delle stesse istituzioni europee, nel senso che anche l’Unione sembra ascrivere alla categoria di antitotalitarismo la capacità di armonizzare in un’unica narrazione le diverse memorie e identità presenti nello spazio europeo. Basti considerare la Risoluzione sul sessantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale del 2005, dove il Parlamento Europeo riconosce che la conclusione del conflitto ha significato per alcune nazioni l’assoggettamento a una nuova tirannia imposta dall’Unione Sovietica stalinista, ribadendo la ferma opposizione di tutte 23 24
Per un’analisi di questo dibattito cfr. Sayner 2011. L’affermarsi di una politica della memoria e dell’identità nazionale incentrata sull’idea di antitotalitarismo ha anche profondamente depotenziato quella memoria antifascista del Novecento, incardinata invece sulla condanna del nazionalsocialismo e degli altri regimi fascisti europei, che aveva rappresentato fino al 1989 un elemento centrale della memoria istituzionale non solo della Germania orientale, ma anche dei paesi fondatori dell’allora Comunità europea. Come ha osservato Joanne Sayner (2011: 239), nel contesto tedesco post-riunificazione la retorica istituzionale antitotalitaria tende a presentare l’antifascismo non più come un movimento di opposizione a un regime dittatoriale, ma piuttosto come un suo risultato sintomatico. Rispetto a tale questione, la Germania non è tuttavia un’eccezione nel contesto europeo: anche in Italia, a partire dai primi anni Novanta, il revival della categoria di totalitarismo, promosso soprattutto dai media, ha profondamente contribuito a screditare l’idea di antifascismo e il suo significato storico per la cultura politica democratica del nostro paese. La nozione di totalitarismo ha infatti promosso una distorcente semplificazione dell’esperienza comunista, ridotta de facto allo stalinismo sovietico, che è stata funzionale a presentare anche l’antifascismo italiano come un fenomeno antidemocratico perché “essenzialmente comunista”. Per una ricostruzione del dibattito italiano su questo tema cfr. Prezioso 2008.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
R. Badii, D. D’Andrea - Introduzione
41
le istituzioni europee contro «ogni potere totalitario, di qualunque credo ideologico» (art. 4); oppure la Risoluzione su coscienza europea e totalitarismo del 2009, che indica chiaramente nell’esperienza degli opposti totalitarismi il «retaggio comune» dei paesi europei (art. K). L’operazione è, dunque, quella di equiparare, attraverso la categoria di totalitarismo, le esperienze politiche del nazionalsocialismo, dei diversi fascismi e dello stalinismo, presentandole come il nemico comune delle istituzioni e dei valori liberaldemocratici che hanno animato il progetto d’integrazione europeo fin dalle sue origini. Le ragioni di questa politica della memoria sono comprensibili, considerando l’odierno scenario europeo, ed è sicuramente condivisibile l’esortazione del Parlamento ad avviare un dibattito «onesto e approfondito» sui crimini perpetrati dai diversi regimi totalitari nel secolo scorso, nella convinzione che la promozione di un senso di comunanza e di solidarietà tra gli europei richieda anche il riconoscimento reciproco dei diversi drammi e fallimenti che hanno caratterizzato la storia novecentesca delle nazioni oggi parte dell’Unione. Tuttavia, sembra legittimo chiedersi se non esistano possibili tensioni tra, da un lato, la promozione di una cultura politica che individua nella Shoah il “massimo esempio” di male politico e che, ricordando continuamente il pericolo del neofascismo e del revisionismo storico, conserva una chiara connotazione antifascista; e, dall’altro lato, il tentativo di promuovere una coscienza europea incentrata invece su un’idea di antitotalitarismo che rischia di oscurare le diversità dei regimi. Lo stesso Parlamento Europeo sembra essere consapevole di questa tensione, dal momento che proprio nella Risoluzione su coscienza europea e totalitarismo tiene a ribadire l’importanza di riconoscere «l’unicità dell’Olocausto» rispetto agli altri casi di violenza politica di massa perpetrati nel corso del XX secolo. Il punto problematico, però, è rappresentato dalla categoria stessa di totalitarismo che, proprio per la sua intrinseca valenza omogeneizzante, rischia di ingenerare semplificazioni distorcenti, e di impedire a priori una comparazione oggettiva fra i diversi totalitarismi in merito al loro rapporto con la violenza genocidiaria e con il razzismo. Se questa comparazione viene meno, risulta impossibile comprendere e argomentare la specificità dello sterminio delle comunità ebraiche sia rispetto alle altre politiche sterministiche perpetrate dal Terzo Reich e dai suoi alleati, sia rispetto ai molteplici casi di violenza politica di massa perpetrati da altri regimi politici. E divengono parimenti incomprensibili le ragioni che hanno portato le stesse istituzioni europee a scommettere politicamente sulla memoria della Shoah come strumento di educazione civica e di prevenzione rispetto a nuovi casi di sterminio e di odio razziale. In altri termini, il rischio implicito in questa scelta è che ognuno continui a riconoscere e a “piangere” esclusivamente i traumi che già percepisce come “suoi”.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
42
Shoah, modernità e male politico
9. Un tema che ritorna in diversi contributi, segnatamente in quelli che compongono la terza sezione del volume, riguarda proprio la funzione educativa attribuita all’insegnamento della Shoah nella scuola. Per perimetrare tale questione può essere utile prendere le mosse da una considerazione di carattere linguistico. Nonostante la loro diffusione nel lessico comune come in quello specialistico, i termini “Olocausto” e “Shoah” suscitano ancora un senso di inadeguatezza, come se si trattasse di parole comunque imperfette rispetto al tentativo di dare un nome all’efferatezza dell’“oggetto” che vorrebbero denotare. Analogamente, è difficile individuare una formula linguisticamente adeguata a denotare la funzione educativa assegnata allo studio dello sterminio perpetrato dal nazismo e dai suoi alleati contro i “nemici della razza ariana”: né l’espressione Holocaust Education, ormai comune nel dibattito internazionale, né quella Didattica della Shoah, affermatasi nel lessico italiano, sembrano in grado di restituirci la problematicità in sé dell’oggetto “Shoah” dal punto di vista del suo portato educativo. Perché è questa, in fondo, la questione principale su cui occorrerebbe riflettere e che rimane invece, il più delle volte, in secondo piano nella pratica dell’insegnamento di questa tematica: che cosa c’è di educativo nel far confrontare degli adolescenti, o addirittura dei bambini, con un orrore che è stato definito “indicibile” dagli stessi testimoni? Come suggerisce Enrico Donaggio nel suo contributo, ogni insegnante che si appresti a parlare di Shoah in una classe dovrebbe essere consapevole di rappresentare, potenzialmente, colui o colei che metterà i discenti di fronte a delle «possibilità dell’umano» assolutamente mostruose, a una intensità tale di dolore e di ingiustizia che rischia di frantumare quella fiducia nel mondo e negli altri che – almeno da giovani – ogni persona ha il «diritto di nutrire». Davvero, dunque, la scuola è il luogo migliore per parlare di Shoah? Il sistema educativo non dovrebbe forse continuare a trasmettere dei «valori positivi», come si chiede Annette Wieviorka nel suo contributo, invece di impartire «un’educazione preventiva, come se i nostri allievi fossero piccoli nazisti potenziali»? Ancora una volta, se la questione del senso di ciò che facciamo e raccontiamo viene rimossa, magari anche perché si ritiene, in buona fede, che le ragioni delle nostre pratiche siano di per sé ovvie, il rischio a cui ci si trova di fronte è quello di isterilire la memoria della Shoah in un nuovo rituale: una ricorrenza come tante altre nella routine scolastica, che genera sempre meno entusiasmo sia nel corpo docente che negli studenti. Sebbene il Giorno della Memoria sia stato istituito nel nostro paese da poco più di un decennio, alcuni analisti parlano già di una “stanchezza da commemorazione” e di un rischio di “sovraesposizione alla Shoah”, che finirebbe per produrre un effetto contro-intenzionale: disinteresse verso la
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
R. Badii, D. D’Andrea - Introduzione
43
conoscenza dell’evento e insensibilità al suo valore educativo. Qual è dunque il senso di studiare e ricordare la Shoah nei diversi percorsi scolastici? Invitando a porsi questa domanda, nel suo contributo Donaggio avanza anche una possibile risposta: se riteniamo sensato impegnarci in un confronto con gli studenti su questo tema, implicitamente crediamo, e promettiamo loro, che questo dolore ci sarà utile per la vita. Si tratta certamente di questioni complesse e per molti aspetti disposte su piani di riflessione non coincidenti. Non esiste in questo volume una risposta condivisa all’insieme di questi problemi, o anche soltanto ad alcuni di essi. Quello che ci sembra però emergere dall’insieme dei contributi è la consapevolezza che l’elemento decisivo per valutare le intenzioni e gli effetti delle nostre politiche della memoria, e a maggior ragione della loro collocazione nel contesto scolastico, dipende in larga misura dalla qualità e dalla coerenza degli interventi programmati. Se pensate in modo non episodico e non rituale, con un approccio interdisciplinare che educhi alla complessità, ma anche con l’attivazione degli opportuni registri emotivi, allora possiamo individuare almeno due buone ragioni per continuare a vedere nella scuola il principale contesto delle politiche della memoria. La prima ragione per intraprendere un confronto sulla Shoah a scuola ci sembra quella di riflettere insieme a degli adolescenti sulla facilità del male: la facilità con la quale delle persone “normali” possono trasformarsi rapidamente, con i giusti incentivi, in sadici aguzzini e killer professionisti. Oppure: la facilità con cui si può obbedire ai comandi di un’autorità che ci ordina di fare del male a un innocente, smarrendo completamente il senso di responsabilità per ciò che facciamo o non facciamo, e rivelando la debolezza della nostra autonomia morale. E ancora: la facilità con cui possiamo scoprirci indifferenti rispetto alla violenza e all’ingiustizia, anche quando queste non si manifestano in luoghi remoti o presso popolazioni lontane, bensì nel nostro ambiente quotidiano – a scuola, al lavoro, negli spazi pubblici che siamo soliti frequentare. Da questa prospettiva, lo studio della Shoah può essere utile laddove ci si confronti sul fatto che i tedeschi dell’epoca del Terzo Reich non erano persone particolarmente sadiche, psicologicamente instabili o cattive, bensì assolutamente normali. E soprattutto, laddove lo studio della persecuzione e dello sterminio degli ebrei europei venga posto in relazione con quegli studi che hanno saputo mostrare come nemmeno le nostre società democratiche siano immuni dal cosiddetto “effetto Lucifero” (Zimbardo 2007) o dal lato oscuro dell’obbedienza (Milgram 1974). Una seconda buona ragione per parlare di Shoah a scuola riguarda la possibilità di trasmettere e tenere viva una domanda di giustizia contro la schizofrenia di cui soffrono le società occidentali. Come ha osservato Enzo
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
44
Shoah, modernità e male politico
Traverso, per noi occidentali oggi il rischio più grande non è quello di «dimenticare la Shoah», bensì quello di «fare un cattivo uso della sua memoria, di imbalsamarla, di rinchiuderla in un museo e di neutralizzarne il potenziale critico, o peggio, di farne un uso apologetico dell’attuale ordine del mondo» (Traverso 2006: 80). In altri termini, l’enfasi posta sulla memoria della Shoah dalle nostre istituzioni, politiche ed educative, può trasformarsi in un’autoassoluzione morale, una comoda scusa per evitare di confrontarsi criticamente non solo con il passato, ma soprattutto con il presente. Occorre invece essere consapevoli che, per un Occidente che si pone dalla parte delle vittime della storia passata, c’è un Occidente che ignora le vittime del presente o che è addirittura parte attiva nella violenza di massa del nostro tempo. Ed è questa consapevolezza, in fondo, che motiva lo scetticismo verso le iniziative dedicate alla Shoah che a volte si può sperimentare tra gli studenti, soprattutto tra coloro che appartengono anche ad altre culture e hanno vissuto altre storie. In una scuola che, al pari della società, è sempre più multiculturale, non è raro sentirsi dire durante un dibattito sulla Shoah: «Che senso ha parlare di uno sterminio accaduto settanta anni fa? La mia famiglia è scappata da una guerra, ma nessuno parla del mio popolo e delle violenze che ha subìto!». Di fronte a questa legittima richiesta di riconoscimento, discutere il caso dello sterminio degli ebrei europei potrebbe aiutare docenti e discenti ad acquisire una maggiore sensibilità verso le offese e le ingiustizie patite anche da altri gruppi sociali, disinnescando la spirale di risentimento che caratterizza troppo spesso i rapporti tra vittime di ingiustizie diverse, e insegnando a guardare il mondo e la storia anche da prospettive diverse da quella occidentale. In questo senso, studiare la Shoah a scuola potrebbe anche aiutare a scardinare il meccanismo schizofrenico secondo cui le nostre società delegano al sistema educativo la responsabilità di tener viva la moralità politica, educando cittadini tolleranti e democratici, ma accettano poi sempre più passivamente che le istituzioni politiche governino in modo del tutto irresponsabile, incuranti di quella stessa moralità. Certo, la conoscenza e la memoria della più grande catastrofe politica del Novecento non garantisce eo ipso una maggior sensibilità verso i casi di razzismo, discriminazione e violenza di massa del presente. E la letteratura sulla “crisi dell’Illuminismo” è già troppo consistente per ripetere qui i dubbi circa la reale efficacia della cultura rispetto alla prevenzione del male nel mondo. Eppure, ieri come oggi non abbiamo molti altri strumenti a disposizione. Maneggiare con cura lo studio e la memoria del passato è un esercizio difficile, che rischia però di rivelarsi del tutto fine a se stesso, o persino ipocrita, se non riesce ad attivare almeno un interesse per il presente e un’attenzione per i pericoli che minacciano la pace e la
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
R. Badii, D. D’Andrea - Introduzione
45
convivenza civile. Perché, come osserva Omer Bartov in conclusione del suo contributo, «il comunismo e i totalitarismi sono cose del passato; il colonialismo e l’imperialismo tradizionali, come pure i regimi ispirati a utopie razziali, sono anch’essi stati in gran parte relegati ai libri di storia. Ma la violenza militare è onnipresente, e la sua capacità di alimentare e legittimare il genocidio non è diminuita». Si tratta della stessa violenza militare che, come argomentano molti saggi di questo volume, ha avuto un ruolo centrale nell’implementazione concreta della Soluzione finale del problema ebraico. Ed è anche questo il pericolo che, oggi, lo studio e la memoria della Shoah possono segnalare ai cittadini delle democrazie liberali del XXI secolo. ***** Il presente volume prende le mosse dal Convegno internazionale Shoah, modernità e male politico, tenutosi a Firenze nei giorni 24-25 gennaio 2012 e promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con il Forum per i problemi della pace e della guerra di Firenze nell’ambito delle iniziative regionali del Giorno della Memoria. Alcuni dei contributi che lo compongono sono stati concepiti come relazioni per il Convegno, anche se sono stati poi integralmente rivisti dagli autori; altri, invece, sono stati appositamente commissionati dai curatori per sviluppare temi e prospettive disciplinari che non avevano trovato spazio adeguato durante lo svolgimento del Convegno. Nel portare a termine questo progetto editoriale desideriamo ringraziare sinceramente gli amici Ugo Caffaz e Giovanni Gozzini, con cui abbiamo condiviso l’organizzazione scientifica del Convegno fiorentino; Elena Pianea, responsabile del settore Musei ed ecomusei della Regione Toscana, insieme a Michela Toni e Lucia Dalla Villa, responsabili dell’attività di Programmazione e coordinamento delle iniziative per il Giorno della Memoria, per il loro ineguagliabile supporto alla realizzazione del Convegno e del presente volume; Stefania De Franco, Sirkku Salovaara e Diana Kapo del Forum per i problemi della pace e della guerra di Firenze, che hanno curato l’organizzazione logistica del Convegno; Andrea Erizi, responsabile dell’editing del volume; infine, i colleghi Lucia Claudia Fiorella e Diego Guzzi, che hanno provveduto alla traduzione dei contributi redatti in inglese e francese.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
I. IL DIBATTITO STORIOGRAFICO SULLA SHOAH
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
49
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
ENZO COLLOTTI
LA SHOAH OGGI, TRA STORIOGRAFIA E DIVULGAZIONE*
GIOVANNI GOZZINI: Enzo, nel 1991 sono stati aperti gli archivi ex sovietici agli studiosi, e come sappiamo l’Armata rossa fu la prima a raggiungere il campo di Auschwitz. Che bilancio si può trarre oggi, ormai a quasi venti anni di distanza da quell’apertura, del ricavato che se ne è tratto sul piano degli studi e delle ricerche? ENZO COLLOTTI: Chi utilizza molto gli archivi sovietici, oltre agli americani, sono soprattutto gli storici tedeschi. La storiografia tedesca è sicuramente quella che negli ultimi anni ha ampliato l’orizzonte della Shoah, nel senso che, aldilà delle conoscenze generali che si avevano, oramai c’è una conoscenza molto capillare, area per area (in particolare per quanto riguarda la Bielorussia, e in parte anche per l’Ucraina). Da questo punto di vista, il contributo degli storici tedeschi, in assenza – per quel che mi consta – di una vera storiografia russa su queste problematiche, è assolutamente essenziale. Queste nuove ricerche, che riguardano tutta l’area in qualche misura influenzata dall’Armata rossa, hanno anche un risvolto interessante che non riguarda più soltanto il versante russo – il versante degli occupati –, ma il versante degli occupanti, perché viene messa sempre più in evidenza quella che è l’articolazione e la partecipazione diretta allo sterminio non più soltanto, come si voleva dire una volta, delle SS o delle Einsatzgruppen, ma soprattutto della Wehrmacht e dei battaglioni di polizia – quelli che sono stati studiati, per esempio, da Christopher Browning1. Il problema delle corresponsabilità della Wehrmacht nello sterminio ebraico e in tutta *
1
Questo contributo riproduce, con alcune revisioni editoriali, il testo della videointervista a Enzo Collotti, condotta da Giovanni Gozzini nel dicembre 2011 e realizzata dalla Mediateca Regionale Toscana; l’intervento ha aperto i lavori del Convegno internazionale Shoah, modernità e male politico, tenutosi a Firenze nei giorni 24-25 gennaio 2012. Cfr. Browning 1992.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
50
Shoah, modernità e male politico
la politica di occupazione nei territori orientali oggi è in primo piano nella storiografia tedesca. Vorrei anche aggiungere che molti luoghi comuni relativi in generale al comportamento, all’atteggiamento e alla natura degli organismi tedeschi oggi sono messi in discussione, compreso il discorso che Hannah Arendt fece a suo tempo rispetto ad Eichmann nel presentarlo come “l’asettico protagonista dello sterminio”. Oggi ci sono degli studi estremamente interessanti, che fanno vedere come tutto il quadro – il cervello del Sicherheitsdienst e il vertice delle SS, della Gestapo, ecc. – sia stato costituito da un personale di rango accademico, con specializzazioni particolari: molti sono antropologi, molti giuristi, studiosi di scienze sociali, architetti. In altri termini: non c’è settore del ramo scientifico, specialistico, che non sia stato coinvolto nella costruzione di questa enorme macchina di distruzione. E questo secondo me spiega anche il fanatismo di certi comportamenti individuali, nel senso che questi comportamenti venivano giustificati con uno pseudo-specialismo che chiedeva di “andare fino in fondo”, sorretti dalla convinzione – si trattasse di buona o mala fede – della “scientificità” delle proprie scoperte. GG: Si può dire, Enzo, che oggi si sottolinea maggiormente l’adesione ideologica al nazismo, piuttosto che l’obbedienza burocratica o il tornaconto individuale – di carriera, o di avanzamento economico? EC: Certamente. La convinzione ideologica è alla base di questi comportamenti estremi, che noi consideriamo irrazionali, quasi fossero incomprensibili, come si diceva una volta. In realtà, vi è una costruzione, condotta coerentemente sino all’estremo. Cioè, non c’è alcuna reticenza di fronte alla prospettiva di uccidere milioni di persone, perché questa era la convinzione... GG: ...giustificata dal perseguire uno scopo di risistemazione complessiva di tutto il continente, quindi una missione epocale in cui il fine giustificava questi mezzi. EC: Esattamente: una missione epocale che avrebbe dovuto in un certo senso – come una trasfusione di sangue – cambiare radicalmente la natura del continente, e soprattutto creare delle nuove élites dirigenti, immuni da qualsiasi “inquinamento” razziale. Vorrei citare un esempio concreto. Ho qui un diario scritto da un funzionario dell’amministrazione giudiziaria, il suo nome è Friedrich Kellner:
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
E. Collotti - La Shoah oggi, tra storiografia e divulgazione
51
un modesto funzionario di un piccolo tribunale dell’Assia, l’equivalente di quello che noi oggi possiamo considerare un cancelliere di tribunale. Questo libro è uscito all’inizio del 2011: il diario, redatto negli anni 193945, fu consegnato per vicende varie, che vengono narrate nella Presentazione, al nipote dell’autore, nato negli Stati Uniti e tornato in Germania come soldato americano alla fine degli anni Sessanta. Dopo un silenzio di cinquant’anni, il diario è stato pubblicato da un editore tedesco. Ebbene, questo libro è una confutazione continua, costante, della propaganda nazista, dei trionfi del regime... L’autore è un pacifista, un vecchio socialdemocratico pacifista. Sulla questione degli ebrei racconta pochissime cose, ma fondamentali, perché dice, ad esempio, “oggi tutti gli ebrei di questa località sono stati deportati, e tutta la gente era presente, vedeva il corteo dei deportati”. Questa poche notazioni, ripetute, ci confermano quello che oggi è divenuto, se non proprio un luogo comune, almeno una consapevolezza comune, e cioè che i tedeschi sapevano ciò che il loro governo stava facendo ai loro concittadini ebrei. GG: Arriviamo così alla tesi di una presenza diffusa dell’antisemitismo, anche a livello di cultura di massa. Considerando invece lo scenario attuale, possiamo ritenere che oggi questo antisemitismo sia scomparso? EC: No, l’antisemitismo non è scomparso, e questo vale per tutti i paesi. Il problema è quale sia la sua influenza sociale, perché, d’altro canto, è indubbio che nei confronti dei fenomeni di antisemitismo vi è oggi una maggiore sensibilità, soprattutto in certe aree culturali. In Germania, di sicuro, vi è una fortissima sensibilità a riconoscere le sue tracce. Ma il problema, oggi, riguarda meno la Germania, secondo me. Quando sono stato nei paesi baltici, la cosa che mi ha impressionato è vedere, per esempio, che in una città come Riga esiste un Museo dell’occupazione, che però tratta solo dell’occupazione sovietica, non anche dell’occupazione tedesca, e la questione dello sterminio degli ebrei è del tutto marginale. Nella generalità dei comportamenti, nei paesi baltici la questione ebraica è taciuta. Lo stesso discorso oggi andrebbe fatto – sto lavorando a questo tema in un articolo per Passato e presente2 – per l’Ungheria: la situazione ungherese è più drammatica di quella che noi generalmente conosciamo. Per fare solo un esempio: una recente inchiesta giornalistica rivelerebbe che, della distruzione degli ebrei ungheresi e più in generale del fenomeno che là continuano a chiamare “l’Olocausto”, i giovani ungheresi al di sotto 2
Collotti 2012.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
52
Shoah, modernità e male politico
dei 18 anni non sanno quasi niente. Per di più, nel paese è in atto una forte epurazione dell’intellighenzia ebraica, quindi questi fenomeni rischiano di passare assolutamente sotto silenzio; e giustamente qualcuno ha detto che, in alcuni di questi paesi – sto parlando dell’Ungheria, ma potremmo fare lo stesso discorso per la Slovacchia –, gli ebrei tornano ad avere paura. Questi sono fenomeni estremamente rilevanti, però l’opinione pubblica europea non sembra percepirli affatto, anche perché spesso non li conosce – e secondo me si dovrebbe insistere su questo aspetto, l’informazione. Quello che noi oggi possiamo dire è che, rispetto a valutazioni di tanti anni fa – ma tanti anni fa vuol dire solo dieci anni fa, perché ormai un decennio fa un’enorme differenza per la ricerca storiografica contemporaneistica –, oggi le conoscenze sono molto più capillari, le metodologie sono molto più affinate, la possibilità di accedere agli archivi è infinita. Qualsiasi storico, inoltre, oggi si attiene a quella che Saul Friedländer chiama la “storia integrata della Shoah”3, cioè la storia che comprende sia le vittime che i carnefici; oggi chiunque fa una storia di questo tipo, perché sarebbe impensabile spaccare in due il processo, e ricostruire solo la storia delle vittime o solo la storia dei carnefici. In breve, la conoscenza del fenomeno Shoah nel suo complesso è enormemente avanzata. Ci può essere un problema, però, importante: la traduzione del discorso storiografico-scientifico non è altrettanto diffusa sul piano divulgativo, cioè rimane sempre uno iato molto forte tra il livello della conoscenza dal punto di vista scientifico e il livello della divulgazione – e questo è un discorso che non riguarda solo l’Italia, riguarda il mondo intero. L’anello fondamentale di questo passaggio, dalla storiografia alla divulgazione, è in tutto il mondo la scuola. Non c’è dubbio che è l’istituzione scolastica il momento in cui occorre concentrare tutte le energie, perché o si promuove un’opera di educazione alla base, alla radice, oppure ogni altro momento è sempre troppo tardi. E, anche in questo caso, se consideriamo anche solo lo spaccato Europa, ci rendiamo conto che le Europe sono tuttora due, se non più; Europe plurime, dove le situazioni sono estremamente diversificate. Cos’è Sarajevo, oggi? Insomma, questi problemi ce li dovremmo porre, non possiamo pensare che Sarajevo resterà per l’eternità sotto una tutela militare, e lo stesso ragionamento vale per il Kosovo: entità che vivono, o meglio sopravvivono solo perché c’è una forza militare che spegne l’incendio. Ma l’incendio cova, e questa è la nostra tragedia, il nostro dramma – perché riguarda anche noi. 3
Friedländer 2007.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
E. Collotti - La Shoah oggi, tra storiografia e divulgazione
53
GG: Ti sottopongo una doppia domanda sull’Italia, per sviluppare questa linea di pensiero: credo di poter dire che la ricerca oramai ha fatto giustizia del luogo comune, a suo tempo formulato da Renzo De Felice, per cui il fascismo sarebbe stato fuori dal cono d’ombra dell’Olocausto4. Pensiamo inoltre ai risultati degli studi di Angelo Del Boca sull’Etiopia e sulla Libia5, alle ricerche sul nostro comportamento nella sfera coloniale, ma poi anche nei Balcani, durante la Seconda guerra mondiale... Di tutto questo però – ecco la doppia domanda – forse manca ancora una consapevolezza a livello di massa, una penetrazione di queste acquisizioni storiografiche nel senso comune? EC: Sono assolutamente d’accordo. È il problema della divulgazione scientifica e dell’educazione civica, cui accennavo prima. A ciò si aggiunge, purtroppo, anche un certo atteggiamento dei politici italiani. Consideriamo la questione della crisi libica del 2011: chi mai si è sognato di ricordare che forse con la Libia noi qualche problema l’abbiamo avuto? Abbiamo fatto solo del trionfalismo, e la stessa cosa era avvenuta all’epoca del nostro intervento militare in Kosovo: dovevamo pur ricordare che il Kosovo era stato teatro di una presenza militare italiana non propriamente benevola all’epoca in cui l’Italia patrocinava la Grande Albania. Sarà forse il nostro scetticismo, sarà forse un’eredità della nostra educazione cattolica, ma noi italiani tendiamo a voltar pagina troppo presto, a perdonare troppo presto, indistintamente: e il nostro perdonismo ci accusa.
4 5
De Felice 1987-88. Del Boca 1976-82, 1986, 1996.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
55
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
CHRISTOPHER R. BROWNING
CONTESTUALIZZARE LA SHOAH*
Nell’estate del 1979 visitai la Repubblica Popolare Cinese in un periodo in cui il paese si misurava in una schermaglia di confine con il suo vicino meridionale, il Vietnam. In precedenza alleati durante la guerra americana in Vietnam, i due Stati si erano progressivamente allontanati quando apparve chiaro che una gran parte dei boat people che fuggivano dal regime comunista vittorioso in Vietnam appartenevano alla borghesia della diaspora di etnia cinese. Nel mio albergo a Pechino mi capitò fra le mani una vignetta satirica su un quotidiano in lingua inglese, chiaramente orientato a una sensibilità straniera. In questa vignetta, un barcone in mare aperto stracolmo di disperati affonda davanti a Hitler e a un leader vietnamita, che dalla costa osservano la scena. Hitler chiede «Perché non usate il gas?», e il vietnamita risponde: «Perché l’acqua costa meno». Evidentemente, persino in una cultura politica tanto distante quanto la Cina del 1979, che emergeva allora dalla Rivoluzione culturale, dalla morte di Mao e dalla famigerata “Banda dei Quattro”, era implicito che la Shoah – compendiata nei suoi più importanti segni distintivi, Hitler e le camere a gas – fosse il massimo esempio di male politico nel mondo moderno. Di qui la ragione di collegarla alle proprie sofferenze. Giustapponendo lo sterminio col gas e l’annegamento, ed evocando la Shoah in una cornice non europea, questa vignetta toccava anche, tangenzialmente, due questioni centrali nelle argomentazioni storiografiche sul contesto più ampio della Shoah, e cioè sulla sua relazione con la modernità e la modernizzazione da un lato, e con il colonialismo europeo e i genocidi d’oltremare dall’altro. Questi due dibattiti sono l’argomento del mio contributo1. * 1
Traduzione dall’inglese di Lucia Claudia Fiorella. Una prima versione di questo contributo è apparsa in «Passato e Presente», n. 86, 2012. Per l’analisi più attuale, completa e raffinata del primo dibattito si vedano Roseman 1996, 2011. Vale la pena di notare che già nei primi anni Cinquanta Hannah Arendt aveva esaminato il rapporto tra l’imperialismo europeo ottocentesco e l’impatto corrosivo della modernizzazione sulla società europea, che producendo individui “superflui” si dimostrò fondamentale per le “origini del totalitarismo”,
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
56
Shoah, modernità e male politico
Negli anni Sessanta la teoria della modernizzazione era molto di moda, sia per spiegare la presunta superiorità della società occidentale, industriale, capitalista, democratica e borghese come lo stadio più alto di una linea di sviluppo ascensionale, sia per stigmatizzare l’aberrante storia della Germania come il prodotto di un’evoluzione difettosa e divergente rispetto a quella traiettoria ideale. A causa del fallimento della rivoluzione borgheseliberale nel 1848, la Germania avrebbe conosciuto uno sviluppo asimmetrico: pur trasformandosi in una moderna economia industriale e sperimentando sempre maggiori tensioni sociali, il paese era rimasto sotto il saldo controllo di élites tradizionali, che avrebbero poi precipitato l’Europa nella catastrofe della Prima guerra mondiale nel tentativo di scongiurare il processo di democratizzazione in patria attraverso la vittoria e l’espansione territoriale all’estero. La rivoluzione incompiuta del 1918 aveva lasciato la Repubblica di Weimar indifesa contro le continuate macchinazioni delle vecchie élites, che prima si allearono con i nazisti per minare la fragile democrazia tedesca, e poi li innalzarono al potere nell’illusione di restaurare un regime autoritario tradizionale. La Germania aveva insomma seguito una “via peculiare”, o Sonderweg, verso la guerra e la dittatura piuttosto che la “via normale” verso la pace e la democrazia stabilita dalla teoria della modernizzazione2. Basandosi sull’idea del Sonderweg, Martin Broszat e Hans Mommsen sostennero che la coalizione impacciata e disparata su cui Hitler fondò il suo dispotismo e la natura competitiva del suo regime policratico portarono i nazisti – in un incontrollato «balzo in avanti» e in una «radicalizzazione complessiva» – a enfatizzare le sole politiche sulle quali tutte le parti potevano convergere: l’espansione territoriale, la progressiva intensificazione della persecuzione e dello sfruttamento dei nemici interni ed esterni, e infine il genocidio (Broszat 1970; Mommsen 1983). L’intero
2
soprattutto nella variante nazista (Arendt 1951). Per un più recente tentativo di sintesi, si veda Traverso 2002. Per la formulazione classica della tesi del Sonderweg rimando a Wehler 1985. Questa interpretazione era vulnerabile su più fronti. Barrington Moore ha osservato che non c’era niente di «speciale» in questo percorso, poiché anche altrove la «modernizzazione conservativa dall’alto» portò a regimi autoritari ed espansionistici, come ad esempio in Giappone (Moore 1966). Geoff Eley e David Blackbourn hanno contestato radicalmente l’idea del fallimento della rivoluzione borgheseliberale e hanno affermato che una trasformazione borghese-liberale era di fatto avvenuta, in modo graduale ma pervasivo, nonostante l’apparente insuccesso del 1848 (Blackbourn – Eley 1984). Eley, in particolare, si è spinto oltre, sostenendo che l’ascesa dei nazisti al potere non fosse conseguenza della disperazione delle élites pre-capitalistiche, ma il risultato di una crisi particolarmente grave nella società capitalistica tedesca degli anni Venti (Eley 1986).
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.R. Browning - Contestualizzare la Shoah
57
approccio del Sonderweg combaciava perfettamente con gli studi sul fascismo e sul nazismo che negli anni Sessanta ritraevano quest’ultimo come una forza segnatamente arcaica, retrograda e ostile non solo alla democratizzazione, ma anche alla modernizzazione economica e alla modernità culturale; di qui l’iniziale compatibilità e il rapporto di collaborazione fra il nazismo e gli alleati della vecchia destra3. L’immagine di Hitler e dei nazisti come reazionari anti-moderni, che vagheggiavano il ritorno a un’utopia agraria, fu messa apertamente in discussione negli anni Ottanta. Infatti, Rainer Zitelmann (1989) sostenne che Hitler era piuttosto un rivoluzionario modernizzatore, che da un lato desiderava smantellare le vecchie barriere sociali e migliorare la mobilità sociale, e dall’altro promuoveva schiettamente la tecnologia moderna e lo sviluppo industriale. Molti altri nazisti condividevano questo progetto, e l’elemento tecnocratico modernizzante ebbe abbastanza successo, secondo Zitelmann, nel mettere da parte gli elementi arcaici nel partito dopo il 1933. Se Zitelmann semplicemente ignorò la questione della Shoah nella sua tesi sulla modernità del nazismo, non così fece Götz Aly. Aly sostenne che la forza propulsiva dietro alla Soluzione finale fosse un gruppo di tecnocrati modernizzatori, o un’«intellighenzia di pianificatori», consapevolmente impegnati nel tentativo di spezzare il circolo vizioso di povertà, bassa produttività e sovrappopolazione nell’Europa orientale occupata dai tedeschi. Questi tecnocrati propugnavano lo sterminio degli ebrei come strumento per diminuire il surplus di popolazione, convertire la piccola e arretrata attività manifatturiera in un’industria moderna e razionale, indurre i polacchi delle campagne a spostarsi nelle città grazie a nuove opportunità economiche, e creare una prospera classe media polacca con degli interessi nel Nuovo ordine tedesco. Così, la Shoah non sarebbe stata il risultato della radicalizzazione fuori controllo di un regime mal funzionante, come volevano Broszat e Mommsen, ma piuttosto una linea politica assai conscia e razionale, per quanto disumana, che puntava alla modernizzazione capitalistica e tecnocratica dell’Impero tedesco nei territori orientali (Aly 1988; Aly – Heim 1991)4. 3
4
Per esempio si vedano Turner 1975 e Weiss 1967. Per quanto il regime nazista favorì effettivamente la modernizzazione, lo fece però per il bisogno di conseguire obiettivi anti-moderni; la modernizzazione fu perciò una conseguenza non intenzionale della guerra industriale totale scatenata dal Terzo Reich. Si vedano Dahrendorf 1965 e Schoenbaum 1966. Per un’altra monografia che mette in evidenza la compatibilità fra nazionalsocialismo, modernizzazione e Shoah (anche se con maggiore enfasi sull’aspetto ideologico), si veda Thad Allen 2002.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
58
Shoah, modernità e male politico
Era avvenuto un cambiamento importante fra le prime e le seconde tesi sulla modernizzazione. Nella prima versione, alla modernizzazione era assegnato un valore positivo, e l’esito tedesco – che aveva portato fatalmente a Hitler e all’Olocausto – era considerato come il cattivo risultato di una modernizzazione incompleta e difettosa. Nella seconda versione, quella descritta da Aly, lo sviluppo tedesco, che includeva Hitler e la Shoah, era un risultato esemplare della modernizzazione, cui però veniva assegnato un valore negativo. Questa concezione negativa della modernizzazione – che rimane collegata all’industrializzazione, alla secolarizzazione, alla mobilità sociale, all’avanzamento della scienza e della tecnologia, e a un atteggiamento razional-strumentale che è però nettamente disgiunto da qualunque nozione di democratizzazione e progresso – venne rispecchiata dalla “svolta linguistica” degli anni Ottanta, quando l’interesse e il lessico degli studiosi si spostarono dalla modernizzazione come linea di sviluppo alla modernità come insieme di assunti e percezioni culturali. Quel che Geoff Eley aveva ritenuto una grave crisi nell’economia capitalistica e nella società classista della Germania degli anni Venti, veniva ora definita da Detlev Peukert come «la crisi della modernità classica», e il fatto che questa avesse aperto la porta alla dittatura nazista dimostrava il potenziale «patologico» della modernità, in precedenza frainteso ed erroneamente scambiato per progresso (Peukert 1987). Peukert mise esplicitamente in relazione questa «crisi della modernità» con la Shoah, poiché la comunità pseudo-nazionale o Volksgemeinschaft dei nazisti – risposta essenzialmente utopica ai mali della società moderna – poteva essere formata e resa credibile solo tracciando dei confini che escludessero sia gli irregolari sia i “colpevoli”, e cioè gli ebrei, i bolscevichi e gli sfruttatori capitalisti, considerati come una cosa sola. Inoltre, il bisogno del regime di sostenere il suo mito utopico fondamentale ebbe conseguenze distruttive: «Più la denuncia nazista dei nemici della razza mancava di portare la promessa concordia della Volksgemeinschaft e la soluzione ai veri problemi e alle contraddizioni della società, più radicale e spietata doveva essere la pressione distruttiva esercitata contro gli “alieni” della comunità» (Peukert 1982: 35 ss.). Secondo Peukert, questo processo di delimitazione che stava al centro della politica razziale nazista non si ricollegava con l’antisemitismo tradizionale dei secoli precedenti, ma piuttosto con la pratica moderna – di stampo accademico-medico-assistenziale – di selezione e separazione sulla base della distinzione fra valore e disvalore. Il razzismo nazista, concludeva, era un esempio del potere seduttivo della
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.R. Browning - Contestualizzare la Shoah
59
“patologia” del progresso e della modernità, e la Shoah era uno dei suoi possibili, anche se non inevitabili, risultati5. Altri, fuori dalla Germania (e dunque senza la necessità di misurarsi con l’ipoteca rappresentata dalla storia di questo paese), si unirono a Peukert nel proclamare la Shoah una manifestazione della modernità, e quindi un segno allarmante delle sue potenzialità negative e patologiche. Prima di Peukert, Richard Rubenstein aveva già sostenuto che la Shoah fosse «un esercizio assolutamente moderno di potere assoluto, che solo una comunità politicamente avanzata poteva portare a termine», e che doveva essere considerata «come l’espressione di alcune fra le tendenze più profonde della civiltà occidentale del XX secolo» (Rubenstein 1975: 4, 21)6. Fra queste tendenze si contavano la secolarizzazione pervasiva della cultura, un potere burocratico assoluto e disumanizzante, la razionalizzazione economica e la sovrabbondanza di gente apolide, “superflua”. Come implica il titolo del suo Modernità e Olocausto, anche Zygmunt Bauman ha rifiutato il mito teleologico delle “magnifiche sorti e progressive” della civiltà occidentale, e ha descritto l’Olocausto come un fenomeno moderno in cui la mentalità burocratica, fondata sull’obbedienza all’autorità, la routinizzazione della vita sociale e il calcolo razionale – non rabbia, passione, spontaneità –, ha neutralizzato le inibizioni morali, plasmando quello specifico ethos che ha poi reso possibile la realizzazione dell’Olocausto. In primo luogo, fu l’atteggiamento ingegneristico derivato dal potenziamento scientifico – in cui il governo si rappresentava come «amministratore razionale» che si proponeva di curare il corpo sociale attraverso le «scienze applicate» (facendo così eco a Peukert) – a rendere concepibile una versione “sterministica” dell’antisemitismo. Per Bauman, la Shoah era il prodotto di un’unione tra l’idea moderna, sterministica, dell’antisemitismo e la moderna burocrazia (Bauman 1989: 11-3, 17, 90)7. Edward Ross Dickenson ha sostenuto che lo spostamento dell’analisi dalla modernizzazione, concentrata sulla struttura sociale, a quel che egli chiama «modernità discorsiva» – caratterizzata dalla razionalità strumentale, dallo scientismo e dalla fiducia nella capacità di rinnovare o rifare la 5
6 7
Cfr. Peukert 1989. Uno dei partecipanti al convegno in cui Peukert presentò questo contributo disse che così aveva creato un «Olocausto puramente ebraico (Judenrein)». Per una prima e penetrante analisi delle prospettive di Zitelmann, Aly e Peukert, si veda Frei 1993. La questione del rapporto modernità-nazionalsocialismo è affrontata anche dallo storico americano Ronald Smelser (1990). Rubenstein riconosce apertamente il suo debito nei confronti di Hannah Arendt. Anche George Kren e Leon Rappoport (1980) hanno descritto la Shoah come un fenomeno essenzialmente moderno.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
60
Shoah, modernità e male politico
società – ha segnato la comparsa di una nuova grande narrazione «biopolitica» della storia tedesca. Sotto questo aspetto, la Germania partecipava dei più grandi rivolgimenti del mondo moderno, ma manifestava anche «una particolare variante di biopolitica». Al posto della paura delle vecchie élites per la democratizzazione e la rivoluzione che dominava la grande narrazione precedente, nel nuovo approccio ampi settori della società tedesca condividevano la paura della degenerazione del Volkskörper. «La Germania», conclude Dickenson, «qui non sembra tanto una nazione che abbia problemi a modernizzarsi, quanto una nazione dalla modernità problematica» (Dickenson 2004). Dickenson difende però una prospettiva non-teleologica, osservando che gli esponenti del ramo antisemitico dell’“igiene della razza” rimasero un gruppo marginale all’interno dell’eugenetica e della biopolitica tedesca finché non furono cooptati dai nazisti, che gli diedero pieni poteri nel 1933 in virtù della comunanza di idee sulla sterilizzazione di massa, l’aborto eugenetico e le uccisioni di massa (eufemisticamente chiamate “eutanasia”) di quanti venivano reputati “vite indegne di essere vissute” (lebensunwerten Leben)8. E il “programma eutanasia”, come hanno argomentato Henry Friedlander (1995) e altri, fu determinante nella genesi della Soluzione finale. Tuttavia, Dickenson è categorico sulla relazione tra causa ed effetto: «Non è stata l’eugenetica a spianare la strada all’omicidio di milioni di ebrei, ma il razzismo etnico, e in particolare l’antisemitismo». E ancora: «La modernità e la scienza non sono responsabili dei crimini dei nazisti. I responsabili sono i nazisti» (Dickenson 2004: 19, 21). Qual è stato l’apporto di queste due stagioni o generazioni di studi sulla storia tedesca e il nazionalsocialismo, con le loro rispettive lenti interpretative della modernizzazione e della modernità? Come hanno contribuito a contestualizzare e ad arricchire la nostra comprensione della Shoah? In sostanza, entrambe hanno cercato di rispondere a due domande cruciali sulla Shoah, e cioè Perché i tedeschi? e Perché nel XX secolo? Sono state assai meno efficaci nell’affrontare una terza domanda chiave, e cioè Perché gli ebrei? Adesso esaminerò invece la posizione adottata, rispetto a tali questioni chiave, da un secondo filone storiografico, che ha cercato di sviluppare una più ampia contestualizzazione della Shoah a partire dall’analisi di elementi come l’imperialismo, la colonizzazione e le pratiche genocidiarie. Come per le interpretazioni incentrate sulla modernizzazione, anche tra quelle che pongono l’accento sul contesto coloniale ce n’è una che implica una sorta di Sonderweg tedesco, tracciando una linea di collegamento di8
Per un inquadramento storico si veda Weindling 1989.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.R. Browning - Contestualizzare la Shoah
61
retta dal genocidio degli Herero e dei Nama nell’Africa tedesca sud-occidentale al comportamento dei tedeschi in Europa. Isabel Hull osserva che l’«imperialismo era una guerra» e insiste sulla continuità della mentalità istituzionale nell’esercito tedesco come fattore chiave nello scatenamento di guerre di «distruzione totale», prima nell’Africa sud-occidentale e poi nella Prima guerra mondiale; tuttavia Hull traccia una connessione indiretta, piuttosto che diretta, con la successiva Vernichtungskrieg (guerra di sterminio) e la Shoah9. Altri hanno invece trovato una connessione diretta, e nessuno in modo più deciso di Jürgen Zimmerer, che ha posto la questione fin dal titolo del suo Von Windhuk nach Auschwitz? (Da Windhuk ad Auschwitz?), e ha risposto affermativamente a quella domanda con il capitolo intitolato La nascita dell’Ostland dallo spirito del colonialismo10. Zimmerer sostiene che erano simili sia le giustificazioni ideologiche (l’opposizione binaria fra la razza degli europei, superiori ed evoluti, e quella dei nativi, inferiori e primitivi) sia i metodi di dominio (lavoro forzato ed estromissione dalla terra da un lato, e dall’altro guerra di distruzione – caratterizzata da terre bruciate, massacri, sterminio per abbandono nei campi per prigionieri – e, infine, il genocidio). Anzi, per l’Africa tedesca sudoccidentale «venne organizzato un sistema di mobilitazione e controllo totale probabilmente unico nella storia del colonialismo», facendone così «il caso paradigmatico che collegava colonialismo e nazionalsocialismo» (Zimmerer 2005: 207). Inoltre, l’ampia diffusione del pensiero razzista e colonialista in Germania e il favore con cui venne accolto consentirono ai tedeschi di percepire il proprio comportamento nell’Europa orientale come “normale” anziché criminale. L’atteggiamento nazista può risultare trasgressivo e senza precedenti solo se lo si analizza dalla prospettiva occidentale contemporanea, che ha dimenticato il comportamento tenuto dagli europei nei territori d’oltremare durante il XIX secolo, ma non certo se lo si 9
10
Cfr. Hull 2005: 332-33: «Il “culto della violenza” che il nazionalsocialismo impersonificava era semplicemente la reificazione di pratiche e comportamenti (vale a dire, di modelli di agire) che provenivano dalla vecchia mentalità militare dell’Impero tedesco. Nel Terzo Reich questi modelli vennero facilmente messi al servizio di fini ideologici che implicavano distruzioni di massa e stermini ancora maggiori». Cfr. Zimmerer 2005, 2011. Un altro capitolo in quest’ultimo libro con un titolo dello stesso tenore è Von Windhuk nach Warschau. Die rassische Privilegiengesellschaft in Deutsch-Südwestafrika – ein Modell mit Zukunft? (Da Windhuk a Varsavia. La società del privilegio razziale nell’Africa sud-occidentale: un modello per il futuro?); cfr. Zimmerer 2011: 222-53. Per la legislazione coloniale e razziale nazista si veda Ehmann 1998.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
62
Shoah, modernità e male politico
considera dalla prospettiva del colonialismo ottocentesco o da quella della Germania prima del 1945. Zimmerer si concentra sull’Africa tedesca sud-occidentale anche per confutare quella che considera la visione ingenua, nel suo paese, di un benefico passato coloniale tedesco e di una soluzione di continuità fra età imperialista ed epoca nazista nella storia della Germania (Zimmerer 2008). Per ciò che concerne invece la relazione fra colonialismo, genocidio, nazionalsocialismo e Shoah nel suo complesso, Zimmerer opera alcuni distinguo. Partendo dalla definizione di genocidio della Convenzione delle Nazioni Unite, basata sul criterio dell’“intenzione”, Zimmerer sostiene che «il genocidio coloniale» non è «una categoria essenzialmente diversa» da quello nazista: si basavano entrambi sulle stesse nozioni di razza e di spazio. Tuttavia, dato il basso livello di organizzazione dello Stato nelle colonie, è molto più difficile identificare singoli casi di genocidio coloniale piuttosto che di genocidi nazisti, e la maggior parte dei decessi nelle colonie era dovuta a malattie e alla schiavitù, anziché a uccisioni deliberate. Zimmerer non è alla ricerca di un’equivalenza, ma sta facendo piuttosto quel che lui chiama «archeologia del genocidio». Il suo intento è quello di scavare alle origini del pensiero genocidiario, dove l’Africa sud-occidentale funge da punto di collegamento fra i «momenti genocidiari» perpetrati sulla frontiera coloniale e l’entità «senza precedenti» dell’«omicidio pianificato» perpetrato dal nazionalsocialismo nella «più grande guerra coloniale della storia» (Zimmerer 2004). All’estremo opposto dello spettro si trovano quegli studiosi che denunciano tutti i colonialismi come genocidiari. Ad esempio, Dominik Schaller è apertamente critico nei confronti di Zimmerer, sostenendo che «dovunque i colonizzatori mirino a imporre» con la violenza un diverso modo di vivere alle «popolazioni sottomesse», il colonialismo è «intrinsecamente genocidiario». E insiste sul fatto «che non solo i genocidi sono sempre coloniali, ma il dominio coloniale e il colonialismo come tali sono costantemente genocidiari» (Schaller 2008: 316-17). A metà strada fra Zimmerer e Schaller si collocano un gruppo di ricercatori, esemplificati da A. Dirk Moses11, che mostrano insofferenza per un dibattito tanto polarizzato da opporre l’Olocausto e il genocidio coloniale in un gioco a somma zero, in cui sia la definizione sia la valutazione delle somiglianze e delle differenze sono, in ultima analisi, d’ordine politico anziché storico. Così, Moses attribuisce etichette politiche alle due concezioni rivali di genocidio. La prima 11
Mi baso su due contributi chiave fra una miriade di pubblicazioni: Moses 2004, 2007.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.R. Browning - Contestualizzare la Shoah
63
è secondo lui la concezione «liberale», che enfatizza l’azione e l’intenzione dello Stato, e per la quale l’Olocausto è paradigmatico. La seconda è la concezione «post-liberale», in cui fattori strutturali determinanti e forze sociali (generalmente intese come manifestazioni dell’intrusione occidentale) non solo guidano un «processo genocidiario» o creano delle «relazioni genocidiarie», ma rendono anche difficile concettualizzare l’intenzione degli attori e individuare le responsabilità. La prima sottolinea l’intento genocidiario, mentre la seconda mette in rilievo il risultato genocidiario, inteso come distruzione o menomazione permanente di gruppi umani. Credo che Moses tracci qui una distinzione importante, ma preferirei che adottasse i termini descrittivi di genocidio “sistematico” e “sistemico”, piuttosto che parlare di concezione “liberale” e “post-liberale” di genocidio. Moses propone diversi modi per cambiare le “regole” di questo gioco a somma zero. Una possibilità è prendere in considerazione un’accezione più ampia del termine “intenzione”, chiamando in causa il concetto giuridico di “prevedibilità”. Il risultato distruttivo dell’insediamento dei coloni, sostiene Moses, era perfettamente prevedibile, ma persone concrete (non strutture o forze anonime) accettarono il “destino” delle popolazioni indigene come qualcosa di “inevitabile”, e presero decisioni politiche che assicurarono precisamente quel risultato, come se si trattasse di una profezia che si auto-avvera. Una seconda possibilità – per cui Moses evoca, sebbene in modo critico, la Hannah Arendt delle Origini del totalitarismo – è l’idea di un «processo unitario» in quel che chiama il «secolo della razza» (18501945), in cui la violenza della competizione scatenata dalla modernità europea e dal sistema degli Stati-nazione si spostò dalla periferia al centro, dall’imperialismo d’oltremare alla guerra civile europea, per culminare nel nazionalsocialismo e nell’Olocausto. Hitler cercò di realizzare consapevolmente nell’Europa del Novecento quel che altre nazioni occidentali avevano compiuto meno sistematicamente oltremare nell’Ottocento. Cosa ci permette di capire sulla Shoah (se davvero ce lo consente) il contesto coloniale? In pratica, tutti gli studi recenti concordano sul fatto che il regime nazista fosse impegnato in una vasta campagna di conquista territoriale e di colonizzazione, con l’obiettivo di portare a termine una rivoluzione razziale per riscrivere la mappa demografica dell’Europa orientale secondo le indicazioni del Generalplan Ost (Piano generale per l’Est). E credo che Moses abbia ragione nel sostenere che molte delle caratteristiche di questo Piano rivelavano il desiderio dei gerarchi nazisti di conseguire rapidamente e in modo sistematico quel che un insediamento coloniale non sistematico aveva raggiunto per gradi in America settentrionale nel secolo precedente, con le popolazioni slave a patire le stesse con-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
64
Shoah, modernità e male politico
seguenze che avevano sofferto i nativi americani. Ma la Soluzione finale era indipendente dal Generalplan Ost, e la Shoah non si adatta pienamente al modello del genocidio coloniale. Gli ebrei non furono uccisi perché se ne desiderava la terra o perché erano considerati un popolo primitivo e destinato a sparire perché di ostacolo sul cammino del progresso. Piuttosto, vennero massacrati perché si credeva che minacciassero la capacità della Germania di realizzare i sogni di Hitler della conquista del Lebensraum e dell’egemonia. Che fossero accusati di contaminare il sangue ariano, di diffondere idee sovversive che minavano la determinazione tedesca a combattere, o di ordire una cospirazione planetaria che bloccava militarmente l’espansione della Germania – tirando ora i fili del regime comunista sovietico, ora quelli dei governi democratici di Gran Bretagna e Stati Uniti –, gli ebrei erano percepiti come una minaccia mortale all’esistenza stessa della Germania: un problema che generò misure sempre più radicali e culminò in un programma genocidiario che prevedeva di uccidere ogni singolo ebreo (uomo, donna, bambino) che cadesse nella morsa tedesca. Diversamente da molti suoi colleghi, Moses è pronto a riconoscere che, a differenza delle politiche genocidiarie nei confronti degli slavi, la Shoah non può essere spiegata «nei termini di una logica imperialistico-coloniale» (Moses 2008: 34-40). E tuttavia sostiene che la Shoah possa e debba essere situata «in processi che sono universali in contesti imperialisticocoloniali», e anzi «deve essere intesa (corsivo mio) […] come un genocidio di subalterni», perché «si spiega meglio come nazionalismo razzista nei confronti di subalterni». Oltre al fatto che gli Ostjuden (ebrei dell’Est) vennero «trattati nei modi consueti» per l’«Altro coloniale» – e cioè furono ridotti alla fame, costretti al lavoro forzato, cacciati, incarcerati e decimati –, i nazisti vedevano gli ebrei come gli oscuri dominatori della Germania, e come una minaccia alla sicurezza del paese da cui i tedeschi dovevano liberarsi con l’equivalente di una guerra genocidiaria di liberazione nazionale. Il problema di questa analisi, come ammette lo stesso Moses, è che quest’idea della dominazione e della minaccia ebraica era «una convinzione assurda». Niente, nel paragone psicologico di Moses con la furia verso i subalterni e le concretissime sofferenze inflitte dalla dominazione e dallo sfruttamento coloniale, spiega perché – in una nazione potente e moderna, e anzi in un intero continente – si poté organizzare una mobilitazione e perpetrare un genocidio per una fantasia paranoica. Siamo tornati alla domanda ricordata in precedenza, lasciata senza risposta: Perché gli ebrei? Direi che né la prospettiva che spiega la Shoah contestualizzandola nella modernità europea, né quella che la iscrive nella colonizzazione extra-europea possano rispondere a questa domanda; credo piuttosto che si debba
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.R. Browning - Contestualizzare la Shoah
65
tornare alla questione della modernizzazione e del suo impatto sulla società europea, ma senza limitarsi all’età moderna. Nel primo millennio della relazione antagonistica fra ebrei e cristiani, il conflitto fu principalmente d’ordine teologico. Nell’ultimo secolo di quel millennio, i popoli assediati dell’Europa occidentale vivevano in una società caratterizzata da popolazione disseminata sul territorio, agricoltura di sussistenza, analfabetismo e ricorrenti invasioni. Nei tre secoli successivi, però, l’Europa sperimentò quel che chiamerei la sua prima grande modernizzazione. La popolazione esplose, le città crebbero, la ricchezza si moltiplicò a mano a mano che il commercio si integrava all’agricoltura e il denaro sostituiva il baratto, le monarchie accentratrici cominciarono il lungo processo di addomesticamento dell’anarchia feudale, furono inventate le università, si diffuse l’alfabetizzazione, almeno una parte della tradizione classica venne recuperata (seminando dubbi sulle certezze religiose acquisite), e le frontiere della cristianità si allargarono. Come in ogni grande trasformazione, ci furono anche molti disordini e ansietà. Per tutto quel che era nuovo e allarmante, la minoranza ebraica forniva un simbolo adatto, e l’antisemitismo teologico venne sostituito da quel che Gavin Langmuir ha chiamato «antisemitismo xenofobo» – uno stereotipo negativo molto diffuso, composto da varie asserzioni che non descrivevano la vera minoranza ebraica, ma esprimevano piuttosto varie minacce e pericoli che la maggioranza cristiana non poteva e non voleva capire (Langmuir 1989, 1990: 275-305). In genere esclusi dal possesso della terra, dall’appartenenza alle corporazioni, dalla professione militare, gli ebrei divennero una minoranza urbana ghettizzata, commerciale e non militare; e non solo venivano bollati come miscredenti, ma ora anche come vigliacchi chiusi nei propri clan, come parassiti e usurai. L’antisemitismo di matrice religiosa assunse dimensioni economiche, politiche e sociali. Questo terreno di antisemitismo xenofobo si dimostrò estremamente fertile per piantare e far crescere lussureggianti accuse assurde e pazzesche, come quelle degli omicidi rituali e dell’avvelenamento dei pozzi, che Langmuir chiama «antisemitismo visionario»; e per la fine del Medioevo questa sempre più inestricabile mescolanza di antisemitismo xenofobo e visionario aveva messo radici assai profonde nella cultura europea. La duplice rivoluzione che iniziò nel tardo Settecento sembrò una manna per gli ebrei d’Europa. La rivoluzione liberal-democratica proclamò la libertà di coscienza e l’uguaglianza davanti alla legge, ed emancipò gli ebrei da secoli di discriminazione legale. La rivoluzione industriale dischiuse opportunità economiche senza precedenti per una minoranza dinamica, istruita, adattabile, desiderosa di lasciarsi il passato alle spalle.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
66
Shoah, modernità e male politico
E tuttavia, per gli ebrei la seconda grande “crisi della modernizzazione” europea era carica di pericoli persino maggiori della prima. Ancora una volta, gli “sconfitti” della società – soprattutto le élites tradizionali e i piccoli produttori – potevano trovare negli ebrei un simbolo adeguato per la loro angoscia. In un’età scientifica e laica era ora la razza, piuttosto che la religione, a fornire la presunta spiegazione del comportamento degli ebrei, e lo stereotipo negativo, antisemita, venne facilmente aggiornato con nuovi strati di accuse, sia xenofobe che visionarie. L’ebreo era il simbolo xenofobo di tutto quel che minacciava il vecchio ordine: liberalismo e bolscevismo, capitalismo rapace e rivoluzione proletaria, internazionalismo ed eversione, sperimentazione culturale e disprezzo per la tradizione – cui si aggiungevano le fantasiose accuse di avvelenamento dei pozzi e di cospirazione planetaria. Se nel tardo Ottocento l’antisemitismo era ancora un «codice culturale» fra conservatori «irriducibili alla modernità» (Volkov 1978), la sequenza di disastri che colpì la società europea nei primi decenni del Novecento – la Prima guerra mondiale, l’umiliazione della sconfitta e il collasso degli imperi, la rivoluzione, l’inflazione e la Grande depressione – arrivarono a minacciare un’implosione totale e aprirono le porte alla rapida ascesa del nuovo movimento politico del fascismo, che prometteva salvezza e rigenerazione, e mostrava la capacità – almeno in Italia e in Germania – di costruire un’ampia e composita alleanza sociale di scontento e speranza. Secondo me, questa crisi europea non si spiega come “crisi della modernità”, né il fascismo si intende come movimento moderno o anti-moderno – una forma di categorizzazione binaria più importante per i sociologi degli anni Sessanta che per gli stessi fascisti. In Germania, in particolare, l’antisemitismo giocò un ruolo cruciale come collante, tenendo insieme Hitler, le varie sponde del nazionalsocialismo, i conservatori tradizionali e le ampie fasce di tedeschi delusi. Per gli elementi retrivi e arcaici del partito, come pure per gli alleati conservatori, l’antisemitismo funse da codice per tutte le manifestazioni d’odio per la modernità e il cambiamento. Per coloro che vedevano con favore la modernità, invece, l’antisemitismo rispecchiò e agevolò l’atteggiamento selettivo e ambivalente di Hitler, che accettava il socialismo nazionale tedesco ma non quello internazionale e sovversivo “degli ebrei”; il capitalismo pianificato e amministrato dai tedeschi, subordinato allo Stato, ma non il capitalismo egoistico “degli ebrei”, basato sullo sfruttamento, che metteva il profitto al di sopra della nazione; la mobilitazione delle masse della politica moderna, ma non la democrazia partecipativa “ebraica”; e ancora, ammetteva la mobilità sociale e l’apertura delle professioni al talento affrancato dalle vecchie barriere sociali se all’interno del Volk tedesco, ma
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.R. Browning - Contestualizzare la Shoah
67
non l’egalitarismo “ebraico”, che difendeva i diritti dei deboli contro i forti e che guastava il reclutamento di una nuova élite attraverso la lotta per la sopravvivenza stabilita dalla natura12. In breve, la centralità dell’antisemitismo per il nazionalsocialismo non fu solo il frutto delle ossessioni personali di Hitler, e nemmeno un modo per mobilitare una minoranza di antisemiti “redentori” e di esponenti radicali nel partito che condividevano quelle ossessioni13. L’antisemitismo era piuttosto un collante vitale per tenere assieme il movimento: permise a Hitler come agli antisemiti “visionari”, ai nazisti anti-moderni come a quelli favorevoli alla modernizzazione, agli alleati conservatori tradizionali come ai tedeschi delusi e smarriti, e infine ai loro collaboratori in tutta Europa, di usare le stesse parole, anche se non sempre lo stesso linguaggio, e di prendere lo stesso treno politico in una comune direzione senza prima accordarsi a quale fermata sarebbero tutti scesi. Come ora sappiamo, quel treno andò avanti finché non raggiunse Auschwitz.
12 13
Per l’atteggiamento selettivo del nazionalsocialismo nei confronti della modernizzazione si veda Herf 1984. Per la nozione di «antisemitismo redentore», si veda Friedländer 1997: 73-112.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
69
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
OMER BARTOV
RIPENSARE L’OLOCAUSTO Obiettivo di guerra od ostacolo alla vittoria?*1
Fra il marzo del 1942 e gli inizi del 1943 furono uccisi più ebrei che in qualunque altro periodo della guerra. Nella sola Polonia furono massacrati quasi un milione e mezzo di ebrei, il che ne fece «la più grande operazione unitaria di sterminio nel corso dell’Olocausto» (Longerich 1998: 340). Fu anche un anno di pesanti combattimenti: in seguito alla controffensiva sovietica alle porte di Mosca nel dicembre del 1941, la Wehrmacht subì perdite catastrofiche. Per la primavera del 1942, un milione di soldati tedeschi – dei tre milioni che erano partiti all’attacco dell’Unione Sovietica l’estate precedente – erano rimasti uccisi. L’inverno successivo, la disfatta di Stalingrado portò alla distruzione dell’intera Sesta armata tedesca. C’era una relazione tra questi furiosi e costosissimi combattimenti e una campagna genocidiaria senza precedenti? Il massacro degli ebrei fu d’intralcio alla vittoria, distogliendo risorse e attenzione dallo sforzo bellico del Reich, o era piuttosto uno degli obiettivi primari della guerra, il cui raggiungimento era visto come parte integrante di quel che avrebbe infine rappresentato la vittoria tedesca? Che ruolo giocava l’Olocausto nello sforzo bellico tedesco, e come ne concepivano la funzione i decisori politici nazisti nel contesto generale di un vastissimo conflitto militare? Nella sua storia generale dell’Olocausto, pubblicata in Germania nel 1998 e poi in un’edizione inglese notevolmente rivista del 2010, lo storico tedesco Peter Longerich sostiene che «nella seconda metà della guerra» la politica nazista nei confronti degli ebrei divenne «un asse portante delle strategie di alleanza e occupazione territoriale della Germania». C’era anzi una chiara correlazione, afferma, fra l’andamento della guerra e la convinzione del regime circa l’«importanza dello sterminio sistematico degli ebrei per la tenuta del blocco di potere tedesco». Sottoposta a una crescente pressione militare, la Germania non poteva più predicare, e tanto meno mettere in pratica, il suo ideale di un Nuovo ordine europeo razziale senza incontrare una forte opposizione da parte dei suoi alleati e fiancheggiatori. *
Traduzione dall’inglese di Lucia Claudia Fiorella. Una prima versione di questo contributo è apparsa in «Passato e Presente», n. 86, 2012.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
70
Shoah, modernità e male politico
Dato che i nazisti non intendevano rinunciare a questo disegno, scelsero di «anticipare l’utopia razzista in modo negativo. Da allora», quel che Longerich chiama «la Entjudung (de-giudaizzazione) della sfera d’influenza tedesca», che prima aveva «rappresentato […] l’inizio di un più vasto nuovo ordine razziale», ne divenne il «surrogato» (374-75). Tuttavia, la Soluzione finale non rappresentò solo il momento “negativo” dell’utopia razziale nazista; ebbe anche un importante impatto “positivo” sulla coesione interna tedesca e sulle sue politiche d’occupazione. Secondo l’espressione usata da Longerich, l’Olocausto «fu la cinghia di ferro con cui il Terzo Reich teneva assieme il blocco di potere che esso dominava». In altre parole, con l’esecuzione del genocidio, poteri rilevanti come le «amministrazioni d’occupazione tedesche, le organizzazioni locali ausiliarie, gli alleati o i governi collaborazionisti furono trasformati in complici o lacchè politici dello sterminio»; e – punto cruciale – «data l’assoluta novità di questo crimine», la complicità «legò irreparabilmente» tutti questi poteri cooperanti interni ed esterni «al motore di quella politica, e cioè ai vertici della Germania nazionalsocialista» (375). Tuttavia, un altro effetto cruciale delle politiche naziste sugli ebrei fu che «ogni ulteriore inasprimento della persecuzione era destinato a rafforzare il potere delle SS e delle forze radicali del partito [… e perciò] a sbilanciare l’equilibrio generale del regime a favore di quelle stesse forze». E cosa ancora più importante, se l’esecuzione del genocidio degli ebrei «equivaleva a centrare l’obiettivo nazista della rivendicazione del potere assoluto», dal punto di vista del regime era anche «l’unica via al successo in questa guerra». Per questo motivo, i gerarchi nazisti cominciarono a vedere i provvedimenti presi contro gli ebrei come «una garanzia per la completa vittoria della rivoluzione nazionalsocialista» (ibid.). Per chi ha familiarità con i precedenti dibattiti storiografici sulla relazione fra l’espansione, l’occupazione e le politiche belliche della Germania nazista da un lato, e le sue politiche genocidiarie, specialmente contro gli ebrei, dall’altro, queste affermazioni possono suonare sorprendenti e un po’ troppo nette. L’argomentazione di Longerich liquida quel che da molti storici era stata vista come la contraddizione intrinseca tra lo sforzo bellico della Germania e l’Olocausto. La sua tesi risolve la presunta tensione tra il primato nazista dell’ideologia – e cioè il bisogno di stabilire un’utopia razziale – e l’obiettivo radicale, e tuttavia più pragmatico e convenzionale, dell’espansione imperialistica per mezzo militare. In questa interpretazione, che scarta l’ipotesi secondo cui le operazioni di sterminio avrebbero intralciato o distratto la Germania nel suo enorme sforzo bellico, le due politiche sono straordinariamente complementari, proprio perché costituivano
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
O. Bartov - Ripensare l’Olocausto
71
un elemento essenziale del piano complessivo del regime nazista. Fuori dal prisma ideologico del nazismo si può sostenere che, con le necessità poste da una guerra totale, massacrare milioni di persone che avrebbero potuto fornire la forza lavoro tanto necessaria per l’industria bellica del Reich fosse un segno della completa follia di Hitler e dei suoi accoliti. Infatti, da un punto di vista razionale, la Germania avrebbe potuto aumentare moltissimo le sue probabilità di vincere la guerra e dominare un enorme impero continentale se solo avesse abbandonato, o almeno rimandato, i suoi propositi sanguinari. E tuttavia, la ragione stessa per cui questa guerra era stata iniziata, e il motivo essenziale per cui la si doveva vincere, erano strettamente legati con quel che si percepiva come il bisogno vitale di estirpare completamente gli ebrei dalla sfera tedesca di influenza e dominio, che si stava espandendo: un progetto imperiale (che mancò poco venisse coronato dal successo) nel quale il genocidio ebbe davvero un ruolo centrale. Si può meglio apprezzare l’importanza di questa tesi per la comprensione del rapporto fra la guerra e il genocidio se la consideriamo nel quadro più ampio del dibattito accademico. Nei decenni dell’immediato dopoguerra, raramente l’Olocausto figurava nella storiografia sul nazismo e la Seconda guerra mondiale. Le cose cambiarono fra gli anni Ottanta e i Novanta, quando la Soluzione finale cominciò a essere vista come un elemento fondamentale delle politiche tedesche interne come di quelle di aggressione verso l’esterno. Negli ultimi anni, però, si è assistito a un’inversione di tendenza, per cui numerosi storici affermati hanno messo in discussione la centralità dell’Olocausto nella politica nazista interna come nei progetti imperialistici. Infatti, alcuni studiosi hanno asserito che la natura delle politiche naziste possa essere compresa solo nel contesto della lunga storia del colonialismo e dell’imperialismo europei, come pure nella prospettiva più ampia dello scontro titanico fra due totalitarismi ugualmente sanguinari, quello di Hitler e quello di Stalin. Pur non confutando direttamente queste proposte di contestualizzazione, Longerich – analizzando attentamente il Terzo Reich – porta ottime ragioni a sostegno della centralità della Judenpolitik, cioè dell’ideologia e delle politiche riguardanti gli ebrei tedeschi, già nei primi anni del regime. Incapace, prima della guerra, di creare una comunità razziale tedesca in modo “positivo”, il regime ricorse a politiche antiebraiche “negative” – l’unica sfera in cui poteva aspirare al successo. I limiti di queste misure divennero chiari già nel 1939, quando i nazisti lanciarono l’idea di una “Soluzione finale della questione ebraica”. Tuttavia, fu solo nell’estate del 1942, quando erano ormai in corso da tempo massacri imponenti, che vennero prese delle decisioni di natura più generale sullo sterminio degli ebrei d’Europa.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
72
Shoah, modernità e male politico
Questo piano generale consolidò una serie di precedenti disposizioni e interventi a carattere più locale, che avevano già armonizzato le direttive di Berlino con iniziative provenienti “dal basso”. Questa tesi, che mette la Judenpolitik al centro della narrazione del Terzo Reich prima e durante la guerra, presenta il vantaggio di sgombrare molti dei detriti accumulati dal dibattito sempre più arido fra “intenzionalisti” – che sostengono l’idea di un genocidio premeditato, guidato dall’alto – e “funzionalisti” – che vedono l’Olocausto come il risultato dell’iniziativa locale e della competizione interna per il potere nel quadro di una dittatura debole. Un punto importante, secondo Longerich, è che, limitatamente al rapporto fra guerra e genocidio, fu proprio quando il vento cominciò a soffiare contro il Terzo Reich che i decisori nazisti presero a figurarsi l’Olocausto non come un ostacolo alla vittoria, ma piuttosto come il collante che avrebbe tenuto insieme la Germania e il suo impero; il che spiega, a sua volta, perché il regime intensificò, invece di abbandonare, i suoi progetti di sterminio proprio quando la situazione economica e militare volgeva gradualmente al peggio. Non tutti gli storici concordano con la centralità data alla Judenpolitik nella valutazione generale delle politiche del regime. Come ho già osservato, molti studi recenti e autorevoli sostengono la necessità di un’interpretazione più ampia, che tende a relegare l’Olocausto a una posizione meno importante. Nella sua vasta analisi dell’impero nazista, Mark Mazower scrive che mentre «gran parte dell’odierno interesse per il Nuovo ordine [nazista] si concentra sul tema dell’Olocausto», in realtà «anche la “guerra contro gli ebrei” nasceva essenzialmente dalla “guerra per i tedeschi” del Führer». Il «perseguimento del sogno imperiale da parte dei nazisti», osserva, non costò solo le vite di «milioni di russi, polacchi, ebrei e bielorussi», ma culminò anche nella strage di soldati e civili tedeschi «in numero probabilmente non molto inferiore a quello delle vittime della stessa Soluzione finale» (Mazower 2008: 22). Di sicuro, continua, «la Soluzione finale fu motivata dall’ideologia nazista e dal rancore personale di Hitler»; ma «quello che accadde agli ebrei d’Europa ebbe origine dalle circostanze della guerra e fu condizionato dai suoi sviluppi» (430). Mazower presenta così la Soluzione finale come una conseguenza, piuttosto che un obiettivo, dell’imperialismo tedesco. La cronaca che del suo incontro con Heinrich Himmler il 20 aprile 1945 ha dato il profugo ebreo tedesco Norbert Masur ha portato Mazower a concludere che «i tedeschi si erano in un certo senso imbattuti nei grandi centri ebraici dell’Est europeo» come conseguenza dello scatenamento della guerra. Questo, scrive Mazower, era un problema cui «i capi del Terzo Reich avevano dedicato [...]
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
O. Bartov - Ripensare l’Olocausto
73
ben poche riflessioni» (ibid.); di conseguenza, quando venne messo in atto l’Olocausto «ciò che davvero influiva sulla politica [era] il modo in cui la questione ebraica si accordava con gli scopi bellici e le relazioni politiche della Germania e dei suoi alleati» (ibid.). Infatti, «le difficoltà logistiche e diplomatiche di una politica di massacri coordinata a livello continentale furono notevoli fin dall’inizio e si aggravarono a mano a mano che peggiorava la situazione della Germania in guerra» (431). Così, a differenza di Longerich, Mazower considera l’Olocausto una questione problematica per l’imperialismo nazista e una linea politica che diede progressivamente sempre meno risultati nell’ultima fase della guerra. Inoltre, Mazower insiste sul fatto che sebbene «gli ebrei occupavano senz’altro un posto speciale nella demonologia politica del Terzo Reich», in fin dei conti essi «rappresentavano soltanto uno […] tra gli obiettivi etnici del regime» (432). Per Mazower, l’Olocausto fu allora un effetto collaterale del «sogno imperiale» della Germania nazista, che non solo causò lo sterminio di milioni di “altri”, ma, come scrive, «indicava forse, nel caso di una vittoria nazista, la prospettiva di orizzonti di annientamento ancora più vasti» (433). Allo stesso tempo, nonostante i suoi aspetti propriamente nazisti, l’impero tedesco era plasmato secondo il modello di precedenti avventure coloniali europee; per questo Mazower colloca l’Olocausto fra un più generale impulso sterminatore nazista e la normale tradizione imperialista europea. Quel che distingueva l’impero nazista dai suoi altrimenti simili predecessori erano le sue politiche di sterminio – che però non furono mai dirette esclusivamente contro gli ebrei, il cui genocidio non era nelle intenzioni originarie e finì per ostacolare la realizzazione del «sogno imperiale» nazista. In conclusione, l’Olocausto fu essenzialmente un “poscritto”, un fattore di distrazione e una prefigurazione di nuove imprese genocidiarie. Lo storico Adam Tooze adotta una prospettiva diversa sulla relazione tra guerra e genocidio nel suo massiccio studio dell’economia nazista. Tooze calcola che i nazisti uccisero almeno 4,8 milioni di potenziali lavoratori, di cui metà erano ebrei, dopo la prima crisi militare dell’inverno 1941-42, e circa 7 milioni se si includono i prigionieri di guerra sovietici che furono uccisi nel 1941 (Tooze 2007: 629). Per questo si può concludere, secondo Tooze, «che il Terzo Reich fosse un regime per il quale le preoccupazioni economiche erano di importanza secondaria» e «il primato della politica era assoluto». Tuttavia, precisa Tooze, «il programma di reclutamento forzato della manodopera e il genocidio si possono considerare più complementari che contraddittori». Tanto per cominciare, l’imponente reclutamento di manodopera in Europa «fece apparire superflui gli ebrei». In secondo luogo, dove gli ebrei costituivano una parte significativa della popolazio-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
74
Shoah, modernità e male politico
ne, come in Polonia e in Ucraina, il «processo di sterminio aveva una sua logica burocratica», dato che «venne portato avanti su iniziativa delle SS […] con l’appoggio di Hitler e di Himmler». In verità, «le SS appaiono una minoranza particolarmente determinata, che vuole imporre il programma di giudeicidio a un’amministrazione militare riottosa». Così, sostiene Tooze, «l’Olocausto si può far apparire come una concessione strappata alla burocrazia pragmatica dell’amministrazione statale tedesca dalla dirigenza, ideologicamente impegnata, delle SS» (629-30). Ma questa non è ancora tutta la storia. Come mostra Tooze, le SS in realtà sfruttarono le preoccupazioni concrete di carattere militare ed economico come ulteriore strumento per mettere in atto il genocidio. La selezione iniziale delle vittime, per cui gli uomini in età militare venivano giustiziati mentre gli altri venivano risparmiati, fu prontamente rovesciata. Nel giro di poche settimane dall’invasione dell’Unione Sovietica, la pratica della selezione arrivò a fornire un imperativo economico per l’uccisione degli inabili al lavoro – donne, vecchi e bambini – cui poi seguirono gli schiavi vittime della politica dello «sterminio attraverso il lavoro». Così, invece della presunta tensione fra massacro indiscriminato di matrice ideologica e sfruttamento economico del lavoro degli ebrei, si trova che la selezione degli operai ebrei costituiva una perfetta razionalizzazione del genocidio senza trascurare del tutto le necessità di ordine pratico ed economico. Inoltre, questa politica incoraggiava la remissività degli stessi ebrei, i quali si illudevano che, finché avessero lavorato, le loro vite sarebbero state risparmiate. Al contrario, la finzione di uccidere solo gli ebrei inabili al lavoro – le cosiddette “bocche inutili” – faceva apparire il genocidio, in un periodo di guerra e risorse limitate, come una misura funzionale e conveniente agli occhi dei suoi esecutori. Così, l’Olocausto finì per essere visto come un elemento importante per conseguire la vittoria, in base al ragionamento che gli ebrei adatti lavoravano per lo sforzo bellico tedesco, mentre la zavorra degli inadatti veniva eliminata (629-33). Nonostante le somiglianze esteriori, c’era però una differenza essenziale tra massacrare di lavoro gli ebrei e sfruttare la forza lavoro non ebrea. Come scrive Tooze, «nel caso dell’Olocausto gli imperativi ideologici erano chiaramente importantissimi, ma soggetti a un compromesso pragmatico imposto dalle circostanze». Viceversa, nel caso della manodopera non ebrea l’equilibrio «tra ideologia e necessità pragmatica» era rovesciato, e vinceva il pragmatismo (633). Questa distinzione venne mantenuta persino quando «il sostegno allo sforzo bellico […]venne a prevalere sempre più su tutte le altre preoccupazioni del regime hitleriano». In una certa misura, fu possibile continuare a giustificare l’Olocausto su basi razionali sostenendo
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
O. Bartov - Ripensare l’Olocausto
75
il principio della selezione fino alla fine. Così, al massacro di centinaia di migliaia di ebrei ungheresi nella primavera e nell’estate del 1944 si accompagnò la selezione di alcune decine di migliaia di loro da destinare al lavoro forzato. E tuttavia, secondo Tooze, attuare la Soluzione finale in questa fase tarda del conflitto richiese comunque «una certa segmentazione della politica, in cui alle SS fu consentito di perseguire l’imperativo ideologico di sterminare la popolazione ebraica», mentre la manodopera straniera non ebrea e alcuni ebrei residui venivano «progressivamente “ridimensionati” per tener conto delle esigenze dell’economia di guerra» (645). In questo modo Tooze ha rivisto quella che definisce «la grande contraddizione tra economia e ideologia», mostrando come l’apparenza dell’imperativo genocidiario del regime fosse sia «“attenuata” da una sorta di compromesso e di specializzazione funzionale», sia razionalizzato per mezzo della creazione di «un collegamento funzionale tra lo sterminio della popolazione ebraica […] e l’incremento delle razioni alimentari» (658). Tuttavia, questa raffinata argomentazione presuppone che l’Olocausto sia stato un evento che poteva rientrare nello slancio generale delle politiche espansionistiche e aggressive tedesche solo per mezzo di una segmentazione burocratica e di calcoli calorici chiaramente strampalati ed esiziali. È una visione molto diversa da quella di Longerich, che percepisce l’Olocausto sia come la ragion d’essere del regime e della sua guerra, sia come il collante che teneva assieme tutto il resto. Non c’era bisogno che la Soluzione finale “rientrasse” in qualche modo nello schema più ambizioso della guerra imperialistica tedesca, perché al contrario essa divenne l’espressione più chiara e comprensibile dell’utopia razziale nazista per la quale si combatteva la guerra. E nemmeno l’idea di una segmentazione burocratica corrisponde alla visione delle SS come il motore principale dell’intera, vasta impresa di occupazione e di governo, motivo per cui la missione genocidiaria che si erano auto-assegnate veniva percepita come un obiettivo primario, essenziale. Lo storico britannico Donald Bloxham ha provato a esaminare l’Olocausto all’interno del contesto più ampio delle guerre, dei casi di pulizia etnica e dei genocidi europei in modo piuttosto diverso. Per Bloxham, la storia dell’Olocausto è «già in se stessa una storia internazionale» che presenta «una dimensione comparativa» (Bloxham 2009: XVII). Come «fenomeno transnazionale», sostiene, «l’Olocausto fu in un certo senso un processo europeo», che «ebbe luogo nel contesto di altri processi europei di esclusione omicida, di disordine geopolitico e di ristrutturazione economica». Da questa prospettiva osserva che «sebbene gli ebrei siano stati le vittime principali dello sterminio di massa, non furono le uniche e la Germania
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
76
Shoah, modernità e male politico
nazista non ne fu la sola responsabile» (XVII-XVIII). Bloxham nota che questa violenza era in gran parte «di tipo etnico o “razziale”», e che si era andata intensificando nell’ultimo quarto del XIX secolo; e che perciò la Seconda guerra mondiale costituiva «solo il terzo e più feroce periodo di conflitto interetnico e transnazionale» risalente almeno agli anni Settanta dell’Ottocento (XVIII-XIX). Bloxham ipotizza che «le caratteristiche specifiche del nazismo all’interno di questa Europa generalmente violenta» siano essenzialmente tre: la posizione e la natura dello Stato tedesco, la natura del razzismo e dell’antisemitismo nazista, e l’estremismo delle politiche antisemite dei nazisti. Tuttavia, secondo lui, persino queste «particolarità del nazismo tedesco […] sono state di frequente esagerate» (XXI). Infatti, afferma Bloxham, «gli obiettivi geopolitici di Hitler erano il risultato dell’unione delle mire imperial-coloniali di una grande potenza e dell’espansionismo irredentista del giovane Stato-nazione europeo» (XXI). Inoltre, «gli architetti del genocidio tedesco» potevano ispirarsi a «precedenti storici pratici di distruzione di gruppi», e a «una serie di idee diffuse in Europa a proposito di “nemici interni”, vere e proprie quinte colonne etniche, e […] l’influenza esercitata dagli ebrei» (XXII). Infine, asserisce, l’Olocausto non cominciò come genocidio ma come politica di espulsione, e persino al suo acme «gli ebrei non [venivano] considerati dovunque una priorità». Di conseguenza, «sebbene sia stato il genocidio più grave, lo sterminio degli ebrei conservò in parte tratti che lo accomunavano ad altri genocidi» (XXV), a prescindere dal fatto che «si sviluppò anche contemporaneamente ad altri omicidi di massa nazisti» (XXV). L’interpretazione di Bloxham ci porta al di là della questione della centralità specifica dell’Olocausto per gli obiettivi militari tedeschi, verso una visione della Soluzione finale come parte di una lunga storia di guerre nazionali, conflitti imperiali e dominazioni coloniali, che, nella sua prospettiva, spesso impiegavano intenzionalmente o culminavano nel genocidio. La questione che il suo studio solleva in relazione al nostro tema è la misura in cui altri genocidi condividessero la caratteristica della Soluzione finale – se accettiamo questa tesi – di costituire una parte essenziale degli obiettivi militari tedeschi e della rappresentazione della vittoria. Si può sostenere che proprio l’approccio comparativo e contestualizzante adottato da Bloxham illumina questa peculiarità dell’Olocausto, anche mentre – peraltro giustamente – lo colloca all’interno di un quadro molto più ampio di genocidi e di altri crimini contro l’umanità. Ma Bloxham è più interessato a trovare i parallelismi e le affinità, e respinge con forza ogni argomento a sostegno dell’unicità delle politiche antisemite naziste.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
O. Bartov - Ripensare l’Olocausto
77
Negli ultimi tempi, la centralità dell’Olocausto per gli scopi bellici della Germania, la Seconda guerra mondiale e i genocidi del XX secolo sono stati esaminati da un’ulteriore prospettiva. In Bloodlands (Terre di sangue), Timothy Snyder rivede il vecchio paradigma totalitario giustapponendo le politiche di sterminio di massa messe in atto dalla Germania nazista e dall’Unione Sovietica. La tesi principale del libro è che i due regimi si siano incalzati a vicenda in un’escalation di violenza nel rovinoso braccio di ferro sul fronte orientale. Snyder, però, comincia a calcolare il numero delle vittime non dall’inizio della guerra, ma dalle carestie di massa in Ucraina e in altri luoghi dell’Unione Sovietica nel biennio 1932-33. Questo gli permette di sostenere che i due regimi totalitari uccisero insieme «14 milioni di persone, deliberatamente sterminate nelle terre di sangue tra il 1933 e il 1945», di cui «un terzo lo si deve ai sovietici». Le vittime di questo “sterminio politico”, scrive Snyder, furono prese di mira dalla «politica di morte sovietica o nazista» in quelle che l’autore chiama, senza offrirne una vera definizione, “terre di sangue” – e cioè i territori che negli anni Trenta corrispondevano «alla Polonia, gli Stati baltici, la Bielorussia, l’Ucraina e i territori occidentali della Russia sovietica» (Snyder 2010: 12-4). Con questa scansione temporale e geografica Snyder intende dimostrare che, mentre «in Europa di solito l’uccisione di massa è associata all’Olocausto», deve essere vista all’interno del contesto delle «due maggiori operazioni di sterminio dopo l’Olocausto – le carestie volute da Stalin nei primi anni Trenta e la soppressione per stenti dei prigionieri di guerra sovietici operata all’inizio degli anni Quaranta» (17). Certamente, entrambi i casi, assieme ad altri misfatti nazisti come la «politica della fame» in Bielorussia e il Grande terrore di Stalin fra il 1936 e il 1938 sono stati ampiamente studiati negli ultimi decenni (Gerlach 1999; Conquest 1990); la novità della tesi di Snyder, com’egli rivendica, è l’idea che la Soluzione finale costituisse un elemento connaturato ai crimini nazisti e sovietici, e che non possa essere compreso al di fuori di questo quadro di riferimento. Per integrare l’Olocausto in queste più ampie politiche criminali, presentate come obiettivi primari di entrambi i regimi, Snyder sostiene la tesi piuttosto bizzarra che «non c’era niente di particolarmente moderno nelle camere a gas», dal momento che il «cianuro di idrogeno» era già stato «isolato nel XVIII secolo», mentre «persino gli antichi greci sapevano» che «il monossido di carbonio […] era letale» – come se una conoscenza simile spiegasse di per sé la costruzione di fabbriche della morte (Snyder 2010: 17). In ogni caso, la tesi centrale è chiara: «tedeschi e sovietici si provocarono a vicenda, commettendo crimini sempre peggiori», e i massacri nelle «terre di sangue» furono il «risultato dell’interazione tra due sistemi» (428-29). In altre
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
78
Shoah, modernità e male politico
parole, come tutti gli altri crimini perpetrati da Hitler e Stalin, l’Olocausto fu la conseguenza di questo scontro tra malvagi titani. Perciò, Snyder incorpora la Soluzione finale in una lunga lista di crimini dei totalitarismi. Ipotizzando che tutti questi crimini fossero un elemento costitutivo delle immagini del mondo nazista e sovietica, e quindi anche una componente essenziale per la definizione degli obiettivi bellici dei due regimi, allora anche lo sterminio di massa degli ebrei può essere visto come una precondizione necessaria alla vittoria tedesca. Tuttavia, la falla di questa teoria è che, mentre si può sostenere che la Soluzione finale prese il sopravvento sugli altri elementi dell’utopia razziale nazista, lo stesso non può dirsi dei crimini sovietici, che non costituivano obiettivi bellici primari, ma erano piuttosto dei mezzi brutali per conseguire altri traguardi ideologici e nazionali che, di per sé, non prevedevano atti genocidiari. Alcune delle tesi qui presentate come nuove e innovative in gran parte sintetizzano studi precedenti, riformulando interpretazioni già note. L’idea che la guerra d’espansione della Germania nazista fosse una radicalizzazione di imprese imperialistiche precedenti era già stata proposta negli anni Sessanta (Hillgruber 1965). Le rappresentazioni dell’Olocausto sullo sfondo di un più ampio contesto genocidiario erano già comuni durante l’Historikerstreit, la controversia degli storici tedeschi della metà degli anni Ottanta (Augstein 1987; Maier 1988; Baldwin 1990). Anzi, lo stesso Hitler sembra aver fatto riferimento al genocidio degli armeni per legittimare i propri disegni di sterminio (Albrecht 2007; Anderson 2010: 199). E il modello dei totalitarismi, riproposto di recente, è profondamente radicato nelle vicendevoli accuse di atrocità che il Terzo Reich e l’Unione Sovietica si scambiavano durante la guerra e poi nel suo lascito, la Guerra fredda (Friedrich – Brzezinski 1956). Il fatto che questa tesi abbia ricevuto un caldo benvenuto nell’Europa orientale è indicativo di come le realtà politiche che si sono là costituite forniscano terreno fertile per un revisionismo datato, presentato però come ricerca occidentale d’avanguardia (Himka – Michlic 2013). Per lo più, i primi studi sulle politiche d’occupazione tedesche, l’esercito tedesco e la Seconda guerra mondiale, le biografie di Hitler, le analisi della struttura del Terzo Reich e così via tendevano soprattutto a “contestualizzare”, marginalizzare, o semplicemente ignorare il genocidio degli ebrei: spesso l’Olocausto veniva presentato come un evento secondario, per quanto certamente orribile; una follia portata a termine da un piccolo
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
O. Bartov - Ripensare l’Olocausto
79
gruppo di fanatici e rivolta contro una minoranza di relativa importanza1. Ma specialmente a partire dagli anni Ottanta, gli studi sull’Olocausto sono entrati gradualmente a far parte degli studi storici tradizionali sulla Germania nazista e la Seconda guerra mondiale; e certamente hanno anche reagito alla precedente tendenza fra gli storici a distinguere fra guerra e genocidio – come pure fra soldati e aguzzini: una distinzione che difficilmente può essere esistita nella realtà o nelle menti degli stessi protagonisti. Perciò, i tentativi recenti di contestualizzare l’Olocausto e sminuirne la centralità per la guerra e la Germania nazista possono essere considerati una terza ondata interpretativa e una reazione a una serie di studi che, secondo molti nuovi storici, hanno messo un’enfasi eccessiva sulla Soluzione finale in particolare e sulle politiche di sterminio naziste in generale. Di sicuro, questi nuovi studi sono stati stimolati anche dall’accesso a nuovi archivi in seguito al collasso del comunismo, come pure da nuove osservazioni, spesso da parte di storici non europei o da gruppi di ricerca internazionali, sul rapporto tra dominazione coloniale e violenza europea. Molti di questi studi sono di grande rilevanza. Tuttavia, l’approccio contestualizzante attraverso paragoni e precedenti li porta spesso a fare affidamento su sintesi di letteratura preesistente, e – a causa della natura polemica di questo ambito e della quantità sempre crescente dei contributi – questi saggi finiscono per proporre generalizzazioni discutibili, basate su una documentazione superata e incompleta. Di conseguenza, rischiano di perdere di vista i tratti peculiari dell’Olocausto e del ruolo che ebbe nella politica tedesca. È per questa ragione che sono così cruciali studi più mirati e più documentati, perché, se si viene affermando una nuova interpretazione della centralità della Soluzione finale per la guerra nazista, allora anche i parametri della comparazione e della contestualizzazione dovranno adattarsi di conseguenza. Lo dimostra proprio il circostanziato saggio di Longerich sulla Judenpolitik: le politiche antisemite naziste non furono né un evento secondario né un ripensamento successivo; lo sterminio degli ebrei non poteva essere visto dalle autorità naziste come una “follia” rispetto al raggiungimento degli obiettivi bellici del Reich, dal momento che era diventato esso stesso uno degli obiettivi bellici primari. L’idea di una “Soluzione finale”, come Longerich persuasivamente sostiene, non emerse con l’invasione dell’Unione Sovietica, perché era già stata concepita nel 1939 e, sebbene non fossero ancora chiari i dettagli della sua implementazione, se ne erano già comprese eloquentemente le 1
Cfr. Bullock 1952; Dallin 1957; Broszat 1961, 1969; Erickson 1975; Seaton 1982.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
80
Shoah, modernità e male politico
implicazioni genocidiarie. Nella seconda parte della guerra, quando la Germania si trovava sotto una crescente pressione militare e le sue alleanze politiche cominciavano a logorarsi, la Judenpolitik non divenne un peso ma piuttosto un test decisivo per il regime per verificare chi gli era a favore e chi contro. Era, certamente, uno strumento politico, e poteva essere brandito quando necessario o messo temporaneamente da parte, almeno parzialmente; ma era anche un concetto distintivo dell’ideologia e della politica naziste. Per i nazisti, la guerra era diretta soprattutto contro nemici che, in ultima analisi, erano manipolati e controllati dagli ebrei. Anzi, chiunque combattesse il nazismo doveva esserlo, persino qualora fosse stato in precedenza un alleato: quando ad esempio il dittatore ungherese Miklós Horthy si rifiutò di continuare a deportare gli ebrei, venne subito percepito come loro difensore e lacchè (Longerich 1998: 406). Né è possibile distinguere tra l’Olocausto e la guerra contro l’Unione Sovietica. Fin dall’inizio, fu una guerra contro il giudeo-bolscevismo, nell’ottica del regime e di buona parte dell’esercito. È per questa ragione che divenne molto più facile trucidare un gran numero di ebrei già nelle prime settimane di scontro con l’Armata rossa. L’equivalenza tra gli ebrei e i nemici militari agì come potente fattore legittimante nella conduzione di una guerra di sterminio contro l’Unione Sovietica da un lato, e nella perpetrazione del genocidio contro gli ebrei dall’altro (Bartov 1991; Förster 1983; Ueberschär 1997). Equiparare i civili da sterminare ai combattenti nemici è evidentemente un potente strumento di legittimazione per qualunque governo che miri a sradicare intere categorie di persone. Questo meccanismo di razionalizzazione mentale è reso ancora più efficace se si organizza lo sterminio come un’operazione militare. Il genocidio è perciò collegato alla guerra perché, in primo luogo, è molto più facile eseguire una strage nel contesto di uno scontro armato. È anzi difficile pensare a un genocidio che nel XX secolo non sia stato direttamente connesso con un conflitto militare di qualche tipo, si trattasse del massacro degli Herero nell’Africa sud-occidentale del 1904, degli armeni durante la Prima guerra mondiale, dei cambogiani nel 1975, dei ruandesi nel 1994, delle stragi in Bosnia nella prima parte degli anni Novanta, solo per citare i più evidenti. In secondo luogo, i genocidi sono collegati alle guerre perché sono costantemente militarizzati. Da un punto di vista psicologico e organizzativo, è molto più facile per gli esecutori di una carneficina agire non solo sotto la copertura della guerra, ma anche comportarsi come se le atrocità che compiono fossero normali azioni militari, anche se le vittime sono anziani, donne, bambini. Indossando delle uniformi, impartendo ordini in stile militare,
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
O. Bartov - Ripensare l’Olocausto
81
mantenendo le strutture gerarchiche e organizzative tipiche della polizia militare o militarizzata, i carnefici trasformano quel che altrimenti apparirebbe loro come violenza criminale in azioni militari spiacevoli ma inevitabili, eseguite con la stessa efficienza e disciplina di qualunque altra operazione bellica. Questa è in realtà una caratteristica essenziale, forse addirittura necessaria, del genocidio moderno come tale, nonostante le esplosioni di violenza incontrollata. Nel caso dell’Olocausto, però, il genocidio prevedeva anche forme di incarcerazione militarizzata, lavori forzati, strutture per lo sterminio. Per quanto anche queste avessero, di nuovo, tutti gli attributi esteriori di campi militari o campi per prigionieri di guerra (come filo spinato, torrette d’osservazione, uniformi per i reclusi, baracche e così via), i campi di sterminio in particolare rappresentavano una novità negli annali dei genocidi, e sono rimasti una caratteristica esclusiva della Soluzione finale. Occorre però anche considerare il rapporto fra guerra e genocidio dal punto di vista inverso. Certamente, mentre la maggior parte dei genocidi moderni sono avvenuti nel contesto o sotto la copertura di una guerra, non tutte le guerre sono genocidiarie. Ma il genocidio tende a influenzare la natura della guerra nel suo complesso, consentendo una vasta gamma di altri crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Se la guerra criminale legittima il genocidio, il genocidio in tempo di guerra corrompe tutti quelli che combattono. I primi mesi dell’invasione tedesca dell’Unione Sovietica ne danno un esempio significativo. Come ha scritto Jürgen Matthäus: Già alla fine del 1941 la mortalità tra i non combattenti toccava livelli devastanti. Da 500.000 a 800.000 ebrei, compresi donne e bambini, erano stati già assassinati – in media da 2700 a 4200 al giorno – e intere regioni risultavano judenfrei. [...] Nell’autunno del 1941 i soldati dell’Armata rossa nei campi tedeschi morivano al ritmo di 6000 al giorno; nella primavera del 1942 erano morti 2 dei 3,5 milioni di soldati sovietici catturati dalla Wehrmacht. [...] È difficile arrivare a stime affidabili sul totale delle perdite sovietiche, ma è probabile che una cifra di 20 milioni non sia lontana dal vero. (Browning – Matthäus 2004: 256-57)
La militarizzazione del genocidio e l’imbarbarimento del conflitto sono quindi strettamente interrelati. Se ne è avuta dimostrazione in molti dei casi già menzionati. Le truppe tedesche in Africa sud-occidentale e i soldati turchi in Anatolia sostenevano di combattere dei ribelli, degli insorti, o traditori in combutta col nemico (Hull 2005). Per i soldati impegnati in un massacro, il fatto stesso di uccidere dei civili può indicare la complicità delle vittime col terrorismo o la guerriglia; proprio perché non indossano uniformi, vengono sospettati di agire alle spalle dell’esercito o addirittura di lavorare per il nemico.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
82
Shoah, modernità e male politico
Naturalmente, la guerra totale porta con sé anche profonde trasformazioni sociali, culturali e politiche2. Quando tali guerre vengono accompagnate da politiche di sterminio e genocidio, bisogna prendere in considerazione l’impatto di queste pratiche sulla società nel suo complesso. Il regime nazista cercò consapevolmente di coinvolgere nel proprio progetto genocidiario cerchie sempre più ampie, sia all’interno del paese che all’estero, persino quando, paradossalmente, cercava di nascondere i dettagli delle uccisioni e di cancellarne le tracce. Al contrario, nei primi decenni dopo la guerra, i tedeschi e i loro fiancheggiatori cercarono di dissociarsi dagli aguzzini, e di dipingerli come soggetti non rappresentativi o addirittura alieni alla società, alla storia e alla cultura tedesca. Tuttavia, giudici e storici erano contemporaneamente impegnati nella ricostruzione delle tracce storiche dei fatti, così che alla fine emerse un quadro molto più chiaro della complicità della società civile tedesca ed europea. L’ultimo grosso ostacolo che il pubblico tedesco dovette superare fu il riconoscimento del coinvolgimento della Wehrmacht nel genocidio e in crimini di massa, che portò a un infiammato dibattito nei tardi anni Novanta. Fu grazie alla ricerca che si faceva già da decenni su questo argomento che si poté delineare una migliore e sempre più pubblica comprensione degli innumerevoli collegamenti fra l’esercito e l’apparato genocidiario del regime, come pure fra la società nelle “retrovie” e i carnefici e i soldati al fronte3. Volgendosi indietro a considerare questo campo di studi in continua espansione, oggi si può concludere che la presunta tensione fra guerra e genocidio, fra aspirazioni imperiali della Germania e furia genocidiaria è stata una costruzione del dopoguerra. Non esisteva nelle menti dei maggiori protagonisti dell’epoca e non avrebbe avuto, per loro, nessun significato. Che i nazisti si ispirarono ad altri imperi, che l’Olocausto ebbe caratteristiche simili a quelle di altri genocidi, e che la Germania nazista e l’Unione Sovietica impararono l’una dall’altra e si incitarono reciprocamente a una sempre maggiore violenza, è innegabile. Ma il rapporto fra guerra e genocidio, cruciale per la nostra comprensione della violenza moderna, non è ancora sufficientemente studiato, forse proprio perché è la questione più rilevante per il nostro presente. In gran parte del mondo, il comunismo e i totalitarismi sono cose del passato; il colonialismo e l’imperialismo tradizionali, come pure i regimi ispirati a utopie razziali, sono anch’essi stati in 2 3
Cfr. Higonnet et al. 1987; Chickering – Förster 2000; Chickering – Förster – Greiner 2005. Cfr. Hamburg Institute for Social Research 1999; Heer – Naumann 2000; Bartov – Grossman – Nolan 2002; Müller 1969; Messerschmidt 1969; Streit 1978; Bartov 1985; Müller – Volkmann 1999.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
O. Bartov - Ripensare l’Olocausto
83
gran parte relegati ai libri di storia. Ma la violenza militare è onnipresente, e la sua capacità di alimentare e legittimare il genocidio non è diminuita. Come Longerich ha persuasivamente sostenuto, «per i nazionalsocialisti, la guerra razziale per lo spazio vitale implicava fin dall’inizio la prospettiva dello sterminio di quel che avevano chiamato “il nemico ebreo”» (Longerich 1998: 424-25). I nazisti perseguirono la dominazione razziale e il genocidio – rispettivamente, gli aspetti “positivi” e “negativi” della loro ideologia – con inaudita inflessibilità. Nel contesto di una guerra totale e di una distruttività diffusa, finirono per privilegiare la politica “negativa” dello sterminio, facendone un obiettivo bellico primario – in effetti, l’unico che essi portarono veramente a compimento. Le implicazioni di questi specifici avvenimenti storici sono ancora oggi assai rilevanti. Lo scatenamento della violenza che qualunque guerra comporta, e l’apparente bisogno di privare prima dell’umanità e poi della vita quanti sono stati designati come vittime, implica sempre la possibilità di prendere a bersaglio intere popolazioni. I civili delle regioni occupate rischiano di essere vittime di crimini di guerra se non vengono protetti dalle norme e dai regolamenti dei militari occupanti. Quando il governo che si serve di questi militari decide che il nemico è meno che umano e fa mancare la sua protezione, la strada per il genocidio è tracciata. In questo senso, il genocidio è sempre stato uno strumento militare nelle mani di chi vuole usarlo. Persino quando farvi ricorso può accorciare la strada verso la propria sconfitta, il suo impiego può apparire a chi lo usa come l’ultima vittoria.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
85
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
CHRISTOPH U. SCHMINCK-GUSTAVUS
INDULGENZA TOGATA La mancata punizione di alcuni esecutori dell’Olocausto nella Germania Federale degli anni Sessanta
Assemblea di magistrati tedeschi nel Tribunale di Moabit, Berlino 1936
1. Il ruolo dei magistrati nell’ascesa del nazismo La disinvoltura della magistratura tedesca nel passare dalla Repubblica di Weimar alla dittatura nazista ha dell’incredibile per chi è cresciuto nel rispetto delle istituzioni democratiche e repubblicane. Oggi sembrerebbe ovvio che la magistratura tedesca avrebbe dovuto rifiutare un regime che sin dai suoi inizi ricorreva alla violenza e al terrore – invece non fu affatto così. Nella stragrande maggioranza, i giudici di Weimar non erano solo ultra-conservatori, ma anche anti-repubblicani accaniti, fomentati da un odio feroce contro il nuovo regime nato dalla sconfitta nella Grande guerra. Molti di loro si sentivano ancora vincolati al giuramento di fedeltà
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
86
Shoah, modernità e male politico
al Kaiser, nonostante costui, appena firmato l’armistizio, fosse fuggito in Olanda. Ora l’odio della destra – e perciò anche di molti giudici – si rivolgeva contro la sinistra, assurdamente additata a responsabile per la sconfitta. Nell’ottica conservatrice, i cosiddetti Novemberverbrecher (criminali di novembre) erano i responsabili per il Dolchstoß (la “pugnalata nella schiena”) dell’esercito, e con ciò i veri colpevoli della sconfitta militare del novembre 1918. Le convinzioni reazionarie della magistratura weimariana sono state descritte per la prima volta in un’analisi dettagliata da Ernst Fraenkel (1968). Queste convinzioni reazionarie portavano la magistratura penale a una parzialità palese nelle punizioni di delitti commessi da esponenti della destra o della sinistra. Tale parzialità dei giudici è stata analizzata e statisticamente provata già nei primi anni dopo la guerra da Emil Julius Gumbel, professore di matematica e statistica a Heidelberg, amico di Albert Einstein (Brenner 2001). Nel 1921 Gumbel ha pubblicato una documentazione dei processi per assassinii politici rispettivamente commessi dalla destra e dalla sinistra (Gumbel 1921). Dall’ultima edizione di questa documentazione risulta che dei 354 assassinii commessi da militanti di destra ben 326 sono rimasti impuniti, mentre dei 22 assassinii commessi da militanti di sinistra solo 4 non sono stati puniti. Gumbel ha constatato lo stesso disequilibrio nelle pene inflitte: mentre l’assassinio da sinistra portava di regola alla pena capitale, quello commesso da destra spesso era punito solo con una pena irrisoria. Così non c’è da meravigliarsi che la magistratura weimariana nella sua stragrande maggioranza abbia salutato l’ascesa al potere di Hitler con sollievo – se non addiritura con entusiasmo. È vero che nei primi anni della Repubblica di Weimar era stato fondato un Republikanischer Richterbund (Lega dei magistrati repubblicani), ma a questa Lega di regola non erano iscritti dei giudici, bensì solo avvocati. Già prima del 1933 più della metà dei perfezionandi di giurisprudenza erano entrati nella NSDAP; perciò i professori nelle Facoltà di giurisprudenza denunciati di appartenere alla “razza ebraica” non potevano più far lezione, perché minacciati in continuazione e silenziati nelle aule dalle urla di teppisti nazisti. In seguito nessun giudice aveva protestato contro l’installazione dei primi campi di concentramento, “selvaggi” e apertamente illegali; ugualmente nessuno diceva una parola contro l’eliminazione della Costituzione di Weimar attraverso il cosiddetto Ermächtigungsgesetz (Legge sui pieni poteri del febbraio 1933), che cancellava i diritti fondamentali dei cittadini. Quando poi si andava verso la Gleichschaltung (l’allineamento nazista) della società e di tutte le organizzazioni professionali, anche quelle dei giuristi – dei magistrati, degli avvocati e degli impiegati statali – furo-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.U. Schminck-Gustavus - Indulgenza togata
87
no trasferite senza resistenza nel NSRWB (Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund, Lega nazionalsocialista dei tutori del diritto). La sua prima spettacolare assemblea fu celebrata a Lipsia nella piazza davanti al Reichsgericht (Corte suprema del Reich) con una manifestazione imponente, capeggiata da Hans Frank, avvocato personale di Hitler durante la Kampfzeit (l’“epoca della battaglia”), che nel frattempo era stato nominato Reichsjuristenführer1.
Notiziario mensile della Lega dei magistrati: Assemblea dei magistrati tedeschi davanti al Reichsgericht a Lipsia, ottobre 1933 1
Hans Frank diventò in seguito Governatore generale in Polonia, cioè supremo massacratore della nazione polacca. Condannato e giustiziato nel primo processo
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
88
Shoah, modernità e male politico
In occasione di quest’appuntamento dei giuristi tedeschi, sulla facciata del Reichsgericht, sotto il timpano, fu appeso un enorme striscione con lo slogan: Durch Nationalsozialismus dem deutschen Volk das deutsche Recht (Il diritto germanico al popolo tedesco per mezzo del nazionalsocialismo). Con questo striscione, l’altro – e molto più vecchio – ammonimento ai giudici sulla facciata del Reichsgericht non era più visibile: il grande medaglione di pietra con le cifre da 1 a 10, un’allusione al Decalogo. La perfetta coreografia dell’assemblea – come sapeva organizzarla il ministero della Propaganda nazista – si concludeva con un grande corteo attraverso la città e l’imponente parata di giuristi in uniforme davanti al Reichsgericht. La Gleichschaltung della magistratura e delle altre organizzazioni professionali andava di pari passo con la nazificazione di tutto l’ordinamento giuridico e dei suoi esecutori. Alle toghe dei giudici fu presto applicato il simbolo del NSRWB, cioè un’aquila che tiene la svastica negli artigli. L’introduzione delle nuove toghe fu festeggiata in tutti i tribunali del Reich con apposite riunioni dei magistrati. Contemporaneamente fu appesa nelle aule dei tribunali un’immagine del Führer subito dietro al banco dei giudici, per ricordare che da ora in poi era in suo nome che veniva fatta giustizia. Per elaborare un codice di “diritto germanico” fu istallata a Monaco la Akademie für deutsches Recht (Accademia per il diritto germanico); come suo presidente fu nominato il già citato Hans Frank. Il lavoro dell’Accademia veniva appoggiato da molti professori di giurisprudenza, specialmente da quelli delle Facoltà “di punta” come la Kieler Schule e altre Facoltà di giurisprudenza che nel frattempo erano state completamente “arianizzate”. Anche gli studi giuridici furono trasformati in senso nazista; tutti gli aspiranti alle professioni giuridiche dovevano partecipare al cosiddetto Referendarlager di Jüterbog (Campo studio per referendari giuridici) alle porte di Berlino. Lì venivano istruiti sul “Nuovo ordinamento giuridico nel Terzo Reich”, sui principi della “tutela della razza” e altri argomenti del genere. Così preparata, la magistratura tedesca è entrata nella Seconda guerra mondiale e ha servito il terrore sparso in tutta Europa dal regime nazista. Solo un’esigua minoranza dei giudici non ha condiviso le scelte del regime2. Inol-
2
di Norimberga, Frank utilizzò gli ultimi mesi della sua vita per scrivere un’autodifesa in cui attribuiva tutte le colpe a Hitler. Poco prima dell’esecuzione della pena capitale si convertì al cattolicesimo; cfr. Frank 1953. Un’eccezione limpida dall’asservimento generale al regime fu il giudice Lothar Kreyssig, membro della Bekennende Kirche (la Chiesa confessante), che osò presentare una denuncia per assassinio quando si accorse che i malati di mente erano
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.U. Schminck-Gustavus - Indulgenza togata
89
tre, la maggioranza dei giudici che non erano stati chiamati ancora sotto le armi vivevano nella paura di perdere la loro U.K.-Stellung3 – il che avrebbe significato partire per il fronte e finire magari a Stalingrado. Hitler, intanto, minacciava di eliminare del tutto la magistratura – una decisione che Himmler con le sue SS aspettava impazientemente. Così, per non dare l’impressione di non essere all’altezza dei tempi, molti giudici emanavano spietate sentenze di terrore. Il Volksgerichtshof (Tribunale del popolo per i delitti politici), i Sondergerichte (Tribunali speciali) e i Kriegsgerichte (Corti marziali) hanno emesso decine di migliaia di pene capitali, che nella stragrande maggioranza dei casi sono state eseguite. Dopo questo sciagurato periodo e dopo il declino abissale del diritto, il crollo finale del regime nazista non fu vissuto dai magistrati tedeschi come una liberazione, ma come la caduta di un sistema statale al quale avevano creduto fino al rinnegamento di ogni giustizia.
Magistrati al servizio del Führer – Seduta della Corte d’appello di Berlino, 1937
3
stati mandati nelle camere a gas nella clinica psichiatrica di Hadamar in quanto Ballastexistenzen (vite zavorra); cfr. Kramer 1988: 342 ss. L’esenzione dal servizio militare per chi svolgeva obblighi professionali ritenuti indispensabili.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
90
Shoah, modernità e male politico
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
2. La magistratura federale dopo il crollo del nazismo e il “caso tre” a Norimberga Il filosofo Karl Jaspers, uno dei grandi pensatori tedeschi del dopoguerra, ha descritto la situazione della Germania in ginocchio dopo la capitolazione incondizionata. Jaspers era sopravissuto alla guerra per miracolo. Sapeva che era prevista la sua cattura, con il trasferimento in un campo di concentramento – il che avrebbe significato la morte sicura. Perciò aveva preparato capsule di cianuro di potassio per sé e la moglie, nel caso la Gestapo avesse suonato alla porta. Gli Alleati lo rimandarono nel 1947 nella sua Università di Heidelberg, dalla quale era stato cacciato nel 1937. In quel periodo, in veste di rettore, Jaspers ha pronunciato un discorso, diventato famoso. L’argomento era la questione della colpa. In occasione della riapertura dell’anno accademico egli descrisse il clima generale in Germania: «C’è come una disposizione degli animi, per cui la gente, dopo sofferenze così terribili, vorrebbe quasi essere ricompensata o in ogni caso confortata, e non ancora afflitta con colpe» (Jaspers 1965: 17-8)4. Questi sentimenti erano diffusi anche tra i giudici che erano sopravissuti alla guerra ma che non erano potuti tornare nella magistratura, perchè in un primo momento gli Alleati avevano chiuso tutti i tribunali: non sembrava infatti pensabile di riaprirli senza aver chiesto prima ai giuristi corresponsabili del terrore nazista di rendere conto del loro operato. Il primo tentativo di chiarire le responsabilità penali dei magistrati tedeschi fu fatto nel “caso tre” dei processi di Norimberga, il terzo dei processi contro i massimi rappresentanti nazisti che seguì al grande processo del 1945-46 contro i Hauptkriegsverbrecher, ovvero i maggiori responsabili per crimini di guerra. Il case three si svolse dal 12 febbraio al 10 ottobre 1947 a Norimberga, la città che negli anni Trenta aveva ospitato i raduni spettacolari della NSDAP5. Il primo processo di Norimberga si concluse con sentenze capitali per otto dei principali accusati, mentre i processi che seguirono contro l’élite del regime nazista inflissero in genere delle pene più miti. Gli esponenti degli apparati repressivi dello Stato nazista – nell’economia, nell’esercito, 4 5
Una foto di Jaspers in cattedra in occasione di queste lezioni si trova in Leonhard 1983: 133. Cfr. Kastner 1997: 699 ss.; questo documentatissimo saggio dell’ex presidente del Tribunale di Norimberga si trova anche in internet: http://www.justiz.bayern. de/imperia/md/content/stmj_internet/gerichte/oberlandesgerichte/nuernberg/kastner_jp.pdf. Precedentemente, cfr. anche Ostendorf – ter Veen 1985.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.U. Schminck-Gustavus - Indulgenza togata
91
nella burocrazia e tra i medici e i giuristi – non dovevano più salire alla forca. Ma questi Nürnberger Nachfolgeprozesse (processi successivi) non furono più celebrati dalle quattro potenze insieme, ma solo da tribunali militari americani: il clima politico era cambiato. La Guerra fredda impediva ormai che le quattro potenze si unissero in un’azione giuridica comune. Nel case three erano stati accusati giuristi e magistrati altolocati. Tutti gli imputati si erano dichiarati «non colpevoli ai sensi dell’accusa» – senza eccezione alcuna. Dieci di loro furono condannati e solo quattro assolti. Nella motivazione della sentenza si legge: I condannati hanno partecipato volutamente a un sistema di crudeltà e ingiustizia, organizzato dal regime ed esteso in tutto il paese; hanno violato le norme del diritto internazionale sulle usanze della guerra e delle leggi umanitarie; hanno commesso questi atti criminosi con l’aiuto dei Tribunali, con riferimento alle leggi vigenti e all’autorità sovrana del ministero di Giustizia. Così il pugnale dell’assassino era nascosto sotto la toga del giurista. (cit. in Peschel-Gutzeit 1996: 65-6)
Non diversamente dagli altri processi davanti ai tribunali militari americani, anche nel case three le pene detentive furono relativamente miti. Solo cinque dei maggiori imputati furono condannati all’ergastolo, ma, dopo pochi anni, anche queste pene furono commutate e ridotte; dopo la concessione della grazia, gli ultimi dei giuristi condannati a Norimberga uscirono dal carcere nel 1951, cioè dopo neanche sei anni dal crollo del nazismo. Ormai a piede libero, avevano diritto a cospicue pensioni che – a differenza di tante delle loro vittime – permettevano loro una vecchiaia agiata (Müller 1987: 262 ss.). Ciò nonostante, anche il case three in seguito è stato denunciato come espressione della Siegerjustiz, la “giustizia dei vincitori”; un’accusa che dimentica il motivo fondamentale per cui tutti i processi di Norimberga furono celebrati dagli Alleati, e cioè il fatto che – come afferma Karl Jaspers – «non siamo stati noi a liberarci dal delittuoso regime, ma ne siamo stati liberati dagli Alleati» (Jaspers 1965: 51). L’accusatore nel case three Robert M.W. Kempner ha dato nelle sue memorie un giudizio amaro sull’incapacità di pentimento che aveva notato nei responsabili del terrore6. Descrivendo un suo interrogatorio di 6
Kempner nella Repubblica di Weimar era stato un funzionario nel ministero regionale di Giustizia a Berlino; dopo l’ascesa al potere dei nazisti fu costretto, perché ebreo, all’emigrazione in America; dopo il 1945 è tornato in Germania come accusatore nel caso tre davanti alla Corte militare americana.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
92
Shoah, modernità e male politico
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Franz Schlegelberger7, condannato a Norimberga all’ergastolo, Kempner riferisce: Accusato principale era il sottosegretario al ministero di Grazia e Giustizia Franz Schlegelberger, un giurista di vecchia scuola che già prima di Hitler aveva scritto tanti lavori giuridici che ogni studente di giurisprudenza doveva conoscere. Era un uomo che la sapeva lunga sin dai tempi precedenti. Tra gli imputati lui era quello che sapeva meglio di tutti che cosa significava il concetto “giustizia”. Ma piano piano anche lui era entrato sempre più nelle reti del sistema nazista. Non riesco a capire come sia stato possibile che alla fine si sia completamente inserito nell’apparato nazista. [...] Io iniziai ad interrogarlo sulla questione ebraica, ma Schlegelberger subito si compromise completamente: cominciò a dirmi che non ne sapeva nulla. Negava di aver saputo che gli ebrei sarebbero stati uccisi. In seguito cominciò ad affermare che avrebbe tentato di “mitigare le cose”. Ovviamente quest’affermazione era poco intelligente: cioè negare all’inizio di aver saputo dell’eccidio degli ebrei, per poi affermare che avrebbe tentato di “mitigare” le leggi razziali. Allora gli chiesi: “Se Lei dunque ha mitigato in tanti particolari le leggi razziali per quanto riguardava gli Halbjuden [mezzo-ebrei], perchè ha fatto così?”. Schlegelberger non rispose e reagì con un movimento brusco; allora gli chiesi: “Mi spiego? Non capisco perchè Lei poco innanzi mi ha detto che non sapeva che cosa sarebbe successo agli ebrei. Ma se non lo sapeva, non aveva neanche nessun motivo per impegnarsi per eventuali mitigazioni”. Questa mia domanda segnò la fine della commedia. Gli venivano le lacrime agli occhi. Che strano: raramente si vedevano delle lacrime a Norimberga. Solo alle vittime venivano le lacrime quando dovevano deporre. Mi ha toccato il fatto che un uomo come lui, che tante volte sin dall’università ci era stato presentato come giurista esemplare, adesso stava lì seduto e piangeva e doveva ammettere: “Naturalmente sapevo che cosa succedeva; ma ho fatto alcune cose, alcune mitigazioni… Così alcuni gruppetti poterono salvarsi la vita”. (Kempner 1986: 286 ss.)
Nella coscienza pubblica della Germania Federale (RFT) anche il processo di Norimberga contro i giuristi per decenni è stato quasi dimenticato. Nel 1983, Kempner ha constatato con amarezza: Non è che il processo contro i giuristi abbia turbato più di tanto il pubblico tedesco. Però in un processo per crimini di carattere burocratico questo è la regola, perché qui il sangue non spruzza direttamente davanti agli occhi del pubblico. Di questo processo si discuteva al massimo tra colleghi. [...] Ma anche nelle teste di molti giuristi di oggi non ne è rimasto molto. (Kempner 1986: 287) 7
Schlegelberger, giurista famoso nella Repubblica di Weimar, era stato ansioso di diventare ministro della Giustizia, però non era stato nominato da Hitler.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
C.U. Schminck-Gustavus - Indulgenza togata
93
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
3. La cosiddetta “denazificazione” della magistratura Negli anni che seguirono al crollo del sistema nazista i problemi della ricostruzione del paese stavano in primo piano. Nell’agosto del 1945 il Potsdamer Abkommen aveva stabilito lo scopo principale del dopoguerra: denazificazione e demilitarizzazione della Germania. Ma l’inizio di quello che in seguito fu definito il “miracolo economico” della Germania rinascente stava rapidamente cancellando, nella coscienza di molti, la questione della colpa. Anche il clima della Guerra fredda entrava nella coscienza politica del paese. Il tentativo delle potenze vincitrici di “denazificare” un intero popolo si rivelò sempre meno realizzabile. Nel tentativo non solo di ricostruire, ma di rieducare la Germania in senso democratico, la Commissione di controllo degli Alleati approvò nel marzo del 1946 il Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus (Legge per la liberazione dal nazionalsocialismo e dal militarismo). Questa legge affidò il procedimento di denazificazione alle cosiddette Spruchkammern (Commissioni di denazificazione). Queste dovevano accertare le responsabilità di ogni singolo per il terrore nazista, classificandolo in una delle cinque categorie: 1. Hauptschuldige, Kriegsverbrecher (responsabili principali, criminali di guerra); 2. Belastete, Aktivisten, Militaristen, Nutznießer (colpevoli, attivisti, militaristi, profittatori); 3. Minderbelastete (responsabili minori); 4. Mitläufer (seguaci, aderenti inattivi); 5. Entlastete (non responsabili). Per la stragrande maggioranza della popolazione tedesca il procedimento davanti alla Spruchkammer finiva con la sentenza di “Mitläufer” (aderente inattivo)8; se invece la Commissione decideva per una responsabilità più grave, il procedimento – tra ricorsi e istanze di appello – si faceva lungo e ampolloso. Così si arrivò presto a una situazione tale che la propaganda politica s’impadronì del tema, chiedendo la fine della denazificazione. Nel 1950, un manifesto della campagna elettorale del Partito liberale (FPD), allora rifugio di molti nostalgici, recitava: «Basta! Facciamola finita con la denazificazione, la privazione dei diritti, le interdizioni! Basta coi cittadini di seconda classe! Chi vuole l’uguaglianza dei diritti civili deve votare FDP». Già nel maggio del 1951 fu approvata la Entnazifizierungsschlussgesetz (Legge sulla fine della denazificazione). Con ciò, il tentativo di auto-epurazione era clamorosamente fallito. Alla domanda come mai si trovassero 8
Cfr. la prima ricerca fondamentale di Niethammer 1972.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
94
Shoah, modernità e male politico
tanti ex nazisti in altolocate funzioni statali della RFT, l’allora cancelliere federale Adenauer rispose con una frase diventata famosa: «Non si può buttar via l’acqua sporca, finchè non si ha da sostituirla con acqua fresca e pulita». Adenauer stesso – a dispetto di tutte le proteste dell’opinione pubblica – aveva assunto Hans Globke nella cancelleria come segretario di Stato: lo stesso Globke che a suo tempo aveva scritto un Commento sulle leggi razziali di Norimberga. Probabilmente anche Globke si era difeso con l’affermazione di aver apportato delle “mitigazioni” al Blutschutzgesetz (Legge per la difesa del sangue e dell’onore tedeschi).
Manifesto elettorale del Partito liberale, 1950
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.U. Schminck-Gustavus - Indulgenza togata
95
Anche nella magistratura federale i risultati della denazificazione furono quanto mai deludenti. Nella RFT quasi non esistevano giudici e procuratori che non fossero stati iscritti alla NSDAP. In quanto giuristi, la maggior parte dei magistrati e procuratori riusciva a sfruttare tutti i possibili ricorsi e cavilli procedurali e finiva spesso come “nur nominell Nationalsozialist” (solo formalmente iscritti al Partito nazionalsocialista) oppure come “Mitläufer” (aderenti inattivi) o addiritura come “Entlastete” (non responsabili)9. Così, nel volgere di un breve periodo, la magistratura federale era caduta di nuovo in mano a magistrati che avevano iniziato la loro carriera durante il periodo nazista –in contraddizione con il Kontrollratsgesetz n. 4 del 20 ottobre 1945, nel quale gli Alleati avevano stabilito l’esclusione di tutti gli ex iscritti della NSDAP dalla funzione di giudice o di pubblico ministero. Con l’argomento che questa disposizione avrebbe significato uno Stillstand der Rechtspflege (interruzione dell’amministrazione della giustizia), ci si era ingegnati a inventare un nuovo procedimento: il cosiddetto Huckepack-Verfahren. Questo significava che ogni magistrato tornato in carica in quanto non iscritto precedentemente al Partito nazionalsocialista portava “a cavalluccio” un magistrato ex nazista nella magistratura federale post-bellica. In questa maniera, già nella primavera del 1946 più del 50% della magistratura era composto da ex nazisti. Nel 1947-48 quasi tutti i magistrati – ad eccezione delle cariche direttive – erano di nuovo ex iscritti della NSDAP (Bundesminister der Justiz 1989: 358). 4. Una lacuna nella storiografia federale, colmata con ritardo Il giudizio amaro di Kempner sulla mancata Vergangenheitsbewältigung (il “fare i conti con il passato”) dei giuristi dopo il caso tre di Norimberga vale in misura uguale anche per i decenni che seguirono al crollo del terrore. Nel 1968 usciva come prima ricerca di largo respiro una documentazione apologetica di Hermann Weinkauff, presidente del Bundesgerichtshof (Corte suprema federale): Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus10. 9 10
Questo era successo anche nella denazificazione dei giudici che per una sciocchezza avevano mandato alla ghigliottina un ragazzino polacco sedicenne; cfr. Schminck-Gustavus 1986: 100 ss. Cfr. Weinkauff 1968; in un primo momento questa “sintesi” portava un titolo diverso: Unter dem Nazionalsozialismus (Sotto il nazionalsocialismo), che allude alla tesi programmatica di tutta la ricerca: la magistratura era vittima dei nazisti.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
96
Shoah, modernità e male politico
Per la sua ricerca, Weinkauff aveva mandato a tutti i presidenti delle corti, dei tribunali e delle procure che erano stati in servizio durante il periodo nazista dei questionari sulle loro esperienze come giudici e procuratori negli anni della dittatura. La sua ricerca era stata resa possibile da generose elargizioni della Deutsche Forschungsgemeinschaft (l’Ente corrispondente al CNR italiano), ma i suoi risultati non meravigliano: i magistrati asserviti al regime non erano corresponsabili ed esecutori del terrore, ma vittime, costrette dalle leggi in vigore. Lo stesso Weinkauff aveva iniziato la sua carriera al Reichsgericht come giudice nel 3° Senato penale (1935-38), presieduto dal presidente del Reichsgericht, Erwin Bumke11. Weinkauff in seguito era passato nel 5° Senato civile della Corte suprema (1938-45); le risposte, in parte negazioniste, in parte piagnucolose dei presidenti della magistratura e delle procure naziste danno un’immagine deprimente della magistratura tedesca in periodi di crisi – non solo prima, ma anche dopo il crollo della dittatura nazista12. Il famigerato caso del presidente del Land di Baden-Württemberg, Hans K. Filbinger, ne è un esempio significativo. Ancora nel febbraio 1945 Filbinger, allora giudice militare, aveva mandato davanti al plotone d’esecuzione il soldato Walter Gröger per diserzione. La sua autodifesa è diventata famosa perché illustra la misera mentalità dei giuristi asserviti al terrore: «Quello che allora era legge, oggi non può essere considerato ingiustizia». Un uragano di proteste costrinse allora Filbinger alle dimissioni, ma il suo detto è rimasto emblematico del modo di pensare di tutta una generazione dell’élite tedesca: dopo il crollo del nazismo si era rifugiata in un silenzio testardo, ma poco dopo era tornata in funzioni di responsabilità. In questi casi, l’argomento principale era che il funzionamento dell’apparato statale aveva bisogno delle competenze degli ex nazisti, ma le con11
12
Per le scabrose attività di Bumke, cfr. Reifner 1983: 13 ss., note 90 ss. Nel 1937 Bumke, con un intervento al ministero di Giustizia, si era impegnato per la condanna retroattiva di un ebreo per Rassenschande (rapporto sessuale con un’ariana), nonostante il “delitto” fosse stato perpetrato all’estero. L’accusato ebreo voleva congedarsi dalla sua fidanzata “ariana” prima della sua emigrazione in Sudamerica, incontrandola a Praga; aveva convissuto 11 anni con lei. L’ebreo fu condannato – il che, scontata la pena detentiva, significava la morte sicura in un campo di sterminio. Bumke, corresponsabile della sua morte, quando già si sentiva il tuono dei cannoni dell’Armata rossa alle porte di Lipsia, si uccise nel Reichsgericht con una capsula di cianuro di potassio, sciolta in un calice di vino rosso. A titolo d’esempio si veda la risposta del presidente del Sondergericht di Brema, dottor Emil Warneken, che nel 1942 aveva condannato alla pena capitale Walerjan Wróbel; cfr. Schminck-Gustavus 1986: 108.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.U. Schminck-Gustavus - Indulgenza togata
97
seguenze spesso rasentarono lo scandaloso. Eduard Dreher, come pubblico accusatore al Sondergericht di Innsbruck, era responsabile di una caccia spietata agli oppositori del regime, ma negli anni Cinquanta fece carriera nel ministero di Grazia e Giustizia federale di Bonn e scrisse il più famoso commentario al Codice penale Schwarz-Dreher, lo STGB-Kommentar: per decenni la Bibbia penale di ogni tribunale federale13. Il sottosegretario Franz Maßfeller, commentatore del Blutschutzgesetz nazista, diventò consigliere ministeriale con competenza per il diritto di famiglia nella Repubblica di Bonn. Hans Gawlik, come pubblico ministero del Sondergericht di Breslavia responsabile delle pene capitali, nel ministero di Bonn diventò capoufficio della Zentrale Rechtsschutzstelle (Ufficio centrale per la tutela giuridica). In questa funzione ostacolò per molti anni la Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen (Ufficio centrale delle amministrazioni giudiziarie regionali per l’accertamento di crimini nazisti), istituita nel 1958 a Ludwigsburg. Senza la Zentrale di Ludwigsburg tante istruttorie contro criminali nazisti non sarebbero mai state possibili. Però, la competenza di questo ufficio si limitava sin dall’inizio all’accertamento dei crimini, non alla loro persecuzione penale. Perciò gli atti delle istruttorie di Ludwigsburg passavano alle rispettive procure federali, dove in molti casi venivano insabbiati da procuratori o magistrati che preferivano mettere fine alle indagini, invece di aprire un’istruttoria. Solo in concomitanza col movimento studentesco negli anni Sessanta e col passaggio ad una nuova generazione di giuristi, il clima cambiò anche nella magistratura. Intanto, il professore Christiaan F. Rüter, dell’Università di Amsterdam, aveva cominciato la sua grande raccolta di sentenze che riguardano il terrore nazista (Rüter 1960). Ovviamente, l’iniziativa olandese ha avuto ripercussioni anche nella Repubblica Federale Tedesca, innanzitutto sulle nuove generazioni di giuristi. Un passo importante in questa direzione è dovuto a un libro, diventato famoso tra gli studenti di giurisprudenza di allora: la documentazione di Ilse Staff, Justiz im Dritten Reich (1964). Questa ricerca è stata letta da tanti giovani che ormai chiedevano alla generazione dei loro padri, testimoni muti o addiritura coinvolti nel terrore nazista, di rendere conto del loro operato. La professoressa Staff, che insegnava diritto pubblico all’Università di Francoforte sul Meno, era la consorte del professor Curt Staff, allora 13
Per questo e i seguenti casi, cfr. l’intervista al ministro di Grazia e Giustizia Sabine Leutheusser-Schnarrenberg apparsa su Die Zeit (Hoffman – Wiefing 2012: 19). Il ministero sta preparando una nuova indagine storica sul passato dei suoi funzionari nel periodo nazista.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
98
Shoah, modernità e male politico
presidente della Corte d’assise di Francoforte14, collega e amico del Generalstaatsanwalt (procuratore generale) in Assia Fritz Bauer, senza il quale non sarebbe mai stato celebrato il famoso processo Auschwitz di Francoforte, che ha aperto un primo squarcio realistico sugli orrori del passato nazista. Significativo è però il fatto che nessuno dei professori nell’allora Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Francoforte ha colto l’occasione per invitare gli studenti ad assistere al processo Auschwitz o a discuterne nelle lezioni di diritto15. Questo però non meraviglierà, se si considera che negli anni Sessanta nelle Università – a Francoforte non diversamente da altrove – erano ancora in carica molti professori di giurisprudenza che avevano iniziato la loro carriera durante il periodo nazista. Ma la breccia era ormai aperta e altre ricerche seguivano: un ruolo da protagonista svolgeva la rivista Kritische Justiz che in tanti articoli trattava il passato dei giuristi nel periodo nazista16. Seguivano le ricerche di Jörg Friedrich (1983), di Joachim Perels (1999) e di tanti altri. Così, anche le istituzioni statali hanno cominciato a muoversi. Per iniziativa del ministero di Grazia e Giustizia, nel 1989 è stata organizzata una grande mostra, Justiz und Nationalsozialismus, che per la prima volta con ricco materiale archivistico ha fatto luce sugli anni bui della magistratura tedesca (Bundesminister der Justiz 1989). Anche la storiografia del diritto aveva fatto ormai proprio l’argomento, approfondendo tanti dei suoi lugubri aspetti (Schumann 2008).
14
15 16
Curt Staff insegnava anche diritto e procedura penale all’Università di Francoforte; era presidente del Justizprüfungsamt (Commissione per l’esame giuridico di Stato); nel novembre 1966 è stato anche a capo della mia commissione nell’esame di perfezionamento giuridico; le domande che mi fece riguardarono il processo di Socrate. Solo decenni dopo ho scoperto che Staff era stato – a quanto pare – l’unico giudice tedesco che nel periodo nazista era stato incarcerato per più di un anno nel campo di concentramento di Dachau. Subito dopo l’ascesa al potere dei nazisti si era fatto odiare per il suo coraggio da socialdemocratico convinto nel resistere alla distruzione dei diritti costituzionali; era stato aggredito per strada e picchiato da un Rollkommando nazista e in seguito allontanato dalla magistratura in base al Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums (Legge sulla ricostituzione della Pubblica Amministrazione) del 7 aprile 1933; sulla biografia di Staff, cfr. Henne 2001: 3030. Lo so in prima persona, perchè nel 1964 ero studente del secondo anno di giurisprudenza all’Università di Francoforte. Cfr. Redaktion Kritische Justiz 1979, 1984: una ricca raccolta di ricerche, tutte apparse sulla rivista Kritische Justiz.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
C.U. Schminck-Gustavus - Indulgenza togata
99
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
5. A titolo d’esempio: l’istruttoria della Procura di Brema sulla Shoah in Grecia (1964-71) Negli anni Novanta ho raccolto in un lungo viaggio delle testimonianze sull’occupazione italo-tedesca in Epiro. Ero andato, molte volte anche a piedi, nei piccoli paesi dell’entroterra di Giannina per sentire i ricordi degli anziani sugli orrori della guerra17. Avevano vissuto da giovani o da bambini gli anni dell’occupazione della Wehrmacht e mi raccontavano spesso di tremende rappresaglie. Molti dei ricordi riguardavano anche un argomento che fino ad allora mi era completamente sconosciuto: l’Olocausto in Grecia e la deportazione degli ebrei di Giannina il 25 marzo 194418. Della numerosa comunità ebraica di Giannina solo pochissimi sono tornati da Auschwitz, ma tra i sopravvissuti non mi è stato possibile trovare neanche uno disposto a parlare con me per conservare il ricordo della tragedia: sono tedesco ed essi, a volte, non hanno raccontato neanche ai propri figli quello che avevano visto ad Auschwitz. Così mi ero convinto di dover desistere e avevo smesso di chiedere le loro testimonianze dell’orrore. Però, quasi vent’anni dopo, con l’aiuto dell’amico storico Hermann Frank Meyer, ho scoperto che proprio la Procura di Brema, la mia città, negli anni Sessanta aveva condotto un’istruttoria contro i responsabili di quest’ultima fase dell’Olocausto in Grecia. L’istruttoria era stata archiviata dopo sei anni di interrogatori, senza arrivare mai all’accusa in un processo penale. La deportazione degli ebrei era avvenuta così tardi perché, come in tutte le zone di occupazione italiana fino all’8 settembre 1943, giorno dell’armistizio, anche a Giannina gli ebrei erano stati risparmiati. Solo col disarmo degli italiani e l’entrata della Wehrmacht nelle loro zone di occupazione, la situazione era cambiata. Ora, preparatisi fino nei dettagli, i nazisti cominciavano a condurre allo sterminio anche gli ultimi ebrei rimasti in Grecia. La competenza della Procura di Brema per quest’istruttoria risultava dal fatto che uno degli inquisiti principali era un ex funzionario della Gestapo di Brema: Friedrich Linnemann. A Brema era stato funzionario nel Judenreferat 17 18
Ho pubblicato il materiale raccolto in questa ricerca in lingua greca nella trilogia Schminck-Gustavus 2007, 2008, 2011. Una versione ridotta del primo e del secondo volume della mia trilogia greca è uscita in lingua tedesca col titolo Winter in Griechenland. Krieg – Besatzung – Shoah; cfr. Schminck-Gustavus 2010. Sto preparando la traduzione di questo volume in lingua italiana.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
100
Shoah, modernità e male politico
(dipartimento per gli ebrei), ma nel 1943-44 tutti gli ebrei di Brema erano già stati deportati. Così, Linnemann fu trasferito ad Atene per collaborare all’“evacuazione degli appartententi alla razza ebraica” verso Auschwitz. Dopo la fine della guerra Linnemann era tornato a Brema – per questo motivo la Procura bremense aveva la competenza a condurre l’istruttoria. Gli atti dell’istruttoria si trovano oggi nell’Archivio di Stato di Brema: sono 35 volumi con verbali di interrogatori, documenti d’archivio e varie decisioni di diverse istanze della Procura e della magistratura locale – migliaia e migliaia di pagine che disegnano un’immagine impressionante della tragedia. 5.1 Gli inquisiti principali L’istruttoria riguardava due responsabili, direttamente coinvolti nella deportazione degli ultimi ebrei dalla Grecia: il primo era Walter Blume, tenente colonello delle Waffen-SS e comandante della Sicherheitspolizei. Sede della polizia di sicurezza tedesca ad Atene durante l’occupazione era la famigerata via Merlin n. 6, per tanti resistenti e perseguitati “η κόλαση της Γκεστάπο”, cioè l’ingresso all’inferno della Gestapo senza ritorno o via d’uscita. All’ultimo piano dell’edificio c’era l’ufficio del dottor Blume. Attraverso la sua scrivania passavano tutti i provvedimenti della polizia e della Gestapo – anche quelli che riguardavano il trasporto degli ebrei ad Auschwitz.
Walter Blume, iscritto dal 1933 nella NSDAP e dal 1935 nelle SS
Blume era Dottore in Legge e dopo l’ascesa al potere dei nazisti aveva fatto una carriera lampo nella Gestapo. Con l’inizio della guerra contro l’URSS era diventato capo del Sonderkommando 7a nell’Einsatzgruppe B che nelle retrovie del fronte orientale aveva il compito di uccidere ebrei, comunisti, zingari, malati di mente e altri “nemici del Reich”. Nel cosiddetto Einsatzgruppenprozess del 1948, il nono dei processi di Norimberga, Blume era stato processato e condannato alla sentenza capitale. Dai rapporti mensili del suo Sonderkommando risultava che da questo reparto, in pochi mesi, erano stati uccisi migliaia di civili.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.U. Schminck-Gustavus - Indulgenza togata
101
Commutata la pena nel 1951 a 25 anni di detenzione, Blume fu graziato dagli americani nel 1955 e, come anche altri criminali di guerra graziati, uscì dal carcere di Landsberg quello stesso anno. Dato che le sue attività in Grecia non erano state oggetto del processo di Norimberga, il principio della res iudicata non impediva l’apertura della nuova istruttoria della Procura di Brema. Dopo la concessione della grazia, Blume era tornato presto alla vita civile e aveva trovato lavoro come consulente giuridico di un’impresa dedita ad attività poco trasparenti. Molto probabilmente, anche in que- Blume all’epoca della condanna, sto caso le reti clandestine di ex na- Norimberga 1948 zisti che aiutavano i loro vecchi camerati che “avevano avuto delle grane” erano intervenute in suo favore. Il capo dell’impresa dove Blume lavorava dev’essere stato un uomo molto ricco; questo risulta dal fatto che egli – per salvare Blume dalla carcerazione preventiva – diede alla Procura di Brema ipoteche di garanzia per un mezzo milione di marchi. Blume, da esperto delle regole del procedimento penale, si è rifiutato per molto tempo di deporre, avvalendosi – senza giusta causa – del principio della res iudicata. Quando alla fine acconsentì all’interrogatorio del pubblico ministero – probabilmente sperando di poter chiudere in questa maniera la vicenda –, si limitò ad affermare di non aver saputo che “l’evacuazione” degli ebrei dalla Grecia sarebbe finita nelle camere a gas di Auschwitz, dichiarando: «L’evacuazione della popolazione ebraica dal territorio greco avvenne per motivi di sicurezza». A Norimberga, Blume si era ancora difeso dicendo di aver limitato le fucilazioni della popolazione ebraica ai wehrfähige Männer (uomini atti alle armi), ma ora sosteneva di non aver saputo dove dovessero finire i carri bestiame carichi di donne, uomini e bambini ebrei. Il secondo inquisito, Friedrich Linnemann, ufficiale della Gestapo di Brema, era stato trasferito ad Atene in quanto il suo lavoro a Brema si era concluso con la deportazione di tutta la comunità ebraica bremense.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
102
Friedrich Linnemann, ex funzionario nel Judenreferat di Brema, detenuto dagli inglesi
Shoah, modernità e male politico
Negli atti dell’istruttoria di Brema si trovano testimonianze raccapriccianti sugli interrogatori dei cittadini ebrei di Brema condotti da Linnemann: bastonature e umiliazioni di ogni genere erano all’ordine del giorno. Giunto ad Atene, aveva subito stretto amicizia col suo capoufficio Toni Burger, incaricato da Eichmann per la Endlösung der Judenfrage in Grecia: i due si davano del tu, una confidenza che anche tra appartenenti alle Waffen-SS in genere richiedeva un tasso alcolico notevole. Alla liberazione della Grecia Linnemann, ricercato come criminale di guerra, era riuscito a tornare in Germania per farsi far prigioniero degli inglesi.
5.2 Le bugie dei responsabili Non diversamente da Blume, anche Linnemann si sentì “non colpevole” per l’Olocausto. Ma per lui era piuttosto difficile affermare la propria ignoranza dei fatti, perchè negli atti dell’istruttoria si trova anche la deposizione di Rekanátis, un ebreo greco che aveva collaborato alla deportazione dei suoi correligionari e aveva servito Linnemann come interprete. Per questo, Rekanátis in Grecia era stato condannato a morte nel 1946; in seguito graziato e rilasciato, era tornato anche lui in Germania, dove aveva vissuto anche prima della guerra. Rekanátis aveva deposto, tra l’altro, di avere accompagnato Linnemann a Rodi per eseguire lì la deportazione della comunità ebraica dell’isola. Tornando in aereo da Rodi avrebbero portato nove valigie piene di oro, gioielli e oggetti di valore che gli ebrei avevano dovuto consegnare prima della deportazione. Le nove valigie con gli oggetti sequestrati sarebbero state portate nella sede della Gestapo, dove furono consegnate al gioielliere Vourákis di Atene, che avrebbe dovuto fondere gli oggetti d’oro per farne dei lingotti.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.U. Schminck-Gustavus - Indulgenza togata
103
Nel suo interrogatorio davanti al pubblico ministero di Brema, nel 1968, Linnemann disse di non sapere nulla di tutto ciò; ammise solo di aver saputo che i trasporti degli ebrei sarebbero finiti ad Auschwitz. Dichiarò: Gli ebrei in seguito furono portati da Atene ad Auschwitz. Ma il mio compito era solo di organizzare il servizio di guardia attorno alla stazione di Atene, quando gli ebrei furono caricati nei vagoni. Non avevo altro a che fare con questo trasporto… Io allora pensavo che gli ebrei venissero trasferiti all’Est per trovare lì una nuova sistemazione, con case nuove e nuovi impieghi. Posso affermare che solo a malavoglia ho partecipato alle azioni contro la popolazione ebraica. Ho aiutato dove potevo. Il mio aiuto consisteva nel fatto che avvertivo quelle persone che sapevo poter aiutare gli ebrei a organizzare la fuga all’estero. Questo l’ho fatto molte volte. Ma i miei mezzi erano limitati. Purtroppo non potevo aiutare tutti.
Come tanti altri dei suoi colleghi della Gestapo, anche Linnemann nel dopoguerra è stato denazificato senza problemi19; come ex funzionario di un servizio statale aveva addirittura diritto di ritornare nella Pubblica amministrazione – questa volta non in un corpo di polizia, ma come impiegato statale nel Versorgungsamt (Ufficio di previdenza sociale). In tale veste affrontava tranquillo gli interrogatori della Procura di Brema. S’intende che per lui quest’istruttoria non aveva più di tanto di preoccupante. La situazione era ormai cambiata profondamente dai tempi della guerra. Allora, Linnemann aveva ancora avuto altri pensieri. Il capo della comunità ebraica di Brema Carl Katz, uno dei pochi sopravvissuti della deportazione a Theresienstadt, nel dopoguerra depose che Linnemann aveva accompagnato il treno della deportazione degli ebrei bremensi fino alla stazione di Hannover. Lì, sul binario di Hannover, Katz avrebbe detto a Linnemann istintivamente: «Auf Wiedersehen!» (Arrivederci!), e Linnemann gli avrebbe risposto: «Se io e Lei ci rivedremo, noialtri [della Gestapo] saremo appesi a un palo della luce».
19
Dei 40 funzionari della Gestapo di Brema solo 9 sono usciti dalla denazificazione come “colpevoli”, mentre 7 erano stati dichiarati “responsabili minori”; questo significa che più della metà dei funzionari della Gestapo di Brema erano stati dichiarati “aderenti inattivi”; cfr. Hesse 2005: 367.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
104
Shoah, modernità e male politico
Linnemann: scheda d’internamento, 1945
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.U. Schminck-Gustavus - Indulgenza togata
105
Funzionario dell’Ufficio di previdenza sociale, 1960
5.3 Un rapporto della polizia segreta militare Nelle 35 cartelle dell’istruttoria della Procura di Brema si trova anche un rendiconto della Geheime Feldpolizei20 della Gestapo di Giannina, capoluogo dell’Epiro e sede di una numerosa comunità ebraica con antichissime radici. Due giorni dopo la deportazione delle 1725 anime verso le camere a gas, il sottufficiale Bergmeyer, funzionario del Gruppo 621 della Polizia militare segreta, descrive gli avvenimenti.
20
La Geheime Feldpolizei (Polizia militare segreta) era il braccio militare della Geheime Staatspolizei, la Polizia segreta di Stato, più nota come Gestapo; cfr. Geßner 1995: 343 ss.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Shoah, modernità e male politico
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
106
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
107
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.U. Schminck-Gustavus - Indulgenza togata
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
108
Shoah, modernità e male politico
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Gruppo 621 della Polizia militare segreta presso il XXII Corpo d’armata alpino
Quartiere di stanza 27 marzo 1944
Rapporto Oggetto: Evacuazione degli ebrei di Giannina Il 25 marzo 1944, sotto il comando del maggiore della Polizia di sicurezza Hawranek, con la collaborazione della truppa, della Gendarmeria militare e del Gruppo 621 della Polizia militare segreta (distaccamento di Giannina) sono stati evacuati gli ebrei di Giannina. Anche unità della Polizia greca sono state utilizzate per collaborare. Alle ore 3.00 di mattina del 25 marzo il ghetto è stato chiuso dalla truppa. Alle ore 5.00 di mattina è stato avvertito il capo della comunità ebraica che tutti gli ebrei – assieme a tutti i loro familiari – erano tenuti a radunarsi nel giro di tre ore in uno dei due punti di raccolta prestabiliti. Ogni famiglia avrebbe avuto il diritto di portare con sé 50 chili di bagaglio. La Gendarmeria greca, la Polizia di sicurezza greca e membri del Consiglio ebraico avvertivano le singole famiglie ebraiche di queste ordinanze. Contemporaneamente, fu annunciato che chiunque non si fosse trovato entro le ore 8.00 al punto di raccolta sarebbe stato fucilato. Entro le ore 7.45 tutto il quartiere si era svuotato e gli ebrei erano giunti ai punti di raccolta. Forti pattuglie di Polizia tedesca controllavano lo svuotamento del ghetto. Manifesti in lingua greca, attaccati a quasi tutte le case, avvertivano che ogni saccheggio nelle case ebraiche sarebbe stato punito con la fucilazione immediata. L’azione si è svolta senza il minimo incidente. Alle ore 8.00 poteva essere iniziato il trasporto. Gli autocarri erano già stati parcheggiati precedentemente nelle vie di accesso ai punti di raccolta. Il carico avvenne sotto il controllo della Gendarmeria e della Polizia tedesca. In più, a ogni conducente fu assegnata la responsabilità di controllare l’elenco degli ebrei e verificare di avere caricato il numero stabilito per ogni camion. Alle ore 10.00 il carico di tutti gli ebrei era stato compiuto e la colonna di circa 80 camion si metteva in moto in direzione di Trikkala. Tutta l’azione è da considerarsi riuscita in pieno, in quanto il 95% degli ebrei registrati è stato evacuato. La collaborazione di tutte le forze partecipanti – anche della Polizia greca – è stata esemplare. La popolazione greca, che nel frattempo era venuta a conoscenza dei fatti, si riuniva nelle strade adiacenti. Con malcelata contentezza – che si poteva notare sulle loro facce – osservavano l’esodo dei giudei dalla loro città. Solo in pochissimi casi un greco si degnava di fare un saluto d’addio a un appartenente alla razza ebraica. Si poteva constatare che questa razza era invisa in egual misura ad anziani e giovani. Compassione per il loro destino o addiritura disappunto per l’azione non sono stati osservati in nessun caso. Secondo diversi rapporti, l’evacuazione degli ebrei ha invece suscitato grande soddisfazione in tutta la popolazione greca. La simpatia per i tedeschi ne ri-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.U. Schminck-Gustavus - Indulgenza togata
109
sulta rafforzata. Visto che suppellettili e viveri degli ebrei sono stati consegnati alle autorità cittadine greche, è stata neutralizzata anche la propaganda antitedesca dell’EAM [il Fronte di liberazione nazionale, di orientamento di sinistra]. Da parte dei simpatizzanti dell’EDES [l’Esercito nazionale democratico greco, di ispirazione nazionalista] il consenso è unanime. In linea di massima, viene però chiesto che alla Commissione per l’amministrazione dei beni ebraici venga affiliato un rappresentante tedesco, per evitare irregolarità e ingiustizie nella distribuzione. In genere, si attende un calo dei prezzi dei viveri, in quanto il commercio e gli scambi con la popolazione nelle zone agricole finora era in gran parte nelle mani di ebrei. Negli ultimi giorni si osserva già un notevole calmierarsi dei mercati; si vede che l’influenza dei pochi ebrei sui mercati era decisiva. Il 25 marzo 1944 furono in tutto evacuati 1725 appartenenti alla razza ebraica. Bergmeyer Sottufficiale Prima copia A conoscenza del reparto Ic (Controspionaggio) presso il XXII Corpo d’armata alpino Dislocamento (Giannina) Zein Maresciallo, Capoufficio del distaccamento
La Procura di Brema ha cercato gli autori di questo documento e il responsabile dell’evacuazione Hawranek. Dato che i fogli matricolari dei soldati della Wehrmacht non sono stati distrutti durante i bombardamenti di Berlino e si trovano tutt’oggi nella Wehrmachtsauskunftsstelle (il Servizio d’informazione per gli ex membri della Wehrmacht) nel quartiere Wedding di Berlino, è stato piuttosto facile trovare le persone cercate. Tuttavia, il sottufficiale Bergmeyer, il funzionario che ha redatto il documento, e il suo superiore Zein erano già morti quando la Procura di Brema iniziò l’istruttoria: essi sono perciò rimasti fuori da ulteriori accertamenti. L’indirizzo del capo di Polizia a Giannina invece è stato trovato nei registri della Wehrmachtsauskunftsstelle. Si trattava del maggiore delle SS Gustav Willy Hawranek. Dev’essere stato lui che aveva ricevuto dai superiori di Atene gli ordini per “l’evacuazione” degli ebrei di Giannina. Hawranek nel 1967 viveva tranquillamente da pensionato a Muggendorf, un paesotto
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
110
Shoah, modernità e male politico
nella Franconia vicino a Bamberga. Tuttavia, all’epoca il pubblico ministero di Brema non ritenne necessario interrogare di persona quest’inquisito; mandò invece un poliziotto con un elenco di domande da fare a Hawranek. Le risposte dell’inquisito rispecchiano una notevole disinvoltura. Hawranek disse nel suo interrogatorio: Non ho nulla da nascondere e sono disposto a deporre. A Giannina ero maggiore di Polizia. Il mio compito era fare da tramite tra la Wehrmacht e la Polizia greca in Epiro. Esisteva anche una stretta collaborazione col XXII Corpo d’armata alpino sotto il comando del generale Lanz. Il mio ufficio a Giannina era molto piccolo. Con me c’erano solo il maggiore Farne da Duisburg e un altro maresciallo di cui non ricordo il nome. In più lavoravano con noi 5 o 6 poliziotti. Anche sforzandomi non posso ricordare i loro nomi. Non possiedo neanche delle foto di queste persone. Avevamo in proprio un impianto radiotrasmittente e vorrei dire che il mio compito principale era tenere i contatti con la Wehrmacht e la Polizia greca via radiotrasmittente. Ricevevamo notizie e ordini dal Capo delle SS e della Polizia [cioè dal dottor Blume]. Attraverso Atene alcune delle nostre notizie venivano trasmesse anche a Berlino. Compiti di polizia – come il mantenimento dell’ordine pubblico – non ci riguardavano. Erano affari che dovevano essere sbrigati dalla Polizia greca. Ricordo l’azione per l’evacuazione degli ebrei da Giannina. La sera prima dell’evacuazione ricevemmo un ordine – mi pare – dal Capo delle SS e della Polizia di Atene. Mi mettevo subito in contatto con l’ufficiale Ic [responsabile per il controspionaggio] nel comando del XXII Corpo d’armata alpino. Anche lui aveva ricevuto un analogo messaggio radiotrasmesso e mi disse che la Wehrmacht avrebbe provveduto a mandare i camion necessari per l’azione. Di questo informavo anche la Polizia greca che era responsabile della realizzazione dell’azione. Tutto era già stato stabilito nei dettagli attraverso gli ordini radiotrasmessi. Anche la Polizia militare segreta, Gruppo 621, era già stata informata con ordini radiotrasmessi. Se ora mi viene detto che sarei stato io il responsabile di quest’azione, non è vero; o almeno è solo in parte vero, perchè tutte le unità partecipanti – reparti della Wehrmacht, Polizia militare segreta, Polizia e Gendarmeria greca – erano autonomi e perciò responsabili per le loro azioni. Io ero responsabile solo perchè fossero eseguiti gli ordini ricevuti da Atene. Per conto mio potevo dare degli ordini esclusivamente ai comandanti della Polizia greca. Le altre unità non mi erano sottoposte. Ma anche la Polizia greca aveva ricevuto ordini, già durante la notte. Non ricordo esattamente come si svolsero le cose nei particolari. Ricordo solo i camion della Wehrmacht, ma non so più se sia stata la Wehrmacht a chiudere il ghetto, perchè durante l’azione non ero neanche presente. Sono state la Polizia e la Gendarmeria greca che hanno portato fuori dalle loro case gli ebrei. Non è neanche vero che le nostre forze di polizia abbiano sorvegliato la raccolta degli ebrei. Non
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.U. Schminck-Gustavus - Indulgenza togata
111
ricordo se a Giannina esisteva un ghetto nel senso stretto della parola. Mi pare che gli ebrei abitavano sparsi qua e là in diverse case nella città. La raccolta si svolse senza il minimo problema. Gli ebrei si sono radunati e in seguito sono stati trasportati coi camion in direzione di Larissa. Non sono successi subbugli di alcun genere; fucilazioni non sono successe di sicuro. Per quanto sappia io, non sono avvenuti disordini di nessun tipo. Se ora mi viene fatta questa domanda, debbo dire che finora non sapevo assolutamente che cosa fosse successo in seguito agli ebrei. Oggi sento per la prima volta che essi sono stati deportati ad Auschwitz e che il 90% di loro sono finiti nelle camere a gas. Non posso dire il numero degli ebrei raccolti. Non ho neanche annunciato questo numero ad Atene perchè non era compito mio. Di più non posso dire sulla vicenda. La deposizione l’ho fatta di mia spontanea volontà e senza costrizione alcuna. Corrisponde in pieno alla verità. Non ho da rimproverarmi nulla. Letto, approvato, firmato Hawranek21
Così si conclude la deposizione del maggiore Hawranek. Dai commenti giuridici negli atti risulta che anche il pubblico ministero condivideva i sentimenti dell’inquisito. Anche il procuratore non ha nulla da rimproverargli; scrive infatti: L’autodifesa di Hawranek, di non aver saputo che gli ebrei sarebbero stati portati ad Auschwitz per essere lì uccisi, non è confutabile. Membri dei corpi di polizia in genere non furono informati sulle finalità della deportazione degli ebrei. Non sono emerse informazioni che farebbero supporre che Hawranek fosse stato informato da altre fonti.
Argomentazioni di questo genere fanno capire che questa Procura vuole chiudere l’istruttoria. In un’altra deposizione dei 35 volumi di interrogatori la verità che questi procuratori e magistrati non vogliono più prendere in considerazione appare invece chiaramente: uno dei testimoni aveva deposto che un soldato del servizio di guardia, addetto alla sorveglianza della raccolta degli ebrei, aveva chiesto a uno dei suoi colleghi come mai gli ebrei non portassero bagagli con sé per il loro “nuovo insediamento all’Est”. Gli era stato risposto che di bagagli non avevano più bisogno perchè non avrebbero avuto più molti giorni di vita.
21
Cfr. Staatsarchiv Bremen 4,89/3-853, fol. 3016 ss.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
112
Shoah, modernità e male politico
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
5.4 L’archiviazione dell’istruttoria Anche da altri elementi nell’argomentazione della Procura risulta che, dopo sei anni di istruttoria, questa aveva ormai condiviso in gran parte le argomentazioni degli inquisiti e dei loro difensori. Nella motivazione dell’archiviazione, lunga oltre trenta pagine dattiloscritte, si leggono delle affermazioni impensabili. Sulla necessità di non procedere per via giudiziaria contro il dottor Blume viene affermato: Nonostante la sua alta funzione ad Atene, il dottor Blume non è da considerarsi responsabile principale della deportazione ebraica dalla Grecia. Perciò non è da considerarsi Täter (autore del reato). Lo stesso vale per Linnemann. La questione se essi ancora oggi possano essere imputati per omicidio colposo dipende dalla questione se – visto che non sono Täter – siano da considerarsi Gehilfen (complici). Seguendo le sentenze del Bundesgerichshof (Corte suprema federale) per omicidio colposo, un complice può essere punito solo se ha condiviso i motivi riprovevoli dell’omicida doloso. Questo nel caso di Blume e Linnemann non risulta.
Quest’argomentazione scandalosa non è stata inventata a Brema, ma corrisponde alla giurisdizione corrente della Corte suprema federale (Schminck-Gustavus 2010: 297, nn. 126-27). Chi, oltre a Hitler, Himmler e Kaltenbrunner, potesse essere condannato per omicidio colposo degli ebrei, la Corte suprema federale non l’ha mai spiegato. Nel caso di Blume e Linnemann significa, ad ogni modo, che le loro attività criminali per l’“evacuazione” degli ebrei erano cadute in prescrizione già prima che fosse iniziata l’istruttoria di Brema. Ci si domanda perciò come siano state possibili tali decisioni pseudo-giuridiche. Emblematica in questo senso appare la carriera professionale del dottor Sigfried Höffler, il pubblico ministero che ha firmato il decreto d’archiviazione a Brema. Quello di Höffler non è un caso singolo – carriere analoghe si riscontrano anche tra i giudici della Corte suprema federale, che con la loro giurisdizione avevano aperto la strada per l’assoluzione non solo di Blume, Linnemann e Hawranek, ma di tanti altri Schreibtischtäter (i “burocrati dello sterminio”), rimasti seduti alle loro scrivanie. A titolo di esempio ho ricercato nel fascicolo personale chi era stato il dottor Siegfried Höffler. Non è stato semplice ottenere l’accesso a questi atti, ma alla fine ci sono riuscito (Schminck-Gustavus 2010: 316 ss.). Dal fascicolo risulta che Höffler – come tanti altri suoi colleghi – è entrato nella NSDAP il 1° maggio 1933 col numero d’iscrizione 2.503.544.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
113
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.U. Schminck-Gustavus - Indulgenza togata
Scheda di indagine statistica della NSDAP compilata da Höffler, 1939
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
114
Shoah, modernità e male politico
Più grave appare però un altro fatto che risulta da un documento che si trova nel Document Center del Bundesarchiv di Lichterfelde a Berlino. In questo archivio vengono conservati tutti gli atti dei membri iscritti del Partito nazionalsocialista. Tra questi si è salvata anche una scheda personale di Höffler conservata nei registri della NSDAP, il cui contenuto Höffler ha sottaciuto nella sua carriera giuridica del dopoguerra; l’informazione non esiste neanche nel suo fascicolo personale, conservato negli archivi della magistratura bremense. Da questo documento risulta che Höffler, da giovane, ha iniziato la sua carriera come pubblico ministero al Sondergericht di Rzeszόw, nel Governatorato generale della Polonia occupata. Per condanne capitali, questo Tribunale è stato al secondo posto in tutta la Polonia sott’occupazione – subito dopo il Sondergericht di Varsavia (Majer 1981). Non mi è stato possibile verificare il ruolo di Höffler a Rzeszów, perchè le mie ricerche nell’archivio locale sono rimaste senza risultato: tutti gli atti sono stati bruciati o distrutti nell’ultimo periodo dell’occupazione.
Certificato di residenza di Höffler; tra gli indirizzi è indicato anche: Rzeszów, provincia di Cracovia, Tribunale Speciale, Governatorato generale – Polonia
Anche Höffler ovviamente era stato denazificato nel dopoguerra ed è rientrato nella Procura di Brema nel 1948 con la seguente motivazione: Il rientro in servizio del dottor Höffler appare indispensabile per il mantenimento dell’ordine pubblico, considerando le sue conoscenze professionali. Una persona politicamente non compromessa non esiste nella circoscrizione della Procura di Brema.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
C.U. Schminck-Gustavus - Indulgenza togata
115
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
5.5 Fotografie scattate il giorno della deportazione da Giannina Ciò che era successo a Giannina quel 25 marzo del 1944 non viene solo descritto nel rapporto della Polizia segreta militare, distaccamento del Gruppo 621; l’ha anche immortalato un fotoreporter di una Propagandakompanie (Compagnia di propaganda) della Wehrmacht che accompagnava i reparti di combattimento per registrare azioni e vittorie delle armate tedesche. In 22 foto, scattate in quella mattina, viene descritta la tragedia degli ebrei di Giannina, che undici giorni dopo trovava fine nelle camere a gas di Auschwitz.
Giannina: 25 marzo 1944, ore 8.00: Donne, uomini, vecchi e bambini al punto di raccolta
50 chili di bagaglio per ogni famiglia
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
116
Shoah, modernità e male politico
Una signora saluta il marito in partenza per fargli coraggio; un ragazzino disperato perchè il padre parte
ì
Caricati per ultimi per escludere resistenze: donne coi bambini
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
117
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
C.U. Schminck-Gustavus - Indulgenza togata
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
119
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
SIMONE DURANTI
A SCUOLA DI RAZZISMO Il Gruppo universitario fascista e le sue strutture per l’antisemitismo nell’ateneo fiorentino
Introduzione Lo studio che proponiamo intende mostrare come la politica antisemita del fascismo in Italia abbia condizionato la vita universitaria e come i suoi attori abbiano contribuito a predicare il razzismo e a commettere azioni discriminatorie nei confronti del “nuovo nemico”. A partire dal caso dell’ateneo di Firenze1, si illustreranno i contenuti razzisti nella didattica universitaria, la costruzione della propaganda e il nuovo clima eugenetico che interessò professori e studenti, secondo una linea di continuità che dal razzismo antiafricano degli anni della guerra in Etiopia giunge alle leggi antiebraiche. Anche a Firenze l’inquadramento politico-disciplinare degli studenti era garantito dalla presenza del GUF2 (Gruppo universitario fascista). Importante strumento politico e propagandistico, l’organizzazione che inquadrava gli universitari interessati a collaborare alle iniziative promosse dal regime anche nell’ateneo fiorentino si distinse per un’azione violenta e incisiva. L’obiettivo non era solo contribuire alla costruzione della propaganda antisemita a mezzo stampa e con pubbliche conferenze, ma anche la schedatura e il controllo politico degli ebrei ancora presenti nell’Università. Va ricordato che proprio dagli studenti del GUF il regime si aspettava un contributo di rilievo in termini agitatori, visto il livello culturale che potevano garantire i propri iscritti. In ogni campagna varata dal Partito, il GUF si distinse sempre non tanto per l’originalità del messaggio quanto 1 2
Fra gli studi disponibili sugli effetti del razzismo fascista nei singoli atenei si veda Galimi – Procacci 2009. Sul caso fiorentino e sul ruolo del corpo docente nella razzistizzazione della didattica si segnala Cavarocchi – Minerbi 1999. Per la storia dei GUF come istituzione dipendente dal Partito fascista cfr. La Rovere 2003. Per la ricostruzione delle attività politico-propagandistiche dei GUF negli anni Trenta e dell’importanza del loro ruolo nella diffusione del razzismo fra guerra d’Africa e leggi antiebraiche cfr. Duranti 1999, 2008.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
120
Shoah, modernità e male politico
per la massiccia presenza di contributi su testate autonome, di Partito, o su riviste e quotidiani a diffusione nazionale. Il case study del GUF di Firenze è utile sia per illustrare le caratteristiche della comunicazione degli universitari, sia per gettare uno sguardo sul contributo che hanno fornito al razzismo di Stato i cultori di discipline come l’antropologia, la geografia, la biologia e le scienze mediche in generale. Docenti e studenti, infatti, si prestarono con solerzia – per convinzione e per opportunismo –, una volta compreso quanto il loro ruolo e le loro competenze potessero essere richieste ed apprezzate nella fase che, dalla campagna etiopica al varo di quella antisemita, poneva il razzismo al centro del discorso politico del fascismo italiano. Le fonti utilizzate sono: la stampa prodotta direttamente dal Gruppo (il periodico Goliardia Fascista) e gli articoli pubblicati sul giornale della Federazione provinciale fiorentina; le relazioni presentate dal segretario del GUF per l’apertura degli anni accademici e pubblicate negli annuari dell’Università; i documenti dell’archivio dell’Università di Firenze e il carteggio fra il gruppo universitario locale e la Segreteria nazionale dei GUF reperiti all’Archivio centrale dello Stato (ACS). Se le carte dell’ateneo fiorentino sono utili per dare una dimensione quantitativa del ruolo degli universitari fascisti ma ci dicono poco sulle loro attività, le relazioni che il Gruppo fiorentino invia alla sede romana sono invece centrali per ricostruire le diverse iniziative politiche e propagandistiche. 1. Il Centro di studi sulla razza Il segretario del GUF fiorentino Enzo Taddei, nella relazione mensile alla Segreteria nazionale dei GUF, riferisce sui preparativi per l’istituzione di un Centro di studi sulla razza a partire dal settembre 19383. A differenza di molti GUF che dedicano alla propaganda e allo studio del razzismo una sezione autonoma della relazione, in questo caso le notizie sulla creazione del Centro studi sulla razza sono contenute nel paragrafo Attività culturale, a dimostrazione di come in alcune realtà universitarie la campagna razziale venga considerata parte integrante della didattica. Il GUF di Firenze infatti, seguendo l’indirizzo del Partito, responsabilizza i propri iscritti ricordando che la prassi razzista necessita di studio e approfondimento. L’immissione 3
«Durante il mese, in più riunioni, si sono convocati i fascisti universitari designati a far parte del Centro di Studi della Razza», in ACS, PNF, Direttorio Nazionale, Segreteria GUF, b. 37, f. 586.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Duranti - A scuola di razzismo
121
del razzismo in un alveo di normalità di lavoro, ammantato dal crisma dell’attività culturale, testimonia sia il ruolo del GUF come agente politico del Partito, sia la capacità dei suoi membri di aderire ad un mandato che solletica ambizioni dei singoli e del gruppo. La corsa al protagonismo, anche in questa “battaglia” culturale e politica, è evidente e dimostrata dalle iniziative ideate da gruppi universitari dipendenti da quello fiorentino. Il Gruppo di Pistoia, ad esempio, non solo indice un «Concorso a carattere nazionale, riservato agli iscritti al GUF, per la miglior monografia sul tema La Razza»4, ma pubblica un bollettino di studi razzisti che rappresenta una rarità, e non soltanto fra i GUF minori5. Il Centro di studi sulla razza si pone, fra le attività del GUF fiorentino, a metà fra laboratorio di studio teorico e luogo di raccolta per i militanti interessati alla formulazione della propaganda. Nei locali messi a disposizione dal GUF si organizza una biblioteca, si raccolgono gli articoli su tematiche razziali realizzati dalle altre testate italiane e si forma il personale attraverso incontri di approfondimento. Viene anche pubblicato un opuscolo illustrativo con la prefazione del noto antropologo Lidio Cipriani, uno degli accademici che contribuì a saldare il razzismo coloniale con l’antisemitismo6. Nel dicembre 1938 si organizza poi un convegno nazionale di politica razzista con la partecipazione di membri dei GUF distintisi ai Littoriali della cultura7. Il Centro studi proseguirà il proprio lavoro anche nel 1939, superati quindi i mesi durante i quali sottrarsi alle suggestioni provocate dallo scatenamento della campagna razziale era più difficile. Sull’organo del GUF fiorentino Goliardia Fascista si annuncia nel febbraio l’organizzazione di 4
5 6
7
ACS, PNF, Direttorio Nazionale, Segreteria GUF, b. 45. Dallo stesso documento, una richiesta di finanziamento indirizzata dal segretario del GUF pistoiese Francesco Bartoletti al presidente dell’Ente di cura di Montecatini Terme, in data 19 novembre 1938, è un esempio della ricaduta della campagna antiebraica sul tessuto sociale ed economico delle comunità locali: «È prevedibile che la premiazione richiamerà un numero rilevante di persone nella città prescelta, che perciò verrà a risentirne un non indifferente vantaggio dal lato turistico». Fra i GUF dipendenti, e quindi non sede di Università, si distinse nella medesima iniziativa quello di Catanzaro, che iniziò la pubblicazione del periodico Razzismo. Il bollettino pistoiese si intitolava Razza. Cfr. GUF Firenze 1938. Se ne veda anche la notizia dell’uscita in Goliardia Fascista, A. IV, nn. 4-5, 31 dic. 1938 – 15 gen. 1939: 2: «Presso la sede del GUF è in vendita l’opuscolo pubblicato dal Centro di Studi sulla Razza, con articoli di Lidio Cipriani, Giuseppe Cei, Franco Melandri, Paolo Succi». Si veda il comunicato alla segreteria nazionale GUF del 18 novembre 1938, in ACS, PNF, Direttorio Nazionale, Segreteria GUF, b. 45.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
122
Shoah, modernità e male politico
un altro convegno di studi sulla razza, questa volta dedicato alla “Necessità di un’educazione sessuale” attraverso la scuola e all’“Educazione nella massa”. All’incontro sono invitati anche i GUF di Roma, Milano, Genova, Siena e Pisa8. Il già citato opuscolo realizzato dai collaboratori del Centro testimonia, come nell’impostazione del convegno del 1938, il rapporto diretto fra razzismo coloniale e antisemitismo. Il regime, secondo la presa di posizione del Centro studi, sarebbe giunto alla legislazione antiebraica come ultima tappa di un percorso di selezione culturale, spirituale ed eugenetica presente fin dal primo fascismo e connesso con le politiche di tutela della maternità e infanzia e per l’incremento della natalità. Quest’ultima è alla base della legittimazione propagandistica di un’impresa coloniale che contribuisce non poco a diffondere nel paese l’intolleranza verso la diversità etnica e culturale. La civilizzazione italiana dell’Africa orientale e della Libia passa attraverso la diffusione di stereotipi razzisti che saranno applicati ad ogni realtà straniera toccata dal fascismo. In questo senso la politica balcanica e il pregiudizio antislavo sono una variante geografica del medesimo modo di approcciare la questione culturale come scontro di civiltà. Anche l’idea dell’ebreo come diverso si giustifica quindi a partire dal sospetto verso qualunque minoranza, sia questa religiosa, linguistica, culturale, politica. Ed è ovvio che una campagna razziale condotta di pari passo all’esasperazione del bellicismo fascista nella seconda metà degli anni Trenta trovi gli strumenti dialettici per condannare l’ebreo come nemico di Stato, perché non assimilato e finanche antitaliano. Quindi, tutti quei bollettini prodotti dai pubblicisti che già hanno propagandato i rischi del meticciato e della degenerazione dell’Occidente a causa della penetrazione degli africani sono un veicolo altrettanto adatto alla diffusione dell’antisemitismo. L’adesione dell’Università e del personale docente alla politica razzista è generalizzata, come dimostrato dal fiorire di centri di studio ad hoc in varie città universitarie o dall’inserimento di questi temi all’interno dell’offerta formativa per gli allievi dei Corsi di preparazione politica. Anche Firenze propone ai propri iscritti corsi sulla politica imperiale (anche sotto forma di studio della profilassi antimeticciato) e più in generale sulla razza. I professori Livio Livi e Giuseppe Mazzaglia, ad esempio, offrono corsi rispettivamente di politica della razza e politica coloniale9, ed è compren-
8 9
Goliardia Fascista, A. IV, n. 6, 31 gen. 1939: 1. Cfr. la relazione del segretario del GUF di Firenze professor Guido Renzo Giglioli, in Regia Università degli Studi di Firenze 1941: 18.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Duranti - A scuola di razzismo
123
sibile che la compromissione dei docenti fosse utile per incrementare la pretesa scientificità del messaggio razzista. A Firenze è soprattutto nella Facoltà di medicina che si nota il condizionamento della didattica da parte del clima razziale grazie al lavoro di Lidio Cipriani, all’impegno del professor Biasutti, direttore dell’Istituto di geografia e autore di un trattato di etnologia razziale, e del professor Lodovico Di Caporiacco, assistente presso l’Istituto di zoologia. Quest’ultimo in particolare manifesta un impegno spiccato nel fare del razzismo l’oggetto dei suoi interventi come pubblicista, tanto ne La Nazione che nel foglio federale Il Bargello, quanto con pubblicazioni e contributi autonomi che, muovendo dal problema coloniale, si concentrano sempre più su un virulento antisemitismo10. A Medicina si segnalano inoltre «i lavori eseguiti dal personale assistente dell’Istituto di anatomia umana», con un Contributo alla encefalometria nelle razze umane di Lorenzo Bianchi e gli studi di Franco Pratesi sull’Uomo medio toscano11. Infine, va ricordato il Laboratorio di valutazione fisica e sportiva della Facoltà di medicina (gestito dal GUF assieme all’Opera universitaria) che, con il varo della campagna antisemita nel 1938, diviene una struttura per il potenziamento della stirpe e per il monitoraggio delle condizioni razziali della gioventù. La dialettica Università-Partito si articola su di un doppio binario: da una parte la preparazione, tramite le strutture dipendenti dal ministero dell’Educazione nazionale, di personale in grado di fare propaganda; dall’altra l’evoluzione di branche del Partito – come i GUF – da una dimensione di controllo dell’ortodossia fascista nell’Università a centro di formazione di nuove professioni e competenze. Anche il razzismo antisemita, richiedendo i suoi specialisti, responsabilizza i giovani che si vedono aprire, con lo studio e la ricerca, spazi di collaborazione lavorativa. Gli universitari fiorentini, come conferenzieri e titolari di posti di responsabilità nei gruppi fascisti rionali e nei dopolavoro, sono chiamati a inquadrare politicamente e ad educare, anche in tema di razza, il resto della popolazione fuori dai 10
11
Per il profilo, le pubblicazioni, gli interventi giornalistici del libero docente di zoologia, esempio di continuità razzista dall’inferiorità dei neri d’Africa alla perfidia giudaica, cfr. Bencini 1999. Di Caporiacco, alternando un approccio scientifico ad uno più immediatamente politico, è in grado di garantire una vasta copertura razzista che dalla biologia e dall’eugenetica passa ai Protocolli dei savi di Sion. Cfr. la relazione semestrale inviata al ministero dell’Educazione nazionale da Serpieri nel 1939, in Archivio Università di Firenze, Anno 1939, Posizione 17, Fasc. A “Relazioni annuali e mensili”, Sottofasc. “La Relazione semestrale gennaiogiugno 1939”.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
124
Shoah, modernità e male politico
circuiti scolastici. Il riferimento è ai giovani lavoratori e più in generale a quei larghi settori del paese spesso distanti dalla presenza dello Stato e quindi anche dall’irreggimentazione della propaganda fascista. Volendo precisare questo aspetto, possiamo considerare le parole del rettore Serpieri pronunciate il 30 ottobre 1938 in occasione dell’adunata del GUF fiorentino a Borgo San Lorenzo12. Concetto centrale è quello della ruralità della stirpe italiana: «la caratteristica dell’attaccamento alla terra proprio della nostra razza ci deve riempire d’orgoglio». Questo passaggio è importante perché sottolinea non soltanto l’operosità delle popolazioni rurali ma anche la disciplina nella vita sociale che è propria dell’organizzazione patriarcale. Si deve, infatti, in gran parte al prevalente ruralismo della gente nostra se attraverso le varie dominazioni straniere e quindi alle vicissitudini storiche ed economiche l’unità sociale italiana non si è dispersa, perché il caratteristico tradizionalismo rurale era una forza ostacolante tale al prevalere dei costumi e delle leggi straniere e degli incroci razziali, per cui la prisca legge e il tipo razziale originario potevano mantenersi incorrotti attraverso il divenire dei secoli [...]. I rurali italiani per millenni non si mossero dalla stessa terra, possono dunque ritenersi i prototipi della razza italiana13.
Il ruralismo è quindi un escamotage del regime per affermare l’idea di una razza originaria in un paese come l’Italia, caratterizzato da incontri e compresenze di svariati popoli ed etnie. Il concetto di “razza” porta con sé, di conseguenza, il concetto di “razza dominante”; quindi se noi vogliamo portare la nostra razza ad un livello superiore, effettivamente degna di dominare un Impero, dobbiamo agire sui rurali e portare tra di essi il soffio vivificatore del clima fascista onde elevarne, insieme alle condizioni economiche, i valori morali-spirituali14.
12
13 14
Goliardia Fascista (A. IV, n. 1, 12 nov. 1938: 1) ricorda l’avvenimento con due resoconti: Il fascismo universitario fiorentino adunato in terra di Mugello si riaccosta alle originarie virtù rurali della stirpe. Il rapporto dei gerarchi del GUF alla presenza del Rettore Magnifico (firmato F. G.), e Giornata rurale (non firmato). Nel primo vengono precisati i criteri che devono guidare i fascisti universitari nell’affrontare il compito loro affidato: lo studio del problema della difesa della razza, lungi da qualsiasi forma di esibizionismo, deve essere affrontato con «un’opera leale ed intelligente, intesa a porre in risalto e a sviluppare le tradizionali virtù della nostra stirpe». Cfr. Il fascismo universitario fiorentino adunato in terra di Mugello, cit. Ibid.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Duranti - A scuola di razzismo
125
L’autorevolezza del messaggio razzista a Firenze passa certamente anche dall’impegno dell’antropologo Lidio Cipriani15, assertore di un ordine razziale gerarchico da porsi come problema politico ora che, con l’Impero, l’Italia si trova esposta al pericolo dell’ibridismo, il degradamento razziale a causa dei bastardi. La società italiana deve quindi dotarsi di una ferrea coscienza di razza così da scongiurare la “piaga del meticciato”, e apprezzare la politica di divisione della nazione fra cittadini a tutti gli effetti e soggetti declassati, come gli ebrei. Il magistero razzista di Cipriani viene particolarmente esaltato nella stampa del GUF, che in piena campagna antiebraica ne plaude i meriti come docente e per aver contribuito con i propri studi a diffondere nella popolazione una seria coscienza di razza a partire dalla minaccia rappresentata dal meticciato16. L’opuscolo del Centro studi si apre proprio con una presentazione di Cipriani dal titolo Razzismo fascista, dove si ricorda da una parte il mandato mussoliniano sul problema razziale, necessario per la formazione di una coscienza imperiale, dall’altra che il Partito si aspetta proprio dagli studenti il contributo più originale in termini scientifici e propagandistici. Ma l’approccio biologico del razzismo fascista si mescola anche in Cipriani con la dimensione più immediatamente spirituale e politica: [Le schiere giovanili] devono mostrare di sapere apprezzare e sviluppare l’ampio contenuto scientifico, non dimenticando al tempo stesso l’indirizzo altamente spirituale che vi si collega. Frattanto non ignoriamo che il razzismo italiano, sereno ed equilibrato, affonda le sue radici nel fertile terreno dei dettami biologici e si ispira a leggi naturali di cui è evidente la suprema portata a chiunque le valuti senza prevenzione.
In definitiva il razzismo non può essere disgiunto dal principio gerarchico come componente ideologica del regime: contro il comunismo che vorrebbe l’umanità tutta «grigia e indifferenziata», il fascismo rilancia una «gerarchia dei valori dello spirito inscindibile dalla gerarchia dei valori razziali». La compromissione di Cipriani (e di molte personalità della cultura e dell’accademia dell’epoca) con la politica 15 16
Su Cipriani, scienziato razzista al servizio del regime, cfr. Cavarocchi 2000. Si veda in particolare l’articolo di Giuseppe Cei L’importanza fondamentale del razzismo coloniale italiano, che ricorda il seguente ammonimento di Cipriani: «Si deve evitare l’apporto di semiti, la principale razza in diretto contatto, che vien considerata pericolosa biologicamente, per caratteri fisici, ma soprattutto psichici e morali, verso un originale e sempre maggior sviluppo della Nazione Italiana»; Goliardia Fascista, A. IV, n. 2, 30 nov. 1938: 2.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
126
Shoah, modernità e male politico
razzista del fascismo si spiega nella convergenza fra ambizione personale e necessità propagandistica del regime. Le suggestioni coloniali ottocentesche e l’africanistica producono anche in Italia una deriva razzista e un portato ideologico alle quali il fascismo attinge largamente e che dalla conquista dell’Impero in avanti renderà tali studiosi utili per le esigenze politiche del regime. L’Africa – secondo Cipriani – va osservata a partire da un’idea gerarchica della moralità delle varie etnie: è dominata da un ibridismo secolare determinato da «onde umane di diversa composizione [...] portatrici di ineguali poteri psichici». Si contribuisce a diffondere un’immagine spaventevole dell’ibridismo e dei meticci, agitando lo spettro del crollo spirituale oltre che fisico di un popolo. «Identica sorte toccherebbe infatti ad ogni altra razza che, stabilendosi in Africa, si incrociasse con gli indigeni»: il regresso, la perdita definitiva di valori secolari «se i nostri discendenti saranno di razza mista»17. L’opuscolo del Centro studi ospita inoltre tre contributi di altrettanti militanti del GUF fiorentino che scrivono frequentemente su Goliardia Fascista. Giuseppe Cei, citando i principali biologi e scienziati dell’evoluzionismo, vuol dimostrare l’importanza inderogabile di una lungimirante politica razzista nelle colonie, dove «si deve costituire una vera e propria gerarchia di valori razziali, destinata ad eliminare squilibri morali e pericoli biologici». In Etiopia sarebbero presenti tre elementi, «il Semita, il Camita, il Negro» e, indipendentemente dalla dominazione italiana, la storia avrebbe provveduto a disporli «in scala discendente seguendo un criterio di valutazione razziale». Cei fa sfoggio di astrusi nomi appresi dalla letteratura coloniale e dal dilettantismo bio-antropologico di molti africanisti di Otto e Novecento, ma, a conclusione di questo lungo elenco di tribù, lingue e aree geografiche, propone la ricetta necessaria non tanto dal punto di vista della salvaguardia spirituale, ma del dominio politico sul nuovo territorio coloniale. C’è bisogno dell’apartheid per mantenere il dominio italiano, oltre alla salvaguardia dei camiti da «ogni ulteriore caduta del loro livello razziale», giacché saranno questi a costituire «le masse militari dell’Impero futuro». Cei 17
Cfr. GUF Firenze 1938: 7. Occupandoci dell’opuscolo con numerose citazioni ne riportiamo l’indice: Lidio Cipriani, Razzismo fascista, pp. 5-8; Giuseppe Cei, Gerarchia umana nell’Impero, pp. 9-15; Franco Melandri, La nostra razza in Africa, pp. 17-20; Paolo Succi, L’antisemitismo nella politica europea dell’Italia, e abbozzo di un ragionamento sulla missione dell’Italia di fronte alla civiltà europea, pp. 21-30.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Duranti - A scuola di razzismo
127
è uno dei tanti teorici improvvisati del razzismo coloniale fascista che sfrutta un clima culturale suggestionato dalla retorica dei destini di civilizzazione dell’Italia e dallo scetticismo nei confronti delle teorie egualitarie. Il messaggio è particolarmente subdolo perché in parte affonda le sue radici (come buona parte dei percorsi mentali razzisti) nel prepolitico, nell’umorale e nel sentito dire, e si snoda secondo variabili che riescono a dargli autorevolezza. Ogni contributo dell’opuscolo affronta il problema da angolature e con linguaggio differente. C’è solo un punto comune a tutti i saggi proposti: la politica razziale italiana non è sinonimo di crudeltà da invasori ma «è improntata a sentimenti di serena umanità, protezione e libertà di esistenza [che] viene largamente offerta anche ai rappresentanti di culture nettamente inferiori, conservando la dovuta distanza ed evitando ogni pericolo di incrocio». L’Italia è “buona” e lungimirante: si difende secondo i principi di razza ora che il fascismo le ha consentito di comprendere quello che un settore della scienza, della politica e della filosofia da tempo andava sostenendo, cioè l’ineguaglianza degli uomini. Il finale dell’articolo ci ricorda che la politica razziale fascista deve basarsi «sulla graduatoria: Italiani-Arabi-Camiti-Negri». I criteri di questa rigida strutturazione della società coloniale del futuro sono scientifici ma anche logici. Queste ultime affermazioni necessitano di una serie di chiarificazioni sui valori posseduti dagli indigeni d’Africa rispetto a quelli italici. L’esasperazione della filosofia del “noi e loro”, dell’impossibilità di un contatto che non sia, nel migliore dei casi, il paternalismo che regola il rapporto coloniale docens-discens, è alla base di molte analisi degli universitari del GUF: sia di coloro che cercano il fronte bellico come soluzione delle loro frustrazioni di fascisti senza la gloria di una guerra combattuta, sia di quelli che rimangono nelle redazioni dei GUF impegnandosi a precisare i contorni di questo scontro di civiltà. Il contributo di Franco Melandri contiene i peggiori e più volgari aspetti di razzismo antiafricano elaborati dal GUF fiorentino: c’è di tutto, dall’Impero romano alle virtù dei cristiani cattolici, e soprattutto l’elogio della lungimiranza dei conquistatori italiani che vanno in Africa per restare e stabilire una variante dignitosa del colonialismo di rapina che finora ha caratterizzato le invasioni europee. Le nostre devono essere colonie di popolamento, le uniche in grado di smentire con la penetrazione militare e civile l’incapacità del “negro” di recepire la civiltà europea.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
128
Shoah, modernità e male politico
E questa lotta fra l’Europa e l’Africa, fra gli uomini e coloro che non vogliono diventare uomini, è stato il dramma latente di molti secoli e acuto di molte generazioni. Quando si medita sugli infiniti tentativi di incivilimento dagli Europei tentati in Africa, quando si pensa che i milioni di negri portati in America non hanno assorbito quasi affatto le caratteristiche della civiltà con cui sono a contatto, si è indotti a credere che sulle genti di Africa pesi un marchio incancellabile di inferiorità. Perché dal Vangelo dei missionari allo scudiscio degli aguzzini, dalle leggi alla forza, dalla politica di separazione a quella di confusione, tutti i mezzi sono stati adoperati verso le genti di Africa.
La nostra missione è quindi per l’Europa e per la giusta impostazione dei rapporti fra le razze: «poiché l’inferiorità degli africani è cronica, o meglio storica», a noi spetta adesso il compito di mettere a frutto quanto di buono questa terra può offrire. Se l’Italia con l’Impero svolge contro tutto e tutti una missione di civiltà per l’Europa intera, a dispetto delle sanzioni e della rapacità delle democrazie occidentali, è necessario sgombrare il campo dalla più seria minaccia che il fascismo si trova ora di fronte: l’ebraismo internazionale. È questo il tema svolto, senza alcuna originalità, da Paolo Succi: un trattato dal sapore di copiatura che dimostra ancora una volta la subalternità di molti attivisti universitari; un saggio che fa costante riferimento a motti del Duce e introduce l’inevitabilità dell’antisemitismo come conseguenza dell’Asse Roma-Berlino. La lotta all’ebraismo come difesa da un nemico interno ed esterno, contro i banchieri ebrei di Londra e Parigi, la stampa ebraica che domina l’opinione pubblica mondiale, le sanzioni che sono ebraiche, il Fronte popolare diretto ideologicamente da «l’ebreo intellettuale Benda». Di fronte a questo assedio, ci dice Succi, «il minimo che potevamo fare era difenderci. [...] L’unico mezzo per colpire era la rappresaglia contro gli ebrei stranieri rifugiatisi in Italia e contro gli individui, fino a quel momento italiani, di razza ebraica». Il contributo del Centro di studi sulla razza dimostra la complessità dell’operazione propagandistica fascista e offre un quadro desolante dei molteplici livelli di compromissione di studenti e personale universitario. I conduttori della campagna razzista ribadiscono costantemente il senso di responsabilità, di missione, e gli studenti, tramite i GUF, dimostrano di aver compreso il mandato politico fascista, facilitati da un clima responsabilizzante e imbonitore, fatto di lusinghe politiche e occupazionali, che solleticano le ambizioni professionali.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
S. Duranti - A scuola di razzismo
129
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
2. Il GUF e il razzismo nell’Università: attività politica, culturale, scientifica e di epurazione La varietà di approccio nel messaggio razzista è garantita dall’incrocio di attività e iniziative provenienti da centri di produzione differenti. I vari atenei e i singoli GUF italiani si attrezzano con celerità ed efficienza per rispondere alle questioni politiche ufficialmente in agenda a fine 1938: colonialismo, razzismo e autarchia. I rettori relazionano a Bottai sulle attività svolte dai vari gruppi e associazioni e soprattutto dai dipartimenti universitari, facendo particolare riferimento ai temi appena ricordati. Ecco che ad esempio il segretario del GUF di Milano Franco Barbieri Sacconaghi comunica al rettore di Firenze Serpieri il programma dei Congressi interuniversitari che il suo GUF svolgerà nel 1939. Il segretario milanese chiede al GUF fiorentino due fascisti universitari per ogni congresso, a partire dal primo di questi che si terrà nel gennaio ed avrà per tema gli studi sulla razza. L’impianto risulta autorevole e testimonia la collusione del corpo docente italiano e la compromissione degli atenei nella politica razzista. Presiede infatti il Congresso di studi sulla razza (che si svolge presso la Regia Università milanese) il rettore, Alberto Pepere. Il programma si articola su due giorni, prevedendo le relazioni Il problema spirituale e politico del razzismo italiano del professor Renzo Sertoli Salis, dirigente del Centro studi sulla razza del GUF milanese, e Il problema biologico e coloniale del razzismo italiano, svolta dal professor Giuseppe Cantoni18. Il GUF fiorentino si mette in moto con una capacità organizzativa che, se non può prescindere dalla voglia di protagonismo degli attivisti, necessita anche dell’impiego di quegli istituti medici che il Gruppo gestiva col contributo dell’Opera universitaria. Infatti, branche del GUF che svolgono un ruolo importante all’interno della politica razziale non sempre sono create appositamente per questo scopo; più spesso, invece, come nel caso del già ricordato Laboratorio di valutazione fisica e sportiva del GUF, vengono adattate alle nuove necessità politiche. Il direttore del Laboratorio e vicesegretario del GUF Pratesi, in una relazione sull’attività svolta indirizzata al direttore della Clinica medica generale fiorentina di Careggi, precisa che scopo dell’attività dei medici del Laboratorio è anche «la raccolta di numerosi dati antropometrici per la determinazione del tipo costituzionale e del tipo raziale [sic]». Il Laboratorio del GUF viene allestito con apposita
18
Archivio Università di Firenze, Anno 1938, Posizione 7, Fasc. G “Gruppo Universitario Fascista”.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
130
Shoah, modernità e male politico
convenzione nel novembre 193619, dimostrando la tendenza avviata dalla conquista dell’Impero in avanti a spingere la società verso una sempre più marcata politica eugenetica, con l’istituzione di libretti individuali che registrino i dati psicofisici degli studenti, la morbilità in relazione alle abitudini dei singoli e il collegamento di questo insieme di dati con le attività speculative della Facoltà di antropologia. Quindi, se è vero che il Laboratorio si inserisce all’interno di quell’idea della politica della razza che comprende anche l’assistenza e il miglioramento delle condizioni previdenziali, il suo ruolo di ricerca va a coprire una serie di indagini che prevedono l’applicazione dell’eugenetica allo studio della società italiana. Pratesi ricorda infatti «lo studio dei rapporti esistenti tra tipo morfologico costituzionale e tipo raziale [sic], per contribuire ad alcuni problemi riguardanti la distribuzione geografica della costituzione morfologica». Tutto questo richiede il supporto logistico dell’Opera universitaria, e quindi del ministero dell’Educazione nazionale, dei GUF e degli specialisti delle singole Facoltà. Ad esempio, gli allievi ufficiali medici della Scuola di sanità militare di Firenze sono coinvolti nella raccolta di «notizie riguardanti la regione di appartenenza del soggetto e dei suoi ascendenti». Il lavoro di Pratesi produce inoltre diverse ricerche sulla «determinazione dell’uomo medio toscano, che attualmente manca nella serie degli uomini medi regionali già pubblicati». L’importanza del Laboratorio per il GUF e più in generale per l’ateneo fiorentino è testimoniata anche dall’illustrazione del lavoro svolto al suo interno attraverso una relazione presentata, subito dopo quelle del rettore e del segretario del GUF, per l’apertura dell’anno accademico e pubblicata negli annuari dell’Università. La produzione scientifica del Laboratorio porta alla realizzazione fra il 1937 e 1938 di comunicazioni e pubblicazioni sulle “peculiarità” della razza italiana. Fin dal 1937 l’Archivio italiano di antropologia ed etnologia pubblica i risultati della ricerca di Pratesi su I rapporti tra tipo morfologico e tipo razziale studiati su 709 adulti sani, dimostrando la tenuta di suggestioni relative alla razza tipiche delle discipline antropologiche, se non altro a partire dall’affermazione che le razze esistono. È chiaro inoltre il significato – e le conseguenze culturali – di un approccio di ricerca sulla cosiddetta “personalità biologica”, che rappresenta, a detta di Pratesi, uno dei principali interessi del Laboratorio e
19
Accordo fra il GUF e l’Università sotto la guida del Consiglio di consulenza, presieduto dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia professor Ferruccio Schupfer.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Duranti - A scuola di razzismo
131
la forma di attività che più direttamente si inquadra con le teorie razziali divenute oggi di attualità politica, in quanto si propone di contribuire a sempre meglio conoscere le caratteristiche intrinseche di ordine morfologico e di ordine funzionale che costituiscono l’appannaggio biologico della stirpe italiana20.
Colpisce, valutando il lavoro svolto da altri GUF sede di ateneo, l’importanza dell’approccio pseudoscientifico, il ricorso ad un linguaggio tecnico da manuale di biologia e soprattutto il privilegiare un’idea di razzismo che ponga la separazione razziale alla base del miglioramento eugenetico della stirpe italica. Gli studenti del GUF fiorentino sono radicali su questi aspetti e ne lasciano ampia traccia sul loro periodico Goliardia fascista. Paolo Prosperi, ad esempio, ricorda che per “razzismo” il fascismo intende sostanzialmente il problema della “difesa della razza”: si tratta quindi di un problema scientifico che deve essere affrontato con rigore attraverso ricerche da affidare ai medici. La fede nell’approccio medico-scientifico razzista per la risoluzione dei problemi di inquinamento giudaico e dei meticci spinge Prosperi a lamentarsi del fatto che i vari Centri di studio sulla razza affrontano il problema soprattutto dal punto di vista dell’antropologia, mentre è «evidente che l’apporto della medicina è fondamentale in questo ambito, e che proprio dalla medicina dobbiamo aspettarci la soluzione più efficace al problema»21. Ora che la propaganda razziale è sostenibile su basi scientifiche, il ruolo dei medici va considerato centrale per l’autorevolezza che riesce a garantire in sé, ma anche perché è in grado di completare la saldatura fra razzismo come difesa dal contagio ebraico e “difesa della razza” come tutela e miglioramento della stirpe. La propaganda del GUF alterna quindi contributi sull’importanza del ruolo dei medici a quelli nei quali si elencano le provvidenze del regime. Nel commentare la Mostra della difesa sanitaria della razza22, si illustrano – definendole esempi di politica razzista – le iniziative promosse dal regime per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini in ambito medico-sanitario. 20 21 22
Cfr. Regia Università degli Studi di Firenze 1939: 28. Cfr. Il razzismo visto dai medici, in Goliardia Fascista, A. IV, n. 6, 31 gen. 1939: 2. Cfr. Franco Monterisi, Mostra della difesa sanitaria della razza alla IX Fiera del Levante, in Goliardia Fascista, A. III, n. 17, 4 ott. 1938: 5. Gli scopi della Mostra sono: 1) dimostrare cosa ha già fatto il regime per la promozione della difesa sanitaria della razza italiana; 2) propagandare il problema razziale presso i cittadini, ovvero lavorare per «la formazione della nostra coscienza sanitaria». Si tratta infatti di «debellare tutti i nemici patologici che tentano di minare l’integrità o l’esistenza della razza [italiana]».
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
132
Shoah, modernità e male politico
Come opzione politica e scelta propagandistica il razzismo fascista va visto come un tutt’uno, un insieme di soluzioni radicali per colpire nemici biologici e spirituali che dovrebbero stimolare la compattezza del corpo nazionale “sano”. La razzistizzazione della società, dalla campagna d’Etiopia in avanti, contribuisce quindi a rafforzare il senso di identità nazionale nella fase dell’imperialismo fascista. Scienza e Impero nella visione del GUF si compenetrano: gli studi bio-antropologici trovano un immediato rilancio con la campagna d’Africa e la ricerca universitaria serve a sventare la minaccia dell’immissione dei “negri” nel tessuto nazionale italiano. Secondo il GUF il meticciato è il rischio principale per il fascismo. Poiché l’Impero si prende con le armi ma si conserva con la subalternità culturale e civile dell’indigeno, è dunque importantissimo mantenere «il nostro prestigio di fronte alle popolazioni suddite che da noi si staccano enormemente per la loro inferiorità morale, sociale, intellettuale»23. Per questo si sottolinea l’importanza delle leggi che vietano il matrimonio tra italiani e indigeni, aggiungendo però che è ancora più importante preparare i coloni, e in generale la società italiana, attraverso una campagna di informazione volta a prevenire i rapporti sessuali tra razze diverse. Si tratta quindi di temprare i costumi con ogni mezzo di propaganda, dal cinema alla stampa, dai viaggi di istruzione nelle colonie alle conferenze. Questa fede nella scienza razzista mista alle possibilità di persuasione della propaganda lascia traccia sulla stampa del GUF fiorentino in maniera rilevante: secondo una dinamica di emulazione e condizionamento reciproco dei vari collaboratori, si verifica un “gioco al rilancio” da un numero al successivo, che ha come esito la presa di posizione a favore dei vantaggi che si possono ottenere dall’eugenetica. Poiché la famiglia è la cellula fondamentale della società, essa è parimenti il cardine della politica razziale, ed è quindi fondamentale proibire unioni tra razze diverse. Oltre a ciò, all’interno della stessa razza ariana si deve provvedere «a diminuire sempre più l’unione sessuale delle persone non sane; e si cerchi anzi di favorire il connubio dei tipi che la scienza ritenga specialmente adatti a riunirsi»24. Conformemente a questa scelta in favore dell’eugenetica si prospetta addirittura la sterilizzazione per gli individui non sani. I secondi anni Trenta, l’ultima fase dell’era Starace, dal punto di vista dell’irreggimentazione e del controllo totalitario della nazione registrano 23 24
Cfr. Carlo Sechi, Il Meticciato, in Goliardia Fascista, A. IV, n. 10, 1 apr. 1939: 2. Cfr. Sergio Zambrini, La scelta degli individui in demografia e l’intervento statale, in Goliardia Fascista, A. IV, n. 12, 30 apr. 1939: 2.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Duranti - A scuola di razzismo
133
un’accelerazione, sia con strumenti coercitivi e polizieschi, sia con la diffusione di concetti culturali di forza e intransigenza bellicista. Aumenta il controllo sugli istituti intermedi e anche quegli ambiti di discussione critica controllata, come i Littoriali della cultura, con la segreteria di Fernando Mezzasoma subiscono, dal 1935 a tutto il 1938, un ritorno progressivo all’ortodossia. L’introduzione di norme per l’obbligatorietà dell’iscrizione al GUF (sancita dalla Carta della scuola di Bottai del 1939) e del conseguimento del brevetto sportivo come prerequisito per entrare a far parte dei GUF sono un’ulteriore dimostrazione dell’organicità di questo modello di irreggimentazione della società. Il fascismo si dimostra conseguente nelle proprie realizzazioni e imposizioni con i propri postulati teorici e il razzismo, che filosoficamente sta alla base della sua concezione della vita e dell’organizzazione sociale, si biologizza e si arricchisce di suggestioni eugenetiche inedite, a partire dalla insistita polemica contro il meticciato. Non stupisce dunque che il segretario del GUF fiorentino Taddei concluda il suo discorso di apertura dell’A.A. 1938-39 facendo ricorso all’idea di superiorità di razza: una palese concessione al clima del momento, non necessaria e nemmeno troppo pertinente, a dimostrazione degli effetti pervasivi di una campagna propagandistico-culturale che ha saturato gli spazi della comunicazione pubblica, arrivando a ridursi a concetto scontato. Il razzismo sinonimo di orgoglio della propria superiorità etnico-culturale che trae le sue origini dalla gloria del popolo erede dell’Impero dei cesari, «eterna generatrice di eroi, di artisti, di scienziati, di santi e di guerrieri»25. Rivolto alle eccellenze e ai camerati del consesso accademico, il segretario del GUF fiorentino conclude: Animati da questo nostro fervore, forti della nostra superiorità di razza guardiamo diritto nella strada che ci è stata additata, sicuri, matematicamente sicuri che sia la buona, la strada della vittoria e della gloria: con questa suprema certezza ci mettiamo al lavoro con semplice e serena tranquillità26.
Le relazioni di apertura degli anni accademici consentono di comprendere il ruolo e il peso della questione razziale per i GUF dal momento che tracciano, oltre al consuntivo dell’anno precedente, gli obbiettivi per la stagione che si apre. I punti all’ordine del giorno per il 1938-39 sono l’assistenza ai bisognosi in clima autarchico e, in primis, la politica razziale: 25 26
Questo passaggio costituisce il finale della Prefazione di Cipriani; cfr. GUF Firenze 1938: 8. Cfr. Regia Università degli Studi di Firenze 1940: 23.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
134
Shoah, modernità e male politico
Il problema di attualità, quello della razza, deve ottenere da noi il contributo che ci spetta, un contributo di studio intelligente, dell’importante provvedimento, sia dal punto di vista scientifico, politico e culturale. Per questo è stato costituito il Centro di studi sulla razza che mirerà alla impostazione della campagna raziale [sic] secondo le direttive di marcia dateci dal segretario del Partito.
Quindi anche Firenze si allinea alla generale tendenza dei GUF a costituire delle strutture per l’elaborazione teorica, che abbia un travaso pratico nella sfera propagandistica. Saranno infatti i membri del Centro studi a firmare i contributi antisemiti nelle sue varie accezioni e implicazioni sul foglio di federazione Il Bargello e su Goliardia Fascista. L’importanza del Centro studi in un certo senso compendia il lavoro avviato dal ricordato Laboratorio di valutazione fisica e sportiva che «ha potuto già portare in questo campo un riconosciuto contributo di dati sui caratteri etnico-biologici della razza italiana». Ed è qui un punto centrale: una delle peculiarità dell’elaborazione teorica razzista dei GUF riguarda proprio il lavoro di sbancamento, per così dire, del discorso e della costruzione antisemita. Si demonizza il nemico di razza parallelamente alla costruzione di stereotipi a sostegno di una identità italica. A far questo contribuiscono gli universitari di tutte le discipline, con ricerche per così dire classiche, come quelle legate alla romanità, fino alle più improbabili, come l’impegno degli studenti del GUF palermitano per la dimostrazione dell’arianità dei siciliani, giudicati immuni da incroci con le popolazioni che hanno occupato questa terra nel passato27. Nel caso di Firenze, un forte senso di autorappresentazione spinge Taddei a ricordare con orgoglio quanto il contributo teorico del GUF spinga in avanti la conoscenza del problema razziale “interno ed esterno”, cioè rivolto verso la codificazione dei tratti comuni del popolo italico ariano-latino e la definizione dei tratti aberranti biologico-culturali, sociali e morali dei giudei28. L’impegno del GUF va però oltre la produzione di studi razzisti e abbraccia quella tradizionale dimensione del controllo e della selezione dei propri iscritti per garantire l’ortodossia e l’inquadramento della massa studentesca. Se con la Carta della scuola si dà l’impulso all’iscrizione in massa, obbligatoria, degli universitari al GUF, ecco che la compilazione degli sche27
28
Si veda ad esempio N. Buffa (del GUF di Palermo), Sicilia Ariana, in Libro e Moschetto, 28 gen. 1939: 7. Nell’articolo La Sicilia alla mostra della razza, pubblicato sul bollettino nazionale del GUF Libro e Moschetto (8 gen. 1940: 8), il Gruppo palermitano ricorda i risultati conseguiti attraverso gli studi condotti sulla purezza razziale ariana dei siciliani. Cfr. Regia Università degli studi di Firenze 1939: 20.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Duranti - A scuola di razzismo
135
dari da parte dei singoli GUF provinciali e di ateneo consente di approntare un censimento parallelo e aggiuntivo degli israeliti. Se come primo provvedimento le Leggi razziali vanno a colpire proprio l’istruzione, con l’esclusione degli ebrei, il GUF fiorentino, senza attendere specifiche sollecitazioni dal Partito, provvede alla revisione dei propri schedari, definendo tale operazione “attività politica”. Dal novembre 1938 infatti il tradizionale spoglio e revisione dello schedario degli iscritti non si effettua più soltanto per controllare il raggiunto limite di età dei 28 anni per la militanza nella struttura, ma per garantire la «eliminazione degli elementi giudei»29. L’attività di epurazione coinvolge varie branche del GUF fiorentino, come la sezione studenti stranieri che curava «la riorganizzazione dello schedario dei propri iscritti in particolar modo per quanto si riferisce agli iscritti stranieri israeliti che erano iscritti alla nostra Università»30. Il GUF rappresenta l’avanguardia politica e intellettuale del Partito ed è necessario eliminare la presenza ebraica non solo dall’ateneo ma soprattutto dal suo stesso seno, ora che si è chiarita l’essenza dell’ebreo come nemico della nazione e, in particolar modo se straniero, come antifascista dichiarato. Per scongiurare questa minaccia il fascismo, che aveva comunque sempre sottoposto ad un’osservazione speciale gli studenti ebrei fuggiti dalla Germania nazista31, produce una serie di norme che coinvolgono tre soggetti: il ministero dell’Educazione nazionale, quello degli Affari Esteri e lo stesso PNF, attraverso il vicesegretario dei GUF Fernando Mezzasoma. La norma emessa il 6 agosto 1938, che sanciva l’espulsione in blocco degli studenti universitari stranieri, era stata rivista da una nuova circolare di Bottai, indirizzata ai rettori delle Università e ai direttori degli Istituti superiori. Non c’era possibilità di nuove immatricolazioni ma, su indicazione del ministero degli Affari Esteri, ad un ebreo straniero era adesso consentito, senza poter andare fuori corso, di conseguire la laurea32. Se il fascismo 29 30 31 32
Cfr. la relazione dell’attività del mese di novembre 1938, in Archivio Università di Firenze, Anno 1939, Posizione 17, Fasc. A “Relazioni annuali e mensili”, Sottofasc. “Relazioni del GUF dal dicembre 1938”. ACS, PNF, Direttorio Nazionale, Segreteria GUF, b. 37, fasc. 586. Sui destini di studenti e docenti ebrei dell’ateneo fiorentino cfr. Cavarocchi – Minerbi 1999; in particolare p. 480 per il caso degli ebrei tedeschi. La circolare n. 6408, firmata dal ministro Bottai, recita: «Il ministero degli Affari Esteri ha comunicato che gli studenti ebrei di nazionalità straniera che abbiano già iniziato negli anni scorsi gli studi universitari nel Regno e risultino regolarmente iscritti per l’anno 1937-38 in una Università o Istituto superiore sono autorizzati a rimanere nel Regno e proseguire i loro studi sino a conseguimento del titolo di laurea. Tale concessione non si applica però agli studenti ebrei di nazionalità tedesca. A parziale modifica di quanto fu stabilito con la circolare del 6 agosto
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
136
Shoah, modernità e male politico
concedeva, pur in un clima ostile e deprimente, costellato di divieti (come l’impossibilità di ottenere sussidi o borse di studio), la possibilità ad un ebreo straniero – purché non tedesco – di terminare gli studi, il Partito attraverso una circolare di Mezzasoma ne impediva però la presenza nel GUF: Gli studenti ebrei, di cui parla la circolare [di Bottai], non potranno però essere iscritti alla sezione studenti stranieri dei GUF. Ogni studente straniero che chiede l’iscrizione al GUF dovrà pertanto compilare una domanda d’iscrizione, in doppia copia, come dall’esemplare allegato; una copia [parola illeggibile] dovrà essere inviata a questa Segreteria. Per ogni studente dovrà inoltre essere effettuato un ulteriore controllo con i documenti depositati presso l’Università. Tutto questo dovrà avvenire con la massima precisione ed esattezza in modo da evitare iscrizioni ai GUF di studenti stranieri di razza ebraica33.
Per comprendere il valore “politico” e l’aspetto vessatorio di questa norma bisogna ricordare la funzione assistenziale che i Gruppi universitari fascisti avevano svolto, soprattutto attraverso la sezione studenti stranieri. Il numerus clausus che limitava in vari paesi dell’Europa orientale l’iscrizione alle Università per gli ebrei aveva portato molti di loro a scegliere l’Italia come paese di adozione, vista la tradizionale politica di accoglienza di alcuni dei suoi prestigiosi atenei34. Al GUF, al di là della militanza per ambizione politica e aderenza ideologica, ci si avvicinava anche per i numerosi vantaggi che offriva agli iscritti, dato che aveva stabilito città per città una rete di convenzioni privilegiate con esercizi commerciali ed istituzioni. Avendo il GUF monopolizzato interamente lo spazio universitario, fuori dalla sua orbita uno studente con mezzi esigui non aveva altra istituzione assistenziale alla quale rivolgersi. Essere cacciati dal Gruppo universitario del proprio ateneo non era quindi soltanto una delle tante vessazioni puntigliose del regime, ma il tentativo di rendere la vita difficile ad un soggetto che in quanto straniero correva gravi rischi. La schedatura e la denuncia di uno “studente israelita straniero” aveva delle conseguenze particolarmente gravi, dal momento che
33
34
1938 – XVI, n. 19153, dispongo, pertanto, che gli studenti in parola possano alle condizioni suindicate rinnovare la loro iscrizione». ACS, PNF, Direttorio Nazionale, Segreteria GUF, b. 45. Nella bozza di circolare approntata da Mezzasoma, la domanda d’iscrizione in allegato presenta l’aggiunta a penna della voce “Appartiene alla razza ebraica?” subito dopo la voce “Nazionalità”. Oltre ai numerosi riferimenti in pubblicazioni relative alle storie dei singoli atenei italiani, per il caso bolognese è stata ricostruita la vicenda degli studenti ebrei stranieri; cfr. Mirri – Arieti 2002; Brizzi 2002.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Duranti - A scuola di razzismo
137
con la sua espulsione si apriva lo scenario di un rimpatrio forzato verso paesi che si erano abbandonati proprio per la natura discriminatoria delle loro legislazioni. Gli atenei italiani, benché fascistizzati, erano comunque stati dei rifugi preziosi per i destini individuali di numerosi giovani, ma la svolta antisemita del fascismo li stravolse repentinamente, sottoponendo queste vite alla discriminazione, alla schedatura, all’espulsione. È anche grazie alla politica razzista praticata negli atenei come quello fiorentino che questa terra d’asilo – come ci ricorda lo studio di Klaus Voigt – poté rapidamente trasformarsi in un “rifugio precario”35. In un clima generalizzato di istigazione all’odio di razza, gli atenei e il Partito si servono dunque dei GUF per la diffusione dell’antisemitismo in funzione interna ed esterna, scrivendo sulla stampa fascista e universitaria e portando in provincia l’impostazione razzista del regime. L’impegno e le parole scritte da studenti e docenti, le affermazioni pubbliche di molti rettori, dimostrano quanto la questione razziale fosse divenuta di assoluta centralità all’interno delle Università. È quindi comprensibile che proprio il ministero dell’Educazione nazionale fosse interessato a sapere cosa e quanto in materia di razza studenti e professori stessero elaborando alla metà del 1939, primo anno accademico investito dal nuovo clima razzista. E il quadro non soltanto dimostra lo zelo di parte degli intellettuali all’interno degli atenei, ma dà la dimensione della corruzione delle coscienze che tale stato di cose aveva determinato. Oltre a monitorare una stampa universitaria traboccante di razzismo, le autorità politiche plaudono anche all’arte antisemita e Bottai si fa perfino mecenate, acquistando, a margine della Mostra d’arte dei Littoriali del 1939 alla quale aveva presenziato, l’opera di uno studente fiorentino: la caricatura di un ebreo36. Inoltre, in presenza di una didattica che si permea di razzismo con la creazione di corsi appositi, di docenti che promuovono tesi di laurea in tematiche razziali, non può stupire l’impegno profuso come propagandisti da parte degli studenti. In un clima nel quale i media sono permeati di antisemitismo, dalla metà del 1938 si aggrava, ma anche si rende coerente, la saldatura con il senso comune di superiorità di stirpe diffuso fra quei giovani già esposti alle “suggestioni africane”. È dei giovani, degli studenti universitari in modo particolare, la convinzione di rappresentare un baluardo di coscienza contro la corruzione del corpo nazionale da un punto 35 36
Cfr. Voigt 1989, 1993. L’autore dell’opera, prima classificata per la categoria di bianco e nero, è Armando Nocentini del GUF di Firenze. Cfr. Goliardia Fascista, A. IV, n. 12, 30 apr. 1939: 6.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
138
Shoah, modernità e male politico
di vista biologico e spirituale. Frequenti infatti sono gli appelli a scongiurare, con una adatta forma mentale e senso di responsabilità, il meticciato, ricordando che la stessa guerra di Spagna si combatte anche in nome della neutralizzazione del virus bolscevico37. Ben prima del 1940, almeno dalla guerra d’Africa, il pervertimento delle coscienze della nazione segue oltreconfine il piano della conquista militare, mentre internamente si alimenta di un credo razzista e di suggestioni da scontro di civiltà prodotti e sostenuti anche dagli atenei italiani.
37
Per un vasto campionario della stampa razzista prodotta dai GUF (anche da quello fiorentino), cfr. Duranti 2008: 309-62.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
II. LA CONDIZIONE UMANA DOPO IL MALE RADICALE
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
141
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
ZYGMUNT BAUMAN
MALE E MODERNITÀ: TRE PARADIGMI*1
1. I demoni che infestarono e straziarono il XX secolo si nutrirono degli sforzi risoluti con cui l’età moderna tentò di conseguire un obiettivo cui mirava fin dal suo inizio – un obiettivo che ne costituiva anzi lo stesso presupposto, dal momento che aveva determinato un modo “moderno” di vivere. L’obiettivo era quello di imporre una forma limpida e gestibile al caos: di ridurre il mondo degli umani – fino ad allora fastidiosamente opaco e indisciplinato, di sconcertante imprevedibilità ed esasperante turbolenza – all’ordine, un ordine completo e inattaccabile. Un ordine siffatto implicava l’assenza di ogni ridondanza inutile o indesiderabile, di ogni possibile causa di infelicità, confusione e disagio, ossia di tutto quel che poteva rappresentare un ostacolo alla sottomissione del mondo umano a un totale e indisturbato controllo. In ultima analisi, significava rendere l’ammissibile obbligatorio, ed eliminare il resto. La convinzione che una tale impresa fosse accettabile, praticabile, in vista e a portata di mano, e l’irresistibile impulso ad agire sulla base di questa convinzione, erano e rimangono i tratti distintivi della modernità che raggiunse l’apice all’alba del XX secolo. L’età moderna era un viaggio verso la perfezione, verso uno stato in cui gli sforzi di miglioramento si sarebbero arrestati, perché qualunque ulteriore intervento sulla forma del mondo umano avrebbe solo potuto peggiorarla. Per questa stessa ragione, l’età moderna è stata anche un’età di distruzione. Lo sforzo di raggiungere la perfezione richiedeva lo sradicamento, la cancellazione e l’estinzione di innumerevoli esseri che difficilmente avrebbero trovato posto nel perfetto schema delle cose. La distruzione era la sostanza stessa della creazione: la distruzione delle imperfezioni era condizione sufficiente quanto necessaria a lastricare la strada per la perfezione. La storia della modernità, e in particolare del suo esito novecentesco, è stata la cronaca di una distruzione creativa. Le atrocità che hanno distinto il corso del “secolo breve” (come lo chiamò Eric Hobsbawm, fissandone il vero inizio *
Traduzione dall’inglese di Lucia Claudia Fiorella.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
142
Shoah, modernità e male politico
al 1914 e la fine effettiva al 1989) furono figlie del sogno di precisione, purezza, chiarezza e trasparenza di una perfezione ultima. I tentativi di realizzare quel sogno sono stati troppo numerosi per poter essere elencati qui; fra tutti, però, se ne distinguono due per l’inaudita ambizione e la straordinaria risolutezza. Entrambi si sono guadagnati un posto fra le interpretazioni più esaurienti ed abbaglianti del sogno dell’“ordine ultimo”; è in base ai modelli da loro istituiti che si misurano tutti gli altri esperimenti, veri o presunti, avviati, progettati o immaginati; ed è la loro piatta e intransigente completezza a incombere sulla memoria collettiva come il prototipo di tutti i casi che ne hanno seguito l’esempio – in modo schietto o camuffato, deciso o esitante. I tentativi in questione sono naturalmente l’impresa nazista e quella comunista di sradicare una volta per sempre, integralmente e in un colpo solo ogni elemento o aspetto turbolento, opaco, accidentale o riottoso della condizione umana. In base all’attenta analisi degli archivi delle commissioni di studio e degli uffici amministrativi delle autorità naziste, Götz Aly e Susanne Heim sostengono che, nelle politiche naziste che miravano a ridisegnare la mappa politica, etnica e sociale dell’Europa, la “politica della modernizzazione” e quella della “distruzione” erano intimamente connesse. I dominatori nazisti erano determinati a instaurare in Europa, dopo la conquista militare, «nuove strutture politiche, economiche e sociali il più velocemente possibile» (Aly – Heim 1991: 14, 482)1. Un’intenzione del genere significava, ovviamente, che il problema di prendere in considerazione accidenti storici come la collocazione geografica degli insediamenti etnici e la conseguente distribuzione delle risorse naturali e della forza lavoro non si poneva proprio; l’essenza del potere, dopo tutto, è la capacità di ignorare simili capricci della fortuna. In un mondo fatto su misura secondo un piano razionale prestabilito non può esserci spazio per i molti avanzi di un passato accidentale, non integrabili o addirittura dannosi per il nuovo ordine delle cose. Alcuni popoli andavano perciò deportati in luoghi dove le loro capacità produttive potevano essere imbrigliate e meglio sfruttate per altre imprese. Altri, di cui non si ravvisava alcuna utilità, dovevano essere cacciati o sterminati, in modo da sgombrare il terreno per l’insediamento dei più degni. 1
Cfr. anche 125-26: «Inizialmente un piccolo ufficio, istituito il 6 ottobre 1939 con la consegna di coordinare “il riassetto delle nazioni europee”, il Commissariato del Reich per il consolidamento della germanicità (Reichskommissariat für die Festigung deutschen Volkstums) si trasformò presto in una struttura potente con numerose filiali, che oltre ai propri dipendenti impiegava migliaia di etnografi, architetti, agronomi, contabili e specialisti d’ogni tipo di disciplina scientifica». Si veda altresì Aly 1993.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Z. Bauman - Male e modernità: tre paradigmi
143
Comandanti delle SS, burocrati, scienziati, ingegneri e amministratori furono tutti ugualmente abbagliati e incantati dalla grandiosità dei territori appena conquistati e ancora da conquistare, dalla potenziale infinità delle loro prospettive, e dall’enormità dei problemi posti da un loro adeguato sfruttamento. In particolare l’Europa orientale appariva loro come una vasta, anzi, sconfinata terra lasciata a maggese che chiedeva solo di essere dissodata e ripulita dalle erbacce, arata e seminata. Proprio come gli antropologi, i medici e i biologi si preoccupavano di “sanare il corpo della nazione” applicando i criteri scientifici della purezza razziale, dell’idoneità fisica e del coraggio, come pure dell’isolamento e dell’eliminazione degli individui e delle categorie “indegne” (unwert), così economisti, agronomi ed esperti di pianificazione territoriale sentivano il dovere di “igienizzare la struttura sociale” delle regioni conquistate. Secondo gli ingegneri sociali nazisti, la qualità delle razze umane poteva essere migliorata soltanto attraverso l’annientamento, o almeno la castrazione, della “vita indegna” (unwertes Leben) (Dörner 1988). Cynthia Ozick, nota romanziera ebrea americana, ha descritto l’Olocausto come il gesto di un artista che cancella una macchia che rovina l’armonia della composizione. Un gesto simile è comune fra gli artisti – e non solo fra gli artisti, dato che una più o meno pronunciata inclinazione artistica è un tratto umano, fin troppo umano. Nel caso dell’Olocausto, è accaduto che la “macchia” fosse composta di uomini, donne e bambini che non coincidevano con una certa idea di perfezione – ma d’altra parte, qualunque genere di composizione perfetta seleziona ed esclude una serie di elementi o di esseri non integrabili (a chi gli chiedeva come creasse le sculture perfette che erano il suo marchio di fabbrica, Michelangelo pare rispondesse che il suo metodo era semplicissimo: si limitava a tagliar via dal marmo tutti i pezzi non necessari). I massacri del XX secolo furono esercizi di distruzione creativa, ritenuti indispensabili per l’igiene sociale; un intervento chirurgico necessario al miglioramento o alla salvezza della vita, o alla sopravvivenza delle chiese e delle nazioni. Esercizi che si ispiravano al nazismo furono condotti nel cuore stesso della civiltà, della scienza e dell’arte europea, in paesi che si gloriavano di essere quasi arrivati a realizzare il sogno della “Casa di Salomone” di Francis Bacon: un mondo in cui regnava integra e indiscussa la ragione, serva leale dei migliori interessi dell’uomo, del suo benessere e della sua felicità. L’idea di rassettare il mondo asportandone e bruciandone le impurità, come pure la convinzione della sua fattibilità – a condizione di mobilitare forze e volontà sufficienti – germinava nella mente di Hitler a passeggio per le vie di Vienna, allora l’autentica capitale delle scienze e delle arti europee.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
144
Shoah, modernità e male politico
Più o meno nello stesso periodo, al confine della modernità europea, un’idea simile veniva coltivata da persone che contemplavano con timore reverenziale, e un misto di rispetto e gelosia, quel che accadeva dall’altra parte di quel confine poroso, e ne erano sbigottite: era il sogno comunista di inseguire, raggiungere e superare la civiltà moderna sulla pista che portava alla perfezione. L’umiliante consapevolezza di essere rimasti indietro in quella corsa suscitava un senso d’urgenza, spingeva alla fretta e suggeriva scorciatoie; richiedeva di condensare nell’arco di vita di una sola generazione quel che dall’altra parte del confine si era compiuto in una lunga serie di generazioni. E naturalmente, la generazione scelta per inaugurare il nuovo mondo liberato dalla sofferenza avrebbe pagato con sofferenze enormi. Nessun sacrificio sembrava eccessivo se visto alla luce delle attrattive della sua nobile destinazione. E non c’era parte della realtà esistente che potesse garantirsi l’immunità o un salvacondotto sulla base di passati meriti, men che meno per la sua mera presenza-nel-mondo. Il biglietto d’entrata al mondo della perfezione doveva essere riguadagnato, e naturalmente non tutti avevano il diritto di mettersi in coda. Esattamente come qualunque altro modello pseudo-utopico, quello comunista non sarebbe stato completo senza un inventario dei divieti di accesso. Diversamente dal modello nazista, la variante comunista insisteva molto sulle sue credenziali universalistiche e dichiarava che il mondo che si proponeva di costruire sarebbe stata la casa dell’intera umanità; a maggior ragione era importante che, prima dell’inizio effettivo dei lavori, l’umanità fosse mondata dalle sue impurità, e cioè da tutti coloro che non erano benvenuti, invitati o autorizzati sul sito di costruzione. La formula che legittimava gli atti genocidiari comunisti differiva dalle giustificazioni dei massacri di matrice nazista; ma dietro le differenze argomentative si nascondeva la comunanza delle premesse. Comunisti e nazisti condividevano l’idea che il diritto alla vita non fosse universale, perché alcuni uomini meritavano di vivere e altri no; e che la differenza fra loro fosse determinata dal loro essere o non essere idonei al nuovo ordine, concepito per sostituire e migliorare la situazione corrente. L’adozione di queste premesse sarebbe stata tuttavia impensabile se non fosse stata coadiuvata da un convincimento moderno, fin troppo moderno, entusiasticamente abbracciato e portato alle sue logiche conclusioni da entrambi i rami dei totalitarismi del Novecento: la fede nell’onnipotenza umana, come disse Hannah Arendt – la ferma convinzione che si potesse raggiungere qualunque cosa con l’organizzazione opportuna. Fu questo convincimento a indurli a fare esperimenti con cui l’immaginazione si era prima solo trastullata, ma che non erano mai arrivati alla pratica (Arendt 1951).
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Z. Bauman - Male e modernità: tre paradigmi
145
Perché quelli che si erano auto-accreditati, auto-nominati, auto-acclamati giudici auto-legittimati a pronunciarsi sulla in-degnità umana alla vita non furono fermati in tempo, appena resero pubbliche le loro intenzioni, o più tardi, quando salivano in piena luce sulla scala del potere? Una delle ragioni principali fu l’ammirazione – in genere tacita, e però fin troppo spesso dichiarata – che le menti più stimate e rispettate del tempo nutrivano per i loro scopi e le loro pratiche: troviamo infatti un’impressionante consonanza tra la ricerca dell’ordine ultimo, totale e perfetto, e il “pensiero progressista” dell’epoca. Qualunque fosse la variante, la modernità dichiarava guerra al disordine della condizione umana; sognava una purezza ultima e la trasparenza dell’ordine sociale – anzi, identificava l’idea di perfezione con l’omogeneità del disegno e l’eliminazione di qualunque suo inquinante. Non voleva rinunciare al logico risultato di un siffatto ideale: la necessità di ridurre drasticamente, o meglio ancora, di risolvere una volta per tutte la questione terribilmente irritante della varietà umana, e di mandare al macello quanti erano colpevoli di rendere irriducibile questa varietà. Per la modernità, l’eliminazione degli elementi deteriori o indegni era un atto di creazione e il mezzo principale per la costruzione dell’ordine, come pure dell’estinzione del caos e della casualità, i due demoni alleati in una guerra di logoramento contro il dio ordine. I visionari nazisti e comunisti non erano selvaggi primitivi che la civiltà moderna non era riuscita o aveva mancato di civilizzare, ma costituivano piuttosto l’avanguardia del suo esercito, che arrivava dove altre unità erano troppo timide, troppo scrupolose, male armate o prive del coraggio che il loro zelo avrebbe richiesto per potersi avventurare. I movimenti fascisti amavano dipingersi come “pronti all’azione”. L’idea abbondava: mancava solo la dose di determinazione necessaria a trasformare le parole in realtà. Come ha illustrato Helen Fein nel suo vasto studio sui genocidi moderni, fra il 1960 e il 1979 si verificarono numerosi casi di genocidi e atrocità affini. Fein ci ricorda il tentato sterminio totale dei curdi iracheni, delle tribù del Sudan del Sud, dei tutsi in Ruanda, degli hutu in Burundi, dei cinesi in Indonesia, degli indù e dei bengalesi nel Pakistan orientale, degli indiani ache in Perù, e di numerose etnie in Uganda. Di alcuni di questi casi sappiamo qualcosa; di altri, poco o nulla. Solo pochi fra noi hanno provato a fare qualcosa per scongiurarli o fermarli (Fein 1993: 6). Quei crimini non erano “affari nostri”, perché erano commessi lontano dalle nostre case e rivolti contro categorie cui nessuno di “noi” apparteneva. Anche se poi, di fatto, erano, almeno in parte, “affari nostri”: i nostri governi – preoccupati del “nostro” agio e benessere, motivati dalla nobile necessità di salvare le
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
146
Shoah, modernità e male politico
nostre fabbriche e i nostri posti di lavoro – continuavano a fornire armi, munizioni e gas tossici per consentire agli assassini di procedere. Götz Aly e Susanne Heim hanno mostrato come la distruzione degli ebrei europei possa essere pienamente compresa solo se vista come uno degli elementi, per quanto centrale, della più generale visione nazista di un’Europa riorganizzata diversamente sotto il profilo geografico, economico ed etnico. Oltre all’estinzione degli ebrei, la visione includeva, come parti ugualmente indispensabili, espulsioni di massa e trasferimenti forzati dei popoli insediati nei luoghi “sbagliati”, cioè in quelli destinati ad altro uso. Al famigerato Abteilung IV D4, istituito nel 1939 e posto sotto il comando di Adolf Eichmann, venne assegnato il compito e il potere di organizzare e portare a termine non solo la “deportazione” degli ebrei, ma anche la ricollocazione di polacchi, francesi, serbi, croati e lussemburghesi. In ogni impresa genocidiaria, come in ogni tipo di persecuzione o discriminazione per categorie, le vittime vengono punite per quello che sono, e per quello che sono sospettate di fare essendo quello che sono – non per quel che veramente fanno o hanno fatto. Una volta messe sotto accusa, la minima infrazione sarà meticolosamente registrata e sommata ai capi d’imputazione, mentre gli atti più esemplari e lodevoli o una condotta quotidiana immacolata non saranno sufficienti a far meritar loro la grazia, e tanto meno il proscioglimento. Non fa differenza che si sottomettano mansuete o si ribellino, che si arrendano o contrattacchino: il verdetto di colpevolezza rimarrà immutato. Sono i loro carnefici e persecutori, e nessun altro (e certamente non le vittime stesse), a decidere chi dev’essere sradicato e deportato, chi ucciso o lasciato morire. Giustamente Frank Chalk e Kurt Jonassohn hanno trovato proprio in questa asimmetria il tratto distintivo del genocidio: secondo la loro formulazione, il genocidio è una forma di massacro unilaterale attraverso il quale uno Stato o un’altra autorità intende eliminare una specifica categoria umana; una categoria che viene scelta unilateralmente e i cui criteri di appartenenza vengono unilateralmente decisi dai perpetratori (Chalk – Jonassohn 1990: 23). Prima che gli esecutori di un atto genocidiario acquistino potere di vita e di morte sulle loro future vittime, devono ottenere il potere di definirle. Questo potere consiste nel negare a priori qualsiasi valore a quel che le persone classificate come “indegne di vivere” fanno o smettono di fare. Il genocidio comincia con la definizione di una classe di “indegni” e continua con la strage della categoria. L’unica colpa di quanti ricadono nella categoria selezionata per lo sterminio è essere stati accusati. E sono i loro accusatori che li giudicano.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Z. Bauman - Male e modernità: tre paradigmi
147
2. C’è un mistero che, forse più di ogni altro, tiene svegli di notte i filosofi morali, e cioè il mistero dell’unde malum: da dove viene il male? Più esattamente, la questione – terribilmente urgente – è quella di capire “Come le persone buone diventano cattive”2, svelando il segreto della misteriosa metamorfosi che trasforma buoni padri di famiglia e premurosi vicini di casa in mostri. Nel XX secolo, gli sforzi di penetrare questo mistero hanno ricevuto un primo potente impulso dalla marea montante dei totalitarismi, si sono moltiplicati in coincidenza delle rivelazioni sull’Olocausto e da allora sono cresciuti in modo esponenziale per la sempre più evidente somiglianza che è venuta a crearsi, dopo l’Olocausto, tra il nostro mondo e un campo minato – in cui si sa che prima o poi ci sarà un’esplosione, ma nessuno può dire dove e quando. Per capire quanto sia scioccante questa evidenza, e quanto siano urgenti le contromisure da prendere, basta portare ad esempio i calcoli dello psicologo Robert J. Sternberg (2004): nei 36.525 giorni del XX secolo, da 100 a 160 milioni di civili hanno perso la vita in un massacro – il che significa una media di più di 3000 morti innocenti al giorno, e il ritmo non è rallentato nel nuovo millennio. Da un punto di vista statistico, osserva dunque Sternberg, l’11 settembre è un giorno normale. Ci vuole molta malvagità per uccidere 3000 civili in un giorno. Quanta ce ne vuole per ucciderne fra i 100 e i 160 milioni? I tentativi di comprendere il suddetto mistero hanno seguito tre piste diverse e, in tutta probabilità, continueranno a seguirle anche in futuro, perché nessuna delle tre traiettorie sembra portare a una stazione finale dove gli esploratori possano riposarsi soddisfatti per aver raggiunto la propria destinazione. Lo scopo dell’esplorazione, dopo tutto, è quello di prendere nella rete della ragione il tipo di fenomeni che Günther Anders ha descritto come “sovra-liminali” (überschwellig): fenomeni che non si possono cogliere e assimilare intellettualmente perché eccedono la misura di qualunque rete sensoriale/concettuale, condividendo perciò il destino del loro apparente opposto, i fenomeni “sub-liminali” (unterschwellig) – abbastanza piccoli e veloci da passare attraverso la più fitta delle reti e svanire prima che possano essere catturati e spediti alla ragione per un reimpiego intelligente. La prima pista (sulla quale sembra procedere ad esempio Jonathan Littell in Le benevole3, con pochi distinguo di carattere secondario) porta a 2 3
È questo il sottotitolo di The Lucifer Effect di Philip Zimbardo (2007). Cfr. Littell 2006, tradotto in inglese da Charlotte Mandell con il titolo di The Kindly Ones. Il titolo originale francese (Les Bienveillantes), come quello della traduzione tedesca (Die Wohlgesinnten), sembra comunicare meglio della tradu-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
148
Shoah, modernità e male politico
sondare e scandagliare le particolarità psichiche (o le profondità psichiche di peculiarità biografiche) scoperte o ipotizzate in individui che notoriamente si sono macchiati di atti di crudeltà o che sono stati colti in flagrante, e che perciò si ritiene superino la media quanto a inclinazione o a entusiasmo nel commettere atrocità quando vengono tentati o quando è loro imposto di farlo. Questa pista era stata tracciata ancora prima che le mostruosità dell’epoca successiva all’Olocausto rivelassero la terribilità delle dimensioni potenziali del problema: ebbe infatti inizio con il memorabile e autorevole studio La personalità autoritaria di Theodor Adorno, che proponeva l’idea di un’auto-selezione, per così dire, dei malfattori, suggerendo che tale auto-selezione fosse determinata da una predisposizione naturale, anziché indotta, dell’individuo. La seconda pista, probabilmente la più ampia e battuta, è stata tracciata sulla linea del condizionamento comportamentale, e ha portato ad esaminare quel tipo di collocazione sociale, o di situazione, che spinge gli individui “normali” – quando si trovano ad agire in circostanze “normali” o comuni – a prendere parte all’esecuzione di atti di crudeltà; o, in altre parole, a studiare le condizioni capaci di risvegliare inclinazioni malvagie che in circostanze diverse sarebbero rimaste sopite. Per gli studiosi che hanno seguito questa traccia, è una società di un certo tipo, e non certi tipi di caratteri individuali, a dover essere messa sul banco degli imputati. Per esempio, Siegfried Kracauer o Hans Speier cercarono nelle file degli Angestellten, gli impiegati che si moltiplicavano senza posa, la fonte della fetida atmosfera morale che favoriva il reclutamento delle forze del male. Quell’atmosfera maleodorante, davvero velenosa sotto il profilo morale, sarebbe stata di lì a poco ascritta, da Hannah Arendt, alle inclinazioni “proto-totalitarie” dei borghesi, al filisteismo e alla volgarità di classi trasformate a forza in masse (e secondo il principio del «Viene prima il cibo, poi la morale», come si espresse in breve Bertolt Brecht). Hannah Arendt – probabilmente l’interprete più autorevole di questa visione radicale, tenacemente avversa alla riduzione dei fenomeni sociali alla psiche individuale – osservò che l’autentico genio fra i seduttori nazisti era Himmler: non essendo un bohémien come Goebbels, né un pervertito come Streicher, un avventuriero come Göring, un fanatico come Hitler o un pazzo come Rosenberg, egli organizzò le masse in un sistema di controllo totale grazie alla (corretta!) intuizione che, nella dezione inglese il significato cercato. Un titolo come The Well-wishers o, ancora meglio, The Benevolent, sarebbe molto più fedele all’intenzione originaria.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Z. Bauman - Male e modernità: tre paradigmi
149
terminante maggioranza, gli uomini non sono né vampiri né sadici, ma lavoratori e padri di famiglia (Arendt 1951: 468-69). Dove la portassero queste considerazioni è testimoniato dal suo Eichmann in Jerusalem. Fra le sue conclusioni, la più citata è la concisa sentenza sulla “banalità del male”. Quel che Arendt intendeva pronunciando quel giudizio è che le mostruosità non hanno bisogno di mostri, le atrocità non richiedono necessariamente delle belve, e che il problema di Eichmann stava precisamente nel fatto che, secondo le valutazioni di eccellenti psicologi e psichiatri, lui (come tanti altri suoi compagni di scelleratezze) non era né un mostro né un sadico, ma era scandalosamente, terribilmente, spaventosamente “normale”. Littell avrebbe seguito almeno in parte questa conclusione, insistendo che Eichmann non era «un robot senz’anima e senza volto» (2006: 550). Fra gli studi più recenti che hanno seguito questa linea, L’effetto Lucifero di Philip Zimbardo, pubblicato nel 2007, presenta un’indagine angosciante e raggelante su come un gruppo di bravi ragazzi e ragazze americani, normali, simpatici e benvoluti, si siano trasformati in dei mostri una volta trasportati in una sorta di “non-luogo”, nel lontano paese dell’Iraq, e incaricati di sorvegliare prigionieri accusati di cattive intenzioni e sospettati di appartenere a una classe inferiore di esseri umani, o addirittura di non essere pienamente umani. Come sarebbe sicuro e confortevole, accogliente e affabile il mondo se fossero solo e soltanto mostri a compiere atti mostruosi. Contro i mostri siamo piuttosto ben protetti, e così possiamo stare tranquilli di essere al riparo dalle malvagità di cui i mostri sono capaci e che minacciano di commettere. Disponiamo di psicologi per individuare psicopatici e sociopatici, sociologi per dirci dove è più probabile che si moltiplichino e che si concentrino, giudici per condannarli alla prigione e all’isolamento, e poliziotti e psichiatri per assicurarci che ci rimangano. Ma, ahimè, quei bravi ragazzi americani normali e simpatici non erano né mostri né depravati. Se non fosse stato loro conferito il potere di spadroneggiare sui detenuti di Abu Ghraib, non avremmo mai saputo (immaginato, fantasticato, congetturato, indovinato) le cose orrende che sono stati capaci di inventare. Non ci sarebbe mai venuto in mente che la ragazza sorridente al bancone potesse eccellere, una volta assegnata oltreoceano, nell’architettare sistemi sempre più ingegnosi e fantasiosi, come pure spietati e perversi, per molestare, tormentare, torturare e umiliare le persone che aveva in custodia. Nella sua cittadina d’origine, come in quelle dei suoi compagni, i vicini ancora oggi si rifiutano di credere che quei cari ragazzi e ragazze, che essi conoscono fin dall’infanzia, siano gli stessi mostri ritratti nelle istantanee delle stanze della tortura di Abu Ghraib. Ma lo sono.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
150
Shoah, modernità e male politico
Philip Zimbardo, concludendo il suo studio psicologico di Chip Frederick, il presunto capo della banda degli aguzzini, ha dovuto riconoscere che: nel suo fascicolo non sono riuscito a scoprire assolutamente nulla che facesse prevedere manifestazioni di comportamento sadico, vessatorio. Anzi, molti elementi suggeriscono che se non fosse stato costretto a lavorare e a vivere in una situazione così anormale, avrebbe potuto essere il soldato americano modello, da pubblicità per il reclutamento. (Zimbardo 2007: 486)
In effetti, Chip Frederick avrebbe passato brillantemente qualunque test psicologico come pure la più accurata indagine della condotta, come si richiede quando si selezionano i candidati per gli incarichi più onerosi e delicati, come quelli dei tutori ufficiali, in uniforme, della legge e dell’ordine. Nel caso di Chip Frederick e di Lyndie England, sua intima e famigerata compagna, si potrebbe ancora insistere (seppur contrariamente ai fatti) che essi abbiano eseguito degli ordini, e siano stati obbligati a impegnarsi in delle atrocità che detestavano e aborrivano: pecorelle, piuttosto che lupi rapaci. Allora l’unica accusa che resterebbe in piedi contro di loro sarebbe quella della codardia, o di un rispetto eccessivo per i superiori; al limite, l’accusa di aver abbandonato troppo facilmente, senza neanche un mormorio di protesta, i principi morali che li avevano guidati nella loro vita “normale” a casa. Ma cosa si deve pensare di quanti stanno al vertice della gerarchia burocratica? Quelli che hanno impartito gli ordini, imposto l’obbedienza e punito le resistenze? Sono quelli, allora, i mostri? L’inchiesta sulle nefandezze di Abu Ghraib non ha mai raggiunto i gradi più alti del comando militare americano; per poter citare in giudizio e processare per crimini di guerra i comandanti, sarebbe stato necessario che essi si trovassero dalla parte degli sconfitti nella guerra che stavano combattendo – ma non è stato così. Adolf Eichmann, invece, che governava gli strumenti e le procedure della “Soluzione finale del problema ebraico” e che dirigeva le operazioni, era dal lato degli sconfitti, era stato catturato dai vincitori e portato nei loro tribunali. C’era quindi l’occasione di sottoporre l’“ipotesi del mostro” all’esame accuratissimo di illustri psicologi e psichiatri. La conclusione finale di quell’approfondita e affidabile analisi fu tutt’altro che ambigua. Eccola, nelle parole di Hannah Arendt: Una mezza dozzina di psichiatri lo aveva dichiarato “normale”, e uno di questi, si dice, aveva esclamato addirittura: “Più normale di quello che sono io dopo che l’ho visitato”, mentre un altro aveva trovato che tutta la sua psicolo-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Z. Bauman - Male e modernità: tre paradigmi
151
gia, tutto il suo atteggiamento verso moglie e figli, verso la madre, il padre, i fratelli, le sorelle e gli amici era “non solo normale, ma ideale”. [...] Ma il guaio del caso Eichmann era che di uomini come lui ce n’erano tanti e che questi tanti non erano né perversi né sadici, bensì erano, e sono tuttora, terribilmente normali. Dal punto di vista delle nostre istituzioni giuridiche e dei nostri canoni etici, questa normalità è più spaventosa di tutte le atrocità messe insieme. (Arendt 1963a: 33-4, 282)
Dev’essere stato davvero il risultato più agghiacciante: se non sono orchi ma persone normali (sarei tentato di dire, “gente come voi e me”) a macchiarsi di atrocità e a essere capaci di agire come sadici depravati, allora tutti i setacci che abbiamo inventato e messo all’opera per isolare i “portatori di disumanità” dal resto della specie umana o si rivelano inutili durante l’uso o sono mal concepiti fin dall’inizio, e, in ogni caso, inefficaci. E così siamo, per farla breve, in-difesi. Potremmo aggiungere: inermi contro la nostra comune “capacità di fare del male”. Ingegnandosi al massimo, e tentando quanto meglio potevano di “civilizzare” i costumi umani e i modelli di convivenza, i nostri antenati erano, per così dire, del tutto fuori strada, e lo stesso vale per coloro che oggi continuano a seguire questo modo di pensare e agire. Leggendo attentamente Le benevole di Littell, ricordato prima, vi si può scorgere una critica implicita all’interpretazione comune, e appoggiata dalla stessa Arendt, della tesi della banalità del male, e cioè che il malfattore Eichmann fosse un “in-cosciente”. Secondo il ritratto che ne fa Littell, Eichmann è tutt’altro che un incosciente esecutore di ordini o uno schiavo delle proprie abiette passioni. «Non era certo il nemico del genere umano che è stato descritto a Norimberga, [...] e non era nemmeno l’incarnazione della banalità del male», ma al contrario «un burocrate di grande talento, molto competente nelle sue funzioni, di grande levatura e con un notevole spirito di iniziativa personale» (Littell 2006: 550). Come dirigente, Eichmann sarebbe certamente un vanto per qualunque stimata azienda europea (incluse le società di proprietà o amministrazione ebraica, si potrebbe aggiungere). Il narratore del romanzo di Littell, il dottor Maximilien Aue, insiste sul fatto che nei suoi numerosi incontri con Eichmann non ha mai notato traccia di pregiudizi personali, e tanto meno di odio violento, nei confronti degli ebrei, che considerava né più né meno come la materia che il suo incarico richiedeva di trattare in un certo modo. A casa come sul lavoro, Eichmann era coerentemente la stessa persona. Il tipo di persona che era quando, per esempio, assieme ai suoi compagni delle SS, eseguì due quartetti di Brahms: «Eichmann suonava con calma, metodico, gli occhi incollati allo spartito; non commetteva errori» (545).
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
152
Shoah, modernità e male politico
Se Eichmann era “normale”, allora nessuno è esente a priori da sospetti. Nessuno dei nostri normalissimi amici e conoscenti; e nemmeno noi. I Chip Frederick e gli Adolf Eichmann camminano sotto gli occhi di tutti per le nostre strade, fanno la fila come noi alle stesse casse nei negozi, riempiono i cinema e le tribune degli stadi, viaggiano sui treni e sugli autobus in città o sono bloccati accanto a noi negli ingorghi nel traffico. Possono essere i vicini di casa, o magari sedere alla nostra tavola. Ciascuno di loro, nelle circostanze opportune, potrebbe fare quel che Chip Frederick o Adolf Eichmann hanno fatto. E io?! Dato che così tante persone possono, almeno potenzialmente, commettere atti efferati, io potrei essere, per un caso, per un mero capriccio del fato, una delle loro vittime. Loro possono farlo – questo è quel che so già. Ma non potrei essere io a diventare altrettanto facilmente uno di loro? Un altro uomo normale che può fare ad altri uomini quel che hanno fatto loro... Traendola dalla terminologia delle reti di spionaggio, John M. Steiner (1980: 431) ha utilizzato in modo figurato la nozione di “agente dormiente” per indicare un’inclinazione personale latente a commettere atti di violenza, o una vulnerabilità personale alla tentazione di parteciparvi – un odioso potenziale che si può supporre presente, ma per lungo tempo invisibile, in particolari individui; un’inclinazione che può (è destinata a?) emergere, o una vulnerabilità che si rivela, solo in condizioni particolarmente favorevoli, presumibilmente una volta che le forze fino ad allora capaci di dominarla vengono improvvisamente indebolite o rimosse. Ervin Staub ha fatto un (enorme) passo avanti cancellando entrambi i riferimenti al “particolare” nella proposizione di Steiner e ipotizzando la presenza di malevoli “dormienti” nella maggior parte, se non in tutti gli esseri umani: «Il male […] commesso dalla gente normale è la norma, non l’eccezione» (Staub 1989: 126). Ha ragione? Non lo sappiamo e non lo sapremo mai, almeno mai con sicurezza, dal momento che non c’è modo di provare o confutare quest’ipotesi per via empirica. Le possibilità non sono poi diverse dai pulcini: si possono contare con certezza solo dopo la schiusa delle uova. Cosa conosciamo con certezza? La facilità «con cui si è potuto istigare comportamenti sadici in individui che sadici non erano» (Haney – Banks – Zimbardo 1973), come scoprì lo stesso Zimbardo in un noto esperimento condotto nel 1971 alla Stanford University con studenti selezionati a caso per il ruolo di “carcerieri” nei confronti di altri studenti, anch’essi scelti a caso, per la parte di “prigionieri”. Oppure, quel che ha trovato Stanley Milgram nei suoi esperimenti a Yale con partecipanti di nuovo scelti a caso, cui veniva chiesto di infliggere ad altri esseri umani quel che credevano fossero delle dolorose scariche elettriche di intensità crescente: e cioè, che
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Z. Bauman - Male e modernità: tre paradigmi
153
l’«obbedienza all’autorità», qualunque autorità, a prescindere dalla natura del comando impartito da quell’autorità, è «una tendenza comportamentale radicata profondamente» (Milgram 1974: 1), persino quando i soggetti trovino disgustose e ripugnanti le azioni che vengono loro ordinate4. Se a questo fattore si aggiungono quei sedimenti di socializzazione pressoché universali che sono gli attributi di lealtà, senso del dovere e disciplina, «gli uomini vengono portati a uccidere con poca difficoltà» (1974: 7). In altre parole, è facile spronare/spingere/sedurre/indurre persone non cattive a compiere delle malvagità. Christopher R. Browning (1992) ha studiato il tortuoso, e invariabilmente sanguinoso, percorso di alcuni uomini appartenenti al Battaglione 101 della Riserva di Polizia tedesca incaricati di partecipare ai massacri degli ebrei in Polonia. Queste persone – che non erano note per atti violenti, e tanto meno omicidi, e non avevano mai dato modo di sospettare che ne fossero capaci – furono pronte (non al 100%, ma in grande maggioranza) a obbedire all’ordine di uccidere: sparare a bruciapelo a uomini, donne, vecchi e bambini, disarmati e ovviamente innocenti, dato che non erano stati accusati di alcun crimine, e che non avevano manifestato la minima intenzione violenta verso di loro o i loro commilitoni. Quel che Browning ha scoperto, tuttavia (e che ha pubblicato sotto l’eloquente titolo di Uomini comuni), è che solo in una percentuale fra il 10 e il 20% i riservisti si dimostrarono «contrari» e «disobbedienti» e chiesero di essere esonerati; e che c’era anche «un nucleo di aguzzini sempre più fanatici che si offrivano volontari per i plotoni d’esecuzione e le pattuglie di “caccia all’ebreo”» (Browning 1992: 175); ma che, in gran maggioranza, i riservisti svolgevano tranquillamente i loro compiti di assassini e bonificatori di ghetti, anche se non cercavano di propria iniziativa occasioni per uccidere. Secondo me, l’aspetto più interessante di questi risultati è la straordinaria somiglianza della distribuzione statistica fra “carnefici zelanti”, renitenti e indifferenti di Browning con quella delle reazioni agli ordini autoritari impartiti ai partecipanti agli esperimenti di Zimbardo e di Milgram. In tutti e tre i casi, alcuni di coloro cui era stato ordinato di commettere crudeltà furono più che solleciti nel cogliere l’occasione di dare sfogo ai loro istinti brutali; altri, più o meno nello stesso numero, si rifiutarono di fare del male in qualsiasi circostanza e qualunque fossero le conseguenze del rifiuto; mentre un nutrito gruppo intermedio era costituito da soggetti indifferenti, poco entusiasti e non particolarmente partecipi o convinti dell’uno o dell’altro estremo dello spettro dei comportamenti: quest’ultimi non si ponevano il problema 4
Per un’analisi completa, si veda Bauman 1989: cap. 6.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
154
Shoah, modernità e male politico
morale, e preferivano invece seguire la linea della minor resistenza possibile, facendo quel che la prudenza dettava, e l’indifferenza permetteva, di fare. In altre parole, in tutti e tre i casi (come in numerosissimi altri campioni di un’ampia serie di studi, di cui queste tre indagini sono considerate esempi straordinariamente illuminanti), la distribuzione delle probabilità di obbedienza o di resistenza all’ordine di usare violenza ha seguito la norma di quel che in statistica si chiama curva gaussiana (altrimenti detta “campana”, distribuzione o funzione gaussiana), considerata il grafico più tipico e comune, vale a dire, “normale”, della distribuzione delle probabilità. Dato che le probabilità delle varie reazioni comportamentali dei soggetti cui è stato ordinato di usare violenza mostrano una chiara tendenza a disporsi in una curva gaussiana, potremmo arrischiarci a supporre che, anche nel loro caso, i risultati siano stati determinati dalla mutua interferenza di un gran numero di fattori indipendenti, ad esempio, ordini dall’alto, rispetto o paura – istintivi o profondamente inculcati – dell’autorità, fedeltà rafforzata dal senso del dovere e dall’abitudine alla disciplina, e altri ancora. Un possibile motivo di ottimismo in questa uniforme oscurità è che sembra plausibile (solo plausibile) che in condizioni di “modernità liquida” – caratterizzata da un rilassamento o da una dispersione delle gerarchie burocratiche dell’autorità, come pure dalla moltiplicazione delle fonti che emettono esortazioni discordanti (i due fattori responsabili dell’indecifrabilità crescente e dell’udibilità calante di queste voci) – altri fattori, più individuali, idiosincratici e personali, come ad esempio il carattere delle persone, possano giocare un ruolo di importanza crescente nella determinazione di una linea di condotta. Se fosse così, l’umanità degli umani potrebbe vincere. E tuttavia, l’esperienza comune ha finora offerto scarsissime ragioni per essere ottimisti. Come ha osservato Winfried George Sebald, «la disgrazia di cui siamo noi stessi causa non può insegnarci nulla», e «continuiamo ad avanzare, incorreggibili, su piste battute che si ricollegano – appena accennate – all’antica rete di comunicazione» (Sebald 1999: 72). Inclini come siamo, per natura o educazione, a cercare di trovare la via più breve per gli scopi che perseguiamo e che crediamo valga la pena di perseguire, le “disgrazie” (e in particolare quelle patite dagli altri) non ci sembrano un prezzo troppo alto da pagare per accorciare la strada, abbattere i costi e aumentare gli effetti. 3. Finora abbiamo sommariamente descritto e confrontato due delle piste lungo le quali si è di recente inoltrata la ricerca di una risposta al mistero
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Z. Bauman - Male e modernità: tre paradigmi
155
dell’unde malum. C’è tuttavia anche una terza pista, che merita di essere chiamata “antropologica” per l’universalità e la perennità degli elementi che chiama in causa e impiega nell’intento di capire; una pista che col passare del tempo sembra diventare sempre più promettente, proprio quando le altre due descritte prima sembrano aver esaurito il loro potenziale cognitivo. Se ne potrebbe intuire la direzione dallo studio di Sebald; e tuttavia era già stata tracciata prima da Günther Anders, in un saggio autorevole – ma trascurato o ignorato per decenni – sul fenomeno della “sindrome di Nagasaki”, cui Anders imputa un micidiale potenziale “globocida”. «La sindrome di Nagasaki», come scrive Anders, significa che «quel che è stato fatto una volta può essere ripetuto ancora, con sempre minori riserve»; e ad ogni reiterazione, con sempre più «pragmatismo e disinvoltura, e sempre meno ponderazione e ragioni». «La reiterazione delle atrocità non solo è possibile, ma probabile, dato che le possibilità di vincere la guerra per prevenirle si assottigliano, mentre quelle di perderla, crescono» (Anders 1964). La decisione di sganciare le bombe atomiche su Hiroshima il 6 agosto 1945 e, tre giorni più tardi, su Nagasaki venne ufficialmente giustificata, ex post facto, dal bisogno di anticipare la capitolazione del Giappone, in modo da salvare un numero non calcolato di vite americane che sarebbero andate assai probabilmente perse se l’esercito americano avesse dovuto invadere l’arcipelago giapponese. La giuria della Storia è ancora riunita, ma la versione ufficiale del motivo che giustifica la meschinità e la malvagità del mezzo in riferimento alla grandiosità e alla nobiltà del fine è stata recentemente messa in dubbio da storici americani, che hanno esaminato la documentazione da poco svincolata dal segreto di Stato sulle circostanze in cui il provvedimento venne valutato, deciso e messo in atto – cosa che permette di mettere in discussione la versione ufficiale anche sulla base dei fatti, e non solo dal punto di vista morale. Come affermano coloro che criticano la versione ufficiale, il governo giapponese era già pronto a capitolare circa un mese prima che la prima bomba atomica fosse sganciata, e per deporre le armi aspettava solo due assicurazioni: che Truman permettesse all’esercito sovietico di unirsi a quello americano nella guerra contro il Giappone, e che gli Alleati si impegnassero a tenere l’imperatore sul trono dopo la resa del Giappone. Truman, tuttavia, prese tempo. Aspettava i risultati del collaudo delle prime bombe atomiche, che si doveva tenere ad Alamogordo, nel New Mexico, dove si davano i ritocchi finali per l’evento. Le notizie dell’esito arrivarono il 17 luglio a Potsdam: il test non era semplicemente riuscito, ma aveva polverizzato ogni più audace aspettativa... Non volendo sprecare una tecnologia così costosa, Truman cominciò a temporeggiare. Si può facilmente dedurre quale fosse il vero motivo del
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
156
Shoah, modernità e male politico
suo atteggiamento dal trionfale discorso presidenziale pubblicato sul New York Times il giorno seguente al massacro di centomila persone a Hiroshima: «Abbiamo fatto la scommessa scientifica più audace della Storia, una scommessa da due miliardi di dollari: e abbiamo vinto». Non si potevano certo sprecare due miliardi di dollari, no? Se l’obiettivo originario fosse stato raggiunto prima che si fosse potuto sperimentare il prodotto, si sarebbe dovuto trovare subito un altro scopo per preservare o restituire alla spesa la sua “ragione economica”. Il 16 marzo 1945, quando la Germania nazista era già in ginocchio e la rapida fine della guerra era ormai fuor di dubbio, Arthur “Bomber” Harris mandò 225 bombardieri Lancaster e 11 caccia Mosquito a scaricare 289 tonnellate di esplosivi e 573 tonnellate di materiale incendiario su Würzburg, una città di medie dimensioni con 107.000 abitanti, ricca di storia e di tesori d’arte ma di scarso rilievo industriale. Tra le 21.20 e le 21.37 furono uccisi circa 5000 abitanti (di cui il 66% erano donne e il 14% bambini), e vennero incendiate 21.000 abitazioni: solo 6000 persone ritrovarono un tetto sulle loro teste quando gli aerei se ne furono andati. Hermann Knell (2003: 25, 330-31), che ha calcolato le cifre citate attraverso una scrupolosa indagine d’archivio, si è chiesto perché una città del tutto priva di qualunque importanza strategica (opinione confermata, anche se per via indiretta, dal fatto che non vi sia alcuna menzione del nome della città nella storia ufficiale della RAF, che elenca meticolosamente anche i minimi successi strategici delle forze aeree) fosse stata scelta per essere distrutta. Dopo aver preso in esame e scartato una a una tutte le possibili motivazioni, Knell si è trovato di fronte all’unica risposta sensata alla sua domanda, e cioè che Arthur Harris e Carl Spaatz (comandante delle forze aeree americane in Gran Bretagna e in Italia) all’inizio del 1945 si fossero ritrovati a corto di obiettivi: I bombardamenti proseguivano come era stato programmato senza considerare il mutamento della scena militare. La distruzione delle città tedesche continuò fino alla fine di aprile. Evidentemente, una volta che l’apparato militare era stato messo in moto, non poteva essere fermato. Aveva una vita propria. Tutto l’equipaggiamento e i soldati erano ora disponibili. Dev’essere stato questo a far decidere a Harris di far attaccare Würzburg... (Knell 2003: 330)
Ma perché proprio Würzburg? Solo per ragioni di convenienza. Come voli di ricognizione precedenti avevano mostrato, «la città poteva essere localizzata facilmente con gli strumenti elettronici disponibili all’epoca», ed era sufficientemente distanziata dalle truppe alleate che avanzavano per ridurre il pericolo di un altro caso di “fuoco amico” (e cioè di bombarda-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Z. Bauman - Male e modernità: tre paradigmi
157
mento su truppe proprie). In altre parole, la città era «un bersaglio facile e privo di rischi». Questa fu la colpa involontaria e inconsapevole di Würzburg, un tipo di colpa per cui nessun “bersaglio” sarebbe mai stato risparmiato una volta che «la macchina militare si fosse messa in moto». Ne La violenza nazista: una genealogia, Enzo Traverso (2002) propone il concetto di “potenziale barbarico” della civiltà moderna. In questo saggio dedicato alla violenza nazista, Traverso giunge alla conclusione che le atrocità naziste furono uniche solo nel senso che condensarono un gran numero di mezzi di asservimento e annientamento che erano già stati sperimentati, anche se separatamente, nella storia della civiltà occidentale. Le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki indicano che il contro-illuminismo non costituisce una premessa indispensabile per i massacri tecnologici e che l’umanità non è al riparo da una ripetizione di tali catastrofi. Sia la bomba atomica sia i campi nazisti si inscrivono nel “processo di civilizzazione”, in seno al quale non agiscono come una controtendenza e non sono un’aberrazione [...], ma l’espressione di una delle sue potenzialità, di uno dei suoi volti, di una delle sue derive possibili. (Traverso 2002: 182)
Traverso termina la sua indagine con un monito: non c’è alcuna base per escludere la possibilità di altre “sintesi” in futuro, non meno sanguinarie di quella nazista. L’Europa liberale e civilizzata del XX secolo ha dimostrato di essere, dopo tutto, un laboratorio di violenza. E io aggiungerei che all’alba del XXI secolo non ci sono segni che quel laboratorio abbia cessato di operare e sia stato chiuso. Günther Anders (1964) si chiede se, in questa età delle macchine, noi non siamo forse relitti del passato che non sono ancora riusciti a scuotersi di dosso i residui tossici delle passate atrocità. E risponde che gli orrori in questione furono commessi allora non perché fossero ancora praticabili (o non fossero stati ancora sradicati), ma al contrario, furono commessi già allora, perché già allora erano divenuti accettabili e possibili. Per riassumere: ci deve essere stato un “primo momento” in cui le atrocità tecnologicamente assistite, fino ad allora inconcepibili, sono diventate praticabili; l’orrore deve aver avuto un punto di inizio; ma non ne segue che debba avere anche una fine. Non ne segue che sia in visita presso il consorzio umano solo per breve tempo, e ancora meno che porti con sé o metta in moto le dinamiche che ne dovrebbero causare prima o poi la partenza. È piuttosto il contrario: una volta che venga messa in opera, la trappola che permette di separare i mezzi tecnologici dall’immaginazione morale diventa semovente, in grado di alimentarsi e rinforzarsi autonomamente. Le è sufficiente la capacità umana di adattarsi, abituarsi, adeguarsi,
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
158
Shoah, modernità e male politico
cominciando oggi dal punto in cui si era arrivati ieri, e insomma reimpiegando ciò che ieri era impensabile nella realtà delle cose di oggi. In altri termini, l’orrore non si condanna da solo, e non si auto-distrugge. Al contrario, si riproduce: quel che una volta era lo scarto inaspettato e terrificante del fato e una violenta emozione (una scoperta impressionante, una rivelazione orribile) degenera nella routine di un riflesso condizionato. Hiroshima fu uno shock dagli echi assordanti e apparentemente inestinguibili. Tre giorni più tardi, Nagasaki non lo era già più, e gli echi furono scarsi, se ce ne furono. Uno dei meccanismi di questa assuefazione anestetizzante è stato indicato da Joseph Roth: Quando scoppia una catastrofe, i vicini, sconvolti, si dimostrano soccorrevoli. Tale è l’effetto di gravi catastrofi. Sembra che gli uomini sappiano che le catastrofi non durano a lungo. Le catastrofi croniche, invece, sono così mal sopportate che delle loro vittime non importa più niente a nessuno, quando addirittura non sono vissute come qualcosa di molesto […]. Se però la follia dura a lungo, le braccia soccorrevoli si paralizzano e si spegne il fuoco della misericordia. (Roth 1927: 120-21)
In altre parole: una catastrofe di lunga durata apre la strada alla propria continuazione consegnando lo shock e la commozione iniziale all’oblio, e così logorando e fiaccando la solidarietà umana verso le sue vittime – e quindi minando la possibilità di unire le forze per evitarne altre.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
159
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
ALBERTO BURGIO
IL CONFLITTO TRA MORALI NELLA GERMANIA NAZISTA
Jamais on ne fait le mal si pleinement et si gaiement que quand on le fait par conscience. Blaise Pascal, Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets
1. L’«enigma» del consenso Un dato di fatto, assodato da diversi decenni, è che gli avvenimenti che caratterizzarono la tragica storia della Germania di Hitler non scaturirono esclusivamente dalle decisioni dei capi politici e militari del regime né chiamarono in causa soltanto le autorità, le istituzioni o l’establishment. Da un cinquantennio (dalla ricerca di Raul Hilberg sulla distruzione dell’ebraismo europeo) e in particolare dagli anni Settanta, grazie ai contributi degli storici sociali della Alltagsgeschichte (Kershaw 1989; Berg 2003) la storiografia viene documentando che quanto accadde in Germania sin dalla fase preparatoria della conquista del potere da parte di Hitler non si potrebbe comprendere senza considerare il consenso e la partecipazione (in forme che vanno dall’accettazione passiva all’intervento diretto nelle pratiche genocidiarie) di gran parte dei tedeschi (e, in minor misura, delle popolazioni di alcuni Paesi annessi, alleati o occupati, a cominciare dall’Austria, dall’Italia e dalla Francia di Vichy). È ormai convinzione condivisa che l’esercizio del potere nel nazismo coinvolse anche una dinamica egemonica, suscitando una vasta adesione emotiva, ancor prima che ideologica, al progetto di trasformazione sociale e politica della Germania e dell’Europa posta sotto il dominio tedesco. E che non sarebbe possibile capire il nazismo senza intendere la logica del comportamento degli «uomini comuni». Se questo è vero, uno degli «enigmi» che fronteggiano gli storici del nazismo può essere formulato riprendendo un’espressione di Harald Welzer: si tratta di comprendere come «una società a maggioranza psichicamente normale» (Welzer 2007: 112)1 abbia potuto prendere parte ai processi di emar1
Cfr. anche Welzer 2005.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
160
Shoah, modernità e male politico
ginazione, persecuzione, deportazione e sterminio di milioni di esseri umani, sostenendoli con un consenso crescente almeno sino al 1941. In questione è la disponibilità di una grande massa di persone «normali» («per bene») a seguire e sostenere un regime criminale, e a farsi coinvolgere nella sua violenza estrema e sistematica, sino a partecipare in prima persona alle atrocità da esso pianificate e dirette (Frei 2001: 181; Browning 1992). Come si può spiegare questa disponibilità? Che cosa determinò o permise il «consenso genocidiario» (Koonz 2003: 15) di buona parte della popolazione tedesca? E come fu possibile tale consenso, posto che quella violenza contraddiceva in radice principi e valori che non solo esteriormente avevano regolato (e continuavano, in parte, a regolare) la vita privata e pubblica della società tedesca? Queste domande appaiono ancora più ineludibili alla luce di quanto Erich Fromm osservò mentre la Seconda guerra mondiale era ancora in corso. Se è vero che «una parte della popolazione si è inchinata al regime nazista [...] senza ammirare l’ideologia e la prassi politica naziste» – senza, cioè, condividere realmente la delirante costruzione ideologica del suo capo –, il fatto che la maggior parte di questo popolo si sia lasciata trasformare, «senza opporre una forte resistenza» (Fromm 1941: 182), nel complice di feroci assassini sollecita spiegazioni tanto più urgenti2. 2. Questioni morali Senza pretendere di fornire con ciò una risposta esauriente (l’unica certezza fornita dalla ricerca storica è che qualsiasi spiegazione monocausale risulta inadeguata), molte ragioni inducono a ritenere cruciale – per quanto paradossale tale affermazione possa apparire – il tema morale. Nel suo libro sul consenso di massa nel nazismo, Ian Kershaw ha sottolineato la corrispondenza tra quanto il regime prometteva e faceva e i «valori sociali o politici» radicati nel senso comune (Kershaw 1991: 114-15). Ma non si trattò soltanto di questo. Anche la sfera interiore fu mobilitata dalla propaganda (che un medico arrivò a definire «una salutare risposta al diffuso bisogno di forme di psicoterapia suggestiva»; Cocks 2
Il che naturalmente non implica ignorare l’incidenza del terrore procurato dalla violenta repressione esercitata dal regime lungo tutto l’arco della sua esistenza, e rivolta dapprincipio proprio contro il dissenso politico e le organizzazioni della sinistra operaia: cfr. Frei 2001: 45, 136, che insiste sul nesso tra consenso e terrore. Sull’esigenza di problematizzare il tema della coercizione e del terrore in rapporto al consenso di massa in epoca nazista insiste Ian Kershaw (2009), suggerendo di non considerare questi elementi in termini immediatamente oppositivi; cfr. Burgio 2013a: 36-7.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Burgio - Il conflitto tra morali nella Germania nazista
161
1985: 82) e a rendere vittoriosa l’ideologia nazista fu proprio il fatto che «essa poteva allacciarsi a ideali dell’Io già formati» (Mitscherlich – Mitscherlich 1967: 28). Com’è stato osservato, grandi sforzi vennero profusi dai nazisti, anche al massimo livello, per fornire una legittimazione giuridica e una «giustificazione morale della loro attività omicida» e «mettere a tacere scrupoli o riserve» (Fritzsche 2008: 201)3. Benché la loro azione si traducesse molto spesso in atti criminali, il consenso coinvolse in larga misura anche la sfera morale, il che sembra confermare il ruolo chiave svolto nella violenza politica di massa dalla «certezza soggettiva di possedere una morale forte, data da Dio» (Mitscherlich – Mitscherlich 1967: 171). E dipese dalla capacità del regime di presentare i propri obiettivi e le stesse pratiche sterminatrici, a cominciare dalla Aktion T44, come azioni eticamente connotate e legittime. Coglieva insomma nel segno Otto Dietrich zur Linde, il vicecomandante del fantomatico campo di Tarnowitz creato dalla fantasia di Jorge Luis Borges, nel definire con orgoglio il nazismo, «intrinsecamente, un fatto morale» (Borges 1949: 833). Il «Nuovo ordine europeo» frutto della vittoria del Terzo Reich non avrebbe soltanto cementato una gerarchia «razziale», ma anche dato alla luce una nuova e superiore umanità, insensibile alla violenza e temprata ai rigori di un’«epoca implacabile» (836-37). Con ciò non si tratta certo di escludere altri elementi, non meno influenti. Convinzioni e principi morali non esauriscono in generale l’ambito delle motivazioni consapevoli e inconsce delle azioni umane. Nel caso specifico della Germania nazista incisero diversi altri moventi, a cominciare dal cinismo, dalla paura e dall’opportunismo. La persecuzione di oppositori e minoranze, l’occupazione di territori e la sottomissione di intere popolazioni offrivano grandi opportunità e cospicui vantaggi materiali. Non per caso le delazioni alla Gestapo erano perlopiù motivate da ragioni d’interesse personale (Gellately 2001). L’«arianizzazione» dell’economia tedesca procurò posti di lavoro e avanzamenti di carriera, e consentì a molti di acquisire a prezzi di realizzo la proprietà di imprese commerciali o industriali. Le aste dei beni ebraici confiscati permisero a tante madri di famiglia di conclude3 4
A proposito degli aspetti giuridici, si veda Frei 2001: 33, 37, 58, 62 ss. Cfr. Klee 1985: emblematica in proposito la tesi argomentata dal teologo cattolico Hans Mayer nella sua Gesetzliche Unfruchtbarmachung Geisteskranker (La sterilizzazione dei malati di mente), dotata di imprimatur da parte dell’autorità ecclesiastica: posto che «ogni singola persona si rapporta alla comunità come la parte rispetto al tutto», «se una persona è pericolosa per l’intera comunità e può rappresentare per essa una minaccia, è onorevole e sano ucciderla al fine di preservare il bene comune» (Mayer 1927: 45).
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
162
Shoah, modernità e male politico
re affari decisamente lucrosi5. Un ruolo importante svolse anche la boria nazionalistica (nutrita da risentimento e vittimismo a seguito della sconfitta nel primo conflitto mondiale, che parve a molti tedeschi un’«ingiustizia» nella misura in cui frustrò le «legittime» aspirazioni della Germania a mettersi al passo con le altre grandi potenze occidentali; Stierlin 1975: 139), e altrettanto influirono la recente esperienza del colonialismo tedesco (nelle leggi anti-meticciato del 1905-07 l’espressione «tradimento razziale» sanzionava le relazioni sessuali tra coloni tedeschi e soggetti colonizzati6) e il diffuso etnocentrismo razzista (in specie antisemita) che, del resto, costituì uno dei cardini della «nuova morale» nazista. Né – come vedremo – si possono escludere moventi inconsci, radicati nell’«anima tedesca» e tendenzialmente trascurati dalla storiografia, come se le dinamiche psichiche influenti nella vita quotidiana individuale e collettiva cessassero di operare e di produrre conseguenze allorché i fatti divengono eventi storici. La caduta del senso critico nelle dinamiche di massa, l’efficacia dei miti di gruppo, le conseguenze della fuga da una libertà inconsapevolmente percepita come schiacciante deresponsabilizzazione e l’incidenza dei «demoni dormienti della fantasia inconscia» – per fare solo qualche rapido cenno ad alcuni temi focalizzati dalla ricerca psicoanalitica in relazione all’esperienza del nazismo7 – rimangono questioni aperte che sarebbe sbagliato accantonare o enucleare dal complesso dell’analisi storica. Un interrogativo è, nondimeno, se queste ragioni possano da sole spiegare il comportamento della grande maggioranza della popolazione e il consenso diffuso e duraturo che consentì al regime di praticare politiche criminali di inaudita violenza. Un consenso del genere (quando si tratta di repressioni massicce e feroci, di deportazioni e uccisioni di massa, di guerre di aggressione e stermini pianificati) difficilmente potrebbe non coinvolgere «un qualche senso morale» (Welzer 2007: 194) e non armonizzarsi con principi e valori diffusi, per trarre da questi legittimazione e incoraggiamento. Da questo punto di vista la tesi centrale dell’analisi 5
6 7
Fritzsche (2008: 245) indica in 30.000 il numero di carri-merci impiegati per trasportare in Germania i beni requisiti ai soli ebrei dei paesi dell’Europa occidentale occupati; sui vantaggi che il regime procurò alla popolazione (in particolare alle famiglie dei militari impegnati nel conflitto) amministrando oculatamente il gettito fiscale, i beni ebraici e le derrate alimentari confiscate alle popolazioni sottomesse, cfr. Aly 2005; ma sulla provenienza delle risorse cfr. le discordanti deduzioni di Tooze 2007. Cfr. Koonz 2003: 176, 319; Zimmerer 2011. Cfr., tra i molti studi, Money-Kyrle 1941; Mitscherlich – Mitscherlich 1967; Stierlin 1975.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Burgio - Il conflitto tra morali nella Germania nazista
163
di Zygmunt Bauman, secondo cui lo sterminio sarebbe stato il risultato dell’autonomizzarsi della razionalità tecnica dai vincoli morali, non fa che riproporre il problema, poiché assume come un dato quella «irrilevanza delle norme morali» (1989: 147) tradizionali che dev’essere indagata nei suoi presupposti e nella sua concreta fenomenologia. 3. Una rivoluzione etica Sembra dunque del tutto verosimile che, lungi dall’essere oggetto di rimozioni o tabù, nella Germania nazista «la moralità delle scelte fosse un tema-chiave nella vita intellettuale dei cittadini» (Fritzsche 2008: 19). Molti indizi si direbbero confermare la tesi di Hannah Arendt secondo la quale il regime realizzò una vera e propria rivoluzione etica, che preparò i tedeschi a una guerra razzista ben prima dell’intervento dei battaglioni addetti al genocidio e dell’istituzione dei campi di sterminio8. Può non suscitare grande interesse che dal questionario di Theodore Abel (1934) risultasse il primato delle ragioni morali ed etiche (dell’idealismo, della ricerca di senso, della fede nel Volk) tra i motivi di adesione al Partito nazionalsocialista da parte degli «alte Kämpfer» (i militanti della prima ora; Koonz 2003: 27-8). Indubbiamente significativo è invece che, nell’applicare le misure eugenetiche, attivisti politici e professionisti della sanità pubblica ritenessero di «agire con il più elevato idealismo nell’interesse del popolo tedesco» e di «obbedire alle leggi fondamentali della storia» promuovendo la «rigenerazione» fisica e morale della comunità popolare (Fritzsche 2008: 84; Lifton 1986: 50 ss.). Non la neutralità del relativismo etico, tipico di una visione scientistica della realtà, portò agli stermini di massa, bensì «una visione iper-morale del mondo», caratterizzata dalla distinzione manichea tra bene e male, propria delle morali religiose (Forti 2012: 170-71). Le stesse teorie razziste veicolavano prepotentemente il senso delle antiche distinzioni morali (ibid.), unitamente a più o meno sofisticate teleologie. In una lettera di un ispettore di polizia gli stermini sono emblematicamente definiti un obbligo verso la storia, che va sopportato per offrire ai figli «un futuro migliore» (Fritzsche 2008: 194). L’insistito richiamo alla vita (al valore del normotipo biologico da preservare e consolidare anche a mezzo della disinfestazione del corpo 8
Cfr. Arendt 1965-66: 8; a sua volta Fritzsche 2008: 87 parla di una «rivoluzione spirituale» tesa a inculcare una «coscienza nazista» e a creare uomini e donne nuovi.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
164
Shoah, modernità e male politico
della comunità da ogni agente patogeno) si inscriveva in un quadro dualistico connotato in chiave morale. Come nella tradizione classica, anche nell’«umanesimo» nazista – del quale l’opera di Hans Günther rappresentò un’espressione tra le più influenti – la vita è il bene (il luogo dell’identità di essenza e apparenza, e dell’armonia di anima e corpo e di ragione e passione) e la sua difesa implica e giustifica lo sterminio delle forme deteriori, de-umanizzate e identificate con la morte e con il male (Forti 2012: 184, 202, 206). Di particolare interesse appare il nesso operativo che in questo contesto si instaura tra morale e violenza. Con ogni probabilità, proprio la connotazione (paradossalmente) morale delle pratiche discriminatorie e persecutorie permise di liberare una violenza estrema, senza remore né limiti9. I roghi di libri vennero giustificati dagli studenti universitari nazisti come misure di «purificazione morale» (Koonz 2003: 135). Descrivendo i milioni di soldati comuni che arrivavano al fronte pronti a uccidere a freddo i «nemici razziali» (in gran parte bambini, anziani e donne inermi), Omer Bartov osserva che «i valori morali che questi giovani avevano interiorizzato prima del loro reclutamento» ne condizionavano le reazioni al fronte, e che «la creazione di questo consenso tra le truppe fu probabilmente il successo più significativo colto dagli sforzi pedagogici del regime nazista» (Bartov 1991: 7, 148). In tal senso (senza con ciò ritenere risolto una volta per tutte il problema della consapevolezza dei carnefici nazisti in merito alla natura criminosa delle proprie azioni; cfr. Burgio 2013b, 2014) appare fondata l’idea secondo cui la visione del mondo del Terzo Reich andrebbe «interrogata come una morale, anzi un’iper-morale», prendendo sul serio «le intenzioni “virtuose” dei tanti perpetratori» che si percepirono «come esecutori di una suprema legge morale, che li spingeva ad agire in conformità con quell’imperativo» (Forti 2012: 169). Così come non andrebbe liquidato alla stregua di un semplice espediente retorico l’argomento di Carl Schmitt secondo cui – essendo il Führer il giudice supremo e insindacabile, l’incarnazione stessa della giustizia – il regime uccideva nel nome della moralità (Schmitt 1934: 945-50). In questo quadro si inscrive la costante attenzione riservata dal nazismo ai metodi e ai modelli pedagogici. La scuola fu incaricata di creare nientemeno che «idee diverse su ciò che era morale» (Fritzsche 2008: 93), dando seguito ai progetti pedagogici ripetutamente enunciati dal Führer (Miller 1990). Già nel Mein Kampf Hitler aveva avvertito che «lo Stato 9
Sui devastanti effetti «liberatori» del «rovesciamento della coscienza» provocato dagli appelli a «sacrificare la vecchia coscienza» e dal «permesso di compiere misfatti aggressivi» (onde «ciò che ieri era ancora crimine ha preso il valore di una convinzione eroica, di esecuzione del “volere della Provvidenza”»), cfr. Mitscherlich – Mitscherlich 1967: 61, 279.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Burgio - Il conflitto tra morali nella Germania nazista
165
etnico deve assolvere il più gigantesco compito educativo», il quale «un giorno apparirà come un’azione ancor più grande delle più eroiche vittorie belliche». Parlando a 45.000 militi delle SA riuniti a Kiel il 7 maggio 1933, Hitler ribadisce: «Abbiamo conquistato il potere, nessuno può resisterci. Ora dobbiamo educare il popolo tedesco per questo Stato [...]. Dobbiamo combattere la battaglia per i cuori e l’interiorità della Germania» (Koonz 2003: 105, 84). E, rivolgendosi alla Hitlerjugend (Norimberga, 1935), conferma: «Dobbiamo educare un nuovo tipo umano, in modo da preservare il nostro popolo dai sintomi dell’odierna degenerazione» (Koonz 2003: 160). Il fuoco della lotta ideologica per una nuova moralità nella scuola e nell’università (la «innere Gleichschaltung») è il contrasto dell’individualismo nel nome dell’interesse collettivo. In gioco è l’affermazione di una rinnovata nozione di dignità umana, incentrata sull’appartenenza alla comunità10, non certo sul valore dei singoli né, tanto meno, sulle sorti di un genere umano la cui unità viene negata in radice. 4. I nuovi «valori» In definitiva, il tema morale appare ineludibile e centrale per la semplice ragione che è qui sistematicamente in gioco la violenza. Lo sforzo di legittimare le politiche criminali del regime implicò l’elaborazione di una nuova etica, tesa a «preparare i tedeschi ad accettare quella che nell’etica universale o cristiana sarebbe stata considerata un’attività criminale» (Fritzsche 2008: 91). E spesso determinò un conflitto tra codici morali alternativi, teso a sancire il primato – certo contrastato e problematico – di un nuovo codice capace di neutralizzare i dettami della morale tradizionale e di trasfigurare comportamenti normalmente considerati meritevoli di sanzione morale (fonti di sentimenti di colpa e vergogna). Sul piano ideale, tale conflitto vide contrapporsi alla morale tradizionale («universalistica», benché in modo astratto e contraddittorio11) una nuova morale etnocentrica e razzista («völkische»). Modellata dal nazismo in funzione dei propri obiettivi politico-sociali e geopolitici, intessuta di «valori» correlati alla superiorità «razziale» dello Herrenvolk, questa morale, segnata 10 11
Cfr. Koonz 2003: 133; sui libri di scuola e il modo in cui inculcano l’ideologia nazista della selezione dei migliori e dell’esclusione degli estranei, cfr. 145-46. Sul “controcanto” comunitarista e in nuce razzista che accompagna sin dal basso medioevo la costruzione della civitas christiana, fondata sulla esclusione e deumanizzazione di eretici e infedeli (ebrei in primis) si vedano i fondamentali studi di Todeschini 2002, 2007.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
166
Shoah, modernità e male politico
da un estremismo comunitarista, ebbe il compito di legittimare pratiche discriminatorie e persecutorie sino allo sterminio, commisurando il giudizio morale all’identità di coloro con i quali si è di volta in volta in relazione. Vedremo come in molti casi lo scontro tra codici abbia provocato una scissione della coscienza dei tedeschi12, che mobilitò una complessa fenomenologia psichica (meccanismi di razionalizzazione, proiezione, diniego e derealizzazione). Per il momento, soffermiamoci su alcuni valori-chiave dell’etica nazista, avvertendo che sarebbe impossibile fornirne in questa sede un catalogo completo. Un primo nucleo valoriale attiene naturalmente all’ethos militare. L’etica nazista valorizza l’onore e l’eroismo, evoca con insistenza l’importanza dell’ordine, della lealtà e dell’obbedienza (sulla quale torneremo); del disinteresse e della sobrietà; del dovere dinanzi alla «comunità», della purezza e della fedeltà assoluta al Volk (e alla Patria e alla famiglia); e afferma il valore supremo del sacrificio («non sei niente, il tuo Volk è tutto»; «il tuo corpo non appartiene a te, ma al tuo Volk»13) e della virilità (la necessaria durezza contro il fatuo «sentimentalismo umanitario»). Questi valori (sui quali la retorica hitleriana batte costantemente) contribuiscono a costruire l’immagine dello stesso Hitler (modesto e sobrio, mite e paterno, normale e pacifico, impegnato nella riconciliazione interclassista della «comunità»), procurando al regime anche il consenso dei settori meno ideologizzati (e potenzialmente ostili alla violenza estremistica delle SA e delle SS; Koonz 2003: 17 ss., 42-5, 75-9). Sulla base di una siffatta morale eroicizzante si sviluppa, nella fase conclusiva del conflitto, il tema del presidio della civiltà europea minacciata dalle orde asiatiche: come ricorda Peter Fritzsche, autore di uno dei più importanti contributi storiografici degli ultimi anni, dopo Stalingrado sia i soldati che i civili considerarono sempre più se stessi eroici difensori della civiltà europea contro la Russia e la tirannide comunista (Fritzsche 2008: 265). L’effetto complessivo di questo nuovo codice fondato sulla logica amico/nemico (Volkskameraden/Volksfeinde) è il ribaltamento dei tradizionali criteri di giudizio: una reale «trasvalutazione di tutti i valori». Gli uomini nuovi debbono essere spietati, freddi come il ghiaccio, dotati di «saldezza di nervi» nel commettere carneficine e nel guardare in faccia «l’inumanità». Il «coraggio» coincide con la capacità di colpire senza remore gli iner12
13
Di «scissione della coscienza» parlano in proposito, tra gli altri, Alexander e Margarete Mitscherlich, osservando come solo tale processo possa consentire di «trattare problemi sociali nello stile della Endlösung» compiendo al tempo stesso «un’agevole transizione alla “vita quotidiana”» (Mitscherlich – Mitscherlich 1967: 22). Cfr. Koonz 2003: 145, 147.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Burgio - Il conflitto tra morali nella Germania nazista
167
mi nel nome del Volk (Koonz 2003: 67-8); l’«eroismo», con la totale sottomissione (Jesi 19952: 152-53); l’«integrità» e la lealtà verso l’universale, con l’imperturbabilità al cospetto delle cataste di cadaveri (per riprendere il famigerato discorso di Himmler a Posen, l’odierna Poznań; Himmler 1943). Tratto caratteristico dell’identità tedesca, la spietatezza favorisce l’avanzamento di carriera. Naturalmente non si tratta di essere spietati con tutti (nello scagliarsi contro i «sentimentalismi» e «ogni pensiero compassionevole», Hitler afferma di volere «avere compassione» per il popolo tedesco; Fritzsche 2008: 200), ma nei confronti degli estranei, debitamente de-umanizzati14. Nei loro riguardi occorre immunizzarsi dal «sentimentalismo» e dall’«umanitarismo affettato», facendo spazio a un «corretto umanitarismo biologico»15. Si tratta di «guarire» dall’empatia, per dirla con Wantzen, compiaciuto del fatto che, «a seguito degli avvenimenti a est», il popolo tedesco si è finalmente liberato dal vecchio «sentimento di simpatia totalmente umanitario» (Fritzsche 2008: 241). Così configurata, la morale incontra la religione, un cristianesimo riletto in chiave socialdarwinistica e razzista. Nel 1933 Achim Gercke, funzionario del ministero dell’Interno, afferma, nel corso di un’udienza generale, che «la volontà della natura è la volontà di Dio, e la natura sta dalla parte del forte, del buono, del capace, separando il grano dal loglio»: nel combattere per la purezza del proprio sangue, i nazisti non fanno che «obbedire al suo comandamento»; a sua volta il teologo Gerhard Kittel ridicolizza l’empatia con gli ebrei, sostenendo che la loro espulsione è ispirata da ragione, conoscenza e amore, visto che «il comandamento divino ad amare il prossimo non è un’esortazione al sentimentalismo» (Koonz 2003: 166, 63, 67-8). Lo stesso Hitler indica in un cristianesimo riformulato a misura della «comunità» («la religione è un affare del Volk!», proclama già in un discorso del 1930; Allen 1965: 233) il «fondamento di tutta la nostra morale» (Koonz 2003: 33)16. Si tratta evidentemente di un cristianesimo purgato da scorie ebraiche e universalistiche, e fondato sulla riformulazione in chiave comunitarista della regola d’oro. Già nel vademecum del nazista Goebbels enuncia il primo comandamento in questi termini: «Ama la Germania al di 14 15 16
Cfr. in proposito quanto Fritzsche 2008: 115 osserva, sottolineando l’unilateralità delle proteste di von Galen per l’eutanasia, a fronte del suo totale silenzio (anche nella corrispondenza privata) sulla persecuzione degli ebrei. L’espressione, attribuita ad Alfred Rosenberg, è riportata nel diario di Paulheinz Wantzen, direttore del quotidiano di Münster, in data 9 maggio 1943 (2000: 1093); cfr. Fritzsche 2008: 170-71. Sulle frequenti citazioni bibliche alternate a frasi di Hitler e Goebbels sulle pareti delle scuole, cfr. Fritzsche 2008: 93.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
168
Shoah, modernità e male politico
sopra di ogni altra cosa, e il tuo Volksgenosse come te stesso» (Goebbels 1930: 1). Sfruttando la propaganda razzista che presenta gli ebrei come vettori di degenerazione morale, un’altra versione traduce il principio evangelico nei termini di una legge del taglione ispirata al pregiudizio: «Fa’ agli altri ciò che immagini gli altri abbiano fatto a te» (Koonz 2003: 15). A loro volta, filosofi, medici e giuristi favorevoli all’eugenetica teorizzano che la sterilizzazione coatta rispetta la morale cristiana in quanto la regola d’oro concerne soltanto i «camerati di razza»17. In questo senso Wilhelm Frick, ministro dell’Interno del Reich, afferma, nel giugno del ’33, che la valorizzazione del «corpo del Volk conforme al suo valore genetico» per mezzo dell’eugenetica è un momento «moralmente incontestabile» della più complessiva rivoluzione morale incentrata sui valori della comunità, poiché il rischio della «morte etnica» di un popolo superiore deriva dal fallimento morale causato dal pervasivo egocentrismo che induce i «degni» a limitare la prole, favorendo gli «indegni». Contro un simile rischio mortale Frick invoca un nuovo ethos civico, una moralità etnica, obbediente ai «propositi della natura» di favorire le forme di vita superiori (Koonz 2003: 103-04). Un ulteriore filone valoriale concerne i temi del dovere e dell’obbedienza all’autorità legittima (la weberiana morale del Beruf). Ad essere coinvolti sono in primo luogo i pubblici funzionari. Complice la loro formazione formalistica, astrattamente legalista, le schiere di funzionari e burocrati impegnati nell’elaborazione e nell’applicazione delle leggi si sentono per ciò stesso nel giusto. Indipendentemente dal contenuto delle norme, essi si ritengono impegnati in una benemerita opera di pulizia e purificazione, e si fanno un punto d’onore nel «sospendere il proprio giudizio morale» (Koonz 2003: 169, 188-89, 194). Come spiegò al Tribunale di Norimberga, Lutz Graf Schwerin von Krosigk (il ministro delle Finanze di von Papen, von Schleicher e Hitler) si considerò sempre «non un uomo politico ma un funzionario»: in quanto tale aveva «servito la Germania per tutta la vita» alla guida di un ministero che, sulla base dei decreti da lui controfirmati, «imponeva tasse supplementari agli ebrei, compresa quella del 1938» (che obbligò gli ebrei a riparare i danni provocati dagli autori del pogrom della cosiddetta “Notte dei cristalli”) «e confiscava le proprietà degli ebrei emigrati e deportati» (Hilberg 1992: 60). Come scrive Robert Lifton a proposito della condotta di Eduard Wirths, medico capo ad Auschwitz, in casi come questo «la coscienza lasciò il posto alla coscienziosità» (Lifton 1986: 501 ss.). Ma non si trattò soltanto dei pubblici funzionari. Nel corso della guerra Thomas Mann lamenta che, nel rimanere schiavi del misero 17
Cfr. Koonz 2003: 119; cfr. in proposito Lifton 1986; von Cranach 2007: 87 ss.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Burgio - Il conflitto tra morali nella Germania nazista
169
fanatismo di Hitler, tutti i tedeschi, privi di spirito critico, danno prova di una «obbedienza sconfinata», «di giorno in giorno più imperdonabile» al pari della loro credulità (1945: 402)18. Ma già nel 1934 scrive che il popolo tedesco «non ama la libertà, in cui avverte come una forma di abbandono», e sa sentirsi «al suo posto» soltanto sotto una dittatura (Mann 1961: 271)19. E non è improbabile che un importante contributo in tal senso l’abbia dato una tradizione pedagogica autoritaria, incentrata su «un’impaziente richiesta di obbedienza che non ammette domande» (Mitscherlich – Mitscherlich 1967: 111)20. 5. L’unità della Volksgemeinschaft Come si vede, tutto in questa «nuova etica coerente con il cameratismo razziale» (Fritzsche 2008: 19) ruota intorno alla «comunità del popolo» (la Volksgemeinschaft) da costruire e blindare (escludendone gli estranei) e far prevalere in ambito internazionale, vincendo una guerra percepita come lotta per la vita e per la morte, nella quale «la salute del popolo tedesco presupponeva l’annientamento fisico degli ebrei europei e la distruzione di tutti i paesi non tedeschi dell’Europa orientale» (Fritzsche 2008: 280). Il tema dell’unità del Volk – cuore pulsante dell’etica nazista e aspetto centrale nel quadro delle «intuizioni psicosociali» di Hitler già nella elaborazione del Mein Kampf (Capozza – Volpato 2004: 41 ss.) – merita un’analisi più ravvicinata. Alla base, incide con ogni probabilità la debolezza del sentimento di appartenenza dei tedeschi a una storia condivisa, una fragilità dell’identità nazionale dovuta alla tardiva unificazione e agli instabili e imprecisi confini linguistici e geografici a ovest e, soprattutto, lungo il fronte orientale21. Di qui un bisogno primario e imperativo di sentirsi partecipi di una comunità salda e omogenea, un’esigenza inderogabile che, in assenza di miti positivi (di una «narrativa nazionale edificante»; Volkov 1990: 13 ss.), induce 18 19 20 21
Radiomessaggio del dicembre 1940. Lettera del 2 aprile 1934, a René Schickele; cfr. Burgio 2012. Cfr. anche Eilers 1963; Maida 2002: 281 ss. Cfr. al riguardo Stierlin 1975: 137-38, che sottolinea come il fatto di rappresentare «il cuore dell’Europa» abbia per contro affidato alla Germania il compito di elaborare «una solida identità nazionale, insieme aperta e cosmopolita»; analoghe considerazioni svolgono Eric Weil (1948a, 1948b) e Cesare Cases, che parla di un «complesso d’inferiorità» che «si rovesciava spesso all’esterno nell’elogio della forza» (1963: 36).
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
170
Shoah, modernità e male politico
un ripiegamento autoreferenziale e una dinamica di autoriconoscimento fondata – oltre che sulla negazione dell’altro, individuato in primo luogo nell’ebreo22 – sulla «tecnicizzazione» delle mitologie neo-romantiche (dalle grandi narrazioni wagneriane all’Übermensch nietzscheano) rese funzionali a un’utopia di dominio23. Per di più è pervasivo e oppressivo un senso di minaccia gravante sulla comunità, soprattutto dopo Versailles e il disastro della repubblica di Weimar: minacce esterne, nell’un caso, provenienti da un mondo popolato da traditori e nemici (polacchi, bolscevichi ed ebrei innanzi tutto) contro i quali combattere una lotta all’ultimo sangue; minacce interne nell’altro, ma non per questo meno insidiose. Al contrario. Il bisogno parossistico di unità e di omogeneità sociale (un bisogno talmente radicato che, quando si profilò la sconfitta della Germania, le accuse al regime erano formulate perlopiù nel nome della Volksgemeinschaft, il cui valore dominava le menti dei tedeschi anche nell’agonia del nazismo; Fritzsche 2008: 269 ss.) testimonia l’incapacità di fare i conti con l’ambivalenza, di reggere la contraddizione e di gestire i conflitti. Da qui discendono la demonizzazione delle divisioni e l’invocazione angosciosa dello «spirito della comunità germanica», culminate nella generale ostilità verso la repubblica di Weimar, definita «Stato di partito». Insieme al nazionalismo, alla percezione dei nazisti come incarnazione della forza e alla loro indubbia capacità di offrire alle classi popolari colpite dalla crisi economica servizi di welfare (mense gratuite, assistenza sociale, campi comunitari), il bisogno di comunità fu un fattore decisivo della conquista del potere da parte di Hitler. Sin dall’inizio il nazismo si impegnò a soddisfarlo, stimolando i tedeschi a considerarsi parti di una comunità nazionale cosciente di sé e a riconoscere nella comunità un soggetto attivo sulla scena mondiale. Si trattava di riunificare il Volk nel riferimento a un ideale condiviso, anche convertendo i nemici di un tempo (di 22
23
Cfr. Traverso 1992; Ferrari Zumbini 2001; Burgio 2010: 118 ss.; Traverso 2011: 110-11; Traverso sottolinea come la centralità del tema dell’unità della Volksgemeinschaft sia essenziale nel distinguere nazismo e stalinismo: mentre la violenza staliniana si collegava a un «progetto di trasformazione coercitiva e autoritaria della società» (per cui le sue vittime furono quasi tutte cittadini sovietici, perlopiù russi), quella nazista – funzionale all’unità della comunità: quindi un «fine in sé» rispetto al contesto bellico – si proiettò essenzialmente «verso l’esterno»: contro gli esclusi dalla comunità del Volk (ebrei, «zingari», malati e omosessuali), quindi contro gli slavi, i prigionieri di guerra, i deportati antifascisti e gli ebrei stranieri, a cominciare dagli Ostjuden (Traverso 2011: 121-22). Cfr. Jesi 19952: 9, 173 ss.; sul concetto di «tecnicizzazione» del mito cfr. Kerényi 1964: 153-68.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Burgio - Il conflitto tra morali nella Germania nazista
171
qui la centralità dell’educazione e della costruzione dei «nuovi tedeschi»), e di unire emotivamente gli individui in una «comunità di esperienza», spezzandone l’identificazione col proprio milieu sociale24. Come traspare anche dai diari di Victor Klemperer (1995: 249)25, sempre più spesso i tedeschi ricavarono dalle iniziative del regime (trasmissioni radiofoniche, grandi parate, leggi razziste, produzioni cinematografiche) la rassicurante sensazione di ritrovarsi finalmente «in famiglia» («tra noi»), in seno a una comunità omogenea e chiusa, emendata da presenze estranee. Tutto questo avvalora la tesi di Fromm, secondo il quale, dopo la conquista del potere, «il governo di Hitler si identificò per milioni di persone con la “Germania”», per cui «combatterlo significava estraniarsi dalla comunità dei tedeschi» (Fromm 1941: 183). Ma poi perché combatterlo, considerati i doni che sembrava portare? Per quanto oggi possa sorprendere, numerose testimonianze mostrano come la maggior parte della popolazione vivesse a proprio agio nella Germania di Hitler, la quale – fatte le debite terribili eccezioni – «sembra aver garantito un certo benessere materiale e psicologico» a un gran numero di tedeschi (Cocks 1985: 33)26. La vittoria dei nazisti finì ben presto per convincere i più di essere «giunti alla fine delle discordie interne» e delle divisioni di classe, della «insensata lotta politica» e della «frantumazione in partiti» (Allen 1965: 246-47). Agli occhi dei più, i nazisti si presentavano come un’alternativa di unità, impegnata ed energica, «in contrasto con l’insensata girandola di alterchi e di inefficienza politica» che aveva segnato gli anni della repubblica: i cittadini «erano elettrizzati dalle prospettive di “unità nazionale”» (Allen 1965: 279). Torneremo brevemente su questi aspetti, connessi, per dirla con Mann, all’«interiorità tedesca» (Mann 1961: 589-90)27. Basti, per il momento, aver chiarito come la nuova etica nazista facesse leva su un radicato bisogno di identità, appartenenza e armonia, e come l’essere riuscito a intercettarlo abbia fruttato al regime un duro zoccolo di consenso popolare. Milioni di tedeschi si nutrirono con avidità delle immagini dell’unità nazionale: il «socialismo dei fatti» prodotti dal regime godeva di una generale legittimazione, e l’eliminazione «chirurgica» e «biologica» della poltiglia 24
25 26 27
La «semplificazione» sociale all’insegna dell’allineamento di ogni istanza ai dettami del partito (era questo il senso della cosiddetta «Gleichschaltung») mirava all’atomizzazione e disorganizzazione della massa e all’immediata subordinazione dei singoli al potere statale, secondo il modello tempestivamente prospettato da Emil Lederer (1940: 7-8, 52 ss.). Annotazione del 17 agosto 1937. Cfr. anche Johnson – Reuband 2005: 169, 176-77. Lettera del 7 settembre 1945, a Walter von Molo.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
172
Shoah, modernità e male politico
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
umana composta da estranei e nemici appariva un prezzo ragionevole per la pulizia della comunità finalmente rigenerata (Fritzsche 2008: 53, 82). 6. Il «diniego» come chiave di volta Se volessimo, a questo punto, descrivere in concreto lo svolgimento del conflitto morale che divampò nella Germania nazista e che contribuì ad assicurare al regime il consenso della maggioranza dei tedeschi, dovremmo illustrare nel dettaglio diverse dinamiche psicologiche (in particolare meccanismi di difesa e di adattamento), alle quali è qui possibile accennare soltanto per titoli28. Una forma di razionalizzazione consentì di rappresentare l’aggressività nei termini di una risposta difensiva contro le minacce incombenti sulla comunità nazionale, o come una pur dolorosa contromisura imposta dalle vicissitudini dell’epoca. Questo atteggiamento caratterizzò in particolare i moderati (i «nazisti sì, ma») che più di altri avvertivano il bisogno di giustificare il proprio sostegno al regime banalizzando come «incidentali» i crimini del regime (Koonz 2003: 102). Ma razionalizzazioni volte a «disfarsi della colpa e ad armonizzare il comportamento con la moralità» intervenivano anche nella rappresentazione della persecuzione degli ebrei, come nel caso del giudizio favorevole nei confronti della deportazione di intere famiglie, considerata – o, meglio, raccontata a se stessi – come una misura umanitaria (Bankier 1992: 137-38). Alla propria deresponsabilizzazione si provvedeva appellandosi al vincolo di «responsabilità» nei confronti del Führer e invocando la natura legale delle decisioni e dei comandi. Mentre le violenze conclamate e arbitrarie delle milizie suscitavano una diffusa avversione, la «legalità» (non per caso definita da Carl Schmitt «la chiave per il problema del potere statale in Germania»; 1950: 281) rendeva accettabili agli occhi dei più le misure discriminatorie e persecutorie (Koonz 2003: 164-66, 182). Il contributo dei cosiddetti «etnocrati» (burocrati e giuristi impegnati, fra il 1933 e il ’35, nella definizione di «ebreo» e nella codificazione delle misure discriminatorie contro i Gemeinschaftsfremde29) fu quindi determinante, in quanto consentì, per così dire, di dislocare l’antisemitismo dalle strade agli 28
29
Oltre allo studio citato dei Mitscherlich, si vedano in proposito A. Freud 1936; Hartmann 1939: 62-135; White – Gilliland 1975; Parin 1977. Sono grato a Pier Francesco Galli per queste indicazioni bibliografiche e per i preziosi suggerimenti che ho da lui ricevuto nel corso della redazione di questo saggio. Cfr. Koonz 2003: 168 ss.; Burleigh – Wippermann 1991: 55 ss.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Burgio - Il conflitto tra morali nella Germania nazista
173
uffici, alle scuole e alle camere da letto, passando dal «disordine» della violenza squadrista al pogrom freddo delle leggi di Norimberga30. Altrettanto efficace si rivelò, nella fase finale della guerra, l’interpretazione vittimistica della catastrofe. I tedeschi si ritenevano vittime di una storia crudele: del tradimento dei capi nazisti, delle bugie della loro propaganda e soprattutto di una guerra che, assumendo uno dei temi-chiave dell’ideologia hitleriana, tendevano a considerare frutto di un complotto ebraico. Il più classico meccanismo proiettivo, attivato da «fantasmi inconsci di vendetta» (Mitscherlich – Mitscherlich 1967: 52 ss.)31, induceva a un rovesciamento della realtà ben sintetizzato dal detto secondo cui «i tedeschi non avrebbero mai perdonato Auschwitz agli ebrei» (Fritzsche 2008: 250). A permettere l’obbedienza acritica a prescrizioni confliggenti con le proprie convinzioni morali contribuivano in misura rilevante anche meccanismi di «identificazione col ruolo» (funzionali al comportamento «desiderato e richiesto» dal proprio ambiente o dall’istituzione in cui si opera; Parin 1977: 393 ss.) o di difesa dissociativa (in forza della quale è possibile agire anche per lunghi periodi «come se» si fosse un’altra persona «provvista di tratti caratteriali estremamente diversi da quelli esibiti normalmente»; White – Gilliland 1975: 103 ss.). Naturalmente agivano in questa direzione con particolare efficacia i meccanismi di identificazione con il capo (Hitler in primis) messi a fuoco da Freud già nel ’21 (White – Gilliland 1975: 117 ss.; S. Freud 1921) e rinforzati dall’attivarsi dell’«Io di gruppo» e dalla «coscienza di clan» (Parin 1977: 386 ss.). In questo clima gli stati d’animo si alternavano «opportunisticamente» tra fasi euforiche, in corrispondenza con le vittorie in guerra, e momenti di angoscia, quando i rovesci militari evocavano lo spettro delle vittime e della loro terribile vendetta. Alle paure, sempre più frequenti dopo il 1941, si reagì con una diffusa apatia nonché, talvolta, ignorando strumentalmente le prescrizioni antisemite, al fine di tabuizzare lo sterminio. Lo scopo era ridurre al minimo il disagio derivante dalla conoscenza del 30
31
Cfr. Koonz 2003: 191-92. Appare emblematica in proposito la richiesta, avanzata da alti gerarchi nazisti, che le deportazioni avvenissero in modo «corretto», «decoroso», «pulito», «tedesco», onde evitare di apparire dei «pazzi sadici»; cfr. Bankier 1992: 135. Lo stesso Bankier (77) nota che la Legge per la protezione del sangue e dell’onore tedesco «fu accolta con particolare favore perché conteneva la violenza antisemita nel quadro della legge e dell’ordine»; lo stesso vale per la richiesta che le pratiche di sterilizzazione coatta e di eutanasia si svolgessero in conformità con una legge che permettesse di «liberare i malati dalle loro sofferenze croniche» (Gellately 2001: 156). Cfr. anche White – Gilliland 1975: 95-6.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
174
Shoah, modernità e male politico
destino degli ebrei e delle altre vittime del regime, senza che ciò coinvolgesse minimamente implicazioni affettive né comportasse «sincero rimorso, travaglio interiore o auto-condanna morale» (Bankier 1992: 147). Proprio l’esigenza di difendersi da una realtà dolorosa, percepita sempre più come fonte di sentimenti di colpa e di vergogna, rese cruciale il ricorso al diniego irrazionale, con il suo corteo di dinamiche di derealizzazione e di manifestazioni maniacali. Durante la guerra la realtà apparve ben presto diversa da quella sperata, e troppo dura per essere riconosciuta. La si rifiutò, spesso semplicemente denegandola32, rifiutando di prendere atto di ciò che molto spesso era non soltanto noto, ma anche evidente33. Il peso delle responsabilità, dei ricordi e degli impulsi disturbanti finì con l’indurre la negazione della realtà e il disconoscimento del suo vero significato. In sostanza, ci si rifiutò di ammettere la verità, non di rado opponendo alle frustrazioni e all’angoscia un rifiuto trionfante ed esaltato e ribadendo la propria presunzione di superiorità e di onnipotenza34. Il diniego caratterizzò, si può dire, l’intera vita psichica dei tedeschi negli anni del nazismo, fu la sua cifra: determinò l’atmosfera in cui si svolse, informò di sé le relazioni tra le persone e la loro stessa vita interiore. Come non scorgere un paradigma di derealizzazione collettiva nella vita serena condotta da migliaia di famiglie «normali» in una fiorente cittadina tedesca di nome Auschwitz, alle porte del Lager? O nell’ostinato silenzio dei tedeschi in merito ai bombardamenti a tappeto che negli ultimi due anni di guerra rasero al suolo quasi tutti i centri cittadini e gran parte dei villaggi 32
33
34
«Si può credere a una storia così orrenda? Non può essere vera. Neanche i fanatici più brutali potrebbero essere così assolutamente bestiali». È questa la reazione di Ursula von Kardorff, giornalista collegata agli ambienti della resistenza, alla lettura del racconto di Vrba e Wetzler, i due ebrei slovacchi fuggiti da Auschwitz che parlavano delle camere a gas, riportato dal Journal de Genève nel dicembre 1944; cfr. Bankier 1992: 114-15. Cfr. Johnson – Reuband 2005; Longerich 2007. A tal proposito Alexandre Koyré (1945: 294 ss.) ha sottolineato come la verità in merito ai progetti persecutori (peraltro enunciati a chiare lettere già nel Mein Kampf) «rimanesse costantemente celata, implicita», benché fosse, al tempo stesso, pubblicamente intuita: si trattava, in sostanza, di un segreto aperto e «crittografato». In merito a una comunicazione funzionale al diniego, Claudia Koonz (2003: 107-08) insiste sulla doppiezza comunicativa di Hitler e di altri alti funzionari, a cominciare dal «camaleonte ideologico» Walter Gross, incaricato nel 1933 di coordinare le politiche demografiche e di tutela della razza. Cfr. White – Gilliland 1975: 91 ss., 155-56; sulla differenza tra diniego e rimozione (termine correntemente impiegato per designare tutti i tentativi di scaricarsi da esperienze disturbanti): 49-50; Mitscherlich – Mitscherlich 1967: 34n.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Burgio - Il conflitto tra morali nella Germania nazista
175
rurali? Come osserva Winfried Sebald, questa «sorprendente carenza di osservazioni e commenti» rientrava con ogni probabilità in «una continua strategia di evitamento» nei confronti di eventi che, per un verso, avevano trasformato «nel popolo dei ratti» proprio il popolo che «si era dato l’obiettivo di ripulire e igienizzare al completo l’Europa», e, per l’altro, rimandavano ai crimini di cui il nazismo si era macchiato e dei quali la popolazione tedesca si sentiva «complice»35. Sta di fatto che spesso la negazione dello sterminio degli ebrei riuscì appieno. Tracciando una sintesi delle «storie popolari di sofferenza collettiva», Fritzsche rileva che essi «semplicemente non c’erano». Sommerse sotto la copiosa produzione di narrazioni incentrate sui propri dolori, le loro sofferenze «non facevano parte degli orrori della guerra». Verso la fine del conflitto la «questione ebraica» era divenuta a tal punto intollerabile che i tedeschi non scorsero altra via d’uscita fuorché il rifiuto immediato della realtà, che li indusse allo «smembramento della cognizione dell’assassinio» (Fritzsche 2008: 220, 240, 289). Si pone qui il problema della consapevolezza e volontarietà di queste reazioni difensive. L’analisi psicologica considera i meccanismi di difesa e di adattamento reazioni automatiche e involontarie: processi inconsci posti in atto precisamente per «escludere dalla consapevolezza degli impulsi inaccettabili» (White – Gilliland 1975: 15) o per affrontare le influenze provenienti dall’ambiente sociale «alleggerendo l’Io da una contrapposizione continua col mondo esterno» e così permettendo «una connessione ampia della psicologia individuale con la psicologia sociale» (Parin 1977: 383, 393). Ma per quanto concerne il caso della popolazione tedesca sotto il nazismo – un regime sostenuto da un diffuso consenso, a dispetto della sua natura e prassi francamente criminali – il quadro appare, a questo riguardo, meno univoco. Più verosimilmente ci si mosse, per così dire, su un terreno anfibio, ibrido, dove consapevolezza e ignoranza sfumavano l’una nell’altra, alimentandosi a vicenda. Si evitava di sapere; ci si convinceva di non disporre di sufficienti elementi di fatto e di adeguati criteri di giudizio; si evitava di procurarsi notizie; si faceva in modo di seminare dubbi su ciò di cui si veniva a conoscenza («Cercavamo di non crederci», ricorda Hubert Lutz, che trascorse l’adolescenza a Colonia negli anni della guerra; Johnson – Reuband 2005:
35
Cfr. Sebald 1999: 44, 94, 98; di proiezioni dei sensi di colpa (i bombardamenti come punizione divina per la distruzione delle sinagoghe nel ’38) parla invece Bankier 1992: 146-49.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
176
Shoah, modernità e male politico
170); ci si sforzava di dimenticare, evitando in primo luogo di parlare di ciò che si riconosceva intollerabile36. D’altra parte non convince la tesi opposta, secondo cui la complicità, attiva o passiva, dei tedeschi rispetto al regime avrebbe sistematicamente sotteso decisioni liberamente assunte nella piena consapevolezza del loro significato e delle loro conseguenze. Contro l’alibi deterministico (o funzionalistico) invocato dalla difesa dei carnefici nazisti in occasione dei processi del dopoguerra, si è spesso parlato di «decisioni consapevoli» (Bankier 1992: 130) (come quella di «non vedere nemmeno l’ebreo, di attraversarlo con lo sguardo come se fosse di vetro, o meglio come se fosse aria»; Fritzsche 2008: 202, 239, 120) e di una «deliberata indifferenza» di fronte all’ondata di suicidi compiuti dagli ebrei per evitare la deportazione (Bankier 1992: 137-38). Nella misura in cui mirano a screditare goffe argomentazioni deresponsabilizzanti (nemmeno il più oppressivo dei dispotismi sarebbe in grado di ridurre decine di milioni – né centinaia di migliaia – di individui allo stato di automi), queste ricostruzioni sono senz’altro condivisibili. Ma è probabile che in molti casi – forse il più delle volte – le dinamiche psicologiche fossero assai poco limpide e alquanto confuse e contraddittorie. In questo senso la migliore sintesi del problema sembra quella prospettata da David Bankier (1992: 137-38), secondo il quale, se «è indubbio che quanti volevano sapere disponevano dei mezzi per acquisire sufficiente conoscenza», i più «non vollero credere» proprio perché «sapevano abbastanza per sapere che era meglio non sapere altro». 7. Una rivoluzione riuscita? Poc’anzi abbiamo rapidamente accennato al radicamento dell’ossessione per l’unità del Volk nell’«anima tedesca», intendendo con questa espressione non certo una presunta identità metastorica, bensì la configurazione storicamente determinata di una cultura e di un clima psicologico (Burgio 2012: 187 ss.). Il tema era implicito nell’affermazione di Kershaw dalla quale siamo partiti: se corrisponde al vero che il successo del nazismo di36
Cfr. Burgio 2014. Di un’atmosfera di «attonito silenzio», pervasa da «un sentimento sotterraneo di colpa e complicità», parla Frei 2001: 209; rientrano in questa casistica le «omissioni e interpretazioni vantaggiose» funzionali alla creazione del passato da parte della memoria selettiva (che elimina i ricordi dolorosi) di cui parla Michael Billig 1999: 212-14; per il nesso tra memoria selettiva e miti di gruppo, cfr. Stierlin 1975: 145, 148-49, 154-57.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Burgio - Il conflitto tra morali nella Germania nazista
177
pese in buona misura dalla sua capacità di accreditarsi come garante di valori radicati e diffusi, allora per svelare l’«enigma» del consenso di massa al regime è necessario ricercarne le radici culturali e psicosociali in un’ottica di lungo periodo, al di là dell’immediata incubazione dell’avvento di Hitler, tra Versailles e la repubblica di Weimar. Come sintetizzare, a questo punto, il quadro, avviandoci alla conclusione? Due elementi appaiono decisivi. Da una parte, una tenace propensione alla apoliticità, sullo sfondo della separatezza della società da un apparato statuale saldamente egemonizzato dalla casta nobiliare-militare. Con buona pace del vecchio Kant, la borghesia tedesca non era divenuta maggiorenne (autonoma, responsabile); aveva accettato che la politica fosse affare di specialisti (o, come oggi si direbbe, di «tecnici»), e ad essi riteneva naturale affidarsi, chiedendo in cambio, per ricordare il Mann critico di Wagner, la «protezione della propria interiorità» (Cases 1963: 36 ss.). A favorire una sindrome autoritaria vi era, dall’altra parte, un esasperato nazionalismo, figlio legittimo della paura (del sentimento della debolezza della propria identità) e del desiderio di sicurezza e potenza (che alimentava, insieme alla presunzione della propria superiorità «razziale», il bisogno di visioni eroicizzanti del proprio futuro). Su questa base il recente passato (Versailles, Weimar, la crisi economica e sociale) aveva reso i tedeschi disponibili a convertirsi a nuove idee che alludessero a nuovi inizi. E questo bisogno di credere in un futuro eroico preparò la resa incondizionata a un capo carismatico capace di evocare la visione di una Germania rigenerata. Il paese della tecnica e della razionalità amministrativa rispose come un sol uomo al «richiamo quasi messianico» del Führer, che ne venne a sua volta divinizzato (Kershaw 1991: 70, 132, 245-47, passim). E la cieca fiducia che milioni di persone riposero nella sua persona si tradusse, sorprendentemente, in una delega in bianco anche sul terreno morale. Ma ricercare le lunghe radici del nazismo nella storia tedesca non significa affatto relativizzarne le colpe e gli orrori. Significa, al contrario, impedire la via di fuga – questa sì deresponsabilizzante – nel mostruoso o nel diabolico. Sostenere che i crimini del nazismo coinvolsero a vario titolo una società normale non significa banalizzarli, bensì affermare la necessità di interrogare questa normalità capace di adeguarsi al crimine, di routinizzarlo e di convivere con esso. L’interrogativo che qui prende forma arriva sino a noi. Quale esito ebbe la perversa «rivoluzione intellettuale e morale» del nazismo? Fallì, o cambiò veramente la coscienza dei tedeschi? Oppure, peggio ancora, rivelò la «verità nascosta» della coscienza tedesca?
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
178
Shoah, modernità e male politico
Che essa abbia avuto successo non sembra dubbio. «I nazisti – ha scritto con piena ragione Fritzsche – fanno paura perché hanno ampliato la nozione di ciò che è politicamente e moralmente possibile nel mondo moderno»: almeno per quel tempo «l’idea di normalità era stata trasformata in senso razziale» e la «nozione di vita normale e ordinaria» ne uscì sfigurata. La Germania nazista normalizzò l’eccezione ricollocando il crimine «all’interno dei canoni morali convenzionali» (Fritzsche 2008: 16, 80, 205). Sebald ha sintetizzato questo fatto sostenendo che a contraddistinguere la «particolare deformazione intervenuta nelle menti dei tedeschi» fu «il sovrapporsi di idee paranoidi alla capacità di condurre una vita normale» (Sebald 1999: 101). E non sembra dubbio nemmeno che tale successo riposasse su solide premesse. Quando, poco dopo la Machtergreifung, ci si cominciò a provare «l’abito dell’antisemitismo», in tanti scoprirono che esso «calzava a pennello» (Fritzsche 2008: 118). Diverso e più complicato sarebbe il discorso in merito alla persistenza della nuova etica nazista. Di certo essa non scomparve nel rogo di Berlino senza lasciare tracce di sé. Per decenni perdurò la propensione a negare il passato e persino la disfatta, stendendo una spessa coltre di oblio sui crimini commessi nel nome di Hitler (Mitscherlich – Mitscherlich 1967: 16-7, 65, 103). E molti hanno collegato la determinazione dei tedeschi a «ricostruire il proprio paese più grande e più potente di quanto fosse in passato»37 (per non parlare dell’ampio consenso dell’opinione pubblica all’amnistia giudiziale approvata a stragrande maggioranza dal Bundestag all’inizio degli anni Cinquanta; Fritzsche 2008: 256-57; Portinaro 2011: 147 ss.) a quella ferma volontà di «non voler prendere coscienza» del proprio passato38 in cui Mann aveva letto i segni di una sconvolgente «ottusità di fronte a ogni orrore»39. Ma è difficile stabilire fino a quando 37
38
39
Cfr. Enzensberger 1990: 24, che riporta un’affermazione di Robert T. Pell risalente all’aprile 1945; cfr. Sebald 1999: 53: «il loro petto non si gonfiava forse di orgoglio perverso al pensiero che nessuno, nella storia dell’umanità, aveva mai dato una così alta prova di sé sapendo far fronte a tanti rovesci come i tedeschi?». Per lo stesso Enzensberger 1990: 20-1 sarebbe impossibile capire «la misteriosa energia dei tedeschi, se rifiutiamo di ammettere che essi hanno sublimato il loro difetto facendone una virtù. Il non voler prendere coscienza fu il presupposto del loro successo». Cfr. Mann 1938: 282. Cfr. anche Mann 1961: 559 (7 gennaio 1945, ad Agnes Meyer: «in Germania si manca totalmente della consapevolezza delle ingiustizie commesse (e di quale massa d’ingiustizie)») e 586-87 (7 settembre 1945, a Walter von Molo: «incoscienza e insensibilità» dei tedeschi e «immediatezza ingenua [...] come se questi dodici anni non ci fossero mai stati»).
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Burgio - Il conflitto tra morali nella Germania nazista
179
questo clima sia perdurato, quanto a lungo abbia persistito questa «incredibile bancarotta morale» (Fritzsche 2008: 133). Piuttosto che dare risposte improvvisate, preme riflettere sul fatto che, se dopo Stalingrado le sorti della guerra non fossero andate tanto male per la Germania, con ogni probabilità le vittime dei campi di sterminio sarebbero rimaste per sempre invisibili (Fritzsche 2008: 218). Il pensiero di questa concreta eventualità ci consegna il preciso dovere di fare tutto il possibile per portare alla luce la loro sorte.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
181
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
FABIO DEI
TRA STORIA E SCIENZE SOCIALI: LE GRAMMATICHE DELLA VIOLENZA
1. Confini disciplinari? I miei commenti riguarderanno principalmente il problema del rapporto tra storia e scienze sociali nella comprensione della Shoah e della violenza nell’età contemporanea. Parto da una questione epistemologica, che potrebbe apparire banale se non fosse che si ripropone costantemente nei dibattiti ed è all’origine di sospetti e difficoltà nella collaborazione interdisciplinare. Il rapporto tra storia e scienze socio-antropologiche non può esser ricondotto a quello tra un sapere individuante o idiografico e uno generalizzante o nomotetico. Nel caso della Shoah, non è corretto contrapporre una comprensione storicizzante, che la tratta come caso unico e peculiare, le cui condizioni andrebbero ricostruite come irripetibile corso di eventi, e dall’altra parte una conoscenza tipizzante, che la riconduce a categorie più ampie e in qualche modo metastoriche. Da antropologo interessato al tema della violenza, sono naturalmente convinto che la mia disciplina possa contribuire a capire alcuni aspetti della violenza di massa del Novecento. Ciò può avvenire attraverso l’impiego di strumenti metodologici e teorici peculiari rispetto a quelli della tradizione storiografica: ad esempio un più ampio uso della comparazione, l’attenzione per i modelli culturali e le forme di “costruzione sociale della realtà”, e soprattutto il metodo etnografico (per quanto possa sembrare bizzarra l’applicazione del concetto di etnografia allo studio del passato; tornerò in conclusione su questo punto). Ma tali approcci e strumenti vanno a integrare l’intelligenza storica, volta alla descrizione e alla comprensione di una razionalità contestuale (non importa se nell’ordine degli eventi di breve periodo oppure della lunga durata): non pretendono certo di sostituirle un sapere universalistico e generalizzante, che pretenda di “spiegare” la violenza, poniamo, attraverso presunte invarianti della “natura umana”, tendenze evolutive, leggi sociologiche e così via. Dicevo che questo rifiuto della vecchia dicotomia idiografico/nomotetico può apparire banale o scontato – specie per una tradizione antropolo-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
182
Shoah, modernità e male politico
gica, come quella italiana, saldamente fondata sullo storicismo di Ernesto De Martino. Tuttavia le implicazioni, esplicite o implicite, di quella dicotomia sono ancora piuttosto diffuse – sia fra gli storici che fra gli scienziati sociali. Mi sembra ad esempio che molti storici, laddove siano interessati all’antropologia (o ad altre discipline che riguardano la soggettività umana, come la psicologia e la psicoanalisi), assumano una divisione del lavoro di questo tipo: la storia è chiamata a ricostruire la razionalità dei contesti e degli eventi, le scienze umane sono chiamate a intervenire su quanto sporge rispetto alle “ragioni” e ai contesti. Ad esempio la Shoah, i massacri e le violenze della Seconda guerra mondiale sono in parte spiegabili in termini di obiettivi economici e politici degli Stati, della volontà di dominio del nazismo, di strategie militari, di fattori ideologici come il razzismo, ecc. La guerra come proseguimento della politica con altri mezzi, lo sterminio come conseguente applicazione di strategie biopolitiche, e così via. Da questa spiegazione restano però esclusi alcuni aspetti che sembrano irriducibili allo specifico contesto storico: ad esempio il “surplus” di violenza che caratterizza certe pratiche – l’efferatezza e la crudeltà “inutile” della persecuzione nei campi di sterminio, già notata da Primo Levi, che sembra rivelarsi a tratti persino controproducente rispetto agli obiettivi del nazismo stesso. E ancora, la configurazione “rituale” che la violenza sembra talvolta assumere, con modalità simboliche che vanno ben oltre l’aspetto utilitario. È qui che vengono convocate antropologia, psicoanalisi, storia delle religioni, magari con riferimenti a testi classici, da Frazer a Freud a Girard, e a nozioni generalissime come rito sacrificale, istinto di morte, e simili, che promettono di inserire nella storicità dell’evento una dimensione di “natura umana”, o almeno di profondità evolutiva. Per quanto affascinanti possano talvolta apparire queste suggestioni, non mi pare si tratti di un corretto terreno di collaborazione interdisciplinare. Non c’è un punto in cui si arresta l’analisi storica e comincia quella socio-antropologica, o viceversa. Se il surplus della violenza o le sue configurazioni simbolico-rituali sono temi importanti, allora vanno affrontati come problemi storici a tutti gli effetti: ad esempio ricostruendo i codici – storicamente e culturalmente situati – che li rendono possibili. 2. Storia, evoluzione e “natura umana” Ma è da alcuni versanti delle scienze sociali che vengono i segnali più preoccupanti di una radicale incomprensione della dimensione storica. In
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
F. Dei - Tra storia e scienze sociali: le grammatiche della violenza
183
particolare, sembra godere oggi di rinnovata fortuna un approccio naturalistico che pretende di ridurre i problemi storici a grandi leggi dello sviluppo evolutivo e a caratteristiche strutturali della “natura umana”. Egemonizzato negli anni Settanta e Ottanta dalla sociobiologia, oggi questo approccio è sostenuto da una saggistica che si muove tra ecologia culturale, scienze cognitive e neoevoluzionismo, nascondendo visioni altamente ideologiche dietro una retorica scientista e fattuale. L’idea di storia espressa in un libro come Armi, acciaio e malattie di Jared Diamond (1997) ne è un esempio: una grande narrazione universale condotta sul filo di un rigido determinismo ecologico, in cerca delle leggi che garantirebbero lo sviluppo ottimale (che alla fine si scopre coincidere con i principi della organizzazione neoliberista del lavoro, come notato da Bill Gates in una entusiastica recensione al libro). Per quanto riguarda la violenza, vale la pena ricordare la risonanza del recente enciclopedico lavoro di Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature (2011): anche in questo caso niente di meno che una storia universale, dalle scimmie antropomorfe all’11 settembre, volta a sostenere la tesi di un progressivo declino della violenza che culmina con l’Occidente moderno (Il declino della violenza è per l’appunto il titolo della traduzione italiana). Mi soffermo un istante a sintetizzarne l’impianto. La violenza farebbe parte della “natura umana”: sarebbe, per l’autore, un comportamento evolutivamente adattivo, messo in atto per fini utilitari sulla base di un calcolo costi-benefici. Sarebbe altresì alimentata da cinque “demoni interni” della nostra natura: l’istinto predatorio, la volontà di dominio, la vendetta, il sadismo, l’ideologia. Ai demoni si oppongono però quattro forze psicologiche positive (i “migliori angeli della nostra natura”, nella frase di Lincoln che dà il titolo al libro nell’edizione originale): l’empatia, l’autocontrollo, il senso morale e la ragione (si noti intanto come la presunta conoscenza scientifica della natura umana si risolva nel più banale ed etnocentrico senso comune). Ora, per l’autore, nella storia umana hanno agito e agiscono due grandi principi che hanno portato al progressivo dominio degli angeli sui demoni. Questi principi sono lo Stato e il mercato. Il Leviatano riduce la violenza diffusa assumendone il monopolio; e il mercato, in quanto gioco a somma positiva (in cui tutti guadagnano), rende strategica la sopravvivenza più che la morte degli altri. Pinker individua una serie di fasi successive di allontanamento dalla violenza (la rivoluzione neolitica, il “processo di civilizzazione” dell’Europa moderna, la rivoluzione umanitaria dell’Illuminismo e, in una scala novecentesca, la “lunga pace” del dopoguerra, la “nuova pace” post-1989, e infine quella che chiama la “rivoluzione dei diritti umani”); individua inoltre alcune momentanee fasi o luoghi di reces-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
184
Shoah, modernità e male politico
sione, a suo parere provocati dall’indebolimento del controllo dell’ordine statale-psicologico. Il libro viene presentato come un tentativo di sfatare – prove e dati alla mano – il mito di un Novecento come “secolo delle tenebre”, teatro di violenze senza precedenti per quantità e qualità. Si contrappone dunque frontalmente alla tesi prevalente negli Shoah Studies. Questi ultimi vedono per lo più nel genocidio un prodotto della modernità e non una parentesi o un buco nero aperto all’interno di essa; un prodotto dello Stato stesso, per certi versi (anche se non certo la necessaria conseguenza dell’esistenza dello Stato). Per Pinker solo un pregiudizio ideologico può far ignorare l’evidenza del progressivo declino della violenza nella modernità. Il problema, con questa sua tesi generale, non è che sia falsa: anzi, si potrebbe dire, è tautologicamente vera. Infatti il declino della violenza è incluso nel significato che diamo a termini come “civiltà” o “progresso”: fa parte dell’autointerpretazione di quella che chiamiamo “civiltà occidentale”. È certo vero – contro una certa visione rousseauiana della tradizione – che tutta la storia gronda lacrime e sangue; e che il monopolio statale della violenza e il processo di civilizzazione (nel senso di Norbert Elias) hanno ridotto la pratica della violenza nelle relazioni quotidiane e abbassato la soglia di tolleranza verso l’aggressione fisica e la crudeltà. Alcuni dei fenomeni su cui Pinker insiste, come il recente radicale mutamento di sensibilità nei confronti della violenza sui bambini e sugli animali, rappresentano importanti questioni culturali su cui le discipline sociali e storiche non hanno forse riflettuto abbastanza. Il punto è che il libro usa questa tesi come una clava, saltando disinvoltamente tra i contesti e le civiltà più diverse e offrendo di molti problemi storici una rappresentazione a dir poco caricaturale. Caricatura che culmina proprio nella parte dedicata ai genocidi novecenteschi – la cui principale causa, apprendiamo, è stato «l’apparire della ideologia marxista, uno tsunami storico dall’impatto umano devastante». Non solo essa ha provocato i genocidi compiuti dai regimi sovietico e cinese, ma ha contribuito anche a quello nazista. Infatti «Hitler aveva letto Marx nel 1913. E il suo nazionalsocialismo sostituì le razze alle classi nella ideologia di una lotta verso l’utopia». Se non bastasse, il marxismo è anche responsabile delle reazioni genocide da parte dei regimi anticomunisti in Indonesia e in America Latina (colpevole di averli “provocati”, evidentemente). Ma Stalin, ci si chiede, non è forse stato il più grande Leviatano di tutti i tempi? È di per sé interessante la facilità con cui il libro passa dalla retorica scientista a quella da pamphlet ultraconservatore. La sua parte forse più insidiosa è quella che riguarda le “società senza Stato”, cioè i gruppi “tradizionali” di cacciatori e raccoglitori: Pinker li considera come le società
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
F. Dei - Tra storia e scienze sociali: le grammatiche della violenza
185
più violente e crudeli della storia e con i più alti tassi di omicidio – sulla base di una ragione statistica per cui una morte violenta in una “banda” di 50 persone equivarrebbe al genocidio di un milione di persone in un paese di 50 milioni di abitanti. Questi argomenti rischiano di diventare qualcosa di più di innocenti sciocchezze quando si applicano a gruppi in disputa con i governi centrali per la loro autonomia e sopravvivenza. Ma non è argomento che posso qui approfondire. Ho citato il libro di Pinker solo come rappresentativo di una sorta di “neo-naturalismo” incapace di distinguere la storia dall’evoluzione, i problemi di comprensione da quelli di correlazione statistica – e, in fin dei conti, l’analisi critica dal senso comune. Non è certo in questa direzione che le scienze sociali (di cui Pinker si dichiara rappresentante) possono contribuire al sapere storico. 3. Nuda vita e filosofie della storia Al polo opposto del posizionamento politico ed epistemologico troviamo un rapporto ugualmente difficile con la dimensione storica. Mi riferisco a un insieme di teorie elaborate in ambito filosofico ma assai influenti nella sociologia e nell’antropologia contemporanee, che fanno capo a concetti quali “biopotere”, “nuda vita” e “stato di eccezione”. Questa costellazione concettuale evoca naturalmente il pensiero di Giorgio Agamben e il suo Homo sacer: libro assai popolare malgrado una impervia struttura e un linguaggio molto tecnico. Si tratta di un lavoro che pone al centro il problema dell’esclusione dei migranti dalla cittadinanza nelle moderne democrazie, ma che propone al tempo stesso una peculiare interpretazione della Shoah. Per Agamben la globalizzazione, rendendo possibile una mobilità senza limiti materiali, cambia le condizioni dell’esercizio del potere, che si trova a dover gestire incontrollabili eccedenze umane. Nelle forme classiche di Stato, la nascita è criterio immediato di appartenenza a un territorio e a un ordinamento giuridico. Quando i flussi migratori generalizzati fanno saltare questo criterio, il potere ha bisogno di un meccanismo regolatore – la creazione di confini e spazi separati, che Agamben concettualizza nella nozione di “campo”. «Lo scollamento crescente fra la nascita (la nuda vita) e lo Stato-nazione è il fatto nuovo della politica del nostro tempo e ciò che chiamiamo campo è questo scarto» (Agamben 1995: 196-97). Campi sono appunto i centri di segregazione temporanea dei migranti, così come lo sono stati Auschwitz, i Lager e tutti gli spazi di separazione di eccedenze etniche. Non importa, per Agamben, se vi si pratica lo sterminio o un semplice controllo: quello che caratterizza i campi è la sospensione dei diritti
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
186
Shoah, modernità e male politico
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
per interi gruppi di persone che non hanno commesso alcun reato, sulla base della loro semplice esistenza. Se l’essenza del campo consiste nella materializzazione dello stato di eccezione e nella conseguente creazione di uno spazio in cui la nuda vita e la norma entrano in una soglia di indistinzione, dovremo ammettere, allora, che ci troviamo virtualmente in presenza di un campo ogni volta che viene creata una tale struttura, indipendentemente dall’entità dei crimini che vi sono commessi... (195)
Agamben si schiera certamente con la tradizione arendtiana che vede i campi come una componente strutturale della modernità, ma prende le distanze in modo decisivo dalla tesi della “banalità del male”. Quest’ultima ha visto nelle politiche segregazioniste e genocide una possibilità che si colloca in una irriducibile tensione con altri aspetti della modernità – ad esempio con la decolonizzazione, l’universalismo umanitario, la “democrazia”. Per Agamben il campo è invece il nomos stesso della modernità. La presenza di zone d’eccezione all’interno delle democrazie occidentali non è una contraddizione da denunciare, ma il disvelamento dell’essenza stessa di quelle presunte “democrazie”. Inoltre il concetto stesso di modernità si dilata a dismisura, finendo per coincidere (come l’“Illuminismo” della teoria francofortese) con l’intera civiltà occidentale, o meglio con l’esistenza del potere di uno Stato. Il campo è stato “fin dall’inizio” il destino del potere sovrano, il quale si afferma e si esercita attraverso la facoltà di “mettere al bando” e attraverso la creazione di forme di “nuda vita”. Quest’ultimo concetto gioca un ruolo cruciale in Homo sacer. Agamben lo riprende dall’espressione bloßes Leben usata in un celebre scritto di Walter Benjamin, cambiandone però il significato e facendolo coincidere appunto con quello dell’homo sacer – una figura del diritto romano arcaico, testimoniata da Festo, secondo la quale chi fosse stato riconosciuto dal popolo colpevole di un delitto non doveva essere immolato ma poteva essere ucciso impunemente da tutti. Il nesso con la definizione di bloßes Leben è difficile da vedere: la “pura vita” di Benjamin è oggetto di una violenza arbitraria e pre-giuridica, laddove l’homo sacer è un colpevole che viene punito per volontà popolare all’interno di un ordinamento giuridico, di cui ha infranto le regole1. Ad Agamben interessa tuttavia, in quell’istituto giuridico, la prerogativa del potere di porre al bando un individuo, di escluderlo non solo dalla comunità e da alcuni diritti ma dallo statuto stesso 1
Per un’analisi più dettagliata di questo scivolamento di significato rimando a Dei 2013.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
F. Dei - Tra storia e scienze sociali: le grammatiche della violenza
187
di essere umano; di renderlo dunque non sacrificabile (giacché il sacrificio implica il riconoscimento della comunità) ma immediatamente uccidibile. In questa esclusione o riduzione a “nuda vita” Agamben riconosce «la prestazione originaria della sovranità»: «l’homo sacer rappresenterebbe la figura originaria della vita presa nel bando sovrano e conserverebbe la memoria dell’esclusione originaria attraverso cui si è costituita la dimensione politica» (92). In altre parole, il peccato originale sta nella costituzione dello Stato: il diritto attraverso cui esso si legittima è fondato su una violenza originaria e può in ogni momento esser revocato in uno “stato di eccezione”. Il passo successivo di Agamben è l’identificazione della nuda vita con la soggettività dei detenuti nei campi – in particolare con la figura del “sommerso” o del “musulmano” di Auschwitz. In effetti questa è la situazione in cui il concetto di “immediata uccidibilità” e “non sacrificabilità” si applica in modo reale. La natura del campo di sterminio è tale che le SS hanno un totale e arbitrario potere di vita e di morte sui detenuti: possono decidere in un certo momento di ucciderli o di risparmiarli, senza venir puniti né premiati per questo. «Il campo è il più assoluto spazio biopolitico che sia mai stato realizzato, in cui il potere non ha di fronte a sé che la pura vita senz’alcuna mediazione», afferma Agamben (191), che prende qui le distanze in modo decisivo dalla tesi della banalità del male. La «domanda corretta rispetto agli orrori commessi nei campi» – prosegue – non è «quella che chiede ipocritamente come sia stato possibile commettere delitti tanto atroci rispetto a degli esseri umani»: occorre piuttosto «indagare attentamente attraverso quali procedure giuridiche e quali dispositivi politici degli esseri umani abbiano potuto essere così integralmente privati dei loro diritti e delle loro prerogative, fino a che commettere nei loro confronti qualsiasi atto non apparisse più come un delitto» (ibid.). Non è dunque una “assenza” ma un dispositivo giuridico-politico che apre lo spazio del male. D’accordo. Ma la risposta di Agamben sulla natura di questo dispositivo è tanto più astratta e generica quanto più cerca di esser radicale: la Shoah non è che l’inveramento della più profonda essenza dello Stato, e il detenuto di Auschwitz è la figura perfetta della soggettività moderna, la conclusione inevitabile della filosofia della storia occidentale. Data la ferrea premessa che domina e muove la storia (il bando sovrano), tutto il resto ne segue tautologicamente – in spregio alla più banale evidenza, cioè che l’immediata uccidibilità è stata prodotta per fortuna solo in alcuni momenti e contesti della storia (moderna o meno), solo da alcune forme del potere e dello Stato. Non si può seriamente sostenere che la Shoah o i genocidi coloniali siano stati buchi neri di una modernità altrimenti pacifica e democratica, come non
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
188
Shoah, modernità e male politico
si può seriamente sostenere che la storia contemporanea si riduca ad essi, che ne sarebbero l’essenza, l’inveramento, l’ovvio sviluppo a partire da una originaria premessa. In questo modo non si comprende storicamente la peculiarità di quegli eventi e delle strutture politiche che li hanno prodotti, come ha notato fra gli altri Enzo Traverso (2009). Si perde inoltre così il senso stesso di una storia fatta di contrasti e contraddizioni, e di una politica il cui scopo è discernere e comprendere le forme più giuste e quelle meno giuste dell’esercizio del potere. 4. La violenza come costruzione culturale I due approcci fin qui discussi, così diversi per taglio e per qualità scientifica, sono tuttavia accomunati dal soffocamento della concreta e peculiare dimensione storica. Nel primo caso essa si perde dietro una metafisica naturalista ed evoluzionista: la violenza dipende dalla natura umana, e la storia è il processo lineare del suo controllo da parte della mano visibile dello Stato e di quella invisibile del mercato (per un’antropologia depurata dal concetto di “natura umana” si veda Sahlins 2008). Nel secondo caso la dimensione dominante è quella di una filosofia della storia vista come il dispiegamento di un significato originario – il “bando sovrano”, di fatto la costituzione dello Stato come fonte dell’esclusione e della violenza. In entrambi i casi, alla storia è sovrapposta una Grande Narrazione che ne stabilisce in anticipo ogni significato. Non si tratta certo qui di evocare vecchie nozioni di “unicità” degli eventi storici, o un approccio idiografico contrapposto a uno nomotetico; piuttosto, di rivendicare una grana sottile della comprensione storica, fatta fra l’altro di interpretazioni locali, di tensioni e contraddizioni, di chiaroscuri più che della luce accecante di un senso che si dispiega e si replica in modo inesorabile. È solo in una simile “grana sottile”, io credo, che l’intelligenza socioantropologica può utilmente combinarsi con quella storica; e che – è quanto da antropologo mi interessa forse di più affermare – il concetto di cultura può contribuire alla comprensione della violenza e della Shoah. Parlare di cultura è cosa ben diversa dal proporre una spiegazione “culturalista” degli eventi o delle strutture di lunga durata – del tipo ben espresso in un celebre passo di Wittgenstein (1967), che ricorda come sui libri delle elementari stia scritto che Attila intraprese le sue guerre perché credeva di possedere la spada del dio del tuono. Una “spiegazione”, per inciso, non molto diversa da quella di Goldhagen (1996), che vede il “modello cognitivo” antise-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
F. Dei - Tra storia e scienze sociali: le grammatiche della violenza
189
mita come causa della Shoah2. Il problema è piuttosto capire i codici e le pratiche interpretative che costituiscono una certa realtà sociale e le stesse soggettività che ne sono protagoniste: codici e pratiche che costituiscono dunque il significato dell’azione sociale. È importante osservare che non v’è spazio alcuno per la cultura, intesa in questo senso, né nel determinismo neoevoluzionista di Pinker (dove tutto è ricondotto a psicologia) né nella filosofia della storia di Agamben (dove tutto è ricondotto a potere). In entrambi i casi il significato degli eventi è già stabilito a priori da un impianto teorico che si confronta con la realtà empirica asfaltandola come uno schiacciasassi. Il modello interpretativo più discusso in questo volume, quello della “banalità del male”, resta forse il più fecondo per una interazione tra storia e scienze sociali. È stato infatti la base dei lavori sulla Shoah proposti dalla psicologia sociale e da importanti indirizzi sociologici. Anche per l’antropologia si tratta di un riferimento importante – lasciando tuttavia aperta una difficoltà alla quale vorrei accennare in conclusione di questi rapidi commenti. Il problema che ha portato Hannah Arendt a coniare l’espressione “banalità del male” è quello della soggettività di Eichmann, e più in generale dei modi in cui una coscienza umana può accettare di rendersi attivamente partecipe di un male così grande, ignorando quelli che potremmo chiamare universali ed elementari principi morali. Ed è questo stesso problema che sta al centro di una serie di famosi lavori incentrati su “uomini ordinari” indotti con relativa facilità a compiere violenze e atrocità – da Milgram (1974) a Browning (1992), da Bauman (1989) a Todorov (1991). Com’è noto, Arendt decide di rispondere prendendo sul serio la strategia difensiva adottata da Eichmann al processo di Gerusalemme: quella di presentarsi come un banale funzionario che non ha mai fatto direttamente del male a nessuno, limitandosi ad eseguire – al meglio che poteva – i compiti affidatigli dai suoi “datori di lavoro”. Per Arendt il “grigio burocrate” è appunto la figura del male che caratterizza la modernità. La domanda è: in che modo le condizioni strutturali della modernità stessa (tecnologiche, burocratico-amministrative, ecc.) producono una simile soggettività, normale e mostruosa al tempo stesso? È una domanda che implica una concezione della coscienza come non preesistente agli eventi storici e ai contesti culturali, ma come plasmata da essi. Nei lavori della filosofa, tuttavia, accade spesso che il problema della costruzione sociale della coscienza si trasformi in quello, per così dire, del2
Cfr. Hinton 1998 per una critica antropologica a questa nozione di modello cognitivo.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
190
Shoah, modernità e male politico
la sospensione di una coscienza “naturale” o universale. La caratteristica cruciale che Arendt attribuisce ad Eichmann è la “mancanza di pensiero” (Arendt 1978: 84). Nella sua ricostruzione storica del personaggio, la studiosa pone l’accento sui modi in cui egli riesce a “mettere a tacere” la sua coscienza: «Eichmann [...] aveva una coscienza, e questa funzionò per circa quattro settimane nel senso normale, dopo di che cominciò a funzionare in senso inverso» – cioè compatendo se stesso, piuttosto che le vittime, per il “lavoro sporco” che era costretto a fare (Arendt 1963a: 103). E lo stesso argomento viene usato in riferimento agli “spettatori” tedeschi: Tutto sta a dimostrare che la coscienza in quanto tale era morta, in Germania, al punto che la gente non si ricordava più di averla [...]. Il problema era quello di soffocare non tanto la voce della loro coscienza, quanto la pietà istintiva, animale, che ogni individuo normale prova di fronte alla sofferenza fisica degli altri. (111, 113)
La possibilità di compiere il male scaturirebbe dunque da una mancanza, da un’assenza. L’influenza del sociale consisterebbe nel togliere qualcosa, nel mutilare la soggettività di una funzione che dovrebbe normalmente esserci: nel produrre un “vuoto” laddove si supporrebbe esistere un “pieno” di valori o sentimenti elementari, uguali per tutti (una “coscienza istintiva, animale”). Tutto ciò lascia in secondo piano la questione di come la violenza viene concretamente praticata, come i gesti violenti sono appresi e incorporati, quali codici culturali ne regolano la manifestazione. Anche nei modelli di psicologia sociale basati sul lavoro di Milgram il contesto sociale (l’obbedienza all’autorità) sembra influire sospendendo il normale stato di autonomia e responsabilità morale – sostituito da una condizione “eteronoma” in cui la coscienza resta per così dire la stessa ma non si applica (e il problema diviene piuttosto quello della produzione dell’indifferenza). Nell’ottica antropologica si tratterebbe invece di ricostruire i modelli culturali che in positivo plasmano una soggettività capace di compiere il male. Modelli culturali da intendersi naturalmente come incorporati. Non è la coscienza astratta che impara a compiere la violenza, e che della violenza serba una memoria specifica: è piuttosto il corpo, sono le mani. È come andare in bicicletta: non una conoscenza astratta e discorsiva, ma un saper fare talmente introiettato da apparire “naturale”. Ma è appunto questa naturalità che l’approccio etnografico vuole smontare, risalendo alle regole sintattiche che la costituiscono. In altre parole, serve un approccio etnografico alla violenza. L’etnografia viene talvolta intesa esclusivamente come studio del presente, basato su metodi partecipativi. Sarebbe più corretto
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
F. Dei - Tra storia e scienze sociali: le grammatiche della violenza
191
considerarla come una descrizione fenomenologica delle pratiche sociali, che con una adeguata interrogazione delle fonti può essere applicata anche al passato. In questo modo potremmo giungere a considerare gli orrori della Shoah non come un collasso o un vuoto della cultura, ma come un pieno di cultura, qualcosa di faticosamente e consapevolmente costruito (nell’addestramento, nell’educazione, nelle relazioni quotidiane) da certi (non poi così banali) esseri umani.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
193
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
ROBERTO ESPOSITO
NAZISMO E SHOAH
1. Cosa è che lega la Shoah al nostro presente, ed anche al nostro futuro? Cosa ne fa ancora, e sempre di più, un elemento decisivo della nostra autointerpretazione? Sappiamo tutti che si tratta del filo necessario della memoria storica – con tutto ciò che essa comporta sul piano antropologico, etico, politico. Senza il ricordo, sempre vivo, dell’orrore, non avremmo riparo rispetto alla possibilità, mai del tutto esaurita, del suo ritorno. Non solo noi stessi, ma soprattutto le nuove generazioni crescerebbero prive degli anticorpi necessari a vaccinarle dall’evento senza dubbio più tragico della storia contemporanea e forse dell’intera civiltà occidentale. Ma io credo non si tratti solo di questo – della memoria dell’immemorabile, della postura etica che essa reclama da parte di tutti coloro che comunque sono figli di quella tragedia. Credo ci sia qualcosa di più, e forse anche di più inquietante, che ci rende in qualche modo contemporanei di quell’evento, nonostante i settanta anni che ci separano da esso. La mia impressione è che se il nazismo in quanto tale è ormai ricacciato definitivamente nelle tenebre del passato, non è, però, venuto meno l’orizzonte di senso all’interno del quale esso si è generato e rispetto al quale siamo chiamati a fornire nuove risposte. Di quale orizzonte si tratta? Cosa condividiamo con la stagione tragica in cui è apparso il nazismo? Cosa, di esso, non solo non è passato, ma sta ancora, certo in forme diverse, davanti a noi? Si tratta del nodo che alla fine dell’epoca moderna si è stretto tra politica e vita biologica in una modalità che nella Germania degli anni Trenta ha avuto come esito la morte di massa, ma che non è detto debba assumere in futuro una simile connotazione mortifera. Come si sa, del fenomeno nazista – e dunque anche dello sterminio ebraico – sono possibili, e sono di fatto state proposte, numerose interpretazioni di carattere storico, politico, ideologico. Esso è stato, di volta in volta, collegato alla crisi dirompente della Prima guerra mondiale, ai caratteri particolari della storia tedesca, all’intreccio micidiale di tecnica, mito e volontà di potenza, all’esito parossistico dell’ideologia colonialista
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
194
Shoah, modernità e male politico
e imperialista, per non parlare del razzismo che da secoli scorreva nelle vene dell’Europa. Ma tutti questi elementi, presenti in varia misura e combinazioni, non bastano a dare conto della deriva nazista se disarticolati dal quadro categoriale all’interno del quale si sono generati, costituito dalla caduta delle mediazioni e dei filtri – istituzionali e concettuali – tra politica e vita biologica che avevano caratterizzato fino ad un certo punto la storia moderna. Mi riferisco al doppio processo di biologizzazione della politica e di politicizzazione della biologia intervenuto alla fine del XIX secolo. In particolare il razzismo, nella configurazione strettamente biologistica che ha assunto all’inizio del Novecento, non sarebbe comprensibile fuori da questo passaggio decisivo, cui una corrente della filosofia contemporanea ha conferito il nome di “biopolitica”. In realtà, a quanto è successo nella Germania degli anni Trenta e Quaranta – culminato nella vertigine del genocidio – meglio si attaglia il nome di “tanatopolitica”, di politica della morte. Ma, a sua volta, tale tanatopolitica non è riconoscibile nei suoi effetti catastrofici che in rapporto alla sovrapposizione tra politica e vita, di cui essa costituisce allo stesso tempo il rovescio e l’assoluta perversione. Il nodo cruciale su cui si è interrogato il pensiero contemporaneo, almeno a partire dalle ricerche di Foucault in argomento, è anzi proprio questo intreccio inestricabile tra politica della vita e pratica di morte. Come è stato possibile, egli si chiede in un passo cruciale di una delle sue lezioni, che una politica che ha posto al centro la difesa e lo sviluppo della vita biologica l’abbia poi destinata ad una pratica di morte? Di tale intreccio enigmatico tra politica della vita e pratica di morte esiste più di una prova. Basti pensare alla singolare coincidenza tra l’ideazione del piano Beveridge di intervento sulla salute mondiale e lo scoppio simultaneo di una guerra che ha fatto cinquanta milioni di morti. Non solo, ma anche alla circostanza, apparentemente inspiegabile o almeno singolare, che la Germania degli anni Trenta è stato il paese di gran lunga più avanzato nell’ambito della ricerca medica, soprattutto quanto alle cure per il cancro. Del resto lo stesso Hitler, notoriamente animalista, salutista e vegetariano, amava farsi chiamare “il grande medico tedesco”. Mai come nella Germania nazista, d’altra parte, i medici hanno svolto una funzione centrale, prima nell’ambito del sapere e poi, sempre più, anche in quello del potere allorché, all’avvento del regime, sono divenuti, insieme agli antropologi, l’ordine professionale più importante del paese, arrivando ad occupare posti di primo piano nell’amministrazione dello Stato. Quanto, poi, al loro ruolo specifico nella effettuazione dello sterminio, dalla selezione dei prigionieri alla loro soppressione materiale nelle camere a gas, per non parlare degli esperimenti su cavie umane, è troppo noto perché ci si debba
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
R. Esposito - Nazismo e Shoah
195
insistere, nonché attestato nei verbali dei processi cui i medici nazisti sono stati sottoposti a guerra finita. Resta, però, il problema di partenza: perché proprio coloro cui era, in linea di principio, affidata la custodia della vita umana si sono trasformati nei massimi sacerdoti della morte? Perché spesso la morte arrivava vestita col camice bianco dei medici? Certo, alcuni di loro lo hanno fatto per interesse personale e altri per una perversione manifesta. Ma non è stato così per tutti. Non è stato così per la maggioranza dei medici tedeschi. Molti credevano in ciò che facevano. Tutte le risposte che essi hanno dato negli interrogatori cui sono stati sottoposti vanno nella stessa direzione. Sopprimendo non solo il popolo ebraico, ma chiunque fosse ritenuto portatore di germi degenerativi, a partire dai tedeschi cosiddetti difettosi, sterminati nelle procedure di eutanasia che precedettero la guerra, essi dichiaravano di aver difeso il corpo sano della loro nazione dai rischi biologici che lo insidiavano dall’esterno e dall’interno. Tutt’altro che sentirsi assassini, quali di fatto erano, essi ritenevano di aver rispettato nel modo più coerente il giuramento di Ippocrate, asportando dal corpo malato della Germania il tumore che ne minacciava l’integrità e la crescita. Quanto agli antropologi, poi, spesso in piena sintonia con gli zoologi, essi si occupavano di ridefinire le soglie esterne ed interne della vita umana, confrontandola con quella animale ad essa contrapposta, ma anche sovrapposta, nella figura ibrida di uomini-animali, dichiarati simili o addirittura inferiori a bestie. Non a caso Humanitas si intitolava uno dei più noti manuali di igiene razziale, inteso, nella intenzione dell’autore, a proteggere la vera umanità dell’uomo dalle tare ereditarie e dalle malattie infettive sempre in agguato. Più che una specie diversa, l’animale era inteso come qualcosa che, all’interno del genere umano, lo separava da se stesso in due zone diverse e contrapposte, l’una destinata al servizio o anche alla scomparsa a favore dell’altra. A partire da questi presupposti si rende evidente la connessione antinomica che, in quelle circostanze, ha finito per congiungere biopolitica e tanatopolitica in un corto circuito che assunse la forma di una vera e propria voragine. Una volta assunta la vita biologica di un paese e di una razza come il bene supremo da difendere e potenziare, ad esso poteva ben essere sacrificata quella di altre razze che parevano minarne la salute e la potenza espansiva. Fuori da questo orizzonte biologico lo stesso razzismo sarebbe rimasto confinato ad uno stadio etnico-culturale o comunque non sarebbe sfociato necessariamente nella distruzione di massa. Da questo lato della questione si dimostra tutta la debolezza del paradigma, ancora oggi in voga, di “totalitarismo”, nella sua tendenza erroneamente omologante. Non a caso, usato anche con risultati apprezzabili
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
196
Shoah, modernità e male politico
da Hannah Arendt, esso si è poi rivelato incapace a definire la specificità della biocrazia nazista rispetto all’ideologia comunista. Ciò che di fatto gli sfugge è che mentre il comunismo ha come trascendentale, cioè come categoria costitutiva, la storia, come presupposto la classe e come lessico l’economia, il nazismo ha come trascendentale la vita, come presupposto la razza e come lessico la biologia. Da questo punto di vista, mentre il comunismo reale, colpevole anch’esso di orrori inauditi, non avrebbe mai potuto macchiarsi di un genocidio con le caratteristiche di quello perpetrato dai nazisti, il nazismo solo in esso doveva trovare il suo esito destinato. Senza il genocidio ebraico il nazismo non sarebbe esistito in quanto tale, perché, a differenza del comunismo, la sua catastrofica parabola è tutta inscritta dentro un orizzonte biopolitico, rovesciato e rinnegato in tanatopolitica. Da questo lato, tornando alla questione iniziale della nostra vicinanza a quegli eventi, si deve ammettere che, nonostante gli anni che ci separano dalla sua fine, il nazismo ci è in un certo senso più prossimo del comunismo. Mentre questo resta interno al tratto terminale della storia moderna – nasce all’interno delle sue categorie filosofiche –, il nazismo sporge da essa lungo una linea che per certi versi arriva fino a noi. Se siamo ormai fuori dalla filosofia della storia che ha prodotto, sul piano concettuale, il comunismo, siamo ben dentro quella filosofia della vita che, rovesciata nel suo opposto, ha prodotto il nazismo. 2. Ma tale caratterizzazione biopolitica, o anche tanatopolitica, non basta, di per sé, a definire il nazismo e, in particolare, il genocidio ebraico, se ad essa non si aggiunge un qualcosa di più, che ricondurrei alla categoria di “immunizzazione”. Come si sa, per “immunità” non si intende soltanto una pratica di protezione medica o, altrimenti, giuridica, di qualcuno nei confronti di un rischio che lo minaccia. Il termine “immunità” si contrappone logicamente a quello di “comunità”, di cui condivide l’etimo munus, che in latino significa “dono”, “ufficio”, “incarico”, rovesciandolo in negativo. Immunitaria è non soltanto una pratica di protezione, medica o giuridica che sia, nei confronti di un pericolo cui gli altri sono esposti, ma anche una forma di negazione della comunità stessa, una rottura della socialità, del nostro essere in comune gli uni con gli altri. Ora è proprio questa attitudine negativa, e anzi sterminatrice, che ha caratterizzato la biopolitica nazista, pervertendola in tanatopolitica. Intanto sotto il profilo del vocabolario, della mutazione e del terribile impoverimento linguistico che i nazisti hanno prodotto. Lo stesso Hitler in più di un’occasione aveva usato una terminologia immunologica, come
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
R. Esposito - Nazismo e Shoah
197
quando aveva dichiarato che la scoperta del virus ebraico è una delle più grandi rivoluzioni di questo mondo. Corrispondentemente gli ebrei vennero definiti dalla propaganda nazista “virus”, “microbi”, “bacilli”, “batteri”, “parassiti” che infestano, contaminandolo, il popolo tedesco, e da cui questo deve liberarsi combattendoli esattamente come si fa con una malattia infettiva – disinfestandosi e poi vaccinandosi. Quando Himmler arrivò ad affermare che l’antisemitismo è come la disinfestazione, la riduzione immunologica degli ebrei in virus letali era ormai effettuata. Essi non si comportavano solamente come parassiti, ma, agli occhi dei nazisti, lo erano effettivamente diventati. La scelta, che fu fatta, di costruire il ghetto di Varsavia in una zona già contaminata della città ebbe questo effetto performativo – quello, come si dice, di rendere reale una profezia, facendo degli ebrei realmente quei portatori di germi che si voleva vedere in loro. In questo modo il cerchio immunitario si chiuse su se stesso. Se essi erano di fatto ciò che sembravano essere – dei bacilli infettivi – non restava che mettere in pratica una sorta di derattizzazione generalizzata. Ma il lessico immunitario, nel caso della tanatopolitica nazista, vale anche nell’altro senso – quello del raddoppiamento del negativo implicito nella pratica medica di vaccinazione. Come, attraverso di essa, la malattia viene contrastata attraverso un frammento dello stesso male, così la possibile morte dell’organismo politico tedesco viene contrastata con la morte coatta di una parte dei suoi abitanti, necessaria a salvaguardare l’altra ancora non contaminata. In questo senso si ritenne che la vita – quella stessa vita posta al centro di tutte le dinamiche biopolitiche – potesse, e dovesse, essere salvata soltanto da una ingente immissione all’interno di essa del suo contrario. Che solo la morte su larga scala potesse contrastare validamente la tara che il corpo del popolo tedesco portava dentro. Così la morte divenne allo stesso tempo il fantasma, la malattia e la cura contro se stessa. Qui, perché il lessico immunitario assumesse la sua piena valenza, si era reso necessario un altro passaggio semantico, relativo appunto al concetto di “corpo politico”. Mentre questo termine, nel vocabolario politico classico, era stato da lungo tempo usato come una metafora, volta ad indicare l’unità inseparabile dell’organismo, con il nazismo slittava dall’ambito metaforico a quello reale – il popolo tedesco appariva davvero come un solo corpo unificato nella figura del suo capo. È solo allora che il paradigma immunitario potette invadere l’intero linguaggio del regime. Se quello che pareva attaccato non era solo un paese, ma un vero e proprio corpo vivente, allora esso non richiedeva soltanto una difesa militare, ma, prima ancora, una difesa medica, se non anche chirurgica. Visto che il rischio da
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
198
Shoah, modernità e male politico
cui esso doveva difendersi era, in ultima analisi, la morte, tale rischio poteva essere contrastato solo con la morte stessa di chi minacciava di farlo morire. Quando tutta la vita di un popolo apparve in gioco, solo la morte altrui sembrò tanto forte da prevenire la sua morte, attaccandola con le sue stesse armi. La morte dei suoi avversari, identificati innanzitutto negli ebrei, ma anche, alla fine, quella dei medesimi tedeschi. Già si è fatto riferimento alle pratiche di eutanasia che, prima della guerra, hanno colpito quasi 300.000 malati tedeschi, in buona parte donne e bambini. A tale numero va aggiunto quello degli aborti provocati per evitare figli non provvisti delle necessarie credenziali razziali. Ma a ciò bisogna aggiungere, almeno nelle intenzioni di Hitler, il numero di tutti gli abitanti tedeschi, quando, a guerra ormai persa e con i russi alle porte, egli dette l’ordine di suicidio collettivo. In tale ordine si può riconoscere il passaggio, a quel punto inevitabile, dal paradigma immunitario ad uno autoimmunitario – come quando, nel corpo umano, il sistema immunitario di difesa e di offesa contro l’altro da sé diventa tanto forte da battere contro se stesso, provocando l’esplosione dell’interno organismo. In tal modo quella morte invocata a difesa della vita finiva per ingoiarla in una forma che ha rischiato di non lasciare superstiti. E del resto i cinquanta milioni di morti della guerra scatenata dal nazismo sono la conferma ultima di cosa abbia significato la traduzione della biopolitica in compiuta tanatopolitica. 3. E adesso? Cosa ci lascia, come eredità e come compito, il crollo del nazismo? Quale è, e quale può essere, il mondo dopo il genocidio? Come questo ha cambiato, in modo per certi versi irreversibile, la storia contemporanea? Quando parlo di irreversibilità, naturalmente, non alludo alla possibile continuità di pratiche sterminatrici ormai improbabili, almeno in Europa, anche se anche qui, perfino nel nostro paese, ogni tanto ascoltiamo parole che non avremmo più voluto sentire. Parlo piuttosto di un mondo sempre più attraversato e governato da dinamiche biopolitiche, certo ben diverse da quelle consumate nella Germania nazista, ma non per questo meno accentrate sul controllo, la gestione e a volte anche la trasformazione della vita biologica. Rispetto alle quali da un lato non è possibile tornare indietro, dall’altro bisogna attrezzarsi a dar loro un segno diverso ed opposto a quello che hanno avuto nel Novecento. Chi si illudesse di poter ripristinare il lessico politico precedente la Seconda guerra mondiale, ancora unificato dalle categorie politiche di diritto individuale, società civile, Stato sovrano, sperimenterebbe una rapida delusione. Nulla, o assai poco, di quel
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
R. Esposito - Nazismo e Shoah
199
linguaggio è recuperabile in un mondo reso globale dalla centralità assunta dalla categoria di vita biologica. Una politica che oggi si chiamasse fuori da questo terreno, che non lo assumesse come presupposto inevitabile, che non parlasse il linguaggio della vita, anche direttamente biologica, degli individui, delle popolazioni e del mondo stesso perderebbe ogni legittimità e sfumerebbe nell’insignificanza. Ben aldilà dalla nozione moderna di soggetto astratto ed uguale, padrone delle proprie scelte informate e responsabili, tutte le questioni di politica interna ed internazionale hanno ormai a che fare con il corpo vivente delle donne e degli uomini, con i suoi bisogni, i suoi impulsi, i suoi desideri incontenibili ed incomprensibili nel vecchio lessico della cultura liberaldemocratica. La stessa idea di democrazia è ben lontana da quella in corso prima della guerra ed è, in un certo senso, finita con essa. Benché i riti e gli istituti democratici della votazione e della rappresentanza parlamentare siano ancora in piedi, essi sono del tutto svuotati di efficacia e di senso dentro quelli che possiamo ben definire gli attuali regimi biopolitici postliberali. Che ci piaccia o no, questa è la situazione cui dobbiamo confrontarci. Cosa ha a che vedere, questo discorso, con la memoria di quanto è accaduto nell’Europa degli anni Trenta? Con l’orrore dello sterminio ebraico? Si è detto che, in quelle forme, è ben difficile che qualcosa del genere possa oggi riprodursi, almeno nell’Occidente. Ciò vale già meno per altre forme di genocidio, ancora operanti soprattutto in paesi non occidentali. Ma quanto è recentemente avvenuto nella ex Iugoslavia ci rammenta che nulla, nella storia, è passato per sempre. Anche in quel caso una pretesa politica della vita, intesa ancora nel senso del razzismo etnico, ha prodotto un numero insopportabile di vittime. Tutto ciò mentre, soprattutto nell’ultimo decennio, si è scatenata una nuova guerra di religione, anch’essa sempre a rischio di trasformarsi in un catastrofico scontro di civiltà. In questo quadro, reso ancora più fosco dall’attuale crisi economica, è inimmaginabile rivolgere lo sguardo al vecchio ordine politico moderno, a quel ius publicum europaeum uscito dalla pace di Westfalia e organizzato nel concerto degli Stati sovrani, arbitri ciascuno del proprio destino. Tutto ciò è irreversibilmente finito, come anche il sistema bipolare di un mondo diviso tra le due superpotenze, travolto dal crollo del muro di Berlino e dalla fine del comunismo – anche se non mi pare che il capitalismo vincente stia oggi troppo bene. Ma anche qua non dobbiamo illuderci: la caduta del muro di Berlino, anziché segnare la fine di ogni muro divisorio, ha determinato l’innalzamento di tanti piccoli muri che di nuovo dividono il mondo con barriere non meno escludenti. Perfino gli Stati nazionali tendono a frammentarsi in comunità regionali spesso armate, almeno da
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
200
Shoah, modernità e male politico
un punto di vista ideologico, l’una contro l’altra, come anche in Italia abbiamo avuto il modo di sperimentare. Ciò nasce dal fatto che, negli odierni regimi biopolitici, pur nella loro diversità da quelli novecenteschi, tende a prevalere ancora una volta quel paradigma immunitario che ha condotto, nella sua esasperazione, ai risultati devastanti che conosciamo. Si può anzi dire che esso, tutt’altro che venire meno, sia uscito addirittura rafforzato dalle dinamiche di globalizzazione – come una sorta di rifiuto, o di rigetto immunitario, rispetto alla contaminazione che esse hanno rappresentato. Quanto più il mondo è apparso unificato da un flusso senza confini di idee, uomini, tecniche apparentemente irresistibile, tanto più le comunità, e a volte persino gli individui, vanno chiudendosi in pratiche autoreferenziali e ostili al rapporto con gli altri. Qui se non c’è una minaccia accostabile a quella nazista, c’è sicuramente un rischio crescente che non può lasciarci inerti. Lo stesso conflitto in corso tra fondamentalismi religiosi – compreso quello occidentale, raccolto intorno all’idolo del denaro e della sua riproduzione, chiuso nel proprio egoismo non meno di quello islamico, a sua volta chiuso in se stesso per difendersi dalla secolarizzazione occidentale – è nel suo insieme interpretabile come una generale crisi immunitaria, come l’esito dello scontro tra due monoteismi politici, tra due mentalità contrapposte, ciascuna con la pretesa di essere portatrice dell’unica verità. Da cosa altro sono nate le due guerre mondiali del Novecento, con tutte le catastrofi umanitarie che le hanno precedute e seguite, se non da una simile pretesa? Se non da una interpretazione immunitaria, e a volte autoimmunitaria, della biopolitica in atto? Io credo che il modo migliore di ricordare la Shoah sia oggi quello di non fuggire da questa realtà, richiamandoci in maniera nostalgica quanto ineffettuale al lessico politico prebellico. Quello di cui si tratta, per testimoniare nel senso più concreto la nostra lontananza, ed il nostro orrore, rispetto a ciò che è accaduto in Europa settanta anni fa, è piuttosto invertire l’asse di senso dei nostri regimi, ormai irreversibilmente biopolitici, in una direzione contraria a quella che fu percorsa allora, quando si spinse la politica della vita a ridosso di una pratica di morte. Quello – ecco il punto che a volte pare sfuggire – non fu l’esito della centralità che la vita biologica ha assunto all’interno della pratica politica, ma il risultato della sua conversione immunitaria e anche autoimmunitaria. Perciò, ciò che occorre fare, per evitare i risultati distruttivi ed autodistruttivi cui allora si pervenne, non è cercare, invano, di sciogliere il nodo stretto alla fine dell’epoca moderna tra politica e vita, ma di spingerlo nella direzione di quel mondo in comune che dispositivi immunitari sempre più potenti hanno progressivamente svuotato o spezzato. Cosa con ciò si debba, o possa, intendere –
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
R. Esposito - Nazismo e Shoah
201
nell’ambito sociale dell’immigrazione; in quello, giuridico, della giustizia internazionale; in quello, politico, dei rapporti tra gli Stati sovrani – non è il tema di quest’intervento. Quello che volevo indicare è il rapporto, non sempre visibile, non sempre visto, tra l’evento più tragico del Novecento e le questioni decisive che abbiamo ancora di fronte.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
203
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
MASSIMO GIULIANI
LA MISURA DELLA RESPONSABILITÀ DOPO AUSCHWITZ
Nella quarta delle sue dieci tesi, scritte a conclusione di un’indagine sul “male radicale”, il filosofo americano Richard Bernstein afferma che dopo Auschwitz, dobbiamo rinunciare a ogni idea di happy end, ossia all’aspirazione a una sorta di armonia cosmica nella quale il male estremo e la sofferenza [indotta da violenza politica] siano funzionali a quell’armonia. Dopo Auschwitz, è osceno continuare a parlare del male e della sofferenza in modo da giustificarli grazie a, oppure riconciliarli con, uno schema cosmologico benevolo... [Al contrario] essi costituiscono delle rotture e degli iati, delle ferite e degli abissi; sono mali così profondi che una guarigione completa è impossibile. (Bernstein 2002: 229)
Anche a distanza di molti decenni dalla Shoah noi sentiamo una contemporaneità con quegli eventi, che hanno segnato per sempre la storia della civiltà occidentale, e percepiamo di vivere – al di là del cambio di secolo e persino di millennio – “nell’età di Auschwitz”. Un profondo disagio verso il conatus filosofico che vorrebbe farsene una ragione e verso la qualità del male, che è l’eredità tragica del XX secolo, è divenuto il nostro inevitabile punto di partenza per ogni ulteriore esplorazione della natura umana. Ahinoi, tale esplorazione ci è possibile solo con la rinuncia consapevole all’aspettativa per cui essa potrebbe davvero gettare una nuova luce sulle leggi che governano il potere e le potenzialità dell’umano date certe circostanze sociali e politiche, o forse potrebbe saggiamente prevenire l’aggressività umana o addirittura sradicare i pregiudizi e le loro degenerazioni in pogrom, in persecuzioni violente e/o in forme di genocidi. 1. È possibile riconciliarsi con l’eredità del XX secolo? Sulla base di tali premesse, è nell’ordine morale delle cose che noi – le generazioni post-Auschwitz – si voglia e si debba elaborare le cause
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
204
Shoah, modernità e male politico
di quel disagio filosofico e, alla fine, accettare la situazione paradossale, esperita soprattutto dai filosofi morali, di non essere in grado di “qualificare” la Shoah semplicemente scegliendo tra approcci diversi: è solo un caso di male politico, oppure è davvero un caso di “male radicale” (nel senso kantiano-arendtiano del termine)? E ancora, proprio a partire dalla pletora di dibattiti scaturiti dal famoso report gerosolimitano di Hannah Arendt: come interpretare l’aggettivo “radicale”, quando esso è associato a una tale vasta nuova forma di male e di malvagità? Vi è un certo grado di ambiguità persino nelle espressioni meglio intenzionate e assai frequenti del tipo “dopo Auschwitz, il pensiero non può che ripartire daccapo”. Perché ripartire daccapo o, come suona il titolo di un famoso convegno, parlare di beginning of a new era1, di un “nuovo inizio”, quando ciò di cui avremmo invece bisogno è una migliore comprensione dello scacco e del fallimento del presunto “vecchio pensiero” e della “vecchia era”, grazie al quale e nella quale è stato possibile che Auschwitz si verificasse? Non dovremmo piuttosto fare i conti con l’inevitabile continuità del nostro fare ricerca e insegnare all’interno delle categorie tradizionali che pur si sono mostrate insufficienti a comprendere, non dico a prevenire, la debacle delle ideologie fascista e nazista? Dopo tutto, nelle nostre università diamo ancora corsi su Martin Heidegger, nonostante il fatto che questo filosofo abbia “mancato la prova” come public intellectual nell’ora più buia della moderna storia europea. Non v’è dubbio che il pensiero heideggeriano fosse, sotto certi aspetti, innovativo e provocatorio dal punto di vista della storia della filosofia; nondimeno, è stato eticamente muto dinanzi al male, se non corresponsabile, e dunque ingiustificabile dinanzi al tribunale della storia. Potremmo concludere, ancora una volta con Arendt, che Auschwitz è Auschwitz esattamente perché ha esaurito e svuotato la stessa cogenza di ogni pensiero morale, gli stessi standard della moralità, nonché l’affidabilità della ragion filosofica così come siamo venuti costruendola nella nostra tradizione occidentale. Ma anche accettando questa disincantata conclusione, il compito della nostra generazione è quello di mettere a registro, verificare e misurare la capacità delle nostre categorie morali e dei nostri standard etici a essere implementati in situazioni estreme. Forse la Shoah non ha dato origine a un nuovo concetto di essere umano o a una visione più ampia della condizione umana, 1
Auschwitz: Beginning of a New Era? è il titolo di un simposio internazionale sulla Shoah tenutosi nella cattedrale anglicana Saint John the Divine a New York nel 1974, uno dei primi a far dialogare storici, rabbini, filosofi/e ebrei/e e teologi/ghe cristiani/e delle diverse confessioni e a scandagliarne le implicazioni sociali e pedagogiche.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
M. Giuliani - La misura della responsabilità dopo Auschwitz
205
ma certamente ci ha forzati a ripensare e a revisionare quelli vecchi e a cercare nuove forme di responsabilità – in inglese direi di accountability – per le azioni umane e a instaurare nuove e migliori pratiche giuridico-politiche tese a difendere i senza-diritti, oltre che i valori etici e la dignità di tutti gli esseri umani. In tal senso può essere utile rimeditare una pagina scritta da Tzvetan Todorov oltre vent’anni fa, nella quale il filosofo bulgaro si chiedeva: Che cosa sappiamo di più della natura umana, dopo Kolyma e Auschwitz? L’uomo è fondamentalmente malvagio, homo homini lupus, come sosteneva Hobbes, o è naturalmente buono, come affermava Rousseau? Personalmente non penso che da queste esperienze estreme si possa trarre un nuovo insegnamento sulla natura dell’uomo. Né le teorie ottimiste del progresso né quelle, apocalittiche, del declino possono appellarsi all’esperienza dei Lager. Oggi è chiaro che il totalitarismo è peggiore della democrazia. Quanto agli esseri umani, per natura essi non sono né buoni né cattivi, oppure sono l’una e l’altra cosa: l’egoismo e l’altruismo sono egualmente innati. Ma si chiedeva Vasilij Grossman: “La natura dell’uomo subisce una mutazione nel crogiuolo dello Stato totalitario?” (Todorov 1991: 155-56)
Queste sono le domande e i problemi che fino a oggi molti pensatori politici e morali hanno cercato di eviscerare. Ma ciò che in vero sappiamo di più circa la condizione umana, nell’epoca della possibilità di Kolyma e Auschwitz, è il grado di difficoltà di saggiare la ragione stessa, ovvero di far sì che a dar conto e a rispondere sia un intero sistema, dato che per definizione responsabili, di solito, sono le persone e non i sistemi o le macchine burocratiche o le società anonime o, in sintesi, lo Stato totalitario o semplicemente lo Stato come una totalità. A ben vedere, come può un tribunale processare un ethos sociale degenerato o la mancanza di scrupoli morali di un gruppo politico, soprattutto quando si organizzano in sistema e vengono legittimati come Stato moderno o parte di un’istituzione apparentemente democratica? La questione della “imputabilità” di un crimine è essenziale per un processo, e lo è anche per un processo agli standard etici di una società o di una civilizzazione. Naturalmente questo tipo di processo non è nelle mani di un sistema giuridico nazionale, e men che meno internazionale (come ha mostrato proprio il processo di Norimberga, così acutamente criticato da Arendt). Esso è, forse, nelle mani di qualche autorità morale transnazionale o, più probabilmente, nelle sanzioni dettate dai vincitori (appunto, come nel caso del processo di Norimberga). Ma, da un punto di vista più filosofico, la domanda diventa: come la ragione – che degenera moralmente – può mettere se stessa in discussione e sotto processo, dato che ogni sistema rivendica una qualche razionalità, almeno per se stesso?
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
206
Shoah, modernità e male politico
Definire un concetto di umanità dinanzi ai limiti posti da una “ragione insana” è divenuto nel tempo il compito più difficile, la vera crux di ogni pensatore che desideri dar conto – making sense – dei tragici eventi del XX secolo. Così il mantra del “pensare ancora”, del “ri-pensare” e “ri-definire” i limiti della ragione umana resta vero a dispetto del suo risuonare altamente retorico. Come possiamo infatti continuare ad accettare espressioni del tipo: “la colpa è del sistema”, oppure “nella moderna catena dei poteri la responsabilità viene meno”? O dovremmo, con più coraggio, riesumare l’idea di “consapevolezza” allorché trattiamo di sistemi complessi (come uno Stato) o di agenti/società globali (come transnational companies) o persino di mercati (come le filiere di produzione-vendita-consumo di beni alimentari)? A me pare che problemi come l’imputabilità dei crimini globali – contro l’umanità ma anche contro la sostenibilità del pianeta, gli ecosistemi, la qualità di beni pubblici come acqua e aria – oppure la prevenzione della dissoluzione della responsabilità nell’anonimato di una catena di decisori, oppure il livello di coscienza individuale e sociale, ecc., siano assai analoghi a ciò che, più di vent’anni fa, Zygmunt Bauman ha chiamato “le conseguenze morali del processo di civilizzazione”. Nell’introduzione al suo testo Modernity and the Holocaust, Bauman ha spiegato come [sia] necessario valutare attentamente il fatto che il processo di civilizzazione si presenta, tra le altre cose, come un processo che sottrae l’uso e lo spiegamento della violenza al giudizio morale e svincola i criteri di razionalità dall’interferenza delle norme etiche o delle inibizioni morali. Poiché la promozione della razionalità a principio che esclude criteri di azione alternativi e, in particolare, la tendenza a subordinare l’uso della violenza al calcolo razionale sono state da tempo identificate come aspetti costitutivi della civiltà moderna, i fenomeni che rientrano nella logica dell’Olocausto devono essere riconosciuti come esiti legittimi del processo di civilizzazione e come suo costante potenziale. (Bauman 1989: 50)2
Da queste acute e inquietanti considerazioni deduco che esiste un legame profondo tra la possibilità di costringere un sistema a render conto delle sue decisioni e il permesso concesso alle regole e alle inibizioni morali di interferire nei processi razionali globali della nostra vita moderna. Dopo i genocidi e le grandi catastrofi indotte dall’uomo nel corso del XX secolo, reinstallare sentieri etici al cuore dei meccanismi giuridico-economico-politici che regolano le società occidentali ha costituito la preoccupazione principale “post-Olocausto e post-arma atomica” di filosofi ebrei 2
Su questo tema, si veda anche Goisis 2011.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
M. Giuliani - La misura della responsabilità dopo Auschwitz
207
come Hans Jonas ed Emmanuel Lévinas, ai cui nomi possiamo aggiungere naturalmente quelli di Günther Grass, Theodor Adorno, Emil Fackenheim, la stessa Arendt e molti altri, i cui sforzi intellettuali si sono concentrati proprio nella ri-definizione e nel ri-posizionamento dell’essere umano nel mondo al fine di istillarvi un senso di maggior responsabilità/obbligazione e una più vasta coscienza etico-politica. 2. Maggior responsabilità e più vasta coscienza etico-politica È ormai un ragionamento comunemente accettato quello per cui Auschwitz fu possibile, tra le altre cause, a motivo dell’enorme avanzamento della tecnologia reso disponibile da ciò che chiamiamo modernità, e in particolare dalle diverse rivoluzione industriali europee. Non va dunque provato: la tecnologia moderna non fu causa sufficiente ma certamente fu causa necessaria. Hans Jonas, soprattutto nei suoi anni americani, ha avuto il merito di approfondire questo punto, il cui significato è persino più ampio del raggio di pensiero della Shoah. Lawrence Vogel, il curatore di alcuni saggi di Jonas – a cui fu dato l’intrigante sottotitolo A Search for Good After Auschwitz –, ha sintetizzato le premesse sulle quali Jonas costruisce il suo “principio responsabilità” opponendolo al “principio speranza” di Ernst Bloch. Scrive Vogel: Oggi la tecnologia ha alterato la struttura stessa dell’agire umano permettendoci di influire sulla natura, sia dentro sia fuori di noi stessi, in modi che sono di lunga durata, cumulativi, irreversibili e su scala planetaria. Purtroppo, l’etica tradizionale ha sempre supposto che gli effetti delle nostre azioni fossero abbastanza limitati. Ad eccezione della medicina, la tèchne è sempre stata reputata come eticamente neutra o neutrale. I significati etici appartenevano al regno dei rapporti umani, ma non intaccavano il rapporto tra uomo e natura. L’umanità era una costante, un dato, non un oggetto che potesse venir forgiato o cambiato dalla tèchne. Mentre le azioni immediate potevano essere giudicate un bene o un male morali, le conseguenze lontane erano lasciate al caso, al fato o alla provvidenza. Ma tutto questo è drasticamente cambiato con l’avvento della moderna tecnologia, e pertanto le etiche tradizionali ci sono apparse strumenti insufficienti per dar conto o costringerci a dar conto delle nostre responsabilità allorché sia in gioco il futuro stesso dell’umanità. (Vogel 1996: 5)
In questa riflessione, Vogel va oltre il fatto assodato che, senza dubbio, Auschwitz ha mostrato la fragilità del principio per cui «i significati etici appartenevano al regno dei rapporti umani», anzi per alcuni aspetti lo ha messo in crisi. Il motore di questa considerazione sta piuttosto nella quan-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
208
Shoah, modernità e male politico
tità e nella qualità del potere tecnologico che viene a sfidare, o meglio, che fa venir meno la possibilità per noi di mantenere qualcosa “costante” e di agire in un modo etico non irreversibile. È degno di nota che, in un periodo come quello degli anni Cinquanta e Sessanta, allorché la temperie filosofica dominante era segnata dal prevalere dell’esistenza sull’essenza – Heidegger e Sartre ne furono i padri ispiratori sulle due sponde dell’Atlantico –, Hans Jonas, in controtendenza, osava riflettere sull’essenza delle cose: l’essenza della natura biologica della vita, l’essenza della natura morale dell’uomo, l’essenza della scienza e della tecnologia in rapporto alla storia dell’umanità. Probabilmente fu questo approccio così audace e contro-culturale che gli permise di pensare alla cura del futuro lontano dell’umanità, e al contempo di vedere Auschwitz come un evento di portata cosmologica, ossia un set di azioni storiche e del tutto umane attraversato tuttavia da un significato teologico, vale a dire tale da “impattare” e influenzare la divinità stessa (si veda a riprova il ben noto saggio su Il concetto di Dio dopo Auschwitz; Jonas 1987). Per citare lo stesso Jonas: Il potere umano e i suoi odierni eccessi, che ci privano del tutto della possibilità di fare previsioni certe circa le sue conseguenze, ha assunto tali enormi dimensioni che persino l’esercizio quotidiano dei nostri poteri – che rende possibile la routine della civiltà moderna e dal quale tutti dipendiamo – è diventato un problema etico. (Jonas 1996: 103)
Gli eccessi del potere umano sono, invero, il potenziale di quello stesso potere e gli sono intrinseci, e soprattutto le loro conseguenze sono al di là della nostra capacità di previsione e predizione. Ecco il cuore della sfida etica per le civiltà moderne, sostiene Jonas. Da qui viene la sua urgente preoccupazione di riformulare un nuovo principio categorico, capace di allargare la massima di Kant sui valori universali e di contro-bilanciare il mero formalismo dell’antica etica kantiana. Per Jonas, il compito era ed è quello di “ri-mettere Kant a disposizione” dopo il fallimento dell’interpretazione che di Kant aveva dato Heidegger. Come chiarisce ancora una volta Lawrence Vogel, «Jonas fa risalire il “salto” di Heidegger nel nazismo all’“assoluto formalismo della sua filosofia della decisione” nella quale “non per cosa o contro cosa uno si decide, ma il solo fatto che uno decide diventa il marchio di autenticità del Dasein autentico» (Vogel 1996: 7-8). L’inclinazione jonasiana a parlare del bene-in-sé o dell’ordine delle cose o persino di teleologia può sembrare un vezzo retorico, oltre che demodé, a rischio di dogmatismo. Al contrario, in Jonas questo linguaggio è stato una forma di resistenza contro l’abuso di una razionalità che aveva perso il senso
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
M. Giuliani - La misura della responsabilità dopo Auschwitz
209
dell’etica, che aveva smarrito la direzione e abbisognava di ritrovare (kantianamente) i propri limiti e dunque il suo vero valore e la sua autentica dignità. Filosoficamente è stata una battaglia per il senso della stessa autenticità, e non a caso tale categoria ritorna centrale nell’opera di Emil Fackenheim. Pensare daccapo l’intero fenomeno del potere e le inedite potenzialità umane significa andare alle radici di una nuova etica, con le sue stratificate dimensioni a livello personale come a livello politico, con le sue giustificazioni sia nella storia sia nella meta-fisica, dato che, con la comprensione del potere – anzi, proprio nel segreto svelato dell’essenza della potenzialità umana – sta la più alta giustificazione di una prassi responsabile e, ancor più rilevante da una prospettiva filosofica, della stessa responsabilità elevata a imperativo categorico. Ancora una volta non v’è esempio migliore del caso di Heidegger. In un saggio che revisiona lo stato della filosofia alla fine del XX secolo, letto a Monaco nel 1992, Jonas sfida il suo auditorio tedesco menzionando la condotta del suo antico maestro nel 1933 e interrogandosi retoricamente: Ciò ha qualcosa a che fare ciò con la filosofia? Ai miei occhi, sì. Sin dai tempi più antichi la filosofia, diversamente da ogni altra branca della conoscenza, è stata guidata dall’idea che il suo scopo forgia non solo il suo sapere ma anche i comportamenti dei suoi discepoli, che sono particolarmente votati al servizio del Bene, che è dopo tutto il fine stesso della conoscenza. Alla fin fine, il training filosofico nel discernere tra i valori dovrebbe proteggere i suoi seguaci dal farsi corrompere e infettare da ciò che pensa la massa [...]. Dunque, allorché il più profondo filosofo del mio tempo cedette al fascino dei battaglioni delle camicie brune di Hitler non si trattò soltanto di un’amara delusione personale, ma assurse, ai miei occhi, a emblema del fallimento della filosofia. La filosofia stessa, non un uomo, era finita in bancarotta [...]. Il raro calibro del filosofo in questione trasformò quel fallimento in un evento storico. Ma vi porterò un contro-esempio, che fa nascere ulteriori domande. Tra i miei docenti vi era anche Julius Ebbinghaus, un kantiano rigoroso e non incline a compromessi, certo non paragonabile a Heidegger quanto a originalità. Ebbene, egli superò il test egregiamente, e appena lo seppi andai a fargli visita a Marburgo già nel 1945, per rendergli onore. Egli mi guardò negli occhi con quel vetusto fuoco che è tipico della convinzione interiore e mi disse: “Lo sa, Jonas? Senza Kant, non avrei avuto la forza di resistere al nazismo”. Compresi allora che in quest’uomo teoria e vita erano un tutt’uno. Ora, dei due miei insegnanti, in quali mani la filosofia si sarebbe salvata? Nelle mani del genio creativo la cui profondità non era riuscita a evitargli la caduta nell’ora della prova, o nelle mani di questo suo collega per nulla originale e tuttavia moralmente retto? Ad oggi non presumo di avere una risposta a questa domanda, ma credo che la domanda stessa – senza risposta – appartenga al panorama autentico del XX secolo. (Jonas 1996: 49)
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
210
Shoah, modernità e male politico
Dobbiamo rispettare il desiderio di Jonas di lasciare questa domanda senza risposta e la questione, per così dire, irrisolta. Ciononostante, il senso di questo racconto, che diventa una parabola moderna, è già una risposta e un giudizio a favore della sostanza etica degli insegnamenti kantiani contro ogni interpretazione formalista tesa a giustificare l’impossibilità o incapacità di scegliere il bene e prendere una decisione etica dinanzi al potere. Il dovere per il dovere, certo, fu anche l’argomento usato da Adolf Eichmann durante il processo che lo vide imputato a Gerusalemme per “crimini contro il popolo ebraico”, ma di converso una citazione di Fichte servì da argomento usato contro il nazismo da parte del leader della Rosa Bianca Kurt Huber nel processo di Monaco a suo carico nell’aprile 1943 (e gli costò la pena capitale). Proprio riferendosi a quest’ultimo caso, il filosofo ebreo-tedesco Emil Fackenheim ha affermato che Huber, e non Heidegger, ha garantito un futuro alla filosofia (Fackenheim 1982: 225-36). 3. La “passione di Israele” e le altre “passioni”: la lezione di Lévinas Sopra ho menzionato, accanto al nome di Jonas, quello di Emmanuel Lévinas. Questo intellettuale francese ha scritto un capolavoro filosofico – Autrement qu’être – che è dedicato, in ebraico, ai suoi familiari vittime della Shoah, e che può e deve essere considerato una delle risposte più radicali del pensiero ai campi nazisti di concentramento e di sterminio; e tuttavia, in tale opera i nomi di Auschwitz e degli altri luoghi simbolo delle tragedie del XX secolo non compaiono mai né sono, in modo intenzionale ed esplicito, evocati. È come se Lévinas avesse sentito una specie di vergogna o di pudore nel parlare di tali vittime, delle loro sofferenze, della loro morte. Ed è come se egli avesse preferito coprire un tale insopportabile ammontare di sofferenze – causato da quell’odio razziale e sciovinista che chiamiamo antisemitismo – con una nuova cifra linguistica, a tratti ripetitiva e quasi ossessiva ma capace di veicolare e articolare sensibilità, prossimità, vulnerabilità, passività, sostituzione, oblazione, offerta di sé come ostaggio, espiazione e soprattutto responsabilità pour autrui, per altri... Si tratta di uno strano linguaggio per esprimere i traumi della Shoah. Ma proprio dentro questo linguaggio Lévinas ha elaborato il progetto filosofico più arduo e ambizioso mai tentato dal 1945, ossia il progetto di rifondare la filosofia stessa, di capovolgerne il senso di marcia (a partire dal fallimento di Heidegger) e invertire il trend dell’intero pensiero occidentale moderno. Non è facile individuare un pensatore che sia più distante da Hans Jonas (l’unico punto in comune sembrerebbe la critica all’erede di Husserl, che fu maestro ad entrambi). Perché allora Lévinas ha percorso una strada così complessa per rispondere alla “filosofia
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
M. Giuliani - La misura della responsabilità dopo Auschwitz
211
dell’hitlerismo” (espressione levinasiana già nel 1934)? E perché ha taciuto della sua esperienza di prigioniero politico negli anni della guerra? Solo di recente i suoi diari sono stati pubblicati e tradotti dal francese, aiutandoci enormemente nella comprensione della sua opera (Lévinas 2009). A dispetto dell’eloquente silenzio cui ho appena accennato, nei testi levinasiani (soprattutto nella raccolta Difficile libertà; Lévinas 1976b) sono sparsi qua e là significativi frammenti sulla sua esperienza di prigionia e sulla Shoah. In questi testi la Shoah è “allusa” attraverso una metafora che suonerebbe scandalosa se fosse proferita da altri, che non sia appunto un Lévinas. Si tratta della metafora della Passione, termine/icona con cui il cristianesimo sintetizza la sofferenza e la morte salvifica di Cristo. Non v’è, in questa nominazione, alcuna lettura meta-testuale. È solo una metafora o una citazione semplice e diretta, forse venata da un pizzico di polemica, presa a prestito da uno dei più potenti simboli della civiltà occidentale (si pensi alla sua rappresentazione nell’arte o nella letteratura). Con tale prestito, l’ebreo Lévinas ci forza a un improvviso ripensamento, dovuto al capovolgimento di significato del simbolo stesso, che in questa sua nuova applicazione storica “significa” non più la cifra familiare e ormai pacificata della grazia e della redenzione cristiana, ma piuttosto il colmo della disgrazia e della derelizione ebraiche, la sintesi delle sofferenze dei giusti nonché le loro discriminazioni e persecuzioni. Usando la metafora della “Passione di Israel”, Lévinas traduce in parole le immagini già usate, negli anni Trenta e Quaranta del XX secolo, dal pittore ebreo Marc Chagall in una serie di quadri appunto dedicati alla crocifissione di Gesù – un Gesù che ha un tallit (manto rituale ebraico) come perizoma – e nei quali sono raffigurate scene dalla lunga storia di odio antigiudaico: espulsioni, pogrom e una micro-shoah come la cacciata degli ebrei dalla penisola iberica. Usato per dire la recente tragedia ebraica, il vecchio simbolo cristiano della Passione viene ad assumere un inedito, duplice significato: da una parte sottolinea il profondo e imbarazzante legame tra la Shoah e la secolare tradizione dell’“insegnamento del disprezzo” cristiano verso ebrei ed ebraismo, dall’altra eleva quella specifica sofferenza degli ebrei a vero “olocausto”, tingendo la Shoah di un’aura sacra e universale, evento che dovrebbe ispirare rispetto e timore da custodire in un memoriale. Memoriale di cosa? Nel codice di Lévinas, ossia il linguaggio dell’ontologia e della metafisica occidentali, senza dubbio ciò che va ram-mentato e ri-cordato è – in una sinergia di mente/ragione e cuore/emotività – il senso e il primato dell’obbligazione verso l’altro/gli altri anche quando, o meglio soprattutto quando l’altro non ha gridato nella mia direzione, non mi ha (ancora) chiamato o non ha (ancora) gridato. Questa è la chiave del pensiero etico di Lévinas: io
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
212
Shoah, modernità e male politico
sono impegnato nei confronti dell’altro/degli altri indipendentemente dalla mia decisione di esserlo. Ciò che va tenuto sempre a mente e posto al cuore della nostra responsabilità per altri è la radice stessa del nostro essere semplicemente, totalmente e radicalmente umani. Il sentiero etico descritto con linguaggio fenomenologico da Lévinas è un modo nuovo, dopo Auschwitz e a motivo di Auschwitz, di rimodellare il significato di “essere umano”, ossia un essere nel quale il potere deve collimare e farsi congruente con la responsabilità, nel quale vale il principio: maggiore il potere sull’altro/gli altri e maggiore è la responsabilità per l’altro/gli altri. Su questo punto le intuizioni di Jonas e Lévinas sembrano convergere e rafforzarsi reciprocamente, nonostante i differenti contesti di elaborazione delle loro filosofie. Rileggiamo un passaggio da Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, nel quale il trauma della Shoah/Olocausto/Passione ebraica è pensato attraverso le categorie della più radicale rivoluzione che il mondo occidentale abbia mai conosciuto: non le categorie del perdono o della sublimazione della sofferenza in strumento semi-magico di redenzione spirituale (il paradigma o la tentazione del cristianesimo), quanto invece le categorie di assumersi il compito – una responsabilità così alta da sembrare impossibile – di educare il carnefice, di restituire il bene a chi ci ha fatto del male, e di elaborare e trasformare il trauma in un’opportunità per espiare anche per il carnefice. Parlando della soggettività, Lévinas cita il Tanakh (la Bibbia ebraica), la meghillà Eichà (Lamentazioni) 3,30, che commenta con parole e concetti eticamente straordinari: “Presenti la guancia a chi lo percuote e sappia saziarsi anche d’oltraggi” [...] non significa trarre dalla sofferenza una qualche virtù magica di riscatto, ma passare, nel trauma della persecuzione, dall’oltraggio subìto alla responsabilità per il persecutore e, in questo senso, dalla sofferenza all’espiazione per altri [...]. La soggettività del soggetto è la responsabilità o l’essere-in-questione sotto forma di esposizione totale all’offesa, nella guancia tesa verso colui che percuote. Responsabilità anteriore al dialogo, allo scambio di domande e risposte, alla tematizzazione del Detto che si sovrappone alla mia messa in questione per l’altro nella prossimità e che, nel Dire della responsabilità, si produce come digressione [...]. L’unicità di sé è il fatto stesso di portare la colpa d’altri. Nella responsabilità verso Altri, la soggettività non è che questa passività illimitata di un accusativo. (Lévinas 1978: 139-40)3
Gli interpreti più acuti di Lévinas, come Paul Ricoeur, lo hanno criticato proprio su questo punto, ossia sulla mancanza di spazio allocato al tema 3
Cfr. Paris 2012.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
M. Giuliani - La misura della responsabilità dopo Auschwitz
213
della giustizia e alle risposte sociali – non soggettive e individuali – al male quando si presenti in forme pubbliche, politiche. L’etica levinasiana è così esigente ed estrema che può, forse, soddisfare i più elevati standard di moralità, ma fallisce o non riesce ad aderire alla capacità umana di dar conto di un dolore subìto ingiustificatamente, di un’ingiustizia o anche solo di un’offesa verbale. E tuttavia, il carattere iperbolico di questa riflessione etica non ne diminuisce il potente, grandioso messaggio: la nostra responsabilità, per definizione, è infinita e il solo potere che non conosce limiti è precisamente il potere di prenderci cura dell’altro/gli altri. Al fine di cogliere pienamente la radicale necessità di ripensare le nostre vecchie categorie etiche e di riformularne di nuove è fondamentale sentire e assimilare intellettualmente ciò che all’inizio ho chiamato “il nostro essere contemporanei ad Auschwitz”. Ciò implica un profondo ascolto del grido mai esaurito delle vittime, l’eco dei loro traumi, il senso irredimibile di perdita che affiora dalle loro testimonianze accorate e angosciate (lettere, diari, poesie, memoriali, ecc.). Ed implica anche, in un modo meno evidente, un’altrettanto profonda interrogazione su ciò che inquieta e disturba la nostra coscienza quando consideriamo e meditiamo – come suggerisce Primo Levi – quegli eventi, e su ciò che resta, dopo tutto, della nostra fiducia nella ragione umana, nel progresso, nella scienza e nel potere della tecnologia. Il già citato filosofo e teologo ebreo Emil Fackenheim ha insistito sull’universalità della lezione che possiamo e dobbiamo apprendere dalla Shoah precisamente perché, come scrive in To Mend the World, «l’Olocausto mette in questione non solo questo o quel modo di essere umani, ma tutti i modi. L’Olocausto costituisce una rottura per le civiltà, le culture e le religioni, non dentro questo o quel contesto storico e sociale ma dentro ogni possibile contesto» (Fackenheim 1982: 224)4. Poiché la lezione è universale, senza ignorare e nulla togliere a ciò che essa ha di specifico come tragedia del popolo ebraico e come effetto di precise cause e concause, è ragionevole prendere con serietà i sentieri etici tracciati dai maestri illuminati e dai testimoni sopra evocati. Tra di loro vorrei raccomandare la lettura di Primo Levi e di Jorge Semprún, che non furono filosofi in senso tecnico ma le cui opere hanno avuto, e ancora hanno, un impatto grande e profondo sulla ricerca filosofica contemporanea del bene dopo Auschwitz. Mi sia pertanto concesso chiudere questa riflessione proprio citando Semprún, il quale, in un discorso tenuto a Parigi,
4
Di Fackenheim si veda anche 1987. Sull’idea di Shoah come frattura di civiltà si consideri Cohen 1981.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
214
Shoah, modernità e male politico
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
alla Sorbonne, nel 1990, come Marc Bloch Lecture, affermava (lo lascio in francese, perché è più efficace): Si le mal a son fondement dans le fond constitutif de la liberté humaine, le bien l’a tout autant. Le mal n’est ni le résultat ni le résidu de l’animalité de l’homme: il est un phénomène spiritual, consubstantiel de l’humanité de l’homme. Mais le bien l’est autant. Et s’il n’est pas question d’extirper de l’être de l’homme sa libre disposition spirituelle au mal […] il est tout aussi impossible d’interdire à l’homme, dans son irréductible liberté, l’expression concrète de sa volonté de bien, qui se nomme selon les circonstances : courage civique, solidarité, compassion religieuse, dissidence, sacrifice de soi. Rien, jamais, n’empêchera l’homme de décider de résister au Mal. Quelles que soient les couleurs dont il se pare, même s’il se déguise avec les oripeaux du Bien et du Bonheur pour tous. (Semprún 1995: 62)5
5
Sulla medesima lunghezza d’onda si iscrive Tzvetan Todorov: «È a Ravensbruck che Germaine Tillion ha potuto rinforzare il proprio rispetto per la persona umana, perché, se il male vi si estende ovunque, il bene non vi è assente. Egoismo e generosità sbocciano fianco a fianco, come se ogni essere rivelasse la propria identità fino a quel punto mascherata dalle convenzioni sociali. Il bene si afferma attraverso virtù quotidiane: il mantenimento di una dignità personale; la preoccupazione per gli altri, talvolta prossimi e talvolta sconosciuti (nessuno è sopravvissuto al campo senza l’aiuto degli altri); l’attività stessa dello spirito, tanto è che lo sforzo di Tillion di capire il mondo concentrazionario, e farlo capire agli altri, diventa a sua volta virtù» (Todorov 2000: 362).
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
215
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
SUSAN NEIMAN
SENZA CATTIVE INTENZIONI Ripensare il male dopo Auschwitz*1
1. In un passo di Dialettica negativa, Theodor W. Adorno suggerisce l’idea di un confronto tra Auschwitz e il terremoto di Lisbona del 1755 (Adorno 1966: 326-27). Nel mio libro Evil in Modern Thought (Neiman 2004) ho cercato di riflettere su questa idea. Entrambi i toponimi si riferiscono a eventi che hanno significato il collasso della più elementare fiducia umana nel mondo, il fondamento che rende possibile ogni civiltà. Nell’apprendere questo, i lettori contemporanei provano malinconia: fortunati i tempi in cui un terremoto poteva fare così tanto danno. Perché infatti, a prima vista, non sembrano esistere eventi fra loro più diversi. Lisbona indica quel tipo di cosa che le compagnie di assicurazione chiamano disastri naturali, rimuovendole dalla sfera dell’azione umana. Così, gli esseri umani vengono assolti: non solo dalla responsabilità di averli causati come pure dall’onere di doverli indennizzare, ma persino dalla necessità di doverci pensare – se non in termini squisitamente pragmatico-tecnologici. Solo i teisti della prima modernità vi cercavano un significato. Auschwitz, al contrario, rappresenta tutto quel che intendiamo quando oggi usiamo l’espressione “il male”: la malvagità assoluta che non può essere spiegata o espiata. È proprio la percezione di questa diversità radicale tra i due problemi a segnare la coscienza contemporanea. Nelle concezioni giuridiche del passato, il crimine veniva collegato al concetto di intenzione in vari modi. Tutti gli sforzi fatti da Edipo per eludere il suo destino potevano forse mitigare la sua colpa, ma non cancellarla, perché il suo crimine danneggiava l’ordine dal quale dipendeva la vita nella concezione greca. L’esempio di Edipo ci ricorda che le conseguenze morali delle intenzioni di un’azione non sono più evidenti dello stesso concetto di “intenzione”. Entrambi possono variare molto, e con loro varia il modo in cui interpretiamo il mondo. *
Traduzione dall’inglese di Lucia Claudia Fiorella.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
216
Shoah, modernità e male politico
Certamente, sia Lisbona che Auschwitz si verificarono in contesti di grande fermento intellettuale. In entrambi i casi, la catastrofe fece crollare un castello di assunti già pericolante. E, in entrambi i casi, furono gli eventi stessi a tracciare un limite fra il pensabile e l’impensabile. Come Lisbona, Auschwitz acquistò significato all’interno del sistema di credenze in cui si verificò. Lisbona scosse il XVIII secolo più di quanto terremoti ben più violenti e distruttivi poterono smuovere il XX secolo. E sebbene stesse infuriando la Guerra dei sette anni – spazzando via due terzi della popolazione del Brandeburgo, dove lavoro –, questa non lasciò ai sopravvissuti un senso di devastazione intellettuale. Auschwitz, invece, sì. Le diverse reazioni si spiegano con la diversità delle strutture che ciascuna epoca aveva usato per dare un senso alla sofferenza. Se sceverare l’elemento umano da quello naturale è parte del progetto della modernità, la distanza fra Lisbona e Auschwitz mostrava come fosse difficile tenerli distinti. Dopo Lisbona, la sfera delle categorie morali subì una contrazione. Prima di Lisbona, potevano essere applicate al mondo intero: dire che i terremoti erano un male aveva un senso. Dopo, quelle categorie morali rimasero confinate a una piccola parte del mondo, cioè agli esseri umani – gli unici che avrebbero potuto realizzarle. Auschwitz ha sollevato dubbi sul senso stesso con cui noi applichiamo le nostre categorie morali. Un interesse quasi ossessivo e a volte discutibile per la catalogazione degli orrori del XX secolo continua a riempire il mondo di testimonianze in tutte le forme di cui i media oggi dispongono. Ma molti concordano sul fatto che ci mancano le risorse concettuali necessarie a poter fare qualcosa di più della semplice testimonianza. Il significato di Auschwitz sembrò essere chiaro verso la fine del Novecento, ma le ragioni solitamente addotte per spiegarlo non hanno peso né storico né filosofico. Per molti studiosi, la crisi della modernità avvenne molto prima. Soprattutto la Prima guerra mondiale fu oltre modo sconvolgente. La fiducia acritica nella capacità umana di migliorare le proprie sorti fu distrutta dalla Prima, e non dalla Seconda, guerra mondiale, mentre la certezza nella perennità della specie umana si perse in Giappone, e non in Polonia. Comparare ciò che è accaduto a Auschwitz, Hiroshima o nei gulag sovietici può essere importante, per molte ragioni. Molti dei tentativi volti ad affermare che una forma di sterminio è peggiore di un’altra hanno motivazioni politiche piuttosto che filosofiche; tuttavia, in certi contesti le preoccupazioni politiche dovrebbero essere la prima cosa, e promuoverle diventa un’esigenza morale. Durante il dibattito degli storici tedeschi degli anni Ottanta, ad esempio, enfatizzare l’elemento universale di Auschwitz serviva a negare la colpa tedesca. Affermare invece che quel che accadde
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Neiman - Senza cattive intenzioni
217
ad Auschwitz fu peggiore di quanto successe nei gulag significava schierarsi contro i tentativi dei conservatori tedeschi di sottrarsi alla responsabilità dei propri crimini di guerra mettendo in evidenza quelli degli altri. Purtroppo, nella Germania di oggi questa consapevolezza manca, ed è perciò divenuto normale parlare delle “due dittature tedesche”, come se il sistema della Repubblica Democratica Tedesca non fosse stato radicalmente diverso da quello del Terzo Reich. Le discussioni politiche che comparano i mali possono essere oneste o disoneste, ma sono tutte eminentemente pratiche. In questo contributo, il mio scopo non lo è. Vorrei piuttosto capire se e come l’Olocausto abbia cambiato la nostra consapevolezza. Si dice spesso che Auschwitz abbia travolto credenze precedenti sull’inevitabilità del progresso, ma queste affermazioni si basano su un’ingenuità che pochi testi possono suffragare. Lo scetticismo sulle effettive capacità che ha l’uomo di migliorarsi attraversa l’opera di illuministi fra loro diversissimi come Voltaire e Rousseau. Per il 1794, al più tardi, ogni residua fiducia nell’inevitabilità del progresso veniva messa a dura prova, nella pratica, dal periodo del Terrore e, nella teoria, dall’incisiva argomentazione di Kant sulla fede razionale. Come hanno sostenuto numerosi studiosi, altre stragi hanno fatto molte più vittime – sia in termini assoluti sia relativi. E tuttavia non consideriamo il male solo da un punto di vista quantitativo. Il Talmud associa la salvezza di una vita alla salvezza di un mondo. Dostoevskij affermava che uccidere un bambino poteva comportare la dannazione. Se c’è qualcosa di nuovo nel male della contemporaneità non può essere semplicemente una questione di quantità relativa, e nemmeno di crudeltà relativa. Le camere a gas furono inventate per risparmiare alle vittime forme di uccisione più cruente, e agli aguzzini scene che potevano turbare le loro coscienze. Per alcuni, è proprio questa perversa mescolanza di industrializzazione circondata da una pretesa di umanità a rendere agghiaccianti i campi di sterminio. Tuttavia, è il semplice fatto che siamo abituati all’icona della morte di Gesù a mettere in ombra l’atrocità della crocifissione. Obbligare un condannato a trascinare gli strumenti che di lì a poco saranno usati per torturarlo a morte in mezzo a una folla che lo schernisce è una crudeltà di una raffinatezza tale da togliere il fiato, e dovrebbe essere sufficiente a soffocare sul nascere l’impulso a relativizzare la sofferenza. Quel che rende Auschwitz oggetto della riflessione sul male non può essere una questione di gradi, perché a questo livello non ci sono strumenti di misura. Per comprendere cosa ci fosse di concettualmente sconvolgente in Auschwitz è fondamentale assumere una prospettiva più ampia. Se il terremoto di Lisbona segna il luogo di nascita della modernità, è perché ha preteso che
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
218
Shoah, modernità e male politico
si riconoscesse che la natura e la morale sono distinte. La catastrofe di Lisbona non sarebbe dovuta succedere, ma è successa. L’accettazione di questo fatto divenne un segno minimo di maturità, e la lunga lamentazione di Voltaire sul terremoto non sembrò altro che una versione elegante delle maledizioni tirate da un bambino alla sedia sulla quale è inciampato. Né i terremoti né le sedie possono essere fatti oggetto di rabbia perché né i primi né le seconde sono provvisti di alcuna proprietà morale. La natura non ha significato, i suoi eventi non sono segni. Non pensiamo più che i fenomeni naturali siano oggetto di giudizio morale, e nemmeno tentiamo di rifletterci in essi o di entrarvi in sintonia. Per quanti si rifiutano di abbandonare i giudizi morali, la richiesta di smettere di cercare un’unità fra natura e morale significa accettare un conflitto che sta al cuore dell’essere e che niente potrà mai risolvere. Questa richiesta sembrò diventare così palese che costrinse a un cambiamento di lessico. Prima di Lisbona, il male si divideva in naturale, metafisico e morale. Dopo Lisbona, il termine venne circoscritto fino a coincidere con quel che prima si chiamava “male morale”. Il male moderno è il prodotto di una volontà. Ridurre le azioni cattive alle sole azioni accompagnate da cattive intenzioni libera il mondo di un gran numero di mali in modo apparentemente sensato. Meno chiari erano i concetti stessi di volontà e intenzione. Le rocce che cadono e le onde che sommergono non ne hanno. Che cosa implichi averle rimaneva però oscuro. Prima di Lisbona, gli sforzi di dare un senso alla sofferenza erano tentativi di conciliare natura e morale; dopo quella catastrofe, i tentativi insistono sulla loro completa e radicale differenza. Le categorie naturali non sostengono né riflettono quelle morali, e viceversa. Se questo è vero, la natura e i fenomeni naturali non sono mai né buoni né cattivi. Questa visione elimina completamente quel che si intendeva con male “naturale” o “metafisico”, e sottolinea che il male è solo una categoria morale. In cambio della rinuncia all’idea che la sofferenza naturale possa essere intesa come un male, questa visione conquista una certezza: è chiaro a tutti cosa intendiamo quando si parla di male morale. Ciò che intendo sostenere qui è che, di tutte le perdite che l’umanità ha patito ad Auschwitz, la perdita di questa certezza è la più devastante. Dopo la svolta rappresentata da Lisbona, la volontà e l’intenzione divennero così cruciali nella concezione del male che l’etica di Kant cominciava dall’asserzione che solo la volontà buona è intrinsecamente buona. Il suo esempio del bottegaio ne dà illustrazione: un bottegaio che si astiene dall’imbrogliare perché la buona reputazione è importante per la sua attività è cosa diversa dal negoziante che sa che potrebbe passarla liscia, ma non imbroglia. Anche se non potremmo mai vedere questa differenza, sappia-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Neiman - Senza cattive intenzioni
219
mo che nel primo caso si tratta di una scelta prudente, nel secondo di una scelta buona. Sotto il profilo della moralità quotidiana, anche un bambino sa riconoscere la differenza. Rousseau diede una spiegazione politica dell’origine del male che, pur basandosi sul concetto di responsabilità umana, non implicava l’idea di peccato originale. Nella versione rousseauiana della caduta, l’umanità diviene malvagia senza volere il male. La nostra discesa dall’innocenza alla barbarie civilizzata non fu causata da una sfida deliberata che portò Adamo ed Eva alla rovina; piuttosto, i nobili selvaggi della storia di Rousseau fecero una serie di errori naturali, comprensibili e accidentali. Il racconto aveva le sue falle, ma anche il grande merito di spiegare le apparenze come pure di affermare che c’era un ordine sottostante. Era particolarmente efficace nella spiegazione di mali come la diseguaglianza e persino la schiavitù, e nell’offrire la speranza che potessero essere debellati, perché Rousseau mostrava come questi mali non fossero parte dell’ordine naturale ma conseguenze delle azioni umane, che non erano il frutto di volontà inemendabili. Così, i tentativi tradizionali di stabilire una distinzione fra natura e morale lasciavano aperte molte questioni cruciali. Ma la distinzione si adattava bene e intercettava bisogni che provenivano da un mondo disincantato. Con il male naturale ridotto a deplorevole incidente, e il male metafisico trasformato nella ricognizione dei limiti che ci aspettiamo ogni adulto riconosca, il problema del male s’era inoltrato sulla via della dissoluzione come già tanti altri problemi filosofici. C’è già abbastanza da fare nel cercare di eliminare i mali che sono alla nostra portata senza preoccuparci di quelli che non possiamo raggiungere. Decidere di assumerci la responsabilità di una porzione del mondo in assenza di basi metafisiche convincenti è parte di quel che comunemente s’intende per “diventare adulti”. In questo contesto, Auschwitz poneva dei problemi filosofici perché non chiariva quale fosse la natura di questa assunzione di responsabilità. È facile capire che il male è assente in cose come i terremoti, ma cosa significava dire che c’era del male nell’umanità? Auschwitz è diventato il simbolo del male morale, mentre altri crimini di guerra non lo sono diventati, perché, a differenza di questi ultimi, è sembrato qualcosa di deliberato. Mandare dei ragazzi a combattere per l’Inghilterra nel pantano delle Fiandre senza rendersi conto del potere delle armi che sono state loro messe in mano può essere definita una palese negligenza criminale. Ma rastrellare bambini da tutti gli angoli d’Europa e mandarli nelle camere a gas in Polonia, no. Il numero di ebrei ammassati nei carri bestiame veniva attentamente calcolato; per trasportare questa gente al macello le SS non volevano pagare
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
220
Shoah, modernità e male politico
alla Reichsbahn più della tariffa economica riservata ai gruppi. A livello strutturale, è difficile immaginare un atto più premeditato. Quanto ai singoli individui, le cose sono infinitamente più nebulose. La giurisprudenza considera efferati i crimini commessi con intenzioni malvagie (malice) e premeditazione. Questi due aspetti del nostro concetto di intenzione erano spesso assenti in tanti di coloro che svolgevano il lavoro quotidiano dello sterminio. L’opportunità di evitare di essere mandati a combattere al fronte faceva arruolare molte più guardie dei campi di concentramento di quante ne facesse iscrivere la possibilità di tormentare gli ebrei. Ai livelli più alti, spesso mancava anche una visione chiara delle conseguenze delle proprie azioni. Eichmann è solo l’esempio più famoso di un ufficiale nazista i cui obiettivi iniziali non avevano niente a che fare con lo sterminio, ma piuttosto con meschini desideri di avanzamento di carriera. Ad ogni grado, i nazisti producevano più male, e con minore malvagità (malice), di quanto la civiltà avesse fino ad allora conosciuto. L’apparente assenza di intenzioni malvagie e/o premeditazione si è dimostrata così inquietante che molti commentatori hanno preferito sostenere che queste dovevano essere presenti in qualche forma occulta. Scrittori come Goldhagen hanno affermato che dietro la maschera di una relativa tolleranza la cultura tedesca ospitasse forme particolarmente virulente di antisemitismo. L’attrattiva di queste affermazioni deriva più dalla loro ingenuità filosofica che dall’accuratezza storica. La vecchia immagine del male cui è necessariamente connessa un’intenzione malvagia è assai più rassicurante delle alternative. Allo stesso modo, i tedeschi “normali” che assicurano di non aver mai saputo quali crimini si commettessero a Est nel loro nome vengono tacciati di disonestà. Funzionari che affermano di aver aderito al Partito nazionalsocialista senza essere a conoscenza dei suoi fini ultimi vengono trattati con disprezzo. È più facile ipotizzare che, dietro a queste azioni, ci sia un odio inconscio o una conoscenza inconscia, piuttosto che ammettere una possibilità più angosciante. Davvero non ne avevano intenzione – ma tanto ciò non è rilevante. Continuiamo così ad ignorare che Auschwitz rappresenta un male che confuta due secoli di speculazioni moderne sul concetto di intenzione. Quelle speculazioni identificano a tal punto il male con l’intenzione malvagia che negare la seconda viene normalmente considerato come un modo per negare il primo. Dove manca l’intenzione malvagia, si possono ancora imputare i torti a coloro che li infliggono, ma li consideriamo come questioni di negligenza criminale. Altrimenti, chiunque affermi che in una determinata azione manca l’intenzione criminale viene preso per uno che vuol discolpare il criminale. Questa è la causa dello scalpore che ancora
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Neiman - Senza cattive intenzioni
221
circonda l’Eichmann in Jerusalem di Arendt (1963a), il contributo filosofico più importante del XX secolo sulla questione del male. La convinzione che la colpa richieda un’intenzione malvagia e la premeditazione portò la maggior parte dei lettori a concludere che Arendt negasse la colpa perché negava un’intenzione malvagia e la premeditazione – sebbene ella ripetesse spesso che Eichmann era colpevole, e credesse che dovesse morire impiccato. La sua tesi principale era che le intenzioni inoffensive di Eichmann non alleggerissero la sua responsabilità. Così, si diceva, Eichmann non ha mai odiato gli ebrei, non si è mai messo ad ammazzarli, e pare che quando gli capitò di vedere altri che lo facevano si sentì male. Il processo ad Eichmann si trasformò in una discussione per verificare la fondatezza di queste asserzioni. E facendo così, secondo Arendt, trascurò le questioni più importanti1. Il resoconto di Arendt fu determinante nel rivelare cosa fa di Auschwitz un emblema del male contemporaneo. I criminali come Eichmann non hanno nessuno dei tratti soggettivi che si usano per identificare i malfattori, e tuttavia i suoi crimini erano così oggettivamente enormi da rendere quei tratti irrilevanti. Gli sforzi che faceva per provare di essere perfettamente normale erano tanto tenaci quanto quelli dell’accusa per dimostrare che non lo era. Entrambi gli sforzi furono vani, se quel che è in discussione è ciò che spaventa: i crimini più inauditi possono essere commessi dalla gente più comune. È questo l’aspetto che Auschwitz condivide con altri casi contemporanei di sterminio, per quanto permangano le altre differenze. Nel male contemporaneo, raramente le intenzioni degli individui corrispondono alla magnitudo del male che questi possono causare. I nazisti obbligarono tutti – dagli spettatori passivi fino alle vittime – a partecipare al loro immenso sistema di distruzione. Il loro successo dimostrò l’impotenza dell’intenzione in sé. Poiché quel che conta non è con cosa sia lastricata la strada, ma se conduca all’inferno oppure no. Proprio la credenza che le azioni malvagie richiedano intenzioni malvagie ha permesso ai regimi totalitari di convincere le persone a ignorare quelle obiezioni morali che altrimenti avrebbero potuto funzionare. Una 1
La descrizione di Arendt continua a suscitare polemiche, soprattutto perché viene trattata come un documento storico anziché filosofico. Ai fini della mia analisi, i giudizi contrastanti su Eichmann sono meno importanti della tesi principale di Arendt. Supponiamo che, contrariamente ad Arendt, varie testimonianze dimostrino che Eichmann sia stato una figura meno banale di quella che risultò al processo; molti studi storici, da Browning 2003 a Welzer 2005, mostrano come l’analisi di Arendt si applichi ad altri attori senza i quali l’Olocausto non si sarebbe potuto realizzare.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
222
Shoah, modernità e male politico
propaganda imponente si assunse il compito di convincere la gente che le azioni criminali cui partecipavano erano guidate da principi accettabili, se non addirittura nobili. La percezione della colpa è talmente inaffidabile che può spesso servire come indice di innocenza. I “migliori” fra gli spettatori sono quelli la cui coscienza è la più tormentata, perché raramente le anime indifferenti sono turbate dal pensiero di aver fatto troppo poco per impedire delle scelleratezze. Eichmann, come la maggior parte degli ufficiali nazisti, provava uno scarso senso di colpa. Supponiamo che fosse sincero: quel che aveva nell’animo era comunque misero come riferì al processo. Non è una ragione per negare la sua responsabilità, ma per cercare la responsabilità in un posto diverso dall’intimo della sua coscienza. Il dibattito tra funzionalisti e intenzionalisti nella storiografia sull’Olocausto tradisce una mancanza di chiarezza sulla nozione stessa di “intenzione”: ci si chiede se si trattasse di colpa (Schuld) o di negligenza (Fahrlässigkeit), quando nella maggioranza dei casi erano presenti entrambe le cose. Le discussioni, così ricorrenti, che cercano di stabilire se i campi di lavoro nazisti fossero peggiori di quelli sovietici, o se il bombardamento di Hiroshima sia paragonabile ai massacri di civili effettuati dalle forze dell’Asse, in ultima analisi dibattono sempre su quale peso si debba attribuire al ruolo dell’intenzione. Gran parte della veemenza che caratterizza queste polemiche è causata dal desiderio di mantenere una connessione tra il male e l’intenzione, che non è teoricamente difendibile. Se l’aguzzino trasforma gli individui in cadaveri numerati, anch’egli, come individuo, non è più molto presente a se stesso. Siamo minacciati più spesso da quanti hanno intenzioni indifferenti o incaute piuttosto che malvagie; persino forme deliberate di malvagità sono spesso così insignificanti da essere sconcertanti. Ovunque, erano dei bruti sadici a gestire la vita quotidiana nei campi di concentramento, ma non li avevano costruiti loro. C’erano abbastanza intenzioni malvagie e sconsideratezza negli architetti, ma queste non aggiungono molto all’enormità del male che costoro hanno causato. L’Olocausto non è avvenuto per caso o per sbaglio. Ma quel che per certi versi sembra un progetto imponente e accurato, per altri va in briciole. Auschwitz ha rivelato i vuoti fra le tessere delle nostre idee di intenzione. Né le intenzioni malvagie né la capacità di prevedere le conseguenze sono bastate a spiegare tutto il male che dovevano spiegare. In fondo, la speranza di trovare una teoria esaustiva circa il rapporto tra il male e la nostra intenzione era una richiesta minima – e per questo la mancanza di una simile teoria ci angoscia profondamente. La questione del male è iniziata col tentativo di comprendere le intenzioni di Dio. Ora pare che non riusciamo a capire nemmeno le nostre. Se Auschwitz ci lascia più
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Neiman - Senza cattive intenzioni
223
smarriti di Lisbona, è perché le nostre risorse concettuali sembrano essersi esaurite. Dopo Lisbona, si poteva comunque rimettere insieme i pezzi di un’immagine del mondo andata in frantumi e decidere di vivere con coraggio, assumendosi la responsabilità di un mondo disincantato. Dopo Auschwitz, persino i tentativi di far questo sembrano destinati al fallimento. Eichmann in Jerusalem era, fra le altre cose, il tentativo di dare un quadro di riferimento per comprendere l’assunzione della responsabilità dopo Auschwitz. Mostrando come i più grandi crimini possano essere commessi da uomini che non recano alcun tratto criminale, Eichmann in Jerusalem sosteneva che il male non è una minaccia per la ragione. Piuttosto, tali crimini dipendono dalla sventatezza, dal rifiuto di usare la ragione come si dovrebbe. In una famosa lettera a Gershom Scholem, Arendt paragonò il male a un fungo. «[Il male] non possiede né profondità né una dimensione demoniaca. Esso può invadere e devastare il mondo intero, perché si espande sulla sua superficie come un fungo» (Arendt 1963b: 227). La metafora del fungo accenna quindi a un male che può essere compreso. Indica anche un oggetto che non ha alcuna intenzione. Questa è stata la più grande rottura di Arendt con la tradizione filosofica moderna – e in particolare con l’opera di Kant, cui peraltro Arendt deve molto. È più facile riconoscere, e quindi resistere, alle grandi tentazioni, perché alla resistenza si addicono termini eroici. I pericoli contemporanei iniziano invece da passi insidiosi ma banali. Affermare che il male è banale non è un’affermazione sulla grandezza, ma sulla proporzione: se crimini così grandi possono risultare da cause così piccole, allora c’è speranza di sconfiggerli. Dire che il male è banale non significa darne una definizione ma proporre una teodicea, perché implica che le fonti del male non sono misteriose o profonde, ma alla nostra portata. Se è così, esse non infettano il mondo a una profondità tale da farci perdere la speranza per il mondo stesso. Come un fungo, possono devastare la realtà distruggendone la superficie. Le radici, però, sono abbastanza corte da poter essere sradicate. Dire che il male è generalmente comprensibile non significa però affermare che ogni sua manifestazione sia trasparente: significa piuttosto negare che per spiegarlo occorra chiamare in campo forze sovrannaturali, divine o demoniache. Significa anche dire che, come ne sono responsabili dei processi mondani, così si possono usare dei processi mondani per impedirlo. Dire che il male è banale, inoltre, è anche una strategia retorica: un modo per neutralizzare il potere che rende attraente il frutto proibito. Da quando il Marchese de Sade è divenuto salonfähig (presentabile), è cresciuta la tendenza a estetizzare il male. Arendt cercava una descrizione del male che resistesse al bisogno di dargli una “grandezza satanica”, perché tali bisogni sono sia
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
224
Shoah, modernità e male politico
puerili sia pericolosi. Il diabolico può essere ambiguo; il ridicolo, no. Dire che il male è banale è come dire che è noioso. E se è noioso, perderà di attrattiva. Dopo tutto, un fungo non è certo erotico. Le idee di Arendt non erano completamente sviluppate; sulla scia dell’intensa ostilità con cui fu accolto Eichmann in Jerusalem, Arendt ripiegò dicendo che si trattava solo di uno scritto giornalistico – invece di spiegare che era un testo filosofico. Questo è a dir poco un peccato; se fossimo stati in grado di riflettere di più all’interno del quadro di riferimento che lei ci aveva dato, forse avremmo potuto evitare parte della confusione con cui ora abbiamo a che fare, e della quale ora intendo occuparmi. 2. Nel 2009, Benjamin Netanyahu fece la sua prima visita di Stato a Berlino, e, per celebrare l’occasione, l’editore del più grande quotidiano tedesco preparò un dono speciale. In una cerimonia attentamente orchestrata i cui ospiti contavano sessanta diplomatici, numerosi ministri, e un gruppetto di sopravvissuti di Berlino, il capo redattore offrì a Netanyahu le piantine originali dell’architetto del campo di concentramento di Auschwitz. C’erano in tutto 29 disegni, meticolosamente spiegati da un certo Ralf Georg Reuth, giornalista e autore di un libro su Goebbels. Questi riferì: Gli mostrai dove si trovavano le 144 baracche per gli uomini e quelle in numero un po’ inferiore per le donne. Qui c’era la rampa, e qui c’erano i binari ferroviari. I forni crematori e le camere a gas non erano disegnate su questo progetto, c’era solo un enorme obitorio. Ma mostrai al primo ministro la grande foto sul muro che avevano fatto i piloti americani. Lì [i forni e le camere a gas] si vedevano bene.
Netanyahu fece un discorso assai misurato esprimendo la sua gratitudine, e portò con sé le piantine al successivo incontro in programma, e cioè dalla cancelliera Merkel, che si disse «molto emozionata». L’editore si riferì ai disegni come a un dono «al popolo ebraico in segno di rispetto»2. Netanyahu ebbe la cortesia di dirsi «senza parole» prima di portare le piantine alle Nazioni Unite per sventolarle all’Iran. Forse, come disse in quella sede, questa è la prova storica che le biblioteche, già colme di documenti e testimonianze, stavano aspettando per convincere finalmente l’allora presi2
Un equivalente del dono tedesco dei disegni di Auschwitz potrebbe essere, diciamo, il figlio di Ponzio Pilato che offre a San Paolo un frammento della vera croce. Devo a Lorraine Daston l’ipotesi che l’unica spiegazione sensata del dono si basa sul presupposto che l’editore Sterling lo considerasse una sorta di reliquia.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Neiman - Senza cattive intenzioni
225
dente Ahmadinejad della realtà dell’Olocausto. «Le piantine di Auschwitz mi sono state date a Berlino, e sono firmate da un incaricato di Hitler, Heinrich Himmler. I governi tedeschi che hanno conservato questi piani sono tutti dei bugiardi?». Quel che lascia me quasi senza parole non è l’uso politico delle piantine – pressoché tutto, dai massacri ai cagnolini, può essere adibito a scopi politici – ma il fatto che un tale uso sia concepibile. Cosa significa dare le piantine di Auschwitz agli ebrei in segno di rispetto? Cinquant’anni fa sarebbe stato uno schiaffo in piena faccia. Ma sebbene l’Olocausto sia diventato il paradigma della tendenza contemporanea a distogliere lo sguardo dagli eroi della Storia per concentrarsi sulle sue vittime, questa tendenza non è iniziata in Israele. Al contrario, come Tom Segev mostra nel suo magnificamente sconcertante The Seventh Million (1993), fino all’inizio degli anni Sessanta, in Israele, ogni riferimento alle vittime dell’Olocausto era un’occasione di vergogna. Israele era stato fondato per offrire un’alternativa all’immagine degli ebrei come vittime indifese, e lo Stato degli inizi era così impegnato a contrastare quell’immagine che spesso trascurava di curarsi delle vittime stesse. Oggi, gli studenti delle scuole superiori vengono spinti a partecipare a quelli che vengono laconicamente chiamati “viaggi delle radici”, che lo Stato sponsorizza per mandarli ad Auschwitz, ma nei primi decenni della nazione l’Olocausto quasi non figurava nei programmi scolastici. Israele aveva bisogno dei sopravvissuti che uscivano barcollando dai campi di concentramento, ma aveva difficoltà ad abbracciarli, poiché costituivano una minaccia agli ideali che avevano guidato il sionismo fin dalle sue origini. L’obiettivo simbolico era la normalizzazione: avere l’opportunità di quell’auto-determinazione politica che le altre nazioni danno per scontata, essere una terra e un popolo come tutti gli altri. Ma quel che portava i pionieri a combattere i “banditi” e la malaria, a prosciugare paludi e piantare alberi non era una visione di normalità – di poliziotti e prostitute ebrei, come suggeriva una battuta di allora – ma una visione di eroismo ebraico. Gli ebrei non dovevano più essere l’oggetto passivo, ma il soggetto attivo della Storia. La solenne accettazione delle piantine da parte di Netanyahu rappresenta così il preciso opposto del nucleo di quel sionismo che egli afferma di difendere – e si può dire lo stesso del comportamento del suo governo sotto altri punti di vista, ma questa è un’altra storia. E tuttavia, è assolutamente in linea con la tendenza dominante di gran parte del clima intellettuale del dopoguerra su scala internazionale. In Israele come altrove, gli ebrei si concentrarono sull’Olocausto relativamente tardi; difficile trovarne nota prima degli anni Settanta. Ma esso divenne il tratto distintivo dell’identità nell’epoca della cosiddetta politica dell’identità, quando si affermò una
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
226
Shoah, modernità e male politico
competizione crescente fra popoli che cercano di dimostrare di essere povere vittime al pari degli altri. All’inizio, la spinta a trasformarsi da eroi in vittime fu progressiva. La Storia è sempre stata la storia dei vincitori, e le voci delle vittime venivano purtroppo ignorate. Questo modo di scrivere la storia condannava le vittime a una duplice morte: prima nella carne, poi nella memoria. Rovesciare le posizioni e pretendere che le storie delle vittime entrassero a far parte della narrazione storica era un modo per riparare a vecchi torti. Se le storie delle vittime possono reclamare la nostra attenzione, possono anche rivendicare le nostre simpatie e i loro diritti nei nostri sistemi di giustizia. Quando gli schiavi cominciarono a scrivere le loro memorie intrapresero un percorso di soggettivazione e riuscirono ad essere riconosciuti; e in modo lento ma deciso ottennero anche i risarcimenti che venivano da quel riconoscimento. Il movimento che portò a riconoscere le vittime della schiavitù, delle stragi e del colonialismo era partito con le migliori intenzioni. Faceva parte di un processo per cui si riconosceva che il potere e il diritto spesso non coincidono, che le cose brutte accadono a tutti i tipi di persone e che, anche se non possiamo cambiarle, dobbiamo tenerne viva la memoria. Lo status di vittima doveva essere una fonte di legittimazione per rivendicare un risarcimento, per quanto complicato fosse decidere chi ne avesse diritto, e dove dovessero finire le rivendicazioni. Tuttavia, nel corso di questa rivalutazione della posizione delle vittime nella nostra concezione della storia, è accaduto qualcosa di profondamente malsano. Una volta che ci si mette a considerare lo status di vittima di per sé come la valuta di scambio del riconoscimento, si rischia di dissociare del tutto il riconoscimento e la legittimità dalla virtù. Perché nessuno ha mai sostenuto che l’essere vittima fosse fonte di virtù. Come ha scritto Jean Améry con parole assai sofferte: Ad Auschwitz non siamo divenuti più saggi […]. Neanche nel campo siamo diventati più profondi, ammesso che la fatale profondità sia una dimensione spiritualmente definibile. Inutile aggiungere, credo, che ad Auschwitz non siamo nemmeno divenuti migliori, più umani, più benevoli nei confronti dell’uomo e più maturi moralmente. […] Il verbo perisce ogni qual volta una realtà pretende di essere totalità. Per noi è perito da molto tempo ormai. E non ci è rimasta nemmeno la sensazione che dovessimo dolerci della sua scomparsa. (Améry 1966: 55)
Anche se l’Olocausto non è stato l’origine della competizione per lo status di vittime che, nell’odierno scenario internazionale, domina molte agende politiche, ne è certamente il paradigma. Un saggio sul massacro di Nanchino ha come sottotitolo L’Olocausto dimenticato della Seconda
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Neiman - Senza cattive intenzioni
227
guerra mondiale (Chang 1997) e quando l’autrice cino-americana Iris Chang è stata intervistata ha espresso il desiderio che anche il suo Olocausto «trovasse il suo Spielberg». Spesso la contesa rasenta l’isteria nell’Europa orientale e centrale, dove i paesi che hanno sofferto sotto lo stalinismo richiedono pari trattamento per le loro ferite. In Europa, gli attuali dibattiti politici sulle eventuali somiglianze tra oppressione fascista e comunista sono guidati da necessità diverse: alcuni sono tentativi di usare l’anticomunismo per promuovere programmi economici neoliberali; altri, specialmente nei paesi baltici, sono stati messi in campo per coprire una diffusa complicità, durante la guerra, con i crimini nazisti. Nella forma, tuttavia, si mira invariabilmente a dimostrare che la propria pena è peggiore di quella degli altri. Talvolta, le rivendicazioni sono indirette; una volta ho partecipato a un convegno dove il ministro degli Esteri ucraino ha dichiarato: «Noi ucraini comprendiamo bene gli ebrei a causa delle nostre stesse sofferenze nel secolo scorso. In una sola delle carestie pianificate degli anni Trenta, l’Ucraina ha perso sette milioni di abitanti». Sette milioni contro sei, e in un solo anno! Ci stava forse suggerendo di gettare la spugna, di fronte all’evidenza dei dati, e riconoscere che “vinceva” l’Ucraina? Ma vinceva cosa? La lotta per il riconoscimento che Hegel vedeva nel tentativo di sopraffare il proprio nemico – prima in battaglia, poi con la produzione – è stata sostituita. Il riconoscimento non deriva più dal fare di più di un altro, ma dal soffrire di più di un altro. È un rovesciamento fatale per qualunque nozione di moralità politica, perché dipende dal presupposto che nel mondo non conta quello che fai, ma quello che il mondo ti fa. Mentre questo presupposto è assai frequente a destra – si pensi alla Bund der Vertriebenen (Federazione degli sfollati) tedesca, o alla nota di vittimismo che risuona in molte delle tirate dei Tea Party –, da alcuni decenni si nota particolarmente anche a sinistra. Rifiutando qualunque cosa possa tendere verso screditate nozioni di eroismo, gran parte del pensiero contemporaneo di sinistra è radicato nella retorica della vittima. Si noti quanto questo sia diverso dalla visione marxista di ispirazione hegeliana data per scontata in cose come la vecchia canzone operaia Solidarity Forever3. L’enfasi di questa lunga canzone è sull’idea che «senza la nostra testa e i nostri muscoli non si può girare neanche una sola ruota» e non sull’idea che «si sono presi un’infinità di milioni per i quali non hanno mai faticato». 3
NdR: la canzone venne composta nel 1915 sul testo di una poesia dello scrittore e sindacalista Ralph Chaplin (1887-1961), e divenne l’inno della Industrial Workers of the World, l’associazione operaia nata negli Stati Uniti agli inizi del XX secolo.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
228
Shoah, modernità e male politico
Per Ralph Chaplin e Joe Hill4, come per Hegel, lo schiavo è il vincitore della dialettica non perché ha perso la battaglia, ma perché ha saputo trasformare la sua sconfitta in qualcosa di produttivo. Al contrario, per molti, oggi, l’aspetto essenziale è la sconfitta in sé. Il caso limite di Binjamin Wilkomirski, lo scrittore svizzero che nel 1995 ha trovato fama e fortuna con il racconto autobiografico della sua infanzia in un campo di concentramento, mostra fin dove possano arrivare questi sviluppi. Si scoprì poi che la storia era inventata, e la fortuna di Wilkomirski fu breve, ma non abbastanza per impedire che fosse imitato. In passato, altri furfanti avevano piuttosto cercato di nascondere origini dubbie o dolorose, inventandosi genealogie che li trasformavano in figli di vescovi o cavalieri erranti. Dove invece si riconoscevano le proprie origini drammatiche, come nelle autobiografie di Frederick Douglass, il dolore veniva sì descritto, ma come un preludio al suo superamento5. Il superamento della condizione di vittima era fonte di orgoglio; l’essere vittima, un motivo di vergogna. Al contrario, la corsa degli autori contemporanei che cercano attenzione inventandosi storie peggiori di quelle che hanno effettivamente sofferto è un tributo a quel “fascino della miseria”, come lo ha brillantemente definito la sociologa Eva Illouz (2003), a cui noi siamo diventati vulnerabili. Se la competizione fra vittime non genera modelli né ispirazione per una virtù attiva, è in grado di generare qualcos’altro? Il racconto della sofferenza può generare compassione, primo passo sulla strada della giustizia. La storia della vittima rivela com’ella abbia lo stesso tipo di anima del vincitore, e così facendo suscita spesso il tipo di reazione viscerale necessario a trasformare la mera cognizione dell’ingiustizia nella volontà di contrastarla. Il ritratto che Harriet Beecher Stowe diede del terrore di Eliza e della generosità dello Zio Tom rese il male della schiavitù così lampante per i lettori di tutto il mondo da ingrossare le fila degli abolizionisti più velocemente di qualunque argomentazione usata in precedenza6. 4 5
6
NdR: Joe Hill (1879-1915), sindacalista statunitense dell’Industrial Workers of the World, anch’egli autore di celebri canzoni della lotta operaia. NdR: Frederick Douglass (1818-1895) è stato uno scrittore e politico afro-americano, leader del movimento abolizionista dopo essere stato egli stesso uno schiavo. Le sue tre autobiografie, composte in un arco di tempo che va dal 1845 al 1881, divennero celebri come armi di propaganda nella campagna abolizionista. Chi considera ormai datato il bisogno di simili sentimentalismi dovrebbe riflettere sul fatto che, mentre in Germania il dibattito intellettuale ha cominciato a confrontarsi con l’Olocausto fin dal 1947, coniando persino un nuovo termine come Vergangenheitsbewältigung (il fare i conti con il passato), l’evento mediatico più “efficace” è stata la messa in onda della serie televisiva hollywoodiana Holocaust.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Neiman - Senza cattive intenzioni
229
Niente affascina il popolo americano più del coraggio personale. Prova ne sia il caso Cinque, di fama memorabile, a bordo dell’“Amistad”. La lotta di un uomo audace e fino a un certo punto vittorioso per la vita e la onesta difesa dei propri diritti, suscitò in quell’epoca maggiori simpatie in tutta la nazione, che le sofferenze accumulate di tre milioni di negri rassegnati alla propria sorte; inutile poi ricordare le manifestazioni di solidarietà per i greci in lotta contro gli oppressori turchi, per i polacchi contro la Russia, per gli ungheresi contro la Russia e l’Austria unite. (Brown 1851: 43-4)
Queste parole furono pronunciate nel 1851 da John Brown alla Lega dei Gileaditi, fondata per organizzare la resistenza armata in reazione alla Legge sugli schiavi fuggitivi. Indubbiamente, le storie individuali delle vittime stimolano la nostra simpatia e non se ne può negare il valore, ma questo non dovrebbe nemmeno essere sopravvalutato. Ho citato Brown appunto per suggerire che – anche quando l’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dei mali che si abbatterono sugli schiavi afro-americani, le più numerose vittime d’America – ci sono buone ragioni per rifiutarsi di ricorrere alla retorica della vittima. Vorrei concludere affermando che la valorizzazione della figura della vittima è una reazione comprensibile ma inefficace di fronte alla perdita di comprensibilità che ha investito la figura del perpetratore dopo decenni di riflessione su Auschwitz. Con buona pace di casi come quello di Wilkomirski, riconoscere le vittime è piuttosto semplice – certamente più semplice che individuare coloro che le hanno torturate. Si può arrestare e mettere in carcere un ex sorvegliante di un campo di concentramento particolarmente crudele, ma la catena di persone comuni che ha reso possibile la sua malvagità è già quasi troppo grande per essere calcolata, e decisamente troppo grande per poter essere arrestata. Ci sono due modi per rispondere ai cambiamenti nella nostra cognizione del male dopo l’Olocausto: concentrandoci sulla competizione fra le vittime, prendiamo la più penosa; se si potesse cominciare a ripensare la nostra concezione dell’agire alla luce di quel che il XX secolo ci ha insegnato sul male, faremmo più posto al bene.
Gli spettatori dichiararono che, di fronte alla visione di questo telefilm, avevano realizzato che i sei milioni di ebrei uccisi erano persone, proprio come loro.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
III. AUSCHWITZ COME “FRATTURA DI CIVILTÀ”: LA COSCIENZA CONTEMPORANEA DI FRONTE ALLA SHOAH
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
233
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
ANNETTE WIEVIORKA
DI CHE COSA AUSCHWITZ È IL NOME?*1
I filosofi tedeschi, per esempio Theodor W. Adorno o Hannah Arendt, hanno abbondantemente scritto sulla “frattura di civiltà” rappresentata dal nazismo. Viene ricordata, isolata dal suo contesto, la frase di Adorno «Scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie» (Adorno 1955: 22), divenuta il comando perentorio che non ha mai preteso di essere. O ancora, in ambito cinematografico, l’affermazione di Luc Mollet «La morale è una questione di carrellata», che Jean-Luc Godard trasformò in «Le carrellate sono una questione morale» e Jacques Rivette illustrò nel 1961 in un testo sul film Kapo di Gillo Pontecorvo. A proposito dell’inquadratura in cui Emmanuelle Riva si suicida lanciandosi contro il filo elettrificato, Rivette scrive: «L’uomo che in quel momento decide di fare una carrellata in avanti per inquadrare il cadavere dal basso verso l’alto, avendo cura di porre la mano alzata esattamente in un angolo dell’inquadratura, merita il più profondo disprezzo» (Rivette 1961). Si tratta di problemi complessi, e non sono sicura di essere la persona giusta per risolverli, perché scaturiscono dalla riflessione filosofica più che dal lavoro, spesso terra terra, molto empirico, dello storico. Nessun altro luogo della distruzione degli ebrei d’Europa si è imposto alla memoria con la stessa universalità di Auschwitz. Anzitutto perché Auschwitz è probabilmente il più grande cimitero del mondo: degli ebrei di tutta Europa (quasi un milione), ma anche di polacchi (da 70.000 a 75.000 morti) e di sinti e rom del Grande Reich (circa 20.000) – un cimitero senza tombe, poiché i corpi sono stati ridotti in cenere. In secondo luogo, perché ha rappresentato la destinazione della maggioranza dei convogli partiti dall’Europa. Infine, e soprattutto, perché migliaia di uomini e donne vi sono sopravvissuti. Una sopravvivenza che ha precise ragioni: il complesso di Auschwitz era composto da un «centro di messa a morte», per riprendere la terminologia di Raul Hilberg, da un campo di concentramento *
Traduzione dal francese di Diego Guzzi.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
234
Shoah, modernità e male politico
e da una quarantina di “commando”, vale a dire di fabbriche, miniere e altri stabilimenti, ai quali venivano assegnati i detenuti selezionati per il lavoro. I superstiti hanno mantenuto viva la memoria del luogo sia collettivamente, attraverso le loro associazioni, sia individualmente, tramite innumerevoli testimonianze. Gli altri centri di messa a morte in Polonia – Treblinka, dove vennero assassinati tra i 700.000 e i 900.000 ebrei, Bełżec, Chełmno o Sobibór – sarebbero più emblematici della modalità della “Soluzione finale”: non comprendevano campi di lavoro e si contarono pochissimi superstiti. Per lungo tempo hanno rappresentato per gli ebrei polacchi i luoghi della memoria della distruzione. Vasiliji Grossman scrisse un volume su Treblinka, pubblicato nell’immediato dopoguerra, che stimolò l’immaginazione dei romanzieri, come nel caso di Jean-François Steiner nel suo omonimo libro, o di J.M. Coetzee in Elizabeth Costello. Ciononostante, il nome di Treblinka, al pari di quelli di altri centri di messa a morte in Polonia, viene pronunciato di rado. “Auschwitz” intervenne presto a designare il genocidio degli ebrei, anche se è difficile stabilire con esattezza in quale data. Quando in Francia Wladimir Rabi, in occasione della Guerra dei sei giorni, evocò il timore che si verificasse, nel lasso di una stessa generazione, un “secondo Auschwitz”, si riferiva chiaramente alla Soluzione finale. Con altrettanta rapidità il termine divenne simbolo della barbarie (la frase di Adorno è del 1949). Ma la sua affermazione nel discorso pubblico risale agli anni Ottanta e accompagna quella della memoria del genocidio. Nel 1985 scoppiò il caso del Carmelo di Auschwitz – sul quale tornerò più avanti –, nel cui ambito la memoria cattolica polacca e quella ebraica del campo si affrontarono con una violenza di cui ci si era dimenticati. Nel 1986 un ente tedesco costruì il Centro internazionale di incontro per i giovani che si vede nel film Am Ende kommen Touristen (Alla fine arrivano i turisti) di Robert Thalheim, realizzato nel 2007. Il primo viaggio ufficiale di licei francesi, co-organizzato dal ministero dell’Istruzione e dal Congresso ebraico mondiale, si svolse nel 1988. Da allora, uomini politici di ogni schieramento vi si sono recati per pronunciare discorsi di diverso contenuto. Qualcuno ha persino proposto di riconciliarvi israeliani e palestinesi. Oggi quasi un milione e mezzo di visitatori passa ogni anno sotto la scritta Arbeit macht frei. Nel 1998 la casa editrice Le Seuil mi commissionò, per una collana destinata ai ragazzi, il libro pubblicato l’anno successivo con il titolo Auschwitz spiegato a mia figlia (Wieviorka 1999). Il lettore ideale per cui lo concepii aveva l’età di mia figlia Mathilde – tredici anni – e frequentava come lei la terza media. L’obiettivo era scrivere una lezione di storia sul
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Wieviorka - Di che cosa Auschwitz è il nome?
235
genocidio degli ebrei che partisse dalle domande dei giovani. Domande che conoscevo, per averle spesso ascoltate quando insegnavo nella scuola secondaria. Prendemmo in esame tutti i titoli possibili. “Olocausto” era escluso. Ero riluttante a utilizzare il termine Shoah. Visto che si era già affermato nel linguaggio corrente, il nome di Auschwitz finì per imporsi come metonimia della distruzione degli ebrei d’Europa: pars pro toto, come sostiene l’attuale direttore del Museo di Auschwitz, Piotr Cywiński. Ma il “tutto” si è esteso. Auschwitz è ormai metonimia di tutte le vittime del nazismo, anzi di tutte le vittime di tutti i genocidi e i crimini di massa. È iscritto nella cultura contemporanea come l’incarnazione del male nella storia. Compare addirittura nell’ultimo film della serie X-Men. Quando scrissi Auschwitz, 60 anni dopo (Wieviorka 2005), volli restituire Auschwitz alla storia e rendere il più nitido possibile un luogo offuscato da tanti discorsi, divenuto lo schermo su cui si proiettano, a livello individuale e collettivo, gli incubi e i sogni di una società. Intendevo fornire alcune informazioni sulla sua evoluzione, sugli esseri umani che vi morirono in massa e sulla minoranza che sopravvisse. Auschwitz è anzitutto il toponimo tedesco della città polacca di Oświęcim. Ed è rimasto il nome del campo, creato nella primavera del 1940, divenuto museo a partire dal 1947, mentre la città riacquisiva il nome polacco. I significati di questo luogo di memoria, di competenza dello Stato polacco, furono – e sono ancora – oggetto di conflitti memoriali. Iscritto dall’UNESCO nel patrimonio mondiale dell’umanità, è un sito turistico che rientra in numerosi circuiti dell’Europa centrale. È altresì un luogo di istruzione per le comitive di studenti che arrivano dalla Polonia e dal resto d’Europa, rappresentando la parte preponderante dei visitatori. Scrissi il mio libro stabilendo continui rimandi tra ciò che il sito, oggetto di continue trasformazioni, era diventato e gli eventi che vi si svolsero. Partii dalle tracce, incessantemente rimaneggiate dall’uomo, per riscoprirne la storia. Di questi mutamenti fui io stessa testimone. Partecipai al primo viaggio ufficiale dei licei francesi, organizzato nel 1988. A quel tempo insegnavo al Liceo Voltaire di Parigi, e la scuola fu scelta perché dieci allievi, accompagnati da un insegnante, partecipassero all’iniziativa. In quel periodo, successivo al verdetto del processo Barbie, il “dovere di memoria” andava consolidandosi. Il preside mi chiese di accompagnare gli allievi estratti a sorte – si erano tutti offerti volontari – del penultimo anno. La richiesta mi lasciò di stucco. Non avevo mai pensato di andare ad Auschwitz. Un luogo, per me, senza realtà. Quel viaggio, cui presero parte un centinaio di liceali di diversi istituti parigini, venne guidato da Serge Klarsfeld, Jean-Claude Pressac e alcuni deportati, tra cui Ida Grinspan. Poiché si trattava anche di un’operazione
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
236
Shoah, modernità e male politico
mediatica, eravamo accompagnati da numerosi giornalisti, fra i quali Bertrand Poirot-Delpech per Le Monde. Partimmo di mattina presto dall’aeroporto di Orly con un volo speciale. Quattro pullman ci attendevano all’aeroporto di Cracovia. La visita cominciò da Birkenau (Auschwitz II), a tre chilometri da Auschwitz I. Il campo, immenso, era stato inizialmente costruito per la detenzione dei prigionieri di guerra sovietici. Circa 15.000 russi lavorarono alla sua edificazione, in condizioni micidiali: un piccolo memoriale è loro dedicato. La finalità di Birkenau mutò nel 1942, quando il campo fu destinato all’assassinio in massa degli ebrei inviati dai paesi europei occupati dai nazisti, dapprima in strutture “artigianali” installate in due abitazioni di contadini polacchi, che vennero poi chiamate Bunker 1 e Bunker 2. In seguito, il comandante del campo Rudolf Höss fece costruire quattro enormi edifici che comprendevano sistemi di gasazione e forni crematori, dove i membri dei Sonderkommandos bruciavano i corpi spogliati di tutto ciò che avesse un valore – le protesi dentarie, i capelli. L’enorme estensione di Birkenau comprende in realtà due zone diverse. Osservando l’area dal satellite, grazie a Google Earth, è facile distinguerle. La prima, quella che di solito viene visitata, è il quadrilatero del campo di concentramento. Le baracche di mattoni formavano il campo femminile. Marie-Claude Vaillant-Couturier, Charlotte Delbo e Wanda Jakubowska vi trascorsero parte del loro internamento. Queste baracche rischiano oggi di crollare e i responsabili del Museo si adoperano per il loro restauro. Di altri settori del campo, come quello in cui vennero rinchiuse le famiglie sinti e rom, rimangono soltanto poche tracce. Le baracche in legno – stalle mobili di campagna – vennero smontate dopo la guerra, in particolare per farne baracche di cantiere per gli operai che ricostruivano Varsavia. Quando per la prima volta abbracciai Birkenau con lo sguardo, rimasi colpita dalla sua desolata immensità, dalla quale si ergeva una moltitudine di camini in mattoni. Per un istante mi sembrò di scorgere, tra quei resti di baracche, le sagome dei crematori. Quei monconi diritti sortivano un effetto disorientante. Da allora, sono ritornata numerose volte a Birkenau, e ogni volta rivivo questa fuggevole impressione. La seconda zona è quella della messa a morte. In genere si visitano soltanto le rovine delle quattro grandi camere a gas-crematori. Ma al di là di esse l’area si estende come all’infinito. Da Birkenau il nostro gruppo si spostò ad Auschwitz I, il “vecchio” campo, il campo principale. Il cancello, sormontato dalla scritta in lettere di metallo Arbeit macht frei, e gli edifici di mattoni rossi sono diventati familiari al mondo intero attraverso il cinema e la televisione. In origine gli edifici furono costruiti per creare un quartiere di migranti. Poi vennero usati come caserma, quindi
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Wieviorka - Di che cosa Auschwitz è il nome?
237
riadattati a campo di concentramento dopo la conquista tedesca della Polonia e l’annessione dell’Alta Slesia al Reich. Oggi ospitano il Museo propriamente detto. Da una quindicina di anni vi è chi sostiene l’opportunità di separare la museografia dei due luoghi, Auschwitz e Birkenau, lasciando Auschwitz I alla gestione polacca e trasformando Birkenau in una sorta di museo in cui si racconti la storia della Soluzione finale. Una separazione di questo tipo sarebbe, a mio avviso, assurda. Gli internati circolarono sempre fra i due campi. Le sterilizzazioni di cui furono vittime gli ebrei, i sinti e i rom venivano inflitte anche ad Auschwitz I. Il campo delle donne – le donne di ogni nazionalità, ebree e non – si trovava a Birkenau. Lì vennero girati alcuni film: L’ultima tappa di Wanda Jakubowska; La passeggera di Andrzej Munk, che fu allievo di Wanda Jakubowska – un bellissimo film rimasto incompiuto perché il regista morì in un incidente d’auto rientrando da una ripresa a Birkenau; la pellicola, parzialmente autobiografica, di Marceline Loridan-Ivens, La piccola prateria di betulle. Film realizzati da donne, o di cui le donne sono protagoniste. Alcune fotografie tratte dal cosiddetto “album Auschwitz”, scattate dai nazisti all’arrivo di un convoglio di ebrei ungheresi nel maggio 1944, e alcuni cartelloni esplicativi accompagnano la visita di Auschwitz I. La Sauna centrale, attraverso cui transitavano gli uomini che entravano nel campo – lì venivano disinfettati e i loro vestiti sterilizzati – è stata aperta al pubblico nel 2001. Lo spazio include una mostra di fotografie ritrovate nei bagagli dei deportati. Non vedo con favore il progetto di museificare ulteriormente Birkenau, per il rischio di perdere la sensazione di dismisura e desolazione che quei luoghi suscitano. Il sapere necessario a comprendere il genocidio può, assai opportunamente, precedere la visita – come peraltro in genere accade. Per capire la Soluzione finale, la visita ad Auschwitz, che veniva solitamente accompagnata dai sopravvissuti, presenta però una difficoltà specifica. I centri di messa a morte dove vennero assassinati gli ebrei polacchi – che dell’ebraismo avevano costituito il cuore, nel periodo tra Prima e Seconda guerra mondiale – sono Treblinka, Chełmno, Bełżec, Sobibór. Se non si tiene conto del mezzo di distruzione – fucilazione o gas –, Babi Yar, nei pressi di Kiev, o la foresta di Ponary, vicino a Vilnius, la “Gerusalemme della Lituania”, sono altri luoghi fondamentali del massacro. Mentre i testimoni, che nello spazio pubblico rievocano ciò che Auschwitz fu, sono sopravvissuti all’universo concentrazionario. A Birkenau la situazione è particolarmente complessa. Oggi tutti sanno che, all’arrivo dei convogli di ebrei, una “selezione” separava la minoranza che “entrava nel campo” dalla maggioranza di deportati inviata direttamente, come dicevano i de-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
238
Shoah, modernità e male politico
tenuti, “al gas”, senza che il loro nome venisse registrato negli archivi. Il numero di coloro che entravano nel campo variava a seconda dei convogli, soprattutto in funzione del bisogno di manodopera dei diversi stabilimenti industriali. Il più importante era l’impianto dell’IG Farben, destinato alla produzione di caucciù – Buna in tedesco –, situato ad alcuni chilometri di distanza, a Monowitz, e al quale Primo Levi venne assegnato. Coloro che entravano nel campo vivevano un’esperienza concentrazionaria per certi aspetti identica a quella di altri campi, come Buchenwald o Ravensbrück. Ma per certi aspetti soltanto. Chi veniva selezionato alla “rampa” d’arrivo, infatti, spesso vi era stato condotto con la propria famiglia: il coniuge, i genitori, i figli, che vedeva scomparire nella parte di Birkenau sottratta agli sguardi e separata dal campo – quella dell’assassinio di massa. Avrebbe potuto seguirne lo stesso cammino ed era altresì consapevole che nuove “selezioni” avrebbero avuto periodicamente luogo e chi fosse stato dichiarato “inabile” al lavoro sarebbe stato a sua volta inviato alla camera a gas. In occasione del mio primo viaggio provai, come molti altri, un autentico choc davanti alle vetrine allestite nei blocchi 4 e 5, dedicate allo “sterminio” e alle “prove materiali dei crimini”. Vi si trovano ammassati occhiali aggrovigliati, scialli di preghiera, vestiti di bambini, valigie su cui sono scritti un nome, un luogo, una data. E, soprattutto, capelli. All’epoca mancava un riferimento esplicito al fatto che gli assassinati erano, per la grande maggioranza, ebrei. Il modo in cui i polacchi avevano rimosso la distruzione degli ebrei, facendone una componente tra le altre del vasto insieme delle “vittime del fascismo” era, a quei tempi, un tema assai dibattuto, legato peraltro alla vicenda del Carmelo, cioè al tentativo di cristianizzare il luogo. Nel 1984 otto suore carmelitane si stabilirono nel vecchio teatro, un edificio esterno al Museo, ma che era servito per immagazzinare lo Zyklon B. Le organizzazioni ebraiche pretesero il loro allontanamento, che avrebbero poi ottenuto nel 1993, dopo una lunghissima trattativa. L’allestimento museale, ora in piena trasformazione, risale al 1955 ed è stato in gran parte pensato, all’indomani della guerra, per i “prigionieri politici” – espressione utilizzata per indicare gli internati polacchi. Nel 1988 scoprii con sorpresa che alcuni di essi vivevano ancora nel campo. Quando il nostro pullman lasciò il parcheggio del Museo di Auschwitz, mi voltai per fissare nella memoria un luogo dove credevo non sarei più tornata. Alle finestre di uno dei blocchi vidi della biancheria stesa ad asciugare. Fu uno choc. Interpellai la guida che ci accompagnava, la quale, con un poco di imbarazzo, mi rispose che era il bucato delle persone che abitavano nel campo. Alcuni ex detenuti polacchi, che lavorarono al primo allestimento del Museo, vi risiedevano ancora. Kazimierz Smoleń, direttore del Museo dal 1955 al 1990, cui è
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Wieviorka - Di che cosa Auschwitz è il nome?
239
ispirato il personaggio di Stanisław Krzemiński nel film Alla fine arrivano i turisti, ha continuato ad abitarvi sino alla morte. Ma è stato l’ultimo a farlo. Rimpiango, al pari del mio amico sociologo Jean-Charles Szurek, che ha svolto la prima ricerca sul campo-museo di Auschwitz, che nessuno studio sia stato condotto sulle famiglie che hanno vissuto nel campo, sui bambini che vi sono cresciuti e sul cui terreno hanno giocato. Dopo la liberazione, un piccolo gruppo di detenuti non abbandonò il sito, che nel maggio 1945 il governo provvisorio polacco mise sotto l’amministrazione del ministero della Cultura e dell’Arte. Furono quindi gli ex internati a improvvisare un primo museo. Avevano concepito l’idea durante la detenzione e ottenuto che il perimetro del campo fosse ufficialmente dichiarato «terra di martirio». Organizzarono in tempi rapidi un mausoleo nei blocchi 10 e 11 di Auschwitz e nel blocco 4 riunirono oggetti in ricordo della distruzione. Nel luglio 1947 la Dieta – il Parlamento polacco – approvò la legge che istituiva un museo investito della missione di conservare perennemente il sito e le sue installazioni come «monumento del martirologio e della lotta del popolo polacco e di altri popoli». A una prima concezione del campo, nazionalista e cattolica, si sovrappose, sempre per volontà del governo di una Polonia ormai parte del mondo sovietico, una visione “antifascista” e internazionalista. Fu quest’ultima a ispirare la realizzazione della mostra inaugurata per il decimo anniversario della liberazione del campo, nel 1955. Le vetrine vennero allestite in quell’occasione. I polacchi onorano le proprie vittime con cerimonie che si tengono ad Auschwitz I, il campo principale, in particolare davanti al “muro della morte”, tra i blocchi 10 e 11, dove numerosi detenuti vennero fucilati. Lì accendono le candele del ricordo. Si raccolgono nella cella di Massimiliano Kolbe, un francescano che sacrificò la propria vita per salvare quella di un compagno di prigionia, padre di famiglia, e venne poi beatificato nel 1972. Ma le grandi manifestazioni si sono sempre svolte a Birkenau – dove lo spazio è immenso, mentre ad Auschwitz è limitato. Le commemorazioni sono l’occasione per discorsi di diverso tenore, adattati alle necessità politiche del momento. Fondamentale fu quella dell’aprile 1967 – a quei tempi le celebrazioni per la liberazione non venivano organizzate in gennaio, ma in aprile, come in tutti gli altri campi. Fu inaugurato il monumento internazionale, eretto alla memoria di «tutte le vittime del fascismo», in cui gli ebrei venivano appena citati. Il professore di medicina strasburghese Robert Waitz, presidente del Comitato internazionale di Auschwitz, evocò la loro sorte nel suo intervento in francese, che non fu tradotto in polacco. Gli altri discorsi non menzionarono né gli ebrei né l’antisemitismo, denunciando anzitutto l’imperialismo americano in
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
240
Shoah, modernità e male politico
Vietnam. In seguito a questa commemorazione, il professor Waitz si dimise dal proprio incarico: dimissioni che sarebbero diventate senza appello dopo l’inaugurazione del padiglione ebraico nel 1968, al momento della grande campagna antisemita in Polonia. Il Comitato internazionale di Auschwitz, che riunisce i rappresentanti delle associazioni nazionali di superstiti, si trovava allora ampiamente sotto l’influenza comunista. Anche in Francia le figure più attive nell’Amicale d’Auschwitz erano comuniste, come Marie-Claude Vaillant-Couturier e Marie-Elisa Cohen, o molto vicine a esse, come Louise Alcan. Lo stesso accadeva tra gli ebrei di cultura yiddish, che costituivano un’associazione a parte. La più imponente manifestazione svoltasi a Birkenau fu la messa celebrata da Giovanni Paolo II, primo papa polacco, nel 1979, all’inizio del suo pontificato. La folla era immensa. Un altare venne montato tra le rovine delle due grandi camere a gas-crematori. Fu innalzata un’enorme croce, sovrastata da una corona di filo spinato anziché dalla corona di spine, con il numero di matricola di Massimiliano Kolbe. Ma nonostante il monumento internazionale, di supporto alle commemorazioni, Birkenau rimane ciò che Thierry Jonquet descrive nel romanzo Cercatori d’oro: «un’area abbandonata della memoria». Sino agli anni Ottanta veniva visitato soltanto Auschwitz I, soprattutto da gruppi di studenti polacchi, che vi apprendevano il martirio del proprio popolo. A quel tempo Auschwitz apparteneva fondamentalmente alla storia della Polonia e alla sua identità. Sin dall’immediato dopoguerra alcune persone vi si recarono per raccogliersi nei luoghi dove i loro cari erano stati assassinati. Ma si trattava di viaggi individuali e familiari. Auschwitz divenne un vettore della memoria ebraica a metà degli anni Ottanta. Fu allora che i viaggi collettivi si moltiplicarono, per iniziativa di diverse associazioni: in Francia possono ricordarsi l’Amicale d’Auschwitz e dei campi dell’Alta Slesia, l’associazione Figli e figlie dei deportati ebrei di Francia, il Movimento ebraico liberale, il Memoriale della Shoah. Ma questo tipo di visitatori restava minoritario, perché Auschwitz cominciò a diventare un museo in cui affluivano le folle. Il numero dei visitatori variò secondo gli anni, con picchi al momento della beatificazione di Massimilano Kolbe (circa 800.000 persone nel 1972) o della messa di Giovanni Paolo II ricordata prima (circa 750.000). Negli anni Ottanta e Novanta il flusso di visitatori si stabilizzò intorno al mezzo milione. Dal 2001 cominciò una lenta crescita, sino a raggiungere 1,4 milioni di visitatori, con un culmine nel periodo estivo. Piotr Cywiński precisa che nel mese d’agosto sotto il cancello Arbeit macht frei passa una persona ogni due secondi e arrivano trenta classi all’ora. Quest’aumento di
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Wieviorka - Di che cosa Auschwitz è il nome?
241
visite non ha equivalente nei memoriali degli altri campi, di Dachau o di Buchenwald. È una caratteristica esclusiva di Auschwitz. Considerando l’afflusso medio di tutto l’anno, i visitatori sono in grande maggioranza polacchi, soprattutto studenti. Gli altri provengono da molti paesi: specialmente dagli Stati Uniti e da Israele, ma anche dall’Europa occidentale (Germania, Francia, Italia) e, dalla metà degli anni Novanta, dall’Europa centrale, dalla Repubblica Ceca e dalla Repubblica Slovacca, e persino dalla Corea del Sud. Fa eccezione l’Austria, nonostante Auschwitz sia più vicino a Vienna che a Varsavia. Anche nel caso dei visitatori provenienti da questi paesi, i primi viaggi, quelli dei figli dei deportati, erano viaggi di raccoglimento; poi è arrivato il momento dei viaggi scolastici, analoghi a quello francese del 1988. Piotr Cywiński ha manifestato la propria preoccupazione per l’assenza dei “carnefici” – ossia di chi ha la responsabilità del genocidio o in quel luogo lo ha attuato – nell’allestimento della mostra di Auschwitz, interrogandosi sul senso di creare «un mondo in bianco e nero, in cui si mostra solo il bianco, il bianco terribile, il bianco assassinato. Un’identificazione, questa, che non consente di formulare le domande antropologiche e filosofiche più profonde, le domande sulla natura dell’essere umano» (Cywiński 2011: 24). Sarà interessante vedere come il problema verrà affrontato nella nuova mostra. Che Auschwitz sia diventato un museo è un fatto incongruo in sé. Se infatti lo scopo di un museo consiste nel mostrare al pubblico e conservare opere d’arte e prodotti culturali, quello di Auschwitz testimonia, al contrario, un eclissamento della cultura, un episodio di de-civilizzazione. Nelle sue “collezioni” sono custoditi migliaia di oggetti che presentano problemi di conservazione complessi e onerosi. Alcuni sono in plastica o in materiali compositi, e ancora non si sa come preservarli. Altri, come il filo spinato, vengono periodicamente sostituiti. Alcune baracche di legno sono state ricostruite con elementi originali. La massicciata della ferrovia, un tempo invasa di erbe selvatiche, è cosparsa di ghiaia. I prati di Birkenau vengono tosati con regolarità. Si cura la vegetazione e gli alberi sono considerati «testimoni muti dell’Olocausto» (Wieviorka 2011: 224). All’esterno del perimetro di Birkenau, sulla rampa – la Judenrampe – dove arrivavano i convogli dalla Francia sino alla primavera 1944, prima che la ferrovia venisse prolungata sino alle camere a gas-crematori, è stato posto un memoriale inaugurato da Jacques Chirac nel 2005. Il tempo, dunque, ha modificato i luoghi e le cose. Il sito è in perenne evoluzione. Oggi il Museo di Auschwitz-Birkenau si deve confrontare con il cambiamento di prospettiva sulla storia del campo di Auschwitz e, al
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
242
Shoah, modernità e male politico
tempo stesso, con le sfide della conservazione. “Conservare nello stato originale” è un principio-guida. Eppure, lo stato da non alterare non è quello del sito originale. Risale agli anni Cinquanta: non è quello della liberazione, nel gennaio 1945, quando vennero distrutte le camere a gas e il “Canada” – le trenta baracche dove venivano immagazzinati gli oggetti requisiti agli ebrei –, né quello che precedette gli smantellamenti. In quei cinque anni, d’altronde, il campo fu un continuo cantiere. Le questioni sollevate dalla conservazione di Auschwitz – di questo «patrimonio negativo», per riprendere un’espressione di Sophie Wahnich – costituiscono di certo un avvincente tema di discussione. Auschwitz è così diventato un nodo centrale dei discorsi sull’identità europea e sulla costruzione di un nuovo ordine internazionale. Elie Wiesel ha formulato, probabilmente per primo, l’idea che non si deve provare vergogna per essere stati vittime della persecuzione nazista. Egli non vuole pensare all’ebreo come sofferente. Preferisce considerarlo un essere che può «vincere la sofferenza – la propria, e quella altrui. Perché la propria ha una dimensione messianica: può salvare il mondo da un nuovo Auschwitz» (cit. in Chaumont 1997: 114). Il pensiero di Wiesel è profondamente impregnato di cultura ebraica e la concezione di un messianismo sorto ad Auschwitz è ovviamente estranea al modo di pensare di molti. Ma, nel contesto del crollo del comunismo, egli l’ha trasposta in una dimensione secolare. Nel corso degli anni Novanta, iniziati con la caduta del muro di Berlino e la fine della Guerra fredda, si prospettò l’illusione di un trionfo della democrazia e dei diritti umani. Insegnare la Shoah significava, oramai, stigmatizzare il male. Ho assistito a tre conferenze che hanno istituzionalizzato questi principi: Washington nel 1998, Stoccolma nel 2000 e Strasburgo nel 2002. Il tema della Conferenza internazionale di Washington riguardò la questione dei fondi bancari e delle opere d’arte saccheggiate dai nazisti. Wiesel si ribellò al fatto che il genocidio degli ebrei potesse tradursi in una questione di denaro. Richiamò la necessità di interventi educativi, e venne ascoltato. Nel 2000 numerosi capi di Stato e di governo, riuniti a Stoccolma, adottarono una risoluzione riguardante l’istruzione. In quell’occasione si discusse anche dell’opportunità di esigere la messa in atto di un programma educativo sull’Olocausto come condizione per l’ingresso nell’Unione europea dei paesi dell’Europa orientale. L’idea venne poi abbandonata. Fu attivata, in compenso, la Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research: un’organizzazione intergovernativa che si pose l’obiettivo di prevenire, attraverso l’educazione, i genocidi e gli altri crimini contro l’umanità. Si trattò della traduzione in termini di politi-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Wieviorka - Di che cosa Auschwitz è il nome?
243
ca internazionale delle idee di Wiesel. Questa Task Force, la cui presidenza spetta a turno a tutti i paesi membri, globalizza – e persino uniforma – le modalità di ciò che chiamiamo “memoria”. Nell’ottobre 2002 i ministri dell’Istruzione dei 48 Stati membri del Consiglio d’Europa realizzarono un’altra promessa fatta a Cracovia nel 2000: istituire una giornata dedicata «alla memoria dell’Olocausto e alla prevenzione dei crimini contro l’umanità». Ogni Stato poté scegliere autonomamente la data in cui celebrarla. La Francia, come l’Italia, optò per il 27 gennaio, giorno dell’anniversario dell’apertura dei campi di Auschwitz. Si tratta, dopo la Giornata internazionale della deportazione e quella in memoria delle vittime dello Stato francese, di una terza giornata commemorativa ufficiale. Nel 2005 l’ONU concluse il processo di globalizzazione: il 27 gennaio divenne la Giornata internazionale in memoria delle vittime dell’Olocausto. Occorrerebbe interrogarsi sulla centralità del ruolo conferito alla scuola, sulla situazione per cui ai partiti politici non spetterebbe più il compito di garantire la continuità della democrazia e l’uguaglianza tra gli uomini, indipendentemente dalla loro origine e dalla loro appartenenza religiosa o etnica. È sufficiente trasferire questa responsabilità al corpo docente, che deve educare la gioventù “contro Auschwitz”? Bisogna passare dall’inculcare valori positivi a un’educazione preventiva, come se i nostri allievi fossero piccoli nazisti potenziali? Ad Auschwitz sono stati pronunciati molti discorsi. Tanti uomini politici – Charles de Gaulle, Jacques Chaban-Dalmas, Valery Giscard d’Estaing, Fidel Castro, Kurt Waldheim, il Dalai Lama, George Bush senior, Juan Carlos, Helmut Kohl – hanno visitato il sito durante i loro viaggi in Polonia e scritto frasi sul libro degli ospiti del Museo. La commemorazione del sessantesimo anniversario della liberazione del campo fu l’occasione per una cerimonia che radunò capi di Stato e di governo di tutto il mondo, compreso Putin. Presero la parola Simone Veil a nome degli ebrei, Romani Rose a nome di sinti e rom e Władysław Bartoszewski a nome dei prigionieri politici. Durante le settimane di commemorazione si dibatté molto di ricordo, di pace nel mondo, di diritti umani. Recarsi ad Auschwitz corrisponde, per un politico, a cercare una patente di moralità. Poco importa il modo in cui governa, o se le sue prigioni siano piene di detenuti politici, e vi si pratichi la tortura, e si muoia di fame mentre una classe dirigente corrotta vive nel lusso. Vorrei concludere facendo mie le parole di Piotr Cywiński, direttore del Museo di Auschwitz: il «mai più» è un tema filosofico avvincente, ma
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
244
Shoah, modernità e male politico
quando diventa la tua effettiva responsabilità professionale, ti consuma a fuoco lento […]. Quando ci si rende contro che un milione e trecentomila persone passano per questi luoghi e piangono, s’indignano, si sentono in colpa, e tutti appaiono sconvolti, e poi l’anno successivo, in qualche parte del mondo, si verifica un genocidio o un inizio di genocidio o una carestia, e quel milione e trecentomila persone non fa nulla, nonostante i mezzi di informazione di cui disponiamo, allora ci si comincia a porre delle domande sul ruolo di questa storia, così come la raccontiamo. Mi manca una risposta. (Cywiński 2011: 21)
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
245
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
DIEGO GUZZI
SE QUESTO È UN LUOGO Auschwitz e le memorie europee
Tracciando un bilancio della seconda metà del Novecento, lo storico Tony Judt ha osservato come a partire dagli anni Novanta il riconoscimento della Shoah abbia costituito un “ticket di ingresso” indispensabile per partecipare al processo di integrazione europea, di cui prima i paesi baltici, poi la Polonia e la Romania si sono dovuti dotare per poter entrare a pieno titolo nell’Unione. Senza ticket, questi Stati rischiano di rimanere esclusi dal dibattito pubblico e dal sistema di valori comunitario, perché negli anni in cui il continente si propone di voltare definitivamente la pagina della Seconda guerra mondiale – in cui si onorano gli ultimi sopravvissuti e l’“età dei testimoni” volge inesorabilmente al termine – la memoria degli ebrei assassinati d’Europa costituisce la principale garanzia di un umanesimo ritrovato (Judt 2005: 989-1023). Tale provocazione invita a riflettere sulle ripercussioni che prima il riconoscimento della singolarità dell’Olocausto, poi il consenso tributato alla specificità della sua memoria, hanno proiettato sulla costruzione dell’identità europea. Nella gamma di eventi, simboli e luoghi che compongono il concetto di “coscienza europea”, Auschwitz – inteso come metonimia del genocidio – occupa infatti una posizione centrale. E se tale circostanza è per certi versi apprezzabile, perché sancisce l’ammissione di una catastrofe inizialmente rimossa dalla memoria pubblica, o comunque confinata ai suoi margini, in altro senso rappresenta un approdo problematico, poiché la iscrive nello scenario di una violenza politica senza precedenti: una sorta di vortice oscuro del Novecento che, dopo aver assorbito e annientato virtù morali, diritti ed esseri umani, costituisce oggi il perno intorno a cui gravita il concetto di “male assoluto”. Prima di riflettere sulle caratteristiche che rendono Auschwitz il cardine ambiguo dell’identità europea, può essere utile rievocare per sommi capi le principali tappe dell’evoluzione del ricordo della Shoah. All’inizio del mio contributo farò pertanto cenno ad alcuni snodi fondamentali di questo sviluppo per rammentare che il riconoscimento del genocidio non è stato spontaneo e lineare, ma ha al contrario richiesto un laborioso sforzo di
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
246
Shoah, modernità e male politico
costruzione. Cercherò in seguito di illustrare in quale senso Auschwitz può essere considerato un “luogo” della memoria europea, nell’accezione conferita al termine dall’intellettuale francese Pierre Nora e ormai entrata nel lessico storiografico. Mi soffermerò infine sulle difficoltà in cui è incappato, e potrà continuare a imbattersi, il proposito – ratificato dall’istituzione della Giornata internazionale della memoria – di universalizzare il valore pedagogico della riflessione sulla Shoah. Suggerendo l’ipotesi secondo cui le prospettive postcoloniali, e più in generale extraeuropee, non rappresentano l’unico ostacolo alle strategie di globalizzazione del ricordo. Le quali, già entro la cornice del discorso pubblico europeo, devono misurarsi con l’esistenza di una pluralità di memorie, non di rado dissonanti o contrapposte. 1. Le genealogie della memoria della Shoah concordano nell’individuare, dalla fine della Seconda guerra mondiale agli anni Sessanta, un’iniziale fase di silenzio. Anche in conseguenza di una deliberata amnesia istituzionale, fatta di epurazioni mancate e sollecite amnistie, si registrò in Europa una diffusa rimozione della catastrofe. Senza distinzioni di rilievo tra Est e Ovest, le società del dopoguerra non mostrarono uno specifico interesse verso il genocidio, di norma considerandolo un effetto collaterale del conflitto. Celebravano i soldati uccisi dal nemico e i resistenti immolatisi per la libertà, mentre scarsa compassione veniva riservata agli ebrei perseguitati. Nelle retoriche commemorative antifasciste, per esempio, un’implicita gerarchia della sofferenza anteponeva la deportazione politica a quella razziale, perché la contrapposizione frontale ai regimi era ritenuta un atteggiamento indispensabile al riconoscimento vittimario. In un sistema di relazioni ancora improntato all’agonismo del contesto bellico, la presunta remissività dell’atteggiamento ebraico veniva invece giudicata in modo negativo. E in virtù di un nesso che oggi può apparire paradossale, la piena innocenza diventava spia di una passività biasimevole. Non si può escludere che la sottovalutazione del genocidio dipendesse anche dal persistere di pregiudizi antisemiti, ma la causa principale sembra risiedere nel solco di un’invalsa logica nazionalista. Se durante il conflitto lo status di apolidi aveva reso gli ebrei facili prede della ferocia nazista, al termine della guerra impedì loro di affermare la particolarità della tragedia che li aveva decimati. Venivano considerati vittime italiane o francesi, tedesche o polacche, e si ometteva che erano stati perseguitati e uccisi per motivi esclusivamente razziali. D’altronde, le stesse comunità ebraiche si mostrarono riluttanti a indicare le effettive misure della deportazione.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
D. Guzzi - Se questo è un luogo
247
Tardarono, per esempio, a unirsi in gruppi di rivendicazione coesi, non riuscendo così a esercitare l’influenza necessaria a concorrere nell’arena delle narrazioni postbelliche. La memoria dello sterminio fu occasionalmente trasmessa da associazioni che agirono però senza coordinamento e si mostrarono riluttanti a reclamare un’appartenenza che era stata all’origine di tante discriminazioni. Come accadde in Italia, dove le persecuzioni furono a lungo taciute anche nell’intento di ristabilire il buon livello di integrazione del periodo prefascista. Più in generale, si può sostenere che per volontà di distensione o difetto di sensibilità, con intento di pacificazione o obbedendo alle convenienze suggerite dalla ragion di Stato, i paesi europei scelsero di non fare i conti con il passato: preferirono occultare le colpe e le responsabilità, o almeno procrastinarne l’accertamento. Su questo punto si trovarono d’accordo De Gasperi e Togliatti, de Gaulle e il giovane Mitterrand, Adenauer e i segretari dei partiti comunisti dell’Europa orientale. L’incantesimo del silenzio venne infranto negli anni Sessanta da fatti accaduti in Israele e negli Stati Uniti, che sortirono però effetti rilevanti anche in Europa, contribuendo a definire un paradigma “occidentale” della memoria della Shoah. Nel 1961 si tenne a Gerusalemme il processo Eichmann. Per la prima volta le testimonianze delle vittime, rese credibili dalla congruenza di una pluralità di deposizioni e amplificate da un puntuale resoconto mediatico, sollecitarono l’opinione pubblica internazionale a interrogarsi sulle reali dinamiche delle persecuzioni razziali. E da quel momento, confortati dall’ascolto, molti sopravvisuti trovarono il coraggio per uscire dalla condizione di afasia cui l’oblio istituzionale li aveva in certo senso relegati. Alcuni anni più tardi, nel 1967, un discorso pronunciato a New York dallo scrittore Elie Wiesel in occasione della conferenza annuale della rivista Judaism, espresse con chiarezza le impressioni emerse nell’aula di Gerusalemme. «Perché» si domandò Wiesel «pensiamo all’Olocausto con vergogna? Perché non lo rivendichiamo come un capitolo glorioso della nostra storia eterna? Dopotutto, ha mutato l’uomo e il mondo […]. Ha addirittura avuto il potere di cambiare il linguaggio. I quartieri dei neri vengono chiamati ghetti; Hiroshima viene spiegata attraverso Auschwitz […]. Resta il più grande evento del nostro tempo. Perché ne abbiamo vergogna?» (Wiesel 1967). Queste parole, passate all’epoca quasi inascoltate, acquisiscono retrospettivamente un significato non solo simbolico. Propongono infatti un mutamento radicale di prospettiva, indispensabile per bandire dal dibattito sulla Shoah una sensazione, paradossale e diffusa, descritta da Primo Levi con la lucidità consueta: «La vergogna […] che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altrui, e gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
248
Shoah, modernità e male politico
che esistono, e che la sua volontà buona sia stata nulla o scarsa, e che non abbia valso a difesa» (Levi 1963: 10-1). In altri termini, tra il processo Eichmann e il discorso di Wiesel si crearono le condizioni per rappresentare la figura del deportato sotto una luce diversa. Da un lato, l’ebreo discriminato, ghettizzato, internato e assassinato cominciò ad acquisire il profilo di una vittima “assoluta”, meritevole di una commiserazione universale. Dall’altro, la sua sorte, definita come il peggiore dei mali possibili, prese ad assumere i tratti di un’eventualità da scongiurare in ogni modo, invertendo una tormentata tradizione di sudditanza e assoggettamento. Non fu dunque un caso che, in quello stesso periodo, sia stato un evento militare, la Guerra dei sei giorni, combattuta nel giugno 1967, a indirizzare la riflessione sul futuro del popolo ebraico. In particolare nella diaspora europea, il rischio di un attacco distruttivo dei paesi arabi rafforzò il sentimento di appartenenza e il legame con Israele: una “patria” da difendere con risolutezza anche – e forse soprattutto – per chi aveva deciso di non trasferirvisi. Profittando dell’onda emotiva suscitatata dal timore di una seconda catastrofe, alcuni esponenti politici israeliani iniziarono al contempo a evocare implicazioni e conseguenze dell’Olocausto a fini propagandistici, inaugurando una deplorevole consuetudine di strumentalizzazione della memoria. Più in generale, e prescindendo dagli abusi, lo scenario mediorientale divenne per l’Occidente un riferimento geopolitico irrinunciabile e il baricentro degli equilibri internazionali. La rievocazione dei crimini del passato cominciò allora a intrecciarsi e confondersi con le poste in gioco del presente in una miscela spesso esplosiva di storia e attualità. Da un punto di vista più strettamente culturale, bisogna precisare che in Europa sarebbe trascorso un altro quarto di secolo prima che gli effetti di tali accadimenti si dispiegassero appieno e la specificità della Shoah diventasse patrimonio condiviso. Tra i vettori della memoria collettiva che propiziarono questo sviluppo, due almeno meritano di essere menzionati, perché tra gli anni Ottanta e Novanta esercitarono più di altri un’influenza decisiva sull’opinione pubblica: il cinema e i processi della “seconda epurazione”. Si indica solitamente nel serial televisivo di Marvin J. Chomsky Holocaust, trasmesso nel 1978 dal canale statunitense NBC – e diffuso l’anno successivo nella Repubblica Federale Tedesca, in Francia e in Italia – la prima fiction che affrontò direttamente il tema del genocidio nazista, incentrando la trama sulla sorte di una famiglia ebraica perseguitata. Furono poi Schindler’s List di Steven Spielberg, vincitore di sette premi Oscar nel 1994, e La vita è bella di Roberto Benigni, che ne ottenne tre cinque anni più tardi, a rendere la Shoah – e la rappresentazione della sorte vittimaria
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
D. Guzzi - Se questo è un luogo
249
– soggetto di film concepiti per il grande pubblico. Non è possibile calcolarne gli spettatori, prima al cinema, poi nelle frequenti repliche televisive, ma è senza dubbio grazie a essi che decine di milioni di persone si sono interessate per la prima volta alle dinamiche dell’Olocausto. In entrambe le pellicole non mancano scelte registiche criticabili che tendono a banalizzare, estetizzare o edulcorare la realtà, per esempio nel deprecabile tentativo di conformarla all’imperativo hollywoodiano dell’happy end. Sarebbe tuttavia ingeneroso negar loro il merito di aver reso “popolare”, semplificandola, la conoscenza di un tema confinato per decenni entro gli argini della commemorazione identitaria, della ricerca accademica o, nel migliore dei casi, della letteratura memorialistica. Il secondo vettore del ricordo, altrettanto efficace, è invece costituito dai processi della “seconda epurazione”; locuzione con cui si indicano i procedimenti penali intentati negli anni Ottanta e Novanta contro vecchi nazisti e collaborazionisti scampati alla rete – a dire il vero molto allentata – della giustizia postbellica. Ai processi tenutisi in Francia contro Klaus Barbie (1985), Paul Touvier (1994) e Maurice Papon (1997-98), o in Italia contro Erich Priebke (1996-98), vennero dedicate prime pagine di quotidiani, copertine di riviste e puntate speciali di programmi televisivi con elevate percentuali di ascolto. Anche in virtù della loro implicita struttura drammatica, i procedimenti penali attirarono così l’attenzione di ampie fasce di pubblico che appresero la specificità ebraica della persecuzione nazista in Europa non più attraverso il filtro della finzione cinematografica, bensì ripercorrendo le cronache di fatti realmente accaduti. Ma affinché questi sforzi – rivolti, seppur da angolazioni diverse, al medesimo obiettivo – potessero tradursi in un effettivo radicamento della memoria della Shoah nel discorso pubblico, divenne indispensabile attivare precise strategie di istituzionalizzazione del ricordo. I primi passi in questa direzione vennero mossi, una volta ancora, negli Stati Uniti. Tra il 1995 e il 1999 un’accesa controversia oppose alcune associazioni israelitiche americane agli istituti bancari elvetici. Al centro della disputa, le somme di denaro che migliaia di ebrei morti nel genocidio avevano depositato, prima e durante la guerra, su conti correnti svizzeri. Rimasti senza titolari e successibili, i beni erano stati trattenuti dagli istituti, che avevano ostacolato a più riprese le richieste di risarcimento avanzate dalle associazioni che rappresentavano le vittime. Quando gli avvocati decisero di spostare la contesa sul piano legale, intentando una class action che si preannunciava di forte impatto mediatico, le banche si allarmarono per i possibili danni d’immagine della denuncia e scelsero di anticipare l’autorità giudiziaria intavolando una trattativa con il Congresso ebraico
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
250
Shoah, modernità e male politico
mondiale. Una commissione indipendente, incaricata di consultare archivi rimasti sino a quel tempo inaccessibili, accertò l’esistenza di circa trentaseimila conti, mai rimborsati, intestati a vittime del genocidio. E, al termine di un negoziato, venne pattuita tra le parti una riparazione forfettaria di oltre un miliardo di dollari. La vicenda costituì un precedente che indusse altre comunità ebraiche a esigere analoghi indennizzi dalle rispettive banche nazionali. Sull’onda dello scandalo, nel dicembre venne organizzata a Londra una conferenza internazionale sul problema delle requisizioni, cui presero parte le delegazioni di quaranta Stati. L’anno successivo un secondo convegno si tenne a Washington per iniziativa di Elie Wiesel, che volle però scongiurare il rischio di ridurre il tema della memoria della Shoah a una mera questione di riparazioni monetarie. Accanto al problema economico venne così affrontato, per la prima volta a livello internazionale, il tema dell’Holocaust Education, nell’auspicio – in numerosi casi realizzatosi – che gli indennizzi servissero a finanziare fondazioni culturali e progetti di ricerca sul genocidio. Negli stessi mesi il primo ministro svedese Göran Persson – capo del governo socialdemocratico di un paese rimasto neutrale durante la guerra – agì in una direzione convergente. Dapprima incentivò la memoria della Shoah a livello nazionale, favorendone lo studio nelle scuole. In seguito estese il progetto oltreconfine, coinvolgendo il primo ministro britannico Tony Blair e il presidente americano Bill Clinton nella creazione di una Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research (ITF). All’organizzazione si unirono nel 1998 Germania e Israele, l’anno successivo Olanda, Polonia, Francia e Italia. Il primo appuntamento di rilievo fu una conferenza sul tema dell’educazione tenutasi a Stoccolma dal 26 al 28 gennaio 2000, cui parteciparono seicento delegati di quarantasei paesi, tra i quali venti capi di Stato, mossi dall’intento di determinare le risorse necessarie per l’insegnamento della Shoah alle giovani generazioni. Due altre circostanze contribuirono frattanto a collocare la memoria del genocidio al centro del discorso politico europeo. Da un lato, il successo elettorale in Austria della destra estrema di Jörg Haider – che nel 1999 divenne governatore della Carinzia, portando il suo partito a ottenere oltre il 27% dei suffragi nelle elezioni federali – allarmò l’opinione pubblica sul pericolo di reviviscenze autoritarie. Il ricordo dei crimini del nazismo venne allora utilizzato come antidoto contro la tentazione di rievocare, in chiave nostalgica, vecchi stereotipi di stampo fascista. D’altro lato, le operazioni di pulizia etnica perpetrate dal governo serbo in Kosovo vennero indicate da molti osservatori quale pericolo di un nuovo genocidio sul
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
D. Guzzi - Se questo è un luogo
251
territorio europeo. Gli attacchi della NATO su Belgrado – tra il marzo e il giugno 1999 – furono in più circostanze motivati dallo slogan “Mai più Auschwitz!”. E fu nell’ambito del conflitto nei Balcani che le retoriche occidentali sancirono lo slittamento dell’Olocausto, nel sentire comune, da crimine di guerra a «trauma culturale» (Alexander 2003: 95-100). Sia l’ascesa politica di Haider sia la pulizia etnica in Kosovo influenzarono direttamente la dichiarazione finale della conferenza di Stoccolma, in cui si affermava che l’«Olocausto ha sostanzialmente sfidato i fondamenti della civiltà [e il suo] carattere senza precedenti avrà sempre significato universale». Una consapevolezza, questa, tesa a «rafforzare l’impegno morale dei nostri popoli e quello politico dei nostri governi, per avere la certezza che le future generazioni possano comprendere le cause dell’Olocausto e riflettere sulle sue conseguenze». L’impegno istituzionale venne consolidato a stretto giro dal Consiglio d’Europa, che nell’ottobre 2002 approvò un documento in materia di ricordo della Shoah. I ministri dell’Educazione degli Stati membri decisero di istituire un Giorno della memoria allo scopo di sensibilizzare gli studenti «nei confronti delle pagine nere della nostra storia, analizzando le tematiche del genocidio e di tutti i crimini contro l’umanità al fine di promuoverne la prevenzione, la comprensione, la tolleranza e il dialogo tra nazioni, razze e religioni». In particolare, il Consiglio si propose di coadiuvare gli insegnanti a realizzare progetti didattici, mettendo a loro disposizione documenti e materiale informativo. La risoluzione dell’ONU che nel novembre 2005 istituì la Giornata internazionale della memoria si limitò, in sostanza, a recepire le conclusioni della conferenza di Stoccolma cosmopolitizzandone la validità, ossia applicando le categorie concepite in ambito europeo a una dimensione globale. Venne scelta, come è noto, la data del 27 gennaio: il giorno del 1945 in cui l’Armata rossa, in marcia verso Berlino, si imbatté per caso nel campo di Auschwitz; poi diventato, nel corso dell’evoluzione memoriale sinteticamente abbozzata, metonimia della distruzione degli ebrei d’Europa per almeno tre ragioni. Anzitutto, è stato il Lager in cui si sono contate più vittime, oltre un milione e centomila. Costituisce inoltre, per l’ampiezza dell’area in cui sorse e la diversità delle strutture che lo componevano – non solo il campo di concentramento di Auschwitz I, ma anche Birkenau, uno dei sei campi di sterminio del sistema concentrazionario, e numerosi campi di lavoro – la struttura più rappresentativa delle differenti articolazioni della violenza nazista. Da ultimo, buona parte delle testimonianze che sono divenute narrazioni esemplari della condizione vittimaria sono state scritte da deportati che lì furono internati.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
252
Shoah, modernità e male politico
2. Auschwitz, simbolo del genocidio ebraico, può essere considerato un “luogo” della memoria europea, nell’accezione attribuita al termine dall’intellettuale francese Pierre Nora, curatore dell’imponente opera Les lieux de mémoire. Il lavoro, realizzato con il contributo di decine di collaboratori e pubblicato in sette volumi tra il 1984 e il 1992, si propone di inventariare, come voci enciclopediche, i “luoghi” in cui si incarna la memoria nazionale francese. Il dizionario Grand Robert, ricalcando un’espressione dello stesso Nora, definisce il lieu de mémoire come un’«unità significativa, di ordine materiale o ideale, che la volontà degli uomini o il lavoro del tempo ha reso elemento simbolico di una qualche comunità». Il carattere topografico, che si supporrebbe centrale, ha dunque una funzione secondaria, perché i “luoghi” sono anzitutto vettori culturali della memoria pubblica – paletti identitari del gruppo per cui valgono – che Nora intende sottrarre alla «rapida scomparsa» cui l’accelerazione della storia, tipica dell’età contemporanea, sembra condannarli (Nora 1984: VII). Repertoriarli significa dunque mettere al riparo dall’impeto delle trasformazioni sociali e dall’erosione dell’oblio elementi significativi del patrimonio nazionale: festività, monumenti, istituzioni, pratiche commemorative, consuetudini, movimenti politici e personalità celebri. E al contempo riconoscere loro il valore normativo di strumenti di stabilità sociale volti alla codificazione di una pedagogia nazionale. Appare tuttavia evidente sin dal prologo dell’opera che i “luoghi” rispecchiano l’epoca contemporanea nella prospettiva di uno sguardo nostalgico condizionato dal rimpianto del passato. Secondo Nora, la democratizzazione e la globalizzazione del discorso pubblico hanno infranto il modello della società tradizionale e le istituzioni che assicuravano la trasmissione dei valori – scuola, famiglia, Stato – hanno perso autorevolezza, riscoprendosi incapaci di innervare le memorie collettive. Il fenomeno non si è verificato in modo imprevedibile, configurandosi piuttosto come l’epilogo di un lungo processo, caratteristico della modernità, per cui la carica trasformatrice della storia ha progressivamente prevalso sulla lenta, ripetitiva trasmissione intergenerazionale. Poiché, però, la situazione sembra giunta al proprio culmine – a un suo «convulso traguardo» (Nora 1984: XVIII) – la memoria delle origini deve essere condensata in “luoghi” rappresentativi. Nell’ottica di Nora, la memoria abita la dimensione del sacro e dell’assoluto, mentre la storia appartiene all’ambito del prosaico e del relativo. Se la prima è per natura molteplice, collettiva, plurale, ma strettamente vincolata all’identità del gruppo di cui è manifestazione, la seconda tende alla generalizzazione e rivela una vocazione universalistica. Ecco perché una società che vivesse integralmente sotto il segno della storia perderebbe ogni punto di riferi-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
D. Guzzi - Se questo è un luogo
253
mento memoriale. Ed ecco perché, per contrastare la deriva omologante dell’epoca contemporanea, occorre creare archivi, organizzare celebrazioni, festeggiare anniversari, rivolgendo un’attenzione specifica a operazioni un tempo spontanee. I lieux hanno insomma un carattere residuale: musei, cimiteri e collezioni, monumenti, santuari e memoriali rivestono nelle società secolarizzate e democratiche la funzione di succedaneo. Sono, se si vuole, presidi di vigilanza memoriale che la storia accetta di sottrarre alle trasformazioni di cui è essa stessa promotrice. Les lieux de mémoire ha avuto un forte impatto sul dibattito accademico, ispirando analoghe operazioni culturali in altri paesi europei. In Italia, per esempio, tre volumi curati da Mario Isnenghi (1996) hanno raccolto I luoghi della memoria, accorpando simboli e miti, strutture ed eventi, personaggi e date dell’Italia unita. Ma la declinazione di maggior interesse del paradigma riguarda probabilmente la versione tedesca: i Deutsche Erinnerungsorte, curati da Étienne François e Hagen Schulze (François – Schulze 2001). Numerosi elementi hanno reso complessa a priori l’impresa editoriale. Se in Francia il progetto si ancora a robuste continuità storiche e al radicamento repubblicano della coscienza nazionale, in Germania la tradizione di Kulturnation, la giovane storia unitaria, le implicazioni emozionali del rapporto al passato recente e i dibattiti sull’identità che ne sono conseguiti, prefigurarono da subito le difficoltà della trasposizione. Lo stimolo fu allora trovato nell’indagine delle memorie tedesche, al plurale. In parallelo, la constatazione che la complessità della storia nazionale non sarebbe stata colta se non nella prospettiva più ampia dell’intera vicenda europea, ha indotto i curatori a contemplare tra le voci un ragguardevole numero di riferimenti condivisi. Vi sono infatti, non solo in Germania, “luoghi”, materiali e immateriali, che segnano una cesura tra due nazioni, ma risultano al contempo fondamentali per la memoria pubblica di entrambe, anche se sotto prospettive distinte o persino opposte. Nelle relazioni franco-tedesche, per esempio, la cattedrale di Strasburgo, Versailles o Napoleone rappresentano “luoghi” significativi, pur se per ragioni differenti, per entrambi i paesi. Oppure, l’immagine del cancelliere Willy Brandt che nel dicembre 1970 si inginocchia davanti al monumento ai resistenti del ghetto di Varsavia è iscritta, per motivi diversi, nella coscienza nazionale sia tedesca sia polacca. In un certo senso, tali tentativi snaturano l’intenzione originaria, perché autorizzano il reinserimento della memoria pubblica nei processi di estensione sopranazionale ai quali la storiografia dei “luoghi” avrebbe voluto sottrarla. D’altro canto, però, prendono semplicemente atto della realtà, cercando di applicare la lente storiografica di Nora all’osservazione di un
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
254
Shoah, modernità e male politico
mondo che, dalla Seconda guerra mondiale in avanti, ha iniziato a sfuggire all’impianto nazionalistico. Anche se la globalizzazione non ha l’efficacia che i suoi sostenitori le attribuiscono, essa logora comunque l’idea di nazione. Il caso dell’Unione europea è emblematico. Da una parte il progetto di integrazione non entusiasma i popoli, come dimostrano lo scarso tasso di affluenza alle elezioni del Parlamento e la formazione, in seno a esso, di gruppi euroscettici. D’altro lato, è improbabile, almeno nel breve periodo, che il trasferimento progressivo di potere dai governi nazionali alle istituzioni unitarie si interrompa. Ciò non elimina i problemi, che permangono e assumono anzi proporzioni crescenti. L’integrazione istituzionale ha mosso pochi e timidi passi e quella economica sta rivelando tutte le sue contraddizioni. Ma è forse in ambito culturale che emerge la più clamorosa lacuna del tentativo di integrazione: manca un terreno comune e gli analisti registrano un crescente divario tra “comunità morale” e “comunità legale”. A oltre mezzo secolo dall’inizio del processo unitario, si può parlare, nella più indulgente delle diagnosi, di coabitazione pacifica delle diverse memorie patrie, che mantengono però con determinazione la propria specificità, reagendo fermamente alle spinte transnazionali. Il fatto è di solito motivato dalla carenza di eventi significativi condivisi: non esistendo una storia condivisa, nemmeno può esistere una memoria europea e dunque mancano “luoghi” che possano a buon titolo rappresentarla. A ben vedere, però, la questione è più complessa. In un intento comparativista, infatti, non è impossibile rintracciare elementi comuni della storia europea, ma si tratta di catastrofi e carestie, guerre e genocidi. Le idee di risonanza sopranazionale si sono rivelate lugubri e criminali: l’avventurismo coloniale, l’intransigenza religiosa, l’entusiasmo bellicista o, negli anni Trenta e Quaranta del Novecento, le politiche fasciste. In tali avvenimenti le somiglianze non mancano. Ma possono difficilmente valere da paletti identitari, poiché di solito la coesione si crea intorno a gesta eroiche condivise. Più arduo è basarla sulla comunanza di una tragedia. Il progetto stesso di integrazione europea, in effetti, prima ancora che da una volontà di convergenza sopranazionale, è stato mosso dalla constatazione che soltanto neutralizzando i particolarismi si sarebbe spenta la spirale di conflitti che troppo a lungo avevano insanguinato il continente. Le voci di Schuman, Adenauer o De Gasperi si levarono dalle macerie della Seconda guerra mondiale e alcuni atti dall’evidente carica simbolica – che si configurano come “luoghi” della memoria europea – sono privi di valenza costruttiva, essendo piuttosto gesti di pentimento, ammissioni di colpa, tentativi di riparazione. Come l’immagine di François Mitterrand e Helmut Kohl che, mano nella mano, il 23 settembre 1984 rendono omag-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
D. Guzzi - Se questo è un luogo
255
gio all’ossario di Douaumont, oppure le commemorazioni dello sbarco in Normandia. Avendo sinora raggiunto l’obiettivo di assicurare la pace, tali operazioni hanno senza dubbio avuto un’efficacia positiva. Però manca loro una carica propositiva, che possa renderli eventi seminali, svincolati dalla rievocazione del passato e dalla contrizione per gli errori che lo hanno segnato. E, d’altra parte, il “luogo” che attualmente si impone nel modo più ampio alla memoria pubblica europea è il simbolo stesso del male politico contemporaneo: Auschwitz. 3. Auschwitz si presenta come il più internazionale dei deutsche Erinnerungsorte. La voce, redatta da Peter Reichel, si apre con una constatazione di ordine paradossale: «das ist ein eigentümlich ortloser Ort» (François – Schulze 2001: I, 600). Auschwitz, in effetti, è per certi versi un “luogo”, ma per altri potrebbe non sembrarlo; è una sorta di “luogo” senza luogo, o anche di luogo delocalizzato. Sulle carte non compare: la cittadina nei cui pressi venne costruito il Lager è tornata a chiamarsi nel dopoguerra con il nome polacco di Oświęcim. Auschwitz, così, è simbolo insieme del visibile e dell’invisibile: un sito di cui sono rimaste le vestigia, ma che è scomparso dalle mappe e, di fatto, un enorme cimitero, ma senza pietre tombali. È un topos che ha assunto il valore di antonomasia, ma al contempo il nome più concreto per indicare il genocidio degli ebrei d’Europa, perché privo delle connotazioni metafisiche o religiose implicite nei termini Olocausto e Shoah. Geograficamente, è un luogo polacco. Per tre decenni dopo la liberazione del campo, è stato un memoriale e un museo in cui il governo di Varsavia raccontava la «storia delle sofferenze della nazione polacca e delle altre nazioni». La prima aveva un posto di riguardo poiché rappresentava, nell’ottica del socialismo reale, il prezzo pagato nella lotta antifascista. Le altre vi si accostavano narrando, ciascuna in un padiglione, le vicende delle proprie vittime. Dalla fine degli anni Settanta si pose in evidenza il fatto che la maggior parte dei deportati erano ebrei e il campo cominciò a rappresentare un “luogo” della memoria ebraica – di una memoria, dunque, diasporica e transnazionale. Ciononostante, Giovanni Paolo II (2005: 32) cercò di farne un “luogo” dell’identità cattolica in occasione della beatificazione di Massimiliano Kolbe ed Edith Stein. Un gruppo di suore carmelitane tentò persino di edificare un avamposto di quest’impresa di colonizzazione memoriale issando un imponente crocifisso a pochi metri dal recinto di filo spinato (Bartoszewski 1991; Klein 1991). Auschwitz rappresenta anzitutto un ineludibile punto di domanda nella storia della Germania, che interroga il paese sulle ragioni del nazionalso-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
256
Shoah, modernità e male politico
cialismo. Tuttavia, sia i ripetuti tentativi di appropriazione simbolica cui si è accennato, sia l’emblema cupo che oggettivamente rappresenta, gli conferiscono un valore universale. Il simbolo della massima catastrofe politica moderna diventa così un “luogo” dall’estensione potenzialmente globale, perché i crimini che vi sono stati perpetrati riguardano, in ultima istanza, ogni individuo. Il nazismo considerò infatti le proprie vittime nemici “oggettivi”, da perseguitare a prescindere dalle azioni che compissero o dalle idee che esprimessero, segnati da una condanna pregiudiziale: l’appartenenza razziale come assurda e inemendabile colpa di essere nati. Su tali presupposti è maturato il concetto di crimine contro l’umanità e la sorte del deportato razziale è stata indicata come condizione vittimaria assoluta. Per le stesse ragioni, si è cominciato a ritenere la Shoah un evento negativo per antonomasia e Auschwitz il simbolo del male politico novecentesco. Il tentativo di globalizzare la memoria dell’Olocausto si è però esposto a obiezioni e dissensi. Il primo ostacolo è consistito in una critica che si potrebbe definire “postcoloniale”, fondata sulla constatazione che, al di fuori del contesto occidentale, il valore cosmopolitico del ricordo del genocidio rappresenta un elemento problematico. È un dato di fatto che, nonostante gli auspici dell’ONU, in gran parte dell’Asia, dell’Africa o dell’America Latina Auschwitz non è diventato l’unità di misura del male politico. A tal riguardo, è interessante sfogliare i verbali della seduta dell’Assemblea generale che nel 2005 votò la risoluzione sulla Giornata internazionale della memoria. Nessuno degli intervenuti mise in dubbio le proporzioni storiche della Shoah, di cui tutti riconobbero la tragicità. La rappresentante del Venezuela invitò però a non dimenticare che la distruzione di Hiroshima e Nagasaki, o i frequenti episodi di terrorismo di Stato verificatisi nella seconda metà del Novecento contro popolazioni extraeuropee, rappresentano crimini contro l’umanità imputabili alle stesse democrazie liberali che hanno sconfitto il nazismo. Da una prospettiva analoga, il delegato egiziano esortò la comunità internazionale a ricordare, accanto alla Shoah, altre forme di genocidio commesse contro i musulmani o i cristiani, osservando che nessuno detiene il monopolio della sofferenza. Il rappresentante della Malesia si unì a tali sollecitazioni, chiedendo che nella dichiarazione si menzionassero anche altri crimini del XX secolo, come le guerre e le operazioni di pulizia etnica. Il delegato dell’Indonesia osservò infine che l’Olocausto non costituisce la sola catastrofe umana in grado di indirizzare un forte messaggio all’umanità sulle conseguenze dell’odio politico e del pregiudizio. L’obiezione postcoloniale si inserisce peraltro nel solco di una tradizione di pensiero che interpreta la centralità assunta dall’Olocausto nel discor-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
D. Guzzi - Se questo è un luogo
257
so pubblico globale come la conferma dell’autoreferenzialità della cultura occidentale. L’intellettuale martinicano Aimé Césaire ha scritto in tono provocatorio che quel che l’Occidente non perdona a Hitler «non è il crimine come tale, il crimine contro l’uomo; non è l’umiliazione dell’uomo in sé, ma il crimine contro l’uomo bianco, il fatto di aver applicato all’Europa metodi coloniali finora riservati agli arabi d’Algeria, ai coolies dell’India e ai negri d’Africa» (Césaire 1950: 18-9). Una vicenda senza dubbio tragica sarebbe insomma assurta a emblema della radicalità del male per il fatto di essersi consumata in Europa. Al contrario, i massacri perpetrati nel mondo dall’Occidente vengono occultati e dimenticati perché riguardano vittime di paesi extraeuropei, la cui eliminazione non costituisce scandalo. A sostegno di tale tesi, numerosi studi hanno nel frattempo documentato che le strategie di disumanizzazione attuate sotto il Terzo Reich trovano significativi precedenti nella terminologia imperialista. Concetti cruciali della retorica nazista, come il Lebensraum, lo spazio vitale, o l’Untermensch, il “subumano”, rinviano infatti a un lessico coloniale che considerava l’espansione territoriale un legittimo diritto di conquista e il “selvaggio” un essere inferiore (Traverso 2002: 63-96). Si è detto che nell’antisemitismo risulta anzitutto aberrante la discriminazione degli ebrei per ragioni esclusivamente razziali. Ma come non rammentare che alcuni dispositivi “extralegali” applicati nelle colonie – le leggi contro il “madamismo” nel caso italiano, il “codice dell’indigenato” in quello francese – hanno costituito il precedente non solo cronologico dei provvedimenti antisemiti durante la Seconda guerra mondiale? O come rispondere alla questione sollevata da Frantz Fanon, che negli anni Cinquanta si domandava come può un nero, qualora volesse, cambiare il colore della propria pelle per sottrarsi a una condizione di emarginazione sociale? Il dibattito sul valore storico della Shoah non può tuttavia ridursi a un’antitesi tra Occidente e civiltà extraoccidentali. Sia perché, se declinato con sensibilità e rispetto, il paradigma di condizione vittimaria emerso nel processo pocanzi descritto può essere universalmente applicato alla tutela dei diritti umani, al di là delle frontiere territoriali e culturali. Sia perché anche in Europa alcuni ostacoli si sono frapposti alla sua piena affermazione. Prima – e a fianco – della cosmopolitizzazione, vi è dunque la questione dell’“europeizzazione”. La quale si addensa, in sintesi, attorno a due nodi problematici. Di uno si è già trattato, perché riguarda la difficoltà di conferire a un evento fondatore tragico il ruolo di “luogo” della memoria europea. L’altro richiama invece le osservazioni di Tony Judt evocate in apertura. L’allargamento dell’Unione ai paesi orientali, coinciso con il percorso di istituzionalizzazione della memoria della Shoah, ha infatti provocato pole-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
258
Shoah, modernità e male politico
miche e incomprensioni, perché il ricordo del genocidio non suscita ovunque le medesime reazioni. Alcuni Stati non hanno accettato di buon grado il ticket necessario all’integrazione, il “lutto diplomatico” imposto dalla retorica comunitaria (Traverso 2011: 185). In certi casi per ragioni ideologiche – esplicitamente antidemocratiche e filofasciste, o subdolamente anti-antifasciste – come nel caso della Polonia dei gemelli Kaczyński o nell’Ungheria di Viktor Orbán. In altri casi per uno slittamento di memorie storiche descritto con lucidità da Simone Veil, in un discorso pronunciato al Bundestag il 27 gennaio 2004 per l’anniversario della “liberazione” di Auschwitz: La Shoah non è ancora stata opportunamente riconosciuta in un certo numero di paesi dell’Europa orientale […]. Manipolato dai regimi comunisti a lungo al potere, il ricordo delle sofferenze inflitte dall’occupante nazista alle popolazioni ha sfumato il ricordo delle sofferenze inflitte agli ebrei, talvolta con la complicità di quelle stesse popolazioni […]. Per questi popoli, sottomessi per quasi mezzo secolo alla dominazione sovietica, le vittime del comunismo hanno cancellato quelle del nazismo […]. Nel momento in cui l’Europa si allarga a est, di queste derive bisogna allarmarsi, perché tali controversie, in apparenza storiografiche, toccano in profondità l’identità dell’Europa futura1.
Controversie, occorre precisare, non semplici da risolvere, perché attinenti al nucleo profondo della memoria del male e a una gerarchizzazione delle sofferenze patite sotto il nazismo e sotto il regime sovietico. Per un cittadino dell’Europa orientale la conclusione della Seconda guerra mondiale non corrisponde a un momento di vittoria. Segna soltanto un cambio di dittatura: il passaggio da una forma di oppressione a un’altra. Per alcune popolazioni la fine della dominazione nazista è infatti coincisa con l’inizio dell’incubo staliniano e la Liberazione sarebbe arrivata quasi mezzo secolo più tardi, con il crollo dell’Unione Sovietica. Se in Europa occidentale, per esempio, l’immagine del vagone bestiame è il simbolo della deportazione degli ebrei, negli Stati baltici viene di norma associata alle deportazioni di massa in Siberia. Le differenze di prospettiva sono evidenti e se ne possono indicare numerosi casi: a Budapest un museo denominato Casa del terrore commemora i soprusi subiti dall’Ungheria nel corso del Novecento dedicando molto più spazio all’occupazione sovietica che a quella nazista; in Polonia il crimine per antonomasia della dominazione totalitaria è l’uc1
Il testo dell’intervento di Veil è disponibile online in traduzione inglese all’indirizzo: http://www.fondationshoah.org/FMS/DocPdfUS/Discours/Bundenstag2004. pdf.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
D. Guzzi - Se questo è un luogo
259
cisione, nella foresta di Katyn, degli ufficiali dell’esercito fatti prigionieri dai russi; nel 2006 il Parlamento ucraino ha votato una legge che definisce “genocidio” la collettivizzazione delle campagne decisa da Stalin. In quest’ottica, lo sterminio degli ebrei assume spesso un’importanza secondaria, perché altre sono le forme di male politico considerate emblematiche, assolute o radicali. La questione, in fondo, non riguarda la verità storica o il metodo storiografico, bensì una diversa configurazione assiologica. Non deve dunque sorprendere che la sollecitazione a rievocare la Shoah possa essere interpretata come una forma di prepotenza culturale. La ragione sembra risiedere semplicemente nel diritto che ogni popolo ha di anteporre il ricordo delle proprie sofferenze a quello delle pene altrui. Perché, a dispetto delle retoriche della solidarietà globale, non sempre le estensioni geopolitiche corrispondono a proporzionali allargamenti della coscienza collettiva. Nel seguire il processo di costruzione del ricordo non si può dunque ignorare che questo dato di fatto, semplice e fondamentale, vige anche all’interno dello spazio pubblico europeo. E per universalizzare la funzione pedagogica e civile della memoria dell’Olocausto sarà indispensabile svincolarla dalle rivendicazioni segnatamente identitarie e dai riferimenti a un dovere categorico – o a un ticket indispensabile per ottenere una patente ufficiale di umanità – aprendola alla comparazione e alla riflessione critica. Senza mai dimenticare, spostando un’ultima volta l’attenzione dal piano del ricordo a quello della storia, le peculiarità che rendono il genocidio nazista, nelle finalità della violenza che ha scatenato come nelle tecniche della sua attuazione, una forma di male politico di esclusiva intensità.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
261
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
STEFANO RAIMONDI
NONOSTANTE TUTTO, NONOSTANTE IL TUTTO La poesia nel tempo di Auschwitz Wieviel Stuck? – “Quanti pezzi?” Era questo il modo di contarli […] venticinque pezzi ogni lunedì, sì pezzi. Questo è il linguaggio ufficiale per designare le vite umane. (Mengaldo 2007: 27) A casa mi attendeva un compito: fare poesia dopo Auschwitz. (Tedeusz Rosewicz, cit. in Zych 2001: 61)
Premessa Quanto più totale la società, tanto più reificato lo spirito e tanto più paradossale la sua impresa di svincolarsi dalla reificazione con le sue sole forze. Persino la più lucida consapevolezza dell’imminente catastrofe rischia di degenerare in chiacchiera inane. La critica della cultura si trova davanti all’ultimo stadio della dialettica di cultura e barbarie. Scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie e ciò avvelena la consapevolezza stessa del perché è divenuto impossibile oggi scrivere poesia. (Adorno 1955: 22)
Scrivere una poesia dopo Auschwitz, dunque, è realmente un atto di barbarie? Così affermò il filosofo Theodor Adorno in uno scritto del 1949, Critica della cultura e società, uscito in Prismi. Saggi sulla critica della cultura, che poi ripensò e corresse – cercando di riportare la sua “frase” nella mappabilità dell’accettazione filosofica – in Dialettica negativa, correggendone il tiro e scrivendo: «[...] il dolore incessante ha tanto diritto di esprimersi quanto il martirizzato di urlare» (Adorno 1966: 327). Probabilmente, con questa fatidica “frase”, Adorno non intendeva enunciare un giudizio assoluto e definitivo sul futuro della storia e della creazione poetica, ma voleva segnare/tracciare un aspetto che l’attività creativa, dopo “l’evento Auschwitz”, avrebbe dovuto tener presente. Scriverà infatti: «[...] scrivere una poesia dopo Auschwitz avvelena la stessa consapevolezza del perché è diventato impossibile scrivere poesie oggi». Con questa
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
262
Shoah, modernità e male politico
affermazione, è come se Adorno avesse cercato di sottolineare una frattura epocale, oltre la quale ed entro la quale l’uomo doveva riflettere e passare, per restare fedele a se stesso e alla sua tanto bistrattata umana gloria. Non è il tempo a essere qui il nuovo punto di osservazione, quanto il soggettouomo a farsi luogo di una possibile rappresentazione sociale. Un “Io” che diventa prima “Tu” e poi un “Noi”, al quale domandare perdono, al quale chiedere la via per la testimonianza necessaria e infinita del vero. La poesia diventa così luogo e testimonianza insieme, trascrivendo non più il “bello” della vita ma il suo “vero”, e da questa ripartenza filosofica e letteraria il poeta non è più un’individualità segnata dalla vita, ma un suo testimone oculare, fatto d’Altri e reso Altro, per necessità di sopravvivenza e responsabilità. La poesia dunque poteva e può “dire”, ancora, la tragedia incarnata nei campi di sterminio; dirlo d’ora in poi e per sempre, in un modo inestinguibile, da testimone, proprio come ebbe a scrivere Benjamin Fondane, in una delle ultime strofe del poema Ulysse, scritto undici anni prima di scomparire ad Auschwitz: […] je ne peux pas fermer les yeux, je dois crier toujours jusqu’à la fin du monde: «il ne faut pas dormir jusqu’à la fin du monde» - je ne suis qu’un témoin. […] non posso chiudere gli occhi devo urlare sempre fino alla fine del mondo «non si deve dormire fino alla fine del mondo» - io non sono che un testimone. (Fondane 1938)
Il dovere della poesia è in primis quello di testimoniare. Dopo Auschwitz questo dovere si trasformò improvvisamente e kierkegaardianamente in “compito”. Un compito che i poeti hanno assunto come il segno di una verifica dell’esistenza rapportata al proprio tempo e alla propria realtà quotidiana e che, da Paul Celan in poi, si potrà di nuovo nominare, ponendo l’estrema domanda: Chi testimonierà per il testimone? È dalla poesia più famosa di Paul Celan (ormai divenuta una sorta di sua marca scritturale e, paradossalmente, tolta dal poeta stesso dalle scalette delle sue letture pubbliche, negli ultimi anni della sua vita), che vorrei partire, per evidenziare quanto la poesia nei Lager e la poesia sui Lager sia stata e sia un vero modo di restare ad occhi aperti sul tempo sgrammaticato della Shoah.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
S. Raimondi - Nonostante tutto, nonostante il tutto
263
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Fuga di morte Nero latte dell’alba lo beviamo la sera lo beviamo a mezzogiorno e al mattino lo beviamo di notte beviamo e beviamo scaviamo una tomba nell’aria là non si giace stretti Nella casa abita un uomo che gioca con i serpenti che scrive che scrive all’imbrunire in Germania i tuoi capelli d’oro Margarete lo scrive ed esce dinanzi a casa e brillano le stelle e fischia ai suoi mastini fischia ai suoi ebrei fa scavare una tomba nella terra ci comanda ora suonate alla danza Nero latte dell’alba ti beviamo la notte ti beviamo al mattino e a mezzogiorno ti beviamo la sera beviamo e beviamo Nella casa abita un uomo che gioca con i serpenti che scrive che scrive all’imbrunire in Germania i tuoi capelli d’oro Margarete I tuoi capelli di cenere Sulamith scaviamo una tomba nell’aria là non si giace stretti Lui grida vangate più a fondo il terreno e voi e voi cantate e suonate impugna il ferro alla cintura lo brandisce i suoi occhi sono azzurri spingete più a fondo le vanghe voi e voi continuate a suonare alla danza Nero latte dell’alba ti beviamo la notte ti beviamo a mezzogiorno e al mattino ti beviamo la sera beviamo e beviamo nella casa abita un uomo i tuoi capelli d’oro Margarete i tuoi capelli di cenere Sulamith lui gioca con i serpenti Lui grida suonate più dolce la morte la morte è un maestro tedesco lui grida suonate più cupo i violini e salirete come fumo nell’aria e avrete una tomba nelle nubi là non si giace stretti Nero latte dell’alba ti beviamo la notte ti beviamo a mezzogiorno la morte è un maestro tedesco ti beviamo la sera e la mattina e beviamo e beviamo la morte è un maestro tedesco il suo occhio è azzurro ti colpisce con palla di piombo ti colpisce preciso nella casa abita un uomo i tuoi capelli d’oro Margarete aizza i suoi mastini contro di noi ci regala una tomba nell’aria gioca con i serpenti e sogna la morte è un maestro tedesco i tuoi capelli d’oro Margarete i tuoi capelli di cenere Sulamith. (Celan 1948: 61)
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
264
Shoah, modernità e male politico
1. Molti autori, e tra questi molti poeti, hanno portato all’estremo il loro “nonostante tutto!”. L’hanno fatto dopo aver subito e vissuto l’esperienza terrificante della Shoah, trovandosi, inesorabilmente, di fronte ad una grammatica del disumano, mai pensata prima, mai immaginata fino ad allora con tanta precisione e solerzia1. Sono voci che hanno lasciato gravitare, attorno alla loro “insistenza” etica, una parola poetica sommersa e salvata da una memoria capace di non essere più portatrice di un estetizzante ed egolatrico io – in grado solo di traslocare il dolore da una natura domata e proiettata come mero sfondo sentimentale, ad una parola strappata al proprio sopravvivere – ma marca/ marchio evidente di un vero e proprio affondo in una tragedia chiamata, inesorabilmente, Auschwitz. La poesia è dialogica: essa si riferisce quasi sempre a un “Tu” che sta in attesa di essere interpellato, coinvolto, messo in udienza. È un genere che ha bisogno di un “interlocutore”, come scrive Osip Mandel’štam nel suo celebre scritto: Quando parliamo, noi cerchiamo nel viso dell’interlocutore una sanzione, una conferma della nostra ragione; ancor più il poeta, [perché] “Il poeta è legato solo all’interlocutore che gli fornisce la provvidenza”. (Mandel’štam 1930: 60)
Questo “Tu” dialogico e provvidenziale segna la presenza dell’Altro nell’ascolto, nella prossimità della rilevanza dell’essere persona. Da qui inizia l’intesa della comprensione della parola, del verso, del testo lasciato andare nel circondario dell’esistenza, diventando “colloquio tuttavia”, capace di ricordare il prima e poi del reale e della disperazione. Il poeta 1
Cfr. Zampieri 1996: 41: «Bisogna vedere il Lager come un estremo, non come una eccezione. La realtà che in esso si è prodotta è un effetto di coerenza radicale della società nazista la quale, a sua volta, non fu un semplice errore nella storia, non fu la follia collettiva di milioni di uomini, ma un frutto sempre possibile (magari sotto altra veste) della società occidentale. Nel Lager si è tentato un esperimento, la produzione dell’uomo artificiale, l’uomo obbediente, l’uomo ridotto a numero, l’uomo macchina destinato al lavoro, quale che sia, anche il più improduttivo, il lavoro come dimensione semplicemente simbolica, privato della sua naturale capacità di produrre il necessario, di riprodurre l’uomo stesso, il lavoro come semplice esercizio di morte. Ma la condizione prima perché un simile esperimento potesse riuscire era proprio la condizione dell’isolamento individuale: che l’uomo fosse tagliato fuori da ogni relazione con gli altri uomini, che abdicasse alla sua naturale condizione di essere-con-altri, perché solo così l’uomo diviene soggetto, nel senso passivo di carne morta, di atomo ubbidiente nel grande organismo della società».
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Raimondi - Nonostante tutto, nonostante il tutto
265
si rivolge sempre a un “Tu” quasi a scongiurare la solitudine, l’isolamento che la parola stessa rimanda dal suo bianco che la circonda. Egli deve ancora “cantare” per farsi udire e in questo estremo tentativo di sopravvivenza la poesia si fa grido di paura e di denuncia. Emblematico è il testo del poeta Yitzhak Katzenelson, Il canto del popolo ebreo massacrato, e il suo ritrovamento. Un testo terminato poco prima di morire ad Auschwitz e sotterrato a Vittel, il 17 gennaio del 1944, in bottiglie sigillate, «là dove si esce, vicino al sesto palo che aveva una sporgenza a mezz’asta, sotto le radici intrecciate del vecchio albero»: IV. I vagoni sono tornati! 1 Orrore e paura mi assalgono, mi soffocano – i vagoni sono già di ritorno! Sono partiti solo ieri sera – e oggi sono qui di nuovo, già pronti all’Umschlag Li vedi, là con le fauci aperte, spalancate nell’orrore? 2 Hanno ancora fame! Niente li sazia. Aspettano gli ebrei! Quando glieli porteranno? Sono affamati – come se non avessero già divorato i loro ebrei… Ne hanno avuti tanti! Ma ne vogliono di più, ancora di più! 3 Ne vogliono ancora di più. Sono là in attesa che sia servito loro il pasto, che arrivino gli ebrei in grandi quantità! Avanti, vecchio popolo dai giovanissimi germogli, uva fresca di una vecchia vite, vecchi ebrei forti come il vino. 4 Ne vogliamo di più, molti di più… gridano i vagoni come freddi e spietati criminali: di più! Non ne hanno mai abbastanza! Stanno aspettando all’Umschlag. Aspettano noi i vagoni, aspetta noi il treno. […] 14 E ora? Ora siete vagoni, e state a guardare, testimoni muti di un tale carico, di una tale pena. In silenzio tutto avete osservato. Oh, ditemi, vagoni, dove andate, dove avete portato a morire il popolo ebraico?
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
266
Shoah, modernità e male politico
15 Non è colpa vostra – vi caricano e poi vi dicono: andate! Vi fanno partire pieni e tornare vuoti. Voi che tornate dall’altro mondo, ditemi una parola. Vi prego, ruote, parlate, ed io, io piangerò… (Katzenelson 1963: 43)
Ma sono le parole di Paul Celan a fare qui da segnavia in questi pensieri, tra queste parole, quasi fossero loro a dettare un passaggio obbligato nella comprensione dei fatti: Il poema – tra quali condizionamenti! – diventa l’opera di qualcuno che tuttavia continua a usare i sensi, rivolto a tutto quanto appare, integrandolo, apostrofandolo; diventa colloquio – spesso un colloquio disperato. È solo entro lo spazio di questo colloquio che si costituisce l’entità interlocutoria, la quale si aduna attorno all’io che l’appella e la nomina. Ma in questa presenza, l’entità interloquita e nominata, fin quasi a diventare un tu, introduce il suo essere altro. Ancora nell’hic et nunc del poema […] ancora in questa immediatezza e contiguità il poema consente che abbia voce quanto, all’Altro, è più proprio: ossia il suo tempo. (Celan 1961: 16-7)
È questa la forza della poesia: l’alterità e la sua capacità di creare spazio all’Altro e per l’Altro. Ora, in un caso estremo come quello della Shoah, la poesia assume altre funzioni, si concreziona per altre necessità e obiettivi: la sopravvivenza e la testimonianza. Sono i poeti come – solo per nominarne alcuni – Primo Levi, Paul Celan, Nelly Sachs, Rose Ausländer, Edmond Jabés, Benjamin Fondane, Jorge Semprún, Yitzhak Katzenelson, Gertrud Kolmar, Uri Orlev, Jean Cayrol a diventare portatori di una parola capace di essere ancora viva, ancora testimoniale, come segno di un rifiuto e di un giudizio irrefutabile delle barbarie del nazismo. Qui il “Tu” dialogante impersonato/impressionato da poeti del “nonostante Auschwitz” – cioè di coloro che hanno scelto la poesia come arma di rivendicazione di una possibilità concessa dalla sopravvivenza – si è trasformato in un “Tu” che non è più solo un pronome, ma piuttosto una valenza aperta da una molteplicità di voci e di trascendenze. Molteplicità dove il loro “Tu” non è solo un referente unico, ma un “Voi” aperto a chi sa porsi in relazione con coloro che diventeranno ricettori di narrazioni e di storie. La loro poesia è un “Tu/Voi” con il quale dialogare/dire; un “Tu/ Voi” inteso per essere recepito come un luogo/sponda/argine nel quale depositare le vedute e le denunce di un essere lì per forza, di un essere coinvolti, quali portatori di vite poste nell’annientamento.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Raimondi - Nonostante tutto, nonostante il tutto
267
Dopo Auschwitz la poesia non ha più un carattere specificatamente catartico, ma rivelatore di una “fragilità” imposta da una crudeltà inumana e ingestibile. Un esempio fra i molti è il “Tu” celaniano. Esso è un “Tu” di ri-conoscenza (conoscere due volte) appartenente a un prima e un poi distanziati dalla terribilità della Shoah. Per quanto riguarda la trascendenza è da chiarire che il termine non si riferisce ad un’entità sovrannaturale o divina, ma piuttosto ad una presenza costretta dall’orrore a trascendere se stessa nel reale, assumendo una sembianza plurivoca e capace di accogliere l’estraneo cambiamento dell’essere estirpato dalla propria condizione di “persona”. Una trascendenza che porta all’Altro, da non intendere come rappresentazione di un essere divino, ma come la collimazione/somiglianza ad un sé coscienziale, legato all’elemento identitario più che a quello fideistico/messianico. Come scriveva Emmanuel Lévinas nel suo saggio dedicato a Celan: «È come se, nell’andare verso l’altro, io potessi ricongiungermi con me stesso e impiantarmi in una terra, ormai natale, affrancata da tutto il peso della mia identità» (Lévinas 1976a: 52). Sia la molteplicità che la trascendenza sono condizioni che qui espongono la parola poetica ad un’apertura di e del senso, rendendola una parola speciale non per bellezza, ma per verità. Il linguaggio poetico cambia rotta, diventa traccia e tracciato di un’evidenza del vero, proprio come ebbe a scrivere Celan, in una risposta data per un questionario della libreria Flinker, di Parigi, nel 1958: Il linguaggio (della poesia) si è fatto più sobrio, più attento ai fatti, essa diffida del “bello”, essa tenta di essere vera. […] Pur nella totale, irrinunciabile poliedricità dell’espressione, ciò che preme a questo linguaggio è di essere preciso. Esso non trasfigura, non “poetizza”, esso nomina e instaura, cerca di delimitare il campo del possibile e del dato. Beninteso: all’opera qui non è mai la lingua stessa, la lingua in sé e per sé; bensì sempre e soltanto un io che parla dal particolare angolo d’incidenza della propria vita e che ricerca una delimitazione, un orientamento. (Celan 1958: 37-8)
La poesia diventa qui ancora più particolare, in quanto scelta e trascelta dal linguaggio della vita e della morte, quello che dopo Auschwitz è barattato con l’orrore del silenzio e della paura e che, paradossalmente, è colmo della speranza per l’Altro – che sia l’Altro da me oppure l’Altro me. Inoltre sarà una parola non più semplicemente pronunciata/scritta, ma pro-ferita/ tra-scritta, in quanto nata e data da una taglio/cesura, che rivelerà un’apertura, un’esposizione: una possibilità.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
268
Shoah, modernità e male politico
È dunque su questo “Tu” dialogico – perché dialogante – che la poesia dopo Auschwitz innesta la sua sopravvivenza al e nel mondo, lasciando ad Adorno la sua frase spartiacque. Nella parola poetica è lo statu nascendi dal quale deriva ad interessare i poeti; è il luogo originario/adamitico della loro lingua espressiva e di comunicazione ad essere per loro decisiva, adottata e cercata unicamente qui, per riportare all’unità una parola spezzata, interrotta, defraudata. È dunque l’elemento dialogico a fare di questo dire una poesia in grado di oltrepassare se stessa, sia come genere letterario, che come condizione esistenziale. Scrivere poesia da Auschwitz in poi è interrompere, per forza, la predominanza di un “Io” disossato e portato all’annullamento, nel tentativo di riattuarne un altro, capace di essere portatore di una verità testimoniale, colma di speranza, proprio come sostiene Lévinas: [...] significa interrompere la mia esistenza di soggetto e di padrone […]. Il soggetto che parla non situa il mondo in rapporto a se stesso […] ma in rapporto all’Altro. Questo privilegio dell’Altro smette di essere incomprensibile non appena ammettiamo che il fatto primario dell’esistenza non è l’in sé, né il per sé, ma per l’altro […]. Grazie alla parola proferita, il soggetto che si pone si espone. (Lévinas 1987: 52)
Ma ad Auschwitz l’Altro non è più un privilegio, ma un’occasione di sopravvivenza, tanto da diventare stato e condizione di uno scambio ossessivo di esistenza risparmiata alla morte. Qui la poesia diventa essenziale e necessaria proprio per tentare di riconnettere la vita al suo quotidiano, per reimpostare la temporalità del prima e del poi su l’adesso, che viene perpetuamente disconnesso e annientato dalla furia del disumano, posto alla più ravvicinata prossimità. 2. Esiste una poesia dei Lager e una poesia scritta sui Lager e questa differenza è sostanziale per capire quanto essa sia stata necessaria ai poeti, e non solo, per riappropriarsi della propria dimensione – anzitutto – umana e poi emotiva/creativa. La prima redatta durante la segregazione, da poeti e scrittori anche d’occasione; la seconda scritta negli anni successivi del dopoguerra, da poeti che hanno trovato, nel genere “poesia”, una forma letteraria consona e necessaria alla loro sopravvivenza e memoria. Nei Lager c’erano i cosiddetti “cantastorie”, come li ebbe a definire Primo Levi, che deambulavano da baracca in baracca, a recitare versi di testi ricordati a pezzi, o inventando poesie estemporanee, che sapessero come rendere evidente una condizione vissuta ed esperita da ognuno, nella pro-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
S. Raimondi - Nonostante tutto, nonostante il tutto
269
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
pria condivisione con il peggio. Uomini deputati a testimoniare dall’inferno di una sensibilità modulata sulle parole e sulla loro ritmicità interiore. Il Cantastorie del ghetto di Varsavia Avevo padre e madre e tre graziose sorelline sono scomparsi nel fumo e nelle fiamme e io sono rimasto solo al mondo. Suono l’organetto oggi suono per voi con coraggio perché domani potrei essere a Treblinka e di noi resterà solo un cumulo di cenere. La fame è un tormento la strada è lastricata di morti oh ebrei, figli della misericordia vogliamo vivere ancora un giorno. Il vento trasporta la mia voce dall’alba a notte tarda possa il ghetto annegare nelle nostre maledizioni e con lui i suoi infami costruttori. Ci danno la caccia come le bestie la vita è come un abisso. I corpi sono banderuole di scheletri il sole che continua a splendere vada all’inferno. Dai cuori scaturisce il fuoco basta col massacro di innocenti oh! ebrei, impugnate le spade e venite, facciamola finita! Suona l’organetto per alleviare le nostre pene e disgrazie perché piuttosto che andare a Treblinka è meglio cadere in battaglia. (Lifshutz 1943)
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
270
Shoah, modernità e male politico
I canti che i cantastorie come Lifshutz componevano venivano recitati a memoria dai prigionieri, quasi per riappropriarsi di un mondo “fuori”, portato “dentro” alle stesse condizioni e con le stesse parole di resistenza e dignità. Recitavano per se stessi e per gli altri, donando – o estorcendo alla morte – brandelli di rigore umano, dove la dignità poco sopita di una mente pensante poteva ancora dare segno di evidenza e coraggio. Dalla porticina posteriore, di nascosto e guardandosi attorno con cautela, è entrato il cantastorie. Si è seduto sulla cuccetta di Wachsmann, e subito gli si è raccolta attorno una piccola folla attenta e silenziosa. Lui canta una interminabile rapsodia yiddisch, sempre la stessa, in quartine ritmate, di una malinconia rassegnata e penetrante […]; dev’essere una canzone da lui stesso composta, dove ha racchiuso tutta la vita del Lager, nei più minuti particolari. Qualcuno è generoso e remunera il cantastorie con un pizzico di tabacco o una gugliata di filo; altri ascoltano assorti ma non danno nulla. (Levi 1947: 52)
Sono poesie nate per riappropriarsi del proprio tempo smembrato, parcellizzato dalla disfonia del terrore, composte anche per barattare vita con vita. Qui all’auditore/interlocutore/Altro, almeno per un attimo, pareva di vivere nuovamente con quella parte di sé accantonata, costretta ad essere dimenticata. Grazie alla loro melodia e ritmicità queste parole avevano il potere, per chi rimaneva in ascolto, di alleviare in parte le proprie sofferenze psichiche, proprio come scriverà Adam A. Zych, nella prefazione al suo volume di cinquecento liriche nate nel campo di sterminio: Queste poesie sono in prevalenza frutto di un impulso interiore, scaturito dalla necessità di comunicare e fissare nella memoria – in forma poetica – emozioni e sentimenti vissuti […]. Le opere letterarie nate nei carceri e nei campi di sterminio nazisti nascono come segno di ribellione contro la schiavitù, a testimonianza del fatto che persino nelle condizioni più estreme lo spirito umano non si lascia assoggettare e si leva contro la violenza, l’odio e il male […]. È grazie all’attività artistica se “l’uomo del Lager” divenne “homo creator”. (Zych 2001: 9)
La poesia nei Lager era l’arte più apparentemente semplice, più a portata di mano. Bastavano dei brandelli di carta e un lapis per lasciare tracce irrefutabili di sé e della propria esistenza respirata piano. Essi erano anche facili da nascondere o distruggere, in caso di perquisizioni. La poesia non richiedeva altro materiale se non la vita, e il supporto era minimale e concentrato. Inoltre le poesie avevano anche la funzione di attivare una memoria, altrimenti disintegrata dallo spossamento delle forze fisiche. Imparare a memoria dei versi era una sorta di ginnastica mentale – oltre che spirituale
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
S. Raimondi - Nonostante tutto, nonostante il tutto
271
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
– per coloro che sapevano come farsene portatori e custodi. Ruth Klüger lo dice nel suo Vivere ancora: Bisogna mettere le parole consunte sul piatto della bilancia come fossero nuove, perché tali erano per me bambina, e poi capire l’astuzia che mi indusse a comprimere in un verso il trauma delle settimane ad Auschwitz. Sono poesie infantili, che con la loro regolarità volevano creare un contrappeso al caos; sono un tentativo poetico e terapeutico di opporre a quella baraonda insensata e distruttiva, nella quale stavamo morendo, una totalità linguistica, rimata: sono, in realtà, la finalità estetica più antica. Per questo le mie poesie dovevano avere diverse strofe, in segno di controllo, della facoltà di articolare e di oggettivare. (Klüger 1992: 128)
Questi testi nati dalle fondamenta della barbarie nazista non erano parole fruite solo da intellettuali o addetti ai lavori, ma condivise da tutti, anche da coloro ai quali, prima di allora, la poesia era stata preclusa. La poesia era uno scambiarsi qualcosa, un barattare il proprio sé con il sé di qualcuno d’Altro, nella convinzione che in quello spazio, fatto da poche parole, potesse dimorarvi ancora un briciolo di umanità e fedeltà alla vita. Esse erano una possibilità di ritorno alla propria intimità: una sorta di rimpatrio. Da qui si poteva di nuovo essere riconosciuti dal proprio nome, essere chiamati ancora per nome. È proprio questo atto del nominare cose e del nominarsi vivi tra esse ad essere la materia della poesia. Una materia che s’incarna nella parola e nel linguaggio, appunto, maternale, proprio come ha scritto Fabrizio Desideri: Ma qual è la materia cui la poesia dà forma? Non certo il sentimento nella sua mitica immediatezza. Piuttosto il linguaggio che articola il sentire. Non, però, il linguaggio originario, ma la propria lingua in cui dico Io e pronuncio il mio nome, la lingua che parla, la lingua che potremmo dire materna. (Desideri 2008: 69)
Una lingua dunque che si fa audace per ricordo e intima per memoria. Una memoria che non è rammemorazione e che in poesia diventava il ritmo sul quale innestare il proprio faticare, la propria postura: la propria stremata resilienza. Essa si trasformava in uno strumento di volontà e di scelta. Caratteristiche queste che, purtroppo, andavano giorno per giorno nella censura di una dimenticanza coatta di sé. La poesia nel Lager aveva anche il compito di portare distrazione, una sorta di magica e ancestrale astrazione dal contesto che, di poetico, non aveva ormai più nulla da sottolineare né da porre in evidenza. Ogni luogo del campo era esposto e la promiscuità era dovunque. Non era possibile
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
272
Shoah, modernità e male politico
restare soli con sé stessi; erano costretti a viversi nonostante tutto e nonostante il tutto, perpetuamente attenti alla propria fine, al proprio immiserimento, alla propria follia. Il recitare o scrivere versi, dunque, significava farsi una “stanza tutta per sé”, nella quale stare e restare ancora una volta e per sempre. Ogni atto, anche il più personale (dal defecare agli atti sessuali), era fatto di fronte agli altri. Da un punto di vista strutturale, poi, la poesia rappresentava ancora una forma vivibile di ordine e rigore. La scansione sillabica dei versi e l’ordine delle strofe impegnava il “cantastorie” o il poeta a ristabilire dentro di sé una partitura da eseguire. È ancora Ruth Klüger a darcene testimonianza: Non racconto nulla di straordinario quando dico che, ovunque fossi, nei campi recitavo e componevo poesie. Molti abitanti dei campi di concentramento trovavano conforto nei versi che sapevano a memoria. Chissà in cosa consiste il conforto in un simile recitare. Di solito vengono menzionate poesie che avevano rivestito un particolare valore emozionale nell’infanzia del prigioniero. A me sembra invece che il contenuto dei versi avesse importanza solo secondaria, e che in primo luogo fosse la forma, la lingua poetica a costruirne un sostegno. Ma anche questa semplice interpretazione, forse, è troppo sofisticata e si dovrebbe constatare innanzitutto che i versi, poiché suddividono il tempo, sono in senso letterale un “passatempo”. Quando il tempo è dolore, non si può far nulla di meglio che farlo passare e ogni poesia diventa una formula magica. […] Le ballate di Schiller divennero le mie poesie dell’appello; grazie a loro riuscivo a stare al sole per ore senza svenire, perché c’era sempre un altro verso da recitare e quando un verso non ti veniva in mente, potevi pensarci, anziché pensare alla tua debolezza. (Klüger 1992: 118-19)
3. Se dunque, come abbiamo potuto intendere, la poesia scritta nel Lager era segnata/governata direttamente dal vissuto, esperito e trascritto senza troppe mediazioni o strutture intellettuali e culturali, avendo essa il compito, principale, di allenare l’animo – sia dello scrivente che del ricevente – alla resistenza della disperazione, la poesia scritta negli anni seguenti sarà totalmente differente. Essa è un portare in udienza il tempo della Shoah, usando la lingua stessa degli sterminatori – come ebbe a dire Paul Celan. È quindi una poesia nata da un’esigenza testimoniale, fondata sulla volontà di “non dimenticare”. Questi testi, che costituirono inizialmente gran parte della letteratura sull’Olocausto2, ebbero una grande divulgazione in Germania e nel resto 2
Solo per indicare una cifra si deve citare il lavoro compiuto da una ricercatrice berlinese, Costanze Jaisser (2000), che ha curato una raccolta comprendente più
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Raimondi - Nonostante tutto, nonostante il tutto
273
dell’Europa, ma con il proseguire del tempo – dagli anni Sessanta in poi – la poesia fu sostituita dalla memorialistica, da resoconti documentaristici e da scritti dove l’elemento autobiografico era predominante. La pubblicazione di raccolte di poesie sull’esperienza concentrazionaria, subito dopo la guerra e soprattutto fino alla fondazione delle due repubbliche tedesche, ebbe scarsa risonanza, mentre raggiunsero una più vasta schiera di lettori i singoli testi pubblicati sui quotidiani dell’epoca. Ma ciò che muta nell’analisi critica ed estetica delle liriche scritte dopo la liberazione è da imputare alla certezza che qui, a guidare la scrittura, fosse un’intenzionalità linguistica completamente diversa. La poesia nata in questi anni e riguardante l’esperienza dei campi è maturata proprio sull’idea e sulla necessità di rendere evidente, anche linguisticamente, la “frattura di civiltà” e le varie interpretazioni dell’arte contemporanea di fronte alla Shoah. Infatti, a proposito della frase adorniana, Sibylle Rothegel nel suo Chi ha subito la tortura non può più sentire suo il mondo scrive: Quella frase non voleva suonare come un divieto, bensì esprimere quella frattura nella civilizzazione che – nella riflessione su vita e morte dopo Auschwitz – rende ormai impossibile parlare a priori di sentimenti quali speranza, gioia, nostalgia. (cit. in Cavaglion 2007: 47)
La poesia del dopo Auschwitz ha avuto a che fare direttamente sia con la lingua di partenza di ogni individuo/poeta, sia con la lingua di chi impartiva morte, creando in tedesco un mondo infernale, nel quale stare e al quale ubbidire. Questo inospitale rapporto tra la lingua delle vittime e quella dei carnefici nasce da una sorta di nemesi. Ora è la vittima a riappropriarsi del proprio linguaggio originario, concedendosi quell’unica possibilità per chiunque di sentirsi capito nella propria linguamadre. Una lingua, dunque, che dopo Auschwitz e la deportazione in tutta Europa non era più una “patria” e non costituiva più un rimpatrio, ma piuttosto un terribile territorio di permanenza di fronte alla morte e di soggiorno coatto nel dolore, di fronte al suo progressivo ammutolire. Bisogna dunque farsi carico del problema della lingua anzitutto per poter comprendere come la parola, in poesia, sia la sua evidenza prima e portatrice diretta di significanza. Theodor W. Adorno, con Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, riuscì a sommuovere il pensiero filosofico e letterario a proposito di un genere che solitamente era considerato portatore di un’arte del di 1200 poesie nate solo nel campo di Ravensbrück.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
274
Shoah, modernità e male politico
bello, colma di struggimenti e vibrazioni romantiche della vita; e, probabilmente, fu proprio questa “distorsione” a ispirare il pensiero adorniano. Alla poesia, infatti, non fu mai dedicata tanta attenzione speculativa e critica come da allora. Molte furono le soluzioni e le risposte tentate/lanciate da poeti, filosofi e dagli artisti in generale, ma a chiarire palesemente l’equivoco furono le rimostranze di coloro che vissero l’esperienza della Shoah e vollero rendere/ridare quell’esperienza in versi. Primo Levi fu categorico quando in un’intervista rilasciata a Giancarlo Borri disse: «A dispetto di Adorno, non solo si possono ancora fare poesie dopo Auschwitz, ma su Auschwitz stesso si possono, e forse si debbono, fare poesie» (Borri 1992: 72). Questa chiarezza e volontà di riappropriazione del proprio ambito morale dell’arte, Primo Levi l’ha fatta diventare marca e calco di un suo dettato scritturale, capace di trasformarsi in un luogo rappresentativo per tutti coloro che hanno condiviso le sue sorti. Un punto di vista che non solo ha saputo ricucire, nel tempo e almeno a livello storico, la frattura di civiltà che Auschwitz ha imposto alla Storia, ma è riuscito a creare un ponte tra i sommersi e i salvati di entrambe le sponde. Molte furono le reazioni filosofiche e letterarie a questo tentativo del grande filosofo francofortese di produrre un pensiero “Altro” dopo Auschwitz, ma i poeti reagirono direttamente esponendosi dalla loro linguamadre (che spesso era il tedesco), imponendo il proprio linguaggio espressivo a loro difesa. Ad Adorno furono indirizzate poesie come questa, scritta da Hans Sahl, intitolata imperiosamente Promemoria: Un uomo, che taluni reputano saggio, ha spiegato che, dopo Auschwitz, non è più possibile fare poesia. Il saggio pare non possedere un’alta opinione delle poesie, quasi si trattasse di consolazioni per l’anima di sensibili librai o vetri a tondi dipinti attraverso i quali guardare il mondo. Noi crediamo che soprattutto ora sia possibile scrivere poesie, poiché in versi è possibile direttamente ciò che altrimenti si sottrae ad ogni descrizione. (cit. in Cavaglion 2007: 64)
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Raimondi - Nonostante tutto, nonostante il tutto
275
Molti poeti tra i sopravvissuti contestarono la posizione di Adorno, rivendicando alla parola poetica la necessità del dire e ai poeti la necessità di fare poesia. Ruth Klüger scriverà a tale proposito: Ho un bel dire come tutti gli altri, Adorno innanzitutto, intendo gli esperti in fatto di etica, di letteratura e di realtà, che chiedono che non si scrivano più poesie su Auschwitz, di Auschwitz e dopo Auschwitz. L’invito deve venire per forza da persone che possono fare a meno della lingua in versi, perché non ne hanno mai avuto bisogno, non l’hanno mai usata per mantenersi spiritualmente a galla. Invece di scrivere poesie ci si informi, è l’esortazione, si leggano e si studino documenti; e lo si faccia controllando i propri sentimenti, siano pure di sgomento e di dolore. E cosa debbono pensare i lettori o gli osservatori di tali documenti? Le poesie sono un preciso genere di critica alla vita, e potrebbero aiutarli a capire. Perché non dovrebbero poterlo fare? E, comunque, cosa sono questo Dovere, questo Potere? Principi religiosi, morali? A quali interessi servono? Chi interviene qui? (Klüger 1992: 127)
La poesia, oltre ad essere un “genere di critica alla vita”, realizza dei veri e propri luoghi progettuali, dove far decantare il proprio vissuto – qualunque esso sia – e la propria esistenza – qualunque essa sia –, modellata dalla necessità prima di un silenzio che sa come raggrumare in sé tutte le voci possibili di autenticità e verità. «Le poesie sono progetti esistenziali: il poeta vi modella la sua vita» (Celan 1958: 56). La poesia dunque, attraverso la sua partitura espressiva, mediante le sue regole governate e decise dalla lingua che la sostiene, è stata capace – anche in questo grado zero della parola e non solo della scrittura – di porsi di fronte al limite umano e, addirittura, ai propri limiti, gestendo il suo spazio d’inveramento proprio là dove le veniva impedito l’accesso. Hölderlin ha saputo descrivere questo limite, lasciando poesie calate da una torre colma di follia e d’esclusione, facendosi portavoce, ante litteram, di una condizione che nel tempo si sarebbe trasformata in situazione eseguita, in realizzazione di morte. Al limite estremo del dolore infatti non sussiste nient’altro che le condizioni del tempo e dello spazio. Qui l’uomo dimentica se stesso, poiché è totalmente nel momento; Dio perché non è nient’altro che tempo; ed entrambi sono infedeli, il tempo perché in tale momento si ribalta categoricamente facendo sì che inizio e fine non trovino condizione in alcun modo; l’uomo perché in questo momento deve seguire il ribaltamento categorico non potendo più in ciò che segue uguagliarsi a ciò che era all’inizio. (Hölderlin 1804: 101)
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
276
Shoah, modernità e male politico
La determinazione linguistica della parola poetica sembra dare così, ai suoi poeti, il materiale e la materia per ricostruire quello scarto di irreparabile disuguaglianza tra un ancora e un non ancora, facendo sì che i versi estorti alla morte e alla sua oscurità si potessero generare da queste situazioni/categorie, trovando nella morte la rappresentazione, oramai non ultima, della fine e nell’oscurità una protezione da quella che Celan definì una variopinta chiacchiera comune, e Adorno una chiacchiera inane. Sarà questa una parola che diventerà una “parola contro”: una vera e propria antiparola. Una parola dunque spezzata, recuperata e riproposta dai poeti per testimoniare la Shoah e tutto ciò che ne è conseguito. Scrivere poesie su questa frattura è stato come operare una sutura e un azzardo; una ripartizione epocale del senso dell’umano, dove è proprio nel fondo di un mistero insondabile e incomprensibile che la parola poetica concede nuovamente all’individuo lo spazio per deambulare alla ricerca della propria via, della propria svolta, facendosi portatrice di un’attesa che rende irrefutabile ogni gesto di superficialità e non degno ogni incontro con una parola gettata nella menzognera esistenza. È ancora una poesia di Paul Celan a riportare concretezza al pensiero. Una poesia appartenente al ciclo di ventun testi, intitolato Atemkristall (Cristallo di fiato) e inserito nella raccolta più ampia – Atemwende (Svolta di respiro) – uscita presso Suhrkamp nel 1967 e qui riproposta nella traduzione di Franco Camera: […] Spazzata via dal vento raggiante del tuo linguaggio, la variopinta chiacchiera dell’esperienza ammucchiata – la poesia dalle cento lingue, menzognera, il niente di poesia. Sgombrato dal moto vorticoso, libero è il sentiero nella neve dalla forma umana, la neve penitente, verso le tavole del ghiacciaio, verso le stanze ospitali.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
S. Raimondi - Nonostante tutto, nonostante il tutto
277
Al fondo del crepaccio dei tempi nel favo del ghiaccio attende, cristallo di fiato, la tua non intaccabile testimonianza. (cit. in Gadamer 1986: 77-8)
Ma è sulla lingua e sul linguaggio che la reale svolta si attua e si attualizza; che la “rottura della civiltà” si fa evidente per oscurità e rivelazione e, proprio a questa “ferita”, la poesia guarda e agisce come una “sutura”, come il “resto” che è venuto a mancare, in un tempo anti-umano che ci si accanisce contro, proprio come scrive ancora Celan, in una lettera mai spedita all’amico poeta René Char: Il tempo si accanisce contro coloro che osano essere umani – è il tempo dell’anti-umano. Viventi, noi siamo morti, anche noi. Non c’è un cielo di Provenza: c’è la terra, aperta e senza ospitalità; non c’è che quella. Niente consolazione, niente parole. Il pensiero è un affare di denti. (cit. in Fimiani 2008: 89)
Dal tempo della Shoah in poi, nella lingua della poesia il poeta parla in prima persona, parlando per conto d’Altri, esponendosi da versi/parole/ tracce che non sono più dedicati alla natura, ma diretti a un ascolto umano-più-che-umano, capaci di essere portatori di un luogo u-topico, dove redimere l’impossibile e l’incredibile, come anche un tutt’altro che possa diventare possibile e reale: una speranza. Nel suo celebre discorso Il Meridiano, Celan scrive: Il poema parla, vivaddio! Esso non smarrisce il senso delle proprie date, eppure – parla. Certo esso parla, sempre e soltanto, rigorosamente in prima persona. […] Io ritengo che da sempre tra le speranze del poema vi sia quella di parlare in tal modo anche per conto di estranei – no, questa parola ormai non posso più usarla – di parlare, precisamente in tal modo, di parlare per conto di un Altro – chissà di tutt’altro. (Celan 1961: 14)
Saranno poesie in grado dunque di essere un’evidenza irrisolta – ma non per questo inconoscibile – della rottura epocale della civiltà, dove il linguaggio è la codificazione di codici giunti ad un traguardo terminale, in cui l’irriconoscibilità emotiva diventa ritmo di fondo di una riflessione posta al suo limite estremo. Il fallimento dell’inumano qui è detto per contrappasso,
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
278
Shoah, modernità e male politico
posto com’è, dalla forza implosiva della poesia, sopra un meridiano che non ha più un luogo preciso, individuabile come riferimento. È un laggiù che accade in continuazione per chi ha avuto esperienza e per chi è ebreo, mentre è una data per chi non l’ha patito, ma pensato: riflettuto. Qui la differenza è l’appartenenza, proprio come dice in una intervista lo scrittore David Grossman: Ho notato che quando gli ebrei parlano della Shoah dicono “quello che è successo laggiù”, in qualsiasi lingua si esprimano. Quando a parlare dell’Olocausto sono i non ebrei, essi dicono “quello che è successo allora, in quei giorni”. Penso che la differenza sia importante e significativa perché per noi, stranamente, è come se quel periodo e quel luogo esistessero ancora, “laggiù”, in modo simultaneo e parallelo rispetto alla nostra realtà odierna e quotidiana. (Grossman 2000: 19-20)
Un laggiù che per molti autori è diventato una necessità umana e scritturale alla quale rivolgersi per esporre, eticamente, il proprio sguardo sugli accadimenti del mondo e portare la memoria nel punto esatto non solo di “ricordare”, ma di non far “ripetere”. La poesia ha il compito dunque di “modificare” il punto di vista autentico sulla realtà, fornendo un angolo d’incidenza tra il reale e l’esistere, sul quale fare leva per l’interpretazione del vero che appare. Anche Salvatore Quasimodo, nel suo Discorso sulla poesia, si pone il problema dell’uomo e del poeta di fronte alla responsabilità etica della Storia. Infatti sarà uno dei primi poeti a dubitare della positività e della credibilità dell’uomo, abitante di una società capitalistica, annodata fra la miseria e le apparenze, mentre è ancora forte il ricordo della guerra: La posizione del poeta non può essere passiva nella società: egli “modifica” il mondo. Le sue immagini forti, quelle create, battono sul cuore dell’uomo più della filosofia e della storia. La poesia si trasforma in etica [...] la sua responsabilità è in diretto rapporto con la sua perfezione... Un poeta è tale quando non rinuncia alla sua presenza in una data terra, in un tempo esatto, definito politicamente. (Quasimodo 1956: 88-9)
Infatti in una silloge dal titolo Il falso e vero verde (1956), Salvatore Quasimodo pubblicò una poesia che rivelò all’Italia intera un luogo mai conosciuto prima, dal nome inquietante e contorto: Auschwitz.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
S. Raimondi - Nonostante tutto, nonostante il tutto
279
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Auschwitz Laggiù, ad Auschwitz, lontano dalla Vistola, amore, lungo la pianura nordica, in un campo di morte: fredda, funebre, la pioggia sulla ruggine dei pali e i grovigli di ferro dei recinti: e non albero o uccelli nell’aria grigia o su dal nostro pensiero, ma inerzia e dolore che la memoria lascia al suo silenzio senza ironia o ira. Da quell’inferno aperto da una scritta bianca: “Il lavoro vi renderà liberi” uscì continuo il fumo di migliaia di donne spinte fuori all’alba dai canili contro il muro del tiro a segno o soffocate urlando misericordia all’acqua con la bocca di scheletro sotto le docce a gas. Le troverai tu, soldato, nella tua storia in forme di fiumi, d’animali, o sei tu pure cenere d’Auschwitz, medaglia di silenzio? Restano lunghe trecce chiuse in urne di vetro ancora strette da amuleti e ombre infinite di piccole scarpe e di sciarpe d’ebrei: sono reliquie d’un tempo di saggezza, di sapienza dell’uomo che si fa misura d’armi, sono i miti, le nostre metamorfosi. Sulle distese dove amore e pianto marcirono e pietà, sotto la pioggia, laggiù, batteva un no dentro di noi, un no alla morte, morta ad Auschwitz, per non ripetere, da quella buca di cenere, la morte. (Quasimodo 1956: 30-2)
Ma come ogni luogo, anche quell’inesorabile laggiù ha per tutti delle date e delle parole per dirlo, dove dire è ricordare. Ma è anche proferirlo attraverso una lingua divelta, oscura, come quella poetica, sempre posta in uno stato di allerta – incomprensibile come potrebbe apparire quella di Celan – nella convinzione che essa ha, da allora, adottato l’oscurità per rimarcare l’inappartenenza ad una condizione/realtà disumana, come quella
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
280
Shoah, modernità e male politico
della Shoah. Nessun luogo è segnato nella mappa dell’umanità così indelebilmente come quello di Auschwitz, e nessun meridiano – ci si augura – lo dovrà mai, laggiù, attraversare ancora. La visita, Auschwitz 1971 Il Dottor Bronowski in piedi negli acquitrini. È tornato in Polonia e si accovaccia sulle scarpe pesanti, raccoglie del fango e lo versa da mano a mano. Qui, dice il Dottor Bronowski, con lo sguardo che concentra la luce, stanno le ceneri di quattro milioni di persone. Osserviamo la melma fina dei nostri genitori scivolare fra le sue mani. Ci parla camminando nell’acqua. L’umidità gli sale nelle scarpe. Nel centro viscido il cielo è diventato i suoi occhi, la pellicola dello stagno gli si avviluppa contro, abbracciandogli la carne. (Ress 1985)
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
281
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
ANDREA MINUZ
TRAUMA, MELODRAMMA, MEMORIA Percorsi nel cinema della Shoah
1. Introduzione La riflessione sull’eredità della Shoah accoglie ormai al suo interno una nutrita quantità di studi dedicati esclusivamente al cinema. Si tratta di una letteratura cresciuta in termini esponenziali soprattutto a partire dalla metà degli anni Novanta, sulla scia della popolarità internazionale di film come Schindler’s List (S. Spielberg, 1993) o La vita è bella (R. Benigni, 1997)1 e che a partire dallo studio pionieristico di Annette Insdorf, Indelible Shadows (1983)2, fino ad arrivare al monumentale The Holocaust Film Sourcebook (Picart 2004), per proseguire con studi sempre più specifici, circoscritti a precisi contesti nazionali o singoli film, non cessa di interrogare il ruolo decisivo svolto dal cinema nella costruzione della memoria della Shoah. D’altro canto, come ormai ribadito a ogni stagione cinematografica, la Shoah continua a offrirsi come un canone narrativo significativo per il cinema contemporaneo. Una storia cinematografica della Shoah scorre pertanto parallela e s’intreccia inevitabilmente a una più ampia storia della memoria culturale della Shoah. Al suo interno troviamo documentari, film di finzione di ogni genere, cinegiornali e materiali d’archivio divenuti testimonianze storiche (come nel caso delle riprese filmate dagli Alleati al momento della liberazione dei campi). Un importante tentativo di sistemazione e classificazione è offerto dal Cinematography of the Holocaust Project, organizzato dal Fritz Bauer Institut di Francoforte, un centro di studi e documentazione per la storia e l’impatto dell’Olocausto nella nostra cultura. Dal 1992, questo progetto coinvolge storici e archivisti nella raccolta dei materiali cinematografici riguardanti l’Olocausto e grazie alla sua attività dal 2000 è possibile consultare in rete uno dei più importanti 1 2
Vedi ad esempio Niv 2003; Loshitzky 1997. Sempre negli Ottanta è da segnalare Avisar 1988.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
282
Shoah, modernità e male politico
dizionari sul tema, contenente il materiale audiovisivo più vario3. Ma è anzitutto il cinema di finzione l’agente più significativo della diffusione della Shoah nella cultura popolare, nonché quello più coinvolto nella didattica e nella cosiddetta pedagogia della memoria. Allo stesso tempo esso è oggetto di critiche radicali. Seguendo quest’ultime, il cinema avrebbe sfruttato in chiave spettacolare il tema dell’Olocausto e, più di altri medium, sarebbe l’agente principale di una banalizzazione dei suoi significati. Viceversa, al cinema è stata riconosciuta non soltanto una funzione testimoniale determinante ma anche la capacità di poter elaborare su un piano propriamente artistico la sfida del racconto della Shoah. Questa non meglio definibile polarità morale ha preso una forma nell’opposizione tra Schindler’s List, il più celebre e importante film hollywoodiano sul tema, e Shoah, il documentario di Claude Lanzmann, realizzato nel 1985, considerato come la risposta artistica più radicale alla sfida rappresentativa dell’Olocausto elaborata dal cinema europeo, cui peraltro si deve l’ingresso e l’adozione del termine “Shoah” nello spazio pubblico. Si tratta di un’opposizione in cui si confrontano non soltanto le due vocazioni del cinema, quella industriale legata alla logica di Hollywood e quella documentaristica, in questo caso intesa nella forma di un estenuante lavoro sulla testimonianza. In modo più ampio, questi due film rappresentano anche la sintesi dei percorsi narrativi della testimonianza che si confrontano nella costruzione di una memoria cinematografica della Shoah, ovvero quello di una indicibilità dell’evento da un lato, di una sua sacrale irrappresentabilità, e viceversa della sua universalizzante lezione morale dall’altro (Hansen 1996). D’altro canto, se nella cultura europea la memoria della Shoah è diventata lo specchio attraverso cui riflettere sulla propria identità, e il ruolo paradigmatico di Auschwitz si esercita nel quadro di una autocomprensione negativa, diverso è il discorso da fare per la cultura americana. Qui la Shoah funziona ancora oggi come uno dei più efficaci paradigmi morali di riferimento per continuare a stabilire un confine netto tra il “bene” e il “male”. La sua popolarità è stata via via costruita attraverso una sovrapposizione tra l’universalismo della cultura americana e la specificità della vicenda 3
Cfr. http://www.fritz-bauer-institut.de/. Una sezione di valore storico è indubbiamente rappresentata dal corpus di film tedeschi realizzati prima del 1945 che include, oltre ai tristemente noti film della propaganda antisemita organizzata da Goebbels o al finto documentario realizzato dai nazisti nel campo di Theresienstadt, alcune rare testimonianze della barbarie filmate dagli stessi carnefici (Judenexecution in Libau, 1941; Die Zusammenlegung der letzen Juden aus Dresden in das Lager am Hellerberg, 1942).
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Minuz - Trauma, melodramma, memoria
283
ebraica, facendo ricorso a una narrazione che attinge alla tradizione dei morality plays e al melodramma hollywoodiano. Trauma da un lato, melodramma dall’altro, si costituiscono quindi non già come due generi di scrittura ma come le due principali forme simboliche su cui si sono costruite l’istanza memoriale europea e americana. Attorno ad esse si radunano non soltanto i film della Shoah ma, ad esempio, anche i discorsi sociali legati all’architettura dei musei e ai memoriali, intesi come rappresentazioni collettive dove prende forma una precisa ideologia della memoria4. Mantenendo questa dicotomia sullo sfondo, ricostruiremo qui in estrema sintesi le principali tappe di una filmografia della Shoah per poi discutere alcune questioni che, attraversando il cinema, si rilanciano nel più ampio orizzonte degli interrogativi che la Shoah pone alla modernità. 2. Percorsi storici Lo schema generalmente condiviso dagli studiosi (relativamente ai due grandi ambiti della finzione e del documentario) ricalca il percorso di trauma, rimozione e anamnesi, attraverso cui si dipana la più vasta costruzione culturale della memoria della Shoah. Sono queste, d’altronde, le tappe del processo che ha condotto Auschwitz dalla sua sostanziale invisibilità negli anni Cinquanta all’attuale onnipresenza nello spazio pubblico. Innanzitutto è bene ricordare che grazie ai filmati realizzati dagli operatori di guerra, con il processo di Norimberga l’immagine filmica si offre per la prima volta ad un impiego probatorio (le stesse sessioni del processo vennero filmate integralmente e conservate come archivio storico)5. Attorno alle immagini della liberazione dei campi e ai film didattici prodotti dai vincitori per esibire lo sviluppo criminale del regime nazista, si costruisce poi nell’immediato dopoguerra una grande operazione di rieducazione morale della Germania. Tuttavia, a causa dell’impatto devastante che quelle immagini avevano sul pubblico sia in Germania che altrove, i filmati con le atrocità dei campi uscirono ben presto dal circuito dei cinegiornali. Nel decennio 1945-1955 la Shoah è ben lungi dall’essere un tema cinematografico, e tuttavia i pochi film che affrontano l’argomento offrono già 4 5
Sui musei e memoriali della Shoah si vedano i fondamentali lavori di James Young (1993, 1994, 2000). Sul rapporto tra film e musei della Shoah mi permetto di rimandare il lettore a Minuz 2010. Su questi temi rinvio all’ottimo lavoro di Delage 2006.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
284
Shoah, modernità e male politico
uno spettro significativo delle principali opzioni di stile e linguaggio. È il caso di The Stranger (Lo straniero, O. Welles, 1946); Ostatni Etap (L’ultima tappa, W. Jakubowska, 1948); e Nuit et Brouillard (Notte e nebbia, A. Resnais, 1955); tre film che a loro modo sintetizzano i modi con cui il cinema di genere e quello documentaristico avvicineranno la Shoah. Il film di Orson Welles, scritto e girato alla fine del 1945 durante il periodo del processo di Norimberga e uscito poi negli Stati Uniti il 25 maggio 1946, è il primo ad includere immagini d’attualità e testimonianze filmate dei campi in un racconto di finzione – in questo caso, un noir tradizionale costruito come una spy story6. L’ultima tappa è invece una accurata e sofferta ricostruzione cinematografica dell’universo concentrazionario. Girato negli stessi luoghi dello sterminio prima che molti campi venissero distrutti o convertiti in memoriali, era interpretato da attori che in gran parte avevano vissuto l’esperienza della deportazione. Il film si offre pertanto come una prima significativa rielaborazione della testimonianza e di un vissuto personale nel quadro del cinema di finzione e, pur con tutti i suoi limiti storici, rappresenta ancora oggi uno dei contributi più significativi della cinematografia dell’Est alla costruzione memoriale della Shoah. Notte e nebbia, di Alain Resnais, è invece uno dei primi e più importanti documentari europei. Prodotto nell’ambito delle commemorazioni per i dieci anni dalla fine della guerra, costituisce una delle opere fondamentali del cinema moderno nato dalle ceneri di Auschwitz. Alcune soluzioni formali adottate da Resnais si riveleranno infatti decisive per elaborare la sfida di una rappresentazione cinematografica della Shoah, tanto nel campo della finzione che nel documentario, come i lunghi e articolati movimenti di macchina che restituiscono l’esperienza di uno sguardo “fantasma” che si aggira nella desolazione dei campi, o la contrapposizione tra colore e bianco e nero che corrisponde all’alternanza tra il presente, cioè le immagini dei campi filmati alla metà degli anni Cinquanta da Resnais, e il passato, ossia il 6
Le immagini d’archivio utilizzate da Welles provenivano per lo più da un filmato degli alleati, Army Signal Corps Atrocity Film, di cui un primo montaggio era stato mostrato a Norimberga (fu il primo film visionato, durante l’udienza del 29 novembre 1945). Nel film di Welles la proiezione delle immagini d’archivio è motivata con l’esigenza dell’ispettore Wilson (Edward G. Robinson) di convincere Mary Rankin (Loretta Young) che suo marito Charles è in realtà Franz Kindler (interpretato da Orson Welles), ovvero un famigerato nazista rifugiatosi negli Stati Uniti subito dopo la guerra. Siamo ovviamente in un ambito ben distante dalla presa di coscienza dell’evento storico Shoah, e tuttavia la sequenza realizzata da Welles esibisce qui un motivo iconografico che verrà ripreso in molti film di finzione a venire (la visione di materiale d’archivio legato alle atrocità naziste all’interno di un film di finzione).
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Minuz - Trauma, melodramma, memoria
285
materiale d’archivio7. Certo i limiti storici del film sono noti, a cominciare dal fatto che la parola “ebreo” non viene mai pronunciata – e da questo punto di vista, L’enclos (Otto ore al buio, A. Gatti, 1960), il primo film di finzione francese che affronta l’universo concentrazionario, per quanto minore sul piano artistico, è certo un passo in avanti. Tuttavia, anziché al contesto della memoria della Shoah, queste e altre opere del periodo (tra cui l’interessante film di montaggio di Leo Hurwitz, The Museum and the Fury, dedicato al museo di Auschwitz, uscito nello stesso anno di Notte e nebbia) devono essere ricondotte all’orizzonte della cultura antifascista dell’Europa degli anni Cinquanta e alla celebrazione dei valori della Resistenza, vista come il mito fondativo del nuovo mondo emerso dalla vittoria sul nazifascismo (van der Knaap 2006). In quest’orizzonte non c’era alcun posto per la specificità della Shoah ebraica, le cui vittime erano frettolosamente assimilate tra i martiri (inconsapevoli) della Resistenza. Del 1952 è invece la traduzione inglese del diario di Anne Frank, adattato poi per il teatro da Frances Goodrich e Albert Hackett, con enorme successo di pubblico e critica sin dalla prima tenutasi al Cort Theatre di Broadway, il 5 ottobre 1955. Sulla scia di questo successo, la Twentieth Century Fox produrrà nel 1959 una versione cinematografica della riduzione teatrale, affidando la regia a George Stevens. Oltre che autore di alcuni capolavori del cinema classico hollywoodiano come A Place in the Sun (Un posto al sole, 1951), Stevens fu operatore cinematografico per la U.S. Army Signal Corps, ed è a lui che dobbiamo le immagini della liberazione del campo di Dachau. The Diary of Anne Frank rappresenta anche una delle tappe significative della cosiddetta americanizzazione dell’Olocausto – quel processo, ovvero, di integrazione della memoria della Shoah nella cultura popolare americana in cui un ruolo decisivo è svolto proprio dall’industria hollywoodiana. Un processo che ha le sue tappe decisive nella miniserie televisiva Holocaust (prodotta dalla NBC nel 1978) e nel già citato Schindler’s List. Holocaust narrava come un qualsiasi feuilleton la saga di una famiglia di ebrei tedeschi contrapposta ad una famiglia nazista e le conseguenti vicende legate allo sterminio; ebbe un successo di pubblico e un clamore straordinari, con punte negli Stati Uniti e successivamente in Germania di oltre il 50% di share. In Germania, in particolar modo, Holocaust funzionò come una rielaborazione collettiva del trauma di una nazione intera, della sua responsabilità e della sua colpa. Lo sceneggiato segnò anche un decisivo spartiacque nel tentativo di narrare, attraverso un linguaggio (e un medium) popolare, le vicende della Shoah. 7
Una delle più accurate analisi del film di Resnais si trova in Lindeperg 2007.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
286
Shoah, modernità e male politico
D’altro canto, una tappa fondamentale nell’elaborazione collettiva della memoria della Shoah è com’è noto rappresentata dal processo ad Adolf Eichmann, celebrato a Gerusalemme tra il 1960 e il 1961. Un evento epocale, ripreso dalle televisioni di tutto il mondo, che cambiò radicalmente la percezione collettiva dell’evento. Oltre alla figura del freddo burocrate su cui Hannah Arendt costruì l’impianto teorico del suo celebre La banalità del male, furono soprattutto i numerosi sopravvissuti chiamati a testimoniare a generare una nuova e diversa sensibilità nei confronti della testimonianza. Al di là del suo valore storico e politico, il processo Eichmann è sin da subito letto come «un momento catartico di liberazione della parola, in cui i sopravvissuti dei campi nazisti possono testimoniare in aula, in presenza della stampa e di fronte alle telecamere del mondo intero» (Traverso 2004: 232). Il cinema raccolse così il nuovo impulso dato dal racconto individuale del trauma dell’esperienza concentrazionaria e lo trasformò in un nuovo canone con cui avvicinare la Shoah. Il continuo ritorno del fantasma dei campi nella nuova vita del sopravvissuto è affrontato da numerosi film degli anni Sessanta e Settanta. Tra gli esempi più riusciti nel cinema europeo e americano possiamo ricordare qui l’opera incompiuta di Andrzej Munk, Pasazerka (La passeggera, 1963), e The Pawnbroker (L’uomo del banco dei pegni, S. Lumet, 1965); mentre un discorso a parte deve essere fatto per film come Il portiere di notte (L. Cavani, 1974), da collocare nel ricambio culturale che investe il discorso della Shoah nel corso degli anni Settanta, e nella cosiddetta erotizzazione del nazismo – un controverso orizzonte di risignificazione dell’immaginario della Shoah che comprende anche film pornografici ambientati nell’universo concentrazionario. Il lavoro sul trauma dell’esperienza dei campi trova invece il suo apice artistico nel citato Shoah, di Claude Lanzmann. Frutto di dodici anni di ricerche, questo documentario della durata di oltre nove ore è stato accolto come un’opera monumentale e un documento storico di eccezionale importanza8. Il film di Lanzmann ricostruisce i dettagli della complessa catena dello sterminio e isola la specificità della Shoah ebraica dal generico immaginario della barbarie nazista. Nel far questo, rifiuta l’impiego di immagini d’archivio di qualsiasi tipo nella convinzione che siano ormai vuote di significato, banalizzate dalla loro stessa reiterazione, e che invece i luoghi desolati dove un tempo sorgevano i campi poi distrutti dai tedeschi, le voci, i gesti dei testimoni costringano lo spettatore nello sforzo di 8
Lo storico Pascal Vidal-Naquet (1987) affermerà di trovarsi di fronte al migliore esempio di sintesi tra scrittura storiografica e sensibilità artistica; Simone De Beauvoir parlerà di un inestricabile intreccio di orrore e bellezza.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Minuz - Trauma, melodramma, memoria
287
immaginare un evento impensabile9. Le immagini di corpi scheletriti dalla fame e dagli stenti prese dai liberatori diventano così inservibili innanzitutto perché attestano un altro universo (quello dei campi di concentramento), pensato come radicalmente diverso da quello dello sterminio sistematico perpetrato con il gas. Qui prende forma la principale differenza (che Lanzmann pensa nei termini di un’opposizione irriducibile) tra Shoah e i documentari precedenti, incluse opere pur importanti come Notte e nebbia. 3. Forme, generi, modelli Gli anni Novanta segnano l’avvio di una nuova ulteriore fase che conduce ai nostri giorni. È in questo decennio, d’altronde, che la Shoah viene saldamente collocata al centro dello spazio pubblico come un prisma di lettura di tutta la storia del XX secolo. La progressiva, inevitabile scomparsa dei testimoni fa il resto. Dal successo di un film come Schindler’s List ad oggi, la Shoah si è trasformata in un orizzonte narrativo da cui attingono il cinema, la letteratura, l’arte, i media. La proclamata indicibilità che abbiamo assegnato a questo evento fa da sfondo a uno degli ultimi grandi racconti rimasti che, come una sorta di epica negativa, attraversa tutte le forme e le riscritture possibili dell’immaginario. Quel male assoluto che, secondo la popolare provocazione di Adorno (scrivere poesie dopo Auschwitz è un atto di barbarie), doveva costringere l’arte ad interrogarsi radicalmente sui propri presupposti, è insomma diventato uno dei temi narrativi decisivi della nostra epoca. D’altronde, come già notava Primo Levi commentando la serie TV Holocaust in controtendenza rispetto alle critiche degli intellettuali: Si tratta di imprese ad un tempo ciniche e pie, e la contraddizione non deve stupire, dal momento che l’autore non è uno solo: gli autori sono molti, e fra i molti ci sono appunto i cinici e i pii. Non mi pare che si possano fare obiezioni serie; fin da Eschilo, lo spettacolo pubblico ha attinto alle sorgenti che più muovono il pubblico e queste sono il delitto, il destino, il dolore umano, l’oppressione, la strage e la riscossa. (Levi 1978: 2)
Il successo di film, libri, iniziative pubbliche, mostre, dibattiti intellettuali e quant’altro riguardi in qualche modo l’Olocausto appare inarrestabile. Da questo punto di vista, basta guardare alle ultime stagioni cinematogra9
Su Shoah esiste una cospicua letteratura. Tra le monografie segnalo almeno Alterman 2006; Didi-Huberman 1995; Koch 1989; Dagrada 2005; La Capra 2007. Vedi anche Perniola 2007.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
288
Shoah, modernità e male politico
fiche. Non soltanto per l’ampio numero di film, sia europei che americani, realizzati per il grande pubblico, ma anche per il coinvolgimento sempre maggiore di grandi nomi dello show business, come Kate Winslet (The Reader, S. Daldry), Tom Cruise (Valkyrie, B. Singer), Daniel Craig (Defiance, E. Zwick), fino a Quentin Tarantino (Inglourious Bastards); film realizzati tutti nel 2008. Proprio a commento di questi e altri film, un lungo articolo del New York Times si interrogava sul numero sempre crescente e sul successo di queste finzioni, avanzando il timore che esse ormai costituiscano per il pubblico un genere cinematografico come altri (Scott 2008). L’idea di guardare all’Holocaust Film come a un “genere” era già stata presa in considerazione dagli studiosi. Nel giugno del 2000, ad esempio, il Center for Advanced Holocaust Studies del Museo dell’Olocausto di Washington D.C. organizzò un workshop di due settimane dedicato all’Holocaust Film, incentrato sulla lettura e la ridefinizione di questi film nello spazio dei generi cinematografici. In quest’occasione veniva notato come la classificazione tra i generi risulti problematica innanzitutto per i diversi regimi dell’immagine e del racconto di volta in volta impiegati. Saremmo cioè di fronte a un genere che avrebbe la sua nascita nella metà degli anni Cinquanta, biforcandosi pressoché contemporaneamente nella ricostruzione poetica e commemorativa del documentario (come nel caso di Notte e nebbia) e nelle forme del melodramma hollywoodiano (Il diario di Anna Frank); film che ovviamente non definiscono la genesi di un incontro cinematografico con l’evento, ma costruiscono le tappe importanti di una germinale fase di rimemorazione dell’Olocausto nel discorso pubblico10. Bisogna d’altronde ricordare ancora una volta che è soltanto retrospettivamente che possiamo parlare di questi film in riferimento alla memoria della Shoah (vale a dire ad un campo preciso di implicazioni storiche e culturali, pressoché assente dallo spazio pubblico fino agli inizi degli anni Sessanta). In tal senso, siamo di fronte ad una costruzione discorsiva postuma che è il frutto della centralità assunta dalla Shoah ebraica nella storia del XX secolo e nella nostra idea di modernità. Tuttavia, a partire dalla fine degli anni Sessanta e in modo definitivo con la comparsa dello sceneggiato Holocaust, il complesso di questi film è radunato dalla critica e dalla teoria di fronte ad una più o meno consapevole assunzione del problema della rappresentabilità della Shoah. A questo paradigma si aggiunge – soprattutto nella critica americana – un parametro che fa leva invece sul grado di consapevolezza della connotazione ebraica 10
Sul rapporto tra memoria della Shoah, generi cinematografici e cultura popolare rimando a Vitiello 2012.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Minuz - Trauma, melodramma, memoria
289
dell’evento, e dunque sull’ebraismo del film stesso. Il criterio adottato ad esempio da Ilan Avisar nella sistemazione tematica (e nel giudizio di valore) dei film ricorre alla presenza o meno di una specificità ebraica del plot, a prescindere dalla forma impiegata – e in base a ciò gran parte dei film sono giudicati inadeguati (Avisar 1988). Ma è evidente che ogni rappresentazione della Shoah per quanto nazionale e/o microstorica (cioè riferita ad un episodio e alla memoria di una nazione o di un’etnia in particolare) si confronta con un evento preso nel concetto di Zivilisationsbruch, ossia di una frattura di civiltà in cui si riuniscono sia la prospettiva dell’esperienza subita storicamente e in particolar modo dal mondo ebraico, sia la mobilitazione di tutto l’orizzonte culturale del mondo occidentale nato dalle ceneri di Auschwitz11. In una prospettiva estremamente critica verso i lavori che si occupano di Holocaust Film, Terri Ginsberg (2007) denuncia la prevalenza di studiosi non specialisti – o comunque con scarsa confidenza nei confronti dell’analisi del film – e di conseguenza orientati principalmente verso una lettura (eccessivamente) tematica dei testi12. Ciò che lei definisce come «gli approcci incentrati sulle categorie di tema/genere/autore che caratterizzano la maggior parte delle analisi culturali dell’Olocausto, promosse da studiosi non specializzati in Film Studies» compongono dunque il quadro di una letteratura in cui le implicazioni culturali più ampie appaiono spesso sbiadite, in riferimento non solo alla scarsa attenzione alla dimensione formale dei testi, ma soprattutto alle connessioni tra il contesto economico-produttivo, alla ricezione del pubblico e alle politiche delle memorie nazionali. 4. Percorsi teorici: i limiti della rappresentazione Nella variegata costellazione concettuale prodotta dall’indicibilità di Auschwitz, anche i rapporti tra il cinema e la Shoah si riconfigurano come una potente macchina discorsiva che ha fatto dei “limiti della rappresentazione” un’estenuante, non priva di ambiguità, battaglia culturale. Di fronte ai film sull’Olocausto, l’irrappresentabile funziona come un codice etico, un distributore di valore delle opere, quasi un intrinseco coefficiente di artisticità. Da questo punto di vista, Shoah di Lanzmann si offre come la più compiuta manifestazione cinematografica di tale nozione. La netta po11 12
Sulla dimensione epistemologica dell’evento storico Shoah mi riferisco qui a Diner 1988, 1999, 2000, 2005. Per un discorso allargato alla sfera contestuale vedi anche Lawrence 2005.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
290
Shoah, modernità e male politico
sizione di rifiuto nei confronti del materiale d’archivio fu infatti adottata da Lanzmann come risposta al fatto che i documenti visivi non avevano comunque impedito agli storici negazionisti, come Faurisson, di mettere in dubbio l’esistenza delle camere a gas13. Shoah, d’altronde, è un film che si concentra quasi esclusivamente sulla ricostruzione del dato più orrorifico e insondabile del crimine nazista. La sfida raccolta da Lanzmann era precisamente rappresentata da questa sorta di buco nero della prova visiva ed è a ciò che va ricondotto il suo rifiuto dei documenti visivi e del materiale di repertorio. L’assenza di immagini si inserisce nel solco delle aporie di quella testimonianza inattestabile interrogata da Primo Levi, Lyotard e Agamben14. Anche per questo, la critica più sofisticata ha intravisto nella costruzione formale di Shoah il dispiegarsi di una precisa posizione al contempo etica e teorica. Poiché non disponiamo di immagini prese all’interno delle camere a gas – e qualora esistessero, queste non solo non aggiungerebbero nulla alla nostra incapacità di comprendere, ma proporrebbero esclusivamente il punto di vista dei carnefici – Lanzmann ha più volte dichiarato che se le avesse trovate non avrebbe esitato a distruggerle. Una posizione che è stata fonte di un’accesa polemica con Jean-Luc Godard, il quale invece non ha dubbi sulla loro esistenza. In realtà, la possibilità che dagli archivi emergano immagini filmate dai nazisti all’interno delle camere a gas è secondo gli storici una discussione priva di reale fondamento15, e tuttavia essa appare interessante proprio sul piano del dibattito attorno ai limiti della rappresentazione e della conseguente sacralizzazione del film di Lanzmann. Erettosi a monumento iconoclasta delle rappresentazioni dello sterminio, Shoah entra così nell’alveo delle estetiche negative che nel corso del XX secolo hanno rigettato l’idea di rappresentazione e di mimesis (così, Gérard Wajcman (1988), ad esempio, ha paragonato Shoah al Quadrato nero di Malevič). Da qui, anche, l’uso strumentale del film in una dubbia battaglia per difendere i valori dell’arte contro l’americanizzazione dell’Olocausto 13
14 15
Proprio contro di lui si assiste nel 1979 a un primo, netto atto di demarcazione epistemologica degli storici francesi, i quali, in un manifesto pubblicato su Le Monde, pur salvaguardando la libertà metodologica e interpretativa di ogni storico che indaga le ragioni e i modi di funzionamento della macchina dello sterminio nazista, dichiarano l’impossibilità categorica che questa possa prodursi in un dibattito circa l’esistenza delle camere a gas; cfr. Ariès et al. 1979. Su questi temi rimando a Montani 2004. Cfr. Delfour 2000; Lanzmann 1994; Godard 1998. Lo storico Christian Delage (2006) ha ricostruito le vicende della ricerca di filmati realizzati dai nazisti, commissionata a una squadra dei servizi segreti americani con a capo John Ford (Field Photographic Branch, Office of Strategic Services) sin dall’estate del 1945.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Minuz - Trauma, melodramma, memoria
291
e in particolare contro Schindler’s List (battaglia che vede lo stesso Lanzmann tra i suoi più accesi animatori). Anche George Didi-Huberman, che pure nel suo celebre libro Immagini malgrado tutto ha mosso una critica radicale alla nozione «davvero abusata» di irrappresentabile e alla sua nebulosa semantica, non mette tuttavia in dubbio la superiorità del documentario o del film-saggio (francesi) sulle forme della narrativa di finzione: Ci sono almeno due modi, nel cinema d’oggi, di mettere all’opera questo assillo in riferimento alla distruzione degli ebrei d’Europa: Claude Lanzmann ha creato, in Shoah, un tipo di montaggio che fa ritornare i volti, le testimonianze, i paesaggi stessi verso un centro mai raggiunto: montaggio centripeto, elogio della lentezza. È una sorta di basso continuo che scava il tempo delle nove ore e mezza di durata del suo film. Jean-Luc Godard ha creato invece, in Histoire(s) du cinéma, un tipo di montaggio che fa turbinare i documenti, le citazioni, gli estratti di altri film verso un’estensione mai coperta: montaggio centrifugo, elogio della velocità […]. Lanzmann pensa tuttavia che nessuna immagine sia capace di “dire” questa storia ed ecco perché filma senza posa la parola dei testimoni. Mentre Godard pensa che tutte le immagini ormai ci “parlino” solo di questo (dire che “ne parlano” non significa però che “lo dicono”) ed ecco perché rivisita senza posa tutta la nostra cultura visiva sulla sfondo di tale questione. (Didi-Huberman 2003: 159)
Didi-Huberman, insomma, salva l’immagine ma a suo modo condanna la finzione. Anch’egli cioè si muove lungo il monito lanciato a suo tempo da Elie Wiesel: «un romanzo su Auschwitz non è un romanzo, oppure non è su Auschwitz» (Wiesel 1982: 191); una massima che a sua volta circoscriveva al perimetro del “romanzesco” la celeberrima interdizione adorniana, una formula ridotta a monito simbolico o ampiamente riletta e rivista a cominciare, come si sa, dallo stesso Adorno16. L’arte anti-rappresentativa che lavora sul pathos della distanza è stata così considerata come la naturale forma incaricata di affrontare adeguatamente il tema dell’Olocausto. La frattura del modernismo – una rottura con le forme classiche della rappresentazione e della figurazione – si è rivelata l’opzione necessaria per rielaborare l’idea di trauma sottesa a questa sfida narrativa. In quest’ottica, va da sé, si rifugge da ogni dimensione finzionale, melodrammatica, sentimentale, quali registri intesi come profondamente inadeguati al trattamento di questo tema. Ma, tanto più al cinema, questa idea presta anche il fianco a una serie di iperboli, equivoci, paradossi e terrorismi intellettuali che rischiano di non comprendere le ragioni di un trattamento popolare dei temi legati alla Shoah, di opere che fanno leva sul16
Rinvio in sintesi a Traverso 2004, in particolare pp. 109-26.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
292
Shoah, modernità e male politico
le emozioni e sui più classici meccanismi di identificazione spettatoriale, e che hanno svolto e svolgono anche una funzione divulgativa necessaria. Dovremmo pertanto cercare di mettere in luce lo spettro di significati che il paradigma della indicibilità della Shoah innesca nei dibattiti attorno alle sue rappresentazioni cinematografiche; interrogarci circa «l’uso inflazionato della nozione di irrappresentabile e della costellazione di nozioni vicine: l’impresentabile, l’impensabile, l’intrattabile, l’incomparabile» (Rancière 2003: 155). Attorno a questi termini si tesse invero una disputa politica sulle immagini, in cui tra un oggetto postulato come sacro, unico e indicibile e il suo consumo di massa in vari generi di scrittura, si rintracciano le incomprensioni, le distanze, le diffidenze e i rispettivi pregiudizi con cui, ad esempio, il cinema d’arte europeo e quello hollywoodiano si guardano reciprocamente. Ci si trova di fronte a uno scollamento tra una posizione teorica cristallizzata attorno a una serie di precetti e divieti e le eterogenee esperienze che ci fanno entrare in contatto con la memoria e le rappresentazioni della Shoah. Lo studioso che affronta i film e gli eterogenei oggetti della cultura visuale con cui si è costruita una memoria della Shoah si trova così di fronte a una complessa rete di discorsi sociali in cui Auschwitz, simbolo degli orrori del XX secolo, è stato pensato in relazione ad una sua possibile rappresentazione collettiva. Ma si confronta anche con una serie di discorsi etico-filosofici che hanno progressivamente pensato l’idea stessa di rappresentabilità in relazione ad Auschwitz. In entrambi i casi, si tratta di ricostruire quei passaggi decisivi con cui è stato possibile negoziare una memoria e demarcare una rappresentabilità della Shoah. 5. Il cinema della Shoah: prospettive di studio Schindler’s List non segna soltanto l’innesto definitivo dell’Olocausto nella cultura americana, ma anche la ricollocazione in un orizzonte transnazionale della produzione memoriale della Shoah. In questo senso siamo ormai di fronte ad uno spazio conflittuale in cui si riconfigurano i rapporti tra l’idea di cultura nazionale e la sua contemporanea articolazione globale (Dennison – Lim 2006). Occuparsi dei film della Shoah significa allora affrontare un nodo decisivo del rapporto simbiotico tra il cinema e la modernità da un lato, e la memoria e l’identità dall’altro. Significa muoversi lungo un orizzonte in cui le questioni messe in gioco dai film appaiono inseperabili dall’interrogazione dei contesti culturali in cui esse si configurano. Come già ipotizzato nel lavoro curato da Barbie Zelizer (2001), Visual Culture and the Holocaust, si tratta di costruire un campo di ricerche
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
A. Minuz - Trauma, melodramma, memoria
293
da cui sono rimossi non soltanto i confini tra i diversi medium (il cinema, la fotografia, l’architettura museale, e così via), ma anche i cosiddetti confini di valore, che opporrebbero cioè le forme dell’Arte a quelle della cultura popolare. Entrambe partecipano invece di un universo di immagini in cui prende forma una specifica cultura memoriale. Tutte le immagini e i modi di visualizzazione della Shoah – non solo quelli espressi dai documenti storici o dalla grande Arte che ha accettato la sfida rappresentativa posta da questo tema – determinano atteggiamenti e contribuiscono alla costruzione di valori e significati condivisi o contrastanti. Attraverso le istituzioni culturali e i luoghi, gli artefatti e gli emblemi, i media, i racconti orali e molto altro ancora, «la memoria non si materializza semplicemente ma il passato scende a compromessi, viene mediato ed elaborato collettivamente per divenire cultura condivisa» (Grande 2007: 61). Il cinema della Shoah può essere così definito nell’intersezione di una cosiddetta serie culturale in cui si inscrivono tutto un insieme di pratiche commemorative, identitarie, politiche, e pedagogiche (il Giorno della memoria e la visione dei film nelle scuole, i musei, i discorsi pubblici). Inoltre, nel vasto insieme di film che raccontano la Shoah, l’idea di una selezione a partire da ciò che si esprime nei frammenti, più che nel racconto, può rivelarsi determinante – poiché sono le immagini, o meglio alcune immagini, anziché i cosiddetti “messaggi”, ciò che noi stessi ricordiamo di un film: la bambina con il cappotto rosso di Schindler’s List è un’icona della memoria della Shoah, anche se non tutti ricordano la vicenda, tantomeno i dettagli della trama del film, su cui spesso si esercitano le letture della critica. La possibilità di educare alla memoria anche attraverso il cinema, come da più parti si sostiene, passa insomma per una doppia capacità; da un lato, quella di riconoscere i codici estetici e produttivi impiegati, e, dall’altro, di interrogarsi su come e perché alcuni segmenti di questo immaginario siano entrati a far parte della nostra memoria. L’analisi e l’interpretazione dei film deve essere rilanciata nel circuito più ampio della cultura visuale e della serie di trame e moduli di costruzione della memoria che essi intercettano. Non dovremmo, attraverso il cinema, far proprio il messaggio consolatorio della commemorazione, ma interrogare le circostanze entro cui si costruisce la nostra memoria mediata in rapporto ad altri discorsi sociali.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
295
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
TULLIO SEPPILLI
RAZZISMO E “COSTRUZIONE SOCIALE DEL MALE”: UNA RIFLESSIONE ANTROPOLOGICA
1. L’interrogativo su cui questo contributo cercherà di riflettere è semplice e ad un tempo smisurato: in verità, una catastrofe umana paragonabile a quella della Shoah potrà nuovamente accadere? In quelle dimensioni? Con quelle caratteristiche? Quali potrebbero esserne le nuove vittime? E quale contributo a “capire”, e soprattutto a prevedere e forse a prevenire, può risultare da un percorso di pensiero di tipo antropologico (che è in sostanza quello che posso qui proporre, in conformità con la mia formazione e il mio lavoro)? Appunto lungo tale percorso credo che dovremmo riflettere intorno a tre ordini di questioni: a) Cosa sono, con precisione, e quali funzioni soggettive e oggettive svolgono o possono svolgere – nei quotidiani rapporti interindividuali e nei grandi processi di integrazione e conflitto sociale – quei dispositivi mentali che denominiamo stereotipi e pregiudizi? Come essi sono affrontati nell’ambito della ricerca antropologica, psicologica e in generale delle scienze storico-sociali, e dunque in riferimento ai concetti-chiave di cultura, di egemonia, di potere? b) Quali condizioni oggettive e soggettive incentivano il prodursi o l’intensificarsi di stereotipi e pregiudizi e, in particolare, attraverso quali meccanismi e con quali funzioni può realizzarsi la loro promozione e il loro uso politico da parte di taluni settori della società? In sostanza, quali agenti sociali tendono a produrre e/o a esasperare taluni stereotipi e pregiudizi? a funzionalizzarli per l’avvio di progetti di potere? a trasformarli da semplici atteggiamenti o da sporadici comportamenti individuali in pratiche organizzate di vera e propria violenza collettiva? È certo, in effetti, che ci troviamo di fronte a processi che vengono condotti intercettando diffusi sentimenti di incertezza, spaesamento, frustrazione, e incanalando verso gruppi sociali in qualche modo “diversi” l’aggressività e il bisogno di sfogo che pressoché inevitabilmente si sviluppano in consistenti strati di popolazione quando essi non riescono a individuare e ad affrontare le cause e i responsabili reali del loro disagio. E in quali
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
296
Shoah, modernità e male politico
condizioni economico-sociali e politiche i pregiudizi possono assumere la “naturalità” del senso comune e risultare legittimati e codificati anche in termini normativi e istituzionali, aprendo così la strada a regimi di terrore organizzato? c) Cosa ci insegna, in merito, e quali questioni apre, l’esperienza-limite del nazismo, dello sterminio dei “diversi” e della tragedia della Shoah? d) Infine: esistono oggi, nel nostro paese, concrete condizioni – analoghe a quelle degli anni Trenta e Quaranta del Novecento o anche “nuove” – tali da produrre, sotto la spinta di taluni gruppi politico-sociali, uno spostamento delle tensioni e delle attenzioni collettive verso direzioni disegnate dalla diffusione di stereotipi e pregiudizi contro specifiche fasce di popolazione? E tali da spingere verso una ulteriore riduzione degli spazi democratici e verso la costruzione di forme autoritarie di potere? 2. Anzitutto, prima ancora di esaminare le funzioni e i fattori sociali che li alimentano e li esaltano, è bene anticipare una definizione, pur di massima, di ciò che nelle scienze sociali intendiamo oggi con i termini “stereotipo” e “pregiudizio”: a) lo stereotipo è una rappresentazione sociale costituita da una ipersemplificazione, una distorsione o una vera e propria arbitraria invenzione, di caratteristiche psico-culturali e comportamentali attribuite a un determinato gruppo o a una determinata condizione sociale (di qualunque tipo: somatico, etnico, territoriale, culturale, politico, religioso, di genere, o altro ancora); b) il pregiudizio è in sostanza uno stereotipo “caricato” di un giudizio di valore, in genere negativo: un gruppo o una condizione vengono cioè valutati aprioristicamente in termini negativi sulla base di un loro preliminare “etichettamento”; vengono caratterizzati, in altre parole, attribuendo loro specifici orientamenti psico-culturali e comportamentali che nel contesto dato sono largamente ritenuti negativi. È forse opportuno sottolineare, in proposito, che stereotipi e pregiudizi non concernono le possibili effettive diversità fra il gruppo che viene “giudicato” e colui o coloro che formulano tale giudizio. Il problema non sta nella esistenza di una loro “diversità” – in taluni casi del tutto inventata e in altri invece persino ovvia –, bensì (a) nella arbitraria attribuzione, al gruppo “diverso”, di infondate qualificazioni psico-culturali o comportamentali “aggiuntive”, oppure (b) in un atteggiamento di diffidenza e rifiuto a fronte della “diversità” tout court – somatica, psico-culturale o degli stili di vita.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
T. Seppilli - Razzismo e “costruzione sociale del male”
297
3. Senza dubbio, il bisogno di interpretare/valutare coloro con cui veniamo a contatto, per prevederne i comportamenti e “aggiustarvi” i propri, è generale e “naturale”. Ed è “normale” che in mancanza di una sufficiente esperienza relativa a qualcuno che non si conosce a fondo, si cerchi di avvalersi di segni che richiamino in qualche modo precedenti esperienze con altre persone apparentemente simili, oppure si utilizzino informazioni culturalmente diffuse che sembrano in qualche modo poter vicariare la carenza di verifiche dirette. Ciò porta spesso a errate attribuzioni di caratteristiche inesistenti. Ma siamo di fronte, in tal caso, a procedure “normali”, che in certo senso ci guidano e ci “tranquillizzano” nei primi incontri con una persona ignota. E tuttavia è altrettanto “normale” che in seguito a una maggiore frequentazione diretta, l’opinione che in un primo momento è, appunto, in qualche misura arbitraria e precostituita, lasci il posto a una valutazione specifica ed empiricamente fondata. Ed è peraltro da dire, in generale, che la conoscenza del proprio contesto – persone, luoghi, situazioni – e dunque la prevedibilità di quanto vi accade e il possibile “aggiustamento” del proprio agire sociale sono un importante fattore di semplificazione della vita e un elemento assolutamente centrale nei meccanismi di produzione dei vissuti di sicurezza individuale e collettiva: pensiamo all’ansia che ci assale in ogni improvvisa situazione di grave spaesamento o, di contro, alla sensazione confortante di avere attorno persone “come noi” oppure alla tranquilla certezza che ci danno i luoghi noti... 4. Ovviamente, da tutto questo deriva una grossa questione, quella dei centri di potere che in un contesto storico determinato sono in grado di diffondere o anche semplicemente rafforzare con reale successo modelli stereotipici di definizione e valutazione di “alterità negative”: modelli dotati di tale intensità e capacità di penetrazione, in una parte significativa dell’opinione pubblica, da apparire come “cosa ovvia” e annullare, stabilmente, ogni volontà soggettiva di controllo diretto e di autonoma valutazione delle reali caratteristiche delle persone appartenenti ai gruppi sociali additati come “inferiori” o comunque “pericolosi” e “nemici”. E deriva, soprattutto, la questione della funzione che l’affermarsi di stereotipi negativi rappresenta negli equilibri politico-sociali. È strategica, infatti, per i gruppi dominanti – e non solo –, la possibilità di canalizzare, appunto verso gruppi “deboli” assunti al ruolo di capri espiatori, gli stati di disagio, frustrazione e conseguente aggressività diffusi in larghe fasce di popolazione – stati peraltro dei quali sono di frequente gli stessi gruppi dominanti, almeno in larga misura, i diretti responsabili.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
298
Shoah, modernità e male politico
Per questo, non stiamo parlando, qui, dei semplici e spesso arbitrari giudizi provvisoriamente formulati da ognuno di noi in un “normale” percorso di avvicinamento e di definizione nei confronti di persone ancora sconosciute. Stiamo parlando di fenomeni di grossa e pesante portata, che antiche e recenti vicende impongono alla nostra attenzione: la questione politica della produzione degli stereotipi e dei pregiudizi, dei gruppi sociali che li definiscono e li diffondono, delle situazioni di stigma che ne conseguono, degli effetti che ne derivano per le vittime e per l’intera società: una questione, questa, che costituisce di fatto una fra le componenti più significative e drammatiche delle dinamiche anche moderne di egemonia e di potere. Certo, dai “blasoni” o dalle barzellette malevole sugli abitanti di questo o quel paese, di questa o quella città, alla pratica dei roghi inquisitoriali o dei campi di sterminio, corre un largo spazio. E tuttavia nei passaggi da una formulazione quasi scherzosa alla violenza di Stato esiste un continuum, su cui possono incidere un gran numero di fattori di contesto, che vanno comunque e sempre attentamente valutati (e contrastati). 5. In effetti, le ricerche hanno individuato da tempo almeno tre fattori che sembrano avere un peso notevole nel facile radicamento di stereotipi e pregiudizi: a) la semplificazione interpretativa – consentita dalle stereotipizzazioni – della crescente eterogeneità e complessità del panorama sociale e dei rapporti interindividuali che ci circondano, e la conseguente apparente e “comoda” disponibilità di modelli già precostituiti, utili alla valutazione del prossimo e a un adeguato comportamento nelle relazioni sociali; b) il senso di superiorità che stereotipi e pregiudizi consentono di avvertire nei confronti degli individui appartenenti ai presunti gruppi “inferiori”: una sensazione che risulta particolarmente gratificante per le persone e per gli strati sociali oggettivamente collocati in situazioni di forte precarietà e subordinazione, i quali attraverso l’assunzione del pregiudizio, e per opposizione ai “diversi”, possono sentirsi in qualche modo accomunati agli strati collocati al vertice del sistema (il “noi bianchi” della manovalanza sottoproletaria aizzata al linciaggio di capri espiatori afro-americani, per fare un esempio); c) il rafforzamento di una rassicurante rete di legami di coesione sociale: quando la tensione nata da stati di disagio, insicurezza e frustra-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
T. Seppilli - Razzismo e “costruzione sociale del male”
299
zione, individuale o collettiva, da situazioni di grave crisi economica e/o culturale, viene canalizzata e spostata verso un nemico “altro” (esterno o interno), ne risultano rafforzati la coesione e un positivo senso di appartenenza all’interno di quello che è avvertito come il proprio (e “puro”) gruppo di appartenenza (la esoclastia, analizzata per altri versi anche da numerose ricerche etnologiche sulle tensioni intertribali). 6. Soprattutto in riferimento al successo nazista nella condivisione di massa dei pregiudizi contro gli ebrei e altri “diversi”, e delle connesse pratiche di sterminio, sono emerse nella ricerca e nel dibattito scientifico e politico almeno altre due questioni che è bene sottolineare. La prima è quella del rapporto fra tale successo e la possibile preesistenza di specifici orientamenti nella cultura e nella struttura di personalità di larghi strati della popolazione tedesca: e viene fatto riferimento, in proposito, a una antica eredità di pregiudizi antisemiti, a un indiscusso spirito di obbedienza all’autorità e allo Stato, a un diffuso “spirito militare”, a un forte bisogno di coesione e di identità pangermanica costruito in riferimento ad antichi miti di origine e in opposizione alla “inferiorità” degli altri popoli (il popolo tedesco come Herrenvolk, ecc.). In sostanza: quanto ha pesato la “tradizione”, la “cultura tedesca”, una educazione di tipo autoritario e un conseguente orientamento della struttura di personalità nella adesione di massa alle pratiche naziste? Il che riapre interrogativi interpretativi non solo sul merito concreto dei riferimenti storici ma anche, in termini teorici, sulla definizione e la misura di validità del concetto di “carattere nazionale” proposto nell’ambito degli studi antropologici. La seconda questione riguarda un meccanismo implicito nella partecipazione, e anche nella sola “complicità”, rispetto alle violenze contro i gruppi minoritari: un meccanismo (e le sue modalità di produzione) attraverso il quale viene operata una scissione fra il proprio gruppo – con il quale permangono i normali rapporti comunitari, le normali relazioni “fra eguali”, la normale condivisione di affetti ed emozioni –, e “gli altri”, verso i quali si estingue ogni empatia, ogni solidarietà, ogni attenzione etica, ed è legittima e positiva ogni violenza, perché essi appaiono esclusi da una comune appartenenza alla specie umana. E mi viene in mente un semplice parallelo: la affettuosa cura con cui il giardiniere si occupa delle proprie piantine mentre, proprio in rapporto a tale amore, estirpa senza dubbi o esitazioni le vicine “erbacce”...
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
300
Shoah, modernità e male politico
7. Le condizioni economiche, socio-culturali e psicologiche che hanno prodotto il nazismo, fino alla tragedia della Shoah, sono state esaustivamente esaminate da una vastissima e multidisciplinare letteratura. Basti qui ricordare i testi ormai classici di Wilhelm Reich (1933), Erich Fromm (1941), Theodor W. Adorno (Adorno et al. 1950). Come si è detto all’inizio, dunque, il quesito principale che oggi dobbiamo porci sembra potersi così formulare nei suoi termini generali: esistono allo stato attuale condizioni – analoghe a quelle degli anni Trenta e Quaranta del Novecento o anche diverse – tali comunque da far riemergere, nello scenario europeo, forme istituzionali di terrore organizzato, o comunque consistenti e aggressivi movimenti di massa nei confronti di un qualsiasi tipo di minoranza? Il ragionamento fin qui delineato deve svilupparsi, dunque, tentando di affrontare questo quesito – almeno in termini molto generali – proponendo alcuni principali temi di riflessione che cerco qui molto sinteticamente di indicare. Una prima diversità rispetto al Novecento è certamente costituita dal fatto che i processi di controllo sociale, e dunque di conformazione culturale, possono giovarsi ora di un tale ventaglio di potenti canali di comunicazione da consentire un maggiore spazio ai meccanismi di egemonia rispetto a quelli di coercizione (meno bisogno di forme aperte di dittatura e di militarizzazione ideologica): la cosa ha, malgrado tutto, un certo peso (ma va costantemente monitorata in relazione ai cambiamenti anche tecnologici delle reti di comunicazione). Una seconda diversità rispetto al passato è che il vero e proprio razzismo, inteso nei suoi riferimenti a “superiorità” o “inferiorità” fondate su matrici biologiche, sembra battuto non solo sul terreno scientifico ma anche in forte misura nella pubblica opinione (anche i peggiori diffusori di pregiudizi si proclamano oggi “non razzisti”). E tuttavia, questo è importante ma non decisivo. Il pregiudizio viene oggi riferito non già alla “razza” bensì ad altre condizioni – etniche, religiose, ecc. –, ma appare comunque significativamente diffuso1: e in condizioni “fertili” può comunque risultare assai pericoloso. Occorre d’altronde ricordare che proprio per la loro reale funzione i pregiudizi possono anche mutare il loro gruppo-bersaglio: certo, le stereotipie “tradizionali” pesano fortemente e in modo significativo, dove esistono, ma la direzione delle 1
Valgano ad esempio i risultati della ricerca Permanenza e metamorfosi delle forme del pregiudizio: antisemitismo e islamofobia, recentemente promossa da alcune importanti istituzioni culturali torinesi sulla presenza di pregiudizi antisemiti e antislamici nell’intero territorio italiano.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
T. Seppilli - Razzismo e “costruzione sociale del male”
301
discriminazioni può anche cambiare nel tempo in conformità con specifiche situazioni (ad esempio con il prodursi e il mutare di differenti flussi immigratori). In larga sintesi mi sembra esistano, comunque, alcune condizioni che spingono oggi, e potrebbero spingere ancor più in futuro, verso il prodursi e il diffondersi di stereotipi e pregiudizi – di tipo populista – con possibili esiti di violenza collettiva o almeno di semplice apatia nei confronti di legislazioni e/o pratiche repressive della diversità: a) il senso di sradicamento e spaesamento conseguente ai rapidi e continui cambiamenti socio-culturali e la conseguente caduta delle certezze nell’esistenza di una propria comunità e nella stabilità di valori e condivisi modelli di comportamento; b) la caduta dei legami familiari e comunitari di sostegno primario e il parallelo rarefarsi degli orizzonti di comune partecipazione a imprese e orizzonti ideali di cambiamento collettivo della società (un fenomeno aggravato dal rarefarsi e dal progressivo allontanamento e “invisibilità” delle “controparti” e dei centri reali del potere dalla vita quotidiana dei cittadini); c) in conseguenza dei processi di globalizzazione e di riequilibrio della popolazione planetaria, la crescente presenza di gruppi immigrati facilmente identificabili come “diversi” non solo e non tanto per le fattezze somatiche quanto per abitudini, modi di vita e di costume, possibilità di comunicazione: sarebbe un grave errore sottovalutare le difficoltà “etnocentriche” nei rapporti interindividuali quando viene a mancare il grande fattore di semplificazione relazionale costituito dalla pratica di una comune cultura; d) così, sempre in rapporto ai processi di globalizzazione e ai loro contraccolpi localistici, il possibile rinchiudersi di intere fasce di popolazione dentro ai miti di una identità e di una tradizione comunitaria come cosa da difendere e salvare, a fronte di una progressiva presenza di “alterità” e della evidente caduta di tutte le convenzioni e di tutte le certezze; e) infine, gli stati di incertezza, di frustrazione, la paura di perdere quanto già conquistato e il vanificarsi delle stesse speranze di un futuro migliore, in conseguenza della gravissima crisi economica e socio-politica che stiamo vivendo: la quale acuisce peraltro tutte le altre contraddizioni. Si tratta, penso, di fattori abbastanza pesanti e significativi: una situazione nella quale il rafforzarsi e il diffondersi di stereotipi e pregiudizi, la ricerca di facili capri espiatori e anche le tentazioni di affidarsi a un qualche “potere forte” (che certo non mancherà di manifestarsi), non sono assolutamente da sottovalutare. Su questi ultimi temi credo sia op-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
302
Shoah, modernità e male politico
portuno concentrare la nostra riflessione e una discussione collettiva, ricordando quanto è stato già anticipato poco dopo la fine del nazismo da uno dei più grandi scrittori del XX secolo: E voi imparate che occorre vedere e non [solo] guardare in aria, occorre agire e non [solo] parlare. Questo mostro stava, una volta, per governare il mondo! I popoli lo spensero ma ora non cantiamo vittoria troppo presto: il grembo da cui nacque è ancor fecondo2.
2
Cfr. Bertolt Brecht, La resistibile ascesa di Arturo Ui, 1941-56, Epilogo.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
303
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
ENRICO DONAGGIO
SPREMERE I CERVELLI, ACCAREZZARE I CUORI La Shoah a scuola
1. Un giorno questo dolore vi sarà utile Ogni insegnante ha probabilmente sperimentato almeno una volta la sensazione agra, intrisa di un impreciso retrogusto di sconforto e fallimento, che si sprigiona quando, durante una lezione o una discussione con un gruppo di adolescenti, si affrontano temi di capitale rilevanza (per chi siede in cattedra), ma così scabri e dolenti da eccedere la normale capacità di assimilazione da parte di quei giovani. I loro sguardi improvvisamente si spengono, i cuori si chiudono. Capaci sino a poco prima di appassionarsi intorno a ragionamenti complessi, si fanno refrattari o assenti; come schiantati contro un muro, rimbalzano indietro, verso oasi di infantilismo, compensatorie e artificiali quanto basta per riprendere fiato e speranza. In quei frangenti si “perde” la classe non per le consuete ragioni di cui qualsiasi docente si lamenta ogni giorno: altissima volatilità della capacità di concentrazione, concorrenza con gadget elettronici ben più seduttivi di consumati insegnanti, tedio criminale del programma e di chi lo somministra. Lo scollamento, l’andare fuori sintonia di professore e studenti, ha qui luogo per un altro motivo. L’avere varcato – in parte per la natura dell’argomento, in parte per il modo di trattarlo – una linea di confine che qualsiasi adulto con responsabilità formativa dovrebbe sapere individuare e rispettare, pur non condividendola necessariamente: i margini di quel terreno, calpestando il quale si fa strage – con gli impari mezzi che il disincanto della maggiore età non manca purtroppo di fornire – dei sogni e delle illusioni su se stessi, gli altri e il mondo che qualunque ragazzo ha il sacrosanto diritto di nutrire. Lo sganciamento tra chi, almeno in teoria, avrebbe qualcosa da insegnare e chi, sempre in teoria, qualcosa da imparare, avviene dunque qui per lo scontro – frontale quanto infecondo – tra accanimento e insensibilità (il più delle volte con le migliori intenzioni), da un lato, e vulnerabilità, con i meccanismi di difesa che questa attiva, dall’altro. Uno dei tanti casi in cui
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
304
Shoah, modernità e male politico
delle acquisizioni importanti mancano l’incontro con il materiale umano che da esse potrebbe trarre un qualche beneficio. La Shoah può facilmente essere uno di questi. Discutere di Shoah a scuola o, esempio ancora più impegnativo, accompagnare una classe in uno dei tanti viaggi della memoria verso un campo di sterminio, non è una scelta facile né leggera. Significa – sia detto con tutta l’enfasi possibile – accettare l’eventualità di essere colui che, con probabilità minima ma non nulla, porrà forse per la prima volta quei ragazzi a contatto con fatti, pensieri, possibilità dell’umano orribili e sconvolgenti: illustrando loro nei dettagli il progetto dell’Aktion T4 o della Soluzione finale, soppesando le implicazioni morali del comportamento di vittime, carnefici e spettatori, camminando insieme tra i resti di una camera a gas nel gelo di Polonia. Propositi, congetture, esperienze da cui qualunque individuo sano di mente e che abbia mediamente cara la propria felicità, potendo scegliere, si terrebbe alla larga. Con eccellenti ragioni e, auspicabilmente, per una vita intera. Decidere che tutto questo valga la pena, che meriti di essere affrontato, significa assumersi la responsabilità, al tempo stesso pedagogica, politica e umana, di promettere almeno implicitamente a quei ragazzi: “un giorno questo dolore vi sarà utile” (per fare il verso al bel titolo di un brutto romanzo). Cercare, insomma, di trarre il meglio possibile dalle scoperte estreme e difficili da maneggiare che questa esposizione alla sofferenza, altrui e propria, trasmette. Rispettando al contempo – pena la perdita del partner e del destinatario di questa esperienza in comune – la frontiera che protegge il territorio, in estensione parossistica quanto patologica negli ultimi decenni, della fragilità giovanile. Un ambito di sensibilità su cui un impatto non sorvegliato della costellazione di problemi che ruota intorno allo sterminio nazista può produrre una gamma di effetti indesiderabili: dall’orrore sensazionalistico o affascinato sino all’ordinaria noia scolastica. Cosa può dunque indurre e giustificare una simile decisione in un docente fornito delle migliori intenzioni? La retorica ufficiale in materia – quella della storia maestra di vita e del cattivo passato che non deve ritornare – fornisce argomenti e motivazioni evidenti soltanto dal suo punto di vista. Che alimentano una modalità di gestione e manutenzione della memoria della Shoah che isterilisce molto facilmente nelle forme del rituale, della liturgia politica e civile, della ricorrenza per tutti e per nessuno che, con cadenza regolare, deve essere celebrata a ogni costo, benché con slancio e fantasia sempre minori. Difficoltà a cui l’esperienza, spesso effettivamente eccezionale, dell’ascolto della testimonianza diretta degli scampati ai Lager ha finora posto un provvisorio rimedio. Ma che, con l’uscita di scena
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
E. Donaggio - Spremere i cervelli, accarezzare i cuori
305
ormai imminente degli ultimi salvati, non potrà essere aggirata ancora a lungo. Un nuovo radicamento, in primis di senso, da parte di chi assume su di sé la decisione, onerosa e non obbligatoria, di elaborare, non soltanto in proprio bensì anche insieme a dei giovani, quel che resta della Shoah, sembra dunque necessario e urgente. 2. Impossibile indifferenza Da dove cominciare dunque? Dal punto scoperto, dal terreno più lontano da quello su cui abitualmente si colloca e mantiene il discorso ufficiale in materia, che assume il coinvolgimento personale in questa vicenda – non diversamente da qualsiasi discorso religioso, confessionale o laico poco importa – come un obbligo, un dovere, un comandamento manifesto e inderogabile. Vale a dire dal più prossimo, intimo e spesso meno scandagliato grumo di interrogativi che qualsiasi insegnante dovrebbe anzitutto porsi nel momento in cui riflette se affrontare o meno un compito simile: chi me lo fa fare? Come mai per me ne vale la pena? Perché ritengo che quel dolore un giorno mi sia stato o mi sarà utile. Gli stessi quesiti, o meglio, lo stesso patto di onestà esistenziale e formativa che andrebbe stretto con gli studenti, va insomma prima di tutto siglato in privato. Diventando così, almeno secondo Pier Paolo Pasolini o Heiner Müller, quel che un vero intellettuale dovrebbe essere: la cavia di un esperimento rischioso e appassionante condotto su se stessi. In questo specifico caso, un test per vagliare il personale rapporto con il male politico e sociale che ci circonda e di cui la Shoah rappresenta a tutt’oggi il non plus ultra; la manifestazione suprema, e dunque il termine di raffronto più insidioso, ma potenzialmente più ricco di insegnamenti. Se è infatti vero – come viene ricordato a ogni Giorno della memoria – che la Shoah rappresenta il crimine più nefasto di cui si sia macchiato il genere umano, allora il confronto con questo “male assoluto” dovrebbe effettivamente costituire per ciascuno di noi qualcosa di straordinario ed eccezionale. Un’esperienza da cui un qualche tipo di luce dovrebbe poi ricadere sulla modalità più diffusa con la quale la maggior parte degli individui, nella maggior parte dei frangenti, si relaziona al male politico e sociale di cui è intessuta la nostra quotidianità: una enigmatica e arcana forma di indifferenza. Disposizione d’animo praticata e patita da ciascuno, l’indifferenza possiede una natura quanto mai ambigua e promette di schiudere, a chi sia in grado di fornirne una descrizione plausibile, una via d’accesso intrigan-
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
306
Shoah, modernità e male politico
te alla complessità del male politico-sociale e delle sue implicazioni. Nel corso dei secoli questa passione schiva è stata ritenuta fortuna o vizio, il coronamento di una saggezza oltreumana o la chiusura in un orizzonte di subumana grettezza. Una discrepanza di giudizi che riflette, tra l’altro, le oscillazioni storiche di un’economia del turbamento: la mutata valutazione, con l’andar del tempo, del potere che gli uomini hanno di incidere sulle cose che angustiano, di alterarne il coefficiente di scandalo e inevitabilità. Non è sensato, infatti, darsi tormento per ciò su cui è vano interferire. Ma non è tanto una decifrazione o una genealogia di questa passione capitale per la comprensione del male politico e sociale a essere qui in gioco. Quanto la nostra impossibilità di attivarla sempre e comunque, come invece vorrebbe il senso comune psicologico e sociologico oggi più accreditato in materia. Che ci dipinge sempre più, con le tinte spente e finali di un cliché, come individui inerti e insensibili, anestetizzati e indenni di fronte al nostro e all’altrui dolore. Non riuscire a essere indifferenti almeno al cospetto della Shoah, e del devastante portato di malvagità politico-sociale di cui trabocca, smentisce infatti la pretesa totalizzante di questa diagnosi epocale. E costituisce al contempo un grado zero di esperienza, una base di senso e una fonte di motivazione, fragile e preziosa, per chi decide di affrontare questo tema dapprima da sé, poi, magari, insieme ad altri, in particolare a dei giovani. Una sorta di caso limite da cui, attraverso una serie di passaggi intermedi, è lecito indagare e riconsiderare forme di manifestazione meno estreme e più sfumate di quel medesimo fenomeno. Questa impossibile indifferenza va però interrogata, chiedendo a se stessi – e successivamente a coloro con cui si decida eventualmente di discuterne – perché il male di quegli estranei ormai lontani (nello spazio e nel tempo) non vuol saperne di passare, ma seguita invece a turbare e a cagionare patimento. Occorre far risuonare in se stessi – in modo assolutamente non enfatico o retorico – quesiti elementari quanto insolubili. Come schegge di pietra, si configgono in chi soffre per una sventura remota che – sotto un’infinità di punti di vista – non lo dovrebbe riguardare affatto: perché quei bambini sui treni? Perché quasi tutti stanno a guardare? Cosa spinge a obbedire a leggi, ordini e poteri che si sanno criminali? E cosa avrei fatto io in quel frangente? Queste domande sono ferite che non si cicatrizzano, linee di minor resistenza lungo cui la sofferenza altrui s’insinua al pari dell’acqua nelle fessure, squarci nella blindatura che tiene a distanza dalla quota di dolore superfluo, evitabile, che la storia e la politica immancabilmente producono. Patire per questi interrogativi – una versione in minore della sindrome di Filottete – può essere ritenuta, non soltanto per amore del paradosso, se
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
E. Donaggio - Spremere i cervelli, accarezzare i cuori
307
non una fortuna, almeno una chance da cogliere. A patto di escogitare strategie non solitarie, né estreme o compiaciute, di trattamento. Discutere in un certo modo di Shoah a scuola può essere una di queste. 3. A giusta distanza Cosa ne facciamo della vulnerabilità davanti a ciò che, almeno in teoria, non dovrebbe toccarci né procurarci pena? Questo l’interrogativo che un’autoriflessione sincera sulle ragioni che spingono a condividere e a elaborare con altri la memoria della Shoah – di quel male estraneo ed estremo – ci consegna. La scuola, purtroppo, sembra tra i luoghi meno adatti per affrontarlo. Rischia infatti sempre più di trasformarsi in generatore e accumulatore di passioni tristi, equamente ripartite tra insegnanti e studenti; un luogo in cui, malgrado l’impegno commovente spesso profuso da chi la frequenta, la curiosità e le emozioni che si sprigionano a contatto con interrogativi, scoperte, problemi (la cosiddetta “cultura”) vengono per lo più mortificate. Ma la scuola resta pur sempre il luogo principale in cui, magari proprio intorno al motivo della Shoah, due vulnerabilità distinte (e che tali devono rimanere) possono trovare un significativo momento di confronto. Quella di chi insegna, intesa come una dei moventi di senso meno retorici e superficiali, più effettivamente radicati in chi sceglie di assumersi questa responsabilità. E quella di chi apprende, di cui danno prova sia le reazioni descritte nelle prime righe di questo testo – l’eccesso di presa e di invasività che un certo modo di porgere e maneggiare il tema può generare in molti giovani – sia, per converso, la noia o l’indifferenza manifestate, non del tutto a torto, da altri studenti in occasione delle celebrazioni più paludate e meno vitali di quella ricorrenza. Per tentare una prima uscita da questa impasse – la scuola come luogo principale e, al contempo, tra i meno adeguati per trattare la Shoah – pare necessaria una strategia della giusta distanza tra due atteggiamenti. O meglio, tra due imperativi, in cui si potrebbero cristallizzare, per usare un’immagine sufficientemente banale, il polo freddo e il polo caldo di questo modo di procedere: “spremere i cervelli”, “accarezzare i cuori”. Dalla loro giustapposizione risulta anzitutto una linea di condotta ispirata all’individuazione di un confine o, se si preferisce, di un punto di equilibrio dinamico tra istanze confliggenti e non facili da conciliare. Per le ragioni illustrate finora, la Shoah può risultare un tema che rischia di non dare tregua né scampo a chi decida di affrontarlo. Anzitutto per la difficoltà
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
308
Shoah, modernità e male politico
di pattuire nei suoi riguardi un limite onesto e sensato, perimetrando un terreno che sfugga all’alternativa – in ultima istanza a somma zero – tra un atteggiamento esclusivamente “caldo” e uno soltanto “freddo”: tra sprofondamento e leggerezza, ossessione e diniego, emotività parossistica e distacco artificiale. Tra una sensibilità che riconosce che è avvenuto qualcosa di enorme e irreparabile, degno di assillo accanito. E un gusto di vivere che implora invece misura, per non marchiare con stigma nefasto tutto quel che presenta comunque un volto e un’origine umani. Tenere lo sguardo fisso sull’orrore, infatti, non rende migliori, semmai più inerti o perversi. Distoglierlo anzitempo, addirittura preventivamente, regala innocenze di corto respiro. La saggezza che potrebbe ispirare una strategia per affrontare la Shoah a scuola dovrebbe sfuggire alla strettoia di questa alternativa, procedendo secondo le movenze e i ritmi del transito. Non disertare sulla soglia del male, né restarne però irretiti. Prediligere l’attraversamento, di sé e di quei territori devastati dalla patologia politico-sociale: un antidoto contro la morbosità, greve o beata, che talvolta corrompe l’accostarsi a questo fenomeno; così come contro una religione civile officiata in modo troppo ingenuo e fiducioso, che talvolta rischia di banalizzarlo o disinnescarlo. Una congerie di problemi e dilemmi di cui la scuola sembra in fondo poco curarsi, sicura come si mostra del fatto che la storia – forse la più avvilita e avvilente delle discipline oggi amministrate tra le sue mura – rappresenti la via maestra, spesso la sola, per affrontare il tema della Shoah. In piena sintonia con l’ordine del discorso ufficiale sulla memoria di questo trauma, la scuola crede infatti ancora che il principale nemico da sconfiggere sia l’ignoranza. Ma da tempo le cose non stanno più così. Il problema infatti, anche in materia di Shoah, non è conoscere. Ma cosa farsene di quel che si sa. Un dilemma che si cristallizza nell’interrogativo: “come ricordare quel che spesso non si riesce neppure a immaginare?”. Un dubbio reso ancora più tagliente dalla scomparsa degli ultimi sopravvissuti allo sterminio nazista. Ora che la cura di un materiale così esplosivo passa nelle nostre mani. E i riti fin qui escogitati sembrano spegnersi nell’inadeguatezza. 4. Pensare, immaginare e sentire il male A differenza di quanto sostenuto e praticato finora, affrontando il tema della Shoah a scuola la storia deve arrivare dopo. Il bisogno di storia, sacrosanto e necessario, non va cioè saturato in anticipo e a freddo, in nome di un’erudizione bulimica e coatta. Ma deve giungere come risposta a un
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
E. Donaggio - Spremere i cervelli, accarezzare i cuori
309
bisogno, addirittura a una fame di storia, che un certo modo di trattare lo sterminio nazista – almeno questa è l’esperienza di chi scrive – finisce spesso per generare. All’inizio, quel che gli studenti già sanno a riguardo, avendolo appreso dalle fonti più disparate, risulta sufficiente (il che non esime, invece, da un interessante lavoro di verifica e rettifica su quanto di sbagliato – errato, pregiudiziale, ideologico, mitologico o fantascientifico – vi sia in quel che già conoscono). In modo complementare, anche l’atteggiamento dell’insegnante dovrebbe cercare di approssimarsi a quella figura che Jacques Rancière – in un libretto che andrebbe regalato in tutte le scuole d’Europa – definisce “il maestro ignorante”. Non il detentore esclusivo di un patrimonio di verità da elargire o inculcare, procedendo dall’alto verso il basso, in chi ne è privo. Ma un operatore, un facilitatore di emancipazione intellettuale in un orizzonte improntato, almeno in questo ambito, al più democratico dei postulati: l’uguaglianza delle intelligenze. Qualcuno che ha fatto un po’ più d’ordine, essendosi confrontato prima e in modo più intenso, in un groviglio di questioni e dilemmi che non ammettono soluzioni o risposte definitive, simili cioè a quelle che si possono fornire da soli. Di Shoah, insomma, si può discutere soltanto dialogando con gli altri e prestando ascolto alle loro parole su un piede di parità. Resta il problema cruciale di porsi le domande giuste, quelle che promettono di attivare in modo non schizofrenico o scisso, il momento caldo e quello freddo evocati nel paragrafo precedente. Sotto questo rispetto il materiale più promettente pare quello che consente, simultaneamente, di pensare, immaginare e sentire il male che la Shoah ha prodotto su tutte le figure che il male politico convoca sulla scena: vittime, carnefici, spettatori. Decifrando gli arcani capitali del totalitarismo: la disumanizzazione delle vittime, sino all’opacizzarsi della linea di demarcazione che le separa dai loro persecutori (la “zona grigia” scontornata ne I sommersi e i salvati); la banalità ordinaria e senza grandezza dei carnefici (incarnata in modo dubbio e discutibile nella ormai logora figura di Adolf Eichmann); l’inerte e attivissima indifferenza degli spettatori (il materiale umano rispetto al quale la distanza spazio-temporale che separa dalla Shoah pare maggiormente scemare). A mero titolo di esempio si possono citare le pagine di Primo Levi, Hannah Arendt, Gitta Sereny, Stanley Milgram, Zygmunt Bauman, Christopher Browning, per menzionare gli autori più noti di opere che posseggono felicemente i requisiti indicati. Senza ovviamente dimenticare il cinema, il teatro o la musica, con tutte le possibilità di “incorporazione” che regalano. Sarebbe riduttivo e arbitrario catalogare o confinare questo materiale nelle
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
310
Shoah, modernità e male politico
gabbie canoniche del genere o della disciplina: memorialistica, letteratura, filosofia, psicologia, sociologia. Più importante è il fatto che le domande che producono le risposte più stimolanti non si isolino qui nel deserto astratto della riflessione o si frammentino nel pulviscolo di percorsi biografici individuali. Ma conoscano, invece, un riverbero ad ampio spettro, andando a nutrire e arricchire una passione ragionata e sentita. Consentendo così di “spremere i cervelli”: di lanciarsi, cioè, sulle tracce degli indagatori più spregiudicati della Shoah, all’ostinata ricerca di un senso, di una ragione, di un perché (declinati auspicabilmente al plurale); malgrado venga sempre il giorno in cui questo impegno pare vano. Ma anche di “accarezzare i cuori”: dando prova della delicatezza e del tatto richiesti per porgere e affrontare insieme un tema che, per definizione, risulta vietato ai minori; capace cioè, per lo squarcio di orrore che apre su alcune possibilità dell’umano, di intaccare una fiducia nel gusto di vivere e nello stare al mondo insieme agli altri che, almeno nei giovani, andrebbe comunque serbata.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
311
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
OPERE CITATE
Avvertenza: il metodo di citazione utilizzato nel volume è quello autoredata, dove la data indica la prima edizione dell’opera. Quando nei riferimenti bibliografici di un’opera è indicata anche la traduzione, i numeri di pagina delle citazioni presenti nel volume si riferiscono sempre alla traduzione; in caso contrario, i numeri di pagina rinviano all’edizione originale indicata. Adorno, T.W. 1955 Kulturkritik und Gesellschaft, in Id., Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt a.M.; trad. it. Critica della cultura e società, in Id., Prismi. Saggi sulla critica della cultura, Einaudi, Torino 1972: 3-22. 1966 Negative Dialektik, Suhrkamp, Frankfurt a.M.; trad. it. Dialettica negativa, Einaudi, Torino 1975. Adorno, T.W et al. (a cura di) 1950 The Authoritarian Personality, Harper&Row, New York; trad. it. La personalità autoritaria, Edizioni di Comunità, Milano 1973. Agamben, G. 1995 Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino. Albrecht, R. 2007 “Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?” Adolf Hitlers Geheimrede am 22. August 1939, Shaker Verlag, Aachen. Alexander, J.C. 2003 On the Social Construction of Moral Universals. The “Holocaust” from War Crime to Trauma Drama, in Id., The Meanings of Social Life. A Cultural Sociology, Oxford University Press, Oxford; trad. it. La costruzione sociale degli universali morali: l’Olocausto da crimine di guerra a trauma culturale, in Id., La costruzione del male. Dall’Olocausto all’11 settembre, il Mulino, Bologna 2006: 27-127.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
312
Shoah, modernità e male politico
Allen, W.S. 1965 The Nazi Seizure of Power. Experience of a Single German Town 19301935, Quadrangle Books, Chicago; trad. it. Come si diventa nazisti. Storia di una piccola città 1930-1935, Einaudi, Torino 1968. Alterman, A. 2006 Visage de Shoah le film de Claude Lanzmann, Cerf, Paris. Aly, G. 1988 The Economics of the Final Solution. A Case Study from the General Government, in «Simon Wiesenthal Center Annual», 5: 3-48. 1993 Erwiderung auf Dan Diner, in «Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte», 41: 623-35. 2005 Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, Fischer, Frankfurt a.M.; trad. it. Lo stato sociale di Hitler. Rapina, guerra razziale e nazionalsocialismo, Einaudi, Torino 2007. Aly, G. – Heim, S. 1991 Vordenker der Vernichtung. Auschwitz und die deutsche Pläne fur die europaische Ordnung, Hoffmann und Campe, Hamburg. Améry, J. 1966 Jenseits von Schuld und Sühne: Bewältigungsversuche eines Überwältigten, Szczesny, München; trad. it. Intellettuale ad Auschwitz, Bollati Boringhieri, Torino 1987. Anders, G. 1964 Wir Eichmannsöhne, Verlag C.H. Beck, München; trad. it. Noi figli di Eichmann, Giuntina, Firenze 1995. Anderson, M.L. 2010 Who Still Talked about the Extermination of the Armenians: German Talk and German Silences, in R. Suny et al. (a cura di), A Question of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire, Oxford University Press, New York: 199-220. Arendt, H. 1951 The Origins of Totalitarianism, Schocken Books, New York; trad. it. Le origini del totalitarismo, Edizioni di Comunità, Torino 1999. 1963a Eichmann in Jerusalem. A Report On The Banality Of Evil, Viking Press, New York; trad. it. La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 2004. 1963b Briefwechsel Arendt-Scholem, in «Mitteilungsblatt», 33; trad. it. Lettera a Gershom Scholem, in Id., Ebraismo e modernità, Feltrinelli, Milano 1993: 221-28.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Opere citate
313
1965-66 Some Questions of Moral Philosophy, in Id., Responsibility and Judgement, Schocken Books, New York 2003: 49-146; trad. it. Alcune questioni di filosofia morale, Einaudi, Torino 2006. 1978 The Life of the Mind, Harcourt Bruce Jovanovich, New York; trad. it. La vita della mente, il Mulino, Bologna 1987. Ariès, P. et al. 1979 La politique hitlérienne d’extermination. Une declaration d’historiens, in «Le Monde», 21/02/1979. Augstein, R. (a cura di) 1987 Historikerstreit: die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, Piper, München. Avisar, I. 1988 Screening the Holocaust. Cinema’s Image of the Unimaginable, Indiana University Press, Bloomington. Badii, R. – Fabbri, E. 2011 Framing Our World, or: Reconsidering the Idea of Weltbild, in Id. (a cura di), Weltbilder and Philosophy, «Humana.Mente. Journal of Philosophical Studies», 18, ETS, Pisa: III-XXIX. Baldwin, P. (a cura di) 1990 Reworking the Past: Hitler, the Holocaust, and the Historians’ Debate, Beacon Press, Boston. Bankier, D. 1992 The Germans and the Final Solution. Public Opinion under Nazism, Blackwell, Oxford. Bartoszewski, W.T. 1991 The Convent at Auschwitz, George Braziller, New York. Bartov, O. 1985 The Eastern Front, 1941-45: German Troops and the Barbarisation of Warfare, Hampshire, Basingstoke / St. Antony’s College, Oxford; trad. it. Fronte orientale. Le truppe tedesche e l’imbarbarimento della guerra (1941-1945), il Mulino, Bologna 2003. 1991 Hitler’s Army. Soldiers, Nazis, and War in the Third Reich, Oxford University Press, New York. 2007 Erased: Vanishing Traces of Jewish Galicia in Present-Day Ukraine, Princeton University Press, Princeton. 2008 Eastern Europe as the Site of Genocide, in «The Journal of Modern History», 80, 3: 557-93.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
314
Shoah, modernità e male politico
Bartov, O. – Grossman, A. – Nolan, M. (a cura di) 2002 Crimes of War: Guilt and Denial in the Twentieth Century, New Press, New York. Bauer, Y. 2000 Speech at the Ceremonial Opening of the Stockholm International Forum, disponibile online all’indirizzo: http://www.d.dccam.org/Projects/Affinity/ SIF/DATA/2000/page898.html (17/10/2013). Bauman, Z. 1989 Modernity and the Holocaust, Cornell University Press, Ithaca; trad. it. Modernità e Olocausto, il Mulino, 1992. Beattie, A.H. 2008 Playing Politics with History: The Bundestag Inquiries into East Germany, Berghahn Books, New York. Belliti, D. 2012 Io che sono uno solo. Giudicare il male dopo Eichmann, ETS, Pisa. Bencini, C. 1999 “Il Bargello” di Firenze e “Il Ferruccio” di Pistoia, in E. Collotti (a cura di), Razza e fascismo. La persecuzione contro gli ebrei in Toscana (19381943), Carocci, Roma: 293-312. Benjamin, W. 1940 Über den Begriff der Geschichte, in Id., Gesammelte Werke, vol. I/2, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1991: 690-708; trad. it. Tesi di filosofia della storia, in Id., Angelus Novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino 1982: 75-86. Berg, N. 2003 Der Holocaust und die westdeutschen Historiker. Erforschung und Erinnerung, Wallstein, Göttingen. Bernstein, R.J. 2002 Radical Evil. A Philosophical Interrogation, Policy, Cambridge. Billig, M. 1999 Freudian Repression. Conversation Creating the Unconscious, Cambridge University Press, Cambridge; trad. it. L’inconscio freudiano. Una rilettura del concetto di rimozione, Utet, Torino 2000. Blackbourn, D. – Eley, G. (a cura di) 1984 The Peculiarities of German History. Bourgeois Society and Politics in Nineteenth-Century Germany, Oxford University Press, Oxford.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Opere citate
315
Bloxham, D. 2009 The Final Solution: A Genocide, Oxford University Press, New York; trad. it. Lo sterminio degli ebrei. Un genocidio, Einaudi, Torino 2010. Blumenberg, H. 1960 Paradigmen zu einer Metaphorologie, Suhrkamp, Frankfurt a.M.; trad. it. Paradigmi per una metaforologia, Raffaello Cortina, Milano 2009. 1961 Weltbilder und Weltmodelle, in «Nachrichten der Giessener Hochschulgesellschaft», 30: 67-75; trad. it. Immagini del mondo e modelli del mondo, in «Discipline filosofiche», 11, 1: 13-23. 1966 Die Legitimität der Neuzeit, Suhrkamp, Frankurt a.M.; trad. it. La legittimità dell’età moderna, Marietti, Genova 1992. Borges, J.L. 1949 Deutsches Requiem, in Id., El Aleph, Losada, Buenos Aires; trad. it. Deutsches Requiem, in Id., Tutte le opere, vol. I, Mondadori, Milano 1984. Borri, G. 1992 Le divine impurità. Primo Levi tra scienza e letteratura, Luisè, Rimini. Brenner, A.D. 2001 Emil J.Gumbel, Weimar German Pacifist and Professor, Brill, Boston. Brizzi, G.P. 2002 Bologna 1938: Silence and Remembering. The Racial Laws and the Foreign Jewish Students at the University of Bologna, Clueb, Bologna. Broszat, M. 1961 Nationalsozialistische Polenpolitik, 1939-1945, Deutsch Verlags-Anstalt, Stuttgart. 1969 Der Staat Hitlers: Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfassung, Deutscher Taschenbuch Verlag, München. 1970 Soziale Motivation und Führer-Bindung im Nationalsozialismus, in «Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte», 18: 392-409. Brown, J. 1851 Union Is Strenght, in W.E.B. Du Bois, John Brown, Jacobs&Company, Philadelphia: 246-49; trad. it. L’unione fa la forza, in Id., La schiavitù è uno stato di guerra, Il Saggiatore, Milano 1962: 43-7. Browning, C.R. 1992 Ordinary Men. Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland, Harper Collins, New York; trad. it. Uomini comuni. Polizia tedesca e «soluzione finale» in Polonia, Einaudi, Torino 1995. 2003 Perpetrator Testimony: Another Look at Adolf Eichmann, in Id., Collected Memories: Holocaust History and Postwar Testimony, The University of Wisconsin Press, Madison: 3-36.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
316
Shoah, modernità e male politico
Browning, C.R. – Matthäus, J. 2004 The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939-March 1942, University of Nebraska Press, Lincoln / Yad Vashem, Jerusalem; trad. it. Le origini della Soluzione finale. L’evoluzione della politica antiebraica del nazismo. Settembre 1939-marzo 1942, Il Saggiatore, Milano 2012. Bullock, A. 1952 Hitler: A Study in Tyranny, Harper, New York; trad. it. Hitler. Studio sulla tirannide, Mondadori, Milano 1965. Bundesminister der Justiz (a cura di) 1989 Im Namen des Deutschen Volkes. Justiz und Nationalsozialismus. Katalog zur Ausstellung des Bundesministers der Justiz, Wissenschaft und Politik, Köln. Burgio, A. 2010 Nonostante Auschwitz. Il «ritorno» del razzismo in Europa, DeriveApprodi, Roma. 2012 Il nazismo come malattia dell’«anima tedesca», in «Psicoterapia e Scienze Umane», 46/2: 187-209. 2013a Acconsentire allo sterminio. Per un’indagine sui motivi del consenso di massa ai crimini nazisti, in A. Burgio – A. Zamperini (a cura di), Identità del male. La costruzione della violenza perfetta, Franco Angeli, Milano: 21-54. 2013b Arendt, Jaspers e i «massacri amministrativi», in «Dianoia», XVIII: 67102. 2014 Dire il vero mentendo. Sulla memorialistica dei carnefici, in corso di pubblicazione negli atti del Convegno “Storia e memoria. Raccontarsi e raccontare il passato” (Trieste, 8-10 maggio 2013), a cura del Laboratorio della Memoria della Provincia di Trieste. Burleigh, M. – Wippermann, W. 1991 The Racial State. Germany 1933-1945, Cambridge University Press, Cambridge; trad. it. Lo Stato razziale. Germania 1933-1945, Rizzoli, Milano 1992. Capozza, D. – Volpato, C. 2004 Le intuizioni psicosociali di Hitler. Un’analisi del Mein Kampf, Pàtron, Bologna. Cases, C. 1963 I tedeschi e lo spirito francese, in Id., Saggi e note di letteratura tedesca, Einaudi, Torino: 5-58.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Opere citate
317
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Cavaglion, A. (a cura di) 2007 Dal buio del sottosuolo. Poesia e Lager, Franco Angeli, Milano. Cavarocchi, F. 2000 La propaganda razzista e antisemita di uno “scienziato” fascista. Il caso di Lidio Cipriani, in «Italia Contemporanea», 219: 193-225. Cavarocchi, F. – Minerbi, A. 1999 Politica razziale e persecuzione antiebraica nell’ateneo fiorentino, in Razza e fascismo, in E. Collotti (a cura di), Razza e fascismo. La persecuzione contro gli ebrei in Toscana (1938-1943), Carocci, Roma: 467-510. Celan, P. 1948 Todesfuge, in Id., Der Sand aus den Urnen, A. Sexl, Wien; trad. it. Fuga di morte, in Id., Poesie, Mondadori, Milano 1998. 1958 Kurzer Text über seine dichterische Arbeit, in «Almanach der Libraire Flinker»; trad. it. Risposta a un‘inchiesta della libreria Flinker, in Id., La verità della poesia, Einaudi, Torino 1993. 1961 Der Meridian, Fischer, Frankfurt a.M.; trad. it. Il Meridiano, in Id., La verità della poesia, Einaudi, Torino 1993. Césaire, A. 1950 Discours sur le colonialisme, Réclame, Paris; trad. it. Discorso sul colonialismo, Lilith, Roma 1999. Chalk, F. – Jonassohn, K. 1990 The History and Sociology of Genocide. Analysis and Case Studies, Yale University Press, New Haven. Chang, I. 1997 The Rape of Nanking. The Forgotten Holocaust of World War II, Basic Books, New York; trad. it. Lo stupro di Nanchino. L’Olocausto dimenticato della Seconda guerra mondiale, Corbaccio, Milano 2000. Chaumont, J.-M. 1997 La concurrence des victimes. Génocide, identité, reconnaissance, La Découverte, Paris. Chickering, R. – Förster, S. (a cura di) 2000 Great War, Total War: Combat and Mobilization on the Western Front, 1914-1918, German Historical Institute, Washington DC / Cambridge University Press, Cambridge. Chickering, R. – Förster, S. – Greiner B. (a cura di) 2005 A world at Total War: Global Conflict and the Politics of Destruction, 19371945, German Historical Institute, Washington DC / Cambridge University Press, Cambridge.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
318
Shoah, modernità e male politico
Cocks, G. 1985 Psychotherapy in the Third Reich. The Göring Institute, Oxford University Press, New York; trad. it. Psicoterapia nel Terzo Reich. L’Istituto Göring, Bollati Boringhieri, Torino 1988. Cohen, A. 1981 The Tremendum. A Theological Interpretation of the Holocaust, Crossroad, New York; trad. it. Il Tremendum. Un’interpretazione teologica dell’Olocausto, Morcelliana, Brescia 2012. Collotti, E. 2012 Quanto lontana è l’Ungheria?, in «Passato e Presente», XXX, 86: 7-14. Collotti, E. (con la collaborazione di N. Labanca e T. Sala) 2000 Fascismo e politica di potenza. Politica estera 1922-1939, La Nuova Italia, Firenze. Conquest, R. 1990 The Great Terror: A Reassessment, Oxford University Press, New York; trad. it. Il grande terrore, Rizzoli, Milano 1999. Cruzzolin, R. 2009 L’istituzione del giorno della memoria in Italia, in RI.LE.S (a cura di), Rammemorare la Shoah. 27 gennaio e identità europea, Rubettino, Sovenia Mannelli: 89-102. Cywiński, P. 2011 Auschwitz, site mémoriel au XXIe siècle: réalités, enjeux, questions, in «Les Cahiers Irice», 7: 9-25. Dagrada, E. 2005 La giustezza è il fardello di chi viene dopo. A proposito di “Shoah” di Claude Lanzmann, in A. Costazza (a cura di), Rappresentare la Shoah, Cisalpino, Milano: 509-26. Dahrendorf, R. 1965 Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, Piper, München; trad. it. Sociologia della Germania contemporanea, Il Saggiatore, Milano 1968. Dallin, A. 1957 German Rule in Russia 1941-1945: A Study of Occupation Policies, Macmillan, London. D’Andrea, D. 2005 L’incubo degli ultimi uomini. Etica e politica in Max Weber, Carocci, Roma. 2009 Tra adattamento e rifiuto. Verso una teoria delle immagini del mondo, in «Quaderni di teoria sociale», 9: 17-49.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Opere citate
319
2013 Il Grande Inquisitore di Max Weber. La politica come etica alla prova del mondo, in R. Badii – E. Fabbri (a cura di), Il Grande Inquisitore. Attualità e ricezione di una metafora assoluta, Mimesis, Milano: 93-103. D’Andrea, D. – Badii, R. 2010 Introduzione, in Id. (a cura di), Sterminio e stermini. Shoah e violenze di massa nel Novecento, il Mulino, Bologna: 23-62. De Felice, R. 1987-88 Perché deve cadere la retorica dell’antifascismo, intervista rilasciata a G. Ferrara, in «Il Corriere della Sera», 27/12/1987 e 08/01/1988; ripubblicato in F. Focardi, La guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi, Laterza, Roma-Bari 2005: 252-58. Dei, F. 2013 Spettri del biopotere, in F. Bachis – A. Pusceddu (a cura di), Storie di questo mondo, CISU, Roma. Delage, C. 2006 La Vérité par l’image. De Nuremberg au procès Milosevic, Denoel, Paris. Del Boca, A. 1976-82 Gli italiani in Africa orientale, 3 voll., Laterza, Roma-Bari. 1986 Gli italiani in Libia, 2 voll., Laterza, Roma-Bari. 1996 I gas di Mussolini: il fascismo e la guerra d’Etiopia, con contributi di G. Rochat, F. Pedriali, R. Gentilli, Editori Riuniti, Roma. Delfour, J.J. 2000 La pellicole maudite. Sur la figuration du réel de la Shoah: le débat entre Semprún et Lanzmann, in «L’Arche», 508. Dennison, S. – Lim, S.H. 2006 Remapping Word Cinema: Identity, Culture and Politics in Film, Wallflower Press, London-New York. Desideri, F. 2008 Il Meridiano e la croce della poesia, in M. Baldi – F. Desideri (a cura di), Paul Celan. La poesia come frontiera filosofica, Firenze University Press, Firenze: 69-76. Diamond, J. 1997 Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies, Norton, New York; trad. it. Armi acciaio e malattie, Einaudi, Torino 2006. Dickenson, E.R. 2004 Biopolitics, Fascism, Democracy. Some Reflections on Our Discourse about ‘Modernity’, in «Central European History», 37/1: 1-48.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
320
Shoah, modernità e male politico
Didi-Huberman, G. 1995 Le Lieu Malgré tout, in «Vingtième Siecle», 46: 36-44. 2003 Images malgré tout, Minuit, Paris; trad. it. Immagini malgrado tutto, Raffaello Cortina, Milano 2005. Diner, D. 1999 Das Jahrhundert verstehen: eine universalhistorische Deutung, Luchterhand, München; trad. it. Raccontare il Novecento. Una storia politica, Garzanti, Milano 2000. 2000 Beyond the Conceivable. Studies on Germany, Nazism and the Holocaust, University of California Press, Berkeley. 2005 «Zivilisationsbruch»: la frattura di civiltà come epistemologia della Shoah, in M. Cattaruzza – M. Flores – S. Levis Sullam – E. Traverso (a cura di), Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo, vol. I, Utet, Torino: 17-43. Diner, D. (a cura di) 1988 Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz, Fischer, Frankfurt a.M. Donaggio, E. 2005 Che male c’è. Indifferenza e atrocità tra Auschwitz e i giorni nostri, L’ancora del Mediterraneo, Napoli. Dörner, K. 1988 Tödliches Mitleid: Zur Frage der Unerträglichkeit des Lebens, Hoddis, Gütersloh. Dubiel, H. 2003 The Remembrance of the Holocaust as a Catalyst for a Transnational Ethic?, in «New German Critique», 90: 59-70. Duranti, S. 1999 Gli organi del GUF: Arezzo, Grosseto, Pisa e Siena, in E. Collotti (a cura di), Razza e fascismo. La persecuzione contro gli ebrei in Toscana (1938-1943), Carocci, Roma: 367-414. 2006 La memoria pubblica del secondo conflitto mondiale: due mostre berlinesi, in «Passato e Presente», 67: 103-12. 2008 Lo spirito gregario. Storia dei GUF fra politica e propaganda (1930-1940), Donzelli, Roma. Ehmann, A. 1998 From Colonial Racism to Nazi Population Policy: The Role of the So-Called Mischlinge, in M. Berenbaum – A. Peck (a cura di), The Holocaust and History. The Known, the Unknown, the Disputed, and the Reexamined, Indiana University Press, Bloomington: 115-33.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Opere citate
321
Eilers, R. 1963 Die nationalsozialistische Schulpolitik. Eine Studie zur Funktion der Erziehung im totalitären Staat, Westdeutscher Verlag, Köln. Eley, G. 1986 What Produces Fascism. Pre-Industrial Traditions or a Crisis of the Capitalist State, in Id. (a cura di), From Unification to Nazism: Reinterpreting the German Past, Allen&Unwin, Boston: 254-82. Enzensberger, H.M. (a cura di) 1990 Europa in Trümmern. Augenzeugenberichte aus den Jahren 1944-1948, Eichborn, Frankfurt a.M. Erickson, J. 1975 The Road to Stalingrad, Weidenfeld and Nicolson, London. Fackenheim, E.L. 1982 To Mend the World. Foundations of Post-Holocaust Jewish Thought, Schocken Books, New York; trad. it. Tiqqun. Riparare il mondo, Medusa, Milano 2010. 1987 Holocaust, in «Contemporary Religious Thought»; trad. it. Olocausto, Morcelliana, Brescia 2011. Fein, H. 1993 Genocide. A Sociological Perspective, Sage, New York. Ferrari Zumbini, M. 2001 Le radici del male. L’antisemitismo in Germania da Bismarck a Hitler, il Mulino, Bologna. Fimiani, F. 2008 Pietre. Per Paul Celan, in M. Baldi – F. Desideri (a cura di), Paul Celan. La poesia come frontiera filosofica, Firenze University Press, Firenze: 77-96. Focardi, F. 2013 Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della Seconda guerra mondiale, Laterza, Roma-Bari. Fondane, B. 1938 Le mal des fantômes, in «Messages», I, 3: 82. Ford, G. (a cura di) 1992 Fascist Europe. The Rise of Racism and Xenophobia, Pluto, London. Förster, J. 1983 Das Unternehmen ‚Barbarossa‘ als Eroberungs- und Vernichtungskrieg, in H. Boog et al. (a cura di), Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg,
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
322
Shoah, modernità e male politico
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
vol. IV: Der Angriff auf die Sowjetunion, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart: 413-47. Forti, S. 2012 I nuovi demoni. Ripensare oggi male e potere, Feltrinelli, Milano. Fraenkel, E. 1968 Zur Soziologie der Klassenjustiz (1927) und Aufsätze zur Verfassungskrise 1931-32 mit einem Vorwort zum Neudruck, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. François, É. – Schulze, H. (a cura di) 2001 Deutsche Erinnerungsorte, 3 voll., Verlag C.H. Beck, München. Frank, H. 1953 Im Angesicht des Galgens, A. Beck Verlag, München. Frei, N. 1993 Wie modern war der Nationalsozialismus, in «Geschichte und Gesellschaft», 19: 367-87. 2001 Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 1933 bis 1945, Dtv, München; trad. it. Lo Stato nazista, Laterza, Roma-Bari 1992. Freud, A. 1936 Das Ich und die Abwehrmechanismen, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien. Freud, S. 1921 Massenpsychologie und Ich-Analyse, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien. Friedlander, H. 1995 The Origins of Nazi Genocide, University of North Carolina Press, Chapel Hill; trad. it. Le origini del genocidio nazista. Dall’eutanasia alla Soluzione finale, Editori Riuniti, Roma 1997. Friedländer, S. 1997 Nazi Germany and the Jews, vol. I, The Years of Persecution, 1933-1939, Harper&Collins, New York; trad. it. La Germania nazista e gli ebrei, vol. I, Gli anni della persecuzione, 1933-1939, Garzanti, Milano 2004. 2007 Den Holocaust beschreiben. Auf dem Weg zu einer integrierten Geschichte, Wallstein, Göttingen; trad. it. Aggressore e vittima. Per una storia integrata dell’Olocausto, Laterza, Roma-Bari 2009. Friedrich, C.J. – Brzezinski, Z.K. 1956 Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Harvard University Press, Cambridge (MA).
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Opere citate
323
Friedrich, J. 1983 Freispruch für die Nazi-Justiz. Die Urteile gegen NS-Richter seit 1948. Eine Dokumentation, Rowohlt, Reinbek. Fritzsche, P. 2008 Life and Death in the Third Reich, Harvard University Press, Cambridge (MA); trad. it. Vita e morte nel Terzo Reich, Laterza, Roma-Bari 2010. Fromm, E. 1941 Escape from Freedom, Rinehart, New York; trad. it. Fuga dalla libertà, Edizioni di Comunità, Milano 1963. Gadamer, H.G. 1986 Wer bin Ich und wer bist Du? Ein Kommentar zu Paul Celans Gedichtfolge “Atemkristall“, Suhrkamp, Frankfurt a.M.; trad. it. Chi sono io, chi sei tu. Su Paul Celan, Marietti, Genova 1989. Galimi, V. – Procacci, G. (a cura di) 2009 Per la difesa della razza. L’applicazione delle leggi antiebraiche nelle università italiane, Unicopli, Milano. Gallerano, N. 1999 Le verità della storia. Scritti sull’uso pubblico del passato, Manifesto Libri, Roma. Gellately, R. 2001 Backing Hitler. Consent and Coercion in Nazi Germany, Oxford University Press, Oxford; trad. it. Il popolo di Hitler, Longanesi, Milano 2002. Gerlach, C. 1999 Kalkulierte Morde: die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weissrussland 1941 bis 1944, Hamburger Edition, Hamburg. Geßner, K. 1995 Geheime Feldpolizei: die Gestapo der Wehrmacht, in H. Heer – K. Neumann (a cura di), Vernichtungskrieg: Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, Hamburger Edition, Hamburg: 343-58. Ginsberg, T. 2007 Holocaust Film. The Political Aesthetics of Ideology, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge. Giovanni Paolo II 2005 Memoria e identità, Rizzoli, Milano. Godard, J.-L. 1998 Intervista rilasciata a «Les Inrockutibles», 170, 21-27/10/1998.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
324
Shoah, modernità e male politico
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Goebbels, J. 1930 Das kleine ABC des Nationalsozialisten, Freyhoff, Bernau. Goisis, G. 2011 Hannah Arendt: il male politico tra orrore e banalità, in I. Adinolfi (a cura di), Dopo la Shoah. Un nuovo inizio per il pensiero, Carocci, Roma: 21130. Goldhagen, D.J. 1996 Hitler’s Willing Executioners. Ordinary Germans and the Holocaust, Alfred A. Knopf, New York; trad. it. I volenterosi carnefici di Hitler, Mondadori, Milano 1997. Grande, T. 2007 Memoria, storia e pratiche culturali, in E. Agazzi – V. Fortunati (a cura di), Memoria e saperi. Percorsi transdisciplinari, Meltemi, Roma. Grossman, D. 2000 La memoria della Shoah, Casagrande, Bellinzona. GUF Firenze 1938 Centro di Studi sulla Razza, Edizioni “Goliardia Fascista”, Firenze. Gumbel, E.J. 1921 Vier Jahre politischer Mord, Verlag der Neuen Gesellschaften, Berlin. Hamburg Institute for Social Research (a cura di) 1999 The German Army and Genocide: Crimes Against War Prisoners, Jews and Other Civilians in the East, 1939-1944, New Press, New York. Haney, C. – Banks, C. – Zimbardo, P. 1973 Interpersonal Dynamics in a Simulated Prison, in «International Journal of Criminology and Penology», 1: 69-97. Hansen, M.B. 1996 “Schindler’s Schindler’s List” is Not “Shoah”: Second Commandment, Popular Modernism, and Public Memory, in «Critical Inquiry», 22: 292-312. Hartmann, H. 1939 Ich-Psychologie und Anpassungsproblem, in «Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse und Imago», 24: 62-135. Heer, H. – Naumann, K. (a cura di) 2000 War of Extermination: The German Military in World War II, 1941-1944, Berghahn Books, New York.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Opere citate
325
Henne, T. 2001 Curt Staff zum 100. Geburtstag, in «Neue Juristische Wochenschrift», 54: 3030-31. Herf, J. 1984 Reactionary Modernism: Technology, Culture and Politics in Weimar and the Third Reich, Cambridge University Press, Cambridge; trad. it. Il modernismo reazionario. Tecnologia, cultura e politica nella Germania di Weimar e del Terzo Reich, il Mulino, Bologna 1988. Hesse, H. 2005 Konstruktionen der Unschuld. Die Entnazifizierung am Beispiel von Bremen und Bremerhaven 1945-1953, in Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen, vol. 67, Bremen. Higonnet, M.R. et al. (a cura di) 1987 Behind the Lines: Gender and the Two World Wars, Yale University Press, New Haven. Hilberg, R. 1992 Perpetrators, Victims, Bystanders. Jewish Catastrophe 1933-1945, Harper&Collins, New York; trad. it. Carnefici, vittime, spettatori. La persecuzione degli ebrei 1933-1945, Mondadori, Milano 1997. Hillgruber, A. 1965 Hitlers Strategie: Politik und Kriegführung, 1940-1941, Bernard&Graefe Verlag für Wehrwesen, Frankfurt a.M. Himka, J.-P. – Michlic, J.B. (a cura di) 2013 Bringing the Dark Past to Light: The Reception of the Holocaust in Postcommunist Europe, Nebraska University Press, Lincoln. Himmler, H. 1943 Rede auf der SS-Gruppenführertagung in Posen am 4. Oktober 1943, in Internationaler Militärgerichtshof, Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher, vol. 29, Delphin Verlag, Nürnberg 1948: 149 ss.; trad. ingl. Speech to the SS Officers. Posen, Oct. 4, 1943, in International Military Tribunal, Trial of the Major War Criminals (Nürnberg, 1947-49), vol. 29, pp. 110-73. Hinton, A.L. 1998 Why did the Nazis kill? Anthropology, Genocide and the Goldhagen Controversy, in «Anthropology Today», 5: 9-15. Hoffman, G. – Wiefing, H. 2012 “Unfassbar. Aber so war das“, in «Die Zeit», 26/04/2012: 18.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
326
Shoah, modernità e male politico
Hölderlin, F. 1804 Anmerkungen zum Ödipus, in Id., Theoretische Schriften, Meiner, Hamburg 1998: 94-9; trad. it. Note all’Edipo in P. Montani (a cura di), Antigone e la filosofia, Donzelli, Roma 2001: 101-05. Hull, I. 2005 Absolute Destruction: Military Culture and the Practices of War in Imperial Germany, Cornell University Press, Ithaca. Huyssen, A. 2000 Present Pasts: Media, Politics, Amnesia, in «Public Culture», 12, 1: 21-38. Illouz, E. 2003 Oprah Winfrey and the Glamour of Misery: An Essay on Popular Culture, Columbia University Press, New York. Insdorf, A. 1983 Indelible Shadows. Film and the Holocaust, Cambridge University Press, Cambridge. Isnenghi, M. (a cura di) 1996 I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita, Laterza, RomaBari. Jaisser, C. 2000 Poetische Zeugnisse. Gedichte aus dem Frauen-Konzentrationslager Ravensbrük 1939-1945, Metzler, Stuttgart. Jaspers, K. 1965 Die Schuldfrage, Piper, München; trad. it. La questione della colpa, Raffaello Cortina, Milano 1996. Jesi, F. 19952 Germania segreta. Miti nella cultura tedesca del ’900, Feltrinelli, Milano. Johnson, E.A. – Reuband, K.-H. 2005 What We Knew. Terror, Mass Murder, and Everyday Life in Nazi Germany - An Oral History, Basic Books, New York; trad. it. La Germania sapeva. Terrore, genocidio, vita quotidiana. Una storia orale, Mondadori, Milano 2008. Jonas, H. 1987 Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme, Suhrkamp, Frankfurt a.M.; trad. it. Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica, Il melangolo, Genova 2005. 1996 Mortality and Morality. A Search for the Good after Auschwitz, Northwestern University Press, Evanston.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Opere citate
327
Judt, T. 2005 Postwar. A History of Europe since 1945, Penguin Press, New York; trad. it. Dopoguerra. Come è cambiata l’Europa dal 1945 a oggi, Milano, Mondadori 2007. Kansteiner, W. 2006 In Pursuit of German Memory: History, Television, and Politics After Auschwitz, Ohio University Press, Athens. Kastner, K. 1997 Der Nürnberger Juristenprozess 1947, in «Juristische Arbeitsblätter»: 699706. Katzenelson, Y. 1963 Dos lid funem oysgehargetn yidishn folk, Ikuf, New York; trad. it. Il canto del popolo ebreo massacrato, La Giuntina, Firenze 1995. Kellner, F. 2011 “Vernebelt, verdunkelt sind alle Hirne”. Tagebücher 1939-1945, a cura di R.M.S. Kellner et al., Wallstein Verlag, Göttingen. Kempner, R.M.W. 1986 Ankläger einer Epoche, Ullstein, Frankfurt a.M. Kerényi, K. 1964 Dal mito genuino al mito “tecnicizzato”, in E. Castelli (a cura di), Tecnica e casistica. Tecnica, escatologia e casistica, (Atti del IV Colloquio internazionale sulla tematica della “demitizzazione”), Istituto di studi filosofici, Roma. Kershaw, I. 1989 The Nazi Dictatorship. Problems and Perspectives of Interpretation, Arnold, London. 1991 Hitler. A Profile in Power, Longman, London; trad. it. Hitler e l’enigma del consenso, Laterza, Roma-Bari 2008. 2009 Consensus, Coercion and Popular Opinion in the Third Reich: Some Reflections, in P. Corner (a cura di), Popular Opinion in Totalitarian Regimes, Oxford University Press, Oxford: 33-46. Klee, E. (a cura di) 1985 Dokumente zur “Euthanasie”, Fischer, Frankfurt a.M. Klein, T. 1991 L’affaire du carmel d’Auschwitz, Jacques Bertoin, Paris. Klemperer, V. 1995 «Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten». Tagebücher 1933-1945, Aufbau, Berlin; trad. it. Testimoniare fino all’ultimo. Diari 1933-1945, Mondadori, Milano 2000. www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
328
Shoah, modernità e male politico
Klüger, R. 1992 Weiter leben. Eine Jugend, Wallstein, Göttingen; trad. it. Vivere ancora, Einaudi, Torino 1995. Koch, G. 1989 The Aesthetic Transformation of the Image of the Unimaginable. Notes on Claude Lanzmann’s Shoah, in «October», 48: 15-24. Koonz, C. 2003 The Nazi Conscience, Harvard University Press, Cambridge (MA)-London. Koyré, A. 1945 The Political Function of Modern Lie, in «Contemporary Jewish Record», VIII, 3: 290-300. Knell, H. 2003 To Destroy a City. Strategic Bombing and Its Human Consequences in World War II, Da Capo Press, Cambridge (MA). Kramer, H. 1988 Lothar Kreyssig (1898-1986), Richter und Christ im Widerstand, in Kritische Justiz (a cura di), Streitbare Juristen. Eine andere Tradition, Nomos Verlag, Baden Baden: 342-54. Kren, G. – Rappoport, L. 1980 The Holocaust and the Crisis of Human Behavior, Holmes&Meier, New York. La Capra, D. 2007 Here There Is No Why, in S. Liebman (a cura di), Claude Lanzmann’s Shoah, Oxford University Press, Oxford-New York: 191-229. Langmuir, G. 1989 Prolegomena to Any Present Analysis of Hostility against the Jews, in M. Marrus (a cura di), The Nazi Holocaust, vol. II, Meckler, Westport: 133-71. 1990 History, Religion, and Antisemitism, University of California Press, Berkeley. Lanzmann, C. 1994 La représentation impossibile, in «Le Monde», 03/03/1994. La Rovere, L. 2003 Storia dei GUF. Organizzazione, politica e miti della gioventù universitaria fascista, Bollati Boringhieri, Torino.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Opere citate
329
Lawrence, B. 2005 Projecting the Holocaust into the Present: The Changing Focus of Contemporary Holocaust Cinema, Roman&Littlefield, New York. Lederer, E. 1940 The State of the Masses. The Threat of the Classless Society, Norton, New York; trad. it. Lo Stato delle masse. La minaccia della società senza classi, Bruno Mondadori, Milano 2004. Leonhard, J.F. 1983 Karl Jaspers in seiner Heidelberger Zeit, Heidelberger Bibliotheksschriften, Heidelberg. Levi, P. 1947 Se questo è un uomo, De Silva, Torino. 1963 La tregua, Einaudi, Torino. 1976 Appendice a Se questo è un uomo, in Id., Se questo è un uomo. La tregua, Einaudi, Torino 1989: 327:50. 1978 Presentazione a “Olocausto”, in Olocausto. Dalla realtà alla TV, numero speciale di «TV radiocorriere». Lévinas, E. 1976a Noms propres, Fata Morgana, Montpellier; trad. it. Nomi propri, Marietti, Casale Monferrato 1984. 1976b Difficile liberté, Albin Michel, Paris; trad. it. Difficile libertà, Jaca Book, Milano 2004. 1978 Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Martinus Nijhoff, Den Haag; trad. it. Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, Jaca Book, Milano 1983. 1987 Hors sujet, Fata Morgana, Montpellier; trad. it. Fuori dal soggetto, Marietti, Casale Monferrato 1992. 2009 Carnets de captivité et autres inédites, Bernard Grasset/Imec, Paris; trad. it. Quaderni di prigionia e altri inediti, Bompiani, Milano 2011. Levy, D. – Sznaider, N. 2001 Erinnerung im globalen Zeitalter. Der Holocaust, Suhrkamp, Frankfurt a.M. Lifshutz, R. 1943 Der hoyfzinger fun Varshever geto; trad. it. Il Cantastorie del ghetto di Varsavia, disponibile online all’indirizzo: http://specchi-e-riflessi.blogspot. it/2010/10/blog-post.html (13.11.2013). Lifton, R.J. 1986 The Nazi Doctors. Medical Killing and the Psychology of Genocide, Basic Books, New York; trad. it. I medici nazisti, Rizzoli, Milano 2002.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
330
Shoah, modernità e male politico
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Lindeperg, S. 2007 «Nuit et Brouillard». Un film dans l’Histoire, Odile Jacob, Paris. Littell, J. 2006 Les Bienveillantes, Gallimard, Paris; trad. it. Le benevole, Einaudi, Torino 2008. Longerich, P. 1998 Politik der Vernichtung: Eine Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen Judenverfolgung, Piper, München; trad. ingl. The Holocaust: The Nazi Persecution and Murder of the Jews, Oxford University Press, New York 2010. 2007 «Davon haben wir nichts gewusst!». Die Deutschen und die Judenverfolgung 1933-1945, Pantheon, München. Loshitzky, Y. (a cura di) 1997 Spielberg’s Holocaust. Critical Perspectives on Schindler’s List, Indiana University Press, Bloomington. Magris, C. 1997 Microcosmi, Garzanti, Milano. Maida, B. 2002 Educazione e scuola: verso il “nuovo tedesco”, in A. Deoriti – S. Paolucci – R. Ropa (a cura di), Germania pallida madre. Cultura tedesca e Weltanschauung nazista, L’orecchio di van Gogh, Chiaravalle: 281-96. Maier, C.S. 1988 The Unmasterable Past: History, Holocaust, and German National Identity, Harvard University Press, Cambridge (MA). Majer, D. 1981 «Fremdvölkische» im Dritten Reich. Ein Beitrag zur nationalsozialistischen Rechtssetzung und Rechtspraxis in Verwaltung und Justiz unter besonderer Berücksichtigung der eingegliederten Ostgebiete und des Generalgouvernements, in Schriften des Bundesarchivs, vol. 28, Boldt, Boppard a.R. Mandel’štam, O. 1930 Chetvertaia proza, in Id., Stikhotvoreniia Proza, Ripol Klassik, Moscow 2001: 411-26; trad. it. La quarta prosa, Editori Riuniti, Roma 1982. Mann, T. 1938 Achtung, Europa! Aufsätze zur Zeit, Bermann Fischer, Stockholm; trad. it. Attenzione, Europa!, in Id., Tutte le opere di Thomas Mann, vol. XI, Mondadori, Milano 1957: 273-88.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Opere citate
331
1945 Deutsche Hörer! 55 Radiosendungen nach Deutschland, Bermann Fischer, Stockholm; trad. it. Attenzione tedeschi! Cinquantacinque radiomessaggi alla Germania, in Id., Tutte le opere di Thomas Mann, vol. XI, Mondadori, Milano 1957. 1961 Ausgewählte Briefe, Fischer, Frankfurt a.M.; trad. it. Lettere, Mondadori, Milano 1986. Mayer, H. 1927 Gesetzliche Unfruchtbarmachung Geisteskranker, Herder, Freiburg. Mazower, M. 2008 Hitler’s Empire: How the Nazis Ruled Europe, Penguin, New York; trad. it. L’impero di Hitler. Come i nazisti governavano l’Europa occupata, Mondadori, Milano 2010. Mengaldo, P.V. 2007 Aspetti della letteratura della deportazione, in A. Cavaglion (a cura di), Dal buio del sottosuolo. Poesia e Lager, Franco Angeli, Milano: 11-28. Messerschmidt, M. 1969 Die Wehrmacht im NS-Staat: Zeit der Indoktrination, R. v. Decker, Hamburg. Milgram, S. 1974 Obedience to Authority. An Experimental View, Harper&Row, New York; trad. it. Obbedienza all’autorità, Einaudi, Torino 2003. Miller, A. 1990 Abbruch der Schweigemauer. Die Wahrheit der Fakten, Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg; trad. it. La fiducia tradita. Violenze e ipocrisie dell’educazione, Garzanti, Milano 1991. Minuz, A. 2010 La Shoah e la cultura visuale. Cinema, memoria, spazio pubblico, Bulzoni, Roma. Mirri, D. – Arieti, S. (a cura di) 2002 La cattedra negata. Dal giuramento di fedeltà al fascismo alle leggi razziali nell’Università di Bologna, Clueb, Bologna. Mitscherlich, A. – Mitscherlich, M. 1967 Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens, Piper, München; trad. it. Germania senza lutto. Psicoanalisi del postnazismo, Sansoni, Firenze 1970.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
332
Shoah, modernità e male politico
Mommsen, H. 1983 Die Realisierung des Utopischen: Die ‘Endlösung der Judenfrage’ im ‘Dritten Reich’, in «Geschichte und Gesellschaft», 9: 381-420. Money-Kyrle, R. 1941 The Psychology of Propaganda, in «British Journal of Medical Psychology», 19: 82-94; trad. it. La psicologia della propaganda, in P.F. Galli (a cura di), La propaganda. Scritti di Sigmund Freud, Elliott Jaques, Ernst Kris, Roger Money-Kyrle, Bollati Boringhieri, Torino 1995: 97-120. Montani, P. (a cura di) 2004 L’estetica contemporanea. Il destino delle arti nella tarda modernità, Carocci, Roma. Moore, B. 1966 Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Beacon Press, Boston; trad. it. Le origini sociali della dittatura e della democrazia. Proprietari e contadini nella formazione del mondo moderno, Einaudi, Torino 1979. Moses, A.D. 2004 The Holocaust and Genocide, in D. Stone (a cura di), The Historiography of the Holocaust, Palgrave-MacMillan, Basingstoke: 533-53. 2007 Conceptual Blockages and Definitional Dilemmas in the ‘Racial Century’: Genocides of Indigenous Peoples and the Holocaust, in A.D. Moses – D. Stone (a cura di) Colonialism and Genocide, Routledge, London. 2008 Empire, Colony, Genocide: Keywords and the Philosophy of History, in Id. (a cura di), Empire, Colony, Genocide. Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History, Berghahn Books, New York: 3-54. Müller, I. 1987 Furchtbare Juristen. Die unbewältigte Vergangenheit unserer Justiz, Kindler, München. Müller, K.-J. 1969 Das Heer und Hitler: Armee und nationalsozialistisches Regime 19331940, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart. Müller, R.-D. – Volkmann, H.-E. (a cura di) 1999 Die Wehrmacht: Mythos und Realität, Oldenbourg, München. Neiman, S. 2004 Evil in Modern Thought. An Alternative History of Philosophy, Princeton University Press, Princeton; trad. it. In cielo come in terra. Storia filosofica del male, Laterza, Roma-Bari 2011.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Opere citate
333
Niethammer, L. 1972 Die Mitläuferfabrik. Die Entnazifizierung am Beispiel Bayerns, Dietz, Bonn. Niv, K. 2003 Life is Beautiful, But Not for Jews. Another View of the Film by Benigni, The Scarecrow Press, Lanham-Oxford. Nora, P. 1984 Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux, in Id. (a cura di), Les lieux de mémoire. I: La République, Gallimard, Paris: XVII-XLII. Ostendorf, H. – ter Veen, H. 1985 Das Nürnberger Juristenurteil. Eine kommentierte Dokumentation, Campus, Frankfurt-New York. Oz, A. 2002 The Tubingen Lectures. Three Lectures; trad. it. Contro il fanatismo, Feltrinelli, Milano 2004. Parin, P. 1977 Das Ich und die Anpassungs-Mechanismen, in «Psyche», XXXI, 6: 481515; trad. it. L’Io e i meccanismi di adattamento, in «Psicoterapia e Scienze Umane», 40/3, 2006: 379-408. Paris, A. 2012 Trauma e sostituzione. Emmanuel Lévinas tra esperienza ed etica, Aracne, Roma. Parlamento Europeo 1985 Committee of Inquiry into the Rise of Fascism and Racism in Europe, Luxembourg. 1994 Risoluzione su razzismo, xenofobia e antisemitismo, OJ C 323/154, 20/11/1994. 1995 Risoluzione sulla giornata commemorativa dell’Olocausto, OJ C 166, 03/07/1995. 1996 Risoluzione su Auschwitz, OJ C 141, 13/05/1996. 2005a Risoluzione sulla memoria dell’Olocausto, l’antisemitismo e il razzismo, OJ C 253 E/37, 24/1/2005. 2005b Risoluzione sul sessantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, OJ C 92 E/392, 12/05/2005. 2009 Risoluzione su coscienza europea e totalitarismo, OJ C 137 E/25, 27/5/2010. Perels, J. 1999 Das juristische Erbe des “Dritten Reiches“. Beschädigungen der demokratischen Rechtsordnung, Campus, Frankfurt-New York.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
334
Shoah, modernità e male politico
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Perniola, I. 2007 L’immagine spezzata. Il cinema di Claude Lanzmann, Kaplan, Torino. Peschel-Gutzeit, M. (a cura di) 1996 Das Nürnberger Juristenurteil von 1947, Nomos Verlag, Baden-Baden. Peukert, D. 1982 Volksgenossen und Gemeinschaftsfremde. Anpassung, Ausmerze und Aufbegehren unter dem Nationalsozialismus, Bund-Verlag, Köln; trad. it. Storia sociale del Terzo Reich, Sansoni, Firenze 1989. 1987 Die Weimarer Republik: Krisenjahre der Klassischen Moderne, Suhrkamp, Frankfurt a.M.; trad. it. La Repubblica di Weimar. Anni di crisi della modernità classica, Bollati Boringhieri, Torino 1996. 1989 Die Genesis der ‚Endloesung‘ aus dem Geist der Wissenschaft, in Id. (a cura di), Max Webers Diagnose der Moderne, Vandenhoeck&Ruprecht, Goettingen: 102-21. Picart, C.J. (a cura di) 2004 The Holocaust Film Sourcebook, I, Fiction; II, Documentary and Propaganda, Praeger, Westport-London. Pinker, S. 2011 The Better Angels of our Nature: Why Violence has Declined, Viking Books, New York; trad. it. Il declino della violenza, Mondadori, Milano 2013. Portinaro, P.P. 2011 I conti con il passato. Vendetta, amnistia, giustizia, Feltrinelli, Milano. Prezioso, S. 2008 Antifascism and Anti-Totalitarianism: The Italian Debate, in «Journal of Contemporary History», 43, 4: 555-72. Probst, L. 2003 Founding Myths in Europe and the Role of the Holocaust, in «New German Critique», 90: 45-58. Quasimodo, S. 1956 Il falso e vero verde. Con un discorso sulla poesia, Mondadori, Milano. Rancière, J. 2003 Le destin des image, La fabrique editions, Paris; trad. it. Il destino delle immagini, Pellegrini Editore, Cosenza 2007. Redaktion Kritische Justiz (a cura di) 1979 Der Unrechtsstaat. Recht und Justiz im Nationalsozialismus, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a.M.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Opere citate
335
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
1984 Der Unrechtsstaat. Recht und Justiz im Nationalsozialismus, vol. II, Nomos Verlag, Baden-Baden. Regia Università degli Studi di Firenze 1939 Annuario per l’Anno Accademico 1938-1939 (Anno XVII), Sansoni, Firenze. 1940 Annuario per l’Anno Accademico 1939-1940 (Anno XVIII), Sansoni, Firenze. 1941 Annuario per l’Anno Accademico 1940-1941 (Anno XIX), Sansoni, Firenze. Reich, W. 1933 Massenpsychologie des Faschismus, Sexpol Verlag, Kopenhagen; trad. it. Psicologia di massa del fascismo, Sugar, Milano 1971. Reifner, U. 1983 Juristen im Nationalsozialismus, in «Zeitschrift für Rechtspolitik», 16: 139. Ress, L. 1985 The Visit. Auschwitz, 1971, in Id., Flight Patterns, University of Virginia Press, Charlottesville; trad. it. La visita, Auschwitz 1971, disponibile online all’indirizzo http://www.la-shoah-e-la-memoria.it/mostre/poesie.htm (13.11.2013). RI.LE.S. (a cura di) 2009 Rammemorare la Shoah. 27 gennaio e identità europea, Rubbettino, Soveria Mannelli. Rivette, J. 1961 De l’abjection, in «Cahiers du cinéma», 120: 54-5. Roseman, M. 1996 National Socialism and Modernisation, in R. Bessel (a cura di), Fascist Italy and Nazi Germany. Comparisons and Contrasts, Cambridge University Press, Cambridge. 2011 National Socialism and the End of Modernity, in «The American Historical Review», 116/3: 688-701. Roth, J. 1927 Juden auf Wanderschaft, Die Schmiede, Berlin; trad. it. Ebrei erranti, Adelphi, Milano 1985. Rubenstein, R. 1975 The Cunning of History, Harper&Row, New York.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
336
Shoah, modernità e male politico
Rüter, C.F. (a cura di) 1960 Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen, vol. I, Amsterdam University Press, Amsterdam. Sahlins, M. 2008 The Western Illusion of Human Nature, Prickly Paradigm Press, Chicago; trad. it. Un grosso sbaglio. L’idea occidentale di natura umana, Eléuthera, Genova 2010. Sayner, J. 2011 Between Denigration, Idealization, and Historicization: Memories of Nazism and Everyday Antifascism, in D. Clarke – U. Wölfel (a cura di), Remembering the German Democratic Republic: Divided Memory in a United Germany, Palgrave, London: 237-48. Schaller, D. 2008 From Conquest to Genocide: Colonial Rule in German Southwest Africa and German East Africa in A.D. Moses (a cura di), Empire, Colony, Genocide. Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History, Berghahn Books, New York: 288-324. Schminck-Gustavus, C.U. 1986 Das Heimweh des Walerjan Wrobel. Ein Sondergerichtsverfahren 1941/42, Dietz, Bonn; trad. it. Mal di casa. Un ragazzo davanti ai giudici 1941/42. Con un ricordo di Nuto Revelli, Bollati Boringhieri, Torino 1994. 2007 Mnìmes Katochìs. Tom. 1: Ta pedià tu dàsus ton Aspranghèlon ke ènas Italòs chamènos sta Tsumèrka, Isnafi, Giannina. 2008 Mnìmes Katochìs. Tom. II: Italì ke Ghermanì sta Iannena ke i katastrofì tis evraikìs kinòtitas, Isnafi, Giannina. 2010 Winter in Griechenland. Krieg - Besatzung - Shoah, Wallstein, Göttingen. 2011 Mnìmes Katochìs. Tom. III: I Lighiàdes stis flòges, Isnafi, Giannina. Schmitt, C. 1934 Der Führer schützt das Recht. Zur Reichstagsrede Adolf Hitlers vom 13. Juli 1934, in «Deutsche Juristen-Zeitung», 39: 945-50; trad. it. Il Führer protegge il diritto, in Id., Posizione e concetti in lotta con Weimar-GinevraVersailles, 1923-1939, Giuffrè, Milano 2007: 326-35. 1950 Das Problem der Legalität, in «Neue Ordnung», V, 3: 270-75; trad. it. Il problema della legalità, in Id., Le categorie del “politico”. Saggi di teoria politica, il Mulino, Bologna 1972. Schoenbaum, D. 1966 Hitler’s Social Revolution, Doubleday, New York. Schumann, E. (a cura di) 2008 Kontinuitäten und Zäsuren. Rechtswissenschaften und Justiz im “Dritten Reich“ und in der Nachkriegszeit, Wallstein, Göttingen. www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Opere citate
337
Scott, A.O. 2008 Why So Many Holocaust Films Now and For Whose Benefit?, in «New York Times», 21/11/2008. Seaton, A. 1982 The German Army, 1933-45, St. Martin’s Press, New York. Sebald, W.G. 1999 Luftkrieg und Literatur, Carl Hanser Verlag, München; trad. it. Storia naturale della distruzione, Adelphi, Milano 2004. Segev, T. 1993 The Seventh Million. The Israelis and the Holocaust, Hill and Wang, New York; trad. it. Il settimo milione. Come l’Olocausto ha segnato la storia di Israele, Mondadori, Milano 2002. Semprún, J. 1995 Mal et modernité: le travail de l’histoire, Editions Climats/Seuil, Paris; trad. it. Male e modernità, Passigli, Firenze 2002. Smelser, R. 1990 How Modern were the Nazis in «German Studies Review», XIII, 2: 285302. Snyder, T. 2010 Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin, Basic Books, New York; trad. it. Terre di sangue. L’Europa nella morsa di Hitler e Stalin, Rizzoli, Milano 2011. Staff, I. (a cura di) 1964 Justiz im Dritten Reich. Eine Dokumentation, Fischer Taschenbuch, Frankfurt a.M. Staub, E. 1989 The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence, Cambridge University Press, Cambridge. Steiner, J. 1980 The SS Yesterday and Today. A Sociopsychological View, in J.E. Dinsdale (a cura di), Survivors, Victims and Perpetrators, Hemisphere, Washington DC: 405-56. Sternberg, P. (a cura di) 2004 The Psychology of Hate, American Psychological Association, Washington DC. Stierlin, H. 1975 Adolf Hitler. Familienperspektiven, Suhrkamp, Frankfurt a.M.; trad. it. Hitler, Carocci, Roma 2003. www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
338
Shoah, modernità e male politico
Streit, C. 1978 Keine Kameraden: Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941-1945, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart. Thad Allen, M. 2002 The Business of Genocide. The SS, Slave Labor, and the Concentration Camps, University of North Carolina Press, Chapel Hill. Todeschini, G. 2002 I mercanti e il Tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna, il Mulino, Bologna. 2007 Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all’età moderna, il Mulino, Bologna. Todorov, T. 1991 Face à l’extreme, Seuil, Paris; trad. it. Di fronte all’estremo, Garzanti, Milano 1992. 2000 Mémoire du mal, tentation du bien, Robert Laffont, Paris; Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, Garzanti, Milano 2001. Tooze, A. 2007 The Wages of Destruction. The Making and Breaking of the Nazi Economy, Viking Press, New York; trad. it. Il prezzo dello sterminio. Ascesa e caduta dell’economia nazista, Garzanti, Milano 2008. Traverso, E. 1992 Les juifs et l’Allemagne. De la «symbiose judéo-allemande» à la mémoire d’Auschwitz, La Découverte, Paris; trad. it. Gli ebrei e la Germania. Auschwitz e la «simbiosi ebraico-tedesca», il Mulino, Bologna 1994. 2002 La violenza nazista. Una genealogia, il Mulino, Bologna. 2004 Auschwitz e gli intellettuali. La Shoah nella cultura del dopoguerra, il Mulino, Bologna. 2006 Il passato: istruzioni per l’uso. Storia, memoria, politica, Ombre Corte, Verona. 2009 Biopotere e violenza. Sugli usi storiografici di Foucault e Agamben, in «Contemporanea», XII, 3: 523-30. 2011 L’histoire comme champ de bataille. Interpréter les violences du XXe siècle, La Découverte, Paris; trad. it. Il secolo armato. Interpretare le violenze del Novecento, Feltrinelli, Milano 2012. Turner, H. 1975 Fascism and Modernization, in Id. (a cura di), Reappraisals of Fascism, New Viewpoints, New York.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Opere citate
339
Ueberschär, G.R. 1997 The Ideologically Motivated War of Annihilation in the East, in R.-D. Müller – G.R. Ueberschär (a cura di), Hitler’s War in the East 1941-1945: A Critical Reassessment, Berghahn Books, Providence: 209-80. van der Knaap, E. (a cura di) 2006 Uncovering the Holocaust. The International Reception of Night and Fog, Wallflower Press, London-New York. Vidal-Naquet, P. 1987 Les assassin de la mémoire, La Découverte, Paris; trad. it. Gli assassini della memoria, Editori Riunti, Roma 1993. Vitiello, G. 2012 Il testimone immaginario. Auschwitz, il cinema e la cultura pop, Ipermedium, Napoli. Vogel, L. 1996 Editor’s Introduction, in H. Jonas, Mortality and Morality. A Search for the Good after Auschwitz, Northwestern University Press, Evanston: 1-40. Voigt, K. 1989 Zuflucht auf Wiederruf. Exil in Italien 1933-1945, vol. I, Klein-Cotta, Stuttgart; trad. it. Il rifugio precario: gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, La Nuova Italia, Firenze 1993. 1993 Zuflucht auf Wiederruf. Exil in Italien 1933-1945, vol. II, Klein-Cotta, Stuttgart; trad. it. Il rifugio precario: gli esuli in Italia dal 1933 al 1945,La Nuova Italia, Firenze 1996. Volkov, S. 1978 Antisemitism as a Cultural Code, in «Leo Baeck Institute Yearbook», 23: 25-46. 1990 Antisemitismus als kultureller Code, in Id., Jüdisches Leben und Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert. Zehn Essays, Verlag C.H. Beck, München. von Cranach, M. 2007 The Physicians’ Reasons for Using Euthanasia during the Nazi-Fascist Regime, in H. Fröstl (a cura di), Theory of Mind: Neurobiologie und Psychologie sozialen Verhaltens, Springer, Berlin; trad. it. Motivazioni dell’agire dei medici che hanno applicato l’eutanasia nel regime nazi-fascista, in «Rivista Sperimentale di Freniatria», 133/1, 2009: 87-102. Wajcman, G. 1988 L’object du siècle, Lagrasse, Verdier.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
340
Shoah, modernità e male politico
Wantzen, P. 2000 Das Leben im Krieg 1939-1946. Ein Tagebuch, Das Dokument, Bad Homburg. Weber, M. 1917 Der Sinn der “Wertfreiheit“ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften, in Id., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Mohr, Tübingen 1951; trad. it. Il senso della “avalutatività” delle scienze sociologiche ed economiche, in Id., Il metodo delle scienze storico-sociali, Einaudi, Torino 1974. 1919 Politik als Beruf, in Max Weber Gesamtausgabe, I/17, Mohr, Tübingen 1992; trad. it. La politica come professione, in Id., Il lavoro intellettuale come professione: due saggi, Einaudi, Torino 1966. 1920 Einleitung zur Wirtschaftsethik der Weltreligionen, in Max Weber Gesamtausgabe, I/19, Mohr, Tübingen 1984; trad. it. Introduzione a “L’etica economica delle religioni universali”, in Id., Sociologia della religione, vol. I, Comunità, Milano 2002. Wehler, H.-U. 1985 The German Empire, Berg, Leamington Spa. Weil, E. 1948a Allemagnes et allemands. Le problème des deux Allemagnes, in «Critique», IV, 27: 719-22; trad. it.: Germanie e tedeschi. Il problema delle due Germanie, in Id., Questioni tedesche, QuattroVenti, Urbino 1982: 65-9. 1948b Analyse psychologique ou psychanalyse de l’Allemagne, in «Critique», IV, 24 : 447-56; trad. it. Analisi psicologica o psicanalisi della Germania in Id., Questioni tedesche, QuattroVenti, Urbino 1982: 78-86. Weindling, P. 1989 Health, Race and German Politics between National Unification and Nazism 1870-1945, Cambridge University Press, Cambridge. Weinkauff, H. 1968 Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus. Ein Überblick, in Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus. Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, vol. 16/1, Deutsche Verlags Anstalt, Stuttgart. Weiss, J. 1967 The Fascist Tradition. Radical Right-wing Extremism in Modern Europe, Harper&Row, New York. Welzer, H. 2005 Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massmörder werden, Fischer, Frankfurt a.M.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Opere citate
341
2007 Wahrnehmung, die Realität schafft. Ein Gespräch über die Sozialpsychologie von Tätern, in S. Friedländer, Den Holocaust beschreiben. Auf dem Weg zu einer integrierten Geschichte, Wallstein, Göttingen: 121-60; trad. it. Percezioni che creano la realtà. Una conversazione sulla psicologia sociale dei colpevoli, in S. Friedländer, Aggressore e vittima. Per una storia integrata dell’Olocausto, Laterza, Roma-Bari 2009: 95-127. White, R.B. – Gilliland, R.M. 1975 Elements of Psychopathology. The Mechanisms of Defense, Grune&Stratton, New York; trad. it. I meccanismi di difesa, Astrolabio, Roma 1977. Wiesel, E. 1967 Jewish Values in the Post-Holocaust Future. A Symposium, in «Judaism», 3: 266-99. 1982 Paroles d’etranger, Seuil, Paris; trad. it. Parole di straniero, Spirali, Milano 1986. Wieviorka, A. 1999 Auschwitz expliqué à ma fille, Seuil, Paris; trad. it. Auschwitz spiegato a mia figlia, Einaudi, Torino 2005. 2005 Auschwitz, 60 ans après, Robert Laffont, Paris. 2011 L’heure d’exactitude. Histoire, mémoire, témoignage, Albin Michel, Paris. Wittgenstein, L. 1967 Bemerkungen über Frazers “The Golden Bough”, in «Synthese», 17: 23353; trad. it. Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, Adelphi, Milano 1975. Young, J. 1993 The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, Yale University Press, New Haven-London. 2000 Art’s Memory’s Edge: After-Images of the Holocaust: Contemporary Art and Architecture, Yale University Press, New Haven-London. Young, J. (a cura di) 1994 The Art of Memory: Holocaust Memorials in History, Jewish Museum, New York. Zampieri, S. 1996 Il flauto d’osso. Lager e letteratura, Giuntina, Firenze. Zelizer, B. (a cura di) 2001 Visual Culture and Holocaust, Arthlon Press, London. Zimbardo, P. 2007 The Lucifer Effect, Random House, New York; trad.it. L’effetto Lucifero. Cattivi si diventa? Raffaello Cortina, Milano 2008.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Zimmerer, J. 2004 Colonialism and the Holocaust: Towards an Archeology of Genocide, in A.D. Moses (a cura di), Genocide and Settler Society. Frontier Violence and Stolen Indigenous Children in Australian History, Berghahn Books, New York: 49-76. 2005 The Birth of the Ostland out of the Spirit of Colonialism: a Postcolonial Perspective on the Nazi Policy of Conquest and Extermination, in «Patterns of Prejudice», 39/2: 197-219. 2008 Colonial Genocide: The Herero and Nama War (1904-8) in German South West Africa and its Significance in D. Stone (a cura di), The Historiography of Genocide, Palgrave-Macmillan, Basingstoke-New York: 323-43. 2011 Von Windhuk nach Auschwitz. Beiträge zum Verhältnis von Kolonialismus und Holocaust, Lit Verlag, Münster. Zitelmann, R. 1989 Adolf Hitler. Eine politische Biographie, Musterschmidt, Göttingen; trad. it. Hitler, Laterza, Roma-Bari 1991. Zych, A.A. 2001 Vorwort, in A.A. Zych – D. Müller-Ott (a cura di), Auschwitz Gedichte, vol. I, Weg zum Himmel, Verlang des Staatliches Museums Auschwitz-Birkenau, Oswiecim.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
343
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
GLI AUTORI
RENATA BADII OMER BARTOV ZYGMUNT BAUMAN CHRISTOPHER R. BROWNING ALBERTO BURGIO UGO CAFFAZ ENZO COLLOTTI DIMITRI D’ANDREA FABIO DEI ENRICO DONAGGIO SIMONE DURANTI ROBERTO ESPOSITO
CHRISTOPH
MASSIMO GIULIANI DIEGO GUZZI ANDREA MINUZ SUSAN NEIMAN STEFANO RAIMONDI ENRICO ROSSI U. SCHMINCK-GUSTAVUS TULLIO SEPPILLI ANNETTE WIEVIORKA
Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa Brown University Leeds University University of North Carolina Università di Bologna Consigliere sulle politiche della memoria per la Regione Toscana Università di Firenze Università di Firenze Università di Pisa Università di Torino FUA – Florence University of the Arts Istituto Italiano di Scienze Umane – Firenze Università di Trento Università di Torino Università “La Sapienza” – Roma Einstein Forum – Potsdam Poeta e saggista Presidente della Regione Toscana Universität Bremen Università di Perugia CNRS – Université de Paris I
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
345
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
INDICE DEI NOMI
Abel, T. 163. Adenauer, K. 94, 247, 254. Adorno, T.W. 21, 148, 207, 215, 233-34, 261-62, 268, 273-76, 287, 291, 300. Agamben, G. 185-87, 189, 290. Ahmadinejad, M. 225. Albrecht, R. 78. Alcan, L. 240. Alexander, J.C. 20, 251. Allen, W.S. 167, 171. Alterman, A. 287n. Aly, G. 57-8, 59n., 142 e n., 146, 162n. Améry, J. 226. Anders, G. 147, 155, 157. Anderson, M.L. 78. Arendt, H. 22-5, 50, 55n., 56n., 59n., 63, 144, 148-51, 163 e n., 189-90, 196, 204-05, 207, 221 e n., 223-24, 233, 286, 309. Ariès, P. 290n. Arieti, S. 136n. Augstein, R. 78. Ausländer, R. 266. Avisar, I. 281n., 289. Bacon, F. 143. Badii, R. 25, 33n. Baldwin, P. 78. Bankier, D. 172, 173n., 174 e n., 175n., 176. Banks, C. 152. Barbie, K. 235, 249. Barbieri Sacconaghi, F. 129. Bartoletti, F. 121n. Bartoszweski, W.T. 243, 255. Bartov, O. 26, 28, 34n., 45, 80, 82n., 164. Bauer, F. 98. Bauer, Y. 19n.
Bauman, Z. 21, 27, 59, 153n., 163, 189, 206, 309. Beattie, A.H. 40. Becker, W. 35n. Beecher Stowe, H. 228. Belliti, D. 23. Bencini, C. 123n. Benda, J. 128. Benigni, R. 37, 248, 281. Benjamin, W. 30, 186. Berg, N. 159. Bergmeyer 105, 109. Bernstein, R.J. 203. Bianchi, L. 123. Biasutti, R. 123. Billig, M. 176n. Blackbourn, D. 56n. Blair, T. 250. Bloch, E. 207. Bloxham, D. 75-6. Blume, W. 100-02, 110, 112. Blumenberg, H. 25, 27. Borges, J.L. 161. Borri, G. 274. Bottai, G. 129, 133, 135 e n., 136-37. Brandt, W. 253. Brecht, B. 148, 302n. Brenner, A.D. 86. Brizzi, G.P. 136n. Broszat, M. 56-7, 79n. Brown, J. 229. Browning, C.R. 33, 49 e n., 81, 153, 160, 189, 221n., 309. Brussig, T. 35n. Brzezinski, Z.K. 78. Buffa, N. 134n. Bullock, A. 79n.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
346 Bumke, E. 96 e n. Buonarroti, M. 143. Burger, T. 102. Burgio, A. 26, 160n., 164, 169n., 170n., 176 e n. Burleigh, M. 172n. Bush, G.H.W. 243. Camera, F. 276. Cantoni, G. 129. Capozza, D. 169. Cases, C. 169n., 177. Castro, F. 243. Cavaglion, A. 273-74. Cavani, L. 286. Cavarocchi, F. 119n., 125n., 135n. Cayrol, J. 266. Cei, G. 121n., 125n., 126 e n. Celan, P. 262-63, 266-67, 272, 275-77, 279. Césaire, A. 257. Chaban-Dalmas, J. 243. Chagall, M. 211. Chalk, F. 146. Chang, I. 227. Chaplin, R. 227n., 228. Char, R. 277. Chaumont, J.-M. 242. Chickering, R. 82n. Chirac, J. 241. Chomsky, M.J. 248. Cipriani, L. 121 e n., 123, 125 e n., 126 e n., 133n. Clinton, W.J. 250. Cocks, G. 160, 171. Coetzee, J.M. 234. Cohen, A. 213n. Cohen, M.E. 240. Collotti, E. 34, 37n., 51n. Conquest, R. 77. Craig, D. 288. Cruise, T. 288. Cruzzolin, R. 39n. Cywiński, P. 235, 240-41, 243-44. Dagrada, E. 287n. Dahrendorf, R. 57n. Dalai Lama 243. Daldry, S. 288. Dallin, A. 79n.
Shoah, modernità e male politico D’Andrea, D. 25, 29, 33n. Daston, L. 224n. De Beauvoir, S. 286n. De Felice, R. 53 e n. Dei, F. 186n. De Gasperi, A. 247, 254. de Gaulle, C. 243, 247. Delage, C. 283n., 290n. Delbo, C. 236. Del Boca, A. 53 e n. Delfour, J.J. 290n. De Martino, E. 182. Dennison, S. 292. de Sade, D.-A.-F. 223. Desideri, F. 271. Diamond, J. 183. Di Caporiacco, L. 123 e n. Dickenson, E.R. 59-60. Didi-Huberman, H. 287n., 291. Diner, D. 30, 31n., 289n. Donaggio, E. 24, 42-3. Dörner, K. 143. Dostoevskij, F. 217. Douglass, F. 228 e n. Dreher, E. 97. Dubiel, H. 38n. Duranti, S. 35n., 119n., 138n. Ebbinghaus, J. 209. Ehmann, A. 61n. Eichmann, A. 20, 22-3, 25, 50, 102, 146, 149-52, 189-90, 210, 220, 221 e n., 222-24, 247-48, 286, 309. Eilers, R. 169n. Einstein, A. 86. Eley, G. 56n., 58. Elias, N. 184. England, L. 150. Enzensberger, H.M. 178n. Erickson, J. 79n. Eschilo 287. Esposito, R. 26, 28. Fabbri, E. 25. Fackenheim, E.L. 207, 209-10, 213 e n. Fanon, F. 257. Farne 110. Faurisson, R. 290. Fein, H. 145. Ferrari Zumbini, M. 170n.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Indice dei nomi Festo, S.P. 186. Fichte, J.G. 210. Filbinger, H.K. 96. Fimiani, F. 277. Focardi, F. 37n. Fondane, B. 262, 266. Ford, G. 39n. Ford, J. 290n. Förster, J. 80. Förster, S. 82n. Forti, S. 24, 26, 163-64. Fraenkel, E. 86. François, É. 253, 255. Frank, A. 285. Frank, H. 87 e n., 88 e n. Frazer, J. 182. Frederick, C. 150, 152. Frei, N. 59n., 160 e n., 161n., 176n. Freud, A. 172n. Freud, S. 173, 182. Frick, W. 168. Friedlander, H. 60. Friedländer, S. 52 e n., 67n. Friedrich, C.J. 78. Friedrich, J. 98. Fritzsche, P. 161, 162n., 163 e n., 164-66, 167 e n., 169-70, 172-73, 175-76, 178-79. Fromm, E. 10, 160, 171, 300. Gadamer, H.G. 277. Galimi, V. 119n. Gallerano, N. 32n. Galli, P.F. 172n. Gates, B. 183. Gatti, A. 285. Gawlik, H. 97. Gellately, R. 161, 173n. Gercke, A. 167. Gerlach, C. 77. Geβner, K. 105n. Giglioli, G.R. 122n. Gilliland, R.M. 172n., 173 e n., 174n., 175. Ginsberg, T. 289. Giovanni Paolo II 240, 255. Girard, R. 182. Giscard D’Estaing, V. 243. Globke, H. 94.
347 Godard, J.-L. 233, 290 e n., 291. Goebbels, J. 148, 167 e n., 168, 224, 282n. Goisis, G. 206. Goldhagen, D.J. 188, 220. Goodrich, F. 285. Göring, H. 148. Gozzini, G. 49. Grande, T. 293. Grass, G. 207. Greiner, B. 82n. Grinspan, I. 235. Gröger, W. 96. Gross, W. 174n. Grossman, A. 82n. Grossman, D. 278. Grossman, V. 205, 234. Gumbel, E.J. 86. Günther, H. 164. Guzzi, D. 34. Hackett, A. 285. Haider, J. 250-51. Haney, C. 152. Hansen, M.B. 282. Harris, A. 156. Hartmann, H. 172n. Hawranek, G.W. 108-112. Heer, H. 82n. Hegel, G.W.F. 227-28. Heidegger, M. 204, 208-10. Heim, S. 57, 142, 146. Henne, T. 98n. Herf, J. 67n. Hesse, H. 103n. Higonnet, M.R. 82n. Hilberg, R. 159, 168, 233. Hill, J. 228 e n. Hillgruber, A. 78. Himka, J.-P. 78. Himmler, H. 72, 74, 89, 112, 148, 167, 197, 225. Hinton, A.L. 189n. Hitler, A. 13, 33, 35, 55-8, 63-4, 66-7, 712, 74, 76, 78, 86-7, 88n., 89, 92 e n., 112, 143, 148, 159, 164-66, 167 e n., 168-71, 173, 174n., 177-78, 184, 194, 196, 198, 209, 225, 257. Hobbes, T. 205. Hobsbawm, E. 141.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
348 Höffler, S. 112-14. Hoffman, G. 97n. Hölderlin, F. 275. Horthy, M. 80. Höss, R. 236. Huber, K. 210. Hull, I. 61 e n., 81. Hurwitz, L. 285. Husserl, E. 210. Huyssen, A. 32n. Illouz, E. 228. Insdorf, A. 281. Isnenghi, M. 283. Jabés, E. 266. Jaisser, C. 272n. Jakubowska, W. 236-37, 284. Jaspers, K. 90 e n., 91. Jesi, F. 167, 170n. Johnson, E.A. 171n., 174n., 175. Jonas, H. 207-10, 212. Jonassohn, K. 146. Jonquet, T. 240. Juan Carlos I di Spagna 243. Judt, T. 245, 257. Kaczyński, J. 258. Kaczyński, L. 258. Kaltenbrunner, E. 22, 112. Kansteiner, W. 40. Kant, I. 177, 208-09, 217-18, 223. Kastner, K. 90n. Katz, C. 103. Katzenelson, Y. 265-66. Kellner, F. 50. Kempner, R.M.W. 91 e n., 92, 95. Kerényi, K. 170n. Kershaw, I. 159, 160 e n., 176-77. Kittel, G. 167. Klarsfeld, S. 235. Klee, E. 161n. Klein, T. 255. Klemperer, V. 171. Klüger, R. 271-72, 275. Knell, H. 156. Koch, G. 287n. Kohl, H. 243, 254. Kolbe, M. 239-40, 255. Kolmar, G. 266.
Shoah, modernità e male politico Koonz, C. 160, 162n., 163-64, 165 e n., 166 e n., 167, 168 e n., 172 e n., 173n., 174n. Koyré, A. 174n. Kracauer, S. 148. Kramer, H. 89n. Kren, G. 59n. Kreyssig, L. 88n. La Capra, D. 287n. Langmuir, G. 65. Lanz 110. Lanzmann, C. 282, 286-87, 289, 290 e n., 291. La Rovere, L. 119n. Lawrence, B. 289n. Lederer, E. 171n. Leonhard, J.F. 90n. Leutheusser-Schnarrenberg, S. 97n. Levi, P. 9-10, 28, 182, 213, 238, 247-48, 266, 268, 270, 274, 287, 290, 309. Lévinas, E. 207, 210-12, 267-68. Levy, D. 32. Lifshutz, R. 269-70. Lifton, R.J. 163, 168 e n. Lim, S.H. 292. Lincoln, A. 183. Lindeperg, S. 285n. Linnemann, F. 99-104, 112. Littell, J. 22-3, 147 e n., 149, 151. Livi, L. 122. Longerich, P. 69-73, 75, 79-80, 83, 174n. Loridan-Ivens, M. 237. Loshitzky, Y. 281n. Lumet, S. 286. Lutz, H. 175. Lyotard, J.-F. 290. Magris, C. 11. Maida, B. 169n. Maier, C.S. 78. Majer, D. 114. Maleviĉ, K. 290. Mandell, C. 147n. Mandel’štam, O. 264. Mann, T. 168-69, 171, 177, 178 e n. Mao, Z. 55. Marx, K. 184. Maβfeller, F. 97. Masur, N. 72.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
349
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Indice dei nomi Matthäus, J. 81. Mayer, H. 161n. Mazower, M. 72-3. Mazzaglia, G. 122. Melandri, F. 121n., 126n., 127. Mengaldo, P.V. 261. Merkel, A. 224. Messerschmidt, M. 82n. Meyer, A. 178n. Meyer, H.F. 99. Mezzasoma, F. 133, 135, 136n. Michlic, J.B. 78. Milgram, S. 21, 43, 152-53, 189-90, 309. Miller, A. 164. Minerbi, A. 119n., 135n. Minuz, A. 283n. Mirri, D. 136n. Mitscherlich, A. 161, 162n., 164n., 166n., 169, 172n., 173, 174n., 178. Mitscherlich, M. 161, 162n., 164n., 166n., 169, 172n., 173, 174n., 178. Mitterand. F. 247, 254. Modou, S. 13. Mollet, L. 233. Mommsen, H. 56-7. Money-Kyrle, R. 162n. Montani, P. 290n. Monterisi, F. 131n. Moore, B. 56n. Mor, D. 13. Moses, A.D. 62 e n., 63-4. Müller, H. 305. Müller, I. 91. Müller, K.-J. 82n. Müller, R.-D. 82n. Munk. A. 237, 286. Naumann, K. 82n. Neiman, S. 21, 215. Netanyahu, B. 224-25. Niethammer, L. 93n. Niv, K. 281n. Nocentini, A. 137n. Nolan, M. 82n. Nora, P. 246, 252-53. Novick, P. 30. Orbán, V. 258. Orlev, U. 266. Ostendorf, H. 90n.
Oz, A. 11. Ozick, C. 143. Papon, M. 249. Parin, P. 172n., 173, 175. Paris, A. 212n. Pasolini, P.P. 305. Pell, R.T. 178n. Pepere, A. 129. Perels, J. 98. Perniola, I. 287n. Persson, G. 33n., 250. Peschel-Gutzeit, M. 91. Peukert, D. 58, 59 e n. Picart, C.J. 281. Pinker, S. 183-85, 189. Poirot-Delpech, B. 236. Pontecorvo, G. 233. Portinaro, P.P. 32n., 178. Pratesi, F. 123, 129-30. Pressac, J.-C. 235. Prezioso, S. 40n. Priebke, E. 16, 249. Probst, L. 38n. Procacci, G. 119n. Prosperi, P. 131. Putin, V. 243. Quasimodo, S. 278-79. Rabi, W. 234. Rancière, J. 292, 309. Rappoport, L. 59n. Reich, W. 300. Reichel, P. 255. Reifner, U. 96n. Rekanátis, I. 102. Resnais, A. 284, 285n. Ress, L. 280. Reuband, K.-H. 171n., 174n., 175. Reuth, R.G. 224. Ricoeur, P. 212. Riva, E. 233. Rivette, J. 233. Robinson, E.G. 284n. Rose, R. 243. Roseman, M. 55n. Rosenberg, A. 148, 167n. Rosewicz, T. 261. Roth, J. 158. Rothegel, S. 273.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
350 Rousseau, J.-J. 205, 217, 219. Rubenstein, R. 59 e n. Rüter, C.F. 97. Sachs, N. 266. Sahl, H. 274. Sahlins, M. 188. Sartre, J.-P. 208. Sayner, J. 40n. Schaller, D. 62. Schickele, R. 169n. Schiller, F. 272. Schlegelberger, F. 87 e n. Schminck-Gustavus, C.U. 95n., 96n., 99n., 112. Schmitt, C. 164, 172. Schoenbaum, D. 57n. Scholem, G. 223. Schulze, H. 253, 255. Schuman, R. 254. Schumann, E. 98. Schupfer, F. 130n. Scott, A.O. 288. Seaton, A. 79. Sebald, W.G. 154-55, 175 e n., 178 e n. Sechi, C. 132n. Segev, T. 225. Semprún, J. 213, 214n., 266. Seppilli, T. 15. Sereny, G. 309. Serpieri, A. 123n., 124, 129. Sertoli Salis, R. 129. Singer, B. 288. Smelser, R. 59n. Smoleń, K. 238. Snyder, T. 77-8. Spaatz, C. 156. Speier, H. 148. Spielberg, S. 227, 248, 281. Staff, C. 97, 98n. Staff, I. 97. Stalin, J. 71, 77-8, 184, 259. Starace, A. 132. Staub, E. 152. Stein, E. 255. Steiner, J. 152. Steiner, J.-F. 234. Sternberg, P. 147. Stevens, G. 285.
Shoah, modernità e male politico Stierlin, H. 162 e n., 169n., 176. Streicher, J. 148. Streit, C. 82n. Succi, P. 121n., 126n., 128. Sznaider, N. 32. Szurek, J.-C. 239. Taddei, E. 120, 133-34. Tarantino, Q. 288. ter Veen, H. 90n. Thad Allen, M. 57n. Thalheim, R. 234. Tillion, G. 214. Todeschini, G. 165n. Todorov, T. 189, 205, 214n. Togliatti, P. 247. Tooze, A. 73-4, 75 e n. Touvier, P. 249. Traverso, E. 26, 43-4, 56n., 157, 170n., 188, 257-58, 286, 291n. Truman, H. 155. Turner, H. 57n. Ueberschär, G.R. 80. Vaillant-Couturier, M.-C. 236, 240. van der Knapp, E. 285. Veil, S. 243, 258 e n. Vidal-Naquet, P. 286n. Vitiello, G. 288n. Vogel, L. 207-08. Voigt, K. 137 e n. Volkmann, H.-E. 82n. Volkov, S. 66, 169. Volpato, C. 169. Voltaire 217-18. von Cranach, M. 168. von Galen, C.A. 167n. von Kardorff, U. 174n. von Krosigk, L.G.S. 168. von Molo, W. 171n., 178n. von Papen, F. 168. von Schleicher, K. 168. Wahnich, S. 242. Waitz, R. 239-40. Wajcman, G. 290. Waldheim, K. 243. Wantzen, P. 167 e n. Warneken, E. 96n. Weber, M. 23, 25, 29. Wehler, H.-U. 56n.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Indice dei nomi Weil, E. 169n. Weindling, P. 60n. Weinkauff, H. 95 e n., 96. Weiss, J. 57n. Welles, O. 284 e n. Welzer, H. 159 e n., 162, 221n. White, R.B. 172n., 173 e n., 174n., 175. Wiefing, H. 97n. Wiesel, E. 242-43, 247-48, 250, 291. Wieviorka, A. 42, 234-35, 241. Wilkomirski, B. 228-29. Winslet, K. 288. Wippermann, W. 172n. Wirths, E. 168.
351 Wittgenstein, L. 188. Wróbel, W. 96n. Young, J. 283n. Young, L. 284n. Zambrini, S. 132n. Zampieri, S. 234n. Zein 109. Zelizer, B. 292. Zimbardo, P. 21, 43, 147n., 149-50, 152-53. Zimmerer, J. 61 e n., 62, 162n. Zitelmann, R. 57, 59n. Zwick, E. 288. Zych, A.A. 261, 270.
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.
Content accessed by Alma Mater Studiorum - Univ. di Bologna [IP address 137.204.24.180] on 05/12/2018
Finito di stampare gennaio 2014 da Digital Team - Fano (PU)
www.torrossa.com – Uso per utenti autorizzati, licenza non commerciale e soggetta a restrizioni.