Mario Bava 8880336681, 9788880336686
Mario Bava (Sanremo, 1914 - Roma, 1980) in vita fu considerato solo un abile artigiano specializzato nell'horror. D
124 67
Italian Pages 164 [166] Year 2013
Polecaj historie
Citation preview
Alberto Pezzetta è autore tra l’altro di Ridere civilmente. Il cinema di Luigi Zampa, Il western italiano, La critica cinematografica, Regia Damiano Damiani, e di altri tre
"Castori” (Clint Eastwood, Abel Ferrara e Mauro Bolognini, quest'ultimo con Pier Maria
Bocchi). Ha curato con Anna Gilardelli Cinema italiano. Recensioni e interventi 19331990 di Alberto Moravia. Scrive su «Corriere della Sera», «Cinefonim», «Ciak» e II
Mereghetti. È stato selezionatore per la Mostra del cinema di Venezia dal 2008 al 2011. Ha collaborato alla produzione di L'intervallo dì Leonardo Di Costanzo (2012).
Per questa terza edizione completamente rifatta, l'autore ringrazia per l'aiuto: Gabriele Bigonzoni (Italia Taglia), Gabriele Giuli, Domenico Monetti, Roberto Curti, Lorenzo
Pellizza ri.
Il Castoro Cinema
Direttore responsabile: Renata Gorga ni
Redazione: viale Abruzzi 72, 20131 Milano i nfo@ca sto ro-o n-l i ne. it www. ca sto ro-o n-l i ne. it
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 373 del 30/6/97 Progetto grafico: Studio Tapiro, Venezia
In copertina: Il rosso segno della follia © 2013 Editrice II Castoro srl ISBN: 978-88-8033-668-6 Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume die tro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rila
sciata da AIDRO, corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, [email protected] e www.aidro.org.
Alberto Pezzetta
Mario Bava
il castoro cinema
«Il cinema è tutto un trucco»
Infanzia
Mio padre, cravatta e flocco rivoluzionario era un artista. Prototipo del bohé mien. Era pittore, scultore, fotografo, chimico elettricista, medium, inventore; perse anni a studiare il moto perpetuo. Verso il 1908 conobbe il cinema, si gettò a capofitto nella nuova arte, e divenne operatore (allora non si diceva direttore della fotografia). Anni dopo, fra un’inquadratura, un modellino e una manciata di iposolfito, mi mise al mondo. Sono cresciuto avviluppato nella pellicola. A tre anni giocavo con pezzi di cianuro di potassio, che mi piaceva tanto per il suo rosso rubino, e lo alternavo in lunghe file con i grani bianchi dell’iposolfito. A mio padre non passò mai per la testa che potessi avvelenarmi: sapevo che era veleno e non dovevo leccarmi le dita quando lo toccavo. Erano tempi eroici di pionieri in un nuovo spazio a due dimensioni. Non esisteva la specializzazione. Il cianuro e l’iposolfito servivano a fare i fondu chimici, e io tenevo un capo della pellicola mentre mio padre con un batuffolo di ovatta imbevuto di cianuro strofinava l’emulsione sul lavandino di cucina, stando attenti che le gocce non finissero nell’insalata. A questa infanzia passata nella bottega di mio padre, nel senso di “bottega” dei pittori del rinascimento, sono dovute le mie origini arti gianali. Facevamo di tutto, si risolveva tutto con pochi mezzi, con l’ingegnacelo, e con un grande entusiasmo che si appagava dei risultati ottenuti e non dei soldi che si sarebbero potuti ottenere. Le radici del mio amore-odio per Ì trucchi risalgono a quei tempi, a quelle esperienze. (Fant’Italia, 1976) Maestri
Diventai anch’io operatore, e feci una cinquantina di film, lavorando con molti registi: da Francesco De Robertis - un vero genio, il vero inventore del neorealismo - a Mario Soldati, altro genio, forse troppo colto per fare il cine ma. Fra questi due poli, una moltitudine di altri, e da tutti, anche dai più defi cienti (dal latino defi cere) ho appreso qualcosa: quel che si deve fare, e in spe cie quel che non si deve fare; ma ora, ripensandoci, quest’ultimo assunto credo di non averlo appreso troppo bene. (Fant’Italia, 1976) Cinema italiano
Mi viene da ridere a pensare al neorealismo: bello sforzo. Vai per le strade e giri! («L’Espresso», 1979) 5
Se parliamo degli orfani di Rossellini che oggi riprendono le strade di Roma in Super8, è un cinema nato morto. Se parliamo del cinema italiano come lo si conosce in Francia, è un cinema a metà. I falsi thriller di Rosi, i falsi melodram mi di Comencini, la falsa volgarità di Scola, il falso barocco di Fellini... Si addolcisce tutto, si rende accettabile tutto: l’assassino agisce per un ideale poli tico, il bambino muore di malattia e non di calci nello stomaco, i poveri non sono poi tanto brutti visto che fanno ridere, e il mare di plastica di Casanova sembra un mare vero. («Liberation», 1980) Trucchi
Il cinema è tutto un trucco. (L’ospite delle due, Rete 1, 1975) E molto difficile spiegare i trucchi. Me l’hanno fatto fare alla televisione e ho fatto la figura barbina dell’ospite delle due. La cosa più tremenda è che rimani incassato su poltrone scomode e vedi il tuo naso sullo schermo davanti. E impos sibile spiegare i trucchi perché se si vede significa che un trucco non è venuto bene, e se non si vede nessuno si accorge che è un trucco. In Diabolik non c’era niente, erano tutti pezzi di carta. Nel sotterraneo non c’era niente: la terra si apre ed entra un modellino radiocomandato fatto con un pezzetto di compensato... Mi ricordo dei documentari che feci nel 1947 per Richwìld. Lui voleva fare delle costruzioni, io misi dei teli bianchi. Per fare II lago dei cigni ritagliavo dei cigni con delle frasche che si muovevano, tutte cose sfocate, strane. Quello che li fece impazzire fu che misi un tale a reggere le frasche e andava a tempo. Se tu dici a un americano di reggere la frasca, non te la regge, deve mettere un apparecchio. Che poi a uno venga in mente di muovere la frasca a tempo di musica, è una cosa che se andiamo in America diventiamo miliardari. Io mi sono sempre rifiu tato di andare in America, e ho fatto malissimo. Quattro volte me l’hanno chie sto, l’ultimo è stato De Laurentiis con King Kong, mi ha offerto 100.000 dollari. Io odio l’America, sono casereccio. (La città del cinema, 1979)
Esordio Io il regista non lo volevo fare, perché secondo me il regista deve essere vera mente un genio, e poi stavo tanto bene a fare il direttore della fotografia, gua dagnavo un sacco di soldi. Anni prima avevo letto II Vij di Gogol’. Lo lessi a Silvi Marina ai figli che erano piccoli e non c’era ancora la televisione. I due, 6
poveretti, dalla paura dormirono in mezzo al letto. Siccome in quel periodo era uscito Dracula, pensai di fare un film del terrore. Venne fuori La maschera del demonio, dì II Vij era rimasto solo il nome del protagonista. {La città del cinema, 1979)
Comunque Ì1 film ebbe un grosso successo in America e da allora sono stato costretto a dibattermi tra vampiri, mostri e streghe. E io che sono una persona mite e timorosa, che non ammazzerei neanche una zanzara per il sacro rispetto che ho di ogni forma di vita, sono stato sommerso da un lago di sangue bruli cante dì vampiri e morti a galla. {Fantltalia, 1976) Economia
Giravo sempre in fretta. Dodici giorni al massimo per fare un film. Con tutte le battute già in testa. Avevo già chiaro il montaggio, e non sciupavo niente, neanche un metro di pellicola. Ho girato un film con 8.000 metri di pellicola a disposizione. Gli americani, Walsh per esempio, sì “coprivano”, come dicono loro. L’unica preoccupazione loro non era inventare, ma “coprirsi”, cioè essere sicuri dì averci messo tutto. Giravano la stessa scena venti volte, per paura di sbagliare. Una volta ho detto a Walsh, sul set di Ester e il re: «Perché non dite tutte le battute del copione inquadrando un braciere, così siete sicuri dì non dimenticarvi niente?». Capì l’antifona, e ci rise su. («L’Espresso», 1979) Metodo
Fino ai vent’anni, prima di darmi al cinema, ero pittore, così anche adesso sono solito tracciare uno story board, disegno cioè tutto il film, con le inqua drature, gli stacchi. Mi aiuta molto, ma se non mi danno il tempo per prepa rarlo, lavoro quasi alla cieca, («Horror», 1971) Paura
Io prima manco sapevo che esistessero i vampiri. Da piccolo mi ricordo che la tata ci raccontava le favole dei briganti sardi, e io avevo paura, ma il vampiro non l’avevo mai sentito. Da noi c’è il sole che scaccia tutto. Così mi sono spie gato il successo dei miei film in America e nei Paesi nordici e non in Italia. {La
città del cinema, 1979) 7
Tanto sono pauroso e anche vigliacco nella vita, tanto mi prende il terrore sullo schermo. Deve essere un modo distorto per prendermi una rivincita. D’altra parte le mie fantasie sono sempre orribili. Amo mia figlia più di ogni cosa al mondo, ma quando la sogno, le manca un piede. Di questi tempi sogno un personaggio che fa la serenata alla sua bella e suona l’archetto sui nervi messi a nudo del suo braccio. La vita quotidiana si preoccupa di alimen tare la mia immaginazione. Ho appena scoperto che la mia casa di campagna apparteneva a un lupo mannaro. E questa mattina ho trovato, ancora sigillata, la lettera di un mio amico morto tanto tempo fa. Temevo che avesse delle lamentele da farmi e l’avevo nascosta... L’ho bruciata. («Positif», 1971) Suspense I mostri non si prestano psicologicamente per il nostro pubblico. C’è sempre qualcuno che fa lo spiritoso, e ha ragione. Ho visto King Kong contro Godzilla, il gorillone di cartapesta si batteva con il dinosauro di plastilina... a un certo punto una jeep carica di soldati si dirigeva verso i mostri, forse per aumentare la suspense. Uno del pubblico ha gridato: «Li vanno a dividere!». È stata la fine del film. Non bisogna mai offrire spunti di questo genere. Se una porta scric chiola o qualcuno percorre lentamente il corridoio, prima della soluzione della scena il pubblico l’ha già smontata con le sue battute. Se invece lo shock è provocato istantaneamente, il pubblico salta sulle sedie... salta davvero. («Horror», 1969)
Critica I miei film hanno successo anche in Francia. Mi hanno detto che a Parigi c’era un club intitolato a Mario, cioè io. Sono venuti quelli dei «Cahiers du cine ma» e mia figlia mi diceva che volevano sapere il tessuto connettivo tra quella targa che oscilla all’inizio del film {Sei donne per Vassassino), dove c’è un tem porale, e il telefono che casca quando la Bartok muore. Io non mi ricordavo neanche come finiva il film. {La città del cinema, 1979) - Come spiega che americani efrancesi hanno apprezzato i suoi film più degli stessi italiani? - Perché sono più fessi di noi. {Fant’Italia, 1976)
8
Passato
Il passato prossimo ci fa ridere; il passato remoto, invece, ci esalta e ci com muove. (Fantitalia, 1976) Ho rivisto La maschera del demonio cinque anni fa perché sono venuti gli ame ricani che volevano rifarlo a colori. Ho mandato a monte l’affare perché io e mio figlio ci rotolavamo dalle risate a rivederlo. Eccetto rari capolavori, i film di Chariot o All’ovest niente di nuovo, quando vedi film di dieci anni prima, ridi, e un film del terrore è già passato dopo due anni. (La città del cinema, 1979)
Autostima Io ho il torto di accettare tutti i lavori che mi propongono; poi non so essere serio, mi viene sempre da scherzare e per i produttori un regista che scherza è inconcepi bile. Ma sono nel cinema da troppo tempo... conosco tutto e tutti, come potrei prendere sul serio quest’enorme, assurdo baraccone? («Horror», 1971)
Sono sicuro di aver fatto solo grandi stronzate... Sono un artigiano. Un artigia no romantico, di quelli scomparsi. Ho fatto il cinema come fare le seggiole. Anzi, l’ho fatto per una doppia sfida... Contro gli americani, per esempio. Loro con le loro superproduzioni, io con il mio geniaccio alla cazzo di cane. Per quel che riguarda l’estetica, quando vedo uno dei miei film vomito... Nei miei film ci sono battute come: «Io sono una medium inconscia». («L’Espresso», 1979)
Temi Tutti i miei film sono delle specie di viaggi, di itinerari iniziatici. Non importa l’ambiente e l’obiettivo che si propone l’eroe. La vita umana ha una sola con clusione possibile. E la morte è l’unico tema su cui valga la pena di riflettere... Le fruste, le maschere, i coltelli mi permettono di giocare con l’idea della morte, di trasmetterne il gusto, l’odore. L’aldilà è visto solo come consolazio ne, quel “chissà mai” che fa sì che continuiamo a vivere, quell’incertezza che fa sì che non ci si impicchi subito. Nei miei film non ci sono mostri, si tratta delle visioni deformate di personaggi che si avventurano ai limiti della malattia mentale, dell’aberrazione sessuale... («Libération», 1980)
9
Se fosse per me, girerei un film con un unico personaggio, solo nella sua camera: l’uomo che finisce con l’avere paura di se stesso. Allora tutto comincia a muoversi attorno, gli oggetti si animano pericolosamente. Non ci sono più mostri davanti a noi, i mostri siamo noi stessi, è chiaro. Ma il mercato, a quanto pare, domanda sempre dei vampiri che escono dalla tomba, delle penose creature di cartapesta. («Positif», 1971)
Società
I miei film non fanno che riflettere un’evoluzione generale: per evadere da una società tecnocratica fondata sul progresso scientifico, ci si rivolge all’insolito, si provocano dei deliri terapeutici: basti pensare alla controcultura americana legata alla droga. Oggi si dice che la controcultura non esiste più, ma solo per ché si è diffusa nella società con una rapidità incredibile, impregnandola tutta. D’altra parte, non si crede più alla scienza. E così si vedono riapparire correnti di pensiero più vicine al romanticismo, alla mistica della natura nel caso degli ecologisti, per non dire delle sette religiose... («Liberation», 1980)
Radici Non ho mai abusato dei lettini da psicoanalisi, dei crocifissi, dei rosari o delle teste d faglio, non più che dei fumo ni, delle gelatine colorate o degli obiettivi deformanti. La frigidità di La ragazza che sapeva troppo, l’incesto di La masche ra del demonio, il masochismo di La frusta e il corpo hanno radici nella mitolo gia greca. Sono molto greco, per essere un italiano... Un giorno spero di rag giungere la fama di Basilide, Valentino, Carpocrate o di quel fantastico Simone Mago, che presentava sua moglie, scappata da un bordello di Tiro, come incarnazione della Sophia. («Liberation», 1980)
Per i riferimenti bibliografici completi dei testi citati, si rimanda alla bibliografia. io
Un autore in meno
Ambiguity cant be measured like a change in temperature. Peter Blegvad, Kew. Rhone
Nelle poche interviste che ha rilasciato, Mario Bava (1914-1980), ligure di nascita ma romano di spirito, si è definito un “artigiano” (un artigiano “romantico”, per l’esattezza), enfatizzando la manualità del proprio modo di fare cinema. Dei suoi film, infatti, spesso è stato anche direttore della fotogra fia, autore degli effetti speciali, montatore e scenografo. Facendo mostra di uno spirito pragmatico e di un sarcasmo greve da mestierante di Cinecittà, ha amato sminuirsi, arrivando all’auto denigrazione; ha dichiarato di accettare qualunque offerta pur di sbarcare il lunario; e in genere ha negato ogni lettura auto riale alla propria opera, facendosi beffe dei critici, specie se francesi. Apprezzato direttore della fotografia e autore di effetti speciali, Bava esordisce come regista a quarantasei anni, nel I960. Il suo cinema nasce come esperi mento ah’interno di quel laboratorio che è il cinema popolare italiano della fine degli anni Cinquanta: un modello straniero di successo - l’horror, reso popolare da Dracula il vampiro {Dracula, di Terence Fisher, 1958) - viene imi tato in una politica di contenimento dei costi. All’interno di questa prassi che pochi anni dopo darà origine al genere più redditizio e longevo del dopo guerra, Ì1 western italiano - Bava ha l’indiscutibile importanza storica dì ini ziare e impostare almeno due filoni. Con il suo esordio La maschera del demo nio codifica l’horror-gotico (che conta una ventina abbondante di titoli fino al 1966). La ragazza che sapeva troppo (1963) e Sei donne per l'assassino (1966), invece, creano Ì presupposti stilistici e tematici per il thriller (che all’estero viene chiamato “giallo”) lanciato da L'uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento nel 1970. Nei due decenni della sua carriera registica, Bava gira più di venti film di genere, frequentando anche, con apporti più o meno originali, la fantascienza, l’avven tura, il western, il comico e la commedia erotica. Muore quando ormai da tempo fatica a lavorare, e il cinema italiano si appresta a diventare qualcosa di diverso, e di più piccolo. Complice la televisione, si spegne il cinema dì genere, e si appresta a essere sostituito da un nuovo genere di massa, quello comico. Gran parte del percorso di Bava si svolge comunque in un’età aurea del nostro cinema: quella in cui l’artigianalità regge un intero sistema produttivo. I capo 12
lavori di Fellini e Antonioni, come ripetono i produttori dell’epoca, sono finanziati dagli incassi del cinema di serie B; e la separazione tra piani alti e bassi della produzione spesso è solo una questione di etichette, dato che tecni ci e cast spesso migrano da un set all’altro. Bava, di fatto, lavora quasi sempre all’interno di un cinema destinato a un consumo popolare, ed estraneo al dibattito critico più influente. Ma anche se è un innovatore e alcuni suoi film diventano modelli più o meno dichiarati per la produzione di genere, non fa un cinema di massa. Nessun suo film gode di incassi clamorosi, diventa oggetto di una fruizione trasversale e incide nella storia del costume, come succede negli anni Sessanta ai superspettacoli d’auto re di Fellini e Visconti, alle commedie all’italiana, ai western di Leone. Dal punto di vista produttivo, il cinema di Bava è al tempo stesso archetipico e marginale. Non è privo di redditività, anche se spesso i guadagni arrivano più dalle vendite all’estero che dagli incassi casalinghi. E pur avendo vocazione popolare e non intellettuale, è un cinema di nicchia, che alimenta presto un consumo cinefilo. È la critica straniera, e nella fattispecie francese, che per prima si accorge del l’opera dì Bava. La maschera del demonio, il suo film d’esordio, suscita interesse sia presso i «Cahiers du cinema» sia nel rivale «Positif», che nel 1961 gli dedica addirittura la copertina. Da questo momento il nome di Bava circola tra Ì cinefili europei. Da noi la critica ufficiale, quella dei quotidiani e delle riviste, di solito lo ignora, e quando se ne occupa lo tratta con sufficienza, anche se è disposta a riconoscere l’eccellenza tecnica dei suoi film. Ciò non toglie che un prestigio cinefilo di Bava esiste anche in Italia già nella prima metà degli anni Sessanta: come si spiega altrimenti che il nome di Bava figuri in copertina del feltrinelliano Film 1964 curato da Vittorio Spinazzola? O che Bernardino Zapponi annunci nel 1966 un numero del suo libro-rivista II delatore dedicato a Bava, mai uscito per la cessata pubblicazione della testata? Nel 1968, nel secondo volume di Arcana della Sugar (dedicato a «Il meraviglioso, l’eròtica, il surreale, il nero, l’insolito nelle arti figurative e plastiche e nei mass media di tutti Ì tempi e Paesi»), Piero Zanotto scrìve che all’interno dell’«horror-film» Bava «occupa un tronetto che lo situa al di sopra di tutti gli altri»; e aggiunge che l’«orripilante gotica sfilata d’impalpabili sensazioni necroforo» del suo primo film «recò al nostro cinema qualcosa di “diverso”, invano imitato da artigiani privi dell’intuito» del «maestro ligure». Bava è quindi considerato molto presto maestro e iniziatore di un genere, parecchie spanne al di sopra degli epigoni. Nello stesso anno, in occasione dell’uscita di Diaboli!, Giovanni 13
Grazzini scrive sul «Corriere della Sera» che il film piacerà agli «intellettuali snob»; gli fa eco Leo Pestelli su «Stampa Sera». Certo, in Italia la fama di Bava resta appannaggio degli happyfew, estranei a con dizionamenti crociani e marxisti (quelli per cui era agevole, già nel 1955, rivalu tare i melodrammi di Matarazzo, ma era più arduo appassionarsi a vicende ambientate in castelli infestati da streghe e vampiri). In Francia La maschera del demonio e i film successivi trovano invece un contesto in cui la cinefilia da tempo valorizza il cinema di genere, dimostrandone l’eccellenza stilistica e la complessità tematica. Per i giovani critici, la “serie B” consente di scoprire nuovi territori, affermare la propria originalità e rompere con l’accademismo benpensante. Di più, la tradizione surrealista, con il suo culto dell’erotismo e del bizzarro, legitti ma culturalmente l’apprezzamento de 11’horror, genere che conta anche su riviste specializzate, come «Midi Minuit Fantastique». In tal modo l’opera di Bava comincia a venire fruita in maniera auto riali stica, e addirittura fanatica. Dalla Francia la fama di Bava si estende, fin dall’inizio degli anni Settanta, all’Inghilterra e agli Stati Uniti. Di generazione in generazione, gruppi di fan tra smettono il culto della sua opera, pro ducendo analisi spesso pompose e un po’ ridicole. In anni recenti tale culto sotterraneo emerge, approfittando di un muta to clima culturale. Nell’ambito di una vasta rivalutazione del cinema di genere, l’opera di Bava esce dal ghetto delle fanzine, acquista prestigio culturale e medìatico, stimola un’ampia produzione saggistica, alimenta il mercato homevideo, riceve l’investitura di prestigiosi registi, il primo dei quali è Martin Scorsese. Ma che razza di autore è Mario Bava? Ha senso leggere la sua opera in una prospettiva che non sia solo strettamente storiografica e socio-economica? E solo un artigiano, come amava dipingersi, non diversamente da tanti colleghi coevi? Ma allora perché è diventato una curiosità per cinefili smunti e raffina ti? E uno dei tanti mostri creati dal delirio pseudocritico di un gruppo di inva sati, legittimati da mutati paradigmi culturali? Oppure è un vero autore, dota to di una poetica che oggi si può analizzare serenamente, senza più alibi né scuse? Non sono mancate analisi che hanno cercato di costruire e giustificare l’auto rialità bavìana con tradizionali argomenti tematici e stilistici. C’è chi ha rileva to nei suoi film una classica poetica dell’incertezza tra sogno e realtà. Altri, con maggior pertinenza, hanno sottolineato la misantropìa e il pessimismo: Ì suoi personaggi sono trattati sovente come oggetti o come insetti; e Bava ha realiz zato alcune delle sue sequenze più belle solo con elementi della natura, senza attori. Altri, infine, hanno analizzato l’uso del colore e le caratteristiche della 14
fotografia, mostrandone la maestria tecnica e la precìsa funzione narrativa all’interno dì una poetica del fantastico. Queste argomentazioni, che possono dare sostanza all’analisi dei sìngoli film, non sono però sufficienti né totalmente persuasive. Trattano Bava come un regista privo dì contesto: ne fanno un unicum senza spessore storiografico, scollandolo dal cinema italiano dell’epoca, da cui Bava prende tanto quanto dà. Per avvicinarsi al cinema dì Bava, e per verificare se ha senso trattarlo in chiave autorìale (come in fondo presuppone scrìvere una monografìa su dì luì), è necessario invece rimetterlo nel suo contesto produttivo, e poi valutare gli eventuali scarti dalla norma. Il fatto di avere realizzato due o tre film arche tipici non basta a giustificare nei confronti di Bava un’attenzione indubbiamente più cospicua dì quella tributa ta a tanti colleghi (Riccardo Freda, Giacomo Gentìlomo, Antonio Margherìfì, Sergio Corbucci...) ugualmente eclettici, a volte parimenti innovativi, e spesso meglio inseriti nella macchina produttiva. Si potrebbe liquidare la questione pensando alle sopravvalutazioni (e complementari sottovalutazioni) dì cui vìve la crìtica autorìalìsta. Ma due fattori vanno considerati per capire la specificità dì Bava. In primo luogo occorre prendere in considerazione un dato dì tipo paratestuale e biografico. Va preso con la dovuta cautela, ma trova riscontri precisi nel testo dei film. Bava spesso sì rappresenta come un regista insoddisfatto, che non può realizzare Ì progetti a cui tiene; e sì sente anzi costretto nel ghetto dell’horror, che per altro gli ha dato maggior fama. E una spìa per capire che cosa l’opera dì Bava abbia di diverso da quella dei suoi colleghi. Se ha una qualche coerenza e spicca rispetto a quella dì un Margherìti o dì un Mastrocìnque, non è perché Bava sia più autore dì loro: lo è meno. Esìste un auto ritratto caricaturale più volte riprodotto, dove Bava si è rappre sentato nell’atto di rompersi letteralmente le palle (fot. 1). A differenza dì tanti colleghi, Bava segnala sempre, nel suo modo dì girare, il disinteresse per quello che fa. Raramente sì comporta da semplice esecutore, neutro e professionale; e non è nemmeno quel tipo di regista (ce ne sono tanti, nel cinema italiano dì serie B e C) che gira con prosopopea ignobili eia!tronate, convìnto dì realizzare capolavori. Bava mostra quanto poco crede in quello che sta girando. E que sto è percepibile e decodiflcabile all’interno del film, al di là delle dichiarazioni a posteriori. FOT. i 15
In secondo Imogen sin da aL cwfro dWù 2?ra2 si assiste nel cinema di Bava a una ridondanza dell'appaiato formale che va a scapito della narrazione. Tale ipertrofia stilistica esorbita dal semplice orgoglio delf artigiano che osten ta la bella inquadratura o il piano sequenza riuscito. Essa invece pone incon gruamente in risalto la mediocrità quasi sistematica delle sceneggiature* la scarsa definizione dei personaggi,. verosimiglianza degli snodi narrativi. In certi cast come 5 b&nboiz Li si arriva a un autentico autosabotaggio* dove al tro$x> po di suspense e logicasi contrappone un frappo di stile : una per restare in un ambito concettuale caro a Girmelo Bene. E proprio ciò differenzia Bava dai suoi colleghi, che quando sono poco convinti di ciò che girano cercano di cavarsela in modo indolore e di sfornare un pro dotto il più neutro possibile. Un buon esempio è oSèrto da una sequenza alh fine di Dopo che Eva Bartok (uno dei due assassini del film) è appena caduta da un cornicione* tornarne nell atelier dei delitti: h. macchina eh presa inizia un lungo carrello* zigzagando trai manichini di un salone vuoto (uno di essi cade* come se f avesse spostato una mano)* fino a inquadrare* attraverso lo spiraglio di una porta* Cameron Mitchell (feltro assassino* complice della Bartok) chestascassinando un cofanetto (fot. 2). Dovremmo avere paura di quello che potrebbe succedere: in realta non proviamo alcun interesse per i personaggi (non solo esseri spregevoli* ma figure minori e poco delineate* che tengono banco dopo uriora e passaselo perché sono gli unici superstiti)* e siamo invece distratti chi colon inverosimili come in un quadro manierista e efelf arditezza hitchcockiana del piano sequenza. A questo punto Bava stacca* e dedica una serie di piani a Mitchell che* insospettito* vaga nel salone (fot. 3). Quando toma nelhstanza* Eva Bartok* rediviva e minacciosa* spunta non dal salone* ma da dove meno ce lo aspettiamo: da un passaggio segreto dietro una libreria posta di fronte alla porta da cui abbiamo spiato Mitchell (fot. 4). Pèrche ha fatto ungilo cosi macchinoso? Chi si muoveva* allora* nel salone? I conti non tornano* tutto il piano sequenza preparatorio si rivela un atto gra ie
tuito* uro svohzzo prima che il racconto si decida ad arrancare verso la fine. Se un regista diserie Q di quelli che si sono riscoperti alla fine del secolo scorso* annaspa per far quadrare i conti* Bava gira con il massimo impegno le sequenze sbagliate* che alla finesono anche le piu belB. Che cosa permette a Bava di agire così? Esat tamente il sistema produttivo in cui è inserito. La ridondanza stilistica dei film baviani è tollerata in quanto non mette a rischio grossi capitali* ed è ininfluente per la redditività finale. Al dis tub utore e allo spettatore non importa apprezzare la fotografia di un horror; se poi capita che sia raffinata non va comunque a detrimento degli incassi: basta che non ab bia fatto lievitare i costi. Bava è un esempio* tutf altro che unico* degli spazi di libertà e di sperimentazione che i registi estrosi e bizzarri potevano ritagliarsi all'interno di un sistema caotico e privo di forti controlli. Da Mino Guerrini a Brunello Rondi* da Cesare Cànevariad Alberto Cavallone* da Sergio Garrone a Renato Polselli* non mancano* in questi due decenni* altri irregphri tollerati dal sistema che operano tra la serie B e hsene D; nel caso di Bava* forse* questa bizzarria è stata praticata con maggio re pervicacia o divertimento* in rispondenza a una particolare inclinazione. Formalista innamorato delh tecnica* spesso interessato alle immagini piu che alle storie* non per questo Bava è un regista esteta* né sfodera le impari pretese intellettuali di alcuni dei registi appena citati Egli rimane sempre all'interno di un contesto basso* culturalmente poco qualificato* e non fa mi Ih per uscir ne. Anche per questo non servoh mai nel ridicolo involontario* né fa avvertire il divario tra ambizione e risultato. L'ipertrofia dello stile non genera una redenzione estetica* rimane un gesto gratuito. A volte si avvicina a produrne quello che aseconch delle epoche* e con sfumai ure di valore via via piu positi ve* è stato chiamato kitsch* camp* pop* cult* trash. Ma sono categorie non sempre pertinenti per Bava possono descrivere un tipo di fruizione posteriore* ma non rendono pienamente conto di un cinema che non cerca lasoddisfàzio ne a buon mercato dello spettatore. Il cinema di Bava non è mai midbufa se accettiamo la definizione di Dw^ht Macdonald* per cui il Midcult iffinge di 17
rispettare i modelli dell’Alta Cultura, mentre in effetti li annacqua e li volga rizza». Alcuni film baviani (pochi: Ecologia del delitto, Cani arrabbiati) cercano di parlare della società che li circonda. Ma più spesso sembrano negare una possi bilità di comunicazione con Ì1 pubblico. Come Alain Robbe-Grillet o Paul Morrissey, per citare due registi coevi, anche Bava spesso smonta ironicamente i materiali del cinema popolare rendendone impossibile la fruizione ingenua. Ma non ha un atteggiamento intellettualistico e una prospettiva dall’alto : rimane un istintivo, un anti-intellettuale, un bizzarro e un solitario. Il cinema di Bava arriva ben prima del postmoderno, e non lo prepara. Non è un cinema di secondo livello, citazionista, metatestuale, anche se si concede qualche oculato saccheggio. Per questo occupa una singolare posizione storica: non è classico (è troppo di genere, difforme e auto distruttivo per esserlo); non è moderno (è troppo istintivo e anti-intellettuale); e non è nemmeno postmo derno. Perché se del postmoderno anticipa alcune modalità (la fine del discri mine tra modelli estetici alti e pratiche basse, Ì1 formalismo come momento di euforia ludica, per parafrasare Fredric Jameson), non ne possiede né la consa pevolezza né gli scopi. Nel 1986 Sandro Bernardi, su «Filmcritica», ha sintetizzato il disagio dello sto rico nei confronti di Bava, affermando che «non si riesce a capire, e forse non si capirà mai, se si tratti di un grande, ostacolato dalla povertà dei mezzi tecnici con cui dovette lavorare, oppure di un mediocre, facilitato equìvocamente da quella stessa povertà, e illuminato solo in certi casi da strani lampi dì ambi guità». Oggi forse non ci chiediamo più in che nicchia della storia del cinema (“grande” o “mediocre”) collocare Bava, anche se molti propenderebbero per la prima. Chiarire se Bava facesse apposta o per caso, decidere fin dove arrivassero le sue intenzioni, probabilmente non è né possìbile, né interessante. Il cinema dì Bava non vuole essere emblematico dì un’epoca, non elabora alcuna angoscia dell’influenza, non riflette sulla fine della Storia o delle storie. Rimane un fatto privato, un gesto gratuito. Per questo è fruibile in una prospettiva auto riale, anche se resta estraneo a ogni progettazione artistica.
L'arte della fotografia
Mario Bava nasce a Sanremo il 31 luglio 1914. Il padre, Eugenio, è secondo le parole di Mario «una specie di Archimede Pitagorico». Scultore, inventore, fotografo, comincia a lavorare per la Pathé, tra il 1904 e il 1908. Da allora si 18
occupa prevalentemente di cinema, anche se continua a realizzare statue sacre per le chiese («Uno scultore di santi» è l’occhiello del suo necrologio su «L’Osservatore Romano» il 7 dicembre 1966). Nella bottega paterna il giovane Mario conosce gli strumenti del mestiere, imparando a creare meraviglie con materiali da quattro soldi. Eugenio tra smette al figlio non solo l’amore per l’arte, il cinema e Ì trucchi, ma anche una dirittura morale d’altri tempi. A tredici anni Mario offre al padre un suo qua dro, ma in cambio riceve uno schiaffo perché ha messo la sua firma: «Neanche Raffaello firmava le sue opere!», lo redarguisce Eugenio. Dopo avere fondato una compagnia dì breve durata, la San Remo Film, all’ini zio degli anni Dieci Eugenio si trasferisce a Torino, allora capitale del cinema italiano. Eugenio lavora ad alti livelli: fotografa Quo vadis? (di Enrico Guazzonì, 1913) e Cenere (di Febo Mari, 1916), con Eleonora Duse. Non accreditato, collabora a Cabiria (di Giovanni Lastrone, 1914): a fianco dì Segundo de Chomón, è uno dei responsabili della fotografìa e degli effetti speciali. I suoi ultimi lavori torinesi sono la supervisione (e, secondo le testimonianze dei familiari, la realizzazione) di due film con il forzuto Alfredo Bo eco lini, Le ulti me avventure di Galaor (1921) e Galaor contro Galaor (1924), attribuiti per la regia rispettivamente a Mario Restivo ed Eugenio Perego. Intanto è arrivata la crisi postbellica, ed Eugenio sì trasferisce a Roma con la famìglia. Nel 1930 Eugenio entra all’istituto Nazionale Luce, fondato da Mussolini nel 1924. Pare anzi che goda dì buone aderenze con il fascismo, per quello che sì può capire dai ricordi dei familiari raccolti con una certa confusione da Tìm Lucas nella sua monumentale biografia Mario Bava - All the Colors of the Dark. Eugenio lavora come supervisore dì documentari (parrebbe di propa ganda), e poi come direttore del reparto trucchi cinematografici. Mario, che ha fatto il liceo artistico senza conseguire la maturità (si è rifiutato di sottopor si alla prova obbligatoria di ginnastica), sogna intanto dì diventare pittore, e collabora brevemente come vignettista al «Marc’Aurelio». Nel 1934, ventenne, sposa Iole Sergio, e inizia a guadagnarsi da vivere andando a bottega dal padre. Rimangono vaghe le notizie di sue collaborazioni a disegni animati; di fatto il grosso del suo lavoro pare consista nel realizzare i titoli di testa delle versioni doppiate dei film americani, e delle versioni dei film italiani per il mercato estero. Nel 1936, con le sanzioni, le case americane chiudono, e quelle italiane «quando si trattava di avere i soldi per il lavoro fatto, ti dicevano sempre di ripassare». Mario decide allora di lasciare l’impiego all’istituto Luce, con l’in tenzione di diventare cineoperatore. Il primo gradino della gavetta è fare l’assi19
•stente: b d rende sotto la sua ala Massimo Terzane., uro dei professionisti più stimati dell'epoca. bfel 1939 Bava esordisce come direttore della fotografia di due cortometraggi del giovane Roberto Rossellini: IL taccbiw pi?potente (in origine intitolatoli ^rfìdiALih^: il pennuto del titolo è un simbob dellInghilterra) e Lavica 2? resa. Tanno dopo» poco prima che inizi h. guerra viene promosso a operato re di lungometraggi e lavora tra f altro con Marcel THerbier in LijfeLMÌtà> pecione italiana di La. comèdi du Nel 1941 conosce Francesco De Robertis («un >ero genb> l'inventore del neo realismo. non Rossellini che gli ha rubato tutto^ dichiara in La. città dd ciwma) ed è operatore del dittico sot tomarino suL e laid Lavora anche in La #ave biacca che firma Rossellini ma cne> secondo Bava dirige De Robertis. bfel 1943 esce il suo primo lungometraggio come direttore della fotografia SartBe*a. p icce La Ai di Renato Simoni e Umberto Scarpelli. Bava attraversa indenne la guerra lavorando all'an nona del comune di Roma; nel 1944 nasce il figlio Lamberto, bfel dopoguerra il hvoro riprende a ritmo sostenuto» sul doppio fronte dei lungometraggi e dei documentari. In questo campo Bava firma le prime regie vecchie > 1946; Arfiteafiv Ravi^ 1947)> oggi irreperibili. Come direttore della fotografia Bava lavora in un ambito probabilmente redditizio ma poco prestigioso: i film musicali di Mario Còsta (5 barbiere 1946; Ltlisìr dimore* 1947X* l'edificante Astone dì Padova. (di Pietro Francisci. 1949X che i-esce in tutte le parrocchie^ e per cui costruisce una mirabolante gxrtta con la carta del pane. Il fetto che rimanga estraneo al neorealismo foce dipende da passate frequentar io ni politiche. Un avanzamento di carriera importante avviene quando irlo Ponti» zate e più una delle case di produzione meglio ux è A&ss innovative delfepoca II suo primo Italia. (li Dnilin Còletti 1950). Seguono Quel bandito %>w> à/ (di Mario Solati. 1950) e due capolavori di Steno e Monrelli Vitadaca^i (1950) e Guardie* ladri (1951). Strirge amicizh con Aldo Fabrizi. che b vuole come direttore della fotografia della sua trilogia La 20
(1951\ L&famtà&Pattsguaj J&. for tumi (1 951\ PdpàdìvMta. ^^^2(1952). Che dilettole delh fotografia è Mario Bava? Monicelli (in Kill Ba£y Ki2.( 2 wm. riprende i due visitatori sulle scale; poi li ab bandone* e sembra diventare una loro sog gettiva (e la voce fuori campo di Choma a un certo punto sembra avvalorare questa ipotesi); rra alla fine delh rotazione torna a inquadrarli fot. 25). Lo sguardo della sezione centrale* quindi* non era il loro; o se apparteneva a loro* inseguito è servo hto via da essi. Il risul tato è che alla fine i personaggi sembrano g tardai j* e sono diventati delle potenziali vit time. Tanfè che subito dopo la macchina da presa abbandona Choma che rovista nella tomba e si immerge nel buio di un ossario* finche rimmagine diventa completamente nera. A chi appartiene quest'ultimo sguardo* questasoggettrva senza soggetto? Q mieosa di simile avviene quando la figlia dell'ostessa entra nella stalla* e la macchina da presa h ab bandora per avvicinarsi a una fine stra da cui possiamo vedere il cimitero e la tomba eh cui sta per risorgere Javutich fot. 2é). Chi ci fa vedere questa immagine? Perché ce la fa vedere ? Lo sguardo dello spettatore* privo del filtro del personaggio* viene catturato dalla fluidità del movimento* e condotto dolcemente a vedere l'irreale. Senza tirare in ballo vecchie teorie dellenunciazione* va rilevato lo statuto incerto di molte immagini in movimento* dove la cessione delh sguardo segnala sempre f irru zione del fantastico. Nel caso estremo* h macchina da presa arriva a incarnare f invisi bile. Quando Javutich entra nel salone del castello* vedano solo l'efiètto del suo passaggio : mentre la macchina eh presa carrella verso destra* il vento scompiglia glispartiti
e le tende* farnaturae un busto cadono a terra £òt. 27). Bava in .seguito disse - per spregio degli attori - di voler girare un film consoli oggetti: ma già nel s uo primo film dimostra come il cinema funzioni anche senza i corpi* grazie a uno sguardo in costante e ambiguo movimento. Alla rappresentazione del fantastico contribui sce inoltre lo zoom* che Bava usa in modo ancora più. vistoso che in CaLtiii, il ùfMwrt&Zs. Le funzioni drammaturgiche del carrello ottico sono chiare: evi denziare f irruzione dell'orrore* rendere fulminea e perentoria fazione. Si veda lo zoom in avanti che sottolinea l'apparizione di Javutich nelhstanza di "\^jda (fot. 28); e quello* all'indietro* sulla croce impugnata da Vajda che respinge Javutich. Sara nei film s uc cessivi che Bava cornine era a servirsi dello zoom in modo grat aito e autodistruttrvo. Bava però non punta solo su un sofisticato apparato formale per mettere inscena il fanta stico. Egli infetti rappresenta l'orrore anche nel modo piu diretto ed esplicito* attraveso gli effètti speciali. Còsi facendo apre nuovi spazi di rappresentabilità e sfida i limiti della censura dell'epoca. Come questo sia potuto avvenire* è ab bastanzasorprendente. AU inizio degli anni Sessantasi usa ancora la revisione preventiva delle sceneg giature* come da legge 379 del 16 maggio 1947 : i produttori inviano a un'ap posita commissioned. copione* attendendo un parere positivo prima di inizia re le riprese, bfella revisione di La dd dimwit datata 9 aprile I960* si legge: idi copione è talmente infarcito di streghe di vampiri di scheletri* di fantasmi* con relativo complemento di delitti e di cacbven* che in confronto a questa pellicola il film su Dracula diventa uno spettacolo per bambini e per dilettanti di orride manipolazioni spettacolari [...] Le varie sequenza per quanto concerne la loro carica orripilante* potranno essere valutate sob su fotografico^. L'anonimo censore intuisce che il film di Bava* p ur inquadrando si in un genere già noto* è qualcosa di inedito* e di potenzialmente pencobso. Ma il film passa in censura il 10 agosto I960* con un semplice divieto ai 39
minori di 16 anni* senza apparenti problemi né richieste di tagli* almeno secondo quanto si evince dai documenti disponibili all'Archivio di Stato e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali: forse il clima estivo favorisce fin dulgenza o la fretta della commissione. 0 forse viene sotto valutato un genere poco roto e considerato ancorasocialmente poco perico loso. In altri Paesi* invece* La maschera ha problemi di censura: in Inghilterra viene proibito fino al 1%8. Fin dalla scena d'apertura* con il marchio rovente impresso nelle carni della strega e il mascherone chiodato conficcati? nel suo volto con un martello (e il sangue che zampilla)* La masebem. m trasgredisce vis tesamente i canoni del visibile dell'epoca, e prosegue nella linea di Calt&i il immettale rappot. » presentando il fantastico e l'orrore con la mas sima concretezza corporea unita a un compiaciuto estetismo macabro. Il racconto è scandito dalle trasformazioni del volto deltas trega* prima trafitto dalla maschera chiodata* poi con le orbite cava in seguito dotato di occhi ma segnato ancora chi buchi dei chiodi (nel primissimo piano in cui ipnotizza Cfìomà* fot. 2?)* e infine sempre piu bello. Il corpo* invece* rimane cadaveri co sotto il manto (fot. 30): coincidenza degli opposti* ancora una volta* e shock visivo cui gli spettatori dellepoca non erano preparati. Ed è qiasi sem pre il volto a essere oggetto della violenza a Chomà viene trafitto un occhio dal pope (e anche stavolta si vede il sangue zampillare); del principe padre ormai vampirizzato si vede la tasta che si squaglia tra le fiamme. Le forze del male e (hi bene - in que sto indifferenti - infierirono su quanto findi viduo ha di piu personale* la fisionomia (o maschera che sia).
.2*
dell'ap parato formale e iconografico* ci si pub chiedere quanto si sentisse o volasse essere auto-
re Bava in questo suo primo film ufficiale. Al di fa della ricerca tecnica. una -spia di ambizioni alte può essere costituita (falle citazioni. Oltre a quella di La. L*Lla. * La. tasria ce né una ancora più esplicita di il vanpiw *ifi* -jymphofii* d*s Gro-utfiSy di Friedrich Wilhelm Murrau> 1?22\ nella sequenza della carrozza di Javutich che attraversa il bosco. Se Mumau accelerava le immagini per rendere la dimensione fantastica Bava ricorre al ralenti: in tal modo sottolinea fapropna originalità e stabilisce con il classico un dfalogo da pari a pari come può fare sedo chi sia consapevole del proprio talento. All'epoca tuttavia gli spettatori e i critici italiani non hanno glistrumenti per valorizzare il film* o se li hanno sono soffocati fai pregiudizi. Su «LEuropecM Ivfarotta liquida il film in modo sbrigativo (parla di i 1545) per gli angoli di ripresa la profondità di campo> la quantità di nero. Quando bfora sale le scale> il suo volto entra ed asce dalla luce $òt. 48)> con Tefiètto noto chi tempi di La maschera demonio. Ma dentro 1"appartamento vuoto> tutto è innaturalmente illuminato^ e quindi ancora piu pauroso. La ragazza che sapevi troppo è una storia classicas ul divieto di guardare^ sul voje lirismo p uni to: e la luce> in quanto visione segnala il peri colo tanto quanto fombra. Quando inquadra il cadavere della vecchia EtheL per renderlo pauroso Bava non lo nasconde tra le ombre> lo illumina in mezzo al bric-àbraz della stanza (fot. 45). E nel confronto finale tra Laura e Nora* è soprat tutto quest "ultima e non la pazza a essere illuminata espressionisticamente $òt. $0). Cbsìc quando Nora sente una voce femminile che la chiama nelf ap partamento vuoto e illuminato non sa da cosa fuggire. e si sente ancora piu in trappola. Non ci sono ombre in cui possa nascondersi h pre senza minacciosa: questa sembra ovunque. Senonché proprio sul piu bello,. si torna alla tradizione: sispegne la luce nella stanza da cui proviene la voce> e Noia resta sulla sogli a. incertase avventurarsi nelle tenebre. La sequenza in esame ha una conclusione in cruenta e sdramrratizzante. in linea con h. comS6
ponente rosa del film la voce misteriosa provie ne da un registrato re» e chi ha-seguito Nora è il .suo innocuo spasimante. MaJgrado ciò» il con fronto con h -sequenza di L*ìwctiL> ddLe piwne dì crìstaiLf in cui una donna entra in un pahzzo» -sale incautamente le -scale al buio e infine viene uccisa a rasoiate» evidenzia numerosi ele menti stilistici in comune: dall'inverosimiglian za alla dialettica tra rumore e musica* tra buio e luce. Qò non significa che Argento abbia per forza visto il film di Bava (per quanto imp robabile > Tha negato pubblicamente)» che rabbia copiato furbamente» o che se ne sia ricordato inconsciamente: è solo il segno di come un repertorio di soluzioni stilistiche» nel giro di alcuni anni» diventi patrimonio condiviso e codificato» funzionale alt effetto voluto e rico noscibile dallo spettatore. Nel 1%3 una sequenza come quella esaminata è ancora un esperimento» non si imprime nella memoria collettiva* ma rimane come un modello nelhs uà complessa elaborazione linguistica. La vecione americana di La ragazza che inserisce molte più gag (quando Norasi mette in baby-doll un ritratto -quello di Bava stesso -sem bra spiarla) e ha un finale diverso : Nora e Marcello assistono a un omicidio» ma questa volt a decidono di disinteressarsene. In quella per il mercato italiano e francese si inserisce invece il dubbio che finterà vice neh possa essere stata un'allucinazione. Il gioco è vecchio (vedi La dd. stratte Wt>ma# w? di Fritz Lang» 1?44])» e in questo caso è una boutade in linea con h vera leggera del film su cui non vale la pena di insistere. Htocìioal golcoc / frte vrWtV delfapaufae Lìffustì e p7 corpo
Nel 1963 l'americana Aip» che ha distribuito con successo negli Stati Uniti i precedenti film di Bava* unisce le forze con la Gahtea e h francese Société Qnématographique Lyre per produrre un horror; Z fre wltì ddLa pauia a epi-
s?
re materiali delle produzioni precedenti: le scenografie e le musiche di Li maxberi dèi Aw/w nell episodio IWurdiLk fot. 51X e le scenografie di Li rigizziche trtypQ in i tdqftw. Lascenegghturaè del giovane Alberto Bevilacqua e alsecondo film con Bava» consente alla produzione di ottenere il minimo garantito nelle pre vendite ai distributori. Il film» in ogni caso» in Italia viene visto eh pochi: 7 2 milioni di incasso, un record negativo nell opera baviana
Un castello rìcino al mare, un cavaliere Nel castello la governante Giorgia contempla la teca che racchiude il pugnale con cui si è suicidata sua figlia ISnia dopo essere steta sedotta da Kurt Men lift. Kurt adesso è tornata raccolgono gelidamente il pad conte Vlad imi [ il fratello Cristiana che ha appena sposato la bella Nevenka e la cugina Katia un tempo innamorata di Cristiana Nessuno cede ai propositi di penti mento che manifesta Kurt Pu tardi sulla spiaggia Kurt soipende Nevenka da sola. Un tempo erano amanti la bacia la frusta sulla schiena («Ti è sempre piaciuta la violenza*), la bacia anco e. Dissolvenza. La sera Nevenka non si trova Kurt nd la sua stanza, viene pugnalai) al la gola da mano ignota con il pugna le fatidico. Il servo Losat trova Nevenka svenuta sulla spiaggia e poi il cadavere di Kurt Nessuno è molto com mosso II corpo viene inumato nella cripta del castella Cristiano sospetta che ad avere ucciso Kurt sia stato il pad re Neven la. a letta sente s ibil i e schiocchi di frusta si alza, va nella stanza di Kurt vede dei rami che sferzano la finestra aperta intanto comincia a conere voce di presenze soprannaturali Neven la vede alla finestra Kurt con il collo fasciate e macchiato disangue Ancora a lette, sente dei passi vede gli stivali infangati di Kurt e la sua mano che le strappa la camicia da notte Urla accorre Cristiano II giorno dopa nella cripta vede orme fangose Poi mentre è in deliquio davan ti a Ilo specchio, le appare Kurt chevince la sua resistenza, la frusta e la bacìa «Sono tornato per vendicarmi dice La mattina il conte Vladimir viene trovato sgozzata Nevenka grida che è la vendetta di Kurt l sopravvìssuti si scambiano accuse Cristiano trova il servo losat nella cripta le impronte te ngose potrebbero essere sue senonchè i due odo no la risata di Kurt dietro la sua pietra torn baie trova no Nevenka svenuta. Pattando con Katia Cristiano sidioe convinto che Kurt sìa ancora viva e decide di aprire la sua bara. Kurt appare a Nevenka dice cheè lultima volta che può vederla a meno che non b segua. Cristiano trova nella bara un cadavere irriconosci bite, che dà alte fiam me poi sente la risata di Kurt e insegue uifombra fin nella camera di Nevenka Qui qualcuno ceca di pugnalarla è Nevenka Attraverso un passaggio segreta Nevenka torna nella cripta Kurt te appare era stata Neven la auccidere sìa biche il padre Adessa mentre KUrt la bacia per tuItima volta vuote pugnalarb e liberarsi di bi definitivamente Cristiano arriva appena in tempo pervadere Nevenka che parla da sola e abbraccia il vuota pugnalandosi Morente. Neven la confessa di essere stata succube di Kurt Cristiano la perdona. Nella bara in fiamme si contorce il fustino di Kurt 63
La.frusta.* il è un esempio tipico di horror italiano* con piu di un punto di contatto con LcyyibiL* &gy*to Hìcbdi Freda. Non per nulla sceneggiatore di entrambi è Ernesto Gastaldi. Le caratteristiche sono ormai codificate: 1 ambientazione genericamente ottocente sca; l'atmosfera morbosa ametàstradatra il fumetto nero (Dìa&oltà esce nel novem bre 1962) e il io manzo dapperdice; l'at trazione verso il perturbante* sospesa tra senso di colpa cattolico e consapevolezza freudiana e infine fine ertezza tra spiega zione razionaihtira e accettazione del soprannaturale. Ma viene a mancare f au ra di La maschera f impres sione di avventurarsi per h prima voltas u un terreno pericoloso. Quanto fosse spiccato 1'interesse che Mario Bava doveva provare per la storia* si evince dallasequenza in cui esistano e Katia stanno dibattendo se Kurt sia o meno un fantasma: (fai pedante campocontrocampo dei due personaggi che par lano* il regista stacca su un vaso di rose rosse (intanto il dialogo continua fuori campo)* e vi gira attorno per circa 180 gradi* fino a tornare a riprendere* sullo sfondo* 1 due attori ancora intenti a scambiarsi battute foncfementali (fot. %): ma ormai f attere io re - dello spet tatore cosi come del r^ista - se nè andata da qualche altra parte. Se Lafrusta. s ilcotpo resta affascinante* none per il morigerato sadomasochismo (Tot. 57)> che p ure all'epoca costò al film già teliate efei produttori per avere un abbas samento del divieto ai minori* una denuncia per oscenità con conseguente confisca di alcune scene e del manifesto; e non è nemmeno per il vieto tor mentone del sogno o realtà A renderlo interessante è la capacità di Bava di costruire un fantastico diffuso e impalpabile con mezzi squisitamente cinematografizi. 64
Lafruste. s il
è uro di quei filra in cui* come notava Scorsese* donne in ’rita glia ’ragano per i corridoi* e non s accede praticamente nulla 0 meglio* s u: cede che Bava dipinge le scenografie* alternando le luci naturali (zandefe* lampade* fuochi) a Ilici irreali che sembrano far parte dell'arrechmento (i colori preferiti sono gialb* azzurro* viola e verde* in genere usati in corn binazioni di due* piu di rado di tre). Allo stesso modo* Bava dipirge l'atmosfera di rumore : i sibili veri o immaginari (fella frusta il ’renio onnipresente* ma arche il mare* presenza ab bastanza are nala in uri horror [Tfes di Roger Corman è dello stes so anno). La musica di Carlo R.ustichelli (che ne riciclerà qualche tema per Operaztiw non stacca quasi mai: all'inizio urta con la sua enfasi tardororaantica* poi finisce con il diventare anches-sa un elemento «del conte le luci variopinte. Bava* sicuramente* non vuole fare paura* e ciò spiega f insuccesso commerci-afe del film. Non c'è alcuna suspense o contenu to onorifico nelle apparizioni rituali dell'orab radi Kurt* che Bava non ripren de qmsi mai nello stesso pano con Ne ’renio. Il gioco del campo-controcampo (con le inquadrature magari riprese a distanza di giorni) crea letteralmente il
compresenza «dei due personaggi* e non altro. Vediamo la mano o la fàccia di Kart che avanzano verso l'obiettivo* mentre la luce cambia due o tre volte (fòt. 58): ma per un piano che unisca i due pesonaggi dobbiamo aspettare il finale* quando Nevenka e Kurt si abbracciano per f ulti ma volta (fot. 59)- -Sembrerebbe la smen tita del teorema* h. dimostrazione delf esi65
stenza di Kurt: ma subito dopo Bava ci mostra lastessascena vista con gli occhi di Cristiano e bk>enk^ «questa volta abbrac cia il vuoto (fot. 60). Chi vedeva allora la scena precedente;, quella con il fantasma (zhe non era una soggettiva si badi)? A Bava non interessa.sciogliere fambiguità* o magari impartire qualche lezio re ira sul cinema come illusione. La frustai il è un film fantastico proprio perche i conti non quadrano e la logica zoppica: non solo e non tanto nella storia, ma •soprattutto nella rappresentazione. Contraddizioni* false piste (poco prima che Kurt venga ucciso* sembra che il padre vada «da lui attraverso un passaggio •segreto che solo loro due conoscono^ equivoci che la sceneggiatura non sa
(il tormentare delle orme fangosa che rinuncio a ricostruire per pietà Ss1tirelettale): egra cosa contribuisce a creare un mondo che ha leggi (o non-
leggi) del tutta particolari Il vero fantastico è altrove: fantastico* per esempio. è il raccordo tra le nubi che circondano h luna (un fondale dipin to?) e i capelli (in fuori fuoco) di Nevenka sul cuscino* cui segue un movimento di macchina verso is udì «occhi* Tunica parte illuminata del suo volto cone in un qua dro di Alberta Martini (fot. 61). C'è una resola fissa* in Laputta t il rt-o* ed è che chiunque cammini in un corri doio viene ripreso con uri carrello in primo piano* nentre ombre e luci colora te sfilano sul suo volto: che sia vivo o che sia morto> buono oppure cattivo. La vera operatrice di irrealtà è la macchina da presa* che* con isuoi percorsi a vuoto* segue gli attori si allontana* gira loro at torno* come in una spece di L'&m aÀ$ariMt>ad (L'awèe t>aaL «di Alain Pesnais* 1?61) in ver?ione «da edicola.
Sadifmo eforìrdlsmo: Sei Awne per tassassimo
Abbandonati fantasmi e vampiri» di cui deve essere saturo^ nel 1964 Bava diri ge un thriller di ambientazione contemporanea per Ibttuww. Al contrario di Li ngdz&iche sapeva tx>ppe> è a colori e vengono a cadere tutti gli elementi di commedia. La Roma post Dolce vita che appare sullo sfondo è popolata da belle modelle di nazionalità indefinita» drogati e nobili penasi di vano tipo. Nelfe. coproduzione italo-franco-tedesca il nome più noto è quello di Georges de Beauregard sempre in equilibrio tra cinerea cfautore (Jean-Luc Godard e Jean-Pierre Melville; e operazioni commercili. Tra le intenzioni» verosimilmente» de quella di inserirsi nel filone tedesco di gialli ispirati dai libri di Edgar Xfàlfece» i cosiddetti Krimi» dove il si abbina a un uso sempre più audace dellerotismo e della violenza. Anche nel film di Bava scrit to cn ìmrcello Rondato e Giuseppe Barilla» f inchiesta poliziesca diventa cor nice per urtasene discene di suspense, dove vengono uccise le vittime prede stinate. Ma più che negli esempi stranieri» f intreccio diviene un mero prete sto: il film è in funzione delle sequenze di terrore e di orrore» temute e agogna te dalln spettatore-modello. Le performance dellassassino diventano fequivalente delle scene hard in un porno, e vanno valutate volta a volta per f inge gnosità della messa in scena. Il che» nell’Italia del 1964 è senza dubbio in anticipo sui tempi: da cui un divieto ai minori di 18 anni senza apparente richiesta di tagli (che invece vengono imposti al film nel 1999 per il passaggio televisivo)» ma anche uno scaco incasso. soffia il vento, e si stecca uri insegna deltatelier Christian Nel pa icq al buio, la modella Isabella viene stango lata da un assassino con il volto ricoperto da un cappuccio bianco Poco dopo, in un armadio, la contessa Cristina di ettrice delfateliet ne scopre il cadavere L'ispettore Si testi arri va sul posto e interroga i presenti. Si scope che Isabella era l'amante del tant quarto Franco Scalo Durante una sfilata Nicolo amica delladàunto ritrova per caso il diario di Isabella. Pare contenga delle rivelazioni compio mettenti per tetti Nicole decide di avvisare stalo che la richia ma poco dopo chiedendole di raggiungerlo subita II diario, lasciato incustodito scompare nel nulla Nicole va a casa di scalo dove ^aspetta t assassino senza volta dopo un lungo inseguimen to fe uccide con il guanto chiodato di u riarmate ra. Lo stilista Marco che èun tossicomane accompagna a casa Peggyc di cui è in/ano innamorata Peggy viene avvertita da una telefonata di Silvestri che Nicole è scomparso e manda vìa Marca Rimasta solo brucia il diario di isabelle che precedentemente av&a Libato a Nicole Poco prima che arrM Sitestrì. ^assassino si introduce in casa sua. cera il diario la tramortisce e la porta 67
via. La lega a una sedia e la tortura bruciandole una mano contro una stufa. Quando Peggy strappa il cappuccio all'assassino, questi le brucia la faccia contro la stufa. L’ispettore Silvestri porta al commissariato tutto l'entourage dell’atelier: Scalo, il marchese Morelli (che si è accordato con Scalo per un alibi), Marco, Massimo Morlacchi - direttore ammini strativo -e Cesare Lazzarini, un altro stilista. Decide di fermarli tutti. All'atelier la modella Creta, nervosa, chiede inutilmente alla collega Tao Li di farle compagnia. Tornata alla sua abitazione, Creta scopre il cadavere di Peggy nel bagagliaio della sua auto, e lo porta in casa. L'assassino la soffoca con un cuscino. Dopo avere trovato i due cadaveri, Silvestri rilascia i sospettati. All’atelier, Morlacchi scende in un sotterraneo dove c'è la stufa del delitto. Arriva Cristina, che spiega di avere ucciso Creta per stornare i sospetti da Morlacchi, autore dei primi tre omicidi. I due sono amanti: Morlacchi aveva ucciso il marito di Cristina, ed era ricattato da Isabella, la prima vittima. Morlacchi le propone di uccidere Tao Li e simulare un suicidio, in modo da dare la colpa a lei di tutti i delitti. Stacco brusco: il volto di Tao Li sott’acqua. L'assassino mascherato la sta annegando. Si toglie il cappuccio (è Cristina), mette il corpo di Tao Li nella vasca, e le taglia le vene: l’acqua si colora di rosso. Qualcuno bussa alla porta: è Morlacchi, ma Cristina, spaventa ta, non lo sa. Esce sul cornicione, e cade. All'atelier Morlacchi sta prendendo i gioielli dalla cassaforte. Sente un rumore: è Cristina, ancora viva, che lo accusa di averla voluta eliminare. Morlacchi la bacia protestando il suo amore, ma Cristina gli spara. Poi chiama la polizia, e crolla sul suo cadavere. La cornetta del telefono dondola.
Con radicalità insolita per l’epoca, Sei donne per [assassino è un un film sulla morte, o meglio ancora sui modi di uccidere. Ogni omicidio è diverso dall’al tro, si usano armi insolite e minacciose come una specie di guanto con due punte letali (ispirato forse all’attrezzo che dà il tìtolo a Sherlock Holmes e l'arti glio scarlatto [The Scarlet Claw, dì Roy William Neill, 1944]). DÌ più, Bava è sempre attento ai tempi dell’agonìa, al momento in cui il corpo cessa dì essere vivo e diventa una cosa inanimata. I primi due omicidi hanno la connotazione di uno stupro, per l’accanimento sulla vittima e l’iconografia allusiva (fot. 62). Certe sequenze come quella della faccia bruciata - sono di una crudeltà insolita anche e proprio per la durata: dopo avere mostrato il volto terrorizzato della ragazza arrossato dalla luce che proviene dalla stufa, Bava mostra da dietro la mano dell’assassi no che ne tiene premuto il volto contro il metal lo rovente (fot. 63), mentre in colonna sonora, sotto la musica di Rustichelli, sì sente il rumore 68
orripilante di carne che sfrigola. Foto dì scena testimoniano che Bava girò una sequenza in cui Ì1 volto ustionato veniva sollevato dalla stufa, anche se nelle copie correnti non appare. Bava però evita dì mettere in scena Ì1 sangue fino all’omicidio di Tao LÌ (fot. 64). I corpi che con segna alla morte non sono infatti che manichini, che contengono al massimo vernice — come quella che colora l’acqua della vasca, con effetto lìrico e sdrammatizzante, che verrà citato da Martin Scorsese in Kundun (Id., 1997) nella scena in cui Ì1 sangue dei monaci uccìsi arrossa una fontana. Il pathos della morte e lo shock del sadismo, tuttavìa, per quanto rappresentati con tale evi denza, vengono anche messi a distanza. Fin dalla sequenza dei tìtoli dì testa, Ì personaggi sì confondono con Ì manichini dell’atelier e sì assomigliano tutti (fot. 65). Per un probabile taglio dei costì nel reparto costumi, assassino e poliziotto sì vestono allo stesso modo; ed è facile fare confusione tra le varie modelle. La vera suspense non sta nel temere la morte delle ragazze, che è scontata, ma nel sapere quando ricom pariranno Ì loro cadaveri (fot. 66). E una moritat di fantocci quella che mette in scena Bava: e ciò che gli interessa è più Ì1 contorno che la sostanza. Dopo La frusta e il corpo, Bava e Terzano tornano a sperimentare sul colore con radicalità ancora maggiore. Se l’irrealismo cromatico del film precedente aveva una sua giustificazione nel carattere fantastico degli eventi, qui domina il puro arbitrio. Sia che girino in interno con la luce artificiale o in esterno-notte, Bava e Ter zano danno l’impressione di colorare più che dì illuminare: riempiono l’inquadratura di macchie (in genere i colorì sono due o tre: verde/viola, giallo/malva, blu/verde/viola...) che non hanno nessuna motivazione naturalìstica. L’effetto, sle gato com’è dalla suspense o dalla funzione dì segnalare il soprannaturale, sarebbe solo di un surrealismo da luna park, come non mancava 69
nel cinema di genere dell'epoca. Ma Bava non -si limita a comporre cartoline bizzarre: ancora una volta» tiene la macchina et presa in costante movimento. Duso del pano sequenza è sistema tico e» come se non bastasse» le inquadrature sono sature di oggetti e di corpi. I uCahiers du cinema?। scrissero sarcastici: ir&
.ALopm. Da un paio d'annii produttori italiani hanno cominciato adancfere in Spagna a girare western; nellaprile 1%4 Sergio Leone inizia in Almeria le riprese del film che alla fine si intitolerà ter u# pugm dì datari. Bava* come tutto il cast* adotta nuovamente uno pseudonimo inglese: ma il produttore Achille Razzi non può permettersi una trasferta iberica* e il film viene girato 71
nelfa campagna romana con i cons ueti matte shots as ugenre location ben piu monumentai. Bui un contadino che ha perso la fattoria nella guerra di Secessione arrte a vvagon City: masi fa subito scacciare per aver difeso il giovane Slim da un baro, slim porta Pud nel covo di un amico bandite ted. Insieme progettano di svaligiare la banca del paese travestiti da soldati ma nella rapina una vecchietto ci rimane secca. Pud e Slim protestane vengono pestati dagli altri banditi e lasciati in balìa degli indiani I due vengono salvati da un drappello di soldati veil che sta scortando a torte Alamo le mogli degli ufficiali Pud si spaccia per un tenente ma la recita è difficile e uno scafato sergente lo smaschera pesto. Tuttavìa decide di non rivelare nulla agli altri, perchè Pud è tonico a conoscere i costo mi degli india ni d i cui sto nno attraversa ndo i termo ri Tra Pud e Jana. u na p rigion iera che aveva ucciso un soldato sto pratore, nasce del tenero. Dopo un primo attacco degli indiani i soldati trovano crocifissi i banditi che avevano rapinato la banca tunioo supectìte è Red che si spaccia anche lui per soldato ed è costretto a consegna e i soldi Prima che gli indiani sferrino un secondo attacca Pud lascia taccampamento per cercare rinforzi che arrivano appena in tempo per salare il convoglia Red, dopo avere ucciso Slim, fogge con i soldi Pud lo raggiunga ma sarà il segante a uccidete il cattivo. Pud riconsegna il bottino al segante e si allontana con Janet, per ricominciate una nuova vite Il modello di La. stradaper Rrte .Alamo è il vsestem americano» e non vi si trova quasi nulla delle innovazioni tematiche e stilistiche che renderanno unico il Ytestem italfano di Leone» Cbrbucci» Tesseri e Sollina. Di fatto è una classica storia di interazione in cui un fuorilegge si redime e alla fine trova un posto nelfa società: più o meno come Ombre wss? (Stagecoach, di John lord» 1939)> evocato anche dalla presenza degli indfarù che è invece assai rara nel western post- leoniano. A onore della sceneggiatura di Vincenzo Gioca Pàlli cadetto che le atmosfère e i personaggi nonsono così na£ almeno per f epoca Eeroe incerto tra bene e naie Mene direttamente cfai vrestern di Anthony Mann. Sequenze come guelfa del capitano ott uso che non rispetta un cimitero indiano. manefando così allo sbara glio isuoi uomini» o come guelfa degli indfani che buttano i dollari nel fiume per far uscire allo scoperto gli avidi soldati» mostrano una sensibilità abbastanza avanzata. E fa sequenza della rapina sfalla banca coni del inguanti nervosi sotto il travestimento rasckfati» ha una buonasuspense e se si vuole anticipa addirit tura 1*apertura di LI mucchio sehwgio (The Wilddi Sam feckinpah» 1%9)> di cinque anni posteriore. Un diretto ispiratore invece potrebbe essere 72
•stato un Fbckinpah de If anno prima Sterni Cv&riim (My&r 196$) dove an altro rranipob disoldati poco eroici va a farsi massacrare in territo rio indiano Certo» nel film di Bava manca il pessimismo del regista americano» e il finale è roseo e convenzionale. Quanto alt aspetto figurativo» Bava contiene Usuo tocco. ma fa del suo meglio per evitare lasciattena. Uuso estremo del Totalscope spinge i personaggi ai margini opposti del quadro (fot. 68) cercando di infondere una certa anosita per ovvnre alla povertà delle sce nografie: cactus di cartone e notti blu in ciclorama» bo schetti delfAgro Romano e paesi di due case. Labilità con cui Bava ha supe rato i problemi logistici di Li stmdiptrRrte - dipin gendo una specie di Monu ment "'Alley su un vetro posto chvanti alTobrettivo flòt. 69)> o sostituendo gli indiani con fantocci nei campi lunghi - giunge alTorecchio del produttore Fulvio Lucisano» che lavora per Htalian International Film il ramo italiano delf American International Pictures di Samuel Z. Adroff heasa di produzione di Corman. Nel 1%4 Lucisano propone a Bava di girare un film di fantascienza tratto da un racconto dello scrittore veneziano Penato Ifetriniero Lkn Hotte dì 21 pubblicato nel gitano I960 sulla rivista i< Oltre il cielo>i. Il titolo provvisorio dinwo/^ ddLombni diventerà ftelL ^2dopo ^esperimento di Li morte v'tefte d/rifo è Punico film di fanta scienza (genere di cui è lettore appassionato) ere Bava riesce a realizzale in prima persona Dei generi dimport aziona la fantascienza è quello che ha piu difficoltà ad attecchire in ItaiR0 anche per problemi di budget. Al film di Heusch e Bava del 1958 hanno fatto seguito» con scarso successo» due film di Antonio Margherita Spaci Mw (I960) e IL piatita. degLì wm&i spwtì (1961). Ma 73
Lucisano ha alle -spalle coproduttori internazionali che sembrano assicurare una produzione d^nitosa. Lucrano invia il racconto di Pestriniero agli -spa gnoli Antonio Rorràn e Rafael J. Salvia e alTarnencano Ib Melchior; perche -scrivano una-sceneggiatura È la versione di quesf ultimo che convince di più; Bava ? affida ad Alberto Bevilacqua e al critico Callisto Cbsulich perché la riscrivano in modo più vicino al suo gusto. Melchior voleva che gli astronauti atterrassero nel Missouri per trovare PEden con Atfamo ed Èva: e se de una cosa che Bava ha sempre avuta chiara è la differenza tra auto ironia (e autou miliazione) e ridicolo involontario. Rimaneggiato cfai due sceneggiatori italiani» il film viene girato a Cinecittà nelt aprile-giugno Ffer ottenere vendibilità sui vari mercati di riferimen to» ci sono attori di media fama (l'americano Barry Sullivan» gli spagnoli Norma Bengali e Angel ArancfaX ma il budget è risicato» specie nel comparto scenografia: e Bava provvede in prima persona» con isuoi disegni, a stabilire il look del film» usando poi modellini e métte j&>&. bfel film il capo elettricista Antonio Rinaldi esordisce come direttore della fotografia» sostituendo Terzane; e come assistente alla regia è accreditato per la prima volta il primo genito di Mano» Lamberto.
Le navi spaziali Agos eCa^ot ricevono segna li da un pianeta coperto da Ita nebbia Attirata da una forza misteriosa. tArgos atterra I membri deltequipaggio, in preda a un*improvvisa follia cercano diattoccare il capito no Mark Poco dopo si risvegliano da Ila tra noe. perfettamente nor mali Ricevono un messaggio di aiuto da Salas, il capitano delfaltra astronave Una pattuglia attraversa un paesaggio di ooze e crateri di lava, e trova gli astronauti del Calyot morti con i volti dilaniati sembrano essersi uccisi tra bru II Calyot è pieno di cadaveri e ha il reattore nudea le sabotate C li uomin i delfArgos seppell isoo no i p rimi corp i c he hanno trovata ma qua ri do tornano nel Calyot gli altri cadaveri sono scomparsi così come un uomo lasciato di guardia Nodeg Mente il professor Karan, sultArgos; è certo che sul pianga esiste una fórma di vtta astile che cerca di ìmpadron fcidi foragli astio nauti sepolti escono dalle foro tombe lacerando (in talento la plastica di cui sono avvolti SultAgos Mark sventa un tentativo di sabotaggio da pa rte d i un memb io deltequ ipaggio. Wess, che rinsavisce su bita Uno degli uomini di guardia vede delle luci misteriose" e tiova il suo collega con il volto sfigura to: questi viene condotto nel laboratorio dell’Agas In lealtà non è morto, e fa una gran paura a unadeUedonneTiona Poi viene seppellito. Piu tabi, per insistenza diTorra. la sua torn tra tiene aperta: c'è solo il cellophane vuoto. Mark guida una nuova spedizione sul pianeta tiene scoperta urtastronave appartenente a urfaltra civiltà piena di scheletri mestinosi e gigarrtesc hi Per poco Maik e Sanya c i rima ngono chiusi dentici ?4
Mark decide di partile dal pianeta quando toma Saias e un altro astronauta delia Galyot che dicono di non ricordarsi nulla Mark li fa sorvegliare e li ferma appena prima che sabotino tAgos. Satas ("Non sono Satas, sono il suo corpo*), che sotto ta tuta è uno scheletro» spiega il mistero. Il pianeta è abitato da una razza d i a tieni che si sta estinguendoe ha bisogno dei corpi altrui per vivere per questo hanno attirato in una trappola le due astio ra/ì Poi il corpo di Satas cade senza vita Mark e i suoi decidono di far saltate in aria ta Ca^ot e di toggie quanto prima Si scontrano con i lo io « compagni ora preda degli esseri misteriosi Dalla battaglia a colpidi laser tornano so lo due MarkeSanya Vfess fa partile tArgos. Ma si accorge che in Mark c'è qual cosa di strana confida la sua p ©occupazione a Sanya, ma anche lei è diventata unaliena Vifes muore nel tentativo di sabotare ^astronave. I due alieni non potendo raggiungere il pianga di Mark e V¥es$ dee ido no d i accontentarsi e scende© su u n pianeta p ù p ri mìtlva b Terra
Lasorpresa finale come segnala Curti* pare ripresa da un episodio diu4^ ooflfìdd soie (Ihirdfìwn the Sw*> 1 %0)> diretto da Richard L. Bare e tratto cfe un racconto di Richard Matheson. Pastriniero ha negato di essersi ispirato a filmo racconti precedenti* ma è abbastanza eviden te che il materiale tematico del film è in parte derivato cfe Licosa. da uà att?v moAdo (The Th'iAgfìvm Aflother 'Wortd cu Christian Nyby e Howard Hawks» 1951) e da Lìmas'iOAe degti Ultx&orpì (favarioA of the £odb Sfla&hers di Don Siegei* 19%). I temi del contagio a catena e deuimposs milita di distinguere f alieno rimonefeno» daltra parte» a ura tradizione piu antica e ben nota* guel fe dei vampiri. Innovativo e invece il rifiuto delfantropocentrismo: i protago nisti* coloro con cui b spettatore è portato a identificasi* non sono umani* come si poteva dedurre dagli strani simboli di femiera massi sulle tombe al exsto delle croci (fot. 70). ietro fe scorza futurista 2?nc>?e Aeilo spa&o è comunque un condensato del ibo nor bavfeno» e come tale viene riconosciuto anche dalla critica dellepoca. Scrive Ugo Casiraghi su idUnitài del 31 marzo 1%5: idi regista Mario Bava è» come sapete» un probo artigiano» uno che riesce sempre a for paura con niente. Il suo stile potrebbe definirei un rococò vbfeceo» nel quale gocce di sangue rosso colano nei momenti crucialbi. E un'indicazione pre ziosa del grado di autorialità con cui alfe poca veniva recepita tasta opera; e anche del fatto che lasm fomadi regista horror rOT. 70 aì ddh ^fcàintitofeto 2
75
condiziona la fruizione di un film che cerca di aprire nuovi spazi di rappresentabilità in un altro genere. D'altra parte f ibridazione tra generi diversi è chiara fin dal titolo. A riprova che la consapevolezza autoriale era presente anche nel regista* va sottoli neato come E iconografia di Hello spazi# sia un punto di raccordo di film baviani precedenti e futuri. Da La radel d>xx>#i vengono le resurrezioni chlla tomba Questa volta girate in ralenti* e con il motivo dei sacchi di cel lophane [fot. 71] > che torneranno in $ (tombole per lo.iufiad'ogtrtd) e il parti colare dello scheletro che spunta dasotto i vestiti; da-SwZ? al certi# della Terra il paesaggio hvico; mentre in Opeia&Mepauratorneranno le resurrezioni sul tavolo delf autopsia. Da perias22SM*o deriva infine il racconto cora le* in cui i personaggi sono poco caratterizzati e distinguibili f uno dall'altro. Non solo perché la sceneggiatura non da loro spessore* o perché sono inguainati in tute che hsciano scoperto solo il viso: nulla segnala infetti* quando i personaggi siano preda degli alieni* e diventino pericolosi. Ira alieni e non alieni* alla fine* non vi è nessuna differenza. Tanto piu che gli alieni non hanno forma in sé. ma assumono quella altrui: «bbnsiamo parassiti^ contesta Sahs divenuto alieno* «preferiamo padane di simbiosi^. È h metafora
perfetta di un incubo eh omologazione quale poteva nascere in unasocieta con sumista sullasciadegli "ultracorpi" di Don SregeL Mae anche h mise ex aiyme di un modo di fere cinerea povero* in cui si sdoppia l'identico: due sono le astronavi - f Argos e la Galjot - ma di fatto sono identiche; ovviamente h sce nografia (che a volte ha invenzioni piraneshne [fot. 7 2] ) era la medesima. Di assaiscarso s uc casso alfepoca* nonsi può dire che xelb spazi# abbia contribui to a lanciare una fantascienza italiana né che abbia influenzato la tetralogia della "Gamma Uno" che Antonio Margreriti gira nel 1 % 5* iniziando con Z criminali della galassia. Un'influenza sotterranea su varie generazioni di cinefili il film comunque l'ha esercitata: quando è uscito dlie* $d.> di Ridley Scott* 1$79)> la comunità cinefila 76
internazionale ha .sostenuto che almeno due motivi derivano da ttU> $>£&> '. l'astronave attirata in una trap poh su un pianeta popolato da una razza di alieni bisognosi di corpi nuovi* e h naw spaziale abbandonata (ma ancora minacciosamente in funzione), popolata daschehtd di esseri sconosciuti. Questi nel film di Bava. non sembrano essere gli alieni-vampiri ma vit time precedenti di questi ultimi (fot. 73): la coincidenza iconografica esclude comunque la casualità. Il si conclude per Bava con un lavoro alimentare per Lucisano: viene chiamato sul set di un western spagnolo. Rifigt dd Ndra&G che il veterano regista Antonio Roman sembra avere difficolta a dirigere. Fhr motivi di con tratto il nome di Bava (al contrario di quello del figlio Lamberto aiuto regista) non figura nel film finito che risulta firmato dal solo Roman; a confermare la paternità* provvede comunque un'intervista del 1970 con Luigi Cozzi pubbli cata su «New Cinema^, oltre a un documento manoscritto pubblicato da ii dove Bava lo elenca tra i suoi lavori. Alcune testimonianze, comunque, limitano f apporto di Bava a quello di una seconda urdù. Tfer iro nia della sort Rixg? dd incassa 401 milioni* più di molti altri film di Bava e si tratta comunque di un'opera poco originai e molto meno inte ressante di anche se gli spazi sono quelli* piuadosi* consentiti dalle location iberiche. Il solito, inespressivo Ken Chrk interpreta un pistolero alla Alan Ladd che si installa in una fattoria, si innamora della moglie delsuo ospite, e fa fuori una banda di delinquenti che infèsta la zona E interesse delh sceneggiatura è nullo, i personaggi privi di sfumature, l'influenza del wstem italhno qiasi assente, se non nelh colonnasonoia e in una sequenza iniziale in cui uns donatore messica no arranca ferito per tutta la durata (hi titoli di testa prima di schiattare. Sipuò immaginare di vedere h mano di Bava in alcune sequenze abbastanza elaborate (some guelfa in cui Ken Chrk sfrutta lo specchio di un saloon per uccidere un cattivo che lo minacch), o in certi usi della profondità di campo. Manon basta per giustificare il recupero di un'opera priva di interesse.
ftr quanto nato eh premesse simili* il coinvolgimento di Bava nel successivo Z dd produce un film più personale, anche se ormai anacroni7?
stioo e sostanzialmente fuori dal mercato. Il film» originariamente intitolato J&bnut eia stato iniziato da Leopoldo Savoia alte fine del 1964,. che era stato allontanato dopo che isoidi erano finiti. Bava viene chiamato in parte per la sua fama e in parte per il buon rapporto che bacon las tarde! film famencano Cameron Mitchell» che ha già diretto in Gli Mva&ri e per lassasse. Visionato il girato» decide £ b uttarlo via quasi interamente e in una settimana riesce a portare a termine il film» firmando lo come John Hold come per minimizzare il proprio ooinvolgmento. Il genere é quello vichingo di Gli MVéx>rì> ormai agli sgoccioli» ed è ampiamente ibridato con il vwtem classico. E in cobnnasonoraspiecano anacronistiche armoniche a bocca
Su una spiaggia, un'indovina predice alla regina Kaien e a suo figlio Moki il ritorno di suo mari to. il re Harald da anni dispeco in un naufragio; ma prima si dovranno guardare dal predone Hagen. Questi arringa i suoi uomini sulla spiaggia riconquisteranno il villaggio dal quale sono stati banditi da re Harald Hagen dà ondi ne di rapine Karen la vedova di Harald che intende spo sare L'indovina gli pedice la morte, ma se la ride un cavaliere solitario cerca invano ospitalità nella capanna in cui Karen e il tìglio adolescente Moki, vhono sotto mentite spoglie Quando due sgherri di Hagen arrivano a rapine Karen il cava liere li uccide e si ferma nd la fattoria Si guadagna la fiducia di Kaien e insegna al ragazzo Fuso di anco e coltelli Interrogata. Kaien raoconte al cavaliere la sua storia (mostrata in flashback). Il giorno delle nozze di Haralde Kaien. Hagen aveva p esentato come dono le teste di una donna e di un bambina la moglie e i I figlio d i Rurik un vichingo alleate di Harald, il cui villaggio Hagen aveva barbaramente assaltate. La notte stessa Rurik eia arrivato a vendicarsi \tediamo un cava liere con il ve Ito coperto da un elmo che ferisce Harald e violenta - si intuisce - Karen Si tog lie telma non è altri che il cavaliere solitario, che da anni vaga perseguitato dal rimorso Rurik ora vorrebbe rimediane proteggendo Karen Moki biondo come lui potrebbe essere suo figlia Rurik sa ha Moki da un altro agguato degli uomini di Hagen ma Karen pur riconoscente gli dice di non avere perso la speranza che un giorno torni suo marito In una locanda Rurik sfida Hagen a duella si lanciano coltelli tenno a pugni ma alla fine Hagen scappa In compenso è appena sbarcato Harald, che è sopravvissuto al naufragio e arriva alla locanda dove trova Rurik addormentata Mentre Hagen rapisce Moki Harald deciso a vendicar si sfida a duello Rurik che non ne ha la minima voglia costretta Rurik si difende con la spada disarma Harald inizia afarea pugni, finché non arriva Kaien a separarli Rurik e Harald riconci liati vanno a salvare Moki che Hagen tiene prigioniero nelle gioite sace. Hagen meditadispedireun orecchio di Moki alte madia e chiede a Harald un carico doro in riscatta Rurik trafigge il cuore di Hagen con un coltello lanciato con precisione millimetrica La famiglia di Harald è ricom posta Ru rik si a Itonta na a cavalla 78
Fossero o no previsti nella, sceneggiatura originale di Alberto Liberati e Gior gio Simonelli* in Z # abbondano i riferimenti a 2 xtiit&M. ($?&*£> di George Stevens* 1953). E un allusione a SMtteri setteggi 5&2?vA*?$. di John Ford* 19 56) si può riconoscere nellasolitudine finale dell'eroe* che contempt eh estraneo la gioia della famiglia ricomposta per merito suo. Con intelligent Bava decide però di sporcare il modello: il cavaliere generoso che affascina il ragazzo minacciando di sostituirsi al vero paternon solo potrebbe essere veramente suo padre* ma è tutf altro che senza macchia* avendo stuprato la madre. Lars Hdmstein* nel citalo curato eh Le utrat* ha interpretato Z a>ìtelti di copnrh di dollari e di diamanti e cfusarh. in santa pace nell'alcova elettronica che è co struita nelle viscere della terra un ideale in cui siete in molti a riconoscervi». E ravvisa con pertinenza 1'«ingenuità qualunquistica del personaggio che fa esplodere l'ufficio delle imposte «con gran gaudio del contri buente.!: Diabolik incarna «non già la rivolta contro h storia ma appena la protesta del cittadino che si lamenta delle tasse». Non ha torto nemmeno Tullio Kezich quando scrive su «Panorama» che si riserva un «posticino.! nello «-st lapidario degli anni Sessanta^ ed è «un campione del sottosviluppo culturale.!. Ma proprio per questo l'operazio ne baviana è più pop di quanto non gli appaia* ed è sicuramente più moderna dei KriMMoi e (di Piero Vivarelli* 8) già arrivati sullo schermo. DtàMié non usa il materiale di partenza “bassd' per denunciare o smascherare lasocietà dei con sumi come fa CautiM, mh ALpbavìlLe twz avMture Cautù#) di Jean-Luc Godard* 1% 5). Non finge di essere più roT« 91
intelligente di quello che è» come Mufety BLaist. Non vuole sembrare nem meno piu divertente e aucfece di quello che é» come Krwwtàl. o È un film kitsch che mette in crisi il concetto di prodotto commerciale» cosi come le lattine di minestra Campbell di Warhol mettono in còsi il tradizionale concetto di arte per la pedanteria e la piattezza con cui sono riprodotte. Il kitsch di D iaA^ifc» la stupidita dellas ua trama e h. povertà della sua realizza zione pongono lo spettatore di Conte alla pacoottjglia» al trucco svelato» alla pochezza dell'irnrnaginazione. Cóme i guari ri di Lichtenstein (che sembrano citati nella sequenza cf anima zione delridentikit [fot. 87]> dove i tratti mutano vorticosamente)» propone un immaginario mediocre; e come certi film di Warhol esibisce un'a moralità da quattro soldi, fin troppo simile alla morale corrente: non altro per mettono i tempi. In un mondo che sembra abitato solo da ladri e poliziotti Bava mostra la “gente" solo due volte: i fre quentatori drogati delh discoteca di "Vàlmont e i telespettatori, che sbeflègg^ano il ministro qifìndo invita i cittadini a pagare le tasse: è evidente come non si riconosca nel suo tempo» mostrandone gli opposti estremismi delh mediocrità è un film perversamente antispettacolare che finge di sedurre con immagini di modernità trasgressione» lusso» erotismo e Diabolik ed Èva che forino ? amo re tra le banconote (fot. 88); Diabolikche ruba smeraldi per buttarli in una piscina E finisce per esibire attori cani (o bravi attori sotto utilizzati: Michel Piccoli» Adolfo Ceri» Claudio Gora)» modellini ed effetti da quattro soldi È la rivincita lucidista-ideista delTart igiano» impiegato dal piu potente dei produttori* 0 una riflessione piu generale sulla vanità del cinema da parte di un regista che comincia a essere stanco e deluso» e a nonsapere piu che cosa fore* Forse a Bava del personaggio-Dhbolik inte ressa nostalgicamente piu che il lato qualun quista» queflo di manipohtore delle apparen ze» un maestro non solo di travestimenti ma di letterali come quello della
fotografia posta di fronte alla telecamera. E come il personaggio. Bava è un rraestro del l'illusione. L'immagine è piatta* non ha profondità anche quando .simula prospettive vertiginose: come nella sequenza in cui Diabolik. si arrampica su una torre grazie a ventose» sfidando ogni logica e leg^e della gravità (fot. 8?). E se 1' immagine e a due dimensioni* tanto vale saturarla incrociando Fbp Art involontarh* Optical Art inevitabi le > psirherifilia contingente all'epoca* futurismo inconscio e liberty residuala in un'orgia di coloracci stesi a campiture piatte» a meno che le immagini siano distorte e sbilenche come quelle di 2 serpente di fivco (2$v Trip> di Roger Gbrman* 1%7). ftr una volta c'è anche una colonna sonora fantasiosa com posta da un Ennio Morncone mai così precursore di John Zorn* che mescola generi e stili con estro mirabile. Certo» restano tante sequenze di raccordo» necessarie per for procedere il racconto e per soddisfare un produttore che scalpita per avere una merce commerciabile. Ma Bave* pittore raffinato e crea tore di mondi impossibili fo esattamente come Diabolik butta via* distrugge» spreca Lo fo ancora con un po' di timidezza ma in Dìa£>oi& ci sono le pre messe dels uo film più aucface in questo senso» 5 t>ami>oleperla. lw*a. d'agosto.
Bava e De Laurentiis pare che non si intendano perfettamente, e viene accan tonata l'idea di un sequel. Nell'ambito del cinema-fumetto» a De Laurentiis ns ulta più redditizia f esperienza di Ba^laxila. (di Roger Vadim 1 % 8)» scritto ch Tucfor Gates e Brian Degas» che esce poco dopo Diaùoiiè. De Laurentiis offre comunque a Bava di collaborare all'O^itf^ televisiva di Franco Rossi come supervisore degli effetti speciali. Gbn f accordo di Rossi* Bava gira il segmento di Polifemo» che nella ver sione televisva originale è diviso tra terzo e quarto epi sodio» per una durata di circa mezz'ora. Anche i titoli di testa ordinali attribuiscono a Bava h regh: rea il cartel lo è caduto nell edizione in Dvd Bava* con l'aiuto di Carlo Rambaldi* crea un ciclope ab bastanza credibile» grazie a un occhio meccanico posto sulla fronte di Samson Burke» ex divo dei peplum (fòt. ?0). Lasceneggiatura segue fedelmente il tasto omerico»
dall’arrivo di Ulisse e dei suoi compagni nella grotta del ciclope al pasto canni bale dì Polifemo, dall’accecamento alla fuga di Ulisse e dei suoi compagni aggrappati al ventre delle pecore. Le immagini suggeriscono con una certa esplicitezza i passi più cruenti: il ciclope non viene mostrato nell’atto di sfracel lare teste o di ruttare ubriaco, ma si intuisce che squarta uno dei malcapitati compagni di Ulisse, e poi ne arrostisce gli arti. Ovviamente allo spettatore è offerto solo il controcampo: le reazioni inorridite dei superstiti; ma non è quel lo che ci si aspetta da una produzione televisiva destinata a un pubblico di famiglie. Certo, l’episodio baviano è tra quelli che più si imprimono nella memoria degli spettatori. Ed è uno dei momenti più riusciti dì un’operazione innovativa, che traduce il poema omerico con un linguaggio cinematografico che parte dal peplum e arriva al mondo felliniano (evidente per esempio nell’e pisodio di Eolo). Per Bava è anche un ritorno forse nostalgico al fantastico di cartapesta, con una punta di compiacimento macabro. Bava tratta Omero alla stregua di una favola che si racconta per spaventare i bambini; da tempo sogna, d’altra parte, un film tratto dalle Fiabe italiane di Italo Calvino. Anni diffìcili: Il rosso segno della follia. Quante volte... quella notte Nel settembre-ottobre 1968 Bava gira in Spagna Un accetta per la luna di miele. Il film esce nel giugno 1970 con il titolo II rosso segno della follia dopo un supplemento di riprese all’inizio del 1969, inaugurando un periodo di pro duzioni tormentate e di distribuzioni difficili. Il set è una villa che pare appar tenesse al Caudillo. La sceneggiatura è firmata dal prolifico Santiago Moncada, assai attivo nel cinema di genere iberico dell’epoca, e spesso disin volto nei prestiti: e se la storia riecheggia elementi dei film dì Alfred Hitchcock, come Io ti salverò, Psyco {Psycho, I960) e Marnie (1964), è proba bile che la responsabilità sia più dello sceneggiatore che di Bava. Il quale, per altro, mette mano al copione con maggiore licenza del solito, dando maggior spazio al personaggio interpretato da Laura Betti, appena premiata a Venezia per Teorema (di Pier Paolo Pasolini, 1968), e subito disponibile a imbarcarsi Ìn un’impresa ben diversa: segno del prestigio dì cui poteva godere Bava anche Ìn un milieu intellettuale. Il produttore Manuel Cano insiste per un’ambientazione parigina — malgrado i nomi inglesi dei personaggi - e impone a Bava di inserire brevi scene Ìn esterno girate a Parigi. Bava si vendica, forse, facendo scrìvere ìn un francese 94
pieno dì errori i titoli di un giornale. Sberleffo a parte, si tratta dì uno dei film più controllati e personali dì Bava, come mostra Ì1 fatto che torna a firmare la fotografia. In un treno un uomo - che scambia uno sguardo con un ragazzino nel corridoio - si introduce in uno scompartimento dove una coppia di sposini si sta baciando, e li uccide con un tagliacarne. Il volto della vittima si riflette deformato nella lama, un'altra donna - in un altro tempo - urla. Stacco. Una mano afferra un trenino giocattolo. È quella di John Harrington, proprietario di un atelier di abiti nuziali ereditato dalla madre. La sua voce over lo presenta mentre si sta facendo la barba: «Sono un paranoico... ho ucciso cinque donne». Mentre riflette sulla morte, salva una mosca da un bicchiere e la dà in pasto al suo pappagallo. Sua moglie Mildred lo prende in giro perché è impotente, ma non ne vuole sapere di divorzio. John ha una stanza segreta, dove tiene decine di manichini in abito da sposa, che ama baciare. Mildred partecipa a una seduta spiritica, per evocare il primo marito. John invita nel suo atelier segreto la sua modella Alice, in procinto di sposarsi. La bacia, le fa indossare un abito da sposa, e la uccide con il tagliacarne. Quando cala l'arma, l'immagine si spezza in due, mostrando la solita donna urlante. Poi John ne mette il cada vere in un inceneritore. Il giorno seguente John, dopo un'altra lite con Mildred, assume una nuova modella, Helen, che corteggia, pur avendo saputo che si tratta della sorella di una sua modella scomparsa. La sera trova a casa Mildred, che credeva fosse partita. Sembra che stia finalmente per fare il suo dovere di marito, ma dopo che ha visto uscire acqua rossa dal lavandino, la uccide con la solita arma, indossando un velo da sposa. Mentre Mildred agonizza sulle scale, arriva l'ispettore Russell, che sospetta John degli omicidi. Ha sentito delle urla, ma John gli mostra che era la televisione, che trasmette (in bianco e nero) / Wurdalak. Russell non si accorge neanche del sangue di Mildred che gocciola. John la seppellisce. Scambio di sguardo con il solito ragazzino il quale, in flashback, trova la madre sgozzata. Per ogni delitto, riemerge un nuovo tassello nella memoria di John. Il mattino dopo, a colazione, la cameriera si rivolge alla sedia vuota di Mildred come se lei fosse pre sente. Subito dopo Mildred appare, vestita di nero. Anche nell'atelier e a una sfilata si ripetono le stesse apparizioni: tutti fanno come se Mildred fosse viva. Durante un'apparizione notturna, il fanta sma spiega a John la regola: lui sarà l'unico a non poterla vedere, e rimarrà sempre al suo fianco. Di notte John esuma il cadavere e lo brucia. Va in un night con una borsa che - si intuisce - ne contiene le ceneri. Ma il cameriere vede sempre una Mildred viva. John butta la borsa nella Senna ma la borsa, e poi Mildred, riappaiono a casa. Dopo aver svuotato la borsa nella tempesta, John si rifugia nella sua stanza da bambino, in mezzo a giocattoli meccanici. Arriva Helen e lo bacia. Si salta a John nascosto nelle tenebre (dapprima se ne vede solo l'occhio) nella casa di una ragazza conosciuta alla sfilata, e vestita da sposa. L'arrivo dell'ispettore Russell lo fa scappare. John porta Helen nella stanza segreta e la veste da sposa. Quando sta per ucciderla, ricorda di 95
esseie stato hi. da ragazzo, a uccìdere h madre e il patrigni h notte delle loro nozze Helen un'agente della polizia in incogn ito- si saka e riesce ad aprire la porta a It ispettore Russell John vene condotto in un celli lare assieme a Ita borsa deltecenerì Si ritrova di tiancoMildred (adesso sarà so lo John a poterla vedere! che gli promote di stare sempre con lui ««prima in manicomio e poi alt internet John cerca di fuggite In un altro Logo, in un altro tempo, John ragazzino, con un'aria triste, china la testa
Cóme Z ìpo, 3 MLifoiba è un film dove gli eventi osci Ih no tra realtà e allucinazione con ampi margini di indecidibilità. I mecca nismi retorici» però» -sono piu-sofisticati: non solo perche di molte sequenze è impassibile stabilire il livello di realtà- ma per la precisione concur Bava aderi sce al punto di vista dell'assassino. Insieme alt uso classico del monologo inte riore per entrare nella testa del personaggio. Bava cerca di trovare gli strumenti espressivi per rendere lo stato d'animo del protagonista. Accanto al grandangolo» emblema di una visione deformata della realtà (fot. 91 \ comincia a usare in modo sistematico il fuori fuoco» per aprire e chiudere le apparizioni del fantasma di Mildred» una Laura Betti beffarda e per fettamente in parte (fot. 92). Dove hsoggettivizzazione del racconto crea risultati innovativi anche rispetto al genere» è pro prio nel meccanismo delle apparizioni di questo personaggio. A differenza dei fantasmi tradizionali» Mildred appare prima agli estranei che alla sua vittima designata Agli occhi di John» e dello spettatore» Mildred è un fantasma che sconcerta piu per l'assenza che per la presenza. È sempre in un secondo momento che all'immagine della sedia vuota o delh. borsa con le ceneri si sosti tuisce quelh di Laura Betti. Ilsoprannaturale» quindi» è tale solo per una pedona John - che ha la coscienza sporca per il resto del mondo passa inavvertito. Questa meno reazione dello sguardo colpi sce» come contrappasso» un personaggio eminentemente voyeur. Non solo vediamo John armeggiare con un binocolo (che usa
nelsenso corretto per-spiare Alice» e capo volto per allontanare l'immagine di Mildred a cohzione) e sbucare - ch pic colo -nel buco della-senatma. John .spes so guarnh anche in macchina (fot. 93)> come se si accorgesse di un'altra presenza fàntasmatica. quella degli spettatori; e nei momenti cruciali» scambia sguardi con il fantasma di se stesso da piccolo. Il fanta sma di Mildred quindi e una visione & wo che incrina il primato dell occhio (nelh scena dell'assassinio mancato» John è ridotto a un occhio che balena nelle tenebre)» è una realtà che non trova posto in un mondo rudi nato e concentrico. E intreccio è in lotta tra una forza centripeta — che vorrebbe costruire suspense centellinando la rivelazione di un prevedibile segreto - e una centrifuga. che minala Egra del racconto. Maglio che in il #?£*>» Bava fa saltare i raccordi logici tra le sequenze. Non solo perche abbondano le ellissi - ciò di cui magari saranno responsabili i buchi della sceneggiatura e il fatto che la parte centrale» con le apparizioni della Betti» sareb be stata in parte improwisatas ul set - e mancano indizi s ufficienti che permettano una precisa collocazio ne spazio-temporale di molte sequenze. Ma anche perche» in uno stesso piano» si passa da un mondo all'altro. Si veda, per esempio» il carrello che chi mani chini delh stanza segreta porta a John e da qui - con un balzo nel tempo e nello spazio - alh seduta spiritica di Mildred O F inquadrato a nell'atelier in cui la macchina da presa passa chi primo piano di Mildred-fantasma a quello di John» per poi zoomare all'indietro e rivelare che non c'è nessuna Mildred Quesf ultimo esempio mostra non solo h funzionalità narrativa del vituperato zoom» ma anche come Bava» in questo film, si costringa a una disciplina di mezzi che sembrava dimenticata. Non mancano certo piccoli pezzi di bravura» legatisoprattutto a giochi con le s uperficispecchianti (il campo?controcampo di
John e MildfFd prima dell'omicidio» risolto coni riflessi dei loro occhisul taglacarneX eppure stilisticamente. ^iky&ZZ^è il film di Bava piu vici no allachssicitàdi L&XMxfwei demone. Bava non usa i colori in funzione irrealistica come haspesso fatto in passato» e gioca su uro tavolozza molto piu controllata; di certo» la profondità di campo che riesce a ottenere in alcune sequenze non la nulh eh invidiare al bianco e nero $òt. $4). (piando John avanza verso Alice (questa volta cammina non scivola come in tanti film bava-
ni) e le luci passano sul suo volto» sono ombre nere e non filtri colorali» come in Lafruste.* il ^o» che lo rendono tenibile. Di rossi ce ne sono meno di quanti ne pro metta il titolo: sono i bianchi degli abiti nuziali e i neri del buio ad affascinare Bava. Libero (ò quasi) cfe mnd izin m me nt i nmduttivi e con unattnce che sa recitar^ Bava resiste alfe tentazione di buttare tutto sulla parodia» e gira uno dei suoi film piu impre vedibili Còsi come il mondo dolcemente allucinato dell assassino oscilla tra illu sione e realtà» e lo spettatore tra adesione simpatetica e voglfe di punizione nei confronti del mostro» lo psycho-thriller (crisolito films ul mattai nelle parole di Bave) viene sabotato» e grazie essenzialmente alfe presenza della Betti diventa unacommedfe nera. Lo humour quindi abbonefe (basti pensare al passaggio efei fumi che escono (fella torre del forno crematorio al fumo del toast che sta bru ciando): e John Harrington» perseguitato da un fantasma ciarliero e appiccicoso» non ha festatura tragica di Norman Bates in Ma f umorismo resta interno al racconto» e non uno strumento per porlo a distanza o demolirlo. E Tinconfondibile risata della Petti che risuona nella casa vuota mentre la macchina cfe presa impazzita riprende isoffitti» si integra con nat uralezza alla sto ria Anche una boutade come f autocitazione - f unica in forma così esplicita - di I fre volti pzw. trova una sua funzione nell'intreccio. E ispettore Russell» infetti» dira di aver scoperto che in quel film non ci sono scene di urla prima della sequenza vista in televisione a casa di Harrington: e che quindi» a urlare» doveva essere qualcun altro! Un modo sottile per fere finta di non essere ironici» mentre lo si è: esattamente come quando» allinizio» Bava mostra un trenino gio cattolo dopo averne ripreso uno vero. Dal direttore delfe fotografia di Guadi* * Lutti ci si aspetterebbe» per ragioni dieconomfe» un trucchetto del genere: mail trenino finto non è 'Sero"» è proprio finto» come mostra la irono di Harrington. Cbn buona pace dello spettatore pronto a beccare l'inverosimglianza. Pfer essere lastorfe di unserfel killer velatamente necrofilo» n sg/v d*lLi fillió. è singolarmente p untano» forse per adeguaci ai criteri più. rigidi delfe cen sura spagnofe. Le sequenze di omicìdio, rispetto a dow* terlasztHiw e ai film die seguiranno» sono poco esplicite: quando cafe il tagliacame» al posto degli effetti sui corpi vediamo raffiche di immagini deformate (fot. 9 5) secondo un gusto psichedelico già sperimentato in Non si può dire» 38
tuttavia che ciò non risponda a unabgica internaall'intreocio: Jonrv perseguitato dal ricordo della madre assassinata> rimuove infetti la violenza nel momento in coi la commette. Mentre -scene come quella in cui mette il cadavere di Alice nel forno crematorio diventano, complice la colon na sonora* scene d’amore. E probabile che piu che a Hitchcock* Bava pensasse a Etaft di Luis Bunuel* 1?55)> anche per via dei nanichini: per altro già familiari dai tempi di tforwep^rL asszss'&o. •Se de un elemento di debolezza, in questo film cosi calibrato è nella chiusura narrativa secondo le regole del genere. Il colpo discena che Helen* la modella e vittima designata* era una poliziotta lascia perfettamente indifferenti. cosi come la rivelazione che Harrington aveva ucciso la madre è uno stanco calco di Fy. Sono appigli a una fruibilità del pubblico del tutto inutili* (feto che il film nonio va a vecfere nessuno malgrado una recensione lusinghiera di Tullio Kezicfe che scrive: «È apprezzabile per la qualità figurativa e l'eleganza di certe soluzioni quasi surrealiste»!. Troppo poco per attirare il pubblico che nei feb braio 1970 ha decretato il successo di daìLe pàwne in questo caso* diventa funzionale alh rappresentazione di un mondo amorale dominato da pulsioni brutali. Evlógvi dd Slitto è il primo film di Bava pienamente immerso nelh contem poraneità. Il regista di horror gotici e in costume descrive questa volta una società smaliziata e consumista che si è gjà. lascia ta alle spalle la contestazione. Vi reagisce con allegra feroca* e al tempo stesso sca valca a sinistra* per così dire* il nuovo thriller aigentiano* facendo scorrere anco ra piu sangue in un intreccio dove la vio lenza è f unica motivazione. Ciascuno dei tredici omicidi del film è gra tuito* alla luce delle convenzioni di una narrazione classica rea è al tempo stesso giustificato da una legge biologica immanente : f'éoologiadel delittd' del titolo si può intendere sia come un meccanismo di difésa Alh natura che distrugge gL speculatori che vogliono minacciarla sia come enunciazione di una legge istintiva del piu forte. Alcuni critici fanno parlato a ragione di «meccanismo quasi astratteci (tvfora) o di «dinamica irrimedabile>i (Moullet). Ma l'originalità dell'intrec cio sta anche nellassenza di ogni suspense sull identità dellassassino: per cominciare non è uno solo* e la sua identità viene sco perta casualmente e senza h. minima enfasi. In quanto quasi sempre ’'meritata"* Alla avidità o dalla scemenza del personaggio* 109
Bava mette inscena ogni morte con oompiaciuta accuratezza* come e piu che in 5# perl'a&MMM. E tocca punte sphtter per Pepoca inusitate* come nelh sequenza in cui uno dei giovani viene colpito eh una roncola in piena feccia Alla calcohta sor presa* che fasob balzare lo spettatore* segue una coch insistita e raccapricciante* in cui si assiste all"estrazione deLiarma conflccatasinelvolto (fot. 10$). Il gusto sadico* con h connessa attenzione alh zurà/tf £i assiste a impiccagioni* de capitazioni* sgozzamenti* impalamenti* strangolamenti.. .)* approda a una fenomenologh del morire* che forse è anche una sorta di metafisica del trapasso. A Bava non interessa tanto 1" omicidio in se* quan to le sue conseguenze: per questo inquadra sempre i corpi dopo che sono stati feriti mortalmente* spiandone gli ultimi sussulti come se t si nascondesse qualche segreto (fòt. 107). Nel caso della coppia trafitta sembra addirittura che le vit time continuino a copulare finché ne hanno la forza* che sa una ricerca di piacere fino all"estremo e malgrado tutto* o faffermazione alla Georges Katai Ile di una continuità tra sesso e morte. Continuità riecheggiata nella. sequenza di Simone che strangola Laura e che* datala posizione dei corpi e la violenza sembra uno stupro. Còme aveva mostrato Hitchcock in li sib&M stipate (25 w Curtail 1 %é)* uccidere una persona è un"operazione lunga e difficile* ed eliminarne il cadavere lo è ancora di piu. I corpi straziati di Bava* dopo avere vomitato sangue (come Simona che inzacchera le mani di Alberto)* rimangono in scera* ingombranti e onni presenti Quello di Donati anzi pare sem pre in circolazione* in un andirivieni comi co dentro e fuori le acque della baia È1" ul tima ostinazione biologica dell"insetto-
no
□Diro: la renitenza a scomparire. Se il ca davere di Simone riacquista dignità e Ethos infilzato alla parete (alla fine serria un crocifisso [fot. 108])* lo stesso non si può dire del conte Donati* che è laido anche da morto (quando ne riaffiora il cadavere* la mano galleggia in direzione del p ube della hippie Brigitte Skay) : non a caso Bava lo punisce mettendogli un poli po sul voltosemiputrefàtto $òt. 10?). Di Ewlcgladd dritto Bava firma anche la fotografia, contando s u un operato re Emilio ^vàrnano* scelto per fatalità a manovrare lo zoom Come in 5 per Li Lwa dty&sto il primo tentativo per eliminare gli esseri umani si compie proprio nell obiettivo: di fronte a una baiasemiselvaggia* Bava è piu interes sato alla natura cne agli uomini* e non certo per gusto decorativo (le tonalità pre ziose* autunnali* palustri sono lontane da qualunque effetto cartolina). Nel film* inoltre* i uso del fuori fuoco diventa quasi sistematico* con una pervicacia dietro cui si avverte una poetica Una sequenza emblematica merita un ap prossimativo decoupage. È un sequenza di raccordo (e quindi in apparenza insignificante) traTomicidio della bagnante e fomicidio del primo ragazzo:
1. Esterno. Fissaggio eh fuori-fuoco a fuoco: sole nel cielo - zoom indietro panorama della baia (fot. 110) 2. Esterno. Passaggio da fuori-fuoco a fuoco: primo piano della ragazza sgozzata e ormai immobile. Segue zoom verso la finestra della villa* con passaggio eh fuoco a fuori-fuoco. 3. Interno. Zoom veco il totale di Luca passaggio eh fuoco a fuori-fucco. 4. Interno. Passaggio da fuori-fuoco a fuoco: primissimo piano di Roberto e dal li i
r altra ragazza che fanno l'amore. Segue zoom verso gli occhi dell'assassino che spiano tra le tapparelle» con passaggio da fuoco a fuori-fuoco e poi ancora a fioco. 5. Esterno. Soggettiva la macchina da presa a mano cone lungo 1 muri della vil la facendo cadere un vaso di fiori. Cose e persone sono sempre sospese tra visibilità e invisibilità Se la funzione dello zoom è quella di mettere in rilievo» di avvicinare f occhio alle cose» il fuori-fuoco ne è la negazione : è il ritorno delh materia in un caos indistinto e inorganico» o forse il segno di una visione mentale» come i colori che si vedono quando si chiudono le palpebre. In Svlògiadtl Slitto il passaggio da fuorifuoco a fuoco suggerisce analogie» opera metamorfosi: come quando ciò che sembra un sole ndcielo si trasforma in un occhio che spia fot. 111). Eoe chic dell'assassino sembra quello della nat ora» il sole sempre al tramonto che splende sulh baia hh il fuori-fuoco ha anche la funzione precisa di rallentare h suspense» di private cose e persone di interesse : e quindi di mettere tra parentesi una verosimiglianza già sabotata da un ordito temporale quanto meno disinvolto. Già apprezzato altepoca da alcuni insospettabili recensori (Leonardo Autera sul i suggeri sce un posizionamento di mercato un po' ingannevole: ai argentiano. nel film» desolo lacobnnasonoradei Libra» che imita quelle dei Goblin.
La macchina da plesa si addentra in una viltà deserta Una scopa spasa le ragnatele entrano alcuni operai Dos chiama suo figlio Marco, un moccioso che sta parlando a un albera Marca attirato da un carillon, scende in cantina, e si ferma damanti a un muro di mattoni Dora toma nella villa sette anni dopo il suicidio, in mare di suo marito Cario, tossicodipendente Adesso è sposata con Bruno, pilota. Marco sembra molto affezionato al patrigno La sere mentre Dora e Pruno fanno l'amore sul dfrana si sposta una mano di porcellane e Marco si alza nel suo letta sibilando '«Porci!". il giorno dopa giocando Marco salta addosso a sua madre riproducendo la posizione di Pruno Più tardi Dora gli spiega che suo padre non eé P ite "Essere morto vuol dire andate via per sempre Marco insìste per dormire con la mamma di nottosisveglia e le tocca il viso ma è una mano da zombi quella che vediamo noi A una festa per la riaperto radei la villa. Marco dà segni di nervosismo dice a sua madre di voler ti
la uccidere, la fa inciampare. Dora è vittima di allucinazioni. Il giorno dopo si taglia con urie lametta che qualcuno ha messo tra i tasti del pianoforte. Marco la spia mentre fa la doccia, fa finta di stare male, la esaspera in ogni modo. Dora inciampa in un rastrello e si vede ghermita da una mano da zombi. Dora vorrebbe andarsene da quella casa, ma Bruno è più propenso a fidarsi del piccolo, con la sua aria da innocentino. La notte Dora ha un incubo: vede entrare una mano armata di taglierino dalla porta, apre la finestra e si trova di fronte al muro della cantina, viene minacciata da un taglierino volante che le lacera la camicia da notte. La mattina, dopo la caduta di una tapparella, ha i nervi a pezzi. Marco attacca la foto di Bruno all'altalena: mentre la fa oscillare, Bruno per un attimo perde i comandi del suo aereo. Dopo che le è stato recapitato un mazzo di rose con un biglietto scritto con grafia infantile che dice «Sei ancora mia», Dora porta Marco dallo psicologo: ma il risultato del test è che, al massi mo, il piccolo ha bisogno di affetto. A casa Dora crede di vedere gocce di sangue sul pianoforte (è solo un petalo) e che qualcuno lo suoni (è solo un disco). Marco le dà un disegno, in cui ha rappresentato la madre che uccide Carlo. Flashback: Carlo droga Dora, che lo sgozza con un taglierino. Dora ormai è convinta che il fantasma di Carlo si serva di Marco, ma Bruno non le vuole ancora credere. Nuovo incubo: Dora sembra fare l'amore con un essere invisibile, mentre i capelli le cado no sul volto. Si sveglia, e va in cantina, dove Bruno sta sfondando il muro misterioso: è lì che ha nascosto il cadavere di Carlo. Dora, impazzita, uccide Bruno con un colpo di piccone in pieno petto. Poi fugge per la casa, mentre i mobili cercano di colpirla. Carlo, ormai, si è sostituito a Marco, e le salta addosso. Dora fugge, un armadio le blocca la strada. Si apre: una mano le porge il taglierino. Dora si sgozza. Fuori Marco serve il tè a una presenza invisibile («Adesso papà a che gioco giochiamo?») e va a giocare con lui sull'altalena. Nel 1977 Shock suscita una certa delusione: Ì critici riconoscono a Bava la qualìfica di “piccolo maestro” dell’horror, ma lo rimproverano di avere perso smalto; a muovergli questa accusa, paradossalmente, spesso sono coloro che non lo hanno mai preso in considerazione quando girava le sue opere migliori (vedi Morando Morandini in una recensione su «Il Giorno» dal titolo emble matico: Il maestro del!orrore tradito dal mestiere). DÌ fatto, fin dalle prime inquadrature di Shock, si avverte un abisso rispetto a Lisa e il diavolo: luci naturalistiche e piatte, taglio quasi televisivo, niente zoom, nessuna traccia di ironia. Bisogna aspettare venticinque minuti per trovare lo stile di Bava, nella prima sequenza di allucinazione, un poemetto visivo di cui vale la pena di ren dere conto per esteso.
Dora (in primo piano) vede Marco imbronciato sull’altalena. L’altalena diventa vuota. 126
Appare un metronomo che oscilla. Il copritastiera di un pianoforte si alza e si abbassa: sembra che il piano rida. Due mani esitanti suonano la tastiera: ne vengono fuori suoni disarmonici. Cluster rabbioso. Un tramonto in fuori-fuoco è in realtà una sirin ga. Nuovo passaggio da fuori-fuoco a fuoco: questa volta è davvero il sole. Immagini di braccia, siringhe e volti distorti. Paesaggio marino con sole abbagliante. Ritorno alla realtà con il caffè che esce dalla caffettiera. L’immagine del piano che sghignazza, molti anni prima che Sam Raìmì facesse rìdere le lampade in La casa 2 {Evil Dead2, 1987), potrebbe consegnare Shock ai classici del surrealismo. E a partire da quel momento, come se il fantastico vi avesse fatto irruzione, Ì1 film cambia decisamente, e riprende con nuovi accenti il tema dell’allucinazione già visitato in La goccia d'acqua, La frusta e il corpo e LI rosso segno della follia. Al contrario che nei film precedenti, l’accento non è tanto sull’incertezza tra sogno e realtà, quanto sui modi in cui Ì1 fantastico invade Ì1 quotidiano. Che in casa aleggi una presenza soprannaturale è chiaro fin da quando la mano dì cera mica sì sposta: nessuno, se non lo spettatore, la vede muoversi, e tanto basta a dare statuto oggettivo alla presenza funesta. Bava, quindi, prende l’assunto sul serio: ma decìde dì giocare contemporanea mente sul fronte psicoanalitico. La lezione dì LI giro di vite dì Henry James è evidente: la patologia è la porta d’ingresso dei fantasmi. Che quello del pìccolo Marco sia un caso di gelosia edipica da manuale è rappresen tato con fin troppa chiarezza: ma le turbe psi chiche sono la premessa perché il fantasma di Carlo prenda possesso del corpo del figlio, o vi sì sostituisca materialmente, come nel piano in cui, senza interventi di montaggio, Marco salta in braccio a Dora, che sì ritrova faccia a faccia con il fantasma del marito (fot. 126). Nello stesso modo in cui l’ombra paterna possiede il ragazzino, il fantastico sì impadro nisce progressivamente dì una scenografia rea listica. L’inizio in sordina, piatto e didascali co, diventa così funzionale al rovesciamento della seconda parte. Suppellettili kitsch, mo127
biLu oggetti quotidiani (rastrelli» tapparelle» pianoforti) -si animano letteralmente tino ad assalire la protagonista in sequenze di rara forza fantastica» in parte prefigurata re Ih. se quenza di soli mobili di La. maschera del demonio. Anche Tarma fetale è un prosaico taglierino» non una mannaia o un suggestivo cdtelhccio: tanto più incongruo» allora è il fatto che volteggi a mezz'arie o venga brandi ta da mani verdognole. Il fantastico scaturisce così dal banale» senza luci» colon irreali» ombre goti che: quasi senza trucchi. Q sono muri che sanguinano» certo» ma non e su quelli che insiste Bava ad affascinarlo è piuttosto la chustrofobia delh fine stra che» a sorpresa è murata (fot. 127)> foce lontano retaggio di LMervo degli assenti (di Raffaello Mat arazzo» 1939). Nella sequenza del sogno erotico» il s urrealismo nasce sempli cemente dai capelli che si nbelhno alla forza di gravità (fot. 128 - nella realtà Daria Nicolodi era legata a una tavoh che veniva fetta ruotare di 180 gradi). Le distorsioni delTimmagine (fuori-fuoco» giochi di specchi e riflessi come in II rojro della.foUid} sono riservate unicamente ai flashback» mostrati secondo il punto di vista di Dora. Il presente» invece» per quanto invaso dal passalo» è chiaro e senza ombre. Rimane» in Shock, qualche cascame di paranormale anni Settanta: Tinsopportabile ragazzino David Colin Jr. ha un'aria fin troppo smaliziata (non a caso aveva già interpretato un epigono di Lèsoxista a firma Olivier Hellman alas Ovidio Assoniti : Chi sei\ 1974)» e sfoggia anche in questa occasione» in una breve sequenza» occhi verdi da figlio defdemonio. Parimenti gratuito è il caril lon alla Pfofindo reze che si sente altinizio del film. e che poi viene dimenti cato. Cbn le sue contraddizioni Shock sembra comunque indicare una nuova stracfa. per il fantastico» dopo il ripiegamento manierista e autodistruttivo di Zùtas il diavolo: una strada di economia espressiva inedita per Bava» ma ormai fuori dalle tendenze correnti in un cinema di genere prossimo alla morte» sia dal punto di vista produttivo sia da quello delle idee. Tra le saghe splatter di Lucio Pulci e le ambizioni sempre più alte di Argento» quale spazio ci può
ns
essere per Bava? Scorrendo la lista dei progetti che Mario Bava cerca invano di realizzare in questi annù almeno qrattro sono di fantascienza a partire da I camLien delie fdiefStar Rìder* scritto cfa. Lu^i Cozzi Bava conosceva bene il genera era un fedele lettore di Urann» e ci si chiede che cosa avrebbe potuto dare in questo ambito con b udget meno risicati di quelli di lerwre #ei£> . Uno dei pro
getti piu curiosi è quello di 2 wgabcKdò delb tratto dal romanzo jwZù MtthìglÀi {Vevasof* tbe fialf-Sheli) che l4iilip José Rimer ha pubblicato
con lo pseudonimo vonnegutiano di Kilgore Trout. Lo dovrebbe produrre Fulvio Lucisano» sceneggiare Lucio Battistrada (che però intervistato nel 3004> non ricordava nulla in proposito) e interpretare Paolo Villaggio» nella parte di un Fantozzi chesisveglk nell'anno 3000. tvfa. non se ne fervente: è invece un ennesimo gotico canonico e in costume> che Bava dirige nel 1979: Li Vevere dille* un mediometraggio per la serie televi siva Igtod? ì del dkwoL. Storie fe&testtobe deli Vttoce* to. Lamberto questa volta firma ufficialmente la regia insieme al padre» e la sceneggiai ora assieme all'illustre critico Gasare Garbali. Il soggetto è» ancora una volta, decisamente chssico: il racconto omonimo di Prosper Mérimée (1837). Bava suggelh specularmente la pro pria opera tornando al fantastico ottocentesco, ferendo un cinema come ormai non si usa più. E le fiamme che aprivano Li mascheri del demo# to chiudono dopo molti altri suoi film» anche Li dille (fot. 129). Netta campagna di lite, nel Roussillon. alcuni contadini scoprono una statua di \feneredi bronza il loro timore superstizioso sembra giustificata, visto che ka statua, mente viene tirata su con delle fj ni. cade su u no d i brq azzop pendolo. A lllearrfraMathiaj, disegnai) e e archeologo parigino, ospite di Monsieur de P^rehorade gen tiluomo di provincia oon ambizioni erudite Mentre un contodino racconta a Mathieu ta storia del ritrova menta appae una donna a cavalla è Clara che fra pochi giorni deve sposare Alfonsa f igl io di de Peyehorade La prima notea lite Mathieu scorge un monello chete un sasso contro la statoa la pietra rimbalza colpendo il ragazza chefugge spaventato. Poco dopouna presenza misteriosa -suggerita da una soggetta - sale lescaledi casa Peyretorade ma feseè solo la servetta che va a letto oon il padroncino 11 g torno dopoMathiaj va alla festa per il contratto d i fidanzamento e oonosceClara timida e reticente Mathieu ne è turbato tanto più che ha avuto modo di conoscere la volgarità di Alfonso Più tardi ritraendo la Venere, finisce con il disegnare il
volto di Clara. Il giorno del matrimonio, appena prima di andare in chiesa, Alfonso il bullo non resiste a una par tita di pallacorda. Per essere più libero, infila l'anello che dovrebbe dare a Clara nel dito della sta tua. Più tardi, alla sposa, consegnerà un anello più modesto che gli aveva donato una sua amante. La festa di matrimonio è chiassosa, e Clara è a disagio. Alfonso prende da parte Mathieu: è spa ventato perché la statua non gli avrebbe voluto rendere l'anello. Clara trova Mathieu solo in giar dino e lo bacia, rimproverandolo però di non «sapere sacrificare all'amore». Notte di nozze: Clara aspetta Alfonso a letto, ma entra una presenza misteriosa - preannunciata dalla solita soggettiva - che prende il suo posto, cacciandola atterrita in un angolo. Entra Alfonso e viene afferrato da due braccia che - si intuisce - lo stritolano dopo un breve sussulto. Il mattino viene ritrovato il cadavere di Alfonso. Clara è come impazzita. Una lettera comunica a Mathieu che la Venere è stata fusa per ricavarne una campana. L'ultima immagine mostra la statua tra le fiamme. Più che nei casi precedenti dì adattamento di testi letterari, la fedeltà al testo d’orìgine è puntigliosa, anche se né pedante né illustrativa. A dire Ì1 vero c’è una prima infrazione, madornale quanto inevitabile: Ì1 testo di Mérìmée è rac contato da un narratore in prima persona, mentre Bava rinuncia alla voce fuori campo — Ì1 classico procedimento con cui al cinema sì soggettivizza Ì1 racconto — e dà invece corpo, volto e nome a quella che, nel testo, era una voce anoni ma. Mathieu (Marc Potei) attraversa gli eventi come un testimone solo parzial mente coinvolto, mai veramente in perìcolo anche se non è insensìbile al fasci no delle due Veneri, e destinatario, almeno una volta, dì un’apparizione minac ciosa: quando vede riflessa la statua nel vetro della propria finestra, ma come se laVenere sì trovasse dentro la stanza, e non fuori, come nella realtà. L’innovazione della sceneggiatura rispetto al racconto di Mérìmée sta nell’accentuare l’identificazione dì Clara (nome assente nell’originale) con la statua maligna. Mérìmée vi alludeva quasi dì sfuggita: in un primo momento, quan do il narratore confronta le due creature («La sua [della sposa] espressione dì bontà, che pure non era priva d’una sfumatura maliziosa, mi ricordò, mìo malgrado, la Venere del mìo ospite. Facendo dentro dì me tale confronto, mi chiedevo se l’evidente superiorità di bel lezza della statua non dipendesse dalla sua espressione tigresca»); poi quando il padre, ubriaco, celebra le “due Veneri” che ha in casa. Bava, invece, costruisce fin dal l’inizio una rete di segnali per suggerire un’affinità tra Clara e la statua. La prima apparizione di Clara è un FOT. 130 130
breve flash, in primo piano (fot. 130), quando il contadino parla a Mathieu della «faccia da malvagia» della Venere. In seguito Mathieu, anziché ritrarre la statua, disegna Clara: forse aiutato dal fatto che la statua ha una rassomiglian za non casuale con la Nicolodi. Clara come reincarnazione di Venere apparterrebbe quindi a pieno diritto alla sfera del meraviglioso: e la sposa pudica in costume Impero cela una natura doppia (arriva infatti a baciare lo sconcertato Mathieu di propria iniziativa), quasi unendo nella stessa persona gli opposti che, Ìn La maschera del demonio^ avevano identità separata. Ma la rete di allusioni fin troppo esplicite non porta da nessuna parte: l’episodio finale, nella camera nuziale, rovescia le carte e ria pre le porte del fantastico, ossìa deH’ambÌguìtà e dell’incertezza. L’iden tificazione Clara-Venere si spezza, e la prima ne diventa anzi vìttima. Quanto alla natura della presenza che entra Ìn camera da letto, e a ciò che succede nel talamo, Bava è ancora più reticente di Mérimée che, sia pure per bocca della sposa sconvolta, descriveva il povero Alfonso a letto con il «gigante verdastro» della statua di bronzo. Nel film di Bava laVenere omicida, per quanto preceduta dalle canoniche sog gettive minacciose con rumori dì passi da convitato di pietra, si vede ancora di meno che nel racconto: e in questo modo il ridicolo è scongiurato, e il dubbio permane. Per descrivere il terrore di Clara, Bava può tornare a far uso di luci azzurre, arancioni e gialle come negli anni d’oro, grazie anche a un bravo direttore della fotografia come il giovane Nino Celeste; ma l’orrore è coperto dall’ellissi, e lascia aperti spiragli più inquietanti. Senza scomodare la psicoana lisi, La Venere dille, più che la storia di una statua omicida, è un piccolo saggio di misoginia, con annessa paura di castrazione. La Venere prima si tiene l’anel lo, e poi sì prende tutto il resto. L’unico sangue che scorre è quello del maiale sventrato che compare subito dopo l’apparizione della statua a Mathieu. Il cibo (la cena Ìn cuì Mathieu viene ingozzato, i preparativi per il banchetto di nozze e il banchetto stesso) e il sesso (nella forma degli svaghi ancillari di Alfonso) costituiscono il contro canto basso alla sfera del fantastico. E un mondo ben concreto, descrìtto da Bava con gusto bozzettìstìco e realista, quello Ìn cui fa irruzione il soprannatu rale. Il teorema, però, non si chiude: e come l’ordine viene spezzato per sem pre nel racconto, così il film rimane aperto, non spiegando nulla. Classi camente ambìguo.
131
Bava dopo Bava Nel 1979 Bava cura alcuni effetti speciali visivi di Inferno di Dario Argento: realizza una maquette con grattacieli newyorkesi, e il trucco in cui l’attrice Veronica Lazar si trasforma nella Morte. Inoltre assiste all’esordio del figlio Lamberto, che dirige Ì1 suo primo film da solo, Macabro (1980). Prodotto e cosceneggiato da Pupi Avati (che nel 1976 si era valso della consulenza di Bava per l’uomo invisìbile che appare alla fine di Bordello}, racconta un caso patolo gico tra allucinazione e soprannaturale, che discende direttamente da Shock: una donna (Bernice Stegers) si tiene nel frigo la testa di un amante, le cui performance erotiche e omicide vanno al di là di quanto consentito normal mente ai cadaveri. Alla fine della proiezione di un primo montaggio del film, Bava afferma dì poter morire in pace, sorprendendo tutti i presenti: ha solo sessantacinque anni. Intanto è sempre alla fantascienza che pensa. Dardano Sacchetti gli propone un soggetto intitolato Anomalia: un gruppo di astronauti arriva aì limiti del l’universo, dove una muraglia separa bene e male, e i mostri scolpiti su di essa prendono vita. Poi comincia a lavorare a Star Express, che scrive con Massimo De Rita. L’inizio delle riprese è fissato per il maggio 1980: producono Italo Zingarellì e Massimo Palaggi. Del film rimangono due scalettoni: la differenza maggiore è nel finale (più elaborato nel secondo) e nell’indicazione dei tagli da apportare per la versione televisiva.
Sulla Terra è avvenuta una catastrofe ecologica, e su un'astronave scassata e a corto di ossigeno si trova una compagnia eterogenea: la maitresse da saloon, Ma' Peripat; il vecchio sceriffo inter stellare Le Carré (5/c); il vecchietto ladro Old Scass-cazz (5/c); una mamma con bambino, che poi si scoprirà essere alieno; lo scienziato nevrotico Nevron; il giovane Vagabond un po' fricchettone; l'eroe tutto d'un pezzo e dal ceffone facile Old Moses; e i suoi due figli che non vedono l'ora di perdere la verginità con due adepte di Ma' Peripat. In una sfera attaccata a un uomo carbonizza to viene trovata una sostanza aliena capace di produrre sfracelli, ma anche di salvare la Terra. E qualcuno comincia a uccidere tutti i membri dell'equipaggio, in modo cruento. I sospetti cadono sul bambino alieno che va in giro con una palla stile Operazione paura. E c'è anche diffidenza per le "amebe'', forme di vita aliena conservate da Nevron, e che in realtà sono sodali con gli uomini. Alla fine si scopre che l'assassino è il Capitano che, dietro l'aria perbene, è un megaloma ne che aspira a essere come Dio e a decidere le sorti dell'universo. Vagabond lo sfida e il Capitano viene risucchiato nello spazio. 132
Lo spirito, come si vede, è scanzonato, e in qualche modo debitore del progetto di II vagabondo dello spazio. Nel 1973, non a caso, Bava ha scritto un soggetto intitolato Porno Giove, una parodia della mitologia improntata a una comicità goliardica e pecoreccia. Nel trattamento di Star Express Ì1 lato comico, va detto, fatica a fondersi con gli elementi horror e splatter. Da una parte ci sono dialo ghi parolacciari e situazioni osé (uno dei ragazzi viene minacciato di castrazione con lo stesso metodo che patisce Ninetto Davolì Ìn IIfiore delle Mille una notte [di Pier Paolo Pasolini, 1974]: ma è solo una lezione, dice il padre, «per farti capire che le scopate che faresti non valgono le inculate che beccheresti»). Evidenti anche gli elementi western: nel duello finale, il pacifista Vagabond dice al Capitano: «Quando un uomo armato incontra un uomo disarmato, l’uomo armato ha già perso». Non mancano per altro elementi di Bava puro, quasi intimi, covati da anni. Prima dì morire carbonizzato, il vecchietto si strappa la carne e cerca di suonare una melodia incantatrice usando i propri tendini come se fossero le corde del suo violino: è l’incubo raccontato da Bava a Ornella Volta nell’intervista su «Positif» nel 1971. Il cinema stava cambiando, è chiaro: ce l’avrebbe fatta Bava a conciliare nuove pretese di spettacolarità (gli effetti speciali richiesti appaiono complessi e impo nenti) ed esigenze di censura? Le intenzioni beffarde e iconoclaste, mai così sco perte, avrebbero potuto convìvere con un finale che, nella seconda versione, è da telefilm per ragazzi? Ma la morte sorprende Bava il 25 aprile 1980. Quattro giorni dopo, per una strana ironia della sorte, muore Alfred Hitchcock. Una morte così prematura ha risparmiato a Bava dì assistere alla fine del cine ma di genere italiano, di lì a poco assorbito dalla televisione e spodestato dal cinema comico, che negli anni Ottanta si afferma come unico genere di massa. Ma gli ha precluso anche la soddisfazione di vedere rivalutata e celebra ta la propria opera.
A partire dagli anni Novanta, i fan più prestigiosi di Bava vengono allo scoper to. Nel primo e più celebre dei suoi libri-intervista, Martin Scorsese dichiara: «Mi piacciono molto anche i film di Mario Bava nei quali non c’è praticamente storia, solo atmosfera, con tutta quella nebbia e le signore che camminano lungo i corridoi: sono una sorta di gotico italiano. Dal momento che ho molti televisori in casa spesso metto una di queste videocassette in un registratore, una in un altro, creando una specie di atmosfera, e giro per le stanze. Bava mi sembra appartenere al secolo scorso...» (Scorsese secondo Scorsese, Ubulìbri, Milano, 1991). Fa eco pochi anni dopo Tim Burton: «Di tutti i film che ho 133
visto, quello che mi torna sempre in mente è La maschera del demonio di Bava. È buffo perché non riesco a ricordarmi la trama, per quanto lo riveda spesso. Eppure resta sconvolgente, e le sue immagini ti bruciano nella testa. Mi ha mostrato il magnetismo, il mistero e il potere del cinema, e che qualche volta ci sono cose più importanti di una storia lineare» («Positif», n. 412, 1995). E Joe Dante coglie uno dei motivi di fascino che l’opera di questo regista poteva eser citare sui giovani cinefili anti-intellettuali: «Bava filmava la morte così amore volmente che ti faceva sentire un perverso, appena fuori dal cinema. Nessun altro ha fatto queste cose tanto bene». («Sight and Sound», n. 6, 1993). In questi stessi anni, l’industria dell’homevideo di tutto il mondo scopre che il cinema di Bava è redditizio: si moltiplicano le edizioni dei suoi film, man mano migliorate e aggiornate con l’evoluzione dei supporti (Vhs, Laserdisc, Dvd, Blu-ray). E in ambito accademico cadono i pregiudizi sui generi, che diventano anzi un nuovo, ghiotto oggetto di studio, terreno vergine, materiale per tesi di laurea e pubblicazioni. Nel decennio successivo nuove generazioni di spettatori scoprono il cinema di Bava grazie alle dichiarazioni cinefile di un regista come Quentin Tarantino, che sulla riscoperta e riappropriazione del cinema di genere italiano costruisce il proprio personaggio mediatico e, in misura molto inferiore, il proprio cine ma. Nel supermercato globalizzato del cinema del passato, il nome di Bava appare così sempre con più frequenza. Superato da tempo il vecchio gusto camp che teorizzava Susan Sontag, in cui era ancora implicito un senso di colpa; ormai abbandonata la pratica del cult movie, che presupponeva la marginalità e la semiclandestinità; all’inizio del nuovo millennio si arriva al trash di massa: che pretende di rovesciare Ì vecchi canoni accademici, imponendo un’estetica del basso, fondata sull’ammiccamento, la goliardia, l’anti-intellettualismo. Succede così che in certe comunità cinefile (all’estero, e non solo) registi come Bava (o Fulci, Deodato, Castellari, DÌ Leo) sono più divulgati, studiati e amati di Pietrangeli e di Lattuada, di Comencìni e di Monicelfi, o addirittura di registi ancora maggiori. Viene in mente il giudizio di Bava sui critici stranieri «più fessi di noi». Ma senza farsi troppo forti dell’autocritica che Bava riservava ai suoi film (e che di certo non comprendeva Ecologia del delitto e Cani arrabbiati), va detto che la sua opera sembra fatta per sfuggire dalle grinfie dì chiunque: troppo auto distruttiva per farsi prendere interamente sul serio, troppo complessa per essere etichettata come semplice cinema trash o di serie B. Bava amava certo il suo mestiere: ma più che il cinema in sé, come fabbrica di 134
racconti e di mondi, da ex pittore amava soprattutto le immagini. È quanto si è cercato dì dimostrare nelle pagine precedenti. Anche Ìn film quasi classici e per nulla autodistruttivi come La maschera del demonio e Operazione paura, c’è un singolare disinteresse nella possibilità dì articolare le immagini in un rac conto coerente. Ne segue la scelta dì costruire mondi che negano la logica dello spazio e del tempo sia quotidiano che - soprattutto - cinematografico: notti che durano troppo, notti che sembrano giorno e viceversa, spazi che sì contraggono, personaggi che svaniscono nelle pieghe del racconto, buchi che restano aperti, film che spesso non significano molto (anche se c’è chi li ha trattati alla stregua di riflessioni filosofiche sulla labilità delle apparenze). Un personaggio dì Tommaso Landolfl (nella pièce Faust 67), messo alle strette da un interlocutore alla ricerca di una morale della storia, si difende così: «Eh no, signor mìo, cavar qualcosa è troppo dire: questo poi no! La conclusione, se le piace e anche se non le piace, sarà a mìo modo, in altri termini non sarà punto una conclusione». Come l’ultimo LandoIfi, quello di Racconti impossibi li e dì A caso, anche Bava è un anarchico involontario che non vuole conclude re, un avanguardista suo malgrado arrivato al momento sbagliato. Con Ì suoi carrelli sinuosi, i suoi zoom illogici e i suoi fuori-fuoco gratuiti, si è divertito a scardinare grammatica, logica e sintassi del racconto cinematografico: ma senza fare scuola, e senza voler dimostrare alcunché. Quasi sempre impossibilitato (a causa delle sceneggiature e delle circostanze produttive) a parlare del presente, si è rivalso sulla forma. Quando ha potuto, ha mostrato gli uomini come stupidi e crudeli. Altrimenti ha fatto del suo meglio per rendere bello il brutto, e seppellire Ì suoi film in una risata.
135
Una filmografìa di Mario Bava affronta numerosi problemi. Nel caso di molti film, corrono diversi anni tra la lavorazione, la data ufficiale di produzione, il visto di censura e la distribuzione. La soluzione più logica è sembrata quella di seguire Lordine di realizzazione. Un altro problema riguarda la paternità: in numerosi film, di cui spesso è direttore della fotografia, Bava è anche co regista non ufficialmente accreditato. Distinguere tra la semplice ese cuzione di una seconda unità, un lavoro più ampio di supervisione dell’intero film, o addirittura un tocco autoriale, è materia ogni volta discutibile e spesso imponderabile. Nel testo si è privile giata l’analisi dei film che, ufficialmente diretti da altri registi, appaiono di maggior rilievo per l’evoluzione dello stile e della poetica del regista, come I vampiri e Caltiki, il mostro immortale. In sede di filmografia, il criterio inclusivo è più largo. L’elenco delle edizioni straniere non ha pretese di completezza. In queste ultime si è rinunciato inoltre a seguire le varianti dei credit, privilegiando sempre la versione italiana, con l’appoggio di fonti esterne e testimonianze. Le durate sono riscontrate sulle edizioni homevideo. Per quanto riguarda le collaborazioni non accreditate, si sono incluse solo quelle verificate su fonti attendibili, escludendo congetture fantasiose e testimonianze incerte; molto lavoro resta comunque da fare. Non sono stati reperiti i seguenti cortometraggi di cui Mario Bava è regista, direttore della fotografia (in bianco e nero), montatore e autore degli effetti speciali, e di cui si indica solo anno e titolo: Lorecchio (1946); Anfiteatro Flavio (1947); Santa notte (1947); Leggenda sinfonica (regia in collaborazione con Riccardo Melani, 1947); Variazioni sinfoniche (regia in collaborazione con Riccardo Melani, 1949); Lamore nell’arte (1950). COLLABORAZIONI E COREGIE PRIMA DELL'ESORDIO UFFICIALE
1957 I I vampiri
Regia: Riccardo Freda [e Mario Bava] ; soggetto: Piero Regnoli, Rijk Sijòstrom; sceneggiatura: Piero Regnoli, Rijk Sijòstrom; fotografia (b/n, Cinemascope, 2,35:1): Mario Bava; operatore: Corrado Bartoloni; musica: Roman Vlad; montaggio: Roberto Cinquini; scenografìa e costumi: Beni Montresor; aiuto regista: Piero Regnoli; interpreti: Gianna Maria Canale (Gisèle Du Grand/Maiguerite Du Grand), Dario Michaelis (Pierre Lantin), Antoine Balpetré (prof. Julien Du Grand), Carlo d’Angelo (ispettore), Wandisa Guida (Laurette Robert), Paul Muller (Joseph Signoret), Renato Tontini (assistente del professore), Riccardo Freda (medico dell’autopsia, non accreditato); produzione: Ermanno Donati e Luigi Carpentieri per Titanus e Affiena Cinema tografica; distribuzione: Titanus; origine: Italia, 1956; visto di censura: n. 23894 del 02/04/1957 (v.m. 16 anni); prima proiezione pubblica: 05/04/1957; incasso: 125,3 milioni; durata: 81’. 137
Titoli e uscite all'estero: Les Vampires (Francia, 1957), Der Vampir von Notre Dame (Rft, 1958), Lust ofthe Vampire, The Devil's Commandment (Usa, I960). 1958 | Le fatiche di Ercole
Regia: Pietro Francisci [e Mario Bava]; soggetto: Pietro Francisci, liberamente tratto da Le Argonautiche di Apollonio Rodio; sceneggiatura: Ennio De Concini, Piero Francisci, Gaio Fratini; fotografìa (Eastmancolor, Dyaliscope 2,35:1) ed effetti speciali: Mario Bava; operatore: Corrado Bartoloni; assistenti operatori: Ubaldo Terzane, Silvio Fraschetti; musica: Enzo Masetti, diretta da Carlo Savina; montaggio: Mario Serandrei; scenografia: Flavio Mogherini; costumi: Giulio Coltellacci; aiuto regista: Ettore G. Mattia; interpreti: Steve Reeves (Ercole), Sylva Koscina (Iole), Gianna Maria Canale (Antea, regina delle amazzoni), Ivo Garrani (Pelia), Mimmo Palmata (Ifìto), Arturo Dominici (Euristeo), Lydia Alfonsi (sibilla), Gina Rovere (amazzone), Luciana Pai uzzi (ancella), Gabriele Antonini (Ulisse), Gino Matterà (Orfeo), Andrea Fantasia (Laerte), Paola Quattrini (Iole bambina) ; produzione: Federico Teti per Oscar Film (Organizzazione Sociale Cinematografica Artistica Roma) e Galatea; direttore di produzione: Ferruccio De Martino; assistente alla produzione: Massimo De Rita; distribuzione: Lux Film; origine: Italia, 1957; visto di censura: n. 26179 del 07/02/1958; prima proiezione pubblica: 20/02/1958; incasso: 887,5 milioni; durata: 103’. Titoli e uscite all'estero: Les Travaux d'Hercule (Francia, 1958), Die unglaubichen Abenteuer des Herkules (Rft, 1959), Hercules (Gb e Usa, 1959). 1958 | La morte viene dallo spazio
Regia: Paolo Heusch [e Mario Bava] ; soggetto: Virgilio Sabel; sceneggiatura: Marcello Coscia, Alessandro Continenza; fotografìa (b/n, 1,66:1) ed effetti speciali: Mario Bava; operatore: Corrado Bartoloni; musica: Carlo Rustichelli, diretta da Pier Luigi Urbini; montaggio: Otello Colangeli; scenografìa: Beni Montresor; aiuto regista: Franco Rossetti; interpreti: Paul Hubschmid (John MacLaren), Madeleine Fischer (Kay Dandridge), Fiorella Mari (Mary MacLaren), Ivo Garrani (prof. Weisser), Gerard Landry (Randowsky), Jean-Jacques Delbo (Boetnikov), Giacomo Rossi Stuart (Stuart) ; produzione: Guido Giambartolomei per Royal Film, Lux Film (Roma), Lux Compagnie Cinématographique de France; distribuzione: Lux Film; origine: Italia/Francia 1958; visto di censura: n. 27630 del 27/08/1958; prima proiezione pubblica: 04/09/1958; incasso: 142 milioni; durata: 82’. Titoli e uscite all'estero: Le danger vient de l'espace (Francia, 1959), Death Comes from Outer Space (Gb, I960), The Day the Sky Exploded (Usa, 1961).
138
1959 I Ercole e la regina di Lidia
Regia: Pietro Francisci [e Mario Bava]; soggetto: Pietro Francisci, dalle tragedie Edipo a Colono di Sofocle e I sette a Tebe di Eschilo; sceneggiatura: Pietro Francisci, Ennio De Concini; fotografìa (Eastmancolor, Dyaliscope 2,35:1) ed effetti speciali: Mario Bava; operatore: Ubaldo Terzano; musica: Enzo Masetti, diretta da Carlo Savina (la canzone Con te per l eternità è interpretata da Marisa Del Frate); montaggio: Mario Serandrei; scenografia: Flavio Mogherini; costumi: Maria Baroni; aiuto regista: Pietro Nuccorini; interpreti: Steve Reeves (Ercole), Sylvia Lopez (Onfale, regina di Lidia), Sylva Koscina (Iole), Gabriele Antonini (Ulisse), Sergio Fante ni (Eteocle), Mimmo Palmara (Polinice), Primo Camera (Anteo), Andrea Fantasia (Laerte), Daniele Vargas (Anfiarao), Fulvia Franco (Anticlea), Cesare Fantoni (Edipo), Patrizia Della Rovere (Penelope) Sergio Ciani [poi Alan Steel] (Megreo) ; produzione: Bruno Vailati per Galatea, Lux Film, Lux Compagnie Cinématographique de France; distribuzione: Lux Film; origine: Italia/Francia 1958; visto di censura: n. 28586 del 31/01/1959; prima proiezione pubblica: 14/02/1959; incasso: 890 milioni; durata: 96’. Titoli e uscite attesterò: Hercule et la Reine de Lydie (Francia, 1959), Herkules unddie Kònigin der Amazonen (Rft, I960), Hercules Unchained(Gb e Usa, I960). 1959 I Caltiki, il mostro immortale
Regia: Robert Hamton [wc; Riccardo Freda] [e Mario Bava] ; sceneggiatura: Philip Just [Filippo Sanjust], da un’antica leggenda messicana; fotografia (b/n, 1,66:1) ed effetti speciali: Mario Bava; musica: Roberto Nicolosi; montaggio: Mario Serandrei; scenografìa e costumi: non accreditati; aiuto regista: Edoardo Fiory; coreografìa: Paolo Gozlino; interpreti: John Merivale (John Fielding), Didi Sullivan [Didi Perego] (Ellen), Daniela Rocca (Linda), Gerard Herter (Max Gunther), G.R. Stuart [Giacomo Rossi Stuart] (assistente), Victor André (prof. Rodriguez), Daniel [Daniele] Vargas (Bob), Arthur Dominick [Arturo Dominici] (Nieto), Black Bernard [Nerio Bernardi] (commissario), Gay Pearl (danzatrice);produzione: Bruno Vailati per Galatea, Samuel Schneider per Climax Pictures (Parigi); direttore di produzione: Massimo De Rita; distribuzione: Lux Film; origine: Italia/Francia, 1959 visto di censura: n. 29967 del 04/08/59 (v.m. 16 anni); prima proiezione pubblica: 08/08/1959; incasso: 94,1 milioni; durata: 76’. Titoli e uscite attesterò: Caltiki, le monstre immortel (Francia, I960), Caltiki Ràtseldes Grauens (Rft, 1960), Caltiki - The Immortal Monster (Usa, I960 e Gb, 1962). 1959 I La battaglia di Maratona
Regia: Jacques Tourneur [e Mario Bava, Bruno Vailati] ; soggetto: Alberto Barsanti e Raffaello Pacini; sceneggiatura: Ennio De Concini, Augusto Frassinetti; fotografìa (Eastmancolor, Dyaliscope 2,35:1): Mario Bava; operatore: Ubaldo Terzano; musica: Roberto Nicolosi, dirette da Pier Luigi Urbini; montaggio: Mario Serandrei; scenografìa: Vincenzo Del Prato, Mario Chiari; 139
costumi: Marisa Crimi; aiuto registi: Odoardo Fiory, Ottavio Oppo; interpreti: Steve Reeves (Filipp id e), Mylène Demongeot (Andromeda), Sergio Fantoni (Teocrito), Alberto Lupo (Milziade), Ivo Garrani (Creuso) Philippe Hersent (Callimaco), Daniela Rocca (Karis), Daniele Vargas (Dario), Miranda Campa (ancella), Sergio Ciani [poi Alan Steel] (Euro);produzione: Bruno Vailati per Galatea, Titanus, Socie té Cinématographique Lyre, Lux Compagnie Cinématographique de France; direttore di produzione: Ferruccio De Martino; assistente di pro duzione: Massimo De Rita; distribuzione: Titanus; origine: Italia/Francia 1959; visto di censura: n. 30708 del 27/11/1959; prima proiezione pubblica: 03/12/1959; incasso: 605 milioni; durata: 86’. Titoli e uscite all’estero: La Bataille de Marathon (Francia, I960), Die Schlacht von Marathon (Rft, I960), The Giant ofMarathon (Gb e Usa, I960), La batalla de Marathon (Spagna, 1961). REGIE UFFICIALI E PRINCIPALI COLLABORAZIONI 1960 I La maschera del demonio
Regia: Mario Bava; soggetto: Mario Bava, da II Vij di Nikolaj Gogol’; sceneggiatura: Ennio De Concini, Mario Serandrei [non accreditati: Mario Bava, Marcello Coscia, Dino De Palma)] fotografia (b/n, 1,85:1): Mario Bava; operatore: Ubaldo Terzano; musica: Roberto Nicolosi; mon taggio: Mario Serandrei; scenografìa: Giorgio Giovannini; costumi: Tina Loriedo Grani; aiuto reg ista: Caruso; interpreti: Barbara Steel [Steele] (strega Asa/principessa Katia), John Richardson (dottor Andrej Gorobek), Andrea Checchi (dr. Chomà Kruvajan), Ivo Garrani (principe Vajda), Arturo Dominici (Javutich), Enrico Olivieri (Costantino), Antonio Pietfederici (pope), Tino Bianchi (Ivan), Clara Bindi (ostessa), Germana Dominici (sua figlia), Mario Passante (cocchiere);produzione: Massimo De Rita per Galatea e Jolly Film; distribuzione: Unidis; origine: Italia, I960; visto di censura: n. 32584 del 05/08/1960 (v.m. 16 anni);prima proiezione pubblica: 11/08/1960; incasso: 141,1 milioni; durata: 85’. Titoli e uscite all’estero: La Masque du demon (Francia, I960), Die Stende, wenn Dracula kommt (Rft, 1961) Black Sunday (Usa 1961), Revenge of the Vampire (Gb, 1968), La mascara del demonio (Spagna, Messico), Djàvulsmasken (Svezia), Seytanin maskesi (Turchia). 1960 I Ester e il re
Regia: Mario Bava; supervisione: Raoul Walsh [nei credits: «Un film di Raoul Walsh/Regia di Mario Bava»]; soggetto e sceneggiatura: Raoul Walsh, Michael Elkins; collaborazione alla sceneg giatura: Ennio De Concini; fotografìa (Technicolor, Cinemascope, 2,35:1): Mario Bava; opera tore: Ubaldo Terzano; musica: Angelo Francesco Lavagnino, Roberto Nicolosi; montaggio: Mario Serandrei; scenografia: Giorgio Giovannini; costumi: Anna Maria Feo; aiuto regista: Ottavio Oppo; interpreti: Joan Collins (Ester), Richard Egan (re Assuero), Daniella [wc] Rocca (regina Vashti), Sergio Fantoni (Haman), Denis O’Dea (Mordecai), Rick Battaglia (Simone), Renato 140
Baldini (Clidrate), Gabriele Tinti (Samuele), Rosalba Neri (Keresh), Robert Buchanan (eunuco), Folco Lulli (Tobia) ; produzione: Raoul Walsh per Galatea; distribuzione: 20th Century Fox; orig ine: Italia/Usa I960; visto di censura: n. 33959 del 28/01/1961 ; prima proiezione pubblica: 14/12/1960 (Usa), 17/02/1961 (Italia); incasso: 424,8 milioni; durata: 109’. Titoli e uscite all’estero: Esther and the King (Usa, 1960), Esther et le Roi (Francia, 1961), Das Schwert von Persien (Rft, 1961), Esthery el rey (Spagna, 1961). 1961 | Le meraviglie di Aladino
Regia: Mario Bava; supervisione: Henry Levin [nei credits: «Un film di Henry Levin/Regia di Mario Bava»] ; soggetto: Stefano Strucchi, Duccio Tessati; sceneggiatura: Paul Tuckaoe, Silvano Reina, Franco Prosperi, Pierre Very (non accreditato: Marco Vicario); fotografìa (Technicolor, Cinemascope, 2,35:1): Tonino Delli Colli; operatore: Franco Delli Colli; musica: Angelo Francesco Lavagnino; montaggio: Maurizio Lucidi; scenografia: Flavio Mogherini; costumi: Rosine Deiamare, Giorgio Desideri; aiuto registi: Alberto Cardone, Franco Prosperi; interpreti: Donald O’Connor (Aladino), Noèlle Adam (Djalma), Milton Reid (Omar), Mario Girotti (Moluk), Fausto Tozzi (Gran Visir), Vittorio De Sica (Genio della lampada), Aldo Fabrizi (Sultano), Michèle Mercier (Zaina), Raymond Bussières (mago/astrologo), Marco Tulli (fachiro), Adriana Pacchetti (madre di Aladino), Giovanna Galletti (levatrice), Franco Ressel (aiutante del Visir); produzione: Lux Film (Roma), Lux Compagnie Cinématographique de France (Parigi), Embassy Pictures (Los Angeles); direttore di produzione: Massimo Patrizi; distribuzione: Lux Film; origine: Italia/Francia/Usa 1961; visto di censura: n. 35171 del 13/07/1961; prima proiezione pubblica: 31/10/1961; incasso: 173,2 milioni; durata: 99 ’. Titoli e uscite all’estero: Les mille et une nuits (Francia, 1962), Aladins Abenteuer (Rft, 1962), The Wonders ofAladdin (Gb e Usa, 1962). 1961 I Ercole al centro della terra
Regia: Mario Bava; soggetto e sceneggiatura: Alessandro Continenza, Franco Prosperi, Duccio Tessati, Mario Bava; fotografìa (Technicolor, Totalscope, 2,35:1): Mario Bava; operatore: Ubaldo Terzane; musica: Armando Trovatoli; montaggio: Mario Serandrei; scenografia: Franco Lolli; costu mi: Mario Giorsi; aiuto regista: Franco Prosperi; interpreti: Reg Park (Ercole), Leonora Ruffo (Deianira), Christopher Lee (Lieo), George Ardisson (Teseo), Franco Giacobini (Telemaco), Ida Galli (Miosotide), Marisa Belli (Aretusa), Mino Doro (Keros), Rosalba Neri (Egle), Ely Draco (Giocasta), Gaia Germani (sibilla), Raf Baldassarre (capo dei mercenari), Elisabetta Pavan (Tamar); produzione: Achille Piazzi per Spa Cinematografica; distribuzione: Imperiai; origine: Italia, 1961; visto di censura: n. 35906 del 17/10/1961; prima proiezione pubblica: 16/11/1961; incasso: 448,9 milioni; durata: 84’. Titoli di lavorazione: Ercole contro i vampiri, Ercole nel regno dei morti. 141
Titoli e uscite attesterò: Hercule contre les vampires (Francia, 1962), Vampiregegen Herakles (Rft, 1962), Hercules in the Center ofthe Earth (Gb, 1962) Hercules in the Haunted World (Usa, 1964). 1961 I Gli invasori
Regia: Mario Bava; soggetto e sceneggiatura: Oreste Biancoli, Piero Pierotti, Mario Bava; fotografìa (Technicolor, Dyaliscope, 2,35:1): Mario Bava; operatore: Ubaldo Terzano; musica: Roberto Nicolosi, diretta da Pier Luigi Urbini; montaggio: Mario Serandrei; scenografìa: Giorgio Giovannini; costumi: Tina Loriedo-Grani; aiuto regista: Franco Prosperi; interpreti: Cameron Mitchell (Iron), Giorgio Ardisson (Erik), Ellen Kessler (Daja), Alice Kessler (Rama), Franchise Cristophe (regina Alice), Andrea Checchi (barone Ruthford), Folco Lulli (Harald), Franco Giacobini (scudiero di Erik), Raffaele Baldassarre (arciere Blak), Franco Ressel (re Lothar), Enzo Doria (Bennet), Livia Contardi (Hadda), Jacques Delbò (Olaf);produzione: Galatea, Criterion Film, Societé Cinématographique Lyre; direttore di produzione: Massimo De Rita; distribuzione: Unidis; origine: Italia/Francia, 1961; visto di censura: n. 36204 del 01/12/1961; prima proiezione pubblica: 07/12/1961; incasso: 382,6 milioni; durata: 89’. Titoli e uscite all'estero: Die Rache der Wikinger (Rft, 1962), La Ruée des Vikings (Francia, 1963), Fury ofthe Vikings (Gb, 1963), Erik the Conqueror (Usa, 1963), La furia de los Vikingos (Spagna). 1962-1963 I La ragazza che sapeva troppo
Regia: Mario Bava; soggetto e sceneggiatura: Ennio De Concini, Enzo [Sergio] Corbucci, Eliana De Sabata, con la collaborazione di Mino Guerrini, Franco Prosperi, Mario Bava; fotografìa (b/n, 1,66:1): Mario Bava; operatore: Ubaldo Terzano; musica: Roberto Nicol osi {Furore, di CelentanoVivarelli, cantata da Adriano Celentano) ; montaggio: Mario Serandrei; scenografìa: Giorgio Giovannini; costumi: Tina Loriedo Grani; aiuto regista: Franco Prosperi; interpreti: Leticia Roman (Nora Davis), John Saxon (dottor Marcello Bassi), Valentina Cortese (Laura Craven-Torrani), Dante Di Paolo (Andrea Landini), Robert Buchanan (dottor Alessi), Gianni Di Benedetto (prof. Torrani), LuciaModugno (infermiera), Chana Coubert (Ethel), Luigi Bonos (portiere), Adriana Pacchetti (lavandaia), Milo Quesada (De Vico);produzione: Galatea e Coronet Film; organizza tore: Massimo De Rita; direttore di produzione: Paolo Mercuri; distribuzione: Warner; origine: Italia, 1962; visto di censura: n. 39415 del 26/01/1963 (v.m. 14 anni); prima proiezione pubblica: 10/02/1963; incasso: 80,1 milioni; durata: 86’. Titoli di lavorazione: L'incubo, Incubus. Titoli e uscite all'estero: La Fille qui en savait trop (Francia, 1964), The Evil Eye (Gb, 1964), Evil Eye(Vs2L, 1964).
142
1963 I I tre volti della paura
Regia: Mario Bava; soggetto: EG. Snyder (primo episodio), Lafamilledu Vourdalak di Aleksej Tolstoj (secondo episodio), Dalle tre alle tre e mezzo di P. Kettridge [Franco Lucentini] (terzo episodio); sceneggiatura: Marcello Fondato, con la collaborazione di Alberto Bevilacqua e Mario Bava [non accreditato: Ugo Guerra]; fotografia (Technicolor, 1,85:1): Ubaldo Terzano; operatore: Mario Mancini; musica: Roberto Nicolosi; montaggio: Mario Serandrei; scenografìa: Giorgio Giovannini} costumi: Tina [Loriedo] Grani; aiuto regista: Giuseppe Berta; interpreti: Il telefono: Michèle Mercier (Rosy), Lydia Alfonsi (Mary), Gustavo De Nardo (Frank); IWurdalak: Boris Karloff (Gorka), Suzy Andersen (Sdenka), Mark Damon (Vladimiro d’Uifé), Glauco Onorato (Giorgio), Rika Dialina (moglie di Giorgio), Massimo Righi (Pietro); La goccia d'acqua: Jacqueline Pierreux [Jacqueline Soussard] (Miss Chester), Milli Monti [Milly] (domestica), Harriet Medin (portinaia,); produzione: Emmepi Cinematografica, Galatea, Societé Cinématographique Lyre; direttore di produzione: Paolo Mercuri; distribuzione: Warner Bros.; origine: Italia/Francia, 1963; visto di censura: n. 40988 del 12/08/1963 (v.m. 14 anni); prima proiezione pubblica: 17/08/1963; incasso: 160,1 milioni; durata: 92’. Titoli e uscite all'estero: Black Sabbath (Gb e Usa, 1964), Die drei Gesichter derFurcht (Rft, 1964), Les trois visages de lapeur (Francia, 1965), Las tres caras del miedo (Spagna). 1963 I La frusta e il corpo
Regia: John M. Old [Mario Bava]; soggetto e sceneggiatura: Julian Berry [Ernesto Gastaldi], Robert Hugo [Ugo Guerra], Martin Hardy [Luciano Martino]; fotografia (Technicolor, 1,85:1): David Hamilton [Ubaldo Terzano]; musica: Jim Murphy [Carlo Rustichelli] ; montaggio: Bob King [Renato Cinquini] ; scenografìa: Dick Grey [Ottavio Scotti] ; costumi: Peg Fax [Anna Maria Palleri]; aiuto regista: Julian Berry [Ernesto Gastaldi]; interpreti: Daliah Lavi (Nevenka), Christopher Lee (barone Kurt Menliff), Tony Kendall [Luciano Stella] (barone Cristiano Menliff), Isli Oberon [Ida Galli] (Katia), Harriet White Medin (Giorgia), Alan Collins [Luciano Pigozzi] (Losat), Dean Ardow [Gustavo De Nardo] (conte Vladimir), Jacques Herlin (pope);pro duzione/John Oscar [Elio Scardamaglia] per Vox Film, Leone Film, Francinor, Pip; distribuzione: Titanus; origine: Italia/Francia, 1963; visto di censura: n. 41063 del 24/08/1963 (v.m. 18 anni, poi derubricato a v.m. 14 osWi}} prima proiezione pubblica: 29/08/1963; incasso: 143,4 milioni; durata: 88’. Titoli e uscite all'estero: Le Corps et le fouet (Francia, 1966), Night Is the Phantom (Gb, 1965), What? (Usa, 1965), Der Damon unddie Jungfrau (Rft, 1967), The Whip and the Body (Canada, 1967). La versione disponibile su Dvd è quella vietata ai minori di 18 anni.
143
1964 | Sei donne per l'assassino
Regia: Mario Bava; soggetto e sceneggiatura: Marcello Fondato, con la collaborazione di Giuseppe Barilla e Mario Bava; fotografìa (Eastmancolor, 1,66:1): Ubaldo Terzano; operatore: Mario Mancini; musica: Carlo Rustichelli; montaggio: Mario Serandrei; scenografìa: Arrigo Breschi; cos tumi: Tina [Loriedo] Grani; aiuto regista: Priscilla Contardi; interpreti: Eva Bartok (contessa Cristina), Cameron Mitchell (Massimo Morlacchi), Thomas Reiner (ispettore Silvestri), Arianna Gorini (Nicole), Mary Arden (Peggy), Lea Krugher [Lea Lander] (Greta), Claude Dantes (Tao Li), Dante Di Paolo (Franco Scalo), Massimo Righi (Marco), Franco Ressel (marchese Riccardo Morelli), Francesca Ungaro (Isabella), Luciano Pigozzi (Cesare Lazzarini), Harriet White Medin (cameriera), Enzo Cerusico (benzinaio), Giuliano Raffaelli (poliziotto);produzione: Massimo Patrizi, Alfredo Mirabile per Emmepi Cinematografica, Productions Georges de Beauregard, Top Films e Monachia Films; direttore di produzione: Armando Govoni; distribuzione: Unidis; origine: Italia/Francia/Rft 1964; visto di censura: n. 42445 del 10/03/1964 (v.m. 18 anni);prima proiezione pubblica: 14/03/1964; incasso: 137,3 milioni; durata: 88’. Titolo di lavorazione: L'atelier della morte. Titoli e uscite attesterò: 6 Femmes pour l’assassin (Francia, 1964), Blutige Seide (Rft, 1965), Blood and Black Lace (Usa, 1965 e Gb, 1966), Seis mujeres para el asesino (Spagna). 1964 | La strada per Forte Alamo
Regia: John Old [Mario Bava] ; soggetto: Vincent Thomas [Vincenzo Gicca Palli] ; sceneggiatura: Vincent Thomas, Charles Price [Franco Prosperi], Jane Brisbane [Livia Contardi] ; fotografìa (Eastmancolor, TotalScope 2,35:1): Bud Third [Ubaldo Terzano]; operatore: Claude Raguse [Claudio Ragona]; musica: Piero Umiliani (The Way to Alamo cantata da Tony Wendall); montag gio: Wilson Dexter [Mario Serandrei] ; scenografia: Demos Philos [Demofìlo Fidani] ; costumi: Mila Vance [Mila Vitelli]; aiuto regista: Charles Price [Franco Prosperi]; interpreti: Ken Clark (Bud Massedy), Jany Clair (Janet), Michel Lemoine (Red Carson), Andreina Paul (signora Collins), Kirk Bert [Alberto Cevenini] (Slim), Anthony Gradwell [Antonio Gradoli] (capitano Hull);produzione: Pier Luigi Torri per Protor Film, Piazzi Produzione Cinematografica, Comptoir Francis du Film Production; distribuzione: Bel otti Film; origine: Italia/Francia, 1964; visto di censura: n. 43923 del W)l\^lW>k>^\ prima proiezione pubblica: 24/10/1964; incasso: 173 milioni; durata: 78’. Sui manifesti la grafìa è La strada per Fort Alamo. Titoli e uscite attesterò: Arizona Bill (Francia, 1965), DerRitt nach Alamo (Rft, 1965), The Road to Fort Alamo (Usa, 1966). 1965 I Terrore nello spazio
Regia: Mario Bava; soggetto: dal racconto Una notte di 21 ore di Renato Pestriniero; sceneggiatura: Ib Melchior, Alberto Bevilacqua, Callisto Cosulich, Mario Bava, Antonio Roman, Rafael J. 144
Salvia; fotografìa (Technicolor, 1,85:1): Antonio Rinaldi; operatore: Saverio Diamanti; musica: Gino Marinuzzi Jr.; effetti elettronici: Paolo Ketoff; montaggio: Romana Fortini, Antonio Gimeno; scenografìa: Giorgio Giovannini; costumi: Gabriele Mayer; aiuto registi: Serena Canevari, Manuel San Roman; assistente alla regia: Lamberto Bava; interpreti: Barry Sullivan (capitano Mark Markary), Norma Bengell (Sanya), Angel Aranda (Wess), Evi Marandi (Tiona), Fernando Villena (prof. Karan), Stelio Candelli (Mud), Massimo Righi (Nordeg), Mario Morales (Eldon), Franco Andrei (Garr), Ivan Rassimov (Carter), Rico [Federico] Boido (Keir), Alberto Cevenini (Wan);produzione: Fulvio Lucisano per Italian International Film (Roma) e Castilla Cooperativa Cinematografica (Madrid); organizzazione generale: Giorgio Silvestri; distribuzione: Sidis; origine: Italia/Spagna, 1965; visto di censura: n. 45629 del 03/09/1965 (v.m. 18 anni);/>nwMfproiezione pubblica: 15/09/1965; incasso: 57,2 milioni; durata: 88’. Titoli e uscite attesterò: Planet ofthe Vampires (Usa, 1965, Gb, 1968), Terror en el espacio (Spagna, 1966), Elpianeta de los vampiros (Messico, 1967), Planet der Vampire (Rft, 1969). 1965-1966 I Ringo del Nebraska
Regia: Anthony [Antonio] Roman [e Mario Bava, non accreditato] ; soggetto: Jesiis Navarro, Antonio Roman; sceneggiatura: Jesiis Navarro, Antonio Roman, Adriano Bolzoni; dialoghi: Adriano Bolzoni, Grazia Benedetti; fotografia (Eastmancolor, Techniscope, 2,35:1): Guglielmo Mancori; operatori: Mario Sbrenna, Felix Miron; musica: Nino Oliviero, diretta da Robby Poitevin; montaggio: Renato Cinquini, Antonio Gimeno; scenografìa: Gastone Carsetti, Augusto J. Lega; costumi: Rafael Arienzo; aiuto registi: J. Manuel de la Rasilla, Lamberto Bava; interpreti: Ken Clark (Ringo Nebraska), Yvonne Bastien (Kay Hillman), Peter Carter [Piero Lulli] (Bill Carter), Red Ross [Renato Rossini] (Lou Felton), Charles K. Lawrence [Livio Lorenzon] (Marty Hillman), Paco Sanz (Parson);produzione: Fulvio Lucisano per Italian International Film, Castilla Cooperativa Cinematografica; distribuzione: Sidis; origine: Italia/Spagna, 1965; visto di censura: n. 46675 del 22/03/1966; prima proiezione pubblica: 18/03/1966; incasso: 401,7 mil ioni; durata: 86’. Titoli e uscite attesterò: Nebraska Jim (Rft, 1966), Savage Gringo (Usa, 1966), Les dollars du Nebraska (Francia, 1967), El rancho maldito (Spagna, 1968). 1966 I I coltelli del vendicatore
Regia: John Hold [Mario Bava] [e Leopoldo Savona] ; soggetto e sceneggiatura: Alberto Liberati, Giorgio Simonelli, Mario Bava; fotografia (Technicolor, Techniscope, 2,35:1): Antonio Rinaldi; operatore: Saverio Diamanti; musica: Marcello Giombini; montaggio: Otello Colangeli; scenografìa: Piero Filippone; costumi: Giorgio Desideri; aiuto registi: Roberto Giandalia, Ines Brusci; interpreti: Cameron Mitchell (Rurik), Fausto Tozzi (Hagen), Lissa [Elisa Mitchell/Elissa Pichelli] (Karen), Jack Stuart [Giacomo Rossi Stuart] (re Harald), Luciano Polletin (Moki), 145
Michael Moore [Amedeo Trilli] (re vichingo); produzione: Saro Parane per Sider Film; dis tribuzione: Regionale; origine: Italia, 1966; visto di censura: n. 47021 del 10/05/1966; prima proiezione pubblica: 30/05/1966; incasso: 134,8 milioni; durata: 87’. Iniziato da Leopoldo Savona con il titolo Helmut il solitario. Rieditato nel 1970 con il titolo Raffica di coltelli. Titoli e uscite attesterò: Duel au couteau (Francia, 1966; riedito come La Vengeance du Viking e Le 7 couteaux du vengeur), Eine Handvott blanker Messer (Rft, 1967), Knives ofthe Avenger (Usa, 1968), 1966 | Operazione paura
Regia: Mario Bava; soggetto: Romano Migliorini, Roberto Natale; sceneggiatura: Romano Migliorini, Roberto Natale, Mario Bava; fotografia (Eastmancolor, 1,85:1): Antonio Rinaldi; operatore: Saverio Diamanti; musica: Carlo Rustichelli (e Roman Vlad, non accreditato); montag gio: Romana Fortini; scenografìa: Sandro Dell’Orco; costumi: Tina [Loriedo] Grani; aiuto regista: Lamberto Bava; interpreti: Giacomo Rossi Stuart (dottor Paul Esway), Erika Blanc (Monika Schuftan), Fabienne Dali (Martha), Piero Lulli (commissario Kruger), Max Lawrence [Luciano Catenacci] (Kerl), Micaela Esdra (Nadine), Giana Vivaldi [Giovanna Galletti] (baronessa Graps), Giuseppe Addobbati (oste), Mirella Panphili (ostessa), Valerio Valeri (Melissa Graps), Franca Dominici (Irina) ; produzione: Nando Pisani e Luciano Catenacci per Fui Film; distribuzione: Indief; origine: Italia, 1966; visto di censura: n. 47160 del 07/06/1966 (v.m. 14 \ prima proiezione pubblica: 08/07/1966; incasso: 54 milioni; durata: 85’. Titoli e uscite attesterò: Kill, Baby... Kill! (Usa, 1966), Curse ofthe Living Dead (Gb, 1967), Die toten Augen desDoktor Dracula (Rft, 1970), Operationpeur (Francia). 1966 I Le spie vengono dal semifreddo
Regia: Mario Bava; soggetto: Fulvio Lucisano (James Hartford per la versione americana); sceneg giatura: [Franco] Castellano e Pipolo [Giuseppe Moccia] (Louis M. Heyward e Robert Kaufman per la versione americana); collaborazione ai dialoghi: Franco Del Cer; fotografia (Technicolor, 1,85:1): Antonio Rinaldi; operatore: Saverio Diamanti; musica: Lallo Gori (Bang Bang Kissene, di De Paolis, Castellano e Pipolo, interpretata da Franco Franchi); montaggio: Federico [Frederick] Miiller; scenografìa: Gastone Carsetti; costumi: Ugo Pericoli; aiuto regista: Lamberto Bava; inter preti: Franco Franchi (Franco), Ciccio Ingrassia (Ciccio), Vincent Price (dottor Goldfoot), Fabian [Fabiano Anthony Forte] (Bill Dexter), Laura Antonelli (Rossana), MoaTahi (assistente di Goldfoot), Francesco Mule (colonnello Benson), Mario Bava (angelo, non accreditato); pro duzione: Fulvio Lucisano per Italian International Film (Roma), Louis M. Heyward per American International Pictures (Los Angeles); direttore di produzione: Antonio Raffa; dis tribuzione: Sidis; origine: Italia/Usa, 1966; visto di censura: n. 47392 del 22/07/1966; prima proiezione pubblica: 29/07/1966; incasso: 485,2 milioni; durata: 85’. 146
Rieditato nel 1972 con i titoli II clan dei due mafiosi e I due mafiosi dell'Fbi. Titoli e uscite all'estero: Dr. Goldfoot and the Girl Bombs (Usa, 1966). 1967-1968 I Diabolik
Regia: Mario Bava; soggetto: Angela e Luciana Giussani, Dino Maiuri, Adriano Baracco, dal fumet to omonimo; sceneggiatura: Dino Maiuri, Brian Degas, Tudor Gates, Mario Bava; fotografia (Technicolor, 1,85:1): Antonio Rinaldi; musica: Ennio Morricone {Deep Down cantata da Christy); montaggio: Romana Fortini; scenografia: Flavio Mogherini; costumi: Luciana Marinucci, Giulio Coltellacci; aiuto regista: Lamberto Bava; interpreti: John Phillip Law (Diabolik), Marisa Meli (Èva Kant), Michel Piccoli (ispettore Ginko), Adolfo Celi (Ralph Valmont), Claudio Gora (capo della polizia), Terry-Thomas [Thomas Terry Hoar Stevens] (ministro degli interni), Renzo Palmer (nuovo ministro), Mario Donen (sergente Danek), Caterina Boratto (Lady Clark), Edward Febokelleng (sir Edward Clark), Andrea Bosic (direttore della banca), Giulio Donnini (dottor Vernier), Lucia Modugno (prostituta), Carlo Croccolo (camionista), Annie Gorassini (amante di Valmont), Giorgio Sciolette (medico dell’obitorio), Giuseppe Fazio (Tony), Lydia Biondi (poliziotta), Tiberio Mitri, Francesco Mulè, Isarco Ravaioli, Federico Boido;produzione: Dino De Laurentiis Cinematografica (Roma), Marianne Production (Parigi); direttore di produzione: Bruno Todini; distribuzione: Paramount; origine: Italia/Francia, 1967; visto di censura: n. 50416 del 15/12/1967; prima proiezione pubblica: 24/01 /1968; incasso: 713,5 milioni; durata: 10 T. Titoli e uscite all'estero: Diabolik (Francia, 1968, Jugoslavia, Spagna e Messico, 1969), Gefahr: Diabolik (Rft, 1968), Danger: Diabolik (Usa, 1968, Gb, 1969). 1968 I Odissea
Regia: Franco Rossi, Mario Bava (episodio di Polifemo) [e Piero Schivazappa, non accreditato (episodio del cavallo di Troia)] ; soggetto: dal poema omonimo di Omero; sceneggiatura: Giampiero Bona, Vittorio Bonicelli, Fabio Carpi, Luciano Codignola, Mario Prosperi, Renzo Rosso; fotografia (Technicolor, 1,33:1): Aldo Giordani; operatore: Sergio Bergamini; musica: Carlo Rustichelli, diretta da Bruno Nicolai; montaggio: Giorgio Serralonga, Romana Fortini; scenografìa: Luciano Ricceri; costumi: Dario Cecchi; effetti speciali: Carlo Rambaldi [non accredi tato]; aiuto regista: Lamberto Bava; interpreti dell'episodio di Polifemo: Bekim Fehmiu (Ulisse), Samson Burke (Polifemo) \ produzione: Dino De Laurentiis Cinematografica, Rai Radiotelevisione Italiana, Ortf, Bavaria, Jadran Film; produttore esecutivo: Vittorio Bonicelli; orig ine: Italia/Francia/Germania/Jugoslavia, 1968; prima trasmissione: 24 marzo - 5 maggio 1968; durata: otto puntate per 640’ complessivi (l’episodio diretto da Bava è diviso tra terza e quarta puntata e dura circa 30’). Una versione cinematografica dal titolo Le avventure di Ulisse (105’) viene distribuita in sala nel 1969. 147
Titoli e uscite attesterò: UOdyssée (Francia, 1969), Die Odyssee (Rft, 1969), Las aventuras de Ulises (Spagna, 1971). 1968-1970 I II rosso segno della follia
Regia: Mario Bava; soggetto: Santiago Moncada; sceneggiatura: Santiago Moncada, Mario Musy, Mario Bava; collaborazione ai dialoghi: Laura Betti [non accreditata] ; fotografìa (Eastmancolor, 1,85:1): Mario Bava; operatori: Emilio Varriano, Jaime Deu Casas, Antonio Rinaldi; musica: Sante Romitelli; montaggio: Soledad Lopez Ramirez; scenografia: Jesus Maria Herrero, Giulia Mafai; costumi: José Maria Tresserra; aiuto registi: Lamberto Bava, Mario Bianchi; interpreti: Stephen Forsyth (John Harrington), Laura Betti (Mildred Harrington), Dagmar Lassander (Helen), Femi Benussi (Alice), Jesiis Puente (ispettore Russell), Alan Collins [Luciano Pigozzi] (Vences), Antonia Mas (Louise), Gerard Tichy (dottor Kalleway), Veronica Llimera (Betsy), Silvia Lienas (Vicky), Guido Barlocci (John Harrington ragazzo);produzione: Manuel Cano Sanciriaco per Mercury Produzione Films (Roma), Pan Latina Films (Madrid); coproduttore: Giuseppe Zaccariello [non accreditato]; distribuzione: Mgm; origine: Italia/Spagna, 1969 (riprese nel 1968-1969); visto di censura: n. 55164 del 16/12/1969 (v.m. 18 anni); prima proiezione pub blica: 02/06/1970; incasso: 50,4 milioni; durata: 88’. Titolo di lavorazione: Un accettaper la luna di miele. Titoli e uscite attesterò: Un hacha para la luna de miei (Spagna, 1970), Blood Brides (Gb, 1973), Hatchetfior the Honeymoon (Usa, 1974, Tv), Une hache pour la lune de miei (Francia). La versione italiana del film appare perduta; in homevideo è disponibile la versione doppiata in inglese. 1968-1972 | Quante volte... quella notte
Regia: Mario Bava; soggetto e sceneggiatura: Cari Ross, Mario Moroni; dialoghi: Guido Leoni; fotografìa (Eastmancolor, 1,85:1): Antonio Rinaldi; operatore: Salvatore Caruso; musica: Lallo Goti; montaggio: Otello Colangeli; scenografìa: Andrea Crisanti; costumi: Blanda; aiuto registi: Lamberto Bava, Claudio Rainis; interpreti: Daniela Giordano (Tina), Brett Halsey (Gianni Preda), Pascale Petit (Esmeralda), Dick Randall (portinaio), Brigitte Skay (modella), Valeria Sabel (madre di Tina), Michael Hinz (Giorgio), Rainer Basedow (psicologo), Calisto Calisti (lat taio) \ produzione: Zeljko Kunkera, Dick Randall e Claudio Rainis per Delfino Film (Roma), Hape Film (Monaco); produttore esecutivo: Alfred Leone; distribuzione: Regionale; origine: Italia/Rft 1969 (riprese nel 1968); visto di censura: n. 57791 del 05/03/1971 (v.m. 18 anni); prima proiezione pubblica: 15/07/1972; incasso: 143,6 milioni durata: 86’. Il film viene presentato in censura nel 1969-70 con il titolo di lavorazione Quattro volte... quella notte senza ottenere il nulla osta. Nel 1971 una seconda versione del film viene presentata in cen sura con il titolo Una notte fatta di... bugie, che però non viene utilizzato per la distribuzione; nel 148
1972 infatti il film esce con il titolo definitivo Quante volte... quella notte. La versione in Dvd pare comunque corrispondere a quella del 1969. Titoli e uscite all’estero: Four Times That Night (Usa, 1972), VierMal heute Nacht (Rft). 1969-1970 I 5 bambole per la luna d'agosto
Regia: Mario Bava; soggetto e sceneggiatura: Mario Di Nardo; fotografia (Eastmancolor, 1,85:1): Antonio Rinaldi; operatore: Emilio Varriano; musica: Piero Umiliani {Tisveglierai accanto a me di Jerusso, Simonelli e Umiliani, interpretata da II Balletto di Bronzo); montaggio: Mario Bava; scenografia: Giuseppe Aldrovandi; costumi e arredamento: Giuliana Mafai; aiuto regista: Mario Bianchi; interpreti: William Berger (Gerry Farrell), Ira von Furstenberg (Trudi Farrel), Edwige Fenech (Mary Chaney), Maurice Poli (Nick Chaney), Teodoro Corrà (George Stark), Edith Meloni (Jill), Howard Ross [Renato Rossini] (Jack Davidson), Helena Ro née (Peggy), Justine Gall [Ely Galleani] (Isabelle), Mauro Bosco (Charles) ; produzione: Pac - Produzione Atlas Cinematografica; direttore di produzione: Luigi Aessi; distribuzione: Dear; origine: Italia, 1970 (riprese nel 1969); visto di censura: n. 55536 del 13/02/1970 (v.m. 18 anni); prima proiezione pubblica: 14/02/1970; incasso: 126 milioni} durata: 81\ Titoli e uscite all’estero: 5 Dolls for an August Moon (Gb, 1971), 5 Filles dans une nuit chaude d’été (Francia, 1972; rieditato in video come L’Ile de l’épouvante}, 5 munecaspara la luna de agosto (Spagna). 1970 I Roy Colt e Winchester Jack
Regia: Mario Bava; soggetto e sceneggiatura: Mario Di Nardo; fotografìa (Eastmancolor, 1,85:1): Antonio Rinaldi; operatore: Emilio Varriano; musica: Piero Umiliani {Roy Colt, di UmilianiGizzarelli, eseguita dai Free Love) ; montaggio: Olga Pedrini; scenografìa e costumi: Giuliana Mafai; aiuto regista: Lamberto Bava; interpreti: Brett Halsey (Roy Colt), Charles Southwood (Winchester Jack), Marilù Tolo (Mahila), Teodoro Corrà (Reverendo), Isa Miranda (maitresse), Lee Burton [Guido Lollobrigida], Bruno Corazzati, Mauro Bosco, Rick Boyd [Federico Boido], Vincenzo Crocitti; produzione: Mario Bregni per Produzione Atlas Cinematografica, Tigielle 33; direttore di produzione: Luigi Aessi; distribuzione: Pac; origine: Italia, 1970; visto di censura: n. 56213 del 17706/1970; primaproiezione pubblica: 13/08/1970; incasso: 254,5 milioni; durata: 88’. Titoli e uscite all’estero: Drei Halunken undein Halleluja (Rft, 1973), Roy Colt y Winchester Jack (Spagna). 1970 I I futuribili [serie di caroselli per la Tv]
Regia, sceneggiatura, direttore della fotografìa (b/n, 1,33:1), effetti speciali: Mario Bava; musica: Giulio Songini; produzione: Sandro Bolchi, Mario LanranchiperTed Bates/BL Vision; cliente: Mobil Oil. 149
1971 I Ecologia del delitto
Regia: Mario Bava; soggetto: Dardano Sacchetti, Franco Barberi; sceneggiatura: Filippo Ottoni, Mario Bava, Joseph McLee [Giuseppe Zaccariello] ; fotografìa (Technicolor, 1,85:1): Mario Bava; operatore: Emilio Varriano; musica: Stelvio Cipriani; montaggio: Carlo Reali; scenografia: Sergio Canevari; costumi: Enrico Sabbatini; aiuto regista: Lamberto Bava; effetti speciali: Carlo Rambaldi; interpreti: Claudine Auger (Renata Donati), Luigi Pistilli (Alberto Donati), Claudio Volonté (Simone), Laura Betti (Anna Fossati), Leopoldo Trieste (Paolo Fossati), Chris Avram (Franco Ventura), Anna Maria Rosati (Laura), Isa Miranda (Federica Donati), Brigitte Skay (ragazza che si tuffa), Paola Rubens [Paola Montenero] (ragazza trafitta), Roberto Bonanni (Roberto), Guido Boccaccini (Luca), Giovanni Nuvoletti (conte Filippo Donati), Nicoletta Elmi e Renato Cestié (figli di Renata e Alberto) ; produzione: Giuseppe Zaccariello per Nuova Linea Cinematografica; direttore di produzione: Fernando Franchi; ispettore di produzione: Roberto Cicutto; distribuzione: Regionale; origine: Italia, 1971; visto di censura: n. 58688 del 12/08/1971 (v.m. 18 anni);/>n7»tf proiezione pubblica: 08/09/1971; incasso: 88,9 milioni; durata: 85’. Rieditato nel 1972 con il titolo Reazione a catena (Ecologia del delitto). A questa seconda versione corrispondono tutte le edizioni homevideo. La sceneggiatura depositata alla Biblioteca Luigi Chiarini si intitola L’antefatto, che è il probabile titolo di lavorazione; e come Antefatto il film venne presentato al Festival di Sitges nellottobre 1971. Le fonti citano altri titoli alternativi mai usati ufficialmente, e corrispondenti a una prima fase di scrittura {Così imparano a fare i cattivi) e a una fase intermedia di lavorazione {La baia d’argento). Titoli e uscite all’estero: Carnage (Usa, 1972; rieditato come Twitch ofthe Death Nerve e Last House - Part II, Bay ofBlood), La Baie sanglante (Francia, 1973), Bloodbath (Gb, 1980), Bahia de sangre (Spagna, 1982). 1972 | Gli orrori del castello di Norimberga
Regia: Mario Bava; soggetto e sceneggiatura: Vincent G. Fotre,Willibald Eser, Mario Bava (nelle versioni straniere: Vincent Fotre, William A. Bairn); fotografìa (Technicolor, 1,85:1): Antonio Rinaldi; operatore: Emilio Varriano; musica: Stelvio Cipriani; montaggio: Carlo Reali; scenografìa: Enzo Bulgarelli; costumi: non accreditati; aiuto regista: Lamberto Bava; interpreti: Joseph Cotten (Otto von Kleist/Alfred Becker), Elke Sommer (Eva Arnold), Antonio Cantafora (Peter von Kleist), Massimo Girotti (Karl Hummel), Rada Rassimov (Christina Hoffmann), Alan Collins [Luciano Pigozzi] (Fritz), Dieter Tressler (Dortmund), Nicoletta Elmi (Gretchen), Umberto Raho (ispettore), Valeria Sabel (Martha Hummel); produzione: Alfred Leone per Leone International Film e Dieter Geissler (Monaco); distribuzione: Jumbo; origine: Italia/Rft, 1972; visto di censura: n. 59720 del 09/02/1972 (v.m. 14 anni); prima proiezione pubblica: 25/02/1972; incasso: 268,8 milioni; durata: 10T. Titoli e uscite all’estero: Baron Blood (Usa, 1972), Baron vampire (Francia). 150
1972-1973 I Lisa e il diavolo
Regia: Mario Bava; soggetto e sceneggiatura: Mario Bava, Giorgio Maulini, Romano Migliorini, Roberto Natale [non accreditata: Chicca Rusicka]; fotografia (Technicolor, 1,85:1): Cecilio Paniagua; operatore: Emilio Varriano; musica: Carlo Savina (estratti dal Concerto di Aranjuez di Joaquin Rodrigo); montaggio: Carlo Reali; scenografia e costumi: Nedo Azzini; aiuto regista: Lamberto Bava; interpreti: Elke Sommer (Lisa/Elena), Telly Savalas (Leandro), Alessio Orano (Massimiliano), Alida Valli (contessa), Espartaco Santoni (Carlo), Sylva Koscina (Sophie Lehar), Eduardo Fajardo (Francis Lehar), Gabriele Tinti (George, autista), Franz vonTreuberg (anti quario), Kathy Leone (turista);produzione: Alfred Leone per Euro America Productions (Roma), Tecisa (Madrid) e Roxy Film (Monaco); origine: Italia/Spagna/Rft, 1972; prima proiezione pub blica: 09/05/1973 (Marche di Cannes), 25/11/1974 (in Spagna); durata: 94’. Titolo di lavorazione: Il diavolo e i morti. Titoli e uscite all’estero: El diablo se lleva a los muertos (Spagna, 1974), Lisa and the Devii (Usa, 1983, Tv). La versione italiana non è mai stata distribuita nelle sale; è stata trasmessa per la prima volta da Sky Cinema Max, il 23/04/2004. Vedi anche La casa dell’esorcismo. 1974-1996 I Cani arrabbiati
Regia: Mario Bava; soggetto: dal racconto L’uomo e il bambino (Kidnapped} di Ellery Queen [Frederic Dannay e Manfred B. Lee] ; sceneggiatura: Alessandro Parenzo, Cesare Frugoni; fotografìa (Technicolor, 1,85:1): Emilio Varriano [e Mario Bava, non accreditato]; musica: Stelvio Cipriani; montaggio: Carlo Reali; aiuto regista: Lamberto Bava; interpreti: Riccardo Cucciolla (Riccardo), Maurice Poli (“Dottore”, doppiato da Renato Cecchetto), George Eastman [Luigi Montefìori] (“Trentadue”, doppiato da Gabriele Duma), Don Backy [Aldo Caponi] (“Bisturi”, doppiato da Riccardo Rovatti), Lea Lander (Maria, doppiata da Miriam Spera), Marisa Fabbri (autostoppista), Gustavo De Nardo (benzinaio) ; produzione: Roberto Loyola per Loyola Films (1974), Spera Cinematografica (1995); origine: Italia, 1974-1995; prima proiezione pubblica: Brussels International Festival of Fantasy, Science Fiction and Thriller Films, 1996; durata: 95’. Titolo di lavorazione: L’uomo e il bambino. Nel 1995 il film viene doppiato sotto la direzione di Renato Cecchetto, ed editato con il titolo di Semaforo rosso. Da questa prima edizione provvisoria provengono tre edizioni in Dvd: Rabid Dogs (Lucertola Media, 1998, con una sequenza aggiunta girata da Peter Blumenstock) ; Wild Dogs Semaforo rosso (Astro Records, 2001, con un finale più lungo) e Cani arrabbiati (Ermitage, 2006). Nel 2002 esce una nuova versione per il mercato americano intitolata Kidnapped, a cura del pro duttore Alfred Leone e di Lamberto Bava. Il film, con un nuovo doppiaggio, una nuova colonna 151
sonora di Stelvio Cipriani e un montaggio di Mauro Bonanni e Walter Dio tali evi, aggiunge sequenze di repertorio e altre girate ex novo con l’attrice Fabrizia Sacchi. Di alcuni attori citati nei titoli di coda (Emilio Bonucci, Ettore Manni), non c’è traccia nelle ver sioni conosciute. 1975 I La casa dell'esorcismo
Regia: Mario Bava (Mickey Lion [Alfred Leone] in alcune versioni straniere); soggetto e sceneg giatura: Mario Bava, Giorgio Maulini, Roberto Natale; sceneggiatura aggiuntiva: Alberto Citrini, Alfred Leone; adattamento dialoghi: Leonardo Martin, Giorgio Piferi, Ursula Wedez; fotografìa (Technicolor, 1,85:1): Cecilo Paniagua; operatore: Emilio Varriano; musica: Carlo Savina (estratti dal Concerto di Aranjuez di Joaquin Rodrigo e da La sagra della primavera di Igor Stravinskij); montaggio: Carlo Reali; scenografia e costumi: Nedo Azzini; aiuto regista: Lamberto Bava; inter preti: Elke Sommer (Lisa/Elena), Telly Savalas (Leandro), Robert Alda (padre Michele), Alessio Orano (Massimiliano), Alida Valli (contessa), Espartaco Santoni (Carlo), Sylva Koscina (Sophie Lehar), Eduardo Fajardo (Francis Lehar), Gabriele Tinti (George, autista), Franz von Treuberg (antiquario), Kathy Leone (turista), Carmen Silva (Anna, la tentatrice); produzione: Alfred Leone per Leone International Film, Euro America Productions (Roma), Tecisa (Madrid) e Roxy Film (Monaco); distribuzione: Transeuropa Film; origine: Italia/Spagna/Rft, 1975; visto di censura: n. 66007 dell’l 1/02/1975 (v.m. 18 anni);primaproiezione pubblica: 02/04/1975; incasso: 90,9 mil ioni; durata: 92’. Versione rimontata di Lisa e il diavolo, con sequenze aggiunte. Titoli e uscite all'estero: La casa del exorcismo (Spagna, 1975), The House ofExorcism (Usa, 1976, Gb, 1977), La Maison de Texorcisme (Francia, 1977). 1977 | Shock (Transfert Suspense Hypnos)
Regia: Mario Bava; collaboratore alla regia: Lamberto Bava; soggetto: dal romanzo L'ospite di notte (The Shadow Guest) di Hillary Waugh; sceneggiatura: Lamberto Bava, Francesco Barbieri, Paolo Erigenti [Alessandro Parenzo], Dardano Sacchetti; fotografìa (Eastmancolor, 1,85:1): Alberto Spagnoli; operatore: Giuseppe Maccari; musica: I Libra; montaggio: Roberto Sterbini; scenografìa: Francesco Vano rio; aiuto scenografo: Nicola Salerno; costumi: Massimo Lentini; interpreti: Daria Nicolodi (Dora Baldini), David Colin Jr. (Marco), John Steiner (Bruno), Ivan Rassimov (psichi atra), Nicola Salerno (Carlo); produzione: Turi Vasile per Laser Film; produttore esecutivo: Ugo Valenti; distribuzione: Titanus; origine: Italia, 1977; visto di censura: n. 7C7Ò1 del 12/08/1977 (v.m. 14 anni); prima proiezione pubblica: 12/08/1977; incasso: 196,6 milioni; durata: 95’. Titoli di lavorazione: Al 33 di via Orologio fa semprefreddo, La casa 8. Su alcuni manifesti la grafìa è Schock. 152
Titoli e uscite attesterò: Les demons de la nuit (Francia, 1978), Beyond the Door 77 (Usa, 1979), The Shock (Gb, 1980). 1978-1981 I La Venere dille
Regia: Mario Bava, Lamberto Bava; soggetto: dal racconto omonimo di Prosper Mérimée; sceneg giatura: Lamberto Bava, Cesare Garboli; fotografìa (Technicolor, 1,33:1): Nino Celeste; operatore: Fabio Conversi; musica: Ubaldo Contimeli©; montaggio: Fernanda Papa; scenografia: Alessandro Dell’Orco; interpreti: Marc Porel (Mathieu), Daria Nicolodi (Clara), Fausto Di Bella (Alphonse de Peyrehorade), Mario Maranzana (M. de Peyrehorade), Diana De Curtis (Mme de Peyrehorade), Adriana Innocenti (servetta)'.produzione: Franca Franco per Pont Royal Film Tv e Carlo Tuzii per Rete 2 (serie I giochi del diavolo - Storie fantastiche dettOttocentò); origine: Italia VT7&; prima proiezione pubblica: 27/05/1981 su Rai 2; durata: 60’. COLLABORAZIONI
Operatore
1939 II socio invisibile (b/n; regia: Roberto Roberti [Vincenzo Leone]) [non accreditato]. 1940 Ecco la felicità (b/n; regia: Marcel L’Herbier. Versione italiana di La comédie du bonheur). 1941 La compagnia della teppa (b/n; regia: Corrado D’Errico). 1941 Uomini sulfondo (b/n; regia: Francesco De Robertis). 1942 La nave bianca (b/n; regia: Roberto Rossellini). 1942 Alfa Tau! (b/n; regia: Francesco De Robertis). 1942 Capitan Tempesta (b/n; regia: Corrado D’Errico). 1942 II leone di Damasco (b/n; regia: Corrado D’Errico, Enrico Guazzo ni). 1946 Montecassino nel cerchio di fuoco (b/n; regia: Antonio Gemmiti) [non accreditato]. 1946 II barbiere di Siviglia (b/n; regia: Mario Costa). Direttore della fotografìa - Cortomometraggi
1939 II tacchino prepotente (b/n; regia: Roberto Rossellini). 1939 La vispa Teresa (b/n; regia: Roberto Rossellini). 1946 Donne belle nella pittura italiana (b/n; regia: Raffaele Saitto). 1946 Paolo Veronese, pittore della gioia e delfasto (b/n; regia: Raffaele Saitto). 1947 II mito di Giorgione (b/n; regia: Raffaele Saitto). 1947 Cristo in Gerusalemme (b/n; regia: Pietro Francisci). 1947 Musica nel cielo (b/n; regia: Pietro Francisci). 153
1947 Passaggio del mar (b/n; regia: Pietro Francisci). 1947 La resurrezione (b/n; regia: Pietro Francisci). 1948 Una lezione di geometria (b/n; regia: Leonardo Sinisgalli e Virgilio Sabel). 1948 Lauto nel tempo (b/n; regia: Fernando Pisani). 1948 II trucco nel tempo (b/n; regia: Elio Picconi). 1949 Le porte d'oro (b/n; regia: Riccardo Melani). 1949 II demoniaco nell'arte (b/n; regia: Carlo Castelli). 1949 Fantasie di statuine (b/n; regia: Teli oli). 1949 Porcellana nell'arte (b/n; regia: Teli oli). 1949 Arte nella porcellana (b/n; regia: N. Pasqualini). 1949 II vangelo del Beato Angelico (b/n; regia: Teli oli). 1950 Disastri della guerra (b/n; regia: Luciano Emmer). 1950 La festa di Sant'Isidoro (b/n; regia: Luciano Emmer). 1950 II pittore di Trastevere: Bartolomeo Pinelli (b/n; regia: G. Bagnani). 1950 I nuraghi (b/n; regia: Marino Girolami). 1950 L'ospedale del delitto (b/n; regia: Luigi Comencini). 1950 Sulle orme di Esculapio (b/n; regia: Augusto Petrone). 1951 La leggenda della croce (b/n; regia: Giuseppe Massani). 1951 IIpittore della primavera (b/n; regia: Giuseppe Massani). 1956 Alto Lazio pittoresco (regia: Fernando Pisani). 1956 Copiando la natura (regia:Viviana Pasqualini). Direttore della fotografìa - Lungometraggi
1943 Sant'Elena, piccola isola (b/n; regia: Renato Simoni e Umberto Scarpelli). 1943 L'avventura di Annabella (b/n; regia: Leo Menardi). 1943 Uomini e cieli (b/n; regia: Francesco De Robertis). 1947 L'elisir d'amore (b/n; regia: Mario Costa). 1947 Natale al campo 119 (b/n; regia: Pietro Francisci). 1948 Follie per l'opera (b/n; regia: Mario Costa). 1948 Ipagliacci (b/n; regia: Mario Costa). 1949 Antonio di Padova (b/n; regia: Pietro Francisci). 1950 Miss Italia (b/n; regia: Duilio Coletti). 1950 Quel bandito sono io! (b/n; regia: Mario Soldati). 1950 Vita da cani (b/n; regia: Steno e Mario Monicelli). 1950 È arrivato il cavaliere! (b/n; regia: Steno e Mario Monicelli). 1951 Canzone di primavera (b/n; regia: Mario Costa). 154
1951 Amor non ho... però... però (b/n; regia: Giorgio Bianchi). 1951 Guardie e ladri (b/n; regia: Steno e Mario Monicelli). 1951 La famiglia Passaguai (b/n; regia: Aldo Fabrizi). 1952 La famiglia Passaguai fa fortuna (b/n; regia: Aldo Fabrizi). 1952 Papà diventa mamma (b/n; regia: Aldo Fabrizi). 1952 Gli eroi della domenica (b/n; regia: Mario Camerini). 1953 Spartaco (b/n; regia: Riccardo Freda) [fotografìa aggiunta, non accreditato]. 1953 Perdonami! /n; regia: Mario Costa). 1953 II viale della speranza (b/n; regia: Dino Risi). 1953 Balocchi e profumi (b/n; regia: Natale Mondilo e F. M. De Bernardi). 1953 Villa Borghese (b/n; regia: Gianni Franciolini). 1954 Terza liceo (b/n; regia: Luciano Emmer). 1954 Cose da pazzi (b/n; regia: Georg Wilhelm Pabst). 1954 Graziella (b/n; regia: Giorgio Bianchi). 1954 Hanno rubato un tram (b/n; regia: Aldo Fabrizi). 1955 Le avventure di Giacomo Casanova (Eastmancolor; regia: Steno). 1955 Buonanotte... avvocato! (fi In', regia: Giorgio Bianchi). 1955 La donna più bella del mondo (Eastmancolor, Cinemascope; regia: Robert Z. Leonard). 1955 Non ce amore più grande (b/n; regia: Giorgio Bianchi). 1956 Mio figlio Nerone (Eastmancolor; regia: Steno). 1956 Orlando e ipaladini di Francia (Eastmancolor, Cinemascope; regia: Pietro Francisci). 1957 Città di notte (b/n; regia: Leopoldo Trieste). 1959 Nel segno di Roma (Technicolor; regia: Guido Brignone e, non accreditati, Riccardo Freda e Michalangelo Antonioni) [fotografìa aggiunta, non accreditato, ed effetti speciali]. 1959 Agi Murad il diavolo bianco (Eastmancolor; regia: Riccardo Freda). Effetti speciali
1950 II leone di Amalfi (b/n; regia: Pietro Francisci) [non accreditato]. 1954 Teodora, imperatrice di Bisanzio (Ferraniacolor; regia: Riccardo Freda) [non accreditato]. 1955 Da qui all’eredità (b/n; regia: Riccardo Freda) [non accreditato]. 1955 Beatrice Cenci (Eastmancolor; regia: Riccardo Freda) [non accreditato]. I960 Morgan il pirata (Eastmancolor; regia: André De Toth) [non accreditato]. 1961 Igiganti della Tessaglia (Eastmancolor; regia: Riccardo Freda) [non accreditato]. 1961 II ladro di Bagdad (Eastmancolor; regia: Arthur Lubin) [non accreditato]. 1961 Maciste alla corte del Gran Khan (Technicolor; regia: Riccardo Freda) [non accreditato]. 1972 La vita, a volte, è molto dura, vero Provvidenza? (Technicolor; regia: Giulio Petro ni) [non accreditato].
1975 Mose (Technicolor; regia: Gianfranco De Bosio; anche regia della seconda unità). 1975 Bardella (Technicolor; regia: Pupi Avati) [non accreditato]. 1980 Inferno (Technicolor; regia: Dario Argento) [non accreditato]. Sceneggiature
1967 Nude... si muore (regia: Anthony Dawson [Antonio Margheriti], Bava scrive con Tudor Gates e Brian Degas una sceneggiatura intitolata Sette vergini per il diavolo e Cry Nightmare per la versione inglese; il progetto passa poi a Margheriti, che rimaneggia la sceneggiatura con Giovanni Simonelli e Franco Bottai).
156
Da quando è stata pubblicata la prima edi zione di questo volume, nel 1995, la produzione cartacea su Bava è aumentata vertiginosamente, come il mostro Caltiki del film omonimo; nel frattempo sono emersi materiali d’epoca prece dentemente ignorati. La bibliografìa di questa terza edizione è quindi estremamente selettiva, anche se cerca di essere ragionata. Una raccolta delle recensioni d’epoca non è mai stata fatta, riserva varie soiprese, e presenta ancora molte lacune: gli autori di Kill Baby Kill! hanno inizia to, per questo libro è stato continuato lo spoglio, ma molto lavoro resta da fare. Nell’elenco che segue si indicano i testi “clas sici” della critica su Bava, spesso invecchiati, ma significativi nella storia della ricezione; e una scelta di saggi più recenti, escludendo quelli di carattere compilativo e le fanzine. Per una raccolta di testimonianze e documenti, sono imprescindibili il «Nocturno Dossier» del 2004 e Kill Baby Kill!. Dopo una fatica pluridecennale, nel 2007 Tim Lucas ha pubblicato Mario Bava - All the Colors ofthe Dark, un volume di 1128 pagine di grande formato. E ovviamente un testo con cui fare i conti, ma di uso non facile. L’autore raccoglie una mole di informazioni preziose, spesso di prima mano; ma, animato da un culto autoriale ai limiti del fanatismo, e privo di metodo nell’uso delle fonti, spesso indulge in ipotesi e attribuzioni non attendibili. INTERVISTE E DICHIARAZIONI DI MARIO BAVA
Alfredo Castelli e Tito Monego, La maschera del demonio - Intervista con Mario Bava, «Horror», n. 1, 1969. 158
Luigi Cozzi, Gli artisti egli artigiani del cine ma: Mario Bava, l’evocatore d’ombre, «New Cinema», novembre 1970. Ornella Volta, Entretien avec Mario Bava, «Positif», n. 138, 1972. Luigi Cozzi, Operazione paura, «Horror», n. 13, 1971 (seguito da uno storyboard per [’Odissea dal titolo II cinema è un fumetto: note di regia). Giuseppe Lippi, Lorenzo Codelli, [inter vista] in Fant’Italia, Catalogo del XIV Festival Internazionale del Cinema di Fantascienza, La cappella underground, Trieste, 1976. Mario Bava, in AA. W, La città del cinema Produzione e lavoro nel cinema italiano 19301970, Napoleone, Roma, 1979. Lavinia Ceccarelli, I trucchi del mestiere: come si fa l’horror con la trippa e la p izza!Intervista a Ando Gilardi e Mario Bava, due tecnici dell’immagine, «Giovane sinistra», n. 2, marzo 1979. Dante Matelli, Il cinema ordino: chiamatemi romano!, «L’Espresso», maggio 1979. Louis Safad, Un cintaste d’outre-tombe, «Liberation», 7 maggio 1980. SAGGI E MONOGRAFIE SU MARIO BAVA
P. Z. [Piero Zanotto], “Mario Bava”, in Arcana. Volume Secondo, Milano, Sugar, 1968. Alan J. Silver, James Ursini, Mario Bava The Illusion ofReality, «Photon», n. 26, 1975; trad. it. in «La lettura», settembre 1980. Lamberto Bava, Graziella Fallucchi (a cura di), Omaggio a Mario Bava, «La lettura», n. 47, Nuova Serie, ottobre 1980 [comprende tra l’altro: i saggi di Silver e Ursini e di Mora; Pin-
tervista a Mario Bava di Fant'Italia', un’inter vista a Lamberto Bava]. Pascal Martinet, Mario Bava, Edilig, Parigi, 1984. Luc Moullet, La peur et la stupeur, «Cahiers du cinema», n. 486, 1994. Jean-Louis Leutrat (a cura di), Mario Bava, Editions du Céfal, Liegi, 1994. Stefano Della Casa e Giulia D’Agnolo Vallan (a cura di), Mario Bava. Il cineasta che sapeva troppo, Bellaria, 1995. Luigi Cozzi, Mario Bava -1 milk volti della paura, Profondo Rosso, Roma, 2001. Troy Howarth, The Haunted World ofMario Bava, FAB Press, Godalming, 2002. Manlio Gomarasca, Davide Pulici (a cura di) Genealogia del delitto. Guida al cinema di Mario e Lamberto Bava, «Nocturno Dossier, n. 24, 2004. Gabriele Acerbo, Roberto Pisoni (a cura di), Kill Baby Kill! Il cinema di Mario Bava, unmondoaparte, Roma, 2007. Tim Lucas, Mario Bava - All the Colors of the Dark, Video Watchdog, Cincinnati, 2007. SAGGI CON CENNI A BAVA NEL CONTESTO
DEL CINEMA DI GENERE ITALIANO
Vittorio Spinazzola, “Ercole alla conquista degli schermi”, in Vittorio Spinazzola (a cura di), Film 1963, Feltrinelli, Milano, 1963. Ugo Pirro, Da Caltiki a Per un pugno di dollari, «Ulisse», n. 56, ottobre 1965. Goffredo Fofì, “Maciste sugli schermi”, in Catalogo Bolaffi del cinema italiano. Tutti i film italiani del dopoguerra, direzione di Gianni
Rondolino, a cura di Ornella Levi, Giulio Bolaffi, Torino, 1967. Teo Mora, Storia del cinema dell'orrore voli. Il e III, Fanucci, Roma, 1978; nuova edizione, 2002-3. Enrico Magrelli (a cura di), Cinecittà 2. Sull'industria cinematografica italiana, Marsilio Mostra Internazionale del Nuovo cinema, Venezia, 1986. Michel Maheo, La suspense hitchcockien, à la source du “giallo", «CinémAction», n. 71, 1994 (“La suspense au cinema”). Jean-Louis Leutrat, Vie des fantomes - Le fiantastique au cinema, «Cahiers du cinema», Parigi, 1995, trad. it. Vita dei fantasmi. Ilfan tastico al cinema, Le mani, Recco, 2008; rifonde in parte i saggi contenuti in JeanLouis Leutrat (a cura di), Mario Bava, cit. Marcello Garofalo (a cura di), Sangue, amore efiantay. Ilfantascientifico e il soprannaturale nel cinema italiano dalle origini a oggi, «Segnocinema», n. 85, 1997. Stefano Piselli, Riccardo Morrocchi (a cura di), Bizarre Sinema!Horror all'italiana 19571969, Glittering Images, Firenze, 1997. Richard Dyer, Ginette Vincendeau (a cura di), Popular European Cinema, Roudedge, Londra-New York, 1992. Simone Venturini, Galatea S.p.a., Storia di una casa di produzione cinematografica, Aire, Roma, 2001. Stefano Della Casa, “L’horror”, in Giorgio De Vincenti (a cura di), Storia del cinema italiano, Volume X- 1960/1964, Marsilio-Edizioni di Bianco & Nero, Venezia-Roma, 2001. Riccardo Caccia, “L’horror tra gotico e futuribile”, in Gianni Canova (a cura di), 159
Storia del cinema italiano, Volume XI 1965/1969, Marsilio-Edizioni di Bianco & Nero, Venezia-Roma, 2002. Francesco Pitassio, “L’orribile segreto dell’horrror italiano”, in Giacomo Manzoli e Guglielmo Pescatore (a cura di), L’arte del risparmio: stile e tecnologia. Il cinema a basso costo in Italia negli anni Sessanta, Carocci, Roma, 2005. Francesco Di Chiara, I tre volti della paura. Il cinema horror italiano (1957-1965), Unifepress, Ferrara, 2009. Roberto Curti, Fantasmi d’amore. Il gotico italiano tra cinema, Letteratura e TV, Lindau, Torino, 2011. Stefano Della Casa, Dario Edoardo Vigano, Pierpaolo De Santis, POP FILM ART. Visual culture, moda e design nel cinema italiano anni ’60 e 70, Edizioni Sabinae, Roma, 2012. RECENSIONI Al FILM La maschera del demonio
Morando Morandini, Vampiri russi in un film italiano, «La Notte», 13-14 agosto I960. Fereydoun Hoveyda, Les grimaces du démon, «Cahiers du cinema», n. 119, 1961. J.-P. Torok, Le cadavre exquis, «Positi!», n. 40,1961. Giuseppe Marotta, L’inventiva dei leoni cine matografici d’agosto, «L’Europeo», poi in Facce dispari, Bompiani, Milano, 1963. Danny Peary, Black Sunday, in Cult Movies, Vermilion, Londra-Melb ourne-SydneyAuckland-Johannesbutg, 1982. 160
Ercole al centro della Terra
Michel Caen, «Midi Minuit Fantastique», n. 1,1962. Le meraviglie di Aladino
Marcello Garofalo, Le meraviglie di Aladino (Scult Movie), «Segnocinema», n. 68, 1994. La ragazza che sapeva troppo
Lue Moullet, De la disponibilité, «Cahiers du cinema», n. 154, 1964. Goffredo Fofi, in «Midi Minuit Fantastique», n. 7, 1964. I tre volti della paura
Vittorio Spinazzola, «Cinema italiano 1963», in V. Spinazzola (a cura di), Film 64, Feltrinelli, Milano, 1964. M.M. [Michel Mardore], Les Trois visages de lapeur, «Cahiers du cinema», n. 173, 1965. La frusta e il corpo
Anonimo, «Corriere della Sera», 30 agosto 1963. Bernard Eisenschitz, Les trois dernier films de Mario Bava, «Midi Minuit Fantastique», n. 8, 1964 (comprende anche una stroncatura di La ragazza che sapeva troppo e I tre volti della paura). J.B. [Jacques Bontemps], Le corps et le fouet, «Cahiers du cinema», n. 176, 1966. Sei donne per l'assassino
U.C. [Ugo Casiraghi], «l’Unità», 26 giugno 1964. Anonimo, Six femmes pour l’assassin, «Cahiers du cinema», n. 163, 1965-
La strada per Forte Alamo
Quante volte... quella notte
S.D. [Serge Daney], Arizona Bill, «Cahiers du cinema», n. 166-167.
M.P. [Maurizio Porro], Le tante verità di ognuno di noi, «Il Giorno», 11 maggio 1973P. Per. [Piero Perona], Il Rashomon dei poveri, «La Stampa», 23 novembre 1972.
Operazione paura
Anonimo [Ugo Casiraghi], «l’Unità», 8 agos to 1966 [comprende una nota su Le spie ven gono dal semifreddo]. Sandro Bernardi, in Teoremi della circolarità. L infinito nel cinema, «Filmcritica», n. 365366, 1986.
Cinque bambole per la luna d'agosto
Alessandro Cappabianca, Cinque bambole per la luna d'agosto, «Filmcritica», n. 206, 1970. Alain Garsault, Llle de lepouvante, «Positif», n. 147, 1973.
Terrore nello spazio
U.C. [Ugo Casiraghi], «l’Unità», 31 giugno 1966. I coltelli del vendicatore
P.B. [Patrick Brion], Duelau couteau, «Cahiers du cinema», n. 186, 1967.
Ecologia del delitto
L.A. [Leonardo Antera], «Corriere della Sera», 15 dicembre 1971. Pietro Bianchi, Tra natura e cemento anche Bava ci sta bene, «Il Giorno», 15 dicembre 1971. Gli orrori del castello di Norimberga
Diabolik
Giovanni Grazzini, Rassegna cinematografica, «Corriere della Sera», 27 gennaio 1968. L.P. [Leo Pestelli], Diabolik strizza rocchio anche a chi ignora ifumetti, «Stampa sera», 31 gennaio - 1 febbraio 1968. J.N. [JeanNarboni], «Cahiers du cinema», n. 202, 1968. Tullio Kezich, in IlMilleFilm - Dieci anni al cinema 1967-1977, Il Formichiere, Milano, 1977.
Anonimo «Il Giorno», 28 maggio 1972. S.C., «La Stampa», 13 agosto 1972. La casa dell'esorcismo
Emmanuel Carrère, La maison de l’exorrisme, «Positif», n. 199, 1977 Cani arrabbiati
Alberto Pezzetta, Cani arrabbiati, «Segnocinema», n. 78, 1996. Davide Pulici, Semaforo rosso, «Nocturno», n. 4, 1996.
Il rosso segno della follia
Anonimo, «La Stampa», 5 giugno 1970. Vice, «PUnità», 26 giugno 1970. Tullio Kezich, in IlMilleFilm - Dieci anni al cinema 1967-1977, cit.
Shock
Anonimo, «PUnità», 20 agosto 1977. Anonimo, Shock: un horror, «La Stampa», 21 agosto 1977, 161
G. Gs. [Giovanna Grassi], Un thriller satani co, «Corriere della Sera», 21 agosto 1977. M. Mor. [Morando Morandini], Il maestro dell’orrore tradito dal mestiere, «Il Giorno», 22 agosto 1977. Emmanuel Carrère, Demons de la nuit, «Positif», n. 206, 1978. La Venere dille
Gualtiero Pironi, Quando il diavolo della teatralità ci mette la coda..., «Cinefonim», n. 206, 1981. Progetti non realizzati
Alberto Pezzotta, L’ultimo viaggio spaziale, in Manlio Gomarasca, Davide Pillici (a cura di), Genealogia del delitto. Guida al cinema di Mario e Lamberto Bava, «Nocturno Dossier», cit. Davide Pulici, “Il filo d’Arianna” [su Porno Giove], in Misteri d’Italia 3, «Nocturno Dossier), 70, 2008. TESTIMONIANZE SU MARIO BAVA
Oltre ai citati Mario Bava. Il cineasta che sapeva troppo, Genealogia del delitto. Guida al cinema di Mario e Lamberto Bava e Kill Baby Kill! Il cinema di Mario Bava, si vedano: Franca Faldini, Goffredo Fofì (a cura di), L’avventurosa storia del cinema italiano raccon tata dai suoi protagonisti. 1960-1969, Feltrinelli, Milano, 1981. Riccardo Freda, Divoratori di celluloide -50 anni di memorie cinematografiche e non, Emme Edizioni - Il Formichiere, Milano, 1981. Cesare Garboli, Penna secondo Carmen, in 162
Scritti servili, Torino, Einaudi 1989 [sulla sceneggiatura di La Venere dille]. Eric Poindron, Riccardo Preda - Un pirate à la camera, Institut Lumière/Actes Sud, LioneArles, 1994. Franca Faldini, Goffredo Fofi (a cura di), L’avventurosa storia del cinema italiano. Da La canzone dell’amore a Senza pietà, Cineteca di Bologna, Bologna, 2009.
Franca Faldini, Goffredo Fofì (a cura di), L’avventurosa storia del cinema italiano. Da Ladri di biciclette a La grande guerra, Cineteca di Bologna, Bologna, 2011. DOCUMENTARI SU MARIO BAVA
Mario Bava - Maestro ofthe Macabre', regia: Charles Preece e Garry S. Grant; produzione: creaTty Ltd. - Westbrook Ltd.; origine: Gb, 2000; durata: 60’. Mario Bava: Operazione paura', regia: Gabriele Acerbo e Roberto Pisoni; produzione: Sky Cinema; origine: Italia, 2004; durata: 54’.
Indice
4
«Il cinema è tutto un trucco»
11
Mario Bava
12 18 22 26 29 32 43 52 56 67 71
Un autore in meno L'arte della fotografia I vampiri in anticipo sui tempi La fucina del peplum Dalla fa ntascienzaall'horror: Caltiki, il mostro immortale La maschera del demonio e la nascita del gotico I n c roc i e i bri d i : I e co reg i e, Ercole al centro della Terra, Gli invasori La ragazza che sapeva troppo e il thriller italiano Ritorno al gotico: / tre volti della paura e La frusta e il corpo Sa d i s mo e fo rm a I i s m o: Sei donne per l'assassino Ceneri vece h i, n u ovi e te rm i n a I i : La strada per Forte Alamo, Terrore nello spazio, I coltelli del vendicatore
80 87 94 101 106 113
Marginalitàeinvenzione: Operazione paura Popolare e Pop Art: Diabolik e dintorni An n i d iffici I i : // rosso segno della follia, Quante volte... quella notte L'estetica del brutto: 5 bambole perla luna d'agosto e dintorni Nichilismo contemporaneo, prima parte: Ecologia del delitto N ost aIg ie got iche, pri ma pa rte: Gli orrori del castello di Norimberga, Lisa e il diavolo
121 124 132
Nichilismo contemporaneo, seconda parte: Cani arrabbiati Nostalgie gotiche, seconda parte: Shock, La Venere d'Ille Bava dopo Bava
136
Filmografìa
157
Bibliografìa
163
Finito di stampare nel mese di gennaio 2013 presso Abbiati, Milano

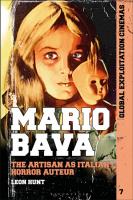
![Mario Bava: all the colors of the dark [1st ed]
096337561X, 9780963375612](https://dokumen.pub/img/200x200/mario-bava-all-the-colors-of-the-dark-1st-ed-096337561x-9780963375612.jpg)






