Marco Polo. Storia del mercante che capì la Cina 9788842089742
Nonostante la sua popolarità, di Marco Polo si sa poco o nulla. Mercante giramondo, autore del "Milione", avve
1,105 282 4MB
Italian Pages 380 Year 2009
Polecaj historie
Citation preview
Economica Laterza 502
Dello stesso autore nella «Economica Laterza»:
Gengis Khan. Il principe dei nomadi
Dello stesso autore in altre nostre collane:
Castelli sul mare «Opere varie»
Vito Bianchi
Marco Polo Storia del mercante che capì la Cina
Editori Laterza
© 2007, Gius. Laterza & Figli Nella «Economica Laterza» Prima edizione 2009 Edizioni precedenti: «i Robinson/Letture» 2007 Progetto grafico di Raffaella Ottaviani Ricerca iconografica di Manuela Fugenzi Alle pp. 2, 64, 132, 192, 256, 332: particolari dalla mappa dell’Asia di Anthony Jenkinson (1562). Londra, British Library. Foto The Bridgeman Art Library/Archivi Alinari L’Editore è a disposizione di tutti gli eventuali proprietari di diritti sulle immagini riprodotte, là dove non è stato possibile rintracciarli per chiedere la debita autorizzazione.
Proprietà letteraria riservata Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari Finito di stampare nell’aprile 2009 SEDIT - Bari (Italy) per conto della Gius. Laterza & Figli Spa ISBN 978-88-420-8974-2
È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico. Per la legge italiana la fotocopia è lecita solo per uso personale purché non danneggi l’autore. Quindi ogni fotocopia che eviti l’acquisto di un libro è illecita e minaccia la sopravvivenza di un modo di trasmettere la conoscenza. Chi fotocopia un libro, chi mette a disposizione i mezzi per fotocopiare, chi comunque favorisce questa pratica commette un furto e opera ai danni della cultura.
Indice del volume
Parte prima MISSIONI IMPOSSIBILI 1 - Bagliori 2 - Furori 3 - Errori
4 22 41
Parte seconda MERCI E COMMERCI 4 - Venezia e il Levante 5 - Ma chi erano mai questi Polo? 6 - I mercanti che divennero ambasciatori V
66 89 110
Parte terza SULLA VIA DELLA SETA 7 - Un nuovo Perceval 8 - Paesi da Mille e una notte 9 - Voci dal deserto
134 154 172
Parte quarta TUTTO UN ALTRO MONDO 10 - L’Oriente di Kubilai Khan 11 - Alla corte dell’imperatore 12 - Passaggio a sud-ovest
194 215 235
Parte quinta L’ASIA RIVELATA 13 - L’agente speciale del gran khan 14 - Il collezionista di universi 15 - Una casa sul Canal Grande
258 278 304
NOTA BIBLIOGRAFICA
333
INDICE DEI NOMI
352
INDICE DEI LUOGHI
364 VI
«Confine», diceva il cartello. Cercai la dogana. Non c’era. Non vidi, dietro il cancello, ombra di terra straniera. Giorgio Caproni, Falsa indicazione
MARCO POLO Storia del mercante che capì la Cina
Parte prima MISSIONI IMPOSSIBILI
Capitolo primo
BAGLIORI
1 | Il fascino dell’ignoto Filtravano notizie inquietanti, dall’Est. Raccapriccianti. Propaggini d’Asia s’erano come incuneate nel basso Volga e lì, da qualche tempo, pulsava gigantesco un accampamento mongolo. Era una città fatta tutta di tende, estesa a perdita d’occhio sui fianchi del padiglione reale che si stagliava, sontuoso, al centro della piana e della folla. Il bacino fluviale aveva calamitato nella libertà dei suoi spazi un’infinità di dimore a base circolare e a tetto conico, intelaiate in legno, rivestite di feltro chiaro e foderate da tappeti variopinti. Gente dal naso piatto, dalle guance prominenti e dalle palpebre strette si aggirava per il campo. C’erano carriaggi, mandrie, nitriti. Paioli in cottura, latte di giumenta sbattuto e fermentato, bevute collettive. Risate, musici, cantori a coronare i falò. Movimento, allegria. E morte: il duca russo Andrea di Cˇernigov era stato giustiziato senza troppi complimenti, per il solo sospetto che avesse rubato dei cavalli. Suo fratello minore, appena un adolescente, si era recato al quartier generale dei carnefici assieme alla neovedova, implorando di non confiscare i beni familiari. Per tutta risposta, i due supplicanti avevano ricevuto l’ordine, perentorio, ineludibile, di «sposarsi», e cioè di congiungersi carnalmente su di un giaciglio 4
appositamente preparato, dinanzi a tutti. Sotto la minaccia delle armi un pianto convulso s’era impadronito del corpo della donna, obbligata a starsene supina, ad aggiungere dolore al dolore. Lacrime silenziose avevano rigato il volto del ragazzo, mentre veniva forzato a mettersi prono su di lei che urlava, e si contorceva, e invocava pietà. Intorno, nessuna misericordia, nessuna indulgenza o emozione: respinta da un muro di freddezza, l’illusione dei condannati al coito non durava nemmeno gli attimi d’una preghiera. Inutile qualsiasi resistenza: per entrambi, quel supplizio era stato quasi peggio che morire. D’altronde, alla metà del XIII secolo, nell’Europa medievale non aveva ancora allignato la legge dello yangalik, quella che obbligava una moglie, in caso di vedovanza, a unirsi al cognato giovane: il risposarsi avrebbe infatti conservato la dama fino al ricongiungimento col primo marito in cielo, quel cielo che era creduto la sede di una rinnovata esistenza, come tra i vivi. Più in concreto, il rimaritarsi evitava di smarrire l’identità sociale e di perdere il posto nella collettività dei nomadi. Mentre il furto di bestiame, e in particolare di cavalcature, vitali in guerra e in pace per dei popoli migranti, equivaleva nell’ottica mongola a un omicidio, e dunque veniva punito con la pena capitale. Si trattava di norme all’apparenza incomprensibili, inconcepibili, inspiegabili. Il fatto è che, tra Ebro ed Elba, dall’Islanda alla Sicilia ristagnava una percezione confusa e approssimativa delle popolazioni e delle consuetudini asiatiche. Si scrutava l’Oriente più estremo ed era come sprofondare nelle brume dell’ignoto, con un sentimento sfuggente, oscillante, in bilico fra attrazione e repulsione, fascino e ripugnanza. L’oscurità di uomini e terre troppo discoste generava mistero. E nel mistero attecchiva il mito, proliferavano le credenze religio5
se, montavano elucubrazioni mondane e speculazioni teologiche. Paesi impraticati ed etnie misconosciute venivano esplorati più spesso dalla fantasia, e le contrade orientali divenivano un universo di caligine dove riversare di volta in volta attese e paure, speranze e angosce: uno specchio, insomma, in cui si riflettevano pezzi consistenti dell’anima europea. Le rare e preziose mercanzie levantine si trascinavano dietro storie mirabolanti, e la psicologia dell’Occidente (e della cristianità) poteva così proiettarsi in un locus fabulae sovrabbondante di brutture e delizie, stranezze e ricchezze. Il pregiudizio si sublimava nello straordinario, e l’«altrove» si popolava di meraviglie e oscenità, non di rado innestate sulle tradizioni antiche: già Esiodo, fra VIII e VII secolo a.C., raccontava degli Hemikynes, una razza a metà fra l’umano e il canino. Erodoto riferiva di Cinocefali in Libia. Ctesia di Cnido associava all’India Calistri e Monopodi. Megastene narrava di Okypodes (termine che propriamente significherebbe «piedi svelti», ma in cui è da riconoscere un adattamento fonetico dal sanscrito ekapada, «unipede») e di Astomi, che avevano una sorta di aspiratore invece delle fauci e vivevano alle sorgenti del Gange, alimentandosi col fumo delle carni cotte e con gli aromi di frutti e fiori. E comunque, passando nei millenni attraverso Strabone, Plinio il Vecchio, Plutarco, Eliano, Solino e, specialmente, il Physiologus (composto fra il II e il IV secolo) e le Etymologiae di Isidoro di Siviglia (circa 560-636), tutte quelle fantasticherie si erano caricate di veridicità. Per cui, alle soglie del Duecento, nel continente europeo non si faceva troppa fatica a credere che laggiù, a Levante, esistessero davvero degli uomini-cane, avvezzi a immergersi nelle acque di gelidi torrenti per poi rotolarsi nella polvere e confezionarsi addosso una corazza di 6
ghiaccio impenetrabile ai dardi. Si favoleggiava di creature semi-umane dal volto animalesco e dagli arti inferiori desinenti in zoccoli bovini, che parlavano pronunciando soltanto due parole e, alla terza, s’inceppavano in un latrato. E non si rifiutava a priori l’immagine dei Parossiti, che si nutrivano inalando i vapori dei cibi cucinati, o dei Ciclopedi, dotati di un braccio solo e una mano in mezzo al petto. Il panorama asiatico poteva tranquillamente contemplare montagne magnetiche che deviavano frecce e armi metalliche, e ominidi muti e privi di articolazioni, somiglianti a dei robot. In lontananza potevano ben muoversi i grandi Blemmi con la faccia piantata nel torace (anziché sulle spalle), e i bizzarri Sciapodi, che usavano il loro unico piedone per incedere velocissimi e, all’occorrenza, per ripararsi dal sole stesi sul dorso. Nell’incognito prosperavano basilischi capaci di uccidere con lo sguardo, e amazzoni indomabili, o cannibali che si cibavano dei genitori defunti e ne usavano i crani a mo’ di coppe per bere. A ruota i serpenti bipedi, gli unicorni, i grifoni, le chimere e i dragoni rappresentavano un repertorio bestiale e leggendario che, stratificandosi nella mentalità euro-occidentale, aveva finito per essere riprodotto in pietra su cornicioni e capitelli di cattedrali e chiostri, come pure nei mosaici effusi a pavimentare le basiliche, o nelle miniature dei codici. Soprattutto, mirabilia e mostruosità rimbalzavano fra le pagine esuberanti del Romanzo di Alessandro, un testo che, tradotto e integrato a più riprese sin dall’antichità, riproponeva l’epopea immaginifica del condottiero macedone lanciato alla conquista della frontiera asiatica. Al culmine di quella corsa incredibile e trionfale, oltrepassati Dario di Persia, Poro d’India e Didimo il bramino, in fondo, il Paradiso chiudeva i confini dell’ecumene. Sul versante opposto, fra i monti del Caspio, le Porte di 7
Ferro rinserravano in una muraglia invalicabile Gog e Magog, spaventosi e cattivi, pronti a scagliarsi sull’umanità e a distruggerla nei tempi ultimi, alla fine del mondo: intrecciate alle superstizioni più popolari stavano le profezie dell’Apocalisse, che si sarebbero realizzate dopo il millennio finale di pacificazione, nell’aspettazione della discesa in terra della Gerusalemme celeste.
2 | Fantasie ed eresie Nella curiosa miscellanea di sapere biblico e geografie immaginarie, le mappae mundi medievali, sia che fossero tracciate su pergamena sia che venissero dipinte su drappo (mappa mundi significa infatti «panno del mondo»), tendevano a conciliare le astrazioni dell’Oriente con gli insegnamenti dell’Antico e del Nuovo Testamento. Gli scritti di Eusebio di Cesarea, san Girolamo o Paolo Orosio avevano distillato in senso filosofico e spirituale i resoconti degli autori classici. Di conseguenza, tutti quei trattati «profani» che nella cultura grecoromana si concentravano sulla descrizione analitica dell’universo coi suoi abitanti, i suoi eroi, i suoi paesaggi e le sue popolazioni, erano stati rivestiti di un’aura mistica e cosmologica, indirizzata a incanalare le più diverse (e spesso stravaganti) conoscenze geografiche nell’alveo, onnicomprensivo, del cristianesimo. Sviluppate su carta, le mappe mentali divenivano topografie della dottrina cristiana: sotto l’alta sovranità del Padre Eterno, la Terra assurgeva a teatro della storia umana e divina, governata di volta in volta da un Cristo «soprastante» (la cosiddetta Psalter Map della British Library a Londra), «giudicante» (mappa della cattedrale di 8
Hereford), «abbracciante» ovvero «consustanziale» allo stesso pianeta (mappa di Ebstorf). Nella restituzione cartografica che se ne dava, il cosmo poteva talvolta assumere l’aspetto di uno scrigno assimilato al tabernacolo di Mosè, con un fondo piatto e rettangolare che identificava le superfici terrene, e con la volta celeste che si inarcava nella parte superiore a rappresentare la calotta stellata. Siffatta concezione, erede di più remote elaborazioni, aveva trovato una compiuta espressione nella Topographia christiana di Cosma detto Indicopleuste («il navigatore delle Indie»), un mercante cristiano che nel VI secolo, girovagando per il Mar Rosso, s’era fatto divulgatore di rendiconti circostanziati e affascinanti su parecchie regioni del Levante. Altri, nel solco di Cratete di Mallo, avevano ipotizzato e raffiguravano piuttosto un orbe sferico, suddiviso in quattro porzioni da due grandi oceani: uno che si allungava in verticale e uno che si estendeva lungo l’equatore. Il compartimento del Mediterraneo era il solo ad esser ritenuto effettivamente conoscibile, e quindi a possedere una caratterizzazione specifica. Un’ulteriore teoria, esposta da Marziano Capella, ripartiva il globo terrestre in grandi fasce o zone, distinte per clima (secondo una rappresentazione ricollegabile al commento di Macrobio al Somnium Scipionis di Cicerone): anche in questo caso, comunque, era solamente la porzione temperata-settentrionale, e cioè quella concernente il comprensorio mediterraneo, ad apparire geograficamente dettagliata. Principalmente, però, nel Medioevo risultava diffuso il modello di un’ecumene circolare, contornata dal Gran Mare Oceano: all’interno di una «O» si usava iscrivere allora una «T» che, incisa dalle acque dei fiumi Don e Nilo (nel tratto orizzontale) e del Mare Nostrum (nel tronco), comparti9
va tre blocchi continentali. Europa e Africa, più piccoli, si spartivano equamente lo spazio in basso, correlati alle stirpi originarie di Japhet e Cam. L’Asia, corrispondente grosso modo alla metà del cerchio, ne occupava l’intera parte superiore, connessa a Sem. Al centro, veniva spesso effigiata Gerusalemme (secondo il dettato di Ez 5,5: «Così dice il Signore Dio: Questa è Gerusalemme! Io l`avevo collocata in mezzo alle genti e circondata di paesi stranieri»). In tal modo, sottoposto all’aggiornamento medievale, un simbolo terracqueo risalente al tempo della Roma antica si cristianizzava andando a definire, biblicamente, il perfetto circolo cosmico che accoglie la crocifissione. Lo schema «T-O», acronimo di Terrarum Orbis, poteva peraltro reiterare con la sua tripartizione la Trinità, ovvero simboleggiare le virtù teologali: ciascuna interpretazione, purché cristiana, era legittima. Nel disegno del globo terrestre, le dimensioni preponderanti – e praticamente doppie – del continente asiatico sembrerebbero quasi voler sottintendere una consapevolezza di ignoranza e, quindi, una sorta di «piccolezza» europea di fronte a uno sterminato enigma: l’incapacità di comprenderne appieno la portata aveva insomma finito per dilatare artificialmente la grandezza dell’Oriente. La catalogazione arbitraria che frazionava l’India in Inferior (con Egitto ed Etiopia), Media (subcontinente e Oceano Indiano, comprensivo dell’isola di Taprobane, oggi Sri Lanka) e Magna (coi territori al di là del Gange) non poteva bastare a penetrare coscientemente delle lande indeterminabili, intrise di immutabile ambiguità. Ad avventurarsi nell’inconoscibile si rischiava di scomparire, di sfumare ingoiati da un buio che neanche la luce della fede era in grado di rischiarare: gli Atti di Tommaso, una compilazione apocrifa redatta nel III secolo a Edessa 10
(l’attuale Sanliurfa in Turchia), centro propulsore di missioni cristiane, avevano propalato con traduzioni dapprima greche e poi latine la fama dell’apostolo Giuda Tommaso, soprannominato Didimo («il Gemello»). Costui si sarebbe spinto sin nelle estreme regioni orientali per predicare, convertire il re Gondophares, fondare chiese, fare miracoli e riunire proseliti fra Taxila, Muziris (l’odierna Kodungallur) e Madras. Nondimeno il santo-architetto, glorificato quale costruttore di religiosità e palazzi regi, era stato anch’egli, ineluttabilmente, inghiottito dalle Indie. Una vulgata incerta e problematica lo voleva missionario in Cina prima del martirio, che sarebbe avvenuto nel 72 a Mylapore, per un eccesso anticristiano dei bramini. Ma se realmente la Chiesa di san Tommaso attecchirà a cominciare da Bombay, e si consoliderà nella trasmissione mitizzata del leggendario apostolato, di converso dell’evangelizzatore e del suo santuario il Medioevo europeo continuerà a non avere che un’idea vaga e astratta. Le offerte che già Alfredo il Grande (871-899), sovrano anglosassone, aveva inviato al supposto sacrario dell’apostolo, non erano servite a dissipare tenebre e confusione. Oltretutto, nel processo di cristianizzazione dell’Oriente la saga tomista appariva mischiata alle derivazioni del monofisismo giacobita (dipendente dai precetti di Giacobbe Baradeo, presule a Edessa nel VI secolo) e, innanzitutto, al nestorianesimo, che valorizzava l’umanità della persona di Gesù e ne ridimensionava la natura divina, sulla scorta di precetti coltivati alla scuola teologica di Antiochia. Eretica, era stata dichiarata dal Concilio di Efeso del 431 la dottrina di Nestorio, patriarca di Costantinopoli nonché propugnatore del magistero antiocheno. Tuttavia quella condanna, lungi dal reprimere, aveva dischiuso al credo nestoriano orizzonti più fecondi. Scacciati, e rifugiatisi nel 11
regno persiano, i nestoriani avevano costituito a Nisibi un fiorente istituto di teologia e di ascesi, mentre la preesistente Chiesa di Persia veniva sempre più informata dai nuovi princìpi dottrinari. Nulla poté intralciare una comunità ormai ben distinta dall’ortodossia bizantina, né le periodiche persecuzioni, né la caduta dei Sassanidi e l’avvento dell’islam. Di più: fianco a fianco col califfato musulmano degli Abbasidi, Baghdad sarà il trampolino di lancio per l’espansione nestoriana, destinata a una decisa accelerazione proprio fra il VII e l’XI secolo. La forza penetrativa fu tale che, fra il 635 e il 638, opere derivate da Teodoro di Mopsuestia, tacciate di eterodossia dall’imperatore di Bisanzio Giustiniano (527-565) con la condanna dei Tre Capitoli, furono trasposte in cinese e associate alla biblioteca imperiale della dinastia Tang. Dal canto suo Timoteo I, che dal 780 all’823 resse il patriarcato nestoriano, ebbe modo di consacrare prelati per la Cina e di potenziare il ministero in Tibet. Inarrestabile il nestorianesimo dilagò, con la sua liturgia in siriaco (una lingua di ceppo aramaico che si parlava in alcune aree mediorientali a ridosso della Mesopotamia) e con le sue peculiarità: i vescovi potevano sposarsi, i fedeli pregavano con le mani protese dinanzi al petto, volti a Est, in attesa della parousia (la nuova venuta del Figlio dell’Uomo annunciata in Mt 24,27), e la croce era adorata nuda, senza il crocifisso, poiché si rigettava la figura del Cristo sofferente. Nel momento di massimo fulgore, milioni di nestoriani si distribuiranno in più di venti province metropolitane e in centinaia di diocesi dall’Asia Minore alle circoscrizioni cinesi. Nel Kurdistan, comunità nestoriane rimarranno vive sino al XX secolo. Per prestigio, dimensioni e radicamento, un’eresia era dunque diventata la principale confessione cristiana, capace di impregnare a fondo l’Oriente. 12
Eppure, al papato romano, di quella storia giungevano riflessi fiochi e distorti.
3 | Il Prete Gianni e altre storie Imbroglioni e ciarlatani erano in agguato. Alla curia papale di Callisto II si era presentato nel 1122 (teste Odone, abate del monastero di San Remigio a Reims) un individuo che asseriva di essere il patriarca Giovanni d’India. Cercava, evidentemente, un riconoscimento del pontefice per il proprio ruolo. E millantava perciò la popolazione cristiana di un’immensa città indiana, con monasteri sorti in onore degli apostoli e le solenni commemorazioni che richiamavano presso la chiesa di San Tommaso tutti i devoti d’Asia. La sbalorditiva novella tornò in auge nel 1145, quando il cronista Ottone di Frisinga affermò d’aver incontrato alla corte pontificia di Eugenio III un vescovo di Siria, Ugo di Jabala, consegnatario d’una rivelazione eccezionale: oltre la Persia regnava il Prete Gianni, discendente dai Re Magi, monarca e contemporaneamente sacerdote di Cristo, disposto a guadare il Tigri col suo portentoso esercito per accorrere in soccorso della cristianità di Terrasanta, oppressa dall’islam. La propaganda ecclesiastica non aveva tardato a mettersi in moto: la «scoperta» di un miracoloso salvatore avanzante da Oriente sopravveniva con notevole tempismo all’indomani della perdita di Edessa, una città che, posta vicino a un’importante arteria commerciale, era stata presa dai musulmani nel 1144. In epoca di crociate, balenavano e avevano buon gioco i miraggi di provvidenziali condottieri che aiutassero i cavalieri crucesignati ad attanagliare le perti13
nenze islamiche, riconquistandole al pieno potere del papa e della nobiltà feudo-signorile. Vero è che nel 1141 i Selgiuchidi del principe Sanjar, turchi islamizzati che controllavano le regioni iraniche, erano stati sbaragliati a Katvan, nei pressi di Samarcanda, dai Kara-Kitai del comandante Yelu Dashi, sopraggiunti dalla Cina settentrionale. Mongoli di razza e buddhisti di religione, gli annientatori delle schiere islamiche annoveravano quote di confuciani e cospicue frange di nestoriani: ma è molto dubbio che il loro capo fosse davvero cristiano. D’altro canto, l’evangelizzazione nestoriana aveva spesso convinto alla conversione capitribù e dinasti centro-asiatici, dalla cui titolatura cinese di wang-han (re-khan) sarebbe disceso, per una vaga analogia fonetica, il nome occidentalizzato di «Giovanni» e la metamorfosi in «Prete Gianni». L’invenzione di milizie salvifiche e del loro benemerito comandante altro non era, dunque, se non un’interpretazione deformata dei rumori di genti e principi d’Asia convertiti al nestorianesimo. Nel montare di emozioni e speranze, una lettera fittizia di Iohannes Presbyter, prodotto di un anonimo e talentuoso compilatore, sarebbe pervenuta intorno al 1165 all’imperatore di Bisanzio Manuele I Comneno (1143-1180), oltreché a Federico I Barbarossa (1152-1190) e a papa Alessandro III (il senese Rolando Bandinelli, 1159-1181). La missiva riferiva di un «Re delle Tre Indie e di tutte le terre dalla Torre di Babele al sepolcro dell’apostolo Tommaso». Offriva agli occhi esterrefatti dell’Occidente un principato colmo di pietre preziose, oro, incenso, mirra e seta. Decantava coltivazioni prospere di cereali, dovizia di erbe mediche, profusione di latte, miele, vino. Esibiva, insomma, un giardino dell’abbondanza in cui non esistevano spergiuri, adulteri, 14
fornicatori, ladri e omicidi. Al contrario, uomini e donne si abbeveravano alla fonte dell’eterna giovinezza e vivevano in armonia, governati con amore e giustizia da un saggio imperatore che aveva rinunciato alle glorie terrene per fregiarsi del modesto titolo di «presbitero». Il suo palazzo era stato «costruito nello stile della reggia che san Tommaso aveva disegnato per il re Gondophares», e la sua corte alloggiava migliaia di persone. In quel reame della beatitudine non c’era pericolo di imbattersi in rettili o serpenti velenosi, canoniche figurazioni del peccato: tutt’al più gironzolava qualche salamandra refrattaria al fuoco. Il benessere generale assicurava anche una milizia di diecimila cavalleggeri, altrettanti luogotenenti e mille arcieri. Trasposti nell’immaginario europeo, quei militi potevano di volta in volta divenire francesi o inglesi, a seconda delle nazioni e dei contesti linguistici in cui la lettera del Prete Gianni transitava, veniva copiata e rimaneggiata. All’origine delle circa centoventi versioni che ci sono pervenute del documento, Bernard Hamilton ha recentemente proposto d’individuare una creazione dell’entourage di Federico I, mirante a esaltare uno Stato esemplare dove i chierici accettano le regole di sovrani equi e ragionevoli. Nell’esegesi di Leonardo Olschki, il resoconto di Iohannes Presbyter è invece l’espressione di un’utopia teocratica ideale. E non è peraltro da scartare, sulle orme di John Larner, l’ipotesi che l’elenco delle fantasticherie fosse un semplice diversivo, un vagheggiare esotizzante preparato da un qualche buffone erudito per divertire i suoi amici. Dal divertissement alla suggestione fu un attimo, giacché il papa, nel 1177, decise di inviare in ambasciata al favoloso re-sacerdote il suo medico personale, Maestro Filippo: il messaggero scomparve però in Palestina, e di lui, delle meraviglie dell’India, non si ebbe più notizia. 15
L’accesso all’Oriente era nuovamente negato, inibito, impantanato nella dimensione onirica di credenze che, per giunta, circolavano quasi esclusivamente in ambienti colti. Riguardo al Levante, restavano aleatorie e disorganiche persino le indicazioni di al-Idrisi (o Edrisi), il dotto nordafricano che, nel 1154, aveva completato per il normanno Ruggero II, nella reggia di Palermo, Il diletto di chi è appassionato per le peregrinazioni attraverso il mondo, una summa di geografia fisica e antropica corredata da un planisfero d’argento. L’opera, realizzata in un quindicennio, rimarrà senza traduzioni fino al XVII secolo, e non sarà mai troppo conosciuta. Per lo più ignorato risulterà anche il Sefer Masacot o Libro di viaggi di Benjamin ben Jonah (Beniamino da Tudela): dalla Spagna, l’ebreo navarrese si era spinto poco dopo la metà del XII secolo in un viaggio che lo avrebbe condotto a scrivere di Italia, Grecia, Siria, Persia, Egitto e Bahrein. Osservando, registrando e assemblando molteplici testimonianze, il giudeo ispanico racconterà della costa del Malabar e di un itinerario che menava direttamente alla Cina. Le Indie, tuttavia, a eccezione degli avancorpi mediorientali, rimanevano niente più che un sentito dire. Pure, stando all’Indagine sul commercio, un opuscolo del IX secolo attribuito (non senza incertezze) ad al-Jahiz, dalle piazze cinesi pervenivano agli empori del Golfo Persico schiave ed eunuchi, assieme a seterie, carta, inchiostro, spezie e chincaglierie. Le sensazioni di bazar, di harem, di sfarzose liturgie civili lievitavano, almeno finché il Levante era una lontananza immobile, cristallizzata. Ma non appena si muoveva, non appena si affacciava alle soglie dell’Europa, quello stesso Levante dava i brividi. E l’incantamento si mutava in terrore, il miraggio in incubo. 16
4 | Invasioni barbariche Germani e Avari. Unni e Ungari. Lo spettro dei barbari ancora infitto nella memoria: allorché avevano puntato a Occidente, i nomadi, e specialmente quelli d’estrazione centroasiatica, s’erano rivelati assolutamente nefasti per gli assetti delle società euromediterranee. Quando i flussi di masse randagie non potevano più essere gestiti mediante politiche di assorbimento programmato, ecco che la militarizzazione del limes palesava la sua fragilità: era allora che i meccanismi di filtro alle frontiere cedevano, le barriere diventavano esili, e le migrazioni si tramutavano in invasioni. Aveva un bel predicare nel 1219 Giacomo da Vitry, vescovo di Acri (l’odierna Akko), proclamando imminente l’arrivo di un Davide, ennesimo re delle Indie, in aiuto dei combattenti cristiani contro gli infidi saraceni. In realtà, la Relatio de rege Davide, che prese a diffondersi fra gli europei dal 1221, rifletteva l’enorme impressione generatasi negli ambienti del nestorianesimo per il crollo della Corasmia, vasto e potente principato islamico che, all’inizio del XIII secolo, incorporava Persia, Afghanistan e Transoxiana (da Oxus, nome latino del fiume Amudar’ja), in un dominio compreso dal Golfo Persico al Syrdar’ja e dal Mar Caspio all’Indo. Ad avventarsi sull’impero musulmano e sul suo scià, Ala al-Din Muhammad II (1200-1220), erano stati branchi di cavalieri ululanti e feroci, provenienti dalle steppe della Mongolia. Pur avendo per lunghi tratti squassato il dar al-islam, la «terra dell’islam», gli aggressori non avanzavano certamente per soccorrere la cristianità del Vicino Oriente. Non arrestarono infatti la loro rincorsa: le prime avvisaglie si ebbero sin dalla battaglia del fiume Kalka (oggi Kal’cˇik, un immissario del Mar d’Azov), dove le milizie mongole sbaragliarono nel 17
1223 una coalizione di truppe dei principi russi e dei loro alleati comani (elemento egemone della confederazione dei Kipchak/Qıpçaq, che dall’XI secolo dominavano le aree steppose poste sopra il Mar Nero, fra il Dnepr, il Don e l’Ural). L’onda devastatrice, che in precedenza aveva scosso la Georgia, si abbatté sulla Crimea: Soldaia (l’attuale Sudak) fu saccheggiata, poco prima che i predatori si ritirassero. Fra i più solleciti a segnalare quei rovinosi avvenimenti fu Andrea II d’Ungheria (1205-1235), che allertò il papato addebitando la terribile incursione a un re Davide, comunemente chiamato Prete Gianni, sbucato dall’Oriente a trucidare 200.000 tra Russi e Comani. Dei disastri patiti dalle genti caucasiche dovette dar conto anche la regina georgiana Rusudan (1223-1247), che nel 1224 indirizzò al pontefice un’apposita comunicazione. Nel turbinare di dicerie e mistificazioni, un’eco farraginosa delle scorrerie si diramerà fino ai cenobi alsaziani e austriaci, confluendo nelle redazioni degli Annali di Marbach o della Continuatio di Klosterneuburg. In ambiente baltico, a più stretto contatto con l’epicentro della catastrofe, il Chronicon Livoniae di Enrico di Lettonia conterrà viceversa notazioni alquanto accurate sui tragici accadimenti. Ugualmente, le voci d’allarme rimarranno inascoltate. E le orde mongole, coadiuvate da ausiliari turchi e genieri cinesi, potranno tornare nel 1236 a farsi ancora più vicine, minacciose, terrifiche: annienteranno la Bulgaria del Volga-Kama e ne sconquasseranno la capitale, Bolgary, attivo mercato alla confluenza dei due fiumi; assoggetteranno i Mordvini, di lingua ugrofinnica, e i Baschiri, attestati fra l’alveo della Belaja e la regione di Ufa, nella Magna Hungaria popolata da quella fetta di Magiari che non erano migrati verso i pianori danubiani; metteranno a ferro e fuoco la Comania massacrando, imprigionando e costrin18
gendo migliaia di famiglie a fuggire verso le foreste settentrionali o nella pustza ungherese. Poi toccherà alle città russe: ad una ad una Rjazan’, Kolomna, Mosca, Rostov, Vladimir e tutti i capoluoghi che non accettavano di sottomettersi agli invasori pagando un tributo, o che, peggio, maltrattavano gli ambasciatori (sacri, per le costumanze mongole), saranno schiacciati, in un’escalation di eccidi immani. Monache stuprate, donne schiavizzate, uomini scuoiati, anziani diaconi bruciati o sgozzati sugli altari, intere cittadine decimate, fanciulli e fanciulle deportati assieme a qualche artigiano specializzato (utile più da vivo che da morto) e a qualche religioso (risparmiato in quanto potenziale mediatore col divino): sull’orlo del baratro, il granduca Jurij II Vsevolodovicˇ di Suzdal’ tenterà di reagire, senza aspettare che i capisaldi russi si sgretolassero come castelli di sabbia. Finirà decapitato, dopo essere stato battuto sulle sponde del Siti, nel Nord, a latitudini teoricamente infrequentabili da chi non avesse familiarità con climi rigidi e territori accidentati. Del resto, i rigori invernali non intralciavano affatto le manovre dei Mongoli, combattenti resistenti e tenaci che nel gelo dell’entroterra asiatico avevano forgiato fisico e mente. Il freddo esaltava le doti di quegli eccellenti guerrieri, abili nel saettare cavalcando, e dei loro cavalli, fondamentali per superare qualsivoglia impervietà: resistentissimi, i corsieri mongoli erano abituati a trovare la pastura scavando nella coltre nevosa con gli zoccoli, e mostravano una dimestichezza innata nel procedere sulle superfici dei fiumi lastricate dal ghiaccio. L’inverno era insomma un prezioso compagno, non un nemico: e in effetti, in prossimità di Novgorod, attaccata nella primavera del 1238, la forza d’urto mongola dovette impantanarsi nella fanghiglia delle nevi disciolte. L’iniziativa bellica non perse peraltro vigore, giacché 19
nel prosieguo dei raid vennero asservite le residue tribù comane della Russia meridionale, e gli Alani del Caucaso settentrionale. Le razzie furono talmente efficaci da cagionare un’eccedenza di prigionieri-soldati: molti di loro vennero pertanto rivenduti (in particolare al sultano d’Egitto, che doveva consolidare la sua preminenza mediorientale), apporˇ ernitando oro ai forzieri mongoli. Quindi furono travolte C gov e Perejaslav. Finché, nel novembre del 1240, innanzi ai conquistatori si pararono i sobborghi di Kiev, vecchia capitale di un principato che aveva brillato fra IX e XII secolo. Nel Duecento era una località in decadenza, infiacchita dalla ricorrenza delle incursioni nomadiche e dalle rivalità intestine. Ma rappresentava pur sempre la «Madre delle Russie» e possedeva fortificazioni massicce, in pietra e legno. Gli eserciti mongoli avevano tuttavia espugnato ben più munite roccaforti dall’altra parte dell’Asia, nelle estenuanti contese coi Cinesi, come pure nelle vittoriose campagne di Corasmia. Anzi, proprio dalle esperienze in Cina e Persia, e dal contatto con tecniche ossidionali sofisticate, avevano tratto insegnamenti in breve adattati, migliorati e trasposti nelle guerre europee. Trabucchi e mangani si univano alla dotazione di razzi incendiari e fumogeni. Bombarde esplosive si combinavano con pezzi di ceramica e vetro scagliati da sifoni in bambù. La gittata delle catapulte variava dai 100 ai 350 metri, e le balestre giganti erano devastanti per potenza e precisione. Di fronte a cotanti marchingegni, per le difese kievane non ci fu scampo: una pioggia tambureggiante di proiettili di qualsiasi genere, scagliati insieme a dardi infuocati, squarciò la Porta Polacca e frantumò i bastioni difensivi. Nella breccia si slanciò la cavalleria pesante mongola, andando a scontrarsi con l’iniziale opposizione guidata dal boiardo Demetrio, luogotenente del gran prin20
cipe Michele Vsevolodovicˇ (che nel frattempo era scappato via). Un secondo assalto ebbe alfine ragione della caparbietà dei difensori. Il 6 dicembre, si consumava il dramma: il saccheggio brutale, l’abbattimento di chiese e palazzi, lo sterminio della cittadinanza ridussero la metropoli russa a una catasta di macerie e cadaveri. Ancora cinque anni più tardi, un macabro spettacolo di teschi e ossa sconvolgeva quanti si trovassero a passare dai luoghi delle stragi. La violenza dell’aggressione inferse il colpo di grazia a una città che, spesso per l’intermediazione ebrea, aveva in passato commerciato con Cracovia, Praga, Pest, coi mercanti della Germania, coi paesi del Caucaso, e che si era legata culturalmente ed economicamente a Bisanzio, recependo il cristianesimo greco fin dal X secolo: da Kiev partivano periodicamente dei convogli che in dieci giorni, se non si incappava in razzie brigantesche, esportavano sul Bosforo pellicce, cera, miele e schiavi in cambio di tessuti, vino, spezie e icone. Con il tracollo definitivo dell’ultimo baluardo russo, le porte dell’Europa si spalancavano adesso alla progressione mongola, giunta a lambire il corso del Dnestr. La conquista immediata di Volinia e Galizia dovette indurre parecchi membri della nobiltà slava a riparare in Polonia e Ungheria, abbandonando a se stesse le comunità contadine, sovente inermi. Fuga effimera: da Przemys´l, coi Carpazi alle viste, e dalla Vistola, i Mongoli incombevano sui confini polacchi e ungheresi.
Capitolo secondo
FURORI
1 | Arrivano i Tartari Non era la prima volta che il domenicano Giuliano d’Ungheria si inoltrava nelle piane russe. Vi andava con la passione del predicatore, con il lucido fervore di chi dispiega intelletto e cuore per innescare l’altrui conversione, nell’incrollabile certezza della fede. La cristianissima Corona magiara degli Árpád incoraggiava i missionari: radicare un patronato spirituale in plaghe semisconosciute poteva preludere all’instaurazione di un protettorato economico e politico, da parte di un regno che, bagnato dall’Adriatico, lambito dai Balcani, era propenso a guadagnare territori sempre più orientali. La missione domenicana del 1237 dovette però incepparsi, e naufragare nello sgomento: un’ondata di profughi fluiva, incontenibile. Decine di migliaia di fuoriusciti si stavano riversando nelle praterie ungheresi, in preda al panico. Erano in prevalenza comani e tutti, dal loro duce Kotyan khan, ai nobili, ai più umili, si dichiaravano propensi ad abbracciare istantaneamente il cattolicesimo, pur di trovare asilo e salvarsi. Li inseguiva lo spettro delle atrocità mongole, la memoria ancora calda delle sevizie, il vivido delle carneficine e delle devastazioni. Frate Giuliano ebbe presto contezza della sciagura. Percepì distintamente l’immi22
nenza del pericolo (essendosi imbattuto anche in alcuni Mongoli e in un loro ambasciatore, prodigo di informazioni sui piani d’invasione dell’Europa). E subito, rientrato in patria, avvertì sia re Béla IV (1235-1270) sia papa Gregorio IX (1227-1241) che gli invasori intendevano conquistare Roma e impadronirsi del mondo. I demoni che infuriavano in Russia venivano chiamati «Tatari», dall’appellativo di una tribù asiatica che era stata in passato fagocitata dai Mongoli. Per l’Europa fu facile mutarne la denominazione in «Tartari», associandoli al Tartarus (in latino) o Tartaros (in greco), le regioni infere della mitologia classica. «Ecce Tartari veniunt!» era dunque il grido terrorizzato che, secondo le cronache medievali, risuonava all’apparire delle armate infernali. Le loro avanguardie allineavano frotte di prigionieri vestiti da soldati e mandati al macello a mo’ di scudi di carne. Da dietro, incedevano cavalieri e arcieri al ritmo incalzante del nakkara, un voluminoso tamburo in bronzo o in pelle portato in battaglia a dorso di cammello. La perfetta disciplina, la distribuzione dei reparti per colonne distinte (e quindi non attaccabili simultaneamente), un efficace sistema di esploratori, la puntualità nelle segnalazioni a distanza con torce o bandiere, l’interdipendenza delle divisioni di fanti e cavalleggeri, il ricambio sistematico delle cavalcature assicuravano versatilità e solidità a un esercito che, semplicemente, nel XIII secolo, era invincibile per le armi e gli armati europei. Da un lato stavano le metodiche e le armature che avevano evoluto i paradigmi militari centro-asiatici, facendo dell’agilità e della maneggevolezza il loro punto di forza. Dall’altro una tecnologia obsolescente e ingombrante: la sopravveste d’acciaio, la camicia imbottita, la calzamaglia di lana, gli stivali allacciati alla coscia, la cuffia, la calotta, l’el23
mo, la lorica, lo scudo, lo spadone, l’ascia e la lancia appesantivano i milites occidentali e ne intralciavano le movenze. Per un cavaliere europeo, lo scontro fisico si risolveva il più delle volte nello sbalzare di sella l’avversario e affrontarlo corpo a corpo in un combattimento che, anche quando coinvolgeva parecchi uomini, altro non era se non una moltiplicazione all’infinito di duelli singoli, da chiudere con un colpo sul cranio. All’esaltazione di questo guerreggiare individualistico ed elementare, sostenuto sovente da una liturgia esibizionistica dello status cavalleresco, si contrapponeva l’indissolubile compattezza dei reggimenti mongoli, sublimata dalla raffinatezza di strategie che prevedevano l’alternanza di manovre avvolgenti e attacchi frontali, l’interscambiabilità delle retroguardie con ali e prime linee, e i lampi di guastatori che a piccole squadre si avvicinavano agli avversari e li sommergevano di saette, per aprire la strada all’irrompere della cavalleria pesante. Con lo stratagemma del mangudai, veloci drappelli di temerari puntavano direttamente sui nemici, vi arrivavano dinanzi, fingevano la ritirata e attiravano gli sprovveduti inseguitori sotto una tempesta di frecce che il resto della milizia mongola aveva predisposto nel sito più idoneo all’imboscata. L’eclettismo e la speditezza erano garantiti da indumenti e armamenti che favorivano la mobilità e consentivano agli arti la massima indipendenza: cotte di maglia, tuniche in stoffa, bassi stivaletti e pantaloni larghi, con colbacchi di pelliccia e mantelli di pecora per le stagioni più fredde, non davano impaccio. A pelle si indossava una blusa di seta pura, trattata in modo che potesse ricevere una frecciata senza strapparsi: gli effetti della ferita venivano così attenuati, e l’estrazione di un quadrello risultava meno lacerante, giacché si lenivano le emorragie e le infezioni che solitamente erano la causa primaria dei decessi. 24
L’abbigliamento militare mongolico contemplava inoltre un elmetto conico in ferro e cuoio, una catafratta in corame bovino ricoperta da piastre metalliche, e un clipeo di vimini intrecciati o in legno di sandalo, che si infilava sulla schiena durante il galoppo e si imbracciava nelle mischie a piedi. La spada corta, la sciabola, il giavellotto, la lancia a uncino per disarcionare, la scure, la mazza ferrata e il lazo fissato alla pertica per imbrigliare i nemici completavano un equipaggiamento che aveva nei due archi (il grande per le lunghe gittate, il piccolo per il corto raggio) l’elemento più specifico delle soldatesche sopravvenute dalla Mongolia. Le stime suggeriscono che si sarebbero mossi in centocinquantamila, per estendere a ponente l’impero dei nomadi e replicare in Terra una sovranità speculare a quella del Tengri, l’eterno Cielo azzurro e onnipotente, adorato nella sconfinata vastità delle steppe d’Asia. Imbattendosi in contesti politicamente disomogenei, l’intrapresa dovette avere gioco facile: erano fattori di debolezza la parcellizzazione dei principati russi, le diatribe fra il pontefice e l’imperatore svevo Federico II Hohenstaufen (1220-1250), le dispute fra i diversi duchi polacchi e il malcontento dell’aristocrazia ungarica, che non tollerava le concessioni fatte dal re agli esuli dalla Comania. Tanto più che la questione era assurta a casus belli: l’ingiunzione di non accogliere e non proteggere i fuggiaschi comani, indirizzata dai Mongoli con messaggerie ripetute, aveva sortito la sdegnosa indifferenza del monarca ungherese. Il pretesto per l’invasione (ammesso che pretesti occorressero) s’era quindi concretato. L’Ungheria, coi suoi pascoli immensi che ricordavano gli immensi erbai centro-asiatici, era la piattaforma migliore per pascere le mandrie e imperniare la conquista. L’attacco venne preparato in più punti su un fronte di un mi25
gliaio di chilometri. Nell’inverno del 1240-1241, varcata la Vistola, l’ala destra mongola entrava in Polonia e saccheggiava Sandomir (Sandomierz), mentre il grosso dell’armata oltrepassava i valichi dei Carpazi tra Uzˇgorod e Mukacˇevo, e il fianco sinistro si spostava dalla Bessarabia e dalla Moldavia. Il tracollo delle milizie polacche a Chmielnik sguarnì Cracovia: a marzo, Boleslao il Casto abbandonava la città all’incendio per fuggire in Moravia. L’Oder fu superato a Racibórz dai contingenti mongoli, lesti a sciamare su Breslavia e sul suo hinterland. La resa dei conti si approssimava: vicino Liegnitz, il 9 aprile, una coalizione di polacchi e crociati tedeschi, al comando del duca di Slesia Enrico II il Pio, sfidò i Tartari. Non ingannino i cliché dei pennacchi al vento, delle bardature sfavillanti e delle corazze luccicanti: la fanteria di quell’esercito centro-europeo si componeva in buona parte di contadini, che erano stati obbligati ad arruolarsi e che, per battersi, disponevano solo di qualche aggeggio in più di falci e forconi. Il combattimento fu comunque durissimo: la ferocia della contesa provocò perdite notevolissime su entrambi i fronti, e le ostilità cessarono solamente con la rotta finale della compagine polacca. Racconta la Hystoria Tartarorum (una compilazione redatta fra il 1247 e il 1251 da un frate di cui si conosce solo l’iniziale del nome, C. de Bridia) che Enrico il Pio fu catturato, svestito, costretto a chinarsi davanti al cadavere di un ufficiale mongolo e decapitato. La sua testa mozza, infilzata su un’asta e portata in giro per spregio, espresse tutta la crudeltà e l’odio non ancora smaltiti. A ognuna delle vittime avverse i vincitori tagliarono un orecchio, riempiendone una moltitudine di sacchi, per testificare il trionfo. Nelle tre settimane successive, della Slesia ricca, della Slesia fertile e popolosa fu fatto un deserto. La desolazione si irradiò alla Mo26
ravia, salda soltanto nella piazzaforte di Olomouc, difesa da Jaroslav di Sternberg. Ormai, le gole carpatiche preannunciavano le terre ungariche, il ricongiungimento dei reparti provenienti dalla Polonia col nucleo principale dell’esercito mongolo.
2 | Le coorti di Satana Fra la nobiltà ungarica e i rifugiati comani il dissidio s’era acuito. L’antagonismo, viscerale, contrapponeva dei proprietari terrieri, gelosi delle proprie prerogative nobiliari, a dei seminomadi, che guastavano poderi e raccolti ovunque migrassero o si accampassero. A fronteggiarsi stavano il consorzio stanziale e la civiltà randagia, incompatibili, come sempre, dappertutto. La controversia, già incandescente, dovette deflagrare con la cattura d’una squadra di perlustratori mongoli: in quella brigata militavano anche alcuni oriundi della Comania. Che fossero stati reclutati a forza (ipotesi del tutto plausibile), che fossero dei mercenari o che effettivamente avessero disertato, la circostanza fu più che sufficiente per scatenare un pogrom. L’uccisione di qualche maggiorente convinse i Comani a una fuga scomposta e violenta, che non avendo una meta precisa addusse solamente scompiglio a un contesto bisognoso, quanto mai, di coesione. Fin dal marzo del 1241 i Mongoli erano infatti debordati da Galizia, Rutenia e Transilvania. Niente e nessuno li aveva potuti contenere. Lungo il Danubio borghi e città erano caduti, compresa Belgrado. E dalle armate procedenti sicure e celeri si dipartivano in continuazione distaccamenti incaricati di stravolgere campagne e villaggi, a contor27
no della traiettoria primaria. Portava diritto alla capitale, la strada: a neanche un mese dall’irruzione in Ungheria, le truppe d’invasione si addensavano alla periferia di Buda. In quei frangenti, Béla si prodigava per ricomporre, a fatica, le proteste del baronato. Le promesse strappate al re, la minaccia impellente, ebbero l’effetto di indurre i nobili a sostenere militarmente la monarchia, nonostante covassero ancora dissapori per l’irrisolta faccenda comana. Nutrito di cavalieri magnifici e di arcieri formidabili, l’esercito ungherese era completo e poderoso. Probabilmente, il meglio che si potesse apprestare nel Duecento europeo. Sfidarne la potenza, affrontarlo in posizione svantaggiata, significava il suicidio. Conveniva agire d’astuzia. Il dietrofront tartaro non corrispose perciò a una rinuncia: i Mongoli sapevano che sarebbero stati incalzati dagli Ungheresi, e che quindi avrebbero pilotato gli inseguitori in posizione più adatta a riequilibrare il gap tattico. A far la differenza era l’arte della guerra: l’11 aprile, sul fiume Sajó, vicino al ponte di Muhi, l’elasticità degli aggiramenti, la scaltrezza nei dislocamenti e la puntualità nei piazzamenti permisero alle schiere mongole di ribattere alle cariche e di accerchiare il campobase ungherese. Accadde allora come nelle grandi battute venatorie delle radure centro-asiatiche, che per mesi e mesi accomunavano i cacciatori in un rito collettivo, allenandoli alla solidarietà e, insieme, addestrandoli alla guerra: le prede sospinte, il cerchio che si stringe fino a includerle in una cornice infima, e l’ecatombe. Là di bestie, qua di esseri umani. Chi sfuggiva alla stretta letale, rimandava di poco la sua fine: veniva rincorso, accalappiato, sgozzato. «Durante un cammino di due giorni», affermarono dei testimoni oculari, «non avresti potuto incontrare lungo il tragitto altro che guerrieri stramazzati, i cui corpi giacevano come pietre in una cava». 28
Con l’esercito magiaro disfatto, e col re datosi alla macchia, il suolo ungherese subì uno scempio immane. Pest, presa d’assalto, fu incenerita, e i suoi cittadini trucidati. Nell’immediatezza dell’occupazione e della razzia, nell’euforia e nell’eccitazione della vittoria, alle fanciulle catturate si assicurò la liberazione in cambio di accondiscendenza sessuale. Poi, le si ammazzò lo stesso. Agli agricoltori si impose invece di raccogliere e immagazzinare i frutti della terra. Poi, li si soppresse, per non avere troppe bocche da sfamare, a scanso di problemi. Bisognava infatti rifocillare le milizie, concedere riposo ai cavalli e farli pascolare nelle praterie erbose. In prospettiva, sarebbero state aggredite l’Austria e la Boemia. A dicembre, la gelata del Danubio permise agli invasori di entrare in Croazia e dirigere su Neustadt, poco più giù di Vienna. Il Friuli, Udine, furono sfiorati. All’inseguimento di Béla IV, che coi più stretti familiari s’era nascosto in Dalmazia giungendo al porto adriatico di Traù, gli avamposti mongoli pervennero nel marzo del 1242 a Spalato e a Cattaro: col fiato sul collo, al sovrano Árpád non resterà che prendere il largo su una nave. Intanto, i nuovi e incontrastati padroni dei territori ungarici provvedevano a nominare un numero elevato di ufficiali e a coniare perfino delle monete, quasi progettassero di stanziarsi lungamente, definitivamente nelle regioni slavo-balcaniche. Sotto tiro, rischiavano ora di andare in frantumi le pertinenze papali e la giurisdizione imperiale di Federico II di Svevia. Solo un braccio di mare separava i Mongoli dalla penisola italica, e le contee tedesche apparivano più che mai esposte all’imminenza di un attacco fatale. Presagi negativi presero così a insinuarsi per ogni dove, in un vortice di sgomento e concitazione. Le nenie sfiduciate profetizzavano giorni apocalittici. Le chiese si riempivano quo29
tidianamente di assemblee terrorizzate, che il clero incitava a pregare ossessivamente per ottenere il perdono. Le tensioni crescenti si scaricavano sugli ebrei, i consueti capri espiatori che, in Germania, subirono l’ennesima persecuzione, incolpati di procacciare armamenti ai massacratori della cristianità. Si accavallavano le opinioni più disparate e disperate, che cercavano di decifrare un’aggressione dai contorni sconcertanti e, ancora una volta, indeterminabili. Affioravano i sensi di colpa di un Occidente che nella catastrofe scorgeva la punizione divina per i suoi peccati e le sue discordie. I sermoni di Serapione, vescovo di Vladimir, lo avevano già rimarcato: «Dio ha mandato contro di noi un popolo spietato, un popolo selvaggio, un popolo che non risparmia né la bellezza della gioventù, né l’impotenza dei vecchi, né l’infanzia. Noi abbiamo chiamato la collera di Nostro Signore». Le cronache di Rjazan’ erano state del medesimo tenore: «Devastarono le chiese di Dio e sugli altari consacrati versarono sangue copioso. E nessuno sopravvisse, tutti perirono allo stesso modo e bevettero fino alla feccia la coppa della morte. Nessuno c’era per piangere o gemere – né padre o madre per i figli, né figli per il padre e la madre, né fratelli per i fratelli, né cugini per i cugini – ma tutti giacevano privi di vita. E ciò accadde come punizione per i nostri peccati». Ma anche più a ovest, nelle parole di Enrico di Lorena, si paventava il collasso dell’Europa e l’estinzione del cristianesimo: «Il pericolo annunciato molto tempo fa nelle Sacre Scritture», registrava il conte francese, «è ormai alle porte, per via dei nostri peccati, e incombe su di noi, pronto a travolgerci. Una tribù crudele, una moltitudine di barbari selvaggi e sfrenati, ha raggiunto, invaso e occupato i nostri confini, e si trova ormai sul suolo della Polonia, dopo aver vagato per molte altre terre sterminando le popola30
zioni». I fantasmi di Gog e Magog, i vendicatori dei tempi ultimi, s’erano di colpo materializzati e si apprestavano ad annientare l’umanità. Nello sforzo di interpretare l’offensiva degli eserciti sconosciuti in chiave teologica e soprannaturale, molti fra gli ecclesiastici e gli intellettuali cristiani vollero riconoscervi i pronipoti delle tribù israelite che avevano ripudiato le leggi mosaiche per adorare il vitello d’oro. Si vociferava anche di sadducei, di farisei, di saraceni, e persino di Parti, gli irriducibili avversari dei Romani. Li si riteneva provenienti dalla terra spaziosa chiamata Tarse, situata al di là della Persia. Qualcuno giurava pure di aver contato alla guida delle legioni malefiche quaranta re, e quattrocento vescovi, e moltissimi arcivescovi. Da più parti si sosteneva che i Tartari intendessero recuperare le spoglie dei Re Magi, traslate in Colonia dalla chiesa di Sant’Eustorgio a Milano. E si consideravano figlie dell’inferno quelle «coorti di Satana», sprigionatesi repentinamente, sorte improvvise e implacabili come la collera dell’Altissimo. I più lungimiranti presentivano che la reale aspirazione delle frotte mefistofeliche era di insignorirsi del continente, tutto.
3 | Fattezze mostruose e animo crudele Fu durante una ricognizione nel ducato austriaco che una pattuglia tartara venne intercettata, attaccata e parzialmente dispersa. Otto perlustratori finirono prigionieri. Fra loro, a sorpresa, figurava anche un inglese. Dalla natìa Britannia era espatriato per un qualche misfatto poco chiaro, andandosene a Oriente. Può darsi che fosse un disertore di crociate. Aveva comunque girovagato per le terre mediorientali, e 31
perduto al gioco ogni residua sostanza. S’era quindi messo al servizio dei Mongoli, e nei ranghi del loro esercito aveva riguadagnato le contrade mitteleuropee. Pare che parlasse molte lingue, e ai carcerieri dichiarò d’essere un diplomatico. Il suo era presumibilmente l’estremo tentativo di sottrarsi a un’uccisione che, però, ineluttabilmente, non risparmiò né lui né i compagni di sventura. Ma simili shock, l’impasto inquietante di razze e personaggi che si sarebbero dovuti trovare dall’altra parte della barricata, non contribuivano di sicuro a sgrovigliare la farragine: l’effettiva composizione e l’entità dei Tartari rimanevano incerte, e l’incertezza figliava un coacervo di congetture talvolta fasulle o esagerate. L’inutilità di qualsiasi opposizione, l’impossibilità di contrastare le falangi demoniache ne aveva infatti gonfiato a dismisura la fama sinistra. E fioccavano le apprensioni: «Gli invasori», illustrava Ivo di Narbona all’arcivescovo di Bordeaux, «sono gente inumana, la cui legge è l’essere senza legge. Sono ira e strumento del castigo divino: devastano terre enormi muovendosi come fiere e sterminando con il ferro e con il fuoco tutto ciò che si trovano davanti. Sono gli alleati dell’Anticristo». Le descrizioni delle efferatezze pescavano a piene mani negli stereotipi che la letteratura tardo-antica di un Ammiano Marcellino o di un Giordane aveva affibbiato alle invasioni barbariche. Si sentiva ripetere allora che «i loro capi si cibano di cadaveri come se fossero pane, e non lasciano agli avvoltoi null’altro se non le ossa [...]. Le donne vecchie e brutte vengono date in pasto a questi antropofagi, costituendo la razione giornaliera del vitto. Le donne più belle, invece, non vengono divorate ma, malgrado le loro urla e le loro lamentazioni, sono soffocate sotto moltitudini di stupratori [...]. Essi violentano le vergini fino a far loro rendere l’anima. Do32
podiché, tagliando alle fanciulle i seni, che sono riservati ai comandanti come cibo prelibato, quei selvaggi mangiano con gusto le restanti membra femminili». L’obbrobrio era altresì esasperato dai tratti fisionomici: in una missiva diretta al re di Francia, un principe musulmano mediorientale aveva prospettato l’incalzare di «una razza di uomini mostruosi e crudeli, discesi dalle montagne del Nord [...] che si nutrono di carne cruda, e anche di carne umana». La diversità delle fattezze, del vestiario e delle presunte abitudini faceva scrivere di «esseri disumani, somiglianti a delle bestie, tanto che li si deve chiamare mostri, piuttosto che uomini. Mostri che hanno sete di sangue, e che ne bevono. Mostri che bramano e divorano la carne dei cani e non disdegnano la carne umana [...], che sono vestiti di pelli non conciate, e che si coprono col cuoio di bue». Lo stesso Matteo Paris, monaco di Saint Albans, in Inghilterra, attribuiva ai barbari delle teste abnormi, sproporzionate rispetto al corpo. Nella mostruosità dell’aspetto e degli atteggiamenti erano involte anche le donne tartare, che stando a Tommaso da Spalato (circa 1200-1268), testimone oculare delle scorrerie, «infierivano con particolare atrocità sulle giovani fanciulle: come ne vedevano una più bella delle altre subito, sguainata la sciabola, la uccidevano. Quelle ritenute adatte a far loro da serve le mutilavano al naso, le sfregiavano in volto e poi le mettevano a servire». Frate Giordano da Giano, vicario provinciale francescano per la Boemia e la Polonia, dovette accennare pure a stuoli di soldatesse battagliere e impavide, sottolineando come per la morale degli sterminatori selvaggi «Colei che combatte meglio è considerata la più desiderabile, proprio come nella nostra società colei che tesse e cuce meglio è più desiderata di una bella dama». Dal33
le accuse di malvagità non veniva esentata neanche l’infanzia: «Si facevano procedere i bambini prigionieri. Dopo averli fatti sedere uno vicino all’altro, i Tartari chiamavano i propri figlioletti, mettevano loro in mano delle stanghe di legno verde e poi li aizzavano a colpire sul capo i giovanissimi prigionieri». Si vuole allora che i piccoli martiri pregassero i coetanei mongoli di colpire forte, per morire con una sola mazzata, senza agonia. Esacerbato dal panico, fermentato negli interrogativi sull’esatta natura dei barbari, l’abominio aveva ingigantito la parvenza dei tormenti che sempre accompagnano le guerre: fermo restando che i Mongoli seminavano scientemente il terrore, e ne facevano un grimaldello psicologico, atto a demoralizzare e a deprimere l’opposta volontà di combattere. Non esisteva propaganda più efficace: talora si lasciava apposta libero qualcheduno, affinché andasse in giro a erodere le coscienze e a fiaccare le speranze col memoriale delle turpitudini osservate, o esperite in prima persona. Nel Carmen Miserabile o Epistola super destructione Regni Hungariae facta, la tragedia della nazione ungherese traspariva dalle dolenti confessioni di Maestro Ruggero delle Puglie, che era stato arcidiacono nel capitolo vescovile di Nagyvárad (attuale Oradea, in Romania) e che aveva trascorso alcuni terrificanti mesi di prigionia presso i crudeli occupatori. Le agiografie polacche non facevano che rincarare la dose, a riprova di quanto l’impatto dell’invasione mongola fosse stato esiziale per un’Europa accartocciata su se stessa, impegolata nelle sue sempiterne beghe politiche. Mentre le orde distruttive impazzavano, alla vigilia delle battaglie cruciali il papato bandiva crociate: ma non contro gli aggressori asiatici, si badi, bensì contro Federico II di Svevia! Il quale, in realtà, era stato uno dei pochi a rendersi conto dell’emer34
genza e a sostenere l’esigenza di una lega fra i potentati occidentali: aveva ordinato a Corrado suo figlio, in Germania, di raccogliere uomini e mezzi per la difesa, invitando le signorie cristiane a coalizzarsi sotto la guida imperiale con l’Encyclica contra Tartaros, emessa il 20 giugno 1241. Nel medesimo anno, Enrico III d’Inghilterra (1216-1272) riceveva dallo svevo l’epistola de adventu Tartarorum, da cui si comprende come l’imperatore germanico, che dimorava a Spoleto, fosse già perfettamente al corrente delle specificità psicosomatiche dei Mongoli, e degli espedienti bellici da essi impiegati per sopraffare le soldatesche nemiche. Sapeva, Federico, che «I Tartari sono bassi di statura, ma resistenti e fortissimi; sono valorosi, audaci; obbediscono ciecamente al loro comandante e si gettano coraggiosamente in mezzo a ogni sorta di pericoli. Inoltre, e lo diciamo fra i sospiri, se una volta usavano soltanto armature in cuoio, ora indossano quelle tolte ai guerrieri cristiani. Noi potremmo essere uccisi dalle nostre stesse armi». Eppure, dinanzi alla seria, palpabile possibilità d’un tracollo, le massime istituzioni europee non sapevano far di meglio che affannarsi nello scaricabarile delle responsabilità: Federico II incolpava il papa di aver infranto l’unità dell’Occidente col suo comportamento anti-imperiale, e il partito papale accusava l’Hohenstaufen di essersi accordato con gli invasori, favorendone la penetrazione. Agli Ungheresi si imputava invece d’essersi arresi con troppa facilità all’incursione nemica, mostrandosi vili proprio nel momento in cui, a tremare, avrebbero dovuto essere gli avversari. E re Béla IV, a suo turno, replicherà alle critiche attribuendo le disgrazie sue e dei suoi sudditi al pontefice, che non era stato tempestivo nell’accogliere le reiterate richieste d’aiuto. Nel marasma, tutti contro tutti: ma se la situazione 35
era giunta sull’orlo del collasso, la colpa era della lentezza, dell’imprevidenza e della cecità che obnubilava i sovrani europei. L’obiettivo di un fronte comune non si sarebbe mai realizzato nel protrarsi di spaccature, polemiche, divisioni. E ad aggravare il disagio era subentrata anche la scomparsa di Gregorio IX: il subentrante Celestino IV, ottuagenario, sedette sul soglio di san Pietro solamente per una manciata di giorni. Si apriva così una crisi che lascerà vacante la sede pontificia per circa un biennio (sino al 1243), e che sottrarrà all’immanenza degli eventi una voce fondamentale per la compattazione della cristianità. La dannazione sembrava ormai prossima per nobili e contadini, preti e cittadini, e monaci, guerrieri, cavalieri: una dirompente barbarie stava per cancellare la civiltà occidentale. La bestialità si accingeva a trionfare sul (presunto) ordine religioso e sociale. Inerti, i regnanti. Paralizzati, i popoli. Rassegnati, gli ecclesiastici.
4 | Una tregua indecifrabile Si tramanda che re Béla IV, ridotto in una desolante prostrazione, avrebbe fatto voto di offrire sua figlia al convento di Santa Caterina di Veszprém, se gli orribili oppressori si fossero ritirati dall’Ungheria. Eventualità assurda, in apparenza. Finanche all’imperatore Federico II era stato intimato di sottomettersi: i Tartari non facevano sconti. Dalla piana ungarica era perciò attesa l’incursione risolutiva, quella che avrebbe proiettato la signoria dei nomadi sull’Atlantico: significava portare le stirpi centro-asiatiche più avanti che mai, perfezionare un’azione che con Attila, alla metà del V secolo, era parzialmente abortita. 36
Già si ammassavano attorno alle vallate del Danubio le milizie e le salmerie. Già si smontavano i bivacchi, si raccoglievano le suppellettili, si preparava il trasferimento di famiglie, armenti, alloggi. Si smosse, dunque, la calca. Non a occidente, però: le ruote dei voluminosi carri mongoli presero la via della Bulgaria (che sarà presto assoggettata a un sostanzioso tributo annuo), per risalire successivamente a nord-est e traversare la Valacchia, la Moldavia e l’attuale Ucraina. Lo strascico dell’evacuazione fu un’ennesima mattanza: nel ritrarsi, i Mongoli congedarono colonne folte di ostaggi e permisero loro di allontanarsi. Pochi chilometri di sopravvivenza dovevano tuttavia toccare a quei poveri disgraziati, trattati come animali da cacciare, rincorsi e abbattuti come agnelli indifesi. D’altronde, non li si poteva rimorchiare tutti quanti. Rallentavano la marcia ed erano un fastidio, merce inservibile, zavorra da rimuovere: ne furono pertanto eliminati in quantità (a fronte di un lotto di prigionieri graziati per assolvere ai compiti schiavili). Sparivano, anche, le cittadine e i paeselli toccati in un ripiegamento che, a quel punto, conteneva in sé davvero un che di clamoroso. Di miracoloso: il riflusso brusco, inaspettato, nemmeno più sperato delle marmaglie tartare dovette apparire un dono della Provvidenza ai cristiani occidentali. Non ci si capacitava del prodigio. Non lo si riusciva a spiegare, a inquadrare in una logica coerente. Si stentava a discernere i motivi della ritirata, con la cristianità che era stata messa in ginocchio, con l’Europa che avrebbe potuto essere divorata in un sol boccone. Il miracolo, invece, s’era verificato. Le province dilaniate, le popolazioni disastrate riprendevano a respirare, almeno per un istante. Tanto sconcertante era stata l’irruzione tartarica quanto disorientante, adesso, pareva il ritiro. Ma non poteva essere diversamente: 37
in Mongolia era spirato l’11 dicembre del 1241 il gran khan Ögödei, consunto nella sua pur robusta costituzione fisica dal presumibile abuso di alcool. Di conseguenza occorreva adempiere al rituale del kuriltai, l’assemblea plenaria convocata fra i principi per eleggere il nuovo imperatore. Le prerogative nobiliari, e dunque il diritto elettivo, inerivano pure a Batu, personalità di lignaggio regale, che dirigeva le operazioni ungheresi. Un corriere dovette comunicargli che il trono era rimasto sguarnito, e che quindi l’autorità khanale risultava, momentaneamente, in sospeso. Saltavano, con quell’annuncio, tutti i piani di conquista, tutte le prospettive di trafiggere più a fondo il ventre molle dell’ecumene occidentale. Occorreva ripiegare, rientrare, per partecipare direttamente ai giochi di potere che già agitavano la corte imperiale: Ögödei aveva designato il nipote Shiremon quale successore. Ma Töregene, la khatun, l’imperatrice, non voleva saperne: approfittando del vuoto istituzionale, s’era incaricata della reggenza temporanea per attuare un radicale smantellamento del precedente apparato burocratico. Ministri esautorati, cancellieri licenziati, amministratori e funzionari esonerati (quando non proprio giustiziati): con audacia e sistematica fermezza, la coriacea sovrana mirava a estromettere i più alti dignitari, anche i presunti «inattaccabili» della nomenklatura imperiale, per concertare l’ascesa al vertice del figlio, Güyük. E Güyük era il principe che, durante le campagne europee, aveva aspramente polemizzato coi comandi dell’esercito, voltando le spalle e tornandosene in Asia centrale, a Karakorum, capitale dell’impero, molto prima che le armi tacessero. Batu, il principale bersaglio d’una polemica che sottintendeva contrasti più o meno latenti in chiave di candidatura dinastica, non dovette avere molte scelte: poteva conti38
nuare a guerreggiare, sì, ma prima o poi, se l’elezione del nuovo khan fosse andata male, se avesse arriso a una fazione avversa, il comando e la gloria gli sarebbero stati quasi certamente revocati. Per di più, con l’estate alle porte, le praterie ungheresi cominciavano a essere insufficienti per nutrire tutti i cavalli delle soldatesche mongole: l’importanza di possedere animali sempre freschi ed efficienti in battaglia imponeva infatti che ciascun cavaliere potesse contare su due, tre o più cavalcature (cosa che i coevi cronisti occidentali sottolineeranno puntualmente). Nel rituale guerresco, al seguito dei Mongoli si spostavano mandrie esorbitanti di destrieri, che andavano foraggiati e mantenuti in forma, affinché non perdessero la loro vigoria, imprescindibile nelle manovre belliche. Di prati e nutrizione abbisognavano parimenti le greggi di ovini e i bovini che, di norma, scortavano le truppe assicurando carne, latticini e forza motrice. Nel volgere di qualche settimana, il caldo estivo avrebbe sbiadito il verde dei pascoli. La disponibilità di erbaggio sarebbe calata, inesorabilmente, col rischio di avere corsieri malnutriti e, quindi, malmessi nella previsione degli scontri decisivi coi regni occidentali. Potevano insomma non bastare i circa centomila chilometri quadrati di superficie erbosa, dodici o tredici volte meno che in Mongolia, a sostenere lo sforzo bellico. E un’eventuale sconfitta, un ancorché parziale sbandamento, non avrebbero sicuramente giovato a Batu, al suo prestigio che a corte, nelle lontane steppe mongole, si cercava a qualsiasi costo di ridimensionare, di sminuire, per non soffrire la sua temibilissima concorrenza. La querelle, irrisolta, col cugino Güyük, aveva convogliato nell’intrico di veleni e ripicche le alleanze familiari e le clientele personali. I distinti partiti erano indaffaratissimi nel tramare e nell’an39
nettersi consensi. Ostilità e partigianerie si inasprivano, esasperavano la contesa in atto. Nell’incertezza, in attesa di chiarezza, per Batu era preferibile retrocedere leggermente e assestare in posizione strategica il suo ulus, il dominio di tende, armenti, gente rimasta fedele. Vitale era per lui il consolidare una posizione che gli consentisse l’equidistanza fra un Occidente sempre attaccabile e un Oriente in preda ai complotti, sull’orlo d’una guerra civile fra i pretendenti allo scettro. Le terre della Russia meridionale, ormai dome, acquisite, sottomesse largamente alla sovranità mongola, offrivano in quest’ottica una sistemazione perfetta, erano la postazione ideale per osservare e attendere l’evolversi della situazione. La tregua, l’indietreggiare dei Tartari avevano dunque ragioni lontane. Ma di tali e tante vicissitudini gli europei non sapevano alcunché, non potevano sapere. E titubavano, ancora turbati, preoccupati per quell’ordu, quell’accampamento tartaro che vibrava, ora, immenso e indecifrabile, sul basso Volga, nelle vicinanze di Astrahan’.
Capitolo terzo
ERRORI
1 | False partenze L’albergo più sicuro era a Lione. Nel regno di Arles (e sotto l’ala protettrice del devoto re di Francia Luigi IX, 12261270) il giurista genovese Sinibaldo Fieschi non avrebbe corso rischi. Da quando era stato fatto papa col nome di Innocenzo IV (1243-1254) il livore di Federico II lo aveva perseguitato, fra rappacificazioni mai conchiuse e un astio, di fatto, irresolubile. La canonica residenza romana, per la celebrazione del Tredicesimo Concilio ecumenico, poteva risultare sensibilmente esposta alle rappresaglie federiciane. Il monastero lionese di San Giusto prometteva invece inviolabilità, e una quiete propizia ad affrontare le problematiche più scottanti: l’ormai indifferibile deposizione dell’imperatore svevo, l’ennesima crociata che riscattasse Gerusalemme (e la débâcle dei Franchi nella battaglia di Gaza del 1244), l’unione delle Chiese orientali separate e, innanzitutto, il remedium contra Tartaros, la soluzione con cui placare l’ansia d’una eventuale ricomparsa della gens impia, portatrice di tanti lutti e patimenti. L’esortazione papale a erigere fortificazioni che arginassero l’impeto tartarico, e l’impegno della Santa Sede «a contribuire con munificenza a spese tanto necessarie e uti41
li», costituivano un palliativo, non un rimedio definitivo. Constatato il fallimento del confronto bellico, l’intento era di sperimentare un approccio politico-religioso coi Tartari. Ma su che basi? Beh, intanto si cominciava a ritenere (o più probabilmente si auspicava) che in Asia i nestoriani avessero agito da battistrada, invogliando alcuni dei principi mongoli a cristianizzarsi. Recentissime e interessantissime informative sui barbari erano poi giunte alla curia papale da un non meglio identificato arcivescovo russo (in cui qualche storiografo suggerirebbe di scorgere Pietro Akerovicˇ). Inoltre, s’era imparato che gli ambasciatori venivano rispettati e considerati praticamente intoccabili, da quei pur bestiali predatori. Dunque, si poteva procedere con delle legazioni. Delle ambascerie furono perciò predisposte dal papa, che per potenziarne l’efficacia si servì del personale viaggiante più dinamico e collaudato di cui disponesse: i francescani e i domenicani, infaticabili viatores, fenomenali propugnatori di cristianesimo e versati nelle più svariate parlate. Il compito era delicato. Solo dei veterani, degli autentici specialisti avrebbero potuto eseguirlo. E con un pizzico, anche, di sana emulazione: i discepoli del Poverello d’Assisi si specializzeranno nelle rotte settentrionali, quelle che collegavano le steppe russe alla Mongolia passando a nord del Mar Nero, del Caspio e del lago d’Aral; i seguaci di san Domenico di Guzmán praticheranno più frequentemente l’itinerario meridionale, che dalla costa siro-palestinese si allungava in Mesopotamia per intersecare, in sequenza, i dipartimenti di Samarcanda, Kashgar (Kashi) e Turfan (Turpan). Gli ordini mendicanti divenivano insomma il vettore precipuo della politica internazionale: dovevano saggiare le intenzioni dei Mongoli, capire se li si potesse deviare sui potentati islamici mediorientali e, magari, se fosse proponibile un’in42
tesa che giovasse al papato, sfibrato dalle perdite in Terrasanta e logorato dalle beghe con Federico II. Ai missionari il pontefice affidò pertanto un paio di lettere bollate: nella Dei patris immensa del 5 marzo 1245 si esponeva una sintesi della dottrina cattolica e si presentavano i monaci delegati a illustrarne il contenuto «al re e al popolo tartaro»; nella Cum non solum homines del 13 marzo 1245 si invitava il sovrano mongolo a chiarire i suoi piani futuri, a rinunciare a ulteriori invasioni e a trattare la pace. Una terza bolla, la Cum simus super del 25 marzo 1245, era poi rivolta ai cristiani d’Oriente, affinché riconoscessero la primazia del cattolicesimo di Roma. Ben presto Domenico d’Aragona, francescano, venne delegato in Siria, in Armenia e a Costantinopoli. Analogamente fu incaricato di partire il minorita Lorenzo del Portogallo: è dubbio, tuttavia, che egli si sia mai effettivamente mosso. Di sicuro partirono dei domenicani: Andrea di Longjumeau, un frate francese che parlava l’arabo e il «caldeo» (da intendersi come persiano o siriaco), era un vecchio frequentatore del Medioriente, dove aveva cercato la corona di spine del Cristo. Nel 1246-1247 attraversò – invero con un bel po’ d’apprensione, vista la più che comprensibile diffidenza dei musulmani – gli Stati islamizzati mediorientali e, a Tabriz, località di pertinenza tartara, poté recapitare i messaggi pontificali al prelato nestoriano Simeone Rabbanata e ad un ufficiale mongolo. Dopodiché, Andrea ripassò da Antiochia e rientrò in Francia, recando seco un mucchio di indicazioni su quanto aveva osservato e ascoltato circa i Tartari (benché gli fosse sfuggito l’abboccamento con le superiori autorità mongole). Ad exercitum Tartarorum, sugli altipiani iranici, dovette pervenire pure il domenicano Ascelino da Cremona nella 43
primavera del 1247. Lo accompagnavano i confratelli Alessandro e Alberto, cui si aggiungeranno frate Guiscardo Cremonese e Simone di Saint-Quentin, artefice di un diario del viaggio che – sebbene incompleto – potrà confluire nello Speculum Historiale di Vincenzo di Beauvais (la sezione storica dello Speculum Maius, l’enciclopedia più celebre del XIII secolo, compilata intorno al 1256). Ignaro delle costumanze mongole, sprezzante fino all’irragionevolezza nel suo marcato integralismo cristiano (e chissà, fors’anche anelante alla gloria del martirio), Ascelino si inoltrò a mani vuote presso popolazioni che, al contrario, andavano lusingate con omaggi e regalie. Per giunta, rifiutò sdegnosamente di genuflettersi a Baiju, il generale che controllava (o che comunque aveva tributarie) vaste zone della Georgia, dell’Armenia Maior, della Persia e del sultanato di Iconio. E non contento, il fervente monaco lombardo si mise ad esaltare il Santo Padre, definendolo «il più grande di tutti gli uomini» e intimando agli astanti, a muso duro, di accondiscendere al battesimo. L’imperizia, la mancanza di tatto, l’altezzosità stavano per costar caro ai delegati papali: fu infatti decretato che venissero scorticati vivi e che le loro salme, impagliate, fossero rispedite al mittente. Soltanto la benevolenza della moglie di Baiju, ligia al principio nomadico che tutelava le delegazioni diplomatiche (a maggior ragione quelle religiose), e ancor più il sopraggiungere provvidenziale di Eljigidei, commissario khanale, fecero sospendere l’esecuzione. Ma pur sollecitato a procedere oltre, di modo che incontrasse comandanti di rango più elevato, Ascelino giudicò concluso il proprio mandato: lasciò quindi che altri messi conducessero a Karakorum i dispacci di Innocenzo IV, tradotti in persiano, e intraprese il tragitto di ritorno. Lo scortavano un paio di agenti diplomatici inviati dai Mongoli: il turcofono (forse uiguro) 44
Aibeg, e il siriano Sergis. I due dovevano interloquire col pontefice, e comunicargli la risposta di Baiju. Che era una risposta nient’affatto confortante: ribaltando il tenore delle istanze papali, nella replica si rimarcava come fossero i Mongoli ad esser stati scelti da Dio per esercitare il potere sugli uomini, e quindi, in quanto legittimi dominatori dell’universo, erano loro che reclamavano la sottomissione dei cristiani, a cominciare dal papa stesso. «L’immutabile volere di Dio e l’ordine del Khan che impera sulla Terra intera», concludeva testualmente il messaggio, «sono le leggi del nostro agire. Chi le ascolta resterà sulla sua terra e sull’acqua e nel possesso dei suoi beni e dovrà porre la sua potenza nelle mani di colui che comanda su tutto il mondo. Ma chi non ascolterà questo comandamento e vorrà agire in contrasto con esso, verrà sterminato e disperso». Raggiunta Lione nell’estate del 1248, i legati tartarici vi si trattennero fino al successivo 22 novembre. Furono congedati con un’epistola conosciuta come Viam agnoscere veritatis, e con poche, scarne speranze di dirimere le dissonanze, visti anche i segnali, tutt’altro che incoraggianti, provenuti, per altre vie, dal gran khan in persona.
2 | L’epopea di un francescano Frate Giovanni da Pian del Carpine s’era messo in marcia il 16 aprile del 1245, domenica di Pasqua, prima ancora che il Concilio di Lione si fosse ufficialmente riunito (ciò che sarebbe avvenuto dal 26 giugno al 17 luglio). Era latore dell’appello papale al sovrano dei Tartari, e possedeva una comprovata vocazione cosmopolita: nato fra il 1180 e il 1190 presso l’odierna Magione, nel Perugino, era stato un 45
precoce sodale di san Francesco, che nel 1221 lo aveva inviato a predicare in Germania. In qualità di custode della Sassonia, dal 1223 aveva stimolato una vigorosa espansione del francescanesimo, e dal 1228 aveva irradiato la predicazione in Boemia, Polonia, Ungheria, Dacia e Norvegia, con le attribuzioni di ministro provinciale dell’ordine. Una successiva esperienza in Spagna, una presenza in Tunisia e, in generale, il contatto con ambienti culturalmente multiformi, avrebbero accresciuto la preparazione e le competenze del monaco, la cui forza comunicativa risiedeva in una sapienza matura e in un eloquio semplice ma intenso. L’abitudine a viaggiare, l’attitudine a rapportarsi col prossimo ne facevano insomma un esemplare perfetto di ambasciatore, specie fra genti aliene e in luoghi estranei ai più fra gli europei: «Familiaris homo et spiritualis et litteratus et magnus prolocutor et in multis espertus», scriveva di lui Salimbene de Adam. Più che naturale, dunque, che il papato gli affidasse la difficile missione diplomatica ad Tartaros. Non importava che Giovanni fosse piuttosto avanti con l’età, né che da un quindicennio trascinasse a dorso d’asino una corporatura più che voluminosa («quia vir corpulentus erat», riporta Giordano da Giano): al papa interessavano la sua perizia e il suo ecumenismo, la sua saldezza e la sua dedizione che, sole, avrebbero consentito di superare tormente di neve e di sabbia, fame e sete, picchi di gelo e caldo, insidie, incognite. Consapevole dei pericoli, ma generoso nell’offrirsi alla causa cristiana, il minorita umbro dovette incominciare il suo itinerarium assieme a Ceslao (o Stefano) Boemo, un francescano che però rimarrà bloccato a Kanev (sul Dnepr, non lontano da Kiev) per una malattia. La comitiva, peraltro, a Breslavia era stata rimpolpata da un confratello, Benedetto Polono, che fungerà da interprete per le lingue slave e 46
che redigerà una relazione dei gravosi cimenti affrontati. Passando di corte in corte fra Slesia e Galizia, i religiosi e i loro servi vennero provvisti dai vari dinasti centro-europei di consistenti regali, che a detta dei bene informati sarebbero risultati della massima utilità nell’approcciare i Tartari. Cracovia, Vladimir, Kiev odoravano ancora d’Europa. Ma dalla Comania sembrava veramente di addentrarsi in un’altra dimensione: le steppe solitarie e il silenzio sospeso precorrevano qualche avamposto mongolo, qualche appiglio umano che rinviava gli emissari papali sempre un po’ più a oriente, ai presìdi di comandanti più alti in grado. Ogni volta una spiegazione laboriosa, ogni volta la sorte da sfidare, fra elargizioni di donativi e il timore che le incomprensioni linguistiche evolvessero in fastidio, avversione, violenza. Prima fu incocciato Michea, un prefetto alano, personaggio notoriamente «ripieno d’ogni malvagità e malizia». Poi Corenza, comandante delle guardie tartare poste alla frontiera con l’Occidente, altrettanto malizioso e avido di largizioni. Nella catena di posti di blocco, di patteggiamenti, di mance, le scorte tartariche non concedevano requie, imponevano agli inviati pontificali di cavalcare a perdifiato per ore e ore, da mattina a sera, saltando spesso i pasti, riposando lo stretto indispensabile fra una tappa e l’altra. Sul Volga, il campo di Batu apparve ai primi di aprile del 1246. I monaci, sfiniti, vennero «purificati» dal passaggio fra due fuochi, un rituale che nelle credenze dei nomadi rimuoveva perversità e veleni. Soltanto allora poterono essere ricevuti nei maestosi appartamenti del governatore tartaro, che erano stati confezionati in tela di lino, usando le tende principesche sottratte a Béla IV, in Ungheria, cinque anni prima, bottino di guerra. Gli intendimenti del pontefice vennero esposti oralmente, e i suoi messaggi furono tradotti per 47
iscritto in persiano, mongolo e russo. Data la rilevanza dell’ambasciata, i legati del papa vennero obbligati a proseguire verso i quartieri khanali a nord del deserto del Gobi, quasi ai confini con la Manciuria. Tremebondi, i frati ripartirono, e non poterono trattenere il pianto, poiché non sapevano se li aspettava la vita o la morte. Avanzando nei territori desertici dei Kanghiti, fra gli Urali e l’Aral, avvistarono molti teschi e ossa umane, residui di chissà quali e quanti smarrimenti, fughe, persecuzioni. Traversarono la terra dei Bisermini (nell’odierno Uzbekistan), che sul basso Amudar’ja accoglieva l’oasi di Hiva. Scorsero città devastate, castelli in rovina, villaggi disabitati. Nell’attuale Kazakistan, dal lago Alakol’, la frequenza di attendamenti fortunatamente si intensificò, e i missionari poterono rifocillarsi, bere birra o vino, ospitati benignamente dai maggiorenti locali. In giugno, la carovana superò i dipartimenti naimani della Mongolia occidentale, montagnosi, sovente glaciali, e nell’ultima settimana di luglio si approssimò alla sira orda, l’«accampamento giallo», la dimora regale di Töregene, madre dell’imperatore in pectore, nei pressi del lago Koko Nor (il Qinghai Hu dei nostri giorni). In due mesi e mezzo i messaggeri francescani avevano coperto qualcosa come quattromila chilometri, su un totale di diecimila dalla partenza: era stata un’impresa avventurosa ed eccezionale, per degli europei. Pure, Giovanni da Pian del Carpine e Benedetto Polono si accorsero di non essere gli unici occidentali spintisi così lontano, nel centro dell’Asia, nel cuore dell’impero dei nomadi. Si ritrovarono infatti insieme a principi russi, georgiani e armeni, rappresentanti di nazioni tributarie dei Tartari. Notarono una folta presenza di deputazioni coreane, tibetane, cinesi, delegazioni di molti sultanati islamici, perfino un’ambasceria del califfo di Baghdad. Videro Jaroslav granduca di Suzdal’, Sem48
pad connestabile d’Armenia, il futuro sultano selgiuchide Kilic Arslan IV, i due aspiranti alla corona della Georgia, e pletore di ambasciatori e vassalli: tutti erano convenuti a sud di Karakorum per assistere all’assemblea elettorale che avrebbe elevato Güyük a gran khan. Partecipava al kuriltai l’intera nobiltà mongola a eccezione di Batu, teoricamente malato, di fatto in dissidio con la casa regnante: in quattro anni di reggenza e macchinazioni, la scaltra Töregene aveva potuto predisporre l’ascesa al trono del proprio figliuolo, con un comportamento che aveva inasprito le acrimonie fra i più seri pretendenti al titolo khanale. Trame oscure, epurazioni dispotiche e accordi sommessi avevano comunque prodotto un nuovo imperatore, e la sua investitura contemplava un grandioso cerimoniale. Le tornate elettorali, la solenne intronizzazione organizzata per il 15 agosto (ma posticipata al 24 per una violenta grandinata), le incombenze cagionate dall’avviamento del rinnovato apparato regio, ritardarono il contatto di Giovanni da Pian del Carpine col nuovo khan. Per ottenere un’udienza i frati dovettero attendere parecchie settimane, e altre ancora perché venisse loro richiesto di comunicare per filo e per segno i termini della trattativa. Fra chiarificazioni e trascrizioni plurilingue dei testi, solamente il 13 novembre i francescani poterono ripartire, muniti di una lettera di Güyük al papa. Evitarono di farsi seguire da diplomatici tartari, temendo che la visione di un Occidente frammentato invogliasse i Mongoli a un’invasione. Marciarono per tutto l’inverno, gli intrepidi minoriti, dormendo per lo più in luoghi isolati, spesso svegliandosi al mattino sommersi dalla neve che il vento sollevava. Ce la fecero, però. E quando nel giugno del 1247 entrarono a Kiev, i cittadini li accolsero festanti e stupefatti, come se fossero risuscitati dall’aldilà. Le stesse scene di giubilo e meraviglia si 49
ripeterono nelle altre località russe, polacche e boeme che il convoglio francescano attraversò sul cammino per Lione. A novembre, reduce da due anni e mezzo di peregrinazioni, Giovanni da Pian del Carpine consegnava a papa Innocenzo IV la missiva contenente le controproposte del gran khan Güyük: il documento, vergato in persiano e corredato di sigillo imperiale mongolo, è tuttora custodito nell’Archivio Vaticano.
3 | Illusioni svanite Non uno spiraglio, nel messaggio di Güyük: «Ma voi, uomini dell’Occidente», replicava il gran khan al pontefice, «credete di esistere solo voi cristiani, e disprezzate gli altri. Ma come potete conoscere a chi Dio concede il suo favore? Noi, adorando Dio, abbiamo con il vigore di Dio devastato ogni terra, dal Levante al Ponente. E se questa non fosse stata la forza di Dio, che cosa avrebbero potuto fare gli uomini? Ma se voi scegliete la pace e intendete consegnare a noi le vostre forze, tu, papa, insieme con i potenti fra i cristiani, non tardate in alcun modo a venire da me per fare pace: e allora sapremo che volete la pace con noi. Se però non crederete a questa missiva di Dio e nostra, e non ascolterete il consiglio di venire da noi, allora sapremo per certo che vorrete avere guerra con noi. Dopo di che, ciò che avverrà noi non sappiamo: solo Dio lo sa». La durezza dei contenuti non ammetteva dubbi. Persisteva un’incomunicabilità di fondo, tanto che in un altro passo della lettera l’imperatore mongolo dichiarava di non capire i motivi per cui la Chiesa gli chiedesse di battezzarsi. Ancor meno il sovrano comprendeva lo stupore manifestato per le stragi di cristiani polacchi, mora50
vi e ungheresi, visto che costoro non avevano ubbidito ai Mongoli e ne avevano, addirittura, ucciso gli ambasciatori. Zero conciliazione, insomma, zero patteggiamenti. La cesura, netta, di fronte a qualsivoglia compromesso paritario, era d’altronde figlia di una pretesa d’onnipotenza: i sovrani mongoli si reputavano investiti direttamente dalla divinità, della cui volontà si professavano esecutori in Terra. Güyük, naturalmente, non rinnegava una simile convinzione: per lui, il papa equivaleva a tutti gli altri dinasti, tenuti a prestare indefettibilmente ossequio alla suprema signoria mongola. Con ogni probabilità, il gran khan era persino bendisposto nei riguardi del cristianesimo, se Sempad d’Armenia poteva scrivere a Enrico I di Cipro che «i cristiani d’Oriente sono venuti [a Karakorum] a porsi sotto la maestà del khan, che li ha ricevuti con grande onore, ha loro accordato libertà e ha vietato che li si molestasse». E nella cancelleria khanale primeggiavano dei dignitari quali Kadak e Cinkai, di fede nestoriana. Ma da qui a trattare pariteticamente col pontefice, ad ammetterne la preminenza, ce ne correva. Sul piano dei negoziati, quindi, l’epopea di Giovanni da Pian del Carpine aveva sortito effetti pressoché nulli. Piuttosto, a valere saranno i risvolti esplorativi dell’impresa, l’eccezionalità di un’indagine degna d’una spia, effettuata nella «tana del lupo» e minutamente ordinata nella stesura della Historia Mongalorum: perscrutando la società nomadica e descrivendola in forma di meticoloso reportage, l’intrepido francescano aveva in effetti disvelato l’inedito, l’inaudito, il brumoso che da sempre era stato associato all’Oriente. I misteri, la forza, le astuzie barbariche venivano adesso messe a nudo, grazie a un trattato etno-geografico che dei Mongoli analizzava la giurisdizione, la popolazione, la religione, gli usi, i costumi, l’ordinamento amministrativo, il dominio sul51
le etnie soggiogate e, con dettagliata diligenza, le tecnologie e le tecniche di guerra. La scrupolosa attenzione alle metodiche belliche dipendeva dall’impellenza che l’Occidente si premunisse in vista d’una possibile aggressione dei cavalieri centro-asiatici: «Se i cristiani vogliono salvare se stessi, i loro territori e la cristianità tutta, è necessario», ammoniva Giovanni, «che si uniscano insieme re, principi, baroni e reggenti dei territori, e mandino di comune accordo un esercito a combattere contro di loro, prima che quelli comincino a spargersi per ogni dove». Conscio dell’impossibilità di intavolare un dialogo da pari a pari fra la Santa Sede e il gran khanato, il francescano annetteva alla sola unità dell’Europa la speranza di ribattere a un attacco mongolo, sfruttando al meglio le conoscenze acquisite con la recente esplorazione. In definitiva, dal sostanziale insuccesso della trattativa s’era recuperato un patrimonio di cognizioni che, perlomeno, serviva a esorcizzare le paure occidentali. Fattore non secondario per Innocenzo IV: soddisfatto (malgrado tutto) dei risultati ottenuti dall’ambasciata francescana, il papa volle nominare Giovanni da Pian del Carpine arcivescovo di Antivari, in Montenegro. Lo mandò, inoltre, in veste di legato, presso Luigi IX, per informare il sovrano sulla difficoltà dei contatti coi Tartari e, forse, per convincere il monarca francese a restare vicino al papato, finché non fossero divenute chiare le intenzioni di Federico II. In quei mesi, il re di Francia era alle prese coi preparativi di uno sbarco crociato nel delta del Nilo. Salpato da Aigues-Mortes il 25 agosto del 1248, il 17 settembre aveva attraccato a Cipro. In dicembre, ancora indeciso sul da farsi, dovette ricevere una visita inattesa: all’isola erano approdati i nestoriani David e Marcus, mandatari mongoli. Perfidi impostori o messaggeri fededegni? Il dibattito storiografico sulla 52
genuinità della legazione è ancora aperto. Le tormentate spedizioni francescane e domenicane avevano fornito fin lì tutt’altro segno. Ed è per questo che diversi studiosi ravvisano nell’episodio cipriota un sotterfugio furbesco, un intendimento spionistico dei Mongoli, smaniosi di intuire gli obiettivi militari della cristianità europea. Qualunque fosse lo scopo, l’ambasciata tartara fu accolta a Nicosia da Luigi IX e dal legato pontificale, Odone di Châteauroux. A loro venne recapitata una missiva (scritta in mongolo) di Eljigidei, rappresentante del gran khan nei dipartimenti iranici. Il messaggio, stranamente, conteneva un vocabolario dagli accenti misurati, garbati, e insieme una proprietà di linguaggio da quintessenza della diplomazia: Güyük vi era sempre acclamato come rex terrae, ma al re di Francia ci si rivolgeva con l’appellativo, insolito per i Tartari, di rex magnificus. Soprattutto, non se ne esigeva la subordinazione e, per di più, gli si prospettava un sodalizio antislamico, asseverando altresì un’irrinunciabile parità fra i cristiani: «Il re del mondo», diceva l’epistola, «ordina che, secondo la volontà di Dio, non debbano esserci differenze fra latini, greci, armeni, nestoriani, giacobiti e tutti coloro che adorano la Croce: essi non sono in effetti che un’unica cosa, ai nostri occhi. Così si chiede al magnifico re che, allo stesso modo, egli non faccia differenze fra loro». È arduo acclarare quanto una tale lezione di tolleranza fosse sincera, oppure se derivasse dalle insinuazioni maliziose di agenti diplomatici che aderivano al nestorianesimo e che, quindi, avversavano i cattolici, considerandoli detrattori (o, peggio, persecutori) degli altri cristianesimi. Quel che è sicuro è che la disponibilità a un accordo, propugnata dall’ambasceria tartarica, bastò a riaccendere l’illusione che Güyük si fosse cristianizzato, ed Eljigidei con lui. A prima vista, pareva che alcuni fra i proponimenti di Mongoli ed europei collimassero, e che 53
sussistessero i presupposti per una lega euro-tartara, da contrapporre all’asse musulmano Il Cairo-Baghdad. Un moto d’entusiasmo dovette pervadere Luigi IX: rasserenato dalle lusinghiere enunciazioni di David e Marcus, il re decise di cementare la nascente amicizia assegnando ad Andrea di Longjumeau (ancora lui, il fido domenicano) la guida d’una delegazione che doveva portare agli alleati d’Asia una sontuosa tenda-cappella (e, si dice, particelle della Vera Croce). L’ambasceria fu allestita agli inizi del 1249. Passò per Mosul, toccò il campo di Eljigidei, e continuò per la Mongolia. A est del lago Balha^, la missione pervenne alla residenza di Oghul Ghaimish, che dell’imperatore mongolo era fresca vedova: Güyük, che aveva regnato per un biennio appena, era morto consumato dell’alcool. A reggere l’impero gli era subentrata la consorte, già indaffarata nell’ammannire la futura elezione di un gran khan che le aggradasse, da scegliere tra il figlio Kuchap e Shiremon. Scarsa predisposizione all’accoglienza dovette quindi mostrare la regina (influenzata, nelle sue scelte, dalla casta sciamanica), e poca voglia di ascoltare i delegati: i doni di Luigi IX furono interpretati come il tipico omaggio di chi faceva formale atto di sottomissione. Con maniere spicce, Oghul Ghaimish licenziò quindi la legazione e ordinò di trasmettere al re di Francia un avviso categorico: «La pace è buona cosa [...] ma tu non puoi averla se non da noi [...]. Devi perciò inviarci ogni anno parecchio del tuo oro e del tuo argento [...]. Se non lo farai, distruggeremo te e la tua gente, come abbiamo fatto con gli altri». Nell’aprile del 1251 Andrea di Longjumeau rientrava in Palestina, e incontrava a Cesarea un Luigi IX depresso dalla rotta crociata di Mansura, umiliato dalla susseguente prigionia personalmente patita in Egitto. Le comunicazioni del frate, l’assenza 54
nel dispaccio mongolo di un minimo accenno a conversioni o cooperazioni, avvilirono ulteriormente il monarca. Stando a Jean de Joinville, suo biografo e collega di ventura, re Luigi dovette pentirsi d’essersi prodigato tanto, per poi ritrovarsi a serrare un pugno di mosche. Per l’avvenire, non se ne sarebbe fatto più nulla: non conveniva approntare nuove legazie, che avrebbero potuto essere intese dai Tartari come un sintomo di debolezza. Stop alle ambascerie, fu perciò deliberato. O quanto meno, stop alle ambascerie «ufficiali».
4 | Dalle Fiandre alla Mongolia I «rumori», nei corridoi ecclesiastici, davano per convertito al cristianesimo il mongolo Sartaq, acquartierato col suo ordu poco al di qua del Volga inferiore. Per i francescani, che mantenevano un immutato entusiasmo apostolico e che non rinunciavano a misurarsi con la predicazione fra idolatri e neofiti, l’occasione si presentava allettante. Guglielmo di Rubruck era un frate minore delle Fiandre, vissuto a Parigi, corpulento, pieno di ardore evangelico. Re Luigi di Francia non poteva esimersi dall’assecondarne la vocazione: ne patrocinò pertanto la missione nei paesi asiatici, con denari e una lettera di accreditamento. L’attestato regio mirava a semplificare la trasferta, senza che vi si dovesse ascrivere alcuna finalità diplomatica. Lungi dai crismi di un’ufficialità politico-istituzionale, non un’ambasciata andava a compiersi, bensì una pura e semplice intrapresa religiosa, un apostolato fra uomini bisognevoli di conforto spirituale, pagani o battezzati che fossero. D’altronde, lo stesso Andrea di Longjumeau aveva riferito della presenza in Asia di cristiani alemanni, che sovente erano prigio55
nieri di guerra (e, talvolta, ospiti volontari). Le prospettive d’una proficua catechesi, il bagaglio acquisito con l’assimilazione degli antichi trattati di Solino e Isidoro di Siviglia, e insieme le recenti vicissitudini di un Giuliano d’Ungheria o di un Giovanni da Pian del Carpine, convinsero Guglielmo ad andare. Nel maggio del 1253, il monaco si imbarcò a Costantinopoli. Viaggiavano con lui il confratello Bartolomeo da Cremona, lo scrivano Gosset, un interprete (che si dimostrerà inaffidabile) e lo schiavo Nicola, comprato all’uopo in una delle fornitissime rivendite costantinopolitane (dato che possedere schiavi era più che normale per chiunque, anche per un pio discepolo di san Francesco). La così acconciata comitiva navigò sul Mar Nero fino a Soldaia, per immettersi dall’emporio di Crimea sulle piste che conducevano ai Tartari. Su consiglio dei mercanti locali, i viandanti fecero scorta di frutta, vino moscato e pane biscottato: tutte derrate che, issate col resto delle provviste su sei carri, dovevano servire a rabbonire i caporioni mongoli incrociati di stazione in stazione lungo il tragitto. Procedendo a cavallo fra picchi montani, foreste fittissime e pianure musicate dal mormorio dei ruscelli, in tre giorni il convoglio addivenne alle prime postazioni tartare. «E quando entrai in mezzo a loro», scriverà Guglielmo di Rubruck nel suo Viaggio nell’impero dei Mongoli, «ebbi proprio l’impressione di entrare in un altro mondo». La reazione esterrefatta, l’espressione sbalordita del francescano confermavano come anni e anni di tentati incontri non avessero saldato la frattura esistente fra universi ancora estranei l’uno all’altro. A dispetto d’un ravvicinamento materiale fra sfere d’influenza politica, le distanze mentali rimanevano abissali: l’estendersi dell’impero centro-asiatico aveva, sì, assottigliato le frontiere fisiche, ma non quelle psicologiche fra società fondamentalmente e vicendevolmente avulse. Nel56
l’aprirsi e nell’accettarsi il disagio reciproco restava intatto, la linea di demarcazione profonda. Varcare la soglia della differenza poteva risolversi in un’esperienza scioccante, anche per dei minoriti coraggiosi, capitati in una dispersa plaga russa e decisi a non arretrare: e la frenesia del farsi intorno di cavalieri nervosi, invadenti, smaniosi di vivande, non fu certo un’accoglienza tranquillizzante. Il turbamento non si estinse del tutto, pur stemperandosi con l’incedere verso il presidio di Scatatai, comandante della provincia circostante al corso del Don. Stare coi capi, essere da loro ospitati e ascoltati risultava più agevole, talvolta gradevole. Peggio era traslocare da un bivacco all’altro, in balìa di accompagnatori tartari che, appena potevano, perfidamente rubavano oggetti o vettovaglie. Logico che, in simili condizioni, un dialogo sereno restasse precluso. L’handicap relazionale era vieppiù aggravato dall’imperizia del traduttore ingaggiato per la missione, il quale di frequente non afferrava né riusciva a esprimere i concetti più elementari. Dal gap linguistico scaturì un qui pro quo dagli esiti grotteschi, allorché la carovana francescana pervenne al campo di Sartaq, il 31 luglio: l’accredito di Luigi IX, redatto in francese (e probabilmente corredato da versioni in arabo e siriaco), fu infatti trasposto in turco dalla cancelleria mongola. Ma diede adito a un fraintendimento: le generiche espressioni di saluto del re francese vennero scambiate per una profferta d’alleanza contro i musulmani mediorientali. La faccenda s’era ingarbugliata, e quindi andava necessariamente sottoposta al vaglio supremo di Batu, a cui Guglielmo di Rubruck e i suoi furono obbligatoriamente indirizzati. Il 5 agosto, una distesa sterminata di tende segnalò l’arrivo all’accampamento dell’uomo che aveva imperversato in Europa, e che dominava sul nascente khanato dell’Or57
da d’Oro, dilatatosi fra la Russia, l’attuale Ucraina e il Caucaso. Il vecchio capitano concesse udienza ai frati, continuando però a ritenerli latori di proposte squisitamente diplomatiche, e dichiarando dunque la propria incompetenza sull’argomento. L’affare meritava d’essere discusso in sedi più appropriate: per questo, al termine d’un soggiorno durato cinque settimane, frate Guglielmo e frate Bartolomeo, col loro malcerto interprete, ricevettero l’ordine di proseguire per la Mongolia, alla volta della corte imperiale. L’ufficiale che faceva da guida equipaggiò i poveri missionari con brache di montone e pellicce adeguate alla stagione, rigidissima. Bisognava percorrere terre gelate per quasi cinquemila chilometri. Ma ad onta di crepacci paurosi e passaggi perigliosi, al prezzo di cavalcate furiose e prolungati digiuni, il 27 dicembre, in meno di tre mesi e mezzo, agli occhi dei minoriti si profilarono le insegne khanali. Da quasi un triennio, al vertice del potere s’era issato Möngke (1251-1259), fiancheggiato nella sua scalata dal cugino Batu, col quale aveva poi sostanzialmente spartito lo smisurato regno mongolo. Il gran khan volle subito appurare gli intendimenti di quei forestieri sopravvenuti dall’Ovest, facendoli interrogare insistentemente per capire chi fossero e cosa chiedessero. Oltretutto, non si trovava più la lettera d’accompagnamento con cui Batu annunciava il sopraggiungere della missione: nel passare fra troppe mani la comunicazione era andata persa, e nessuno ne rammentava il contenuto. In mancanza di sigilli e testi ufficiali, solo le oneste spiegazioni di Guglielmo di Rubruck poterono illustrare il carattere puramente religioso di un mandato protrattosi, evidentemente, più di quanto lo sballottato missionario avesse preventivato. D’altra parte, la permanenza dei francescani in Asia centra58
le era destinata a prolungarsi almeno fino a che il freddo micidiale delle steppe non si fosse addolcito. E nel periodo di sosta, al monaco fiammingo si dischiuse un microcosmo sfaccettato, molteplice, variegato: dimorando fra gli ospiti imperiali riconobbe infatti un buon numero di nestoriani, sacerdoti e no; vide ambasciatori dell’imperatore bizantino di Nicea; e venne visitato da madame Pasqua, una donna nativa di Metz, che era stata catturata in Ungheria e che, rifacendosi una vita, aveva avuto tre bei bambini da un giovane russo («il quale sapeva costruire case, e questo era un buon mestiere presso i Mongoli», ebbe a chiosare Guglielmo). Nel recarsi a Karakorum, il francescano poté distinguervi due quartieri: «uno dei musulmani, dove si tiene il mercato e dove molti mercanti si riuniscono perché la corte si trova sempre lì vicino e perché c’è un gran numero di ambasciatori; e un altro della gente proveniente dalla Cina, tutti artigiani». Il melting pot imperante si trasfondeva anche in «dodici templi di idolatri di diverse nazioni, due moschee [...] e una chiesa cristiana situata all’estremità della città». In una capitale così esplicitamente multirazziale e multireligiosa, il frate incontrò anche Basilio, figlio di un inglese, e Guillaume Boucher, orefice parigino con moglie ungherese, che per il gran khan aveva realizzato un’ingegnosa fontana in argento a forma d’albero, con statue di leoni che alla base sprizzavano latte di giumenta dalle fauci, e con serpenti in oro che, avvinti al tronco, emettevano vino, birra e bevande alcoliche, tramite condotte azionate da servi nascosti nelle cantine sottostanti al macchinario. A ornamento dell’agglomerato urbano si ergeva poi il «Palazzo delle mille [o diecimila] paci», sede della regalità estesa su un consorzio che annoverava non soltanto gruppi di deportati, ma pure nuclei di immigrati, attratti spontaneamente dalle pro59
spettive commerciali che l’unificazione euro-asiatica sotto un unico governo aveva spalancato. In quale misura Guglielmo di Rubruck avvertisse la portata di tali fenomeni è difficile da stabilire: l’attenzione del monaco era assorbita prevalentemente dalle questioni dottrinarie che, a un certo momento, dovettero culminare in una di quelle dispute teologiche tanto care a Möngke (e ai principi mongoli in genere). A confrontarsi pubblicamente col minorita europeo furono convocati esperti di nestorianesimo, maestri dell’islam e «tuini» (taoisti, o più verosimilmente buddhisti venati di manicheismo), in un match che, seppur vibrante, serrato, si chiuse con un nulla di fatto. Ugualmente negativo fu il bilancio dell’evangelizzazione: «In quel luogo battezzammo in tutto sei anime», constatò Guglielmo, mentre nell’estate del 1254 tornava a casa. Era ripartito orfano di Bartolomeo da Cremona che, malfermo in salute, non se l’era sentita di intraprendere a ritroso un itinerario stremante. I sentieri desolati a nord del lago Balha^ permisero in settembre di adire i quartieri di Batu, laddove lo schiavo Nicola e lo scriba Gosset erano stati tenuti in ostaggio, sin dall’andata. Riabbracciati i due compagni e recuperate un po’ d’energie, Guglielmo di Rubruck volse a meridione, verso la depressione caspica. Transitò per Derbent (le Porte di Ferro di Alessandro Magno) e, oltrepassati l’Azerbaigian e l’Armenia, addivenne alla costa cilicia. Nell’estate del 1255, dopo tappe a Nicosia, Antiochia e Tripoli, il frate rientrava nel suo convento, a San Giovanni d’Acri. Non ebbe il permesso dal ministro provinciale dell’ordine di recarsi da Luigi IX, in Francia. E allora spedì al sovrano il resoconto schietto, diretto, realistico delle peregrinazioni compiute. Il Levante ne usciva radiografato e «demitizzato»: la relazione ridimensionava la figura del fantomatico Prete Gianni, e 60
ricusava le fantasie di supposte razze mostruose, precisando fra l’altro che il Caspio era un mare clausum e non un golfo dell’Oceano, come avevano sostenuto le auctoritates antiche (Isidoro su tutti). Tuttavia, alla straordinaria narrazione delle usanze e delle credenze mongole, che rendevano manifesti vizi e virtù di un popolo sempre meno estraneo, faceva da contraltare l’ennesima epistola di un gran khan ai regnanti cristiani, trasmessa mediante Guglielmo di Rubruck: pur ripulito dalle minacce, il messaggio conteneva ancora il solito invito alla sudditanza, «nel nome del Dio eterno», e nella prospettiva che «dal sorgere del sole fino al tramonto tutto il mondo sarà unito nella gioia e nella pace»: unito, naturalmente, sotto la potestà dei Mongoli, i prescelti dal Cielo. Möngke non rinunciava, insomma, all’idea di un imperium universale, tanto da disconoscere persino le proposte d’alleanza che, anni prima, Eljigidei aveva fatto a Luigi IX per mezzo di David e Marcus. Morale della favola: accostarsi ai popoli orientali con la diplomazia o con la religione era vano. E la presunzione di superiorità con cui l’Occidente e la cristianità s’erano accostati aveva lasciato indifferente – quando non indispettito – la controparte. Incuranti delle iniziative politiche e religiose dell’Europa, i Mongoli dell’Orda d’Oro dilagheranno nuovamente nei territori magiari fra il 1254 e il 1255, e nuovamente la Polonia sarà invasa fra il 1259 e il 1260, con effetti più devastanti che in passato: Sandomir espugnata, la sua popolazione falcidiata. Per risultare efficace, l’approccio all’Oriente doveva essere diverso: pacifico sicuramente, e possibilmente scevro dal preconcetto di potervi esportare una civiltà migliore. Qualunque dialogo che prescindesse da una mutua convenienza era fatalmente destinato a fallire. 61
Lione
Breslavia
Buda
Pest
Smolensk Mosca
Kiev
Curzola Dan u
Bolgary
bio
lg Vo
Tana
Co sta nti no po li Nicea Iconio
RN
ERO
GEORGIA
MAR
Negroponte
MA
Ura
Saraj Astrahan’
Caffa
Soldaia
l
Ukek
a
Trebisonda Tiflis Sivas ARM
L. Balhasˇ
L. d’Aral
MIA
Vienna
Don
Dne pr
Cracovia Venezia
CORAS
CA S P IO
’ja Amudar
Otrar ENIA Derbent Edessa Sy rda Hiva Lajazzo r’ja Aleppo Mosul Nicosia Tabriz Tripoli Buhara Samarcanda Sultaniyeh Giaffa Acri Damasco Merv Alessandria Balkh Alamut Nishapur Baghdad Gerusalemme Sheberghan Il Cairo Taloqan Esfahan Kabul Herat Bassora Peshawar Kubanan Yazd Kerman Lahore Kandahar Shiraz Multan ER Hormuz MAKRAN Medina ARMENIA MINOR
GO
L FO
P
MAR
T ARA GUJ
ROSS
SIC O
Mecca
O
Bombay
ETIOPIA
R ABA MAL
MARE ARABICO
As-Shihr Aden
Mangalore
GOLFO DI ADEN SOCOTRA
Itinerario di Giovanni da Pian del Carpine (1245-1247) Itinerario di Guglielmo di Rubruck (1253-1255)
Tun gu
ska Inferiore
sej Eni
B u r ia M
Ob ’
Irty
L. Bajkal
ti
o Keraiti M e rc h it i n g o l i Kirghisi
sˇ
N a im a
Karakorum
ni
Ong Kara-Khoto
Hami Almalik
Turfan
Yumen Zhangye
Dadu/Khanbalik (Pechino)
Ningsian
Wuvei
Lanzhou
Qiemo
Yarkand
Kaiping/Shangdu
IMPERO DEL GRAN KHAN
Dunhuang
Kashgar
uti
) allo G e Gi ran JIANGSU Yangzhou ium Can e (F ale H Suzhou ng a u H Nanchino
Shanghai
Xi’an
Hangzhou
Hotan Yutian
T T I B E
Chengdu gtz
n Ya
Lhasa
Golfo del Tonchino
AN
L
GOLFO DEL BENGALA
REGNO KHMER
H
DE AN
RO M
CO
TAPROBANE
N AM
ong
Capo Comorin
MARE CINESE MERIDIONALE
AM PA
Calcutta
Mek
Quilon
Quanzhou
Tang Long
Bagan
addy
Madras
Fuzhou
FUJAN
Kunming
IA
w Irra
REGNI INDÙ
)
YUNNAN
Dali
BIRMAN
Gange
S U LTA NAT O DI DELHI
F
rro
zu
Az
Canton Bhamo
Delhi
e(
e ium
C
ANDAMANE NICOBARE
Medan
SUMATRA
Parte seconda MERCI E COMMERCI
Capitolo quarto
VENEZIA E IL LEVANTE
1 | Una sposa per ogni porto Se non lercio, il commercio era almeno detestabile. Disdicevole. Indegno. Contrattare, permutare, affannarsi nell’acquisto e nella vendita, interagire con gente d’ogni risma: un raffinato nobiluomo non vi si sarebbe mai cimentato. Anche in un regno moderno come la Francia, solamente nella seconda metà del XV secolo sarà permesso agli aristocratici di commerciare per mare senza perdere il proprio titolo. Trafficare, comprare della merce per rivenderla a un prezzo più alto generava un lucro che i benpensanti giudicavano sommamente ingiusto. Per i Padri della Chiesa, nelle compravendite poteva facilmente insinuarsi il peccato, e che il mestiere del mercante non fosse grato a Dio lo andavano ripetendo in molti fra i teologi medievali. Nella Vita di san Guido di Anderlecht (un’agiografia collocata attorno al 1180), il diavolo tentatore si manifesta al santo in abito di mercator e lo induce a dedicarsi ai traffici di cereali per via fluviale: ufficio abietto, ignobilis mercatura, recita inesorabile il testo. Da quando Cristo aveva scacciato i mercanti dal tempio, un millenario sospetto s’era appiccicato alle faccende mercantesche: e nell’etica cristiana la mercatura, con la sua ricerca insistita del tornaconto personale, rappresentava 66
spesso l’emblema delle più spregevoli incombenze terrene, transeunti, da contrapporre alla purezza delle più gloriose occupazioni celesti, eterne. In una società che gli schemi religiosi di XI e XII secolo pretendevano di impostare su coloro che pregavano (il clero), che combattevano (i cavalieri) e che aravano la terra (gli agricoltori), le attività commerciali rimanevano moralmente riprovevoli. Chi le esercitava, poteva essere assimilato a una specie di paria, anche se adempiva a un compito giovevole un po’ a tutti: «Sono utile», si leggeva già all’inizio dell’XI secolo nel Colloquium di Aelfric, scrittore e abate anglosassone, «al re, al nobile, al ricco e a tutto il popolo. Salgo sulla nave con le mie merci e navigo fino ai territori d’oltremare, vendo la mercanzia e acquisto le cose pregiate che non si trovano nel nostro paese. Le trasporto con grande rischio e faccio talvolta naufragio, perdendo ogni avere e salvando a stento la vita. [...] Rivendo più caro di quanto ho comprato [...] allo scopo di trarne un profitto e mantenere così moglie e figli». La tenue giustificazione non alleggeriva però l’avversione covata nei confronti d’una pratica che facilmente tendeva a sfociare nell’usura. I prestiti a interesse, più o meno elevato, erano prerogativa di mercanti facoltosi, e il Concilio Laterano III del 1179 delibererà che gli usurai non dovessero essere ammessi al sacramento dell’altare, «né ricevere, in caso di morte in questo peccato, sepoltura cristiana». La decretale Naviganti, stabilita da papa Gregorio IX nel 1234, non ammetteva dubbi: «Chi presta ad un navigante, o ad un mercante che va ad una fiera, una certa quantità di denaro e ne riceve di più con la motivazione che essa è in pericolo, è da considerarsi usuraio». Ecco che quindi, ancora nel Duecento, il domenicano Tommaso d’Aquino (12251274), nel codificare il «giusto prezzo» remunerativo per il 67
mercante, pure segnalava che «il commercio ha in sé qualcosa di vergognoso», essendo un esercizio capace di scatenare l’irrefrenabile sete di guadagno, l’amore viscerale per i soldi e l’abominevole bramosia per le rendite ricavabili dalle somme imprestate. L’assioma mercator-peccator, impastato con l’asserto dell’avaritia, venava le convinzioni comuni. E le liste delle professioni «disoneste» e «impure» annoveravano abitualmente la figura del mercante. Era lui che, nell’aneddotica degli Exempla (gli insegnamenti edificanti, inseriti nelle prediche), durante le liturgie sacre raccattava da terra la cera colata dalle candele accese, per poterla rivendere e specularci ingordamente: salvo che la punizione divina non gli si rovesciasse addosso mandando bruciato il bottino sacrilego. Dappertutto, i commercianti erano avvertiti come sovvertitori della morale: in una cronaca del 1070 si dipingono ubriachi sin dal primo mattino i mercatores di Tiel (alla foce del Reno), figuri adusi a truffarsi a vicenda con false promesse, e ad andarsene a caccia d’una moglie provvisoria in ogni porto, fra un negozio in Inghilterra e un combattimento coi pirati. I preconcetti restavano ovunque immutati, nonostante da più versanti – ecclesiastici compresi – si riconoscesse il ruolo ormai essenziale dei commerci, in una realtà sociale che delle mercanzie, dei generi di consumo più disparati mostrava un desiderio crescente. I sovrani o l’aristocrazia, del resto, come potevano rinunciare a crogiolarsi e a sfoggiare la propria eccellenza, se non con l’uso di merci sofisticate che, importate da paesi spesso remoti, soddisfacevano la voglia di prestigio? E come provvedersi di vesti e tessuti di lusso, di vasellami pregiati e pietre preziose, ma anche di articoli ordinari non prodotti sul posto, se non con l’operato dei negotiatores? Nel pieno Medioevo, l’evoluzione del68
l’economia euromediterranea rendeva insomma indispensabili i mercanti, mentre lo sviluppo dei centri abitati corrispondeva e andava di pari passo con una rivoluzione commerciale allacciata ai progressi tecnologico-culturali. Con l’affermazione delle istituzioni comunali, con l’inurbamento dei contadini e l’incremento demografico, nelle città duecentesche – e specialmente in quelle italiane – il ceto mercantile era destinato ad accumulare una potenza economica e politica inusitate, da cui non sarebbe più stato possibile prescindere. Giocoforza, la rinnovata prosperità degli organismi urbani e l’accrescersi dei consumi comportavano una clamorosa riabilitazione del mercante, insieme al rimescolamento dei valori tradizionali che a una componente feudo-signorile, tipicamente rurale, accomunerà la compagine mercantesca-artigiana, propriamente cittadina. La complessità e i fermenti del rinnovato paesaggio umano contraddicevano ormai il modello statico e arcaizzante di «oratori-guerrieri-aratori». Talché Jacopo da Varagine (Varazze, 1228-1298), autore della celebre Legenda aurea, vescovo di una Genova mercanteggiante per antonomasia («genovese, dunque mercante», era il proverbio), arriverà a sostenere che la ricchezza, anche quella ottenuta con la negotiatio, aveva poco di indegno: ricchi erano stati in effetti gli stessi patriarchi biblici, ricco lo stesso Gesù. Fare il mercante, insomma, nel XIII secolo inoltrato, poteva non essere più troppo disonorevole. A Venezia, a dire il vero, non è che si fossero mai fatti troppi scrupoli. Emersa come una novella Venere dai flutti, la futura «regina dell’Adriatico» (l’espressione è di Le Corbusier) diverrà bella, ma nacque povera di risorse. Non disponeva che di pochissima terra, sfuggente con le onde, fangosa, che i residenti si affannavano a reintegrare e conso69
lidare inventandosi ripari di giunchi, più flessibili e resistenti. L’aratura, la semina, la vendemmia vi erano impraticabili, come rilevavano anche le Honorantie civitatis Papie (l’elenco dei diritti e delle entrate di Pavia, capitale del Regno Italico, compilato agli esordi dell’XI secolo e tramandatoci con interpolazioni più tarde). Fra le paludi scarseggiavano i campi, i vigneti e i boschi, e agli albori della sua storia medievale il popolo lagunare, da Grado a Cavarzere, dovette fare di necessità virtù, attivando una rudimentale economia acquatica di pesca e di raccolta del sale, commercializzato a corto e medio raggio. La testimonianza del 537-538 di Cassiodoro, prefetto del pretorio alla corte ostrogota di Ravenna, è poetica e peculiare: «Quando il mare», scriveva il colto intellettuale rivolgendosi ai tribuni marittimi venetici, «è chiuso alla navigazione per l’imperversare dei venti, si apre davanti a voi un itinerario attraverso incantevoli canali. Le vostre navi [...] da lontano sembrano camminare sui prati, quando accade di non vedere il corso del canale. Avanzano tirate da corde, le quali di solito servono a tenerle ferme e, capovolte le condizioni, l’equipaggio aiuta le proprie navi con i piedi; senza sforzo trascinano le loro portatrici e, invece delle pavide vele, adoperano il più sicuro passo dei marinai [...]. Un’unica risorsa hanno gli abitanti, quella di mangiare pesce a sazietà. Ivi i poveri e i ricchi vivono allo stesso modo. Un solo cibo sostenta tutti, uno stesso tipo di abitazione rinserra ogni cosa, né conoscono l’invidia riguardante le case [...]. Tutto il loro sforzo è volto alla produzione del sale [...] cui ogni cibo deve il potere di essere graditissimo». Alla ristrettezza «fisica» di un insediamento tutto sabbie e pantani, alla costrizione di un agglomerato palustre compresso fra isolotti e canali contribuivano pure gli equilibrismi politici del retroterra, che nella concatenazione delle 70
dominazioni di Goti, Bizantini, Longobardi e Franchi precludevano ogni ipotesi di proiezione veneziana in terraferma. La sopravvivenza di una popolazione anfibia, la sua capacità di progredire dipendevano dunque esclusivamente dall’interrelazione con le maree, dal rapporto con le acque, dal drenare, dal rassodare le rive, dal «colonizzare la melma» (per dirla con Elisabeth Crouzet-Pavan). La scelta di perseguire un’espansione marittima era quasi obbligata, e con essa il ricorso ad assidue politiche mercantili. I nobili, i maiores, fin dall’Alto Medioevo ne furono assolutamente partecipi, ad onta delle convenzioni che, nell’Europa dei feudi, nell’Occidente dei castelli, giudicavano i commerci incompatibili col rango nobiliare. Senza remora alcuna, il testamento del doge Giustiniano Partecipazio parlava nell’829 di un’ingente somma di laboratorii solidi, ossia capitali di rischio, investiti nei traffici navali. E nel 1007, un provvedimento dogale istituiva una beneficenza tutta speciale: in favore del «popolo di Venezia» e «per la pubblica utilità» venivano infatti stanziati dei fondi non spendibili subito, ma vincolati a un investimento che moltiplicasse i guadagni da destinare a opere benefiche: e, senza rendita, niente elargizioni. Non diversamente ragionavano le alte sfere ecclesiastiche della Laguna: nell’803, il patriarca di Grado si preoccupava di ottenere da Carlomagno esenzioni fiscali per quattro sue navi dedite ai commerci, e nell’853 il vescovo di Olivolo (isola nel sestiere di Castello), Orso Partecipazio, predisponeva a favore del cenobio di Sant’Ilario un sacco di pepe, mercanzia notoriamente importata dal Levante. Precocemente, le genti lagunari avevano maturato attitudini, sensibilità e atteggiamenti improntati all’azione mercantesca verso orizzonti che, man mano, si faranno più lontani, più orientali. 71
2 | Traslazioni e transazioni Si vuole che i marinai veneziani Bono di Malamocco e Rustico di Torcello, spalleggiati da alcuni complici, riuscissero a prelevare le ossa di san Marco da Alessandria d’Egitto. Le imbarcarono, le nascosero in mezzo a carne di maiale, ed elusero così la sorveglianza delle guardie musulmane, schifate da quel carico che per la loro religione era massimamente immondo: «Kazir, kazir [maiale, maiale]!», gridarono i gabellieri accelerando il rilascio dei permessi di transito. E i santi resti, dopo una navigazione non semplicissima, poterono essere trasportati a Rialto. Era l’828-829, e nei luoghi della sua favoleggiata predicazione riapprodava l’Evangelista, il fondatore del patriarcato aquileiese, l’iniziatore d’una Chiesa che si pretendeva derivata da Grado, e quindi dalla Laguna. Il patronato giusto nel posto giusto. La translatio – sintomatica di per sé dei contatti della marineria lagunare coi lidi egiziani – ebbe effetti plurimi: il primo, più vistoso, fu la celere costruzione d’una basilica deputata a preservare le sacre reliquie; il secondo, più ecclesiale, fu di schivare col prestigio del culto marciano il paventato assoggettamento spirituale a Cividale-Aquileia, sede patriarcale legata al regnum italico e, quindi, foriera di future subordinazioni alla monarchia pavese; il terzo, più simbolico, fu l’emancipazione virtuale di Venezia dal suo vecchio patrono, san Teodoro: un santo greco, emblema d’una bizantinità che aveva segnato fortemente la parabola veneziana. La traslazione di san Marco esprimeva insomma una voglia di autodeterminazione e una piena consapevolezza identitaria. Incastonata fra l’Istria e la pianura padana, la provincia venetica era stata fin dall’età tardo-antica il lembo estremo dell’impero romano d’Oriente. Dal restringimento dei 72
possessi bizantini s’era enucleato l’habitat semi-liquido di un’esile fascia lagunare, in cui fra VI e VII secolo si concentravano anche le famiglie scappate dal Friuli, dal Padovano, dal Trevigiano, dai rivolgimenti bellici di una terraferma invasa dai Longobardi. La stessa amministrazione bizantina aveva rinculato, insediandosi dapprima a Cittanova-Eraclea (nel 639), e in seguito a Malamocco (nel 742), per governare un grappolo di comunità abbarbicate ciascuna al suo isolotto o al suo cordone litoraneo. Dalla compattazione dell’arcipelago attorno al nucleo preminente di Rialto (residenza governativa dall’811) doveva precisarsi un’entità urbana, la civitas Venetiarum, dipendente formalmente da Bisanzio, ma ambita altresì dal Regnum Italiae. Dapprincipio, l’appartenenza a Costantinopoli aveva arrecato i benefici di un’integrazione nel rigoglioso commonwealth bizantino, e aveva dissuaso gli Stati dell’entroterra dall’annettersi la Laguna: se si eccettua una parentesi governativa filo-franca nell’804-806, e qualche successivo colpo di coda di Pipino, le pretese carolinge erano state bloccate dalla flotta romano-orientale che, a scanso di equivoci, alla minima avvisaglia si affrettava a gettare le ancore nel bacino veneziano. L’assistenza delle navi bizantine dovette risultare determinante pure per combattere i Saraceni, che dopo aver assaltato Brindisi (nell’838) si erano insediati a Taranto (nell’840) e che, dall’847 all’871, si erano stabiliti a Bari, istituendovi un emirato ufficialmente ratificato (evento rarissimo) dal califfo di Baghdad. I navigli musulmani sbaraglieranno i vascelli lagunari tanto nel Mar Ionio quanto in prossimità dell’isola di Sansego, e si lanceranno sulla costa dalmata, su Ancona, su Adria. A più riprese ricompariranno a tormentare i litorali nordadriatici, predando Brazza, assediando Grado nell’875, e saccheggiando Comacchio, in una 73
frenesia corsara che verrà spenta solamente dalla risolutezza militare dei Bizantini: l’imperatore Basilio I il Macedone (867-886) libererà infatti Ragusa (Dubrovnik) dall’assedio saraceno nell’868, e i Baresi si consegneranno al primicerio Gregorio nell’876. Ai musulmani sarà strappata la base tarantina dallo stratego Leone Apostippo e dal protovestiario Procopio nell’880, e la squadra navale dell’ammiraglio Nasar estinguerà i focolai islamici lungo le coste calabresi. Tropea, Amantea e Santa Severina verranno riconquistate dal generale Niceforo Foca, e le acque adriatiche saranno infine bonificate dalle infiltrazioni saracene, proprio mentre i dogi sostenevano duri sforzi per tenere a bada i Croati, in un’alternanza di fragili tregue e fiammate di guerra. Con la sicurezza garantita da una metropoli provvidenziale nel supporto militare, ma anche fisicamente non troppo vicina (e quindi non troppo ingombrante), Venezia aveva potuto coltivare una propria autonoma identità mercantile, sfruttando appieno una collocazione geografica di cerniera fra il Mediterraneo e il continente europeo. Per le Venezie transitavano oreficerie, spezie e sete orientali, che venivano ridistribuite nel Regno Italico (principalmente alla corte di Pavia) da battelli che risalivano le grandi arterie fluviali, ridiscendendovi con granaglie. Dalla Laguna partivano inoltre per l’Oriente islamico e per Costantinopoli il salmarino, le armi (provenienti verosimilmente da Carinzia e Stiria), le pelli e il legname (dai paesi slavi), e gli schiavi. Anche schiavi cristiani: la qual cosa suscitava nelle stanze curiali un’irritazione che sarà fedelmente appuntata dal Liber pontificalis. Le proporzioni degli scambi registravano comunque un costante incremento, che vivificava uno snodo commerciale pulsante fra la sfera economica islamo-bizantina, a circolazione monetaria aurea, e il circuito continentale, basato 74
sul monometallismo argenteo. Il rinvenimento a Torcello di un denaro carolingio e di un dirham arabo, saldati per l’ossidazione, sembrerebbe quindi assumere (come sottolinea Gherardo Ortalli) un significato paradigmatico della fondamentale intermediazione veneziana fra l’VIII e il IX secolo. Dal misero insediamento paludoso era sbocciata una città protagonista di flussi mercanteschi considerevoli, che nel rafforzare le proprie posizioni tendeva vieppiù a ridefinire le relazioni con Bisanzio. La potenza veneziana era ormai adulta sul degradare del X secolo, quando il viaggiatore iracheno ibn Hawqal, nel 972-973, poteva chiamare l’Adriatico Giun al-Banadiqin, «Golfo di Venezia». In quei decenni, il dogato già negoziava faccia a faccia con l’impero bizantino: al 992 si data infatti una crisobolla (un editto imperiale munito di sigillo aureo) di Basilio II (976-1025), con cui si fissavano dazi vantaggiosi per i bastimenti di Venezia che frequentavano il Bosforo. In cambio, la flottiglia lagunare si impegnava ad appoggiare le iniziative belliche dei Bizantini in Italia. Non era più il rapporto deferente fra suddito e padrone. E le piagge altoadriatiche stavano ormai strette ai Veneziani, così come insopportabili apparivano i tributi da versare ai pirati della Narenta, profumatamente remunerati onde scongiurarne l’interferenza nei traffici navali: con l’anno 1000, il doge Pietro II Orseolo conquistava Zara, Spalato, Ragusa e le isole del Quarnaro, insignendosi della titolatura di dux Veneticorum atque Dalmaticorum. I centri dalmati, in verità, non riconosceranno a Venezia che un’egemonia labile, più volte ritornata in ballo. Ma intanto i vascelli dogali si erano accollati l’onere di pattugliare il «proprio» golfo, il «proprio» mare: furono imbarcazioni veneziane a sgombrare le masnade saracene che nel 1002-1003 avevano assediato Bari. 75
A distanza di ottant’anni, nella primavera del 1081, la marina da guerra di san Marco si misurava in Albania con un avversario ancor più agguerrito: i Normanni di Roberto il Guiscardo, freschi conquistatori del Mezzogiorno italico, che intendevano attaccare i possessi bizantini nei Balcani iniziando da Durazzo, da dove partiva l’antica Via Egnatia, che passava per Tessalonica e terminava a Costantinopoli. L’intervento dei Veneziani, concordato col basileus Alessio I Comneno (1081-1118), efficace e pur vittorioso, non fermerà l’esercito normanno, impadronitosi della piazzaforte durazzesca l’8 febbraio 1082. Tuttavia, l’imperatore bizantino ripagherà l’aiuto prestato da Venezia con l’emissione di un’altra bolla d’oro: ed è Anna Comnena, primogenita e biografa del sovrano, a sintetizzare i termini della concessione, fatta agli alleati veneti in cambio dell’impegno a cooperare anche per l’avvenire: «La maggior agevolazione», spiega la principessa nell’Alessiade, «fu l’aver reso il loro commercio esente da imposte in tutte le regioni soggette all’impero dei Romani, così che essi poterono liberamente esercitarlo a loro piacimento senza dare neppure un soldo per la dogana o per qualsiasi altra tassa imposta dal Tesoro, in modo da essere al di fuori da ogni autorità romana». I privilegi, esercitabili in più d’una trentina di località, in pratica assicuravano a Venezia un predominio incontrastato sui mercati occidentali dell’Asia Minore, sulle piazze della Siria settentrionale, in Cilicia, Panfilia, nel Peloponneso meridionale, in Attica e negli empori di Nauplia, Corinto e Corfù. A Durazzo, la vivace colonia veneziana beneficiò pure di ulteriori pertinenze connesse alla chiesa di Sant’Andrea. E a Costantinopoli, sul fianco del Corno d’Oro, i Lagunari ottennero un quartiere che includeva tre scali portua76
li, magazzini con alloggi sovrastanti e un forno contiguo alla chiesa di Sant’Akindinos. Fuori dalle franchigie rimanevano Creta, Cipro e i porti del Mar Nero. Ma le prospettive d’azione e le opportunità finanziarie erano talmente vaste da schiacciare ogni concorrenza. Supportata da navi che anche in guerra avevano dimostrato tutto il loro potenziale, l’affermazione di Venezia fra XI e XII secolo si fece impetuosa, irrefrenabile, quasi totale, basandosi su una rigorosa salvaguardia dei diritti acquisiti. Accadrà ai dogi di accorrere in Dalmazia, in Croazia o in Montenegro per arginare la pressione degli Ungheresi, o per ribadire la preminenza veneziana sui principati semi-autonomi del litorale. Ritorneranno i legni lagunari a disinfestare le coste basso-adriatiche o le isole ionie dalle periodiche insidie normanne, pianificate dal Regno di Sicilia con incursioni transmarine. E anche quando entreranno in ritardo nei giochi della prima crociata (1096-1099), i Veneziani sapranno recuperarvi profitti concreti: al servizio di Goffredo di Buglione si accaparreranno un terzo di Haifa, come ricompensa per averla espugnata; intralceranno i rivali Pisani (lanciatisi da subito in Terrasanta per impostarvi nuovi commerci) sbaragliando le navi toscane nella battaglia di Rodi; e trafugheranno da Mira le «vere» spoglie di san Nicola, spacciando per fasulle quelle che già i Pugliesi avevano precedentemente traslato a Bari, nel 1087. Con l’ennesimo furto sacro, Venezia si dotava del protettore dei naviganti, del nocchiero che non teme tempesta, e si appropriava del venerato taumaturgo che, in egual misura, era adorato dai fedeli d’Oriente e d’Occidente. Al raccordo fra Europa e Asia, san Nicola richiamava, esattamente, e legittimava le ambizioni veneziane a farsi fulcro, assoluto, dei movimenti internazionali di uomini e merci. 77
3 | L’ora del gran guadagno Infastidivano, i Veneziani. Infastidiva il loro regime commerciale prepotente, autoritario, che lasciava poco margine agli altri. Infastidiva il loro atteggiamento arrogante, perentorio, spocchioso. Di contro, nessuno poteva infastidire Venezia fintanto che avesse goduto delle sue straordinarie esenzioni daziarie. Né c’era chi riuscisse realmente a competere con la sua flotta militare, che aveva reso il dogato marciano una superpotenza del Mediterraneo. I Genovesi restavano fuori dal giro buono, quantunque si fossero affacciati in Siria. E non disturbavano oltremisura i Pisani, che pure dal 1111 avevano usufruito di un quartiere a Costantinopoli (completo di pontile da sbarco), assieme a una riduzione delle tasse doganali. Le immunità incamerate con la crisobolla del 1082 ponevano gli affari veneziani in una botte di ferro. Sennonché, l’avvento di Giovanni II Comneno (1118-1143) al timone dell’impero d’Oriente scombussolò le carte in tavola. Nel 1119, infatti, il sovrano si rifiutò di rinnovare le quasi quarantennali agevolazioni appannaggio dei commercianti lagunari. Quel rifiuto esternava un profondo risentimento: il mancato rispetto degli obblighi d’alleanza, i comportamenti arbitrari, la sfrontataggine con cui avevano rubato da una chiesa di Bisanzio il corpo di santo Stefano protomartire erano tutti argomenti che condannavano i Veneziani, e giustificavano il diniego imperiale. La crisi era aperta, e la rappresaglia non tardò: i vascelli di san Marco si empirono nel 1121 di quindicimila uomini, al comando del doge Domenico Michiel. Dovevano coadiuvare Baldovino II, re di Gerusalemme, che aveva richiesto man forte alla cristianità per le sue guerre in Terrasanta. E in effetti, i Lagunari conseguirono sui musulmani affermazioni significative, 78
meritandosi l’assegnazione di un quartiere ad Acri e la terza parte di Tiro (come stabilito nei negoziati condotti preliminarmente coi condottieri cristiani). Ma le operazioni non si esaurirono in Palestina: nel 1124, l’armata navale veneziana scatenò un’aggressione in grande stile a detrimento dei possedimenti bizantini. Rodi venne occupata. Samo, Lesbo e Andro saccheggiate. Chio depredata delle reliquie di sant’Isidoro. Stracariche di bottino, palestinese e bizantino, le navi veneziane rimpatriarono nel 1125. Una prova di forza tanto «convincente» dovette costringere il basileus costantinopolitano a mutare indirizzo, e a riformulare, ampliate, le antiche deroghe commerciali in favore di Venezia. Reintegrata nei suoi diritti, l’esuberante potenza nordadriatica poteva così riprendere e accelerare la dilatazione dei suoi traffici sulle rotte per Costantinopoli, per i regni latino-orientali e per l’Egitto fatimide. A San Giovanni d’Acri approdavano metalli, cavalli, legname, armamenti, e si comprava vetro, zucchero, seta e lino. Ad Alessandria e Damietta si vendevano schiavi, armi e materiali per la cantieristica navale, e si acquistava allume, cotone, seterie e spezierie. Dalla Grecia si prelevavano i generi alimentari da distribuire nelle metropoli mediterranee, mentre i movimenti di mercanzie nell’Italia settentrionale proliferavano ai ritmi consueti. Per i mercanti veneziani, i decenni centrali del XII secolo segnarono l’ora del «gran guadagno», facilitato anche dall’apertura in franchigia delle piazze di Cipro e Creta. L’esonero daziario nelle due isole mediterranee, sancito da un decreto dell’imperatore Manuele I Comneno, suggellava una ritrovata intesa militare venetobizantina, mirante a bloccare l’irrequietezza del normanno Ruggero II (1130-1154). Con le sue schiere, il monarca del Regnum Siciliae aveva scompigliato fra il 1147 e il 1149 Corfù, 79
Tebe e Corinto, e minacciava tanto i territori imperiali quanto, appollaiato sulle due sponde all’imbocco dell’Adriatico, l’egemonia marittima di Venezia. Ma venne ricacciato indietro, per la reazione congiunta delle milizie inviate dal Bosforo e dalla Laguna. La comunanza di obiettivi aveva per un attimo riacceso la secolare familiarità fra città «consanguinee», madre e figlia, e la comparsa di un nemico comune, il comune interesse a combatterlo erano stati il fondamento di un accordo che dovette procurare ai Veneziani l’ampliamento del quartiere loro riservato a Bisanzio. Con uno scalo in più, lo stanziamento abbracciava un’area che Peter Schreiner ha calcolato in 30-35.000 metri quadrati: era un’estensione che sopravanzava di gran lunga l’ampiezza dei rioni assegnati a Pisa e, successivamente, a Genova. Quella dei trafficanti italici non era però una presenza ben accetta agli abitanti dell’impero romano-orientale, e tanto meno ai residenti nella capitale. A detta del cronista bizantino Giovanni Cinnamo, i mercanti di Venezia s’erano insuperbiti per le gigantesche ricchezze accumulate e, di conseguenza, trattavano con eguale boria i cittadini, i servi o i dignitari regi. La rete dei commerci era pressoché monopolizzata dai forestieri, che facendo leva sugli sgravi doganali esercitavano una posizione dominante sui traffici esteri e sul mercato interno. I commercianti autoctoni languivano, s’impoverivano, mentre i faccendieri stranieri ingrossavano i proventi e, gelosi gli uni degli altri, sovente tramutavano l’aspra concorrenza in tafferugli e disordini violenti. Montavano, quindi, la tensione e l’intolleranza. Le popolazioni bizantine erano stanche dell’oppressione di quei barbari ignoranti, portatori di corruzione e tumulti. E la stanchezza sfociava in ostilità allorché gli incidenti fra Veneziani, Pisani e Genovesi riverberavano sulla cittadinanza turbamenti e sfa80
celo, odio e rovina. Le vie, i porticati, le botteghe dei quartieri italici, animati dalle compravendite, eccitati dal sopraggiungere di bastimenti nei giorni di ordinario lavoro, divenivano scenari di guerriglia urbana allo scoppiare d’una rissa. Ondate xenofobe, feroci e sanguinose, soggiunsero violenza alle battaglie fra Latini. E la crescente insofferenza popolare nei confronti degli intrusi occidentali indusse Manuele Comneno a espellere in prima battuta le colonie di Genova e Pisa (che saranno peraltro richiamate nel 1170), e poi a liberarsi dell’onerosa presenza di Venezia: il 12 marzo 1171, il basileus ordinò che tutti i Veneziani, in tutto l’impero, fossero arrestati, e i loro beni, le loro mercanzie, le loro imbarcazioni requisite. Per la sola Costantinopoli, si è parlato di diecimila imprigionati (anche se la cifra trova discordi gli storici). Si sa della fuga precipitosa da Bisanzio del mercante Romano Mairano, salito nottetempo su una nave stipata di compatrioti, e di un convoglio veneziano fuggito da Almiro, nel golfo di Volo. Ma in pochi ce la faranno a evitare la reclusione. Ed essendo le carceri insufficienti a contenere tanta gente tutt’insieme, i prigionieri verranno addirittura dirottati nei monasteri. Per lo storiografo Niceta Coniate, l’epurazione aveva punito l’insolenza dei Lagunari, adusi a maltrattare i Bizantini e a deridere le ordinanze imperiali. E comunque, sulla decisione di effettuare un «repulisti» dovevano avere probabilmente inciso due avvenimenti: il sostegno negato dal dogato all’imperatore in previsione di un ennesimo conflitto coi Normanni, e la recentissima devastazione inflitta dai Veneziani ai tenimenti genovesi di Costantinopoli. In ogni caso, per i commerci marciani era un gravissimo smacco. Soltanto parzialmente i saccheggi, subito perpetrati dalla flotta lagunare nell’Egeo, vendicheranno l’umiliazione. Do81
vrà trascorrere più d’un decennio, in un andirivieni convulso di ambascerie, per ritrovare dei Veneziani a Bisanzio, in coincidenza col regno di Andronico I Comneno (11831185), e all’indomani dell’ennesima sollevazione popolare contro alloggi e depositi di Pisani e Genovesi, massacrati dalla plebe inferocita. Il riavvicinamento del basileus al doge, la promessa di rifondere i danni e restituire i patrimoni confiscati ai Lagunari derivavano dal bisogno, che i Bizantini avevano, di uscire dall’isolamento internazionale in cui erano caduti per gli attriti con Federico Barbarossa, col papato e con Bulgari, Ungheresi e Serbi. Furono tuttavia ancora le armate normanne a scompigliare i territori bizantini, allorché nel 1185 presero Durazzo, Corfù, Cefalonia, Zacinto e, soprattutto, Tessalonica. La caduta della metropoli greca e la strage della sua cittadinanza innescarono a Bisanzio un panico che sconvolse la capitale e produsse l’uccisione dell’imperatore, torturato e fatto letteralmente a pezzi dalla folla impazzita. Il potere andò a Isacco II Angelo (1185-1195), che seppe reagire e respingere l’avanzata normanna, e che nell’intento di ricucire gli strappi coi vecchi alleati ripristinerà i privilegi commerciali dei Veneziani, impegnandosi a risarcirli per le confische subite in passato, e concedendo loro di ampliare il quartiere di Costantinopoli, a spese di Tedeschi e Francesi. Non tutto, però, era risolto. Perché il Mar Nero continuava a essere precluso a Venezia. Perché le acque adriatiche soffrivano dell’invadenza pisana, ungara, normanna. Perché la Dalmazia era in fermento, e i dipartimenti siroegiziani ormai in gran parte controllati da Salah al-Din Yusuf (il Saladino delle cronache occidentali, che pure favoriva gli scambi commerciali). Mentre le rate del risarcimento promesso dai Bizantini venivano rimborsate a singhiozzo. 82
Alla mercé degli umori popolari, inoltre, la leadership veneziana nei commerci dell’impero era minata da una perenne incertezza. Il turbinoso alternarsi di imperatori, le loro propensioni ora filoveneziane, ora antilatine, non tranquillizzavano uno Stato che, dalla Laguna, premeva per affermare compiutamente il proprio colonialismo mercantile. Se necessario, anche scavalcando Bisanzio.
4 | Una crociata sballata Per realizzarsi pienamente, l’allievo doveva uccidere il maestro. Venezia doveva liberarsi dalla claustrofobia d’un rapporto ormai castrante con Costantinopoli. E l’occasione propizia si prospettò con la quarta crociata, quella di inizio Duecento. Crociata strana, sballata, che aveva nel mirino l’Egitto, e che deviò invece per tutt’altra strada. A differenza del passato, non era sorta come una spedizione di re o imperatori. A prendere la croce erano stati feudatari di svariata estrazione, signori della Francia, dei Paesi Bassi, della Renania o dell’Italia settentrionale che, per concretizzare il progetto, ebbero l’urgenza di reperire una quantità sufficiente, e sufficientemente affidabile, di bastimenti con cui trasportare armi e armati nel Vicino Oriente. Sei plenipotenziari furono perciò mandati nel febbraio del 1201 in ambasciata a Venezia. Li accolsero a palazzo ducale il doge Enrico Dandolo e i maggiorenti, che nel volgere di pochi giorni dettarono le condizioni per un accordo: il dogato avrebbe approntato navi adatte al trasporto di quattromilacinquecento cavalieri (coi rispettivi cavalli), di novemila scudieri e di ventimila fanti, con viveri per un anno. Il costo dell’operazione veniva fissato in 85.000 marchi d’argento al peso di Colonia. Altre cinquanta 83
galere di scorta sarebbero inoltre state allestite a spese del Comune lagunare, a patto che la metà delle conquiste fosse spettata ai Veneziani. Prendere o lasciare. I delegati della nobiltà europea valutarono durante tutta una notte l’opportunità della stipula. Poi accettarono. Come da copione il papa, Innocenzo III (1198-1216), venne informato della convenzione, e la benedisse, ammonendo tuttavia i contraenti a non molestare l’Ungheria, che era una discepola della Santa Sede e andava dunque rispettata. Col benestare papale, dall’aprile del 1202 affluirono in Laguna gli armigeri cristiani e il relativo seguito di poveri inermi o avventurieri baldanzosi. L’imbarco era annunciato per il 28 giugno. Ma a quella data i militi convenuti erano molto meno del previsto, e mancavano ancora un bel po’ di quattrini per saldare i conti coi Veneziani. Senza la somma concordata, i Lagunari non si muovevano. La partenza fu pertanto rinviata, e la moltitudine dei crociati confinata nell’isola di San Nicolò al Lido. Qualcuno se ne andò a cercare un traghetto per la Terrasanta dai porti delle Puglie. Altri morirono per la calca, la calura, l’aria insalubre delle paludi, mentre i mercanti locali speculavano sull’assembramento di uomini, coi rifornimenti che venivano spacciati a peso d’oro. Al colmo della sopportazione, in agosto il doge propose una soluzione alternativa: avrebbe dilazionato il versamento del denaro pattuito qualora fosse stato aiutato, in itinere, a riprendere Zara, ribellatasi a Venezia e protetta dalla Corona ungherese. Significava, ovviamente, contravvenire alle prescrizioni del pontefice. E tuttavia non c’era scelta: anche Enrico Dandolo si fece quindi crociato, e in autunno più di duecento vascelli poterono salpare dalla Laguna, con a bordo diciassettemila veneziani e trentaduemila crucesignati. Le vibrate rimostranze di Innocenzo III sortirono nei partenti qualche flebile titubanza, subito cancellata dalla decisa accelerazione che il doge impose agli 84
eventi: alla metà di novembre le mura zaratine (che pure il popolo aveva voluto simbolicamente coronare di crocifissi) cedevano agli assalitori, i quali si abbandonavano al saccheggio e stabilivano di svernare nella cittadina dalmata. Le settimane che seguirono impressero una piega inattesa all’avventura: una legazione del monarca germanico, Filippo di Svevia, e del principe bizantino, Alessio Angelo, venne a domandare un appoggio militare per ripristinare la legittima successione sul trono di Costantinopoli, che nel 1195 Alessio III aveva sottratto con una congiura al fratello Isacco II, finito accecato in prigione. L’eventuale supporto sarebbe stato ripagato con 200.000 marchi d’argento, con il ritorno della Chiesa di Bisanzio all’obbedienza di Roma, con un reggimento di diecimila soldati da associare alla crociata e con provvigioni per cinquecento cavalieri da mantenere in Palestina, vita natural durante. Osteggiata da alcuni fra i baroni partecipanti all’impresa, l’ipotesi deviazionista fu fortemente caldeggiata dai capi più autorevoli, più politicamente influenti e, di sicuro, più ambiziosi: il marchese Bonifacio di Monferrato e il doge Enrico che, peraltro, intrattenendo buone relazioni commerciali con il Cairo, vedeva di buon occhio una diversione delle forze crociate dagli obiettivi egiziani. Sfumava così lo spirito originario dell’iniziativa, ma si spalancava l’allettante prospettiva di ridurre ai minimi termini l’impero d’Oriente, e di profittare delle sue immense ricchezze. Durazzo, Corfù, Andro, Abido, il Bosforo: all’incedere della potente armata occidentale i Bizantini non poterono opporre che «venti scialuppe in condizioni pietose e praticamente marce», ricorda nei suoi appunti Niceta Coniate. L’attacco crociato proseguì dunque senza eccessive difficoltà. La grossa catena che sbarrava l’accesso al Corno d’Oro saltò con la caduta della torre di Galata, cui era fissa85
ta. Per mare i Veneziani e per terra i loro alleati soffocarono Costantinopoli in una stretta mortale. A luglio del 1203, il gonfalone di san Marco già campeggiava sulle fortificazioni litoranee, mentre un incendio inghiottiva l’abitato, e le truppe europee incalzavano le soldatesche bizantine. Per parte sua Alessio III sceglieva di eclissarsi, rifugiandosi in Tracia con la figliuola prediletta e con un copioso quantitativo d’oro e gioielli. Il disastro si sarebbe protratto fino in fondo se, con un coup de théâtre, Isacco II non fosse stato riesumato dal carcere e rimesso in sella come imperatore. Cieco, anziano, il malfermo sovrano fu obbligato ad associare al seggio imperiale il figlio Alessio Angelo, ideatore della restaurazione, e assicurò che avrebbe assolto gli impegni contratti dal suo rampollo con la feudalità occidentale. Il ribaltone interruppe i combattimenti. Gli aggressori arrestarono la loro foga guerriera, e si attestarono sulla sponda asiatica della capitale, in attesa del pagamento. Che avvenne, però, solo per metà del dovuto: sicché la permanenza in loco degli eserciti stranieri fu prorogata fino al marzo del 1204. Nella proroga, gli animi si innervosirono. Il clero greco non tollerava di dover dipendere dalla curia romana, e non ammetteva che i suoi tesori, il vasellame delle chiese, le suppellettili liturgiche fossero requisite per estinguere i debiti imperiali. I milites latini si comportavano poi da padroni strafottenti. Cavalcavano tracotanti per le vie, si ubriacavano, predavano i sobborghi. Le angherie nei riguardi degli Ebrei, il rogo di una moschea e il terribile fuoco volutamente appiccato a un settore della città (per ripicca verso le autorità bizantine) confermarono la brutalità dei crociati, e li resero ancor più sgraditi a una cittadinanza che aveva esasperato il suo nazionalismo. Non ci volle molto perché scoppiassero sommosse, e la casa reale venisse tacciata di complicità con gli in86
trusi. Un colpo di Stato tolse di mezzo i vecchi dinasti e li rimpiazzò col nazionalista Alessio V Ducas. Furono allora avviate trattative per allontanare gli Occidentali versando un riscatto. Ma l’intermediazione fallì, e i Bizantini si predisposero a battaglia: le difese murarie furono rinforzate, la popolazione organizzata per fronteggiare lo scontro finale, preannunciato da scaramucce extra moenia. Quando tuttavia una foresta di scale si levò dagli enormi vascelli veneziani per essere poggiata alle mura cittadine, i difensori dovettero sentire imminente la tragedia. Dalle torri e dalle porte conquistate si effuse la marea crociata e, il 12 aprile, il quartiere adiacente al Corno d’Oro fu in mani straniere. Con l’imperatore datosi alla macchia, Costantinopoli si ritrovò allo sbando, in balìa del nemico. Un ulteriore incendio divampò assieme alla furia del saccheggio, delle uccisioni, delle violenze inconsulte che non risparmiarono i civili, le monache, i bambini, le biblioteche, i templi, le opere d’arte, le tombe nobiliari scoperchiate per asportare i corredi funebri e gli ornamenti dei defunti. Bestie da soma entravano nelle chiese per prelevarvi oro e argento. In Santa Sofia, una donna «in scherno a Cristo si pose a sedere sul seggio patriarcale, cantando sguaiatamente», riferiscono le fonti. Per tre giorni di seguito la metropoli venne orribilmente oltraggiata. Ai cronisti bizantini, perfino i musulmani dovettero sembrare «umani e benevoli» in confronto a quella gente «che porta la croce di Cristo sulle spalle». E Goffredo di Villehardouin, maresciallo di Champagne, testimone oculare di parte franca, dovette annotare che «Dalla creazione del mondo non era mai stato fatto un tale bottino in una città». Quasi idillico, Roberto di Clari, cavaliere di Piccardia, scrisse invece che «Una volta presa la città, non fu fatto del male né a povero né a ricco». I conquistatori si spartirono comunque un bottino immenso, riflesso di una storia 87
plurisecolare e splendida. Bisanzio e il suo impero vennero smembrati, sulla base degli accordi intercorsi fra i vincitori alla vigilia della conquista. Nasceva un impero latino d’Oriente che il papa, plaudente, saluterà come un evento «miracoloso», voluto dalla provvidenza divina. La latinizzazione di Costantinopoli fece di Baldovino I di Fiandra l’imperatore, e del veneziano Tommaso Morosini il patriarca. Venezia ebbe i tre ottavi della città, e il suo doge diventò dominator quarte et dimidie partis totius imperii Romaniae, signore di una quarta parte e mezzo dell’impero di Romània. La giurisdizione veneziana (benché scalfita dal despotato che, in Epiro, andava formando Michele Angelo Comneno Ducas, cugino di Isacco II) includeva ora coste e isole del Mar Ionio, parti del Peloponneso, le Cicladi e alcune Sporadi, l’Eubea, le basi di Gallipoli, di Rodosto e di Eraclea fra i Dardanelli e il Mar di Marmara, l’Ellesponto e l’importantissima Creta, acquistata a suon di denari dai marchesi di Monferrato. Un fitto sistema di scali, fondachi, piazze e possessi strategici corroborava la propensione imperialistica di Venezia. Il suo era un imperialismo commerciale, basato sul controllo dei mercati e delle mercanzie, più che delle terre e dei popoli. Ed era un impero orientato a Levante, incline a penetrare i contesti mediorientali. Ma in Medioriente avevano riparato anche i membri delle classi dominanti bizantine: a Trebisonda s’erano ritagliati un potentato autonomo Alessio e Davide Comneno, nipoti di Andronico I, mentre a Nicea moltissimi fuoriusciti s’erano andati raccogliendo intorno a Teodoro Lascaris, genero di Alessio III, strenuo propugnatore delle tradizioni politiche e religiose greco-ortodosse. Recuperare Costantinopoli: sarà questo il pensiero fisso che, per più di cinquant’anni, animerà la schiatta dei Lascaridi. 88
Capitolo quinto
MA CHI ERANO MAI QUESTI POLO?
1 | Testamento pre-parto Fare testamento alle soglie del parto non era infrequente per le gestanti veneziane. Il travaglio poteva facilmente sfociare nel decesso della partoriente, squarciata a morte negli spasmi della procreazione, abbattuta dall’insostenibilità delle doglie. Dunque, meglio premunirsi. Ma se la madre di Marco Polo abbia terminato i propri giorni terreni dando alla luce un figlioletto, oppure si sia spenta per un qualsiasi altro male, non lo sapremo forse mai. Di lei, del suo nome, della sua vicenda non si conosce alcunché. Tralasciata da ogni memoria. Fuori da tutti i documenti finora esaminati della Venezia duecentesca. Oscurata, sepolta nel dimenticatoio, quasi fosse ininfluente, marginale, o peggio: immeritevole d’esser ricordata. L’unico appunto riconducibile alla sua esistenza è che nel 1254 mise al mondo un figlio, che viaggerà parecchio e sarà chiamato come il santo cittadino (e come lo zio paterno, Marco, che diremo «il Vecchio»). Per il resto, è una donna completamente sconosciuta, del tutto inaccessibile. Un personaggio accantonato, celato nelle pieghe delle vicissitudini poliane, sovrastato dalle mille peripezie di una famiglia di mercanti solerti e intraprendenti. Il che suona strano. Specie considerando che la seconda moglie del ve89
dovo, messer Niccolò, è perfettamente nota: Fiordelise Trevisan era infatti una signora di buon lignaggio, che al marito darà un maschietto chiamato Matteo (o Maffio, alla veneziana). Altri due figli naturali, Zanino (che sta per Giovannino) e Stefanino, il padre di Marco Polo li avrà da una certa Maria, non altrimenti identificabile, ma almeno nominata in alcune carte familiari: un’altolocata o una popolana? Di sicuro le nobildonne non rinunciavano ai piaceri erotici, anche extraconiugali, mentre serve e schiave erano prede semplici, bottino quotidiano, addomesticato e casalingo, nelle residenze di borghesi e aristocratici. Silenzio, invece, sulla prima compagna del mercatante, sulla sua prima sposa, sulla genitrice del viaggiatore. Eppure la funzione delle mogli, «colonne per il marito e la famiglia», cardine della vita domestica nell’allevare la prole e nell’aiutare il coniuge a dirigere la casa o a moltiplicare i beni, era rimarchevole. Il matrimonio disciplinava le strategie sociali, e rinsaldava le fondamenta delle casate che volevano perpetuarsi sul proscenio della società veneziana: per cui i protagonisti della messinscena solevano esibire forte e chiaro la qualificazione dello status acquisito nel corpo cittadino. I padri, le madri, i consanguinei di chi contava, o di chi intendeva imporsi e riscuotere il riconoscimento della collettività, non potevano essere trascurati e dimenticati. E i Polo erano un clan che nel XIII secolo andava coltivando una sicura agiatezza coi proventi del commercio. Una genealogia infondata, divulgata dall’araldista Marco Barbaro nel Cinquecento, vorrebbe la loro stirpe oriunda di Sebenico, in Dalmazia, da dove il gene poliano sarebbe derivato in Laguna nel 1033. Dello stesso avviso è Giovanni Battista Ramusio, autore dei tre volumi Delle navigationi et viaggi pubblicati tra il 1550 e il 1559. Epperò un 90
Johanne Paulo è attestato sin dal 1028 a Chioggia, in una donazione al monastero di San Michele di Brondolo. E, per i secoli XI e XII, dei Paulo/Polo compariranno in più documenti e in più punti del bacino lagunare, con la qualifica di giudici, di notai, o come proprietari di saline e terreni, o ancora come firmatari di importanti atti pubblici: ed è ovvio che, per risultare abbienti e ricoprire incarichi di rilievo, la loro presenza in zona doveva essere alquanto retrodatata. Così a Equilo (nei pressi dell’attuale Jesolo), a Lio Maggiore, a Torcello, a Rialto troviamo con lo stesso cognome una lunga lista di Domenico, Stefano, Giovanni, Pietro, Enrico, Andrea, Lazzaro, Vitale, Bortolotus, Martino o Frugerius. Quanto sangue abbiano in comune tutti questi attori della quotidianità medievale veneziana è complicato da verificare, per l’estrema popolarità di un gentilizio discendente dal comunissimo appellativo di «Paolo». Rintracciare un ceppo univoco per le molteplici ramificazioni poliane risulta quindi disagevole. A giudizio di Rodolfo Gallo, l’ascendenza marcopoliana potrebbe essere riferita a quei Polo attestati a San Trovaso (contrazione dialettale dei santi Gervasio e Protasio), nel sestiere di Dorsoduro, nel 1140, i coniugi Giovanni e Auria: Marco il viaggiatore ebbe in effetti una cugina di nome Auria che, figlia di Flora, la zia paterna, nel 1301 elencava in una scrittura testamentaria alcune delle sue proprietà dotali situate proprio in contrada San Trovaso. Allo stesso rione veneziano apparteneva quel Marco Polo nauclerus che, nel 1168, faceva affari a Costantinopoli, ma in cui comunque non è possibile riscontrare con certezza un antenato del più famoso omonimo duecentesco. Oltretutto, l’omonimia si ripete in un Marcus Paulus di Cannaregio testimoniato per il 1224, ed è ulteriormente ribadita nella concordanza ono91
mastica con un mercante di San Leonardo, ricordato nel 1291. Alla saga poliana del XIII secolo appartiene pure una sfilza di Dominicus, Petrus, Iohannes, Thomas, Nicolaus, Jacobus operanti in Venezia, oppure impegnati a Candia, nella colonizzazione dell’isola di Creta. A fatica si disegna poi la figura di un nonno Andrea Polo: di lui si è tramandato il ricordo, ma nessun documento può provarne la pur ipotizzata esistenza in San Felice. Una maggiore veridicità è piuttosto attribuibile alle disposizioni testamentarie stilate in data 27 agosto 1280 da Marco il Vecchio, che rivela di aver soggiornato a Bisanzio e in Oriente e di esser tornato a Venezia, insediandosi nella parrocchia di San Severo. Fra calli strette e canali che si gonfiavano al palpito lento delle maree trascorse dunque la sua infanzia il nostro Marco, allevato in un contesto, familiare e cittadino, di mercanti e mercanzie. Il Canal Grande pullulava di volti e accenti forestieri, di barche e chiatte che scivolavano sull’acqua attraccando vicino a magazzini e botteghe. Artigiani, cambiavalute, drappieri, fruttivendoli, erbivendoli, fornai, macellai e pescatori allineavano l’abbondanza dei loro articoli in una babele di negozi e bancarelle. Pellegrini all’imbarco, marinai d’ogni risma e prostitute per ogni tasca facevano la spola fra i navigli addossati alle rive e le taverne disseminate per campi e viuzze. Riva del Vin, Riva dell’Ogio (olio): in un crescendo eccitato di voci e gesti mercanteschi, in uno scalpiccio ininterrotto di venditori e acquirenti, il brulichio culminava sulle banchine di Rialto, laddove un ponte univa le sponde del «Canalazzo» e apriva la sua pedana lignea al trascorrere, lento e quasi dolce, dei vascelli più ingombranti. Ai piedi del ponteggio, una bilancia pubblica garantiva una pesatura senza frode alle merci sbarcate in quella fiera permanente, perno economico di un impero 92
commerciale enorme. A qualche metro di distanza, i Tedeschi usufruivano di un loro fondaco, organizzato fra il 1222 e il 1225 per favorire le intermediazioni concernenti l’oro ungherese e l’argento boemo: coi metalli pregiati, in effetti, i Veneziani finanziavano il costoso commercio nel Mediterraneo orientale, mentre sulla direttrice continentale, più terrestre, si rapportavano con le aree germaniche tramite i secolari sentieri del Brennero. Panni e manufatti fiamminghi o francesi transitavano per la dogana. Le banchine traboccavano di pellami e legnami balcanici, di prodotti agricoli delle Marche e della Romagna. Sui moli i battelli scaricavano la cera, l’olio, il miele, i formaggi, i cereali e i vini cretesi, le granaglie della Puglia, la malvasia del Peloponneso, il vino di Negroponte (l’isola Eubea), il cotone e lo zucchero di Cipro, e le arance, i limoni, l’uva secca di Corfù, di Zante e delle più disparate piazze greche, in un bazar che risucchiava in Laguna i flussi commerciali euromediterranei. Le compravendite coinvolgevano cittadini di qualsiasi estrazione, che il giovanissimo Marco sentiva contrattare, litigare e alla volte accordarsi per la colleganza (o commenda), il tipo di compromesso mercantile più praticato: ne conseguiva un contratto per cui un socius stans, il sovvenzionatore deputato a restare a terra, conferiva denari o merci al socius procertans o tractator, incaricato di viaggiare e far fruttare l’investimento. Al termine del viaggio, il finanziatore recuperava il capitale iniziale e, in più, incassava i tre quarti del guadagno. L’altro quarto costituiva invece la ricompensa per il lavoro del socio viaggiante. La cannella, i chiodi di garofano, lo zenzero, la noce moscata, le droghe più care e ricercate come pure le gomme, i profumi, i balsami e le sostanze medicamentose arrivavano a pervadere con le loro fragranze speziate e orientaleggianti i rii e i campielli di Vene93
zia, le stradine o le piazzette che ai ragazzini come Marco facevano annusare, quasi indovinare il Levante.
2 | Lo Sposalizio del mare L’Oriente, i suoi miti, le sue dorature dovevano impressionare il piccolo Marco. Le suggestioni olfattive stimolate dalle spezie si intrecciavano indissolubilmente alla familiarità con gli schiavi che transitavano per la Laguna, e che spesso venivano presi nei palazzi veneziani per diventare, talora, poco meno che persone di famiglia. In casa, in un ambiente protetto e protettivo, si sperimentava perciò una naturale confidenza coi soggetti allogeni. La frequentazione quotidiana, l’abitudine anche semplicemente a vedere o a parlare con uno straniero ne attenuavano l’esotismo e gli restituivano umanità. Per le strade, poi, il pot-pourri di nazionalità, l’eterogeneità di razze, lingue e abbigliamenti evitava ai giovinetti veneziani di ispessire gli steccati culturali, e li predisponeva all’accettazione spontanea del diverso, ad un adeguato contatto con uomini d’ogni provenienza. Alleviata da ogni paura, liberata da ogni barriera, la fantasia del giovane Polo poteva sbizzarrirsi ancor di più a immaginare paesi e atmosfere levantine. Le storie raccontate dai parenti-commercianti, le narrazioni mirabolanti udite per bocca dei mercanti di passaggio riempivano il domani del ragazzino. E coi racconti sbalorditivi dei viaggiatori si impastavano anche le leggende di Alessandro Magno alla conquista delle Indie: come ha fatto notare Olschki, proprio l’effigie del condottiero macedone, portato in aria dai grifi, campeggiava in un bassorilievo che tutti potevano osservare, alla metà del 94
Duecento, scolpito sul lato occidentale della chiesa di San Marco. La stessa basilica marciana era un inno alle meraviglie orientali: oltre ad esser stata costruita sul modello del tempio (oggi distrutto) dei Santi Apostoli di Costantinopoli, aggrumava in sé gli ornamenti, i trofei, le prede e i tesori condotti a Venezia da province lontane: gli interni lussureggiavano in una parata di marmi, colonne, rilievi e suppellettili recuperate dai territori bizantini, a comporre un’ornamentazione spettacolarizzata dal profluvio di mosaici e ori; il fianco meridionale era ornato dal gruppo in porfido purpureo dei Tetrarchi, avvinghiati in un abbraccio; e sul portale sarebbe stata levata la quadriga di cavalli in bronzo dorato, asportata da Bisanzio col saccheggio crociato del 1204. Dinanzi al sacrario, la fastosa piazza risaltava a imitazione dei grandi fori costantinopolitani, ricavata in uno spazio che doveva risultare enorme per il XIII secolo europeo e per una città da strappare, palmo a palmo, alla palude. In un perenne viavai di merci e mercanti, all’intersezione del sacro col profano, fra reliquie e mercanzie, magazzini e santità, la grande spianata sfociava nel bacino d’ancoraggio a sposare l’Adriatico, in una connessione fisica e ideale fra la terra e l’acqua che compendiava la genesi urbana. Le virtù, i simboli, le icone, le metafore della gloria cittadina si dispiegavano così nel campanile, nelle colonne monumentali sfiorate dai flutti, nel santuario dell’Evangelista e nel Palazzo Ducale, manifesti in pietra di una metropoli che si avviava a contare centomila abitanti. Con lo sguardo meravigliato ed entusiasta di un fanciullo, Marco Polo vedeva dipanarsi le liturgie del potere nello scenario di magnificenza e di acuto simbolismo creato dalla perfetta osmosi di architetture civiche e religiose. I cerimoniali pubblici, modulati con sistematicità dall’almanac95
co delle ricorrenze veneziane, enfatizzavano la concordia della cittadinanza, e celebravano l’armonia sociale da cui la propaganda statale faceva discendere le fortune di Venezia. Non che fossero sconosciuti i disordini, le rivolte cagionate dalla pressione fiscale, avvertita principalmente dalla parte debole della società, in un contesto urbano che ai ricchi esponenti dell’aristocrazia e della borghesia mercantile abbinava i piccoli e i medi artigiani, gli operatori economici più modesti, i manovali o i marinai senza fissa occupazione. La povertà o la criminalità emergevano specie di notte, specie dai labirinti fetidi di acque morte e miseria che ansimavano attorno al Castelletto, quanto più ci si allontanava dai poli d’attrazione di Rialto e della Piazza. Risse, insulti, locande disgraziate, figuri sinistri, puttane, ladri, rapinatori e giocatori d’azzardo farcivano di violenza e squallore il «dietro le quinte» della grandeur veneziana. Ma nei giorni di festa tutta quella spazzatura finiva sotto il tappeto dei cortei sfavillanti che facevano sgranare gli occhi ai giovincelli dell’età di Marco. Stoffe d’alta qualità e pellicce eccezionali esaltavano la prosperità dei drappieri e dei pellicciai, che si esibivano nei corteggi celebrativi dell’opulenza mercantile. Per la ricorrenza dell’Ascensione, nel rito della Sensa, il doge navigava col suo sontuoso seguito da San Nicolò del Lido e, sul Bucintoro, la pomposa nave di rappresentanza, andava a gettare alle onde un anello d’oro, rinnovando lo Sposalizio del mare con la formula: «Noi ti sposiamo, mare, in segno della vera e perpetua dominazione». Lo sfavillio degli addobbi e un’intensa partecipazione popolare vivacizzavano pure la festa delle Dodici Marie, in cui altrettante ragazze da marito, ingioiellate di tutto punto, si imbarcavano su sei navi poste vicino alla cattedrale di San Pietro di Castello e, scortate da armigeri, clero, dame, 96
accompagnate dal vescovo e dalle autorità dogali, andavano a comporre una processione che sfilava per il Canal Grande, fra squilli di tromba e il fragore metallico dei piatti. Con una parata altrettanto entusiasmante e sfarzosa, centinaia di bambini veneziani, ordinati per file, chi con una croce d’argento, chi con una bandiera, commemoravano il 31 gennaio la traslazione delle spoglie marciane. Spettatore di tanta ritualità, Martino da Canal cita nelle sue cronache il grido che veniva lanciato durante quei solenni festeggiamenti: «Cristo conquista! Cristo regna! Cristo domina! Al nostro nobile signore, per grazia di Dio doge di Venezia, Dalmazia e Croazia, nonché sovrano di una quarta parte e mezzo di tutto l’impero di Romània, salute, onore, lunga vita e vittoria! Sostienilo, san Marco!». Da sola, tuttavia, e i Veneziani lo capivano bene, la protezione del patrono non era sufficiente. Lo sviluppo della città dipendeva dai commerci, e i commerci esigevano un sussidio statale che fosse ininterrotto, vigoroso e concreto. L’Arsenale, col suo serbatoio di imbarcazioni fabbricate a getto continuo, era la risposta alle istanze dei mercanti di Venezia. Sottoposto all’autorità di magistrati urbani (i patroni dell’Arzanà), il cantiere pubblico di costruzioni navali sussultava dal XII secolo al margine orientale dell’abitato, succhiando le energie di carpentieri, calafati, segantini, e attirando manodopera più o meno specializzata a seconda dei tempi e delle occorrenze. Scaricatori, vinai, bottai, fabbri, rematori, le famiglie intere dei costruttori di navigli finivano per essere asservite alle inesorabilità dell’industria, ai ritmi che schiacciavano l’esistenza operaia sui cicli ineludibili del lavorare-mangiare-dormire. Intorno alle parrocchie di San Martino o della Santa Trinità s’addensava il corollario d’umanità, bettole e case popolari, che qualificava una delle 97
aree industriali più vaste e infernali del Medioevo occidentale. Dante Alighieri ne fornirà un quadro di potente realismo nel libro XXI dell’Inferno, ai versi 7-15: «Quale ne l’Arzanà dei Viniziani / bolle l’inverno la tenace pece / a rimpalmare i legni lor non sani / ché navigar non ponno, e in quella vece / chi fa suo legno novo e chi ristoppa / le coste a quel che più viaggi fece; / chi ribatte da proda e chi da poppa, / altri fa remi e altri volge sarte, / chi terzeruolo e artimon rintoppa». La produzione nautica si accresceva simmetricamente all’accrescersi della potenza imperialista di Venezia. Alla gigantesca fabbrica di navigli approdavano piante resinose della Valsugana e del Grappa, travi d’abete per i pennoni e gli alberi dei bastimenti, assi di larice per gli interni, e tavole di quercia per le armature e le bordature. Il legname discendeva dalle valli del Brenta e dell’Adige, e dal Friuli, dal Trevigiano, dall’Istria, dalle Alpi, per essere lavorato, assemblato, mutato dai demiurghi veneziani in capolavori della tecnologia cantieristica. Dall’Arsenale e dagli squeri (i cantieri privati) uscivano così le cocche, dei natanti tondi, a vela latina, adatti ai carichi pesanti, dotati di almeno due ponti e concepiti per i trasporti su lunghe distanze, con una stazza media di duecento tonnellate (che rare volte raggiungeva le cinquecento). La flotta da guerra poteva contare su vascelli lunghi e più bassi, muniti di remi, e apprezzati per l’agilità e la maneggevolezza. Erano in particolare le galere biremi che assicuravano una tranquilla navigazione ai convogli mercantili, venendo usate anche per veicolare articoli preziosi e poco voluminosi. Tutti i giorni, Marco Polo vedeva tutte quelle imbarcazioni puntare a Levante, o ritornarvi con le stive rese sature dai buoni affari. Figlio e nipote di commercianti, nato 98
e cresciuto in una località plasmata sul negotium, il giovanetto aveva la strada segnata. A tal grado era connaturato il viaggio commerciale alle vite lagunari, che una norma statutaria del 1229 aveva concesso ai giudici la facoltà di accogliere le istanze di rinvio dei processi, qualora la richiesta provenisse da un soggetto che aveva «pane e vino» su una nave in procinto di lasciare il porto. Fin nel primo Rinascimento lo andrà ripetendo il memorialista Marino Sanudo il Giovane: i Veneziani erano stati mercanti ab origine, e mercanti restavano sempre.
3 | L’educazione di un mercante Del latino e della grammatica si poteva abbastanza fare a meno. Degli studi classici si riteneva lo strettissimo indispensabile. All’educazione di un mercante in erba convenivano le scienze applicate, più attinenti alla pratica quotidiana del commerciare, più consone alle necessità del computare, del dividere, del moltiplicare. La compravendita di mercanzie o le conversioni monetali richiedevano una preparazione che non poteva essere apparecchiata dalle scuole religiose, tutte tese ad approfondire i testi sacri e a ridurre l’aritmetica alla mera osservazione del calendario. Con l’espansione dei traffici e la conquista di mercati sempre più reconditi, un commerciante analfabeta non avrebbe mai potuto avere successo. Leggere, scrivere, fare di conto erano ormai requisiti imprescindibili per un mercator duecentesco. E il clero, col suo tradizionalismo didattico, non poteva soddisfare i rinnovati bisogni del ceto mercantile, né conservare l’esclusiva dell’insegnamento. 99
L’ampliamento dei commerci imponeva modelli scolastici alternativi, impostati su una mentalità aritmetica che assecondasse l’inclinazione per i calcoli, per la precisione, per quella che un satirico del XIII secolo chiamava «l’arte monetaria». Si implementarono perciò i corsi di abaco, che introducevano una gran quantità di discenti all’apprendimento di conteggi e operazioni commerciali. Un’istruzione laica risultava più confacente ai giovani che, nati da mercanti, erano votati a seguire le orme paterne, istruendosi nelle discipline matematiche. Non è pertanto casuale che a introdurre in Europa il numero zero e le cifre indo-arabe (più idonee alla contabilità rispetto ai vecchi numeri romani) sia stato, nel primo quarto del Duecento, Leonardo Fibonacci: figlio di un mercante pisano, l’insigne scienziato aveva appreso i fondamenti algebrici e la geometria araba durante i viaggi compiuti nell’Africa musulmana insieme al padre. Grazie al suo Liber abaci, al Liber quadratorum e agli scritti di altri eruditi (come il Carmen de algorismo di Alessandro di Villedieu, del 1205 circa, o come l’Algorismus vulgaris di Giovanni del Sacrobosco, elaborato intorno al 1220), la matematica era uscita dalla ristretta cerchia dei dotti ed era stata resa accessibile, in Occidente, a chiunque avesse voluto utilizzarla per le incombenze mercantesche. La straordinaria accelerazione che l’incremento dei traffici dovette imprimere alle corrispondenze d’affari produsse inoltre il ritorno dei caratteri alfabetici dalla «minuscola carolingia» al più agile «corsivo», adoperato largamente dai mercatores che si muovevano su più fronti. La composizione variegata dei mercati euromediterranei o mediorientali, e i molteplici rapporti con popolazioni diversificate, consigliavano peraltro al buon mercante lo studio delle lingue straniere. L’inglese, il tedesco, e più a nord il russo o l’estone erano 100
raccomandabili per agire negli empori continentali, in aggiunta all’italiano che, da idioma internazionale, prevaleva nel Mediterraneo (assieme al greco-bizantino e all’arabo). Per semplificare i contatti col Levante circolavano altresì dei frasari, dei vocabolari ovvero dei manuali che contenevano i rudimenti delle grammatiche d’Asia, con in primis i fondamenti del persiano, la lingua franca del periodo: e il Codex cumanicus, steso a Genova (o in una colonia genovese) quasi sicuramente ai primi del Trecento, sarà un comodo dizionario latino-persiano-comano, ad uso mercantesco. Così, modellata sulle esigenze professionali, la formazione del commerciante appariva moderna ed efficiente. Marco Polo non vi si sottrasse, e il suo apprendistato può essere esemplificato dal contenuto dello Zibaldone da Canal, un sussidiario primo-trecentesco che raccoglieva diversi esercizi per studenti, coi problemi aritmetici (e relative soluzioni) che dovevano forgiare la mente «matematica» del futuro mercante. In questa miscellanea si trovavano suggerimenti su come districarsi negli scambi, sul valore delle merci e sulle equivalenze fra pesi, misure e monete di varie località, a complemento di un esatto ammaestramento sulla geografia dei commerci. Il prontuario era completato da nozioni concernenti l’astrologia, le previsioni meteorologiche, la religione, la letteratura corrente, le cronache storiche e gli atteggiamenti di cortesia da tenere con gli estranei. Istruirsi alle buone maniere e all’esercizio della gentilezza (anche a prescindere dall’autenticità del sentimento) poteva in effetti rivelarsi decisivo per l’esito di un affare, a tutte le latitudini. Nello Speculum regale, che descriveva ceti e categorie sociali della Norvegia duecentesca, il mestiere del mercante appariva perciò improntato a precetti universali: «L’uomo che intende diventare mercante», spiegava un padre a un fi101
glio, «espone la sua vita a molti pericoli, sia sul mare sia in terre pagane e tra popoli stranieri. Egli deve perciò attenersi costantemente alla prudenza là dove si trova. Sul mare è necessario saper prendere decisioni immediate ed essere dotati di grande coraggio. Quando invece giungi in una località commerciale o in un altro qualsiasi posto, devi mostrarti persona educata e ammodo per conquistarti la simpatia generale». Importante era conoscere la parlata e il diritto commerciale dei luoghi visitati, sapersi orientare con gli astri fra i punti cardinali, e memorizzare, fare tesoro delle proprie esperienze: «Non lasciar passare nemmeno un giorno senza apprendere qualcosa di utile per te», continuava infatti il precettore scandinavo, «[...] e se davvero vuoi acquistare la reputazione di saggio devi imparare continuamente». Pacatezza e riservatezza costituivano il presupposto d’ogni azione. «Ma se le circostanze ti costringono a uno scontro con l’avversario», evidenziava ancora l’istitutore, «non avere fretta di abbandonare il campo; dopo aver valutato con attenzione tutto, agisci a colpo sicuro». Di un simile background culturale s’era nutrita la giovinezza di Marco Polo, in un’epoca che tuttavia vedeva le posizioni di Venezia messe in crisi dall’ascesa di Genova. L’intromissione dei Liguri nelle piazze del Medioriente aveva in effetti acceso una conflittualità avviata ad esplodere violentemente. A San Giovanni d’Acri, il principale porto degli Stati crociati di Terrasanta, l’aperto antagonismo aveva inasprito i dissapori fra le ben incardinate colonie dei Veneziani e dei Genovesi. Ma fra il 1256 e il 1258 si andò oltre, e le periodiche scaramucce degenerarono in ostilità selvaggia: il quartiere genovese venne saccheggiato, e i rancori viscerali si tramutarono in una guerra che, fra armistizi e rinfocolamenti, si protrarrà per parecchi decenni. Nella lot102
ta furibonda per la preminenza economica, gli atti di pirateria si accavalleranno a vere e proprie battaglie navali, configurando uno quadro geopolitico di notevole fluidità, gravido di conseguenze. Gli imperatori di Nicea, che s’erano riappropriati di porzioni sostanziose dell’impero latino d’Oriente, premevano difatti per reinsediarsi in Costantinopoli. L’irruzione sulla scena di Michele VIII Paleologo (1259-1282), un energico comandante militare divenuto sovrano niceno, risultò deflagrante: il 13 marzo del 1261, col trattato di Ninfeo, Genova affiancava la sua flotta ai Niceni e alla loro mai sopita ambizione di rimontare, da legittimi successori, sul trono costantinopolitano. I bastimenti genovesi erano necessari per divellere le difese marittime, assicurate al malfermo dominio di Baldovino II dai vascelli di Venezia, il solo effettivo baluardo cittadino, assieme alle mura urbiche. Non sarà tuttavia dal mare che Bisanzio verrà espugnata: a conquistare la capitale, rimasta incredibilmente priva delle guarnigioni (impegnate coi navigli veneziani e siciliani ad attaccare l’isola di Dafnusia, nel Mar Nero), sarà un pugno di ottocento soldati, che Michele Paleologo aveva spedito in Tracia per una ricognizione, al comando di Alessio Strategopulo. Con l’aiuto dei «Volontari», gruppi di origine greca che vivevano nei dintorni, Costantinopoli fu violata nella notte fra il 24 e il 25 luglio dalle esigue schiere nicene. Ai residenti occidentali, colti alla sprovvista e mancanti d’una protezione militare, toccò scappare o morire, dopo un’ultima, disperata resistenza. Nel fuoco arsero allora i magazzini, le case, i monumenti della comunità veneziana: in fumo finiva l’egemonia commerciale di Venezia, e insieme le sorti di un organismo imperiale che, pur essendo sopravvissuto cinquantasette anni, risultava ormai rabberciato, sofferente 103
per la scarsa coesione delle sue intrinseche componenti politiche. Solamente gli interessi del papato e del doge avevano mantenuto a galla un barlume d’apparato statale, funzionale al primato ecclesiastico del pontefice e alla supremazia economica del dogato. Con la restaurazione dei Paleologi la situazione si capovolse: in ossequio ai patti pregressi, la licenza di commerciare liberamente in tutto il territorio bizantino, senza pagare dazi, venne aggiudicata ai Genovesi. La loro smania di rivalsa si riversò sul monastero del Cristo Pantocratore, che a Bisanzio era stato il quartier generale dei Veneziani: il complesso monastico venne demolito fino alle fondamenta, e le sue pietre portate a Genova. La sciagurata perdita di Costantinopoli dovette enormemente colpire l’opinione pubblica lagunare, ingenerando gravi tensioni sociali e il timore che venissero meno Corone, Modone, Creta, l’Eubea, le isole dell’arcipelago greco e la catena di pertinenze essenziali per l’economia dogale. Le acque adriatiche, egee o tirreniche fino al 1270 furono perciò agitate da un durissimo conflitto navale, con Venezia tesa a difendere accanitamente (ed efficacemente) i propri scali portuali, e la marineria genovese intenta ad ampliare le proprie prerogative mercantili. All’isola di Settepozzi (presso Malvasia, in Morea), trentadue galere veneziane distruggeranno nel 1263 una folta squadra di vascelli liguri. Al largo di Trapani, nel 1266 la flotta di Genova patirà un’altra disfatta, amplificata dalla morte per annegamento di migliaia di marinai. Nel rincrudire del duello, i tradizionali circuiti commerciali non erano più sicuri come una volta. Occorreva, per poter trafficare con profitto e in tranquillità, escogitare nuove soluzioni. Serviva trovare, quindi, o incentivare, dei mercati alternativi. 104
4 | La fraterna compagnia Non erano stati accecati o mutilati, come i Veneziani che a Costantinopoli erano rimasti. Non erano morti per la fame e gli stenti, come i Veneziani che da Costantinopoli erano fuggiti alla volta di Negroponte, stipati su navi stracolme di profughi e povere di alimenti. Niccolò e Matteo Polo, padre e zio di Marco, si trovavano altrove quando i Paleologi entrarono a restaurare il loro potere nella città imperiale. Da qualche tempo, i due commercianti lagunari avevano subodorato che la congiuntura economica non era delle migliori, e s’erano accorti che i conti non tornavano più. Il cinquantennio di signoria latina aveva prodotto meno, molto meno di quanto probabilmente ci si attendesse in Laguna. I traffici, dal giorno dell’occupazione crociata, non erano mai stati troppo entusiasmanti, e avevano stentato a decollare, o anche soltanto ad attestarsi sui livelli del XII secolo. La forte concorrenza di Cipro e dell’Armenia Minore aveva limitato la crescita del commercio costantinopolitano. Gli scambi apparivano in declino, e il subentrante governo occidentale s’era fatto notare prevalentemente per l’incuria sostanziale a cui aveva condannato l’economia cittadina. Bisanzio, perciò, alla metà del Duecento, versava in un degrado tragico. Mentre in altre piazze i commerci prosperavano, e il predominio sugli stretti del Mar di Marmara favoriva i Veneziani nell’accedere al Mar Nero, le attività mercantili sul Bosforo tendevano a languire, e sembravano atrofizzarsi. Le vane e dispendiose guerre intraprese contro Nicea, l’inerzia politico-amministrativa, le perenni carenze finanziarie avevano prostrato la capitale dell’impero latino d’Oriente. Nel 1225, i Latini erano usciti sconfitti da una guerra contro i Niceni, e avevano dovuto sottoscrivere col 105
sovrano avversario, Giovanni III Ducas Vatatze (12221254), un gravoso trattato di pace col quale i domini bizantini venivano privati di quasi tutti i possessi dell’Asia Minore, eccezion fatta per Nicomedia e per la costa dirimpetto a Costantinopoli. Per due volte consecutive poi, nel 1235 e nel 1236, le milizie nicene, sostenute dai contingenti dei neoalleati bulgari, s’erano poste all’assedio della metropoli, salvata solo dal deciso intervento dell’imperatore Giovanni di Brienne e dai cospicui rinforzi navali inviati dal doge. Malgrado però la tenace resistenza, in Bisanzio gli indizi del dissesto saltavano agli occhi. I sintomi di una depressione si potevano cogliere con frequenza sempre più ravvicinata, e dalla stessa corte promanavano segnali poco incoraggianti: per raccattare un po’ di fondi, nel 1237-1238 non si era infatti esitato a impegnare la corona di spine di Cristo, una delle reliquie di maggiore valenza per i cristiani occidentali, permutandola con una consistente somma imprestata da finanzieri di Venezia (e subito dopo sarà re Luigi IX di Francia a riacquistare il veneratissimo oggetto, portandolo a Parigi). In un ennesimo momento critico, Baldovino II si vedrà costretto a rivendere addirittura le coperture in piombo dei propri palazzi regi, pur di racimolare qualche denaro che tenesse in efficienza una parvenza di apparato governativo. E finanche il suo figlio unico, Filippo, verrà dato in pegno ai commercianti veneziani in cambio d’un prestito. In tanta precarietà, di fronte a un avvenire preoccupante, l’attrazione esercitata da nuovi empori asiatici dovette convincere Niccolò e Matteo Polo a cambiare aria. Entrambi erano legati col terzo fratello, Marco il Vecchio, in una fraterna compagnia, un consorzio familiare che prevedeva la comunione dei beni. E prima ancora che Bisanzio tornasse greca, prima degli esili forzosi, delle torture e degli eccidi che co106
stringeranno i Veneziani di Costantinopoli a rientrare in Laguna, i Polo avevano incentivato i loro affari dal banco di Soldaia. Sul capoluogo commerciale della Crimea convergevano le ambre russe, il miele, la cera, le pellicce pregiate, gli schiavi da avviare ai regni musulmani dell’Egitto e del Vicino Oriente, il pesce salato del Mar d’Azov, il grano delle pianure ucraine, il cotone come pure le spezie aromatiche e le seterie levantine. Per soddisfare le corti di Trebisonda e di Bisanzio si pescavano storioni in quantità, e se ne ricavava un apprezzatissimo caviale. Il bucherame, un tessuto fine e ricercato, prodotto nelle botteghe del grande centro di Buhara, vivacizzava le negoziazioni, in un traffico ininterrotto di mercanti che si snodava sulle direttrici nord-sud ed est-ovest. L’effervescenza dell’emporio crimeo aveva permesso all’azienda dei fratelli Polo di lasciarsi alle spalle la decadenza del regno baldoviniano, e di proiettarsi ancora più a oriente, per commerciare principalmente in oreficerie e pietre preziose. Non erano i soli mercanti europei ad avere avuto l’intuizione di battere itinerari più orientali. Nel 1263, in effetti, sappiamo che a Tabriz, domicilio d’una colonia mercantile italiana, aveva messo radici Pietro Vilione (o Vioni) da Venezia, un mercator che basava i propri introiti sul commercio del lino, delle stoffe del Nord Europa e del cristallo di rocca. L’uomo, risoltosi a fare testamento, aveva dettato le sue volontà in presenza di un paio di pisani e di un francese, appositamente convocati per fungere da testimoni. Di lì a tre anni, troveremo un Arnoldo Marinier da Marsiglia che, armato di un salvacondotto fornitogli dal principe Carlo d’Angiò, viaggerà attraverso le regioni vicino-orientali per accedere alla «terra dei Tartari». Lo stesso Guglielmo di Rubruck aveva incontrato a Iconio nel 1255 «parecchi Franchi e un mercante genovese di Acri, Nicola di San Siro, che insieme a un suo compa107
gno veneziano, Bonifacio di Molendino, aveva monopolizzato l’esportazione di tutto l’allume della Turchia, così che il sultano poteva vendere solamente a loro due. Essi, poi, lo rivendevano a un prezzo così alto che ciò che di solito veniva venduto per trenta bisanti [moneta bizantina del valore di circa quindici libbre d’oro, conosciuta anche come nomisma o iperpero] finiva per costarne cinquanta». E i genovesi di Soldaia organizzeranno addirittura un servizio di navigazione sul Mar Caspio per facilitare il trasporto della seta prodotta nel Mazanderan. Ma anche a Caffa e alla Tana (presso l’attuale Azov, alla foce del Don), la ricorrenza di negoziatori di Venezia, di Genova o comunque occidentali aveva fortemente concorso a instaurare una fitta rete di scambi con la Comania e le province asiatiche più interne. Del resto, immettersi sulla strada che conduceva ai distretti centro-asiatici non era una novità: le monete romane del VI secolo, trovate in Mongolia e nello Shansi, dicono dei traffici esistenti in età tardo-antica fra il Mediterraneo e la Cina. E quindi non possono meravigliare nemmeno le porcellane cinesi che, probabilmente attraverso le carovaniere mediorientali e gli scali della Palestina, affluivano a Brindisi nei decenni iniziali del Duecento, in piena epoca federiciana, come è stato rivelato dalle indagini archeologiche sulla ceramica medievale rinvenuta nella città portuale pugliese (che specialmente in epoca crociata era un perno dei movimenti da e per la Terrasanta). Il lievitare dei commerci nel XIII secolo aveva insomma allargato le prospettive d’azione dei mercatores d’Occidente, predisposti a spostarsi nei luoghi che meglio rispondevano alle loro esigenze economiche. La famiglia dei Polo, con la sua capacità di intuire le opportunità di guadagno e fiutare gli affari, era parte integrante di quell’imprenditoria 108
europea stanziatasi negli avamposti di una frontiera commerciale che tendeva a spingersi sempre più a levante. La spinta, d’altra parte, era recepita con buona facilità: a semplificare le comunicazioni trans-continentali, e ad aprire ai mercanti occidentali un universo restato per lungo tempo inaccessibile, era stata l’espansione dell’egemonia mongola. Da qualche decennio, l’autorità khanale dei gengiskhanidi aveva infatti riunificato una larga fascia di distinti territori dal Pacifico al Vicino Oriente. Nell’assecondare i collegamenti, la cosiddetta pax mongolica aveva dischiuso all’uomo medievale nuove opportunità di esperienze e relazioni. E il tutto s’era concretizzato non attraverso degli improbabili accordi politici, non mediante le predicazioni irricevibili di un missionario inviato dal papa, ma con la forza immediata e diretta del commercio, col vigore incruento di una forma d’interazione (o, se si vuole, di conquista) intrinsecamente e autenticamente pacifica.
Capitolo sesto
I MERCANTI CHE DIVENNERO AMBASCIATORI
1 | L’eredità di Gengis Khan Se ne vagheggiava ancora nel XVII secolo: «Sotto il regno di Gengis Khan ogni paese fra Persia e Mongolia godeva di una tale tranquillità che una vergine nuda, con un piatto d’oro colmo di perle sulla testa, avrebbe potuto avanzare da Levante a Ponente senza subire da alcuno la minima violenza». Per Abdul Ghazi, principe turco di Hiva fra il 1644 e il 1663, l’età dell’oro, l’epoca dell’ordine mondiale s’era materializzata agli inizi del Duecento, con l’impero mongolo. Un nomade aveva determinato il prodigio. Un self-made man, un orfano di padre che, fra i secoli XII e XIII, aveva avuto la capacità di aggregare uno stuolo di tribù centro-asiatiche in perenne e vicendevole attrito, e di farne una nazione. I Tatari, i Naimani, i Merchiti, i Taiciuti, i Keraiti e decine di popoli diversi, branche di famiglie turco-mongole, drappelli di clan abituati a vagare sparpagliati per le brughiere erano stati raccolti, politicamente e ideologicamente, sotto un unico capo, quel Temugin che sarà nominato Gengis Khan (titolatura che ha il significato di «sovrano universale») e che saprà esaltare l’indole fiera e la tempra inossidabile dei cavalieri della steppa. Le abitudini, le secolari abilità di stirpi fin lì più o meno smar110
rite nella Storia erano state tradotte in una formidabile forza d’urto. I Mongoli, l’elemento trainante della grande rivoluzione nomadica, avevano preso coscienza della propria identità, e s’erano espansi e imposti ovunque, con potenza e prepotenza. Erano dilagati nella Cina settentrionale, infrangendo il Regno d’Oro dei Jin e impadronendosi di Pechino nel 1215. Dalla Manciuria avevano conquistato tutta l’Asia centrale, inglobando pacificamente il progredito regno degli Uiguri, soggiogando gli imperi di Xi Xia, del Kara-Kitai, del Kipchak, della Corasmia, e dilagando sia al di sopra che al di sotto del Mar Caspio e del Mar Nero. Nessuno aveva saputo resistere all’Orda Azzurra, che dall’azzurro Cielo (il divino Tengri, nume protettore) si sentiva ispirata: non le civiltà sedentarie, i Cinesi del Fiume Giallo o i musulmani dei floridi regni mediorientali; non i cacciatori-raccoglitori della tundra; e tanto meno le etnie che praticavano il nomadismo pastorale o il seminomadismo nelle sterminate praterie euroasiatiche. Ne era scaturito uno fra gli imperi più vasti che l’umanità potesse ricordare, dilatato in tre quarti di secolo dall’Oriente all’Occidente, e dalla Siberia all’Himalaya, in una fascia inusitatamente lunga e larga, abbastanza da annoverare il grosso dell’ecumene. Il gigantismo dell’impero fondato da Gengis Khan prefigurava un’idea di cosmocrazia che i regnanti gengiskhanidi coltivarono nella convinzione di dover imporre per mandato celeste una monarchia planetaria su genti e religioni affatto eterogenee, e sovente dissonanti. Anche per questo i Mongoli cercheranno di elaborare una tipologia di società e convivenza che – una volta stabilizzato il potere – fosse impostata sulle regole del mutuo rispetto, dell’integrazione religiosa e della conciliazione (sebbene la compagine mongola 111
attribuisse a se stessa, comunque e dovunque, una posizione preminente). Con la sistematizzazione politico-militare ed economica di un governo globale improntato all’equità, la pax Mongolorum era stata il fattore fondante per la promozione del commercio e dei contatti fra culture discoste, fra mondi che il Medioevo aveva distanziato in una diversa evoluzione storica. Dall’età di Gengis Khan si era in effetti intensificato un formidabile movimento di gente, allettata dalla caduta delle frontiere, sedotta da una maggiore libertà di circolazione e dalla migliore sicurezza delle strade. La Via della Seta era agibile ancor meglio di prima, e su più linee: con un percorso settentrionale che, da Kiev, costeggiava il lago Balha^ per arrivare al Xinjiang e a Karakorum; con l’itinerario centrale che, da Damasco, Baghdad o Trebisonda lambiva Merv, Buhara, Samarcanda, Kashgar e, attraverso Turfan, si concludeva nel distretto pechinese; e col segmento più meridionale, che dalla Siria superava il Tigri e l’Eufrate a sud di Baghdad, proseguendo per Balkh, Hotan e Xi’an. Nella collana di caravanserragli che cadenzavano il cammino, tutti gli spostamenti carovanieri erano inclusi ed avvenivano sotto l’egida di un impero unificante, esteso su un territorio incommensurabile, che anche dall’estensione derivava il suo fascino. La smisuratezza dei domini mongoli annidava però i germi della debolezza. Tanta vastità non poteva essere gestita con sufficiente padronanza da un’amministrazione centralizzata, per quanto si sperimentasse celermente una burocrazia periferica che si poggiava sull’ottimo sistema dei jam, il servizio di collegamenti imperniato su velocissimi corrieri a cavallo e su un reticolo di stazioni per il cambio delle cavalcature. La stessa gestione che Gengis Khan aveva di112
sposto per il territorio imperiale, dividendolo fra i suoi quattro figli in regni connessi da un legame «genealogico-federale», era fatalmente destinata a implodere: le diatribe familiari e le lotte di successione, spesso rabbiose e senza esclusione di colpi, finiranno difatti per prevalere sulla volontà unitaria del capostipite già all’indomani della sua scomparsa (avvenuta nel 1227), e causeranno un irreversibile processo di smembramento dell’impero. La spartizione primigenia evolverà così nella formazione di quattro macroprincipati che – almeno esteriormente – resteranno legati da vincoli dinastici e di consanguineità, fino agli anni Cinquanta e Sessanta del XIII secolo. Dopodiché, nell’acuirsi della disgregazione, il gran khanato sino-mongolo, il reame turkmeno di Chagatai, l’Orda d’Oro nelle steppe russe e l’il-khanato persiano del Medioriente vivranno ciascuno una propria storia, distinta e indipendente da quella delle altre dinastie di matrice gengiskhanide. Ciascuna delle entità khanali giungerà ad assumere gradualmente una specifica fisionomia, e perseguirà obiettivi peculiari, che potranno talora accordarsi con gli obiettivi degli altri khanati, come pure divergervi, anche aspramente, fino a sconfinare in guerra, in un astio dimentico dell’univocità di lignaggio. Il particolarismo arriverà a soverchiare insomma il perseguimento d’una comunanza d’intenti su scala intercontinentale, e saranno i criteri della convenienza individuale a determinare, di volta in volta, gli indirizzi politici d’ogni khanato, non più le ragioni dell’unitarietà. La scomposizione della sovranità faceva seguito a un trentennio di conquiste che, peraltro, avevano condotto la dominazione mongola a estendersi sulla Corea, a inglobare importanti porzioni di terre cinesi e tibetane, a interessare il Punjab e ad allungarsi sull’Europa centro-orientale. Su un 113
fronte più meridionale, buona parte della Persia era stata domata dagli eserciti dei gengiskhanidi, e la stessa Baghdad aveva capitolato nel 1258: il luminoso califfato abbaside, faro secolare dell’islam sunnita, era franato, travolto dalla furia mongolica. Nell’immediatezza del dopo-Gengis Khan, tutte le vittorie e l’inarrestabile espansione erano state in qualche misura il collante che aveva tenuto assieme i pezzi della signoria mongola, e che aveva temporaneamente occultato le controversie intestine. A lungo andare, tuttavia, i contrasti interni e i rovesci militari accentueranno le tendenze centrifughe, gli individualismi, i separatismi. La vittoriosa resistenza del sultanato di Delhi, nel 1245, dovette propalare che le armate centro-asiatiche erano battibili. E quando i Mamelucchi d’Egitto nel 1260 infliggeranno una dura batosta ai Mongoli nella battaglia di Ain Jalut, alle «Sorgenti di Golia», in Galilea, la progressione nomadica verso il Mediterraneo potrà dirsi sostanzialmente e definitivamente troncata. A quel punto, però, l’abboccamento era avvenuto e, malgrado la parcellizzazione che segmenterà per sempre l’imperio mongolo, la ricucitura delle distanze fra il Ponente e il Levante era cosa fatta. Se di una effettiva pax mongolica non si potrà forse più parlare negli anni a venire, nondimeno gli strascichi della pacificazione generale, la conoscenza reciproca fra due mondi e il consolidamento delle relazioni dovette permettere a commerci e commercianti di continuare a svilupparsi. Il potenziamento della rete dei trasporti aveva ormai riattivato una circolazione di uomini e mercanzie che poteva prescindere, molto spesso, dalle scomposizioni politiche. Oltretutto, i singoli khan si mostravano tutt’altro che refrattari a traffici mercantili che vivificavano le economie statali: cosicché, meno di chiunque altro i mercanti risentivano 114
degli ostacoli frontierali. Esercitate con la dovuta prudenza, eseguite con le precauzioni assimilate sin da piccoli, magari sui prontuari del «bravo mercatante», le intraprese commerciali nelle regioni mongolizzate aggiravano qualsiasi impedimento. E perseveravano nel valorizzare (si sarebbe tentati di dire «nel monetizzare») l’eredità di Gengis Khan.
2 | Commercianti rampanti Come mercanti, Niccolò e Matteo Polo ci sapevano fare per davvero. Insuperabili, nel ricavare il massimo lucro da una compravendita. Intuitivi, nell’afferrare al volo un’opportunità di guadagno. Intelligenti e scaltri, nel soppesare i sorrisi e corrispondere alle aspettative dell’interlocutore, captandone in un attimo il temperamento o blandendolo, avendone studiato per tempo la personalità. Il bagaglio professionale di un commerciante d’avanguardia includeva infatti lo screening dell’altrui psicologia, l’adattamento all’indole della persona incontrata o da contattare. Il mestiere del negoziatore si giocava parecchio sulla sensibilità nel percepire il codice d’accesso alle inclinazioni, alle simpatie, ai desideri del prossimo: e azzeccarne i gusti, assecondarne le preferenze, incoraggiarne le attitudini costituiva la carta vincente per introitare profitti più che sostanziosi. Sorretti da questo loro purissimo spirito mercantesco, i fratelli Polo s’erano quindi inoltrati nel territorio dell’Orda d’Oro portandosi appresso una sporta di gioielli variegati. Conoscevano probabilmente alla perfezione le predilezioni del khan Berke, che nel 1257 era succeduto al germano Batu (dopo i brevissimi regni di Sartaq e Ulakci) al comando dei Tartari di Ponente. E 115
d’altronde, un’oreficeria pregiata poteva incontrare con discreti margini di sicurezza le voglie di lusso dei regnanti, di tutti i regnanti, essendo un articolo universalmente gradito. Merce quasi infallibile, dunque, mercanzia affidabile e dal rendimento praticamente garantito, con la cui provvisione i due trafficanti veneziani addivennero alla corte khanale. In altalena fra la capitale Saraj (sul corso inferiore del Volga) e il centro di Bolgary (residenza alternativa della monarchia, posta sulla riva destra del fiume), Niccolò e Matteo giunsero a conferire col sovrano mongolo, porgendogli i preziosi che avevano tradotto nel khanato. Per Berke non c’era niente di più attraente: avvolto nel suo caffettano di seta serrato in vita da una cintura in cuoio tempestata di gemme, con un pendente aureo che gli impreziosiva un orecchio, agghindato con vezzosi spadini finemente lavorati a niello, coi calzari zigrinati in rosso, la barba rada e i capelli tirati all’indietro (il suo minuzioso ritratto ci è stato tramandato da un ambasciatore d’Egitto), il khan accettò ben volentieri le gioiellerie, e in cambio offrì sostanze che valevano almeno il doppio di quanto i monili fossero stati pagati alla fonte. Per i Polo s’era trattato nuovamente di un ottimo affare, di un realizzo favorevole, con i cui proventi sarebbero potuti rientrare soddisfatti a casa. Ma l’annuncio che Costantinopoli era stata espugnata da Michele Paleologo, con le terribili notizie delle sevizie inflitte per vendetta alla popolazione veneziana di stanza nei territori bizantini, dovettero indurre i pur audaci fratelli a programmare un rientro per vie traverse, che aggirasse il rinascente impero di Bisanzio e scongiurasse i sopraggiunti pericoli d’una cattura. A meridione, transitando per la Georgia e l’Armenia, nelle terre persiane era teoricamente raggiungibile la colonia di Venezia a Tabriz, da dove sarebbe stato possibile riguadagna116
re in discreta scioltezza il Mediterraneo orientale. E invece, un ulteriore impedimento sopravvenne a ostacolare l’attuazione del programma: nell’inverno del 1261-1262 era infatti esplosa una guerra fra i cugini Berke e Hülegü, che aveva messo l’una contro l’altro l’Orda d’Oro e l’il-khanato di Persia. Anche la strada per il Sud, scossa dal conflitto, era pertanto divenuta insicura e praticamente impercorribile. Dopo aver indugiato un anno, Niccolò e Matteo si risolsero a ripartire, volgendo a settentrione. Da Ukek, nelle vicinanze all’attuale Saratov, presero per il Levante. Viaggiarono lungamente attraverso lande semidesolate, e tutto ciò che poterono scorgere furono soltanto sporadiche tende di mongoli col relativo bestiame. Entrati in Transoxiana, nel khanato centro-asiatico di Chagatai, i mercanti veneziani raggiunsero l’antica Buhara, località che le cronache medievali descrivevano «molto nobile e grande». Le strade, le piazze, i palazzi, le madrase, le magnifiche moschee della città (che per l’eccellenza delle sue scuole di studi religiosi era stata definita la «cupola dell’islam») ancora un po’ mostravano le crepe dei disastri cagionati dall’assalto di Gengis Khan nel 1220. Pian piano, tuttavia, il fermento mercantile e l’artigianato locale avevano ridato linfa all’abitato, e l’amministrazione mongola stava gradualmente rigenerando la secolare propensione mercantesca della cittadina. I bazar, le taverne, le bancarelle ricolme di frutta all’ombra degli eucalipti avevano ripreso ad attrarre i pellegrini di passaggio, gli avventurieri senza meta, i venditori ambulanti e i commercianti di lungo corso, provenienti dai cantoni più disparati dell’Asia. Le lingue si rincorrevano, e la gestualità degli individui supportava la confluenza di etnie e mercanteggiamenti: inserita sull’asse carovaniero che menava a Oriente, Buhara non poteva che allettare i Polo. Il loro soggiorno in 117
zona, però, durò oltre il previsto: l’evolversi degli eventi bellici impediva gli spostamenti a ovest. Nella partita mediorientale s’erano inseriti prepotentemente i Mamelucchi d’Egitto, e persino i Bizantini erano stati coinvolti nel conflitto, finendo sconfitti nel 1264 da Berke. Sicché, il fermo di Niccolò e Matteo dovette protrarsi per tre buoni anni. Può darsi che in quei frangenti essi imparassero il mongolo, così da ottimizzare la sosta forzata e arricchire la gamma delle esperienze lavorative. La dotazione economica era evidentemente più che sufficiente per prolungare la fermata, e non si può escludere che in quel triennio di pausa i due fratelli abbiano effettuato qualche negozio. La loro sostanziale immobilità venne rotta dall’arrivo di alcuni legati, che presero con sé i Polo per recarsi presso il gran khan: l’imperatore aveva desiderio vivissimo di conoscere dei forestieri, i quali certamente sarebbero stati trattati col massimo rispetto e con ogni onore. Non che gli occidentali fossero ignoti al sovrano: gli annali cinesi registrano in effetti la visita che nel 1260-1261 gli fu resa da fo-lang, e cioè da stranieri provenienti probabilmente dalla Scandinavia, o comunque da paesi nordici (stando alle ipotesi di Herbert Franke o di Luciano Petech). Parimenti degli europei meridionali sarebbero risultati ben accetti. Al che, premuti da un invito che sarebbe stato sconveniente respingere, Niccolò e Matteo ripresero a muoversi sulle piste che conducevano ancora più a levante. Per alcuni critici, l’aggregazione al convoglio fu un’abile mossa congegnata astutamente dai Polo per accreditarsi presso un altro potentato e imbastire nuove trame commerciali. Da una traduzione in latino dei testi poliani sembrerebbe inoltre che i due fratelli fossero accompagnati da servitori cristiani portati da Venezia. Ma per la comitiva, 118
qualunque fosse la sua composizione, non si trattò di una passeggiata. Le nevi esorbitanti, i fiumi eccezionalmente ingrossati, i deserti roventi, le intemperie incessanti rallentarono notevolmente l’andatura della delegazione, e ne intralciarono la marcia lungo un itinerario che ora puntava a nord e ora piegava a est. Un anno intero ci volle, per arrivare finalmente alla residenza imperiale, in un imprecisabile luogo delle remote terre asiatiche (in cui, peraltro, studiosi come Luce Boulnois vedrebbero Kaiping/Shangdu, «Capoluogo Superiore», la capitale estiva situata nella Mongolia cinese, corrispondente all’odierno sito di Duolun, presso la frontiera dell’Hebei). Niccolò e Matteo erano partiti per farsi una clientela nel khanato dell’Orda d’Oro. Si ritrovavano, adesso, al cospetto del gran khan Kubilai (1260-1294), che in quel momento era il più prestigioso fra gli eredi di Gengis Khan.
3 | Pragmatismo e scaramanzie A Möngke era risultata fatale una dissenteria, contratta nella campagna militare con cui si prefiggeva di estendere i propri domini nella Cina centromeridionale, storico regno dei Song (960-1279). L’11 aprile del 1259, la scomparsa del sovrano dovette spalancare un vuoto di potere che i candidati al khanato si affrettarono a colmare. In queste circostanze, la prontezza nelle scelte politiche poteva rivelarsi determinante per artigliare lo scettro. Specie se a contendersi la signoria erano personaggi di pari dignità, come Arik Boge e Kubilai, ambedue fratelli del defunto monarca, e ambedue fermamente intenzionati a prenderne il posto. Il primo, ancorato ai tradizionali possedimen119
ti della Mongolia interna, aveva raccolto il consenso di una certa parte dell’aristocrazia principesca, riunita attorno alla vedova-reggente e a ufficiali del carisma di Bolghai, ministro di fede nestoriana; il secondo, rientrato dall’incompiuta spedizione bellica nelle province cinesi, aveva fissato a Kaiping/Shangdu la sede di un raduno fra coloro che avrebbero dovuto innalzarlo al rango khanale. Ma tanto nelle antiche terre mongole quanto nella Cina settentrionale i rispettivi kuriltai organizzati per l’elezione del nuovo imperatore s’erano rivelati parziali, essendo fondati su una ridotta partecipazione di dignitari, parcellizzati nelle varie fazioni o addirittura riluttanti a schierarsi. Pertanto, le elezioni andavano considerate fondamentalmente nulle, giacché l’insufficiente pienezza del consesso elettorale inficiava di per se stessa la regolare assegnazione del potere assoluto. Ciononostante, in barba ai protocolli, nell’estate del 1260 due colpi di Stato simmetrici avevano partorito un khan e un antikhan, innescando un’ostilità fratricida. Nella preventivabile prospettiva d’uno scontro armato, in un territorio scisso nettamente su due fronti, entrambi i contendenti erano inizialmente apparsi in difficoltà: all’uno, più a nord, erano state precluse le forniture alimentari che soltanto l’agricoltura cinese sapeva produrre in quantità bastante a un esercito e a regioni dipendenti dai vettovagliamenti esterni; all’altro, più a sud, erano state negate le riserve di cavalli che solamente le praterie centro-asiatiche potevano garantire (e nutrire) nel numero occorrente per una belligeranza. Ma pur coi previsti disagi la guerra civile era divampata per circa quattro anni, fra alleanze familiari e voltafaccia improvvisi di questo o quel membro delle casate gengiskhanidi, interessate ad assicurarsi i massimi privilegi nel riposizionamento gerarchico che il conflitto avrebbe prodotto. Dal 120
valzer di appoggi promessi e disattesi era uscito vincitore Kubilai, che nell’estate del 1264, al termine di battaglie, saccheggi, ritorsioni e accomodamenti, aveva ottenuto la resa di Arik Boge, sancendo il diritto a fregiarsi da solo, unico attore della scena, del titolo imperiale. Il gran khan non aveva voluto però insediarsi in Karakorum, la prima e canonica capitale dei Mongoli, che era stata residenza del suo rivale. S’era piuttosto risolto a trasferire la propria dimora a Dadu (la «Grande Capitale»), detta pure Khanbalik (la «Città del Khan»), in corrispondenza grosso modo dell’odierna Pechino. La dislocazione aveva di fatto spostato verso la Cina il baricentro degli interessi khanali, e di conseguenza il fulcro dell’impero s’era allontanato dalla Mongolia, che peraltro andava svuotandosi anche della nobiltà militare, migrata dai luoghi aviti per divenire classe dirigente nei paesi di nuova conquista. Il gran khanato gravitava adesso in una rinnovata dimensione sedentaria al di sotto della Grande Muraglia, in quello che per il Medioevo europeo era il «Catai» (o il «Kitaj» d’ambito slavo), eco toponomastica della dominazione esercitata dai Kitai fra X e XII secolo. Kubilai Khan, un imperatore mongolo, il nipote diretto del leggendario Gengis Khan, il figlio dell’ardimentoso Tului e della giudiziosa Sorgaktani (che il letterato, medico ed erudito persiano Rashid al-Din, vissuto fra XIII e XIV secolo, reputava «estremamente intelligente, capace e dotata più di ogni altra donna al mondo»), aveva così gettato le fondamenta di una potente dinastia che, in breve, protenderà la sua spinta espansiva sulla Cina intera. Fu lui il signore che Niccolò e Matteo Polo si ritrovarono innanzi in tutta la sua magnificenza, sgravato – momentaneamente – dalle lotte in famiglia (benché il focoso Kaidu reclamasse ancora i diritti imperiali del ra121
mo ogodeide dai suoi appannaggi sull’Imil, nell’alta Asia centrale). Con le nozioni di lingua mongola apprese a Buhara, o presumibilmente con l’ausilio di qualche interprete, i mercanti di Venezia poterono discettare col gran khan, accolti con cortesia e ospitati con riguardo. Il sovrano esibì nei loro confronti un’attenzione dettata, forse, più che da uno spirito illuminato, da motivi contingenti: i medici, i militari, gli artisti, i consiglieri, i commercianti, gli specialisti forestieri, e il personale tecnico o amministrativo che non fosse cinese, saranno sovente selezionati da Kubilai per controbilanciare l’influenza degli intellettuali confuciani, e per bloccare le possibili spinte nazionalistiche. In definitiva, a comandare sui Cinesi erano degli invasori di origine nomade che – seppure non sgraditi almeno ai contadini settentrionali, che in precedenza erano stati odiosamente sfruttati dai grandi proprietari terrieri – costituiranno perennemente un corpo estraneo per una società rimasta sedentaria nei millenni, e che quindi concepiva tutt’un altro modus vivendi. Il materiale umano di cui il gran khan poteva disporre risultava abbastanza striminzito per strutturare un governo stabile in una Cina del Nord strapazzata da anni di guerre, dai sovvertimenti politici e da disastri naturali (sebbene nel 1261 venisse istituito, a beneficio delle moltitudini contadine, un Ufficio per lo sviluppo dell’agricoltura, che si proponeva di supportare il lavoro dei braccianti nei campi). La dirigenza mongola rimaneva insomma minoritaria, a fronte di contrade popolosissime. E lo sbilanciamento andava riequilibrato ricorrendo a contributi esterni. Appena nel 1265 un editto aveva disposto che la gestione amministrativa dei circondari (lu) venisse affidata a terne di funzionari composte ciascuna da un darugaci mongolo, da uno 122
zongguan cinese e da un tongzhi musulmano (di solito un burocrate centroasiatico o mediorientale, e comunque un nonmongolo, eventualmente anche nestoriano). Non appaia anomalo pertanto che Kubilai, «signore di tutti i Tartari del mondo e di tutte le province e i regni di quelle grandissime parti della Terra» – come viene presentato dal racconto poliano –, interrogasse Niccolò e Matteo sui metodi dei re europei di governare saggiamente, e si mostrasse avido di informazioni sulle monarchie occidentali, sulla Chiesa di Roma e sul papa. I due fratelli dovettero replicare con saggezza alle domande loro rivolte, consci di giocarsi molte delle chances di poter entrare nelle grazie dell’imperatore. E in effetti il gran khan mostrò gradimento per le risposte e i modi dei Polo, finendo per investirli di una missione diplomatica che dal Levante doveva attraversare tutta l’Asia, fino a raggiungere la Palestina e l’Europa. Con una lettera da recapitare al pontefice, Kubilai espresse infatti il desiderio che dall’Occidente gli venissero mandati dei dotti, istruiti nella fede cristiana e nelle sette arti liberali del Trivio (Grammatica, Retorica, Dialettica o Logica) e del Quadrivio (Aritmetica, Geometria, Musica e Astronomia), discipline che fondavano il patrimonio d’istruzione dell’intellettualità europea. Il gran khan volle inoltre che, insieme a quei sapienti, gli fosse inviato l’olio della lampada che ardeva nella chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. In teoria, gli esperti occidentali avrebbero dovuto divulgare i precetti cristiani nelle località soggette alla giurisdizione mongola; nel concreto, gli eruditi si sarebbero potuti rivelare un’efficace risorsa intellettuale, utilizzabile – anche nell’ottica di un’estensione dell’impero alla Cina del Sud – in un’amministrazione imperiale malvista dalla popolazione sottomessa. Agli obiettivi pratici si collegava poi un substrato 123
magico-religioso: degli abili «maghi», o dei sapienti di vaglia, avrebbero saputo come neutralizzare i malefici degli avversari di Kubilai. Lo stesso olio del Santo Sepolcro avrebbe potuto funzionare da talismano o da unguento portentoso, analogamente alle tante reliquie cristiane che entravano in connessione coi retaggi del più classico sciamanesimo mongolo. I due Polo, naturalmente, accolsero volentieri l’invito a farsi ambasciatori, e per quel loro incarico furono affiancati da Koketei, che dell’imperatore era uomo di fiducia. In compagnia del delegato khanale, nel 1266 i mercanti veneziani poterono volgere il passo a ponente. Portavano il presente del gran khan per il papato, una magnifica stoffa in tela d’amianto, dai poteri ignifughi. E non avrebbero avuto ostacoli, lungo l’itinerario: Kubilai li aveva muniti d’una preziosissima paiza, la tavoletta aurea che serviva da lasciapassare e che proteggeva il possessore nel transito attraverso l’impero mongolo fra le città, i villaggi o le stazioni del jam, dove fare rifornimento e sostituire le bestie da viaggio.
4 | Vizi cardinalizi La piastra d’oro, incisa col sigillo reale, dovette funzionare alla perfezione. Vitto, alloggio, cavalli, scorte di qualsiasi genere, e tutto ciò che si sarebbe potuto desiderare per il viaggio erano garantiti ai messaggeri che possedevano la «tavoletta della signoria», quasi si trattasse di Kubilai in persona. Col salvacondotto del gran khan, percorrere le vie dell’impero diveniva una pacchia. Ancor più per dei veneziani come Niccolò e Matteo, che sebbene fossero stati incaricati d’una ambasceria non perdevano occasione per mer124
canteggiare. Ogni cittadina si apriva loro con somma facilità. Ogni ufficiale o soldato era tenuto a riverirli. Ogni governatore centrale o periferico dell’immenso dominio mongolo si metteva a loro totale disposizione. Girare, commerciare e farlo liberamente, con la certezza dell’immunità, sondare nuovi mercati e scoprire nuove mercanzie in terre inusitate, rappresentava un’opportunità troppo ghiotta per non approfittarne. I fratelli Polo s’erano lietamente impelagati in un’impresa che forse non avrebbero mai immaginato, di proporzioni planetarie, e non intendevano astenersi dai vantaggi d’una congiuntura che s’era fatta privilegiata. Con gioia mercantesca dovettero quindi allineare le tappe del ritorno a quella che per Ugo Tucci era «l’incidenza di un calendario commerciale, al quale dovevano essere subordinati i movimenti delle carovane». Soste, scambi, cavalcate, incontri. Chiaro, non era propriamente una scampagnata: nei cicli mutevoli delle stagioni, chi risultasse disavvezzo alle brusche tormente di neve, alla furia del sole, o al gelo delle notti e della pioggia soffriva di più, era più esposto ai rischi di uno stop. È quanto accadde in effetti a Koketei, impossibilitato, a un certo punto del tragitto, a continuare. Colto da un’infermità, il fiduciario di Kubilai Khan rimase indietro, e rinunciando a proseguire lasciò ai soli Niccolò e Matteo l’incombenza di condurre a buon fine l’ambasciata. La consumata esperienza e la resistenza fisica condussero i fratelli Polo nel 1269 a Lajazzo (o Ayas, odierna Yumurtalik, in Turchia), sulla costa nordoccidentale del golfo di Alessandretta (Iskenderun). Oggi, dell’emporio che fu fiorente e vitale nel Medioevo non si vedono che scarne rovine, a corolla di un porto che ritagliava nella costa una morbida semiluna. Ma nel Duecento, quella località era la tappa iniziale dell’itinerario terrestre per 125
l’Oriente, e uno dei cardini per i traffici navali del Mediterraneo. Vi albergava una popolazione cosmopolita che usufruiva di negozi, chiese, bagni e uffici pubblici. Nel Palazzo Reale e nel Palazzo di Giustizia echeggiavano l’armeno, il latino, il francese, l’italiano o l’arabo, parlati dagli interpreti dell’amministratore regio (il connestabile o duca). Il re Hethum I d’Armenia (1226-1270), vassallo fedele dei Mongoli, con l’editto del 1261 aveva accordato ai Veneziani la possibilità di impiantare qui un fondaco, dando loro la facoltà di soggiornare e trafficare liberamente. Nell’esuberanza delle negoziazioni la città sarà frequentata anche da Pisani, Genovesi, Piacentini, Pavesi, Mantovani, Livornesi, Catalani, e da Spagnoli di Siviglia, Saragozza, Maiorca, da Francesi di Marsiglia, Nîmes, Narbona e Montpellier, da Britannici, da Fiamminghi di Bruges e Anversa, da Egiziani, da Siriaci, da finanzieri di Costantinopoli, Trebisonda, Cipro, Rodi e Creta. La Dogana riscuoteva le imposte sui commerci fra Bisanzio e Pechino, ovvero fra l’Europa e le Indie, e tutte le attività mercantili erano protette da una duplice fortificazione che integrava i castelli di terra e di mare. La piazza di Lajazzo era l’imbuto per le spezie e lo zucchero del Levante, per le lane di cammello e di capra, per il cotone, il lino, il pellame (anche di bufalo), per le armi prodotte in Occidente, e per gli schiavi caricati nelle stive o scaricati sulle banchine estese per oltre un chilometro. A Niccolò e Matteo Polo tutto ciò ricordava atmosfere amiche, era aria di casa. Da quel luogo così tanto connaturato al loro animo di mercanti-viaggiatori i due fratelli si spostarono ad Acri, apprendendo però una notizia che complicava i loro piani: papa Clemente IV (1265-1268) era spirato, e il consesso cardinalizio tardava a eleggerne il successore. 126
La dilatazione delle elezioni pontificie non era d’altronde inusuale: il divampare delle conflittualità fra i prelati-elettori spesso procrastinava sine die la designazione del vicario di Cristo, e i cardinali avevano il vizio di prendersela comoda anche perché, nel periodo della vacanza, godevano per diritto delle entrate normalmente spettanti al Santo Padre. Più si ritardava l’investitura, quindi, più si gonfiavano i proventi per i principi della Chiesa. E la scelta cardinalesca, nei mesi che segnavano il transito palestinese dei Polo, dovette risultare quanto mai «meditata». A chi consegnare, allora, il messaggio del gran khan? Con chi conferire sulle grandezze cinesi e sui proponimenti di Kubilai, il sovrano più eminente del Levante? Impediti dal perfezionare la delicata ambasciata, obbligati ad attendere la designazione del nuovo pontefice, Niccolò e Matteo decisero di rientrare a Venezia, di rivedere la famiglia. In Laguna erano anni di cambiamenti: dal 1268 Lorenzo Tiepolo rivestiva la carica di doge, essendo subentrato a Reniero Zeno. L’assise cittadina del Maggior Consiglio, infarcita di componenti appartenenti alla nobiltà mercantile, aveva accresciuto le proprie prerogative decisionali, nel solco di un processo riformista della Repubblica marciana. L’arengo, la più larga assemblea popolare, era stata viceversa esautorata. Quanto alle faccende personali, Niccolò s’era ritrovato con una moglie defunta e con a carico un figlio, Marco, quindicenne: grandicello dunque, maturo a sufficienza per intraprendere viaggi e affinare, sul campo, l’arte della mercatura. In attesa che un nuovo papa andasse finalmente a occupare il soglio di Pietro, il mercante vedovato pensò bene di risposarsi, e di ritemprarsi dalle fatiche sopportate nelle lunghe peregrinazioni orientali. Per un paio d’anni, le vi127
te spericolate dei fratelli Polo s’acquietarono fra le acque lagunari. In parallelo, si placavano le annose controversie fra Venezia e Genova, con l’armistizio siglato a Cremona nell’agosto del 1270 (auspice Luigi IX di Francia, interessato a disporre delle flotte italiche per un’ennesima crociata). L’accordo faceva seguito al trattato che nel 1264 aveva sancito l’intesa dei Lagunari con Ancona (altra vecchia antagonista nei commerci adriatici), per cui la città marchigiana s’era impegnata – fra le altre cose – a non intromettersi nel redditizio trasporto dei pellegrini in Terrasanta. Nel 1267, inoltre, il dogato aveva allacciato delle relazioni politiche con gli Angioini, che s’erano appena impadroniti del Meridione d’Italia a spese di Manfredi, figlio naturale di Federico II Hohenstaufen, e che ora puntavano decisamente a insignorirsi di Costantinopoli. E ancora, in un complesso gioco di equilibrismi diplomatici, nel 1268 il governo marciano aveva sottoscritto una tregua quinquennale con l’impero bizantino di Michele Paleologo: al passaggio fra gli anni Sessanta e Settanta del XIII secolo, la strategia politico-economica di Venezia pareva pertanto entrata in una fase che attenuava, parzialmente, gli urti frontali con la concorrenza. Le rivalità, tuttavia, non s’erano smorzate. Non poteva rallentarsi la corsa all’accaparramento di ulteriori mercati e al potenziamento dei dispositivi finanziari. Né i Polo potevano starsene troppo a lungo con le mani in mano, quasi in letargo, fermi, distanti da quel Levante che come una droga era penetrato nei loro desideri di mercanti. Le opportunità commerciali intraviste nell’impero di Kubilai erano un richiamo irrefrenabile. L’impegno a esaudire i desiderata dell’imperatore doveva essere onorato. Urgeva andare. Un biennio d’attesa era già stato troppo. E del neo-pontefice, nemmeno l’ombra. Perciò, tralasciandone l’elezione, Nic128
colò e Matteo progettarono di ripartire per la Cina, prima che magari lo facesse qualcun altro, prima che fossero preceduti sulla via dei guadagni, sulla rotta delle ricchezze promesse dall’immenso mercato del Catai. Era il 1271. Stavolta, insieme ai fratelli avrebbe viaggiato Marco, diciassette anni e l’entusiasmo di mille sogni da rendere vivi.
Breslavia
Pest
Kiev
Curzola Dan ub io
IMP lg Vo
Iconio
RN
ERO
DELL ’ O R DA l
Ura
GEORGIA
MAR
MA Nicea
Ukek
D’ORO
Saraj Astrahan’
Caffa
Soldaia
Bolgary
ERO
a
Tana
Co sta nti no po li Negroponte
Smolensk Mosca
Trebisonda Tiflis Sivas ARM
L. d’Aral
MIA
Vienna Buda
Don
Dne pr
Cracovia Venezia
L. Balhasˇ Sy
rda
r’ja Otrar ENIA Derbent Edessa Hiva Lajazzo IMPERO Aleppo Mosul Nicosia Tabriz Tripoli Buhara Samarcanda Sultaniyeh Giaffa Acri Damasco Merv Alessandria Balkh Alamut Nishapur Baghdad Gerusalemme Sheberghan Il Cairo Taloqan Esfahan Herat IL -K H A N Kabul A T O D I P E R S IA Bassora Peshawar Kubanan Yazd Kerman Lahore Kandahar Shiraz ’ja Amudar
CORAS
CA S P IO
ARMENIA MINOR
GO
L FO
Multan
ER
P
MAR
Medina
Hormuz
MAKRAN T ARA GUJ
ROSS
SIC O
Mecca
O
Bombay
MARE ARABICO
ETIOPIA
R ABA MAL
As-Shihr Aden
Mangalore
GOLFO DI ADEN SOCOTRA
I khanati dominati dagli eredi di Gengis Khan (XIII-XIV secolo)
Tun gu
ska Inferiore
sej Eni
B u r ia ’
Kirghisi
Irtys ˇ
o Keraiti M e rc h it i n g o l i
N a im a
Karakorum
ni
Ong Hami Almalik
Turfan
Yumen Zhangye
) allo e Gi Gran JIANGSU Yangzhou Can Fium ( e ale Lanzhou ang H Suzhou Hu Shanghai Nanchino
Ningsian
Wuvei Dunhuang
Qiemo
Yarkand
Dadu/Khanbalik (Pechino)
Kara-Khoto
D I C H AG ATA I Kashgar
Kaiping/Shangdu
uti
Xi’an
IMPERO
Hotan
Hangzhou
DEL GRAN KHAN
Yutian
T T I B E
Chengdu gtz
n Ya
Lhasa
IA
Golfo del Tonchino
L AN DE
RO M
H
CO
g
REGNO KHMER
on Mek
dy wad Irra
GOLFO DEL BENGALA
MARE CINESE MERIDIONALE
AN N AM
C
ANDAMANE Quilon Capo Comorin TAPROBANE
Quanzhou
Tang Long
Bagan
Calcutta
dy
Madras
Fuzhou
FUJAN
Kunming
wad Irra
REGNI INDÙ
)
YUNNAN
Dali
BIRMAN
Gange
S U LTA NAT O DI DELHI
rro
zu
Az
Canton Bhamo
Delhi
e
(F
e ium
AM PA
M
Ob
L. Bajkal
ti
NICOBARE
Medan
SUMATRA
Parte terza SULLA VIA DELLA SETA
Capitolo settimo
UN NUOVO PERCEVAL
1 | Groviglio internazionale Troppi strapazzi, per un regnante senescente e stanco quale egli si sentiva. Enrico III, re d’Inghilterra, si giudicava ormai inabile a guidare un contingente armato in Terrasanta. Era completamente logorato dalle guerre civili. Aveva esaurito nelle snervanti contese coi baroni inglesi la linfa e l’ardimento che sarebbero occorsi per buttarsi in un’altra spedizione crociata. Cesarea, Giaffa, Antiochia erano da poco crollate sotto i colpi dei Mamelucchi d’Egitto. E il loro capo s’era rivelato avversario politicamente avveduto, e militarmente preparato. Un osso più che duro, un nemico difficile da sconfiggere. Di polvere ne aveva mangiata, Rukn al-Din Baibars al-Bunduqdari (o, più semplicemente, Baibars), prima di assumere la signoria del Cairo (1260-1277). Ne aveva fatta di gavetta, quell’uomo sulla cinquantina, imponente di statura, scuro di carnagione, ma con occhi azzurrissimi: era infatti nato kipchak, nelle steppe russe, e in gioventù era stato venduto come schiavo all’emiro al-Bunduqdar. Successivamente, aggregato al corpo di guardia sultanale, aveva subito dimostrato in battaglia valentia e intelligenza fuori dall’ordinario. Nei ranghi dell’esercito s’era costruito una solida carrie134
ra e una fama che, passando per la vittoria sui Franchi del 1244, era culminata nella trionfale affermazione di Ain Jalut sulle schiere mongole. Facendosi largo con violenza e destrezza fra i meandri delle gerarchie emirali, l’ex servo comano aveva acquisito un ruolo di prestigio a corte. E nell’autunno del 1260, sicuro ormai del fatto suo, aveva ucciso a tradimento il sultano Qutuz, colpendolo con una spada alla schiena e carpendogli definitivamente lo scettro. Da quell’istante, Baibars s’era proiettato da protagonista sulla scena mediorientale, ergendosi a campione dell’islam e raccogliendo intorno a sé le simpatie di larghi strati musulmani, nella lotta che mirava a svellere una volta per tutte la presenza cristiano-occidentale. Per contrastare un nemico della forza e della personalità di Baibars erano indispensabili dunque un’energia e una passione guerriera che, probabilmente, Enrico III, l’esausto monarca inglese, non possedeva più. Energico e volitivo era invece suo figlio Edoardo. Il talento dell’erede al trono era stato appena riaffermato dalla risolutezza con cui aveva ripristinato l’auctoritas paterna, a fronte delle mene baronali. Nessuno meglio di lui, fra i Britannici, avrebbe potuto prendere la croce. E così fu. La chiamata alle armi riscosse però pochi consensi fra i nobili inglesi, che uno dietro l’altro rifiutarono di arruolarsi sotto le insegne crociate, adducendo scusanti per lo più pretestuose. Un migliaio di armati fu tutto ciò che la casa reale riuscì a racimolare e a far salpare dalle coste britanniche nell’estate del 1270, al seguito del principe plantageneto e di sua moglie, Eleonora di Castiglia. Nel volgere di qualche mese, la magra compagnia di Edoardo venne un po’ impinguata dai reparti guidati da Edmondo di Lancaster suo fratello, da contingenti bretoni, e dai rinforzi provenienti dai Paesi Bassi al coman135
do dell’arcidiacono di Liegi, Tedaldo (o Tebaldo, o Odaldo) Visconti da Piacenza. Scopo della missione era di intervenire nell’Africa settentrionale al fianco del re di Francia, per scalzare l’emirato tunisino e incanalare le milizie in Palestina. Ma proprio allora l’esercito francese dovette essere falcidiato da un’epidemia devastante (tifo, colera o peste), che alle porte di Tunisi infettò mortalmente lo stesso Luigi IX. La campagna nordafricana, di fatto, era abortita. I progetti d’una sinergia anglo-francese andavano riconsiderati. Durante l’inverno successivo, trascorso in Sicilia presso il Regnum di Carlo d’Angiò, fu quindi pianificata una nuova manovra militare, che avrebbe portato i difensori della cristianità a sbarcare sul litorale palestinese, previa una sosta a Cipro. Così, nella tarda primavera del 1271 i vessilli crociati potevano già campeggiare sulla costa dell’Outremer. Ma in quella, a Edoardo si presentò uno spettacolo per lui poco piacevole e, verosimilmente, del tutto inatteso: credeva, l’ambizioso condottiero, che avrebbe ritrovato nei Luoghi Santi una spaccatura fortissima, una marcata differenziazione fra gli europei e la civiltà musulmana. Pensava, presumibilmente, ad un antagonismo attizzato da odi aviti, a barricate erette su versanti decisamente contrapposti. Si aspettava, e magari auspicava, un livore atavico, profondo, guerresco, su cui far leva per rimpolpare le proprie truppe. E invece, trovò che i Veneziani continuavano imperterriti a commerciare col sultanato egiziano, rifornendolo di legname da costruzione e del metallo grezzo adatto a forgiare le armi. A ruota, i Genovesi pressavano per introdursi con maggiore incisività e profitto negli accattivanti mercati islamici. Con tutta quella promiscuità, un rafforzamento militare che potesse concretizzarsi direttamente nell’Oltremare era un’opzione impraticabile. 136
Scarso affidamento suscitava pure la nobiltà cipriota, riluttante a tuffarsi in un’avventura che, sulla terraferma, si prospettava piena zeppa di incognite. Qualche timida speranza proveniva piuttosto dal successore di Hülegü, Abaqa, l’il-khan mongolo di Persia (1265-1282), che verosimilmente era buddhista ma che simpatizzava per la cristianità: cristiana era stata la sua matrigna, Dokuz Khatun, mentre una delle sue spose, Maria, era figlia naturale dell’imperatore bizantino Michele VIII Paleologo. Pur assorbito dalla conflittualità che lo opponeva all’Orda d’Oro e ai cugini chagataidi del Turkestan, Abaqa s’era dichiarato disponibile a stringere un’alleanza con le armate anglo-europee, convinto alla coalizione da un’ambasceria condotta su mandato di Edoardo da Giovanni Parker, Goffredo Welles e Reginaldo Russell. Di conseguenza, nell’ottobre del 1271, l’il-khanato persiano aveva distaccato dalle sue guarnigioni d’Anatolia diecimila cavalleggeri, che rovesciandosi sulla Siria s’erano diretti ad Aleppo, Maarat an-Numan e Apamea. La controffensiva mamelucca non aveva tardato tuttavia a manifestarsi in tutta la sua potenza: e alla vista delle impressionanti soldataglie egizie, la cavalleria il-khanide era stata obbligata a rinculare al di là dell’Eufrate (consolandosi, peraltro, coi guadagni d’un più che ragguardevole bottino). Dal canto suo, l’esercito cristiano aveva anche provato a invadere la piana di Sharon, sorpassando il Monte Carmelo. Ma persino il piccolo presidio mamelucco di Qaqun era parso troppo ostico da attaccare, per le sparute divisioni crociate. Senza un più cospicuo aiuto dei Mongoli, e con gli eserciti franchi ridotti all’osso, Edoardo aveva ben poche speranze di successo, e un’unica possibilità di uscire indenne dal pantano in cui s’era cacciato: siglare una tregua con Baibars, ri137
mandando a tempi migliori l’impresa crociata e cercando di salvare il salvabile, almeno per il momento. Cesarea fu il luogo dell’armistizio, sottoscritto nel maggio del 1272 dal sultano d’Egitto e dal governatorato del regno latino di San Giovanni d’Acri. Per i successivi dieci anni e dieci mesi, gli occidentali avrebbero potuto esercitare la loro sovranità sulla striscia di terra libano-palestinese che costeggiava il mare e arrivava a Sidone, usufruendo altresì della libertà di pellegrinaggio sulla strada per Nazareth. Erano accordi che, sommandosi alla tregua decennale che sin dall’anno precedente era stata offerta dagli Egiziani alla contea di Tripoli, concedevano un attimo di respiro alla latinità. Ma non ne risolvevano l’emergenza: sbrindellato, lacerato, sminuzzato in porzioni che Baibars provvedeva a usurare con sistematica tenacia, il dominio europeo nel Vicino Oriente appariva in pieno disfacimento, all’impasse di una parabola discendente, al capolinea di un’agonia in fase terminale. Il decadimento era irreversibile. E che non fosse più aria per le crociate, per i proclami papali e per le ambizioni politiche dell’Occidente, dovette accorgersene Edoardo in persona, quando un assassino travestito da cristiano indigeno attentò alla sua persona, ferendolo con un pugnale avvelenato. Per qualche mese, la ferita procurò una grave malattia al principe inglese, indebolendone l’organismo e fiaccandone le aspirazioni. Oltretutto, l’azione crociata aveva da poco perduto un personaggio di prim’ordine: a Viterbo, il consesso dei cardinali s’era finalmente deciso a sciogliere le riserve, e aveva nominato papa proprio quel Tedaldo Visconti che, fin dalle battute iniziali, aveva supportato con vigore l’avventura edoardiana. Il neo-eletto pontefice era stato quindi obbligato a lasciare la Terrasanta, per andarsi a insediare sullo scranno di san Pietro col nome di Gre138
gorio X (1271-1276). Per Baibars, che mirava a eliminare ogni ingerenza della latinità sul suolo mediorientale, non c’era alcuna fretta. Il sultano intuiva benissimo che le piazzeforti occidentali si stavano inesorabilmente deteriorando. I presìdi degli ordini monastico-cavallereschi di templari, giovanniti o teutonici, le pertinenze delle città mercantili italiane (e mediterranee in genere), e insomma quel che restava del movimento crociato avevano i giorni contati. Nel garbuglio internazionale, che angustiava in una crescente inquietudine i distretti siro-palestinesi, era venuto a capitare Marco Polo, col padre Niccolò e lo zio Matteo. In cammino per il Levante, i tre non si sarebbero mai potuti ripresentare al gran khan senza recargli l’olio del Santo Sepolcro: Kubilai aveva manifestato di desiderarlo, ardentemente, e i mercanti veneziani non intendevano perdere i favori dell’imperatore.
2 | L’odore dei santi Reliquie. Memorie della Terrasanta. Pignora: ne circolavano, e in discreta abbondanza, anche nella stessa Europa. Erano i ricordini da regalare al ritorno dai pellegrinaggi a chi non aveva potuto compiere il passaggio nell’Outremer. Erano i trofei della fede da esibire fieramente, emblema della forza d’animo e insieme della felicità d’essere tornati sani e salvi da un viaggio non sempre comodo. Ed erano, non di rado, paccottiglia da rivendere in Occidente, articoli più o meno autentici, importati per appagare le richieste dei cristiani, delle chiese, degli apparati devozionali. Non sarebbe stato complicato trovare, nel XIII secolo, fra le mercanzie europee, 139
delle (presunte) schegge in pietra tolte dal Santo Sepolcro di Gerusalemme, dei sassi provenienti dalla valle di Giosafat, della terra dal monte degli Olivi, o delle palme dall’oasi di Gerico, della polvere derivata dalla grotta «del latte» presso la basilica della Natività a Betlemme, dell’acqua prelevata dal Giordano. Nel redditizio commercio del «sacro» si inserivano pure le eulogie (dal greco eulogiai, corrispondente a «benedizioni», «offerte»), boccette in terracotta o in metallo che contenevano l’olio delle lampade accese sulla tomba del Redentore: proprio ciò di cui dovevano dotarsi i Polo. I tre veneziani, tuttavia, preferirono andarne a ritirare direttamente sul luogo d’origine. E per farlo, per raggiungere la Città Santa, dovettero ovviamente percorrere le province palestinesi. Marco vide per la prima volta quei paesi di cui tanto aveva sentito parlare, e contemplò da novizio quelle contrade così prodighe di vantaggi, per le finanze e per lo spirito. L’asprezza del territorio era intervallata da tratti di fertilità nelle pianure di Esdraelon, di Sharon e di Gerico. Le campagne d’Oltregiordano ospitavano coltivazioni di grano (sebbene l’importanza del distretto dipendesse per lo più dal controllo strategico dei collegamenti fra Damasco e l’Egitto). Orti, frutteti e distese di uliveti si concentravano attorno ai centri abitati, e ricca di risorse era la fascia costiera a ridosso delle montagne libanesi. Gli alberi abbondavano di melograni, limoni dolci, albicocche, e nelle piane cresceva il lino che riforniva le industrie delle stoffe. Dai bachi spuntava la seta per i tessuti più fini. Manifatture di sciamito erano ad Acri, Beirut e Laodicea (Latakia). Nabulus primeggiava per la sua speciale tela. Tiro era famosa per lo zendado (o zendale, un velo serico), oltreché per la sua tintura di porpora. Nel paesaggio extraurbano, l’allevamento di pecore, 140
maiali e capre prediligeva i rialzi collinari. Fisse sulle alture, le fortezze erano segnacoli di guerra tendenti a infittirsi soprattutto nella striscia che, compresa fra Ascalona e Sidone, s’ispessiva arretrando dal Mediterraneo alla Transgiordania. Più su, sul versante nordorientale di Tripoli, le superbe fortificazioni del Krak des Chevaliers dominavano l’accesso al litorale del Libano. Più di qualcuno aveva fatto fortuna, nei regni latini d’Oltremare: gli Ibelin di Beirut s’erano arricchiti con le miniere di ferro, i Montfort di Tiro con le fabbriche di zucchero. Ad Antiochia e in altre località, le vetrerie facevano discreti affari. Le città apparivano radiose, realizzate com’erano in pietra, e abitate da una popolazione che poteva acquistare a buon mercato vestiti di seta, profumi e spezie che per le metropoli occidentali rappresentavano spesso un lusso. D’altronde, era in Medioriente che innanzitutto sboccavano i prodotti levantini, per essere venduti subito, in zona, a prezzi più convenienti, o per essere trasportati negli empori europei, coi costi rincarati dall’ulteriore trasferimento. Dalle Indie, dalla Cina, dall’Afghanistan o dallo Yemen giungevano i legni odorosi, le seterie, le porcellane, il lapislazzuli, il cinnamomo, la robbia, il muschio, la galanza, il macis, la noce moscata, l’indaco, i chiodi di garofano, il cardamomo, l’aloe o l’avorio che sarebbero andati a ricolmare gli esuberanti mercati del Vicino Oriente, e a soddisfare la sempre più sofisticata clientela euromediterranea. L’intreccio di genti era più che normale, e le contrattazioni prescindevano dalle religioni. Ad Acri i musulmani del Maghreb potevano tranquillamente comprare. I mercanti italici si approvvigionavano direttamente da fornitori islamici. Negli ostelli, cristiani e maomettani venivano alloggiati indistintamente. La frequentazione giornaliera stempera141
va le distanze nella reciprocità, e assottigliava i muri che, invece, le sovrastrutture politiche dei re, dei governatori, delle varie autorità provavano a tenere ben levati, per impedire rapporti distesi, per precludere i contatti e appoggiare il potere sulla paura. I Polo, naturalmente, abituati a confrontarsi e a non avere pregiudizi, erano vaccinati, immuni da queste costrizioni psicosociali, e non potevano esserne ingabbiati. Provenendo da Venezia, Marco non si meravigliava più di tanto della promiscuità: le mescolanze etniche, le commistioni di lingue, il profluvio di merci dovevano sembrargli cose del tutto naturali. Forse, solamente la sovreccedenza di pellegrini era per lui insolita, la quantità di cristiani che prendevano d’assalto i Luoghi Santi. I fedeli scendevano a Giaffa da battelli che avevano schivato la fila degli scogli parallela alla costa. Oppure sbarcavano al porto acritano, più accogliente ma anche più lontano da Gerusalemme. Se l’attracco era difficoltoso, piccole imbarcazioni facevano la spola fra i traghetti ancorati al largo e la terraferma. Sbarcati in Palestina, i peregrini si gettavano in ginocchio a baciare e venerare la Terrasanta, anche per ringraziare Iddio dell’avvenuta realizzazione d’una prima tranche del viaggio. Ciascuno pagava una tassa, e contribuiva ad alimentare un più che proficuo turismo religioso, basato sulla rete di xenodochia e hospitalia che assicuravano una sistemazione alberghiera. I gestori del servizio d’accoglienza erano sovente gli ordini monastico-cavallereschi, destinatari di munifiche e frequenti largizioni che andavano ad accrescere patrimoni già cospicui. Contando sulla disponibilità di grossi capitali, i templari (e in misura inferiore i giovanniti e i teutonici) avevano fondato un’attività bancaria che ben presto dovette condurli al prestito di denaro con tassi d’interesse elevatissimi: la Militia Templi era insomma un 142
riferimento importante per le imprese finanziarie di parte tanto islamica quanto cristiana. Il denaro serviva, talora, a costruire o a ristrutturare santuari e parrocchiali, in metropoli o villaggi: l’attivismo edilizio d’età crociata disseminerà infatti di monumenti il cammino ad Loca Sancta. Guardando le grandiose testimonianze della cristianità, Marco Polo dovette perciò avvertire la veridicità delle parole di Giacomo da Vitry: «Da quel tempo [il 1099]», aveva scritto il vescovo di Acri, «la Chiesa d’Oriente cominciò a fiorire rafforzandosi, e a spandersi il culto religioso nelle parti di Oriente. La vigna del Signore [...] cominciava a germogliare nuovi grappoli [...]. Dalle diverse parti del mondo, da ogni tribù e lingua, da ogni nazione che sta sotto il cielo, i pellegrini votati a Dio, e uomini religiosi confluivano verso la Terrasanta, attratti dall’odore dei Santi e Venerabili Luoghi. Si riparavano le vecchie chiese, se ne fabbricavano di nuove; si costruivano i monasteri dei religiosi in luoghi idonei, mediante le elargizioni dei Principi e le elemosine dei fedeli; venivano disposti sufficientemente e opportunamente i ministri delle chiese ed altre cose appartenenti al servizio e al culto divino. Uomini santi, rinunciando al mondo, attratti da vari affetti e desideri, e accesi dal fervore religioso, si sceglievano luoghi convenienti al loro scopo e più adatti alla loro devozione». Se per Niccolò e Matteo tutto quello era un déjà-vu, per Marco Polo si trattava invece di un composto speciale di umanità e religiosità, in cui la robustezza della fede (e degli edifici di culto) andava al di là delle guerre che c’erano state, o che erano in corso. A prescindere dal possesso momentaneo, dalla disponibilità mamelucca o franca, le basiliche e i sacrari non cessavano d’accogliere uomini mossi da un’intensissima pietas. E non solo da quella. 143
3 | Su e giù per la Palestina Un lago di sole, stordente, al punto da affogare i rumori di fondo della città. La pietra abbacinante delle pareti. I conci squadrati e perfetti. I riflessi avoriati. E il chiasso, a diluirsi nel silenzio. Il chiarore, a raccogliersi nella dimensione fioca delle arcate ogivali, delle nicchie, dei tabernacoli. La luce che a fiotti, immobili, zampillava dalle finestre, e che dipingeva bagliori nel buio, titillava l’oro dei mosaici. A Gerusalemme, la basilica del Santo Sepolcro era stata recuperata in età crociata dalla devastazione a cui l’aveva condannata nel 1009 al-Hakim, il califfo fatimide d’Egitto, il persecutore, sciita, di cristiani, ebrei e musulmani sunniti. L’Anastasis (o Resurrezione) non era più il santuario fondato dall’imperatore Costantino il Grande nel IV secolo. I restauri apportati entro il 1048 – per la pietosa dedizione degli imperatori bizantini Romano Argiro e Costantino Monomaco – avevano in qualche misura anticipato le intense ristrutturazioni susseguenti alla conquista franca del 1099. All’originaria rotonda costantiniana, le maestranze del regno latino di Terrasanta avevano soggiunto strutture architettoniche che in un organismo omogeneo conglobavano la Tomba del Salvatore, la Roccia del Calvario, il sacello dell’Invenzione della Croce e diverse altre cappelle votive. La facciata d’ingresso, spostata sul lato meridionale del complesso basilicale, era stata articolata in un doppio portale colonnato, scompartito in due ordini ed esuberante di squisite sculture. In una lunetta troneggiava l’affresco della Vergine col Bambino. Gli architravi pullulavano invece di rilievi con scene evangeliche e ornamenti fantastici: a sinistra erano riprodotte la Resurrezione di Lazzaro, l’Entrata di Gesù in Gerusalemme e l’Ultima cena con gli apostoli; a destra era effigiata una folla di 144
uomini nudi, e uccelli, animali immaginari, un centauro armato d’arco e una sirena, che tutti si contorcevano fra le spirali di un tralcio a foglie e pampini, figurando i malcostumi da cui l’umanità doveva mondarsi. Nel varcare la soglia del tempio, nel rimirare tutte quelle figurazioni fantasiose, Marco Polo ritrovava le narrazioni sull’Oriente che tante volte aveva ascoltato a Venezia. Dentro, le decorazioni scultoree, gli incensi galleggianti nella penombra, lo scintillio delle iscrizioni auree, il bisbiglio delle preghiere non cessavano di carezzare i sensi e avvolgere morbidamente l’intelletto in un involucro di suggestioni. Fulcro dell’anelito spirituale, la Sacra Edicola sormontata da una cupola si offriva ancora ai visitatori in una bellezza del tutto corrispondente al giudizio di al-Idrisi, il geografo che nel 1154 l’aveva definita «una delle meraviglie del mondo». Il tempietto che gloriava la sepoltura di Cristo non possedeva finestre, ma era illuminato da lampade che gli pendevano sul fronte. Fra queste ce n’era una che, a leggere i Viaggi (immaginari) di Giovanni da Mandavilla (ovvero Jehan de Mandeville) del XIV secolo, «rimane sempre accesa, e ogni venerdì santo si spegne da sola, per poi riaccendersi nel momento stesso in cui nostro Signore risuscitò dalla morte». Era là, era quello il «tesoro», l’olio consacrato che doveva contentare il gran khan Kubilai, rispondere alle sue attese, soddisfare le sue pretese. Niccolò, Matteo e Marco se ne procurarono una dose sufficiente. E ripartirono. La circospezione era d’obbligo. La cautela, la sapienza, l’esperienza pregressa di formidabili traversate in regioni inesplorate improntavano ogni passo dei tre viaggiatori, nell’ulteriore esacerbarsi delle tensioni fra i Mamelucchi di Baibars, gli Inglesi di Edoardo e i Mongoli di Abaqa. Il sultano d’Egitto puntava a levare il respiro alle piazzeforti 145
crociate, a fare terra bruciata attorno alle città portuali, impoverendone con regolare inesorabilità l’entroterra, e tagliando le vie commerciali: togliendo insomma il sangue alle malconce colonie cristiano-occidentali. I Franchi, dal canto loro, non avevano più né la coesione né la forza necessarie a ostacolare l’asfissiante pressione mamelucca. Incedere per le province del Vicino Oriente richiedeva dunque oculatezza, saggezza, scaltrezza. Bisognava sapersi muovere schivando gli eventuali pericoli. Conveniva raggiungere le mete prescelte anche allungando il cammino, anche a costo di fatiche supplementari, qualora si profilasse il rischio di incocciare una linea bellica, o di cadere in un’imboscata, di ritrovarsi alla mercé dei briganti. I Polo si spostarono, guardinghi, per paesi in cui un’agitazione epidemica indiziava il rombo imminente della guerra. Superarono indenni contrade dove le rovine fumanti erano le sole scorie, ancora calde, di saccheggi sconvolgenti. E poterono infine entrare a Lajazzo. Non si immisero però immediatamente sulla carovaniera per il Levante. La recente evoluzione delle vicende palestinesi doveva sollecitare infatti i tre veneziani a ridiscendere in Terrasanta. Li attendeva San Giovanni d’Acri. Tranne che fra il 1187 e il 1191, quando era stata occupata dal Saladino, la città costituiva dal 1104 non solo il principale scalo commerciale degli Stati crociati, ma anche una delle più movimentate stazioni di transito dei pellegrinaggi, lungo gli itinera hierosolymitana per Gerusalemme, Betlemme, Nazareth e il fiume Giordano. Prevalentemente in primavera (poco prima della Pasqua) o in autunno, i navigli che facevano la spola sulle rotte mediterranee riversavano sui moli acritani folle di pellegrini, che qui trovavano infrastrutture idonee all’accoglienza. La funzione del centro portuale 146
era cruciale, tanto per il compimento della visita dei Luoghi Santi quanto per disbrigare le pratiche di rimpatrio dei fedeli. Il passaggio di folle pellegrinanti aveva generato un sostanziale apporto di capitale, stimolando i commerci e ampliando il settore dei servizi, in un processo di crescita economica che si abbinava allo sviluppo urbano e all’incremento demografico. Marco Polo poté osservare taverne, alberghi, negozi grondanti di souvenir e di oggetti devozionali, e uffici per le prestazioni religiose o finanziarie, agenzie per il trasporto di bagagli e persone, interpreti, guide, notai, scorte armate. Le strade cittadine, scandite dall’imponenza di chiese maestose o dalla grazia di oratori raccolti, apparivano talora bordate dai banchi che allineavano le merci più svariate. Ciascun mercante sapeva come ritrovare volti amichevoli o dialetti familiari nei grossi quartieri occupati dalle comunità dei compatrioti. I Veneziani, ad esempio, risiedevano in un’area quadrangolare che, solcata da una grande ruga (arteria principale) mediana, era prospiciente alla costa orientale. Il bailo, in rappresentanza del governo dogale, vi possedeva un proprio palazzo e sovrintendeva alle attività di un rione che annoverava una chiesa dedicata a san Marco, una parrocchiale intitolata a san Demetrio e una sfilza di botteghe, residenze, cisterne, torri, prigioni, depositi comuni e loggiati su cui si ergeva, superbo, il gonfalone marciano. A tutti gli effetti, quei dodicimila metri quadrati d’abitato costituivano un’appendice del dogato fuori Laguna, un pezzo di Venezia trasposto in Oltremare. Non era da meno l’insediamento acritano di Genova. Gli scavi archeologici hanno in effetti rinvenuto nella zona di competenza genovese un’impressionante strada commerciale coperta, lunga 150 metri. Le ricerche condotte alla riscoperta dei monumenti crociati hanno poi evidenziato, 147
a una profondità di circa quindici metri dall’attuale piano di calpestio, la cittadella militare appartenente all’ordine degli ospitalieri di San Giovanni, con architetture solenni, sale voltate e un cortile impostati su preesistenze ellenistiche (e che, a loro volta, saranno seppelliti da strutture tardo-ottomane, dalla Prigione Britannica e da più recenti rimaneggiamenti). L’archeologia ha rilevato inoltre un ulteriore settore urbano riservato alla vendita di oggettistica confezionata per il turismo religioso, mentre nella zona di Montmusard è riemerso un grande edificio termale pubblico. Il rinvenimento di dimore e rivendite, integre talora fino a due piani, ha contribuito a chiarire un assetto urbanistico pianificato nei secoli medievali con l’ausilio di un evoluto sistema di drenaggio sotterraneo. E a protezione di una cittadinanza variegata e indaffarata, che si frammischiava alla proteiforme provenienza dei flussi pellegrinanti, si ergevano le salde fortificazioni urbiche, quelle che avevano salvato Acri dai ripetuti assalti mamelucchi, condotti fra il 1263 e il 1269. Al riparo delle poderose mura acritane, Marco, Niccolò e Matteo Polo dovevano ricevere delle nuove consegne da parte del papa. E due nuovi compagni di viaggio.
4 | Crociate d’inchiostro Gregorio X era sinceramente preoccupato per la Terrasanta. Vi aveva dimorato a lungo. Si era accorto che il regno latino vacillava paurosamente, e che l’usurata presenza occidentale svaporava giorno dopo giorno. L’angoscia per le sorti della Palestina cristiana travagliava il papa. Nel suo quinquennio di pontificato, la sua abnegazione dovette quindi 148
profondersi nel restituire l’antica lena alle crociate, e nel recuperare il terreno perduto con appelli insistiti agli ordini religioso-militari, alle città mercantili e ai governi principeschi. La riorganizzazione di un’offensiva contro gli infedeli, la preparazione della riconquista passavano attraverso la stesura di piani sistematici e responsabili pro defensione Terrae Sanctae: e tempestivamente il pontefice ne predisporrà una disamina al Secondo Concilio di Lione, nel maggio del 1274. Alla convocazione conciliare risponderanno Paolo di Segni, vescovo di Tiro; una folta delegazione di prelati d’Oriente; Giacomo I d’Aragona (1213-1276), monarca senescente eppur bramoso di avventure armate; Guglielmo di Beaujeu, gran maestro dei templari; e i messi di Michele Paleologo, il quale paventava brame (e trame) angioine, e perciò sarebbe stato anche disposto a ricomporre il vecchio scisma, riconducendo all’obbedienza di Roma la Chiesa di Costantinopoli, pur di proteggersi dagli Angiò. Persino dall’il-khanato mongolo giungeranno dei delegati di Abaqa (e due di loro saranno pure battezzati dal vescovo di Ostia, il futuro Innocenzo V): alla sensibilità dell’il-khan per le problematiche cristiane non era d’altronde estraneo l’operato del domenicano David d’Ashby, che già dai tempi di Hülegü prestava servizio alla corte il-khanide, dove lo aveva inviato il patriarca Tommaso di Lentini. Ma i pezzi grossi della cristianità europea, il re di Francia Filippo III l’Ardito (1270-1285), e il re d’Inghilterra Edoardo I (1272-1307), a Lione non arriveranno mai. L’uno negandosi recisamente, l’altro motivando l’assenza con le impellenze dovute agli affari interni al suo regno d’Oltremanica. Le defezioni delle corone francese e inglese evidenziavano la disaffezione dell’Europa per un ideale crociato inattuale, insensato, superfluo. Rivelavano la sfiducia ormai radicale e irreversibile nelle possibilità di un riscatto dei ter149
ritori siro-libano-palestinesi. Mostravano, insomma, l’insufficienza di motivazioni, per un Occidente benestante e in pieno sviluppo economico, a impelagarsi in conflitti dispendiosi e sterili, inutilmente agganciati a presupposti pseudoreligiosi: del resto, i musulmani non intendevano certo impedire e, di fatto, non limitavano le visite ai Luoghi Santi, fonte di guadagno costante e sostanzioso per il giro di affari connessi al pellegrinaggio. Lo stesso Marco Polo aveva sperimentato personalmente che la Gerusalemme dei Mamelucchi era agibile, che il Santo Sepolcro era praticabile, e che vi si poteva addirittura prelevare l’olio delle lampade sacre. Le ragioni del cristianesimo non possedevano più una forza e un grado di consistenza tali da giustificare un intervento plenario di crociati euro-occidentali in Medioriente. Dal campo di battaglia, dunque, la questione dell’Oltremare si sposterà sul piano della speculazione. Il clangore degli scontri armati traslocherà sul candore eburneo della carta, e le crociate si faranno d’inchiostro, producendo una vivace letteratura de recuperatione Terrae Sanctae. Il dibattito impegnerà in una feconda trattatistica il pensiero di un Raimondo Lullo (predicatore catalano), di un Fidenzio da Padova (frate francescano esperto di missioni diplomatiche), di un Ricoldo da Montecroce (missionario domenicano), di un Galvano da Levanto (medico della curia papale), di Benedetto Zaccaria (ammiraglio genovese), di Pietro Dubois (consigliere alla corte di Parigi), di Haython l’Armeno (monaco premostratense), di Marino Sanudo il Vecchio (cronista veneziano), di Giacomo di Molay (gran maestro del Tempio) e, più avanti, di Filippo di Mézières (mistico sognatore di nuovi ordini cavallereschi). Ancora nel Cinquecento il protestante François de la Noue, e nel Seicento Pietro della Valle, produrranno scritti crociatistici. 150
Di pagina in pagina, di elucubrazione in elucubrazione, si tirerà in causa, per spiegare le sconfitte, l’apporto negato da Dio alle armi dei peccatori cristiani, propensi a combattere più per la gloria personale che per il trionfo di Cristo. Si criticherà aspramente la condotta di ospitalieri, templari e teutonici, tacciati di avidità e mondanità, e si auspicherà una ridefinizione dei loro compiti e dei loro assetti associativi. Ci si scervellerà nell’escogitare l’itinerario terrestre o la rotta acquatica più adeguata al conseguimento della vittoria, e si proporrà di affidare ora a questo ora a quel sovrano il comando di spedizioni molto virtuali. Decine di teorie, virate ora in un senso ora nell’altro, si accavalleranno spesso confusamente fra il XIII e il XIV secolo. Ma una formulazione realistica, concretizzabile, risolutiva non potrà evidentemente più sbocciare, nonostante la passione intellettuale di laici ed ecclesiastici, e malgrado gli sforzi di Gregorio X: su iniziativa papale tornerà in auge finanche il prelievo della «decima» sui redditi, la tassa che avrebbe dovuto finanziare gli eserciti per future crociate. Invece, le crociate non decolleranno mai più. Preso dall’ansia di salvare il prestigio cattolico, avvinghiato idealmente al regno latino di San Giovanni d’Acri e aggrappato con tutta la sua fede alle speranze di un recupero della Terrasanta, il pontefice non voleva lasciare nulla d’intentato. Qualsiasi appiglio, ogni sostegno avrebbe potuto aiutare la Chiesa romana a risollevarsi dalla prostrazione. Anche dei contatti – per vaghi che fossero – con un gran khanato mongolo remoto e abbastanza ignoto. Pertanto a Marco, Niccolò e Matteo Polo, che si accingevano a ritrovare il Levante, furono consegnate credenziali pontificie e vennero aggregati due domenicani, in rappresentanza dei sapienti europei richiesti da Kubilai. Due, 151
non un gran numero. Ma insomma Niccolò da Vicenza e Guglielmo di Tripoli dovevano essere almeno dei frati ben preparati e dotti, visto che il secondo avrebbe redatto nel 1273 il De statu Saracenorum et de Mahomete pseudopropheta eorum et eorum lege et fide. La mera preparazione dottrinaria, però, non sempre soccorreva fisicamente ed emotivamente. L’erudizione poteva sciogliersi in sgomento e debolezza, dinanzi alle prospettive di incorrere nella mischia di una guerra, di fronte al rischio di attraversamenti malsicuri fra le province insanguinate da un conflitto. E infatti mollarono, i monaci che andavano coi Polo, interruppero il viaggio ai primi echi delle baruffe che, fra il novembre e il dicembre del 1271, dovettero contrapporre in Siria i Mamelucchi di Baibars ai Mongoli di Abaqa. Il cedimento dei domenicani, la rinuncia degli ambasciatori selezionati dal papa, così prematura, quasi brusca, lasciava il palcoscenico ai soli Marco, Niccolò e Matteo. Era un abbandono che scontornava ancor meglio i tre veneziani quali protagonisti assoluti dell’avventura, e che li sollevava di una spanna su tutto e tutti, ne rimarcava il coraggio, tanto più vivido se paragonato alla fragilità di accompagnatori pusillanimi. Nell’esegesi che Valeria Bertolucci Pizzorusso fa dei testi marcopoliani, la sottolineata défaillance dei monaci risponderebbe esattamente all’intento dei Polo di auto-celebrare la propria fermezza e tenacia. Anzi, si potrebbe ben dire che ad essere celebrata era l’immagine del mercante duecentesco, l’homo novus che, riconsiderando le proprie specificità in una versione contemporanea, aggiornata, attagliata a un’epoca di rivoluzione commerciale, rappresentava il nuovo eroe senza paura, pronto a lanciare il cuore oltre l’ostacolo, a proiettarsi laddove nessuno aveva mai avuto l’ardire di andare. L’esplosione dei commerci ave152
va offerto ai mercatores le chiavi per penetrare il mondo, i suoi segreti, le sue meraviglie. Ed esplorare universi inediti, conoscere gli altri per conoscere meglio se stessi, valeva a surrogare, a traslare nella modernità il mito dei cavalieri della Tavola Rotonda. Il traguardo era la visione senza veli del Levante, e il raggiungimento di una piena coscienza di sé. Il Graal era il Catai. E Marco Polo era Perceval.
Capitolo ottavo
PAESI DA MILLE E UNA NOTTE
1 | Petrolio Veniva fuori a fontana. Gorgogliava scuro e spontaneo dal suolo. E allagava, ungeva. Ma nonostante facesse del terreno una poltiglia marcia, giungevano da lontano a captarne il gettito individui d’ogni risma. Nei distretti posti fra gli odierni Iraq settentrionale, Georgia, Azerbaigian e Mar Caspio, il petrolio premeva dal sotterra, tracimando dai pertugi delle rocce che non avevano lo spessore per resistergli. Marco Polo rimase affascinato da quel fenomeno naturale, e un po’ si sbalordì per l’esubero di un liquido che avrebbe potuto riempire tantissimi grandi contenitori tutti insieme. Che l’olio minerale non fosse buono per gli alimenti lo si deduceva facilmente dal puzzo che emanava. Però era adatto a lenire le malattie della pelle: anche i ricettari di medicina elogiavano le proprietà curative dell’olio di pietra o olio di sasso. E poi prendeva fuoco in un attimo, bruciava che era una meraviglia: requisito di fondamentale rilevanza in territori aridi e pietrosi, dove si suppliva alla carenza d’alberi e di legname con lo sterco di vacca che, impastato con paglia triturata, veniva essiccato sotto forma di mattonelle. Procedendo dai dipartimenti cilici dell’Armenia Minor, i Polo avevano saggiato quanto brullo e spettrale potes154
se diventare, per lunghissime settimane, il paesaggio che menava all’Anatolia orientale, verso il plateau incasellato fra i laghi Sevan, Van e Urmia. Quasi epicentrico rispetto ai bacini lacustri, il massiccio dell’Ararat sorpassava le nuvole con la sua cima candida di nevi, e nella solennità della sua natura evocava la leggenda dell’Arca di Noè, ergendosi a baluardo visivo per piste sabbiose schiaffeggiate dal vento, o per sentieri scoscesi rasentati dai crepacci. Nel loro orientarsi fra gli altopiani anatolici e le montagne armene Niccolò, Matteo e Marco avevano costeggiato villaggi rupestri semifusi nei fianchi dei canyon: in un’unica coloritura rocciosa, sfumata d’ocra, gli occhi di porte e finestre si spalancavano allora su gole vallive, e quel poco d’apporto pluviale annuo concentrava per gravità nei fondovalle irrigui una verzura che raccoglieva l’operosità umana. L’acqua fondava la vita, e quindi anche i bordi dei torrenti erano fonte generatrice di vichi e caseggiati sparsi. Guadare i fiumi, traghettare dall’una all’altra proda era possibile a volte con delle zattere, equilibrate da otri in pelle di capra gonfi d’aria, e a volte transitando sui ponti monumentali, a uno o più fornici e con le corsie modellate a schiena d’asino, che i regnanti Selgiuchidi avevano commissionato alle esperte maestranze locali. In una geografia comunque ruvida, di scogli affioranti su mari di sterilità, di faticose coltivazioni e di molta pastorizia transumante, l’incognita dei briganti era un ulteriore fardello da portarsi appresso. Il ristoro da apprensioni e dannazioni lo fornivano i caravanserragli che, ogni trenta o quaranta chilometri, potevano ospitare in complessi spesso fortificati i viandanti, le loro mercanzie e le bestie da soma. I Polo vi dimorarono con frequenza, trovando la protezione talora di modesti ospizi, e talvolta di mura che, intervallate da semitorri sporgenti, si aprivano in un unico ingres155
so, imponente, propedeutico a una corte quadrangolare circondata da porticati. In mezzo al cortile poteva ergersi un’edicola-cappella a due piani, e tutt’intorno si disponevano gli spazi per merci, animali, persone. In asse con l’ingresso e il tabernacolo si innestava, sulla parete opposta all’entrata, un vasto salone basilicale, che aveva sovente la navata mediana sollevata e presentava una cupola sul tiburio. L’impiego sapiente di conci litici ben levigati, di volte cuspidate e apparati scultorei finissimi derivava dalla mancanza di legno da costruzione, che aveva affinato le capacità degli Armeni di lavorare e mettere in opera il pietrame soverchiante. Così, regolari e omogenee, apparvero ai tre viaggiatori veneziani anche le pareti delle fortificazioni cittadine, dei castelli extraurbani e delle torri d’avvistamento, che in lande spesso depresse presidiavano il territorio e, attraverso segnalazioni visive, creavano i nodi di un sistema integrato di comunicazione a distanza. Alla configurazione territoriale contribuivano pure i monasteri, isolati sui costoni delle forre, o spersi in fondo a dirupi, o ancora immersi nel cuore oscuro di qualche foresta, oppure in bilico sugli isolotti emersi dalle conche lacuali d’altopiano. Nemmeno i conventi disdegnavano orlature turrite, che cingevano la pacata quotidianità di oratori, refettori, mausolei, cucine, campanili, orti, celle, cimiteri, biblioteche e gavit, ampie sale (coperte spesso da archi incrociati) antistanti alla chiesa maggiore, la cui funzione liturgica era abbinata all’esercizio dell’amministrazione e all’esplicazione del magistero scolastico, a un livello sovente universitario. I cenobi armeni erano infatti rinomati per i loro scriptoria, che iterando una tradizione già consolidata nell’Alto Medioevo copiavano e producevano nel XIII secolo codici miniati di splendida fattura. Nei laboratori monastici di Ske156
vra, di Drazark o di Hromkla, l’arte della miniatura si esprimeva in decori che amalgamavano il registro geometriconaturalistico con una potente visionarietà fatta di mostri e paesi immaginari. Per merito del miniaturista Toros Roslin, poi, al repertorio classico s’erano congiunti nel Duecento i volti umani e le figure divine, la cui espressività animava l’armonia dell’impianto coloristico di base. All’euritmia cromatica erano del resto ispirate nell’Armenia Maior anche le figurazioni dei tappeti, che a Marco Polo dovettero sembrare i migliori del mondo: a sublimare l’allevamento ovino e serico, lana e seta venivano effettivamente tinte con coloranti naturali, e subivano un pregevole e paziente processo di tessitura. A lavaggio avvenuto, l’asciugatura al sole tappezzava i terrazzi degli opifici con policromie che rompevano la monotonia dei caseggiati, giallognoli d’argilla (nelle pareti) e di terra battuta (nei tetti), e dunque mimetici a un circondario semidesertico. E negli spacci dei centri urbani o dei paeselli i venditori andavano a imbandire le loro tappezzerie affinché le chiese, le moschee, i settori più importanti delle abitazioni potessero impreziosirsi proprio coi drappi di manifattura armena, esemplari di una civiltà vocata alla bellezza. Testimoni di un’innata predisposizione degli Armeni per l’artigianato artistico erano pure i khatchkar (termine che significa «croce di pietra»), segnacoli litoidi di dimensioni variabili che, disseminati dovunque, piantati a migliaia come tanti menhir, venivano posizionati con la fronte a occidente e traducevano un’inestinguibile identità religiosa: avevano in effetti un significato commemorativo, funerario o votivo. Il macramè scolpito nei blocchi incastonava perciò i simboli cristiani in un traboccare di circonvoluzioni islamizzanti, fra intrecci fitomorfi e geometrie tanto ossessive 157
quanto eleganti, che potevano attingere o comunque assimilarsi ai disegni ornamentali degli stessi tappeti. Tutte quelle lastre scolpite conferivano talora un’aura sacrale alle contrade armene, un che di misterioso e fatato, che magari predisponeva il giovane Marco ad accostarsi con più curiosità alle leggende sulle gesta di Alessandro Magno nel Caucaso, o alla favola del monastero dedicato a san Leonardo, ubicato presso un lago in cui i pesci comparivano solo nel periodo di quaresima, mentre si eclissavano durante tutto il resto dell’anno. Re, eroi, vescovi, cittadine, fauna esotica: i Polo osservavano, orecchiavano, annotavano talvolta quanto appreso in una locanda, in una stazione per il pernottamento, nel mercato di un capoluogo. Ed ebbero così contezza della famigerata setta degli Assassini.
2 | La setta degli Assassini Da quando Hasan-i Sabbah, sullo scorcio dell’XI secolo, ne aveva insediato le prime roccaforti fra gli impervi crinali del Gilan, del Mazandaran e del Dailam, a sud del Caspio, la loro fama aveva preso a serpeggiare in tutto il Vicino Oriente. Gli Ismailiti erano una fazione islamica di ispirazione sciita che, nelle intenzioni del suo fondatore, doveva instaurare un nuovo ordine politico, sociale e religioso, rivoluzionando l’assetto istituzionale che i Selgiuchidi, da sunniti ortodossi, avevano conferito alla Persia. Dalla fortezza di Alamut, fra i monti Elburz, la dottrina ismailita – dall’imam Ismail, riconosciuto discendente di Maometto e perciò legittimato a succedere al Profeta nella guida dell’islam – prese ad essere propagandata con persistenza nelle province mediorientali. Ata158
Malik Juvaini, scrittore persiano del pieno Duecento, racconta che per imporre la sua legge e istituire un regno indipendente il gran maestro della setta «conquistava la gente con la propaganda, mentre i luoghi che rimanevano indifferenti alle sue lusinghe venivano espugnati con massacri, stupri, guerre e spargimento di sangue». Princìpi di rigoroso egualitarismo innervavano un movimento rivoluzionario che aboliva ogni gerarchia censuale, e all’interno del quale tutti divenivano semplicemente rafiq, compagni. Un energico indottrinamento, una preparazione maniacale e una completa dedizione alla causa rendeva i devoti fida’i dei formidabili strumenti per attuare ogni genere d’attentato: «Con l’impostura dell’inganno», è sempre Juvaini a riferire, «e con la bricconeria della falsità, con assurdi preparativi e menzognere frodi si gettarono le basi per l’organizzazione degli adepti». Sin da subito, pertanto, il ricorso all’omicidio diventò il fondamento dell’azione politica di coloro che, per l’intermediazione crociata, saranno conosciuti in Europa col nome di «Assassini», derivato dall’arabo Hashishiyyun. Era un epiteto che i musulmani, in genere, utilizzavano per connotare negativamente un individuo, ma che con superficialità e fantasia si è voluto legare alla parola hashish: si è erroneamente immaginato infatti che i membri della setta fondata da Hasan-i Sabbah consumassero questa sostanza allorché venivano segretamente invitati dai loro capi a pregustare, sotto l’effetto della droga, le delizie che avrebbero assaporato nei giardini del Paradiso al compimento delle missioni. Marco Polo, percorrendo le regioni della Persia settentrionale, sentì parlare del «Vecchio della Montagna» che aveva creato fra picchi asperrimi il giardino più bello e più grande del mondo. Il ragazzo memorizzò per filo e per segno le dicerie che indugiavano sulla soavità di fanciulle e 159
fanciulli dediti a cantare, a suonare e a ballare in un eden dorato di palazzi meravigliosi, di alberi guarniti di tutti i frutti, e di uccelli canterini e animali ammansiti dal fluire di acque cristalline, di miele, di vino. Si persuase, il giovane veneziano, che il capo della comunità ismailita fosse venerato come un grande profeta e che esercitasse sui suoi adepti un ascendente talmente forte da indurli facilmente a compiere qualsiasi assassinio: i suoi seguaci sarebbero stati disposti a tutto pur di ritrovare, in un modo o nell’altro, da vivi o da morti, il Paradiso assaggiato e perduto. Nel convincimento di Marco, lo stato di totale dipendenza metteva i gran maestri nelle condizioni di sguinzagliare dei sicari per compiere i delitti più eclatanti. Travestimenti, agguati, omicidi minuziosamente architettati erano il marchio distintivo degli Assassini, guardati con quella sorta di sospettosa deferenza che si riserva ai praticanti di rituali esoterici, ai depositari di saperi «altri» e inaccessibili per la gente comune: la straordinaria lucidità con cui uccidevano e la dedizione quasi sacrale che ponevano nell’assassinare li distaccavano dalla normalità, li rendevano demoniaci, temutissimi dappertutto. Le circoscrizioni iraniche, le province siriane avevano tutte misurato l’efferata esattezza delle nefandezze ismailite, rivolte indifferentemente contro musulmani o cristiani, a seconda delle alleanze momentanee e della temperie politica: e se il Saladino era scampato fortuitamente ai pugnali assassini, al contrario Corrado di Monferrato, erede designato al trono di Gerusalemme, non aveva avuto altrettanta fortuna: era stato sbudellato, a stilettate, in una chiesa, nel 1192, dai sicari di Rashid al-Din Sinan, signore degli Ismailiti di Siria. Per Guglielmo di Tiro (circa 1130-1186), fra i più famosi cronisti dell’epoca delle crociate e autore di una Historia rerum transmarinarum, «Se, per esempio, un principe è mal visto da 160
questo popolo, il capo consegna un pugnale a uno o più seguaci. Colui che ha ricevuto l’ordine agisce immediatamente, senza considerare le conseguenze delle sue azioni, e senza curarsi della possibilità di fuggire. Ansioso di svolgere il suo compito, lavora alacremente finché non gli si presenta l’opportunità di obbedire agli ordini del suo signore». In viaggio, Marco Polo apprese che molti governi avevano dovuto versare tributi per allontanare la minaccia dei seguaci di Hasan-i Sabbah, e che per oltre un secolo e mezzo la setta aveva imperversato a proprio piacimento. Poi erano arrivati i Mongoli di Hülegü, che nel 1256 avevano intrapreso un sistematico smantellamento delle rocche ismailite espugnandole, abbattendole coi picconi e, se non bastava, incendiandole. Aveva capitolato anche Alamut, il caposaldo principe, innalzato su una stretta cresta fra orridi strapiombi, non lontano dall’attuale città iraniana di Qazvin. Solo un sentiero ripidissimo, intagliato in una gola vertiginosa, saliva alla «fortezza proibita», che era stata munita di muraglie enormi e dotata di un progredito sistema idrico, atto a irrigare una vegetazione che veramente doveva ricreare ambientazioni paradisiache. Per spiegare la possanza del castello, niente è forse più efficace della descrizione tramandataci da Juvaini, che al seguito delle armate mongole era stato incaricato di sovrintendere al fortilizio prima che esso venisse definitivamente decastellato (ed è per questo che poté salvarne parte della imperiosa biblioteca): «In verità», scrisse lo storico, «era un castello le cui entrate e uscite, salite e punti di approccio, erano stati così rafforzati da mura intonacate e da bastioni coperti di piombo che, quando lo si stava demolendo, era come se il ferro battesse la testa su una pietra; ed era sprovvisto di tutto, eppure resisteva ancora. E nella cavità di quelle rocce gli Ismailiti avevano costruito pa161
recchie gallerie lunghe, ampie e alte, e profonde cisterne, facendo a meno di usare pietra e malta. In ugual modo avevano scavato magazzini e serbatoi per vino, aceto, miele e ogni sorta di liquidi e solidi. E l’arte dei demoni tutti si scorgeva in questa struttura come prodotto del lavoro manuale di uomini. Quando si stavano saccheggiando e portando via le sue scorte, un uomo scese nella cisterna del miele per guardarla, senza rendersi conto di quanto fosse profonda, e ancor prima di accorgersene si ritrovò immerso nel miele come Giona. E dal fiume vicino avevano portato una conduttura sino ai piedi del castello, e di là un condotto era stato tagliato nella roccia in mezzo al castello e cisterne simili a oceani, anch’esse di roccia, erano state costruite al di sotto, cosicché l’acqua vi si raccogliesse per il proprio impeto, e affluisse continuamente. La maggior parte di queste provviste di liquidi e solidi, che avevano accumulato sin dai tempi di Hasan-i Sabbah [...] non mostrava segni di deterioramento, ed essi consideravano ciò un effetto della santità di Hasan». Per un vecchio decreto di Gengis Khan, gli Ismailiti che s’erano arresi o consegnati all’esercito mongolo vennero trucidati, senza distinzione di sesso o età. Solamente i loro correligionari di Siria, combattuti e vinti dal sultano mamelucco Baibars, avevano potuto evitare il massacro. Ma da allora l’ismailismo non era stata che un’eresia minoritaria e sempre più dimenticata: finché, nel XIX secolo, la dinastia persiana dell’Aga Khan non ne aggiornerà il ricordo, assimilando la propria stirpe all’imamato ismailita e promuovendo, nel 1977, a Londra, l’Institute of Ismaili Studies, un ente preposto all’approfondimento delle prerogative socioreligiose di un movimento sciita che, troppo frettolosamente e superficialmente, è stato talora giudicato alla stregua d’un gruppo terroristico ante litteram. 162
3 | Viaggiare informati I Mongoli di Hülegü non erano stati rovinosi soltanto per la compagnia degli Ismailiti. L’irresistibile avanzata dei cavalieri delle steppe aveva infatti travolto anche Baghdad, la «Città Rotonda», e con essa il secolare califfato, fulcro dell’ortodossia islamica. Marco Polo sapeva come s’erano svolti i fatti: nei primi mesi del 1258, le orde centro-asiatiche avevano assediato e preso d’assalto la capitale sul Tigri, per poi abbandonarsi a una depredazione e a stragi che erano risultate esiziali pure per il califfo, al-Mustasim. Le cronache narrano di ottantamila trucidati e di pochi, fortunati superstiti, nascosti in cantine sotterranee oppure rifugiati in quelle chiese che la pietà di Dokuz Khatun, moglie cristiana dell’ilkhan, aveva voluto risparmiare da sangue e distruzioni. Qualche fanciulla avvenente, qualche giovinetto di palese gagliardia erano stati resi schiavi, e s’erano perciò salvati. Per gli altri, neonati compresi, non era valsa alcuna compassione, nessuna speranza di sopravvivere. Dopo una quindicina d’anni, al passaggio dei Polo in Iraq, l’antica metropoli califfale si stava appena riprendendo dai patimenti. I palazzi apparivano scrostati dalle lucenti tarsie in marmo. Le strade soffrivano ancora delle macerie non rimosse. Per la mancanza di arredi, per la polvere mulinante ovunque, si faceva fatica a credere che quella potesse essere stata la casa-madre dell’islam sunnita. Nondimeno, vi si studiava ancora la legge di Maometto. Vi erano coltivate le scienze della fisica, dell’astronomia, della magia. E nei viali ampi, nelle piazze larghe aleggiava ancora l’anima di una grandezza da risarcire, l’alito di una nobiltà da restituire. Gradualmente si stavano riattivando le manifatture dei broccati con le raffigurazioni zoomorfe, tipiche della tradizione abbaside. Avevano ricominciato a operare le fabbriche dei panni intes163
suti d’oro, mentre le botteghe orafe realizzavano con le gemme indiane prodigiosi gioielli da esportare in Occidente. Le rotte commerciali erano insomma sempre attive, sicché Marco Polo poté appurare come a Mosul (e dintorni) fiorisse l’industria della seta che produceva la mussolina, e come un po’ tutta la regione fosse movimentata da flussi continui di droghe e spezie. Tabriz, a sua volta, richiamava dall’India, dal Medioriente e dall’Europa mercanti che commerciavano in seterie e in stoffe ricamate a filamenti aurei. Quantità esorbitanti di perle e pietre preziose affluivano ad arricchire un’imprenditoria dedita a traffici pressoché perpetui, forieri di grossi guadagni. Chi rimaneva fuori da simili giri, inesorabilmente si impoveriva: e questo dovette apparire ben chiaro al più giovane dei tre viaggiatori veneziani. Così come troppo evidente per non accorgersene era la presenza nelle province persiane di folte comunità giacobite e nestoriane: a quei cristianesimi «alternativi» si erano convertite anche alcune popolazioni curde che, notoriamente avvezze al banditismo, erompevano dai monti del Kurdistan a derubare le carovane in transito. I Polo comunque viaggiavano informati, e per non arrischiarsi in attraversamenti azzardati cercavano – quand’era possibile – di acquisire preventivamente ogni genere di notizia utile all’itinerario. Fra le tante informazioni attendibili era inevitabile che ce ne fossero anche di inventate, emanazioni fantasiose di chiacchieroni contaballe. D’altronde, il gusto del novellare, il piacere del meravigliare il prossimo non era forse connaturato a un paese che aveva partorito favole infinite e che aveva dispensato i racconti trasognati delle Mille e una notte? Non è dunque casuale che il cammino di Marco Polo in Persia sia stato cadenzato da una colonna sonora interminabile di novelle. 164
C’era la storia del califfo che, per la sua avarizia nell’approntare un esercito decoroso, era stato punito dai nemici con la reclusione in una torre traboccante di tesori, dove aveva ritrovato il suo amato denaro, ma dove pure era stato privato del cibo, così da morirvi di fame sguazzando fra immense ricchezze, per contrappasso. C’era poi la leggenda dei Re Magi, le cui spoglie mortali si raccontava fossero rimaste intatte, con tutti i capelli, sepolte nelle tombe di Saveh. Avendo donato oro, incenso e mirra al Bambin Gesù, Baldassarre, Melchiorre e Gaspare ne erano stati ricambiati con un astuccio in legno di bosso, contenente una pietra che, giorno dopo giorno, pareva diventare sempre più pesante. Scagliato in un pozzo, il sasso aveva attirato su di sé la vampa inestinguibile di una folgore piovuta dal cielo: subito trasposta in chiesa, la fiamma sovrannaturale era stata offerta alla venerazione dei fedeli, per transitare in seguito presso il castello di Galasaca e, colà, soddisfare i tanti adoratori del fuoco. Nel magma di tradizioni zoroastriane, di retaggi sciamanici e riti cristiani impastati col mito, i cantastorie si divertivano a narrare di come un vecchio ciabattino si fosse accecato volontariamente per castigare il desiderio peccaminoso suscitatogli dalla vista d’una bellissima donna. Orbo, ma provveduto di sincera fede in Cristo, con la grazia di Dio (e supplicato dal vescovo) il calzolaio era stato l’unico cristiano capace di ottemperare a un’ordinanza califfale, arrivando a smuovere una montagna e salvando così da morte certa i suoi compagni, che erano stati obbligati a dar prova di fede oppure a perire: e sul finale della parabola del pio artigiano cieco, era il califfo stesso che, colpito dalla prodigiosa rimozione dell’altura, si convinceva ad abbracciare segretamente la Croce. Divertito, stupefatto, a volte probabilmente inquietato da tali e tanti racconti, Marco Polo aveva comunque segui165
tato a guardarsi intorno e a suggere le tipicità delle terre persiane. I datteri di Bassora li aveva trovati saporitissimi, e nelle pianure irrigue della Mesopotamia aveva scorto alberi da frutto, vitigni, cotone, frumento, orzo, miglio e ogni genere di biade. Il giovane veneziano s’era entusiasmato per i destrieri di gran pregio, esportati a prezzi elevati in India (tramite i porti del Golfo Persico), e aveva rimirato gli asini iraniani, ancor più costosi, poiché superavano i muli in resistenza, battevano i cammelli in velocità, ed erano quindi particolarmente appetiti dai carovanieri per le traversate dei deserti, allorché l’acqua scarseggiava, i fili d’erba non esistevano quasi, e il nulla, assolato, metteva i brividi, imponeva d’esser travalicato in tutta fretta. I malintenzionati, quelli che s’ingolosivano per il bendidio dei convogli commerciali, i violenti che abbondavano in alcune province, e che mai si sarebbero fatti scrupoli nel derubare o nell’ammazzare, erano tenuti a bada dalla ferrea polizia degli il-khanidi, che con somma severità reprimeva qualsiasi loro misfatto. A ruba andava lo iassi, il tessuto in oro e seta confezionato nella città di Yazd, da cui una pista si dipanava verso sud-est, piacevolmente, fra pianure e boschi frequentati da pernici e altri volatili, e da asine selvatiche. A Kerman fioriva un’industria estrattiva che alla dovizia di turchesi accoppiava la produzione di un ottimo acciaio. La qualità eccelsa del metallo sosteneva fabbriche d’armi, di freni e di selle per le cavalcature, in un lavoro di prevalente competenza maschile. Alle donne spettava invece il ricamo ad ago, con oro e seta, di tende, coperte e guanciali, decorati con immagini ispirate al mondo animale. Sulle alture circostanti al centro urbano volteggiavano dei falchi straordinariamente rapidi, tanto che nessun uccello avrebbe potuto sfuggire ai loro artigli. Transitare in inverno fra i sentieri ghiacciati era un’impresa al limite dell’im166
possibile. Ma una volta lasciato alle spalle il freddo montano, smessi i vestiti imbottiti, la distensione del paesaggio in colline soffuse e in alvei fluviali creava le condizioni climatiche adatte al dattero, al pistacchio e a pomi del tutto introvabili in Occidente. Nelle radure boscose svolazzavano tortore. Fagiani dal piumaggio rossastro e screziato di bianco, bovini dal manto niveo e dalle corna tozze, e montoni sovradimensionati (e squisiti da mangiare) erano provvisori compagni di viaggio. I borghi, coi terrapieni e le fortificazioni, indiziavano paure e banditismi. Una piana ancora e i pappagalli, le palme, l’aria salata annunciavano l’Oceano, il bel litorale, Hormuz. Che i Polo fossero pervenuti sullo Stretto scarpinando per la Persia meridionale, ovvero con un piccolo cabotaggio dalla foce dello Shatt al-Arab, è questione dibattuta. In ogni caso, si trovavano a una tappa importante del loro itinerario.
4 | Un caldo da morire La strozzatura di Hormuz s’espandeva sul mare aperto. Piuttosto che fronteggiare predoni e deserti spietati, invece di optare per itinerari terrestri, i Polo avevano preferito un tragitto acquatico. Non che i pirati fossero dissimili dai briganti: anche i navigli erano bersaglio di rapine, di bruschi assalti, di violenze analoghe a quelle dei ladroni che balzavano dai nascondigli montani, o che magari si celavano nelle tormente di vento e che, fulminei come spettri indemoniati, sbucavano fuori dal vortice della polvere che aveva rabbuiato il giorno: ed era un’esperienza che il candido Marco dovette vivere personalmente nei lunghissimi attraversamenti asiatici, uno sconvolgimento che lo porterà a rifugiar167
si in extremis in un qualche abitato fortificato, col cuore in gola, con l’orrore negli occhi per le catture brutali e per gli ammazzamenti degli amici. A dirla tutta, però, poteva anche succedere – ed erano probabilmente i casi più frequenti – che i banditi si contentassero di prelevare soltanto pochi oggetti dalle carovane e che, dopo aver fermato (più che assaltato) i convogli, li lasciassero poi liberi di proseguire, come se fosse stata semplicemente effettuata l’esazione di un pedaggio: era, quella, una forma di dogana che, pur essendo fuori dall’ordinario, tutto sommato doveva risultare abbastanza abituale e quasi scontata, per dei viaggiatori avvertiti e smaliziati. Per cui un buon carovaniere non trascurava mai di trasportare anche l’oggettistica destinata al pagamento di piccoli tributi, che non erano «istituzionali» ma che, comunque, andavano messi in conto. E tuttavia il navigare dovette sembrare ai Polo un po’ meno faticoso e azzardato del marciare per terra. Le opportunità offerte da uno scalo famoso come Hormuz instillavano maggiore fiducia in un trio di mercanti allevati fra le riviere della Laguna e il tramenio di mercanzie multiformi. Nelle locande addensate attorno ai moli che sporgevano all’imbocco del Golfo Persico, Marco, Niccolò e Matteo si rallegrarono nel mescolarsi ai mercatanti, ai marinai, ai faccendieri che trangugiavano un vino di datteri molto speziato, un intruglio che risultava fortemente lassativo per chi non fosse avvezzo a berne, e altamente ipercalorico per coloro che, al contrario, avevano l’abitudine di ingollarne in quantità: li si distingueva, quest’ultimi, per il fatto che erano piuttosto grassi. Del resto, con temperature che rimanevano infernali per gran parte dell’anno, la dieta incideva notevolmente sulle probabilità di sopravvivenza, specie quando, in estate, spirava a ondate torride il simun, il «soffio pestilenziale» di 168
sabbie ardenti, che poteva essere combattuto soltanto con una completa immersione nelle acque delle oasi viciniori. A tal proposito si raccontava che un intero esercito di soldati del re di Kerman, inviato a esigere tasse a Hormuz, fosse stato disciolto dalla calura ventosa, e che ciascuno dei militi defunti fosse stato seppellito direttamente nella porzione di terreno su cui s’era accasciato: anche a volerne subito spostare i cadaveri in un cimitero apposito, infatti, le gambe, le braccia, le membra semimummificate dal calore si staccavano a brandelli dai corpi, e ne impedivano la pietosa rimozione. A condizioni climatiche inenarrabili corrispondevano quindi costumi nutrizionali del tutto specifici: Marco si accorse che in zona non si mangiava né grano, né carne e tanto meno le pietanze della cucina occidentale. Per salvaguardare la sanità dell’intestino e dell’organismo, le vivande più comuni erano il pesce salato, il dattero e, in genere, i cibi non troppo raffinati, derivanti talora da un’agricoltura ai limiti dell’impraticabilità: qualsiasi coltivazione, avviata in novembre, fruttificava al massimo entro marzo. Poi, non esisteva più niente di vivo, nessun vegetale, a eccezione delle palme, che portavano frutti fino a metà maggio. E magari, il più giovane dei tre viaggiatori veneziani dovette anche domandarsi quanto avesse potuto influire l’inadeguatezza del regime alimentare sulla dipartita di tutti quegli uomini alla cui memoria le vedove del posto scioglievano lamentazioni e lacrime ogni giorno, per anni, assieme a parenti, amici, prefiche. Nella canicola madida che confondeva le nenie funebri e i richiami dei muezzin dai minareti, sullo scalo di Hormuz convergeva un’enormità di derrate. Dal cono del Golfo di Oman, dalle Indie si infilavano nello Stretto bastimenti debordanti di spezie e drappi d’oro. Con frequenza incessante approdavano flotte mercantili cariche di qualsiasi mer169
ce, inclusi gli elefanti asiatici. Indaco, avorio e stoffe venivano scambiati coi cavalli persiani, che i sovrani del Maabar (il Coromandel) acquistavano a frotte. Nei regni indiani, la penuria di equini era difatti cronica. Artatamente cronica: le cibarie con cui i quadrupedi venivano nutriti, riso con carne e altri ingredienti cotti, arrecavano infezioni mortali ai magnifici e sventurati animali, che si spegnevano anzitempo per il clima malsano in cui erano stati sbalzati, e per gli alimenti sbagliati. Ma i venditori di destrieri certamente non si sarebbero mai e poi mai preoccupati di annettere al carico di purosangue un qualche palafreniere, che sapesse alimentare correttamente i corsieri e prolungarne la vita: il lucro scaturiva proprio dalla morìa di bestie, che bisognava rimpiazzare in continuità. A traghettare mercanzie e passeggeri in Levante provvedevano imbarcazioni che avevano una vela, un albero, un timone e che, soprattutto, parvero ai Polo ben lontane dai perfetti esemplari di battelli varati dall’Arsenale di Venezia. Le navi di Hormuz non erano infatti assemblate con chiodi in ferro, per cui le componenti nautiche si tenevano insieme col solo cordame ricavato dai filamenti della noce di cocco. Benché fosse opportunamente trattato e reso durevole con ripetuti bagni in acqua, quel tipo di fune sembrava non dare eccessivo affidamento, abbinato com’era a dei piccolissimi pioli in legno con cui si pretendeva di surrogare le ben più salde chiodature impiegate nei cantieri lagunari. Le carene, peraltro, non erano neanche lavorate con la pece, essendo calafatate con uno straterello di grasso di pesce, praticamente inutile. Di cocche o galere nemmeno l’ombra, in quelle settimane, sul Mare Arabico. Marco, e forse più ancora il padre e lo zio, dovettero provare un sentimento di forte delusione, sconfinante nel170
la rabbia. Avevano faticato e sofferto tanto per giungere a Hormuz, da cui erano certi di poter veleggiare abbastanza comodamente alla volta del Catai. S’erano predisposti al viaggio su vascelli che avrebbero circumnavigato il continente asiatico. Ma al momento di salpare avevano arrestato il passo. Costretti a farlo: no, non si sarebbero mai arrischiati a salire su una di quelle sgangherate barcacce. Non avrebbero mai sfidato i marosi orientali su gusci che a malapena stavano a galla. Tanto più che i tre mercanti veneziani, arruolati come ambasciatori, recavano le credenziali del papa e l’olio santo del Sepolcro di Cristo, da porgere al gran khan. Stizza. Un picco d’irritazione, un groppo da diluire lentamente. Poi, la pazienza. Altro non si poteva fare che volgere a settentrione e risalire le plaghe iraniane. Con un’attenzione, se possibile, ancor più intensa: la paiza di Kubilai, il salvacondotto che apriva ogni porta, che dava la sicurezza dell’intangibilità nell’impero mongolo, conservava certo il suo potere anche nell’il-khanato persiano, tradizionalmente fedele all’imperatore. Ma la prima volta che avevano raggiunto la corte khanale, Niccolò e Matteo s’erano mossi da Buhara accodandosi a un’apposita delegazione. Al ritorno, inoltre, almeno per un buon tratto di strada, i due fratelli erano stati scortati da una rappresentanza ufficiale del gran khanato. Ora, invece, non era più tanto sicuro che il lasciapassare imperiale potesse avere un effettivo valore, specie nella percorrenza dei distretti centro-asiatici oggi corrispondenti al Turkmenistan, all’Uzbekistan, al Tagikistan e all’Afghanistan settentrionale: il dissidio fra il potere centrale e l’indocile Kaidu andava sempre più inasprendosi, e non prometteva nulla di buono, per dei temerari che intendessero andare a omaggiare il gran khan calcando, bellamente, le terre di uno fra i suoi più acerrimi antagonisti. 171
Capitolo nono
VOCI DAL DESERTO
1 | Azzurro afghano Il pane era amarognolo. Impastato col salmastro dei pozzi – contaminati dal mare che s’era infiltrato nelle falde acquifere – il grano macinato assumeva nel distretto di Kerman un sapore non proprio gradevole. E per chi non vi fosse abituato anche l’acqua, ad alta salinità, diventava pressoché imbevibile. Tutt’al più, se le sorgenti erano calde, potevano rivelarsi curative per la rogna e altre infezioni, o essere magari opportunamente convogliate in un qualche hamma: indifferenti al credo religioso della clientela, quella sorta di terme islamiche sapevano come ritemprare i viandanti nel lento trascorrere di bagni e massaggi, nel suono cristallino delle caraffe empite e svuotate, negli scrosci liquidi sulle membra. L’abbraccio dei vapori, le abluzioni in acque profumate da petali di rosa con saponi al muschio e al garofano, le aspersioni di fragranze ai fiori d’arancio e al gelsomino, le essenze di aloe e incensi, la cornice di pitture decorative e di maioliche policrome davano davvero un godimento che trasportava sulla soglia della beatitudine. Rilassarsi, raccogliere le forze e rigenerarsi era indispensabile, prima di completare il cammino nel deserto, mortifero, del Dasht-e Lüt. 172
Senza una forma fisica ottimale, senza bevande appropriate e sufficienti, l’addentrarsi in quella sterilità piatta e arroventata era da suicidio. Le rare pozze putrescenti davano la dissenteria finanche alle bestie che, molto di malavoglia, vi si abbeveravano: figurarsi agli uomini. Abitazioni, nessuna. Non un mammifero, a eccezione di qualche sparuta asina selvatica, caracollante nella furia d’un vuoto quasi assoluto, desolante. Per dei viandanti che vi si avventurassero, la salvezza stava nel centrare – un po’ a naso, ed eventualmente con degli ausili cartografici – il sentiero che portava a una delle rarissime oasi dischiuse miracolosamente sulle fenditure di fiumi trascorrenti sottotraccia. Una di queste era Kubanan, località che, in un comprensorio di minerali ferrosi, s’era specializzata nella produzione d’ossido di zinco grezzo (tuzia) e depurato (spodio), sostanze con cui nel Medioevo si disseccavano le piaghe, si curavano le patologie degli occhi e che, in percentuali di purezza variabili, trovavano impiego anche nell’arte vetraria. La fermata fra le palme dell’abitato non dava però che un breve e momentaneo ristoro, in un cammino che persisteva così come era iniziato: e cioè in una siccità talmente letale da imporre al viaggiatore il trasporto supplementare di vivande e beveraggio, con cui supplire al marcio delle pozzanghere e all’assenza totale di ogni essere vivente. Dalle solitudini permanenti la rotta sfumava a settentrione nelle lande dell’«Albero Secco», una pianta grande, grossa, cava, con foglie bianche da una facciata e verdi dall’altra, e con cardi simili a castagne. Sia per l’islam che per la cristianità, quel ceppo monumentale sarebbe rifiorito (secondo le profezie) al nuovo avvento d’un Salvatore: ecco perché era meta di pellegrinaggi ininterrotti, apportatori di credenti e denaro. Ed ecco perché, di «Alberi Secchi», in 173
Medioriente ne era spuntato più d’uno, potendosene enumerare esemplari parimenti «autentici» e ugualmente venerati in vari altri santuari, tutti pullulanti di ex voto e offerte devozionali, tutti attrezzati di regolare tronco sacro presso il quale camminare, o sostare per impetrare guarigioni e supplicare la divinità. In effetti, quelli erano territori dalla religiosità proteiforme e dal passato intriso di epos, di eroismi leggendari, di saghe fenomenali. Ancora al passaggio di Marco Polo non s’era persa la memoria della grandiosa battaglia combattuta nel 331 a.C. fra le schiere greche di Alessandro Magno e i persiani di Dario. Ma il ricordo delle gesta antiche, il riannodarsi dei percorsi storici era come se introducessero a una ritrovata benevolenza del creato. Dalle pendici del Khorasan si poteva attingere una provincia di donne avvenenti, di villaggi prosperi e di città turrite, circondate da boschi gremiti di selvaggina e uccellagione. Le terre, nuovamente coltivate, e le campagne, finalmente vivificate, esibivano tutta la loro fertilità. Nel rigoglio dei frutteti di Sheberghan, i poponi erano i più buoni della Terra, e se ne faceva un proficuo commercio tagliandone la polpa a strisce ed essiccandola al sole: da quel procedimento derivava una frutta conservabile a oltranza, saporita e dolce più del miele. A una novantina di miglia compariva Balkh, quasi alla frontiera (mobile) fra l’ilkhanato di Persia e i domini di Kaidu, il principe ribelle che osteggiava Kubilai e che scorreva il khanato centro-asiatico di Chagatai. L’antica capitale della Battriana presentava ancora le ferite distruttive inflittele dagli eserciti di Gengis Khan nel 1220. Men che pallide erano invece le reminiscenze dei fasti vissuti nel IV secolo a.C., quando era una metropoli che si chiamava Bactra, e aveva accolto sontuosamente le nozze principesche di Alessandro il Grande con Rossane, 174
la splendida figlia del satrapo Ossiarte. La crudeltà aveva dunque sommerso lo splendore. Crudele e splendido era d’altronde un po’ tutto l’Afghanistan: si poteva cavalcare per giorni nell’isolamento completo, con il sussurro dei ruscelli a riempire i silenzi, fra il rosario di cittadelle che s’erano arroccate sulle alture per paura dei banditi. E si potevano incrociare borghi come Taloqan, dove si faceva un gran bel mercato di granaglie, e le cui montagne erano prodighe di salgemma, il conservanteprincipe per le cibarie medievali: lo si cavava con robusti picconi in ferro, estraendolo da giacimenti che Marco dovette giudicare bastevoli all’intero fabbisogno mondiale. La qualità e la quantità del sale erano tali da invogliare gli acquirenti a viaggi lunghi fino a un mese, e a spedizioni spossanti, a intraprese sovente pericolose, zigzagando fra bellezza e ostilità. Il paesaggio lungamente alberato, i campi fitti di cereali e i dolci vigneti contrappuntavano difatti l’indole scontrosa e talora aggressiva che i Polo dovettero riscontrare in quegli afghani che, col copricapo attorcigliato in testa, s’ubriacavano di vin cotto ed erano adusi a cacciare gli animali, per conciarne le pelli e ricavarne calzari o vestiario. Le cacce, peraltro, non difettavano di esotismo e varietà: battendo le boscaglie si potevano in effetti abbattere tanto dei felini di grossa taglia quanto degli innocui porcospini. I pastori, dal canto loro, incavavano dimore fra le giogaie terrose, e disseminavano le contrade afghane di parlate sempre diverse, che dalla madrelingua divergevano nei rivoli di dialetti poliedrici. Fu allora che Marco ebbe un cedimento, e si ritrovò malato, ammorbato da un’affezione che gli impediva di seguitare. Forse le paludi malariche della Mesopotamia meridionale, forse l’intolleranza verso determinati cibi, ovvero lo 175
sconquassamento fra i deserti iranici, gli sbalzi continui di caldo e di freddo, il logorio, il primo viaggio vero e duro, la percezione di mondi, paesaggi, genti che, tutti in un colpo, cercavano un posto e si affollavano in un cervello vergine, avevano finito per disanimare il ragazzo, nel comprensorio del Badakshan. La sosta in quella regione divenne quindi forzata, e si protrasse per mesi e mesi, di modo che il giovane veneziano potesse recuperare appieno la propria efficienza psicofisica. Della pausa non dovettero essere troppo dispiaciuti Niccolò e Matteo Polo. Padre e zio erano grandi intenditori di gioielli, ne avevano fatto commercio a più riprese. E là, tutt’intorno, le viscere montane sfornavano rubini balasci in numero così esagerato che, per evitare la saturazione del mercato internazionale e scongiurarne il deprezzamento, i governatori locali mozzavano il capo a chi ne esportasse illecitamente. Insieme agli spinelli, rosseggianti e trasparenti, si estraevano zaffiri e argento. Ma ancor più celebrato era il lapislazzuli, che una volta tramutato in polvere spandeva l’impareggiabile azzurro afghano ai quattro angoli dell’ecumene. Per il buddhismo, che ne usava da tempo, era una delle «sette materie preziose». Per l’Asia Minore e l’Occidente era un pigmento che trovava impiego nella campitura dei manoscritti, nella tintura degli affreschi e nella coloritura del vasellame. Le più recenti tecniche diagnostiche applicate ai manufatti medievali dell’Italia meridionale e, soprattutto in Puglia, le ricerche archeologiche nei siti di Siponto, Lucera, Ordona o Castel Fiorentino, stanno sempre più palesando la presenza notevole e ricorrente di lapislazzuli nella pigmentazione impiegata per ornare la cosiddetta «proto-maiolica», una ceramica diffusa (specie in ambito mediterraneo) fra il XIII e gli inizi del XIV secolo. Eviden176
temente, in parallelo alle peripezie poliane, la pregiatissima sostanza rivestiva le stoviglie ornamentali, decorava i codici miniati, impreziosiva le pitture murarie di templi e palazzi. Sulla Via del Lapislazzuli, sui circuiti attivati (o riattivati) dall’impero mongolo, la rivoluzione commerciale toccava anche i distretti asiatici più interni e apparentemente irraggiungibili.
2 | Natiche prosperose Il toccasana furono l’aria pura dei rilievi e le scaturigini sulfuree del Badakshan. Fu così che i malanni di Marco, pur se problematici nel loro decorso, si risolsero positivamente. La prolungata permanenza in Afghanistan dovette inoltre consentire al ragazzo di ammirarvi una fauna variegata e spettacolosa: falconi del tipo veloce volteggiavano insieme a falconi lanieri, più lenti, mentre altri piumati si mescolavano a una selvaggina opulenta ed erano il non plus ultra per venazioni generose. Greggi colossali di montoni si inerpicavano su per i monti altissimi, in un tripudio di erbe fragranti, di alberi e di polle d’acqua che sgorgavano tra gli anfratti e solcavano gli alvei torrentizi fino alle basse vallate, cullando lo sguazzare dei timalli (pesci le cui carni avevano un po’ il gusto di timo) e di numerose altre specie ittiche. Nella valle di Fergana, patria di cavalli divini, erano poi dislocate mandrie di stalloni talmente robusti che anche i cinesi ne avevano fatto razzia fra il 104 e il 102 a.C.: le soldatesche degli Han anteriori, armate e corazzate pesantemente, abbisognavano in effetti di palafreni imperiosi, con cui potersi opporre ai cavalieri nomadi delle steppe, 177
che a loro volta montavano equini piccoli di taglia, ma enormemente coriacei. Le cavalcature d’élite erano d’altronde una peculiarità afghana: una leggenda ricordava come da Bucefalo, il fedelissimo corsiero di Alessandro Magno, fosse discesa una razza d’incomparabile eccellenza, distinta sulla fronte da segni particolari. Il ceppo si sarebbe però estinto per l’avidità di alcuni nobili locali, che avrebbero preferito cessarne l’allevamento piuttosto che alienarne il possesso a familiari pretenziosi. A Marco Polo, inoltre, non sfuggì l’insolita agilità dei destrieri locali che, sprovvisti di ferratura ma dotati di zoccoli durissimi, zampettavano per i camminamenti montani e giostravano fra paesi ben incastellati. In quelle contrade, difese da arcieri invero abilissimi, l’olio si faceva dalle noci, e gli abiti dal pellame, poiché di stoffa non ce n’era abbastanza. Tuttavia, le nobildonne usavano portare delle brache imbottite a bella posta da metri e metri di lino o cotone, per conferire più tono al fondoschiena: gli uomini del posto, infatti, tanto più apprezzavano le signore quanto più le rotondità delle natiche apparivano prosperose e debordanti. Gente del tutto diversa popolava invece alcune regioni finitime, dove prevaleva un gran caldo e si consumava cibo a base di riso e carne. Erano persone malvagie, dalla pelle scura, espertissime di incantesimi e magie, che s’agghindavano le orecchie con cerchietti d’oro o d’argento infiorettati di perle e pietre preziose. Anche le aree del Kashmir erano abitate da negromanti che, magri, bruni, idolatri, erano capaci (secondo le credenze popolari) di mutare le condizioni atmosferiche o di creare di colpo l’oscurità nel pieno del giorno, come pure di sorprendere le notti illumi178
nandole all’improvviso. Fra castelli che si alternavano a distese brulle, e con l’arsura che s’avvicendava a freddi glaciali, quegli incantatori condividevano un’orografia selvaggia con degli eremiti (buddhisti?) che, nei romitori, accordavano la loro astinenza e le loro preghiere a una dimensione ascetica. Sull’alto Amudar’ja, il fiume venava terre irrigue assai popolose e, talora, ben fortificate: vi dimoravano prodi guerrieri di fede musulmana e vi proliferava la cacciagione. Più a oriente, a poche giornate di marcia, le pendici del Pamir si preannunciavano con pascoli sconfinati, altipiani verdeggianti, laghi limpidissimi e sorgenti di fiumi, in un ambiente che accoglieva selvaggina d’ogni qualità e mastodontici arieti bradi: le loro corna erano così capienti che i pastori le usavano come recipienti per il desinare. Andando oltre, sfidando passaggi sempre più ghiacciati, il cammino proseguiva privo di villaggi e vegetazione in un gelo che neanche i rapaci più tenaci riuscivano a sopportare: persino il fuoco, lassù, faticava a tenersi desto. Anche a cercarne, non si sarebbe scovato un granché di ricovero neppure nei massicci antistanti al Turkestan cinese, abitati da popolazioni che s’erano inselvatichite in un ambiente rude, e che per sostentarsi ricorrevano quasi esclusivamente alla caccia, derivandone alimenti e abbigliamenti. Ai Polo, in ogni modo, andava bene così. Si fossero trovati alle strette, una loro eventuale fuga avrebbe avuto un nascondiglio sicuro e immediato proprio nei pertugi, nelle spelonche, nei ripostigli che le asperità montane sapevano schiudere, lì di fianco, a margine dei percorsi più frequentati. Scalando tratturi pietrosi e innevati, vincendo grovigli quasi disumani di creste e forre, di radure e burroni, i tre veneziani poterono ridiscendere giusto sotto il Kirghizistan, 179
alla confluenza delle catene del Tian Shan e del Kunlu Shan. Laggiù, Kashgar era baricentrica, in un territorio fertile e commercialmente vivace, spumeggiante di vigneti e piantagioni di cotone, lino e canapa. La cittadinanza era in maggioranza musulmana, sebbene più d’una chiesa cristiana sorgesse a testimoniarvi la penetrazione secolare del culto nestoriano. L’unica pecca consisteva nel carattere dei mercanti indigeni, numerosi e meschini, avidi e miserevoli, dediti alle peggiori abitudini nel mangiare e nel bere. Tutt’altro tenore doveva distinguere la nobile Samarcanda, adagiata in una piana ricolma di frutteti: Marco ne ebbe notizia di seconda mano e, pur senza visitarla, seppe delle ruggini intercorrenti fra i nestoriani e gli islamici che vi risiedevano. Le cronache popolari andavano infatti ripetendo di un incredibile miracolo: si diceva che una volta, col benestare del principe Chagatai, nella famosa metropoli della Sogdiana i cristiani avessero innalzato un tempio in onore di san Giovanni Battista e che, per sostenerne il soffitto, si fossero impadroniti di un masso litico, togliendolo a un edificio maomettano e collocandolo alla base di una colonna. Allorché, cambiato il dinasta (e le relative simpatie religiose), i musulmani avevano preteso la restituzione del grosso macigno, senza intendere ragioni e senza accettare alcuna contropartita in denaro, ecco che, per prodigio, a prescindere da quel fondamentale supporto architettonico, la chiesa era ugualmente restata in piedi: e nel piedritto penzolante si esplicitava simbolicamente tutta la potenza del Signore, tutta la saldezza del cristianesimo, con una forza trascendente che trionfava addirittura sulle leggi di gravità. Il nestorianesimo era in effetti una costante che, seppure di complemento alla predominante dottrina islamica, Marco Polo poté registrare con discreta frequenza nella sfilza di cittadi180
ne attraversate sulla Via della Seta, sul cammino che conduceva al favoloso Catai. Ma non erano solamente le questioni religiose che incuriosivano il giovane mercante: egli notò ad esempio che gli abitanti di Yarkand (oggi Shache), la «città di pietra», soffrivano di gozzo e gambe gonfie. A Hotan, località di antica eleganza e perenne industriosità, conosciuta per la produzione di bozzoli e tessuti di seta, operavano parecchi artigiani e molti commercianti, cosicché nella ridondanza di cotone, lino, canapa, grano, vino e frutta, nel prosperare delle colture, erano pochi gli individui votati alle armi. Il diaspro e il calcedonio si traevano invece dal dipartimento di Yutian, laddove sussistevano delle usanze matrimoniali piuttosto insolite per degli europei: se un marito si allontanava a far mercatura (o altro) per venti giorni, la moglie aveva la facoltà di prendersi un nuovo sposo. Analogamente, il coniuge poteva scegliersi una nuova consorte in qualsiasi luogo pervenisse: e alcuni studiosi avrebbero percepito in una tale costumanza echi della poliandria tibetana, ovvero l’eredità di tradizioni in auge fra Battriana e India durante il regno degli antichi Kushana (almeno stando alla testimonianza del Dialogo delle leggi e dei paesi di Bardesane, scritto nel III secolo e opera fra le più antiche della letteratura siriaca). Qualunque ne fosse l’origine, a mercanti come i Polo, abituati a vederne di tutti i colori e a frequentare trafficanti che vantavano una sposa per ogni emporio, tutto sommato la pratica di risposarsi velocemente non dovette sembrare troppo inusuale, e forse neppure tanto indecente. Altri erano i fastidi, e ben più fisici, che i viaggiatori dovevano provare nel tuffarsi fra coltri sabbiose sempre più spesse e sempre meno popolate, man mano che l’itinerario si sfilava dal Xinjiang. 181
3 | Sull’orlo dell’oblio A conoscerlo, a saperlo prendere, il mare di sabbia poteva anche dimostrarsi un amico fraterno. Un compagno fidato, capace all’occorrenza di custodire dei segreti. Nelle vicinanze di Qiemo, il fluire di un fiume apparecchiava un po’ di vita, e forniva diaspro e calcedonio da esportare nel Catai. Ma poi, per un raggio di centinaia di chilometri, desolazione e aridità parevano risucchiare tutto e tutti in un orizzonte di feroce assenza. Nell’imperare del vento le orme, le tracce, la memoria del viandante erano un attimo subito occultato. I soffi d’aria scivolavano rapidi a cancellare impronte fresche e tracciati appena percorsi. Le folate, molli, brusche, intermittenti, continue, comunque facevano dissolvenza. E tuttavia il deserto e i turbini, feroci coi viaggiatori, erano salvifici per gli autoctoni: all’appressarsi di un esercito o di una banda di predoni, le famiglie locali raccoglievano animali e masserizie e, marciando per due o tre giornate, si addentravano nelle plaghe cocenti. Con quel nomadismo indotto e passeggero dirigevano alle recondite radure che un affioramento acquifero aveva predisposto al bivacco, e vi sostavano col bestiame, in attesa che cessasse ogni l’allarme, nella certezza che ventate amiche fossero passate a dissimulare le loro impronte. Era nelle sabbie desertiche che si mimetizzavano i ripostigli per l’ammasso dei cereali, da prelevare a poco a poco, di mese in mese, a seconda delle necessità domestiche. Le dune prominenti potevano inoltre nascondere gli armenti alla bramosia e alla fame delle soldataglie in transito: i pastori, gli allevatori, gli agricoltori dei paesi assediati dal deserto avevano in effetti imparato che i militi mongoli, in guerra come in pace, non pagavano quasi mai ciò che prendevano durante i loro spostamenti. 182
Con prudenza, perspicacia e abilità, la comitiva poliana seppe evidentemente giovarsi dei punti d’appoggio essenziali per lasciarsi alle spalle il bacino del Xinjiang. Si scansarono le macchie arbustive fecondate da acque nocive e, di oasi in oasi, fu raggiunto l’imbocco di un’ennesima e ancor più spaventevole depressione: il Gobi. Prima di intraprenderne la traversata, Lop era l’ultimo centro abitato, un appiglio che consentiva il ristoro dalle fatiche da cui si era appena usciti, e un riposo di almeno una settimana, obbligatorio se si voleva sopravvivere: per essere oltrepassata, l’immensa conca secca richiedeva difatti un anno di marcia sul tragitto più lungo, e un mese sul tratto più corto. Impossibile attuare la prima soluzione: non c’era modo di attrezzarsi con scorte adeguate su distanze e in condizioni geoclimatiche infernali. Più fattibile si presentava la seconda ipotesi, sebbene anche questa fosse al limite delle possibilità umane. Ad ogni buon conto, in casi estremi si sarebbe potuto ammazzare e mangiare lì per lì qualche animale da basto: rinunciando, certo, a una parte del carico, non più trasportabile, ma almeno salvando la ghirba. Insieme alla preparazione mentale e all’allenamento corporale, la buona sorte incideva parecchio sulle probabilità di riuscita dell’impresa: tre o quattro erano i pozzi putrescenti che si sarebbero potuti incrociare, e allora la morte non avrebbe dato scampo; una trentina erano invece – a giudizio di Marco – le fonti buone, quelle della speranza, con le quali cadenzare l’itinerario. Sempre che, nel frattempo, le sorgenti non fossero state prosciugate dal passaggio di una qualche mandria, o di una carovana con più di cento bocche da dissetare, che era poi il massimo dell’impatto sostenibile per polle affievolite dalla siccità imperante, in lande dove nessuna bestia aveva il coraggio di penetrare spon183
taneamente, nessun uccello di volare. Il Gobi metteva i brividi a ogni essere vivente. Per le mercanzie e per i cammelli, per gli asini e gli uomini che vi si incamminavano era come procedere in bilico sull’orlo dell’oblio. Le sagome, le voci, le orme si assottigliavano nella lontananza. Il senso della caducità e della solitudine sovrastava ogni pensiero. L’esplorazione di piste ciottolose diventava quasi un rovistare in se stessi, un saggio delle proprie forze e della propria fede, il conoscimento esatto dei limiti individuali e più intimi, di un’energia che era, non poteva che essere, inestricabilmente, corporea e spirituale in uno. La psiche perveniva così sul ciglio fra ragione e follia, ai confini della sensatezza, in equilibrio sulla perdizione. Conobbe tutto, Marco Polo: i miraggi di milizie terrifiche che parevano scagliarsi addosso ai convogli, e che nelle menti più fragili producevano atroci turbamenti, fughe confuse, smarrimenti definitivi; le allucinazioni acustiche di quanti rallentavano l’andatura e poi, attardatisi, andavano dietro alle presunte voci dei compagni, per perdersi per sempre; l’illusione di captare nell’aria l’effusione musicale di strumenti, di sentire timpani risuonanti: erano i fenomeni chiamati dai cinesi «le sabbie che cantano», e che non avevano alcunché di fantastico, nulla di inventato, giacché costituivano per davvero gli effetti allucinati che una lunga traversata del deserto, di qualsiasi deserto, provocava nei viandanti: lo si è sperimentato anche in spedizioni recenti, anche nel Sahara. E allora, per mantenere l’orientamento, per non fuorviare l’intelletto e restare agganciati alla realtà effettiva bisognava a ciascuna fermata segnare preventivamente una direzione, da seguire dopo il riposo notturno e da non perdere mai di vista. Gli «spiriti» e le «sirene» desertiche anda184
vano combattuti con sonagli e campanacci da appendere agli animali della carovana, a mo’ di guida sonora: solamente simili accorgimenti consentivano di beffare il Gobi, e di non esserne ingannati. Scrupolosi, lungimiranti, motivati ad andare, a conoscere, a sperimentare, i Polo ce la fecero. Superarono l’ennesima piattaforma disseccata e furono a Dunhuang. Era, quella, una cittadina agricola, i cui abitanti non sembravano avere un’eccessiva confidenza coi commerci. Nestoriani e musulmani si frammischiavano a coloro che – ed erano la maggioranza – Marco riconobbe come «adoratori di idoli», coltivatori di un buddhismo influenzato dallo sciamanesimo (e da un animismo di presunta origine pastorale), in monasteri adorni di statue. Il giovane veneziano dovette rimanere impressionato dalla consuetudine che induceva i padri di famiglia ad allevare e poi a immolare dei montoni, che venivano offerti alla divinità accompagnando l’atto sacrificale con la preghiera di vegliare sui figliuoli. Porzioni della carne santificata erano distribuite non solo ai sacerdoti dei santuari dove si officiava il rito votivo, ma anche ai parenti dell’offerente, affinché ne mangiassero devotamente e, festosamente, ringraziassero gli dei. Ugualmente sconcertanti dovevano sembrare a un occidentale i riti funebri. Il defunto veniva tenuto in casa sine die, finché non giungeva il giorno fissato dagli astrologi per la cremazione del cadavere. Potevano così trascorrere parecchie settimane, in attesa che gli astri del cielo si fossero distribuiti sulla linea giusta, quella che doveva indirizzare il morto perfettamente nell’aldilà. Intanto, a evitare che il fetore della decomposizione appestasse completamente la dimora, la salma subiva un trattamento a base di zafferano e spezie odorose, e veniva deposta in una cassa ben spessa, sigillata e coper185
ta da un panno. Come se il caro estinto fosse ancora vivo, tutti i giorni gli si apparecchiava innanzi una tavola con vino, pane e vivande, fintantoché non fosse giunta l’ora del rogo finale. A volte, per l’influsso infausto di una stella in opposizione all’uscio, si doveva addirittura abbattere una parete dell’appartamento per estrarre le spoglie dal verso più consono, e per poterle scortare alla pira funeraria in allineamento col pianeta di nascita. Il corteo mortuario incedeva preceduto da musicanti e si dispiegava a tappe, fra baldacchini che i familiari avevano preventivamente allestito per offrire libagioni e onorare il trapasso ultramondano: se infatti bistrattato, se non assecondato, lo spirito di chi era deceduto avrebbe potuto «arrabbiarsi» e rivolgersi maleficamente contro i consanguinei. Anche per questo, nel fuoco crematorio bruciavano fantocci di schiavi, cammelli, cavalli e monete auree che sarebbero serviti al trapassato nell’oltretomba. Con tutta probabilità, le cerimonie propiziatorie contemplate da Marco Polo erano l’esito di liturgie spurie, opera di buddhisti poco ortodossi, in un crogiuolo asiatico che incrociava plurime esigenze religiose. Ma il ragazzo non poteva ancora averne una piena consapevolezza. Per lui, le tante cappelle ritagliate nella roccia, guarnite di pitture buddhiste, indiziavano sempre più un Oriente che si stava aprendo sul Catai.
4 | Sesso matto Quanto all’erotismo e ai costumi sessuali, in alcune contrade questi si esprimevano con molta minore inibizione rispetto all’Occidente. Al solo accennare al borgo di Hami le lab186
bra dei viandanti si allargavano in un gaudioso sorriso. Ci scappavano strizzatine d’occhio e sgomitate fra soci di carovana: in quella città, contornata da colture rigogliose, gli uomini non pensavano ad altro che a divertirsi con musica, canti e balli. Le donne, a loro volta, si concedevano con gioia ai forestieri itineranti che intendessero trastullarsi per qualche giorno. E ciò avveniva col benestare dei mariti che, per non risultare d’impaccio ai convegni amorosi, si ritiravano nelle ville di campagna, da dove mandavano agli ospiti quanto essi potessero desiderare durante i sollazzi. Dietro pagamento, si intende: il che farebbe supporre, al di là della sbandierata creanza di accogliere con tutti i crismi i pellegrini stanchi (così da beneficiare della benedizione divina, come si voleva far credere), a forme di prostituzione organizzate per il diletto dei viaggiatori. Era un affare che presumibilmente doveva fruttare parecchio, se è vero che, come apprese Marco Polo, la gente del posto non poté sopportare a lungo un ordine moralizzatore di Möngke Khan, col quale veniva ad essere censurata ogni forma di ospitalità per stranieri e, quindi, ogni conseguente adulterio. In un accorato appello al sovrano mongolo, i cittadini ebbero difatti a confessargli tutto il proprio disagio, che era poi un disagio economico: a loro dire, le divinità si sarebbero mostrate contrarie alla dismissione di un’usanza tanto antica e consolidata, e perciò avrebbero finito per togliere alla cittadinanza l’aiuto celeste, gettandola nel baratro dell’indigenza. «E allora, se volete onta e vergogna, così sia!», pare fosse stata la replica del monarca, che intuendo l’antifona revocò la censura e restituì l’allegria ai maschi giocosi e alle femmine sensuali: ovviamente, l’allegria derivante dai lucrosi mercimoni. Pure, non era quella l’unica risorsa del sistema produttivo territoriale. 187
Da alcune zone montagnose (a tutt’oggi non ancora bene individuate) derivava un buon acciaio e, soprattutto, la speciale «lana di salamandra». Chiaramente, e Marco lo capì bene, non si trattava del geco che le superstizioni occidentali credevano resistente al fuoco e abitatore delle fiamme. Lungi dalle leggende fantasiose che s’erano sedimentate sulla base di trattatelli pseudo-scientifici, era l’asbesto a fornire le fibre lanose che, pestate in mortai di rame e liberate con una lavatura dalle scorie terrose, venivano intessute per foggiare drappi di amianto. Da essere inizialmente scuri, quei panni divenivano poi immacolati con una passata finale sulla vampa: e di siffatto procedimento il sagace Marco, da buon mercante disincantato e razionale, potrà avere conferma tramite il suo compagno Zufircar, un ingegnere turco (non altrimenti identificabile) che per circa tre anni dovette essere preposto dal gran khan alle miniere della Cina nordoccidentale. Il cuore del gran khanato, comunque, non era più tanto distante. Fuoriuscivano adesso, i Polo, dalle terre che nell’VIII-IX secolo avevano visto germogliare la raffinata civiltà degli Uiguri, il popolo che s’era sottomesso volontariamente (e intelligentemente) ai Mongoli nel 1209, e ai cui funzionari era stato rimesso il controllo della cancelleria gengiskhanide. Sarà proprio la scrittura uigura ad essere adottata nella nascente amministrazione di un impero che, per la sua ampiezza e per la sua pluralità etnica, religiosa, sociale e politica, non era più possibile controllare facendo riferimento esclusivamente alla cultura e alle tradizioni nomadiche. Non si poteva insomma tutto trasformare in pascolo per gli allevamenti, per la pastorizia e per le annuali migrazioni, rovinando un’agricoltura che era costata generazioni e generazioni, bestemmie e sudore. Né conveniva «spianare» indiscriminatamente villaggi o metropoli per assimilarli alle steppe 188
centro-asiatiche, non fosse altro che per le decime e i tributi che erano riscuotibili in natura, o in beni materiali, o in denaro. Pertanto, a parte qualche esitazione iniziale, ai conquistatori mongoli dovette apparire sempre più chiaro che anche l’economia rurale era funzionale al fabbisogno statale. La stessa raccolta di essenze o rizomi medicamentosi occupava proficuamente le popolazioni, e ne consentiva la sopravvivenza: sulle alture cino-tibetane cresceva spontaneamente e si raccoglieva il rabarbaro, che nugoli di commercianti stranieri compravano per rivenderne ovunque, a Levante come a Ponente, riattraversando le sabbie di Gobi e Xinjiang, giungendo a Samarcanda e Buhara, e approdando ad Aleppo o agli scali mediterranei, come pure nel Catai e nella Mongolia. Guglielmo di Rubruck, nel suo viaggio asiatico, aveva già potuto verificare e lodare l’eccellenza dei medici cinesi, che «conoscevano molto bene le virtù delle erbe ed erano in grado di fare ottime diagnosi sentendo il polso», e che «tuttavia non facevano uso degli orinali e non facevano studi sull’urina», com’era abituale fra i dottori europei. E l’eccelsa medicina araba apprezzava assai e utilizzava in dosi cospicue le piante erbacee che spuntavano nella florida natura della Cina centro-occidentale. Di quei luoghi ai Polo non sfuggì neanche la religiosità profonda, moltiplicata da una miriade di templi, conventi, statue gigantesche in legno, pietra o terracotta, rivestite d’oro e distese per lungo. Alle effigi e al magistero del Buddha si dedicavano monaci di ineccepibile morigeratezza, che non annettevano troppo peso agli altrui peccati di lussuria: eccezion fatta, in verità, per i rapporti contro natura, condannati con la pena capitale. Nelle contrade del Gansu, fra Yumen, Zhangye e Wuvei albergava pure l’islam e, immancabili, i nestoriani, con 189
le loro belle chiese. Per Marco, per la sua ancor breve esistenza, era un addensarsi di novità: notò la stretta osservanza dei precetti astrologici che vietavano il consumo di carne in determinate fasi del calendario, e meditò sull’usanza che alcuni uomini avevano di accollarsi – potendoselo permettere – fino a trenta spose, ripudiabili e intercambiabili con cugine o zie, qualora qualcuna non fosse più risultata gradita. Sulle locali costumanze, d’altro canto, l’ormai ventenne veneziano poté soffermarsi per circa un anno. Tanto durò difatti la sosta alle propaggini occidentali della Grande Muraglia. Il ciclopico diaframma non impressionava, non poteva sconcertare chi s’era sobbarcato migliaia di chilometri di marcia fra picchi selvaggi e deserti cocenti. Nel Duecento, inoltre, il grande bastione possedeva un profilo più contenuto e comunque diverso rispetto alle potenti ristrutturazioni che, dal XV-XVI secolo, ne hanno configurato l’odierno aspetto. Per come apparve ai Polo, quel pur imponente baluardo non differiva troppo da una qualsiasi altra generica fortificazione. Un muro, benché possente e voluminoso, era pur sempre e soltanto un muro. E poi costituiva una struttura difensiva ormai svuotata di senso, poiché sia semanticamente sia fisicamente non marcava più il confine fra popoli sedentari e popoli migratori, fra i cinesi immersi in borghi e agricoltura e i turco-mongoli imbevuti di steppe e nomadismo: l’estensione del potentato di Kubilai Khan aveva in effetti soverchiato le barriere, deprivando di significato l’argine millenario rialzato a dividere la cultura stanziale e la civiltà nomade. Ai sovrani gengiskhanidi, che erano scesi dal Nord, dalla Mongolia, per impadronirsi della Cina, la linea di demarcazione non doveva essere certo gradita: e l’intelligenza dei Polo era troppo viva per non intuire questa psicologia minima. 190
Altri erano d’altronde gli elementi geografici e antropologici che stimolavano gli interessi di chi aveva studiato e avuto un’educazione da mercante: gli empori, i commerci, le mercanzie, le modalità per procurarsene, gli itinerari per rifornirsene, e i volti, i luoghi da incontrare, le tradizioni da assecondare, le difficoltà da sopravanzare, i paesaggi da esplorare o da farsi raccontare. Più che un muraglione semicadente incuriosivano i falconi, i cammelli, le montagne e le vallate, e i boschi di pino, le asine selvatiche, le distese desertiche che portavano a Kara-Khoto (la cinese Haicheng), la «città nera» (o la «città morta»), ubicata sulla frontiera settentrionale di quello che era stato il regno tanguto dei Xi Xia. A Marco premeva informarsi su Karakorum, la vecchia capitale mongola, famosa anche per essere un polo di artigiani e mercatanti. E gli importava della meravigliosa lana bianca che nel comprensorio tra Xining e Lanzhou si filava dal soffice sottopelo dello yak, o del muschio premuto dalle ghiandole addominali degli zibetti, come pure dei ciambellotti, le stoffe che nella Mongolia centrale si producevano col pelo di cammello (ancor più pregiato se bianco), e dei nasicci, i tessuti dorati, fabbricati nelle contrade degli Onguti. La curiosità era per i fagiani che crescevano il doppio del normale, e per le miniere argentifere, per gli individui dalla scarsa barba, dai capelli corvini e dal naso piccolo, per le belle donne dalle carni lucenti che molto si deliziavano cogli uomini, e per il vizio che più d’un signore aveva di comprare fanciulle da matrimonio, pagando profumatamente le genitrici delle spose. Era il Levante, che si annunciava prepotente. Era il Catai. Avevano pazientato, i Polo, aspettando un cenno del gran khan che li chiamasse a coprire l’ultimo pezzo di strada. Una staffetta, incaricata da Kubilai, già galoppava per andarli a prendere. 191
Parte quarta TUTTO UN ALTRO MONDO
Capitolo decimo
L’ORIENTE DI KUBILAI KHAN
1 | Gente di città, gente senza città La Via della Seta non aveva tradito. Yarkand, Hotan, Yutian, Qiemo nel Xinjiang, e Dunhuang, Yumen, Zhangye, Wuvei, Lanzhou nel Gansu erano stati i vaghi della collana sgranatasi lungo il filo sinuoso del viaggio poliano. Man mano che Niccolò, Matteo e Marco penetravano nel Catai le campagne, i villaggi e le città si infittivano, formicolanti, ordinate. La solitudine dei deserti, la barbaritas delle montagne potevano acquattarsi nei ricordi. L’assioma «montanaro uguale selvaggio» che i Polo, gente di città, si portavano dietro (e dentro) come eredità della cultura medievale europea, e la sensazione di disordine, di feracità, di dispersione associata mentalmente ai luoghi aspri si stemperava, si spianava finalmente e s’addolciva dinanzi agli aggregati cittadini, agli spazi antropizzati della Cina e della sua immutata, millenaria, immutabile sedentarietà. Non che il nomadismo, poco più a nord, fosse scomparso. Nel risalire in Mongolia, dopo avere attraversato terre imbastardite dalla mescolanza di costumi e religioni, le brughiere plasmavano ancora la quotidianità di cavalieri e allevatori. Le cicliche migrazioni di famiglie e mandrie si accordavano al ritmo delle stagioni, in traversate che lente 194
conducevano ai pascoli più freschi, alle acque gorgoglianti di un ruscello o a quelle placide di un lago, e alle radure che accoglievano, materne, esistenze incastonate fra il verde delle praterie e il blu carico, semisolido, del cielo parallelo. Marco Polo ebbe piena coscienza delle più genuine tradizioni mongole, a prescindere dalle descrizioni che già ne avevano fatto un Giovanni da Pian del Carpine o un Guglielmo di Rubruck. Ammirò la bellezza dei capi di bestiame grosso e minuto, spesso lasciati allo stato brado, tutti segnati dal marchio del possessore, di modo che non se ne smarrisse la proprietà. E conobbe alla perfezione l’usanza nomadica di abitare nelle classiche tende circolari, le yurte (o ger): intelaiate in materiale ligneo facilmente trasportabile, erano fasciate da un feltro impermeabile, e possedevano una copertura emisferica che, simbolo della volta celeste, appariva forata al centro per inserirvi la canna fumaria del focolare. Ciascuna di quelle dimore portatili – montate talvolta anche su carrozze gigantesche – possedeva l’uscio rivolto a sud, sia per rendere omaggio alla luce del sole e riceverne i benefici, sia per eludere i freddissimi venti settentrionali. Oltretutto era dal Meridione che, nella concezione mongola, arrivavano le buone novelle. All’interno delle «case mobili», un settore era poi riservato al culto degli idoli domestici, effigiati dai più grandi ai più piccini, come bambolotti in panno o legno, su dei cassoni. Per esaltarne le funzioni apotropaiche li si ungeva col grasso delle vivande o li si aspergeva con del brodo, così da coinvolgerli direttamente nel ménage familiare e cattivarsene la protezione. Ai Polo, sempre propensi a cogliere le sfumature dei rapporti sociali, non passò inosservato il costume per cui anche qui, pur preferendosi di norma la prima sposa, gli uomi195
ni avevano la facoltà di pigliarsi tutte le mogli che volevano e potevano mantenere, previo pagamento di una cospicua dote alle madri delle fanciulle. L’adulterio, fra gente ritenuta da Marco di ineccepibile dirittura morale, era aborrito. E in ogni caso le leggi avite prescrivevano che in queste famiglie «allargate» i maschi dovessero sposare le cognate e le matrigne divenute vedove, affinché non rimanessero sole. Il rito degli sponsali riguardava del resto anche i giovanissimi morti prima delle nozze: i rispettivi parentadi allestivano immagini di carta dei due coniugi virtuali, e ne celebravano la festa nuziale con tutti i crismi, per poi incendiare le effigi dei defunti insieme ai disegni di animali, uccelli, denari e oggetti preposti ad allietare gli sposini «cartacei» nella dimensione ultraterrena. A Marco un simile cerimoniale dovette apparire quantomeno bizzarro. Eppure, in quel modo si stabiliva l’unione fra nuclei parentali precedentemente disgiunti, che stringevano un’amicizia indissolubile. Le intese interfamiliari e il mutuo soccorso erano difatti essenziali in una società modulata sulle occupazioni giornaliere, in un contesto in cui bisognava darsi da fare alacremente per non soccombere all’inesorabilità di lande sovente scabrose, con temperature che oscillavano fra i meno cinquanta gradi invernali e i più quaranta estivi. Le donne che nella steppa, al pari dei vivaci ragazzini, si ponevano alla guida di carri coperti e trainati da buoi o cavalli, e che si dedicavano alle faccende casalinghe, erano per Marco Polo ammirevoli non meno degli uomini, combattenti e cavalieri talentuosi, pronti in guerra a sopportare qualsiasi fatica, e dediti a cibarsi nelle ricorrenti trasferte belliche della semplice cacciagione procacciata sul tragitto. Immancabile negli otri ballava il kumyss (o ayirak), il latte di giumenta acidulo e fermentato, la bevanda nazionale che, 196
coi suoi pochi gradi alcolici, accompagnava i pasti e i momenti di socializzazione, e instillava euforia alla vigilia delle battaglie. Dalla lavorazione dei prodotti caseari si ottenevano pure dei pezzi di butirro cagliato e disidratato, che all’occorrenza veniva riportato alla fluidità con dell’acqua calda e uno sbattimento ripetuto. Al limite, nei frangenti di particolare ristrettezza alimentare, quando le cibarie risultavano esaurite, ciascuno tagliuzzava una vena al proprio destriero e ne succhiava il sangue. La simbiosi completa con le cavalcature rappresentava d’altronde uno fra i punti di forza di una milizia che, agli occhi del giovane mercante veneziano, era senza eguali. Perfettamente inquadrati nelle loro file di decine, centinaia e migliaia di soldati, sorretti da un’impareggiabile abilità nel cavalcare e scagliare frecce nell’attimo stesso in cui il corsiero galleggiava nell’aria coi quattro zoccoli staccati dal suolo, i Tartari delle praterie centro-asiatiche costituivano un esercito invincibile, composto di combattenti indomiti e tenaci, guerrieri che a Marco Polo sembrarono fatti apposta per conquistare terre e reami. Le tattiche d’assalto, provate e riprovate spesso nelle grandi cacce che per mesi impegnavano i reparti militari in esercitazioni collettive, si basavano sull’operato delle avanguardie che, di concerto con le ali dell’armata, preparavano il terreno all’arrivo della colonna principale. La dotazione delle soldatesche si componeva di archi, spade, mazze ferrate e di armature confezionate con un cuoio di notevole consistenza. Altrimenti, l’abbigliamento ordinario di un mongolo prevedeva tessuti ricamati in oro e seta, e pellicce di zibellino, ermellino, volpe o scoiattolo con cui, specialmente, i Polo videro vestiti i signori più facoltosi. Che siffatto universo fosse stata la culla della stirpe gengiskhanide fu cosa ben nota al callido Marco. Ancora ne197
gli ultimi decenni del Duecento riecheggiavano nitidi per il Levante i racconti dell’epopea di Gengis Khan, della sua elezione a principe dei nomadi, delle sue molteplici imprese e della sua (mitizzata) benevolenza nei confronti di genti che, pur soggiogate, di buon grado accettavano di seguire nelle conquiste un condottiero così valente e saggio. Alle orecchie poliane giunse pure la storia dell’ennesimo «Prete Gianni», di quel Toghril che, insignito dai cinesi del titolo di wang-han (foneticamente affine a «Iohan[nes]/Giovanni»), era stato re dei Keraiti, un popolo a prevalenza cristiano-nestoriana, stanziato sotto il lago Bajkal e a settentrione della Grande Muraglia. Per molti anni i Mongoli avrebbero versato tributi al potentissimo «Signore del Gobi», e a lui Gengis Khan in persona, da vassallo e alleato quale inizialmente fu, si sarebbe rivolto per stringere dei vincoli matrimoniali che coinvolgessero esponenti delle nobiltà mongola e keraita. Ma si raccontava che lo sprezzante rigetto della proposta avesse trasformato la vecchia alleanza in ostilità, innescando un conflitto conclusosi con la morte del tracotante Toghril. Dal canto suo, Gengis Khan si sarebbe spento (a dire di Marco, che è l’unico a fornire una tale versione) per la ferita di un dardo a un ginocchio, mentre assediava una località fortificata. Non un cenno al disarcionamento che verosimilmente dovette essere la causa del decesso. E comunque, per le contrade asiatiche si tramandava che il conquistatore, come tutti i khan, fosse stato seppellito fra i viluppi degli Altaj, i «Monti d’oro». Nel condurre il feretro al sepolcro, ogni essere vivente incontrato sulla strada sarebbe stato ammazzato per andare a servire il sovrano anche nell’altro mondo, in ossequio alle più tipiche credenze mongole. Si narrava che, per le esequie del solo Möngke, ventimila uomini fossero stati trapassati, a gloria (ultramondana) del principe che aveva 198
preceduto Kubilai alla guida del regno più vasto dell’ecumene. Era un impero che negli anni Settanta del XIII secolo appariva ancora in fase di ulteriore espansione: i Mongoli si stavano radicando in Cina, e la cultura nomade si stava innestando nella cultura stanziale. Il processo in corso era nettamente percettibile da uno che, come Marco Polo, intuiva, comprendeva, distingueva lucidamente fra popolazioni randagie e civiltà sedentarie, e che quindi meglio di altri, col suo bagaglio di conoscenze pregresse e con la capacità (tutta mercantesca) di acquisirne di nuove, in fieri, avrebbe saputo muoversi in un laboratorio sociopolitico piuttosto singolare. Idee, realtà, desideri erano in via di definizione, in un’Asia estrema che, peraltro, andava oltre la steppa, oltre la Cina.
2 | Kamikaze Il gran khan, il suo seguito, la sua gente. Anche l’impero sino-mongolo del Catai, che pure arrivava ad affacciarsi sull’Oceano Pacifico, all’estremità dell’Asia continentale, alla finis terrae, aveva un Oriente ulteriore, un Oriente fantastico da contemplare e rimirare. Un eden da immaginare stracolmo di perle rosse, tonde e grosse, assai più pregiate delle bianche, più comuni e scontate. Un Levante immaginifico, traboccante di gioielli, popolato da persone dall’aspetto gentile e dalle buone maniere. Una terra luccicante per l’oro che rivestiva massicciamente i palazzi regi, che foderava le residenze signorili, che adornava i saloni, le camere, le finestre, le pareti dei castelli con uno spessore di almeno due dita: mai nessun commerciante ne aveva carpito un solo grammo, ed era perciò che se ne sarebbero potute reperire quantità esor199
bitanti. O per lo meno questo contenevano le previsioni, che altro non erano se non visioni oniriche, di cui Marco Polo sentì spesso mormorare (e che rivelerà, primo fra gli europei, agli occidentali). Quell’Oriente sognato e bramato era l’arcipelago giapponese. E Kubilai non ammetteva che una stirpe di isolani, lì di fronte, con tutte le sue favolose ricchezze, si sottraesse al pagamento del tributo dovuto all’imperatore. Per due volte, nel 1268 e nel 1271, aveva intimato ai Giapponesi di sottomettersi. E per due volte l’ultimatum mongolo aveva ricevuto una risposta piccata, per niente accondiscendente: Hojo Tokimune (1251-1284), e con lui un popolo che pure appariva lacerato da fazioni perennemente in lotta fra loro, non si piegavano. Al contrario, la necessità di far fronte ad un nemico esterno avrebbe in qualche misura contribuito a ricompattare la nazione attorno a un comune obiettivo, e a sanare le spaccature sociopolitiche interne. Dai primi del Duecento in Giappone governavano gli Hojo, una famiglia di reggenti che aveva promosso la filosofia meditativa dello zen. Estendendosi alla casta guerriera dei samurai e trasformandosi in scuola di stoicismo militaresco, la dottrina filosofica s’era nutrita di un misticismo nazionalista che aveva generato la setta degli hokkeshu, ispirantesi all’insegnamento di Nichiren (1222-1282). Domare un popolo innervato di combattenti così indottrinati e galvanizzati era quindi tutt’altro che una quisquilia. Richiedeva sforzi considerevoli per chiunque, compreso il khan dei khan, il dominatore unico e assoluto delle più importanti e celebrate regioni asiatiche (India a parte). Al potentato più esteso di tutta l’ecumene si opponeva ostinatamente, fieramente, un fascio arcuato di isole: sulla carta, sembrava una partita dall’esito segnato sin dal principio. Ma il bakufu, il go200
vernatorato militare giapponese, aveva già predisposto le difese dei confini nazionali, mobilitando tutti gli armigeri disponibili e rafforzando il presidio dell’isola di Kyushu. Da quel versante, giusto in faccia alla penisola di Corea, era infatti attesa un’aggressione di milizie mongolo-cinesi. Che, ineluttabile, si concretizzò nel 1274: decine e decine di bastimenti dal tonnellaggio gigantesco, migliaia e migliaia di fanti, cavalieri e marinai salparono per una spedizione da effettuare nel solco delle più classiche strategie adottate in terraferma dai reparti mongoli: fare terra bruciata tutt’intorno all’obiettivo e colpirlo in profondità, con intensità, suscitando morte, panico, terrore e un’eventuale rassegnazione nei superstiti. Le coste delle isole Tsushima e Ikishima vennero pertanto sconvolte da azioni belliche d’una spietatezza indicibile. Poi gli assalitori entrarono nella baia di Kakozaki, giungendo fin nel porto di Fukuoka/Hakata su battelli preventivamente armati dalle esperte maestranze coreane e cinesi: da soli i Mongoli, avvezzi più alla terra che al mare, sarebbero stati incapaci di operare con cognizione di causa. Qualcosa, tuttavia, andò storto, giacché gli invasori non furono in grado di perfezionare efficacemente lo sbarco programmato su tre diverse spiagge, né di incanalare le truppe sul più congeniale terreno dello scontro campale, del corpo a corpo susseguente alle cariche di arcieri e cavalleria. Del resto, i reggimenti assemblati per l’impresa erano composti in parte da ausiliari cinesi e coreani, e comunque da combattenti non tutti mongoli: soldati, insomma, che erano stati per lo più obbligati, molto di malavoglia, a imbarcarsi, e che mostravano quindi una scarsa convinzione nello slanciarsi con coraggio in un combattimento all’ultimo sangue. Gli stessi ammiragli delle imbarcazioni, da subordinati all’autorità militare mongola, se pure avevano del 201
genio guerresco non erano motivati a metterlo a frutto fino in fondo. Le squadre di cavalieri della steppa risultavano inoltre troppo poche, per potere effettivamente fare la differenza e trascinare gli eserciti del gran khan alla vittoria. Alla provvisorietà di un contingente che, dunque, si teneva assieme piuttosto stentatamente, dovettero sommarsi difficoltà che, probabilmente, si rivelarono del tutto inaspettate. La resistenza eroica e decisa dei difensori si combinò infatti con una tempesta tremenda, che nottetempo finì per decimare le navi e l’esercito khanali, provocando il fallimento totale dell’intrapresa. Di nuovo nel 1281, e con un apparato bellico ancor più dirompente, Kubilai tornerà ad attaccare in forze il Giappone, riversando una milizia immane dai porti della Corea e della Cina meridionale, dopo che a una terza ambasceria il bakufu aveva risposto uccidendo i delegati dei Mongoli. Ma di nuovo gli ardimentosi samurai – che talora osavano proiettarsi contro i colossali (e oltremodo macchinosi) navigli rivali su barche a remi minuscole e agili – riceveranno insperata manforte dall’ennesimo e inesorabile tifone, abbattutosi sulla flotta del gran khan alla fonda presso Takashima. Ormeggiati l’uno accanto all’altro nel disperato tentativo di opporsi tutti insieme, uniti, al terribile ciclone, i vascelli coleranno miseramente a picco, risucchiando nei flutti quasi la metà delle armate apprestate per la guerra giapponese. Coloro che invece avevano cercato rifugio sull’isola cadranno sotto i colpi dei guerrieri avversari, oppure verranno fatti prigionieri. Nella mentalità religiosa dei Giapponesi – che, pur avendo rinforzato la marineria, ormai disperavano di potersela cavare una seconda volta – l’inatteso uragano fu un prodigioso miracolo, il segno evidente di un intervento superiore, protettivo, salvifico: il kamika202
ze, il «vento divino», li aveva messi in salvo, manifestando la sacra tutela estesa dai numi celesti al Giappone. I relitti di entrambi quei disastri navali, del primo e del secondo tentativo d’invasione, giacciono tuttora sui fondali marini del Sol Levante, sovente in uno strato di melma sconvolto da terremoti, maremoti, tsunami, e dalle conseguenze delle esplosioni atomiche del 1945 nelle vicine Hiroshima e Nagasaki. In un denso composto di fango e sabbia, le ripetute ispezioni subacquee (eseguite principalmente da équipe dell’università di Tokyo) discernono ancora le scorie della tragedia: scafi lunghi fino a una settantina di metri; spade ed elmi in metallo, di fattura mongola; ancore in quercia rossa e granito, talvolta pesanti quasi una tonnellata; calotte fittili di bombarde, inzeppate di polvere pirica e di frammenti ferrosi che dovevano accrescerne il potenziale distruttivo; munizioni litiche per catapulte; placche metalliche con iscrizioni in cinese e mongolo; vasellame celadon confezionato in Cina e, persino, una statua in bronzo di Buddha, fusa da officine coreane. Un muraglione lungo circa ventiquattro chilometri, eretto a protezione del perimetro portuale di Fukuoka nel 1276, dà invece la misura di quanto – venti divini a parte – i Giapponesi paventassero un’aggressione da ovest. La mole della possente fortificazione pare quasi riflettere l’ansia di vedersi profilare all’orizzonte le giunche mastodontiche, coi loro alberi (da uno a cinque) ritti fra acqua e cielo, col loro carico di soldatesche bellicose e il traino di più piccole scialuppe d’assalto. Ma le possibilità di nuove aggressioni erano inversamente proporzionali alla gravità dei problemi di riassestamento politico e sociale che, sul continente, andavano risolti al più presto. La mai spenta ribellione di Kaidu, che ancora rivendicava per il ramo ogodeide il supremo potere 203
sui Mongoli, s’era rafforzata nell’alleanza col khanato chagataide e con Möngke Temür, khan dell’Orda d’Oro (12601280). Le complicazioni erano aumentate allorché anche Chirki, figlio di Möngke Khan, aveva ammutinato. Di fronte al pericolo che l’insurrezione potesse estendersi a tutti i distretti centro-asiatici, Kubilai aveva reagito inviando le proprie armate fra il 1275 e il 1278 a ripristinare la propria autorità, l’autorità del khan dei khan. In molti fra i sediziosi erano stati indotti a cedere. Non Kaidu, però, che aveva mantenuto intatti i suoi propositi rivoluzionari. Di lui, tuttavia, troppo non ci si poteva occupare. Gli sforzi maggiori di Kubilai erano concentrati più a sud. Nella Cina dei Song.
3 | La dinastia Yuan Nel 1271-1272 Kubilai Khan aveva voluto sancire per la sua dinastia la condizione di principato universale e, su consiglio dell’influente saggio Liu Bingzhong, le aveva annesso il titolo di Da Yuan, «Grande Origine» o «Forza Primordiale», tratto simbolicamente da una citazione degli esagrammi dell’I Ching (nel Classico della Mutazione, uno dei testi del canone confuciano). Inserendosi col proprio casato nella sequenza dinastica cinese, Kubilai si dichiarava esplicitamente signore assoluto non solo dei Mongoli, ma anche della Cina. Una Cina che, in realtà, rimaneva spezzata in due: i Song non intendevano infatti cedere i dipartimenti centromeridionali: quelli dove, in definitiva, s’erano preservate le più autentiche tradizioni nazionali. Quelli attraversati da benessere e prosperità, immuni dalle guerre e dalle rivoluzioni che per secoli avevano tormentato, più a settentrione, il Catai. 204
La Cina dei Song era in effetti un territorio fra i più progrediti del Duecento, infoltito da un vivificante boom demografico e sostenuto da un’abbondante risicoltura: il clima monsonico apportava piogge propizie e la fertilità del suolo permetteva anche due raccolti all’anno. L’introduzione dal Viet Nam d’un tipo di riso a maturazione veloce, e l’adozione di sementi variegate si coordinava con un sistema di irrigazione esteso a colture multiple, per cui in alcune regioni la disoccupazione stagionale risultava praticamente inesistente. Al rigoglio agricolo si univa una marcata tendenza all’urbanizzazione: i centri abitati pullulavano di commerci terrestri e marittimi, gli scambi si facevano ormai con la cartamoneta, e l’intenso sviluppo economico favoriva la promozione delle arti e della cultura. L’invenzione della stampa aveva consentito una diffusione rapida dei libri, e i cenacoli filosofici s’erano moltiplicati. Lo studio della letteratura e della storia veniva incoraggiato dal mecenatismo pubblico e privato, e nell’Accademia di pittura – un’apposita istituzione statale – da sempre gli artisti trovavano l’atmosfera ideale per coltivare il loro genio. Persino l’artigianato toccava i vertici dell’arte: il vasellame Ding, sottilissimo e traslucido, inciso talora da ornamenti leggiadri, prendeva forma nelle fornaci del Jiangxi, mentre i ceramisti di Longquan, nel Zhejiang, producevano una ceramica ben riconoscibile e ricercatissima ovunque, con le sue infinite sfumature grigioverdi e le tipiche screpolature a tela di ragno. Il dinamismo culturale e scientifico dell’epoca Song, da cui derivavano anche la bussola e la polvere da sparo, era impetuoso. Di fronte all’esuberanza dell’imprenditoria mercantile il secolare feudalesimo si avviava al declino, e contemporaneamente la classe dirigente confuciana veniva messa in discussione dai finanzieri più facoltosi, che con le 205
fortune accumulate avevano acquisito un peso determinante nella politica e nell’economia. Una rinnovata civiltà urbana stava insomma maturando nella Cina del Sud di pari passo con lo sviluppo di una mentalità borghese. Dall’evoluzione della società e dai profitti restavano peraltro escluse le masse contadine, schiacciate dal latifondismo e angustiate dalle tassazioni imperiali (che i ceti mercantili o aristocratici cercavano di evadere). Per questo, dal 1263 il primo ministro Jia Sidao aveva inaugurato una politica di riforme economiche tese a limitare le dimensioni massime della proprietà terriera, e a obbligare gli evasori a un più rigoroso regime fiscale. Scontente per la perdita dei privilegi, le categorie più abbienti avevano tolto l’appoggio alla casa regnante, indebolendo la compagine statale esattamente nel momento in cui Kubilai Khan s’era risolto a impadronirsi, una volta per tutte, dei territori dei Song. Il nodo era nelle località di Xiangyang e Fancheng. Situate su opposte rive del fiume Han, fortificate in posizione dominante, le due città avevano costituito per decenni l’ultima postazione difensiva prima dell’accesso al bacino dello Yangtze (o Chang Jiang, il Fiume Azzurro), il cuore pulsante della Cina meridionale. Fu una faccenda maledettamente complicata, quella dell’assedio. Ne racconteranno sia la Yuan shi (Storia degli Yuan), sia Rashid al-Din: le schiere mongole si fecero sotto nel 1268 e diedero avvio al blocco ossidionale, chiudendo i borghi in una morsa che, nelle ipotesi di attacco, a lungo andare avrebbe dovuto rivelarsi soffocante. E invece, sfruttando la rodata navigazione sui corsi fluviali, i vascelli dei Song erano in grado di assicurare rifornimenti agli assediati: i quali, di per se stessi, avevano già curato di immagazzinare provviste per resistere lungamente. Qualche timida sortita dei difensori, animati dal generale Liu Wenhuang, era servi206
ta più che altro a punzecchiare le truppe d’invasione, ma non a rimuovere lo stallo, che minacciava di protrarsi all’infinito se a rompere l’inerzia non fosse sopraggiunto, nel 1272, un soccorso tecnologico provvidenziale. All’il-khan Abaqa era stata infatti richiesta da Kubilai maestranza suppletiva: ingegneri, esperti, periti d’armi che magari si fossero istruiti nelle logoranti guerre mediorientali, e che avessero acquisito tecniche belliche o sperimentato metodiche da trasporre più a levante, laddove degli ordigni innovativi avrebbero potuto rivelarsi più efficaci, in quanto ignoti agli avversari. Dalla Persia erano perciò arrivati dei tecnici specializzati che poterono esaminare i fossati da superare, le muraglie da abbattere, le distanze da accorciare. Studiarono la topografia. E progettarono: crearono marchingegni dal tremendo impatto, mangani terrificanti, catapulte mai viste in Oriente e capaci di scagliare massi devastanti, del peso di oltre trecento libbre. Quando i proiettili partivano, pare che il frastuono fosse tale da scuotere il cielo e la terra: e qualsiasi cosa venisse centrata finiva irrimediabilmente in frantumi. Sottoposta a un martellamento ininterrotto, senza requie, con la cittadinanza spossata dall’accerchiamento, Fancheng era caduta per prima. Poi, nel marzo del 1273, aveva capitolato anche Xiangyang. La roccaforte s’era arresa sia per la stanchezza della popolazione sia per il decisivo intervento degli specialisti provenienti dall’il-khanato, e dunque da un contesto più occidentale, dove si aveva maggiore dimestichezza con determinati congegni bellici. Nei Polo, che appresero della vicenda, un pizzico d’invidia dovette forse insinuarsi, per non essere stati loro, degli occidentali per l’appunto, i protagonisti di un bombardamento tutto sommato abituale nelle contese euromediterranee. I viaggiatori veneziani sarebbero ben potuti risultare 207
gli artefici dell’azione che aveva permesso a Kubilai di procedere nel completamento delle sue conquiste: e vantarsene, con chi non conosceva come si fossero realmente svolti i fatti, sarà una tentazione a cui Marco, Niccolò e Matteo non sapranno sottrarsi nei racconti orali e scritti che vorranno successivamente proporre delle loro avventure cinesi. Di fatto, il conflitto coi Song era giunto a una svolta. Le milizie mongole, capitanate da Bayan detto «il Cento occhi», avevano potuto avanzare irresistibilmente verso le cittadine meridionali. Una grossa armata comandata da Jia Sidao era stata seccamente battuta, col conseguente licenziamento del ministro. I latifondisti, vista la malaparata, avevano incominciato ad aprire le braccia all’invasore. All’opposto, i contadini avevano provato a organizzare un minimo di resistenza guerrigliera, delusi da un governo centrale che non aveva saputo proteggerli e che si ritrovava allo sbando. Duzong, l’imperatore, era venuto a mancare e nel 1275, al suo posto, gli ufficiali di corte avevano intronizzato col nome di Gongdi un bambino di cinque anni. Parecchie piazzeforti erano crollate con un «effetto domino». E quando anche Anqing, Wuhu e Nanchino avevano ceduto, la grandiosa capitale Lin-An (oggi Hangzhou) s’era ritrovata irreparabilmente sola, senza più copertura, in balìa del nemico. Vecchia e malata, l’imperatrice Xie, la madre di Duzong, aveva inviato ai mongoli un messaggio col quale li invitava a ritirarsi in cambio d’un consistente riscatto. Non se n’era fatto nulla: le milizie di Kubilai avevano completato l’aggressione penetrando nella metropoli. Ma erano stati evitati massacri, distruzioni e depredazioni. La popolazione, per quanto possibile, era stata rispettata, e lo stesso piccolo imperatore decaduto, spedito in ostaggio dal gran khan, aveva potuto godere d’un trattamento più che onorevole. 208
I fratellastri del deposto sovrano, invece, s’erano dati alla fuga e avevano imbastito una residua, ostinata opposizione all’invasione che le schiere mongole, condotte dai generali Arik Kaya e Sogetu, stavano estendendo progressivamente alle province dell’Hunan, del Fujian e del Guangdong. Ancora per un po’, dal 1276 i partigiani cinesi si interporranno alla completa dedizione agli Yuan. Resisteranno per terra e per mare, in uno stillicidio di sangue e disperazione, ora arretrando e ora frenando l’avanzata nemica. Le popolazioni di Changsha nell’interno, di Fuzhou, Quanzhou e Canton (la Guangzhou odierna) sulla costa vedranno gli eroici, inutili tentativi di opposizione al dilagare mongolo. Il conflitto si chiuderà il 3 aprile del 1279 con uno scontro navale: nelle acque del Mar Cinese Meridionale, vicino all’isola di Yaishan, una squadra di Kubilai sconfiggerà la flotta dei lealisti. La marineria, quella che avrebbe potuto essere il perno per una riscossa, l’arma con cui scompigliare i porti degli Yuan e progettare il rientro in Cina, veniva anch’essa cancellata. Quando pure gli ultimi Song saranno annegati, il reame che essi avevano strenuamente difeso potrà considerarsi definitivamente incorporato nel dominio del gran khan. Per la prima volta nella sua storia, la Cina tutta intera era in potere di una monarchia che, pur d’origine nomade, pretenderà di essere riconosciuta dal popolo sottomesso quale legittima detentrice del mandato celeste.
4 | Un pranzo di tre giorni Fu in tutto questo che i Polo entrarono in contatto con Kubilai Khan. L’aver dovuto attendere parecchi mesi per otte209
nere udienza era più che scontato, vista la complessità del frangente politico e gli impegni, soverchi, di un sovrano assorbito dalle gravose incombenze militari. D’altronde Niccolò, Matteo e Marco non erano gli unici a essersi spinti fin laggiù. Il flusso ingente e continuo di viaggiatori, mercanti o ambasciatori che a vario titolo aspiravano a un colloquio col nuovo signore dell’Asia rendeva i Polo, a quasi dieci anni dal primo incontro, dei visitatori uguali a tanti. Per Kubilai, i tre audaci veneziani erano presumibilmente né più né meno che degli onest’uomini, che come molti altri avrebbero potuto essere congedati abbastanza presto se non si fossero rivelati di un qualche interesse per l’apparato istituzionale, ovvero per l’economia di uno Stato in evoluzione, di un governo in costruzione, di un impero dalla duplice anima: una che allignava in Cina, e l’altra che non dimenticava la Mongolia. Una urbana, l’altra nomadica. Ecco perché c’era Dadu/Pechino, capitale di sotto, emblema del vivere cittadino, proiettata nel futuro degli Yuan; e c’era Kaiping/Shangdu, capitale di sopra, residenza imperiale per l’estate, affacciata sulla steppa e, dunque, sul passato. Proprio là erano attesi i Polo, dove il gran khan trascorreva i mesi caldi evadendo dall’afa e dall’umido pechinese, e dove dispiegava il suo enorme baldacchino regale, sfarzoso e adatto a contenere centinaia di ospiti. La prateria verdeggiante di Jinlianchuan, le acque del fiume Luan e dello Shandian, la Collina del Drago, la doratura dei fiori di loto e gli aromi della natura conferivano un incomparabile incanto a quell’angolo fatato del pianeta. I poeti di epoca yuan vi decantavano le «greggi e mandrie pascolanti alla luce del tramonto», placide attrici di una campagna in cui «le erbe selvatiche profumano e il formaggio è dolce». Nei dintorni, nello sfumare dell’orizzonte, si distendeva un paesag210
gio composito. A settentrione il grande deserto. A meridione le province dell’Hebei e, verso levante, del Liaoning. Più a ovest, Tenduc e il comprensorio degli Onguti, terra di ciambellotti e lapislazzuli, di mercanti e artigiani, governata per conto del gran khan da Giorgio, un altro di quei regnanti cristiani che a Marco Polo suggerivano un’ascendenza dall’onnipresente «Prete Gianni», e la cui famiglia s’era imparentata con la stirpe khanale grazie a matrimoni combinati. Intorno all’antica Prefettura di Kaiping tutto sembrava evocare steppe e nomadismi, vastità da percorrere e libertà degli spostamenti. Mobilità, cambiamenti. Ma Shangdu era tutt’altro che un insediamento mobile. Ferma, murata, Shangdu era tre città in una: la Città del Palazzo, la Città Imperiale e la Città Esterna. La sbalorditiva sensazione che dovette suscitare in Marco quella metropoli sfolgorante sui prati è fedelmente documentata dalle vestigia che le indagini archeologiche vanno restituendo. Imponenti porte urbiche con corti d’ingresso quadrate o a ferro di cavallo, muraglie marmoree con l’anima in loess pressato, vie ordinate, torri di guardia, magazzini, botteghe, abitazioni, rioni popolari e quartieri nobiliari sono riconoscibili nel verdeggiare della pianura. I segmenti di un amplissimo cortile sembrerebbero indiziare il favoloso giardino imperiale, che accoglieva animali e uccelli rari e che, ingentilito da piante esotiche, invitava al divertimento e allo svago una corte khanale che amava bearsi nel lusso e nei piaceri. Il diletto lo davano pure i pranzi ridondanti preparati per il gran khan e il suo corteggio: più di mille banchettanti in contemporanea potevano desinare nel palazzo Zongmao, che ospitava il convivio dello Zuoma. Durava tre giorni la festa più splendida e costosa, riunendo aristocratici, guardie imperiali e ministri in un 211
grandioso padiglione che possedeva una travatura di bambù e delle figure serpentiformi in lacca aurea attorcigliate ai pilastri. Nel salone, che era alto più di cento piedi e che veniva saldamente ancorato all’esterno tramite dei tiranti di corda tinteggiata, campeggiavano dipinti murari con ornamentazioni floreali e zoomorfe. Tutti i convitati erano tenuti a presenziare ai festeggiamenti con l’abito Zhisun, donato loro dall’imperatore e caratterizzato dall’uniformità del colore per il copricapo e il vestito: e ad ogni tornata di quei roboanti sollazzi s’imponeva il cambio obbligatorio degli indumenti, che dovevano essere sempre diversi. Tutto lo sfarzo profuso per le liturgie imperiali si avverte ancora nei numerosi frammenti che delle architetture palaziali sono stati rinvenuti, e che sfoggiano decorazioni floreali in marmo, basi di colonne, pavimentazioni policrome, gocciolatoi sagomati a testa di drago e tegolame invetriato. Impronte di edifici buddhisti, taoisti, confuciani e musulmani paiono poi confermare quell’eclettismo religioso che i gengiskhanidi propugnavano per realizzare una pacifica coesistenza fra le varie fedi del loro immenso potentato. Benché, va detto, non sempre potessero evitarsi le scintille: nell’estate del 1258, ad esempio, quando ancora non era divenuto gran khan, Kubilai aveva ricevuto da Möngke l’incarico di presiedere in Kaiping/Shangdu a un dibattito fra i seguaci del Tao e i devoti del buddhismo. La disputa era proseguita fino al crepuscolo, allorché i diciassette discepoli del taoismo erano stati dichiarati perdenti: spogliati, gli si era allora imposta la tonsura affinché fossero fatti monaci del Buddha. Ma non di sola religione si viveva nella capitale estiva. «Ad ovest della via imperiale», cantavano gli aedi, «a fianco del ponte sul fiume Luan, le insegne del vino stanno appese oblique, il sole cala sotto gli spioventi dei tetti». E ancora: 212
«Dieci jin del buon vino del fiume Luan. Scendo da cavallo e bevo senza contare i soldi». In effetti, esternamente alla Porta Mingde, gli scavi hanno intercettato la zona delle osterie e delle botteghe preposte alla somministrazione di bibite alcoliche. Fuori dalla Porta Yutian erano invece allineati i locali in cui verosimilmente i funzionari militari e civili si fermavano, in attesa di essere ricevuti dall’imperatore. La sosta poteva essere più o meno prolungata. Era infatti possibile che Kubilai si trovasse momentaneamente altrove. Magari una trentina di chilometri più a nord-ovest, a compiere sacrifici per il Cielo Eterno e per gli antenati. E magari presso l’altare di Yangqunmiao, che gli archeologi hanno rinvenuto nel 1992, adorno di quattro raffinate statue in pietra. Nei versi delle poesie yuan è immortalato il rituale a cui il sovrano officiava: «Sacrificando al Cielo, si spruzzava il vino di giumenta sulla pianura selvaggia. Il vento del deserto si alzava, e con esso le erbe emettevano i loro profumi». Più che probabile era poi che Kubilai se ne andasse in giro per dedicarsi alla caccia con il falcone, uno dei suoi passatempi preferiti, realizzabile agevolmente per la dovizia di cervi, daini e caprioli. Tutto sommato, a Marco Polo dovette sembrare un’attività ricreativa più che normale e, soprattutto, in linea con il rango principesco: come in Europa i monarchi e gli esponenti del ceto aristocratico, così nel Levante la passione per la falconeria, classico intrattenimento da nobilicortesi, contraddistingueva il gran khan. Riferita a un semplice gioco, l’omologazione culturale era ovviamente solo apparente e abbastanza superficiale. Ben più profonda, a un livello che si potrebbe dire «genetico», era invece la mescolanza di culture che l’impero degli Yuan si trovava a governare: dalla necropoli di Zhenzishan, a sud-est di Shangdu, accanto a sepolture che denunciano prevedibilmente un’etnia cine213
se o mongola, sono riemerse le spoglie di individui di razza bianca. A meno di non volerli collegare con «i più bianchi uomini del paese e’ più begli e’ più savi» che Marco Polo poté discernere per il Tenduc (forse eredi di un originario ceppo indoeuropeo dell’Asia centrale, accertato con sicurezza fino all’VIII-IX secolo), quei resti, assieme al reperimento di alcune iscrizioni in arabo, sarebbero il sintomo di una polarizzazione multiculturale e multietnica. Interrelazioni dunque, scambi, immigrazioni, permanenti o temporanee. Provenienti da Venezia, a quel flusso s’erano aggregati anche i Polo. Con l’estate del 1275 si ritrovarono a Shangdu, genuflessi innanzi a Kubilai, nella deferenza prescritta da un cerimoniale che un po’ era mongolo e, molto, cinese.
Capitolo undicesimo
ALLA CORTE DELL’IMPERATORE
1 | Questione di feeling Non potevano che essere lì. Da mercanti intraprendenti e previdenti, da veri veneziani, i Polo erano risaliti direttamente alla fonte dei commerci, all’origine delle mercanzie, alla sorgente stessa dei guadagni. Laddove, insomma, scoccava la scintilla dei movimenti d’affari internazionali. Soluzione inevitabile. Scelta indifferibile, se ancora si intendeva operare ai livelli economici raggiunti nei decenni precedenti. Bisanzio, con la sua piazza, rimaneva un punto interrogativo: da un anno all’altro l’avvicendamento del basileus poteva ribaltare gli indirizzi commerciali a seconda delle contingenze, delle convenienze o delle inclinazioni personali del sovrano di turno. Nei distretti siro-libano-palestinesi le crociate avevano agitato e incattivito gli animi, e la disgregazione dei presidi latini di Terrasanta non prometteva nulla di buono, specie per chi aveva commerciato liberamente imparando ad apprezzare la bontà e la varietà dei prodotti che dal Levante affluivano nei porti mediterranei. Per di più, l’asse politico-religioso che s’era andato consolidando dal 1263 fra il khanato dell’Orda d’Oro e il sultanato d’Egitto, entrambi retti da dinastie votate all’islam, proiettava un’ombra oscura sulle reali possibilità che i traffici lungo le direttrici mediorientali potessero effetti215
vamente mantenersi inalterati. L’apparente volontà, del khan e del sultano, di continuare a favorire entro i relativi principati un’economia collegata all’importazione e all’esportazione delle merci levantine, non poteva dare certezze a lunga scadenza. E l’irrequietezza di Baibars, che ancora nel 1275 aveva sconquassato l’Armenia Minor saccheggiando diverse località della Cilicia, cagionava ansie e preoccupazioni in coloro che erano abituati a frequentare disinvoltamente il Vicino Oriente e gli empori egiziani. Verso Alessandria erano confluite per un periodo prolungato le porcellane, le spezie, le seterie e tutti i prodotti orientali che, sulla Via marittima della Seta, partivano dalla Cina e transitavano per le coste del Sud-Est asiatico, approdando al Golfo Persico, al Mar Rosso e alle sponde settentrionali dell’Africa. Il delta del Nilo era il fulcro degli scambi: i mercanti cinesi, indiani, e in genere asiatici vi riversavano i loro pregiati articoli, che i mercatores europei (specialmente quelli di Venezia) acquistavano in gran copia per rivenderne in Occidente. L’Egitto era stato quindi per molti decenni un raccordo ineludibile, un crocevia essenziale per le relazioni che avevano permesso alla galassia mercantile dell’Oceano Pacifico di correlarsi col Mediterraneo, al Cinese di incontrare il Veneziano. E Il Cairo non aveva quasi mai osteggiato la pluralità etnolinguistica delle genti che, per commerciare, erano solite riversarsi nelle province egiziane da ogni cantone. Ma l’intransigenza dei dinasti mamelucchi, la loro palese aspirazione a sbarazzarsi dei Latini in un’ampia fascia territoriale che dalle sponde nordafricane tendeva a saldarsi con le steppe russe dell’Orda d’Oro, determinava insicurezza e precarietà insostenibili per gli operatori commerciali. Alle difficoltà pratiche si sommavano altresì delle re216
more morali, per le inesauste interdizioni di un papato che vietava ai cristiani di intrattenere qualsiasi rapporto coi regnanti cairoti: con quei sultani islamici che, nell’opinione della Chiesa di Roma, avevano osato occupare Gerusalemme e i Luoghi Santi della cristianità: e ancora nel Trecento il doge di Venezia scriverà a papa Giovanni XXII (13161334) per chiedergli il permesso di commerciare con Alessandria e gli altri territori sultanali. Gli assestamenti politici che si stavano configurando in Medioriente nel trentennio finale del Duecento sembravano dunque inibire la prospettiva di commerci aperti e durevoli. L’instabilità era avvertibile, quasi tangibile da coloro che avessero un po’ di lungimiranza. In molti non ritenevano che fosse più agibile con sufficiente tranquillità quell’Egitto dove il Levante, con le sue derrate, era stato percepito forte, e aveva fatto invaghire di sé gli occidentali. Per come si presentava adesso, il regno mamelucco andava in qualche modo bypassato: ed era quanto avevano fatto Niccolò e Matteo Polo, assieme a Marco, allettati dai rinnovati scenari commerciali che per gli stranieri s’erano dischiusi in Estremo Oriente su impulso di Kubilai Khan. I Polo sapevano che con artigiani e mercanti i Mongoli avevano avuto sempre un ottimo feeling, e che quindi la dominazione yuan avrebbe finito per aprire la «scatola» del commercio cinese ai trafficanti stranieri, schiudendo loro le immense ricchezze della Cina, a cominciare dalla pregiatissima seta. In un impero cosmopolita, che aspirava a definirsi universale, anche gli imprenditori occidentali avrebbero partecipato alle enormi opportunità d’arricchimento offerte dalle risorse di un territorio traboccante di beni: nel rimescolare le carte, la nuova signoria sino-mongola aveva cambiato le regole e disserrato il succulento forziere asiatico, 217
porgendone i copiosi tesori a chiunque fosse stato in grado di servirsene per creare (e per crearsi) ulteriori benefici. Criteri inediti disciplinavano ora il mercato cinese: il sistema degli ortogh permetteva ad esempio alle corporazioni commerciali di incentivare i traffici tramite i fondi concessi da finanziatori (soprattutto mongoli) che impegnavano una sorta di «capitale di rischio» nell’allestimento di carovane deputate a realizzare profitti. Quelle stesse compagnie mercantili potevano a loro volta dispensare prestiti con una disponibilità istantanea: e la solerzia che un mercante manifestava nell’assecondare con il credito immediato le esigenze di un qualsivoglia aristocratico (o anche della stessa corte imperiale, pressata talora dall’urgenza di sovvenzionare una qualche guerra) veniva, di norma, ricompensata assegnando al creditore una posizione preferenziale nei finanziamenti delle sue future intraprese mercantesche. Ma non era solo con questo dispositivo che il governo degli Yuan regolava le attività commerciali. Fra i privilegi accordati agli allogeni rientrava pure il diritto di muoversi liberamente nei territori cinesi, ovunque essi volessero e con la priorità nei trasporti delle merci. Inoltre, un commerciante europeo o centro-asiatico che si recasse in Cina non veniva gravato né dalle esazioni sulle mercanzie né dalle tasse doganali. Aveva soltanto l’obbligo di cambiare l’oro e l’argento con la cartamoneta, la cui emissione era gestita direttamente dal ministero del Tesoro yuan. Le agevolazioni godute permettevano così un accumulo notevolissimo di sostanze che, molto spesso, venivano trasferite all’estero, nei paesi di provenienza dei mercanti forestieri. A immiserirsi era di conseguenza la locale classe mercantile, condannata a una progressiva scomparsa, o al massimo a una stentata sopravvivenza, in condizioni sfavo218
revoli e, frequentemente, in posizione subordinata, al servizio degli stranieri. Una tale politica non era affatto controproducente o contraddittoria, per un impero che doveva contemperare esigenze di governo e rigurgiti ribellistici. Rispondeva, piuttosto, a un preciso disegno: asfissiare il commercio cinese per neutralizzare l’influenza di un settore particolarmente intraprendente ed energico della società assoggettata, soprattutto nelle terre di più recente acquisizione. All’indomani della conquista del regno dei Song, sarà in particolare nella Cina del Sud che verranno imposte delle drastiche limitazioni, dirette a infiacchire il ceto mercantile. Tradizionalmente attivi e influenti, con la loro vitalità i commercianti cinesi (e specialmente quelli meridionali) rappresentavano una potenziale minaccia per un organismo statale che necessitava d’esser padroneggiato, anche economicamente, dai nuovi dominatori. Kubilai voleva evitare che le pulsioni nazionalistiche e le rivolte, sempre serpeggianti, sempre in agguato e pronte a deflagrare, potessero essere alimentate da congrui sostegni materiali: e pertanto l’amministrazione imperiale mirava a sostituire gradualmente i mercanti indigeni con gli esterni. Che fossero euromediterranei o dell’Italia settentrionale, tutti erano ben accetti, qualora fossero funzionali alla realizzazione di un programma amministrativo che contemplava il ricorso a personale straniero. E non soltanto per le questioni puramente commerciali: alla bisogna, gli uomini più preparati e capaci sarebbero stati utilizzati dagli Yuan per adempiere a mansioni burocratiche spesso rilevanti, con incarichi governativi ragguardevoli, o col compito di consiglieri militari e finanziari. E i Polo certo non intendevano lasciarsi sfuggire tutte queste opportunità. 219
2 | Banconote inflazionate Era un musulmano della Transoxiana, Ahmed Fenaketi, ministro del Tesoro degli Yuan. Un autentico genio della finanza, secondo alcuni. Uno sfruttatore cinico e spietato, che si arricchiva illecitamente ed esercitava un nepotismo sfrenato, secondo altri. Quest’uomo astuto e prepotente, proclive alle malversazioni e alle belle donne, che elargiva nomine governative pretendendo in cambio (con le buone o con le cattive...) la compiacenza delle mogli più attraenti, delle figlie più fascinose o delle sorelle più allettanti dei funzionari nominati, aveva il compito precipuo di accrescere le entrate dell’impero. Per riuscirvi, s’era prefisso di aumentare sostanziosamente il numero dei contribuenti, e aveva previsto di istituire monopoli governativi su tè, liquori, aceto, oro e argento. Un mestatore di tal fatta col denaro pubblico ci giocava: così, le emissioni di ingenti quantitativi di cartamoneta dovevano avere, in teoria, lo scopo di compensare il deficit causato dalla tesaurizzazione estera dei proventi cinesi, effettuata dai mercanti forestieri. Nel concreto, la circolazione di biglietti in esubero generava un’ovvia inflazione, che oberava innanzitutto le fasce deboli della popolazione: e conseguenza della svalutazione monetaria sarà a un certo punto l’abbattimento del valore nominale delle banconote, che finiranno per non essere accettate più nemmeno dagli stessi enti statali. Dei servigi di un Ahmed Fenaketi, tuttavia, la corte sino-mongola di Kubilai non poteva privarsi tanto facilmente. L’immenso complesso di uffici e organismi amministrativi aveva un assoluto bisogno di affidarsi, per i ruoli chiave, a professionisti della dirigenza, che oltre ai Mongoli (numericamente esigui, e talora impreparati a governare un colosso 220
come la Cina) erano sovente degli intellettuali immigrati. Il ricorso a stranieri era una prassi per gli Yuan, che frastagliando l’amministrazione in una burocrazia non solo conferita a specialisti ma, pure, etnicamente composita, potevano schivare i pericoli di corporativismi o di nazionalismi fuori controllo. L’economia o le incombenze ministeriali erano pertanto gestite da personaggi che, come l’islamico Sayyid Ajall Shams al-Din (originario di Buhara e mandato fra l’altro a governare brillantemente lo Yunnan) o come l’uiguro Sanga, potevano provenire un po’ più da occidente. Dalle province siriane era in effetti approdato in Cina Isa, delegato degli Yuan presso l’il-khan nonché commissario del culto cristiano, in sintonia con la propria fede religiosa. E a un altro occidentale devoto dell’islam, lo scienziato proveniente dalla Spagna Muhyi al-Milla al-Din al-Maghribi, conoscitore di varie lingue centro-asiatiche ed esperto di matematica, astronomia e scienza medica, era stata assegnata la direzione di due importanti istituti pubblici, l’Ufficio della medicina e l’Ufficio del calendario astronomico: e proprio con l’intermediazione del celebre luminare giunto dalla penisola iberica verranno introdotte nelle province cinesi la geometria euclidea e le teorie di Tolomeo sui corpi celesti. L’intensificarsi delle relazioni fra il Ponente e il Levante, la fluidità degli spostamenti, il lievitare degli interscambi scientifici incentivavano il dare e l’avere fra culture che, quando s’accostavano l’un l’altra, fecondandosi reciprocamente, generavano progresso. Si vuole che uno dei doni cinesi all’Europa sia stata la ferratura dei cavalli, la quale poté facilitare la percorrenza delle vecchie strade cadute in rovina, assecondando la rivoluzione commerciale. E s’è scritto che la tecnica del giogo a spalla, trasposta dalle cam221
pagne cinesi a quelle europee, dovette agevolare l’aratura profonda quadruplicando la forza di trazione animale. Le mappe marine, le carte nautiche, si suole ritenere che siano tutti regali fatti dalle scienze cinesi all’ecumene medievale. E già dalla fine del XII secolo erano approdate in Italia le procedure per l’allevamento dei bachi e la filatura della seta, da cui nasceranno le famose produzioni seriche di Lucca, Venezia, Firenze, Bologna e Genova. Macchinari per filare, ricamare o cucire (anche broccati dorati) rappresenteranno l’ennesimo lascito dell’industria e dell’artigianato di Cina. E assieme agli occhiali e al calcolo meccanico del tempo, che furono realizzazioni di matrice prettamente occidentale, Friedrich Engels elencherà nel XIX secolo altre cinque scoperte tecnico-scientifiche ritenute basilari per lo sviluppo della società europea, tutt’e cinque derivate dalla Cina (come anche recentemente ha ricordato Zhang Kai, membro dell’Istituto di Storia dell’Accademia cinese delle Scienze sociali): la carta, i caratteri mobili, la polvere pirica, l’ago magnetico e la stampa. Karl Marx andrà ancora più avanti, sottolineando come l’avvento della borghesia fosse stato annunciato proprio dalla polvere da sparo (che aveva distrutto la classe dei cavalieri), dalla bussola (che aveva dischiuso le rotte del mercato mondiale e portato alla creazione di colonie) e dalla stampa (che diventerà uno strumento del protestantesimo). Qualunque possa esser stato l’esito per la storia economica moderna di tali invenzioni, è un fatto che l’epoca degli Yuan contribuì a diffonderne gli effetti con un’ampiezza tale da accelerare enormemente la trasmissione delle conoscenze scientifiche e culturali. Il principato di Kubilai Khan, con la sua vocazione cosmopolita, era irrinunciabilmente aperto alle relazioni esterne. Viceversa, al suo interno il regno appariva bloccato, segmentato in una società a compar222
timenti stagni. Il sistema legislativo frazionava infatti il popolo in diverse categorie, ciascuna coi propri diritti e doveri. Quattro erano i gruppi che ne risultavano: il più importante annoverava i Mongoli, suddivisi nei sottogruppi delle genie antiche, dei Tartari bianchi, dei Tartari neri e dei Tartari non urbanizzati. Dietro la classe dominante venivano i Semuren (la «gente dagli occhi colorati»), comprendenti gli asiatici – di stirpe prevalentemente turca o iranica, e di religione musulmana o nestoriana – che si erano affiancati ai conquistatori mongoli nelle loro imprese: ed erano gli appartenenti a questa categoria che potevano esercitare i commerci, accedere alle cariche istituzionali e usare le armi. Più sotto stavano gli Hanren (la «gente di razza Han»), gli abitanti della Cina settentrionale, il vecchio Catai, un misto di Jurcet, Kitai e Coreani. Ultimi, al grado infimo della scala sociale, i Nanren (la «gente del Sud») erano i Cinesi di più fresca sottomissione, residenti nei territori meridionali del precedente reame Song. Le loro prerogative apparivano davvero minime, se non proprio nulle: il divieto di addestrarsi nell’uso delle armi e di portarne, l’inibizione ad apprendere la lingua mongola, l’interdizione a contrarre matrimoni misti erano misure volte a tenere lontani dalle cariche statali e da ogni intromissione politico-istituzionale i cittadini di un Sud prospero e civilizzato. Privati quasi d’ogni diritto, i Nanren erano per giunta obbligati a provvedere materialmente, col proprio lavoro, al mantenimento di oltre un milione fra Mongoli e Semuren: sicché ciascun capofamiglia mongolo poteva controllare una ventina di famiglie cinesi da cui ricavare sostentamento per sé e i propri familiari. La sperequazione – comunque da considerare normale, in un contesto storico e sociale premoderno, che non aveva assimilato il concetto d’uguaglianza – investiva pari223
menti l’ambito giudiziario: gli iscritti alle classi privilegiate venivano processati secondo le leggi mongole, mentre per i Cinesi valevano le leggi cinesi, comprensive del tatuaggio che, come già prescritto dal codice dei Song, marchiava a vita (e a vista) il colpevole di un delitto. È pur vero che nei casi legali particolari, in cui a confrontarsi erano un mongolo e un cinese, venivano allestiti degli speciali tribunali per cause promiscue: ma di solito la bilancia della giustizia pendeva sempre dalla stessa parte. E tuttavia, quantunque Kubilai badasse accuratamente a escludere l’etnia cinese dalle faccende amministrative, un posto di spicco presso gli Yuan poterono trovarlo consiglieri della levatura di uno Xu Heng, dotto neoconfuciano che sosteneva la necessità per gli studiosi di non aborrire i Mongoli bensì di civilizzarli, o di un Wang E, illustre storiografo che proponeva di guardare alle dinastie passate per trarre modelli da adottare nel presente: fu costui che convinse Kubilai a istituire un Ufficio di studi storici. D’altronde, l’imperatore era troppo intelligente per non riconoscere l’importanza del confucianesimo e la finezza dei suoi rappresentanti: finì perciò con l’avere meno remore nell’ingaggiare in qualche occasione – pur con la debita ponderazione – dei magistrati confuciani, promuovendo la traduzione in mongolo del pensiero di Kong Fuzi, il «maestro Kong» (latinizzato come «Confucius»). Naturalmente, non sempre le lusinghe imperiali facevano breccia fra i letterati, i filosofi o gli artisti: l’eccelso Liu Yin (1249-1293) rifiuterà di divenire accademico dell’Istituto imperiale, scegliendo di appartarsi in quel «romitaggio confuciano» che unirà parecchi pensatori nella protesta silente contro una dinastia considerata usurpatrice. Coloro che invece cercavano un appagamento spirituale (e un soste224
gno materiale) si dedicheranno alla drammaturgia, propedeutica a un intrattenimento, quale era il teatro, che avrà grande fortuna con Kubilai e i suoi successori. Erano cambiate parecchie cose: nel passato, gli intellettuali avevano potuto intraprendere carriere politico-amministrative che permettevano esistenze confortevoli, senza rinunciare all’esercizio delle arti o alla prosecuzione delle ricerche scientifiche e filosofiche. Ma coi rivolgimenti cagionati dai sospetti della casata yuan nei riguardi dei Cinesi, fior di studiosi e intellettuali erano diventati drammaturghi: non potendo accedere – come accadeva un tempo – alle cariche pubbliche, avevano ripiegato sulla scrittura teatrale. Per sbarcare il lunario, non si trovava niente di più soddisfacente.
3 | Nel nome del Buddha La drammaturgia era stata a lungo disdegnata in Cina. Letteratura marginale, secondaria. Produzione per gente incolta, forma di passatempo popolare. Ma dacché vi si erano indirizzati dei maestri di stile, culturalmente attrezzati per compilare trattati filosofici o storici, l’intensità e la bellezza delle produzioni drammatiche s’erano elevate, dando linfa a due filoni specifici: a settentrione, nell’antico Catai, terra di guerre plurime e di cicliche invasioni, le rappresentazioni avevano puntato sull’elemento avventuroso, con scene di battaglia e arditi esercizi acrobatici; nel Meridione, invece, avevano prevalso gli allestimenti più romantici e sentimentali, con storie d’amore e di passione, dal carattere meno guerresco e più soft. Ancor oggi si ripropongono sui palcoscenici cinesi alcuni fra i lavori teatrali di Kuan Hanching, 225
che in origine dovette esercitare la professione di medico e che, nel XIII secolo, sembra abbia composto oltre cinquanta capolavori. La Storia della camera occidentale, di cui è coautore insieme a Wang-Shih-Fu, è popolare adesso come all’epoca di Marco Polo: e dal canto suo il veneziano, teatro a parte, aveva già incominciato a prendere confidenza col fantastico spettacolo di gente, luoghi, attività, gusti e insomma con tutto ciò che di cinese lo circondava. Dalla Laguna, il giovane viaggiatore era stato sbalzato nell’ebollizione di un impero che bisognava far presto a conoscere e penetrare. Capirne immediatamente le dinamiche intrinseche, e adattarvisi, era fondamentale per non restare esclusi dai giri che contavano, e per non mandare persi quasi quattro anni di peripezie attraverso l’Asia. Dunque, sguardo attento. Dunque, intelletto sempre all’erta. E capacità di gestire all’istante le situazioni, di leggere le problematiche, di aspettare, ove occorresse, pazientemente, che maturassero circostanze propizie. Fretta non ce n’era: in Italia, fra i canali di Venezia, in fin dei conti Marco aveva lasciato ben poco. Qualche affetto, probabilmente, e forse un pizzico di nostalgia. Altro non aveva da rimpiangere: il frammento più consistente della sua famiglia, quel padre, e quello zio pure lui così tanto paterno, gli erano a fianco. Seppe quindi contenere i brividi, il figlio di Niccolò, confortato dalla presenza rassicurante dei parenti, allorché per la prima volta poté alzare il capo, piano, a scrutare la maestà di Kubilai. Il sovrano se ne stava in alto, appollaiato su una piattaforma, com’era consuetudine per i grandi khan asiatici. Aveva un fisico non più giovanile, parzialmente imbolsito dalle guerre e dal piacere smodato nel bere. Ma a Marco Polo, abbagliato dalla solennità del ricevimento, le fattezze dell’imperatore yuan parvero davvero degne di un gran princi226
pe. Begli occhi, bel naso, corporatura armonica e proporzionata. Il tutto esaltato dalla ricchezza delle vesti, dalla sontuosità del cerimoniale e dall’accoglienza benigna riservata agli ospiti veneziani. L’olio sacro, prelevato dalle lampade del Santo Sepolcro di Gerusalemme e trasportato per migliaia di chilometri, dovette ben disporre il gran khan, noncurante (o presumibilmente dimentico) del mancato arrivo di quei teologi cattolici che, dieci anni prima, aveva chiesto di poter ricevere a corte. Da allora, del resto, gli eventi s’erano accavallati, e di acqua sotto i ponti ne era passata parecchia. Pur restando ligio all’ancestrale sciamanesimo dei popoli delle steppe, e sebbene il pluralismo religioso fosse assodato entro i confini del suo regno, Kubilai e soprattutto i suoi fiduciari manifestavano una forte inclinazione per il lamaismo. Il monaco tibetano Phags-pa – cui era stato commissionato un nuovo alfabeto per la lingua mongola, che andasse a perfezionare l’antica scrittura uigura – aveva saputo imporsi dal 1261 come uno fra i consiglieri imperiali più ascoltati, ed era stato messo alla testa del clero lamaista: la stessa Storia degli Yuan riferisce della sua nomina a Kuo-shi (Maestro del regno) e Ti-shi (Tutore imperiale). Per contraccambio, Kubilai Khan era stato riconosciuto imperatore universale della tradizione buddhista: un ruolo che gli garantiva poteri religiosi notevolissimi, e che ne legittimava ulteriormente la potestà sulla Cina (o quanto meno su una buona fetta della popolazione dominata). La stessa concessione ai monasteri buddhisti di vasti possedimenti dovette in qualche maniera contribuire a un – seppur indiretto – presidio del territorio cinese: le pertinenze dei conventi lamaisti ammonteranno, con gli Yuan, a 170.000 ching (l’estensione fondiaria dell’agricoltore medio), inglobando qualcosa come 400.000 famiglie contadine (su 227
un totale stimabile in circa quindici milioni). Il supporto economico che dal lavoro della terra derivava alle case buddhiste era pertanto enorme, tale da avvantaggiare i monaci del Tibet nel confronto con molte delle religioni ricadenti nel territorio imperiale: anche con quelle che, come il taoismo, apparivano altrettanto radicate nella società cinese, e avevano sempre conteso al buddhismo il consenso popolare. Certo, l’ampia protezione goduta presso i ceti dominanti porterà talvolta ad alcuni eccessi: un lama di nome Yang, responsabile della dottrina buddhista a sud del Fiume Azzurro, si arrogherà nel 1285 il diritto di violare le tombe della dinastia reale dei Song, usando i corredi funebri per restaurare templi del Buddha: un gesto sacrilego per i Cinesi, che sicuramente non agevolerà l’accettazione dei lamaisti e, ancor più, accenderà il rancore popolare per gli Yuan, patrocinatori di simili profanatori. Pure, Kubilai non si faceva scrupoli nell’attorniarsi di quei monaci tibetani, rinomati per gli specialissimi poteri e le bizzarre liturgie: a Marco Polo fu riferito di coppe colme di vino e di bevande variegate che levitavano durante i banchetti, volando da un angolo all’altro delle sale conviviali. A palazzo si diceva inoltre che i santoni sapessero deviare i temporali, e che fra cori e profumi usassero imbandire per la divinità brodo e montone affumicato (con legno d’aloe), oppure che fossero avvezzi a cibarsi ritualmente delle carni, cotte, dei prigionieri giustiziati. Modesti nel vestire e generosi nel riempire di canti e luminarie i giorni di festa, si distinguevano facilmente dai seguaci del Tao, che invece erano più predisposti al digiuno, alla meditazione e a un regime alimentare fatto di crusca bagnata in acqua calda. Se Marco poté guardare i taoisti mentre recitavano orazioni davanti a un fuoco, e se poté soffermarsi su cert’altri religio228
si che si sposavano e facevano figli, fu perché nessuna confessione era bandita dagli Yuan. Tanto meno il cristianesimo che, sebbene non fosse preponderante, restava comunque saldamente attestato e rispettato: in molte località cinesi sorgeranno difatti diverse chiese fra il 1275 e il 1281, e Kubilai giudicherà utile istituire nel 1279 un ufficio generale per l’amministrazione cristiana dell’impero. Coi loro podii, con le loro coperture a tegole, coi decori a fiori di loto o a «perle fiammeggianti», le costruzioni sacre nestoriane adottavano elementi costruttivi e repertori decorativi di tipo sinico, mescolandoli a «croci gemmate», a raffigurazioni di scene cultuali e a ornamentazioni mutuate dai cicli iconografici mediorientali. Alla fin fine, Marco Polo non dovette troppo stupirsi dei templi cristiani: per lui, che di basiliche ne aveva frequentate, ammirate o evitate a bizzeffe, erano di sicuro più emozionanti le pagode tibetane che, nella scia del buddhismo, stavano iniziando a guarnire un po’ tutta la Cina, e in particolare Pechino. Diversamente dalla classica tradizione cinese, gli edifici di influenza tibetana non presentavano una suddivisione in piani. In più, erano internamente adorni di tappeti dell’Asia centrale: un addobbo di provenienza nomade, particolarmente caro ai Mongoli e relativamente desueto per le dimore cinesi. La produzione dei magnifici drappi richiedeva la tessitura della lana, e cioè una lavorazione abbastanza nuova e non ancora del tutto padroneggiata dall’artigianato della Cina: al servizio pressoché esclusivo della corte imperiale opereranno perciò lungamente delle grandi fabbriche tessili, sfornando arazzi che erano opere d’arte, e che accendevano di colore le favolose regge di Kubilai a Dadu/Khanbalik e Kaiping/Shangdu. Cosicché tutto, in quei palazzi straordinari, doveva sembrare a Marco Polo assolutamente 229
e incredibilmente fantasmagorico, gigantesco, eccessivo. Perfino certe vecchie abitudini del gran khan...
4 | Esuberanze carnali Aveva una sessantina d’anni. Aveva la gotta, e Marco Polo se ne accorse immediatamente. Ma Kubilai, e anche questo non passò inosservato al veneziano, conservava ancora un appetito sessuale incredibile. Una libidine che andava saziata con quanto di più prelibato in fatto di giovinette fosse reperibile. Le khatun, le mogli imperatrici, ciascuna residente in un proprio palazzo con centinaia di damigelle e migliaia di attendenti, non erano sufficienti al sovrano, che pure con loro era solito giacere generando decine di figli. Le fanciulle più belle, le più famose per la loro pelle vellutata e la ricercatezza del trucco estetico, fiorivano notoriamente presso l’antica tribù mongola degli Ongirati, la stessa che aveva fornito la prima e prediletta moglie, Borte, al fondatore dell’impero, Gengis Khan. Così, anche per riattaccarsi idealmente al suo illustre predecessore, e quindi quasi con un che di rituale, di liturgico, di ancestrale, Kubilai faceva accuratamente selezionare le sue compagne di letto solo ed esclusivamente fra le ragazze ongirate. Dei funzionari erano regolarmente inviati a fare una scelta dei migliori esemplari muliebri, che venivano passati in rassegna e giudicati da commissioni esaminatrici. A ciascuna donzella si attribuiva un punteggio variabile in carati, a seconda dell’avvenenza e della formosità. E l’elezione delle migliori non si esauriva con quel «florilegio», poiché alla prima scrematura seguiva un’ulteriore cernita, compiuta direttamente alla corte dell’imperatore. 230
Qui la selezione si faceva ancor più rigorosa, e si affinava: le candidate al giaciglio imperiale dovevano infatti passare controlli severissimi ed essere sottoposte a un tirocinio di buone maniere. Se ne testava la verginità, le abitudini igieniche e perfino la bontà dell’alito, facendole dormire accanto a cortigiane incaricate di certificare che il fiato non puzzasse. Russare nel sonno significava essere scartate, subito: non ammetteva molestie olfattive o uditive, Kubilai, allorché sei nuove ragazze, a turno, venivano introdotte nella sua camera privata, ogni tre giorni e tre notti, per tutto l’anno. Ovviamente, il gran khan faceva di loro ciò che voleva, mentre le dame che non avevano superato l’ultima prova, quelle «quasi buone», restavano comunque nell’orbita khanale come vallette, ricamatrici o spose di un qualche funzionario. Per tutti gli altri, cittadini o stranieri, e per tutti quanti gli amori extraconiugali c’erano le prostitute, che in numero gigantesco affollavano i quartieri periferici delle città più trafficate e che, specialmente a Pechino, esercitavano con discreta larghezza le relative mansioni: o, per lo meno, potevano farlo fino al terzo rintocco della campana a percussione che, da una torre della reggia pechinese, batteva le ore notturne. Dopodiché a nessuno era più consentito uscire di casa, con le porte urbiche sbarrate e le strade pattugliate da una ferrea polizia di trenta o quaranta armigeri, che vigilavano sulla sicurezza pubblica. Alla protezione dell’imperatore era invece preposta la guardia dei kesigten, dodicimila cavalieri sceltissimi che, in drappelli di tremila alla volta, vegliavano a rotazione sul palazzo regio. La favolosa residenza degli Yuan sarà per Marco Polo una visione che non potrà cancellarsi più dai suoi occhi: circondata in quadro da mura lunghe un miglio per ciascun lato, collegata ad ambienti che custodivano archi, frec231
ce, corde, finimenti, corazze in cuoio bollito e armi d’ogni tipo, la dimora di Kubilai a Dadu/Khanbalik comprendeva appartamenti, giardini, vivai e saloni ammantati d’oro e d’argento. Sulle pareti dei padiglioni trionfavano sculture di donzelle e di eroi, di uccelli e di animali. Altre bestie, ma vere (cervi bianchi, caprioli, daini, scoiattoli ed ermellini) si aggiravano nel parco, mentre le acque placide di un laghetto e il quieto trascorrere del fiume Yu-ho, incanalato fra le architetture palaziali, accoglievano banchi di pesci delle qualità più svariate. Tutt’intorno, fra porte monumentali e scalinate marmoree, i tetti policromi delle grandi aule svettavano in un’apoteosi di vermiglio, azzurro e verde, risplendendo nel cielo e riverberando anche a distanza sfumature cristalline e dorate. In direzione settentrionale, un’altura artificiale grondava di alberi sempreverdi: ce n’erano di specie rare e anche di giganteschi, che l’imperatore faceva interrare trasportandone da lontano fusto e radici con l’ausilio di elefanti. La superficie della montagnola era cosparsa di polvere di lapislazzuli che, virando cromaticamente dall’azzurro a tonalità più scure, conferiva al poggio l’aspetto di un «monte verde». Lassù, una villa era stata attrezzata per il piacere dell’imperatore. Nelle vicinanze, altri fastosi alloggi sorgevano per accogliere Temür, nipote di Kubilai e suo erede al trono. Alla rimanente progenie, alla prole numerosa di consorti e concubine e, insomma, a un po’ tutta la discendenza del monarca era comunque assicurato un posto privilegiato nei ranghi aristocratici. Chi principe, chi alto feudatario, tutti godevano d’una grossa porzione di potere. Kubilai era munifico, e non soltanto coi consanguinei: Marco Polo constatò con quanta generosità l’imperatore ricompensasse i soldati più valorosi e fedeli. E la munificenza si manifestava fastosamente nei grandiosi ricevimenti organizzati a corte: nella sa232
la principale del palazzo imperiale, con una disposizione degli ospiti che riprendeva l’assetto mongolo delle yurte, il gran khan si sistemava al centro della parete nord col viso rivolto a sud, su un seggio soprelevato. Alla destra del sovrano (e dunque a occidente) sedevano i maschi, ordinati gerarchicamente a partire dai rampolli della casata regia; alla sinistra (e quindi a oriente) si disponevano le donne, a cominciare dalla moglie più importante. Le due file di cortigiani si distendevano sotto lo sguardo di Kubilai che poteva, dalla sua postazione, scrutare tutti gli astanti. Fuori, una turba di stranieri, ambasciatori o mercanti, premeva per presentarsi con regalie al dinasta, e intanto partecipava agli immensi banchetti apparecchiati per migliaia di convitati. Il vino, caldo e profumato, nelle feste e nelle ricorrenze fluiva copioso, assieme al latte fermentato e alle bevande speziate. Vasellame finissimo, coppe in oro e argento, ciotole laccate e tazze monoansate erano gli strumenti del beveraggio collettivo. Le bibite erano attinte da recipienti aurei grandi come botti, e ogni bevitore riusciva a ingurgitare la quantità di liquore che sarebbe bastata a soddisfare normalmente una decina di persone. Musicanti, giocolieri e prestigiatori allietavano i convivi scandendo con le loro arti l’offerta delle vivande. E quando Kubilai avvicinava alle labbra il calice, ogni sua singola bevuta diveniva un evento da salutare con ossequiosa esultanza. Se si faceva festa per il compleanno dell’imperatore, i nobili si abbigliavano tutti come il gran khan, con ricche vesti laminate in oro e tempestate di gioielli che lo stesso sovrano s’era premurato di donare. Accorrevano a rendergli omaggio sia quelli che erano già signori d’un territorio, sia coloro che volevano diventarlo o che intendevano incrementare le proprie pertinenze. E potevano essere musulmani, 233
cristiani o devoti d’una qualunque altra religione: tutti, indistintamente, erano tenuti a pregare per la salute di Kubilai. Preghiere in onore del grande sovrano si recitavano pure per quella che Marco Polo chiamava «Festa bianca», e che segnava il capodanno del calendario cinese. Una sfilza di vassalli si riversava nella reggia per regalare tesori all’imperatore, augurandogli prosperità e felicità. Il valore delle pietre preziose, dei vasi, degli esemplari di cavalli ed elefanti che a migliaia venivano esibiti a Kubilai era incalcolabile: Marco, stupefatto, non potrà mai più vedere altrove tanta ricchezza, in un sol colpo. Né troverà più un monarca adorato così, alla stregua di un dio, come accadeva allorché il ciambellano degli Yuan invitava i convenuti a prosternarsi con la fronte in terra, a pronunciare delle orazioni e a spargere incenso su una tavola cremisi iscritta col nome del gran khan. Finanche dei grossi leoni (evidentemente ammaestrati) venivano condotti nelle cerimonie più solenni a prostrarsi ai piedi del trono: era il simbolo del potere, onnicomprensivo, dell’imperatore, sugli uomini e sulla natura, anche la più ferina e selvaggia. Era la divinizzazione di Kubilai.
Capitolo dodicesimo
PASSAGGIO A SUD-OVEST
1 | I ribelli del Loto Bianco Stringeva nelle proprie mani gran parte del Levante. Dominava un immenso territorio fatto d’Asia centrale e di Cina. Steppe interminabili e città popolosissime. Pascoli sconfinati e campagne minuziosamente coltivate. Miniere, empori. Vie terrestri e acquatiche. E deserti, oasi, montagne, fiumi. Eppure, di tutto quell’impero Kubilai non conosceva personalmente che qualche distretto. Poche province appena, le terre circostanti ai centri del potere. Non poteva percepirne direttamente ogni remoto compartimento, ogni villaggio o metropoli. L’ampiezza dei domini era smisurata. Gli spostamenti dovevano sembrare eterni e i pericoli perenni, nell’attraversamento di regioni talvolta inospitali: o, almeno, inospitali per chi incarnava l’oppressione, per i rappresentanti dell’imperialismo mongolo e per quei latifondisti pressoché immuni dalla povertà, in forza delle pertinenze comunque conservate anche con la nuova dinastia yuan. Contro di loro, contro amministratori statali e signorotti locali, indistintamente montava un malcontento contadino fomentato dalla società segreta del «Loto Bianco». Era una setta che accomunava cinesi immiseriti, angariati, ma risolti a non soggiacere né alle tasse né alle pesantissime corvées imposte dal235
le autorità imperiali. Fra i ribelli occulti militavano anche piccoli mercanti, pescatori, contrabbandieri o impiegati, che coltivavano la comunanza identitaria nel segno d’una rigorosa dieta vegetariana e della fervente venerazione per il Buddha Amitabha. Così, nell’impasto di rivoluzione e aspettazioni millenaristico-messianiche, era atteso l’avvento del Maitreya che avrebbe riscattato l’umanità sofferente. D’ispirazione buddhista saranno pure i seguaci della «Nuvola Bianca», operanti sul corso inferiore del Fiume Azzurro, mentre i partigiani dei «Berretti rossi» muoveranno a partire soprattutto dalle regioni settentrionali dell’antico Catai. Fra l’Henan e l’Hunan, dal Guangdong al Sichuan i rivoltosi soffieranno sul fuoco delle sollevazioni popolari, contrapponendo le ragioni dei deboli tanto alle classi agiate dei proprietari terrieri quanto alle imposizioni (talora veramente insostenibili) degli Yuan. Ma del popolo cinese, della quotidianità nelle tante contrade annesse al regno, così disperse e spesso così diverse, Kubilai aveva una cognizione parziale. I freddi resoconti della burocrazia, per quanto fossero diligenti, non costituivano che una surroga manierata all’esigenza di sperimentare, apprendere, comprendere. D’altro canto, la necessità di tenere corte nei luoghi del comando, nei palazzi imperiali, o magari l’ozio regale, impedivano il sovrano. Lo trattenevano, lo mantenevano bloccato. Fisso nella sua condizione di aurea incoscienza delle cose del principato, condannato a una staticità da cui, comunque, bisognava cercare di divincolarsi, Kubilai soleva mettere in circolo emissari che raccattassero informazioni complete, che gli regalassero porzioni di quel sapere inibitogli dalla posizione di principe dei principi. Di rado, però, i rendiconti dei molti inviati gli procuravano soddisfazione. 236
Le cifre aride, le elencazioni schematiche non lo appagavano quasi mai del tutto. Le relazioni sulla ricchezza o sulla miseria del popolo, sugli agi o sulle difficoltà, sui costumi, sul compimento di opere pubbliche o sui successi degli uomini di ingegno, si risolvevano sovente in piatte enumerazioni. E invece il gran khan, non fosse altro che per governare con maggiore raziocinio, avrebbe voluto andare oltre, sentire un buon racconto di persone, eventi, paesaggi, fermenti. Storie di vita, insomma, delle vite cinesi. Quel giovane veneziano da poco accolto nelle sale regie, forse, avrebbe potuto fare al caso suo. Quel Marco, figlio e nipote di mercanti dalla collaudata dinamicità: lui sì che sembrava d’intelligenza vivace e di favella appropriata. Sapeva raccontare, e non ce n’era meglio. Amava dettagliare le sue narrazioni, cogliere le sfumature dei fatti, esprimere le piccole grandi specificità che tinteggiavano una descrizione e la rendevano vivida, la realizzavano nel cuore e nella mente dell’interlocutore. Persone così, che guizzassero con le parole, facevano presa su Kubilai. L’imperatore decise perciò di servirsene. Aveva potuto apprezzare Marco Polo per le doti di discrezione e insieme di entusiasmo con cui si rapportava agli altri, ora ascoltando educatamente, ora conversando garbatamente. Lo aveva udito dialogare in persiano coi nobili che frequentavano le regge imperiali, ed esporre le meraviglie dei paesi e delle popolazioni, delle usanze e degli ambienti incontrati sul cammino dal Mediterraneo all’Oriente. I racconti del ragazzo pullulavano di particolari, sovrabbondavano di colori, esprimevano un gusto narrativo coinvolgente e profondamente efficace, che nasceva da uno spirito d’osservazione spiccatissimo. Rispetto alla sterilità dei canonici ragguagli venivano ribaltate le priorità descrittive: più che soffermarsi sui meccanismi politico-amministrativi di un luogo, se 237
ne scontornavano preferibilmente gli aspetti etno-antropologici. Dipendeva tutto dalla forma mentis: per un mercator era semplice adattare le proprie esigenze commerciali alle regole formalmente statuite dall’amministrazione di una qualsivoglia località. Più complessa poteva rivelarsi la sintonia con costumi e culture desuete, peculiari, talora uniche e irripetibili. Per un mercante di razza, ogni specifica abitudine, ogni tratto intrinseco e caratteristico di una comunità o di un territorio doveva risultare interessante: il dettaglio osservato, l’essenza intuita si stampavano indelebili nel cervello, e saltavano fuori al momento opportuno. Memoria di mercante e linguaggio di cantastorie, dunque. Era questo il patrimonio, questo il talento di Marco. Utilissimo, per Kubilai, che teneva sott’occhio il più promettente dei Polo, il più fresco, il più tenero, da plasmare in funzione delle esigenze dell’imperatore. Agli altri due, ai più scafati, ai più induriti e perciò meno acconci Niccolò e Matteo, oltre alle consuete mansioni mercantesche sarebbe eventualmente spettato il ruolo di consiglieri militari, che necessitava di attitudini altre, più generiche e standardizzate. E in ogni caso stare col gran khan, condividerne le giornate, significava partecipare a spettacoli grandiosi, che in Occidente un re, il doge, nelle loro pur fastose esteriorizzazioni della sovranità, non si sarebbero mai potuti sognare. Di Venezia Marco Polo rammentava alla perfezione la maestosità delle liturgie politiche, la profusione di cerimonie pompose ed esaltanti. Ma tutte quelle ostensioni pubbliche, tutte le feste e le ritualità che lo avevano estasiato da adolescente divenivano adesso manifestazioni da mera periferia del mondo. Minuzie, in confronto alla grandezza degli Yuan, esibita e moltiplicata, all’ennesima potenza, anche negli svaghi privati. Le cacce dell’imperatore potevano dare al238
lo spettatore occidentale la sensazione di una magnificenza insuperabile e quasi surreale: quando si dava inizio alle battute collettive, migliaia di mastini coi rispettivi addestratori, metà in uniforme azzurra e metà in rossa, si disponevano sulle ali di innumerevoli cavalieri. Al corteggio venatorio erano associati leopardi, linci, leoni e ogni tipo di felino ammaestrato per braccare orsi, asini selvatici, cinghiali e cervidi. Le aquile addomesticate si lanciavano in picchiata su lupi, volpi, lepri, daini e caprioli. Schiere di falchi delle più diverse famiglie, assistite da un folto esercito di falconieri, erano specializzate nell’uccellagione. Lo stesso Kubilai Khan, trasportato da quattro elefanti a bordo d’una cabina foderata di drappi in oro e rivestita da pelli leonine, aveva sempre con sé una dozzina di girifalchi che, al passaggio delle gru, venivano liberati dal tetto apribile della carrozza: così, disteso sul suo letto mobile, con lo sguardo beato nel cielo, il gran khan si divertiva a seguire i volatili che si azzuffavano fra le nuvole e il blu. Inseguendo le prede, contornato dalla cavalleria e accompagnato dalla corte, l’imperatore solitamente si inoltrava a meridione di Pechino, per piantare più verso l’Oceano il suo accampamento imperiale e i suoi appartamenti mobili. Sorretti da piedritti in legno pregiato, impermeabilizzati da pelle di leone, foderati da pellicce d’ermellino e zibellino, i padiglioni del sovrano accoglievano un’infinità di ospiti e, per le rifiniture dei vani interni, possedevano un valore economico talmente elevato che difficilmente, a giudizio di Marco Polo, se li sarebbe potuti permettere un comune monarca europeo. Dalla sua base di tende pregiate, Kubilai si divertiva a uccellare e a scegliere la cacciagione che, anche a lunghissime distanze, veniva recuperata dai suoi accoliti, almeno fino alla primavera. Poi, i rastrellamenti si interrompevano. 239
Tanta era l’importanza annessa agli animali da cacciare (e tale il rispetto per la natura) che vigeva il divieto di catturarne o ucciderne fra marzo e ottobre, nel periodo della riproduzione: le stragi venivano quindi risarcite e bilanciate dal ripopolamento di mammiferi e volatili. E a tal punto le bestie si sentivano tranquille e protette, in quei mesi di fermo biologico, da vincere la loro naturale diffidenza e avvicinarsi mansuete agli uomini.
2 | Pechino l’opulenta Nelle grandi cacce dei dinasti yuan funzionava come nelle steppe mongole. Sussisteva un obbligo, una vecchia legge mutuata dalle usanze tribali dei nomadi centro-asiatici, per cui nella spartizione delle prede erano dovute al capo le parti migliori del bottino e, dunque, le primizie della cacciagione. Cosicché i partecipanti alle battute accorrevano spesso da lontanissimo a offrire la selvaggina raccattata al principe: perché al principe, in caccia come in guerra, a pranzo come nell’alcova, spettava sempre, e assolutamente, il meglio. Il meglio però Kubilai lo pretendeva anche dalle informazioni: gliele si doveva servire succulente, su un piatto d’argento, complete d’ogni ingrediente. E Marco Polo era ormai pronto a imbandirgliene. L’ospite veneziano aveva conquistato col suo fare e col suo dire la fiducia dell’imperatore. S’era fatto stimare e benvolere, un po’ per le effettive capacità intuitive e un po’ per l’abilità nel soppesare le adulazioni, per il garbo nel saper spargere cortigianerie fino a un attimo prima dell’evidenza smaccata e importuna. L’incensamento andava largito con prudenza, affinché risultas240
se gradito. L’ostentazione sfrenata di piaggeria avrebbe potuto rivelarsi stucchevole, disgustosa, nauseante per il sovrano, che pure ne era il destinatario. Invece il savoir faire di Marco si rivelò esemplare. Il suo tirocinio a corte durò lo stretto indispensabile, in un crescendo di conoscenze ed eccitazione. Da un giorno all’altro, la Cina si sarebbe schiusa completamente a lui, il ragazzo entusiasta che aveva peregrinato, sofferto, sperato e che, adesso, si ritrovava finalmente a un passo dai suoi sogni. E il gran giorno arrivò. Giunse il tempo della partenza, l’ora della missione per conto dell’imperatore. Una porta si apriva. Oltre, c’era davvero tutto un altro mondo. Pechino, innanzitutto. In Europa, nel Duecento, le città contavano soltanto alcune migliaia di abitanti, e gli edifici monumentali consistevano di norma nel palazzo dell’autorità pubblica e nella cattedrale, emblema del potere religioso. In Asia (e Marco Polo lo aveva verificato di persona), quanto più ci si spingeva a levante tanto più gli abitati apparivano ornati, vivaci e raffinati, ben oltre le bigie cittadine occidentali. Nelle province mediorientali, i borghi islamici grondavano di vitalità e splendore. Ed estesissimi dovevano apparire i centri cinesi già prima dell’avvento mongolo: fra gli incanti di giardini stupendi e deliziose pagode, miriadi di case e residenze signorili raccoglievano centinaia di migliaia (e a volte milioni) di persone. La capitale degli Yuan, Dadu/Khanbalik, era allora l’apoteosi dell’Oriente più sfolgorante e meraviglioso. Kubilai ne aveva voluto fare un simbolo sempiterno della potenza imperiale, e non s’era fermato davanti a niente pur di ultimare il suo programma edificatorio. Il denaro era stato largito a cascata, e una quantità esorbitante di contadini aveva dovuto lasciare i campi per lavorare forzatamente alla costruzione della megalopoli. Certo, la manodopera strappata alle cam241
pagne per essere trascinata nei cantieri cittadini, i raccolti compromessi dalla mancanza di braccianti, avrebbero messo in ginocchio l’agricoltura. E il malessere dei Cinesi verso il governo yuan si sarebbe ulteriormente acuito. Ma nulla avrebbe mai distolto il gran khan dal proposito di esternare la grandiosità del proprio dominio. Nemmeno il rischio che l’incolto dilagasse e sommasse le aree improduttive alle superfici che erano state adibite a pascolo per le immense mandrie mongole: «spremendo» le regioni centrali e meridionali della Cina si recuperavano le risorse per il Nord e, nel Nord, i rifornimenti per la mastodontica Pechino. L’impianto urbanistico della metropoli, regolare, traboccante di quartieri per artigiani e mercanti, di complessi religiosi e zone residenziali, si ispirava ai classici canoni cinesi, con il palazzo del khan e la «città imperiale» che insistevano sul grande asse viario centrale sud-nord. Vaste e superbe architetture sovrastavano le porte cittadine, e ne facevano delle gemme in cui si avvertiva l’influenza dell’arte himalayana. Sin dall’inizio del suo regno, Kubilai Khan aveva effettivamente accolto presso di sé il giovane artista Aniko, appartenente alla famiglia reale del Nepal, assieme ad altri trentaquattro nepalesi. Dalla creatività della loro scuola artistica deriveranno sia la progettazione della «Pagoda bianca» del Pai-ta’ssu, enorme mandala tridimensionale, sia le soluzioni scultoree applicate sulle pareti delle costruzioni di Dadu/Khanbalik (e di altri capoluoghi cinesi). Gli estradossi ricamati da plastiche finissime e gli archi polilobati reiteravano continuamente e dappertutto teorie di divinità tibetane. Dalla pietra delle ornamentazioni architettoniche, le figurazioni sacre si propagavano al legno dorato, alla terracotta o al bronzo dei simulacri custoditi nei santuari buddhisti, ovvero alla pregiatissima «lacca secca» (T’uan242
yuan): si trattava di una tecnica scultorea di delicatezza estrema, probabilmente utilizzata fin dal IV secolo e ben padroneggiata in epoca Tang (618-907), con cui si svuotava la statua dall’impalcatura interna e la si lasciava vacante. Ne fu maestro il celeberrimo Liu Yuan, e la stessa Storia degli Yuan ricorda in effetti come «... In tutti i santuari celebri delle due capitali, quando le statue buddhiste in terra modellata, in metallo fuso a stampo e in lacca secca uscivano dalle mani di Liu Yuan, l’anima e il pensiero vi si univano meravigliosamente e l’universo li celebrava». L’opulenza di Dadu/Khanbalik attraeva quotidianamente frotte di commercianti e tonnellate di mercanzie, le più svariate, le più costose, che impressionarono Marco Polo per il valore e per i quantitativi disponibili: perle, gioielli, carri stracolmi di seta da scaricare nelle fabbriche di tessuti, generi di consumo d’ogni fatta attivavano nugoli di compratori e venditori, provenienti anche da molto lontano. Le transazioni si effettuavano con banconote di vario taglio che, garantite dal sigillo di Kubilai ed emesse dalla banca imperiale di stanza a Pechino, Marco riconobbe come un prodotto della lavorazione della corteccia del gelso. Se usurata, la cartamoneta veniva tranquillamente cambiata (benché la sostituzione implicasse una tassa del tre per cento), di modo che le capacità d’acquisto restassero inalterate: anche questi particolari contribuivano all’efficienza di una macchina amministrativa che doveva sovrintendere alle attività private della popolazione e, insieme, provvedere alla gestione delle opere pubbliche, compresa una rete stradale di ineguagliabile estensione e funzionalità. Nel viaggiare per la Cina, nel muoversi di paese in paese, Marco Polo ebbe diretta cognizione di un sistema viario perfettamente organizzato: sulle tante arterie che si dira243
mavano nell’impero erano dislocate, a distanze regolari, delle stazioni attrezzate per il riposo dei viandanti e per il cambio delle cavalcature, specie in relazione ai servizi postali e alle messaggerie del gran khan. Gli alberghi che cadenzavano il cammino erano dotati di stanze particolarmente confortevoli, tali da poter eventualmente alloggiare anche un re fra lenzuola di morbida seta. I cavalli a disposizione erano poi praticamente illimitati, così da agevolare le corse delle staffette imperiali anche nelle emergenze, quando urgeva comunicare il più in fretta possibile di rivolte in corso, oppure bisognava inoltrare dispacci nell’imminenza d’una guerra. Vettovaglie, carri e portantine non mancavano mai, in una maglia che integrava i trasporti terrestri coi collegamenti fluviali. Date le distanze enormi da percorrere, infatti, gli spostamenti di uomini e soprattutto di derrate avvenivano tramite i fiumi e i canali, su cui viaggiatori e merci scivolavano in buona scioltezza grazie a battelli e chiatte. Come per la creazione, il restauro o l’alberatura delle vie terrestri, anche per la realizzazione dei collegamenti acquatici gli Yuan facevano ricorso ai lavori forzati: masse di Cinesi erano pertanto costrette ad abbandonare mestiere e famiglia per provvedere allo scavo di nuove canalizzazioni, alla regolazione dei corsi d’acqua e alla costruzione di grosse imbarcazioni da carico. La mobilitazione coatta di manovalanza era volta al miglioramento della viabilità per il transito dei carichi mercantili, e in particolare per assicurare tempestivamente i rifornimenti di viveri (riso in primis) e di beni voluttuari alla classe dominante, stanziata prevalentemente a Dadu/Khanbalik. La Grande Capitale, a sua volta, risolverà i problemi di approvvigionamento idrico grazie a Guo Shoujing (1231-1316), uno scienziato, ingegnere e astronomo che, deviando gli alvei tor244
rentizi, congegnerà una serie di canalizzazioni essenziali per la vivibilità dell’area metropolitana. Corvées da un lato, quindi, e grandiosità dall’altro. Sulla pelle d’una marea d’operai semischiavizzati, spesso obbligati a prestare cinque o sei anni di bracciantato lontano da casa e dai terreni agricoli, la dinastia yuan rimpolperà la propria gloria: il «Gran Canale», scavato in epoca Sui (581-618) e assai rimaneggiato fra XIII e XIV secolo, coi suoi 1794 chilometri di lunghezza costituirà il corso artificiale più lungo del pianeta. Da Pechino ad Hangzhou intercettava l’Hebei, lo Shandong, il Jiangsu e lo Zhejiang, connettendo i fiumi Hai, Giallo, Huai, Azzurro e Quiantang. Ancora, nel 1289 Kubilai ordinerà lo scavo del canale Tongyu, grazie al quale non sarà più necessario toccare la vecchia capitale Luoyang per connettere le città principali dell’impero. Canali, dunque. Acqua. Un elemento a cui Marco Polo era abituato e in cui era cresciuto, nell’Occidente dell’infanzia, nella Laguna veneziana.
3 | La civiltà delle acque Il potere manifestava e glorificava se stesso con l’esibizione delle acque irreggimentate di fonti, laghi artificiali, giardini e canali. Il dominio esercitato da Kubilai sugli uomini e sulla natura trovava un simbolo potente nell’esaltazione dell’elemento acquifero, che con le sue vene, con la sua capacità penetrativa era come una trasfusione della sacralità regia fra le mura delle città e, nelle città, fra il popolo cinese. Le vie d’acqua vivificavano e unificavano i vari distretti, erano il marchio del ricongiungimento fra Settentrione e Meridione, 245
fra Oriente e Ponente dell’impero yuan. Nella simbiosi del territorio con le scaturigini, nel rapporto dialettico fra la compattezza del suolo e la liquidità di rivi o bacini, la Cina si palesava a Marco Polo con la sua antichissima civiltà dell’acqua. Le canalizzazioni e l’inalveamento di torrenti avevano una storia millenaria, tanto che in prossimità di Xi’an è tuttora visibile un originario sbarramento fluviale risalente a parecchio tempo addietro, testimone della cultura di una regione rigogliosa. Nella storia, nella tradizione più intimamente cinese l’autorità imperiale ritagliava spazi per incastonare la propria magnificenza: presso la Prefettura di Jingzhao, governata dal 1273 al 1278 da Mangalai, un figlio del gran khan, una vasta reggia merlata, sfolgorante d’oro e cinta per cinque chilometri da una ben fatta muraglia, giaceva immersa fra sorgenti e paludi che alimentavano lo zampillio di cascatelle artistiche. L’abbondanza idrica e le giravolte schizzanti dalle fontane erano peraltro uno spettacolo che Marco Polo riscontrò un po’ dovunque nelle province visitate durante il suo andirivieni da Pechino. E allora passeggiare fra parchi magnifici e ricolmi di buoni frutti, percorrere camminamenti soprelevati, passare ponti marmorei fra palazzi che duplicavano la loro bellezza specchiandosi nei giacigli acquatici potevano davvero rievocare Venezia, l’osmosi terracquea d’una città generata dall’acqua, cresciuta nell’acqua e che sull’acqua aveva costruito le proprie fortune. A un veneziano, a Marco di Niccolò Polo, il contesto cinese appariva pertanto più che naturale, quasi familiare e congeniale, congenito (al punto che potrà trascorrervi più di quindici anni). Soltanto che nel Levante, a differenza dell’Europa, tutto assumeva forme e proporzioni inimmaginabili. Una quindicina di chilometri a sud-ovest di Pechino, presso il fiu246
me Yongding, un viadotto fenomenale cavalcava le acque con una miriade d’archi e pilastri in marmo. Erano stati i Jin, nel 1189, a costruire il colossale Ponte Lugou (Lugouqiao), che sulle carte odierne è segnato anche (a beneficio dei visitatori anglofoni) come «Marco Polo Bridge»: adorno di statue leonine e di balaustre finemente scolpite, apparve al viaggiatore così largo da consentire il transito di dieci cavalli affiancati. Sotto le arcate, le correnti sospingevano fino all’oceano placidi vascelli che trasportavano le mercanzie dell’entroterra. Il brulichio di merci e commercianti si intensificava specialmente sui grandi corsi che, come il Fiume Azzurro, l’immensa arteria mercantile della Cina, inserivano borghi e megalopoli non solo nei traffici marittimi, ma pure nei flussi del commercio minuto. Al di sopra dei tenui beccheggi delle imbarcazioni, in corrispondenza degli empori, i fornici potevano essere sormontati da case e botteghe in legno che indiziavano artigiani, negozi, compravendite. A volte, le soste dei convogli fluviali coincidevano con il momento delle riscossioni doganali, che si svolgevano nelle località più importanti, dove le navi attraccavano vicino a strabilianti monumenti marmorei, che Marco dovette spesso ammirare decorati da pitture fascinose. E comunque la Cina poliana era piena di sorprese che, talora, non dipendevano esclusivamente dall’ingegno degli uomini: le pietre nere che prendevano fuoco, il carbon fossile che in quantità si cavava dalla pancia delle montagne, era il combustibile principale dei Cinesi. Costava assai meno della legna, e rendeva molto di più: Marco Polo, abituato a calibrare immediatamente i valori merceologici, intuì al volo la possibilità che quello strano materiale offriva di risparmiare legname e di venire incontro alle esigenze del popolo, col suo prezzo più che abbordabile. 247
Ai bisogni della popolazione poteva provvedere, in casi estremi, anche lo Stato. Specialmente nei frangenti di carestia, quando il costo dei cereali saliva a livelli insostenibili, le necessità di vettovagliamento collettivo erano sostenute dalle riserve di grano, orzo, miglio, panico e riso che, precauzionalmente, Kubilai aveva fatto stoccare in magazzini giganteschi, pronti a immettere sul mercato quantità massicce di granaglie che calmierassero gli aumenti indiscriminati dei prezzi. Ancor più la prodigalità dell’imperatore si esprimeva nelle provvidenze alimentari con cui Marco vide sfamare folle di indigenti, che quotidianamente bussavano alla corte degli Yuan per nutrirsi e vestirsi: per molti, era l’unico modo per attenuare la fame. Per placare invece la sete, nei ricoveri per viandanti, nelle taverne zeppe di mercatores oppure durante i banchetti nobiliari era frequentemente bevuto un vino chiaro, ricavato dal riso, che veniva servito molto caldo e speziato. Spezie e aromi, del resto, inondavano il Catai, e lo zenzero era un articolo diffusissimo. Di seta, poi, straripavano i negozi delle circoscrizioni settentrionali. L’industria tessile produceva stoffe impreziosite da ricami in oro, che illeggiadrivano le dimore aristocratiche cinesi oppure venivano esportate. Spostarsi liberamente nei territori imperiali portava Marco Polo a cogliere le sfaccettature della Cina, e a rimirare i vigneti, a contemplare le coltivazioni di gelso che si abbinavano all’allevamento dei bachi, ad ascoltare nelle locande le leggende sempre diverse del Prete Gianni, e di come un tempo avesse fatto rapire a tradimento (da sette finti nobiluomini) il Re d’Oro, per tenerlo in ostaggio col ruolo di mandriano e lasciarlo andare solo dopo un biennio di servitù, previo atto di vassallaggio. Nelle piazze o negli ostelli si raccontava di come Kubilai avesse spodestato tre principi che s’erano spartiti il regno 248
paterno. E dalle province tibetane, dove i templi buddhisti si infittivano fra le ferite inflitte al paesaggio da guerre passate, giungeva l’eco di uno strano sistema escogitato dai carovanieri per tenere lontani leoni, orsi e altre fiere più o meno pericolose: di notte, nei falò accesi si ponevano grosse canne verdi di bambù che, fessurandosi al calore, scoppiettavano talmente forte da impaurire e volgere in fuga qualsiasi belva. A evitare che il crepitio terrorizzasse i cavalli della carovana e li inducesse a scappare, si turavano le orecchie e si fasciavano gli occhi degli animali, e se ne legavano le zampe. Ove possibile, in Tibet conveniva effettivamente albergare in villaggi o paesi, piuttosto che all’addiaccio, anche per scansare le schiere di ladroni che ingordi e crudeli si aggiravano a rapinare i malcapitati di passaggio. Si sussurrava d’altronde che nei luoghi abitati i viaggiatori fossero attesi da soggiorni oltremodo piacevoli: per le strade, negli alberghi, in alcuni accampamenti, stuoli di vecchie madri proponevano le loro figlie a chi avesse voluto approfittarne. Stando alle dicerie, le donne più adatte al matrimonio erano quelle che avevano giaciuto col maggior numero di uomini, e che potevano certificare l’entità dei loro incontri sessuali tramite la quantità di gioielli ricevuti in regalo dai mercatanti in transito. Più erano insomma le collane di cui ciascuna ragazza poteva fregiarsi, maggiore la dote che avrebbe recato al marito. Un buon partito, dunque: le spose più desiderabili erano evidentemente originate da forme abbastanza esplicite di prostituzione. Al di là delle tradizioni autoctone e dei giudizi morali, presumibilmente il mercimonio era sintomo di un tenore economico precario, che spiegava il locale brigantaggio e i miseri vestiti di canapa e pelli di cui ebbe conoscenza Marco Polo. Eppure, fra monti che s’immaginava dessero oro in pagliuzze, in un territorio famoso per i suoi astrologi e gli in249
cantatori diabolici, in contrade di selvaggina copiosa, di falconi pellegrini, di mastini giganti e di cani da caccia delle più svariate razze, si diceva che circolassero spezie mai viste in Occidente, e ciambellotti, e drappi sontuosi. Sui banchi tibetani si poteva trovare persino il corallo, che le fanciulle mettevano al collo, e con cui si ornavano le statue delle divinità, essendo una materia di gran pregio. Ma di questa mercanzia Marco, il mercante Marco, non dovette stupirsi: ben comprendeva che gli effetti globalizzanti della rivoluzione commerciale potevano spostare i coralli dai fondali del Mediterraneo (lungo la costa algerina e tunisina, attorno alle Baleari, nei mari di Sardegna, di Sicilia, dell’Elba, delle isole Ionie e di Trani, in Puglia) alle giogaie dell’altopiano tibetano.
4 | Denti d’oro e monete di sale Il Nord e il Sud della Cina. Il Catai e il Mangi (da Man-yi, «Barbari del Meridione»): la geografia cinese risultava chiara a Marco Polo. La dividente era il Fiume Giallo: spaventoso e maledetto quando straripava provocando inondazioni che distruggevano le colture; rasserenante e benedetto quando si lasciava incanalare assecondando i contadini che s’erano spaccati la schiena nei campi. Più giù, l’ansa occidentale del Fiume Azzurro s’insinuava dolcemente a ritagliare, quasi alla perfezione, il confine fra Sichuan e Yunnan. Per quei dipartimenti mosse con ogni probabilità messer Marco attorno al 1280, quando principe dello Yunnan era Esen Temür, figlio di Hugeci, quintogenito di Kubilai. Lo scetticismo che sull’autenticità di tale spedizione ha mostrato un certo settore della storiografia contempora250
nea, specie in ambito anglosassone (per esempio con le pur articolate ricerche di un John W. Haeger o di un John Larner), è stato ribaltato dagli studi degli storici cinesi. L’apporto decisivo di un eminente studioso quale Yang Zhijiu, i continui interventi di Fang Guoyu, Lin Chaomin, Chen Dezhi, Gu Weimin e altri specialisti hanno dimostrato come le descrizioni poliane trasmesse all’Europa – ma anche, sia detto, e per la prima volta, agli asiatici – appaiano in questo caso troppo particolareggiate, e insistano su dettagli troppo peculiari per non essere vere. Il giovane esploratore del gran khan non avrebbe mai potuto tratteggiare con tanta esattezza località, usanze, pratiche commerciali se non le avesse viste e vissute di persona, nell’itinerario che da Xichang lo dovette portare a Kunming. Addentrandosi in un coacervo di etnie, credenze, riti e paesaggi, Marco prenderà notizie sulla pesca delle perle nei laghi, monopolizzata dall’amministrazione imperiale; fornirà informazioni sull’estrazione del turchese dalle montagne; e non rinuncerà a condire con un sorriso episodi – tutto sommato usuali – di puro e semplice meretricio: fra le scene più sapide del viaggio, in un’atmosfera boccaccesca, si ritroverà dinanzi all’inveterata abitudine che alcune donne avevano di concedersi ai forestieri di passaggio, col beneplacito del coniuge, o del padre, o comunque del padrone di casa. Anzi, era proprio lui, l’uomo di famiglia, a invogliare mogli e figlie ad accondiscendere alle libidini degli estranei, poiché questa era reputata un’azione gradita alle divinità, un atto beneaugurante, che avrebbe apportato benessere al raccolto e felicità alla compagine familiare. Sicché il cappello, o qualsiasi oggetto personale che lo straniero lussurioso appendeva fuori dalla finestra, aveva un significato inequivocabile: non disturbare. Vedendo quell’indicazione, il marito che frattanto s’era allontanato nella residenza di 251
campagna evitava accuratamente di ritornare al focolare domestico, almeno fintantoché il segnale non era stato rimosso: e potevano trascorrere anche tre giorni filati! Intorno ai caseggiati si svelavano i tratti d’una provincia ubertosa, ricca di garofano aromatico e cannella, popolata dalla fauna più diversa, odorosa del muschio estratto dagli zibetti, prodiga di zenzero e grossi pesci lacustri. Scarseggiavano i vigneti, ma un buon vino lo si stillava dal grano e dal riso, mescolati a spezie che mai avrebbero raggiunto le bancarelle europee. I torrenti donavano pagliuzze auree. E gli scambi, i commerci avvenivano col salgemma: era col sale che in effetti si pagava, dopo averne estratto dalle tante saline e averlo trasformato in panetti mediante cottura. Verosimilmente siffatta tipica modalità di pagamento non la si sarebbe potuta conoscere soltanto per sentito dire. Se Marco Polo non si fosse istruito di persona, molto difficilmente avrebbe saputo valutare con precisione il peso del sale in rapporto al valore dei metalli preziosi. Quaranta libbre di sale valevano un saggio (la sesta parte di un’oncia, circa cinque grammi) d’oro fino. In alternativa – e anche stavolta Marco parrebbe denunciare una ricognizione autoptica – gli abitanti della Cina sudoccidentale utilizzavano delle conchiglie: ottanta cypraeae corrispondevano così a un saggio d’argento, che la conversione marcopoliana equipara a due grossi veneziani (monete argentee piuttosto consistenti). Fra popolazioni dedite all’agricoltura e all’allevamento, fra gente dai dialetti inestricabili si acquistava di tutto, pure la carne che in alcuni territori, ancora una volta per ispezione diretta, Marco Polo vide consumare cruda. I più poveri, in verità, andavano in beccheria a raccattare le interiora di castroni appena macellati, per metterle a macerare in una salsa d’aglio e mangiarne in pezzi grossi. I nobiluo252
mini invece facevano sminuzzare sottilmente le frattaglie e le insaporivano con spezierie massimamente delicate, prima di cibarsene senza cuocerle. Dal ventre degli enormi coccodrilli che proliferavano nelle paludi fluviali o lacustri si ricavava invece un fiele efficace per curare i morsi dei cani, le malattie dei bambini e le difficoltà delle puerpere nel partorire. La molteplicità d’uso e la non semplice reperibilità rendeva quel medicinale carissimo sul mercato, così come un costo elevato aveva la prelibata polpa di alligatore. Visitando città e villaggi con visione mercantesca, Marco Polo capì inoltre che, scarseggiando l’argento, il commutarlo in oro o conchiglie risultava particolarmente vantaggioso. In un sistema economico da penetrare gradualmente, le transazioni e gli affari interni si basavano talora su metodi desueti: i due contraenti incidevano un marchio su un bastone, che veniva tagliato e restava diviso finché non fosse stato concluso definitivamente il negozio. Solo allora le porzioni separate del legno si potevano riattaccare, a suggellare l’esito felice dell’accordo. Il commercio con l’estero riguardava invece spesso mandrie di magnifici cavalli, avviati all’esportazione in India. Nel soffermarsi su razze equine e cavalcature, Marco notò che taluni cavalieri montavano in sella «alla francese», con staffe lunghe, piuttosto che «alla mongola», a staffata corta. Un’antica nobiltà guerriera era riflessa dalla sontuosità delle loro armature damaschinate e arabescate, dal cuoio di bufalo delle corazze, dalla conoscenza delle balestre e dalla meticolosità con cui se ne avvelenavano i dardi. E sì che di veleni se ne intendevano, da quelle parti: prima che la dominazione dei Mongoli riportasse l’ordine ed estendesse le leggi del gran khan, era abitudine avvelenare gli stranieri più belli e più saggi. E non per rubarne i soldi, ma sol 253
perché si riteneva che tutta l’intelligenza, tutta la bellezza e la fortuna del visitatore potessero rimanere per sempre fra le mura casalinghe. Erano abitudini insolite, per l’inviato del gran khan. Stranezze di un comprensorio che lo sorprendeva a ogni passo: in certi posti c’erano uomini che si divertivano, fra una guerra e l’altra, a cacciare e uccellare, proprio mentre le mogli, ben volentieri, se la spassavano con i più aitanti fra gli schiavi privati. Altre costumanze locali volevano inoltre che i neonati venissero accuditi nei loro primi quaranta giorni di vita dal papà, di modo che la madre fosse esentata da ulteriori fatiche post-parto e potesse dedicarsi ai lavori domestici, continuando a servire e riverire il consorte. Di conseguenza il genitore, subentrato nella «covata» alla genitrice, poteva far festa insieme agli amici standosene comodamente nel letto col figliuolo, governandolo e ricevendo regali per il lieto evento. Il serbatoio memoriale di Marco Polo si riempiva dunque di continuo. Segni di diversità, varia umanità si affastellavano nelle terre intersecate dal Mekong (che nel tratto cinese è il Lancang), spesso dalla ridotta accessibilità. Talvolta l’aria si faceva mefitica, e nelle comunità più conservatrici, ignare di scrittura, di idoli e di chiese, la medicina era affidata a incantatori che, per guarire i malati, entravano in contatto con gli spiriti. Nenie, danze, sacri strumenti producevano la trance, e schiumando bava dalla bocca, fra estasi e morte, lo stregone annunciava agli astanti le procedure da mettere in pratica per superare l’infermità: generalmente sacrifici di montoni, e incensamenti, aspersioni sante che, nell’abitazione illuminata a giorno dell’ammalato, si chiudevano in bevute festose, in abbuffate collettive, dove si gozzovigliava con le carni cotte dell’ariete immolato. 254
Sulla strada da Dali a Bhamo, fece poi ancor più meraviglia a Marco Polo scoprire presso i maschi di etnia Dai l’usanza di decorare la dentatura, sia inferiore che superiore, con un rivestimento dorato: ed era un particolare, anche questo, che il veneziano non avrebbe potuto rilevare se non si fosse fisicamente avvicinato alla doratura scintillante. Ma già i tatuaggi, la vasta piana depressionaria dell’Irrawaddy evocavano la Birmania, i suoi rinoceronti facilmente scambiabili per unicorni, la sua capitale, Bagan. Era, quella, la «città dei centomila templi». Traboccava di costruzioni sfavillanti che i regnanti birmani avevano commissionato per magnificenza personale e per zelo religioso. Le torri ricoperte d’oro e argento, le campanelle pendule dalle architetture a giocare col vento, esprimevano la grandezza e la raffinatezza di un reame che rientrava nelle mire egemoniche di Kubilai, e col quale l’imperatore yuan aveva cominciato a guerreggiare dal 1277. Più oltre, a ponente, si preannunciava l’Asia del Bengala, la penisola indiana coi suoi elefanti, i suoi eunuchi, le sue copiose rivendite di nardo, galanga, zenzero. Per Marco Polo era già tanto. Aveva immagazzinato abbastanza per sé, per le proprie prospettive commerciali, come pure per il desiderio e le aspettative del gran khan. Poteva quindi lasciare lo Yunnan, snodo delle conquiste indocinesi degli Yuan, regione che Sayyid Ajall, col suo governo, aveva contribuito a islamizzare (ma senza preclusioni per nestoriani e buddhisti). Sazio per quel segmento di viaggio fuori dall’ordinario, Marco poteva adesso rientrare a Pechino. La Cina gli si stava sedimentando, dentro.
Parte quinta L’ASIA RIVELATA
Capitolo tredicesimo
L’AGENTE SPECIALE DEL GRAN KHAN
1 | Congiure di palazzo Ucciderli tutti. Ammazzare quelli che portavano la barba. Mongoli, musulmani, cristiani. Gli stranieri, insomma: ben distinguibili, giacché i cinesi non erano mai barbuti. La sollevazione era stata preparata con cura. Da Pechino si sarebbe propagata ad altre città, approfittando anche della momentanea villeggiatura di Kubilai Khan a Shangdu, fra il marzo e l’aprile del 1282. In assenza dell’imperatore, l’obiettivo primario della sommossa restava il suo delegato al governo di Khanbalik: l’odiato, il temuto, l’invidiato Ahmed Fenaketi. Era calato il buio. Il procuratore se ne stava nei suoi appartamenti del borgo antico, reduce dal tran tran amministrativo di una giornata appena sfumata. Il trambusto cittadino s’era ricomposto. Il tramonto aveva diluito il caos diurno. La Grande Capitale non sbuffava più. Solo lo stridio a intermittenza degli uccelli notturni fendeva il silenzio. E suoni liquidi, a saperli ascoltare, salivano dolcemente da canali, ruscelli e fontane. I congiurati assecondarono la quiete. Vi si immersero e se ne fecero avvolgere. Freddi, felpati, entrarono di soppiatto nel palazzo imperiale. Uno di loro si issò sul trono, 258
mentre l’aula dei ricevimenti veniva a bella posta inondata da una luce stordente. Un altro andò invece a chiamare Ahmed Fenaketi dalla casa, dicendogli che il principe ereditario era sopraggiunto all’improvviso e che desiderava urgentemente incontrarlo. Il ministro, colto alla sprovvista, mossosi in tutta fretta, non ebbe nemmeno il tempo di sciogliersi dalla confusione di quegli attimi che impastavano sonno, sorpresa, stanchezza. Dall’oscurità si ritrovò catapultato nel salone illuminato a giorno della reggia khanale. E dinanzi al podio degli Yuan, frastornato nel lucore, il funzionario non fece nemmeno in tempo ad accorgersi d’essere ai piedi di un impostore: la testa, recisa da un fendente vibrato con una spada, gli rotolò via dal corpo. A quel punto la rivolta era pronta a esplodere. Fu, invece, un aborto: il segnale che doveva rimbalzare di località in località, e attivare gruppi di cittadini in armi, non partì mai. Prima ancora che il cenno dell’insurrezione fosse dato, i fidatissimi guardiani imperiali, i kesigten, erano già intervenuti a eliminare i capi della sedizione e a ripristinare l’ordine. Lo avevano fatto con una prontezza tale che tutto sembrava quasi esser stato studiato a tavolino, pianificato. In effetti, probabilmente Kubilai aveva bisogno di un capro espiatorio con cui smorzare il malcontento serpeggiante. Le vessazioni, l’esagerata pressione fiscale, la svalutazione galoppante della cartamoneta opprimevano la popolazione cinese. E nessuno, più di Ahmed Fenaketi, arricchitosi smodatamente coi suoi soprusi, incarnava la prepotenza: aveva accumulato una colossale fortuna, per sé e i propri parenti, angariando e manovrando a piacimento l’economia statale; s’era costruito un potere amplissimo e pressoché assoluto, che lo metteva al riparo da qualsiasi addebito e gli consentiva di compiere impunemente i peggiori crimini; e s’era guadagna259
to il rancore di molti cittadini, che avrebbero voluto scannarlo per gli stupri perpetrati su mogli, madri e figlie. Vero è che, con l’operato del potentissimo ministro, le entrate fiscali s’erano gonfiate. Ma ingrassato s’era pure Ahmed Fenaketi, a dismisura, e come lui la compagine musulmana, che stava acquisendo un’influenza eccessiva negli affari statali. Non è escluso, perciò, che nell’assassinio (camuffato da congiura?) del tesoriere degli Yuan ci fosse lo zampino di Kubilai Khan. Il sovrano desiderava ridimensionare le prerogative politiche ed economiche del ceto islamico, e insieme presentarsi pubblicamente come restauratore della giustizia: si spiegherebbe così la teatralità nel far riesumare le spoglie dello scellerato Ahmed per darle in pasto ai cani, e l’esemplarità nel condannare al supplizio i suoi figli, facendoli scorticare vivi. Dal 1279, d’altronde, erano state promulgate delle ordinanze regie che avevano cominciato a limitare l’estrinsecazione dei riti coranici, sottolineandone la discrepanza con le leggi nomadiche dello yasak: si pensi al fatto che per l’islam gli animali andavano macellati spargendone obbligatoriamente il sangue tramite sgozzamento, mentre le prescrizioni mongole proibivano il dissanguamento e imponevano che la macellazione avvenisse con l’esecuzione di un taglio, sapiente, che permetteva alla mano del macellatore di entrare nel petto della bestia e di comprimerle il cuore, senza che neppure un fiotto venisse fuori. Pare inoltre che, per un po’ di tempo, entro i confini dell’impero fosse impedita la circoncisione, pratica usuale degli islamici: ma si trattò comunque di limitazioni di breve durata, che rimasero in vigore per il periodo necessario a ristabilire le priorità nell’esercizio del potere istituzionale. Di sicuro, la morte repentina e tragica di colui che era stato per molti anni il can260
celliere più vicino a Kubilai aveva avuto un valore emblematico, per certi versi addirittura «didattico». Dall’omicidio di Ahmed Fenaketi dovette effettivamente derivare a Marco Polo una salutare lezione: salire troppo in alto nelle gerarchie appariva rischioso, poteva costar caro. Nelle file della burocrazia imperiale era forse preferibile mantenere un profilo basso, non esporsi. E il ruolo di nokor, che Luciano Petech propone di annettere alle attribuzioni cinesi di Marco (equivalente al primo stadio della scala cavalleresca occidentale, ossia all’homme lige francese), sembra consono a definire il grado istituzionale di un uomo libero e al servizio del sovrano. La funzione di emissario imperiale (chishih), con licenza di viaggio e di comando presso le stazioni di posta, e con il diritto di esigere obbedienza dalle autorità locali, era calzante per il viaggiatore veneziano, e ne delineava adeguatamente i compiti. Soprattutto, era uno statuto precario, non permanente: ed è questo l’elemento che potrebbe spiegare la mancata menzione di Marco Polo – e di suo padre Niccolò, e di suo zio Matteo – negli Annali cinesi o nelle fonti sino-mongole della dinastia yuan (come ha tenuto a ribadire anche recentemente Philippe Ménard). Gli incarichi coperti dall’uomo di Venezia avevano evidentemente carattere temporaneo, non definitivo, e venivano a lui affidati in base alle occorrenze, a seconda delle congiunture. In buona sostanza, Marco Polo agiva da battitore libero: «Doveva essere», ha scritto Mario Bussagli, «nella condizione molto particolare di assolvere compiti e di svolgere funzioni che implicavano una notevole fiducia in lui e, temporaneamente, una notevole potenza, anche se egli non assurgeva alle alte cariche della struttura burocratica. Era, verosimilmente, una specie di longa manus del khan, non inquadrata nelle gerarchie se non per quello che serviva ad assicurargli una vita agiata, con po261
teri variabili a seconda del compito da svolgere». Per Kubilai Khan, Marco era quindi un factotum e un passepartout, un jolly a disposizione per ogni evenienza. Per Marco Polo, Kubilai era invece il motore e il motivo del suo eccitante girovagare, l’impulso del suo andare per un Levante che gli si presentava sempre diverso e sempre pieno di novità, sia che si cambiasse obiettivo, sia che si ritornasse a distanza di qualche anno in luoghi precedentemente visitati. In viaggio per la Cina, le opportunità di imparare e contemporaneamente di praticare la mercatura per trarne dei vantaggi economici erano la ragione di un’esistenza. Le ispezioni di Marco Polo non avevano come unica finalità la relazione da riportare all’imperatore. Ciascun sopralluogo rispondeva al desiderio di sapere e di far fruttare, di apprendere e di ottimizzare le cognizioni, in un modo o nell’altro, con le gratifiche del gran khan o con l’imbastitura di un commercio, con gli agi di una condizione privilegiata o con le prospettive di poter mercanteggiare più facilmente, di far mercatura di gemme, di aprire una linea diretta con l’Occidente, oppure col subcontinente indiano, o ancora con gli empori del Sud-Est asiatico, con l’Indocina, con gli arcipelaghi del Pacifico, con isole da guadagnare imbarcandosi dai porti cinesi della costa orientale. Erano ancoraggi che Marco Polo imparò a conoscere sin da quando, tornato dallo Yunnan, Kubilai lo aveva mandato a visitare la regione di Yangzhou, le terre di Cina che sfinivano nell’Oceano.
2 | Verginità e incantesimi Era tutto un andare e un venire, un dare e un ricevere. Nel XIII secolo (secondo la tesi di Dominique Lelièvre) la mari262
neria più potente del mondo era quella cinese, e le giunche fabbricate in Cina irraggiavano ovunque le loro prue. In senso inverso i mercanti arabi, malesi, indiani e persiani frequentavano abitualmente il Mar Cinese Orientale e Meridionale. Grembo per i loro navigli era pure il Golfo del Tonchino, alle cui spalle, fra gli attuali Laos e Viet Nam, regnavano principi dall’incontenibile lussuria: benché potessero godere di centinaia di mogli, quegli ingordi sovrani concupivano e non esitavano a pigliarsi qualsiasi fanciulla di bell’aspetto che capitasse nei loro paraggi. L’idea di bellezza e nobiltà in quei territori era piuttosto originale, essendo collegata ai tatuaggi che, eleganti, con stupende immagini di volatili e mammiferi, s’infittivano sui corpi di uomini e donne, e gareggiavano in magnificenza coi bracciali d’oro e d’argento portati a polsi e caviglie. Marco Polo, acutamente, intese il significato di quel particolarissimo gusto estetico che coniugava la pictografia con la finezza aristocratica: non vi si fosse accostato di persona, certamente non avrebbe potuto cogliere il portato di una cultura così particolare, al di là delle notazioni sulla dovizia di cavalli, buoi, vacche e bufali che si allevavano nelle pianure per la disponibilità di copiosa pastura. Sui monti dell’interno, invece, gruppi di gente dalla pelle bruna e dalla tempra guerriera usavano cremare i defunti e appenderne le ossa incombuste nelle caverne, fuori dalla portata di bestie ed eventuali profanatori. Borghi e fortificazioni picchiettavano contrade alquanto aspre, che si stemperavano più verso levante in grandi e nobili città, votate all’artigianato e ai commerci. Nel muoversi fra un abitato e l’altro, bisognava però stare attenti ai felini di grossa taglia che, specialmente nottetempo, terrorizzavano i viaggiatori: tanto che i barcaioli dei fiumi badavano a mantenere la debita distanza dalle rive, per non ritrovarsi a tu per tu 263
con zanne mortifere. E a eludere incontri troppo ravvicinati e insidiosi, ogni saggio cavaliere addestrava una coppia di cani che, alla bisogna, con la loro agilità, erano capaci di scacciare e addirittura inseguire le belve feroci, ingaggiandovi duelli sanguinosi, a morsi, in una follia di ruggiti e latrati: e il combattimento durava sinché il padrone non sopraggiungeva a finire l’ormai lacerata belva a colpi di freccia e di lancia, nella selva dove la fiera, inseguita, aveva cercato scampo. Alla ruvidezza che talora assumevano gli scenari extraurbani si contrappuntava la grazia delle cittadine. E nei centri abitati, ancora una volta, Marco fermò lo sguardo e impresse nelle proprie meningi un costume che nessuno, se non cogliendolo in diretta, avrebbe potuto registrare: d’estate, l’abbigliamento più in voga era preparato con drappi di scorza d’albero, evidentemente più freschi. Erano abiti confezionati in fibra vegetale, di scarsa rilevanza commerciale, e che in pochi dovevano conoscere: difficilmente, quindi, Marco Polo avrebbe potuto captarne dai racconti di altri mercanti (sebbene vada ricordato come la produzione molto particolare di bei tessuti «selvatici», che arrivavano dalle foreste, rimontasse in Cina a quattordici secoli addietro, e fosse pertanto da ritenere abbastanza tradizionale). Ben più delle stoffe di corteccia arborea, erano le seterie a ingolosire i traffici mercantili. E di seta abbondava la gran parte delle località in cui Marco mise piede spostandosi fra il Catai e il Mangi, sul versante centro-orientale della Cina. Abituatosi fino a quel momento a commentare costumi sessuali piuttosto libertari (se non addirittura agli antipodi della morale corrente), cresciuto in una città che, come Venezia, proponeva una vasta gamma muliebre (dalle fascinose signorine che poggiavano sui davanzali i loro décolletés oc264
chieggiando civettuole ai passanti, alle vere e proprie prostitute conglobate nel luridume del Castelletto di Rialto), Marco Polo restò positivamente meravigliato dalla morigeratezza delle fanciulle cinesi di buona famiglia. Erano pulcelle che rifuggivano dalle feste e dai balli, dalla baldoria e dai discorsi spinti, che non parlavano mai a sproposito, che snobbavano i corteggiatori, e che solo in compagnia delle madri uscivano, di tanto in tanto, per recarsi a pregare nel tempio, o in visita ai parenti: sempre mantenendo, però, lo sguardo basso, per non incrociarlo con gli sconosciuti. In casa, le donzelle bene educate se ne stavano a lavorare nelle proprie stanze, e raramente comparivano dinanzi al padre, ai fratelli, o anche ai familiari più anziani. Va da sé che la verginità, in un simile contesto, era un requisito fondamentale in funzione del matrimonio: per provare l’illibatezza al promesso sposo, la fanciulla veniva condotta nelle terme e ispezionata da esperte ginecologhe, che armeggiando con uova di piccione, ovvero scandagliando la vagina col dito avvolto in un velo bianchissimo, certificavano la castità: una macchiolina indelebile assicurava che era sangue di vergine, mentre la detersione della chiazza significava corruzione. In quel caso, al padre della ragazza toccava rifondere i danni al mancato genero e risarcirlo economicamente, sulla scorta dei patti prematrimoniali. Era dunque comprensibile che, considerata la preziosità dell’essere vergini, le donne camminassero a passettini infinitamente corti, per non allargare più di tanto il compasso delle cosce e compromettere la compattezza della vulva: e Marco Polo non poté fare a meno di paragonare la compostezza delle gentildonne cinesi alla sguaiataggine delle tartare, che addirittura non mostravano remore nell’andare a cavallo a gambe larghe, col serio rischio – secondo il viaggiatore veneziano – di rimanerne deflorate! E talmente radica265
ta era la creanza cinese, da contagiare talvolta anche il sesso forte: per nessun motivo due consanguinei si sarebbero mai provati ad andare in coppia al bagno, nella dilatazione estrema d’una pudicizia declinata anche al maschile. I precetti confuciani avevano chiaramente influenzato larghi strati della società, in particolare nei territori prossimi allo Shandong, la provincia natìa di Confucio. Ma oltre alla verecondia nobiliare, la Cina serbava pure sacche di superstizione popolare, che si estrinsecava nell’adorazione di diverse entità spirituali, e in forme di religiosità prossime alla scaramanzia o alla sfera d’azione delle fattucchiere: Marco Polo dovette conoscere personalmente l’operato di alcune vegliarde che, millantando d’essere in contatto con un’altra dimensione, erano capaci, fra fumi d’incenso ed evocazioni spiritiche, di far recuperare gli oggetti smarriti o rubati. Collegandosi con l’ultraterreno, le vecchie riuscivano infatti a indicare i luoghi e i possessori delle cose perse o trafugate, e a mostrare il sistema idoneo a recuperarle. La maledizione della maga-medium si abbatteva su coloro che rifiutavano di restituire il maltolto: le ladre erano condannate a ferirsi a una mano o a cadere nel fuoco, oppure a incappare in brutti incidenti mentre erano alle prese coi fornelli, affaccendate nelle tipiche mansioni femminili; i furfanti maschi, a loro volta, qualora avessero negato la restituzione della refurtiva, sarebbero incorsi nella frattura di un piede, di una gamba, di un braccio o in un qualsiasi malanno derivante da occupazioni di stampo prettamente virile, come il tagliare la legna. Si trattava di malocchi in piena regola, per certi aspetti affini a dei voodoo. Fatture, sortilegi, che andavano in qualche modo ricompensati con regali pregiati, quali potevano essere dei veli in seta trapunta a filo d’oro. 266
Che dietro a certi incantesimi vi fosse un’evidente irrazionalità (quando non una premeditata messinscena per allocchi), fu abbastanza chiaro a Marco Polo. Il disincanto, lo scetticismo – puro patrimonio mercantesco – erano i suoi anticorpi. Così, il Veneziano dapprima si rivolse a una maliarda per ritrovare un anello perduto. Poi, dopo averlo effettivamente riavuto, si guardò bene dal remunerare la prestazione con un congruo e canonico omaggio «agli dèi». Altre erano le caratteristiche da considerare nella decifrazione di una civiltà evoluta e moderna.
3 | Monopoli di Stato L’entrata di ciascuna abitazione recava scritti i nomi del signore, della signora, di figli e servi. Se moriva qualcuno, il nome veniva depennato. Se qualcuno nasceva, un nome si aggiungeva: così i governatori locali potevano sempre avere sotto controllo il numero dei residenti, in ogni città, in ogni strada di paese. Gli alberghi erano poi tenuti a registrare accuratamente la presenza e il periodo di permanenza degli ospiti, e a cancellare la registrazione al momento della loro partenza: e anche in simili procedure Marco Polo riconobbe un livello elevato di sviluppo civile. Il Veneziano ebbe a pensare che, fossero stati uomini d’armi, quelli del Mangi avrebbero conquistato il mondo. E invece, col loro tenore culturale e con la loro finezza, si dedicavano a tutt’altro: mostravano predisposizione per il commercio, e sembrava avessero una innata vocazione per la filosofia e la medicina. Credevano inoltre nel destino astrologico: per ogni neonato venivano sistematicamente appuntati luogo, giorno e ora 267
della procreazione, insieme alla stella che aveva sovrinteso alla nascita. Gli astrologi erano altresì consultati sull’opportunità di intraprendere un’impresa o un viaggio, e la scienza divinatoria manteneva intatta la sua secolare popolarità. In Cina, Marco Polo constatò che, oltre allo zodiaco, l’igiene corporale era curata con uno scrupolo pressoché sconosciuto altrove: tutti i giorni, sin da bambini, i più costumati fra i cinesi avevano per regola quella di lavarsi ben bene in bagni dotati di acqua fredda, ritenuta più salutare per il fisico (mentre l’acqua calda, che pure non mancava, era appannaggio dei forestieri). Drappelli di servitrici e servitori aiutavano le persone nel detergersi, e non era possibile mangiare se non prima d’essersi lavati. Un che di purificatorio era sotteso anche a determinate cerimonie funerarie: parenti e amici partecipavano al lutto con un abbigliamento di estrema modestia, fatto di canapa o altra materia vile. Fra suoni ritmati e nenie funebri, i cadaveri venivano bruciati assieme a immagini cartacee di schiavi, cammelli, cavalli, denaro, e alle masserizie indispensabili affinché i defunti continuassero a essere onorati nell’oltretomba, almeno quanto lo erano stati in terra: in una terra profondamente cinese ma che pure, adesso, gli Yuan stavano segnando con una propria personale impronta, con una traccia per svariati aspetti profonda e riconoscibile. La robustezza del giogo ne era una componente inequivocabile, che serviva a catechizzare, a mansuefare la popolazione. I ricordi di ribellioni domate passavano di bocca in bocca, a ingigantire la sensazione di indiscutibile saldezza imposta al regno dall’autorità di Kubilai Khan, a inculcare nei sudditi il peso della signoria sino-mongola, in tutta la sua ineluttabilità. Viaggiando fra le province orientali dell’impe268
ro, Marco Polo seppe che, pochi anni prima del suo arrivo, una rivolta di Li Tan, governatore dello Shandong, era stata spietatamente domata dalle truppe imperiali. A Changzhou il Veneziano apprese poi di come alcuni soldati alani, al servizio del gran khan durante la guerra contro i Song, si fossero impadroniti della città e, avendovi scoperto enormi quantità di ottimo vino, ne avessero trangugiato più che volentieri, dopo le stressanti fatiche guerriere: tanto che s’erano addormentati, ubriachi. La popolazione cittadina ne aveva allora approfittato per far strage degli inerti avversari. Ma quel comportamento infido era stato punito con inesorabile crudeltà dal generale Bayan: massacrando brutalmente l’intera cittadinanza ribelle, il comandante mongolo aveva immediatamente riaffermato la forza e la potestà, incontestabile, degli Yuan (e per Fang Hao, storico dell’odierna Repubblica Popolare Cinese, la conoscenza di episodi così tanto circostanziati sarebbe un’ulteriore, effettiva testimonianza della veridicità delle spedizioni compiute da Marco Polo in Cina). I fantasmi di atrocità pregresse non rappresentavano tuttavia gli unici indizi del dominio yuan, che quasi per ogni dove era contrassegnato dall’uso della cartamoneta, dal buddhismo o dal sistema integrato di vie acquatiche e terrestri. Poteva pertanto capitare di vedere in mezzo a un fiume un isolotto, e sull’isolotto un tempio, e nel tempio centinaia di monaci buddhisti. A Zhenjiang sorgevano peraltro due chiese nestoriane, ascritte da Marco alla presenza di Mar Sargis, un sacerdote originario di Samarcanda, che intorno al 1278 era stato nominato amministratore della città cinese e vi aveva incentivato il cristianesimo: una volta di più, le cognizioni poliane scaturivano da un’osservazione diretta, da una «zoomata» che stringeva l’obiettivo su una pe269
culiarità assoluta, in un comprensorio popolato da una fauna che si faceva straordinariamente variegata presso i grandi corsi fluviali. I mammiferi, gli uccelli che si affastellavano festanti lungo gli alvei erano uno spettacolo meglio godibile dai battelli che solcavano la Cina. Non era un problema navigare a favore di corrente. Risalirla, piuttosto, implicava qualche difficoltà, che si risolveva con il traino di una dozzina di cavalli: dalle rive, i palafreni rimorchiavano le imbarcazioni con corde molto solide, che Marco notò fatte di filamenti di bambù (e non di canapa). Sulle navi, che erano spesso coperte e possedevano un albero, poteva viaggiare di tutto, compreso il sale che, monopolizzato dallo Stato, soggetto al controllo ferreo dell’amministrazione khanale, costituiva un altro degli emblemi manifesti del potere di Kubilai. Le saline picchiettavano di bianco terre e metropoli che nella provincia di Jiangsu apparivano spesso immerse in una vegetazione rigogliosa. Fu negli anni Ottanta del XIII secolo che Marco Polo andò a Yangzhou, delegato dal gran khan a esercitare per un triennio i poteri di funzionario imperiale, verosimilmente addetto al mercato del sale. Qualche specialista, a dire il vero, ha avanzato l’ipotesi che il Veneziano fosse stato addirittura preposto all’incarico di governatore generale. Qualunque sia stato l’ufficio, da una considerevole parte della critica è accettato che Marco dovette realmente avere a che fare con la produzione e la rendita del sale. Conobbe infatti alla perfezione e tenne la contabilità delle stratosferiche entrate che la movimentazione del preziosissimo prodotto – in un territorio vicino all’Oceano Pacifico, e dunque favorevole alla coltivazione salina – recava all’erario statale: i calcoli poliani degli 800.000 jin che venivano ricavati dal distretto troverebbero difatti conferma ne270
gli studi di Chen Dezhi, che per lo stesso periodo ha stimato un valore delle tasse sul sale molto prossimo a quanto ebbe a computare Marco Polo (per una cifra quantificabile in circa 900.000 jin). Una pagina scritta da Olschki nel 1957 sintetizza esemplarmente la questione: «Nessun prodotto ebbe [per Marco Polo] tanto rilievo quanto quest’umile cloruro di sodio, abbondante in tutta l’Asia nelle sue più diverse qualità commestibili o medicinali, e certamente non considerato mai da Marco come mercanzia od oggetto d’esportazione [...]. Quindi egli ne studia la produzione nelle varie province della Cina, il suo commercio, l’uso che ne fanno alcuni popoli orientali come moneta e le somme favolose che lo Stato ne ricava come articolo di monopolio più universale, importante e redditizio. Ed è più che altro questa circostanza che accentra la sua costante attenzione sulle saline dell’Estremo Oriente; tant’è vero che egli ne tiene conto soltanto nei territori soggetti al Gran Cane, senza far parola dell’immensa produzione di sale in India e nell’Asia tropicale da lui visitata. Da ciò si riconosce che Marco considerò questo fenomeno cogli occhi del funzionario e non solo del naturalista empirico e curioso. La menzione del sale è [...] così insistente e il calcolo del suo reddito fiscale o del suo valore monetario così preciso in dati e cifre da indurci a credere che egli sia stato occupato lungamente in questo principalissimo ramo dell’amministrazione imperiale. Infatti egli trascorse tre anni a Yangzhou nella provincia salinifera cinese del Jiangsu, non certo in qualità di governatore [...] ma comunque in una posizione ufficiale alla quale, giovane ancora, egli poteva essere avviato con successo. Un tale ufficio poteva essere appunto quello delle saline imperiali, tanto importante quanto impopolare nella Cina [degli Yuan] che ne traeva i massimi redditi, vigilandone lo sfruttamento e 271
appaltandone il prodotto». Fu dunque un lavoro «rognoso», ingrato ai più e malvisto dal popolo, quello di Marco Polo alle prese con il sale? Può darsi. Nondimeno, il mercante di Venezia vi si dedicò con fervore, abitando continuativamente, per parecchi mesi, in un comprensorio di grande armonia paesaggistica. Yangzhou, presso il delta del Fiume Azzurro, collegata a Pechino dal Canale Imperiale, adagiata fra bellezze naturali che tuttora attirano un flusso annuale di milioni di turisti, rappresentò presumibilmente uno snodo fondamentale per il viaggio e l’esistenza di Marco Polo. A lui, qui, è attualmente dedicato un museo cittadino.
4 | Le geishe di Hangzhou Di Marco Polo campeggia pure una statua in una grande piazza ad Hangzhou (che qualche studioso insiste nel preferire a Yangzhou quale sede del soggiorno triennale del viaggiatore). Le contrade attigue a quella che era stata la capitale della monarchia song tracimavano di zucchero, spezie, seta, riso, carbone e ogni ben di Dio. Con le gabelle riscosse per ciascuna mercanzia e coi tributi sull’artigianato, le casse del Tesoro yuan si riempivano vertiginosamente. E al mercante veneziano, inviato dal gran khan, la metropoli che oggi, riveduta e corretta dalla modernità, si apre sull’omonima baia (a sua volta attraversata dal ponte più ampio del mondo, 36 chilometri di lunghezza e tecnologia), dovette presentarsi in uno splendore ancora immutato, nell’intera sua esuberanza e poliedricità. Il nome, innanzitutto: Marco la chiamava Quinsai, da Xingzai, «Sede di passaggio», vale a dire «Capitale prov272
visoria», come i Song definivano la megalopoli dove ritenevano di aver ubicato solo temporaneamente la corte imperiale, in attesa di poter riconquistare le regioni settentrionali della Cina e riallocare le insegne del potere sopra la linea del Fiume Giallo. La supposta temporaneità non aveva però sminuito la grandezza e la magnificenza di un luogo che rimarrà perennemente luminoso nei ricordi marcopoliani, e che per diversi aspetti sociourbanistici era veramente esemplare nel delineare le peculiarità della cultura cinese. Quinsai/Hangzhou appariva innervata di strade e canali che si armonizzavano fra più di un milione e mezzo di case e ville. Ornate spesso da giardini fiabeschi, le architetture residenziali apparivano decorate con pitture e sculture deliziose, giacché per attingere il «bello» la gente del posto non badava a spese. Gli sfarzosi appartamenti dell’aristocrazia, inframmezzati da templi sontuosi e monasteri imponenti, affacciavano spesso su un meraviglioso specchio d’acqua, accarezzato mollemente da lievi imbarcazioni. Sospinte da marinai che, simili nella posa a dei gondolieri, facevano leva su una pertica, le barche permettevano di effettuare delle escursioni in compagnia di amici (e allora s’era in tanti), oppure di allontanarsi dalla riva insieme a qualche fanciulla (e allora s’era in due). In mezzo al lago, due isolotti incastonavano altrettanti padiglioni arredati con mobilia lussuosa, vasellame di pregio, e con stoviglie, taglieri, attrezzature fatte apposta per chi volesse festeggiarvi nozze e convivi di qualsiasi genere. Gli abitanti di Quinsai amavano rilassarsi nello sciabordio lacustre al termine della giornata lavorativa. E i battellini, multicolori, dipinti con figure sinuose, erano accessoriati di tutto punto per intensificare il piacere: avevano comode e belle poltroncine sopra e sottocoperta, e in cabina possedevano oblò apribili o richiudibili, a piaci273
mento, per creare un po’ d’intimità o anche per lanciare sguardi sul variegato incanto del paesaggio intorno, sull’equilibrata morfologia di una città dalle costruzioni maestose e dagli alberi altissimi. Fra file ordinate di chiome verdeggianti, i viali cittadini disponevano d’un perfetto congegno di drenaggio delle acque pluviali, e luccicavano, magnificamente lastricati in pietra e mattoni. A entrambi i lati stradali una fascia era lasciata in terra battuta per il transito dei cavalli. Su e giù per le vie ombrose, a tutte le ore e fino a sera, andavano le vetture, gonfie di tende e di cuscini, dei signori in cerca di trastulli nei parchi cittadini. Nei quartieri in cui medici e astrologi esercitavano le relative professioni si insegnava anche a leggere e a scrivere. Per le piazze era un brulicare di mercanti e un pullulare di mercanzie, specialmente nei tre turni settimanali di fiera, quando decine di migliaia di persone si riversavano negli slarghi a rifornirsi di vivande. C’era di tutto, e tutto era disponibile, a volontà: verdura e frutta, pesche gialle e bianche, pere, riso, spezie, e carni di capriolo, cervo, daino, lepre, coniglio, pernice, fagiano, anatra, oca, e capponi, e pollame vario. Si poteva trovare (per mangiarne) anche carne di cane, mentre nelle macellerie si reperivano tranci di vitello, bue, capretto e agnello. Sulle tavole delle pescherie guizzavano pesci di mare o di lago, che Marco Polo riteneva grassi e saporiti poiché l’immondizia metropolitana, riversata in acqua, si convertiva in un eccellente mangime ittico. Il pepe, poi, fluiva a iosa, al ritmo di quasi diecimila libbre giornaliere, come Marco poté appurare sentendo far di conto gli attendenti della dogana khanale. Nei laboratori artigiani, i maestri tenevano bottega con decine di discepoli che si perfezionavano nelle produzioni tipiche delle dodici corporazioni cittadine. Gioiellerie, vinerie o drogherie orlavano i piazzali al piano274
terra. Ai piani alti s’elevavano invece dimore occupate da gente pacifica ed educata, poco avvezza alle armi e ai battibecchi: mai una lite s’udiva a Quinsai, mai si usava un tono di voce o un gesto che fosse men che cortese e amichevole. L’assenza di gelosie e di invidie, il grandissimo rispetto per le donne e il senso benevolo dell’accoglienza erano i pregi di una città che finì per sedurre Marco Polo. E alla seduzione non erano estranee le dame di piacere: le si «annusava» anche di lontano, per i profumi di cui si fasciavano, e le si trovava per tutta la città, col loro seguito di fantesche, in alloggi riccamente adornati e traboccanti di raffinatezza. Non si trattava di mere prostitute, di puttane di bassa lega: le intrattenitrici cinesi di Hangzhou somigliavano piuttosto a delle etère greche o a delle geishe giapponesi. Erano infatti colte ed esperte non solo nel regalare carezze e lusinghe, ma anche nel dialogare e trovare parole adatte a ciascun uomo. La loro arte erotica era così coinvolgente che – come racconterà Marco Polo – «i forestieri che le gustano una volta rimangono come fuori di sé, e tanto sono presi dalla dolcezza e piacevolezza loro, che mai se le possono dimenticare. E da qui avviene che, come ritornano a casa, dicono d’essere stati in Quinsai, cioè nella città del cielo, e non veggono mai l’ora che di nuovo possano ritornarvi». Hangzhou era insomma un empireo, e le meretrici i suoi angeli che vegliavano sul benessere degli uomini. Non che in città mancassero gli sventurati, gli storpi, i malformati: ma non li si vedeva in giro, poiché tutti venivano ricoverati, accuditi e sostentati negli ospedali. Qualche briccone, che magari si fingeva sciancato per indolenza e per scarsa voglia di faticare, se scoperto veniva obbligato a lavorare. Una polizia inflessibile assicurava d’altronde il rispetto 275
della legge, per cui era pressoché impossibile sfuggire ai controlli, talvolta asfissianti, su ognuna delle attività locali. Nelle loro sedi ufficiali, i magistrati nominati da Kubilai provvedevano a dirimere le controversie insorgenti fra i mercanti, e fungevano da giudici territoriali per qualsiasi contenzioso. I funzionari del gran khan avevano poi il compito di assegnare e verificare la vigilanza sui molteplici ponti cittadini (tutti in pietra e spesso edificati con arcate altissime, per agevolare il passaggio fra i fornici delle navi di stazza superiore). La sorveglianza era affidata a migliaia di guardie che, dislocate nei punti strategici, si alternavano in turni di cinque alla volta. Il coprifuoco andava osservato rigidamente, pena l’arresto immediato. Dalla cima di una torre, eretta su una collinetta, un guardiano poteva scrutare l’area metropolitana e dare l’allarme con un apparecchio sonoro nel caso di risse, ribellioni o incendi. L’impiego del legno nelle costruzioni e delle lucerne per l’illuminazione provocava, infatti, non di rado, dei roghi disastrosi, a stento estinguibili da vigili che si affannavano a recuperare gli effetti personali nelle case, e le merci dei negozi in fiamme, per depositare il tutto, al sicuro, in alcune torrette più riparate o nelle isole del lago cittadino. Le fiamme, allora, potevano compromettere l’integrità delle architetture e sommarsi ai guasti recenti della guerra, alle distruzioni che avevano colpito i luoghi simbolo del potere song. In rovina era andata difatti una porzione della reggia abitata dai sovrani cinesi prima dell’avvento mongolo. L’oro e l’azzurro delle sale palaziali erano state a lungo la cornice per fastosi ricevimenti, a cui avevano partecipato stuoli di nobili che, in uno sfoggio di pomposità, s’agghindavano con seta e gioielli sfolgoranti. Porticati, chiostri, centinaia di ambienti, boschetti e laghetti s’erano offerti agli sva276
ghi del re e delle sue cortigiane, che correvano per le radure alberate o si immergevano, nude, a nuotare nel fresco chiarore delle acque lacuali, sotto lo sguardo compiaciuto del sovrano. Marco Polo giudicò che proprio quelle mollezze dovessero essere stata la causa primaria della disfatta dei Song: una sconfitta che, come il Veneziano poté constatare, non era stata digerita. Certamente Quinsai restava ancora una metropoli grandiosa. Gli effetti del collasso non s’erano avvertiti che in lieve misura. Eppure per le strade, negli occhi delle persone, Marco sentì fermentare l’odio, sommesso, generalizzato: capì, il legato di Kubilai, quanto i cittadini di Hangzhou detestassero incrociare sentinelle e soldati mongoli, ritenuti degli intrusi, degli occupanti illeciti, che avevano tolto ai Cinesi la loro legittima dinastia. Il ruolo di agente imperiale, l’appartenenza ai ranghi statali, e quindi la complicità nelle scelte politiche degli Yuan non avevano offuscato la lucida obiettività di Marco Polo nel vagliare gli aspetti essenziali del pianeta Cina.
Capitolo quattordicesimo
IL COLLEZIONISTA DI UNIVERSI
1 | I misteri di Fuzhou Babbucce. Bianche. In pelle. Le si doveva calzare nel recarsi al cospetto del gran khan, per non insozzare gli stupendi tappeti intessuti di seta e oro, e per non infastidire l’imperatore con lo scalpiccio molesto di tacchi e suole dure. Il cerimoniale di palazzo era regolato da norme precise, che non ammettevano deroghe, e alle quali avevano l’obbligo di attenersi anche i collaboratori più fidati, gli agenti sguinzagliati a ispezionare le province imperiali, gli ambasciatori inviati a parlamentare coi regnanti indiani o indocinesi. Marco Polo era appena rientrato a Pechino da una delle sue missioni. A Kubilai Khan avrebbe raccontato di Suzhou, dell’artigianato che vi germogliava assieme al commercio di seterie e spezierie, del rabarbaro che cresceva in gran copia sulle montagne del circondario, e dello zenzero fresco, di cui si potevano comprare quaranta libbre al costo di un grosso veneziano. Con la ricchezza dell’economia locale si accordavano le delizie cittadine, la dolcezza dei giardini, l’orditura romantica dei corsi d’acqua e dei magnifici ponti in pietra, così imponenti che una galea vi sarebbe passata di sotto in scioltezza. «In cielo il paradiso, in terra Suzhou e Hangzhou», era il proverbio. Da allora, dal tem278
po delle esplorazioni poliane, l’incantesimo che impregna la città non s’è dissolto, e il piacere delle passeggiate fra camminamenti e isolotti, la poesia che dalla natura erompe nel verde degli alberi e negli spruzzi colorati dei fiori, fanno intendere il motivo per cui Suzhou, nel suo meraviglioso paesaggio a nord di Shanghai, sia soprannominata la «Venezia della Cina». L’esplorazione di Marco Polo non s’era peraltro fermata là. Era andata più avanti. Di storie da riportare a Kubilai ce ne erano, parecchie, e succose. Nell’adire la provincia del Fujian, a sud del Fiume Azzurro, cittadelle fortificate e centri urbani più o meno estesi, adorni di monumenti marmorei e belle donne, maculavano contrade floride per selvaggina e uccellagione, ordinate in poderi che, lavorati a oltranza, restituivano una frutta eccezionale. Nelle campagne scorrazzavano bestiole desuete per l’Occidente: i polli pelati (cioè le galline more a seta, curiosi gallinacei coperti da un’insolita peluria nera) e i cosiddetti «papioni» (probabilmente delle scimmie cinocefale d’Asia), che danneggiavano i raccolti e, di notte, si avvicinavano a rubare le cibarie delle carovane in sosta. I carovanieri avevano perciò studiato un trabocchetto che consisteva nello svuotare una zucca e nel riempirla con del grasso a mo’ di esca: i fastidiosi incursori vi infilavano la testa e, per la strettezza del foro d’entrata, non riuscivano più a liberarsi, perdendo l’orientamento e finendo per essere accalappiati: le loro carni, cucinate, dovevano peraltro piacere molto, e il loro vello si poteva rivendere a ottimi prezzi. Per intrappolare invece i grossi felini carnivori (la cui presenza infestante rendeva consigliabile percorrere in comitiva le zone disabitate), venivano impiegati dei cagnolini bianchi, che col loro tenero latrare attiravano le fiere in buche profonde e ben camuffate: anche in questo caso, gli ani279
mali catturati potevano essere uccisi per mangiarne la carne e rivenderne la pelle. Oppure venivano recuperati vivi, per esaudire le richieste dei signori che amavano circondarsi di fauna esotica nelle loro lussuose residenze. La compravendita di animali era solo una voce, e nemmeno la più importante, dei commerci esercitati nella Cina orientale. Presso i capoluoghi regionali, artigiani e mercanti trasformavano in quattrini le cospicue risorse territoriali quali l’immancabile seta, la galanga, lo zenzero (venduto a ottanta libbre un grosso) e una spezie simile allo zafferano (forse la curcuma longa, che dava una sostanza dorata con la quale si trattavano le foglie secche del tè). Abbondava anche lo zucchero, che per lungo tempo però non si era riusciti a raffinare: finché un egiziano del Cairo, inviato dal gran khan, non aveva introdotto un metodo di depurazione che si effettuava mediante la cenere di particolari piante, evitando che, col vecchio sistema della bollitura, la schiuma raffreddata solidificasse in pasta nerastra. Nelle rivendite urbane rifluivano anche altre preziosissime merci. All’emporio di Fuzhou, vivificato dal fiume Min, i commercianti indiani portavano gemme rare e perle. Marco Polo, in compagnia dei suoi parenti, espertissimi mercanti di gioielli, venne certamente attratto dai riflessi multicolori di quella mercanzia. E parimenti l’inviato di Kubilai Khan fu incuriosito dalle informazioni che circolavano riguardo a una strana consorteria religiosa. Nel parlare con un musulmano del posto, lo zio Matteo aveva infatti appreso di una comunità che non sembrava né islamica, né zoroastriana o buddhista, e che manteneva un fitto mistero sui suoi riti. Il segreto andava sciolto. Non poteva non essere indagato da un agente speciale dell’imperatore, da un ispettore che, probabilmente, anche per venire a capo di questi enigmi era sta280
to mandato a perlustrare le province cinesi. E Marco cominciò la sua opera tenace, giornaliera, mai traumatica e sempre conciliante, proprio come soleva fare un buon mercante, come era utile per sgarbugliare situazioni intricate. Si recò una, due, più volte in visita alla misteriosa setta. Ne vinse la ritrosia col dialogo e la calma. Superò la barriera di diffidenza. Ed ebbe fra le mani la prova del loro credo: un Salterio, il Libro dei Salmi per antonomasia. Un testo cristiano, dunque, che gli accoliti, interrogati, dissero di avere ricevuto in eredità dagli avi. Così come ugualmente cristiane parvero le immagini di tre (presunti) apostoli dipinte in uno dei templi della congrega: o quanto meno, in quel senso furono intese le effigi da Marco Polo e dallo zio Matteo. In realtà, non di puro cristianesimo si trattava, bensì di manicheismo. Dei cristiani non avrebbero avuto difatti nulla da temere, alcuna necessità di nascondersi, mentre fra i manichei ancora si tramandava il ricordo delle persecuzioni sofferte sin dalla metà del IX secolo. Del resto, l’ideologia manicheista aveva supportato anche delle rivolte contadine che, verso il 1120, s’erano estese a diverse province del regno dei Song: per cui accentuare gli aspetti propriamente cristiani nell’esternazione del culto garantiva ai seguaci di Mani una qual certa copertura. La loro posizione giuridica, comunque, andava regolarizzata con l’iscrizione nell’elenco degli uffici religiosi yuan. Sollecitati dai Polo (che non li avevano denunciati, probabilmente perché li ritenevano dei correligionari), i rappresentanti della confraternita si presentarono a corte per sanare l’illegittimità e registrarsi regolarmente. Ma sotto quale giurisdizione? Se ne contendevano la pertinenza sia il dipartimento della religione cristiana sia quello degli affari buddhisti, i cui rispettivi funzionari giunsero al punto di inscenare una violenta lite davanti a Kubilai. La discussione dovette apparire interminabi281
le, tanto che il sovrano, seccato dal blaterare improduttivo, cacciò i ministri litigiosi e domandò direttamente ai confratelli della delegazione a quale fede sentissero di appartenere. Coerentemente con le risposte fornite in precedenza a Marco Polo, i delegati di Fuzhou risposero di riconoscersi nel cristianesimo. E ottennero la registrazione ufficiale. Nella Cina meridionale, si scoprirà che la loro confessione contava centinaia di migliaia di adepti. Era un esercito di discepoli: e non soltanto di un credo religioso. Visto il coinvolgimento in precedenti ribellioni, non si può escludere che alcune derive manicheiste – non a caso, perciò, semiclandestine e restie a omologarsi – concorressero all’organizzazione delle sollevazioni antigovernative. Nel Fujian, Marco Polo dovette in effetti riscontrare la frequente deflagrazione di insurrezioni che obbligavano gli Yuan a presidiare l’intera provincia con una foltissima milizia. Lo stato di polizia si estendeva a casali, villaggi, città, a distretti dove il risentimento popolare si abbinava alla bellicosità di uomini che, per la loro abitudine ad andare in guerra coi capelli rasati verso l’alto e il volto tinto d’azzurro, erano assimilati nelle fantasie collettive a dei mostri capaci, addirittura, di cibarsi delle spoglie di un individuo assassinato, e di berne il sangue. Di fronte a simili bruti, l’esercito mongolo cominciava, dal canto suo, a perdere qualche colpo.
2 | Lassismi Una punta di lassismo stava iniziando a insinuarsi fra le soldatesche di stretta origine mongola. Già Marco Polo aveva notato come i cavalieri tartari fossero di norma dislocati a 282
presidio di luoghi secchi e mai paludosi. Per le zone umide, a sorvegliare le città d’acqua della Cina, così diverse, così tanto distanti dalle condizioni geoclimatiche delle più asciutte steppe centro-asiatiche, venivano preferibilmente preposti i militari del Catai, che meglio sopportavano, essendovi abituati, temperature e ambienti roridi. Per quattro o cinque anni, gli armigeri cinesi erano spediti a vigilare su località che distassero almeno venti giorni di marcia dalle terre natìe, a evitare facili connivenze e familismi con le genti indigene e meglio conosciute. Le guarnigioni venivano ovviamente mantenute coi proventi fiscali, ed erano impegnate saltuariamente a reprimere i disordini locali, con azioni poliziesche più che guerresche. Nelle caserme i militi mongoli vivevano ormai con una certa comodità, e sebbene si allenassero spesso nell’uso delle armi, lentamente stavano dimenticando la durezza dell’esistenza nomade, le estenuanti cavalcate nelle praterie, le lotte per la sopravvivenza che corroboravano corpo e psiche e da cui nasceva un’immane energia guerriera, fondamento delle conquiste planetarie di Gengis Khan e dei suoi successori. Il tradizionale e spontaneo addestramento mongolo, progressivamente, stava perdendo di intensità. Gli eserciti degli Yuan erano destinati a diventare ogni giorno un po’ più imbelli. E le avvisaglie dello sgretolamento si facevano sentire, vieppiù in quei contesti bellici alieni dalle classiche regole d’ingaggio, caratterizzati da asperità naturali insopportabili per gli allogeni, da climi e ambienti come la giungla o gli acquitrini che mal si adattavano alla combattività dei Mongoli, e ne impedivano il dispiegarsi del terrificante potenziale militaresco. La duplice spedizione in Giappone s’era, come visto, risolta in un fallimento, e solo con molti sforzi, solo parzial283
mente l’autorità di Kubilai Khan potrà riuscire a estendersi sull’Indocina, suddivisa in quattro Stati: l’Annam, che comprendeva il Tonchino e il Viet Nam del Nord; il Champa, regno prevalentemente marittimo, che si allungava dal Viet Nam alla Cocincina; il reame khmer della Cambogia; e l’impero della Birmania. Negli anni Ottanta del XIII secolo, la penisola indocinese era divenuta bersaglio di incursioni e occupazioni quasi ininterrotte da parte delle truppe sino-mongole. Alcuni dinasti, come il sovrano del Champa Indravarman V (1266-1287), avevano preferito scendere a patti e dichiararsi tributari di Pechino, pur di evitare lo scontro frontale: salvo poi essere smentiti e disconosciuti dalla fiera popolazione indigena, capace di impugnare autonomamente le armi e di opporre, con la guerriglia, un’efficace resistenza alla strapotente macchina bellica schierata dagli Yuan. E tanto meno i Khmer cambogiani mostreranno l’intenzione di arrendersi. Le irrequietudini nazionalistiche avevano perciò costretto Kubilai Khan a tornare in forze, per terra e per mare, alla conquista di posizioni basilari per il controllo dei regni indocinesi (dopo che già una prima volta Vidaya, capitale del Champa, era stata occupata e presto abbandonata dagli invasori sino-mongoli). L’armata del figlio del gran khan, Toghan Temür, era stata allora mandata a prendere Thang Long (l’attuale Hanoi), capoluogo annamita, scendendo da settentrione. La flotta al comando di Sogetu aveva invece avuto il compito di sbarcare sulle coste meridionali del Viet Nam e di risalire, per ricongiungersi con le divisioni terrestri. Ma sul delta del Fiume Rosso (il Song Hong) e presso Teykint, nel 1285, i contingenti khanali avevano subito sconfitte pesantissime, e il re dell’Annam, Tran Nhan Tong (1278-1293), rientrando 284
a Thang Long nel 1287, era stato acclamato salvatore della patria. Nondimeno la guerra era rovinosa, le milizie mongole non sembravano intenzionate a recedervi, e per evitare ulteriori distruzioni il pur vittorioso sovrano annamita, contrattando la pace da una posizione politicamente vantaggiosa, s’era infine risolto ad accettare un compromesso, vassallandosi nel 1288 con l’impero yuan, ma senza per questo apparire vile o debole al suo popolo. Stessa «accortezza» aveva manifestato il prudente nuovo sovrano del Champa, Jayasimhavarman III, che pure s’era precedentemente dimostrato condottiero brillante nel contrastare l’invasione della milizia di Kubilai. Dal canto loro, i Birmani erano stati investiti sin dal 1283-1284 da feroci attacchi che avevano messo a confronto tradizioni e culture belliche abbastanza differenti: lo stesso Marco Polo avrebbe narrato dell’urto fra gli elefanti corazzati del re birmano e la cavalleria mongola, e di come l’abilità degli arcieri e la sagacia tattica avesse permesso all’esercito degli Yuan di vincere uno scontro incertissimo. Azzeccata s’era rivelata la strategia di attaccare battaglia di fianco a un bosco: nella macchia, i cavalli mongoli avevano potuto placare la paura di barriti e proboscidi, e fra i rami della foresta i pachidermi avversari erano andati a infrangere le torrette lignee che, nella rincorsa della mischia, recavano in spalla. Esauritasi la pioggia di frecce, il furioso corpo a corpo aveva lasciato sul campo teste decapitate, e piedi, e mani troncate, mentre i lamenti di moribondi e feriti erano arrivati – a detta di Marco – «sino al cielo». Nemmeno chi aveva cercato rifugio nella boscaglia si era salvato: le difese di fortuna erette con terra, legno e liane non avrebbero mai potuto riparare i sopravvissuti birmani dalla violenta ritorsione sino-mongola. 285
Con grandi sacrifici, comunque, e senza che mai potesse considerarsi completo il dominio sulla Birmania, le milizie yuan si sarebbero spinte fino a Bagan, conquistata da Kubilai – almeno stando alla versione poliana dell’avvenimento – con saltimbanchi e giocolieri, invece che con veri e propri soldati (forse in spregio a un regno ribellatosi proditoriamente, o forse perché quei giullari, d’origine indiana, avevano più dimestichezza con le terre da invadere). Di fatto, la capitale birmana fu espugnata nel 1287. Il saccheggio e la distruzione si estesero a quasi tutta la metropoli, tranne che alle torri straripanti d’oro e argento, che il sovrano locale aveva fatto costruire come proprio mausoleo: per Marco Polo, che era perfettamente al corrente del rispetto dei Tartari per i defunti e i loro corredi, non c’era di che meravigliarsi. Né il Veneziano poteva stupirsi per l’insistenza degli Yuan in un’impresa irta di ostacoli. L’avanzata nel Sud-Est asiatico rappresentava infatti la più che naturale prosecuzione dell’espansionismo di Kubilai Khan. Chissà, probabilmente nascondeva il sogno di una futura conquista dell’India. Ma nell’immediato presupponeva motivazioni sostanzialmente economiche: l’Indocina era infatti un ottimo mercato d’esportazione dei prodotti cinesi. Da lì, il passo per assoggettare l’Indonesia era breve: e tuttavia, a eccezione delle sottomissioni volontarie di qualche signorotto, impaurito dalle intimidazioni camuffate da ambascerie (come il rajah di Malayu, a Sumatra), le spedizioni degli Yuan nell’arcipelago indonesiano non saranno mai coronate da un pieno successo, e anzi l’invasione di Giava, nel 1292, si rivelerà fallimentare. La mancanza di un appoggio terrestre costituiva sempre un grave handicap per armate che con le intraprese marittime non avevano mai avuto eccessiva confidenza. 286
Sul più consono terreno centro-asiatico, a settentrione della Cina, Kubilai Khan invece sapeva ancora farsi valere. L’ennesima ribellione di Kaidu aveva difatti coinvolto in una nuova lega anti-yuan quei principi di stirpe gengiskhanide che, come Nayan, intendevano riaffermare i valori atavici della tradizione mongola, in opposizione alla sinizzazione del gran khanato. I rivoltosi erano attestati in prevalenza nella Manciuria e nella Mongolia orientale, la cui perdita avrebbe tagliato collegamenti vitali per l’impero, impedendo il basilare approvvigionamento di cavalcature. Per soffocare la rivolta e ribadire il primato di Pechino, nel 12871288 Kubilai Khan era intervenuto energicamente. L’imperatore aveva innanzitutto inviato il generale Bayan a occupare Karakorum, simbolo delle antiche prerogative politiche dei nomadi. Poi, a bordo di un alto padiglione trasportato da elefanti, il gran khan s’era addentrato alla guida delle sue truppe nelle piane mancesi, incontro a Nayan, l’avversario principale in quel settore del regno. Colto di sorpresa dal dispiegamento di forze ben superiori, il rivoltoso aveva dovuto soccombere al termine di un combattimento selvaggio (di cui Marco Polo conobbe esattamente l’andamento), sulle sponde del fiume Liao. All’insorto, che s’era battuto innalzando le insegne della sua fede cristiano-nestoriana, e che era stato catturato ancora vivo, toccherà la morte che i Mongoli riservavano ai nobili di stirpe regale: avvolto in tappeti, verrà calpestato dagli zoccoli dei destrieri e battuto da randelli, per non spanderne il sangue. A quanti sottolineavano beffardamente l’inutilità della conversione di Nayan dal buddhismo al cristianesimo (visto come gli erano andate le cose), Kubilai, sempre attento agli equilibri religiosi, aveva fatto replicare che la Croce, essendo per sua natura buona, non poteva tutelare un uomo 287
sleale, ribellatosi al suo signore: non diversamente dai suoi predecessori, il gran khan si dichiarava artefice della giustizia divina.
3 | Addio alla Cina Ispezioni. Ambascerie. Guerre. Popoli. Marco Polo aveva molto viaggiato, in Cina e oltre. È probabile che nel 1288 egli si sia recato nel Viet Nam del Sud, ammirandone l’aloe, l’ebano ideale per i calami dell’inchiostro, e gli innumerevoli elefanti, una ventina dei quali costituivano il tributo annuo versato in vassallaggio a Pechino. Le consuetudini del Champa imponevano una sorta di ius primae noctis, per cui ogni fanciulla in età da matrimonio veniva innanzitutto «saggiata» dal re. Poi, se piaceva al dinasta, veniva presa a palazzo. Altrimenti, poteva anche andare in sposa a un qualche patrizio. Ecco che quindi il monarca sudvietnamita, a detta di Marco, vantava qualcosa come trecentoventisei figli (fra maschi e femmine), centocinquanta dei quali già pronti a portare le armi. Dalle coste meridionali dell’Indocina l’arcipelago indonesiano era quasi a portata di mano, e non si può escludere che le esplorazioni poliane si siano estese almeno a qualcuna delle isole poste di fronte alla terraferma. È ammesso inoltre, anche dai critici più diffidenti, che Marco Polo abbia visitato una porzione dell’India, ambasciatore di Kubilai presso il regno amico del Maabar, fra il 1287 e il 1289: e sin d’allora il viaggiatore si sarebbe entusiasmato per gli enormi vascelli cinesi a quattro o a sei alberi che incasellavano decine e decine di cabine, per l’agio dei mercanti. Fa288
sciati da un doppio strato di legno d’abete, i traghetti che dalla Cina muovevano per l’India possedevano uno scafo suddiviso da paratie in compartimenti stagni, di modo che le falle provocate da uno scoglio o da una balena non pregiudicassero né la linea di galleggiamento né l’integrità delle mercanzie stivate nella pancia delle navi. Per calafatare le chiglie, Marco notò che non si adoperava la pece, bensì un composto di resina, calce e canapa tritata, estremamente vischioso. Su quegli straordinari navigli trovavano posto centinaia di marinai che, alla bisogna, sedevano a vogare in file di quattro per ciascun remo. Alla nave-madre facevano da corona barche di dimensioni minori, trainate con corde o legate in sospensione sui fianchi del battello: venivano impiegate nelle emergenze, nelle operazioni di marineria minuta, oppure per poter imbarcare carichi supplementari di pepe. Tanto, tantissimo pepe, ammucchiato in migliaia di sporte e trasportato a ritmo continuo sulle rotte oceaniche: sicché, a fine stagione, l’usura delle carene consigliava di aggiungervi un’ulteriore fasciatura di tavole, sempre serrate da una duplice chiodatura in ferro, fino a un massimo di sei rinfasci. Simili bastimenti avrebbero certamente garantito a Marco, Niccolò e Matteo Polo una sicura e fruttuosa navigazione sulla Via marittima della Seta. Nuovi porti, nuove occasioni di mercanteggiare. Nuovi universi da collezionare: un quindicennio di Cina poteva essere abbastanza, ora che della società cinese si erano conosciute le glorie e le miserie, gli splendori e le povertà. Spostandosi per lo smisurato regno yuan, Marco aveva sì rimirato tutta la grandiosa potenza dell’imperatore, i suoi palazzi, i suoi sollazzi, l’ordine e la giustizia che – pur faticosamente – Kubilai aveva imposto. Ma il Veneziano non aveva chiuso gli occhi sulle ristrettezze che angustiavano il popolo, sulle costrizioni impo289
ste ai dominati, sulle masse di bambini che nelle città venivano abbandonati per strada dai genitori indigenti, e che lo Stato provvedeva a tenere negli orfanotrofi, o ad affidare ad aristocratici facoltosi. Di tutto questo, Marco Polo s’era reso edotto. E, forse, tutto questo gli bastava. Gli stimoli a restare avevano iniziato a scemare, a dissolversi proprio mentre si riaccendeva la voglia di partire. O, magari, di tornare. Di evadere: Marco sentiva che la libertà di spostarsi era adesso diventato un guinzaglio azionato da Kubilai, una catena che il gran khan allungava e accorciava a piacimento: più in là non si andava. Ma un mercante non avrebbe mai resistito troppo a lungo legato, ingabbiato, in una prigione che era immensa, eppure si faceva asfissiante. Il futuro, Marco Polo lo avvertiva, non era in Cina. Oltretutto, il sovrano invecchiava. E allora, finché fosse rimasto in vita Kubilai c’era una garanzia di continuare a beneficiare di favori e privilegi. Ma dopo? Quale sarebbe stato l’atteggiamento del successore? Avrebbe favorito, epurato, ignorato i tre mercanti di Venezia? I dubbi di Marco, Niccolò e Matteo si accavallavano, nella consapevolezza che non sarebbe stato affatto semplice andarsene dalla Cina. Chiedere anzitempo congedo dal gran khan, prima che il sovrano lo avesse decretato, prima che gli fosse piaciuto, era infatti un passo rischioso: indispettire l’imperatore sarebbe anche potuto costare la testa ai richiedenti. Ci voleva un’occasione propizia. Una circostanza per cui Kubilai stesso si vedesse in qualche maniera obbligato a indire una missione che permettesse ai Polo di dirigere altrove il cammino, lo sguardo, gli interessi. E l’occasione si presentò, nel 1290. L’il-khan di Persia, Arghun (1284-1291), era rimasto vedovo. In base al testamento della moglie, si sarebbe dovu290
to risposare scegliendo una donna della stessa schiatta alla quale apparteneva la defunta regina. Per questo, il monarca aveva inviato una propria delegazione a Pechino, giacché la stirpe in questione era oriunda dei territori governati dagli Yuan: dunque, era a Kubilai che bisognava rivolgersi. In risposta all’istanza, e nella scia di ottimi rapporti diplomatici, ai delegati il-khanali Ulatai, Apusciai e Coja venne pertanto affidata la principessina Kokacin (nome che in lingua mongola sta per «Celeste», ossia «Bella come il cielo»), una magnifica diciassettenne della genia richiesta dal sovrano persiano. Con doni acconci all’evento nuziale, la delegazione avrebbe dovuto intraprendere la strada del ritorno. Ma le continue intemperanze del solito Kaidu e il riaccendersi di vecchi conflitti impedivano di attraversare indenni l’Asia centrale. Occorreva cercare soluzioni alternative. In quella, si verificò l’avvenimento decisivo: gli ambasciatori di Arghun, che avevano sentito parlare della perizia con cui i Polo s’erano spostati nel Levante provenienti dal Mediterraneo, richiesero formalmente al gran khan di poter tornare nell’il-khanato accompagnati da Marco, Niccolò e Matteo, via mare. La richiesta proveniva dai legati di uno fra i più fedeli alleati dell’impero yuan. Era, a tutti gli effetti, una richiesta ufficiale. E a quel punto, Kubilai non aveva scelta: dovette accettare, sia pur a malincuore, che i tre veneziani se ne andassero. La svolta, la congiuntura auspicata da Marco si concretava all’improvviso, finalmente, casualmente. L’imbarco sarebbe avvenuto a Zaitun/Quanzhou, uno fra i porti più attivi della Cina, all’ingresso del canale di Formosa, presso la foce del fiume Jin. Vi transitavano le merci più svariate, e in volumi stratosferici: soltanto il pepe ac291
quistato ogni anno nell’impero degli Yuan era più di dieci volte superiore alla quantità che se ne esportava in Occidente. Per ogni nave di spezie che arrivava ad Alessandria – fu il computo di Marco – cinquanta ne attraccavano a quell’immenso scalo cinese, da cui Kubilai traeva profitti incredibili tassando gli scambi, e talvolta esigendo la metà del valore complessivo delle mercanzie: aloe e sandalo erano fra i prodotti che maggiormente rendevano all’erario imperiale. E nonostante i dazi elevati, i commercianti realizzavano guadagni talmente grossi che più e più volte tornavano a mercatarvi. Tutto il traffico marittimo del Sud-Est asiatico, le rotte degli oceani Pacifico e Indiano, e le flotte mercantili in collegamento con Golfo Persico, Mar Rosso o Africa orientale gravitavano su Quanzhou. È perciò comprensibile come mai, a Pechino, proprio negli anni poliani, potessero osservarsi perfino delle... giraffe africane! Anche da quello andava a separarsi Marco Polo, dalle estemporaneità, dall’eccentricità che il gigantismo degli Yuan imponeva. L’ultima Cina che avrebbe visto accostandosi al porto d’imbarco sarebbero state le circostanti coltivazioni di cedro, di canna da zucchero, di longan (o «occhi di drago») e di cotone, e le decine di pozzi per l’estrazione carbonifera, le montagnole di caolino che rifornivano l’industria ceramica, le fabbriche del raso da esportare fino in Europa: d’altronde, le manifatture di Quanzhou erano a pieno titolo inserite nel circuito dei commerci internazionali. Il cosmopolitismo che fermentava in città richiamava forestieri sinanche a farsi tatuare, con gli aghi che nelle mani di maestri pittori si facevano pennelli sulla morbida tela del derma. Fino all’ultimo istante, altri idiomi entrarono nelle orecchie di Marco, altre acquisizioni, che si sommavano e si intrecciavano al patrimonio accumulato sin dal gior292
no in cui, vent’anni prima, era partito dalla Laguna. Il giovane figlio di Niccolò Polo era cresciuto ed era maturato, come uomo, in Oriente. Seppure non parlasse il cinese, ormai distingueva i dialetti che, nelle diverse contrade del Mangi, adattavano la parlata nazionale alle inflessioni locali. A Marco Polo sembrava ancora di sentirli, quei linguaggi, ciascuno legato a un ricordo, a un gesto, a una delle anime della Cina. Gli era restato tutto dentro. E tanto più ne avrebbe rinserrato nella memoria quanto più, allontanandosi adagio dalla costa, avvertiva il distacco dai luoghi dei suoi sogni giovanili: da un mondo che, mentre salpava, da mercante scafato, spassionato e realista, sapeva che quasi certamente non avrebbe mai più toccato.
4 | Peripezie indiane Quattordici navi erano salpate da Quanzhou. Più di seicento persone fra marinai, dignitari e ambasciatori dovevano portare a sposarsi la principessa Kokacin. Il pomposo convoglio costeggiò il Viet Nam per discendere verso Giava, florida di pepe, noce moscata, galanga, cubebe, garofano e spezie ricercatissime. Kubilai avrebbe tanto desiderato impadronirsi di un simile serbatoio di ricchezza: tuttavia, e questo Marco Polo lo intendeva perfettamente, la conquista era complicata dalle difficoltà nei collegamenti fra la Cina e l’arcipelago malese. Passandovi in mezzo, dal ponte dei vascelli si vedevano rialzati sulle onde isolotti fronzuti, che davano piante dai legni odorosi. Poi, virando a ponente, veniva Sumatra, grande e spartita in otto regni, con una folta presenza di convertiti all’islam. Veleggiando da quelle parti, a ri293
dosso dell’Equatore, era pressoché impossibile scorgere la stella polare. In compenso, visitando il territorio sumatrese, Marco poté constatare la falsità di alcune fra le leggende che aveva udito nell’Europa cristiana: erano chiacchiere che in Oriente gli unicorni bianchi si facessero ammansire dalle vergini. Chiacchiere che avessero connotazioni divine: grossi poco meno d’un elefante, col corno piantato sul capo e la lingua ruvida, i rinoceronti, una fanciulla, l’avrebbero fatta a pezzi, travolgendola sotto zampe spaventosamente voluminose. E una menzogna erano i «piccoli uomini delle Indie»: Marco Polo appurò come in realtà fossero solo delle scimmie antropomorfe che, abilmente depilate, imbalsamate e trattate con canfora e zafferano, venivano rese simili a nanerottoli, da vendere quale mercanzia esotica ai creduloni di tutti i continenti. Di autentico, a Sumatra, c’era piuttosto un creato generoso: palme vinarie, che incise nei tronchi emettevano un liquore dolce fermentabile; noci di cocco, che per la farmacopea medievale affinavano l’intelletto con la polpa biancastra e la purezza del loro nettare; e il verzino, un vegetale – impiegato per miniare le pergamene e colorare di rosso le stoffe – di cui Marco recherà i semi a Venezia (per avviare affari lucrosi?): soltanto che, in Laguna, in un clima inidoneo, l’ortaggio equatoriale non attecchirà. Dai cosiddetti «alberi del pane» si estraeva inoltre (tramite un procedimento di decantazione in acqua del legno pestato) una farina ottima per fare lasagne e altre paste alimentari: e dovette mangiarne di gusto, il viaggiatore veneziano, comprando di quei prodotti farinacei per portarsene in Italia. Tutt’altra dieta si diceva osservassero invece alcune genti isolane, che usavano accelerare la morte dei parenti 294
moribondi soffocandoli, e cocendone il corpo per poi spolparlo ben bene. Dalle ossa si succhiava pure il midollo: e ciò che proprio non si riusciva a ingerire veniva riposto in urne, affinché fosse sotterrato in caverne montane. Brutta razza di persone: se qualcuno cadeva nelle loro mani, non aveva scampo: o pagava un riscatto, o finiva per essere cannibalizzato. E fu anche per le paure innescate da simili notizie, oltreché per l’avvistamento sui monti di oranghi (che però Marco Polo scambiò per ominidi caudati), che la comitiva poliana scese dai vascelli e si trincerò dentro fortini lignei, appositamente costruiti, nei cinque mesi trascorsi a Sumatra in attesa che il vento tornasse finalmente a sciogliere le vele. Una volta che le correnti si furono fatte benevole, la spedizione poté riprendere la navigazione. Nel Golfo del Bengala stavano le isole Nicobare e Andamane, che le fantasie europee associavano ai Cinocefali, a popoli schifosi e selvaggi, adusi a cibarsi di carne umana e a vagare ignudi. Il legname pregiato che pure si sarebbe potuto prelevare da quelle isole interessava relativamente ai Polo: da mercanti pratici nel commercio di gioiellerie, sapevano che le opportunità migliori erano nell’isola di Ceylon/Sri Lanka. Topazi, zaffiri, ametiste, granate: in quel giardino di gemme, il fiore che più rifulgeva era un rubino vermiglio come il fuoco, della grandezza di un palmo e del peso di oltre un chilogrammo. Invano, qualche tempo prima, Kubilai Khan aveva cercato di comperarlo, proponendo in contropartita il corrispettivo in oro e argento di un’intera città. Il detentore dello stupefacente gioiello, il re dell’isola, non aveva ceduto all’offerta: per i membri della sua famiglia, che se ne tramandavano il possesso di padre in figlio, e che lo adoperavano passandoselo su occhi e bocca, il rubino gigante, nella 295
sua sacralità, era inalienabile. Peraltro, le ambascerie inviate da Kubilai in quella terra di sesamo, di riso, di palme vinarie, e di caldo a fatica sostenibile standosene nudi, erano state più d’una. A Dadu/Khanbalik era infatti giunta voce dell’esistenza nello Sri Lanka di una montagna che corrispondeva per alcuni – specialmente musulmani – al sepolcro di Adamo, e per altri al mausoleo del Buddha. Torme di fedeli d’ambo le religioni vi si inerpicavano issandosi con catene in ferro predisposte per il pellegrinaggio. E il gran khan, protettore del buddhismo con simpatie cristiane, aveva chiesto che dal santuario dell’isola gli fossero mandati come reliquie un paio di denti molari e una scodella in porfido bianco e rosso. La traslazione era avvenuta negli anni Ottanta del Duecento, al prezzo di tesori ingentissimi. Giunti in prossimità di Pechino, i cimeli avevano ricevuto un’accoglienza grandiosa. Al che Kubilai, fidandosi dei consiglieri islamici che glieli avevano segnalati, s’era risolto ad attribuire quei sacri resti ad Adamo. Marco Polo, però, da cristiano, aveva letto le Sacre Scritture, e credeva quindi che le spoglie adamitiche stessero altrove, in asse col punto in cui era stata alzata la croce di Cristo. Ritenne pertanto più probabile che il sacrario di Sri Lanka fosse da attribuirsi al Siddharta, sulla cui storia d’altronde aveva avuto nel Levante molteplici ragguagli. Sapeva, Marco, che il rifiuto dei lussi nella reggia paterna, la rinuncia alle lusinghe amorose di ben trentamila giovinette, il ritiro spirituale sulle alture impervie avevano finito per santificare l’esistenza del principe. Allontanatosi volontariamente dalle tentazioni del potere e dei piaceri terreni, purificatosi in ottantaquattro reincarnazioni, il Buddha avrebbe raggiunto la dimensione divina. La sua immagine, fissata in una statua d’oro e pietre preziose, sarebbe stata condotta per 296
ogni dove dal padre, dolente di non aver compreso per tempo la gloria del figlio. «Per quanto il concetto delle rinascite non sembri troppo congeniale alla mente del nostro Marco», asserisce Bussagli, «è chiaro che egli conosce l’esistenza dei jataka, i racconti edificanti delle esistenze precedenti del Buddha». Similmente il Veneziano era informato sul culto di san Tommaso, in cui dovette imbattersi toccando il reame dei Pandya, nel Coromandel. Una tradizione collocava difatti nelle vicinanze di Madras il luogo in cui l’apostolo era stato per errore trafitto dalla freccia di un cacciatore di pavoni: piumati che, sacri al cristianesimo, erano soliti coronare le preghiere del santo. Da allora, una forza sovrannaturale avrebbe respinto dalle chiese tomiste gli appartenenti alla casta dell’improvvido uccisore, mentre la tomba del predicatore sarebbe divenuta meta dei pellegrinaggi di musulmani e cristiani, nonché fonte di miracoli: diluita in acqua, la terra sacralizzata dalle gesta dell’evangelizzatore guariva da terzane e quartane. E di sollievo portentoso beneficiavano pure i lebbrosi. Guai, poi, ad angariare i devoti: si narrava che nel 1288 Tommaso fosse apparso a spaventare, forca alla mano, un nobile indiano che, con prepotenza, aveva requisito le residenze dei pellegrini vicine al sepolcro, per farne dei magazzini di derrate alimentari. Benché convenzionale in Oriente, la trama di un tale episodio sottintende presumibilmente delle lotte di religione, del tutto plausibili in un’India Maior che, inoltre, colpì Marco Polo con l’esotismo di abitudini, credenze e magie inimmaginabili in Europa. La pesca delle perle, per esempio: normalmente predisposta fra aprile e maggio, la si poteva praticare soltanto col sussidio di un bramano, che incantasse gli squali durante le immersioni compiute dai pescatori a otto, dieci, dodici 297
metri di profondità. Un ventesimo del pescato era il prezzo degli incantatori di pescecani; un decimo l’imposta riscossa dal sovrano. Il quale, date le temperature, vestiva come tutti i sudditi, e come i guerrieri (armati di uno scudo rotondo e di una lancia): e cioè coprendosi a malapena le pudende. Certo, sulle membra del monarca si esaltava anche la finezza di bracciali, gorgiere, armille tempestati tutti quanti di gemme favolose (che ben sarebbero valse, secondo Marco, una città). E a una specie di rosario il re teneva cucite centoquattro pietre, tante quante erano le preghiere che il Veneziano ascoltava quotidianamente recitare («Pacauca, Pacauca!», forse dal sanscrito bhagavat, «beato, felice»). Del resto, i cavatori di smeraldi e affini erano ben propensi a vendere i più bei gioielli al dinasta pandya, che apprezzandone lo splendore li pagava fino a due volte il loro reale valore. Amante d’ogni piacevolezza, il signore disponeva di cinquecento donne, giacché, appena ne vedeva qualcuna che gli piacesse, non esitava ad accaparrarsela, fosse stata anche la moglie di un fratello: e ci voleva tutta l’autorità della regina madre per tenere a bada i principi entrati in dissidio: minacciava, l’anziana imperatrice, di tagliarsi le mammelle che avevano nutrito la prole, se questa non si fosse rappacificata. E così tornava la calma. Ovviamente, con tante spose a disposizione, la discendenza regia era molto numerosa. E pur tuttavia, quando il sovrano moriva e il suo cadavere veniva cremato, tutti i suoi figliuoli (tranne il primogenito, che doveva ereditarne il regno) si lanciavano fra le fiamme insieme al defunto genitore, per andare a servirlo nell’altro mondo: si estremizzava, così, il patto sacro che legava il monarca ai più fidi fra i cortigiani e i parenti. Non solo: Marco Polo rilevò come anche fra le persone comuni si perpetuasse la terribile cerimonia del sati, per cui le vedove 298
decidevano di stendersi accanto al marito sulla pira funebre e di accompagnarlo, fedelmente, fin nell’ultimo viaggio. Era un gesto che la società indiana apprezzava parecchio, e che risultava alquanto diffuso. Così come non era raro riscontrare delle autoesecuzioni, in forma rituale, dei condannati a morte: in una sorta di riscatto finale dalle scelleratezze compiute, i rei si munivano di coltelli e si trapassavano più volte col ferro, morendo dissanguati «per amore della divinità» e, quasi, riabilitandosi di fronte all’opinione pubblica. La giustizia indiana poteva altresì imporre ai debitori inadempienti di restare dentro a un cerchio tracciato in terra dai creditori, finché non fosse stata restituita almeno una parte del dovuto, pena la condanna capitale. E fu certamente con un pizzico d’orgoglio mercantesco che Marco Polo venne a conoscere di quel commerciante forestiero che era riuscito a cerchiare un re con tutto il suo cavallo, ottenendo in tal modo la restituzione di un prestito che il monarca tardava a rifondere. Non era del resto impossibile che talvolta un regnante (o un qualsiasi altro signorotto) si trovasse in difficoltà economiche, visto che i sovrani tendevano a tesaurizzare il patrimonio paterno ricevuto in eredità, e a sborsare cifre esagerate per l’acquisto di purosangue arabi, sistematicamente uccisi dal clima caldo-umido e sistematicamente rimpiazzati coi carichi in arrivo dai porti cinesi o dal Golfo Persico. L’ambiente indiano, piovoso nei soli mesi di giugno, luglio e agosto, era micidiale. E non soltanto per i corsieri d’importazione: fondendosi con le prescrizioni religiose, le asperità climatiche avevano imposto agli Indiani abluzioni mattina e sera. Prima del desinare era obbligatorio tergersi le mani. Con la destra si poteva toccare cibo e bevande, mentre la sinistra era riservata alla pulizia delle parti intime e alle fun299
zioni meno nobili. Le regole igieniche prescrivevano inoltre che dai boccali (suppellettili strettamente personali, che non si sarebbero mai condivise con chicchessia) si dovesse bere senza mai portarne alle labbra, tenendoli in sospensione sulla testa e versandone il contenuto in bocca. I bevitori di vino erano poco stimati dagli Indiani, che sullo stesso piano dei beoni mettevano i marinai: gli uni e gli altri godevano di pessima reputazione, e giammai sarebbero stati considerati fededegni. A suscitare rispetto e deferenza erano piuttosto i sapienti, che distinguevano a occhio bontà e cattiveria degli uomini, che esercitavano l’astrologia, che discernevano le ore positive e negative della settimana, e che dal volo degli uccelli o da uno starnuto imprevisto traevano auspici. L’induismo, la religiosità, la cultura di un paese straordinario e spesso mitizzato dagli Occidentali impressionarono profondamente Marco Polo, a cui fu pure riferito del modo speciale (e romanzesco) che gli Indiani avevano di cavare diamanti da crepacci infestati da serpenti velenosissimi. Si raccontava – anche per ingannare i maleintenzionati – che sui giacimenti brillantati dalla pioggia venissero gettate delle frattaglie, e che le aquile volassero a ghermirne. Nel predare, i rapaci avrebbero strappato coi loro artigli anche le pietre preziose, che poi scartavano, lasciandole sui bordi dei dirupi ovvero nei nidi: a quel punto, per i cercatori di gemme il recupero dei diamanti era un gioco da ragazzi. I principali acquirenti di preziosi erano il gran khan e i rajah indigeni che, pure, Marco osservò non farsi problemi nel sedere per terra, a contatto con l’elemento a cui ognuno – in base a un diffuso convincimento – doveva tornare. Il viaggiatore veneziano non poté inoltre non ravvisare la generalizzata adorazione per le vacche: pelo di vacca si porta300
va in battaglia attaccato allo scudo, o al freno equino, o nei capelli; carne di vacca si consumava soltanto presso alcuni gruppi (i non ben identificabili gavi), e solo se l’animale era deceduto naturalmente, oppure se era stato da altri macellato. Grasso di vacca si spalmava talora per la casa. O almeno, per chi una casa ce l’aveva: i signori potevano permettersi dimore accoglienti e letti in vimini sospesi al soffitto, con cui eludere tarantole, pulci, vermi e calura. I miserabili, invece, dormivano per strada, di notte. Già, la notte: passato Capo Comorin, alla punta meridionale dell’India, dalla nave di Marco Polo in rotta per il nord-ovest si cominciava a rivedere la stella polare...
Breslavia Dne pr
Cracovia Vienna
Bolgary
Pest
Kiev
Curzola Dan u
bio
lg Vo
Nicea Iconio
RN
ERO
GEORGIA
Trebisonda Tiflis Sivas ARM
MAR
Negroponte
MA
l
Ura
Saraj Astrahan’
Caffa
Soldaia
Ukek
a
Tana
Co sta nti no po li
L. d’Aral
MIA
Buda
Smolensk Mosca Don
Venezia
Sy
rda
L. Balhasˇ
r’ja
CORAS
▼
CA S P IO
’ja Amudar
Otrar ENIA Derbent Edessa ▲ Hiva Lajazzo Aleppo Mosul Nicosia Tabriz Tripoli Buhara Samarcanda Damasco Sultaniyeh Giaffa Acri Merv Alessandria Balkh Baghdad ▼ Alamut Nishapur Gerusalemme Sheberghan Il Cairo Taloqan ▲Esfahan Kabul Herat Bassora Peshawar Kubanan Yazd Kerman Lahore Kandahar Shiraz Multan ER Hormuz MAKRAN Medina ARMENIA MINOR
GO
L FO
P
MAR
T ARA GUJ
ROSS
SIC O
Mecca
O
Bombay
ETIOPIA
R ABA MAL
MARE ARABICO
As-Shihr Aden
Mangalore
GOLFO DI ADEN SOCOTRA
Itinerario di Niccolò e Matteo Polo (1260-1269) Itinerario di Marco Polo (1271-1295) Itinerario alternativo di Marco Polo da Sivas a Hormuz (1271) Itinerario cinese di Marco Polo
Tun gu
ska Inferiore
sej Eni
B u r ia
M
Ob
’
Kirghisi
Irty
L. Bajkal
ti
o Keraiti M e rc h it i n g o l i
sˇ
N a im a
Karakorum
ni
u t i Kaiping/Shangdu
Ong
Dadu/Khanbalik (Pechino)
Kara-Khoto Hami Almalik
Turfan
Yumen Zhangye
Dunhuang
Kashgar Yarkand
Ningsian
Wuvei
Lanzhou
IMPERO
Qiemo
Gra
JIANGSU
Yangzhou Suzhou Shanghai Nanchino
nC ana
e ng H o) Hua e Giall m (Fiu
le
Xi’an
Hangzhou
DEL GRAN KHAN
Hotan Yutian
tze ro ng zur Ya e Az um (Fi
Chengdu
T T I B E
Fuzhou
)
FUJAN Quanzhou
Lhasa
Canton
Delhi
BIRMAN
Gange
Kunming
IA
Tang Long Golfo del Tonchino
Bagan w Irra
S U LTA NAT O DI DELHI
Calcutta
YUNNAN
Dali
M AN DE
Quilon Capo Comorin TAPROBANE
H
CO
RO
REGNO KHMER
g
Madras
GOLFO DEL BENGALA
on Mek
L
addy
REGNI INDÙ
MARE CINESE MERIDIONALE
AN N AM
AM PA
Bhamo
C
ANDAMANE NICOBARE
Medan
SUMATRA
Capitolo quindicesimo
UNA CASA SUL CANAL GRANDE
1 | Pirati Erano approdati a Hormuz in diciotto, su una sola nave. Kokacin, la principessa, la sposa promessa, s’era salvata. Ma il resto, il novantasette per cento del convoglio guidato dai Polo, non ce l’aveva fatta. Malattie, si presume, evolute in epidemie per la promiscuità e gli stenti del viaggio. Tempeste. Magari anche qualcuno che aveva voluto fermarsi in un qualche posto scorto e subito amato, nel tragitto dalla Cina al Golfo Persico. E poi, i pirati del Mare Arabico: quelli che arrembavano i navigli e li spogliavano di tutto. Quelli che imponevano alle vittime di bere del tamarindo lassativo, per far espellere i gioielli ingeriti nel vano intento di nasconderli. Quelli che a volte uccidevano e a volte, con un sorriso beffardo, risparmiavano le vite, invitando i rapinati a perseverare nell’andar per mare: cosicché loro, i pirati, avrebbero avuto altre occasioni per predare e arricchirsi. E per arricchire i sovrani con cui, talvolta, erano collusi, e a cui cedevano normalmente, a mo’ di tangente, i cavalli rubati, tenendosi il resto del bottino. S’erano organizzati per bene, i predatori dei mari: partivano d’estate insieme a mogli e figli, e spesso incrociavano al largo in gruppi composti da un centinaio di imbarcazioni che, distanziate l’un l’altra di cin304
que miglia, si segnalavano tramite dei fuochi l’eventuale sopraggiungere dei bastimenti da abbordare. La pirateria era una piaga che Marco Polo dovette fronteggiare soprattutto nel secondo tratto della navigazione che dal Levante estremo lo aveva portato a costeggiare l’India occidentale. Da Capo Comorin, vertice del cono indiano, la spedizione era risalita rasentando il litorale del Malabar. Il caldo non aveva concesso respiro: un uovo a bagno nell’acqua, a parere di Marco, si sarebbe lessato senza bisogno di fiamma. Nondimeno, nei boschi e nelle campagne del Kerala si raccoglievano il pepe e i mirabolani emblici, piante dalle proprietà digestive che, confettate in uno sciroppo di mele cotogne e olio rosato, trovavano un largo impiego nella medicina indù, araba ed euromediterranea. Effetto eupeptico doveva avere anche il betel, una foglia aromatica preparata con calce, canfora e spezierie, che Marco Polo vide masticata da un po’ tutti gli Indiani: era quello – a parere del Veneziano – il segreto dei denti che spiccavano bianchissimi sul bruno dei volti, e che illuminavano la pelle di membra scure, per lo più scoperte. Non si coprivano troppo nemmeno quei duellanti che, talora, Marco aveva osservato sfidarsi all’ultimo sangue, armati di spade e scudi tondi all’uopo forniti dal re: erano tenzoni che spesso si producevano per questioni d’onore, e che si innescavano col gesto altamente offensivo d’uno sputo in faccia. Il popolo si accalcava allora attorno al duello, e nella crescente euforia ingenerata dall’imminenza della morte i due sfidanti andavano incontro al destino, ignudi. Seminude erano pure le donzelle che Marco aveva notato mentre, nei templi, convocate dai sacerdoti, imbandivano mense sacre per le divinità. Ballavano e cantavano giocose, le pulcelle, allo scopo di risvegliare i sensi del dio in305
dolente, che aveva smarrito il desiderio di accoppiarsi con la dea. E pare proprio che lo stuzzichio desse alfine i suoi frutti, considerata l’avvenenza delle fanciulle indiane: contemplandone (e forse, chissà, anche toccandone...) le carni sode, apprezzandone i seni che restavano duri anche dopo il matrimonio, Marco Polo aveva avvertito un fremito d’eccitazione: sicché nei suoi quaderni andrà ad appuntare, entusiasta, che «le loro poppe, a causa della durezza, non già pendono, bensì restano sollevate e irte». E comunque, una civiltà che apparentemente sembrava predisporre a comportamenti lussuriosi, e che in certe località accettava la congiunzione carnale fra cugini o con matrigne e cognate vedove, aveva pure partorito uomini casti e miti, quali erano i bramani. La lealtà, l’astinenza da carne e vino, la fedeltà e la franchezza, la premura nel non uccidere alcun essere vivente ne facevano una casta a cui Marco Polo aveva guardato con rispettosa ammirazione. Persino le cremazioni sottendevano una motivazione coerente: bruciare i cadaveri serviva a non disporre per i vermi un nutrimento che, prima o poi, con la decomposizione, sarebbe terminato, e che pertanto avrebbe lasciato gli insetti a bocca asciutta, condannandoli a morte sicura: e i pii indiani mai avrebbero sopportato di essere causa di morte, foss’anche d’un vermetto. Gli asceti, poi, moderati, parchi, tesi soltanto all’adorazione degli dèi, per il regime di vita adottato e per un particolare beverone a base di zolfo, ingurgitato con cadenza mensile, si diceva fossero in grado di campare fino a centocinquanta o duecento anni. Sostavano e dormivano dovunque capitasse, e sul capo esibivano un simbolo vaccino. Certo, un po’ Marco s’era stupito di determinate usanze, come il cospargersi con resti di vacca in polvere, o il 306
mangiare solo vegetali che avessero perso la linfa vitale, e che dunque risultassero secchi, privi dell’anima, usando come scodella delle ampie foglie – anch’esse secche – di Musa paradisiaca (una specie di banano). Ugualmente, il Veneziano era rimasto colpito dalla maniera con cui in alcuni monasteri si mettevano alla prova i neofiti, facendoli palpeggiare da suadenti ragazze: «e se il loro membro si muta, li si mandano via, e dicono che non è onesto, e non vogliono tenere uomo lussurioso; e se il membro non si muta, allora sì che li tengono a servire gli idoli nel monastero», andrà scrivendo Marco nei suoi diari. Ecco che quindi i santoni indiani potevano tranquillamente girare discinti per città e contadi, giustificando la loro nudità col fatto che si sentissero in comunione col cosmo e che non avessero nulla da nascondere, nessun peccato da occultare con una pezzuola sui genitali. La libidine non apparteneva loro: «Voi li portate coperti poiché li adoperate in peccato», sarebbe stata la filosofia dei guru, secondo la narrazione marcopoliana, «e perciò ne avete voi vergogna». Oltre alle peculiarità religiose, fra i ricordi d’India Marco Polo immagazzinerà uno stuolo di animali esotici (felini neri, pappagalli variopinti, babbuini, linci, leopardi, pavoni e galline più appariscenti che in Occidente) e alcuni volatili che, come i pipistrelli e le quaglie, risultavano abbastanza affini ai consimili esemplari europei. Ma è ovvio che a un mercator veneziano interessassero essenzialmente le opportunità commerciali. Lambendo la penisola indiana, di porto in porto, da Quilon in su, Marco aveva verificato quasi ovunque la abbondanza di cotone, pepe e zenzero. Era reperibile anche l’indaco, come pure il cinnamomo e il turbito vegetale (un potente purgante) della zona di Mangalore, e il bucherame e l’incenso di Bombay. Il cuoio ben lavorato 307
e le stoffe bocassine erano caratteristiche del golfo di Khambhath. Le pelli conciate di bue, montone e rinoceronte erano invece proprie del Gujarat. Le importazioni, dal Ponente e dalla Cina, immettevano in India specialmente oro, argento, rame, zinco, garofano, nardo e drappi pregiati. E per gli empori, fra le bancarelle esuberanti di colori e odori, Marco Polo aveva veduto aggirarsi anche dei ragazzini che, mandati via di casa a tredici anni dai padri (poiché ritenuti in grado di cavarsela da soli), cercavano di sbarcare il lunario con commerci minuti, magari acquistando al volo qualche perla ai pontili, e andandola a rivendere porta a porta, per guadagnare qualche spicciolo da consegnare alle madri. Pur distaccandosi progressivamente dai mercati indiani, costeggiando il Makran, sul Tropico del Cancro, Marco continuava a recepire da trafficanti e avventurieri le notizie delle terre che, non troppo esplorate, a ovest dell’Oceano Indiano, possedevano quasi un’aura di intangibilità. Nelle storie apprese qua e là c’era qualche fantasticheria in eccesso, ma anche parecchia veridicità. Si favolava di due isole abitate, rispettivamente, soltanto da femmine e soltanto da maschi (eco di perdute tradizioni sulle Amazzoni), e si credeva che per tre mesi, in primavera, gli uomini andassero a render visita e a «sollazzarsi» con le signore. Poi, ciascuno a casa propria: gli uni a pescare, soprattutto capodogli, per trarne la preziosa ambra grigia; le altre ad allevare la prole. I fanciulli restavano con le genitrici fino alla pubertà, mentre le ragazzine vi rimanevano per sempre. Faceva legge il Vecchio Testamento, e le donne non venivano toccate né durante la gestazione né nei quaranta giorni dopo il parto, in una comunità che era immaginata come fortemente cristianizzata e sottoposta a un suo vescovo. 308
L’arcivescovo era invece a Socotra, e – nestoriano o giacobita che fosse – dipendeva dalla Chiesa di Baghdad (e non da Roma). La marineria locale era specializzata nella caccia alle balene con arpioni e corde che, collegate a botticelle galleggianti, indicavano dove la preda, infilzata e dissanguata, stesse andando a morire. Recuperato il cetaceo, dalla testa si ricavava molto olio, e dalle interiora si prelevavano le ambre canute. Un buon volume di scambi era inoltre garantito dai tessuti di pregio e dalle mercanzie portate a vendere dai pirati e da mediatori cinesi o indiani, che attraccavano piuttosto costantemente a Socotra. Peraltro, l’approdo all’isola – almeno così aveva udito Marco – poteva essere soggetto all’arbitrio di alcuni indovini, abili nel fermare il vento o nello scatenare uragani, regolando a piacere il traffico navale. Meno inghippi si incontravano nel guadagnare il Madagascar (in cui qualcuno vedrebbe piuttosto il nome corrotto di «Mogadiscio»): paese a preminenza musulmana, popolato da mercanti e artigiani, veniva descritto colmo di alberi di sandalo rosso e, naturalmente, prodigo d’ambra di balena. Sfruttando la corrente calda del Mozambico, si impiegavano venti giornate di navigazione per giungervi dal Maabar, mentre tre mesi, contro corrente, erano necessari per effettuare lo stesso tragitto all’incontrario. A sentire «certi mercatanti», inoltre, era sul Madagascar che volteggiava il terrificante rokh, un animale spaventoso, metà aquila e metà leone, dotato di una tale forza e grandezza da poter sollevare in aria un elefante, per poi farlo sfracellare al suolo e nutrirsene a sazietà. Laggiù, sul Tropico del Capricorno, il vitto della gente comune consisteva innanzitutto nello stufato di cammello, un quadrupede che evidentemente era diffuso non meno dei grandi felini africani e dei mae309
stosi pachidermi, catturati per commerciare l’avorio delle lunghe zanne. Una fauna e un’economia analoghe si riscontravano a Zanzibar, laddove cammelli ed elefanti venivano sovente impiegati in combattimento, con in spalla torrette contenenti fino a una ventina di soldati. Giraffe e leopardi erano le bestie tipiche d’un territorio in cui agnelli e pecore avevano il corpo tutto bianco e la testa tutta nera. E a proposito di tonalità: presso un qualche scalo indiano o mediorientale, Marco Polo dovette imbattersi in individui dell’Africa orientale e impressionarsi per il loro colorito assolutamente nero, per la loro virilità sproporzionata, per le bocche e i nasi carnosi, per i capelli ricci e crespi, e per la corporatura massiccia, che rendeva le donne non proprio suadenti e gli uomini nerboruti: del resto, correva voce che ciascuno di quegli africani mangiasse per cinque persone, alimentandosi principalmente con datteri, carne e latte. Il loro vino non era d’uva, bensì un distillato di riso, zucchero e spezie, complemento a un regime nutrizionale che per diversi aspetti concordava con la dieta dell’Abissinia (un distretto che Isidoro di Siviglia, nelle sue Etymologiae, aveva reputato abitato da «plurimae [...] gentes diverso vultu et monstruosa specie horribiles»). Nelle regioni etiopiche vivevano struzzi, giraffe, elefanti, onagri, scimmie, pappagalli, uccelli e mammiferi delle razze più disparate, e coabitavano cristianesimo, ebraismo e islam (col condimento d’un presunto passaggio di san Tommaso). Marco Polo aveva saputo che i cristiani li si riconosceva per i tre segni che essi si imprimevano sulle guance e in faccia; gli ebrei per i due emblemi sulle sole gote; e i musulmani per l’unico marchio, in fronte. La densità dei monoteismi aveva calamitato sull’Etiopia l’ennesima leggenda del Prete Gianni, contribuendo al proliferare di novelle a sfon310
do religioso. Si soleva riferire di un presule mandato dal cristianissimo sovrano abissino al Santo Sepolcro, in Terrasanta: ma, ahilui, il prelato sarebbe stato fermato nelle province islamiche e contrassegnato, in sfregio, con un simbolo musulmano (in altre versioni della novella risulta, piuttosto, circonciso a forza). Il che avrebbe suscitato l’ira del re etiope, risoltosi a guerreggiare per vendetta contro gli islamici dei regni limitrofi: regni invisi, anche, per una spietata rivalità commerciale. Se gli abissini trattavano infatti oro, cotone e bocassine, gli scali dello Yemen e dell’Oman, i bacini portuali di As-Shihr e, soprattutto, di Aden, erano degli inesausti collettori di mercanzie, pronte a risalire fin nell’imbuto del Mar Rosso settentrionale e, da lì, in un soffio, a raggiungere Alessandria. Quei corridoi navali, quegli accessi erano ciò di cui Marco, Niccolò e Matteo Polo volevano sincerarsi, ciò che intendevano focalizzare, riscontrare, conoscere a fondo: una rotta che permettesse di andare e venire dal Levante, di legare via mare l’Egitto all’India e alla Cina; un’alternativa agli itinerari terrestri, che cominciavano a non esser più lineari come un tempo (e dove bisognava sempre fare i conti con la concorrenza genovese). È forse un caso che Giovanni da Montecorvino, il teologo inviato da papa Niccolò IV (12881292) al gran khan, scegliesse nel 1289 il percorso marittimo per giungere a Pechino mediante un soggiorno in India? E allora, per le future attività dei Polo (e di Venezia), era importante avere cognizione dei dazi imposti sulle merci in transito per i porti arabi e africani, dei flussi mercantili, delle inclinazioni religiose (e quindi caratteriali) dei possibili interlocutori, della raccolta dei datteri, della produzione di incenso bianco, della pesca dei tonni, del pesce secco (conservato a lunga scadenza oppure impiegato come mangime 311
per l’allevamento di bovini, cammelli, montoni e ronzini), delle condizioni climatiche, delle importazioni di cereali (stante l’aridità dei suoli), delle esportazioni di corsieri e, insomma, di tutto quello che concorreva a definire il carattere di un territorio. Ai tre veneziani premeva capire perfino i metodi per scampare ai naufragi: seppero allora che, legando in serie degli otri a guisa di zattera e riempiendoli d’aria, di gioielli e vivande (e dunque salvando il materiale portabile), con un pizzico di fortuna si poteva sperare di rientrare a riva. Ma intanto, la missione affidata da Kubilai Khan andava completata. Dallo Stretto di Hormuz, pur avendo in tasca una quantità di nuove informazioni mercantesche da capitalizzare e far fruttare, bisognava coronare mesi e mesi di viaggio arrivando alla corte dell’il-khan e consegnando Kokacin al promesso sposo. Soltanto dopo si sarebbe ricominciato a pensare agli affari.
2 | Lo sposo di riserva Sennonché Arghun era scomparso nel marzo del 1291. I maligni insinuavano che, essendo da tempo malato, avesse voluto presentarsi aitante e giovanile alla principessa che stava per impalmare, e avrebbe perciò abusato di un farmaco portentoso, a base di mercurio, che si sarebbe rivelato mortifero. A cagionare l’intossicazione fatale potrebbe in realtà anche essere stata l’imperizia, nel dosaggio di medicine, dei tanti dottori, guaritori e scapolomanti chiamati a risolvergli i problemi di salute. O forse, semplicemente, più prosaicamente, Arghun era stato avvelenato in seguito a una cospi312
razione, ordita dai detrattori, suoi e del suo governo: con l’ilkhan in coma, il primo ministro, l’ebreo Saad al-Daula, era stato arrestato e giustiziato, reo di aver troppo favorito i correligionari e di aver esercitato un nepotismo smodato nella distribuzione degli incarichi governativi. A onor del vero, il consigliere giudeo era stato un amministratore di talento, e pur di conservare la compattezza statale non aveva lesinato concessioni e indulgenza nei confronti della componente musulmana dell’il-khanato. E tuttavia, i sintomi di un’irrequietudine politico-sociale datavano già da alcuni anni. S’erano infatti manifestati sin dal biennio in cui, fra il 1282 e il 1284, il secondogenito di Hülegü, Tekuder, subentrato ad Abaqa, aveva retto il regno convertendosi all’islam e assumendo emblematicamente il nome di Ahmed. I musulmani avevano allora intravisto la possibilità di riprendersi quel ruolo predominante che nella società persiana s’erano annessi per secoli, prima dell’avvento mongolo. Ma l’azione restauratrice di Arghun, direttamente investito da Kubilai Khan e succeduto a Tekuder Ahmed grazie a una congiura di palazzo, aveva neutralizzato i fermenti islamici. Contemporaneamente, il nuovo il-khan s’era predisposto alla lotta contro i Mamelucchi d’Egitto: appena asceso al potere, aveva inviato una lettera a papa Onorio IV (1285-1287), e si era prodigato nel mandare ambasciatori in Europa fra il 1287 e il 1288. Aveva poi scritto nel 1289 a Filippo IV il Bello, re di Francia (1285-1314), e s’era rivolto al pontefice Niccolò IV nel 1290. Le iniziative presupponevano sempre uno stesso motivo: concertare con i potentati della cristianità un attacco che schiacciasse nel mezzo, a tenaglia, i territori islamizzati di Siria, Libano e Palestina. Protagonisti delle messaggerie che da Tabriz avevano di volta in volta toccato Napoli (con la corte angioina), 313
Roma (col collegio cardinalizio e i pontefici), Genova (coi maggiorenti cittadini), Parigi (col monarca capetingio) e Bordeaux (capitale continentale di Edoardo I d’Inghilterra), erano stati religiosi nestoriani come il monaco Rabban Sauma, e cittadini genovesi di prosapia aristocratico-mercantile, spesso versati nella finanza internazionale, come Tomaso Anfossi e, soprattutto, Buscarello Ghisolfi, un rampollo di buona famiglia entrato al servizio degli il-khanidi con mansioni, per certi versi, analoghe a quelle svolte da Marco Polo nella Cina degli Yuan. Si può ben capire l’estrazione dei delegati che intessevano relazioni fra i Mongoli (fautori dei liberi commerci e, generalmente, bendisposti verso il cristianesimo) e gli occidentali: nelle legazioni figuravano in effetti sia ecclesiastici cristiani, intimoriti da un’islamizzazione che nella Terrasanta pareva irreversibile, sia personaggi provenienti dalla borghesia capitalistica delle grandi città mercantili, preoccupate di perdere i privilegi commerciali sulle vie per l’Oriente. L’interferenza mamelucca, ingigantitasi a compromettere i commerci internazionali e a spezzare le ambizioni espansive del papato, era di indubbio impaccio alla linearità dei collegamenti fra l’Occidente e l’il-khanato, a sua volta piattaforma di lancio per il Levante estremo. E proprio mentre Arghun inviava legazioni in Europa, il sultano del Cairo, Qalawan (1277-1290), provvedeva a fagocitare importanti postazioni della latinità nella fascia siro-libano-palestinese: Laodicea era caduta nel 1287, e Tripoli, caposaldo del commercio genovese, era stata rasa al suolo nel 1289. Tuttavia, per un’irrisolta diffidenza reciproca, per mancanza d’effettiva volontà e risorse, per le diatribe intestine agli Stati euro-mediterranei (Angioini contro Aragonesi, Veneziani contro Genovesi, Inglesi proiettati su Galles, 314
Scozia e Norvegia), e per l’usura che duecento anni di crociate avevano indotto nelle potenze occidentali, gli accordi fra Mongoli ed europei non s’erano concretizzati. Per gli ilkhanidi, privi di sponde con cui sferrare un attacco al sultanato mamelucco, la situazione rimaneva quindi in sospeso. All’esterno, come pure all’interno del principato: le mai sopite ambizioni musulmane erano state difatti rinfocolate dalla morte di Arghun. Suo fratello Gaikhatu (1291-1295), che con un colpo di mano s’era ritrovato sul trono di Persia, non sarebbe rimasto a lungo in sella: a parte le personali inclinazioni ai piaceri bisessuali, al vino e ai lussi più sfrenati, il sovrano doveva disimpegnarsi fra le mene di una fazione che sosteneva la candidatura regia di Baydu, e le aspirazioni del legittimo principe ereditario, Ghazan, di stanza nel Khorasan per difendere i confini dalle incursioni dell’ineffabile Kaidu. Alle discordie più o meno latenti in seno all’aristocrazia mongola si aggiungevano i guasti provocati da un’amministrazione statale che, delegata dal nuovo il-khan a funzionari islamici, favoriva smaccatamente i devoti del Corano e ingenerava ulteriori tensioni sociali. Tutto questo terremotava l’il-khanato e lo rendeva instabile, addirittura insicuro nei distretti che ricusavano l’autorità regia, laddove impazzavano bande di predoni violenti, e il popolo reagiva inviperito a un regime fiscale gravoso. Dunque affaristi italici affannati a ricucire alleanze. Nobili mongoli intenti a complottare. Sedizioni pronte a erompere: in quella concitazione generalizzata s’erano venuti a trovare Marco, Niccolò e Matteo Polo, con la loro preziosa Kokacin. Preziosa, ma per chi? Lo sposalizio con Arghun era evidentemente sfumato. La «Principessa Celeste», che con tanta solerzia e fasto Kubilai Khan aveva inviato dalla Cina, all’improvviso era divenuta quasi una grana. Pu315
re, una soluzione onorevole e diplomatica per l’imbarazzante faccenda bisognava escogitarla, non fosse altro che per evitare il risentimento del gran khan a Pechino. Gaikhatu preferì allora dare la graziosa giovinetta in matrimonio al nipote, a Ghazan, un po’ perché si trattava pur sempre dell’erede del mancato sposo, e un po’, probabilmente, per cercare di stemperare i dissapori dinastici. Dalla corte il-khanale i Polo dovettero pertanto allungare la loro missione fino al dipartimento khorasanide, protetti – in quei frangenti inquieti – da un’imponente scorta armata apparecchiata dal sovrano. Ligi alle consegne ricevute, i tre veneziani affidarono Kokacin al marito «di riserva». La tempra da ostinati mercanti e l’esperienza cosmopolita, tradotta in durezza sentimentale, non poterono impedire ai Polo di intenerirsi nel vedere la dolce principessina che, salutandoli, piangeva, dovendosi separare da coloro che le erano stati accanto, con dedizione paterna, durante le mille traversie affrontate in un viaggio lungo e avventuroso. Commozioni a parte, da quel momento Marco, Niccolò e Matteo potevano considerare assolto il compito di accompagnatori, e intraprendere gli ultimi segmenti della strada che conduceva in Laguna. I tre rimasero in Persia, col beneplacito di Gaikhatu, dal maggio del 1293 al febbraio dell’anno seguente. Dovevano approfondire le conoscenze, comprendere gli sviluppi politici mediorientali, programmare ancora l’avvenire, i commerci, la vita. E poi, dovevano individuare il percorso più conveniente per tornare a Venezia. In altri tempi, non ci sarebbe stato troppo da pensare: la scelta sarebbe caduta abbastanza prevedibilmente su San Giovanni d’Acri. Ma Acri non esisteva più. L’ultima capitale crociata, l’appiglio dei Latini nell’Outremer, la casa di San Marco nel Vicino Oriente era stata cancellata nel 1291 316
dalle milizie di al-Ashraf Khalil, il dinasta cairota. D’altronde, i crociati se l’erano proprio andata a cercare: sbarcati al porto acritano da navigli veneziani (col supporto di cinque galee aragonesi), non avevano trovato di meglio da fare che ubriacarsi e darsi a un insensato eccidio dei contadini e dei commercianti musulmani: gente onesta, inerme, brava gente che, nella pacifica atmosfera suscitata dal libero mercato, vendeva tranquillamente le proprie derrate sui banchi cittadini. La strage, assolutamente immotivata, aveva riguardato tutti gli uomini con la barba, compresi i cristiani non rasati, che erano stati scambiati per maomettani. E le conseguenze di quella scellerata carneficina erano state esiziali. L’ingiustificabile massacro di islamici aveva infatti innescato la collera del sultano egiziano, offrendogli il pretesto per farla finita coi Franchi e le loro basi mediorientali. Così, nonostante gli sforzi dei difensori e le efficaci macchine belliche costruite da veneziani e pisani, Acri era stata assediata, investita dai soldati mamelucchi e annientata, con lucida ferocia. Durante la battaglia, chi aveva voluto salvarsi sulle banchine portuali affollate di fuggiaschi, aveva dovuto pagare somme stratosferiche a squallidi profittatori occidentali che, privi di scrupoli, s’erano appropriati di una qualche imbarcazione per lucrare sulla disperazione altrui. Donne, bambini, soldati in rotta avevano cercato di lanciarsi su battelli di ogni fatta per remare verso i vascelli più grandi che stazionavano al largo, e che comunque non avrebbero mai potuto contenere l’intera popolazione cittadina. Chi invece aveva scelto di restare e battersi, oppure di rinchiudersi in casa, era stato o massacrato oppure catturato per essere ridotto, al pari di fanciulli e ragazze, in schiavitù. Talmente elevato era stato il numero dei prigionieri acritani che, al mercato di Damasco, le giovani schiave ave317
vano finito per essere vendute all’irrisorio prezzo di una dracma a testa. Dopo Acri, il crollo latino si era propagato a catena: Tiro, Sidone, Beirut, Haifa avevano ceduto. Le fortezze templari di Tortosa e Athlit, ormai indifendibili, erano state evacuate. Il sultano al-Ashraf Khalil aveva fatto scorrere le regioni costiere in lungo e in largo, affinché ogni traccia crociata venisse cancellata e la latinità non avesse più possibilità di rimettere piede nell’Oltremare. Erano stati spianati finanche i frutteti, rovinati i sistemi irrigui, smantellati interi quartieri di villaggi e metropoli. A eccezione di qualche fortilizio, tutto era stato ridotto alla desolazione. Non c’era più niente e nessuno che, sul litorale siro-libano-palestinese, potesse aiutare i Polo a rientrare sul Canal Grande. Oltretutto Marco, Niccolò e Matteo si portavano appresso un bel gruzzolo di denaro e gioielli che avevano ricavato dagli affari conclusi in giro per il mondo. E dovevano stare particolarmente attenti ai passi che mettevano, per non perdere i frutti di tante laboriose peripezie. Diressero pertanto sul Mar Nero, giudicandolo l’itinerario meno azzardato.
3 | Ulisse medievale A Trebisonda la stirpe dei Comneni, che aveva dato imperatori a Bisanzio e che era magnificata per la bellezza proverbiale delle sue donne, conservava da una novantina d’anni un regno che si barcamenava fra tributi e alleanze, in posizione nodale sui traffici da e per l’Asia Minore. Il Mar Nero era in quel momento un bacino prevalentemente genovese e, nella città retta dalla dinastia comnena, Genova pote318
va contare su un proprio quartiere commerciale. Venezia, invece, appoggi non ne aveva. E dunque, a Trebisonda, i veneziani fruivano tutt’altro che di particolari vantaggi, specialmente dopo la riapertura delle ostilità fra la marineria ligure e quella marciana, che dal 1294 avevano ripreso a suonarsele di santa ragione fra le acque di Cipro e di Lajazzo. La caduta di Acri aveva scombussolato i fragili equilibri commerciali e, quindi, le sfere d’influenza dei potentati mercantili andavano ridisegnate. Come? Nemmeno a dirlo: col solito sistema della guerra. In transito per il Ponto, i Polo dovettero accorgersi a proprie spese e subire le conseguenze della rinnovata discordia fra le due vecchie rivali: le merci, il denaro accumulato durante i viaggi d’affari nel Levante, vennero sottratti ai tre mercanti e trattenuti dalle autorità locali (sebbene qualche studioso abbia anche pensato a un assalto di predoni), per un importo complessivo di quattromila iperperi bizantini. Spogliati d’una buona quota dei propri averi, Marco, Niccolò e Matteo si affrettarono a riprendere l’itinerario – presumibilmente navale – per Costantinopoli. Anche nella decadente capitale dell’impero Orientale l’aria si faceva ogni giorno più pesante: il trattato decennale che la Repubblica di San Marco aveva stipulato col basileus Andronico II Paleologo (1282-1328) stava per scadere. Di lì a poco, il sostegno assicurato dall’imperatore costantinopolitano ai Genovesi provocherà la violenta reazione dei cittadini veneziani residenti sul Bosforo, seguita da un’ancor più brutale rappresaglia del sovrano bizantino, nel 1296. A quel tempo, tuttavia, Marco Polo, col padre e lo zio, si trovavano già al sicuro. Erano approdati in Laguna nel 1295, al termine d’una navigazione che tramite Negroponte, divisa in terzieri vassalli del doge, aveva riavvicinato con 319
graduale lentezza i tre mercanti alle atmosfere veneziane. Ventiquattro anni erano stati lontano dal Canal Grande, da Rialto, dai parenti. Quasi un quarto di secolo, in cui avevano viaggiato, commerciato, assimilato. A Marco era sfuggito ben poco: s’era pure informato sugli antagonismi che avevano afflitto il Medioriente, sulle lotte dinastiche all’interno dell’il-khanato, o sui dissidi fra l’il-khanato e i chagataidi, fra l’Orda d’Oro e l’il-khanato, sugli antichi scontri fra Hülegü e Berke. In Persia, inoltre, doveva aver rimpolpato con nuovi particolari e nuove fantasticherie le informazioni che, alla corte di Pechino, non gli erano certo mancate sulle terre ghiacciate della Siberia, e sulle usanze russe. Aveva notato già, in una qualche tappa del suo vagare, quanto i Russi costituissero un razza di bell’aspetto, tutti «bianchi e biondi». Sapeva che essi «sono cristiani e tengono la maniera dei greci», e che commerciavano in pelli, che cavavano argento, che ingollavano quantità spropositate di una bibita alcolica, la cerbesia, fatto col miglio. Le bevute collettive, che Marco Polo chiamava straviza (dallo sloveno zdravica, che significa «brindare», «brindisi»), avvenivano allorché allegre brigate di nobiluomini e nobildonne, con figli al seguito, si riversavano nelle osterie. A fine sbronza, si diceva che chi non potesse pagare il conto finiva col dar in pegno la prole a qualche forestiero, in cambio di soldi. Altri insinuavano che le signore fossero tanto prese dal bere e dal ridere che non usavano alzarsi per mingere: ai loro bisogni fisiologici erano piuttosto addette delle serve che, senza farsi vedere dai commensali, inserivano spugne asciutte e le toglievano, zuppe di piscio, da sotto ai sederi. Quando poi alle suggestioni evocate dalle tradizioni locali si congiungevano le speciali condizioni ambientali, ecco scaturire aneddoti grotteschi: era stato raccontato a Mar320
co Polo che una volta, rincasando da una straviza nella notte gelida, una dama avesse sentito l’impellenza di urinare. Accovacciatasi per strada, avrebbe voluto sgravarsi: e però il suo fiotto si sarebbe congelato all’istante, finendo per agganciarle al suolo i peli del pube. Alle urla della sventurata sarebbe accorso il marito che, pur ubriaco, avrebbe tentato di alitare sul ghiaccio che uncinava la moglie. Pure lui, tuttavia, si sarebbe ritrovato immobile, col muso incollato all’inguine muliebre, per l’immediato congelamento del fiato emesso. Per fortuna, pare che alcuni passanti di buona volontà fossero intervenuti a sciogliere marito e moglie dalla bizzarra posa in cui il gelo li aveva cristallizzati. E meno male che esistevano delle specie di saune bollenti, che cadenzando le vie principali permettevano ai russi di incedere a tappe, di stufa in stufa, senza stramazzare per il freddo. Alle latitudini boreali, Marco ne aveva avuto notizia, fra nevi e tundre, il pallore funereo del sole spargeva un crepuscolo grigio, pressoché perenne. Ma l’aneddotica russa costituiva solo una porzione esigua, e neppure troppo importante, di tutto quello che Marco Polo aveva visto e ascoltato, e che avrebbe rivelato all’Occidente. Un buon mercante doveva anche saper esporre, narrare, comunicare il patrimonio cognitivo stratificatosi nel viaggiare. Tanto più se quel patrimonio concerneva le Indie, il Catai, le terre che la prospettiva occidentale stentava a focalizzare. Marco era il nuovo Ulisse ritornato dall’Oriente, pronto a presentare i suoi incredibili ricordi, le sue incredibili esperienze, gli incredibili mondi attraversati. E poi, era anche tempo di mettere a frutto i guadagni dei commerci che in quell’Oriente erano stati svolti, investendo i proventi della compravendita di gemme (di cui i Polo erano maestri) nel settore immobiliare. 321
Il padre Niccolò, con gli zii Matteo e Marco il Vecchio, aveva comprato, fra il 1295 e il 1296, in regime di indivisione e di comunione dei beni, un palazzo in contrada San Giovanni Crisostomo, sulla riva sinistra del Canal Grande, nel cuore stesso di Venezia. Era un vasto edificio a più piani, una sorta di casa-fondaco che oggi non esiste più, ma che è possibile ricostruire in virtù di alcuni scavi archeologici che hanno riguardato il Teatro Malibran, e grazie al contenuto di testamenti, atti processuali, divisioni e sentenze che saranno pronunciate dalle differenti Corti di Giustizia veneziane. Nella Corte Seconda del Milion, la dimora poliana constava d’una grande sala, di dodici stanze, di una cucina, di depositi e, nel cortile, di un pozzo e una latrina, utilizzati sempre in comune (anche quando la proprietà sarà divisa). Per Marco Polo sarebbe stato più semplice accasarsi e vivere tranquillamente nel centro cittadino, assieme alla moglie Donata Badoer, gentildonna di ascendenza nobiliare. Avrebbe fatto affari con qualche colleganza. Si sarebbe mantenuto negli agi d’una condizione sociale invidiabile, servito dallo schiavo tartaro Pietro. E si sarebbe crogiolato negli oggetti che (come si ricava dai lasciti testamentari) rievocavano i migliori anni della sua più che quarantennale esistenza, gli anni della Cina: sete finissime, gioie preziose, un sottile vello di yak, redini dalla foggia singolare, bottoni in ambra e la tavola aurea (la paiza) che il gran khan forniva come salvacondotto ai suoi messaggeri. Invece, dove ritroviamo Marco Polo? Imbarcato su una delle navi veneziane che in quegli agitati frangenti guerreggiavano coi vascelli genovesi. S’erano fatte intraprendenti, le galee di Genova: avevano sgominato ripetutamente le flotte del doge, e solcando il Mediterraneo erano arrivate nel 1298 fino a Curzola, in Adriatico, al comando 322
di Lamba Doria, a sfidare da presso la potenza marciana. Ne era derivato uno scontro asperrimo. La rotta veneziana era stata completa: migliaia di morti, un’ottantina di galere catturate e incendiate, un numero incalcolabile di prigionieri. Che sia stato in quella battaglia famosa o in un altro oscuro combattimento navale, di fatto Marco Polo finì imprigionato a Genova. Non è detto però che le prigionie fossero tutte ceppi e celle buie. Certamente a Genova c’erano carceri riempite d’umido, di promiscuità, di fetore, di sporcizia, di fame. C’erano edifici stipati di detenuti. Una pletora di prigionieri: i Pisani sconfitti nella battaglia della Meloria del 1284, e adesso i Veneziani. E non si andava per il sottile: sfamare tanta gente, sorvegliarla, gestirla, costava enormemente. Le infezioni si propagavano con rapidità. Decine di cadaveri, ogni giorno, finivano in mare. Ma c’erano prigionieri e prigionieri. I nobiluomini godevano non di rado d’un trattamento privilegiato. Jacques Heers ha pure suggerito che alcuni fra gli arrestati potessero essere tenuti come ostaggi nelle case di chi aveva dei parenti in mani nemiche, in serbo per probabili scambi. E in casa, naturalmente, si preferiva detenere degli uomini di lignaggio, piuttosto che dei brutti ceffi.
4 | La descrizione del mondo Marco Polo era un facoltoso commerciante di Venezia. Rustichello (o Rusticiano) un prosatore di Pisa, che si suole accomunare generalmente alla disfatta della Meloria: se così fosse, era da quattordici anni che durava la sua prigionia. Si 323
conobbero fortuitamente, il Veneziano e il Pisano, associati al regime carcerario di Genova. L’uno era uomo d’azione, formatosi nella mercatura, esploratore di un’Asia lontanissima e navigatore dell’immenso Oceano Indiano; l’altro era piuttosto uomo da scrittoio, forse non ignaro di viaggi, ma certo più pratico di letteratura: intorno al 1272 aveva composto il Roman de Meliadus, prosa di avventure cavalleresche arturiane atta ad allietare le corti reali: e in effetti, Rustichello aveva frequentato Enrico III ed Edoardo I d’Inghilterra. Vite fin lì distinte e distanti convergevano adesso a mettere in comunione esperienze e competenze. Non un’eccezione, sia chiaro: molti degli Itineraria redatti fra la fine del XIII e la metà del XV secolo saranno la risultante dell’unione di un viaggiatore-narrante e di un letterato-scrivente, di un auctor-dictator e di un auctor-scriptor che – come giustamente ha sottolineato Alvaro Barbieri – di solito dichiarano la loro collaborazione nelle parti proemiali o nell’explicit delle composizioni. Per la stesura del testo, comunque, il narratore dipendeva inestricabilmente dall’estensore, e viceversa. E così dovette funzionare anche fra Marco e Rustichello, allorché si decise di mettere per iscritto, in forma acconcia, il colossale patrimonio di conoscenze acquisite con le peripezie poliane in partibus Orientis. Va subito premesso che nulla di sicuro si può affermare sulla realizzazione dell’impresa scrittoria. Non si sa con certezza se Marco Polo si sia in questa fase limitato a dettare, o sia direttamente intervenuto nella redazione. Né è da escludere che il mercante veneziano abbia messo a disposizione del compilatore pisano un quaderno di appunti raccolti negli anni trascorsi in Oriente: un diario, un taccuino, un registro di annotazioni sulle modalità e le opportunità of324
ferte dai commerci asiatici, sui canali di distribuzione delle mercanzie, sulle strade da attraversare e i popoli da approcciare. La memoria, comunque, era ben vivida. Per tradurre tutto quanto su carta si scelse il francese, la lingua più diffusa per il genere narrativo, il volgare romanzo più prestigioso, di cui Rustichello era buon conoscitore e che, presumibilmente, non era del tutto oscuro a Marco. La langue d’oil avrebbe consentito di raggiungere un pubblico piuttosto vasto su scala europea, e un uditorio diversificato. Stava infatti per nascere un volume che sarebbe andato incontro ai gusti polimorfi dei più svariati lettori: un po’ relazione di viaggio, un po’ trattato geografico e un po’ manuale ad uso mercantesco, zibaldone d’affari. Senza dimenticare quelle venature che potevano farne un livre des merveilles, e l’inevitabile spruzzatina d’avventura data dalla propensione di Rustichello per il romanzo cortese. Un settore della critica contemporanea, peraltro, sarebbe incline ad attribuire all’opera il carattere di composizione «sul» potere e «per» il potere, inquadrandola nella tipologia degli specula principum, tanto consueta nella cultura medievale europea. E tuttavia, il libro doveva essere anche qualcosa in più. Aveva un protagonista, che non era Kubilai Khan. Il personaggio intorno al quale costruire la narrazione, l’eroe dichiarato sin dal prologo («E questo vi conterà il libro ordinatamente siccome messere Marco Polo, savio e nobile cittadino di Vinegia, le conta in questo libro»), e ribadito anche nel finale («E non fu mai uomo, né cristiano, né saracino né tartaro né pagano, che mai cercasse tanto de mondo quanto fece messere Marco, figliuolo di messer Niccolò Polo, nobile e grande cittadino della città di Vinegia»), era un altro, e bene identificabile: messer Marco Polo. In lui, con lui si glorificava veramente il mercator, la cultura dei commer325
ci, l’identità e il potere di una classe che manovrava le leve dell’economia e che, oltre a volersi solennizzare, rappresentava davvero l’innovazione, la modernità, la linfa più viva del consorzio euro-occidentale. E chi meglio di un Rustichello, abilissimo nel giostrare con dimestichezza fra gli eroismi di cavalieri e donzelle, poteva scrivere del nuovo paladino, «del mercante, che», come afferma Gabriella Airaldi, «proprio mentre guarda a Oriente si autocelebra nelle vesti di uomo dell’Occidente»? Imprimendo le sue storie nei fogli di un manoscritto che avrebbe circolato e comunicato, Marco Polo intendeva celebrare e perpetuare se stesso, la propria città, il proprio ruolo di «uomo nuovo» che rivoluzionava, svecchiava, disincagliava la civiltà europea e cristiana dalle sue viete convinzioni e convenzioni. Non si arrivò a completarlo, il testo. Rimasero incompiute le parti conclusive. Mancò una revisione che rendesse l’insieme dell’elaborato omogeneo col proemio maestoso e sostenuto, e che ripulisse il corpo testuale da sbavature, ambiguità, dimenticanze e pentimenti. La compilazione era evidentemente in progress quando la flotta di San Marco aveva voluto mostrare d’essersi subito riavuta dalle recenti batoste, facendo nel 1299 un’incursione su Genova. La pace (provvisoria) che ne provenne permise ai prigionieri veneziani di tornare liberi, ma impedì a Marco Polo di proseguire il sodalizio letterario con Rustichello. Otto mesi o poco più non erano bastati a ultimare il lavoro a quattro mani. E d’altronde, sarebbe ingenuo credere che Marco avesse con sé, da recluso, l’intero archivio necessario a ricostruire i viaggi attraverso la Cina e l’Estremo Oriente. Rientrato in Laguna, dovette quindi procedere, inevitabilmente e ulteriormente, a delle addizioni rispetto allo scritto originale, che tenessero conto degli ultimissimi even326
ti asiatici: dalla primavera del 1299 erano entrati in conflitto Nokhai, importante generale mongolo dell’Asia centrale, e Toktai, khan dell’Orda d’Oro (1290-1312). Non se ne poteva tacere, in un racconto che descriveva l’ecumene e che alle dinastie mongole aveva dedicato molte, intense sezioni. Così Marco Polo integrò il suo racconto, lo perfezionò di continuo, vi soggiunse dettagli e chiarimenti. Ne discenderanno versioni in francese, franco-italiano, toscano, veneziano, latino e, probabilmente, tedesco: quanto a traduzioni, fu un successo senza precedenti per il Medioevo, e per un autore ancora in vita. Ma quale vita? Il gran viandante pareva essersi fermato. Quasi che il rivedere gli scritti, l’arricchirli, il maneggiarli e rimaneggiarli bastassero a viaggiare fra le memorie, a ritornare nel Levante, in Cina, ai tempi della freschezza giovanile, dell’entusiasmo e dell’apprendistato, irripetibili. Marco Polo si dedicava adesso ad amministrare i beni di famiglia, a investire capitali, a prestare e a esigere denaro. Ma tutto da stanziale, tutto senza allontanarsi troppo di casa. Intorno, Venezia ribolliva: nel 1297 la Serrata del Maggior Consiglio aveva cambiato le carte in tavola alle istituzioni locali, producendo una ripartizione dei poteri cittadini fra i nobili della classe dirigente: sicché solo gli eletti nell’ultimo quadriennio – e dunque i rappresentanti di famiglie potenti – avrebbero potuto in avvenire sedere nel consesso. La congiura di Marino Bocconio nel 1300, pur arenandosi, aveva poi provocato qualche sussulto. La guerra con Padova del 1303-1304, combattuta dal dogato per questioni di saline, era stata sanguinosa. Il dissidio con Ferrara aveva originato una scomunica lanciata nel 1309 sui Veneziani da papa Clemente V (1305-1314). E nella mancata insurrezione architettata dai Tiepolo e dai Querini nel 1310 erano stati 327
coinvolti anche Angelo e Pietro Badoer, cognati di Marco Polo. Il quale, dal canto suo, apparentemente estraneo alla politica, badava piuttosto a farsi liquidare i beni dotali della moglie Donata e predisponeva i matrimoni delle tre figlie: Fantina, che sarà moglie di Marco Bragadin; Belella, che si mariterà con Bertuccio Querini; e Moretta, che sposerà prima Ranuzzo Dolfin e successivamente Tomaso Gradenigo. Buoni partiti, messer Marco aveva di che essere contento. Né poteva lamentarsi degli affari, sebbene non sempre gli investimenti andassero a buon fine: una partita di muschio mercanteggiata in choleganza con Paolo Girardo non aveva dato i guadagni auspicati, sicché s’era dovuto ricorrere ai giudici per la resa di conto. I parenti, poi, cugini e nipoti che non volevano restituire i prestiti: Marco non si faceva scrupoli nel trascinare anche loro in giudizio. Perciò, a risarcimento dei debiti di Marcolino Polo (il cui nonno era stato Marco il Vecchio), il nostro Marco si approprierà nel 1319 di ulteriori porzioni della grande dimora familiare di San Giovanni Crisostomo. Seccature, probabilmente. Più gradevoli risultavano a Marco Polo le visite degli eruditi che, per sciogliere dubbi accademici, lo consultavano in qualità di conoscitore delle Indie: finanche Pietro d’Abano, brillante professore dell’Università di Padova, lo contattò per chiedergli se le regioni equatoriali fossero abitate. E avendo ottenuto risposte esaurienti, il luminare scrisse nel suo Conciliator differentiarum philosophorum, pubblicato nel 1310, che «Queste e altre questioni mi sono state spiegate dal veneziano Marco Polo, l’uomo che più ha viaggiato e l’esploratore più diligente che io abbia mai conosciuto». Evidentemente, a prescindere dalle malelingue che lo accusavano di riportare frottole, una rapida fama e una qual certa autorevolezza avevano già toccato 328
l’estensore del Devisement dou monde (Descrizione del mondo), o Milione: titolo, quest’ultimo, che, divulgato a partire dalla versione toscana, non è stato del tutto spiegato. Potrebbe discendere da Milion, nomignolo (derivante da Emilione) di un ramo della casata poliana. E d’altro canto, connesso col libro, il soprannome riverberava l’idea delle favolose ricchezze ostentate nei capitoli sull’Oriente, ed evocava la spumeggiante molteplicità di un testo che, ibridandosi, ponendosi all’intersezione di generi diversi, diveniva multiuso. Non a caso, si decisero a trasporlo in latino perfino i domenicani, che probabilmente vi avevano intravisto potenzialità ecumeniche e la possibilità che ne usassero i missionari: e frate Francesco Pipino da Bologna dovette distinguere in Marco Polo un «gentiluomo prudente, credente e devoto, adorno di onesti costumi», considerata la magnanimità con cui il Veneziano volle regalare una copia del Devisement all’ordine monastico domenicano. Ma generoso, messer Marco, era stato pure in altre occasioni. Nel 1307 aveva infatti donato il suo manoscritto al nobile Thibaut de Chepoy, affinché lo facesse recapitare a Carlo di Valois, fratello del re di Francia. Forse, non si trattava di un semplice invito alla lettura: in quegli stessi anni, la Corona francese stava ideando il recupero di Gerusalemme e la riconquista di Bisanzio. Proprio il Valois accampava diritti sul trono di Costantinopoli (essendo sua moglie, Caterina di Courtenay, nipote ed erede di Baldovino II, l’imperatore latino d’Oriente scalzato nel 1261 da Michele Paleologo). Nella previsione d’una nuova crociata – o comunque di un’intrapresa armata – era importante apprendere tutto il necessario, tutto il possibile sulle geografie orientali: e il libro di messer Marco rispondeva esattamente a una tale esigenza. Veicolava notizie e, insieme, manifestava la disponi329
bilità dei Veneziani, dei mercanti veneziani, a collaborare coi Francesi, magari per riaprire quei canali commerciali inibiti dalla caduta di San Giovanni d’Acri e dalla fine dell’Outremer, magari per rinvigorire l’asse mediorientale e sopraffare i concorrenti genovesi. Nulla o quasi poté però concludere, fra il 1307 e il 1309, una spedizione navale francese che, sostenuta dai navigli lagunari del Minotto e del Querini, incrociò nell’Egeo riuscendo soltanto a tamponare la pirateria e a difendere i traffici di San Marco. Le speranze, stavolta, andavano deluse. E tuttavia, per Venezia, come per le altre città che vivevano di commercio internazionale, i movimenti mercantili non potevano arrestarsi: piuttosto dovevano deviare, incunearsi in pertugi differenti dal passato, insinuarsi in contesti rinnovati. Non fermarsi. Non ancora. Dei veri mercatores non si sarebbero mai dati per vinti. Genova aveva perso la base di Tripoli nel 1289, e nel 1291 i genovesi Ugolino e Vadino Vivaldi intraprendevano il primo tentativo – seppur inefficace – di circumnavigare l’Africa (o forse, addirittura, di attraversare l’Atlantico) per approdare ad partes Indiarum. Le galee del genovese Benedetto Zaccaria inaugureranno la rotta atlantica per le Fiandre, e i vascelli veneziani non tarderanno a seguirne la scia con le mude, i convogli navali organizzati e protetti dallo Stato. Rientravano in un simile fermento i trattati commerciali stipulati da Venezia col sultanato d’Egitto nel 1302, con Leone IV d’Armenia nel 1307, con l’imperatore di Trebisonda nel 1319 e con l’il-khanato di Persia nel 1320: momenti di un’inesausta vitalità mercantesca di cui Marco Polo s’era fatto pienamente interprete. Morirà nel 1324, il Veneziano, dopo aver predisposto la propria sepoltura in San Lorenzo, accanto al padre Niccolò e allo zio Matteo, nella cappella familiare di San Se330
bastiano. Per testamento rimetterà debiti, beneficherà chiese e monasteri, affrancherà Pietro, lo schiavo tartaro, e lascerà ai suoi cari una cospicua eredità. Del resto, erano quelli i tempi in cui, nella topografia cattolica dell’Ultramondano, si era ampiamente affermato il concetto di «Purgatorio» (l’intermezzo passeggero per il Paradiso): abbreviarvi la permanenza e i tormenti era possibile disponendo la celebrazione di messe di suffragio, facendo donazioni alla Chiesa e aiutando i bisognosi. Non aveva voluto sorprese, Marco Polo, per il suo ultimo viaggio. E guardando indietro dovette, forse, non dispiacersi troppo. Con la sua vita di mercante, viaggiatore, comunicatore aveva rispecchiato un mondo e un modo di agire, concepire, credere. Con la sua storia aveva rivelato all’Europa l’immensità della Cina e la molteplicità dell’Asia, squarciando la miopia dell’Occidente, esortando a guardare più in là. Coi suoi gesti, coi suoi pensieri Marco Polo aveva esaltato lo spirito mercantesco a non fermarsi mai, a non dare niente per scontato, a cercare e ricercare, ancora, sempre. Anche così, a sublimare l’esser nati uomini.
NOTA BIBLIOGRAFICA
Ma Marco Polo è andato davvero in Cina? L’inquietante dilemma dovette cominciare a circolare già nel Medioevo, se a proposito del grande viaggiatore veneziano e del Milione il domenicano Jacopo d’Acqui così scriveva nella sua Imago mundi seu Chronica: «Ha registrato meno di quanto ha visto, causa le malelingue, sempre pronte a riconoscere in altrui i bugiardi e a definire falso ciò che essi stessi sono incapaci di credere o capire. Codesto libro è chiamato del Milione sulle meraviglie del mondo. Ora in esso sono contenute notizie mirabolanti e quasi incredibili; per cui gli amici chiesero all’autore, morente, di emendare la sua opera, e togliere ogni eccesso. E la risposta fu: non ho scritto neppure la metà delle cose che ho visto». I detrattori dell’opera (e della vita) poliana non sono mai mancati, e la querelle sull’effettiva esperienza cinese del veneziano non si è mai del tutto spenta, attraversando i secoli e giungendo più o meno integra fin quasi ai nostri giorni, per riacutizzarsi o smorzarsi a seconda della temperie geostorica, dell’evoluzione delle ricerche ovvero degli interessi personali dei vari studiosi. La definizione di «questione marcopoliana», adottata in G. Bertuccioli, F. Masini, Italia e Cina, Laterza, Roma-Bari 1996, sembra esprimere efficacemente l’alternarsi di polemiche e il comporsi di schieramenti. Il dubbio, peraltro, aveva iniziato ad accendere il dibattito scientifico sin dal 1745, con la pubblicazione a Londra di A New General Collection of Voyages and Travels, una collana di viaggi meglio conosciuta come Astley’s Voyages (dal nome dell’editore). Tradotta in francese col titolo di Histoire générale des voyages (a cura dell’abate A.-F. Prévost, 15 voll., Didot, Paris 1746-1770) e in tedesco col titolo di Allgemeine Historie der Reisen (Breitkopf, 21 voll., Leipzig 1747-1774), l’opera tendeva a ridimen333
sionare i viaggi di Marco Polo, addebitandogli diverse lacune descrittive – quali la mancata menzione della Grande Muraglia – e avanzando l’ipotesi che le storie del viaggiatore fossero state in realtà confezionate per sentito dire. Un tale embrione di teoria «negazionista» dovette essere puntualmente e categoricamente ricusato in W. Robertson, An Historical Disquisition Concerning the Knowledge which the Ancients Had of India, Strahan and Cadell, London 1791 (trad. it., Ricerche storiche su l’India antica, su la cognizione che gli antichi ne avevano, e su i progressi del commercio con questo paese avanti la scoperta del passaggio pel Capo di Buona Speranza, Ferrario, Milano 1827), laddove si intese sottolineare come la narrazione di Marco Polo fosse «l’indagine più minuziosa realizzata riguardo all’Oriente fino a oggi, e la descrizione più completa offerta da un europeo». Ma il dibattimento s’era ormai avviato, e pertanto nuove critiche dovevano essere portate alla veridicità poliana in K.D. Hüllmann, Städtewesen des Mittelalters (4 voll., Marcus, Bonn 1826-1829). In seguito, però, nessuno dei grandi orientalisti dell’Otto e del primo Novecento ebbe a contestare l’autenticità della spedizione di Marco Polo nell’Impero di Mezzo (o Celeste Impero). Non ne dubitò M.G. Pauthier in Le livre de Marco Polo citoyen de Venise, 2 voll., Didot, Paris 1865, né H. Yule in The Book of Ser Marco Polo, the Venetian, Murray, London 1871 (edizione integrata successivamente e a più riprese da H. Cordier, fino a Ser Marco Polo: Notes and Addenda to Sir Henry Yule’s Edition, Containing the Results of Recent Research and Discovery, Murray, London 1920). Non ci fu spazio per lo scetticismo in A.C. Moule e P. Pelliot nella loro edizione del testo poliano, The Description of the World, 2 voll., Routledge, London 1938, e tanto meno in P. Pelliot, Notes on Marco Polo, in Oeuvres posthumes de Paul Pelliot, vol. I, a cura di L. Hambis, Imprimerie National, Paris 1959. E non esitò ad avallare la genuinità del viaggio poliano L. Hambis in La description du monde, Klincksieck, Paris 1955 (edizione aggiornata Le devisement du monde, introduzione e note di S. Yérasimos, Maspero, Paris 1980). Sulla medesima linea tesero a porsi pure un grande geografo e geologo quale Giotto Dainelli con La conquista della Terra, Utet, Torino 1950, e il filologo romanzo Leonardo Olschki (già artefice di una Storia letteraria delle scoperte geografiche, Olschki, Firenze 1937), che in L’Asia di Marco Polo, Sansoni, Roma 1957, condensò il ciclo di lezioni tenute presso la Fondazione «Giorgio Cini» di Venezia e nella vecchia sede dell’Ismeo 334
(Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente) di palazzo Brancaccio a Roma. Lo stesso istituto romano s’era reso promotore nel 1954, su impulso del presidente Giuseppe Tucci, di una serie di conferenze atte a celebrare il settecentenario della nascita di Marco Polo, con l’intervento di insigni specialisti quali lo storico dell’arte medievale Rudolf Wittkower, il mongolista Antoine Mostaert, l’iranista Bertold Spuler, l’indologo Kallidaikurichi A. Nilakanta Sastri, lo stesso Leonardo Olschki e i sinologi Paul Demiéville, Étienne Balázs, Kazuo Enoki, L. Carrington Goodrich, Erich Haenisch, Louis Hambis ed Edward H. Schafer. Le relazioni dovettero confluire nel volume Oriente Poliano. Studi e conferenze dell’Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente in occasione del VII centenario della nascita di Marco Polo, 1254-1954, Ismeo, Roma 1957, che in qualche modo faceva il paio con i contributi elaborati a cura di R. Almagià in Nel VII centenario della nascita di Marco Polo, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, Venezia 1955. In entrambi i casi, la sincerità della vicenda cinese di Marco Polo veniva data per scontata. E una simile impostazione non mutava nella raccolta degli Atti del Convegno internazionale di studi cinesi tenuto alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia nel 1973, intitolata Sviluppi scientifici. Prospettive religiose. Movimenti rivoluzionari in Cina, a cura di L. Lanciotti, Olschki, Firenze 1975 (in cui Alessandro Bausani e Luciano Petech vollero lasciare degli ineguagliabili interventi). Più avanti si è levata invece qualche voce discordante. Un esperto tedesco di studi mongoli, Herbert Franke, nell’articolo Sino-Western Contacts under the Mongol Empire, in «Journal of the Hong Kong Branch of Royal Asiatic Society», 6, 1966, pp. 49-72 (ripubblicato nel volume da lui curato China under Mongol Rule, Variorum, Aldershot 1994), ha suggerito che Marco Polo dovesse improntare le sue narrazioni a un’enciclopedia araba perduta, manifestando perplessità sul viaggio poliano in Estremo Oriente. Ancor più netto è stato il giudizio espresso da Frances Wood, direttrice del Chinese Department of The British Library, e autrice del volumetto Did Marco Polo Go to China?, Secker & Warburg, London 1995 (che faceva seguito ad articoli di tenore affine apparsi in «The Times» e in «The Sunday Times», con un’eco irraggiatasi al grande pubblico anche attraverso le pagine del «Courrier international»). A dire della Wood, la prova dell’impostura di Marco Polo risiederebbe nel fatto che egli avrebbe ignorato alcune specificità della Cina, come la Grande Muraglia, la consuetudine di avvolgere fasce strette ai piedi del335
le bambine per non farli crescere, e l’uso del tè. Inoltre, negli Annali e negli archivi cinesi non esisterebbe traccia alcuna dei Polo, né in funzione di inviati di Kubilai nelle province dell’impero yuan, né come accompagnatori ufficiali della principessa Kokacin presso l’il-khan di Persia. Per di più, la cronaca poliana riferirebbe della partecipazione di Marco, Niccolò e Matteo alla presa di Xiangyang nel 1273, quando i tre non erano ancora arrivati dal gran khan e, dunque, non avrebbero mai potuto esser stati delegati all’assedio della città. La sinologa ritiene credibili solo il primo viaggio di Niccolò e Matteo Polo attraverso l’Asia centrale, il loro arrivo forse nei pressi di Karakorum, e il rientro in Laguna accompagnati dalle tavolette d’oro di uno dei capi mongoli incontrati strada facendo. La partecipazione di Marco al secondo viaggio risulterebbe inverosimile. Sicché, a parere di Wood, il giovane mercante veneziano non sarebbe mai andato al di là degli empori commerciali di famiglia, a Costantinopoli e sul Mar Nero. Ciononostante, la studiosa asserisce che Marco Polo potrebbe aver utilizzato ottime fonti (d’ambito mercantile o di tradizione scritta, persiana e non solo) per compilare una buona descrizione della Cina e dell’Oriente, soprattutto di quello più prossimo al Mediterraneo. Alla marcata diffidenza woodiana si è immediatamente addizionato il ponderoso lavoro di Dietmar Henze, Enzyklopädie der Entdecker und Erforscher der Erde, Akadem. Druck- u. Verlagsanst., Graz 1975-2004, teso nel quarto volume (1995-2000) a disprezzare costantemente le testimonianze di Marco Polo. Come se non bastasse, a soffiare ulteriormente sul polverone delle diatribe sarebbe sopravvenuto un libro a cura di David Selbourne (autore inglese di opere di filosofia politica), The City of Light, Little, Brown, London 1997. L’opera tratta del presunto viaggio del mercante ebreo Giacobbe d’Ancona, che avrebbe raggiunto le coste cinesi e la «luminosa città» di Quanzhou (stupendamente rischiarata pure di notte) qualche anno prima dei Polo. Il commerciante anconetano sarebbe poi tornato in Adriatico nel 1273, recando seco tessuti in seta e cotone, pepe, zenzero, cannella, noce moscata, zafferano, rabarbaro, chiodi di garofano, mirabolano, nardo, galanga, muschio, balsamo, incenso, mirra, storace, indaco, legno di sandalo, ambra, perle, corallo e, insieme, oro e gioiellerie da donare alla moglie Sara. Tale e tanta mercanzia sarebbe stata accumulata comprando e vendendo, lungo il tragitto che, oltre al336
la Cina, avrebbe portato Giacobbe a toccare l’Indonesia, l’India, Sri Lanka, il Golfo Persico e il Mar Rosso. Evidentemente, la vicenda era un po’ troppo simile alle peripezie poliane. E comunque, a detta di Selbourne, il libro su Giacobbe d’Ancona sarebbe la traduzione d’un manoscritto in italiano dialettale (zeppo di termini arabi, ebraici e latini), datato al XIII-XIV secolo e conservato per lunghissimo tempo negli archivi familiari di un personaggio che, in cambio della pubblicazione, avrebbe imposto di restare anonimo per questioni connesse ai rapporti fra la Chiesa di Roma e l’ebraismo. A parte le descrizioni della rete commerciale duecentesca e delle località asiatiche, e insieme alle disquisizioni filosofico-religiose che mettono a confronto giudaismo, confucianesimo e cristianesimo, in diversi passaggi del testo i toni in effetti si inaspriscono e si fanno duri, allorché si parla delle persecuzioni e delle vessazioni patite dai giudei per mano dei cattolici. Da qui sarebbe derivata la decisione di tenere nascosto il documento per tanti secoli, in una regione, come le Marche, appartenente a un paese, come l’Italia, profondamente cattolico. Prevedibilmente, una pletora di storici e orientalisti si è scagliata contro Selbourne, accusandolo di aver confezionato a tutti gli effetti un falso. Parimenti, la gran parte della più accreditata critica occidentale si è opposta, talvolta con crudezza, al «negazionismo» di Frances Wood. Fra gli interventi scientifici che hanno inteso sottolineare la genuinità della storia di Marco Polo, smontando pezzo per pezzo e ribaltando le teorie (invero deboli) della sinologa, vanno citati almeno Igor de Rachewiltz (Università di Canberra), Marco Polo Went to China, in «Zentralasiatische Studien», vol. 27, 1997, pp. 34-92; Ugo Tucci (professore emerito a Venezia), Marco Polo: andò veramente in Cina?, in «Studi Veneziani», Nuova Serie, t. 33, 1997, pp. 49-59; e Lionello Lanciotti, Marco Polo e la sinologia occidentale, in Marco Polo. 750 anni. Il viaggio. Il libro. Il diritto, Atti del congresso internazionale (Roma-Venezia, 23-25 novembre 2004), a cura di Federico Masini, Franco Salvatori, Sandro Schipani, Tiellemedia, Roma 2006, pp. 269-274. A loro si è associato un grande studioso poliano quale Philippe Ménard (Università di ParigiSorbonne Paris IV), che in più occasioni è intervenuto a sottolineare come le occorrenze geopolitiche espresse in Marco Polo siano troppo peculiari per risultare menzognere. Nei racconti poliani c’è insomma molto di vero e soltanto alcune approssimazioni che, però, non scalfiscono, 337
a giudizio del cattedratico di Francia, l’assoluta autenticità delle vicende cinesi. Nemmeno è ipotizzabile, secondo Ménard, che il viaggiatore veneziano sia potuto ricorrere alle guide turistiche in persiano supposte da Franke, poiché un siffatto materiale, a tutt’oggi, risulta inesistente. A sostegno dell’attendibilità del viaggio di Marco Polo in Estremo Oriente si sono schierati eruditi non solo occidentali, ma anche cinesi, nel solco di ricerche che, avendo preso corpo nel XIX secolo, sono state compendiate in una storia degli studi da Yu Shixiong, Make Boluo jieshao yu yanjiu (Relazioni e ricerche su Marco Polo), Beijing 1983, e aggiornate in Gu Weimin, Le ricerche su Marco Polo in Cina, dal 1874 al 1995, in Marco Polo. 750 anni cit., pp. 317–348. In siffatto contesto vanno comprese pure le appassionate analisi di Yang Zhijiu, strenuo difensore poliano, che dal 1941 ai nostri giorni ha offerto un apporto decisivo agli approfondimenti su Marco Polo e la sua opera (come è anche sintetizzato in Zhang Xiping, Il Milione e le ricerche sulla storia del cristianesimo in Cina, in Marco Polo. 750 anni cit., pp. 305-316). Proprio in risposta a Wood, Yang Zhijiu ha scritto Make Boluo zai Zhongguo (Marco Polo in Cina), in «Nankai daxue chubanshe», 1999, dopo che già in precedenza aveva integrato le notazioni di F.W. Cleaves (A Chinese Source Bearing on Marco Polo’s Departure and a Persian Source on His Arrival in Persia, in «Harvard Journal of Asiatic Studies», vol. 36, 1976, pp. 181-203) con il suo Guanyu Make Boluo de yanjiu. Du Kelifu jiaoshou «Guanyu Make Boluo li Hua de anwen ziliao jiqi daoda Bosi de Bosiwen ziliao», in «Nankai daxue xuebao», n. 3, 1979. Ancora nelle Biografie dei protagonisti della storia del cattolicesimo in Cina (Zhongguo tianzhujiaoshi renwuzhan, Xianggang gongjiao zhenlihui, Taizhong guagqi chubanshe, 1970) Fang Hao ha incluso la biografia di Marco Polo, tornando successivamente a trattare del mercante di Venezia e asseverandone l’arrivo in Cina in Zhongxi jiaotong shi (Storia dei rapporti fra la Cina e l’Occidente), in «Hua wang chubanshe», Taiwan 1977. Nuovamente nel 1991, in occasione del convegno indetto per celebrare i settecento anni dalla partenza di Marco Polo dalla Cina per fare ritorno a Venezia, Ma Wenkuan e Li Lanqin hanno elaborato una relazione intitolata Zhongxi wenhua jiaoliu xianqu – Make Boluo (Prime indagini sulle informazioni relative al Cristianesimo in Cina contenute nel Milione), Shangwu yinshuguan, 1995, in cui, grazie a studi comparatistici, si sancisce l’assoluta attendibilità delle informazioni raccolte in pri338
ma persona e presentate dal viaggiatore veneziano. Più recentemente anche Wei Jian, La civiltà sulle rovine. Shangdu di epoca Yuan, in I Mongoli dal Pacifico al Mediterraneo, a cura di G. Airaldi, P. Mortari Vergara Caffarelli, L. Emilia Parodi, Atti del convegno internazionale (Genova, Palazzo Doria Spinola, 7-8 maggio 2002), Ecig, Genova 2004, fa esplicito riferimento alla venuta di Marco Polo in Cina e alla sua ammissione alla corte dell’imperatore Kubilai. In traduzione italiana è vieppiù fruibile un saggio di Li Tse-fen, Un articolo d’autore cinese su Marco Polo e la Cina, in «Annali dell’Istituto Orientale di Napoli», 1 (30), 1982. In nessuno di questi studi cinesi (che peraltro costituiscono soltanto una fetta d’una debordante e molto raffinata quantità di saggi) la presenza poliana a Pechino e nel Levante è stata mai messa in discussione, in linea con una storiografia che, a livello internazionale, è ormai in gran parte concorde nel considerare veritiero il viaggio orientale di Marco Polo. Certo, non manca qualche distinguo: John W. Haeger, Marco Polo in China? Problems with Internal Evidence, in «Bulletin of Sung and Yuan Studies», 14, 1978, pp. 22-30 (ripreso in J. Larner, Marco Polo and the Discovery of the World, Yale University Press, New Haven-London 1999), ritiene che le conoscenze cinesi di Marco Polo dovessero essere limitate in prevalenza alle sedi della corte imperiale di Kubilai Khan, e dunque alle città di Kaiping/Shangdu e Dadu/Khanbalik (Pechino), nella Cina settentrionale. Ma anche in questo caso, le tesi che ridimensionerebbero l’entità degli spostamenti poliani sono state efficacemente confutate sia dalla critica cinese (di nuovo con una serie di articoli firmati dall’autorevole Yang Zhijiu) sia da quella occidentale. Inoltre Alessandro Grossato, Navigatori e viaggiatori veneti sulla rotta per l’India. Da Marco Polo ad Angelo Legrenzi, Olschki, Firenze 1994, esita a dare per sicuro il fatto che Marco Polo si fosse recato in India anche prima del viaggio di ritorno verso il Golfo Persico. Ma al di là delle sfumature, le iniziative cantierizzate dal Comitato nazionale per le celebrazioni del 750° anniversario della nascita di Marco Polo, con convegni a tema o con volumi come Verso l’altro e l’altrove. La geografia di Marco Polo, oggi, a cura di G. De Vecchis, Carocci, Roma 2005, sono indirizzate a documentare decisamente, e senza più troppe esitazioni, l’effettività dei viaggi poliani in Cina. Nonostante gli scossoni subiti nel tempo, dunque, la credibilità di messer Marco rimane solida, corroborando anche con le più recenti acquisizioni un’antica tradizione che intreccia storia e letteratura. Al riguardo, la se339
quela di titoli proponibili è praticamente sterminata. Non potendoli citare tutti quanti se ne propone in questa sede una selezione parziale, che mira a porgere al lettore indicazioni di massima per eventuali, singoli approfondimenti delle tematiche prospettate. Fra le opere più tradizionali vanno almeno richiamate, di Paul Pelliot, Les Mongols et la papauté, Picard, Paris 1923-1931 (suddivisa in tre parti e uscita inizialmente sotto forma di articoli per la rivista «Revue de l’Orient chrétien», con l’esegesi di numerosi documenti orientali dei secoli XIII e XIV); l’Histoire Secrète des Mongols. Restitution du texte mongol et traduction française des chapitres I à VI, Maisonneuve, Paris 1949; Notes sur l’histoire de la Horde d’Or, Maisonneuve, Paris 1950; e Recherches sur le Chrétiens d’Asie centrale et d’Extrême-Orient, Imprimerie National, Paris 1973. Importanti sono i lavori di René Grousset, artefice di una Histoire de l’ExtrêmeOrient, 2 voll., Geuthner, Paris 1929, nonché autore di L’Empire des steppes. Attila, Gengis-Khan, Tamerlan, Payot, Paris 1939, di L’Empire Mongol: 1ère phase, de Boccard, Paris 1941, e di Le conquérant du Monde. Vie de GengisKhan, Michel, Paris 1944. Circa la visione dell’ecumene e, in particolare, dell’Oriente da parte della società medievale euromediterranea (anche in relazione agli apparati cartografici), si possono utilizzare R. Wittkower, Marvels of the East: A Study in the History of Monsters, in «Journal of the Warburg and Courtauld Intitutes», 5, 1942, pp. 159-197; J.B. Friedman, The Monstrous Races in Medieval Art and Thought, Harvard University Press, Cambridge, Mass.-London 1981; R.A. Skelton, Marco Polo and the Map Makers. The European Discovery of the Far East, XIII to XVI century, in Explorer’s Maps, Chapters in the Cartographic Record of Geographical Discovery, Routledge and Kegan, London 1958 (nuova ed. Feltham, Spring Books, London, New York, Sydney-Toronto 1970); J. Le Goff, L’Occident médiévale et l’océane indien: un horizon onirique, in Id., Pour un autre Moyen Âge, Gallimard, Paris 1977, pp. 280-293; e Il meraviglioso nell’Occidente medievale, in Il meraviglioso e il quotidiano nell’Occidente medievale, Laterza, Roma-Bari 20075, pp. 3-23; M. Jancey, Mappa Mundi. The Map of the World in Hereford Cathedral, The Friends of Hereford Cathedral Publications Committee, Hereford 1987; D. Woodward, Medieval Mappae Mundi, in The History of Cartography. vol. I: Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean, a cura di J.B. Harley e D. Woodward, University of Chicago Press, Chicago-London 1987; C. Indicopleustès, Topographie chrétienne, a cura di W. 340
Wolska-Conus, vol. II, Éditions du Cerf, Paris 1970; G. Tardiola, Atlante fantastico del Medioevo, De Rubeis, Anzio 1990; P. Janni, F. Prontera, I geografi e le conoscenze geografiche sul Mondo antico, in Cristoforo Colombo e l’apertura degli spazi. Due mondi a confronto, 1492-1728, Catalogo della Mostra storico-cartografica (Genova, Palazzo Ducale, 1992), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1992; F. Cardini, Oriente e Occidente prima di Colombo. Dell’ignoto Mondo: la realtà e la fantasia, in «Messaggero Veneto», 1920 gennaio 1992; M. Milanesi, Terrae incognitae, in Hic sunt leones. Geografia fantastica e viaggi straordinari, a cura di O. Calabrese, R. Giovannoli e I. Pezzini, Electa, Milano 1983; R. Rubinacci, La Cina nella geografia di AlIdrisi, in «Orientalia Iosephi Tucci Memoriae dicata», a cura di G. Gnoli e L. Lanciotti, vol. III, 1988; A. Graf, Miti, leggende e superstizioni del Medioevo (1892-1893), Tesi, Pordenone 1993; P. Barber, Mito, religione e conoscenza: la mappa del mondo medievale, in Segni e sogni della Terra. Il disegno del mondo dal mito di Atlante alla geografia delle reti, Catalogo della Mostra (Milano, Palazzo Reale, 2001), De Agostini, Novara 2001; L. Lago, Le conoscenze sul ciclo dell’acqua nell’Antichità classica e nell’Evo Medio, Lint, Trieste 1983 e Id., Congetture ed esperienze nell’«imago mundi». Il contributo di derivazione poliana, in Marco Polo. 750 anni cit., pp. 221-265; L. Lago, G. Galliano, La Terra Santa e la sua immagine nella cartografia antica, Alinari, Firenze 1995; e P. Zumthor, La mesure du monde: représentation de l’espace au Moyen Âge, Seuil, Paris 1993 (trad. it., La misura del mondo. La rappresentazione dello spazio nel Medioevo, il Mulino, Bologna 1995). Sul Prete Gianni e il Re Davide, sul Romanzo di Alessandro Magno, sull’invasione mongola dell’Europa, sul timor Tartarorum e sui riflessi psicologici destati dall’attesa della fine del mondo sono consultabili F. Babinger, Maestro Ruggero delle Puglie relatore pre-poliano sui Tartari, in Nel VII centenario cit., pp. 114-124; J. Richard, L’Extrême Orient légendaire au Moyen Âge: Roi David et Pretre Jean, in «Annales d’Ethiopie», II, 1957, pp. 225244 e Id., Les causes des victoires mongoles d’après les historiens occidentaux du XIIIe siècle, in Croisés, missionaires et voyageurs, Variorum Reprints, London 1983; V. Slessarev, Prester John. The Letter and the Legend, University of Minnesota Press, Minneapolis 1959; D.J.A. Ross, Alexander Historiatus: A Guide to Medieval Illustrated Alexander Literature, Warburg Institute, University of London, London 1963; G. Cary, The Medieval Alexander, a cura di D.J.A. Ross, Cambridge University Press, Cambridge 1956; D. Bigalli, I Tartari e l’Apocalisse, La Nuova Italia, Firenze 1971; I. de Rachewiltz, Pre341
ster John and Europe’s Discovery of East Asia, Australian National University Press, Canberra 1972; G. A. Bezzola, Die Mongolen in abendländischer Sicht (1220-1270), Francke, Bern 1974; S.L. Tikhvinskij (a cura di), TataroMongoly v Azii i Evrope (I Tataro-Mongoli in Asia e in Europa), Nauka, Moskva 1970, 19762; C. Frugoni, La fortuna di Alessandro Magno dall’antichità al Medioevo, La Nuova Italia, Firenze 1978; J. Chambers, The Devil’s Horsemen: The Mongol Invasion of Europe, Weidenfeld and Nicolson, London 1979; Storia della Bulgaria, Bulzoni, Roma 1982; R. Manselli, I popoli immaginari: Gog e Magog, in Popoli e paesi della cultura altomedievale, Atti della XXIX Settimana di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (23-29 aprile 1981), tomo II, Spoleto 1983; L. Petech, Introduzione, in Giovanni da Pian del Carpine, Storia dei Mongoli, a cura di P. Daffinà, C. Leonardi, M.C. Lungarotti, E. Menestò e L. Petech, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 1989; J. Pirenne, La Légende du «Prêtre Jean», Presses universitaires de Strasbourg, Strasbourg 1992; Pianto sulla distruzione di Rjazan’, a cura di E.T. Saronne, Pratiche, Parma 1992; F. Cardini, La stella e i Re, Edifir, Firenze 1993; D. Morgan, Prester John and the Mongols, in C.F. Beckingham, B. Hamilton, Prester John, The Mongols and the Ten Lost Tribes, Variorum, Aldershot 1996; A.A. Vasiliev, Prester John and Russia, in Prester John and the Mongols cit.; Z.J. Kosztolnyik, Hungary in the Thirteenth Century, Columbia University Press, New York 1996; N. Assatiani, A. Bendianachvili, Histoire de la Géorgie, Montreal, Paris 1997; O. Pachlovska, Civiltà letteraria ucraina, Carocci, Roma 1998; La lettera del Prete Gianni, a cura di G. Zaganelli, Luni, Milano-Trento 2000; A. Silva, L’invasione mongola dell’Europa: reazioni e conseguenze, in I Mongoli dal Pacifico cit., pp. 227-239. La presenza mongola in Occidente, con particolare riferimento alla Russia e all’Orda d’Oro, è analizzata in G. Vernadsky, The Mongols and Russia, Yale University Press, New Haven 1953; B. Spuler, Die Goldene Horde. Die Mongolen in Russland, 1223-1502, Harrassowitz, Wiesbaden 1965; C.J. Halperlin, Russia in the Mongol Empire in Comparative Perspective, in «Harvard Journal of Asiatic Studies», 43, 1983, pp. 239-261; e J.L.I. Fennell, The Crisis of Medieval Russia 1200-1304, Longman, London-New York 1983. Più in generale sui Mongoli si vedano J.J. Saunders, The History of the Mongol Conquests, Routledge & Kegan, London 1971; J.A. Boyle, The Mongol World Empire 1206-1370, Variorum Reprints, London 1977; J.-P. 342
Roux, Histoire de l’empire mongol, Fayard, Paris 1993; D. Morgan, The Mongols, Blackwell, Oxford-New York 1986; e C.P. Atwood, Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire, Facts on File, New York 2004. Sul confronto fra universo mongolo e universo europeo si concentrano alcuni fra i saggi proposti in 1274 Année Charnière: Mutations et Continuités, Actes du Colloque International (Lyon-Paris, 30 septembre-5 octobre 1974), Centre national de la recherche scientifique, Paris 1977, fra cui si segnalano D. Sinor, Le Mongol vu par l’Occident, e J. Richard, Les Mongols et l’Occident: deux siècles de contacts. Nel medesimo contesto compaiono B. Spuler, Le christianisme chez les Mongols aux XIIIe et XIVe siècles, e A.D. von den Brincken, Le nestorianisme vu par l’Occident, che si soffermano su questioni più propriamente religiose e possono idealmente introdurre a P. Mortari Vergara Caffarelli, Monumenti nestoriani dal Mediterraneo alla Mongolia, in I Mongoli dal Pacifico al Mediterraneo cit., pp. 11-28. Da non trascurare è J. Fiey, Chrétiens syriaques sous les Mongols (Il-Khanat de Perse, XIIIe-XIVe siècles), in «Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium», 362, Subsidia, 44, 1975. Gli itinerari dei missionari e le ambasciate intercorse nel Duecento fra l’impero mongolo da un lato e i potentati europei (compreso il papato) dall’altro sono studiati da varie prospettive in Ch. Dawson, The Mongol Mission. Narratives and Letters of the Franciscan Missionaries in Mongolia and China in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, Sheed and Ward, New York 1955; J.-P. Roux, Les explorateurs au Moyen Âge, Seuil, Paris 1961 (trad. it., Gli esploratori nel Medioevo, Garzanti, Milano 1990); P. Chaunu, L’expansion européenne du XIIIe au XVe siècle, Puf, Paris 1969 (trad. it., L’espansione europea dal XIII al XV secolo, Mursia, Milano 1979); I. de Rachewiltz, Papal Envoys to the Great Khans, Faber and Faber, London 1971; J. Richard, Orient et Occident au Moyen Âge: contacts et relations (XIIe-XVe siècles), Variorum Reprints, London 1976, e Les relations entre l’Orient et l’Occident du Moyen Âge, Variorum Reprints, London 1977; D. Sinor, Un voyageur du XIIIe siècle: le Dominicain Julien d’Hongrie, in Id., Inner Asia and his Contacts with Medieval Europe, Variorum Reprints, London 1977; L. Petech, I Francescani nell’Asia centrale e orientale nel XIII e XIV secolo, in Società internazionale di studi francescani, Espansione del francescanesimo tra Occidente e Oriente nel secolo XIII, Atti del VI Convegno internazionale (Assisi 12-14 ottobre 1978), La Società, Assisi 1979, pp. 213-240; M. Mollat, Les explorateurs du XIIIe au XVIe siècle. Premiers regards sur des mondes nouveaux, Lattès, Paris 1984. Imperdibile è J. Richard, La papauté et les missions d’Orient au 343
Moyen Âge (XIII-XV siècles), nuova ed., Ecole Française de Rome, Paris 1998, da cui si può rimbalzare a Simon de Saint-Quentin, Histoire des Tartares, a cura di J. Richard, Geuthner, Paris 1965, al già segnalato Giovanni da Pian del Carpine, Storia dei Mongoli cit., e a Guglielmo di Rubruck, Viaggio nell’Impero dei Mongoli, a cura di L. Dalledonne, con introduzione di G.L. Potestà, Marietti, Genova-Milano 2002. Da leggere è pure P.G. Borbone, Storia di Mar Yahballaha e di Rabban Sauma, un Orientale in Occidente ai tempi di Marco Polo, Silvio Zamorani, Torino 2000, mentre intramontabile è da considerarsi G. Soranzo, Il papato, l’Europa cristiana e i Tartari, Vita e Pensiero, Milano 1930. Un ennesimo contributo di L. Hambis è Saint Louis et les Mongols, in «Journal asiatique», 258, 1-2, 1970, pp. 25-34. Assai completi risultano i testi proposti da J. Gil in En demanda del Gran Kan. Viajes a Mongolia en el siglo XIII, Alianza Editorial, Madrid 1993, e in La India y el Catay. Textos de la Antigüedad clásica y el Medievo occidental, Alianza Editorial, Madrid 1995. L’espansione commerciale e la figura del mercante nel Medioevo trovano di volta in volta un’ampia trattazione o spunti di notevole interesse in I. Renouard, Les hommes d’affaires italiens du Moyen Âge, Colin, Paris 1949 (trad. it., Gli uomini d’affari italiani del Medioevo, Rizzoli, Milano 1973); A. Sapori, Le marchand italien au Moyen Âge, Colin, Paris 1952 (trad. it., Il mercante italiano nel Medioevo, Jaca Book, Milano 1983); E.M. Carus-Wilson, Medieval Merchant Venturers, Methuen, London 1954; G. Luzzatto, Il mercante veneziano, in Nel VII centenario cit., pp. 120-125; L. Petech, Les marchands italiens dans l’Empire mongol, in «Journal asiatique», 250, 1962, pp. 549-574; E. Maschke, La mentalité des marchands européens au Moyen Âge, in «Revue d’histoire économique et sociale», vol. XLII, n. 4, 1964, pp. 457-484; Città, mercanti, dottrine nell’economia europea dal IV al XVIII secolo. Saggi in memoria di Gino Luzzatto, Giuffrè, Milano 1964; C. Bec, Les marchands écrivains. Affaires et humanisme à Florence, 1375-1434, Mouton & Co., Paris-La Haye 1967; G. Fourquin, Histoire economique de l’Occident medieval, Colin, Paris 1969 (trad. it., Storia economica dell’Occidente medievale, il Mulino, Bologna 1987); M.M. Postan, Medieval Trade and Finance, Cambridge University Press, Cambridge 1973; R. Lopez, The Commercial Revolution of the Middle Ages, 950-1350, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1971 (trad. it., La rivoluzione commerciale del Medioevo, Einaudi, Torino 1975); G. Duby, Guerriers et paysans, VII-XIIe siècle: premier essor de l’économie européenne, Gallimard, Paris 1973 (trad. it., Le origini dell’econo344
mia europea. Guerrieri e contadini nel Medioevo, Laterza, Roma-Bari 1978), in cui si indaga il concetto di mercator-peccator; U. Tucci, Il commercio veneziano e l’Oriente al tempo di Marco Polo, in Marco Polo. Venezia e l’Oriente, a cura di A. Zorzi, Electa, Milano 1981, pp. 41-68; A. Ashtor, Levant Trade in the Later Middle Ages, Princeton University Press, Princeton 1983, e East-West Trade in the Medieval Mediterranean, a cura di B.Z. Kedar, Variorum Reprints, London 1986; B.Z. Kedar, Merchants in Crisis: Genoese and Venetian Men of Affairs and the Fourteenth-Century Depression, New Haven, London 1976 (trad. it., Mercanti in crisi a Genova e Venezia nel ’300, Jouvence, Roma 1981); Mercanti scrittori. Ricordi nella Firenze tra Medioevo e Rinascimento, a cura di V. Branca, Rusconi, Milano 1986; A.Ja. Gurevicˇ, Il mercante, in J. Le Goff (a cura di), L’uomo medievale, Laterza, Roma-Bari 1987, 200619; R. Delort, La vie au Moyen Âge, Seuil, Paris 1982 (trad. it., La vita quotidiana nel Medioevo, Laterza, Roma-Bari 1989, 20066; in particolare il cap. VI: Il mondo cittadino: mercanti, artigiani e borghesi); R.H. Bautier, Commerce méditerranéen et banquiers italiens au Moyen Âge, Variorum, Aldershot 1992; G. Airaldi, Guerrieri e mercanti. Storie del medioevo genovese, Aragno, Torino 2004; e Zhang Kai, Marco Polo e «l’epoca dell’asse Quanzhou-Venezia». Indagine sul rapporto tra il commercio d’oltremare in epoca song e yuan e la rivoluzione commerciale del Mediterraneo, in Marco Polo. 750 anni cit., pp. 275-303. A proposito dell’attività e della psicologia mercantesca si vedano, inoltre, di J. Le Goff, Marchands et banquiers du Moyen Âge, Puf, Paris 1956 (trad. it., Mercanti e banchieri nel Medioevo, D’Anna, Messina-Firenze 1976); The Usurer and Purgatory, in The Dawn of Modern Banking, Yale University Press, New Haven-London 1979, pp. 25-52; e il celebre La bourse et la vie, Hachette, Paris 1986 (trad. it., La borsa o la vita. Dall’usuraio al banchiere, Laterza, Roma-Bari 1988, 20072). Validissimi per una definizione del ruolo e della mentalità mercantile appaiono anche i saggi raccolti da Gabriella Airaldi in Gli orizzonti aperti: profili del mercante medievale, Scriptorium, Torino 1997, con contributi, oltre che della curatrice, di J. Le Goff, R.S. Lopez, E. Ashtor, A.L. Udovitch, N. Oikonomides, A. Sapori, D. Abulafia e J. Heers. Non si può poi prescindere da M. Tangheroni, Commercio e navigazione nel Medioevo, Laterza, Roma-Bari 1996, un’esposizione davvero di ampio respiro e irrinunciabile per chi intenda possedere un quadro d’assieme sulle dinamiche inerenti ai commerci medievali. Un profilo storico intelligente si distingue in G. Dainelli, Missionari e mercadanti rivelatori dell’Asia nel Medio Evo, Utet, Torino 1960. I testi dei viaggiatori che pre345
cedettero Marco Polo, come Giovanni da Pian del Carpine e Guglielmo di Rubruck, sono stati tradotti e commentati anche da Albert T’Serstevens in Les précurseurs de Marco Polo, Arthaud, Paris 1959 (trad. it., I precursori di Marco Polo, a cura di Roberto Ortolani, Garzanti, Milano 1960). Bisogna invece richiamare necessariamente E. Crouzet-Pavan, Venise triomphante. Les horizons d’un mythe, Michel, Paris 1999 (trad. it., Venezia trionfante. Gli orizzonti di un mito, Einaudi, Torino 2001), per la determinazione di un quadro aggiornato e ragionato della storia di Venezia, dalla nascita della città fino all’espansione commerciale sul Mediterraneo e verso il Levante. In quest’ottica – e non potendosi qui riportare l’intera, estesissima bibliografia concernente la Repubblica marciana – sono consultabili, oltre ai primi quattro volumi della Storia di Venezia, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1992-1997, anche G. Luzzatto, Storia economica di Venezia dall’XI al XVI secolo, Centro Internazionale delle Arti e del Costume, Venezia 1961; F.C. Lane, Venice. A Maritime Republic, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1973 (trad. it., Storia di Venezia, Einaudi, Torino 1978); R. Cessi, Venezia nel Duecento: tra Oriente e Occidente, Deputazione, Venezia 1985; G. Cracco, Un «altro mondo»: Venezia nel Medioevo dal secolo XI al secolo XIV, Utet, Torino 1986; e G. Ortalli, G. Scarabello, Breve storia di Venezia, Pacini, Pisa 1990. Per un approccio immediato ai rapporti fra Venezia e Costantinopoli, puntuale si rivela G. Ravegnani, Bisanzio e Venezia, il Mulino, Bologna 2006 (cui si rimanda per ulteriori tracce bibliografiche), al quale può essere annesso S. Borsari, Venezia e Bisanzio nel XII secolo. I rapporti economici, Deputazione, Venezia 1988. In proposito, oltre all’inquadramento storico sviluppato in G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, Beck, München 1940 (trad. it., Storia dell’impero bizantino, Einaudi, Torino 1968), dirimenti per specifiche analisi sono anche A. Carile, Per una storia dell’impero latino di Costantinopoli (1204-1261), Patron, Bologna 19782; D.E. Queller, The Fourth Crusade. The Conquest of Costantinople 1201-1204, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1997; Ch. Maltezou, I Greci tra Veneziani e Genovesi (XIII sec.), in Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV, Atti del Convegno internazionale di studi (Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000), a cura di G. Ortalli e D. Puncuh, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, Venezia 2001, pp. 189-199; T.F. Madden, Enrico Dandolo and the Rise of Venice, Johns Hopkins University 346
Press, Baltimore-London 2003. Si deve inoltre a M. Balard La mer Noire et la Romanie génoise aux XIII-XV siècles, Variorum Reprints, London 1989. Sulla famiglia Polo resta fondamentale G. Orlandini, Marco Polo e la sua famiglia, in «Archivio storico tridentino», IX, 1926, pp. 1-68, cui si possono unire due studi di R. Gallo, rispettivamente Marco Polo, la sua famiglia e il suo libro, in Nel VII centenario cit., pp. 126-161, e Nuovi documenti riguardanti Marco Polo e la sua famiglia, in «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, Classe di Scienze Morali e Lettere», t. CXVI, 1958, pp. 309-325. Tutta la «venezianità» marcopoliana emerge dagli studi di Alvise Zorzi, come Marco Polo e la Venezia del suo tempo, in Marco Polo. Venezia e l’Oriente cit., pp. 13-40, e la vivace Vita di Marco Polo veneziano, Rusconi, Milano 1982. Un profilo di Marco Polo si ritrova pure in M. Collis, Marco Polo, Faber and Faber, London 1959; in J. Heers, Marco Polo, Fayard, Paris 1983; e in U. Tucci, Marco Polo, mercante, in Venezia e l’Oriente, a cura di L. Lanciotti, Olschki, Firenze 1987, pp. 323-337. Utile pure M. Münkler, Marco Polo. Vita e leggende, Vita e Pensiero, Milano 2001. Su Gengis Khan e gli esiti del suo impero, insieme ai succitati lavori di Morgan, si può rimandare a V. Bianchi, Gengis Khan. Il principe dei nomadi, Laterza, Roma-Bari 2005, e alla relativa nota bibliografica. Per gli scambi commerciali e gli itinerari medievali fra il Ponente e il Levante efficace è L. Boulnois, La Route de la Soie, Éditions Olizane, Genève 1992 (trad. it., La via della seta. Dèi guerrieri, mercanti, Bompiani, Milano 2005). Attinente all’argomento è J. P. Drège, Marco Polo e la via della seta [Marco Polo et la Route de la Soie], Electa-Gallimard, Milano 1992. Suggeribile anche F. Brunello, Marco Polo e le merci dell’Oriente, Neri Pozza, Vicenza 1986. La temperie storica delle crociate è ben trattata, oltre che nel classico S. Runciman, A History of the Crusades, 2 voll., Cambridge University Press, Cambridge 1951-1954 (trad. it., Storia delle Crociate, 2 voll., Einaudi, Torino 1966), in C. Cahen, Orient et Occident au temps des Croisades, Aubier Montaigne, Paris 1983 (trad. it., Oriente e Occidente ai tempi delle Crociate, il Mulino, Bologna 1986); in P. Rousset, La croisade. Histoire d’une idéologie, L’Âge d’Homme, Lausanne 1983 (trad. it., L’ideologia crociata, Jouvence, Roma 2000); in M. Balard, Les croisades, Éditions d’un Monde à l’Autre, Paris 1988; in F. Cardini Studi sulla storia e sull’idea di crociata, Jouvence, Roma 1993; in A. Dupront, Le mythe de croisade, 4 voll., Gallimard, 347
Paris 1997; in C. Tyerman, The Invention of the Crusades, MacMillan, Basingstoke 1998 (trad. it., L’invenzione delle crociate, Einaudi, Torino 2000); e in J. Flori, Croisade et chevalerie, De Boeck Université, Paris-Bruxelles 1998. Alla disamina di pellegrinaggi e pellegrini è dedicato P. Caucci von Saucken, F. Lopez Alsina, Il mondo dei pellegrinaggi: Roma, Santiago, Gerusalemme, a cura di P. Caucci von Saucken, Palombi-Jaca Book, Roma-Milano 1999, che si aggiunge a J. Richard, Les récits des voyages et des pèlerinages, Turnhout, Brepols 1981, e a D. Régnier-Bohler (a cura di), Croisades et pèlerinages. Récits, chroniques et voyages en Terre Sainte, Laffont, Paris 1997. Sulle questioni geopolitiche nel Vicino Oriente duecentesco, sui Mamelucchi e su Baibars resta importante S.F. Sadeque, Baybars I of Egypt, Oxford University Press, Dacca 1956, da unire a P. Thorau, The Lion of Egypt: Sultan Baybars I and the Near East in the Thirteenth Century, Longman, London 1992, e a R. Amitai-Preiss, Mongols and Mamluks: The Mamluk-Ilkhanid War 1260-1281, Cambridge University Press, Cambridge-New York 1995. Motivi di interesse presenta anche D. Morgan, Medieval Persia 1040-1797, Longman, London 1988. Un ritratto di Edoardo I d’Inghilterra è in M. Prestwich, Edward I, Methuen, London 1988. Studio intelligente e fresco sull’il-khanato persiano è quello di D. Calcagno, Rapporti politico-diplomatici fra Genova, Piccola Armenia e Il-Khanato di Persia (XIII-XIV secolo), in I Mongoli dal Pacifico al Mediterraneo cit., pp. 259-268, da combinare col sempre opportuno B. Spuler, Die Mongolen in Iran, Akademie-Verlag, Berlin 19683. La cosiddetta «setta degli Assassini» viene trattata in P. Filippani Ronconi, Ismailiti ed «Assassini», Thoth, Basilea 1973; F. Daftary, The Ismailis. Their History and Doctrines, Cambridge University Press, Cambridge 1990, e The Assassin Legends. Myths of the Ismailis, Tauris, LondonNew York 1994; B. Lewis, The Assassins: A Radical Sect in Islam, Weidenfeld and Nicolson, London 1967 (trad. it., Gli assassini. Una setta radicale islamica, I primi terroristi della storia, Mondadori, Milano 1992); W. Madelung, P.E. Walker (a cura di), The Advent of the Fatimids, Tauris-The Institute of Ismaili Studies, London 2000; W.B. Bartlett, The Assassins: The Story of Islam’s Medieval Secret Sect, Sutton, Stroud 2001 (trad. it., Gli assassini: storia e leggenda della più temuta setta islamica, Corbaccio, Milano 2004); P. Willey, The Eagle’s Nest. Ismaili Castles in Iran and Syria, Tauris, London-New York 2005. Al viaggio di Marco, Niccolò e Matteo Polo in Cina, e ai territori da loro attraversati lungo il cammino, si rivolge l’attenzione di A. Al348
pago Novello, L’Armenia al tempo di Marco Polo (XIII secolo), in Marco Polo. Venezia e l’Oriente cit., pp. 69-100, cui seguono nello stesso volume: E. Grube, Il mondo islamico al tempo di Marco Polo, pp. 101-158; G. Scarcia, I Mongoli e l’Iran: la situazione religiosa, pp. 159-172; e M. Bussagli, La grande Asia di Marco Polo, pp. 173-226. Notevole è altresì P. Ménard, L’itinéraire de Marco Polo dans sa traversée de la Chine, in «Medioevo romanzo», 26, 2002, pp. 321-360. La conquista mongola della Cina, la dinastia degli Yuan e l’assetto politico dell’impero creato da Kubilai Khan sono indagati in J.D. Langlois Jr (a cura di), China under Mongol Rule, Princeton University Press, Princeton 1981; J. Gernet, La vie quotidienne en Chine, à la veille de l’invasion mongole 1250-1276, Hachette, Paris 1959 (trad. it., La vita quotidiana in Cina alla vigilia dell’invasione mongola 1250-1276, Rizzoli, Milano 1983); M. Rossabi, Khubilai Khan. His Life and Times, University of California Press, Berkeley 1988 (trad. it., Qubilay Khan: imperatore dei mongoli, Garzanti, Milano 1990); I. de Rachewiltz (a cura di), In the Service of the Khan. Eminent personalities of the Early Mongol-Yuan Period, Harrassowitz, Wiesbaden 1993. Un’interpretazione del processo acculturativo dei Mongoli nei confronti della civiltà cinese si trova in H. Franke, Could the Mongol Emperors Read and Write Chinese?, in «Asia Major», III (1), 1953, pp. 28-41. Capitoli di approfondimento sulle religioni e sulle strutture sociali cinesi in epoca yuan sono anche in M. Sabattini, P. Santangelo, Storia della Cina, Laterza, Roma-Bari 1986, 20074; P. Corradini, Cina. Popoli e società in cinque millenni di storia, Giunti, Firenze 1996; e J.A.G. Roberts, A History of China, Macmillan, Basingstoke 1999 (trad. it., Storia della Cina, il Mulino, Bologna 2001). Sicuramente notabili sono pure C.O. Hucker, A Dictionary of Official Titles in Imperial China, Stanford University Press, Stanford 1985; J. Needham, Science and Civilisation in China (1954), 3 voll., Cambridge University Press, Cambridge 1979 (ristampa) (trad. it., Scienza e civiltà in Cina, 3 voll., Einaudi, Torino 1981-1986); e D. Lelièvre, Le dragon de lumière. Les grandes expéditions des Ming au début du XV siècle, Empire, Paris 1996. Gli aspetti artistici della Cina tardo-duecentesca sono tratteggiati in P. Mortari Vergara Caffarelli, L’arte cinese ai tempi di Marco Polo, in Marco Polo. Venezia e l’Oriente cit., pp. 227-280. La conoscenza del paesaggio, delle città e della società sino-mongola da parte di Marco Polo è evocata in I Mongoli dal Pacifico al Mediterraneo cit. da almeno due articoli: G. Airaldi, La città come simbolo, pp. 179-189, e M. Macconi, Realtà e immagi349
nazione nella Cina di Marco Polo: l’incontro nel sogno tra Oriente e Occidente, pp. 281-285. Sulla prigionia genovese di Marco Polo, sul suo incontro con Rustichello e sulla redazione del loro libro, oltre a un dettagliato capitolo dedicatovi da J. Larner in Marco Polo and the Discovery of the World cit., sono consultabili F. Borlandi, Alle origini del libro di Marco Polo, in Studi in onore di Amintore Fanfani, Giuffrè, Milano 1962, vol. I, pp. 107-147; P.-Y. Badel, Lire la merveille selon Marco Polo, in «Revue des sciences humaines», 183, 1981, pp. 7-16; Il romanzo arturiano di Rustichello da Pisa, edizione critica, traduzione e commento a cura di F. Cigni, Edizioni Cassa di Risparmio di Pisa, Pisa 1994; M. Ciccuto, Storia e mito del Milione, in Id., Icone della parola. Immagine e scrittura nella letteratura delle origini, Mucchi, Modena 1995, pp. 147-171. A L.F. Benedetto si devono Marco Polo, Il Milione, I edizione integrale, Olschki, Firenze 1928, e Grandezza di Marco Polo, in Id., Uomini e tempi. Pagine varie di critica e storia, Ricciardi, Milano-Napoli 1953, pp. 71-85. Basilari appaiono attualmente gli studi di Valeria Bertolucci Pizzorusso, fra cui Enunciazione e produzione del testo nel «Milione», in «Studi Mediolatini e Volgari», XXV, 1977, pp. 5-43 (ripreso in Morfologie del testo medievale, il Mulino, Bologna 1989); Nuovi studi su Marco Polo e Rustichello da Pisa, in La cultura dell’Italia padana e la presenza francese nei secoli XII-XV, Atti del convegno (Pavia, 11-14 settembre 1994), a cura di L. Morini, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2001, pp. 104-105; Lingue e stili nel «Milione», in L’epopea delle scoperte, a cura di R. Zorzi, Olschki, Firenze 1994; La figura del redattore nella ricezione delle scritture di viaggio medievali. Un caso esemplare, in A. Gargano, M. Squillante (a cura di), Il viaggio nella letteratura occidentale tra mito e simbolo, Atti del convegno internazionale di studi (Napoli, 19-20 maggio 2004), Liguori, Napoli 2005; Le versioni storiche del Milione in Italia, in Marco Polo. 750 anni cit., pp. 199-208; nel medesimo volume, illuminante sui risvolti connessi alla redazione dei racconti di viaggio di Marco Polo si rivela G. Airaldi, Autobiografia di Marco, pp. 209-219. Riguardo alle diverse redazioni dei racconti poliani ci si può riferire a Marco Polo, Milione. Le divisament dou monde. Il Milione nelle redazioni toscana e franco-italiana, a cura di G. Ronchi, introduzione di C. Segre, Mondadori, Milano 1982; Marco Polo, Il Milione, versione toscana del Trecento, edizione critica a cura di V. Bertolucci Pizzorusso, indice ragionato di G.R. Cardona, Adelphi, Milano 1975; Marco Polo, Milione. 350
Redazione latina del manoscritto Z, a cura di A. Barbieri, Fondazione Pietro Bembo, Guanda, Milano-Parma 1998; Marco Polo, Il «Milione» veneto: ms. CM 211 della Biblioteca Civica di Padova, a cura di A. Barbieri e A. Andreose, con la collaborazione di M. Mauro, premessa di L. Renzi, Marsilio, Venezia 1999; e all’eccellente, monumentale edizione critica di P. Ménard della redazione francese di Marco Polo. Le Devisement du Monde, Droz, Genève 2001-in corso di stampa (tomo I: Départ des voyageurs et traversée de la Perse, a cura di M.-L. Chênerie, M. Guéret-Laferté e P. Ménard, 2001; tomo II: Traversée de l’Afghanistan et entrée en Chine, a cura di L. Harf-Lancner, con L. Matthey-Maille e J.-M. Boivin, 2003; tomo III: L’empereur Khoubilai Khan, a cura di J.-C. Faucon, D. Quéruel e M. Santucci, 2004; tomo IV: Voyages à travers la Chine, a cura di J. Blanchard e M. Quéreuil, 2005; tomo V: À travers la Chine du Sud, a cura di J.-C. Delclos e C. Roussel, 2006). Infine, sulle postille di Cristoforo Colombo al libro di Marco Polo è chiarificatore El libro de Marco Polo anotado por Cristóbal Colón. El libro de Marco Polo. Versión de Rodrigo de Santaella, cura, introduzione e note di J. Gil, Alianza Editorial, Madrid 1987.
INDICE DEI NOMI
Abaqa, il-khan di Persia, 137, 145, 149, 152, 207, 313. Aelfric, abate e scrittore anglosassone, 67. Aibeg, diplomatico mongolo, 45. Airaldi, Gabriella, 326, 339, 345, 349-350. Ajall, Sayyid Shams al-Din, ministro di Kubilai Khan e governatore dello Yunnan, 221, 255. Alberto, frate domenicano, compagno di Ascelino da Cremona, 44. Alessandro, detto il Grande o Magno, sovrano macedone, 60, 94, 158, 174, 178. Alessandro, frate domenicano, compagno di Ascelino da Cremona, 44. Alessandro III (Rolando Bandinelli), papa, 14. Alessandro di Villedieu, 100. Alessio Angelo, principe bizantino, poi Alessio IV co-imperatore, 85-86. Alessio Comneno, principe bizantino, nipote di Andronico I Comneno, 88.
Alessio I Comneno, imperatore bizantino, 76. Alessio III Angelo, imperatore bizantino, 85-86, 88. Alessio V Ducas, imperatore bizantino, 87. Alfredo il Grande, sovrano anglosassone, 11. Alighieri, Dante, 98. Ammiano Marcellino, letterato e storico latino, 32. Andrea di Cˇernigov, duca kievano, 4. Andrea di Longjumeau, frate domenicano, legato di Luigi IX, 43, 54-55. Andrea II, re d’Ungheria, 18. Andronico I Comneno, imperatore bizantino, 82, 88. Andronico II Paleologo, imperatore bizantino, 319. Anfossi, Tomaso, mercante genovese, 314. Aniko, artista membro della famiglia reale del Nepal, 242. Anna Comnena, figlia dell’imperatore Alessio I Comneno, 76. Apusciai, delegato il-khanale, 291.
352
Arghun, il-khan di Persia, 290291, 312-315. Arik Boge, fratello dei khan Möngke e Kubilai, 119, 121. Arik Kaya, generale mongolo, 209. Árpád, dinastia reale ungherese, 22, 29. Ascelino da Cremona, frate domenicano, 43-44. Attila, re degli Unni, 36. Badoer, Angelo, cognato di Marco Polo, 328. Badoer, Donata, moglie di Marco Polo, 322, 328. Badoer, Pietro, cognato di Marco Polo, 328. Baibars (Rukn al-Din Baibars alBunduqdari), sultano d’Egitto e Siria, 134-135, 137-139, 145, 152, 162, 216. Baldovino I di Fiandra, imperatore latino di Costantinopoli, 88. Baldovino II, imperatore latino di Costantinopoli, 103, 106, 329. Baldovino II, re di Gerusalemme, 78. Barbaro, Marco, araldista veneziano, 90. Barbieri, Alvaro, 324. Bardesane (o Bar Daisan), poeta e filosofo siriaco, 181. Bartolomeo da Cremona, frate francescano, compagno di Guglielmo di Rubruck, 56, 58, 60. Basilio, figlio di un inglese, abitante a Karakorum, 59. Basilio I il Macedone, imperatore bizantino, 74.
Basilio II, imperatore bizantino, 75. Batu, khan dell’Orda d’Oro, nipote di Gengis Khan, 38-40, 47, 49, 57-58, 60, 115. Bayan, detto «il Cento occhi», generale mongolo, 208, 269, 287. Baydu, il-khan di Persia, 315. Beaujeu, Guglielmo di (Guillaume de Beaujeu), gran maestro dell’ordine templare, 149. Béla IV Árpád, re d’Ungheria, 23, 28-29, 35-36, 47. Benedetto Polono, frate francescano, compagno di Giovanni da Pian del Carpine, 46, 48. Benjamin ben Jonah (Beniamino da Tudela), viaggiatore ebreo, 16. Berke, khan dell’Orda d’Oro, fratello di Batu e nipote di Gengis Khan, 115-118, 320. Bertolucci Pizzorusso, Valeria, 152. Bocconio, Marino, 327. Boleslao il Casto, principe di Cracovia, 26. Bolghai, ministro di Kubilai Khan, 120. Bonifacio, marchese di Monferrato, 85. Bonifacio di Molendino, mercante veneziano, 108. Bono di Malamocco, marinaio veneziano, 72. Borte, prima moglie di Gengis Khan, 230. Boucher, Guillaume, orefice pari-
353
gino presso la corte del khan a Karakorum, 59. Boulnois, Luce, 119. Bragadin, Marco, genero di Marco Polo, 328. Buglione, Goffredo conte di (Godefroy de Bouillon), re di Gerusalemme, 77. Bunduqdar, Aydekin al-, emiro, 134. Bunduqdari, Rukn al-Din Baibars al-, vedi Baibars. Bussagli, Mario, 261, 297. C. de Bridia, frate francescano autore della Hystoria Tartarorum, 26. Callisto II (Guido di Guglielmo conte di Borgogna), papa, 13. Capella, Marziano Minneio Felice, scrittore latino, 9. Carlo I d’Angiò, re di Sicilia, 107, 136. Carlo di Valois, pretendente al trono di Costantinopoli, 329. Carlomagno, re dei Franchi e imperatore del Sacro Romano Impero, 71. Caterina di Courtenay, moglie di Carlo di Valois, 329. Celestino IV (Goffredo di Castiglione), papa, 36. Ceslao (o Stefano) Boemo, frate francescano, compagno di Giovanni da Pian del Carpine, 46. Chagatai, figlio di Gengis Khan, fondatore del khanato centroasiatico, 113, 117, 174, 180. Chen Dezhi, storico cinese contemporaneo, 251, 271.
Chepoy, Thibaut de, nobiluomo al servizio di Carlo di Valois, 329. Chirki, figlio di Möngke Khan, 204. Cicerone, Marco Tullio, scrittore e politico romano, 9. Cinkai, dignitario alla corte del khan Güyük, 51. Cinnamo, Giovanni, cronista bizantino, 80. Clemente IV (Guy Le Gross Foulquois), papa, 126. Clemente V (Bertrand de Gouth), papa, 327. Coja, delegato il-khanale, 291. Coniate, Niceta (Nicetas Acominatus), storico bizantino, 81, 85. Corenza, comandante delle guardie tartare alla frontiera occidentale, 47. Corrado di Monferrato, erede al trono di Gerusalemme, 160. Corrado di Svevia, poi Corrado IV, re di Germania, 35. Cosma, detto Indicopleuste, mercante, autore della Topographia christiana, 9. Costantino, Gaio Flavio Valerio, detto il Grande, imperatore romano, 144. Costantino IX Monomaco, imperatore bizantino, 144. Cratete di Mallo, grammatico e filologo, principale esponente della Scuola di Pergamo, 9. Crouzet-Pavan, Elisabeth, 71. Ctesia di Cnido, medico del re persiano Artaserse II, 6.
354
Dandolo, Enrico, doge di Venezia, 83-84. Dario, re di Persia, 7, 174. Daula, Saad al-, primo ministro dell’il-khan Arghun, 313. David, emissario mongolo, 52, 54, 61. David d’Ashby, frate domenicano, inviato alla corte il-khanide, 149. Davide Comneno, principe bizantino, 88. della Valle, Pietro, viaggiatore e scrittore, 150. Demetrio, luogotenente del gran principe Michele Vsevolodovicˇ, 20. Din, Muhyi al-Milla al-Maghribi al-, scienziato musulmano alla corte degli Yuan, 221. Din, Rashid al-, medico ed erudito persiano, 121, 206. Dokuz, moglie cristiana dell’ilkhan Hülegü, 137, 163. Dolfin, Ranuzzo, genero di Marco Polo, 328. Domenico d’Aragona, francescano, delegato papale nel Vicino Oriente, 43. Domenico di Guzmán, santo, fondatore dell’ordine domenicano, 42. Doria, Lamba, condottiero genovese, 322-323. Dubois, Pietro (Pierre), consigliere alla corte di Parigi, 150. Duzong, imperatore Song, 208. Edmondo di Lancaster, fratello di Edoardo I, re d’Inghilterra, 135.
Edoardo I, re d’Inghilterra, 135138, 145,149, 314, 324. Eleonora di Castiglia, moglie di Edoardo I, re d’Inghilterra, 135. Eliano, Claudio, erudito e filosofo romano, 6. Eljigidei, commissario del gran khan Güyük, 44, 53-54, 61. Engels, Friedrich, 222. Enrico, conte di Lorena, 30. Enrico I di Fiandra, re di Cipro, 51. Enrico II, duca di Slesia, detto il Pio, 26. Enrico III, re d’Inghilterra, 35, 134-135, 324. Enrico di Lettonia, autore del Chronicon Livoniae, 18. Erodoto, storico greco, 6. Esen Temür, principe dello Yunnan, nipote di Kubilai Khan, 250. Esiodo, poeta greco, 6. Eugenio III (Pietro Bernardo dei Paganelli), papa, 13. Eusebio di Cesarea, vescovo e storico della Chiesa, 8. Fang Guoyu, storico cinese contemporaneo, 251. Fang Hao, storico cinese contemporaneo, 269. Federico I di Svevia, detto il Barbarossa, imperatore del Sacro Romano Impero, 14-15, 82, Federico II di Svevia, re di Sicilia e imperatore del Sacro Romano Impero, 25, 29, 34-36, 41, 43, 52, 128.
355
Fenaketi, Ahmed, ministro del Tesoro degli Yuan, 220, 258-261. Fibonacci, Leonardo, matematico pisano, 100. Fidenzio da Padova, frate francescano e diplomatico, 150. Fieschi, Sinibaldo, giurista genovese, poi papa Innocenzo IV, 41, 44, 50, 52. Filippo, duca di Svevia e re di Germania, 85. Filippo, Maestro, medico di papa Alessandro III, 15. Filippo III, detto l’Ardito, re di Francia, 149. Filippo IV, detto il Bello, re di Francia, 313. Filippo di Courtenay, poi Filippo I, imperatore latino d’Oriente, 106. Filippo di Mézières, cancelliere di Pietro I, re di Cipro, 150. Francesco d’Assisi, santo, fondatore dell’ordine francescano, detto il Poverello d’Assisi, 42, 46, 56. Francesco Pipino da Bologna, frate domenicano, 329. Franke, Herbert, 118. Gaikhatu, il-khan di Persia, 315316. Gallo, Rodolfo, 91. Galvano da Levanto, medico presso la curia papale, 150. Gengis Khan (Temugin), fondatore dell’impero mongolo, 110112, 114-115, 117, 119, 121, 162, 174, 198, 230, 283. Ghazan, il-khan di Persia, 315316.
Ghazi, Abdul, principe di Hiva, 110. Ghisolfi, Buscarello, patrizio genovese presso la corte il-khanide, 314. Giacobbe Baradeo, vescovo di Edessa, 11. Giacomo I, re d’Aragona, 149. Giacomo da Vitry, vescovo di San Giovanni d’Acri, 17, 143. Giacomo di Molay, gran maestro dell’ordine templare, 150. Giordane (Jordanes Gothus), storico latino di origine gotica, 32. Giordano da Giano, frate francescano, vicario dell’ordine in Boemia, 33, 46. Giorgio, governatore cristiano degli Onguti per conto del gran khan, 211. Giovanni II Comneno, imperatore bizantino, 78. Giovanni III Ducas Vatatze, imperatore bizantino, 106. Giovanni XXII (Jacques d’Euse), papa, 217. Giovanni da Mandavilla (Jehan de Mandeville), autore dei Viaggi, 145. Giovanni da Montecorvino, teologo, inviato del papa in Cina, 311. Giovanni da Pian del Carpine, frate francescano, legato papale presso la corte khanale di Karakorum, 45-46, 48-52, 56, 195. Giovanni de Candia, conte di Brienne, re di Gerusalemme, imperatore latino e reggente di Costantinopoli, 106.
356
Giovanni del Sacrobosco (John of Holywood), astronomo e matematico, 100. Girardo, Paolo, mercante veneziano, 328. Girolamo (o Gerolamo), Sofrone Eusebio, santo e Padre della Chiesa, 8. Giuliano d’Ungheria, frate domenicano, 22, 56. Giustiniano, Flavio Pietro Sabbazio, imperatore romano d’Oriente, 12. Gondophares, sovrano indiano, 11, 15. Gongdi, ultimo sovrano dei Song, 208. Gosset, scrivano al seguito di Guglielmo di Rubruck, 56, 60. Gradenigo, Tomaso, genero di Marco Polo, 328. Gregorio IX (Ugo o Ugolino dei conti di Segni), papa, 23, 36, 67. Gregorio X, papa, vedi Visconti, Tedaldo (o Tebaldo, o Odaldo). Guglielmo di Rubruck (Willem van Ruysbroeck), frate francescano, legato di Luigi IX alla corte khanale di Karakorum, 55-58, 60-61, 107, 189, 195. Guglielmo di Tiro, cronista delle crociate, 160. Guglielmo di Tripoli, frate domenicano inviato presso Kubilai Khan, 152. Guido di Anderlecht, santo, 66. Guiscardo Cremonese, frate domenicano, compagno di Ascelino da Cremona, 44.
Guo Shoujing, scienziato, ingegnere e astronomo presso gli Yuan, 244. Gu Weimin, storico cinese contemporaneo, 251. Güyük, gran khan mongolo, 3839, 49-51, 53-54. Haeger, John W., 251. Hakim, Amr Allah al-, califfo fatimide d’Egitto, 144. Hamilton, Bernard, 15. Hawqal, Mohammed Abdul-Kassem ibn, viaggiatore e mercante iracheno, 75. Haython l’Armeno (Haithonus Armenus o Het’owm Patmich), monaco premostratense, autore di Liber historiarum partium Orientis, sive Passagium Terrae Sanctae, 150. Heers, Jacques, 323. Hethum I, re d’Armenia, 126. Hojo Tokimune, imperatore del Giappone, 200. Hugeci, figlio di Kubilai Khan, 250. Hülegü, fondatore dell’il-khanato di Persia, nipote di Gengis Khan, 117, 137, 149, 161, 163, 313, 320. Ibelin, potente famiglia di Beirut, 141. Idrisi (o Edrisi), Abu Abdullah Muhammad al-, geografo arabo, 16, 145. Indravarman V, re del Champa, 284. Innocenzo III (Lotario dei conti di Segni), papa, 84.
357
Innocenzo IV, papa, vedi Fieschi, Sinibaldo. Innocenzo V (Pietro di Tarantasia), papa, 149. Isa, delegato cristiano degli Yuan presso l’il-khan di Persia, 221. Isacco II Angelo, imperatore bizantino, 82, 85-86, 88. Isidoro di Siviglia, scrittore latino, santo, 6, 56, 61, 79, 310. Ismail, settimo imam, discendente di Maometto, 158. Ivo di Narbona, 32. Jacopo da Varagine (Varazze), frate domenicano e scrittore, poi vescovo di Genova, 69. Jahiz, al- (Abu Uthman Amr Ibn Bahr al-Kinani al-Fuqaimi alBasri), studioso e scrittore arabo, 16. Jaroslav di Sternberg, burgravio di Olomouc, 27. Jaroslav, granduca di Suzdal’, 48. Jayasimhavarman III, re del Champa, 285. Jean de Joinville, cavaliere crociato e biografo di Luigi IX, re di Francia, 55. Jia Sidao, primo ministro dei Song, 206, 208. Jurij II Vsevolodovicˇ, gran principe di Suzdal’, 19. Juvaini, Ata-Malik, scrittore persiano, 158, 161. Kadak, dignitario alla corte del gran khan Güyük, 51. Kaidu, principe mongolo ribelle,
121, 171, 174, 203-204, 287, 291, 315. Khalil, Ashraf Al-Malik al-, sultano d’Egitto, 317-318. Kilic Arslan IV, sultano selgiuchide, 49. Kokacin, principessa, promessa sposa dell’il-khan di Persia, 291, 293, 304, 312, 315-316. Koketei, uomo di fiducia e delegato di Kubilai Khan, 124-125. Kong Fuzi (Confucio), filosofo cinese, 224, 266. Kotyan, condottiero comano, 22. Kuan Hanching, drammaturgo cinese, 225. Kubilai, gran khan e capostipite degli Yuan, 119, 121-125, 127128, 139, 145, 151, 171, 174, 190-191, 199-200, 202, 204, 206-210, 212-214, 217, 219220, 222, 224-243, 245, 248, 250, 255, 258-262, 268, 270, 276-281, 284-293, 295-296, 312-313, 315, 325. Kuchap, figlio del gran khan Güyük, 54. La Noue, François de, gentiluomo ugonotto, memorialista delle guerre di religione francesi, 150. Larner, John, 15, 251. Lascaris, Teodoro, poi Teodoro I, imperatore di Nicea, 88. Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret-Gris), architetto e urbanista franco-svizzero, 69. Lelièvre, Dominique, 262. Leone Apostippo, stratega bizantino, 74.
358
Leone IV, re d’Armenia, 330. Lin Chaomin, storico cinese contemporaneo, 251. Li Tan, governatore dello Shandong, 269. Liu Bingzhong, saggio alla corte di Kubilai Khan, 204. Liu Wenhuang, generale cinese, 206. Liu Yin, artista e scrittore della Cina dei Song, 224. Liu Yuan, scultore della Cina degli Yuan, 243. Luigi IX, detto il Santo, re di Francia, 41, 52-54, 57, 60-61, 106, 128, 136. Lullo, Raimondo (Ramon Llull), filosofo e predicatore di Maiorca, 150. Macrobio, Ambrogio Teodosio, scrittore latino, 9. Mairano, Romano, mercante italico a Costantinopoli, 81. Manfredi, figlio naturale di Federico II di Svevia, poi re di Sicilia, 128. Mangalai, figlio di Kubilai Khan, 246. Manuele I Comneno, imperatore bizantino, 14, 79. Maometto, 158, 163. Marcus, emissario mongolo, 52, 54, 61. Maria, amante di Niccolò Polo, 90. Maria, figlia naturale di Michele VIII Paleologo, moglie dell’ilkhan Abaqa, 137. Marinier, Arnoldo, viaggiatore e mercante di Marsiglia, 107.
Mar Sargis, sacerdote nestoriano, amministratore di Zhenjiang, 269. Martino da Canal, cronista veneziano, 97. Marx, Karl, 222. Megastene, geografo greco, 6. Ménard, Philippe, 261. Michea, prefetto alano, 47. Michele Angelo Comneno Ducas, despota di Epiro, 88. Michele VIII Paleologo, imperatore bizantino, 103, 116, 128, 137, 149, 329. Michele Vsevolodovicˇ, gran principe di Kiev, 21. Michiel, Domenico, doge di Venezia, 78. Möngke, gran khan mongolo, nipote di Gengis Khan, 58, 60-61, 119, 187, 198. Möngke Temür, khan dell’Orda d’Oro, 204, 232. Montfort, famiglia, signori di Tiro, 141. Morosini, Tommaso, patriarca di Costantinopoli, 88. Muhammad II, Ala al-Din, califfo abbaside, 17. Mustasim, Abu Ahmad Abd Allah ibn al-, ultimo califfo abbaside, 163. Nasar, ammiraglio bizantino, 74. Nayan, principe ribelle a Kubilai Khan, 287. Nestorio, patriarca di Costantinopoli, iniziatore dell’eresia nestoriana, 11.
359
Niccolò IV (Girolamo Masci), papa, 311, 313. Niccolò da Vicenza, frate domenicano inviato presso Kubilai Khan, 152. Niceforo II Foca, generale bizantino, poi imperatore, 74. Nichiren, monaco buddhista giapponese, 200. Nicola, schiavo di Guglielmo di Rubruck, 56, 60. Nicola di San Siro, mercante genovese a Iconio, 107. Nokhai, generale mongolo, 327. Odone, abate a Reims, 13. Odone di Châteauroux, legato papale, poi vescovo di Frascati, 53. Ögödei, gran khan mongolo, 38. Olschki, Leonardo, 15, 94, 271. Onorio IV (Giacomo Savelli), papa, 313. Orosio, Paolo (Paulus Orosius), monaco e storico latino, 8. Orseolo, Pietro II, doge di Venezia, 75. Ortalli, Gherardo, 75. Ossiarte, satrapo di Battriana, suocero di Alessandro Magno, 175. Ottone, vescovo di Frisinga, monaco cistercense e cronista, 13. Paolo di Segni, vescovo di Tiro, 149. Paris, Matteo (Matheus Parisiensis o Matthew of Paris), monaco benedettino inglese, 33. Parker, Giovanni, legato di Edoardo I, re d’Inghilterra, 137.
Partecipazio, Giustiniano, doge di Venezia, 71. Partecipazio, Orso, vescovo di Olivolo (Venezia), 71. Petech, Luciano, 118, 261. Phags-pa, monaco tibetano, 227. Pietro, schiavo tartaro di Marco Polo, 322, 331. Pietro Akerovicˇ, boiardo di Kiev e vescovo, 42. Pietro d’Abano, medico, filosofo e astronomo, 328. Pipino, primogenito di Carlomagno, 73. Plinio, Gaio Secondo, detto il Vecchio, scienziato e naturalista romano, 6. Plutarco di Cheronea, scrittore e biografo greco, 6. Polo, Andrea, nonno di Marco, 92 Polo, Auria, cugina di Marco, 91. Polo, Belella, figlia di Marco, 328. Polo, Fantina, figlia di Marco, 328. Polo, Flora, zia di Marco, 91. Polo, Giovanni, cugino di Marco, 91, Polo, Giovannino (Zanino), fratellastro di Marco, 90. Polo, Marco, detto il Vecchio, zio di Marco, 322, 328, Polo, Marcolino, cugino di Marco, 328. Polo, Matteo, fratellastro di Marco, 90. Polo, Matteo, zio di Marco, 105106, 115-119, 121, 123, 124129, 139, 143, 145, 148, 151152, 155, 168, 171, 176, 194, 208, 210, 217, 238, 261, 280-
360
281, 289-291, 311, 315-316, 318-319, 322, 330. Polo, Moretta, figlia di Marco, 328. Polo, Niccolò, padre di Marco, 90, 105-106, 115-119, 121, 123, 124-129, 139, 143, 145, 148, 151-152, 155, 168, 171, 176, 194, 208, 210, 217, 238, 246, 261, 289-291, 293, 311, 315316, 318-319, 325, 330. Polo, Stefanino, fratellastro di Marco, 90. Poro, re indiano, 7. Prete Gianni (Iohannes Presbyter), personaggio leggendario, 13-15, 18, 61, 198, 211, 248, 310. Procopio, protovestiario bizantino, 74. Qalawan, al-Mansur, sultano del Cairo, 314. Querini, famiglia dell’aristocrazia veneziana, 327, 330. Querini, Bertuccio, genero di Marco Polo, 328. Qutuz, Saif ad-Din, sultano d’Egitto, 135. Ramusio, Giovanni Battista, 90. Ricoldo da Montecroce, missionario domenicano, 150. Roberto d’Altavilla, detto il Guiscardo, duca di Puglia e di Calabria, 76. Roberto di Clari (Robert de Clari), cronista francese, 87. Romano Argiro, imperatore bizantino, 144.
Roslin, Toros, miniaturista armeno, 157. Rossane, moglie di Alessandro Magno, 174. Ruggero II d’Altavilla, re di Sicilia, 16, 79. Ruggero delle Puglie, Maestro, arcidiacono nel capitolo vescovile di Nagyvárad (Oradea), autore del Carmen Miserabile, 34. Russell, Reginaldo, legato di Edoardo I, re d’Inghilterra, 137. Rustichello (o Rusticiano) da Pisa, scrittore, 323-326. Rustico di Torcello, marinaio veneziano, 72. Rusudan, regina di Georgia, 18. Sabbah, Hasan-i, fondatore della setta degli Ismailiti, 158-159, 161-162. Saladino (Salah al-Din Yusuf), condottiero, fondatore della dinastia egiziana degli Ayyubidi, 82, 146, 160. Salimbene de Adam, minorita e cronista, 46. Sanga, dignitario uiguro presso gli Yuan, 221. Sanjar, principe selgiuchide, 14. Sanudo, Marino il Giovane, memorialista veneziano, 99. Sanudo, Marino il Vecchio, cronista veneziano, 150. Sartaq, khan dell’Orda d’Oro, 55, 57, 115. Sauma, Rabban, monaco nestoriano, 314. Schreiner, Peter, 80.
361
Sempad, connestabile d’Armenia, 51. Serapione, vescovo di Vladimir, 30. Sergis, legato khanale al seguito di Ascelino da Cremona, 45. Shiremon, nipote ed erede del gran khan Ögödei, 38, 54. Simeone Rabban-ata, prelato nestoriano, 43. Simone di Saint-Quentin, compagno di Ascelino da Cremona e cronista, 44. Sinan, Rashid al-Din, signore degli Ismailiti di Siria, 160. Sogetu, generale mongolo, 209, 284. Solino, Gaio Giulio, scrittore latino, 6, 56. Song, dinastia, 119, 204-206, 208209, 219, 223-224, 228, 269, 272-273, 276-277, 281. Sorgaktani, madre di Kubilai Khan, 121. Stefano, santo protomartire, 78. Strabone, geografo greco, 6. Strategopulo, Alessio, generale dell’impero bizantino, 103. Sui, dinastia, 245. Tang, dinastia, 12, 243. Tekuder Ahmed, il-khan di Persia, 313. Temugin, vedi Gengis Khan. Temür, nipote ed erede di Kubilai Khan, 232. Teodoro, santo, patrono di Venezia, 72. Teodoro di Mopsuestia, filosofo cristiano, 12.
Tiepolo, famiglia dell’aristocrazia veneziana, 327. Tiepolo, Lorenzo, doge di Venezia, 127. Timoteo I, patriarca della Chiesa nestoriana, 12. Toghan Temür, figlio di Kubilai Khan, 284. Toghril, re dei Keraiti, 198. Toktai, khan dell’Orda d’Oro, 327. Tolomeo, Claudio, astronomo greco, 221. Tommaso, Giuda, detto Didimo, apostolo e santo, 10-11, 13-15. Tommaso d’Aquino, santo, filosofo e teologo, 67. Tommaso da Spalato, detto l’Arcidiacono, cronista, 33. Tommaso di Lentini, patriarca di Gerusalemme, 149. Töregene, moglie del gran khan Ögödei e madre del gran khan Güyük, 38, 48-49. Tran Nhan Tong, re dell’Annam, 284. Trevisan, Fiordelise, seconda moglie di Niccolò Polo, 90. Tucci, Ugo, 125. Tului, padre di Kubilai Khan, 121. Ugo di Jabala, vescovo di Siria, 13. Ulakci, khan dell’Orda d’Oro, 115. Ulatai, delegato il-khanale, 291. Vilione (o Vioni), Pietro, mercante veneziano a Tabriz, 107. Villehardouin, Goffredo di (Geoffroi de Villehardouin), mare-
362
sciallo di Champagne, poi principe di Acaia, 87. Vincenzo di Beauvais (Vincent de Beauvais/Vincentius Bellovacensis), frate domenicano, autore dello Speculum Maius, 44. Visconti, Tedaldo (o Tebaldo, o Odaldo), poi papa Gregorio X, 136, 139. Vivaldi, Ugolino e Vadino, viaggiatori genovesi, 330. Wang E, storiografo cinese alla corte di Kubilai Khan, 224. Wang-Shih-Fu, drammaturgo cinese, 226. Welles, Goffredo, legato di Edoardo I, re d’Inghilterra, 137. Xie, imperatrice Song, 208. Xu Heng, dotto neoconfuciano alla corte di Kubilai Khan, 224.
Yang Zhijiu, storico cinese contemporaneo, 251. Yang, lama buddhista, 228. Yelu Dashi, comandante dei KaraKitai, 14. Yuan, dinastia, 206, 209-210, 213, 218-222, 224, 227-229, 231, 234, 236, 238, 241, 244-245, 248, 255, 259-261, 268-269, 271, 277, 282-286, 291-292, 314. Zaccaria, Benedetto, ammiraglio genovese, 150, 330. Zeno, Reniero, doge di Venezia, 127. Zhang Kai, storico cinese contemporaneo, 222. Zufircar, ingegnere turco al servizio di Kubilai Khan, 188.
INDICE DEI LUOGHI
Abido, 85. Abissinia, 310. Acri, 17, 79, 107, 126, 140-141, 143, 148, 316-319, vedi anche San Giovanni d’Acri. Aden, 311. Adige, 98. Adria, 73. Adriatico, Mare, 22, 69, 75, 80, 95, 322. Afghanistan, 17, 141, 171, 175, 177. Aigues-Mortes, 52. Ain Jalut, 114, 135. Akko, 17, vedi anche Acri. Alakol’, lago, 48. Alamut, 158, 161. Aleppo, 137, 189. Alessandretta, 125. Alessandria d’Egitto, 72, 79, 216217, 292, 311. Almiro, 81. Amantea, 74. Amudar’ja, 17, 48, 179. Ancona, 73, 128. Andamane, isole, 295. Andro, 79, 85. Annam, 284.
Anqing, 208. Antiochia, 11, 43, 60, 134, 141. Antivari, 52. Anversa, 126. Apamea, 137. Aquileia, 72. Arabico, Mare, 170, 304. Aral, lago d’, 42, 48. Ararat, 155. Arles, 41. Armenia Maior, 43-44, 49, 60, 116, 157. Armenia Minor, 105, 154, 216. Ascalona, 141. As-Shihr, 311. Astrahan’, 40. Athlit, 318. Atlantico, Oceano, 36, 330. Austria, 29. Azerbaigian, 60, 154. Azov, Mar d’, 17, 107. Azzurro, Fiume (Yangtze), 206, 228, 236, 245, 247, 250, 272, 279. Bactra, 174, vedi anche Balkh. Badakshan, 176-177. Bagan, 255, 286.
364
Baghdad, 12, 48, 54, 73, 112, 114, 163, 309. Bahrein, 16. Bajkal, lago, 198. Balcani, 22, 76. Baleari, isole, 250. Balhasˇ, lago, 112. Balkh, 112, 174. Bari, 73, 75, 77. Bassora, 166. Battriana, 174, 181. Beirut, 140, 318. Belaja, 18. Belgrado, 27. Bengala, golfo del, 295. Bengala, regione, 255. Bessarabia, 26. Betlemme, 140, 146. Bhamo, 255. Birmania, 255, 284, 286. Bisanzio, 12, 14, 21, 73, 75, 78, 8083, 88, 92, 95, 103-107, 116, 126, 215, 318, 329, vedi anche Costantinopoli. Boemia, 29, 33, 46. Bolgary, 18, 116. Bologna, 222. Bombay, 11, 307. Bordeaux, 32, 314. Bosforo, 21, 75, 80, 85, 105, 319. Brazza, 73. Brennero, 93. Brenta, 98. Breslavia (Wroc¢aw), 26, 46. Brindisi, 73, 108. Bruges, 126. Buda, 28. Buhara, 107, 112, 117, 122, 171, 189, 221.
Bulgaria, 37. Bulgaria del Volga-Kama, 18. Caffa, 108. Cairo, Il, 54, 85, 134, 216, 280, 314. Canale Imperiale, 272, vedi anche Gran Canale. Candia, 92, vedi anche Creta. Canton (Guangzhou), 209. Carinzia, 74. Carpazi, 21, 26. Caspio, Mar, 7, 17, 42, 61, 108, 111, 154, 158. Castel Fiorentino, 176. Catai, 121, 129, 153, 171, 181182, 186, 189, 191, 194, 199, 204, 223, 225, 236, 248, 250, 264, 283, 321. Cattaro, 29. Cavarzere, 70. Cefalonia, 82. Cˇernigov, 20. Cesarea, 54, 134, 138. Ceylon, vedi Taprobane (Sri Lanka). Champa, 284-285, 288. Changsha, 209. Changzhou, 269. Chio, 79. Chioggia, 91. Chmielnik, 26. Cicladi, isole, 88. Cilicia, 76, 216. Cinese Meridionale, Mar, 209. Cipro, 52, 77, 79, 93, 105, 126, 136, 319. Cittanova-Eraclea, 73. Cividale, 72. Cocincina, 284.
365
Colonia, 31, 83. Comacchio, 73. Comorin, Capo, 301, 305. Corasmia, 17, 20, 111. Corfù, 76, 79, 82, 85, 93. Corinto, 76, 79. Coromandel, 170, 297. Corone, 104. Costantinopoli, 11, 43, 56, 73-74, 76, 78-79, 81-83, 85-88, 91, 95, 103-107, 116, 126, 128, 319, 329, vedi anche Bisanzio. Cracovia, 21, 26, 47. Creta, 77, 79, 88, 92, 104, 126, vedi anche Candia. Crimea, 18, 56, 107. Croazia, 29, 77, 97. Curzola, 322. Dacia, 46. Dadu/Khanbalik, 121, 229, 232, 241-244, 258, 296, vedi anche Pechino. Dafnusia, 103. Dailam, 158. Dali, 255. Dalmazia, 29, 77, 82, 90, 97. Damasco, 112, 140, 317. Damietta, 79. Danubio, 27, 29, 37. Dardanelli, stretto dei, 88, vedi anche Ellesponto. Dasht-e Lüt, deserto, 172. Delhi, 114. Derbent, 60. Dnepr, 18, 46. Dnestr, 21. Don, 9, 18, 57, 108. Drazark, 157. Dunhuang, 185, 194.
Duolun, 119. Durazzo, 76, 82, 85. Ebro, 5. Ebstorf, 11. Edessa, 10-11, 13. Efeso, 11. Egeo, Mare, 81, 330. Egitto, 10, 16, 20, 54, 79, 83, 107, 114, 116, 118, 134, 138, 140, 144-145, 215-216, 311, 313, 330. Elba, fiume, 5. Elba, isola, 250. Elburz, monti, 158. Ellesponto, 88, vedi anche Dardanelli, stretto dei. Equilo (Jesolo), 91. Eraclea, 88. Esdraelon, 140. Etiopia, 10, 310. Eubea, 88, 93, 104, vedi anche Negroponte. Eufrate, 112, 137. Fancheng, 206-207. Fergana, valle di, 177. Ferrara, 327. Fiandre, 55, 330. Firenze, 222. Friuli, 29, 73, 98. Fujian, 209, 279, 282. Fukuoka/Hakata, 201, 203. Fuzhou, 209, 280, 282. Galata, 85. Galizia, 21, 27, 47. Galles, 314. Gallipoli, 88. Gange, 6, 10.
366
Gansu, 189, 194. Gaza, 41. Genova, 69, 80-81, 101-104, 108, 128, 147, 222, 314, 318, 322324, 326, 330. Georgia, 18, 44, 49, 116, 154. Gerico, 140. Gerusalemme, 8, 10, 41, 78, 123, 140, 142, 144, 146, 150, 160, 217, 227, 329. Giaffa, 134, 142. Giallo, Fiume (Huan He), 111, 245, 250, 273. Giappone, 200, 202-203, 283. Giava, 286, 293. Gilan, 158. Giordano, 140, 146. Gobi, deserto del, 48, 183-185, 189. Grado, 70-73. Gran Canale, 245, vedi anche Canale Imperiale. Grappa, monte, 98. Guangdong, 209, 236. Gujarat, 308. Hai, 245. Haifa, 77, 318. Hami, 186. Hangzhou, 208, 245, 272-273, 275-276, 278. Hebei, 119, 211, 245. Henan, 236. Hereford, 9. Hiroshima, 203. Hiva, 48, 110. Hormuz, isola e porto, 167-171, 304, 312. Hotan, 112, 181, 194. Hromkla, 157.
Huai, 245. Hunan, 209, 236. Iconio, 44, 107. Ikishima, 201. India, 6, 15, 164, 166, 181, 200, 253, 271, 286, 288-289, 301, 305, 307-308, 311. India Inferior, 10. India Magna, 10, 297. India Media, 10. Indiano, Oceano, 10, 292, 308, 324. Ionio, Mar, 73, 88. Iraq, 154, 163. Irrawaddy, 255. Islanda, 5. Istria, 72, 98. Jiangsu, 245, 270-271. Jiangxi, 205. Jingzhao, 246. Jinlianchuan, 210. Kaiping/Shangdu, 119-120, 210214, 229, 258. Kakozaki, 201. Kalka (Kal’cˇik), 17. Kanev, 46. Kara-Khoto (Haicheng), 191. Kara-Kitai, 14, 111. Karakorum, 38, 44, 49, 51, 59, 112, 121, 191, 287. Kashgar, 42, 112, 180. Katvan, 14. Kazakistan, 48. Kerala, 305. Kerman, 166, 169, 172. Khambhath, golfo di, 308. Khanbalik, vedi Dadu/Khanbalik.
367
Khorasan, 174, 315. Kiev, 20-21, 46-47, 49, 112. Kipchak/Qıpçaq, 18, 111. Kirghizistan, 179. Koko Nor (Qinghai Hu), lago, 48. Kolomna, 19. Krak des Chevaliers, 141. Kubanan, 173. Kunlu Shan, 180. Kunming, 251. Kurdistan, 12, 164. Kyushu, 201. Lajazzo, 125-126, 146, 319. Lanzhou, 191, 194. Laodicea (Latakia), 140, 314. Laos, 263. Lesbo, 79. Liao, 287. Liaoning, 211. Libano, 141, 313. Libia, 6. Liegnitz, 26. Lin-An, 208, vedi anche Hangzhou. Lio Maggiore, 91. Lione, 41, 45, 50, 149. Londra, 8, 162. Longquan, 205. Luan, 210, 212-213. Lucca, 222. Lucera, 176. Lugouqiao (Ponte Lugou), 247. Luoyang, 245. Maabar, 170, 288, 309, vedi anche Coromandel. Maarat an-Numan, 137. Madagascar, 309. Madras, 11, 297. Magione, 45.
Magna Hungaria, 18. Maiorca, 126. Makran, 308. Malabar, 16, 305. Malamocco, 73. Malvasia, 104. Manciuria, 48, 111, 287. Mangalore, 307. Mangi, 250, 264, 267, 293. Mansura, 54. Marmara, Mar di, 88, 105. Marsiglia, 126. Mazandaran, 158. Mediterraneo, Mar, 9, 74, 78, 93, 101, 108, 114, 117, 126, 141, 216, 237, 250, 291, 322. Mekong (Lancang), 254. Meloria, 323. Merv, 112. Mesopotamia, 42, 166, 175. Milano, 31. Mira, 77. Modone, 104. Mogadiscio, 309. Moldavia, 26, 37. Mongolia, 17, 25, 38-39, 42, 48, 54, 58, 108, 110, 119, 121, 189191, 194, 210, 287. Montenegro, 52, 77. Montpellier, 126. Moravia, 26. Mosca, 19. Mosul, 54, 164. Muhi, ponte, 28. Mukacˇevo, 26. Muziris (Kodungallur), 11. Mylapore, 11. Nabulus, 140. Nagasaki, 203.
368
Nagyvárad (Oradea), 34. Nanchino, 208. Napoli, 313. Narenta, 75. Nauplia, 76. Nazareth, 138, 146. Negroponte, 93, 105, 319, vedi anche Eubea. Nero, Mar, 18, 42, 56, 77, 82, 103, 105, 111, 318. Neustadt, 29. Nicea, 59, 88, 103, 105. Nicobare, isole, 295. Nicomedia, 106. Nicosia, 53, 60. Nilo, 9, 52, 216. Nîmes, 126. Nisibi, 12. Norvegia, 46, 101, 315. Novgorod, 19.
288, 291-292, 296, 311, 316, 320, vedi anche Dadu/Khanbalik. Peloponneso, 76, 88, 93. Perejaslav, 20. Persia, 13, 16-17, 20, 31, 44, 110, 114, 117, 137, 158-159, 164, 167, 174, 207, 290, 315-316, 320, 330. Persico, Golfo, 16-17, 166, 168, 216, 292, 299, 304. Pest, 21, 29. Pisa, 80-81, 323. Polonia, 21, 26-27, 30, 33, 46, 61. Porte di Ferro (Derbent), 7-8, 60. Praga, 21. Przemys´l, 21. Puglia (Puglie), 84, 93, 176, 250. Punjab, 113. Qazvin, 161. Qiemo, 182, 194. Quanzhou, 209, 291-293. Quarnaro, 75. Quiantang, 245. Quilon, 307. Quinsai, 272-273, 275-276, vedi anche Hangzhou.
Oder, 26. Olomouc, 27. Oman, 311. Oman, golfo di, 169. Ordona, 176. Oxus (Amudar’ja), 17. Pacifico, Oceano, 109, 199, 216, 262, 270, 292. Palermo, 16. Palestina, 15, 54, 79, 85, 108, 123, 136, 142, 148, 313. Pamir, 179. Panfilia, 76. Parigi, 55, 106, 150, 314. Pavia, 70, 74. Pechino, 111, 121, 126, 210, 229, 231, 239, 241-243, 245-246, 255, 258, 272, 278, 284, 287-
Racibórz, 26. Ragusa (Dubrovnik), 74-75. Ravenna, 70. Reims, 13. Rjazan’, 19, 30. Rodi, 77, 79, 126. Rodosto, 88. Roma, 10, 23, 43, 85, 149, 309, 314. Rosso, Fiume (Song Hong), 284. Rosso, Mar, 9, 216, 292, 311.
369
Rostov, 19. Rutenia, 27. Sahara, 184. Saint Albans, 33. Sajó, 28. Samarcanda, 14, 42, 112, 180, 189, 269. Samo, 79. San Giovanni d’Acri, 60, 79, 102, 138, 146, 151, 316, 330, vedi anche Acri. Sandomir (Sandomierz), 26, 61. Sansego, 73. Santa Severina, 74. Saragozza, 126. Saratov, 117. Sassonia, 46. Saveh, 165. Scozia, 314. Settepozzi, 104. Sevan, lago, 155. Shandong, 245, 266, 269. Shangdu, vedi Kaiping/Shangdu. Shanghai, 279. Shansi, 108. Sharon, 137, 140. Shatt al-Arab, 167. Sheberghan, 174. Siberia, 111, 320. Sichuan, 236, 250. Sicilia, 5, 77, 136, 250. Sidone, 138, 141, 318. Siponto, 176. Siria, 13, 16, 43, 76, 78, 112, 137, 152, 160, 162, 313. Siviglia, 126. Slesia, 26, 47. Socotra, 309. Soldaia, 18, 56, 107-108.
Spalato, 29, 33, 75. Sporadi, isole, 88. Sri Lanka, vedi Taprobane (Sri Lanka). Stiria, 74. Sumatra, 286, 293-295. Suzdal’, 48. Suzhou, 278-279. Syrdar’ja, 17. Tabriz, 43, 107, 116, 164, 313. Tagikistan, 171. Taloqan, 175. Tana (Azov), 108. Taprobane (Sri Lanka), 10, 295296. Taranto, 73. Tarse, 31. Taxila, 11. Tebe, 79. Tenduc, 211, 214. Terrasanta, 13, 43, 77-78, 84, 102, 108, 128, 134, 138-139, 142144, 146, 148, 151, 215, 311, 314. Tessalonica, 76, 82. Teykint, 284. Thang Long, 284-285. Tian Shan, 180. Tibet, 12, 228, 249. Tigri, 13, 112, 163. Tiro, 79, 140, 149, 318. Tonchino, golfo del, 263, 284. Tongyu, Canale, 245. Torcello, 75, 91. Tortosa, 318. Tracia, 86, 103. Trani, 250. Transilvania, 27. Transoxiana, 17, 117, 220.
370
Trapani, 104. Trebisonda, 88, 107, 112, 126, 318-319, 330. Tripoli, 60, 138, 141, 314, 330. Tropea, 74. Tsushima, 201. Tunisia, 46. Turfan, 42, 112. Turkestan, 137, 179.
Vidaya, 284. Vienna, 29. Viet Nam, 205, 263, 284, 288, 293. Vistola, 21, 26. Viterbo, 138. Vladimir, 19, 30, 47. Volga, 4, 18, 40, 47, 55, 116. Volinia, 21. Volo, golfo di, 81.
Udine, 29. Ufa, 18. Ukek, 117. Ulakci, 115. Ungheria, 21, 25, 28, 36, 46-47, 59, 84. Ural, 18. Urali, 48. Urmia, lago, 155. Uzbekistan, 48, 171. Uzˇgorod, 26.
Wuhu, 208. Wuvei, 189, 194.
Valacchia, 37. Valsugana, 98. Van, lago, 155. Venezia, 69, 71-72, 74-81, 83-84, 88-89, 92, 95-98, 102-104, 106108, 116, 118, 122, 127-128, 142, 145, 147, 170, 214, 216217, 222, 226, 238, 246, 261, 264, 272, 279, 290, 294, 311, 316, 319, 322-323, 327, 330. Veszprém, 36.
Xi’an, 112, 246. Xiangyang, 206-207. Xichang, 251. Xining, 191. Xinjiang, 112, 181, 183, 189, 194. Yangzhou, 262, 270-272. Yarkand, 194. Yazd, 166. Yemen, 141, 311. Yumen, 189, 194. Yunnan, 221, 250, 255, 262. Yutian, 181, 194. Zaitun, vedi Quanzhou. Zanzibar, 310. Zara, 75, 84. Zhangye, 189, 194. Zhejiang, 205, 245. Zhenjiang, 269.






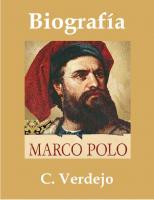


![Marco Polo [2 ed.]
9786052954768](https://dokumen.pub/img/200x200/marco-polo-2nbsped-9786052954768.jpg)
