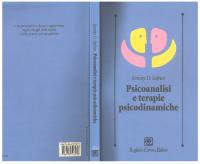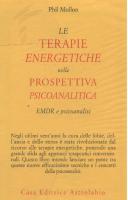Le terapie energetiche nella prospettiva psicoanalitica EMDR e psicoanalisi
165 55 10MB
Italian Pages [298] Year 2006
Polecaj historie
Table of contents :
Pagina vuota
Pagina vuota
Citation preview
Phil Mollon
LE
----- TERAPIE ENERGETICHE nella
PROSPETTIVA PSICOANALITICA •0
EMDR e psicoanalisi
Negli ultimi vent’anni la cura delle fobie, del l’ansia e dello stress è stata rivoluzionata dal ricorso alle terapie energetiche, ponendo una grande sfida agli approcci terapeutici convenzio nali. Questo libro intende lanciare un ponte tra queste nuove efficacissime tecniche e i concetti della psicoanalisi.
Casa E d i t r i c e A s t r o l a b i o
«PSICHE E COSCIENZA» Collana di testi e documenti per lo studio della psicologia del profondo
LE TERAPIE ENERGETICHE NELLA PROSPETTIVA PSICOANALITICA EMDR E PSICOANALISI
di P hil Mollon
Titolo originale dell'opera EMDR AND THE ENERGY THERAPIES PSYCHOANALYTIC PERSPECTIVES
(Karnac, London, New York)
Traduzione di Angelina Cunsolo
© 2005, Phil Mollon. First published by H. Karnac Books Ltd, represented by Cathy Miller Foreign Rights Agency, London, England © 2006, Casa Editrice Astrolabio - Ubaldini Editore, Roma
«PSI CHE E COSCI ENZA» COLLANA DI TESTI E DOCUMENTI PER LO STUDIO DELLA PSICOLOGIA DEL PROFONDO
Phil Mollon LE
TERAPIE ENERGETICHE nella
PROSPETTIVA PSICOANALITICA EMDR e psicoanalisi
ROMA
ASTROLABIO MMV I
ìndice generale
Prefazione...................................................................................................... L'emdr , I'eft e la psicoanalisi.............................................................. Il sogno a occhi aperti: da Freud all’E M D R ..................................... Cosa accade durante una seduta emdr o eft? ................................ L'abbandono dei ricordi, del trauma e della sessualità: l’ecces siva preoccupazione per il ‘transfert' e altri problemi della psi coanalisi contemporanea......................................................................... 3. L'angoscia di disintegrazione: resistenza profonda al cambia mento psicologico................................................................................... 6. Trattamento con emdr di una fobia di viaggiare dalle comples se radici traumatiche.............................................................................. 7. Jane: emdr e psicoterapia in una donna traumatizzata e vittima di violenza sessuale 8. Brevi esempi di c a s i .............................................................................. 9. Come usare I’emdr e i metodi energetici nella pratica. . . . 10. Un modello esaustivo della matrice psicosomatica: verso una te rapia energetica quantistica................................................................... 11. Le conclusioni cui è giunta la r i c e r c a ............................................... 12. Le esperienze personali di due te r a p e u t i..........................................
pag. 7
1. 2. 3. 4.
Bibliografia............................................................................ . . . Appendice........................................................ . N ote ....................................................................... . . . . . Ringraziamenti............................................................................................. Indice analitico ........................................................................ .
Finito di stampare nel dicembre 2003 presso la tipografia Giammarioli, via Fermi 8-10; Frascati per conto della Casa Editrice Astrolabio - Ubaldini Editore, Roma
» 11 » 37 >> 31
» 71 » 91 » 103 » »
120 » 133 194 »220 »232 »247
» » »
»
232 272 274 »283 286
A Hawkie, ... che sa collegare le parole... quelle sciamaniche e quelle psicoanalitiche
Prefazione
Quasi tutti coloro che si sottopongono alla terapia psicoanalitica la tro vano piuttosto utile, in quanto dà spazio al pensiero e ai sentimenti, offre l’opportunità di riflettere su esperienze emotive presenti e passate e costi tuisce un’arena psicologica entro cui mettere in gioco, e in parte risolvere, i conflitti delle prime relazioni di attaccamento. L’analizzato prende maggior coscienza delle proprie risorse più profonde, fatte di desideri, speranze e paure e, al tempo stesso, acquisisce familiarità con il linguaggio misterioso dei sogni e dell’inconscio. Nulla da eccepire, dunque, ma non bisogna dimenticare che tutte le tera pie verbali classiche, psicoanalisi, terapia cognitiva o consulenza individuale che dir si voglia, spesso non sortiscono i risultati sperati o producono mi glioramenti con una certa lentezza (Leuzinger-Bohleber e Target, 2002; Ro th e Fonagy, 1996). Di solito questa loro insufficienza viene spiegata con l’insita difficoltà di suscitare un cambiamento psicologico e psicodinamico profondo, nonché con il tempo inevitabilmente richiesto dal processo di maturazione della personalità. Possiamo a tal punto assuefarci a questi as sunti da non cogliere la cruda verità che nascondono: che le terapie verbali, cioè, non sono particolarmente efficaci o indicate ad assolvere l’obiettivo at tribuito loro, ossia la risoluzione dei modelli disfunzionali dell’emozione, del pensiero e del comportamento. La psicoanalisi può suscitare un grande insight, ma può essere lenta a produrre cambiamenti profondi a livello di sentimenti e di comportamento. L’inerzia del processo terapeutico si spiega con le lunghe discussioni di analisti e terapeuti sui significati del materiale verbale portato in analisi e con le loro interminabili speculazioni circa le di namiche che si creano tra cliente e terapeuta. Ma, se mancano informazioni chiaramente riconoscibili sul progresso del cliente nella risoluzione dei suoi problemi, non ci sono basi sufficienti per scegliere un’ipotesi piuttosto che un’altra. Come se non bastasse, diversi disturbi psicologici comuni, che comportano grande sofferenza, spesso non traggono alcun giovamento dal la psicoanalisi, dalla terapia cognitiva pura o dalla consulenza individuale. Uno di essi è il disturbo post-traumatico da stress.
8 Prefazione
Tra i pazienti in cura presso i servizi di igiene mentale del servizio sanita rio nazionale, un’elevata percentuale soffre in qualche misura di stress post traumatico. Lo stress può essere causato da eventi burrascosi recenti o da un trauma interpersonale subito durante l’infanzia, ma comunemente da entrambi i fattori (Alien, 2001; Mollon, 2002a). Il trauma, nelle sue varie forme, viene sempre più riconosciuto quale elemento fondamentale di un nuovo paradigma interpretativo della psicopatologia, specialmente in con comitanza con i progressi raggiunti dalla neurologia e dagli studi sull’attac camento primario (Schore, 1994; 2003a, b, c). Tuttavia, solo alla fine degli anni Ottanta si è cominciato a comprendere il disturbo post-traumatico da stress e a sviluppare terapie efficaci a curarlo. Tali progressi furono in parte suscitati dalla constatazione che molti reduci del Vietnam non riuscivano a guarire da gravi disturbi mentali dovuti alle esperienze traumatiche vissute in guerra. In un libro curato da Charles Fijley e pubblicato nel 1978 venivano esaminati in dettaglio i problemi psicoogici dei reduci. In un commento più recente, l’autore ha detto: “A distan za di quindici anni, dopo centinaia di ricerche e di articoli sulle terapie per aiutare i reduci a superare gli effetti psicologici della guerra, non ho ancora sentito parlare di guarigione” (Figley, 1999, p. v i i ). Deluso da tale mancan za di risultati terapeutici e nel tentativo di stimolare la ricerca verso più ra pide forme di trattamento del disturbo post-traumatico da stress, Figley, in sieme ad alcuni colleghi, fondò 1’“Active Ingredients Project” (Figley e Carbonell, 1995) e prese contatto con migliaia di medici di tutto il mondo, chiedendo suggerimenti su eventuali forme di trattamento nuove ed effica ci. Tra i metodi scoperti in questo modo emersero I’e m d r e un procedi mento, appartenente alla categoria della psicoenergetica, chiamato t f t (Thought Field Therapy, Terapia del Campo di Pensiero). Entrambi risulta vano molto più efficaci e veloci delle terapie verbali classiche ed entrambi facevano uso dei movimenti oculari. L’emdr e gli approcci che rientrano nel settore emergente della psicoe nergetica (Hartung e Galvin, 2003) si combinano egregiamente tra loro e, da un punto di vista procedurale, hanno molto in comune. Sono inoltre compa tibili con gran parte delle intuizioni originarie della psicoanalisi freudiana, co me pure con gli orientamenti degli studi successivi sull’attaccamento (Cortina e Marrone, 2003). L’emdr e i metodi della psicoenergetica possono essere applicati secondo modalità ispirate alla psicoanalisi. Tali forme di trattamen to, infatti, non sono superficiali, bensì capaci di raggiungere livelli profondi del sistema psicosomatico. Per di più, grazie al concetto di ‘rovesciamento della moralità corporea’ sviluppato da Diamond (1988), psichiatra di impo stazione kleiniana, e ad analoghe osservazioni di altri esponenti della psicoe nergetica, possiamo gettare uno sguardo nei processi corporei profondi della perversione, di certi aspetti della malattia fisica e dell’estinto di morte’.
Ì
Prefazione 9 Ma questi metodi e i risultati terapeutici che ottengono sollevano anche importanti domande su alcune tendenze presenti nella psicoanalisi sin dai tempi di Freud. Per esempio, fino a che punto il transfert è un veicolo fon damentale di guarigione? Dal momento che nell'EMDR e nei metodi ener getici non riveste un ruolo così centrale, è possibile che la vasta attenzione riservata al ‘transfert' da molte varianti della psicoanalisi contemporanea sia in realtà tutt'altro che giovevole, impedendo il necessario processo terapeu tico? Un'eccessiva insistenza sull'interazione che ha luogo ‘qui e ora' nella stanza del consulente non potrebbe sviare dal compito imprescindibile di elaborare il trauma e i conflitti radicati e conglobati sia nei ricordi espliciti sia in quelli impliciti? Nella diffusissima tendenza a gettare a mare la teoria freudiana della libido, modello energetico sopravvissuto nell'opera di Kohut, ma non in altri ambiti della psicoanalisi contemporanea, non è andato perduto qualcosa di importante? L’indagine psicoanalitica, con la sua lunga durata, il taglio non strutturato e le associazioni libere, non avrebbe una maggiore efficacia terapeutica se venisse combinata con un approccio più finalizzato ai problemi emotivi cruciali e alla loro elaborazione? Accanto al l'espressione verbale delle emozioni, non sarebbe importante prestare at tenzione anche all'esperienza che ne fa il corpo, un campo, questo, larga mente trascurato in ambito psicoanalitico anche dopo le ricerche pionieri stiche di Wilhelm Reich (1949)? Non si potrebbe sviluppare un modello più esaustivo del sistema psicosomatico e dei vari interventi terapeutici pos sibili, delineando i livelli gerarchici del corpo energetico, cognizione ed emozione, neurobiologia e fisiologia del corpo fisico (Furman e Gallo, 2000)? Questi sono solo alcuni dei problemi esaminati nei prossimi capitoli, i quali possono essere letti in qualsiasi ordine. A v v e rte n ze
Ci sono alcune ovvie avvertenze che i medici ben informati apprezzeran no senz'altro e che riguardano i concetti discussi in questo libro. Anche se I' e m d r suscita ricordi rimasti impliciti per qualche tempo, ciò non vuol di re che su di esso si può basare una ‘terapia per il recupero della memoria'. L ' e m d r non è assolutamente preposto a questo scopo. I nuovi ricordi emersi devono essere sempre trattati con cautela relativamente al loro sen so letterale o alla loro veridicità (Mollon, 2002a). Simili precauzioni valgo no a proposito del ‘test muscolare’, usato talvolta nell’ambito della psicoe nergetica. Benché in cinesiologia e in psicoenergetica esistano ricerche che ne convalidano i principi (si veda il capitolo 11), si tratta di un metodo es senzialmente soggettivo e intuitivo, la cui efficacia dipende in gran parte dall'abilità di chi lo applica. Può rappresentare una guida, ma non va mai
10 Prefazione
considerato un indicatore pienamente attendibile né della natura della ma lattia né delle esperienze patogene. Raccomando infine ai medici di non ap plicare i metodi delineati in questo libro se non sono sicuri della propria competenza al riguardo e se non conoscono a fondo la psicopatologia di un particolare paziente. Uso del termine EMDR Col termine e m d r (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, De sensibilizzazione e Rielaborazione attraverso i Movimenti Oculari) viene in dicato un metodo terapeutico, con solide basi teoriche e di ricerca, ideato e accuratamente sviluppato da Francine Shapiro, autrice tra l’altro di un esplicito protocollo in otto fasi destinato alla pratica clinica. Altri, compre so l’autore del presente libro, hanno usato alcuni principi e metodi di que sta combinazione di tecniche in modo diverso da quello raccomandato dal la Shapiro. Il lavoro che verrà qui illustrato è quello di uno psicologo clinico con una formazione psicoanalitica ed esperto in e m d r e in psicoenerge tica, il quale considera il proprio adattamento dell’EMDR essenzialmente psicoanalitico, benché probabilmente la maggior parte degli psicoanalisti non farebbe altrettanto. Similmente, alla luce dei protocolli della Shapiro, la maggior parte del lavoro presentato non verrebbe considerato e m d r . Si raccomanda ai clinici di non usare i metodi derivati dalPEMDR e qui illu strati senza una piena e profonda conoscenza dell’EMDR vero e proprio, ac quisita nell’ambito di un corso di formazione riconosciuto. Chi desidera ragguagli circa la pratica convenzionale e comprovata dell’EMDR consulti l’esaustivo volume di Francine Shapiro (2001).
1 L’e m d r , 1’eft e la psicoanalisi Se c’è qualcosa che l’uso clinico dell’EMDR ha dimostrato nei de cenni passati, è che il disturbo post-traumatico da stress rappre senta un eccellente parametro dei problemi soggiacenti alla mag gior parte delle patologie. In altre parole, una codificazione fisiolo gica disfunzionale delle percezioni non riguarda solamente chi ha subito in modo evidente un trauma, ma si ritrova, a dire il vero, in quasi tutti i problemi che spingono a entrare in terapia. S hapi ro , 2002b, p. 8
C O S ’È L ’E M D R ?
L’e m d r (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing;) è un metodo terapeutico che prevede l’uso dei movimenti oculari e di altri stimoli dell’at tenzione ‘bilaterale’ o ‘duplice’, nonché l’esposizione, attraverso le associa zioni libere, ai ricordi, ai pensieri e alle immagini angoscianti o emotiva mente dolorosi. I clinici che si specializzano in questa tecnica tendono a ri conoscerle un’efficacia assai maggiore rispetto a quella delle forme di psicoterapia puramente verbali. L’e m d r trova adepti tra professionisti di diver sissima impostazione terapeutica: psicoanalitica, cognitiva, comportamenta le, sistemica e neurobiologica (Shapiro, 2002a).
La scoperta dei movimenti oculari L’e m d r nasce come metodo di desensibilizzazione per l’ansia, usato principalmente nella cura del disturbo post-traumatico da stress. È stato sviluppato da una psicoioga clinica, Francine Shapiro, la quale si era accor ta in prima persona, durante un periodo di stress, di provare un certo sol lievo assecondando la realizzazione spontanea dei movimenti oculari da una parte all’altra. Condusse una ricerca controllata (1989a) e uno studio di casi che suffragarono la sua ipotesi, secondo cui i movimenti oculari dove vano essere in relazione con la desensibilizzazione dei ricordi traumatici.
12 Le terapie energetiche
Partendo da questa osservazione, la Shapiro sviluppò un protocollo tera peutico che prevedeva il ricorso deliberato ai movimenti oculari. La strate gia di intraprendere intenzionalmente azioni spesso attuate in maniera spontanea è una caratteristica ricorrente in questa impresa della Shapiro: F e m d r infatti si basa sul naturale processo di guarigione della mente e del cervello. I movimenti oculari si rivelarono un mezzo estremamente efficace di desensibilizzazione. Quando se ne occupò Joseph Wolpe, uno dei fonda tori della terapia comportamentale (Shapiro, 2002a, p. xix), i risultati tera peutici da lui riportati (Wolpe e Abrams, 1991) contribuirono a suscitare maggiore interesse per la nuova tecnica. Ma Francine Shapiro scoprì anche che essa conduceva a un cambiamento spontaneo dei pensieri disfunzionali, vale a dire delle cognizioni connesse al trauma. In maniera piuttosto stupe facente, i movimenti oculari sembravano determinare nella persona una ra dicale rivalutazione del trauma e della visione di sé. Di conseguenza, la Sha piro aggiunse al nome del metodo la parola rep ro cessin g (rielaborazione), collocandolo in tal modo oltre l'ambito di una semplice terapia di desensi bilizzazione comportamentale. In seguito Fautrice riconobbe che esso de terminava una rielaborazione generale e accelerata delle informazioni emo tive. Scoprì inoltre che Feffetto non era legato ai soli movimenti oculari, ma si poteva ottenere con qualsiasi tipo di stimolazione bilaterale, purché inte ressasse alternativamente i due lati del corpo o degli organi di senso. La causa probabile del fenomeno è che in tal modo vengono stimolati i due emisferi cerebrali. Per queste ragioni la Shapiro ebbe in seguito a pentirsi del nome assegnato al metodo, preferendo un termine come ‘elaborazione adattiva delle informazioni', ma la denominazione originaria è quella che ha preso piede. L'elaborazione delle emozioni, facilitata dalla stimolazione bi laterale, sembra determinare cambiamenti a livello neurobiologico (Levin, Lazrove e van der Kolk, 1999; Stickgold, 2002), rivelando una guarigione profonda del trauma psicologico. LE EMOZIONI SONO EVENTI CORPOREI L ’e m d r è, in parte, una forma di terapia basata sul corpo, nel riconosci mento che le emozioni sono di fatto eventi corporei.1 Il cliente deve notare le sensazioni corporee e per aiutarlo in tal senso gli va detto: “Fai attenzio ne solo a...''. In qualche modo, Fatto di dirigere l'attenzione alla sensazione, mentre continuano i movimenti oculari o altre forme di stimolazione bilate rale, tende a provocare un cambiamento corporeo, solitamente nel senso di una riduzione dell'agitazione fisiologica. Alcuni stati emotivi, come una for te ansia o il panico, sono fenomeni intensamente fisici, caratterizzati da pal pitazioni, sudorazione, tremore, difficoltà respiratoria, secchezza delle fau-
UEMDR, l’EFT e la psicoanalisi
13
ci, eccetera. Tali sintomi sono notoriamente difficili da alleviare con le sole terapie verbali. Nel caso del disturbo post-traumatico da stress, il discorso psicoanalitico può portare il cliente alla comprensione, ma non intaccherà minimamente la sua tendenza a rivivere i sintomi fisiologici invalidanti delFangoscia. Sono proprio queste impronte somatiche del trauma quelle che affronta 1'e m d r (van der Kolk, 2002). LA ‘P R E S E N Z A M E N T A L E ’
La procedura e m d r porta il cliente ad assumere una posizione di osser vatore relativamente ai contenuti e ai processi della propria mente. Egli vie ne invitato a prestare semplicemente attenzione ai pensieri, ai sentimenti e alle immagini che attraversano la sua coscienza. Ciò ricorda da vicino la ‘re gola fondamentale' freudiana delle associazioni libere. È inoltre piuttosto affine alla pratica della ‘presenza mentale', sviluppata di recente come com ponente della terapia cognitiva (Segai, Williams e Teasdale, 2002), e alla te rapia comportamentale dialettica (Linehan, 1993).
I C A M B I A M E N T I D E L L E C O G N I Z I O N I SU DI SÉ
Lo psicoterapeuta e m d r è attento ai pensieri significativi sviluppati dal cliente in relazione al traum a. I più im portanti si riferiscono alle credenze, ai giudizi o agli a ttrib u ti negativi su se stessi. M an m ano che l'esperienza traum atica viene elaborata, questi pensieri com inciano spontaneam ente a trasformarsi. P er facilitare il cam biam ento delle ‘cognizioni negative' si può scegliere u n ’appropriata ‘cognizione positiva': deve trattarsi di una valuta zione di sé realistica, ma positivam ente orientata. Col procedere dell’elabo razione, tali cognizioni positive vengono sem pre più accettate come valide. La prim a volta che mi sono im battuto nell'EMDR, sono rimasto sconcertato dalla sua palese capacità sia di eliminare le reazioni em otive eccessive (de sensibilizzazione) sia di installare cognizioni positive. Il principio che sem bra stare alla base dell'EMDR è che questo m etodo fa muovere l'elaborazio ne emotiva sem pre in una direzione positiva.
LE C A T E N E D I R I C O R D I T R A U M A T I C I A S S O C I A T I
L ’e m d r fa affiorare alla coscienza ricordi traumatici o emotivamente do lorosi legati da associazioni. Un trauma attuale può aver suscitato reazioni di stress eccezionali o prolungate quanto quelle prodotte da un'esperienza
14 Le terapie energetiche
anteriore, magari risalente all'infanzia, perché i due episodi sono connessi da associazioni. Il trauma più recente non può essere pienamente elaborato finché non lo è l'evento anteriore che esso riecheggia. Spesso queste catene di esperienze associate emergono spontaneamente nel corso della stimola zione bilaterale, ma possono essere suscitate più rapidamente con una sem plice domanda: “Quand’è che ti sei sentito così, in precedenza?". La se quenza di elaborazione che consiste nel tornare indietro nel tempo lungo catene di ricordi emotivi tra loro collegati, prestando attenzione agli aspetti corporei di questi, presenta una straordinaria affinità con l'approccio origi nario di Freud all'isteria (Breuer e Freud, 1895). L’EMDR COMPORTA L’I NSIGHT?
P u r non essendo stato concepito com e una forma di psicoterapia in tro spettiva, di fatto I'e m d r dà luogo alla presa di coscienza e alla com prensio ne dei conflitti psicodinamici e della loro origine. Ciò avviene in gran parte spontaneam ente, come conseguenza della stim olazione bilaterale, ma può essere favorito dal contenuto presentato dallo psicoterapeuta, il cosiddetto ‘intreccio cognitivo', che dovrebbe includere l’interpretazione psicoanaliti ca. La Shapiro ha n o tato che una caratteristica frequente dell'EMDR è il progressivo emergere di una prospettiva adulta relativamente al traum a in fantile. Il senso di im potenza, confusione, m ancanza di controllo e in ad e guatezza vissuto dal bam bino com incia a cedere il passo a una visione più realistica, tipica dell’adulto, e a esserne sostituito.
L’EMDR È UNA TERAPIA CHE F UN Z I O N A IN M O D O A U T ON OMO ?
Francine Shapiro non aveva immaginato I’e m d r come una terapia psi cologica compiuta. Inizialmente lo considerava una forma di trattamento destinato alla desensibilizzazione dei ricordi traumatici e alla riduzione del l’intensità delle emozioni moleste che caratterizzano il disturbo post-trau matico da stress, campo in cui la sua efficacia è stata dimostrata in modo estremamente lampante. Altri psicoterapeuti, però, ne hanno esplorato l'uso in una vasta gamma di problemi mentali. Ne è risultato che I’e m d r sembra avere una certa applicabilità in quasi tutti i settori della psicopato logia, ma soprattutto quando vi hanno parte il trauma o l'ansia. Nondime no, l’efficacia e la sicurezza del suo utilizzo dipendono molto dall’abilità del terapeuta e dalla sua precedente esperienza clinica. In tal caso può essere normalmente inserito in un’altra cornice terapeutica più tradizionale. Il
L’EMDR, I*EFT e la psicoanalisi
15
trattamento EMd r di una singola esperienza traumatica, in assenza di una precedente psicopatologia grave, è spesso facile e rapido, mentre quando ci sono problemi più complessi comporta un lavoro inevitabilmente più lungo e difficile. Se una persona durante l’infanzia ha subito ripetuti traumi inter personali, rifiuti e umiliazioni da parte di chi se ne prendeva cura, la sua personalità si sarà strutturata intorno alle esperienze traumatiche; il suo comportamento adulto presenterà reazioni profondamente radicate, volte a proteggerla dal pericolo di rivivere, in circostanze accidentali che agiscono come elementi associativi scatenanti dell’esperienza traumatica precoce, un’intollerabile sofferenza psichica combinata a ricorrenti rigurgiti di emo zioni negative schiaccianti. In questi casi Pe m d r può utilmente entrare a far parte del lavoro terapeutico, purché affiancato da molta attività psicote rapeutica di tipo più tradizionale o psicoanalitico. L ’E M D R È U N A T E R A P I A D E L L ’E S P O S I Z I O N E ?
L’e m d r suscita fenomeni psicodinamici, cognitivi, fisiologici e neuro biologici, producendo una trasformazione a ciascuno di questi livelli. Come fa? E qual è il meccanismo cruciale di cambiamento che utilizza? La ricerca ha dimostrato al di là di ogni dubbio che i cambiamenti determinati dalI’e m d r sono sostanziali e non attribuibili all’effetto placebo o a effetti non specifici (Carlson, Chem tob, Rusnak, Hedlund e Maraoka, 1998; Davidson e Parker, 2001; Marcus, Marquis e Sakai, 1997; Scheck, Schaeffer e Gillet te, 1998; Van Etten e Taylor, 1998). Alcuni hanno obiettato che I’e m d r sa rebbe essenzialmente una terapia dell’esposizione, simile ad altre forme standard di terapia comportamentale in cui, esponendo il paziente agli sti moli che scatenano l’ansia, si giunge all’estinzione della risposta secondo i principi del condizionamento classico (per esempio Lohr, Lilienfeld, Tolin e Herbert, 1999). Tuttavia, in queste forme di trattamento di solito si dà per scontato che l’esposizione sia prolungata, continua e ininterrotta, senza spostamenti dalla scena o dallo stimolo bersaglio (Foa e McNally, 1996; Lyons e Keane, 1989; Marks, Lovell, Noshirvant, Livanou e Thrasher, 1998). Tutte queste condizioni verosimilmente necessarie vengono violate dal protocollo dell’EMDR, che prevede esposizioni brevi e interrotte, non ché il ricorso alle associazioni libere.
I M O V I M E N T I OCULARI S O N O NECESSARI?
Il ruolo dei movimenti oculari in relazione all’elaborazione delle emozio ni era conosciuto assai prima che venisse sviluppato I’e m d r (Antrobus,
16
Le terapie energetiche
Antrobus e Singer, 1964), e Donna Eden (1998) riferisce di aver “sentito parlare di versioni di questa tecnica tramandate da secoli in varie culture” (p. 330). Alcune ricerche hanno messo a confronto gli effetti di un metodo di esposizione ripetuta con quelli della medesima procedura, cui erano stati aggiunti i movimenti oculari: ne è risultato che quest’ultima componente produceva significative riduzioni dei livelli di angoscia e di eccitazione psi cofisiologica (Lohr, Tolin e Kleinknecht, 1995, 1996; Montgomery e Ayllon, 1994). Siegel (2002) riferisce che, quando ha usato la stimolazione sen soriale non bilaterale o non alternata con pazienti che in precedenza aveva no risposto positivamente all’EMDR, questi non hanno più provato né sol lievo né rilassamento. Studi sui soli movimenti oculari, ossia senza le altre componenti dell’EMDR, indicano che essi sono effettivamente in grado di produrre risultati quali la riduzione dell’eccitazione fisiologica e dell’inten sità delle immagini mnestiche (Andrade, Kavanagh e Baddeley, 1997; Barrowcliff, MacCulloch e Gray, 2001; Kavanaugh, Freese, Andrade e May, 2001; Sharpley, Montgomery e Scalzo, 1996; van den Hout, Muris, Sale mink e Kindt, 2001; Wilson, Silver, Covi e Foster, 1996). Mentre altre ri cerche, caratterizzate da una varietà di progetti e di misurazioni dei risulta ti, hanno avuto esiti ambigui. Secondo Smyth e Poole (2002), la concentra zione dell’EMDR sull’immagine traumatica, le sensazioni corporee, le emo zioni e le credenze sarebbe essenzialmente quella che la terapia comporta mentale cognitiva rivolge all’elaborazione delle emozioni e agli elementi co gnitivi, di modo che, se all’EMDR si tolgono i movimenti oculari, “lo si può considerare una modesta integrazione di tutti gli elementi essenziali della vecchia e della nuova terapia comportamentale” (Smyth e Poole, 2002, p. 159). A tutt’oggi non sono state ancora condotte ricerche rilevanti su altre forme di stimolazione bilaterale. Maxfield (2002) ha sintetizzato a che pun to stia la ricerca suU’e m d r , senza escludere i risultati raggiunti circa il ruo lo dei movimenti oculari e indicando i settori che richiedono ulteriori studi. Chi ha una conoscenza pratica dell’EMDR difficilmente metterà in dubbio il contributo della stimolazione bilaterale: talvolta gli sarà capitato di assiste re all’effetto ‘scroscio’, allorché, non appena iniziano i movimenti oculari, l’emozione straripa. L’I N T E G R A Z I O N E DELLE F U N Z I O N I DEI DUE EMISFERI CEREBRALI
I clinici non hanno tardato a riconoscere la possibile connessione tra mo vimenti oculari dell’EMDR e fasi r e m (R a p id E y e M o v e m e n t , rapidi movi menti oculari) del sonno (Shapiro, 2001). Tanto i sogni quanto I’e m d r han no a che fare con l’elaborazione delle informazioni emotive e le fasi r e m del
L’EMDR, I’EFT e la psicoanalisi
17
sonno potrebbero essere preposte al trasferimento delle informazioni dalrippocampo, dove sono immagazzinate come memoria episodica, al neocor tex, dove vengono trasformate in una conoscenza più generalizzata, o me moria semantica (Stickgold, 2002). Una paziente ha descritto con grande chiarezza questo fenomeno, riferendo che, dopo alcune sedute di e m d r , non era stata più tormentata dai ricordi intrusivi di specifici episodi di abu so sessuale subiti durante l’infanzia, pur continuando a sapere che quei fatti erano quanto le era accaduto da bambina: pertanto si sentiva libera dal pas sato. Un’ulteriore ipotesi è che la sensazione bilaterale, stimolando alternati vamente ciascuno degli emisferi, faciliterebbe la comunicazione tra di essi. La tesi secondo cui i movimenti oculari sarebbero associati all’attivazione dell’emisfero opposto del cervello è stata sostenuta nel lavoro presentato da Kinsbourne trent’anni or sono (Kinsbourne, 1972, 1974). Siegei (2002) se gnala la scoperta seguente: quando le persone devono recuperare un ricordo autobiografico, tendono a guardare a sinistra (il che indica l’attivazione dell’emisfero destro); anche i flashback traumatici sembrano implicare un’in tensa attivazione dell’emisfero destro (e della corteccia visiva), con una con temporanea disattivazione dell’emisfero sinistro, che presiede al linguaggio. Gli elementi fattuali e semantici del ricordo sembrano coinvolgere l’emisfe ro sinistro. Da tutto ciò emerge l’ipotesi che la stimolazione bilaterale ritmi ca induca un’attivazione di entrambi gli emisferi e pertanto favorisca l’inte grazione di elementi diversi del ricordo, consentendo forse anche la forma zione di nuovi percorsi sinaitici in luogo dei precedenti schemi perseverativi dell’eccitazione traumatica. È probabile che la facilitazione dello scambio tra la parte destra del cervello, preposta all’elaborazione delle emozioni, e la parte sinistra, preposta al linguaggio, combinandosi con il breve resoconto verbale che il cliente deve produrre alla fine di ogni serie di stimolazioni bi laterali, agevoli l’integrazione tra emozioni e linguaggio: di conseguenza il ri cordo traumatico non è più un’esperienza da rivivere all’infinito come un so gno a occhi aperti, ma diventa una storia che può essere raccontata. Un altro punto di vista viene offerto dalla tesi secondo cui lo stress trau matico determinerebbe una disorganizzazione cerebrale, la quale provoche rebbe, in particolare, la chiusura dei percorsi integrativi del corpo calloso e della connessura anteriore del cervello che collegano i due emisferi (Krebs, 1998). Ne deriva l’impossibilità per il pensiero logico e razionale di entrare in contatto con l’esperienza emotiva, e per l’immagine visiva e la rappresen tazione verbale (elaborate rispettivamente nell’ippocampo sinistro e in quello destro) di integrarsi adeguatamente. Da ciò possono scaturire svaria te disfunzioni cognitive e, nei bambini, difficoltà di apprendimento. Per correggere questo tipo di disorganizzazione neurologica sono stati usati movimenti oculari piuttosto simili a quelli dell’EMDR (Dennison e Denni son, 1994; Krebs, 1998).
18 Le terapie energetiche IM P L IC A Z IO N I PER LA C O M P R E N S IO N E DELLA PSICOPATOLOGIA
Afferma la Shapiro: La tesi essenziale della terapia em d r è che il sedimento fisiologico delle esperienze passate della vita è la chiave interpretativa del comportamento, del la personalità e dei fenomeni psicologici che vi si accompagnano. Secondo questa prospettiva, le informazioni percettive relative alle esperienze passate, sia negative sia positive, possono essere elaborate in forma di concetti allorché vengono immagazzinate nelle reti della memoria. L’apprendimento naturale ha luogo quando vengono effettuate senza ostacoli associazioni adattive. Tuttavia, a seguito di un trauma, si può creare uno squilibrio del sistema e un immagaz zinamento disfunzionale dell’esperienza. Se un’esperienza viene immagazzina ta in modo disfunzionale, contiene in sé le percezioni originali, comprese le emozioni sconvolgenti e le sensazioni fisiche provate al momento del trauma (Shapiro, 2002a, p. 42).
In questa formulazione sintetica, la Shapiro, richiamandosi forse all’af fermazione freudiana secondo cui l’Io è “prima di ogni altra cosa un Io-cor po” {L'Io e l’Es> 1922b, p. 490), mette in risalto come l’esperienza sia radi cata nella sfera fisiologica. Le prime indagini di Freud riguardavano il cor po: i suoi primi pazienti erano quelli che presentavano disturbi isterici del le funzioni corporee e le sue teorie riguardavano i processi neurobiologici, le zone di eccitamento fisico e le vie corporee della libido. Secondo l’ipotesi illustrata nel Progetto di una psicologia (1895), i desideri dovuti alla spinta biologica, scontrandosi con la realtà, suscitano dolore o piacere e l’organi smo impara a evitare il dolore mediante una varietà di meccanismi di difesa per inibire o deviare l’eccitamento pulsionale: è attraverso questo processo di adattamento che si sviluppa la personalità. Per Freud, come per la Shapi ro, la psicopatologia, al pari dei sogni, è costituita da reti di ricordi; i ricordi sconvolgenti che risalgono all’esperienza dolorosa infantile, benché sotto posti alle strategie di evitamento, possono scatenarsi in qualsiasi momento, con tutte le relative reazioni fisiologiche, se si presenta un indizio associati vo. È questa la mente psicodinamica. La terapia consiste nell’accedere ai desideri e ai ricordi o alle fantasie di dolore associate a essi, rivalutandoli al la luce della consapevolezza adulta, ed è quanto fanno sia I’e m d r sia la psi coanalisi freudiana.
L’EMDR, ÏEFT e la psicoanalisi
19
C O S ’È LA P S I C O E N E R G E T I C A ?
Psicoenergetica è il nome generico dato a una famiglia emergente di stru menti sperimentali di rapida efficacia che utilizzano le vie energetiche corporee (sistema dei punti meridiani di agopuntura), i centri energetici (chakra) e il biocampo (aura) per favorire il raggiungimento di obiettivi psicologici, spiri tuali, mente-corpo e di massimo rendimento (Grudermeyer, 2003, p. vi). Sta per sorgere una nuova era nel campo della terapia psicologica e voi ave te la gioia di contemplarne l’aurora (Gallo, 2002, p. x i i ).
Le origini Il termine ‘psicoenergetica’ si riferisce a una classe di terapie che fanno risalire la sofferenza psicologica e fisiologica a disturbi o blocchi dei campi energetici sottili del corpo (Grudermeyer, 2002). La maggior parte di que ste terapie si ispira ai fondamentali contributi dello psichiatra John Dia mond, scopritore dei legami tra meridiani energetici ed emozioni (si veda per esempio, Diamond, 1985), e il loro approccio solitamente consiste nel far sì che il cliente stimoli con le dita punti di agopressione mentre è con centrato su un particolare aspetto della propria angoscia o sofferenza emo tiva. Molte sono le varianti, ma le due più famose sono la TFT ( Thought Field Therapy, Terapia del Campo di pensiero) e una sua versione modifica ta e semplificata denominata e f t (Emotional Freedom Techniques, Tecni che di Liberazione delle Emozioni). La prima fu scoperta dallo psicologo clinico, Roger Callahan, il quale, dopo mesi di infruttuosi tentativi in cui aveva usato tutti i metodi psicoterapeutici che conosceva (Callahan, 2001a) per curare la sua paziente Mary, affetta da una forma grave e annosa di idrofobia, “per capriccio e per disperazione” {ibid., p. 8) ebbe un’ispirazio ne improvvisa. Attingendo alla propria conoscenza della medicina cinese e della teoria dei meridiani dei flussi energetici, chiese a Mary di tamburella re con le dita (tapping) su un punto di agopressione situato sotto Tocchio pensando contemporaneamente alla propria fobia. L’angoscia della donna tendeva a localizzarsi in particolare nello stomaco e Callahan sapeva che il punto sotto l’occhio era la sede di una terminazione del meridiano dello stomaco. Dopo due minuti di tapping, Mary dichiarò, piena di stupore, che la fobia se ne era andata e, a quanto riferisce Callahan, dopo vent’anni ne è ancora libera. A seguito di questa sorprendente scoperta, Callahan comin ciò a indagare il fenomeno e a svilupparlo come approccio terapeutico. An che se la tecnica talvolta produceva effetti notevoli, all’inizio aveva un suc cesso “soltanto del tre per cento” (ibid., p. 10). A poco a poco, Callahan si
20 Le terapie energetiche accorse che la maggior parte dei suoi pazienti aveva bisogno di sequenze di tapping sui punti di agopressione e che diversi problemi psicologici richie devano formule o ‘algoritmi’ differenti di tapping. Si accorse anche che il metodo, che egli cominciò a denominare ‘terapia del campo di pensiero’, determinava cambiamenti fisiologici, tanto è vero che uno dei fattori scelti per la misurazione dei risultati è stata la variabilità del battito cardiaco (Cal lahan, 2001b, c; Pignotti e Steinberg, 2001). Quando Callahan perfezionò il metodo, la percentuale di successo aumentò sensibilmente. Uno dei suoi studenti, Gary Craig, ideò una sequenza di tapping universale semplificata, applicabile più o meno a qualsiasi problema psicologico e denominata ‘tec niche di liberazione delle emozioni’ (Carrington e Craig, 2000).2 Chi voles se conoscere in dettaglio I’eft e ricevere materiale didattico può consulta re il sito internet di Gary Craig: www.emofree.com. INTERRUZIONI DEL CAMPO ENERGETICO
Una delle implicazioni importanti delle scoperte cliniche di Callahan e di Craig è che l’angoscia e i disturbi emotivi non risiedono essenzialmente nel l’apparato neurobiologico, nei ricordi, nelle cognizioni, nei modelli interni di relazione, nelle fantasie persistenti e in tutto ciò che il trauma ha segnato, ma piuttosto nei campi energetici delle persone. Sono poi i modelli secon do cui sono codificate le informazioni in tali campi a determinare le fre quenti ripercussioni del trauma in tutto il sistema psicosomatico.3 È diffici le sfuggire a questa conclusione, se sono da prendere sul serio le testimo nianze di cambiamenti estremamente rapidi e duraturi determinati dalla sti molazione dei meridiani energetici. Per questo Callahan ha affermato che la causa fondamentale della sofferenza emotiva è una perturbazione di un campo di pensiero. Tale perturbazione “contiene informazioni attive, con cetto mutuato dalla fisica quantistica, di tipo altamente specifico (vale a di re un aspetto sottile, ma nettamente isolabile, del campo di pensiero) re sponsabili dello scatenamento di emozioni negative” (Callahan, 2001a, p. 25). Similmente, Craig nei suoi materiali didattici presenta la seguente for mulazione: “La causa di tutte le emozioni negative è un’interruzione nel si stema energetico corporeo”. Questa ipotesi intorno a informazioni che ri siederebbero nel campo energetico sottile del corpo ricorda molto da vici no quella dei campi morfogenetici che fornirebbero all’organismo una sor ta di progetto, proposta da alcuni biologi. Sheldrake li descrive come “cam pi di influenza auto-organizzanti, analoghi ai campi magnetici e ad altri campi della natura già noti” (Sheldrake, 1999, p. 258) e li considera dotati di memoria. Idee del genere sono state abbracciate dal fisico quantistico David Bohm (Bohm e Sheldrake, 1985) e anche Callahan collega le sue teo-
L’EMDR, I'EFT e la psicoanalisi 21 rie a quelle debordine implicato’ di Bohm. L’ipotesi che intorno al corpo ci sia un campo energetico auto-organizzante, contenente informazioni e capace di ricordare e di evolvere, offre la possibilità di collegare tra loro molti fenomeni differenti e per motivi diversi sconcertanti, come la telepa tia e l’apprendimento di gruppo (Hawkins, 1995; Sheldrake, 1985, 1988, 1999; Sheldrake, McKenna e Abraham, 1998). Tale ipotesi può anche con tribuire in qualche modo a spiegare il ben noto e tuttavia sconcertante pro cesso per cui un’esperienza traumatica precoce rilevante tende a ripetersi in condizioni tematicamente simili, al punto da sembrare non di rado quasi un fenomeno magico. Considerare le relazioni umane in termini di transazioni energetiche ha molte profonde implicazioni (si veda Hartmann, 2003b, 2004). Un’altra idea interessante e originale è che nell’unità energetica corpo/mente è contenuto il modello ideale di come sarebbe la persona se fosse nata in un ambiente convenientemente facilitante (Hartmann, 2004). Se la causa immediata del disturbo emotivo è uno squilibrio del sistema energetico corporeo, ne segue che occorre intervenire innanzitutto a tale li vello. Non è necessario che la persona riviva completamente i contenuti del ricordo traumatico, a patto che l’interruzione energetica venga sbloccata. Pertanto, anche se un ricordo o un pensiero può scatenare sofferenza emo tiva, non si tratta di un effetto diretto: l’elemento intermedio cruciale è il di sturbo del corpo energetico. L’attenzione a tale elemento distingue I’e f t e la TFT dalle altre terapie psicologiche, inclusa la psicoanalisi, la terapia co gnitiva e I’e m d r . Tuttavia, l’approccio energetico può essere utilmente combinato con aspetti dell’EMDR e di altri approcci (Benor, 2002; Hartung e Galvin, 2003; Lane, 2002; Weil, 2002). IL CAMPO ENERGETI CO SOTTILE E I P U N T I DI AGO P RES S I ONE
Nonostante i suoi metodi siano molto nuovi, i concetti e le conoscenze su cui si basa la psicoterapia energetica sono antichi e si ritrovano in molte parti del mondo (Gallo, 1999). L’energia sottile, nota come chi nel sistema cinese e prana nello yoga indiano, può essere individuata e misurata con di spositivi appropriati, quali la ‘camera Kirlian’ e la ‘camera Coggins’, en trambe ideate per fotografare l’aura (Tiller, 1997). Si ritiene che l’energia sottile fluisca lungo i quattordici meridiani principali, collegandosi ai sette chakra, o centri energetici, maggiori. La Pert (1999, 2000) descrive i corre lati neurofisiologici dei chakra come dei ‘minicervelli’, ossia centri dove vengono ricevute ed elaborate le informazioni elettrochimiche. Molte forme di medicina/terapia complementare attingono ai concetti relativi ai campi energetici. L’efficacia dell’agopuntura e dell’agopressione nella cura di va-
22 Le terapie energetiche
rie malattie, non esclusi i problemi di salute mentale, è stata suffragata da ricerche di alto livello (Apostopoulos e Karavi, 1996; Stux e Pomeranx, 1995). Per di più, a conferma della validità dei punti di agopressione, è emersa una marcata differenza tra questi e gli altri punti della pelle in ter mini di resistenza elettrica (Cho, 1998; Cho e Chung, 1994; Liboff, 1997). I P R E C U R SO R I DELLA PSICOL OG IA E NE R GE T IC A
La TFT di Callahan e la e f t di Craig hanno avuto due insigni precurso ri, tra i moderni. Negli anni Sessanta il chiropratico George Goodheart sviluppò il metodo della 'cinesiologia applicata’, in cui viene usata la forza dei muscoli come test di verifica in risposta a vari tipi di indagine sulla sa lute e sulla malattia. Tale approccio, che veniva a collegarsi con la teoria dei meridiani energetici, fu sviluppato in una varietà di direzioni (si veda Krebs, 1998 per un’esposizione informativa, nonché Durlacher, 1995). Qualche anno dopo, lo psichiatra John Diamond (1979, 1985, 1988), che veniva dalla psicoanalisi kleiniana, applicò il metodo di Goodheart alla psichiatria e scoprì che i diversi stati emotivi sembravano associati ai diver si meridiani. Mediante il test muscolare localizzava i meridiani energetici rilevanti per i diversi problemi emotivi e poi invitava i pazienti a mettere una mano sull’organo del corpo associato a quel meridiano, ripetendo con temporaneamente un’affermazione che ne correggesse lo squilibrio. Si ac corse così che, correggendo sistematicamente i disturbi dei meridiani inte ressati, riusciva rapidamente a sciogliere strati di conflittualità psicodina mica inconscia. IL R O V E S C I A M E N T O P S I C O L O G I C O E ALTRI O S T A C O L I
Diamond scoprì un altro fenomeno, che si sarebbe dimostrato di vitale importanza nelle forme successive di psicoterapia energetica: si tratta di un processo, da lui denominato “rovesciamento della moralità corporea” (1988, p. 15), per cui assai spesso le persone reagiscono contro le proprie intenzioni positive. In seguito Callahan e Craig lo chiamarono 'rovescia mento psicologico’, considerandolo una sorta di capovolgimento di polarità del sistema dei meridiani. Quando tale fenomeno è operante, il test musco lare dà risultati paradossali o insensati, per cui ad esempio l’amore risulta cattivo e l’odio buono, e rivela che la persona desidera essere malata e mo rire. Vi è chiaramente qualche somiglianza con i concetti psicoanalitici di resistenza, reazione terapeutica negativa e istinto di morte. Ho riscontrato casi piuttosto sconcertanti di rovesciamento psicologico quando ho usato
UEMDR, l’EFT e la psicoanalisi 23 I’e f t con pazienti che avevano subito gravi forme di abuso durante l’infan
zia. Queste persone percepivano il rilassamento come qualcosa di pericolo so, un abbassare la guardia in am biente ostile; l ’effetto rilassante dell’EFT induceva allora un aum ento paradossale dell’angoscia e dell’agitazione ge nerale. T uttavia possono essere m olte e svariate le cause e le m otivazioni che determ inano il rovesciam ento psicologico (Gallo, 2000).
Effettuando esperimenti con il test muscolare e attingendo ai concetti di Goodheart e Diamond, Callahan sviluppò un metodo capace di neutraliz zare il rovesciamento psicologico e di curare un fenomeno analogo, deno minato 'problema della respirazione clavicolare’ o, secondo altri terapeuti energetici e cinesiologi, 'disorganizzazione neurologica’ (Walther, 1988). In seguito si accorse che, in una minoranza di casi, il mancato sblocco del campo di pensiero sembrava dovuto alla presenza di una tossina, l’elimina zione della quale consentiva la normale e rapida elaborazione. Questa idea, a prima vista sorprendente, diventa più comprensibile quando si considera che i campi energetici corporei possono benissimo subire l’interferenza del le tossine e che il processo può funzionare anche nella direzione opposta, per cui, grazie a metodi energetici recenti, si riescono a ridurre le reazioni allergiche (come riferiscono, per esempio, Radomski, 2000, 2002; Scott e Goss, 1988; Tenpenny, 2002). Callahan sottolinea che la TFT funziona in modo così rapido e palese che il terapeuta è in grado di verificare più o me no all’istante se ha scelto i punti di agopressione giusti o se interferiscono altri fattori, come il rovesciamento psicologico; però questa caratteristica è in netto contrasto con la psicoterapia tradizionale, che agisce in modo così lento e inefficace che raramente è possibile sapere con una certa sicurezza se il metodo o l’obiettivo sono corretti o no. Così scrive Callahan: Il motivo per cui la psicoterapia tradizionale può vantare un così scarso nu mero di successi è che ha sempre giocato la ‘partita sbagliata’. Il problema non risiede essenzialmente nel sistema cognitivo, nelle esperienze passate, oppure nel cervello o nel sistema nervoso, bensì nel campo di pensiero (Callahan, 2001a, p. 39). COME REGOLARE IL CAMPO DI PENSIERO
Se Callahan ha messo in evidenza la specificità delle sequenze di ta p p in g , Craig ha sviluppato I’e f t come sequenza più universale, capace di coprire tutti gli aspetti eventualmente necessari. Attingendo alla propria formazio ne di ingegnere, si serve dell’analogia della macchina sul cui cruscotto una spia segnala la presenza di un guasto: si potrebbe cercare di affrontare il problema con una diagnosi accurata, oppure sottoponendo la macchina a
24 Le terapie energetiche
un servizio completo di manutenzione in modo da scovare ed eliminare ogni difetto. Ma ciò che Craig mette in luce è l’importanza di sintonizzare la mente sull’aspetto giusto e specifico del problema emotivo. Se applicato a livello troppo ampio, I’e f t non funziona. Occorre invece individuare e sottoporre a tapping le esperienze rilevanti e, talvolta, ogni loro aspetto emotivo, stato mentale o sensazione corporea. Lo scopo è cercare di identi ficare i problemi emotivi essenziali più importanti, per localizzare ed esplo rare i quali a volte occorre una notevole perizia clinica. Personalmente, spesso dedico molto tempo all’indagine verbale tradizionale, in modo da in dividuare a poco a poco le sfumature significative dei traumi, delle ansie e dei conflitti e invitare poi il cliente a esercitare il tapping utilizzando le sue stesse parole e frasi. Se non viene trovato il punto focale giusto, il tapping può non aver effetto. Così, se per ogni sequenza di tapping basta qualche secondo, problemi complessi possono richiedere più sequenze nella misura in cui vengono identificati vari aspetti di una situazione emotiva. Comune mente si osserva anche una stratificazione delle emozioni, per cui non appe na ne viene risolta una, ne emerge un’altra. Il mancato riconoscimento di tale stratificazione può rendere poco chia ra l’elaborazione del trauma; se, dopo una sequenza di tapping, il cliente ri ferisce che l’esperienza bersaglio contiene ancora lo stesso livello di soffe renza, vuol dire che è stata elaborata un’emozione, ma ne è emersa un’altra analogamente inquietante. Per esempio I’e f t venne utilizzato per aiutare una donna a elaborare l’esperienza traumatica di avere un figlio malato di mente. Dopo aver esercitato il tapping relativamente ai vari aspetti emotivi, come lo shock, la confusione, l’angoscia e la rabbia, la paziente riferì di pro vare lo stesso turbamento al ricordo dell’esperienza. Ma, quando le fu chie sto quale fosse adesso per lei la parte peggiore, disse che era il vedere il fi glio così sofferente e non poter entrare in contatto con lui. Dopo aver effet tuato il tapping sintonizzata su questo aspetto, riportò di nuovo un elevato livello di sofferenza, che ora aveva a che fare con il pensiero di aver paura del figlio. Anche questo aspetto venne affrontato con il tapping, ma il risul tato rimase il medesimo. Quando le venne chiesto quale particolare ele mento la turbasse adesso, spiegò che si trattava del pensiero di provare rab bia nei confronti del figlio, sentimento che non avrebbe dovuto avere. Sot toposto a tapping anche questo aspetto, alla fine riferì che l’evento non le suscitava più sofferenza. Tale necessità di focalizzarsi o di sintonizzarsi su specifiche emozioni o aspetti di un’esperienza distingue I’e f t dall’EMDR. L’elaborazione suscitata da quest’ultimo è assai più ‘a tappeto’: i movimen ti oculari o le altre forme di stimolazione bilaterale, fanno procedere l’ela borazione da un aspetto emotivo all’altro. Invece il terapeuta che pratica I’e f t deve essere più attento a riconoscere gli impercettibili cambiamenti degli aspetti elaborati.
L ’EMDR, rE F T e la p sic o a n a lisi
25
Talvolta 1 'em d r può rivelarsi utile in quanto fa emergere aspetti più spe cifici che possono poi essere elaborati con I'eft . Per esempio, una donna riferì di aver Voglia di piangere' ogni volta che pensava a un grave inciden te stradale che le aveva lasciato notevoli difficoltà fisiche e psicologiche. Esercitando il tapping mentre pensava di aver Voglia di piangere', non ri portò alcun cambiamento e non fu in grado di individuare nessun’altra emozione. Ma una serie di movimenti oculari fece rapidamente emergere in lei i seguenti pensieri e sentimenti: rabbia per l'impatto che aveva sulla sua famiglia; rabbia e tristezza per aver bisogno di altri interventi chirurgici e, in conseguenza di ciò, dover rimandare il progetto di avere dei figli; paura del dolore che le avrebbero provocato tali interventi; ancora rabbia perché dell’incidente che le provocava tutte queste sofferenze non aveva alcuna colpa; rabbia, infine, perché probabilmente l'altro automobilista non si ren deva conto di quello che lei stava passando. A quel punto fu possibile ela borare ciascuno di questi aspetti con I'eft . Anche se è importante sintonizzarsi sulle specifiche emozioni, quando si usano i metodi energetici non è necessario che il cliente sperimenti tutta l’intensità dell'esperienza angosciosa; è sufficiente che, mentre esercita il ta ppin g , abbia quel tanto di consapevolezza che gli consenta di andare oltre la superficie dell'emozione. Questo è un altro aspetto che distingue I'eft dall’EMDR, il quale tende a immergere totalmente il cliente nell'intensità dcll’esperienza traumatica bersaglio. L’eft e i metodi correlati spesso sembrano funzionare molto bene con i sintomi fisici. Ovviamente non possono guarire direttamente i danni subiti dai tessuti o le malattie gravi, ma spesso danno luogo a un notevole sollievo, specialmente se il dolore dipende in parte dalla tensione e dallo stress. Mol ti di questi casi sono descritti sul sito internet di Gary Craig (www.emofree.com). Avendo trovato nell'EFT un valido aiuto alla risoluzione dei suoi problemi emotivi, una paziente ha chiesto di recente se il metodo l'avrebbe potuta aiutare a guarire da una sinusite che l'affliggeva da una settimana. Non appena il pensiero della ‘sinusite' fu sottoposto a tapping, la donna co minciò a ridere, riferendo di sentirsi improvvisamente liberata dal catarro. Dopo una seconda sequenza, i seni nasali erano completamente liberi. Esperienze del genere non sono rare. RASSEGNA DELLE RICERCHE
Oltre ai molti casi illustrati nei libri sulla TFT e suII’e f t (per esempio, Callahan, 2001a; Figley e Carbonell, 1995; Hartmann, 2002; 2003a; Lynch e Lynch, 2001), esiste sull’argomento una gran quantità di studi pubblicati sul le riviste scientifiche, in particolare su un numero speciale del Journal of Cli-
26 Le terapie energetiche
nicalPsychology (2001, vol. 57, n. 10). Così, Sakai e altri (2001) hanno riferito l’applicazione di queste tecniche a un’ampia varietà di problemi clinici in ambito psichiatrico generale. Il loro uso per curare un trauma di guerra è sta to descritto da Johnson, Shala, Sejdijai, Odell e Dabishevci (2001). La varia bilità del battito cardiaco come interessante misurazione dei risultati della TFT è stata discussa da Callahan (2001b; 2001c) e da Pignotti e Steinberg (2001). Swingle, Pulos e Swingle (2001), nel loro resoconto sull’uso dell’EFT con vittime di incidenti stradali affette da disturbo post-traumatico da stress, hanno descritto significativi cambiamenti nelle onde cerebrali dei pazienti, che però accusavano anche sintomi di stress. Swingle (2001) ha riferito la ri duzione della frequenza delle crisi di epilessia infantile conclamata dopo due sole settimane di e f t praticato giornalmente a casa. Carbonell (1997) ha ri portato i risultati dell’uso della TFT per l’acrofobia. Non mancano comun que gli studi che esprimono critiche e scetticismo circa la teoria delle terapie dei meridiani, come per esempio quelli di Lohr (2001) e di Herbert e Gaudiano (2001). È stato pubblicato uno studio dettagliato e ben progettato sul l’efficacia dell’EFT (Wells, Polglase, Andrews, Carrington e Baker, 2003), in cui si dimostra come una singola seduta e f t di trenta minuti sia in grado di ridurre in modo significativo e duraturo le fobie semplici. PROBLEMI E REAZI ONI PIÙ COMPLESSI
Non c’è dubbio che I’e f t funzioni. La difficoltà consiste nell’applicarlo ai problemi psicologici complessi. Ciò richiede esperienza clinica e cono scenza delle dinamiche psicologiche, della psicopatologia e dei processi evolutivi, nonché capacità di comprendere la stratificazione e il legame tra i ricordi emotivi. Come I’e m d r , anche I’e f t può essere usato in molti modi che si differenziano impercettibilmente l’uno dall’altro. Il medico dotato di mentalità psicoanalitica tenderà a usare il metodo facendo maggiormente ricorso alle associazioni libere, come se si trattasse di un percorso di guari gione rapidissimo attraverso miriadi di ricordi, fantasie, emozioni e strate gie difensive. Il sollievo emotivo procurato al cliente tamburellando su al cuni punti di agopressione gli consentirà di prendere contatto con aree di esperienza che possono turbarlo senza esserne emotivamente schiacciato. L’assenza di intensità emotiva significa che il materiale psichico può essere esplorato molto rapidamente. L ’e f t solitamente offre al paziente un notevole sollievo senza farlo sof frire ed è ben accolto dalla maggior parte dei clienti; tuttavia ho rilevato un maggior numero di reazioni di ostilità e di rifiuto rispetto all’EMDR. In par te il problema può risiedere nella sconcertante efficacia di una tecnica che sembra al tempo stesso semplice e bizzarra e risulta quindi molto incon-
L’EMDR, l’EFT e la psicoanalisi 21 gruente con le aspettative delle persone. Se molti clienti esprimono stupore ed esultanza per la rapidità con cui la loro sofferenza viene alleviata, sen ten d o spesso il desiderio di sorridere e di ridere, alcuni di essi reagiscono con rabbia e con un ostile senso di smarrimento, arrivando talvolta a crede re che il terapeuta si stia prendendo gioco di loro. La persona registra che qualcosa è accaduto, ma non riesce a venirne a capo. Può anche darsi che, non essendo abituata a sperimentare il proprio corpo senza quell’energia molesta, si allarmi di cambiamenti così rapidi. Per affrontare tali reazioni ostili, che possono contenere elementi di transfert paranoico, come pure aspetti di rovesciamento psicologico, si può ricorrere ancora al tapping e al la spiegazione del processo. ALTRE FORME DI PSI COEN ERG ETICA
Esistono numerose varianti nel campo recentemente emerso della psi coenergetica (si vedano Hover-Kramer, 2002, e il sito internet www.energypsych.org). Una tra le più conosciute è la tecnica t a t (Tapas Acupressure Technique, Tecnica Tapas di Agopressione), sviluppata dalTagopressore Tapas Fleming (Fleming, 1999; www.unstressforsuccess.com). Essa implica l’uso di una particolare posizione delle mani, per cui una mano va applica ta in modo da comprimere punti posti alla fine del sopracciglio, in prossi mità del naso e del chakra del 'terzo occhio’, mentre l’altra regge la parte posteriore del cranio, in corrispondenza della regione occipitale del cervel lo. Il paziente procede poi attraverso una serie di profonde affermazioni in teriori che riguardano la guarigione dell’esperienza bersaglio e il perdono di sé e degli altri. Alcuni trovano questo approccio molto bello e quindi capa ce di guarire. Una posizione analoga è quella della cosiddetta tecnica e s d (EmotionalStress Defusion, Riduzione dello Stress Emotivo), in cui con una mano si comprimono le due protuberanze della fronte e con l’altra la base del cranio (presa frontale occipitale); sviluppata sulla base del testo Manua le di cinesiologia applicata con il “Touch for h e a l t h Metodo di integrazione energetica e posturale (Thie, 1979) e di quello di Stokes e Whiteside intito lato Structural Neurology (1985), nonché sull’osservazione del 'riflesso neu rovascolare’, descritto originariamente da Terence Bennett (Martin, 1977; Walther, 1988), viene utilizzata per integrare i problemi emotivi irrisolti. Un altro metodo ampiamente citato è quello dello psicologo clinico Larry Nims, il quale ha chiamato il proprio approccio Be Set Free Fast ("Sii stabi le, libero, rapido”). Al pari di Gary Craig, ha sviluppato un algoritmo com pleto di tapping, ma a poco a poco lo ha semplificato sempre più fino a ri durlo a un comando generale di elaborazione rivolto all’inconscio (Nims, 2001; www.BeSetFreeFast.com). Altri approcci energetici si concentrano
28 Le terapie energetiche sui chakra anziché sui punti di agopressione (per esempio, Clinton, 2002; Millet, 2001). Uno di questi è il lavoro di Asha Clinton con la ‘Matrice Seemorg’: è molto esaustivo e interessa i sistemi delle convinzioni profonde, os sia le matrici delle convinzioni fondamentali, derivate dalle esperienze trau matiche infantili (Clinton, 2001). Un metodo che trae origine dal concetto di campi morfogenetici di Sheldrake è la ‘tecnica del campo di attrazione’ (Hawkins, 1995; www.the-tree-of-life.com). Nel Regno Unito gli sviluppi più innovativi e radicali si devono a Silvia Hartmann (Hartmann, 2002; 2003a, b; 2004). Oltre a delineare modelli avanzati di e f t , l’autrice ha esplorato anche un nuovo punto di vista che, mettendo da parte i meridia ni, consente di concentrarsi su modelli di allentamento e liberazione del l’energia esistente all’interno del corpo sotto qualsiasi forma. Tale metodo, denominato em o -tra n cey consiste nel far sì che il cliente noti e presti atten zione alle sensazioni interne del suo corpo, un po’ come avviene nei con fronti dei vari aspetti dell’esperienza nell’approccio e m d r e in quello della ‘presenza mentale’ cui ricorrono alcune forme recenti di psicoterapia (per esempio, Segai, Williams e Teasdale, 2002). L 'em o-tran ce può essere com binata all’uso delle cellule di energia tachionica (Quinn e Hartmann, 2002; Wagner e Cousens, 1999). Grazie a tutti questi approcci energetici è possi bile produrre cambiamenti psicobiologici intimi e profondi assai più velo cemente di quanto si immaginasse in precedenza. CHE C O S ’È LA P S I C O A N A LI S I ?
Il compito di una teoria della libido sui disturbi nevrotici e psicotici dovreb be essere quello di esprimere tutti i fenomeni osservati e i processi inferiti in termini di economia libidica (Freud, 1905, p. 524). ... l’esito finale della lotta che abbiamo ingaggiato dipende da relazioni quanti tative, dalle energie che riusciamo a mobilitare nel paziente in nostro favore, l’ammontare delle quali va messo a confronto con la somma energetica delle forze che combattono contro di noi... Può darsi che in futuro qualcuno ci inse gnerà come influenzare direttamente... le quantità energetiche e la loro riparti zione nell’apparato psichico (Freud, 1938a, p. 609). LA PSI COANALI S I È UNA PSICOLOGIA ENERGETI CA
La psicoanalisi contemporanea si è sviluppata in molte direzioni diffe renti, ma non tutte sembrano razionali o terapeuticamente utili (si veda il capitolo 4). Personalmente trovo le teorie originarie di Freud più proficue e
L’EMDR, I’EFT e la psicoanalisi 29 chiare di quelle degli analisti più recenti, a eccezione di Kohut, i cui scritti sono profondamente radicati in quelli freudiani (Rubovitz-Seitz, 1999). Sa pendo che l’esposizione della psicoanalisi che sto per fare sarebbe risultata p iu ttosto differente da molte versioni contemporanee di tale teoria, vi ho deliberatamente incluso citazioni di Freud al fine di suffragare l’autenticità della mia prospettiva. Spero quindi di riuscire a chiarire come la psicoana lisi freudiana fosse al tempo stesso una terapia libero-associativa del trau ma, al pari dell’EMDR, e una forma di psicoenergetica interessata ai distur bi del flusso e della distribuzione di un sottile, ma sfuggente, eccitamento: la libido. Lo stesso vale, a mio avviso, anche per le altre scoperte e gli altri sviluppi teorici di Freud, come il significato dei sogni, la modalità di fun zionamento dell’inconscio, i concetti di pulsione di vita e pulsione di mor te, la distinzione tra angoscia traumatica e angoscia segnale, nonché il mo dello strutturale della mente. Con lo sviluppo delle teorie delle ‘relazioni oggettuali’, come quelle di Fairbairn (1952), delle teorie dell’attaccamento e delle teorie kleiniane delle fantasie relazionali guidate dall’istinto, è facile perdere di vista ciò che il cu ratore inglese degli scritti di Freud descrive come la “più fondamentale di tutte le sue ipotesi” (Strachey, 1962, p. 63). Scrive Freud: all’interno delle funzioni psichiche va distinto un qualcosa - ammontare affet tivo, somma di eccitamento - che ha tutte le proprietà della quantità... un qualcosa suscettibile di aumento, diminuzione, spostamento e scarica, e che si propaga sulle tracce mnestiche delle rappresentazioni quasi una carica elettri ca sulle superfici dei corpi. A quest'ipotesi... può essere dato lo stesso senso che i fisici danno alla corrente di un fluido elettrico (Freud, 1894, pp. 133-4). Freud non smise mai di preoccuparsi della distribuzione e del flusso del le quantità di eccitamento, nonché dell’angoscia che può presentarsi quan do tali quantità scendono al di sotto di un livello tollerabile. I N T E R R U Z I O N E DELLE A S SO C I A Z IO N I
In questo scritto iniziale sulle “Neuropsicosi da difesa” Freud delinea le osservazioni e le ipotesi che costituiranno la base delle sue successive teorie. Egli vi descrive l’impressione, condivisa con Breuer, che negli stati di isteria vi sia un’interruzione della normale sintesi e integrazione della coscienza. Secondo Breuer alcuni individui svilupperebbero “particolari stati di co scienza di tipo traumatico con limitata capacità di associazione...” (Freud, 1894, p. 122), stati per i quali propone il nome di ‘stati ipnoidi’. Le rappre sentazioni affioranti negli stati ipnoidi sono “tagliate fuori dai rapporti asso-
30 Le terapie energetiche
dativi con il rimanente contenuto della coscienza” (ibid., p. 122). La psicopatologia sviluppata in tali stati venne chiamata ‘isteria ipnoide\ Un’altra forma di isteria si credeva avesse luogo nel caso di un’insufficiente ab lazio ne dell’esperienza traumatica, per cui venne chiamata ‘isteria da ritenzione’. Ma Freud riteneva che vi fossero altri casi in cui l’isteria era il risultato di un ‘atto di volontà’ teso a bandire dalla coscienza un’idea angosciosa: al loro Io... si era presentata un’esperienza, una rappresentazione, una sensa zione che aveva suscitato un affetto talmente penoso, che il soggetto aveva de ciso di dimenticarla, convinto di non avere la forza necessaria a risolvere, per lavoro mentale, il contrasto esistente tra questa rappresentazione incompatibi le e il proprio Io (Freud, 1894, p. 123).
Secondo Freud, il compito di considerare ‘non arrivée’ la rappresenta zione incompatibile, non può essere assolto dall’Io se non approssimativa mente, strappando alla rappresentazione sgradevole il suo affetto, per cui essa, da forte che era, diventa una rappresentazione debole e, così indeboli ta, “non avrà più da rivalersi sul lavoro associativo” (ibid., p. 124). Tuttavia la ‘somma di eccitamento’ deve essere indirizzata verso un altro utilizzo. Nel caso dell’isteria, tale processo “si realizza a carico di quella innervazio ne motoria o sensoria che risulta più o meno strettamente connessa con l’esperienza traumatica” (ibid., p. 124). Quando nuove impressioni abbatte ranno la barriera o la rimozione e apporteranno un nuovo affetto alla rap presentazione che era stata indebolita, si presenteranno ulteriori ‘attacchi isterici’. Nel caso degli stati ossessivi, la rappresentazione perturbatrice ri mane nella coscienza, ma l’affetto ne viene separato. Scissa da questo affet to, la rappresentazione non spinge in direzione dell’associazione, ma “il suo affetto, che è divenuto libero, aderisce... ad altre rappresentazioni in sé non incompatibili, che, a loro volta, a causa di questo ‘falso nesso’, si trasforma no in rappresentazioni ossessive” (ibid., p. 126). Dunque, in queste pagine Freud formula il problema dell’isteria e degli stati ossessivi in parte in termini di blocco delle normali attività associative della mente. L’inceppamento dell’associazione viene determinato da una separazione dell’idea dall’emozione. Il trattamento freudiano del disturbo associativo consisteva nella nuova tecnica delle associazioni libere. Al pa ziente veniva chiesto di parlare liberamente di qualsiasi cosa gli venisse alla mente e poi, non appena si evidenziavano interruzioni nel flusso di associa zioni, l’analista tentava di discernere la natura delle inibizioni o ‘resistenze’. Questa concentrazione sul soggiacente disturbo associativo è sorprendente mente simile al risalto dato dalla Shapiro, nell’ambito dell’EMDR, alla ne cessità di agevolare l’elaborazione associativa bloccata e alla sua ipotesi che la stimolazione bilaterale provochi uno scambio tra emisfero cerebrale sini-
L’EMDR, ÏEFT e la psicoanalisi 31 stro, preposto alle funzioni linguistiche (e corrispondente alla 'rappresenta zione’ verbale di Freud) e l’emisfero cerebrale destro, preposto all’elabora zione delle emozioni (e corrispondente all’affetto separato di cui parla F reu d ).
Sotto molti punti di vista il concetto freudiano di rimozione po
trebbe essere considerato come un’inibizione della comunicazione tra cer vello destro e cervello sinistro.
LA BASE DE L T R A U M A
Qualche anno dopo, nelle Cinque conferenze (1909), Freud formulò il suo principio psicoanalitico nei seguenti termini: ai nostri malati... soffrono di reminiscenze. I loro sintomi sono residui e simboli mnestici di determi nate esperienze traumatiche” (p. 135). Spiegando il concetto di 'simboli mnestici’ Freud fa riferimento ai mo numenti e alle sculture commemorative che si trovano nelle grandi città, co me per esempio quelli destinati a ricordare il grande incendio di Londra. Si chiede cosa penserebbe la gente se vedesse un londinese fermarsi davanti a uno di essi e versare lacrime. Aggiunge poi: Al pari di... [un simile londinese privo di senso pratico] si comportano inve ce tutti gli isterici e i nevrotici; non solo ricordano le esperienze dolorose del loro remoto passato, ma sono ancora attaccati ad esse emotivamente; non rie scono a liberarsi del passato e trascurano per esso la realtà e il presente. Que sta fissazione della vita psichica ai traumi patogeni è uno dei caratteri più im portanti e praticamente più significativi della nevrosi (Freud, 1909, p. 136).
Dunque Freud mette in evidenza che la nevrosi ha una base traumatica e, di conseguenza, che il processo risiede nella non riuscita elaborazione del trauma stesso, nella sua mancata collocazione tra gli eventi del passato e nell’incapacità della persona di vivere nel presente. Questa prospettiva può essere messa a stretto confronto con il compito dell’EMDR di favorire l’ela borazione dei ricordi traumatici intrusivi in modo che possano essere cedu ti alla normale memoria autobiografica, consentendo alla persona di occu parsi del presente. Nella descrizione di Freud è evidente che i sintomi isterici e nevrotici non sono causati direttamente dalla rappresentazione inaccettabile in sé e per sé, né dal tentativo dell’Io di bandirla, bensì dall’interruzione del nor male flusso degli affetti: Ci si vedeva spinti a supporre che la malattia fosse insorta perché agli affetti sviluppati nelle situazioni patogene era sbarrata una via d’uscita normale, e che
32 Le terapie energetiche
l’essenza della malattia consistesse nel fatto che questi affetti ‘incapsulati’ sot tostavano ora a un impiego abnorme (Freud, 1909, p. 137). Freud mette in rilievo che, normalmente, l’affetto viene espresso sia a li vello psichico sia a livello somatico, ma nell’isteria l’esperienza cosciente dell’affetto è bloccata e, di conseguenza, l’eccitamento viene canalizzato as sai di più lungo le vie somatiche. ... la conversione isterica esagera questa parte del deflusso di un processo psi chico affettivamente investito; essa corrisponde a un’espressione molto più in tensa delle emozioni, avviata su nuove vie. Quando il letto di un fiume si divi de in due canali, se la corrente di uno dei due incontra un ostacolo, si avrà im mediatamente un soverchio riempimento dell’altro (Freud, 1909, p. 137). In tal modo Freud ha descritto la nevrosi come il prodotto di blocchi energetici. L’ENERGIA DELLA SESSUALITÀ
Freud credeva che i conflitti che danno origine alla nevrosi fossero sem pre radicati nelle energie della sessualità infantile, in quella che descriveva come la “caotica vita sessuale del bambino, ricca ma dissociata, in cui la sin gola pulsione persegue la conquista del piacere indipendentemente da tutte le altre” (Freud, 1909, p. 162). Gran parte della sessualità dell’infanzia è soggetta alla rimozione. Si sono imposte, sotto l’influsso dell’educazione, rimozioni estremamente energiche di alcune pulsioni, e sono state prodotte forze psichiche come il pu dore, il disgusto, la morale, che, come custodi, vegliano su queste rimozioni. Quando poi nel periodo della pubertà sopraggiunge l’alta marea dei bisogni sessuali, essa trova, nelle suddette formazioni psichiche di reazione e di resi stenza, degli argini che le prescrivono il deflusso lungo le vie cosiddette nor mali e rendono impossibile la riattivazione delle pulsioni che hanno subito la rimozione (Freud, 1909, p. 163). RICORDARE ATTRAVERSO IL TRANSFERT
L’adulto non ricorda a livello cosciente i conflitti sessuali infantili che gli hanno causato sofferenza, ma nel corso del trattamento psicoanalitico essi vengono rivissuti in relazione all’analista:
L’EMDR, I EFT e la psicoanalisi 33 [Il paziente] rivolge sul medico una certa quantità di moti di tenerezza, ab bastanza spesso frammisti a ostilità, che non sono basati su alcun rapporto rea le e che non possono che derivare, date le particolarità della loro comparsa, dagli antichi desideri fantastici del malato divenuti inconsci. Quella parte del la sua vita emotiva che egli non riesce più a richiamare alla memoria viene dun que da lui rivissuta nel suo rapporto con il medico ed è solo attraverso codesta riviviscenza nella ‘traslazione’ ch’egli si convince dell’esistenza, nonché della potenza, degli impulsi sessuali inconsci (Freud, 1909, p. 169). IL TRAUMA DA I P E RS TI M O L A Z I O N E I MP OT E N T E
Nei suoi primi scritti Freud considerava alcuni stati d’angoscia, da lui denominati nevrosi attuali, come il possibile risultato diretto di uno scari co inadeguato dell’eccitamento sessuale e credeva che si avesse essenzial mente lo stesso risultato, ossia la tenuta a freno della libido, nelle "nevrosi di difesa’, ma in questo caso come esito della rimozione. La sua ipotesi era quindi che l’angoscia fosse una trasformazione della libido. Ma nel 1926 rivide tale concezione, proponendo che la sessualità e l’aggressività infan tili venissero inconsciamente percepite come un pericolo minaccioso e che fosse tale percezione a causare l’angoscia. Il pericolo ultimo era dunque uno stato di impotenza di fronte a un eccitamento crescente, il cui prototi po era l’esperienza della nascita. Freud descrive (1925, pp. 291-2) una se rie di situazioni angosciose corrispondenti a stadi differenti dell’infanzia: la nascita, la perdita dell’amore materno, la paura della castrazione come ri torsione per la rivalità aggressiva verso il padre, la paura del padre (il pa dre interiorizzato). Ciascuna di queste situazioni di pericolo verrebbe per cepita come la minaccia di un ritorno aU’originaria situazione traumatica di impotenza di fronte a una crescente tensione, e questa minaccia dareb be origine alT‘angoscia segnale’, che motiva l’individuo a evitare il perico lo di origine sia interna sia esterna. Nondimeno Freud continuava a pensa re che l’angoscia potesse sorgere direttamente da un eccitamento crescen te non alleggerito. Non si può contestare che l’astinenza, o smodati disturbi nel decorso del l’eccitamento sessuale, o la deviazione di questo dalla sua rielaborazione psi chica, possano far sorgere direttamente l’angoscia dalla libido; che si produca cioè quella situazione di impotenza dell’Io a petto di una fortissima tensione dovuta al bisogno, che, come alla nascita, sfocia in sviluppo d’angoscia... l’analisi delle nevrosi traumatiche di guerra... avrebbe dimostrato che un buon numero di esse partecipa del carattere delle nevrosi attuali (Freud, 1925, pp. 288-9).
34 Le terapie energetiche
In seguito Freud, pur sostenendo: “Non affermeremo più che in questo caso sia la libido stessa a essere trasformata in angoscia...” (1932, p. 203), prende ancora in considerazione l'idea che Tangoscia possa sorgere “... di rettamente da fattori traumatici quando Pio si scontra con una richiesta li bidica eccessiva... secondo il modello della nascita” {ibid., p. 203). Pertanto ipotizza un’angoscia traumatica e un’angoscia segnale, quest’ultima in cor rispondenza della percezione del pericolo di trauma: “Non vedo comunque cosa ci sia da obiettare contro una duplice origine dell’angoscia: una volta come diretta conseguenza del momento traumatico, un’altra come segnale che minaccia il ripetersi di un simile fattore” {ibid., p. 203). LA R E A Z I O N E T E R A P E U T I C A N E G A T I V A
Proprio come gli psicologi successivi, anche Freud scoprì che talvolta l’attesa risposta positiva alla terapia non si presenta e individuò le sconcer tanti reazioni paradossali di alcuni pazienti. Vi sono persone le quali si comportano durante il lavoro analitico in un modo tutto particolare... Ogni soluzione parziale da cui dovrebbe sortire, co me in effetti accade con altre persone, un miglioramento o una temporanea remissione dei sintomi, suscita in costoro un momentaneo rafforzamento del la sofferenza: peggiorano durante il trattamento invece di migliorare. Questi individui manifestano la cosiddetta ‘reazione terapeutica negativa’ (Freud, 1922b, p. 511).
Freud giunse alla conclusione che queste reazioni terapeutiche negative, presenti in alcuni, ma non in tutti i pazienti, fossero il risultato di un incon scio senso di colpa. Con ciò intendeva dire che il Super-Io, o Io ideale, diri ge inconsciamente l’aggressività verso l’Io. Egli considerava il Super-Io una parziale derivazione dell’identificazione con il padre legislatore, ma pensa va anche che contenesse l’aggressività propria della persona: ... l’uomo, quanto più limita la propria aggressività verso l’esterno, tanto più diventa rigoroso, ossia aggressivo, nel proprio ideale dell’Io... È come se si verificasse uno spostamento, un volgersi contro il proprio Io (Freud, 1922b, p. 516).
Dunque, secondo Freud, la reazione terapeutica negativa è la conseguen za di un rovesciamento del naturale flusso dell’aggressività verso l’esterno. In luogo di una risposta assertiva nei confronti di un altro esterno, la cor rente di energia aggressiva viene convogliata verso l’interno.
L’EMDR, l’EFT e la psicoanalisi 35 COME LIBERARE L’ENERGIA
Pure attraverso l’evoluzione della sua teoria riguardo alla mente psicodi namica, Freud ha sempre fatto consistere il metodo psicoanalitico nell'uso delle associazioni libere, grazie alle quali è possibile esplorare i conflitti del paziente e i suoi affetti bloccati, ossia le interruzioni del processo associati vo e mettere in relazione le inibizioni e le angosce presenti con i desideri, le fantasie e le esperienze infantili percepiti come un pericolo. Freud ha sem pre considerato l’angoscia come un fenomeno fondamentalmente correlato alla minaccia di trauma, ovvero a uno stato di iperstimolazione impotente. È tale minaccia a dare origine alla rimozione. Il contenuto rimosso, poi, non potendo essere integrato o elaborato attraverso la mente cosciente o pre conscia, viene tagliato fuori dalla rete associativa. Attraverso l’interpretazio ne dell’analista dei derivati, deformati, dei desideri inconsci, è possibile smantellare le rimozioni e le risultanti interruzioni del flusso di energia pulsionale. L’Io, che “lotta per venire a capo del suo compito economico di stabilire l’armonia tra le forze e gli influssi che agiscono in lui e su di lui” (Freud, 1932, p. 189) viene quindi aiutato a trovare modi realistici di espri mere l’energia dell’Es. È dunque la psicoanalisi freudiana il m etodo terapeutico originario di esplorazione e risoluzione dei conflitti emotivi della m ente, della stratifica zione e della rete di ricordi del traum a, nonché delle interruzioni del flusso di energia pulsionale. Strum ento di indagine delle interruzioni del processo associativo è il m etodo delle associazioni libere. L ’approccio freudiano è stato sem pre interessato alla dim ensione economica, intesa come d istribu zione delle quantità di eccitam ento all’interno del sistema psicosom atico. Sotto questo profilo, la psicoanalisi presenta gli stessi elementi che si ritro vano sia nell’EMDR sia nella psicoenergetica.
CONFRONTO TRA EMDR, PSICOENERGETICA E PSICOANALISI FREUDIANA T utti e tre gli approcci hanno com e obiettivo l’elaborazione delle espe rienze traum atiche. La stimolazione bilaterale dell’EMDR sem bra condurre a u n ’agevolazione generale dell’elaborazione emotiva. L ’accesso libero-as sociativo alle esperienze traum atiche o alle loro reti e stratificazioni ne co stituisce una com ponente intrinseca. Q uando si applica la stimolazione b i laterale, è come se si prem esse il pedale dell’acceleratore della funzione li bero-associativa. Col p rocedere dell’EMDR, viene a rivelarsi tu tta la com plessità psicodinam ica della m ente. L ’e f t e gli altri approcci energetici sbloccano l’affetto legato nei ricordi traumatici, né più né m eno come I’e m -
36 Le terapie energetiche d r , ma, a differenza di questo, I’e f t deve essere focalizzato con precisione, in term ini di pensiero, sentim ento o esperienza corporea bersaglio. Talvol ta è necessario m olto lavoro esplorativo o intuito clinico da parte del tera peuta per trovare l’aspetto cruciale su cui il paziente dovrà fare m ente loca le durante il tapping. E possibile com binare utilm ente e m d r ed e f t im pie gando serie di m ovim enti oculari per generare e rivelare più aspetti del p ro blema emotivo e prendere poi ciascuno di essi come bersaglio dell’EFT, uti lizzando le precise parole, frasi e metafore che il cliente ha prodotto. La psi coanalisi freudiana (ma non necessariam ente tutti i suoi derivati contem po ranei) cerca anche di localizzare ed elaborare i traum i, in particolare quelli della prim a infanzia. Essa ha sem pre rivolto una particolare attenzione ai traum i e ai conflitti evolutivi della prim a infanzia, assai più dell’EMDR e della psicoenergetica.4 Q uesti conflitti e questi traum i si esprim ono e si ri velano nella relazione di transfert con Fanalista: essa è l’arena principale in cui dovranno essere riportati alla coscienza del cliente e, nei limiti del po s sibile, risolti o m odificati. Si tratta di un processo più lento di quello delI’e m d r o della psicoenergetica, che però può d ar luogo a una più ricca com prensione cosciente dei conflitti evolutivi. La prospettiva freudiana era interessata alla distribuzione dell’energia e ai blocchi del suo flusso: u n ’in terpretazione psicoanalitica in grado di liberare banalizzando dal dom inio di un conflitto fino a quel m om ento inconscio consiste di fatto in una libe razione di energia. Dove la psicoanalisi eccelle è nella capacità di risalire al le fonti, probabilm ente p iu tto sto inconsce, del sintom o o del problem a di superficie, seguendo le deform azioni e le trasform azioni che esso ha subito prim a di affiorare alla mente. M entre un suo limite è che non sem pre riesce a generare l’elaborazione e la risoluzione dei traum i e dei problem i psicodi namici m inuziosam ente individuati attraverso il m etodo delle associazioni libere. Sia la psicoanalisi sia la psicoenergetica riconoscono le reazioni parados sali che occasionalmente si presentano al posto dell’attesa guarigione: la psi coanalisi le chiama ‘reazioni terapeutiche negative’ e la psicoenergetica ‘ro vesciamento psicologico’. Fenom eni del genere si presentano indubbiam en te anche nel corso d ell’EMDR, ma vengono elaborati insieme a ogni altra manifestazione psicodinamica. È inoltre possibile che la stimolazione bilate rale e i m ovim enti oculari che caratterizzano I’e m d r funzionino in m odo simile al m etodo cross-crawl (in cui si pone la m ano sul ginocchio opposto) usato nella cinesiologia applicata p er correggere l’inversione di polarità (W alther, 1988), e che quindi I’e m d r agisca com e una sorta di co n tro b i lanciamento continuo di ogni fattore interno alla psiche che si opponga alla guarigione.
2 Il sogno a occhi aperti: da Freud all’EMDR Gli stati affettivi sono incorporati nella vita psichica come sedi menti di antichissime esperienze traumatiche e vengono ridestati quali simboli mnestici in situazioni simili. Freud, 1925, p. 243
“Non sarebbe poi tanto male se questi ricordi fossero come ricordi del passato: invece quando mi tornano alla mente è come se accadessero ades so”: così osservava una paziente nella quale l’esperienza del parto aveva sca tenato ricorrenti fla sh b a c k dell’abuso sessuale subito durante l’infanzia. I suoi ricordi traumatici avevano il carattere vivido del ‘qui e ora’, più tipico dei sogni che dei ricordi situati in una prospettiva passata. Questo rivivere sotto forma di fla sh b a ck un evento passato è caratteristico dei ricordi trau matici e analogo a ciò che accade nei sogni a occhi aperti. Gli eventi vengo no esperiti nel presente con un coinvolgimento sensoriale totale, mentre la consapevolezza realistica del presente stesso viene temporaneamente com promessa. Nel flash back si sperimenta uno spostamento della realtà che cor risponde a uno stato di psicosi temporanea in cui il presente viene invaso dal passato. Al contrario, i sogni veri e propri delle persone traumatizzate possono spesso essere chiusi alla realtà del passato. Il carattere ‘qui e ora’ dei ricordi fla sh b a ck talvolta si manifesta anche sotto forma di messa in atto corporea. Le reminiscenze di abuso infantile di una mia paziente si manifestavano in parte come stati di panico, seguiti da svenimento e poi da convulsioni, quasi nel tentativo di respingere un’aggressione sessuale.1 Anche a livello cosciente ella riviveva molti altri elementi del ricordo traumatico, ma lo svenimento sembrava associato agli episodi più gravi. Pareva ripetere quegli stati di dissociazione o incoscien za che la paziente aveva sviluppato, nel corso del trauma originario, come risposta difensiva/adattiva. Questo ricordare in forma di messa in atto sensomotoria è una sorta di ricordo implicito (Mollon, 2002a). Esso viene vissuto non come narrazione verbalmente accessibile nel contesto di un ri cordo autobiografico, ma piuttosto come ripetizione sensomotoria, spesso
38 Le terapie energetiche
suscitata, anziché dalPintrospezione intenzionale, da segnali scatenanti in cui la persona si imbatte inavvertitamente, per esempio venendo a cono scenza, attraverso i mass media, di episodi di abuso sessuale, dando alla luce un bambino, ritrovandosi sulla scena delPabuso, vedendo o perce pendo con l’olfatto qualcosa che le fa ricordare l’autore della violenza. Questi ricordi sono denominati s a m (Situationally Accessible Memories, vale a dire Ricordi Accessibili Situazionalmente) e si differenziano dai co siddetti v a m ( Verbally Accessible Memories, ovvero Ricordi Accessibili Verbalmente) di cui si compone la nostra memoria autobiografica (Brewin, 2001, 2003). LE C O N C E Z I O N I F R E U D I A N E S U LLA R I P E T I Z I O N E , I R I C O R D I , I S O G N I E LE O R I G I N I D E L L ’IO
La concezione che si ravvisa in tutti gli scritti e in tutte le indagini teori che di Freud dal 1895 in poi è quella di una mente, o di un sistema psicosomatico, la cui tendenza primaria è sgravarsi delle tensioni interne nate dai desideri istintuali.2 Ma tale ‘processo primario’ si scontra con la realtà esterna per cui un reale soddisfacimento dei desideri richiede capacità di dilazione, attenzione e scelta del comportamento appropriato, ossia quelle funzioni del ‘processo secondario’ rese possibili dallo sviluppo di un ‘Io’ capace di bloccare i desideri istintuali che potrebbero condurre al dolore. Questi desideri, viaggiando lungo le relative vie nervose, vengono convo gliati in canali laterali (‘investimenti laterali’), che diventano particolarmen te evidenti nei sogni e nella formazione dei sintomi nevrotici. Secondo Freud, questo blocco del processo primario da parte dell’Io è essenziale per la salute: la sua assenza “provocherebbe disturbi analoghi a quelli della nevrosi traumatica” (Freud, A l di là del principio di piacere, 1920, p. 221). In questo interessante commento Freud implicitamente collega il suo mo dello predominante della psiche, che sarebbe in uno stato di conflitto in trinseco tra desideri istintuali e realtà esterna, con il modello della psiche traumatizzata. Anche secondo le attuali concezioni degli stati traumatici della mente, il mancato deflusso dell’eccitamento lungo canali laterali, ov vero il fallimento dell’assimilazione associativa, costituisce una parte cru ciale della malattia. Un altro punto di contatto tra il modello freudiano della mente e quello della mente traumatizzata è la tendenza alla ripetizione, anziché al ricordo, tendenza che Freud sottolinea a proposito dei desideri rimossi e delle espe rienze associate al dolore e che si riscontra anche nell’esperienza traumati ca, la quale viene rivissuta anziché sperimentata come ricordo. Nella psi coanalisi freudiana, come nelle forme contemporanee di trattamento del di-
Il sogno a occhi aperti: da Freud all’EMDR
39
sturbo post-traumatico da stress, l’obiettivo è aiutare il paziente a non più ripetere, o rivivere, un evento, bensì a ricordarlo e, quindi, a funzionare in modo ottimale nel presente senza troppe deformazioni derivanti dalle espe rienze passate. H transfert come resistenza al ricordare La distinzione tra ricordare e ripetere, comunemente riscontrata nelle trattazioni sul disturbo post-traumatico da stress, fa pensare alle idee freu diane originarie circa il transfert come resistenza al ricordare. È chiaro che Freud considerava il transfert come ciò che oggi chiameremmo una forma di ricordo implicito (non verbale e non esplicito). Per esempio, scrive: ... possiamo dire che l’analizzato non ricorda assolutamente nulla degli elemen ti che ha dimenticato e rimosso, e che egli piuttosto li mette in atto. Egli ripro duce questi elementi non sotto forma di ricordi, ma sotto forma di azioni\ li ripe te, ovviamente senza rendersene conto... Il paziente non si libererà, finche ri mane in trattamento, da questa ‘coazione a ripetere’: e alla fine ci si rende con to che proprio questo è il suo modo di ricordare... Ci rendiamo subito conto che la stessa traslazione rappresenta un elemento della ripetizione, e che la ripeti zione è la traslazione del passato dimenticato, non soltanto sulla persona del medico ma su tutti gli ambiti della situazione attuale. Dobbiamo perciò rasse gnarci a che l’analizzato soggiaccia alla coazione a ripetere (che ora sostituisce l’impulso a ricordare) non soltanto nei suoi rapporti personali col medico, ma anche in tutte le altre attuali attività e relazioni della sua vita... (Freud, 1914a, pp. 355-6, corsivo aggiunto). L'azione della rimozione Dal brano sopracitato risulta assolutamente chiaro che per Freud il tran sfert è una forma di ricordo inconscio (o implicito). Ma il motivo per cui compare implicitamente, anziché in modo esplicito e cosciente, risiede nel l’azione della rimozione e della resistenza, la cui funzione consiste nelTevitare il ‘dispiacere’ e l’angoscia. Pertanto è l’espressione deformata del mate riale rimosso a essere ripetuta nel transfert. Sappiamo dunque che banalizzato ripete invece di ricordare, che ripete sot to le condizioni impostegli dalla resistenza; ma ci possiamo ora chiedere: che cosa propriamente egli ripete o mette in atto? La risposta è questa: egli ripete tutto ciò che, provenendo dalle fonti di quanto in lui vi è di rimosso, si è già
40 Le terapie energetiche imposto alla sua personalità manifesta: le sue inibizioni, i suoi atteggiamenti in servibili, i tratti patologici del suo carattere. Sì, egli ripete anche durante il trat tamento tutti i suoi sintomi (Freud, 1914a, p. 357). I l passaggio dalla rip e tizio n e a l ricordo in p sico a n a lisi
In uno scritto successivo, Freud indica che la psicoanalisi mira allo spo stamento delTequilibrio dalla ripetizione al ricordo. Egli è piuttosto indotto a ripetere il contenuto rimosso nella forma di un’esperienza attuale, anziché, come vorrebbe il medico, a ricordarlo come parte del proprio passato. Queste riproduzioni, che si presentano con una fe deltà indesiderata, hanno sempre come oggetto una parte della vita sessuale in fantile... e hanno invariabilmente luogo nella sfera della traslazione, vale a dire del rapporto col medico. Se il trattamento ha raggiunto questo stadio, si può dire che la vecchia nevrosi è stata sostituita da una nevrosi nuova, da una ‘ne vrosi di traslazione’. Il medico si è sforzato di restringere al massimo l’ambito di questa nevrosi di traslazione, di convogliare quanto più materiale possibile nella sfera dei ricordi e di fare in modo che una parte minima di esso riemerga sotto forma di ripetizione (Freud, 1920, p. 204). Sotto certi aspetti, il transfert potrebbe anche essere descritto come una sorta di m e m o ria p ro ced u ra le. Con questo termine si fa riferimento a tutti quei ricordi impliciti che hanno a che fare con l’apprendimento di attività e coprono un ambito vasto e variegato. Il transfert potrebbe essere in parte descritto come un insieme di moduli di apprendimento, sviluppati nel cor so dell’infanzia, circa il modo di rispondere e di relazionarsi con gli altri, os sia di ‘procedere’ in rapporto agli altri. Ma Freud lo vedeva come l’alternativa del paziente al ricordo diretto dei desideri, dei sentimenti, delle angosce e delle altre esperienze precoci della sua vita, alternativa resa n ecessaria dalla rimozione. Dunque, secon do Freud, il transfert è una sorta di memoria implicita derivante da un meccanismo di difesa. I desideri infantili, resi inconsci dalla rimozione, possono emergere solo in forma implicita. Similmente, i sintomi possono essere considerati espressioni implicite di sentimenti rimossi, ossia di sen timenti non accessibili verbalmente. Ma nel P ro g e tto (1895), Freud chiari sce che, oltre alla rimozione, a produrre i sintomi (originariamente i sinto mi isterici) può intervenire un altro fattore: l’azione di spostamento, in ba se alla quale la fonte originaria dell’affetto e dell’angoscia viene rimossa e l’affetto spostato su un altro elemento, che in tal modo nasconde la fonte originale.
Il sogno a occhi aperti: da Freud all’EMDR 41 l ’imbarazzo di Freud circa i sogni traumatici Nel suo scritto sulla pulsione di m orte {Al di là del principio di piacere, 1920), F reu d p re n d e in considerazione le sconcertanti caratteristiche dei sogni traum atici, la cui n atu ra m etteva in discussione le sue ipotesi circa una psiche governata dal principio di piacere (sebbene modificato dal prin cipio di realtà). Così scrive: Ebbene, la vita onirica delle persone affette da nevrosi traumatica ha la ca ratteristica di riportare continuamente il malato nella situazione del suo inci dente, da cui egli si risveglia con rinnovato spavento. Ci si stupisce davvero troppo poco di ciò. Si pensa che il fatto che l’esperienza traumatica si imponga continuamente al malato, persino nel sonno, sia appunto una prova della sua forza: il malato sarebbe, per così dire, fissato psichicamente al suo trauma... Se si ritiene ovvio che il sogno notturno trasponga nuovamente queste per sone nella situazione che ha creato la loro malattia, si mostra di non aver com preso la natura del sogno. Sarebbe più coerente con la natura del sogno se al malato si presentassero piuttosto immagini risalenti all’epoca in cui stava bene, o relative alla guarigione che spera di raggiungere. Se non vogliamo che i sogni di coloro che soffrono di nevrosi traumatica ci turbino nel nostro convincimen to che il sogno tenda all’appagamento di un desiderio, non ci resta che una via d’uscita: ammettere che in questa situazione anche la funzione del sogno, come molte altre cose, viene disturbata e deviata dai suoi scopi; a meno di non voler ricorrere alle misteriose tendenze masochistiche dell’Io (Freud, 1920, p. 199).
Il trauma agisce come se fosse un desiderio In tal m odo F reu d suggerisce im plicitam ente l’ipotesi che, per qualche strana ragione, il traum a agisca all’interno della psiche come se fosse un de siderio. Esso sem bra funzionare come un corpo estraneo. Per definizione il traum a implica una sorta di rottura dei norm ali confini protettivi e regola tori. Forse possiam o istituire una parziale analogia con l’attività del virus: un intruso che altera alcune funzioni proprie del corpo. O , per usare u n ’al tra analogia, potrem m o dire che, com e il corpo reagisce a una ferita fisica circondandola di cellule protettive del sistema im m unitario in m odo da iso lare e contenere la possibile infezione, così agisce la psiche nei confronti del trauma. Q uesto contenim ento significa che il traum a non viene assorbito né digerito, ma rimane attivo, sebbene sotto sequestro. In presenza di un qual siasi rilassam ento delle difese contenitive, tornerà a prem ere per affiorare alla coscienza e manifestarsi come rappresentazione allucinatoria. In questo
42 Le terapie energetiche modo non verrà vissuto come un aspetto della memoria autobiografica, ma agirà come se fosse un evento che ha luogo nel presente, ossia come sogno a occhi aperti. Il trauma altera il funzionamento del corpo
L’esperienza traumatica agisce proprio sul corpo. Mentre nei ricordi ordi nari non vengono rivissute tutte le sensazioni fisiche e le modalità sensoriali dell’evento originario, l’evocazione del ricordo traumatico consiste proprio nel rivivere fisicamente l’evento a livello sensoriale. Van der Kolk (2002), de scrivendo le cosiddette 'impronte subcorticali’ del trauma, osserva: Numerosi studi hanno dimostrato che la persona affetta da disturbo post traumatico da stress, in presenza di elementi che le ricordano il trauma origi nario, ha reazioni psicofisiologiche e risposte neuroendocrine da cui si deduce che è stata condizionata a reagire come se fosse esposta nuovamente al trauma vero e proprio (van der Kolk, 2002, p. 65). Sembra che una volta che ci sia stato un trauma, la parte del sistema lim bico chiamata amigdala tenda continuamente a interpretare qualsiasi ele mento che ricordi il trauma come un segnale del suo ripresentarsi: si tratta di reazioni emotive condizionate relativamente indelebili (LeDoux, 1996). Per di più, la normale 'elaborazione dall’alto verso il basso’ (LeDoux, 1996; van der Kolk, 2002), in base alla quale le risposte cerebrali subcorticali e i processi fisiologici associati vengono regolati, inibiti o ‘schermati’ alla co scienza da zone corticali superiori (l’'Io’ di Freud) (Damasio, 1999), non riesce a far fronte a queste continue reazioni traumatiche. Le funzioni corti cali superiori preposte alla parola e all’insight verbale sono di scarsa utilità quando la persona traumatizzata non riesce a collegare la propria esperien za al linguaggio, forse per via della diminuita attivazione dell’area di Broca e dell’aumentata attivazione del sistema limbico nell’emisfero destro (non linguistico) (Rauch e altri, 1996). Come il processo primario viene contrastato dall'Io
Nell’originario modello freudiano della psiche, delineato nel Progetto (1895), sono solo i desideri e i bisogni provenienti dall’interno a premere per emergere nei sogni sotto forma di rappresentazioni deformate. Quella che viene descritta è una psiche governata dal principio del ‘dispiacere’, modifi cato da quello di realtà. Gli impulsi/desideri provenienti da spinte endogene
Il sogno a occhi aperti: da Freud all’EMDR 43 tenderanno alla scarica in modo libero-associativo (processo primario), inve stendo un'immagine mnestica piacevole e dando origine così al soddisfaci mento allucinatorio. Ma tale processo primario viene inibito dall’Io investito (o ‘Io coerente’3), un sistema di neuroni continuamente investiti che agisco no per bloccare il passaggio diretto dell’eccitamento, di modo che possa aver luogo un lavoro maggiormente basato sulla realtà e capace di condurre a una gratificazione reale (anziché allucinatoria). Gli investimenti ‘libera mente mobili’ del processo primario vengono inibiti e canalizzati dagli ‘inve stimenti legati’ (o investimenti ‘tonici’) dell’Io. Senza questa funzione inibi trice, la psiche sarebbe sovrastata da un eccitamento che tende alla scarica e il suo funzionamento nel mondo esterno verrebbe gravemente compromes so. Oltre tutto, essa sarebbe, in effetti, traumatizzata. Questo aspetto viene messo in rilievo da Freud in A l di là del principio di piacere (1920): ... gli impulsi originati dalle pulsioni non appartengono al tipo dei processi nervosi ‘legati’, ma piuttosto al tipo dei processi liberamente mobili che tendo no alla scarica... gli strati superiori dell’apparato psichico avrebbero il compito di legare l’eccitamento pulsionale che ubbidisce al processo primario. Il falli mento di questo tentativo provocherebbe disturbi analoghi a quelli della nevrosi traumatica; soltanto dopo che l’investimento libero fosse stato conveniente mente legato, il principio di piacere (e quella sua modificazione che è il princi pio di realtà) potrebbe esplicare indisturbato il suo dominio. Fino a quel mo mento prevarrebbe invece l’altro compito dell’apparato psichico, il compito di domare o legare l’eccitamento, non diremo in contrasto col principio di piace re, ma indipendentemente da esso e in una certa misura senza tenerne conto (Freud, 1920, pp. 220-1, corsivo aggiunto). In questo brano, dunque, Freud sembra dire che “domare o legare l’ec citamento”, vale a dire mantenere l’ordine all’intemo della psiche, è più es senziale che cercare il piacere ed evitare il dolore. Egli prende atto che la padronanza ottenuta mediante la ripetizione può essere di per sé piacevole: “Questo comportamento non contraddice il principio di piacere; è eviden te che la ripetizione, la constatazione dell’identità, costituisce a sua volta una fonte di piacere” (ibid., pp. 221-222). Ulteriori problemi del modello di una psiche che tende all’appagamento dei desideri Poi, però, Freud riscontra altre difficoltà nel suo modello. Si accorge che spesso il comportamento dei pazienti nel corso dell’analisi non produce piacere.
44 Le terapie energetiche ... nel caso della persona sottoposta ad analisi, è evidente che la coazione a ri petere gli eventi della propria infanzia nella traslazione non tiene conto in al cun modo del principio di piacere. Il nevrotico si comporta in modo assolutamente infantile, dimostrandoci così che le tracce mnestiche rimosse delle sue esperienze più remote non sono presenti in lui in forma ‘legata’ e che anzi in un certo senso sono incapaci di ubbidire alle regole del processo secondario. Al fatto di non essere legate esse devono anche la loro capacità di formare, congiungendosi con i residui diurni, una fantasia di desiderio il cui appaga mento è raffigurato nel sogno (Freud, 1920, p. 222).
In tal modo Freud suggerisce che le sofferenze emotive e i problemi evo lutivi irrisolti del passato infantile premono per esprimersi nel presente, quasi senza tenere alcun conto né del principio di piacere né del principio di realtà. Per spiegare questo fenomeno Freud ricorre al meccanismo della coazione a ripetere, che collega alle sue emergenti impressioni circa la “na tura conservatrice degli esseri viventi” (ibid., p. 222), da lui speculativamente definita ‘pulsione di morte’.4 Una pulsione sarebbe dunque una spinta, insita nell’organismo vivente, a ri pristinare uno stato precedente al quale quest’essere vivente ha dovuto rinun ciare sotto l’influsso di forze perturbatrici provenienti dall’esterno; sarebbe dunque una sorta di elasticità organica, o, se si preferisce, la manifestazione dell’inerzia che è propria della vita organica (ibid., p. 222).
È evidente che A l di là del principio di piacere, oltre ad avere il merito di introdurre la teoria freudiana della pulsione di morte, affronta essenzial mente i problemi relativi al trauma, alla ripetizione e a quella che sembra una ricerca del dolore e rispecchia la constatazione di Freud che il trauma mette a dura prova il presupposto di una psiche tendente al piacere. Come la psiche si scarica della tensione: l'importanza degli ‘investimenti laterali’ Sin dal Progetto, il modello freudiano della psiche si delinea come un’or ganizzazione che tende a sgravarsi della tensione (Pribram e Gill, 1976). In base a tale modello, la scarica immediata attraverso gli investimenti libera mente mobili del processo primario viene inibita dagli investimenti legati o tonici dell’i o coerente’ affinché possa essere raggiunto un soddisfacimento reale, anziché allucinatorio, e, inoltre, non vengano investite le cosiddette ‘immagini mnestiche ostili’, ossia per evitare di seguire una via che in pre cedenza ha portato al ‘dispiacere’. Questa inibizione difensiva del processo
Il sogno a occhi aperti: da Freud aWEMDR 45 primario di scarica si produce mediante gli ‘investimenti laterali’. Attivan do (investendo) i neuroni laterali rispetto alla via principale, gli investimen ti mobili subiscono un processo analogo alla dispersione di un circuito elet trico: in tal senso il modello freudiano di connessione neuronaie risulta in linea con la successiva formulazione di Hebb (1949), secondo cui i neuroni che “si attivano insieme tendono a rinforzare le connessioni reciproche”. Se le fonti di tensione venissero scaricate con successo o mediante un even tuale atto motorio riuscito o mediante l’assorbimento e la distribuzione tra ali investimenti laterali, probabilmente non ci sarebbe alcun bisogno di ri petere o rimettere in atto l’esperienza, in quanto mancherebbe la forza mo tivante. Vorigine deWIo Nel brano seguente, Freud descrive l’origine dell’Io (l’esecutivo preposto a organizzare e regolare la psiche), attraverso il processo di apprendimento della differenza tra soddisfazione allucinatoria e soddisfazione reale di un desiderio. Tale sviluppo dell’Io si basa sul principio di evitamento del dolo re o ‘dispiacere’. Siamo... arrivati al più oscuro dei problemi, quello dell’origine dell’Io, vale a dire di un complesso di neuroni che tengono saldamente le loro cariche... L’Io consiste originariamente di neuroni nucleari che, attraverso vie di conduzione, ricevono [eccitamento] endogen[o] e l[o] scaricano lungo la via della modifi cazione interna. LMesperienza di soddisfacimento’ mette questo nucleo in as sociazione con una percezione (l’immagine desiderata) e con l’informazione di un movimento... L’educazione e lo sviluppo di questo Io originario si verifica no in situazioni ripetitive di desiderio, in stati di attesa. L’Io apprende dappri ma a non investire le immagini motorie (con conseguente scarica) finché certe condizioni non vengano soddisfatte dal lato percettivo. Esso impara in seguito a non investire la rappresentazione di desiderio oltre un certo limite, perché al trimenti si illuderebbe in modo allucinatorio. Se, tuttavia, rispetta queste due barriere e rivolge la sua attenzione alle nuove percezioni, potrà sperare di rag giungere il soddisfacimento cercato... Rimane ora solo da sapere l’origine delle due barriere che garantiscono il livello costante dell’Io e, in particolare, di quella contro le immagini motorie, che impedisce la scarica... Tutto ciò che possiamo dire è che quando questa barriera non c’era ancora e il discarico mo torio si verificava simultaneamente con il desiderio, l’atteso piacere veniva re golarmente a mancare e la continua emissione di stimoli endogeni finiva per generare dispiacere. Solo questa minaccia di dispiacere, la quale si è connessa con la scarica prematura, può corrispondere alla barriera in questione...
46 Le terapie energetiche Tutto quello che io chiamo ‘acquisizione biologica’ del sistema nervoso, lo penso rappresentato da una minaccia di dispiacere di questo genere, la cui effi cacia consiste nel fatto che non vengono investiti quei neuroni che conducono a una liberazione di dispiacere. È questa la difesa primaria, conseguenza com prensibile deH’originaria tendenza del sistema nervoso. Il dispiacere rimane l’unico mezzo di educazione (Freud, 1895, pp. 267-9).
La mente in conflitto intrapsichico e la mente traumatizzata Secondo Freud, quindi, il 'dispiacere', o dolore, si ha quando l'eccita mento endogeno che tende alla scarica motoria non raggiunge la gratifica zione: dunque il dolore sorge da pressioni interne. Si tratta del modello di una mente in conflitto (intrapsichico), in quanto impiega difese contro l’ec citamento pulsionale endogeno. Piuttosto diverso è il modello della mente traumatizzata e violata (Mollon, 1996): qui l'eccitamento della violazione ha un'origine esogena e non è il risultato di un'attivazione che nasce dall’inter no. Nella psiche immaginata da Freud nel Progetto e nell’Interpretazione dei sogni (modello cui rimase essenzialmente fedele in tutte le teorizzazioni suc cessive), conflitto e disturbo hanno luogo solo sotto la spinta dell'eccita mento pulsionale di origine endogena, il quale investe i desideri rimossi che potrebbero indurre il 'dispiacere'. Se le pulsioni fossero quiescenti, la psi che sarebbe in pace. Nel caso della psiche traumatizzata, invece, spesso si riscontra che è proprio quando è relativamente rilassata e priva di distrazio ni che la persona comincia a ricordare o a rivivere gli episodi traumatici. Nella realtà, ovviamente, la mente di una persona può essere al tempo stes so traumatizzata e in conflitto. Una prospettiva contemporanea sul trauma, i sogni e il processo primario Freud (1899) ha descritto come i desideri soggiacenti, espressi nei sogni, possano diventare manifesti attraverso catene di significanti, gli investimen ti liberamente mobili del processo primario: in tal modo il sogno, divenuto manifesto alla persona, può non somigliare più aU’originaria rappresenta zione di desiderio. Durante il sonno il potere di rimozione dellTo è indebo lito, per cui i desideri proibiti hanno la possibilità di intraprendere il loro percorso neuronaie, ma l’Io è ancora in grado di bloccarne l’espressione di retta e di dirigere, invece, la via di eccitamento lungo gli 'investimenti late rali’. I sogni sarebbero il risultato di compromesso dello scambio tra il pro cesso primario (con i suoi investimenti mobili e la tendenza alla scarica di retta) e il processo secondario (inibitore) dellTo e dei suoi investimenti le-
Il sogno a occhi aperti: da Freud aWEMDR 41 gati. Freud considerava 'difensivo’ questo processo, in quanto ha la funzio ne di proteggere il sonno; tuttavia tale spostamento su vie associative meno dirette può anche essere letto come un mezzo di digestione mentale del trauma (Shapiro, 2001): La risoluzione dei ricordi traumatici comincia quando, attivando il ricordo del materiale disfunzionale, si determina una catena di eventi differente da quella normalmente avviata... ciò consente al cervello di individuare e rafforza re nuove associazioni con i ricordi traumatici e alla fine di indebolire la presa di quelle associazioni ed emozioni stereotipate che avevano bloccato la risolu zione adattiva dei ricordi traumatici (Shapiro, 2001, p. 237). È proprio l’aspetto stereotipato e ripetitivo che caratterizza i flashback e i sogni traumatici. Questi ultimi tendono ad avere un legame letterale e di retto con l’esperienza originaria. Infatti non sono stati canalizzati lungo i percorsi associativi meno diretti. In termini freudiani si potrebbe dire che i sogni e i flashback traumatici rivelano un’inadeguatezza dell’Io a convoglia re il processo primario lungo i percorsi associativi spostati, i cosiddetti ‘in vestimenti laterali’. La funzione dei sogni Se per Freud l’unica funzione dei sogni era impedire all’insorgenza dei desideri rimossi di disturbare il sonno, in un’ottica moderna si può loro at tribuire una varietà di funzioni e di valori determinanti. Una funzione im portante potrebbe essere l’elaborazione, o ‘digestione’, delle esperienze emotive della giornata, attraverso una classificazione completa dei significa ti e delle implicazioni dei vari episodi. Un’operazione del genere potrebbe implicare il confronto con esperienze precedenti, il loro raggruppamento in categorie e l’estrazione dei significati e delle percezioni meno immediati e coscienti degli scambi interpersonali. Per esempio, una donna sognò che un suo amico aveva l’aspetto di un vagabondo e viveva in una roulotte abban donata: si rese conto che questo sogno rifletteva percezioni e preoccupazio ni subliminali circa lo stato mentale del suo amico, impressioni che la sua coscienza non aveva registrato. Una simile elaborazione delle informazioni emotivo-relazionali richiede un accesso di tipo libero-associativo a immagi ni correlate e dotate di legami connotativi con la percezione o l’esperienza originale. Dunque l’elaborazione normale (non difensiva) delle informazio ni emotive può dipendere dai medesimi strumenti dello spostamento del processo primario e degli ‘investimenti laterali’ descritti da Freud come ma novre difensive dell’Io.
48 Le terapie energetiche
La facilitazione dei percorsi associativi deboli Se questa ipotesi circa Pelaborazione delle informazioni emotive è cor retta, allora la strategia da attuare in presenza di un’esperienza traumatica consisterà nel facilitare i percorsi neurali associativi più deboli (analoghi agli ‘investimenti laterali’ freudiani) e nell’indebolire la loro tendenza a flui re lungo le vie neurali dirette originarie. Che ciò accada durante l’attività onirica è suffragato da prove: il sonno r e m favorisce l’attivazione di asso ciazioni deboli, mentre il sonno non r e m attiva esclusivamente quelle forti (Stickgold, 2002; Stickgold, Scott, Rittenhouse e Hobson, 1999). Per con verso, è dimostrato che i sogni traumatici, che spesso contengono una ripe tizione quasi letterale della situazione originaria, hanno luogo durante il sonno non r e m (Hartmann, 1996).5 Per di più, gli elevati livelli di norepinefrina rilasciata durante lo stress traumatico possono tendere a segnalare maggiori percentuali di rumore nei neuroni corticali e a inibire le associa zioni deboli (Foote, Bloom e Ashton-Jones, 1983), un processo, questo, for se selezionato dall’evoluzione in quanto favorisce la lucidità nelle situazioni che minacciano la sopravvivenza: tale processo probabilmente ha la funzio ne di impedire che le esperienze traumatiche vengano assimilate allo stesso modo delle altre, il che spiega in parte il carattere persistente e intrusivo dei ricordi traumatici. Un altro fattore di rilievo è rappresentato dalle tendenze opposte dei due emisferi cerebrali relativamente alle associazioni deboli e a quelle forti: quello sinistro dà maggior risalto alle associazioni forti, mentre il destro facilita quelle più deboli (Chiarello e Richards, 1992; Nakagawa, 1991). Ciò è coerente con le idee popolari circa il funzionamento ‘creativo’ e olistico dell’emisfero destro rispetto alla modalità lineare e linguistica del l’emisfero sinistro. P roprio com e i rapidi m ovim enti oculari del sonno norm ale sem brano facilitare le associazioni deboli, anziché forti, di pensieri c immagini, così l ’azione d ell’EMDR sem bra favorire il rilascio dell’esperienza sensoriale traum atica nella più am pia rete neuronaie. P er com prendere questo feno m eno lo si p o treb b e paragonare a una tossina, che in quantità concentrata può essere velenosa, ma che diventa relativamente innocua se immessa nella vastità dell’oceano. Senza I’e m d r , o u n ’efficace attività r e m , le sensazioni traum atiche non fanno che perseverare lungo una ristretta via neurale asso ciativa, in trap p o late n ell’ippocam po com e ricordi sensoriali episodici6 (Stickgold, 2002). N on vengono digerite. I ricordi restano impliciti e proce durali: non vengono vissuti come ricordi autobiografici verbalm ente acces sibili (cioè, non sono ricordi espliciti), ma m oduli della risposta neurofisio logica preposta all’azione (procedura) di fronte a un grave pericolo (Mollon, 2002a). Al term ine di una riuscita terapia e m d r , questi ricordi proce durali impliciti traum atici vengono vissuti come reminiscenze di eventi pas-
Il sogno a occhi aperti: da Freud all’EMDR 49 sati, e non più associati a schiaccianti concomitanti fisiologiche dell’emozio ne: sono diventati infatti ricordi espliciti. Secondo la descrizione della Shapiro, l’azione dell’EMDR è in grado di aiutare il sistema fisiologico (cerebrale e corporeo) a elaborare in senso adattivo le informazioni. In circostanze normali il sistema di elaborazione adattiva delle informazioni istituisce adeguate associazioni tra l’esperienza recente e altre informazioni esperienziali, così che può aver luogo un ap prendimento costruttivo. In tal modo l’esperienza viene integrata entro schemi emotivi e cognitivi positivi. Le informazioni traumatiche, invece, ri sultano intrappolate nel sistema nervoso e restano nella loro forma senso motoria e stato-specifica grezza, che una varietà di stimoli, interni cd ester ni, può rapidamente scatenare. L’e m d r fa sì che le informazioni emotive perturbatrici vengano convogliate, a ritmo accelerato, lungo i percorsi neu rofisiologici appropriati. Questa ipotesi per cui l’azione dell’EMDR consisterebbe nel far passare l’esperienza da uno stato di continua ripetizione a uno stato in cui viene ri conosciuta come ricordo di un evento passato, è molto vicina alla posizione freudiana circa la necessità di rimpiazzare la ripetizione con il ricordo: per esempio, laddove Freud parla del tentativo dell’analista “di convogliare quanto più materiale possibile nella sfera dei ricordi e di fare in modo che una parte minima di esso rimanga sotto forma di ripetizione” (Freud, 1920, pp. 204-5). IN S I NT ES I I ricordi trau m atici, in v e c e di essere sp er im e n ta ti c o m e tratti d ella m e moria au tobiografica, ten d o n o a essere rivissuti so tto form a di flashback. In m od o an alogo, F reud ha d escritto il transfert c o m e una form a di rip e tizio ne an ziché co m e u n ’esperien za d el ricordare. In entram bi i casi, l ’o b iettiv o tera p eu tico c o n sis te n el facilitare il p a ssa g g io d alla rip e tiz io n e al ricord o. L ’esp erien za traum atica p rem e co n tin u a m en te p er affiorare alla coscien za , con un m o v im e n to o p p o s to agli sforzi m en ta li p er evitare di rivivere il d o lore. F reu d ha o sse rv a to il m e d e sim o fe n o m e n o n ei so g n i trau m atici, tr o vandoli in co eren ti con il su o m o d e llo di p sich e volta al so d d isfa cim en to dei d esideri e a ll’ev ita m en to d el d olore. Il traum a sem bra alterare il fu n z io n a m ento d el co rp o e della m en te e agire come se fosse un desiderio. N e l m o d e llo freud iano, la p sich e ev o lv e in d irezion e d e ll’ad attam ento al la realtà crean d o un ‘I o ’ ch e b locca il p ro ce sso prim ario e l’esp ressio n e o la scarica d iretta d el d e sid e r io , c o n v o g lia n d o il p e r c o r so d e ll’in v e stim e n to neurale lu n g o vie laterali. Q u esta d ev ia zio n e risulta ev id en te nella struttura dei so g n i, c h e illustra l ’o p e r a z io n e d e llo sp o sta m e n to . I so g n i trau m atici
50 Le terapie energetiche sem brano schiacciare l’Io e costringerlo all’espressione diretta dell’espe rienza traum atica nella coscienza. Sia dal p u n to di vista dell’EMDR sia da quello del m odello freudiano della psiche, un sano adattam ento richiede l’assimilazione del carico neuronaie lungo vie laterali, al posto del percorso diretto verso la coscienza. Si tratta di un processo analogo a quello della di gestione. L ’e m d r facilita precisam ente questo tipo di assimilazione, al pari dei processi libero-associativi della psicoanalisi freudiana.
3 Cosa accade durante una seduta e m d r o e f t ?
Per i clinici che hanno confidenza solamente con la psicoterapia verbale tradizionale, derivata dalla psicoanalisi, può essere difficile capire ciò che accade durante il processo di desensibilizzazione e rielaborazione attraver so i movimenti oculari, o nel corso di altri metodi di psicoenergetica simili all’EMDR dal punto di vista procedurale. Chi ha una formazione comporta mentale o cognitiva può essere fuorviato dal termine ‘desensibilizzazione’ e credere che P e m d r sia una variante della desensibilizzazione comporta mentale, come di fatto era inizialmente. Lo scopo per cui Francine Shapiro, psicoioga clinica di formazione cognitivo-comportamentale, ideò P e m d r , era il trattamento del disturbo post-traumatico da stress; ben presto, però, si accorse che nel corso di quel procedimento accadeva molto di più della semplice desensibilizzazione e che esso gettava molta luce su aspetti scono sciuti della struttura della mente e della sua elaborazione delle informazio ni emotive. Paradossalmente, ciò che era iniziato come una forma di terapia semi-comportamentale delPansia fece riscoprire alla Shapiro fenomeni esplorati un centinaio d’anni prima da Freud: in particolare, le associazioni libere, l’inconscio, le reti della memoria, la stratificazione dell’esperienza traumatica, la rappresentazione del trauma nel corpo e l’importanza dell’elaborazione intrapsichica. Ma fece emergere anche qualcosa di nuovo e di sbalorditivo: ossia che basta un piccolo aiuto perché la mente abbia il suo naturale processo di guarigione. Questa scoperta inficia in gran parte le ipotesi prevalse in molti settori della psicoanalisi: per esempio quella secon do cui la mente di molti pazienti sarebbe in balia di forze distruttive e antievolutive. Ciò che I’e m d r rivela è che quelle che sembrano dinamiche e organizzazioni distruttive sono in realtà meccanismi di difesa della mente contro un dolore e un’angoscia insopportabili.1
52 Le terapie energetiche L ’USO DELLA S T I M O L A Z I ON E BILATERALE
Le prime ricerche della Shapiro si indirizzarono sul potenziale terapeuti co dei naturali movimenti oculari da una parte alPaltra, ossia dei movimenti saccadici. Tuttavia ben presto emerse che anche altre forme di ‘stimolazione bilaterale’ inducono una rapida elaborazione delle informazioni emotive di sturbanti: è il caso della stimolazione auditiva (mediante cuffie stereofoniche che trasmettono suoni o battiti alternati ora a un orecchio ora all’altro), di quella tattile (in cui o il cliente stesso o il terapeuta effettua il tapping alter nativamente ora su un lato del corpo ora sull’altro, per esempio mani, gi nocchia o spalle), e di quella cenestesica (in cui si muove alternativamente ora un lato del corpo ora l’altro, di solito facendo camminare il cliente). Mentre un tempo ci si basava sul movimento di un dito o sul tapping, oggi è possibile usufruire di attrezzature, come le barre luminose su cui si sposta no punti di luce, le apparecchiature acustiche e gli stimolatori tattili di vario tipo. Ai diversi clienti si attagliano forme, intensità e velocità diverse di sti molazione bilaterale, per cui può essere necessaria un po’ di sperimentazio ne. Per esempio, un cliente, che trovava estremamente molesta la barra lu minosa, in quanto le luci gli ricordavano i fari della macchina che lo aveva investito, rispose molto meglio alla stimolazione auditiva. Anche se i vari di spositivi tecnologici risparmiano al terapeuta di affaticare il braccio, il meto do ‘manuale’ originale presenta di fatto alcuni vantaggi in quanto consente un coinvolgimento più diretto e sensibile nell’elaborazione emotiva e soma tica del cliente, rendendo al tempo stesso possibili movimenti che una barra luminosa non può replicare, come per esempio la ‘figura dell’otto’. Facen dosi concretamente trainare dal sistema nervoso autonomo del cliente, il te rapeuta ha modo di rispondere immediatamente agli impercettibili cambia menti del suo stato psicosomatico, aumentando o riducendo la velocità, la curvatura e la direzione dei movimenti oculari a seconda della necessità. Per esempio, quando un cliente ricorda i momenti più strazianti di un trauma, i suoi occhi possono paralizzarsi, indicando che l’elaborazione si è bloccata a quel punto; il terapeuta allora può agevolare l’elaborazione inibita rallen tando e riducendo il movimento del dito per poi tornare a intensificarlo al lorché si accorge di aver ‘catturato’ di nuovo lo sguardo del cliente: si tratta insomma di un processo di rispecchiamento e guida. Analogamente, è pos sibile vedere se il cliente è riuscito a completare l’elaborazione di un’area di esperienza, perché in tal caso i suoi occhi cominciano a muoversi molto più liberamente e il terapeuta può rispecchiare questo evento con più ampi mo vimenti del dito. D’altra parte, alcuni clienti, in particolare le vittime di abu so sessuale, possono vivere i movimenti delle mani del terapeuta come trop po intimi e intrusivi e preferire la neutralità e la distanza della barra lumino sa o della stimolazione auditiva bilaterale.
Cosa accade durante una seduta EMDR o EFT? 53 La stimolazione bilaterale già da sola tende a risultare rilassante, ma per ottenere l’effetto terapeutico occorre anche sintonizzare il ‘campo di pen siero’2 sul problema bersaglio, essenzialmente chiedendo al cliente di pen sare alTesperienza dolorosa o all’angoscia e di fare attenzione alle emozioni e alle sensazioni fisiche che prova. Il clinico che seguisse il protocollo stan dard stabilito dalla Shapiro (2001), dovrebbe anche chiedere al cliente di misurare la gravità della propria sofferenza su una scala a dieci punti ideata da Wolpe (1990) e denominata s u d {Subjective Units of Disturbance, Unità Soggettive di Disturbo), e tentare di identificare la ‘cognizione negativa’ in termini di ferita dell’autostima e dell’immagine di sé connessa al trauma (per esempio, “Io sono debole e patetico”). Una volta stabilito il punteggio sud e la cognizione negativa, si può misurare il successo del cliente nell’ela borazione del trauma e dei pensieri autoreferenziali associati mediante il raffronto con le valutazioni originali. Tuttavia è ovvio che queste fasi non sono essenziali al processo e talvolta i clienti le trovano fastidiose. Viene poi applicata una forma di stimolazione bilaterale invitando il cliente a notare i pensieri, i sentimenti, le immagini e tutto ciò che gli viene in mente. Prima di procedere ad affrontare il trauma o altre esperienze do lorose, può esserci una fase iniziale in cui viene stabilito un ‘luogo sicuro’: questa operazione implica da parte del cliente la scelta di un luogo della memoria o dell’immaginazione in cui si sentirebbe sicuro e rilassato. Con centrandosi su di esso durante la stimolazione bilaterale e facendo caso alle sensazioni visive, auditive, olfattive, tattili e cenestesiche che caratterizzano il ‘luogo sicuro’, egli aumenterà il proprio senso di sicurezza e di rilassa mento. Lo scopo di questa fase è consentire al cliente di sperimentare il ri lassamento in parte come risorsa cui poter accedere in caso di necessità e a cui tornare alla fine della seduta. Anche questa non è una parte strettamen te necessaria del lavoro EMDR, per cui, se l’obiettivo della terapia non è il superamento di un trauma grave, è possibile scartarla. A questo punto si può cominciare a focalizzare il problema bersaglio, trauma noto o sintomo che sia. Il cliente dovrà pensare a tale problema mentre intraprende i movimenti oculari o si sottopone ad altre forme di sti molazione bilaterale. Talvolta l’elaborazione dell’emozione può essere mol to rapida e sorprendente, come se a seguito di tre o quattro movimenti ocu lari soltanto si aprissero d’improvviso delle cateratte. In altri casi, invece, il cliente riferirà che alla mente non gli è venuto un gran che. Di solito, però, già durante la prima serie emergono alcune informazioni emotive nuove: una forte emozione o sensazione corporea, un particolare dettaglio dell’esperienza traumatica o un pensiero relativo a quanto è accaduto. Man mano che il processo va avanti, £1 livello di sofferenza del cliente comincia a salire, per poi calare. Al termine di ciascuna serie di stimolazione bilaterale, il terapeuta può chiedere al cliente cosa gli sia venuto alla mente, o cosa gli
54 Le terapie energetiche
venga in mente in quel momento, ponendo in tal modo l’accento sulla cate na ininterrotta di associazioni libere. Il cliente fornirà allora una breve indi cazione dei sentimenti, delle sensazioni corporee, delle immagini o dei pen sieri che gli sono passati per la mente, oppure farà un discorso più ampio. A questo punto, di solito il terapeuta dice qualcosa come: “Va bene, conti nua a tener presente proprio questo”, e passerà alla serie successiva di sti molazione bilaterale. Se il problema bersaglio è un trauma noto, il cliente quasi sicuramente, prima o poi, comincerà ad accedere a emozioni e immagini angosciose. Col susseguirsi delle serie di stimolazione bilaterale, il suo livello di sofferenza (i punteggi s u d ) comincerà a salire, per poi diminuire gradualmente. Piutto sto spesso un trauma semplice subito da una persona che prima era psico logicamente sana può risolversi con un’unica seduta e m d r , forse in un’ora. Molte volte, però, quando l’esperienza traumatica recente si collega ad altra sofferenza non elaborata, per esempio a un trauma infantile, i problemi so no più complicati. Ogni area di difficoltà deve essere trattata in modo siste matico, consentendo al cliente di elaborare le emozioni, nonché i pensieri e le fantasie su se stesso. Spesso, una volta elaborata l’esperienza più recente, egli si metterà spontaneamente a pensare a un trauma anteriore, tematicamente collegato. Un’altra configurazione è quella in cui il cliente si blocca, non riuscendo a elaborare completamente il trauma bersaglio iniziale come si aspettava. Può darsi che il motivo dell 'impasse sia il collegamento con un trauma anteriore. Se tale legame non emerge spontaneamente, il terapeuta può chiedere: “Quand’è che ti sei già sentito così?”, usando l’emozione at tuale come ponte verso il passato. Una delle lezioni dell’EMDR è che l’ela borazione dei traumi del passato è proprio necessaria, a differenza di quel lo che sostengono alcune correnti psicoanalitiche contemporanee, le quali propugnano un’attenzione esclusiva ai modelli mentali e ai conflitti inconsci attuali del cliente (per esempio, Fonagy, 1999). LA S T I M O L A Z I O N E D E I P U N T I D I A G O P R E S S I O N E N E L L ’EFT
La procedura usata nel metodo psicoenergetico denominato e f t è mol to simile a quella dell’EMDR, tranne che, in luogo della stimolazione bilate rale, il cliente si sottopone al tapping. Questa tecnica consiste nel tamburel lare su una serie di punti di agopressione, situati principalmente intorno al viso e alle mani3 (per un maggior numero di dettagli si consulti il sito www.emofree.com; oppure Hartmann, 2003a; o Lynch e Lynch, 2001; o ancora Llewellyn-Edwards e Buttereil, 2003). I due metodi si differenziano leggermente l’uno dall’altro per l’accento posto nel corso dell’elaborazione: infatti I’e f t si concentra su un aspetto specifico di un’esperienza o di una
Cosa accade durante una seduta EMDR o EFTP 55 costellazione di emozioni, elaborandone un pezzetto alla volta; l’elaborazio ne EMDR sembra agire a livello più ampio. Un’altra differenza è che I’e f t comincia con una procedura iniziale volta a contrastare la frequente ten denza al ‘rovesciamento psicologico’, alla resistenza, all’autosabotaggio o al la reazione terapeutica negativa che impediscono la guarigione psicologica. Questa fase consente di aggirare l’ostacolo del conflitto interiore, produ cendo un’affermazione o una forma di autoaccettazione di ordine più ele vato mentre si fa il tapping su un particolare punto di agopressione. NelTem dr, le lotte interiori e le forze di autosabotaggio vengono elaborate contemporaneamente a tutte le altre emozioni e cognizioni, man mano che emergono nel corso della stimolazione bilaterale. LE A S S O C IA Z IO N I LIBERE ATTRAVERSO L ’ESPE R IE NZ A TRAUMATICA: IL FILO C O N D U T T O R E TEMATICO
Jean, una ragazza di diciotto anni, venne a cercare aiuto perché soffriva di depressione e autolesionismo (si procurava tagli sulle braccia). La valuta zione iniziale fece pensare che una relazione sessuale violenta subita all’età di quattordici anni le avesse lasciato un residuo di rabbia e di vergogna, ac compagnato da sintomi di stress post-traumatico persistenti (pensieri intru sivi di rabbia e ansia riguardo a quella relazione). Al momento aveva una storia importante, che le dava sostegno, con un ragazzo con cui viveva. Quando tra di loro si frapponevano i pensieri intrusivi derivanti dall’altra relazione, Jean ne restava sconvolta. Le esperienze vissute nell’ambito della relazione violenta furono scelte come bersaglio dell’EMDR ed elaborate in modo soddisfacente nel corso di un’unica seduta. In seguito, la ragazza riferì di sentirsi assai meno turbata da quei ricordi. Ma nella seconda seduta la sua angoscia era ancora molto evi dente. Ripercorrendone con I’e m d r l’evoluzione, la ragazza riferì un’espe rienza disturbante non ancora rivelata. Un paio d’anni prima, sulla chat line cui già da un po’ di tempo prendeva parte era comparso un messaggio il cui autore diceva di sapere che si chiamava Jean e dove abitava e di essere in grado di riconoscerla. Non avendo usato, ovviamente, il proprio nome vero né avendo rivelato alcun particolare che potesse identificarla, la ragazza era rimasta estremamente sconcertata e allarmata. A questo episodio aveva fat to seguito una telefonata di minaccia. Da altri episodi aveva ricavato l’im pressione di essere braccata, ma non era riuscita a capire se si trattasse del suo primo ragazzo o di un’altra persona. Durante l’elaborazione di queste esperienze, il terrore si impossessava totalmente di lei. Fu riconosciuta ed elaborata la sua angoscia di trovarsi sola in una stanza con un terapeuta di sesso maschile.
56 Le terapie energetiche Dopo questa seduta, la ragazza riferì una certa riduzione dell’angoscia e della depressione. In un’altra seduta e m d r furono affrontati i problemi at tuali della sua vita, principalmente quelli relativi alle situazioni in cui si sen tiva oppressa dagli altri e priva di autonomia. Poi parlò più diffusamente degli episodi di autolesionismo. Tagliarsi era per lei un momento di sollievo dalla tensione e di autopunizione. Inizialmente non le erano chiare le moti vazioni di questa tendenza, ma il lavoro di introspezione rivelò che era as sociata a un intenso sentimento di rabbia. Pur avendo, in realtà, smesso di tagliarsi, riferì un episodio recente in cui aveva avuto l’impulso a farlo. Era accaduto quando aveva parlato al proprio capo della possibilità di ripren dere a lavorare e quello aveva avuto una reazione piuttosto sgradevole. Mentre effettuava i movimenti oculari, chiesi a Jean di fare mente locale sulla rabbia e di cercare esempi precedenti in cui aveva provato lo stesso sentimento. Mi disse di ricordare esperienze vissute a quattro anni con la baby-sitter. Dalla descrizione venne fuori che questa era una donna decisa mente sadica, che imponeva la propria volontà infliggendo tutta una serie di punizioni fisiche, mentre si presentava ai genitori come una persona estremamente gentile e premurosa. Quando Jean aveva tentato di comuni care alla madre la paura e la rabbia che provava, la baby-sitter l’aveva smen tita. Ma la bambina, non riuscendo più a tollerare la rabbia, si era incaponi ta nelle sue accuse e aveva dichiarato che la bambinaia mentiva: a quel pun to la madre le aveva creduto. Andando avanti nell’elaborazione, Jean ripen sò al suo capo: si trattava di una donna molto simile alla baby-sitter, in quanto tendeva a punire e a controllare. Divenne chiaro che le difficoltà nel lavoro, la crescente depressione culminata in un lungo periodo di congedo per malattia dipendevano dai rapporti di Jean con questa persona, rapporti che le ricordavano le prepotenze della bambinaia sadica, come pure il com portamento violento e autoritario del suo primo ragazzo. Dunque il filo conduttore tematico riguardava le esperienze di coercizione subita da per sone sadiche. RAPIDA L OC AL I Z Z AZ I O NE D EL L ’ES PERIENZA TRAUMATICA
Talvolta le associazioni che il cliente fa nel corso della stimolazione bila terale sono piuttosto sorprendenti, in quanto vanno direttamente a toccare le esperienze determinanti essenziali. C’era, per esempio, un uomo di mez za età che, a seguito di un’affezione cardiaca relativamente modesta aveva sviluppato ansia ipocondriaca e panico. Le numerose sedute di psicoterapia cui si era sottoposto avevano gettato poca luce sulle origini del problema, anche se erano emerse alcune significative piste di indagine: per esempio che la struttura narcisistica della sua personalità era minacciata dall’invec-
Cosa accade durante una seduta EMDR o EFTP 51 chiam ento e dalla consapevolezza di dover m orire. Tuttavia, dopo solo qualche serie di m ovim enti oculari, improvvisamente gli sovvenne, con vivi ti! particolari e con le emozioni che l’avevano accompagnata, u n ’esperienza vissuta all’età di diciotto anni, quando, per fare una bravata, aveva inavver titamente assunto u n ’overdose di droga e lo avevano dovuto p o rtare al pronto soccorso. P rim a delPEMDR non aveva pensato coscientem ente a quell’episodio e ai legami che aveva con l’ansia attuale. D opo alcune serie di m ovim enti oculari, q u ell’esperienza traum atica fu elaborata e l ’uom o non soffrì più di ansia ipocondriaca.
Spesso l’esperienza patogena soggiacente non viene riconosciuta subito, ma se si prende come bersaglio dell’EMDR l’origine del sintomo o della dif ficoltà comportamentale la fonte del problema verrà rivelata. Per esempio, la signora R., giovane professionista sposata, si presentò accusando il sinto mo isterico di non riuscire a parlare in certe situazioni. Era diventato un problema al lavoro, dove era considerata una professionista di grande com petenza. La difficoltà di parlare si era presentata per la prima volta durante il funerale di un amico di famiglia. Era stata assalita da un estremo turba mento, non giustificabile in base ai rapporti con la persona deceduta. Quando aveva cercato di parlare con la figlia del morto si era accorta di non riuscire ad articolare parola. Nel raccontare quest’episodio, la signora R. si ricordò del funerale del proprio padre, morto dieci anni prima, quan do lei aveva tredici anni. Espresse il proprio sconcerto per il contrasto tra la scarsa emozione provata in quell’occasione e i sentimenti che l’avevano travolta al funerale dell’amico di famiglia. Convenimmo di cominciare I emdr con il campo di pensiero della signora R. sintonizzato sulla situa zione in cui erano comparsi per la prima volta i sintomi. Ella li associò im mediatamente al funerale del padre. Si ricordò infatti che prima della ceri monia si era sentita estremamente sconvolta, ma la madre e gli altri parenti l’avevano fatta vergognare, dicendole che doveva smettere di piangere al trimenti non le avrebbero permesso di partecipare al rito. Di conseguenza, la signora R. aveva lottato per soffocare i sentimenti e le lacrime e in segui to, nel corso del funerale vero e proprio, si era sentita intorpidita. Nei gior ni successivi al funerale c’erano state molte visite di parenti, alle quali, nel rispetto della cultura familiare, aveva dovuto presenziare come un’educata padrona di casa. In tal modo le erano rimaste poche opportunità di espri mere il proprio dolore. I ricordi e le emozioni vennero elaborati in un’uni ca seduta, a seguito della quale il sintomo della signora R. fu completamen te risolto. Anche quando l’esperienza bersaglio è nota, possono emergere nuovi e sorprendenti particolari una volta avviata l’elaborazione. Il signor Z. era stato testimone di un’aggressione molto grave in un pub, durante la quale un suo amico aveva subito una ferita che l’aveva messo in pericolo di vita.
58 Le terapie energetiche
Tentammo la terapia e m d r , ma non riuscimmo a procedere con l’elabora zione oltre le prime fasi dell’episodio, perché l’uomo venne ripetutamente travolto da un’angoscia apparentemente irriducibile. A quell’epoca il signor Z. beveva eccessivamente, nel tentativo di fronteggiare l’intenso stress posttraumatico. In molti casi sembra che il forte consumo di alcol interferisca significativamente con l’elaborazione del trauma emotivo: questo aspetto probabilmente è connesso alla scoperta, fatta da Callahan e altri nel campo della psicoenergetica, che talvolta le tossine possono ostacolare la guarigio ne emotiva. Dopo essersi recato da un consulente per i problemi di alcoli smo e aver finalmente smesso di bere, il signor Z. tentò di nuovo I’e m d r . Stavolta reagì in modo piuttosto diverso, ripercorrendo rapidamente le se quenze dell’aggressione con emozioni appropriate, ma tollerabili. A quel punto, si accorse con stupore di ricordare i dettagli delle azioni che aveva compiuto in prima persona e che fino ad allora aveva dimenticato. Appa rentemente aveva agito in modo alquanto eroico, riuscendo ad assestare un pugno gagliardo sul torace dell’aggressore e mandandolo a finire fuori del pub. Poi, non vedendo arrivare l’ambulanza, aveva caricato sulla propria macchina l’amico gravemente ferito e a grande velocità lo aveva condotto all’ospedale; fermato dalla polizia per non essersi fermato col semaforo ros so, aveva urlato che si trattava di un’emergenza ed era stato scortato dagli stessi agenti a sirene spiegate: grazie a tutto ciò, il suo amico si era potuto salvare. Prima dell’EMDR, il signor Z. non si era ricordato di questa succes sione di eventi e gli era rimasta un’immagine di sé debole e impotente. Ela borato l’episodio nel corso di un’unica seduta e m d r , l’uomo ritrovò la pro pria autostima.
L ’E L A B O R A Z I O N E D E L T R A U M A
Quando il campo di pensiero è sintonizzato sul trauma, la persona solita mente comincia a ricordare la sequenza di eventi, accompagnata dall’emo zione appropriata e dai pensieri connessi a quell’evento. Man mano che questi vengono elaborati mediante la stimolazione bilaterale, la tendenza psicologica generale si muove in direzione di una minore sofferenza. All’ini zio, però, il livello di quest’ultima (i punteggi s u d ), prima di calare, au menta. Di solito la strategia migliore consiste nel continuare a ripetere le se rie di stimolazione bilaterale finché i punteggi SUD non si riducono a zero, vale a dire a un livello in cui la persona riesce a ricordare l’episodio trauma tico come un evento sfortunato del passato, ma senza riviverlo. A questo punto l’esperienza è passata nella memoria autobiografica. Comunemente c’è una parte dell’esperienza che suscita più angoscia e questa sarà l’area su cui andrà focalizzata particolarmente l’attenzione. Quando tutto l’episodio
Cosa accade durante una seduta EMDR o EFT? 59 sarà stato elaborato, si potrà procedere alla verifica conclusiva chiedendo al cliente di effettuare una scansione corporea delle aree di tensione o di sof ferenza residua. Se il cliente le trova, si applica ancora la stimolazione bila terale mentre il suo campo di pensiero è sintonizzato su di esse. Questa ac curata verifica della reazione del cliente al ricordo del trauma è importante, perché il lavoro non è completo finché i punteggi sud non arrivano a zero e il cliente non avverte nessun disturbo a livello corporeo.
L’IMMAGINE DI SE, L’AUTOSTIMA E LE CREDENZE CIRCA IL SÉ Un'altra parte cruciale del lavoro consiste nelPesplorare le cognizioni connesse al trauma: si tratta di credenze riguardo al sé derivate dall’espe rienza traumatica. Tra queste potrebbero esserci convinzioni come: “Sono debole”, “Sono incapace di cavarmela”, “Sono merce danneggiata”, “Sono disgustoso”, “Non valgo nulla”, eccetera. Una volta che il cliente le ha iden tificate, gli si può chiedere di continuare a pensarci nel corso della stimola zione bilaterale. Di solito il suo pensiero comincerà a modificarsi sponta neamente, in senso positivo. A dire la verità, il metodo raccomandato dalla Shapiro consiste nel derivare dalla ‘cognizione negativa’ esistente una ‘co gnizione positiva’ contraria e nell’applicare poi la stimolazione bilaterale mentre il cliente la tiene a mente. Ma la cognizione positiva derivata deve rappresentare un’alternativa plausibile a quella negativa: pertanto non si deve andare contro la realtà, trovando cognizioni come: “Posso mettere in fuga qualsiasi aggressore” (per una vittima di stupro), oppure: “Posso esse re completamente al sicuro quando guido” (dopo un incidente stradale). Cognizioni come: “Sono riuscito a sopravvivere”, oppure: “Posso puntare all’obiettivo di guidare nel modo più sicuro possibile”, o: “Posso imparare dalle esperienze passate”, o ancora: “Posso diventare una persona affettuo sa”, invece, hanno maggiori possibilità di essere considerate plausibili e ac cettabili dal cliente. Una variante interessante di questa procedura viene usata nell’EFT, in cui, mediante la formula: “Mi accetto profondamente e completamente anche se... [ho quest’ansia/questo senso di debolezza/questo disgusto di me (eccetera)]”, si induce uno stato di accettazione che al lenta la resistenza al processo di guarigione. Nella tecnica della Shapiro, il terapeuta invita il cliente a misurare la validità soggettiva della cognizione positiva sulla scala v o c a 7 punti, dopo di che, usando la stimolazione bila terale, punta a far crescere tale punteggio. È possibile che la procedura e l’idea di derivare le cognizioni negative e positive risultino noiose per il cliente, ma l’attenzione ai pensieri di quest’ultimo intorno al trauma, spe cialmente ai pensieri sul sé, è importante, talvolta più importante dell’eia-
60 Le terapie energetiche
borazione stessa del trauma (della sua desensibilizzazione). La compromis sione dell’immagine di sé e delTautostima sembrano spesso una componen te cruciale del danno provocato dal trauma. L ’A N G O S C I A DI D I S I N T E G R A Z I O N E
A volte il cliente, di fronte alla prospettiva di modificare l’immagine di sé e le convinzioni riguardo al sé, può opporre una resistenza particolarmente forte. Ciò accade quando la struttura mentale della persona è organizzata intorno a una particolare visione del sé, per cui l’idea di modificare un pila stro fondamentale dell’autorganizzazione scatena un’angoscia di frammen tazione (o disintegrazione) (si veda il capitolo 5). La natura di quest’ango scia raramente è cosciente, ma se identificata e spiegata, di solito viene prontamente afferrata dal cliente. A questo punto, può essere elaborata me diante I’e m d r come qualsiasi altra ansia. Situazioni del genere si possono creare quando il rapido processo terapeutico non è congruente con le forti convinzioni della persona circa la mente o il mondo in generale (se, per esempio, è convinta che il cambiamento psicologico deve essere sempre lento e comportare molto dolore e sofferenza). Ciò può avvenire specialmente quando vengono adottati metodi psicoenergetici straordinariamente rapidi4 (Hartung e Galvin, 2003), che per certi versi non si conformano ai presupposti scientifici occidentali classici. LA S T R A T I F I C A Z I O N E D E L L E E M O Z I O N I
Il problema accusato dal cliente può avere livelli o aspetti differenti, pa ragonabili agli strati di una cipolla. Appena se ne toglie di mezzo uno, emerge quello successivo. L’esempio che segue è tratto dal contesto di una psicoterapia in corso basata sull’uso dell’E f t (www.emofree.com). La paziente, una donna molto disturbata, era stata vittima di gravi maltrat tamenti da parte della madre. Spesso entrava in uno stato di angoscia estrema o di panico, paranoia e confusione, ma, nonostante il caos della sua vita psi chica, aveva instaurato una relazione seria, duratura e molto affettuosa (ben ché, da parte sua, fluttuante) con un uomo che stava per sposare. Con ravvi cinarsi del giorno delle nozze, però, il suo stato mentale peggiorò e fu neces saria una seduta d ’emergenza. Essendo chiaro che il contesto del disagio at tuale era la prossimità del matrimonio, la paziente accettò di usare I’eft per ridurre l’ansia. Inizialmente era così agitata da non riuscire a parlare in modo coerente. Tuttavia, dopo la prima sequenza di tapping, divenne molto più cal-
Cosa accade durante una seduta EMDR o EFT? 61 ma. Riuscì allora a individuare un’ansia più specifica: la paura di non riuscire a pronunciare correttamente la formula matrimoniale di fronte a tutti. Dopo la seconda sequenza, giunse alla conclusione che l’ansia riguardava la paura di non riuscire proprio a parlare, inconveniente cui andava soggetta quando era molto stressata. Ancora una sequenza e riferì di avere ‘paura di aver paura’, problema che venne anch’esso elaborato. Arrivata a questo punto, cominciò a riferire tutta una serie di sensazioni fisiche intense: un gran calore e un formi colio, nausea, difficoltà di respiro, senso di restringimento alla gola e dolori muscolari. Le fu chiesto di far caso a tutte le sensazioni fisiche mentre veniva effettuata la sequenza successiva di tapping. Nel momento stesso in cui le sen sazioni cominciarono a placarsi, la donna riferì subito un’altra sensazione, di confusione. Un’ulteriore sequenza la fece rendere conto che la confusione era connessa ai suoi stati di paranoia e che aveva una gran paura di essere travolta dalla confusione paranoide, come spesso le era accaduto. La sequenza succes siva le diede la sensazione che avrebbe tollerato meglio confusione e paranoia. A questo punto si sentì più calma, anche se esausta e impaziente di addor mentarsi. Dunque l’elaborazione delle emozioni si era dapprima concentrata sull’ansia generale, poi su quella relativa a una prestazione di carattere socia le; in seguito si era spostata sulla ‘paura di aver paura’, che spesso è alla base del panico, e infine aveva mobilitato una gran quantità di tensione fisica, pri ma di discendere fino nello strato più profondo, quello della confusione para noide. Il rapido e sequenziale dipanam ento degli strati d ’ansia talvolta può con
sentire al medico di formarsi u n ’im pressione molto più chiara della struttu ra della psicopatologia. Per esempio, l’uso dell’EMDR con un certo pazien
te perm ise all’autore del presente volum e di individuare le dinam iche e la stru ttu ra di una ‘sindrom e dell’assassinio p sichico’ (M ollon, 2002b), che poi potè essere riconosciuta in molti altri pazienti, la cui terapia non richie se l’uso dell’EMDR.
IL TRANSFERT E ALTRI F EN O M E N I P S I COTERAPEUTI CI DI R O U TI N E
L’impressione iniziale comune è che I’e m d r e I’e f t siano procedure molto bizzarre, ma in esse trovano posto tutte le caratteristiche ordinarie e normali della psicoterapia e della psicoanalisi, anche se con un’accentuazio ne differente, dal momento che l’elaborazione, anziché sorgere dall’intera zione paziente-terapeuta, è essenzialmente interna (o intrapsichica). Pertan to, risulta cruciale la capacità del terapeuta di creare un’atmosfera recettiva cd empatica in cui l’inconscio del cliente possa parlare. Se i problemi psico-
62 Le terapie energetiche
logici del cliente sono complessi e pervadono la sua personalità, è possibile alternare I’e m d r e/o I’e f t con periodi di psicoterapia più tradizionale e di impostazione psicoanalitica. Nella mia esperienza, una simile combinazione è di gran lunga più efficace e valida della sola psicoterapia. In tal modo l’insight resta un elemento importante, ma, anziché essere la causa del cambia mento psicologico, sembra emergere come risultato dell’elaborazione. Ana logamente, l’interpretazione dei contenuti e dei processi finora inconsci vie ne spesso raggiunta dal cliente, anziché dal terapeuta. Il processo di trasla zione (del passato al presente) può essere visto come uno degli aspetti in cui si manifesta il funzionamento generale del trauma non sufficientemente elaborato: sia che si tratti di un trauma infantile sia che appartenga a una fa se successiva della vita, esso tende a deformare la percezione del presente, creando aree di evitamento fobico di quei fattori, interni ed esterni, che sca tenano l’affetto traumatico. Dunque, in virtù di un’assimilazione automati ca al passato, si ha una falsa percezione del presente. Man mano che l’espe rienza passata viene elaborata mediante I’e m d r o I’e f t , il paziente diventa libero di vedere se stesso e l’altro in modo nuovo. NelpEMDR e nell’EFT il ruolo del transfert è spesso abbastanza centrale, ma tendenzialm ente più transitorio, nelle sue manifestazioni, di quanto non lo sia nel lavoro psicoanalitico. La preoccupazione tem poranea per lo psi coterapeuta com e figura di traslazione consente al cliente di concentrarsi piuttosto rapidam ente e spontaneam ente sull’elaborazione delle esperienze e sui conflitti emotivi originari infantili su cui si basa la percezione transfe rale. Q uesto fenom eno viene illustrato dall’esem pio che segue.
Una donna con ansie sociali Una donna di mezza età si presentò lamentando ansie sociali. Da una di scussione ordinaria del problema, basata sulle associazioni libere, non emerse un gran che. Tuttavia durante I’em d r , effettuato mediante la barra luminosa, la cliente cominciò subito a fare maggiori rivelazioni circa le preoccupazioni soggiacenti. Si chiedeva continuamente quale ruolo le attribuissero gli altri e se lo assolvesse in modo soddisfacente. Dopo parecchie serie di movimenti ocula ri, durante i quali emersero questi problemi, rilevò che adesso il suo problema era di non sapere se eseguiva correttamente i movimenti oculari e se io ero contento di come li eseguiva. Non feci alcun commento o interpretazione in proposito, ma le indicai semplicemente che doveva andare avanti nell’elaborazione. Allora la donna cominciò a parlare della preoccupazione, che aveva da bambina, di compiacere la madre e di essere responsabile della sua felicità (re miniscenze e rilievi che indicavano l’origine di alcune sue ansie e, al tempo stesso, gettavano luce sul suo desiderio di compiacere, adesso, il terapeuta).
Cosa accade durante una seduta EMDR o EFT?
63
Ci fu un'altra sedu ta, ch e e b b e il seg u en te svilu p p o. O g n i riga num erata corrisp on d e alla risposta della p a zien te al term in e d i una serie di m o v im e n ti ocu lari. I co m m en ti d ell'a u to re so n o in corsivo. A n c h e in q u esto caso la p a zie n te p a rte da u n 'an sia in tern a al tran sfert p er p o i p assare sp o n ta n e a m en te a esplorarn e gli an teced en ti infantili.
1. Adesso sono preoccupata di non avere abbastanza da dire: di non riuscire a trovare abbastanza cose da dire a una persona che considero più intelli gente di me. Le tipiche ansie sociali di questa donna risultano evidenti nel rapporto che in staura col terapeuta.
2. Mi domando come mai ho bisogno di sentirmi a posto in tutto ciò che pen so e faccio. Si sta ponendo una domanda. L ’EMDR sembra determinare Vemergere spon taneo di domande opportune e stimolare poi nuovi insight e risposte.
3. Credo di ammirare l’intelligenza. Mio padre ha qualcosa a che fare con questo. Lavorava nei cantieri, ma leggeva molto. Diceva di essere circonda to da incompetenti. Era cresciuto in orfanotrofio, aveva dovuto lottare per difendersi, sceglieva sempre persone con cui poteva pontificare. Riconosce che le proprie ansie hanno in qualche modo a che fare con la paura infantile d i suscitare lo scherno del padre.
4. Pretendo moltissimo da me stessa. Penso sempre che gli altri mi giudichino. Riconosce la propria tendenza generale a pretendere molto da sé riguardo agli altri.
5. Sto pensando alla mia paura di arrossire. Teme che il proprio imbarazzo diventi evidente in modo imbarazzante.
6. Posso imparare un comportamento diverso, o sono inchiodata a questo? 7. Da dove viene la mia ansia? Continua a cercare le origini del suo problema.
8. Ricordo l’angoscia che ho provato all’inizio della scuola: ero terrorizzata. Si tratta probabilmente d i una mescolanza d i ansia sociale e d i ansia da sepa razione.
9. Mia madre era ansiosa. Se bussavano alla porta correvamo tutti a nascon derci in bagno. La famiglia sembra essere stata in balia d i un ansia condivisa circa il mondo esterno.
10. Non riuscivo a inserirmi tra gli altri bambini e restavo in un angolo. [Il terapeuta commenta: "Stai descrivendo la paura di essere giudicata da gli altri: come se il mondo fosse pieno di fotocopie di tuo padre pronte a pensare che sei stupida, incompetente, e così via”]. 11. Mia madre aveva il terrore dei medici (sono quarantuno anni che non fa una visita) e mi minacciava di portarmici.
64 Le terapie energetiche Ora sembra cambiare argomento e prendere in considerazione le ansie ma terne. 12. Penso che mia madre sia atterrita al pensiero di trovare una soluzione a questo problema: se io lo superassi, lei dovrebbe giustificarsi di non fare al trettanto. Comincia ad alludere a una relazione simbiotica con la madre, in cui quest’ul tima le chiede di restare unita a lei nella comune visione di un mondo perico loso. 13. Le persone nuove mi destano preoccupazione: non sono sicura se riuscirò a portarle dalla mia parte. Anche qui rivela una visione paranoide del mondo. 14. Se migliorassi, probabilmente deluderei mia madre. Un pensiero fugace: mi sento come se fossimo legate insieme. Un’espressione molto chiara della perniciosa simbiosi con la madre. [Il terapeuta chiede: “Una difficoltà a sviluppare un’identità separata da tua madre?”]. Sì, lei rinforza la mia ansia: sarei dovuta rimanere bambina, ha cercato di bloccarmi a quella fase della vita. Mi sono sentita sempre come la sua pro tettrice. [Il terapeuta chiede: “Hai sacrificato la tua vita per tua madre?”]. Non ci avevo mai pensato: ora ho trovato lo spunto per pensarci. Q uesta sola seduta copre una gran quantità di terreno psicodinam ico piuttosto condensato: la paziente comincia con u n ’iniziale e transitoria con centrazione sull’ansia relativa al terapeuta, ma poi passa a una spontanea re visione delle esperienze rilevanti relative ai rapporti col padre, uom o incli ne allo scherno; infine giunge al più cruciale riconoscim ento dell’ansia su scitata dal pensiero di spezzare la relazione simbiotica con la madre. Il con tenuto e il processo sono chiaram ente di natura psicodinamica, riguardando il conflitto e l’ansia nata dai rapporti con i genitori, ma il m etodo è p iu tto sto diverso da quello della psicoterapia psicoanalitica di tipo verbale, p o i ché, per quanto il terapeuta offra di fatto alcune riflessioni facilitanti, è chiaro che il processo essenziale non si basa sulle sue interpretazioni. D opo quattro sedute e m d r condotte secondo queste linee, la paziente riferì una notevole attenuazione della propria ansia sociale. Un fenom eno non comune ha luogo quando una persona, che per anni si è sottoposta alla psicoterapia psicoanalitica tradizionale, scopre che una se duta o due di e m d r possono aiutarla ad alleviare ed elaborare la propria sofferenza rim asta ingabbiata nel sistem a psicosom atico, come illustra l’esempio tra poco riportato. Pazienti del genere spesso riescono a giovarsi dell’EMDR in m odo particolarm ente rapido ed efficace, probabilm ente p er ché questa terapia riesce ad allentare le loro rigide difese, il che, com binan-
Cosa accade durante una seduta EMDR o EFT? 65 dosi con l’elevato livello di insight già raggiunto in precedenza, consente un accesso relativamente facile alle ansie e alle fantasie inconsce.
Una donna con ansia da parto Una trentenne in stato interessante venne a chiedere di essere aiutata perché soffriva di ansie relative al parto; in precedenza aveva tratto benefi
cio da una psicoterapia di tipo psicoanalitico durata quattro anni con una frequenza di una volta a settimana. Senza fornire tutti i dettagli circa (’anamnesi della paziente, basterà dire che l’ambiente familiare in cui aveva trascorso l’infanzia sembrava essere stato piuttosto brutale sotto il profilo emotivo e deprivante dal punto di vista affettivo. La seguente trascrizione, tratta da una seduta e m d r , indica come la donna ebbe rapido accesso a un materiale psichico primitivo e vivido, che altrettanto rapidamente potè elaborare, incentrato sulla prospettiva del par to: la paura di dare alla luce un mostro; il desiderio di regredire alla vita prenatale per restare per sempre nell’utero materno; un trauma medico in fantile con il dolore e l’umiliazione che aveva comportato; il guadagno se condario derivante dalla malattia infantile, ossia il desiderio di attirare l’at tenzione e l’amore del padre, dato che si trattava di un medico; la vergogna e il senso di colpa legati alla masturbazione e alle fantasie edipiche infantili; un atteggiamento di ritenzione trionfante. 1. Il bambino è bloccato. Non voglio che venga fuori. 2. Ho paura di due cose. Che sia un mostro e che mi laceri.
A questo punto il bambino viene vissuto come una figura minacciosa e perse cutoria. 3. Non so se riguarda me da bambina o il bambino vero e proprio. Non vuole venir fuori. È così bello dentro.
Qui manifesta un rapido insight di come i propri sentimenti e le proprie fan tasie siano legati a un identificazione con il bambino, con il bambino in quan to parte di sé. 4. Penso a quando, a quattro anni, sono stata all’ospedale. Cateteri... dover divaricare le gambe... persone che osservano... mi fanno male. Allora pen so a B. che osserva il mio ultimo parto e scatta fotografie.
È passata di colpo al ricordo di un trauma infantile associato, per poi rivolgere l’attenzione a una precedente esperienza di parto. Questo spostarsi tra espe rienze infantili e adulte è un elemento tipico e, al tempo stesso, necessario per la risoluzione delle reti associative del trauma e del conflitto. 5. Odio questa parte del mio corpo [indica la sua ‘protuberanza’]: è così brut ta e ripugnante.
66 Le terapie energetiche Ora si concentra sui suoi sentimenti disforici riguardo al proprio corpo e continua ad associarli alle esperienze e alle fantasie infantili che lo riguardano. 6. [Perché?] È così brutta... sono malata... c’è qualcosa che non va nella mia pipì... continuano a guardarla... la vergogna... piacere e dolore... dicevano che volevo attirare l’attenzione quando mi sono ammalata di reni... è tutto mescolato con la masturbazione... dolore e piacere fusi insieme. Sta descrivendo la confusione infantile tra sentimenti efantasie differenti: do lore, ma anche piacere derivante dal guadagno secondario della malattia, combinati al tempo stesso con le fantasie che legano i problemi urinari alla masturbazione. 7. Quello che esce da me è cattivo e malato. Vogliono tirarmelo fuori, con la forza... Ho cercato di darglielo volontariamente... così ho fatto pipì... gliel’ho data... hanno gridato... deve venire fuori con la forza. Qui ci sono chiare indicazioni circa le radici della paura di partorire. Nella sua fantasia, la nascita comporta un estrazioneforzosa dal corpo, un processo in cui Iautonomia è calpestata. 8. Un pensiero cattivo che avevo da bambina era che mi sarei tenuto stretto tutto... non avrei mai più lasciato andare nulla... veramente cattivo. I sentimenti e le fantasie sadico-anali sono provocate dalla vergogna e dalÏ umiliazione provate durante gli esami e i controlli intrusivi del corpo da par te di altre persone. 9. Pensieri cattivi... ritenzione trionfante... un desiderio di essere violentata... Non riesco ad arrendermi... specialmente se guardano. Diviene chiaro il legame tra l’ostilità infantile verso medici e infermiere e il più contemporaneo risentimento nei confronti delle ostetriche. 10. Le ostetriche vogliono cacciarmi le dita dentro... mi fanno davvero male... volevo metterci le mie dita... per sentire la testa del bambino... ho provato vergogna... B. le guardava mentre mi cacciavano dentro le dita e io non vo levo che lo facessero... non mi ha aiutato. La masturbazione in ospedale... ho abusato di un’altra bambina... dolore e piacere. Qui comincia ad alludere all’ansia e al senso di colpa circa le fantasie e le at tività sessuali legate al tentativo di ristabilire la propria autonomia. 11. La gravidanza è pura e angelica... ma c’è contaminazione... il parto è odio so da vedere... la vergogna e la bruttezza. 12. La vergogna di essere femmina. Sto pensando a una sessualità molto pre coce... che aveva a che fare con i miei fratelli e con mio padre. 13. Quel senso di contaminazione... di essere stata sporcata... di non essere una bambina. 14. [Da dove viene il senso di contaminazione?] Ho la sensazione che tu sei ar rabbiato... che i miei pensieri non sono corretti... che non sto andando be ne... che i miei pensieri sono tutti sbagliati... il mio amore per il bambino e la sessualità tutto mescolato insieme.
Cosa accade durante una seduta EMDR o EFT? 67 Le sue aspettative di disapprovazione entrano nel transfert. Poi continua ad associare ai desideri infantili riguardo al padre. Questo è un tipico esempio di come i sentimenti e le ansie ‘qui e ora del transfert cedano rapidamente il passo alle associazioni con le esperienze anamnestiche rilevanti. 15. Se cercherò di ottenere amore da mio padre verrò punita. 16. Sento che sto sbagliando tutto... Dovrei parlare del parto... come quando pensavo di essere molto furba con mio padre... ammalandomi per avere la sua attenzione... ma poi sono stata punita. 17. Un pensiero orribile... godere dell’attenzione degli altri dottori... rancore verso i pazienti di mio padre che ottengono la sua attenzione. Un perfido senso di trionfo... io ottengo l’attenzione di parecchi dottori... mi sento co sì impura.
Esprime il proprio risentimento verso il padre che presta attenzione ai propri pazienti e il trionfante guadagno secondario derivante dalla malattia. 18. [Perché impura?] Perché l’amore si è contaminato. Ho la sensazione di aver giocato una partita... ero diventata molto altezzosa... non lo guarda vo... pensavo che mio padre sarebbe venuto a implorare... ma non lo fece... morì. 19.1 miei pensieri ritornano a B. al momento del parto. È diventato mio pa dre... mi stava a guardare mentre altre persone manipolavano il mio corpo. È come se fosse mio padre che resta a guardare con distacco senza interve nire. 20. Non potrei più commuovere mio padre né potrei più commuovere B. Da re alla luce un bambino è come donare tantissimo amore... tutto ciò che so no diventata... la mia altezzosità, la mia asprezza... tutto semplicemente se ne va... non riesco a sopportarlo. Voglio riuscire a essere tenera e vulnera bile... ed essere tenuta tra le braccia... voglio tornare a essere una neonata.
Descrive in che modo ha sviluppato un altezzoso distacco narcisistico per pro teggersi dalla nostalgia dell'amore paterno. Questo stato mentale viene mina to dalla vulnerabilità inerente al parto e dalla vulnerabilità del bambino. 21. Partorire... tutto il pensiero di aprire... essere aperta... accadrà qualcosa di terribile... come la morte. 22. Sento che sto perdendo la mia sessualità... non posso mettere insieme la re sa e l’innocenza con il sesso... la madre e l’amante... sono una madre con un bambino... quindi sono perduta.
Affronta la difficoltà di riconciliare sessualità e maternità, il paradosso del fi glio di una madre con una sessualità (Bollas, 2000). 23. Se il bambino uscirà da me, sarò contaminata? Essere incinta vuol dire ave re una sessualità... ma diventare madre non è associato a niente di buono neanche per me. 24. Paura del rifiuto... sono il bambino... paura del rifiuto di mio padre... paure terribili.
68 Le terapie energetiche
25. Sarò ancora amata quando nascerà il bambino? 26. [Fatti questa domanda] Non mi sono sentita amata quando sono nati i due figli di D. Penso che questa volta lo sarò. 27. [Riesci a rivedere quello che hai detto finora?] Sento che per tutta la vita ho cercato di manipolare e di controllare... ho cercato di controllare il mio corpo e le mie emozioni... ma l’unico modo in cui posso ricevere e non per dere l’amore è lasciandomi andare e arrendendomi. Questa osservazione conclusiva è interessante, perché la paziente riconosce quello che sarebbe potuto apparire un persistente atteggiamento maligno e di struttivo del carattere. L’impressione generale lasciata daWEMDR è che le motivazioni distruttive, benché prevalenti, non sono primarie. Successivamente la paziente riferì che il parto era stato un’esperienza molto positiva e tutt’altro che problematica e che il bambino sembrava par ticolarmente vigile, felice e sano. FACI LI TAZI ONE E I NSTALLAZIONE DELLE RISORSE POSITIVE
Oltre che per elaborare l’esperienza traumatica e il conflitto psicodina mico, I’e m d r viene spesso usato per aumentare o installare le risorse posi tive. Ne è un esempio la prassi comune di installare un luogo sicuro’ prima di procedere all’elaborazione del trauma, ma ve ne sono molti altri. Uno de gli insegnamenti dell’EMDR è che l’elaborazione mentale, se viene facilitata, procede spontaneamente in una direzione positiva. Pertanto le ‘cognizioni negative’, se viene applicata la stimolazione bilaterale, tenderanno a trasfor marsi in ‘cognizioni positive’. Una volta che la mente ha cominciato a con cepire la possibilità di una visione più positiva, I’e m d r può aumentare la percezione della sua validità. Talvolta l’installazione del positivo diventa maggiormente cruciale. Può accadere che una persona non sia in grado di accorgersi che ha delle risorse mentali o comportamentali per portare a ter mine un particolare compito, o che una scarsità di esperienze interpersona li positive durante l’infanzia le abbia lasciato in eredità un deficit psicologi co che si manifesta in un’inadeguata forza dell’Io. In casi del genere si può applicare la stimolazione bilaterale mentre il campo di pensiero del cliente è sintonizzato su esperienze e risultati positivi appartenenti al reale bagaglio del cliente. Per esempio, un uomo venne a cercare aiuto perché affetto da una forma disabilitante di stress post-traumatico caratterizzato, tra l’altro, da ansia e depressione gravi e dovuto a un incidente stradale in cui per po co non era morto. Il paziente, la cui infanzia era stata difficile e contrasse gnata da traumi e trascuratezza, aveva il terrore che qualsiasi tentativo di
Cosa accade durante una seduta EMDR o EFT? 69 elaborare l’esperienza dell'incidente scatenasse in lui sentim enti incontrol labili derivanti dalle circostanze avverse in cui si era precocem ente trovato. Invece di prendere com e bersaglio dell'EMDR l'incidente, si utilizzò la tec nica in questione p e r accedere a precedenti esperienze di successo e di su peram ento di avversità. L 'u o m o com inciò a richiam are alla m em oria vari campi in cui aveva effettivam ente raggiunto dei risultati, com presa la sua abilità nella guida. A seguito di questa operazione si o tten n e un m arcato miglioramento dell'um ore e dei sentimenti di fiducia, che consentirono suc cessivamente di intraprendere in m odo soddisfacente l'elaborazione dell’in cidente. L ’im portanza attribuita dall'EMDR all’installazione delle risorse positive suscita diffidenza in coloro che hanno un'im postazione psicoanalitica: te m ono infatti che questa p ro ced u ra im pedisca di affrontare pienam ente il negativo, costituendo una sorta di collusione tra cliente e terapeuta per evi tare la disperazione o altre form e di dolore emotivo profondo. Senz'altro si tratta di un rischio possibile, ma che si può eludere se vengono osservati scrupolosam ente i p rin cip i dell'EMDR. R icorrere al ‘positivo’ com e a una sorta di evitam ento dell'elaborazione del negativo costituirebbe una cattiva procedura nell'am bito dell’EMDR così come in quello psicoanalitico.
IN SINTESI L’e m d r utilizza fenomeni congruenti con i principi originari della psi coanalisi, come le associazioni libere, le reti della memoria e il conflitto psi codinamico. Tuttavia, mentre in psicoanalisi il raggiungimento della risolu zione avviene prevalentemente mediante l'interpretazione del transfert da parte del terapeuta, I'em d r pone l’accento sull'elaborazione intrapsichica. Questa viene facilitata dalla stimolazione bilaterale, che può assumere la forma visiva, auditiva o tattile e dirige l'attenzione alternativamente sui due lati del corpo e, pertanto, su ciascuno degli emisferi cerebrali. Il cervellomente, quando viene aiutato dalla stimolazione bilaterale, mostra una ten denza naturale a elaborare i traumi e a dirigersi verso una risoluzione emo tivamente positiva. Una parte importante di questa elaborazione è la tra sformazione dei pensieri e delle convinzioni relativi al sé. Ciò può rivelare come la psicopatologia abbia una struttura a strati e a reti, per cui ogni aspetto può essere elaborato sistematicamente. Oltre che per l'elaborazione del trauma, I'em d r può essere usato per installare o potenziare le risorse mentali positive, ma, come nella terapia psicoanalitica tradizionale, la con centrazione sul positivo non deve essere utilizzata per evitare difensivamen te di affrontare il negativo. Le manifestazioni di transfert possono risultare evidenti nel corso dell'EMDR, ma non sono considerate il veicolo cruciale
70 Le terapie energetiche
della guarigione. Il terapeuta ha il compito di facilitare l’elaborazione inter na, ma, in generale, deve fare un uso estremamente parsimonioso dei com menti e della presentazione del contenuto. Principi analoghi si applicano anche al lavoro energetico, a meno che l’elaborazione sembri aver luogo a un livello più elevato del sistema psicosomatico.
4 L’abbandono dei ricordi, del trauma e della sessualità: l’eccessiva preoccupazione per il ‘transfert’ e altri problemi della psicoanalisi contemporanea Noi dunque giungiamo a rappresentarci una quantità di libido... la produzione, Taumento o la diminuzione, la suddivisione e lo spo stamento della quale ci deve offrire le possibilità per spiegare i fe nomeni psicosessuali osservati. F reud , 1905, p. 523
La psicoanalisi, così come è stata originariamente concepita da Freud, è una teoria psicobiologica, che implica i concetti di conflitto psicodinamico, energia (libido), radici corporee della psiche (teoria della libido) e trauma. Secondo Fipotesi freudiana, la corrente della libido, con le sue radici nelle vie corporee, può essere bloccata dall’angoscia, dal conflitto e dal trauma e tale blocco non solo produce sintomi, ma può avere come conseguenza an che la regressione, la risalita del flusso stesso lungo le vie dello sviluppo li bidico e il rischio che riemergano forme di sessualità infantile abbandonate e inaccettabili, le quali, a loro volta, diano origine a un’ulteriore rimozione della libido. Tutti questi concetti fondamentali sembrano essere stati scarta ti dalla psicoanalisi post-freudiana. Non si fa più il minimo accenno né alla libido né ad altre forme di energia a base corporea. Wilhelm Reich, che aveva preso sul serio il concetto freudiano della base corporea delle ‘difese del carattere’, fu bandito e ridicolizzato: le sue teorie, e le terapie bioener getiche che ne scaturivano, sembravano troppo eccentriche all’epoca. Ep pure oggi risultano altamente congruenti con la psicoenergetica contempo ranca e con la ricerca sull’energia biologica (Becker e Seiden, 1985; Bischof, 1995, Reich, 1942).1 Nella psicoanalisi contemporanea, i sintomi non ven gono più letti come formazioni di compromesso, derivanti dalla rimozione, che consentono tuttavia qualche infiltrazione di libido lungo canali defor mati. Similmente, anche la regressione viene menzionata di rado. Più o me no tutti ignorano il concetto di ‘nevrosi di traslazione’, secondo cui tutta la libido rimossa si coagulerebbe intorno alla figura dell’analista consentendo
72 Le terapie energetiche
di risolvere i blocchi psicologici al sano e libero fluire della libido lungo vie realistiche. Un altro fondamentale concetto psicoanalitico chiamato in causa in alcu ne tecniche moderne è quello delle associazioni libere, viste da Freud come lo strumento cruciale per rivelare i blocchi della corrente della libido. Ma Fonagy ha così dichiarato: “Sono venuto per seppellire le associazioni libe re, non per lodarle” (citato in McDermott, 2003), sostenendo che le verbalizzazioni del paziente non sono libere, ma fondamentalmente vincolate a regole, e vanno sempre interpretate nel contesto della comunicazione che si instaura all’interno della relazione con l’analista. In tal modo l’accento vie ne spostato dall’attenzione essenzialmente intrapsichica a quella interperso nale e relazionale. Al posto del modello freudiano, ciò che oggi caratterizza la psicoanalisi britannica è la preoccupazione per la relazione di attacca mento o di dipendenza del paziente nei confronti dell’analista, relazione che viene vista come un esempio dei problemi relazionali tipici del pazien te. Invece che sulla libido, l’attenzione si concentra sugli attacchi distruttivi dichiarati dal paziente contro la dipendenza. La sessualità viene general mente ignorata, a meno che non sia costruita come ‘perversione’ e dunque come espressione delluistinto di morte’ (in quanto opposto alla libido). Il conflitto psicodinamico spesso non viene preso in considerazione (si veda a questo proposito la discussione di Betty Joseph, 1985, riportata di seguito), e certamente non come formazioni di compromesso tra forze della libido e forze della rimozione. Sorprendentemente, questa trasformazione della psi coanalisi freudiana (psicodinamica e psicoeconomica) in una forma di psi coterapia basata sulla relazione e liberamente strutturata su una teoria che non ha più radici nel corpo e nella libido, sembra aver preso piede senza grande consapevolezza del suo totale sradicamento dalle origini. Studiare l’attaccamento e le ‘relazioni oggettuali’, nonché i modelli interni derivati dalle prime esperienze relazionali, è senza alcun dubbio importante, ma nell’abbandono della teoria freudiana della libido e dei concetti relativi al l’energia psichica senz’altro è andato perduto qualcosa. Nella citazione seguente, in cui discute l’angoscia da separazione del bambino, si può cogliere l’importanza che Freud attribuiva al modello dell’energia-libido. Quando il poppante cerca di percepire la madre, ciò avviene in quanto egli sa già per esperienza che essa soddisfa senza indugio tutti i suoi bisogni. La si tuazione che egli valuta come ‘pericolo’, e contro la quale vuol essere assicura to, è dunque quella del mancato soddisfacimento, della tensione crescente do vuta al bisogno, nei cui riguardi è impotente... la situazione del non soddisfaci mento, in cui le quantità di stimoli raggiungono un’altezza spiacevole, senza poter essere dominate mediante un’utilizzazione e una scarica psichiche, deve
Uabbandono dei ricordi' del trauma e della sessualità 73 essere analoga per il poppante all’esperienza della nascita... ciò che è comune a entrambe è la perturbazione economica dovuta all’aumento delle quantità di stimoli che richiedono di essere liquidati (Freud, 1925, p. 285).
Così, Freud descrive in queste pagine le funzioni che riveste la madre nella regolazione degli stati di tensione e di eccitamento del bambino, quel le che Kohut (1971) avrebbe più tardi denominato 'funzioni dell’oggettosé\ E più oltre continua: Contro il ritorno della situazione angosciosa traumatica originaria anche l’es sere adulti non offre alla fin fine alcuna garanzia sufficiente; vi è forse per ognu no un limite oltre il quale l’apparato psichico non riesce a far fronte alle masse degli eccitamenti che pretendono di essere liquidati (Freud, 1925, p. 295).
Dall’inizio alla fine dei suoi scritti, ossia dal Progetto in poi, Freud si è preoccupato delle vicissitudini delle quantità di energia, del loro fluire at traverso il corpo e la mente, o dei blocchi subiti lungo il percorso con con seguente creazione di tensione. Come possono ancora definirsi freudiane una teoria e una terapia che scartino questo fondamentale tema psicodina mico e psicoeconomico? Sotto certi aspetti, nell’EMDR e nella psicoenergetica è possibile trovare un’approssimazione più vicina alla psicoanalisi originaria. L ’e m d r conside ra il danneggiamento del funzionamento psicologico (ovvero non organico) come un fenomeno radicato nel trauma e nel blocco dell’elaborazione emo tiva: come se il trauma venisse a essere, in effetti, imprigionato nel sistema nervoso e nel corpo. I desideri e i pensieri (interni) che potrebbero even tualmente determinare la stimolazione delle esperienze traumatiche imma gazzinate, o gli elementi (esterni) che le richiamano alla memoria, suscitano ansia e inibiscono pensieri e sentimenti. Questi blocchi impediscono il libe ro fluire dell’energia e delle informazioni entro la mente e il corpo. L’elabo razione mediante I’e m d r consente la ripresa del flusso di energia e della normale digestione dell’esperienza. Analogamente, i metodi di psicoenerge tica (Hartung e Galvin, 2003) si basano sul presupposto che il danno psico logico si presenti sotto forma di blocchi del flusso di energia e delle infor mazioni nel sistema dei meridiani del corpo. Tali blocchi derivano da un trauma psicologico, ma il problema non è il ricordo in sé e per sé, bensì le perturbazioni del flusso di energia che ne sono derivate. Entrambi questi approcci, al pari della teoria di Freud, riconoscono la resistenza al tratta mento e alla liberazione del flusso di energia. Nella psicoenergetica, la resi stenza viene concettualizzata in termini di 'rovesciamento psicologico’, una sorta di inversione di polarità del sistema energetico con risultati simili a quelli descritti da Freud quando parla di 'pulsione di morte’, ‘coazione a ri-
74 Le terapie energetiche
petere’, ‘resistenza’ e ‘reazione terapeutica negativa’. Quello che non si tro va nell’EMDR e nella psicoenergetica è una particolare preoccupazione per il transfert (o i conflitti infantili proiettati sulla figura dell’analista), ma è da vedere se Freud considerasse il fenomeno del transfert cruciale per la psi coanalisi o semplicemente non riuscisse a trovare un altro modo per susci tare e liberare la libido. Non esiste alcun fondamento teorico all’idea che l’interpretazione del transfert sia l’unico mezzo per risolvere i problemi creatisi all’interno della mente psicodinamica e del corpo. Nel modello ge nerale freudiano dell’unità psiche-soma, il transfert appare piuttosto come un elemento marginale, una semplice parte dei processi psicodinamici della mente da cui deriva un “falso nesso” (Breuer e Freud, 1895, pp. 436-439) tra una rappresentazione rimossa e una preconscia (Freud, 1899, p. 513), oppure una figura esterna. A dire il vero, Freud ha scritto relativamente po co sulla tecnica relativa al transfert (Freud, 1912,1914b), e certamente non si è dilungato molto sul ‘controtransfert’ come spesso accade oggi. Come analista, sono anni che ascolto resoconti dettagliati di trattamenti analitici contemporanei, provando crescente disagio e sconcerto nel consta tare un’eccessiva insistenza su una particolare visione del transfert (specialmente di quello negativo). Spesso gli interventi dell’analista, anziché cerca re di comunicare empaticamente la comprensione del conflitto psicodina mico e degli stati di tensione intrapsichici allo scopo di liberare l’energia bloccata, sembrano concentrarsi su ipotesi che riguardano X a ttiv ità incon scia del paziente, il quale esprimerebbe una sorta di ostilità nei confronti dell’analista. In relazione a questo aspetto, alcune versioni della tecnica psi coanalitica britannica contemporanea prevedono un apparente antagoni smo tra paziente e analista, al posto dell’alleanza terapeutica che, da quanto risulta in tutta la ricerca, è il fattore più cruciale per ottenere risultati tera peutici positivi (Bordin, 1979; Garfield, 1995; Gaston, 1990; Orlinsky, Grawe e Parks, 1994). La diffusa tendenza a interpretare ostinatamente il cosiddetto ‘transfert’ nei termini dell’attività ‘qui e ora’ del paziente nei confronti dell’analista, benché particolarmente legata a qualche rappresen tante della corrente kleiniana, risulta oggi trasversale ai tre gruppi della So cietà Psicoanalitica Britannica.2 Questo modo di usare la tecnica è associa to a certi presupposti, secondo cui solo le interpretazioni cosiddette ‘tran sferali’ connesse alle angosce immediate vissute in relazione all’analista, sa rebbero ‘mutative’; i commenti interpretativi al di fuori del transfert imme diato sarebbero troppo intellettuali e tenderebbero a implicare un ritiro collusivo dall’angoscia; la ricostruzione delle prime esperienze relazionali è inattendibile perché la percezione che il paziente ha dei genitori sarebbe stata deformata dalla fantasia proiettiva; l’idea dell’‘alleanza terapeutica’ e i concetti correlati sarebbero fuorviami, dal momento che l’intera relazione del paziente con l’analista è pervasa dal transfert; tutte le comunicazioni e le
V abbandono dei ricordi, del trauma e della sessualità 15 attività del paziente nello studio dell’analista sarebbero inconsciamente un’espressione del transfert. Per tutti questi motivi, spesso l’unica attività analitica considerata utile è quella che consiste nel commentare l’attività transferale inconscia del paziente in relazione all’analista. Ma questi diffusi presupposti, con le tecniche associate, benché motivati dalle più elevate preoccupazioni per il rigore, potrebbero risultare azzarda ti. Nonostante la scarsità di ricerche valide che ci indichino le forme più proficue di tecnica psicoanalitica e quelle che potrebbero essere dannose, esistono tuttavia studi dai quali è emerso come eccessive interpretazioni transferali sarebbero associate a scarsi risultati. Per esempio, a quanto rife risce Hoglend (1993), da uno studio condotto dal suo staff di ricerca su pa zienti seguiti fino a due e a quattro anni, è emerso che la psicoterapia asso ciata a poche interpretazioni transferali conduce a risultati migliori di quel la con interpretazioni molto frequenti. Egli commenta inoltre: Si potrebbe ipotizzare che un’analisi costante dell’interazione paziente-ana lista porti a un temporaneo deterioramento, ma che a lungo termine (anni) de termini un aumento dell’insight e la traduzione di questo in azione creativa, nonché un cambiamento comportamentale adattivo sostenuto. Ma questa fa mosa teoria dell’incubazione non trova alcun sostegno nel nostro studio (Hoglend, 1993, p. 504). Piper, Hassan, Azim, Joyce e McCallum (1990) hanno riscontrato un “rapporto inversamente proporzionale significativo tra la percentuale di in terpretazioni transferali fornite dal terapeuta, da una parte, e le misurazioni dell’alleanza terapeutica e il risultato della terapia, dall’altra” (p. 951). Gli autori aggiungono inoltre: Sostenitori dell’uso delle interpretazioni transferali, come per esempio Strachey, sono stati talvolta identificati con la posizione estrema, secondo la quale andrebbero effettuate solo interpretazioni transferali, o più se ne fanno e me glio è; non era questo il punto di vista di Strachey. Egli sosteneva che, duran te la terapia, il normale corso degli eventi è rappresentato da un’oscillazione tra interpretazioni transferali e interpretazioni che non riguardano il transfert e che le prime possono occupare solo una piccola parte del trattamento {ibid., p. 952). Analogamente, anche Connolly e altri (1999) hanno scoperto che “in al cuni pazienti, livelli relativamente elevati di interpretazioni transferali pos sono condurre a scarsi risultati terapeutici” (p. 491). Ovviamente, dobbia mo essere cauti nel trarre conclusioni per la pratica psicoanalitica: gli studi citati non riguardano analisi di cinque volte a settimana e il contenuto delle
76 Le terapie energetiche interpretazioni transferali può variare considerevolmente a seconda della teoria psicoanalitica applicata e del luogo geografico. Nondimeno, questi autori sollevano questioni relative al valore terapeutico dell'interpretazione transferale, mettendo in dubbio la qualità del vestito dell'Imperatore, ossia del transfert ‘qui e ora'. Quali sono le fonti di questa tecnica britannica? Essa sembra in parte scaturire da una lettura errata e da una deformazione della posizione di Freud (1912) e di quella di Strachey (1934). Entrambi gli autori hanno da to risalto all'importanza dell’interpretazione transferale, ma senza conside rarla il fulcro esclusivo dell'analisi. Una seconda origine sembra essere la di retta applicazione della tecnica analitica infantile al lavoro con gli adulti, specialmente laddove viene combinata con la teoria kleiniana del mondo fantastico interiore e del modello proiettivo del transfert. Un altro influsso sembra derivare dalla distinzione che fanno i Sandler (1983,1984,1994) tra inconscio passato e inconscio presente: i due autori hanno messo l'accento sull'impossibilità di accedere all'inconscio passato originario, per cui l'ana lista deve affrontare solamente quello presente manifestato nel transfert. L'idea fondamentale dei Sandler, secondo la mia interpretazione, è la se guente: l'inconscio passato non può essere teorizzato come un serbatoio dei desideri pulsionali rimossi, bensì come il mondo complesso e organizzato del bambino piccolo. È il bambino piccolo che forma il modello ideale dei processi psicodinamici dell’adulto, nell'ambito dell’inconscio presente; ma ciò che è cruciale è l'impossibilità strutturale dell'adulto e dell'analista di accedere al bambino psichicamente organizzato dell'inconscio passato. Co sì, i Sandler affermano: Un desiderio inconscio che sorge nelle profondità dell 'inconscio presente può dirsi modellato sui desideri del bambino interiore, a differenza degli og getti coinvolti, che sono invece oggetti del presente. Pertanto, per fare un esempio semplicissimo, se, nel corso dell'analisi, nell 'inconscio presente del pa ziente sorge un desiderio ostile inconscio nei confronti dell’analista, non si tratterebbe, alla luce della tesi qui avanzata, di un desiderio ostile verso il pa dre spostato sull’analista, ma piuttosto di un impulso ostile che compare nella vita attuale della persona verso l’analista e che probabilmente si modella sulla relazione del bambino interiore col padre. In altre parole, il desiderio di tran sfert conscio o inconscio... non è un trasferimento dal genitore all’analista, bensì un tentativo di interazione con l’analista stesso... che funziona nel pre sente sulla base di regole fissate nei primi anni di vita del paziente (Sandler e Sandler, 1994, p. 176). Sembra dunque che, secondo questo modello, tutto ciò che rimane ac cessibile dei primi anni di vita sia il ‘modello ideale’ su cui si basa l'incon-
V abbandono dei ricordi, del trauma e della sessualità 77 sCio presente: una serie di regole procedurali, e non le vere esperienze o gli autentici desideri infantili.3 Non c'è alcuna traslazione diretta del passato in fantile al presente. Anzi, il passato infantile è strutturalmente inaccessibile. Similmente la regressione a un atteggiamento infantile appare struttural mente impossibile. Così come è difficile concepire che specifici eventi trau matici dell’infanzia, in quanto opposti alle regole procedurali generalizzate che il bambino ha derivato dalle ripetute esperienze con le persone che si occupavano di lui, possano infrangere la barriera strutturale dell'inconscio presente. Questo tipo di teoria, pertanto, non si attaglia facilmente ai reso conti psicoanalitici in cui uno specifico trauma precoce sembra essere rivis suto nel transfert. Ne è un esempio il resoconto di Casement (1985) del l’analisi di una paziente, la quale in età pre-verbale si era ustionata con l’ac qua bollente: l’autore descrive un punto dell’analisi in cui la donna fu colta da un’angoscia estrema, perché l’analista continuava a parlarle, benché ella avesse sollevato la mano per interromperlo; successivamente la paziente spiegò che in quel momento l’analista era diventato come un chirurgo, che aveva continuato a inciderle la cute sotto anestesia locale, incurante della sofferenza di lei. Un’esperienza specifica di questo genere non può essere rappresentata come facente parte di un modello ideale generalizzato, come sostengono i Sandler nella loro interpretazione dell’inconscio presente. Una variante recente della posizione dei Sandler è quella di Fonagy (1999), il quale ha dichiarato che il ricordo è 'terapeuticamente inerte’ e che il cambiamento terapeutico deriva dall’esperienza del 'sé con l’altro’ vissuta nel transfert ‘qui e ora’. Tale posizione è stata fortemente criticata da Blum (2003) e risulta ovviamente incongruente con l’osservazione, fatta in e m d r e in altre terapie, che gli stati del disturbo post-traumatico da stress richie dono l’elaborazione del ricordo traumatico. Dunque il gruppo kleiniano e alcuni dei freudiani contemporanei hanno, di fatto, costituito un movimen to tenaglia, per precludere la legittimità a qualsiasi lavoro analitico diverso dall’interpretazione del transfert 'qui e ora’. Il gruppo indipendente non è riuscito a sostenere un’alternativa coerente. Forse tutto ciò è il risultato a lungo termine dei problemi irrisolti nelle ‘discussioni controverse’ (King e Steiner, 1991; Scarfone, 2002). Questa tendenza contemporanea prevalsa nell’ambito della Società Psi coanalitica Britannica circa l’uso della tecnica è molto diversa dall’approc cio analitico originario. Arthur Couch (2002) descrive come segue la pro pria analisi con Anna Freud: In molte sedute, quando parlavo dei ricordi d’infanzia o di episodi della mia vita presente, intercalandoli con associazioni e autoriflessioni, Anna Freud ri maneva spesso in silenzio, finché non si imbatteva in un aspetto che richiedeva il suo acume. Con questi lunghi silenzi mi faceva intuire che dava grande vaio-
78 Le terapie energetiche
re ai miei sforzi di analizzarmi senza il suo aiuto. Questo atteggiamento rispec chiava la sua fede nel processo psicoanalitico come fattore di guarigione in sé e per sé... Anna Freud era una compagna in ascolto della mia vita attuale e una conoscitrice della mia vita passata. Non esprimeva mai commenti sulle intera zioni che avvenivano tra noi ‘qui e ora’. Simili interpretazioni sarebbero sem brate alquanto estranee a un’analisi focalizzata sul compito di lavorare insieme. Se il senso delle mie comunicazioni circa la vita interna ed esterna fosse stato reinterpretato in riferimento al transfert ‘qui e ora’, ciò sarebbe parso una vio lazione dell’integrita e dell’autenticità della relazione analitica (ibid., p. 65). In un recente articolo del Journal o f the American Psychoanalytic Associa tion, Jacob Arlow rileva: Ho ripetutamente osservato che una concentrazione esclusiva sui possibili derivati del transfert distorce il modo in cui gli analisti ascoltano i loro pazien ti. Di conseguenza sul discorso della situazione psicoanalitica sembra imporsi una insensibilità artificiale... Essi non prestano ascolto al materiale, ma ascolta-: no per avere materiale, materiale transferale. A un seminario sulla tecnica ho. sentito la presentazione di un caso in cui si sorvolava su alcune dolorosissime esperienze del paziente per concentrare, invece, l’attenzione su problemi di transfert di minore importanza (Arlow, 2002, p. 1141). L’autore prosegue portando parecchi esempi che dimostrano come l’at tenzione al transfert sia in realtà difensiva da sentimenti più sconvolgenti relativi ai genitori reali. In questi casi, se l’analista è troppo focalizzato sul l’interazione 'qui e ora’, il materiale viene disgiunto dal suo contesto geneti co. Il punto cruciale è che, proprio come il volgersi alla storia evolutiva del paziente può essere una fuga difensiva dalle difficoltà del ‘qui e ora’, così la preoccupazione per l’interazione ‘qui e ora’ può servire a evitare difensivamente il dolore del passato. Un esempio piuttosto sconcertante della fuga nel ‘qui e ora’ è quello pre sentato da un paziente in terapia e m d r . Quand’era molto piccolo, aveva subito gravi ustioni e, di conseguenza, aveva dovuto trascorrere un lungo periodo in ospedale, dove aveva sofferto dolori atroci ogni volta che gli cambiavano le medicazioni. Mentre stava cominciando a elaborare alcuni di questi ricordi precoci, improvvisamente sbottò a dire che voleva squarciare la pelle della terapeuta. Questo grido divenne parte di un modulo in base al quale, ogni volta che stava per venire in contatto con quegli antichi traumi legati all’ospedale, di colpo la sua preoccupazione si spostava su fantasie ag gressive relative alla terapeuta nel ‘qui e ora’. Nell’ascoltare le presentazioni del lavoro analitico, talvolta è interessante cercare di scorgere in filigrana la teoria implicita dell’analista circa il proces-
Uabbandono dei ricordi, del trauma e della sessualità 79 so analitico. La mia impressione è che dietro alla moderna tecnica del ‘qui e ora’ ci sia l’idea che il paziente migliora allorché diventa capace di instaura re una sana relazione con l’analista (si veda più avanti la disamina che ne fa la Joseph, 1985). Paradossalmente, non siamo più di fronte alla psicoanalisi tradizionalmente intesa, bensì, come ha indicato Pearl King (comunicazio ne personale), a una sorta di psicoterapia relazionale. Il fatto cruciale è la perdita della prospettiva ‘come se’ riguardo al transfert. Coloro che usano la tecnica ‘moderna’ parlano e scrivono come se fosse la relazione reale con Fanalista, con tutti i conflitti e le ansie inconsce che comporta, a veicolare il processo analitico. È andata perduta, a mio avviso, la distinzione tra relazio ne reale e transfert: tutto viene chiamato transfert. Al contrario, nella mo dalità classica del lavoro analitico è la coesistenza della relazione reale e di quella di transfert a mettere a fuoco quest’ultima. Credere che tutto ciò che il paziente dice è riferito inconsciamente al l’analista è chiaramente un’affermazione insana. Basterà fare qualche esem pio banale: i pensieri e il discorso ael paziente possono riguardare una crisi della sua vita, un lutto, un momento significativo di una relazione o un ri cordo infantile di un evento importante. I pazienti che non stanno facendo pratica come analisti possono trovare molto strana l’eccessiva attenzione al transfert dell’analista e percepirlo, almeno a livello inconscio, come un pa ranoico o un narcisista. La relazione oggettuale non è sempre al centro delle preoccupazioni co scienti o inconsce dell’analizzando. Invece, ad avere importanza possono essere le funzioni dell’analista e del setting dell’analisi, specialmente quelle che regolano la tensione. A tali funzioni fanno riferimento il concetto di Kohut (1971) dell’oggetto-sé, il risalto dato da Balint (1968) all’analista non intrusivo e il concetto di Winnicott (1958) dell’‘essere soli in presenza del l’altro’. Se l’analista non fa altro che costringere il paziente a relazionarsi con l’oggetto, non possono svilupparsi questi transfert silenziosi dell’oggetto-sé. Il paziente non ha spazio per esplorare significati e aspetti esperienziali che non hanno direttamente a che fare col rapporto con l’analista, ma riguardano piuttosto l’esperienza del sé, le sue tensioni interne e i suoi trau mi passati. In talune varianti della moderna tecnica britannica si riscontra anche un ‘terzo escluso’, ossia la mancanza di attenzione alla storia evolutiva del pa ziente, il quale, di conseguenza, resta intrappolato nella diade con l’analista. Questi, a sua volta, rischia di incorrere in gravi deformazioni della com prensione del paziente. Infatti, concentrando esclusivamente l’attenzione sull’interazione ‘qui e ora’, può non riconoscere, per esempio, l’importanza di un abuso grave o di altri traumi subiti dal paziente durante l’infanzia. La mia personale ipotesi di lavoro riguardo al transfert, basata sia sulla psicoanalisi (per esempio Greenson, 1974) sia sulla psicologia del sé (Ko-
80 Le terapie energetiche
hut, 1971), tende a essere la seguente. Il transfert contiene due componen ti: da una parte, è un veicolo con cui andare a esplorare e a risolvere il pas sato evolutivo e i suoi traumi; dall’altra, offre l’opportunità di fare nuova esperienza relazionale e relativa all’oggetto-sé. Pertanto, ogni volta che il paziente ritenta un’iniziativa evolutiva carica di angoscia (e spesso di vergo gna), ha paura che si ripeta la risposta traumatizzante originaria e ha la spe ranza di incontrare una risposta diversa e più benevola. Questi due elemen ti del transfert sono intrecciati tra loro. Secondo me, affrontare l’uno senza l’altro non funzionerà; la mia ipotesi è che sia il continuo spostamento tra passato e presente a essere terapeutico. In altri termini, la psiche manifesta generalmente due tendenze opposte: una spinta evolutiva in avanti e la for za contraria del trauma irrisolto che cerca di riportarla indietro. In presen za di un ambiente facilitante (fornito dalla psicoanalisi o dall’EMDR), il pa ziente cerca continuamente, anche se inconsciamente, di portare il passato nel presente al fine di risolvere il trauma e il disturbo evolutivo. Finché il trauma non viene risolto, il presente tende a essere assimilato al passato, ma quando viene realizzata l’elaborazione del trauma, il paziente è libero di vi vere nel presente. Tuttavia uno degli insegnamenti dell’EMDR e della psi coenergetica è che gran parte dell’elaborazione delle informazioni emotive potrebbe non avvenire affatto nell’ambito del transfert, di modo che cerca re di convogliare tali informazioni in una presunta arena di transfert po trebbe impedirne, anziché facilitarne, la risoluzione.
D I S A M I N A D E L L ’A P P R O C C I O C O N T E M P O R A N E O ALLA T E C N I C A P S I C O A N A L I T I C A : “IL T R A N S F E R T : LA S I T U A Z I O N E T O T A L E ” ( B E T T Y J O S E P H , 1 9 8 5)
Mentre la teoria di Freud è perfettamente compatibile con i fenomeni dell’EMDR, alcune forme di psicoanalisi contemporanea risultano fonda mentalmente incongruenti con un approccio terapeutico che abbia per og getto i traumi del passato. Un esempio eclatante di come si possano misco noscere i traumi infantili del paziente è il famoso scritto di Betty Joseph sul transfert. Mi sembra importante da esaminare per due motivi: in primo luo go, si può dire che Betty Joseph è la più famosa rappresentante di quell’ap proccio tecnico che privilegia l’interazione immediata tra paziente e anali sta, a differenza della psicoanalisi classica, che si concentra su un campo più ampio; in secondo luogo, questo scritto in particolare sembra aver eser citato un’influenza piuttosto notevole ed è considerato l’emblema dell’ap proccio della Joseph. L’ho sentito citare con approvazione perfino da anali sti che non si considerano appartenenti al gruppo kleiniano. Senz’altro è in linea con la posizione 'qui e ora’ dei freudiani contemporanei difesa da Fo-
L’abbandono dei ricordi, del trauma e della sessualità 81 nagy (1999). Più in generale, illustra fino a che punto alcune versioni attua li della psicoanalisi si siano evolute e allontanate dalla teoria psicoeconomi ca e psicodinamica di Freud e come sia possibile sviluppare una sorta di psicoanalisi che sembra completamente evitare di affrontare ed elaborare gli stress, le tensioni e i traumi deirinfanzia.
La cornice del transfert e la proiezione secondo la Joseph Betty Joseph comincia così: È mia intenzione in questo capitolo discutere in che modo noi usiamo oggi il concetto di transfert nel nostro lavoro clinico. Porrò l’accento sull’idea del transfert come struttura, all’interno della quale accade sempre qualcosa, e do ve vi è sempre movimento e attività (Joseph, 1985, p. 189). L’autrice fa poi riferimento al contributo di Strachey (1934), che, dice, ha descritto ... il modo in cui la proiezione e l’introiezione influenzano e costruiscono gli oggetti interni dell’individuo, [e ha mostrato] che ciò che viene trasferito non sono essenzialmente gli oggetti esterni del passato del bambino, ma gli ogget ti interni, e che il modo in cui questi oggetti vengono costruiti ci aiuta a capi re come il processo analitico possa produrre un cambiamento (Joseph, 1985, p. 189). Dunque, la Joseph sostiene che il transfert consiste essenzialmente nel trasferimento proiettivo degli oggetti interni del paziente. In una cornice, che l’autrice ha derivato da Abraham e dalla Klein, è possibile ipotizzare che la fantasia innata, determinata dalla vita istintuale propria del bambino, sia il fattore principale che determina gli oggetti interni e che si attacca in modo secondario agli aspetti della realtà esterna. Una volta fatta questa ipo tesi, allora il vero carattere delle persone che si sono prese cura del pazien te durante la sua infanzia diventa relativamente ininfluente. Ciò riesce in parte a spiegare l’impressione, talvolta data da alcuni analisti del gruppo kleiniano, di un atteggiamento sottovalutante e diffidente nei confronti del la ricostruzione. Ma, mentre a Strachey viene spesso riconosciuto il merito di aver dato per primo risalto alla natura ‘mutativa’ delle interpretazioni transferali, rispetto a quelle extrareferenziali, il metodo analitico della Jo seph è marcatamente diverso. Decisamente Strachey non credeva che l’ana lista dovesse fare solo interpretazioni transferali.4 Diceva infatti: “Una torta non può essere fatta solo di uva passa...”. Inoltre la concezione del transfert
82 Le terapie energetiche
della Joseph si distacca profondamente sia da quella dello stesso Strachey sia da quella di Freud, come viene indicato di seguito. Per esplorare lo stile tecnico invocato dalla Joseph, esaminerò la sua de scrizione dell’annoso lavoro analitico con un paziente chiamato N. Se ne deduce il concetto di transfert dell’autrice, l’uso che ella fa del controtran sfert, l’approccio ai sogni, le ipotesi circa la natura della psicopatologia e il suo modo particolare di concentrarsi sull’interazione tra paziente e analista. La visione del transfert della Joseph Innanzitutto, la Joseph descrive un’esperienza di controtransfert, duran te la quale dice di aver notato “una sensazione vagamente di benessere, co me se mi piacessero in modo particolare le sedute con questo paziente”. Spiega che, secondo lei, ciò doveva corrispondere a ... una convinzione interna, da parte del paziente, che qualunque cosa io inter pretassi egli era comunque a posto... che egli occupava un posto molto specia le... che io, Fanalista, avessi un particolare attaccamento o amore per lui, e che, nel mio interesse, non avrei desiderato lasciarlo andare... (Joseph, 1985, pp. 193-194). La Joseph non dice molto sulla storia di N., tranne che era “il figlio più giovane, il preferito di sua madre, che aveva un rapporto molto infelice con suo padre, un uomo piuttosto crudele, sebbene i genitori fossero rimasti in sieme per tutta la vita” (ibid., p. 194). La Joseph afferma che sarebbe stato facile collegare la sensazione di N. di avere un posto speciale con la sua storia di figlio prediletto della madre. Tuttavia, ella obietta: “Ma se avessi fatto questo, di nuovo avrei contribuito alla convinzione del paziente che le interpretazioni fossero 'soltanto inter pretazioni’ e che io non ero veramente convinta di quanto dicevo” (ibid.yp. 194). Un commento del genere non è raro tra gli analisti contemporanei britannici: tra di loro si percepisce una sfiducia generale in ogni forma di dialogo col paziente che possa essere considerata ‘intellettuale’, anziché ca rica del crudo impatto dell’angoscia del ‘transfert’: a dire il vero, questo at teggiamento è così comune che possono sfuggirne le straordinarie implica zioni. La Joseph sembra dire che, se lei avesse collegato l’esperienza vissuta dal paziente nello studio dell’analista alle esperienze dell’infanzia, il pazien te stesso avrebbe pensato che il transfert non era reale, avrebbe avuto la sensazione che le interpretazioni dell’analista erano ‘solo interpretazioni’. La tesi sembra essere la seguente: il ‘transfert’ deve essere vissuto come qualcosa di reale e non ‘come se’. Questo è l’esatto contrario dell’ipotesi,
L’abbandono dei ricordi, del trauma e della sessualità 83 radicata sia nell’analisi classica sia nella posizione di Strachey, secondo cui uno dei compiti dell’indagine analitica consiste nell’individuare i desideri, le angosce e le fantasie relative all’analisi, per poi liberare, però, il paziente dalla morsa delle illusioni rivelandogli che si tratta semplicemente di tran sfert basato sull’esperienza infantile. Sia dal punto di vista della psicoanalisi classica sia da quello di Strachey, il transfert non è reale, ma un illusione-, il compito dell’analisi consiste nel liberare il paziente dall’illusione del tran sfert. Dice infatti Strachey: ... se tutto va bene, l’Io del paziente diventerà cosciente del contrasto tra il ca rattere aggressivo dei suoi sentimenti e la vera natura dell’analista, il quale non si comporta come gli oggetti arcaici del paziente, che sono ‘buoni’ o ‘cattivi’. Egli, cioè, si renderà conto che esiste una distinzione tra il suo oggetto di fan tasia arcaico e l’oggetto reale esterno5 (Strachey, 1934). Questo aspetto relativo all’illusorietà del transfert mi pare che vada spes so perduto negli approcci analitici contemporanei dei circoli psicoanalitici britannici. La posizione abbracciata dalla Joseph sembra consistere nel far restare il paziente nelle fantasie infantili, aiutandolo a raggiungere una mi gliore relazione con l’analista all'interno di questa cornice di fantasia infanti le. Un tema collegato è l’assenza, comune a gran parte della tecnica moder na, di interesse per quella che nella psicoanalisi classica veniva considerata la relazione 'reale’, parallela al transfert. È come se tutta l’interazione tra pa ziente e analista fosse oggi vista in termini di 'transfert’; ma tale concetto, poiché non vi si contrappone quello della relazione reale (e dell’alleanza te rapeutica), finisce per perdere il proprio significato (di illusione) e viene vis suto come qualcosa di concreto. L ’uso dei sogni in Betty Joseph La Joseph riporta un sogno cui attribuisce molta importanza. Ella non fornisce le associazioni del paziente e quindi il suo approccio è davvero molto diverso da quello di Freud (Loden, 2003). Ecco il sogno: ... era in corso una specie di guerra. Il mio paziente partecipava a una riunione in una stanza sulla riva del mare. C’erano persone che sedevano intorno a un tavolo, quando a un tratto udirono un elicottero all’esterno e capirono dal ru more che c’era qualcosa che non andava. Il mio paziente e un maggiore lascia vano il tavolo dove aveva luogo la riunione e andavano alla finestra per guar dare fuori. L’elicottero era nei guai e il pilota si era lanciato col paracadute. C’erano due aerei, che sembrava fossero lì per vigilare sull’elicottero, ma erano
84 Le terapie energetiche talmente alti da sembrare piccolissimi e non in grado di recare alcun aiuto. Il pilota cadeva nell’acqua, il mio paziente si chiedeva se avrebbe fatto in tempo a gonfiare la tuta, se fosse già morto e così via (Joseph, 1985, pp. 194-195). Afferma poi la Joseph: ... gli mostrai che potevamo vedere la guerra che infuria costantemente tra lui e me, evidenziata dal modo in cui, nel sogno, egli tende a voltare le spalle alla riunione che si svolge intorno al tavolo, al lavoro che si svolge qui di seduta in seduta. Ella interpreta i due aeroplani come Panalista dotata di due braccia e due mammelle che guarda dall'alto il paziente senza poterlo aiutare, perché lui è travolto dal fascino del proprio masochismo e lo preferisce all’aiuto offer togli da lei: “Ciò che qui intendo dire è che egli mostra la sua preferenza per lasciarsi assorbire da situazioni di crollo doloroso piuttosto che volger si in direzione e godere dell’aiuto e del progresso” (ibid., p. 195). Il giorno dopo, il paziente dice di essersi sentito turbato a seguito del la voro sul sogno. Dopo aver parlato dei vari aspetti della seduta, rileva che “qualunque cosa avesse luogo in analisi sembrava che in qualche modo egli si lasciasse intrappolare da questo rifiuto e da questa lotta” (ibid., p. 195). Egli parla un po’ di più degli eventi del giorno, ma la Joseph gli fa notare che ogni cosa che dice è come se “venisse usata contro il progresso della se duta, come se si stesse conducendo contro di me un tipo di guerra partico lare e silenzioso” (ibid., p. 195). Il paziente, con voce funerea, replica che nessuna parte di lui desidera lavorare e collaborare. La Joseph dichiara al lora che la situazione tra loro riflette il modo in cui ora il sogno viene vissu to concretamente nel transfert. A questo punto commenterò ciò che la Joseph ha raccontato. Prima di tutto, ella interpreta il sogno interamente nei termini dell’interazione pa ziente-analista, prendendo il contenuto manifesto per una rappresentazio ne allegorica del transfert. Il lettore che non sia già persuaso della corret tezza della posizione tecnica dell’autrice, si renderà facilmente conto che, sebbene possa avere qualche validità, essa è piuttosto arbitraria. Come fa notare Loden (2003), secondo la concezione psicoanalitica originaria, il si gnificato inconscio di un sogno tende a essere estremamente nascosto e non immediatamente distinguibile dal contenuto manifesto. Tuttavia, an che se seguiamo il moderno presupposto secondo cui il sogno può avere significati allegorici, emergono altre ovvie possibilità. Il sogno di N., per esempio, potrebbe riferirsi in parte alle esperienze infantili del paziente: l’ostilità tra i genitori, il sé vulnerabile del bambino che, pur trovandosi in una posizione precaria, non può essere salvato da genitori che sono trop-
Uabbandono dei ricordi\ del trauma e della sessualità 85 po in alto, ossia troppo occupati con la loro guerra. Forse il bambino vor rebbe entrare in contatto con una figura paterna, il maggiore. È possibile che questa allarmante situazione infantile venga rivissuta nel transfert, dando origine a una fantasia in cui Fanalista-madre è tutta presa dal biso gno di essere necessaria al paziente e di non farlo andar via con il maggio re-padre, mentre la difficoltà reale del bambino viene ignorata, perché i genitori sono troppo intenti alla loro guerra. E la comunicazione del pa ziente, che dice di essere rimasto turbato dalla seduta, non potrebbe forse indicare che Fanalista sta seguendo la pista sbagliata? Ma la Joseph la prende come un'ulteriore conferma della propria costruzione e interpreta le osservazioni del paziente a proposito di altri eventi come una 'guerra si lenziosa' contro di lei. Non ci si dovrebbe sorprendere se la voce del pa ziente suona 'funerea'. Quando egli afferma di non trovare in sé alcuna parte desiderosa di lavorare, dovremmo chiederci se questo non rifletta un senso di impotenza circa Yimpasse della terapia. L'osservazione del pa ziente potrebbe essere una frase di compiacenza, come per dimostrare che ha imparato la teoria della Joseph. Quindi potrebbe darsi che il sogno non si riferisca affatto all'interazione tra analista e paziente, ma sia il commen to inconscio di quest'ultimo, che vive lo stile 'qui e ora’ come una distur bante ripetizione dei problemi infantili legati alla madre possessiva e alFostilità tra i genitori. La risposta della Joseph a un ricordo infantile La Joseph continua a raccontarci lo svolgimento della seduta dopo l'in terpretazione del sogno. Dice che il paziente ebbe un improvviso ricordo legato al collegio dove aveva vissuto da piccolo con grande infelicità: teneva nascosto un pacchetto di sigarette e talvolta se ne andava da solo in campa gna a fumare; era così che aveva iniziato, anche se non gli sembrava di trar re alcun vero piacere dalle sigarette. La Joseph spiega al paziente che que sto ricordo ha a che fare con le parole da lui pronunciate per intrappolarla, ossia con la constatazione che nessuna parte di lui vuole collaborare, e con la sua assuefazione all’eccitamento della guerra con lei; ma gli dice anche che lui non vuole prendere atto del proprio miglioramento (la riduzione dell’assuefazione) in quanto ciò significherebbe smettere di provare il pia cere di sconfiggerla; non è ancora pronto a usare con gioia le mani che vor rebbero aiutarlo, simbolizzate dagli aeroplani del sogno. Il paziente “fu ten denzialmente d’accordo su questo” (Joseph, 1985, p. 197), ma poi suggerì che forse provava risentimento e tristezza perché Fanalista si era allontana ta troppo rapidamente dal ricordo del pacchetto di sigarette, per lui così vi vido e importante. La Joseph riferisce di essere tornata “al ricordo del pac-
86 Le terapie energetiche
chetto di sigarette e [di aver preso] in considerazione la sua sensazione che io avessi mancato di afferrare qualcosa dell’importanza di questo episodio” (ibid.). Tuttavia gli ripete che la comparsa del ricordo ha a che fare con l’ec citamento e il piacere di sconfiggere l’analista e che lui è risentito perché i suoi sentimenti sono cambiati a seguito del lavoro dell’analista. N. è d’ac cordo con quest’ultima interpretazione, ma le ripete che si è allontanata troppo velocemente dal ricordo. Spiega che è come se l’analista fosse di ventata una sorta di Pifferaio Magico da cui si è lasciato a poco a poco se durre. Dichiara allora la Joseph: “Dissi che ciò dava l’impressione che egli sentisse che in realtà io non avevo analizzato il suo problema riguardo al l’essere bloccato, ma lo avevo tirato fuori dalla sua posizione con la sedu zione” (ibid., pp. 197-198). Osservate a questo punto come la Joseph dia per scontato che il pazien te sente che lei lo ha sedotto per tirarlo fuori da un particolare problema, quello di essere bloccato. Ma non è questo che il paziente aveva detto. Egli aveva detto che l’analista si era allontanata troppo velocemente dal suo im portante ricordo dell’infelicità e della solitudine infantili, dalle quali si con solava col fumo. Era l’analista a essere preoccupata che il paziente fosse 'bloccato’. È possibile che lo stato di blocco fosse un risultato iatrogeno dell’ostinata concentrazione interpretativa su un aspetto della loro intera zione. A questo punto il paziente aggiunge che teme di venire catturato da caldi sentimenti di eccitazione. La Joseph risponde che si tratta in entrambi i casi di antiche angosce che al momento egli sta usando “perché lui potes se proiettarle dentro di me, in modo da non dover contenere, vivere ed esprimere i suoi veri sentimenti buoni, e in particolare il calore e la gratitu dine” (ibid., p. 198), sentimenti che collega agli aeroplani del sogno, inter pretati come l’aiuto offerto. Processi proiettivi che deformano la storia del paziente
Il solito lettore non ancora persuaso della correttezza della posizione della Joseph troverà un po’ sorprendente che ella definisca tutto ciò mate riale “piuttosto chiaro” (Joseph, 1985, p. 198). L’autrice riferisce che il so gno fu ri-vissuto nella seduta successiva “all’interno della quale possiamo vedere come il paziente preferisca coinvolgersi in modo specifico e volon tario nell’infelicità e nei problemi anziché incontrarsi con i suoi oggetti vi tali, che gli recano aiuto, gli aerei, che vengono minimizzati, sono picco1i”(ibid., p. 198). Non solo, ma afferma anche che la “stessa capacità” del paziente “di muoversi con calore verso un oggetto è rapidamente distorta e proiettata dentro di me: sono io che lo tiro fuori e lo seduco” (ibid., pp. 198-199). Così, la comunicazione del paziente circa l’attività di Pifferaio
Uabbandono dei ricordi, del trauma e della sessualità 87 Magico svolta dairanalista nel condurlo lontano dalla propria storia viene interpretata come proiezione di sentimenti affettuosi appartenenti al pa ziente stesso. Poco oltre, la Joseph afferma: “Possiamo avere un’indicazio ne di un modo in cui, proiettando nella madre il suo amore e distorcendo lo, egli ha contribuito a consolidare il quadro di lei come così seduttiva...” (ibid.). Ella poi riconosce l’esperienza precoce reale del paziente, ma la li quida: “può benissimo darsi che la madre sia stata una donna seduttiva nei confronti del figlio maschio più piccolo, ma possiamo vedere come questo sia stato usato da lui” (ibid.). L'assenza del concetto di conflitto psicodinamico Un analista radicato nella tradizione classica considererà la psicopatolo gia (formazione di sintomo) come il tentativo inconscio di evitare Vango scia associata ai bisogni, ai desideri e alle emozioni infantili e considererà la terapia come un processo in cui il paziente scopre, mediante il transfert, che i desideri e le angosce dell’infanzia non sono più adeguati al presente. È stupefacente constatare, invece, che la Joseph non sembra concentrare l’attenzione sull’angoscia. Per esempio, collega il sogno con la preferenza di N. “per lasciarsi assorbire da situazioni di crollo doloroso piuttosto che volgersi in direzione e godere dell’aiuto e del progresso” (Joseph, 1985, p. 195). Che tipo di ipotesi psicodinamica è questa? Dov’è il conflitto, che implica un desiderio o un bisogno, un’angoscia e un compromesso nevro tico? Al posto del conflitto psicodinamico, la Joseph fa riferimento alla ‘preferenza’ del paziente. Sintetizzando il suo lavoro con N., ella dichiara: “Il paziente raggiunge la consapevolezza, ritengo, di ciò che è quasi una scelta tra il muoversi in direzione di un oggetto che gli reca aiuto o il la sciarsi andare alla disperazione - le sue difese sono mobilitate ed egli pren de quest’ultima strada...” (ibid., p. 199). Nonostante usi spesso il linguag gio del conflitto psicodinamico parlando di ‘difese’, la Joseph non dice mai contro quale angoscia agiscano queste difese. Quando il paziente stesso fa riferimento alle proprie angosce, ora coscienti, spiegando che hanno a che fare con le caratteristiche da Pifferaio Magico dell’analista, e dice di essere preoccupato per i propri sentimenti di calda eccitazione, la Joseph sembra liquidarle: “io ritenevo che in quel momento venissero usate perché lui po tesse proiettarle dentro di me, in modo da non dover contenere, vivere ed esprimere i suoi veri sentimenti buoni, e in particolare il calore e la gratitu dine...” (ibid., p. 198). Sembra dunque che la Joseph consideri proprio compito mostrare al paziente che preferisce relazionarsi emotivamente con lei secondo modalità distruttive per farlo smettere e sviluppare una moda lità più sana.
88 Le terapie energetiche Modi differenti di concepire la ricostruzione della storia evolutiva La maggior parte degli esempi della Joseph riguarda l’interazione 'qui e ora' ed ella evita esplicitamente di considerare la storia e i ricordi di N. in dizi di qualcosa che si ripete nel presente. Laddove cita i suoi ricordi infan tili, tende a scartare la possibilità che siano connessi a un’esperienza reale derivata dall’esterno. Afferma, per esempio, che il paziente percepisce la madre come una persona seduttiva perché proietta su di lei “il suo amore e distorcendolo” (Joseph, 1985, p. 199). Così, anche se considera il tran sfert... “ricco di significato e di storia” {ibid.) ed “essenzialmente basato sul passato del paziente e sul suo rapporto con gli oggetti interni e sulle sue convinzioni riguardo a essi e a ciò che gli sembravano essere” (ib id \ i reso conti clinici della Joseph non riflettono una comprensione del presente ne vrotico sulla base delle immagini, delle credenze, dei desideri e delle ango sce del passato infantile. Dal momento che il paziente viene visto come co lui che ha creato l’esperienza originaria attraverso le fantasie proiettive (e, nel caso di N., attraverso il rifiuto del seno materno, al quale ha preferito gli eccitamenti masochistici), è presumibile che non ci sia motivo di cercare chiarimenti nei ricordi e nelle ricostruzioni della storia e delle esperienze con chi ha realmente accudito il paziente durante l’infanzia; non c’è nulla da scoprire. Il dramma del mondo interiore del paziente si svolge tutto nel presente, nell’interazione con l’analista, ed è lì che deve essere affrontato. Dunque, se il paziente riesce a instaurare una corretta relazione con l’anali sta (venendone adeguatamente nutrito e rispondendo con pari gratitudine), allora la psicopatologia si risolve, ma questa non è la concezione classica della psicoanalisi. Come deve fare il paziente per cambiare il suo modulo interattivo? Poiché la Joseph non vede nelle difficoltà del paziente un’au tentica psicodinamica, non può esserci alcuna liberazione della libido o di altra energia attraverso l’interpretazione del conflitto inconscio, di modo che presumibilmente il cambiamento deve avvenire essenzialmente facendo convertire il paziente al punto di vista dell’analista e facendogli prendere at to della patologia dei suoi modi. Sembra appunto che per la Joseph l’inter pretazione non serva a liberare l’energia bloccata o i sentimenti e gli impul si rimossi, bensì a spingere il paziente a pensarla diversamente circa il pro prio modo di relazionarsi nell’interazione presente.6 Confronto con lanalisi classica L’ostinata ricerca dell’interazione, caratteristica del moderno approccio britannico, sembra lontana mille miglia dallo stile più rilassato dell’analista classico (Couch, 2002), il quale permetteva che, accanto alla relazione reale,
V abbandono dei ricordi, del trauma e della sessualità 89 si sviluppasse il transfert e interpretava le percezioni deformate del presente da parte del paziente come il risultato di intrusioni nel transfert stesso di immagini, desideri e angosce infantili. Dal momento che il transfert veniva considerato un fenomeno 'come se’, un’illusione e non la realtà, l’analista classico dava meno importanza al proprio ruolo, che consisteva in una ripe tuta giustapposizione della realtà alla parte svolta nel teatro del transfert. Secondo Freud, il transfert andava usato come veicolo per esplorare e risol vere i traumi e i conflitti sessuali del passato infantile, tendenza che la Jo seph e molti altri analisti contemporanei sembrano aver abbandonato. IL P U N T O DI VISTA D EL L ’EMDR E DELLA PS ICO ENERGETICA SUL TRANSFERT
Rispetto a questi cambiamenti, per cui dalla concezione freudiana classi ca circa l’interpretazione e la tecnica del transfert si è passati a un eccessivo risalto al ‘qui e ora’, qual è il valore dell’EMDR? In primo luogo, esso dimo stra che l’elaborazione del trauma, dell’esperienza dolorosa o dell’angoscia originari è cruciale per la risoluzione della disfunzione psicologica. Concen trarsi sull’esperienza e sul comportamento presenti tende inevitabilmente a distogliere l’attenzione dal trauma originario.7 La sola elaborazione dei de rivati secondari, indiretti, del trauma o dell’angoscia è destinata a rivelarsi un mezzo inefficace per risolvere il problema soggiacente. In primo luogo, non tutti gli aspetti dell’esperienza traumatica originaria (o di altro tipo di esperienza deformante) si possono facilmente esprimere o rappresentare nella relazione con il terapeuta: non sempre le caratteristiche dell’analista e del setting offrono un aggancio al trasferimento dell’esperienza traumatica passata. In secondo luogo, anche quando alcuni aspetti di essa vengono tra sferiti nel presente, affrontarli solamente nel ‘qui e ora’, senza collegarli all’esperienza originaria, è come curare delle metastasi senza aggredire II tu more principale. Per fare un’altra analogia, è come se un bambino, vittima di abuso grave, venisse dato in adozione a una famiglia e questa, di fronte alle sue manifestazioni di ansia mescolata a comportamento provocatorio, anziché mettersi in ascolto delle passate esperienze traumatiche, ponesse l’accento sulla necessità di modificare il suo comportamento nel nuovo set ting. In una situazione del genere, il bambino imparerebbe che qui non si ripeterà l’abuso, ma l’esperienza traumatica originaria resterebbe irrisolta e gli elementi che gli ricordano il trauma continuerebbero a suscitargli ango scia e risposte di evitamento. Viceversa, il paradigma dell’EMDR ha lo sco po di risalire dalle manifestazioni attuali della disfunzione alle esperienze precoci che hanno contribuito a formarla, per elaborarle, risolverle e quin di modificare il comportamento e le reazioni emotive del presente. Da que-
90 Le terapie energetiche
sto punto di vista, il transfert che si manifesta nel presente è solo un indizici che allude alle esperienze del passato, le quali devono essere affrontate. L’aspetto vantaggioso della psicoenergetica suscita un’altra analogia ché illustra come un’eccessiva concentrazione sul transfert può essere relativa^ mente inutile. Sotto certi aspetti, il transfert è una sorta di dramma inconi scio, rappresentato nel teatro dello studio dell’analista e della relazione te^ rapeutica. Intuire questo e renderlo cosciente può certamente contribuire 4 liberare il paziente dalle illusioni del transfert che deformano la sua perce-jj zione del presente, ma può anche consentire il reinserimento nel tessuto! della personalità di aspetti dello sviluppo precocemente interrotti. Tuttavia! un processo del genere può essere paragonato al costringere due attori in? un modello ideale basilare privo di risoluzione, dando loro il permesso di discutere e improvvisare, nella speranza che alla fine sviluppino un risultato^ soddisfacente e riescano perfino a portare a termine la commedia. Una riso4 luzione più diretta e più rapida consisterebbe nel modificare il copione stes so, ossia le informazioni modellate nel sistema energetico (con le loro rica-1 dute nei vari livelli inferiori: neurobiologico, esperienziale, psicologico e comportamentale) in modo da rendere inutile l’elaborazione completa del dramma. CONCLUSIONE
La moderna tecnica psicoanalitica britannica si è molto allontanata dal l’approccio classico, ponendo l’accento sull’interazione ‘qui e ora’ tra anali sta e paziente. In alcune varianti di questa posizione, l’abbandono di carat teristiche essenziali, come l’interpretazione del conflitto psicodinamico, la ricostruzione della storia evolutiva e l’esplorazione del contenuto latente dei sogni, e il passaggio a una visione del transfert come fenomeno reale e non illusorio rischiano di renderne quasi irriconoscibile l’appartenenza alla psicoanalisi classica. Sembra improbabile che questo approccio, che consi ste nel lavorare interamente sulla relazione presente, risulti una forma di te rapia efficace o efficiente, dal momento che non contiene alcun mezzo di elaborazione del trauma e di altre esperienze danneggianti. Mentre i pre supposti e le osservazioni della psicoanalisi di Freud risultano congruenti con i fenomeni scoperti nella pratica dell’EMDR e della psicoenergetica, non si può dire altrettanto di quelli della maggior parte della psicoanalisi contemporanea.8
5 L'angoscia di disintegrazione: resistenza profonda al cambiamento psicologico
L’angoscia di disintegrazione è un fenomeno nascosto, oscuro e non fa cilmente compreso. Può costituire una formidabile resistenza alla riuscita dell’elaborazione con Pe m d r , o, per meglio dire, di qualsiasi forma di tera pia psicologica. Con estrema probabilità la si riscontrerà in quegli individui che in età precoce non sono stati sufficientemente sostenuti dall’ambiente in cui vivevano. Tra i segni dell’angoscia di disintegrazione si possono tro vare varie forme di rigidità di pensiero e di atteggiamento, tensione musco lare, paura di ‘lasciarsi andare’, allusioni al caos nei sogni e nelle associazio ni libere, crollo e decadimento della struttura. Quando si pratica I’e m d r o I’e f t , la persona può non riuscire a manifestare l’elaborazione normalmen te attesa che conduce al rilassamento. Ciò può costituire una componente significativa di quello che in psicoenergetica viene chiamato ‘rovesciamento psicologico’. Dato che I’e m d r e i metodi correlati sono in grado di deter minare un rapido cambiamento, l’angoscia di disintegrazione può essere più forte e più chiaramente di ostacolo durante queste forme di lavoro. Per comprendere l’angoscia di disintegrazione è necessario esaminare le intuizioni derivanti dalla teoria e dalla tecnica psicoanalitiche tradizionali, attingendo in particolare all’opera di Kohut e a quella di Lacan. Per alcuni anni sono rimasto perplesso di fronte a due fenomeni comuni e correlati fra loro. Il primo è che assai spesso le persone sembrano aver installato, all’in terno della propria psiche, strutture mentali estranee e oppressive, basate in parte sulle caratteristiche di figure di riferimento ostili dell’infanzia, che di fendono vigorosamente come se fossero proprie. Il secondo fenomeno è la tendenza frequente ad aggrapparsi rigidamente a credenze e opinioni fon damentali, anche quando siano disadattive e generino dolore. Un mio pa ziente, per esempio, spesso mi accusava, senza essere sfiorato dal dubbio, di non prendermi veramente cura di lui e di riceverlo solo perché mi pagava. Non molto tempo fa, ha fatto di nuovo riferimento a questa sua convinzio ne, ma ha usato le parole in modo bizzarro: “Cerco continuamente di assi-
92 Le terapie energetiche curarmi che non ti occupi di me”. Se il significato che aveva voluto comuni care a livello cosciente era quello ben noto, il suo linguaggio, come ha am messo, era ambiguo e forse sembrava dire che il suo intento era rassicurarsi che io non mi occupavo di lui. È rimasto colpito nel constatare che, se aves se avuto la prova che io mi occupavo di lui, ciò lo avrebbe allarmato molto, perché avrebbe minacciato una delle sue convinzioni basilari, ossia che le persone non si interessano davvero le une delle altre. Le convinzioni cen trali sono sempre riconoscibili perché i pazienti vi si aggrappano con parti colare veemenza e rimangono relativamente impermeabili alla modifica, no nostante l’evidenza. Analogamente, le percezioni transferali centrali posso no restare immutate anche quando se ne dimostra l’incompatibilità con l’immagine del transfert. Quando un mio paziente mi disse di essere allar mato all’idea che una sua convinzione fondamentale venisse messa in di scussione, mi ricordai di un’altra paziente, schizofrenica, la quale aveva os servato che non poteva concepire l’idea di farla finita con le sue voci perse cutorie interne, in quanto esse costituivano lo ‘scheletro’ che teneva insieme la sua psiche. La conservazione delle strutture psichiche sembra essere un bisogno umano impellente. Il paradigma fondamentale esposto di seguito descrive le origini e la fun zione di questa profonda resistenza. Da un substrato del sé frammentato, la spinta a formare un’organizzazione è decisamente imperiosa. In assenza di un’organizzazione delUoggetto-sé’1 (Kohut, 1971) intorno alle funzioni di accudimento della madre, basate sull’empatia e sul rispetto dei bisogni evo lutivi del bambino, questi formerà un’organizzazione oppressiva e strutture interne altrettanto oppressive servendosi di qualsiasi materiale psicologico gli capiti a disposizione. Il compito della terapia psicoanalitica, eventual mente integrata dall’EMDR, consiste nel favorire la liberazione del paziente da simili strutture in modo tale che possa emergere il suo sé autentico e an cora sconosciuto. L ’I N V I S I B I L E M I N A C C I A D E L L A F R A M M E N T A Z I O N E
Una delle caratteristiche inconsuete degli scritti di Kohut è l’importanza attribuita ai disturbi della struttura e dell’eccitamento, accanto al più comu ne interesse psicoanalitico per il contenuto (di fantasie, desideri, eccetera). Il contenuto manifesto, anche quando è inconscio per il paziente, ma intel ligibile per l’analista, è determinato dal crollo, nascosto o invisibile, della struttura, di quella struttura del sé che viene tenuta insieme dalle funzioni dell’oggetto-sé fornite da chi si prende cura del bambino (e in seguito dal coniuge, dagli amici, dalla cultura, eccetera). Gli impulsi e le fantasie incon sci, che tipicamente e storicamente hanno costituito il fulcro del lavoro psi-
L'angoscia di disintegrazione 93 coanalitico, per Kohut non sono altro che i frammenti della disintegrazione e le difese da essa. Pertanto, egli giunge a considerare impulsi e conflitti in consci essi stessi delle difese da un più profondo e inesprimibile terrore, quello della disintegrazione: "... quando si cerca di descrivere l'angoscia di disintegrazione, si cerca di descrivere rindescrivibile...” (1984, p. 36). Nel saggio sulla rabbia narcisistica (1972), Kohut tratteggia certi tipi di pazienti nel modo seguente: Questi pazienti danno inizialmente l’impressione di una nevrosi classica. Tuttavia, quando ci si avvicina alla loro psicopatologia con le interpretazioni, il risultato immediato è quasi catastrofico: essi rispondono con violenti acting out, sommergono l’analista di richieste d’amore edipico, minacciano il suicidio - in breve, benché il contenuto (dei sintomi, delle fantasie e del transfert mani festo) riguardi esplicitamente la triangolazione edipica, l’espressione aperta dei loro desideri infantili, la mancanza di resistenze al loro essere scoperti non si accordano minimamente con l’impressione iniziale... (Kohut, 1972, p. 148). Dunque Kohut illustra come, in alcuni casi, il materiale analitico manife sto copra qualcosa di assai meno visibile e ne venga determinato. Tale ‘fat tore determinante' è un'assenza, un vuoto in cui dovrebbe trovarsi il nucleo del sé. È forse analogo a un buco nero astronomico, invisibile e distinguibi le soltanto attraverso i suoi effetti secondari. E continua: La psicopatologia nucleare di questi individui riguarda il sé. Essendo mi nacciati nel mantenimento di un sé coesivo a causa della mancanza nelle fasi precoci della vita di adeguate risposte di conferma (‘speculari’) da parte del l’ambiente, essi hanno fatto ricorso all’autostimolazione per conservare la precaria coesione del loro sé percettivo e agente. La fase edipica, con i suoi conflitti e le sue angosce, è diventata, paradossalmente, un fattore stimolante terapeutico, poiché la sua stessa intensità viene usata dalla psiche per con trapporsi alla tendenza del sé verso la frammentazione - esattamente come il bambino piccolo può tentare di usare un dolore autoinflitto (battere la testa, per esempio) al fine di mantenere un senso di vitalità e di coesione (ibid., pp. 148-149). Kohut ipotizza che lo stesso conflitto psicodinamico venga usato come difesa da un pericolo più profondo: la disintegrazione del sé. Egli fa riferi mento alla coesione del sé sperimentante e agente come a una coesione ‘precaria'. In tal modo, il pericolo fondamentale è la frammentazione. Ko hut non aveva molto da dire circa gli stati di frammentazione in sé e per sé, in quanto sembrava considerarli come elementi tipici della psicosi ed essen zialmente al di là delle possibilità dell’analisi. Era più interessato alla minac-
94 Le terapie energetiche
cia di frammentazione e alle difese da essa. Per continuare l'analogia astro fisica, è come se Kohut abbia cominciato a guardare oltre i domini reali e manifesti (benché inconsci) della psiche trovando le aree della materia oscura e dei buchi neri che influiscono su ciò che si osserva. I transfert di oggetto-sé, di rispecchiamento, idealizzante e gemellare tendono a rimane re invisibili finché non vengono mandati in frantumi. È attraverso i prodot ti della loro disintegrazione che se ne distingue resistenza. L’angoscia di disintegrazione è difficile da esprimere e da comunicare, in confronto ad altre angosce più specifiche (come quelle descritte da Freud: perdita dell’oggetto, perdita dell’amore, paura del Super-Io, castrazione). Ha scritto Kohut (1977): ... l’espressione di un’angoscia maldefinita ma intensa e pervasiva che accom pagna l’affiorare nel paziente della consapevolezza che il suo sé si va disinte grando (frammentazione grave, seria mancanza di iniziativa, profonda caduta dell’autostima, senso di profonda mancanza di significato), può anch’essa ini zialmente essere velata; l’analizzando può tentare di esprimere la sua consape volezza delle temibili alterazioni nello stato del proprio sé attraverso il tramite di verbalizzazioni che concernono paure circoscritte (ed è solo gradualmente e superando resistenze che le sue associazioni cominceranno a comunicare il contenuto centrale della sua angoscia, che egli in effetti può descrivere solo con l’aiuto di analogie e di metafore) (Kohut, 1977, pp. 102-103). Una mia paziente, che, dopo circa dodici anni di terapia, oggi sta affron tando la conclusione dell’analisi dovuta alla necessità di trasferirsi in un al tro paese, ha osservato: “L’unica cosa che si pone tra me e la disintegrazio ne sei tu”. In un suo sogno, la casa in cui doveva andare ad abitare insieme al marito veniva crivellata dai tarli e rischiava di crollare al suolo. Il proble ma della paziente è che, se comunica con me, sa rappresentare la frammen tazione con parole e simboli, ma, quando è sola, non ha alcun mezzo per esprimerla; la frammentazione allora si trasforma in un terrore schiacciante e senza nome, e la donna cade in uno stato che non le consente di pensare o usare le parole, ma le fa semplicemente vivere un’agonia psichica che va ol tre la comunicazione. In un simile stato mentale, il senso di solitudine e di desolazione è completo. La sua infanzia è stata caratterizzata da isolamento, rifiuto, freddezza emotiva e abuso sessuale, innestatisi forse su un tempera mento di tipo a d HD {Attention Deficit Hyperactivity Disturb, Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività) che ha incentivato la tendenza alla fram mentazione. Un’altra caratteristica di questa paziente è che a una conoscen za superficiale può apparire piuttosto normale: intelligente, colta, educata; ma si tratta di una vernice della personalità, che ricopre un nucleo di fram mentazione e di agonia psichica.
L’angoscia dì disintegrazione 95 D I F F E R E N T I F U N Z I O N I D E L L ’O G G E T T O - S É NELLA VITA ADULTA
Nel pensiero di Kohut, le funzioni dell'oggetto-sé forniscono un baluar do contro la frammentazione. Il bambino piccolo organizza se stesso attor no agli oggetti-sé. Questa organizzazione garantisce ordine, regolazione degli affetti (Schore, 1994) e significato emotivo, o, per usare un altro linguag gio, facilita la ‘mentalizzazione’ (Fonagy, Gergely, Jurist e Target, 2002). Se gli oggetti-sé originari sono le funzioni organizzatrici fornite dalle persone che si prendono cura del bambino, la mia ipotesi è che, nelle fasi successive della vita, tendiamo a formare organizzazioni con un'ampia varietà di og getti-sé: linguistici, culturali, basati sulle immagini e comportamentali. Que sti possono includere sistemi di conoscenza e di credenza (sistemi politici, scientifici o religiosi, compresa la psicoanalisi), appartenenze tribali (com prese quelle professionali), routine quotidiane (i fenomeni ossessivi e auti stici della vita quotidiana), forme di dipendenza d'ogni tipo (sia comporta mentale e sessuale sia farmacologica) e qualsiasi tipo di ricerca compulsiva della stimolazione. In tutti questi modi possiamo tentare di organizzare i nostri stati psichici interni collegandoli alle fonti esterne di stimolazione, consolazione e ordine. Il problema degli esseri umani, come ha rilevato La can, è che nasciamo prematuri (per adattarci a un cervello grande) e non siamo capaci di coordinare i movimenti e mantenere l'omeostasi corporea senza il continuo intervento materno. Dunque la nostra vita comincia in uno stato di frammentazione e abbiamo bisogno di una fonte esterna di or ganizzazione. Per quanto sicuro sia l'attaccamento che si costruisce sul sub strato di un sé frammentato, poiché tale esso è per qualsiasi neonato della specie umana, sono le cure della madre a tenere lontana la minaccia dell'annichilimento, il che, a mio parere, corrisponde a quella che i kleiniani con sideravano la manifestazione del terrificante istinto di morte e della posizio ne schizo-paranoide delle prime fasi della vita. LO S V I L U P P O D E L L A S T R U T T U R A E LA M I N A C C I A D I P E R D I T A D E L L A S T R U T T U R A
Credo che sia stato a seguito della scoperta degli stati di frammentazione che Kohut ha teorizzato le strutture del sé: il ‘sé nucleare', il ‘sé bipolare', il ‘sé coesivo' e così via. Tali termini indicano strutture (di esperienza, azione, scopi e valori) che possono restare salde o andare in frantumi a seconda che il bambino disponga o no di figure di riferimento empatiche. Il sé bipolare, che contiene le ambizioni e i valori durevoli della persona, esprime una ten sione intrinseca, che risale al passato e conduce fino al futuro. Si sviluppa at-
96 Le terapie energetiche
traverso le funzioni dell’oggetto-sé fornite dall’oggetto, ma non riguarda es senzialmente il rapporto con quest’ultimo. A Kohut interessavano problemi psichici piuttosto diversi da quelli di cui si sono occupati i kleiniani o la scuola delle relazioni oggettuali, o forse perfino le attuali scuole relazionali di psicoanalisi degli Stati Uniti. Tuttavia, i disturbi, le tensioni e le angosce relative alla struttura del sé possono rafforzare i disturbi relazionali. Una persona può aggrapparsi alle strutture o ai moduli patologici delle relazioni oggettuali, poiché il cambiamento minaccerebbe la frammentazione del sé. In tal modo, i modelli operativi interni di relazione, come pure i sistemi di credenze (sistemi religiosi e politici) possono essere tenacemente conservati perché tali strutture costituiscono l’esperienza della persona. L’emergere del sé autentico sconosciuto può suscitare terrore non meno che gioia. Talvolta la paura del cambiamento è osservabile a livello fisiologico. Mi è capitato di notarla nelle vittime di grave abuso infantile: cercando di elabo rare il trauma con I’e m d r o I’e f t , manifestavano una particolare resisten za a far scendere la propria eccitazione e la propria angoscia al di sotto di un certo livello. Una di queste persone fu colta da un grave attacco di pani co quando tentò di ascoltare un’audiocassetta rilassante, si rese conto, in realtà, che l’idea di rilassarsi la terrorizzava. Come altri pazienti, sembrava usare la propria muscolatura e l’eccitazione fisiologica come strumenti per costruirsi una corazza corporea (Reich, 1949), che teneva insieme il sé e lo proteggeva da un mondo ostile. Nel discorso di Kohut è implicito che, anche una volta instaurato un sé coesivo, la minaccia di frammentazione resta, sempre pronta a invadere il sé in caso di circostanze avverse. Secondo Kohut, chi è affetto da psicosi, sin drome borderline o stati schizoidi non è trattabile con la psicoanalisi per ché questa rischia di esacerbare il soggiacente stato di frammentazione del paziente. Senz’altro la fenomenologia di molti stati mentali gravemente di sturbati (come per esempio le voci allucinatorie e le deformazioni percetti ve) può essere in parte interpretata come espressione dei ‘prodotti di disin tegrazione’ della psiche frammentata. Come se non bastasse, Kohut ha messo in luce che l’angoscia di fram mentazione può presentarsi nei momenti cruciali di cambiamento psichico, allorché una preesistente organizzazione disadattiva dell’oggetto-sé sta per essere abbandonata. Per esempio, il signor Z. (Kohut, 1979), proprio men tre stava cominciando ad abbandonare l’arcaico legame con la madre per passare a un’organizzazione dell’oggetto-sé con la forte figura paterna (espressa nel transfert e nell’emergenza di positivi ricordi infantili relativi al padre), ebbe un certo numero di esperienze paurose quasi-psicotiche, nelle quali egli si sen tiva come disintegrare ed era assalito da intense preoccupazioni ipocondria-
L’angoscia di disintegrazione 97 che. In quei momenti sognava di paesaggi desolati, di città bruciate e, cosa profondamente sconvolgente, di ammassi di corpi umani ammonticchiati (Kohut, 1979, pp. 56-57). In uno di questi sogni vedeva la madre che, in piedi, gli dava le spalle. Ciò era accompagnato dall’“angoscia più profonda che egli avesse mai vis suto” (ibid.): così il paziente esprimeva la propria presa di coscienza che la madre si era gelidamente allontanata da lui quando egli aveva cercato di af fermare la propria indipendenza, nonché l’emergente consapevolezza che non gli aveva mai presentato un volto rispecchiante e sorridente in risposta alle sue iniziative evolutive.
PIÙ AMPIE PR O SP E T T IV E SUL SÉ - C O R P O FRAMMENTATO
Il tema del sé-corpo frammentato ricorre nelle teorie di molti analisti. Lo stesso Kohut ha attinto alla deduzione freudiana di uno stato autoerotico anteriore a quello del narcisismo e della formazione dell’Io, nonché al con cetto di Glover di ‘nuclei deH’Io’. Con parole simili a quelle usate da Winnicott, che parlava di ‘impensabili agonie’, Kohut (1984, p. 27) ha scritto delle “indicibili angosce che accompagnano... uno stato prepsicologico”. Anche Lacan ha fatto riferimento allo stadio dell’‘immagine corporea fram mentata’, anteriore all’inviluppamento nella rete delle immagini e del lin guaggio forniti dalla cultura prevalente. Queste sono le versioni lacaniane dell’oggetto-sé. Così, per Lacan, anche se l’Io, cioè il senso illusorio di un sé coerente, è radicato in questa alienante identificazione con le immagini esterne, la minaccia della frammentazione è sempre presente e dà origine a ciò che egli chiamava ‘passione narcisistica’, “la furiosa passione, che speci fica l’uomo, di imprimere nella realtà la propria immagine...” (Lacan, 1948, p. 110). Lacan ha rilevato che tutti noi dobbiamo costruire la nostra ‘iden tità’ a partire dai ruoli, dalle immagini e dal linguaggio di cui disponiamo nell’ambito della cultura di appartenenza, specialmente la microcultura del la nostra particolare famiglia di nascita. Tutti gli esseri umani sono nati in una cultura, ma le culture sono altamente variabili e plastiche. L’identità, il sé, cui gli esseri umani danno valore e che proteggono con tanta veemenza, è totalmente illusorio. Eppure è la minaccia di questa illusione che, svelan doci ed esponendoci alla frammentazione e al terrore, ci fa aderire a essa con tanta passione, come viene dimostrato dai conflitti tribali e dalle forme di fanatismo religioso succedutisi nel corso della storia. Io ritengo che il de siderio di sfuggire al terrore della disintegrazione dell’immagine illusoria susciti ovunque la tendenza umana a terrorizzare gli altri e a imporre loro un’identità. E probabile che la distribuzione e l’equilibrio del potere mon-
98 Le terapie energetiche diale dipendano in gran parte dalla capacità di imporre agli altri un’identità (si veda Mollon, 2002a). LA F R A M M E N T A Z IO N E IN D O T T A DALLE SOSTANZE STUPEFACENTI
Troviamo esempi di crollo del sé illusorio in certe reazioni al consumo eccessivo di droghe sociali come, per esempio, la marijuana. Una ragazza di diciannove anni, che dai quattordici faceva forte uso di questa sostanza, de scrisse un episodio capitatole dopo averne fumato da sola una qualità parti colarmente potente. Si era sentita totalmente schiacciata dall’orrore e dal terrore e aveva creduto di morire, ma non era affatto in grado di comunica re la natura della propria angoscia. Da allora si era spesso sentita incline al l’angoscia e al panico, nonché a sensazioni croniche di spersonalizzazione. Ho il sospetto che un simile stato mentale, fatto precipitare dalPintossicazione da marijuana, comporti un parziale disinvestimento del linguaggio: con questo termine mi riferisco al linguaggio nel senso più ampio, ossia a tutte le strutture di simbolo e del significato che sostiene l’organizzazione del nostro mondo fenomenico. Tale disinvestimento sta a significare che la rete linguistica e simbolica, che normalmente ci contiene sostenendo il no stro senso del sé e dell’identità, la nostra collocazione in una particolare matrice culturale, sociale e familiare, in un particolare momento storico, viene a crollare lasciando il soggetto arenato in uno spazio psicologico vuo to. Senza parole non possiamo entrare adeguatamente in contatto con gli altri. Senza parole, senza la lingua madre dataci nelle ninnenanne delle no stre primissime interazioni, la nostra esperienza diventa muta e inaccessibi le all’empatia. IL DILEMMA D EL L ’ARTISTA
L’identità che assumiamo partendo dai ruoli e dalle immagini messe a di sposizione dalla cultura circostante potrebbe essere vista come il nostro abi to psicologico. Senza di essa ci sentiremmo nudi, esposti e vulnerabili. Que sto l’ho capito parlando con una giovane artista, mia paziente. Ha frequen tato la scuola d’arte e ha ottenuto una votazione dignitosa. Ma la sua arte è difficile da classificare, in quanto sembra collocarsi a metà strada tra l’arte concettuale e la performance art. Non ha avuto successo commerciale. Tal volta ritiene che le piacerebbe realizzare qualcosa di molto tradizionale. Mi ha detto di come spesso provi ansia e imbarazzo nell’uscire di casa, come se fosse nuda, o in dubbio circa l’inadeguatezza del proprio abbigliamento. In
Uangoscia di disintegrazione 99 modo vago ha avvertito che questa sensazione era connessa alla sua creati vità. Mentre parlava, all’improvviso mi è venuto in mente che mi stava co municando quello che significava per lei non avere un ruolo e un’identità sociali noti o riconosciuti, che si sentiva svestita senza una categoria in cui collocare se stessa e in cui gli altri potessero collocarla. Questa idea l’affascino e continuammo a rivolgere lo sguardo al dilemma dell’artista. La spin ta creativa conduce alla sospensione della categorizzazione sociale usuale del sé, degli altri e della vita nel suo insieme, e tuttavia ciò lascia l’artista psicologicamente nudo (ossia privo di un rivestimento semiologico) e senza protezione. K O H U T E LACAN
Benché si tratti di due autori piuttosto diversi per stile e cultura, può essere molto fruttuoso combinare Kohut e Lacan. Entrambi considerano fondamentale lo stadio del sé frammentato. Mettendoli insieme possiamo arrivare alla seguente amara intuizione. Tutti gli esseri umani, nascendo, vengono a trovarsi in uno stato di disorganizzazione e di caos, la ‘discor dia primordiale’ di cui parla Lacan, poiché non sono in grado di coordi nare e regolare il proprio corpo. L’infante deve formare un sistema con la persona che si prende cura di lui, l’oggetto-sé. Grazie a un’adeguata di sponibilità dell’oggetto-sé empatico, l’essere mentale e fisiologico del neo nato viene a organizzarsi; tuttavia la minaccia di caos-frammentazione è sempre incombente. L’oggetto-sé originario di solito è la madre, ma il bi sogno di formare un sistema con un’organizzazione esterna rimane per tutta la vita. Oltre a formare sistemi dell’oggetto-sé con altre persone si gnificative, gli esseri umani creano un’organizzazione anche mediante la partecipazione e l’adesione a ogni sorta di struttura e fenomeno dotato di una configurazione: le routine comportamentali, le varie forme di dipen denza, i sistemi di credenze, le identità (familiare, tribale, razziale, cultura le o professionale) e tutte le strutture linguistiche e semilinguistiche entro le quali è possibile trovare il proprio posto nel mondo sociale. Tutto ciò che minaccia queste strutture e questi fenomeni, per esempio il confronto con sistemi di credenze concorrenziali, implica l’orrore dell’angoscia di di sintegrazione. IL F A S C I N O D E L L E S E T T E
Nel mondo ‘postmoderno’ le strutture della società cambiano rapida mente e, di conseguenza, aumentano i segni dell’angoscia di disintegrazio-
100 Le terapie energetiche
ne, facilmente riconoscibili nelle espressioni artistiche e culturali. Un altro sintomo inquietante è il crescente fascino esercitato dai fondamentalisti e dalle organizzazioni religiose estremiste, comprese le sette di ogni genere. Le sette contemporanee tendono a reclutare i loro membri tra persone emotivamente vulnerabili, alle quali offrono un’organizzazione preconfe zionata, con una serie di credenze e di codici comportamentali ben definiti, nonché un’atmosfera di gruppo che nutre e si prende cura dei bisogni di at taccamento degli adepti. Prima di aderire alla setta, può darsi che l’indivi duo si sia sentito demotivato, privo di uno scopo, di obiettivi e di valori chiari, o, in termini kohutiani, afflitto da un sé infiacchito o parzialmente frammentato; ma, dopo aver aderito alla setta, egli sperimenta tutto il senso di benessere che deriva dall’aver stabilito una nuova organizzazione dell’oggetto-sé con un oggetto idealizzato (il gruppo, le sue credenze e il suo capo carismatico). Il fenomeno della dipendenza da convinzioni e teorie organizzative note è profondamente vero e riscontrabile anche tra gli psicoanalisti, gli psicote rapeuti e gli psicologi. Tutti coloro che esercitano queste professioni spes so, a quanto mi risulta, sono intensamente fedeli ai loro principi teorici qua si al punto da non ammettere fenomeni incompatibili con esse. Tutti noi guardiamo le manifestazioni cliniche attraverso una lente concettuale/teori ca, pensando di vedere le cose nella loro realtà, mentre non è così. Dal pun to di vista intellettuale, psicoanalisti e psicoterapeuti sono spesso profonda mente conservatori, nonostante la natura radicale e rivoluzionaria della psi coanalisi delle origini. Mentre Freud ha forgiato una via autenticamente nuova, indipendente e solitaria, quasi tutti i suoi successori sono stati, in certa misura, dei proseliti e ciascun innovatore ha avuto la tendenza a pro durre adepti sottomessi. Quali sono le ragioni di questo fenomeno? Tra le tante possibili cause concomitanti, si distingue il fascino esercitato da una teoria, o modello scientifico, apparentemente potente. Esso è dotato di una funzione organizzativa analoga a quella del delirio paranoideo, capace di creare ordine dal caos percettivo, cognitivo ed emotivo dello stato psicoti co. Senza una teoria che organizzi il mondo, ci troviamo di fronte alla pos sibilità della frammentazione. L’esistenza di fenomeni incongruenti con la nostra teoria sullo stato delle cose tende a suscitare angoscia, come assai spesso si riscontra nella pratica dell’EMDR. IL S U I C I D I O COME D E S I DE R I O O R G A N I Z Z A N T E
Ecco una breve descrizione di un caso clinico che illustra il fenomeno della frammentazione. Una donna di trent’anni venne da me accusando un continuo desiderio di suicidarsi, pur non presentando nessun altro sintomo
Uangoscia di disintegrazione
101
psichiatrico di tipo depressivo. Oltre a essere socialmente e sessualmente attraente, sembrava una persona competente e riuscita sotto il profilo pro fessionale. Ma la sua infanzia era stata caratterizzata da trascuratezza e caos: infatti aveva vissuto dapprima con la madre alcolista e poi era stata affidata a successive famiglie adottive. Le esperienze della vita adulta avevano rinforzato la sua generale delusione circa l’affidabilità degli esseri umani. Era estremamente intelligente e aveva molta facilità di parola, per cui nel corso della psicoterapia riusciva a comunicare in modo vivace, discutendo con vigore del suo diritto di decidere della propria vita. Tuttavia, mi accu sava di darle risposte insufficienti e di non fornirle una guida chiara circa le soluzioni ai suoi problemi; diceva che la psicoterapia durava troppo e non garantiva un risultato certo. Il suo interesse per il controllo era una caratte ristica dominante, che la paziente riconobbe prontamente. La terapia era connotata da un’alternanza tra periodi in cui la paziente mi consentiva di arrivare a una comprensione e a un contatto emotivo con lei più profondi, il che stava a indicare una accresciuta fiducia nei miei riguardi, e periodi in cui diventava ostile e bellicosa al punto di interrompere le sedute. La sua sembrava una profonda paura di diventare fiduciosa e vulnerabile e quindi di essere ferita e di sentirsi totalmente inerme. Dopo due gravissimi tentati vi di suicidio, era rimasta sconvolta per non essere riuscita a togliersi la vita. Alla fine di uno dei suoi periodi di ritiro, durato un paio di settimane, tor nando da me riferì di aver vissuto in uno stato psicotico, caratterizzato da insonnia e da senso di confusione, in cui le erano venuti alla mente “tutti i pensieri dell’universo”, aveva avuto allucinazioni e sperimentato la para noia, si era sentita sopraffatta dal significato senza tuttavia comprendere nulla: non aveva mai provato niente di simile prima, almeno a quanto ricor dava. Ma un giorno, svegliandosi, si era accorta che quello stato e i senti menti suicidi erano dileguati. Spiegò che si era sentita più calma e positiva. Le dissi ciò che pensavo a proposito dello stadio del sé frammentato e di come forse in lei la paura della frammentazione fosse stata particolarmente pronunciata per via delle esperienze vissute in tenera età. Le mie parole le parvero significative e riconobbe che, durante il periodo di confusione e di disordine, aveva desiderato ardentemente la certezza procuratale dal pro getto suicida cui in precedenza si era aggrappata. Le spiegai che quanto le era accaduto faceva parte del processo di guarigione: aveva abbandonato, cioè, la rigidissima organizzazione psichica precedente ed era entrata in una regressione spontanea allo stadio del sé frammentato, da cui alla fine era riemersa in un nuovo stato, caratterizzato da un’organizzazione meno rigi da. La donna trovò questa formulazione estremamente plausibile e affasci nante. Ma io ebbi anche la vivida impressione che, nello stato di confusio ne, fosse stata vicinissima alla possibilità di riorganizzarsi su una base psico tica di strutture deliranti.
102 Le terapie energetiche IL FALSO SÉ
L’alienazione del soggetto nel linguaggio, ovvero la struttura paranoica dell’identità messa in rilievo da Lacan, può essere vista come la versione so cioculturale di quell’alienazione in false immagini prese dall’esterno che tal volta ha luogo nell’ambito delle relazioni personali della famiglia d’origine. Qui ci imbattiamo nel falso sé descritto da Winnicott, o 'sé estraneo’, se condo la recente descrizione di Fonagy, Gergely, Jurist e Target (2002). Analogamente, Kohut ha descritto molti casi in cui il naturale esibizionismo del bambino era stato deviato nel suo percorso dal narcisismo della madre, dal suo desiderio di avere un figlio che la rispecchiasse e soddisfacesse le sue ambizioni. Il sé autentico, vale a dire le iniziative personali del bambino e i suoi desideri di essere rispecchiato e affermato, viene sopraffatto da un sé estraneo, basato sui desideri narcisistici materni (Mollon, 1993). Ma Ko hut ha anche sostenuto che, se le iniziative personali del bambino trovano risposta e il suo bisogno di idealizzare viene accolto, allora le linee di svi luppo del sé bipolare possono progredire. Questo abbandono della posi zione del falso sé, tipica dell’adattamento al desiderio materno, suscita una profonda angoscia di disintegrazione, la stessa che viene descritta nel caso del signor Z. Per uno sviluppo ottimale la madre deve fornire le funzioni dell’oggettosé, mostrando interesse e piacere verso le naturali manifestazioni esibizioni stiche del bambino. Se ciò non avviene, l’esibizionismo diventa una fonte di angoscia e di vergogna, il flusso di energia verso l’esterno viene rivolto al l’interno e il soggetto si carica di una dolorosa tensione, resa manifesta dalla reazione di rossore; al posto del desiderio di esibirsi insorge nel bambino un urgente bisogno di nascondersi, di sparire. Essere sopraffatti dalla ver gogna significa trovarsi in uno stato di disorganizzazione, in cui la persona non è in grado di funzionare in modo coerente. LA V E R G O G N A T O S S I C A
Ancor più profonde sono la vergogna tossica e la frammentazione che de rivano dall’abuso perpetrato da chi si occupa del bambino (Mollon, 2002b). Per gli scopi di questa trattazione, definirò il termine ‘abuso’ come il rifiuto, la deformazione o il pervertimento deliberati e consapevoli delle normali risposte dell’oggetto-sé per la personale gratificazione sadica di chi si occupa del bambino, precisando che tale gratificazione può anche consi stere nel suscitare nella vittima sentimenti e immagini indesiderati apparte nenti all’autore dell’abuso. Un altro aspetto di questo è quel processo di violenza emotiva che io chiamo ‘identità imposta’ (Mollon, 2001) e che con-
L'angoscia di disintegrazione
103
siste nell’insistente tendenza a vedere una persona in modo particolarmen te irrispettoso della sua esperienza soggettiva e nelTimporle quindi un’iden tità estranea. Questa definizione può includere la violenza fisica, emotiva e sessuale. La vergogna tossica derivante dall’abuso è tutt’altra cosa dalla nor male vergogna, dall’imbarazzo, dalla mortificazione e dal disappunto di sé che a tutti può capitare di provare di tanto in tanto. Essa può avere effetti letali, in quanto avvelena l’anima e sgretola ogni traccia di autostima. l ’a b u s o
e la f r a m m e n t a z i o n e
Mentre il rispecchiamento e l’accessibilità per l’idealizzazione favorisco no la comparsa e il consolidamento del sé bipolare, l’abuso perpetrato da chi si prende cura del bambino costringe quest’ultimo a ritornare allo sta dio del sé frammentato. Come reazione, il bambino organizza il proprio sé frammentato intorno alla figura dell’autore dell’abuso, dando forma a un aspetto del sé estraneo. Questa è una variante dell’identificazione con l’ag gressore. Tutto ciò che mette in discussione la percezione del sé come catti vo e dell’autore dell’abuso come buono comporta una minaccia di fram mentazione. La vergogna si struttura all’interno della personalità e fa sì che una parte di questa venga percepita come cattiva e non amabile e un’altra come accusatoria e condannante. Un’altra eventualità è che il bambino, pur riuscendo a percepire l’autore dell’abuso come cattivo, debba poi organizzare il proprio sé intorno a que sta figura denigrata. In tal caso, a differenza di ciò che accade nella posizio ne idealizzante descritta da Kohut con la formula: “Tu sei perfetto e io so no parte di te”, il bambino avverte: “Tu sei cattivo e io sono parte di te”. Ancora una volta la vergogna pervade l’esperienza centrale del sé. LA S I N D R O M E DE L L ’A S S AS S I N I O P S I C H I C O
In altri casi in cui mi sono imbattuto il paziente non aveva subito un abu so manifesto durante l’infanzia, ma il rifiuto materno delle sue iniziative co municative e dei suoi bisogni di comprensione ed empatia era stato così profondo che il potenziale sé autentico era pervaso dalla vergogna e blocca to nel suo sviluppo. In situazioni simili il bambino ha percepito in età pre coce l’ambiente circostante come fondamentalmente contrario al suo vero, autentico sé e intento a sostituirlo con un’alternativa preferita. In un mio scritto sulla 'sindrome dell’assassinio psichico’ ho affrontato questo argo mento servendomi della metafora del 'bambino perfetto’, che ho tratto dal film La donna perfetta, in cui tutte le mogli di una rispettabile cittadina ve-
104 Le terapie energetiche
nivano uccise e sostituite con copie identiche che, però, si comportavano secondo i desideri dei loro mariti (Mollon, 2002b). Se il bambino interioriz za l’ambiente psichicamente omicida, da allora in poi, per tutta la vita, con tinuerà a essere perpetrato l’assassinio del sé autentico, in quanto il proces so verrà particolarmente attivato ogniqualvolta incomberà la minaccia di in timità emotiva e attaccamento genuini. Il mantenimento della struttura psi chicamente omicida viene suscitato dall’angoscia di disintegrazione. Nel quadro espositivo fin qui delineato, ho descritto come lo stadio del sé frammentato e la minaccia della regressione vengano neutralizzati dall’as similazione di strutture estranee erroneamente percepite come ‘sé’. Se gli viene offerto un ambiente terapeutico, il paziente può cercare inconscia mente di tornare ai bisogni dell’oggetto-sé non soddisfatti nelle prime fasi della vita, scartando le strutture del falso sé, ma rischiando al tempo stesso di precipitare in una frammentazione irreversibile. Prima di effettuare il la voro analitico, il paziente non conosce né se stesso né l’altro. È solo toglien do di mezzo i simulacri del transfert,2 in modo da percepire in termini di immagini imposte i due che si trovano nello studio analitico (il sé e l’altro), che il sé veramente spontaneo ed essenzialmente sconosciuto può comin ciare a emergere. Questo momento di crescita e di cambiamento reca con sé il terrore della disintegrazione, in quanto comporta l’abbandono di strut ture note. I M P L I C A Z I O N I DEL LAVORO CON L’EMDR
Poiché I’e m d r e gli approcci energetici tendono a produrre molto in fretta l’elaborazione, è naturale che l’angoscia di disintegrazione venga alla ribalta. Un rapido cambiamento, anche se positivo, può essere allarmante, specialmente quando l’Io, o l’organizzazione psicologica della persona, è ri gido o fragile, come può avvenire se il bambino ha dovuto instaurare un’in dipendenza e un autocontrollo precoci poiché l’ambiente in cui è stato alle vato era inadeguato, violento o imprevedibile. L ’e m d r allora si troverà a fronteggiare una forte resistenza, suscitata dall’angoscia di disintegrazione. Ciò potrebbe costituire la base di una reazione terapeutica negativa, o di quel fenomeno che gli psicologi energetici chiamano ‘rovesciamento psico logico’. Entro certi limiti è possibile contrastare la reazione negativa all’ela borazione affrontando l’angoscia di disintegrazione stessa con I’e m d r o I’e f t . L’angoscia di disintegrazione deve essere compresa e spiegata.
6 Trattamento con em d r di una fobia di viaggiare dalle complesse radici traumatiche (scritto con S ii Singer) Quella che segue è la versione riveduta e corretta di un racconto orale del mio collega Sid Singer e riguarda il caso di una paziente da lui trattata con ri sultati eccellenti in undici sedute e m d r . Illustra vividamente non solo Pintreccio di traumi passati e presenti nello sviluppo dell’angoscia, ma anche la penetrazione del trauma da una generazione all’altra. La struttura delle diffi coltà psicologiche della paziente era, schematicamente, la seguente. La sua te nace paura di viaggiare in auto, che peggiorava quando non era lei a guidare, aveva avuto inizio dopo la morte per meningite del figlio più piccolo. Il mo mento cruciale dell’insorgenza si era presentato mentre la paziente era in va canza, subito dopo la perdita del bambino. Viaggiando su una strada di mon tagna, col marito alla guida, si era sentita sopraffare dall’emozione e dal pani co. Le cause antecedenti di quest’ansia emersero dalla sua percezione che i genitori non le avevano fornito cure e protezione sufficienti. Ricordò la paura che provava da bambina quando viaggiava con i genitori: essi litigavano e la madre esprimeva la propria ansia circa il modo di guidare del padre. Il clima che aveva permeato la sua esperienza infantile era la silenziosa risonanza della sopravvivenza dei genitori all’olocausto. Tutte le aree di trauma e di dolore emotivo vennero elaborate rapidamente e facilmente mediante I’e m d r .
SIMONE
Prima seduta Simone era una donna di cinquantanni che da oltre trenta viveva in In ghilterra. Nata a New York in una famiglia ebrea, era dinamica, dotata di elevata intelligenza e grande facilità di parola e faceva parte del consiglio di amministrazione di una società internazionale. Il suo problema era un’av versione per i viaggi. Ci incontrammo per un totale di undici sedute. Un
106 Le terapie energetiche amico di New York le aveva consigliato I’e m d r . In precedenza aveva partecipato a diversi seminari di crescita personale e si era sottoposta a terapie di vario genere. Il problema di presentazione consisteva in una forte angoscia che l’assa liva quando viaggiava su un’auto come passeggera. Pur riuscendo a situare più chiaramente il problema negli ultimi diciotto anni circa, si rendeva con to di averlo da sempre. Quando era lei a guidare non provava ansia. Ricor dava che anche i suoi genitori provavano disagio quando non erano loro al la guida. L’angoscia diventava più forte in autostrada o sulle vie di monta gna di qualsiasi tipo, dove insorgeva in forma di panico totale. Di conse guenza, la paziente non era in grado di partecipare a vacanze che prevede vano tragitti in macchina. Il problema era iniziato diciott’anni prima, poco dopo la morte del suo secondo figlio, che all’epoca aveva diciotto mesi. Il bambino aveva avuto un attacco di meningite fulminante ed era morto nell’arco di pochi giorni. La madre ne era rimasta, ovviamente, devastata. Nel tentativo di aiutarla a gua rire, qualche mese dopo la famiglia aveva deciso di fare una vacanza in Ita lia. Viaggiando su una strada di montagna, esattamente tre mesi dopo la morte del bambino, la donna era entrata in uno stato di panico tale da spin gerla a gettarsi letteralmente dall’auto ancora in corsa. Storia della paziente Entrambi i genitori erano superstiti dell’olocausto, erano stati internati ad Auschwitz. Nonostante fosse un campo di sterminio, molte migliaia di persone di fatto ne erano uscite vive. La madre di Simone era tra queste; il padre oltre che al lager era sopravvissuto anche a una successiva marcia for zata, una di quelle marce durante le quali la maggior parte della gente sem plicemente moriva lungo il percorso. Entrambi erano finiti a New York, dove avevano vissuto in una comunità di persone con la stessa vicenda alle spalle. Le comunità statunitensi di questo tipo, forse piuttosto diverse da quelle britanniche, non solo commemoravano l’olocausto, ma lo rivivevano in continuazione, parlandone e mandando i loro figli in campeggi estivi an nuali dove venivano informati al riguardo. In questa atmosfera era cresciu ta la mia paziente. Simone aveva due fratelli maschi più piccoli. La madre era morta quattro anni prima, ma il padre era ancora vivo e risiedeva a New York. A livello scolastico, Simone era stata una bambina estremamente precoce, aveva sal tato parecchie classi e all’età di diciannove anni si era laureata. Era venuta poi a visitare l’Europa e ad Amsterdam aveva conosciuto il futuro marito, col quale in breve tempo si era sposata ed era venuta a vivere in Inghilterra.
Trattamento con EMDR di una fobia di viaggiare
107
Il marito era un professore universitario. Oltre al bambino morto, avevano avuto altri tre figli, ora adulti. Altri traumi Qualche anno prima di intraprendere la terapia, Simone era stata sotto posta a mastectomia e a diverse altre operazioni, ma ora stava bene. Il suo modulo è consistito nel negare la propria malattia. Simone è una vittima dell’olocausto nel senso che, da bambina, non solo doveva ricordare quella tragedia, ma anche essere felice per compensare la sofferenza dei genitori. Si tratta di una reazione comune tra i genitori sopravvissuti all’olocausto. Da piccola, Simone aveva avuto spesso atteggiamenti ostili e provocatori, indice di sofferenza interiore. A diciassette anni, nel tentativo di dimostrare la propria infelicità, aveva cercato di suicidarsi assumendo un’overdose di droga. Per comprendere, almeno in parte, questo episodio, occorre riferir lo alle reazioni dei genitori in quanto superstiti dell’olocausto. La madre, in particolare, manifestava un’ansia eccessiva, in quanto si preoccupava di ogni cosa ed era continuamente in preda al panico e al pessimismo, mentre il padre, al contrario, tendeva a usare il diniego. Simone doveva essere co stantemente consapevole della sua storia di figlia di sopravvissuti. Tutti i bambini con cui faceva amicizia lo erano e le sue vacanze consistevano in campeggi estivi destinati a questa categoria di ragazzi. Cosi, a diciassette an ni, aveva reagito a tutta questa pressione sentendosi molto infelice. Dopo il tentativo di suicidio, le era stata consigliata la terapia familiare. Tutta la fa miglia aveva accettato di sottoponisi, tranne uno dei fratelli, ma già dopo poche sedute entrambi i genitori si erano rifiutati di continuare, dicendo che il problema era della ragazza. Così per quattro anni Simone si era sotto posta a una terapia individuale, che, a suo dire, l’aveva aiutata a compren dere molto, ma senza cambiare nulla. La fobia aveva avuto inizio quando la donna aveva avuto la sensazione che il marito stesse guidando troppo velocemente su una strada di monta gna: era diventata isterica, ma lui non si era fermato. Alla fine lo aveva co stretto a farlo gettandosi letteralmente fuori dall’auto ancora in corsa. Con gli anni il problema era diventato così terribile che l’ultima volta che aveva no programmato un viaggio negli Stati Uniti lo avevano dovuto cancellare: Simone infatti si era rifiutata di andarci per non dover viaggiare in auto. Ma ora il padre era piuttosto malato e lei voleva andarlo a vedere; inoltre desi deravano vedere la loro figlia che viveva lì, per cui, poco prima di venire da me, avevano stabilito che sarebbero partiti in luglio e Simone era decisa a cercare di superare il suo problema prima della vacanza. Ciò mi dava un margine di sei settimane circa, entro le quali avrei dovuto cercare di modifi-
108 Le terapìe energetiche
care la situazione. La prima seduta si concluse con una discussione suITem d r , su cosa aspettarsi dal trattamento e su come lo avremmo effettuato. Seconda seduta
Innanzitutto creammo un ‘luogo sicuro’, che corrispondeva alla sua camera: i letto o guardando da sola la televisione, accucciata sotto il suo piumino d’oca t con un soffice cuscino, si sentiva coccolata e al sicuro; la parola che suscitavi tutto ciò era ‘morbido’. Chiarimmo il protocollo emdr nel modo seguente. 1. Il problema bersaglio era la fobia, iniziata diciott’anni prima, di viaggiare ir auto come passeggera. 2. L’immagine peggiore era quella sulla strada di montagna in Italia. Sul sedile accanto al guidatore, non riusciva a vedere il lato della strada, ma solo le strapiombo; aveva avuto un attacco isterico e aveva cominciato a urlare, d modo che il marito aveva dovuto fermare l’auto e farla scendere. 3. Cognizione negativa: “Sono debole, sono stupida”. 4. Cognizione positiva: “Sono capace, rilassata, coraggiosa”. 3. Valutazione voc: la validità della cognizione positiva risultava tra 4 e 5 (h scala va da 1 a 7). 6. Le emozioni associate alla scena sulla strada di montagna erano rabbia e de lusione di sé. Questo sembrò sorprenderla. 7. Il punteggio sud (la scala va da 0 a 10) era piuttosto basso a questo punto, tra 3 e 4. 8. La sensazione corporea era localizzata nello stomaco, che le sembrava “co me annodato”. Passammo direttamente ai movimenti oculari, utilizzando la barra luminosa nella modalità standard. Le serie di movimenti oculari erano generalmente 40* 60 circa, con minimi interventi da parte mia. Nella seguente trascrizione, i mie: interventi sono tra parentesi quadre, mentre le mie note esplicative sono ir corsivo. EM DR
1. Mi sento scollegata. 2. Non va bene. Ahreazione. 3. Mio figlio è morto, e io devo far finta di essere in vacanza.
Trattamento con EMDR di una fobia di viaggiare
109
4. Sono arrabbiata. [Dov’è che provi rabbia?] Nel torace. 5. Sono arrabbiata con mio marito, ma non c’è niente che avrebbe potuto fa re... eppure non faccio altro che ritornarci su. 6. Sono molto stanca, sono arrabbiata con mia madre. 7. Come se mi facessero girare come una trottola, perché mi devo prendere cura di tutti, vorrei solo scappare. Intensa abreazione. 8. Qualunque cosa faccia... mio figlio è sempre morto. 9. Vorrei essere stupida: così non vedrei le cose. 10. È colpa mia se sono così intelligente. 11. Vengo punita, eppure non so cosa ho fatto. 12. C’è una voce che mi dice che sono troppo intelligente perché questo sia il mio bene... Mi sento come un topo in gabbia. [Di chi è questa voce?] Di mio padre. 13. A diciassette anni... dopo aver preso l’overdose... nella terapia familiare... dopo un po’ i miei genitori non sono più venuti... dicevano che ero io la malata, non loro. Mio fratello non è mai venuto. Intensa abreazione. 14. Abreazione. Insicura... abbandonata... mi hanno lasciato fare tutto da sola. 15. Continuavo a dirglielo ai miei genitori: non ero mai stata in un campo di concentramento, mai. 16. Hanno reso il mio mondo così insicuro, non so perché, davvero tanto insi curo. 17. Mi sento agitatissima, corro da una parte all’altra, apro una porta dopo l’al tra in cerca di un luogo sicuro... agitatissima. 18. Sono stupida... è stupido non fare altro che correre da un posto all’altro... sono stanca... sono stupida... non c’è un posto sicuro. 19. Non sono stupida... posso essere forte, ma non so come. Intensa abreazione. 20. Sono confusa. 21. Tante forze opposte... mi tirano in direzioni differenti... ma sono solo un essere umano. 22. Un vero guazzabuglio. [Torna al bersaglio] È comprensibile. 23. Prendo tutto su di me per proteggere la mia famiglia. 24. Se sarò sempre in ansia impedirò che le cose vadano male. [Dove hai imparato questo?] Da mia madre. 25. Vedevo mia madre dire a mio padre che era troppo stupido avere paura. 26. Mio padre diceva: “Devi solo scollegarti”... ma io non ci riesco. Mio padre dice: “Sei troppo intelligente perché questo sia il tuo bene” (Ride). 27. Ritorno al luogo sicuro e conclusione della seduta.
110
L e tera p ie en erg etich e
Terza seduta Simone disse di sentirsi bene, ma di essere sbalordita dal numero di element emersi durante la seduta precedente e da quanto era risalita nel tempo. Riferì molti vividi sogni in cui risolveva problemi ben al di là delle sue possibilità. L* chiesi come si fosse sentita durante la settimana. Mi rispose che era stata benissi mo e mi parlò di un paio di eventi significativi. Era dovuta andare col marito a ut funerale e avevano dovuto percorrere l'autostrada. Erano un po’ in ritardo, ma; nonostante la fretta e la velocità sostenuta, si era sentita totalmente rilassata ne! posto accanto al guidatore, senza problemi di sorta. Era stupefatta e non poteva credere che le fosse accaduto. Descrisse il ritorno dal funerale sotto la pioggia: benché questa peggiorasse la situazione, non le aveva creato alcun problema. Un altro importante progresso era che aveva iniziato a comunicare al marito ciò che provava quando aveva quelle reazioni: parlandone, si era immediatamente resa conto di usare il marito per alleviare Pangoscia, in quanto provocando la lite trovava sollievo dall'ansia e dallo stress. Ebbe altri insight, tra cui la presa di co scienza che la madre aveva cercato di trasformarla nella propria sorella, morta nel campo di sterminio. Parlò a lungo, passando in rassegna le questioni emerse nel corso della settimana precedente. Questa fu ovviamente una seduta molto più leggera; ci preparammo quindi ad affrontare quella della settimana successiva. Quarta seduta Simone mi disse di essere andata in macchina col marito a prendere una perso na all’aeroporto, senza avvertire alcuna difficoltà. In seguito si era messo a pio vere, ma lei aveva continuato a sentirsi bene. Poi a un certo punto il marito si era spazientito un po' e aveva suonato il clacson per sollecitare la macchina da vanti: a quel punto Simone era entrata di nuovo nel panico. Presa dall'ansia aveva chiesto al marito di fermarsi, ma lui non lo aveva fatto, aveva continuato a guidare e lei era diventata isterica, furibonda e poi era stata colta da grande paura. In seguito ne avevano parlato, il marito aveva riconosciuto che era stata colpa sua, ammettendo di aver riprodotto semplicemente il vecchio modulo, invece di guidare più piano, e se ne era scusato. Quando le chiesi come si sentiva in generale, mi disse di avere la sensazione di non riuscire a credere che il marito si sarebbe preso cura di lei; pensava che fosse lui a voler essere accudito e che provasse risentimento perché lei aveva tutte quelle malattie. Questa può essere una tipica reazione della seconda ge nerazione delle vittime dell’olocausto: la sensazione di non potersi fidare di nessuno. Riguardo ai viaggi in auto disse di sentirsi più a suo agio e di aver perfino offerto un passaggio a una persona. Pur avendo evitato di pensare ad altri problemi, aveva fatto un brutto sogno
Trattamento con EMDR di una fobìa di viaggiare
111
nel quale andava a farsi fare un tatuaggio consistente in un numero: il conte nuto del sogno aveva chiaramente a che fare con i numeri tatuati sulle braccia degli internati nei lager. Negli ultimi giorni aveva provato molta più sollecitu dine nei confronti del padre e aveva avuto molti ricordi in proposito, alcuni piacevolissimi, altri non troppo. In particolare ricordava quando da piccola, a quattro o cinque anni, avevano comprato la loro prima auto. La famiglia aveva cominciato ad andare in montagna nel fine-settimana e in quelle occasioni lei e la madre erano sempre piene d’ansia. Rammentò che il padre per prendere una scorciatoia passava sopra un ponte: la madre non lo sopportava e di solito si arrabbiava ed entrava in agitazione. Lui la ignorava e ciò scatenava il conflit to tra i due. Simone nel corso di quei viaggi aveva paura. Le tornò in mente an che un altro ricordo risalente all’età di cinque anni: un viaggio in macchina per le vie di Harlem, quartiere di New York all’epoca molto pericoloso. Anche in quell’occasione aveva avuto molta paura. Fino a quattro anni prima, anche guidare le faceva spavento. L’elaborazione mediante I’emdr da focalizzata sul timore di essere in auto co me passeggera, ma l’immagine bersaglio era quella in cui viaggiava con i geni tori su una strada di montagna, con la madre in preda al terrore. La sensazione corporea riferita fu ansia localizzata nello stomaco e nel torace. L ’EMDR 1. Paura... una strada di montagna, un alto ponte, perché non la smettono di litigare? Abreazione. 2. Vorrei mettermi dell’ovatta nelle orecchie e non vedere tutto questo. Mia madre è spaventata e mio padre non se ne cura. La ripetizione è molto ovvia. 3. Sono molto arrabbiata con mio padre. [Dove avverti questa sensazione?] Nel torace. Intensa abreazione. 4. Io non esistevo, non avevo diritto di essere li. 5. Completamente persa, non ho dove starmene col mio ricordo. 6. Un’immagine chiara in cui sono con mio marito e, per colpirlo, gli dico: “Non sto bene”. 7. Come un topo in un labirinto, ovunque vada trovo un vicolo cieco. Abrea zione. 8. Sono in una scatola... in un angolo mia madre, pazza, in un altro angolo mio padre, pazzo anche lui, in un terzo il mio bambino morto e in un quar to il mio cancro... e non c’è via di fuga dal dolore. Abreazione. 9. Ho cinque anni e l’unica persona in grado di prendersi cura di me sono io. Sono arrabbiata con mio marito perché non è capace di occuparsi di quella bambina di cinque anni. Abreazione.
112 Le terapie energetiche 10. Finora in tutti i suoi discorsi ha dato la sensazione di riferirsi a se stessa come a quella bambina di cinque anni.., e questo non mi piace e non mi piace* quella bambina, e io lo so che la donna adulta che è in me è abbastanza forte da tenere sotto controllo la bambina di cinque anni. Questa bambinatj è come mia madre, mentre la parte adulta di me è come mio padre... mio£ padre è bravissimo quando c’è una crisi, una malattia. :! Voi è come se parlasse a se stessa bambina di cinque anni. Raggiungerò con^ te un accordo, mi prenderò cura di te anche se non sei malata. ; 11. È strano... sto negoziando un contratto con me stessa. Delinea i termini defy contratto, in base al quale lei si prenderà cura della bambina di cinque anni e\ questa le consentirà di essere malata. Questo passaggio è troppo complicato! per essere annotato in ogni dettaglio. 12. Se firmo il contratto... ma non siamo in due, si tratta di una persona sola. 13. Ho la sensazione che non ho il dovere di essere una sopravvissuta. Ho fir mato il contratto, ho delle cicatrici, ma non sono stata danneggiata. 14. Devo essere come tutti gli altri... quando mi serviranno le capacità di so pravvivenza, le avrò lì a disposizione. Quinta seduta Simone mi raccontò di aver trascorso una buona settimana e di sentirsi molto positiva. Era stata a Cambridge e si era divertita a guidare andando a più di cento all’ora: ammise che era un gran risultato. Era sorpresa di essersi sentita tanto tranquilla e padrona di sé. Passò in rassegna varie questioni e parlò a lun go dei rimproveri che muoveva al marito: lo accusava di non prendersi cura di lei, pur riconoscendo che lui non ne aveva colpa e che, in realtà, le sue lamen tele riguardavano più il padre, il quale era stato incapace di occuparsi di lei nel modo giusto. Emersero altri insight relativi alle sue esperienze con i genitori. Le chiesi che sensazione le procurava il ricordo bersaglio e lei mi rispose che non era più particolarmente angoscioso, essendo diventato solo un ricordo. Non provava più rammarico per non essersi controllata abbastanza. A questo punto discutemmo per capire su quali aspetti procedere con la terapia: lei vo leva continuare a elaborare il problema della fiducia in se stessa. Mise le cose in questi termini: “Perché ho tanta paura che accada qualcosa di terribile?”. Naturalmente questo è piuttosto tipico dei figli dei sopravvissuti all’olocausto, perché nel loro caso qualcosa di terribile è veramente accaduto. La cognizione negativa per la seduta successiva sarebbe stata: “Non merito niente di buono”. Le chiesi di contestualizzare tale cognizione e di accompagnarla con un esem pio: Simone propose la morte del figlio, anche se non avevamo ancora discus so se elaborare quel particolare trauma.
Trattamento con EMDR d i una fobia d i viaggiare
113
Sesta seduta Simone era piuttosto ansiosa perché il giorno successivo sarebbe partita per gli Stati Uniti, dove sarebbe rimasta tre settimane. Riferì di aver avuto alcune esperienze positive in autostrada, sia come guidatrice sia come passeggera. Non aveva avuto alcun problema e questo progresso l’aveva riempita di gioia. Verificai insieme a lei se si sentiva di proseguire il lavoro terapeutico, dal mo mento che non viene considerato opportuno effettuare una seduta di emdr prima di un’interruzione, ma lei insistette, dicendo che ce l’avrebbe fatta. Cominciammo a esplorare la cognizione negativa secondo la quale lei non me ritava niente di buono. Mi raccontò che aveva tre anni quando era nato suo fratello e che aveva cercato di ucciderlo riempiendogli la bocca di bottoni. La madre aveva sentito che il bambino, all’epoca di otto giorni, stava soffocando ed era giunta in tempo per togliergli i bottoni dalla bocca. Ricordò che la ma dre si era molto arrabbiata con lei, ma Simone non aveva ammesso di essere l’autrice del misfatto. Ricordò poi di averlo raccontato a una zia, dicendole che la sua intenzione era stata semplicemente di mandare via il bambino. Aveva la sensazione che da allora in poi la sua vita non era stata più buona; nell’ultima settimana quel particolare ricordo era stato molto intenso e lei aveva provato una grande tristezza. Mi raccontò anche una miriade di altri esempi di quanto fosse cattiva e disobbediente da piccola. UEUDR 1. Mia madre mi sgrida dicendomi: “Chi credi di essere?”. 2. Sono proprio arrabbiata con lei. [Dove senti questa rabbia?] Nel torace. 3. Mi mortifica in continuazione, immagini di lei che mi umilia, mi mortifica e mi dice che la faccio ammalare. 4. Non sono mai riuscita a fare abbastanza, i miei voti non erano mai suffi cientemente buoni, la mia condotta non era mai accettabile. 3. È come se non sapessi mai le regole, se quello che faccio non fosse mai all’altezza. [Mi puoi fare un esempio?] Tornando da scuola, avevo otto an ni, chiamai mia madre dalla strada per dirle che ero tra i sei bambini scelti per saltare l’anno... ma tutto quello che mi rispose fu: “Stai zitta, disturbi i vicini”. Abreazione. 6. Abreazione. Combinavo sempre guai per richiamare l’attenzione su di me. A nove anni circa ebbi la tosse per un anno, giorno e notte, e mamma mi disse che dovevo smetterla di cercare di farmi notare. 7. A dieci, per attirare l’attenzione, derubai mio fratello e mi accorgo che an cor oggi faccio la stessa cosa, ammalandomi o svenendo. Quando va tutto bene, nessuno si accorge di me.
114 Le terapie energetiche
8. Ho cercato di pensare a tutte le cose che so fare, ma la mia mente non rie^ see a soffermarvisi. [Cosa sta emergendo?] Tutte le cose negative. [Che ge* nere di cose?] Tutta la malattia, non la morte di mio figlio. All’età di nov^jj anni mio fratello prese un’influenza gastrica, e io ebbi la diarrea, ma mi^ madre mi sgridò perché per attirare l’attenzione avevo imitato mio frateb lo... quelle parole non mi hanno più abbandonato. Abreazione. 9. Di nuovo sento una scissione tra la bambina e l’adulta. Sono arrabbiata con mia madre... loro hanno reso questo mondo insicuro e non mi hanno dato protezione... mio fratello viveva in un bozzolo, lui sì che era protetto. 10. Immagini di mia madre, isterica. E di mio padre, passivo come Homer Simpson... e mia madre nel suo angolo... e io che combatto col mondo. L’unica volta che non l’ho fatto è stato quando mi sono ammalata: così mi sono ammalata. Intensa abreazione. 11. A me non viene il raffreddore o l’influenza, ma solo malattie gravi... lonta ni problemi di quando avevo otto anni. Non devo avere talento né fare qualcosa, merito attenzione. Abreazione. 12. Ma non ci credo... intellettualmente so che è vero... ma perché non ci cre do? [Chieditelo e segui le luci] 13. Se non ci fosse nessun altro al mondo ci sarei io a dare attenzione a me stessa. Intensa abreazione. 14. In me ci sono abbastanza cose per star bene con me stessa. [Che intendi dire con questo?] Mia madre non ha molta parte in giocc oggi15. Mi sta bene non essere perfetta. Fine della seduta Il giorno seguente Simone partì per gli Stati Uniti e ci rivedemmo sei set timane dopo. Settima seduta Il viaggio negli Stati Uniti era stato un vero successo e la paziente aveva avute pochissimi problemi durante i percorsi in auto. Aveva parlato a lungo col fra tello della storia della famiglia e dell’angoscia provata dalla madre durante viaggi in macchina. C’erano stati solo due episodi di ansia. Uno si era presentato mentre si dirigeva no in macchina verso il centro della città di Buffalo: Simone era stata colta d? un attacco di panico in un luogo molto desolato e con un alto tasso di crimina
Trattamento con EMDR di una fobia di viaggiare 115 lità. Cera poi stata un’altra occasione in cui alcuni amici volevano far vedere lo ro un nuovo giardino di statue che si trovava ad Harlem: Simone, che non vole va andarci, era stata presa dall’angoscia e si era sentita in pericolo, ma era riu scita a nasconderlo, inventandosi la scusa di un mal di testa per tornare a casa. Continuammo a discutere su quale sarebbe stato il prossimo bersaglio e deci demmo per la cognizione negativa: “Sono pazza, sono impotente, non ho pa dronanza sui comportamenti da pazza e non ho alcuna possibilità di scelta”. Ciò aveva a che fare con l’episodio di Buffalo, perché sia il marito sia il figlio, entrambi presenti, si erano arrabbiati con lei e lei stessa era spaventata dalla propria reazione. Ricordò che la madre si era comportata esattamente nello stesso modo e lei stessa l’aveva considerata pazza. Quando col marito litigano lui le lancia questa accusa. Ottava seduta Durante questa seduta, la paziente riferì di sentirsi un po’ giù. Aveva sognato un amico d’infanzia, morto all’età di sedici anni, il quale le aveva detto di non avere nessuna scusa per essere morto (o forse per non essere morto), e lei ave va collegato il sogno alla propria situazione. Andare in macchina non costitui va più un problema, non le veniva neanche in mente che lo fosse anche quan do non era lei a guidare. Tuttavia era consapevole di provare panico uscendo di casa, un panico che l’aveva accompagnata tutta la vita, insieme alla paura dei luoghi nuovi. Sentiva che ciò aveva a che fare con l’insicurezza avvertita durante l’infanzia. Ricordò un campeggio estivo dove l’avevano mandata a se dici anni: in quell’occasione era dovuta tornare a casa perché era stata presa dal panico e aveva avuto un attacco isterico. Pensava che la madre fosse incinta a quell’epoca. Rimanere a casa era stato anche peggio e Simone aveva fatto ri torno al campeggio. Mi parlò di un livello d’ansia moderato ma costante e le chiesi di richiamare al la mente i primissimi ricordi al riguardo. Disse di essere stata molto ansiosa nel 1961, quando il padre era andato in Israele dal fratello moribondo. A quel l’epoca Simone aveva dodici anni. All’età di sette era venuta a sapere che suo padre aveva un fratello che viveva in Polonia e si era convertito al cattolicesi mo; per questo il padre si era rifiutato di aiutarlo a emigrare negli Stati Uniti. Fece di nuovo riferimento all’episodio vissuto a tre anni, quando aveva messo i bottoni nella bocca del fratello appena nato. Ricordò i pianti e i rimproveri e quando la zia le aveva chiesto cosa aveva voluto che accadesse e lei aveva ri sposto che voleva semplicemente che il bambino andasse via. Non ricordava di essere stata punita per quello che aveva fatto. Portò una gran quantità di ricordi di ingiusti trattamenti ricevuti, di soprusi subiti a scuola all’età di dieci anni; di un’insegnante che non l’aveva creduta a
116 Le terapie energetiche
proposito di qualcosa; di alcuni episodi di taccheggio in cui era stata colta in flagrante e fatta sentire in colpa, senza però essere mai punita. Raccontò di provare rabbia nei confronti del marito senza alcun motivo apparente e riuscì a istituire un paragone tra questi sentimenti e il modo in cui si comportava sua madre con suo padre. Cercavo di scoprire dove stavamo andando, quale sarebbe stato il bersaglio successivo, ma non volevo ancora suggerirle la morte del figlio, pur sembran domi ovvio che lei evitasse tale bersaglio. Sentivo che sarebbe stato meglio aspettare per vedere se sarebbe scaturito spontaneamente dalla paziente, anzi ché forzare il processo. A questo punto mi pareva che stavamo un po’ girando su noi stessi. Poi lei portò delle questioni relative alla sessualità e all’intimità, al suo non voler essere toccata. Questo rifiuto di qualsiasi tipo di intimità stava procurando dei problemi a lei e al marito, ma questi era davvero stoico al ri guardo. Mi citò una lunga serie di terapie alle quali si era sottoposta prima del la morte del figlio. A questo punto decisi di prendere l’iniziativa e le chiesi se poteva essere il momento giusto per lavorare su quell’evento. Simone parve piuttosto sollevata che le avessi concretamente fatto questa proposta e accettò. Sapeva che affrontare quel tema avrebbe dato la stura a ogni sorta di proble ma, ma volle ugualmente lavorarci su. Nona seduta Cominciò col dirmi che negli ultimi tempi era stata assai depressa, che sentiva di aver vissuto il lutto come un tumore. L’elaborazione con I’emdr venne focalizzata sulla morte improvvisa del figlio per meningite, avvenuta diciotto anni prima; il ricordo bersaglio fu il momen to di lasciare l’ospedale senza di lui; la cognizione negativa: “Non starò mai più bene”; quella positiva: “Posso essere di nuovo felice” (punteggio voc di 2); co me emozione principale fu scelta la desolazione (punteggio sud di 8) e, come sensazione fisica, quella di un groppo in gola. UEMDR 1. Sono completamente sola. 2. Una parte del mio cuore è stata straziata. Intensa abreazione. 3. Come posso rimediare a questo? 4. Corro da una parte all’altra, come chi non trova risposte. 5. Devo prendermi cura di tutti... se fossi sola non sarei costretta a provare nessun sentimento. Che cosa ho fatto per meritare questo? Intensa abrea zione.
Trattamento con EMDR di una fobia di viaggiare
117
6. A questo punto ho smesso di cercare di scrivere qualcosa, dato che lo stato di angoscia di Simone era tale che non volevo lasciarla e mi sono concentrato esclusivamente su di lei. Non esisteva un modo adeguato difinire la seduta, co sì decidemmo, in via eccezionale, di continuare il giorno seguente. D ecim a sedu ta
La sera seguente continuammo dal punto in cui ci eravamo interrotti. Non riu scii a prendere appunti sui dettagli della seduta in quanto era praticamente im possibile disgiungere il dolore di Simone dall’elaborazione. Tra i problemi che emergevano c’erano molti insight, tantissimi pensieri sull’olocausto, temi legati ai genitori e al modo in cui l’avevano trattata, nonché moltissima intensa abreazione. In questa seduta riuscimmo a raggiungere una conclusione. U ndicesim a sedu ta
Ci incontrammo la settimana dopo. Simone sentiva che in lei era avvenuto un enorme cambiamento in meglio, ma giurava di non riuscire a ricordare esatta mente di cosa avessimo parlato la settimana precedente: dovetti ammettere che neanch’io ne ero capace! Avvertiva che aveva avuto luogo in lei un cambia mento colossale. La settimana era stata caotica, ma adesso si sentiva molto me glio. Si sentiva leggera e disse che anche i rapporti col marito erano mutati in modo straordinario. Durante la settimana gli aveva permesso di avvicinarsi e, abbattendo il muro che li teneva separati da quando era morto il figlio, era sta ta in grado di rispondere: si era trattato di un’esperienza molto positiva. Ora si sentiva molto più vicina a lui, sia fisicamente sia emotivamente, di quanto non lo fosse mai stata prima. Non aveva più paura che il figlio diciottenne, andan do via da casa per frequentare l’università, potesse lasciare un vuoto; mentre in precedenza questa prospettiva l’aveva terrorizzata. Mi spiegò che non si viveva più come una vittima. Avvertiva che le terapie precedenti, pur avendola aiutata a comprendere, non le avevano consentito di cambiare il modo di sentire, mentre stavolta era proprio questo che era mutato. Avvertiva di poter godere la vita e divertirsi senza dover sempre lavorare e giustificare la propria esisten za. Si rendeva conto che erano i suoi genitori i superstiti, e non lei. Poi Simone si rammentò, e mi fece ricordare, che aveva portato un’immagine del padre durante la marcia forzata dopo l’uscita dal lager: se in passato lei aveva avvertito la necessità di continuare a marciare, ora sentiva che non avrebbe più dovuto farlo. Mi fece un esempio del cambiamento che le era ca pitato: aveva partecipato a un corso di crescita personale, uno dei cui compiti consisteva nello sviluppare un programma di azione sociale. Lei aveva creato
118 Le terapie energetiche un progetto eccezionale, ma la differenza significativa era che, mentre in passa to si sarebbe sentita obbligata a fare tutto da sola, ora poteva delegare agli altri il lavoro. Simone aveva la sensazione di aver raggiunto gli angoli bui della propria men te. Le chiesi cosa provava quando parlava della morte del figlio, o ci pensava. Disse che per diciottenni aveva portato sulle spalle il peso del figlio, mentre ora poteva deporlo a terra. Mi fornì un altro esempio: la figlia che viveva in Ca lifornia stava per sposarsi e Simone aveva provato molta rabbia e risentimento perché la ragazza aveva organizzato tutto da sola senza coinvolgerla, ma ora improvvisamente si accorgeva che questo non aveva alcuna importanza e che poteva semplicemente gioire per le nozze. Ne era molto felice e riuscì a parla re con la figlia di molti argomenti cui prima non aveva mai fatto cenno, come la morte del bambino. Aveva la sensazione che ora le si presentava una vera e propria opportunità di cominciare a dipanare questioni irrisolte. Simone concluse che era avvenuto un cambiamento fondamentale, che non sa peva spiegare e neppure descrivere. A questo punto decidemmo insieme che eravamo arrivati proprio dove avevamo bisogno di arrivare e ponemmo termi ne al trattamento. Dati catamnestici Una catamnesi un anno dopo indicò che i risultati raggiunti durante la terapia e m d r si erano conservati. COMMENTO
Il lavoro di Sid Singer con Simone copriva un’area traumatica e psicodi namica molto ampia. I risultati erano chiari non solo in termini di risoluzio ne della fobia con cui la paziente si era presentata, ma anche di altri miglio ramenti in vari aspetti della vita. Una volta elaborato il trauma della scena sulla strada di montagna, successivo alla morte del figlio, Simone fu in gra do di viaggiare in macchina come passeggera senza provare angoscia. Ven ne poi elaborata la scena infantile connessa a quella e riguardante sempre una strada di montagna su cui la paziente aveva viaggiato in macchina con i genitori, nonché molto materiale che aveva a che fare con i loro atteggia menti critici verso di lei. Fu poi affrontata la rivalità con tendenze omicide nei confronti del fratello e, alla fine, il trauma centrale della morte del figlio. Né Simone né il terapeuta riuscirono a ricordare il contenuto di quella se duta emotivamente intensa, il che rispecchia forse l’operazione di adeguata rimozione e sta a indicare che il cambiamento positivo non dipende neces-
Trattamento con EMDR di una fobia di viaggiare
119
sanamente dall’insight. Il risultato fu che Simone si sentì meglio, libera da quell’angoscia disabilitante e capace di avere migliori rapporti col marito e con la figlia. Sentiva che era avvenuto in lei un cambiamento fondamentale e non le importava affatto di non saperlo né spiegare né descrivere!
7 Jane: e m d r e psicoterapia in una donna traumatizzata e vittima di violenza sessuale
Jane, olandese, di trentacinque anni, aveva un passato di tossicodipen denza e relazioni caotiche con uomini violenti. Per un breve periodo i tre fi gli le erano stati tolti e dati in affidamento, ma ora erano tornati a vivere con lei. Aveva cercato di instaurare uno stile di vita più ordinato, libero dal la droga, ma continuavano a tormentarla eventi traumatici del passato, ap partenenti al periodo in cui viveva in una zona di Amsterdam infestata da! crimine. Viveva quasi sempre nella paura e manifestava continui sintomi d: disturbo post-traumatico da stress. Uno degli aspetti che avevano caratte rizzato la sua infanzia era stato l’abuso sessuale da parte del fratello. Si erg sentita vicina alla madre, ma l’aveva percepita bisognosa e negligente. Col padre aveva avuto un rapporto distante e i genitori si erano separati quan do lei aveva quindici anni. Si era già fatta aiutare da un consulente, ripor tando qualche beneficio. Concordammo di procedere con qualche seduta di e m d r , che si sarebbe inizialmente concentrato sull’abuso sessuale per petrato dal fratello. LA STORIA GENERALE RIVELATA DALL’EMDR
Benché il racconto risultante dalle dieci sedute e m d r con Jane non fos se né semplice né lineare, la storia generale della sua vita emerse in mode molto chiaro, evidenziando come da piccola si fosse sentita trascurata e non protetta, disperatamente bisognosa dell’amore della madre, che pure aveva percepito come una persona manipolatrice e ‘volubile’. Il padre era state violento e terrorizzante. Il fratello aveva abusato sessualmente di lei. Anche le relazioni sessuali dell’adolescenza erano state violente e traumatiche, fa cendola diventare cinica e moralmente disordinata. Per bloccare la soffe renza emotiva e lo stress traumatico aveva fatto abbondante ricorso all’alcol e alle sostanze stupefacenti. La rabbia nei confronti della madre risultava
Jane: EMDR e psicoterapia in una donna traumatizzata
121
un tema ricorrente. Jane riuscì anche a riferire (a quanto pare in modo più diretto di quanto avesse mai fatto prima) specifici episodi violenti e trauma tici, provando sollievo nel momento in cui le emozioni venivano sottoposte ad abreazione mediante i movimenti oculari. La sua consapevolezza della funzione difensiva dell’uso smodato di alcol e sostanze stupefacenti diven ne più chiara grazie all’EMDR. SC HEMA DELLE T R A S C R I Z I O N I DELLE SE D U T E
La trascrizione parola per parola dei discorsi della cliente viene riportata senza virgolette. Le sintesi sono in parentesi tonde. Il discorso diretto del terapeuta, in parentesi quadre. Prima seduta (Quando, nella fase iniziale dell’EMDR, chiesi a Jane di pensare a un ‘luogo si curo’, ammise che i movimenti oculari la rilassavano, ma, con tristezza e tra le lacrime, disse di aver perduto il senso della sicurezza; l’unica sicurezza che un tempo aveva avvertito era quella fornitale dalle sostanze stupefacenti, che le to glievano ogni sensazione. Parlando dell’infanzia, riferì di aver provato confu sione, di aver cercato di essere una ‘brava bambina’ e di essersi sentita al sicu ro vicino alla madre, mentre il padre le incuteva spavento. Ricordò che lui pic chiava tutti e tre i figli, anziché scoprire chi aveva effettivamente commesso una trasgressione. Descrisse anche un episodio, accaduto quando lei aveva sei anni, in cui il padre le aveva “fatto fare tutta la strada a calci”).
Jane continuò: 1. Provo una grande rabbia... poi una grande paura... ho un senso di vomito nello stomaco... e provo vergogna e imbarazzo... vorrei nascondermi... come se avessi fatto qualcosa di terribile... e una certa tristezza. 2. Sto pensando: “Dov’è mia mamma?”. Sono arrabbiata con lei adesso... tutto ciò che riesco a ricordare è la violenza di mio papà... perché non l’ha fatto a mia sorella?... Sento proprio che quello che faceva era sbagliato... mi fa arrab biare... vorrei poter tornare indietro e dire: “Va’ al diavolo e toglimi le mani di dosso”... non sapevo che cosa avevo fatto... era proprio un prepotente. 3. Sono arrabbiatissima... mi ricordo che andammo a fare una passeggiata... per raccogliere mirtilli... non mi ha mai considerato molto, ma io cercavo di trovare tanti mirtilli per farmi notare... però non ottenevo mai la sua appro vazione... lui preferiva mia sorella.
122 Le terapie energetiche
4. Mi sono ricordata di quando sui dodici anni andai a un matrimonio con mia mamma... e mi ubriacai perché mio zio continuava a comprarmi da bere... avevo un vestito comprato da “Amsterdam Girl”... poi mi ricordo di esser mi sdraiata su un letto a guardare la televisione... nessuno si curava di me... poi ho pensato che papà stava picchiando mio fratello col bastone... lo sen tivo gridare... ero veramente impaurita e confusa... in piedi fuori della came ra da letto. 5. Non volevo essere lasciata lì senza la mamma... piangevo se lei non c’era... mi prendeva il panico. Ricordo quando i miei genitori partirono per le va canze... io avevo dodici anni... mi avevano affidato a mio fratello... lui aveva sedici anni... mi terrorizzava... mi urlava in faccia e mi picchiava... in casa c’erano sempre amici suoi e di mia sorella, che bevevano... giocavano con una di quelle tavole usate per lo spiritismo... un fantasma disse che mi avrebbe stuprato nel letto... era davvero spaventoso... un manicomio... dopo di allora per me fu come se l’infanzia fosse finita e non potessi più tornare indietro... eppure mi sento ancora come una bambina. Commento Qui Jane esplora il trauma infantile, riferendolo alla paura suscitata dalla brutalità del padre, al desiderio di essere speciale per lui e alla sensazione di non essere protetta, ma abbandonata in balia del fratello violentatore. Seconda seduta 1. Sono in uno stato... mi sto comportando bene, ma mi accorgo di non vivere pienamente... dietro ogni cosa c’è la paura... sono arrabbiata... ma questa settimana ho provato anche tanta gioia e ho smesso di fumare. Mi sono sen tita molto critica nei confronti altrui, ma anche piena d’amore verso i miei bambini, specialmente verso il maschietto... adoro stare con loro... mi sento molto più reale... e la paura di perderli è diminuita... ho la sensazione di es sere migliorata come madre... e avverto che con loro c’è un grande legame... non lo avevo mai permesso prima. 2. Ho provato tristezza... poi rabbia... come se fossi una persona debole... co me posso aver lasciato che accadesse... specialmente con i bambini... mi sen to così debole e stupida. In tutta la mia vita, ogni volta che le persone mi hanno mostrato un briciolo di interesse o di attenzione, mi sono fidata di lo ro... questo mi fa sentire debolissima... ho solo cercato di essere voluta... so no stata un camaleonte che si adattava e basta... ma sono delusa di mia ma dre... non è stata capace di darmi amore e protezione... adesso sono più con-
]ane: EMDR e psicoterapia in una donna traumatizzata
123
sapevole dei miei bisogni... sto proprio cercando di comportarmi bene, do po aver agito così male... sto passando all’estremo opposto... ma per ferma re la paura adesso non c’è nulla che potrebbe funzionare... nessuna droga, nessuna persona, nessun luogo... venire qui è l’ultima speranza... ho paura di venire qui... e se non funzionasse?... ho bisogno di riscoprire il senso di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. 3. È strano... ho sentito la mancanza di mio fratello... ho telefonato a mia sorel la e lei mi ha detto che lui era andato a trovarla... proprio nel momento in cui sentivo la sua mancanza... non riesco a capirlo... lo odio... Mi stavo chie dendo come è diventato... è stato il mio primo persecutore... mi dispiace per lui... mi dispiace per me. 4. Mi dispiace proprio tanto per lui... ricordo che una volta mia madre lo ha sbattuto sul cofano di una macchina e gli ha dato dei gran calci, perché ave va perso le chiavi o qualcos’altro... ma quando è cresciuto non è stata mai più in grado di tenergli testa... sembra tutto un po’ malato... lui la manipola va e lei lo lasciava fare... sono molto arrabbiata con mia mamma... la mia te sta e il mio stomaco stanno dicendo cose diverse... la testa dice che lei non ce la faceva, che aveva le sue difficoltà... ma lei manipolava molto noi tutti... sempre questi segreti... “non dirlo a tuo padre”... ma ho avuto anche un sen so di nausea nello stomaco riguardo a mio fratello. 5. (Lacrime di angoscia) Mi sento male... non riesco ad aprire gli occhi... come se stesse per accadere qualcosa di male... mi sento così in imbarazzo... non riesco a dirlo... mi sento male... lui sta facendo sesso orale con me... non posso pensare che lui mi faccia fare questo... che si faccia masturbare da me... non capivo perché era bagnato. 6. Non riuscivo a dirlo a mia madre... avrebbe detto che era colpa mia... ho la sensazione di aver fatto qualcosa di male... voglio nascondermi... provo una tale vergogna... mi sento spaventata, piena di vergogna e cattiva... non c’è nessun posto dove scappare... sto per svenire... accadrà qualcosa di male se lo dirò... lui ha un fucile giocattolo... mi sparava al sedere con pallottole di plastica... me lo faceva fare a lui... e cercava di mettere il suo pene dentro di me, ma non era abbastanza rigido... è tutto buio e freddo... sento che lui di ce: “Non dirlo a nessuno”... io penso che lui mi ha messo un dito dentro... chiedendo se mi faceva piacere... facendosi masturbare da me... 7. (Rilassamento) Mi sento un po’ triste... ma fiduciosa... mi sento sollevata... Non sono mai riuscita a parlare di questo prima... vorrei arrivare all’inizio del ricordo e poi ci metterei una pietra sopra... il tetto non è crollato... tu non sei corso fuori gridando!
124 Le terapie energetiche Commento A questo punto Jane comincia a parlare dei suoi rimpianti per aver p re| so la droga e della sua ricerca di amore e attenzione che l’ha portata act adottare uno stile di vita camaleontico e a venire a patti con la sua onestà! Da questo momento in poi i suoi pensieri si spostano sul fratello e poi sii un ricordo piuttosto specifico dell'abuso sessuale subito. Dopo aver elaboi rato tale ricordo, la paziente riferisce di provare tristezza, ma anche sollie^ vo e speranza. Terza seduta
(Jane riferì che, dopo Tultima seduta, si era sentita “veramente felice”, più fidu4 ciosa e assertiva, con un maggior senso del proprio valore e una minore preoo| cupazione del rifiuto altrui. Tuttavia accennò anche a sentimenti di panico pro-> vati in presenza di una donna piuttosto minacciosa che le aveva ricordato il ge-; nere di persone cui si era accompagnata durante il suo traumatico passato). L ’EMDR
1. [Vedi solo cosa ti viene in mente] Provo rabbia... non per qualcosa... la sen to e basta... nello stomaco. 2. [Cerca di domandarti riguardo a cosa sei arrabbiata] Sono proprio una vi gliacca... sono arrabbiata con me stessa... non so difendere i miei diritti per ché ho paura di affrontare chiunque... proprio una buona a nulla. È sbaglia to non amare lo scontro? È normale aver paura se si pensa che gli altri ci fa ranno del male. 3. Ho paura per i miei bambini... mi preoccupa terribilmente il pensiero che qualcuno possa fargli del male... desidero solo che crescano sani e sicuri di sé, non come me... desidero con tutte le mie forze che abbiano una mamma e un papà che vivono insieme... ho il terrore che ci sia in me qualcosa... non so cosa. 4. Sto pensando a mia mamma... come se volessi proteggerla... è così debole... così stupida... se ne scappa. Io lascio che mio padre faccia il prepotente con me... e lui fa il prepotente con lei... poi lei se la prende con me. 5. È così egoista. Lo so che le importa... ma non è capace di prendersi cura di noi... è lei che ha bisogno della nostra attenzione, del nostro amore... provo imbarazzo quando mi dà un bacio... lei si impadronisce di tutto... rifiuta, soffoca, poi rifiuta di nuovo... critica chiunque... non si prende nessuna re sponsabilità.
Jane: EMDR e psicoterapia in una donna traumatizzata
125
6. È una povera snob... se fossi malata lei sarebbe felice... mi coccolerebbe, poi mi abbandonerebbe. Papà diceva di odiarmi perché lei mi coccolava... lei è una povera vittima. Non riesco a essere arrabbiata con lei perché provo di spiacere per lei... è così manipolatrice... mi sento così lacerata perché sento ancora di volermi prendere cura di lei... la vedo come una bambina piccola che ha ancora bisogno di essere accudita... vorrei proprio che andasse al dia volo... lei fa solo finta che le importi. Poteva sembrare sempre tanto buona perché mio padre era orribile. Dormivo sempre con mia madre... ma mi sen to proprio come se fossi solo un giocattolo col quale lei può divertirsi e met tere da una parte quando trova un tizio che le va a genio. Non sa affrontare niente. Sento di aver fatto come lei... lasciare che gli uomini avessero potere su di me. Più cerco di darmi da fare per i miei bambini, più mi accorgo di quello che lei non ha fatto. Sono arrabbiata, ma anche divisa in due... le vo glio ancora bene. 7. Ho paura di arrabbiarmi troppo. Lei mi getta addosso queste critiche. Fa finta di essere la mamma che io vorrei... ma quando mi fa le coccole non lo sopporto... eppure una parte di me desidera ardentemente un abbraccio. Mi ha detto troppo... mi ha trattato come una persona adulta... non ho mai po tuto fare la figlia con lei. 8. (Ride) Stavo pensando a qualcosa che ha detto papà l’altro giorno... su mia madre, che è molto volubile. Ora, quando ci penso, mi sento bene. È quan do divento una bambina bisognosa delle cure dei genitori che provo dolore. Lei è proprio come una bambina... sono io che devo badare a lei. Vorrei tanto che fosse come vorrei... ma non lo è. Commento
In questa seduta, Jane parla della propria rabbia nei confronti della ma dre, dalla quale si è sentita non protetta, manipolata e sfruttata. Riconosce il proprio desiderio dell’amore materno. Alla fine della seduta, dopo nume rose serie di movimenti oculari, il suo stato d’animo è più leggero. Quarta seduta
Ho parlato con mia madre... ho tirato fuori molta rabbia... ho cercato di farla sentire una nullità... poi ci siamo riconciliate. Non mi sento più danneggiata dall’abuso sessuale... ma provo una certa vergogna per alcune cose della mia vita adulta... mi sento triste per come è andata la mia vita... ma sto anche ap prezzando le cose positive... è una nuova, strana sensazione... non ci sono abi tuata... una volta passavo da un estremo all’altro: stavo o benissimo o malissi-
126 Le terapie energetiche
mo... avevo difficoltà ad accettare quello che provavo senza cercare di cani biado... forse dipende dall’uso della droga... sembra strano provare questi seri timenti negativi, soprattutto la tristezza, e nello stesso tempo sentirsi bene. (P parlare in pubblico. A seguito del trattamento è stata riscontrata una so stanziale riduzione dell’ansia (riferito in Hartung e Galvin, 2003). Carbonell e colleghi hanno condotto una ricerca in doppio cieco rando mizzata, confrontando la TFT con un trattamento placebo in cui i soggett effettuavano il ta p p in g sui punti non utilizzati nella vera TFT. I soggetti ir condizione TFT autentica hanno manifestato miglioramenti di gran lung} superiori a quelli del gruppo placebo. Questo studio non è stato ancon pubblicato, ma se ne può trovare una sintesi consultando il sito www.tf trx.com/ref/articles/6heights.html. RICERCHE SULLA VALIDITÀ DELLA VERIFICA MUSCOLARE QUALE MEZZO PER EFFETTUARE I CONTROLLI DELL'ENERGIA
Anche se la verifica muscolare contiene di per sé elementi soggettivi t può essere soggetta a una varietà di influenze, come la suggestione, un cer to numero di studi ne sostiene l’essenziale validità. Monti, Sinnott, Marche se, Kunkel e Greeson (1999) hanno utilizzato il dinamometro computerà zato per dimostrare che, in un gruppo di ottantanove soggetti, esistevan< differenze altamente significative nella forza muscolare a seconda che li persona facesse un’affermazione congruente (ossia, vera), anziché una in congruente. Due ricerche hanno dimostrato una significativa attendibile? intraesaminatoria della verifica muscolare (Caruso e Leisman, 2000; Lawson e Calderon, 1997). Parecchi altri hanno rivelato differenze nell’attività elettrica dei muscoli come prova della loro debolezza o della loro forza e che tali differenze non erano attribuibili a semplice affaticamento (per esempio Leisman, 1995; Leisman, Shambaugh e Ferentz, 1989; Perot, Meldener e Gouble, 1991). Schmitt e Leisman (1998) hanno riscontrato un eie-
Le conclusioni cui è giunta la ricerca 245 vato grado di correlazione tra la verifica muscolare per le allergie e la pre senza di anticorpi (sieroimmunoglobuline) per i cibi identificati allergenici da questa procedura. Nondimeno, la verifica muscolare dovrebbe essere chiaramente usata solo come guida e non come tecnica infallibile. RICERCHE RELATIVE AI MERIDIANI E ALL’ENERGIA SOTTILE
L’agopuntura, da cui i metodi psicoenergetici sono in parte derivati, è stata ampiamente studiata (Stux e Pomeranx, 1995) e diffusamente accetta ta quale utile ed efficace trattamento di molte patologie: è approvata, per esempio, dal National Institute of Health degli Stati Uniti, che elenca più di cento malattie che possono trovare sollievo con essa (n i h , 1997). I punti cutanei specifici che vengono stimolati durante l’agopressione e il tapping energetico, rispetto ad altri punti, mostrano differenze nella resi stenza elettrica (Becker, 1990; Bergsman e Woolley-Hart, 1973; Cho, 1998; Cho e Chung, 1994; Liboff, 1997; Syldona e Rein, 1999): le linee meridiane che collegano i punti di agopressione hanno una diversa resistenza elettrica in confronto ad altre parti della pelle.4 Vari studi, utilizzando le tecniche di scansione cerebrale, hanno dimostrato che alla stimolazione di specifici punti di agopressione sono associati cambiamenti nella funzione di varie parti del cervello (Cho, 1998; Darras, 1993; Hui, 2000, Omura, 1989, 1990). La stimolazione dei punti di agopressione provoca il rilascio di peptidi oppioidi (Swack, 2001). Ulteriori prove dell’esistenza dei meridiani so no state fornite dal ricercatore francese Pierre De Vernejoul, che ha inietta to isotopi radioattivi nei punti di agopuntura, scoprendo che il loro movi mento corrispondeva ai percorsi meridiani; non c’era alcun flusso significa tivo quando gli isotopi venivano iniettati in altri punti scelti a caso (De Ver nejoul, 1985), anche se qualcuno ha sostenuto che l’autore francese in realtà stava indagando il sistema linfatico (Stux e Pomeranx, 1995). Lo scienziato russo Vladimir Zagriadskii ha scoperto che una tenue luce laser poteva esser condotta lungo percorsi corrispondenti ai meridiani; giungen do alla conclusione che questi ultimi sono superconduttori, ha costruito un dispositivo elettrico per individuare e ottimizzare l’attività all’interno dei meridiani, dispositivo utilizzato in seguito con successo per sostenere la sa lute dei cosmonauti in viaggio verso la stazione spaziale Mir (Narvaez, Roshmann e Stegenda, 2002). Prove a sostegno dell’esistenza del sistema dei chakra sono state fornite da Pert (1999,2000), il quale riferisce di aver sco perto alte concentrazioni di neuropeptidi nelle sedi dei primi sei chakra principali. II radiologo Bjorn Nordenstrom (1983) ha dimostrato che i tessuti cor porei si polarizzano e intercollegano attraverso sottili correnti bioelettriche,
246 Le terapie energetiche mentre Becker e Seiden (1985) hanno riferito di ricerche in base alle quali si può ipotizzare resistenza di un sistema energetico corporeo responsabile dell’organizzazione e della guarigione del corpo stesso. Similmente, gli scritti del biologo Rupert Sheldrake (1985,1988,1999) presentano un gran numero di prove dell’esistenza di un campo morfogenetico organizzante, recante un progetto per il corpo, ma capace anche di imparare e di trasmet tere informazioni alle generazioni successive. Quest’idea di campo bioelet trico organizzante, o ‘campo L’, è stata esplorata anche nelle precedenti ri cerche di Burr (1972), il quale conclude: Fino al momento in cui i moderni strumenti non hanno rivelato l’esistenza dei campi L di controllo, i biologi erano a corto di spiegazioni circa il fenome no per cui i nostri corpi “si mantengono in forma” attraverso un incessante metabolismo e continui scambi di materiale: ora il mistero è stato risolto, il campo elettrodinamico del corpo ha la funzione di una matrice che continua a conservare la 'forma’ o l’adattamento di qualsiasi materiale riversatovi per quanto spesso il materiale venga cambiato (Burr, 1972, p. 13). L’intero settore di ricerca relativo all’energia biologica, e in particolare le emissioni di fotoni dei sistemi biologici e il loro ruolo di regolazione, viene discusso ampiamente da Marco Bischof (1995).5 La scoperta e la misurazione dei campi di energia sottile del corpo ven gono discusse approfonditamente dal fisico della Stanford University Wil liam Tiller (Tiller, 1997). Tali campi di energia sembrano avere qualche so miglianza con i campi magnetici tradizionali, ma sotto altri aspetti differir ne. Per esempio Justa Smith del Rosary Hill College di New York ha sco perto che sia i campi magnetici tradizionali di elevata intensità sia i campi di energia sottile dei guaritori accelerano in maniera consistente l’attività degli enzimi; ma non è stato possibile scoprire nessuna significativa attività magnetica intorno alle mani dei guaritori utilizzando un magnetometro standard (riferito in Gerber, 2000, p. 326).
12 Le esperienze personali di due terapeuti
1. ATTENTI AL VUOTO: TERAPIA TRADIZIONALE E TERAPIA EMDR NELL’ESPERIENZA DI UNO PSICOTERAPEUTA ANALITICO
L'autore di questo libro mi ha chiesto un caso clinico, tratto dalle mie esperienze di terapia analitica, che possa mettere in luce le differenze tra questa e I' e m d r . Offrirò una rassegna dei problemi esplorati nella terapia analitica, illustrerò Timpano delTinterpretazione sui problemi di presenta zione ed evidenzierò la differenza di approccio della terapia e m d r . Sono arrivato alla terapia e m d r attraverso il lavoro con Phil Mollon nelTambito del servizio sanitario nazionale. Ho presenziato a parecchie sedute e m d r e sono rimasto colpito dalla velocità con cui venivano elaborati e mi gliorati profondi problemi di presentazione come il disturbo ossessivo-compulsivo. Ho raggiunto il livello 1 e il livello intermedio della formazione e m d r , ma ho percepito che, se volevo integrare questa terapia nella mia pratica analitica, dovevo sperimentarla su me stesso. È stato determinante anche un altro elemento: poiché la terapia tradizionale mi aveva già dato molta autoconsapevolezza, la ‘cartina di tornasole' del funzionamento dell’EMDR sarebbe stata vederlo all’opera su quelle aree del mio mondo in teriore che avevano ancora bisogno di essere elaborate. La mia storia Negli ultimi sette anni sono stato in terapia analitica, fino a poco tempo fa con una frequenza di due o tre sedute alla settimana. I principali proble mi esplorati sono stati una relazione insicura con mia madre, fonte di com plicazioni nella prima infanzia, peggiorata da una figura paterna marginale. All'età di cinque anni, questi problemi hanno raggiunto un punto di crisi,
248 Le terapie energetiche allorché ho cominciato a frequentare la scuola materna. Avevo avuto poche occasioni di stare insieme ad altri bambini lontano dall’ambiente domesti co. In parte ciò era dovuto alle gravi malattie di mia sorella (maggiore di me di otto anni) che rischiava continuamente di morire. Ho il sospetto che mia madre fosse traumatizzata da questa esperienza e volesse tenermi vicino a lei, al sicuro dai pericoli. Inevitabilmente, introiettai la sua ansia verso quel lo che lei percepiva come il pericoloso mondo esterno. Somatizzando la mia ansia, attraversai un periodo di circa diciotto mesi durante il quale, la notte, dopo un sogno ricorrente, vomitavo. Suggerirei che i miei problemi potrebbero essere visti dal punto di vista winnicottiano della compiacenza. Mia madre era orgogliosa che tra noi la comunicazione verbale non era necessaria, in quanto io rispondevo a ogni sua alzata di ciglio. Ricordo anche che mi hanno detto che, da piccolo, al l’inizio della giornata mi faceva indossare un vestitino bianco e che questo vestitino rimaneva nelle condizioni originarie fino a sera. Il problema della relazione insicura e della compiacenza hanno inevita bilmente caratterizzato le mie relazioni adulte. La terapia tradizionale
Gran parte del mio primo lavoro nella terapia analitica era legata alle caute interpretazioni del terapeuta che, usando la teoria delle relazioni og gettuali, metteva in luce la scissione tra bene e male che si creava nelle mie relazioni contemporanee. Cominciai a capire come le relazioni esterne fos sero influenzate e deviate dal mio mondo interiore. Il sogno ricorrente del l’infanzia, per esempio, venne esplorato e considerato simbolicamente co me un modo di espellere fisicamente i cattivi sentimenti attraverso il vomi to. Vennero anche esplorati la rabbia e i sentimenti di vergogna. Sebbene riuscissi a raggiungere una notevole comprensione del mio mondo interio re, mi rendevo anche conto che le relazioni chiave della mia vita non veni vano trasformate da queste intuizioni. I miei sentimenti, e specialmente la rabbia, ovvero il contrario della compiacenza, come suggerisce Winnicott, restavano potenti come sempre. Nondimeno, ero riuscito a capire e a speri mentare il dolore emotivo come ci si aspetta che avvenga quando ci si sot topone alla terapia tradizionale. La terapia EMDR
Quando l’elaborazione em dr cominciò, mi fu chiesto di fornire un ri cordo bersaglio. Scelsi un episodio dell’infanzia, risalente agli otto anni, in
Le esperienze personali di due terapeuti 249 cui mia madre si era molto arrabbiata con me perché avevo rovinato un paio di scarpe nuove e aveva minacciato di mandarmi in collegio. Una volta cominciata l’elaborazione emdr con la stimolazione bilaterale (movimenti oculari e suono), rimasi colpito da come essa favorisse una forma diversa e più potente di associazioni libere. Era come se i miei sentimenti venissero immediatamente liberati attraverso immagini che si presentavano alla men te, al posto delle più strutturate parole della terapia tradizionale. Il terapeu ta emdr era più un agevolato re del processo che non un interprete del flus so di materiale. Venivo incoraggiato a sperimentare qualsiasi immagine mentale o sensazione corporea entrasse nella mia coscienza. Descriverei questo fenomeno come 'stato del sé em d r\ Per amore di brevità, conden serò un certo numero di sedute dedicate al tema delle scarpe rovinate. Ini zialmente cominciai a provare lo stesso senso di impotenza e la stessa soffe renza del bambino di otto anni. Questa sensazione a poco a poco si tra sformò, allorché mi si presentò l’immagine di me stesso adulto accanto a me stesso bambino. Fu come se il mio sé adulto confortasse e proteggesse il bambino. Questa esperienza mi colpì sotto molti aspetti, in quanto mi tro vavo in uno stato del sé in cui cominciavo a nutrire il bambino interiore. Se guendo sensazioni corporee come un dolore nel torace, le mie immagini mentali si trasformarono fino al punto in cui il mio sé adulto divenne attivo nella produzione di immagini e portò il mio sé bambino a vivere nella mia casa attuale. Di quella seduta riesco a ricordare un'immagine in cui condu cevo il mio sé bambino fuori dal luogo di profonda infelicità del mio am biente infantile. Durante una seduta successiva, ci fu un periodo in cui non ebbe luogo nessuna produzione di immagini e io, effettuando un gran numero di serie di movimenti oculari, avvertii un acuto dolore al collo. A livello intellet tuale e conoscendo la teoria analitica, sapevo che dentro di me albergava una rabbia profonda. Anche se nella terapia tradizionale avevo esplorato tale rabbia, l’intensità di ciò che cominciai a sperimentare in quell’occasio ne mi sconvolse. Infatti visualizzai la rabbia come l’emergere di uno stato del sé paragonabile al Mister Hyde del film con Spencer Tracy. Avevo lo calizzato una parte di me consumata dalla rabbia, ma anche torturata dal dolore fisico. Il mio lavoro attuale nella terapia emdr riguarda la rabbia, l’instaurazio ne di un dialogo con questo stato del sé e la sua integrazione nel tutto. Ho anche cominciato a capire che, insieme alla rabbia repressa, sono stati im prigionati alcuni aspetti della mia mascolinità e, di conseguenza, della mia autostima. Richard H. J. Reeves Psicoterapeuta analitico
250 Le terapie energetiche 2. IL VIAGGIO DI BAYA PER DIMAGRIRE CON L’EFT
Mentre si allontanava dal bancone della reception, una delle segretarie esclamò: "Ma tu sei dimagrita! Che dieta hai seguito?”. “Il cibo non c’en tra”, rispose andandosene. Di colpo si fermò; qualcosa in lei cominciò a esultare: è vero, il cibo non c’entra per niente... Undici anni di terapie, anfetamine, ginnastica, diete... nulla aveva funzio nato. Aveva preso a pugni i cuscini, incolpato sua madre, frequentato corsi di formazione, riflettuto su come perdere peso; aveva danzato, cantato, ur lato, pregato... nulla. Aveva mangiato sempre di meno, ma non era accadu to niente. Un milione di voci nella testa: “È questione di forza di volontà”; "È un problema ereditario”; “Sei allergica ai cereali”; “Hai perso per sem pre la tua occasione”; “Il tuo sistema di regolazione dell’appetito è sfasato”; “Traumi infantili”; “Violenza emotiva”; “Stai barando”; “E impossibile”. Due anni prima aveva cambiato di nuovo dieta, attratta dal titolo diver tente di un libro: l’aveva seguita, con risultati più o meno pietosi, tuttavia era riuscita a non salire di peso. Chi la invitava a cena fuori, invece di chiederle l’elenco dei cibi proibiti, le chiedeva cosa poteva mangiare, si faceva prima. Poi, a un certo punto, saltò fuori I’e f t . Un mucchio di sciocchezze, pen sò, appigliandosi alla sua storia, ai vecchi rancori, alle antiche rabbie che nemmeno sospettava fossero appiattate nelle pieghe del suo inconscio. In fondo tutto questo materiale era stato “tirato fuori in terapia”. Aveva recu perato frammenti di infanzia e capito perché lei era così. Aveva ‘accettato’ di essere così. Era stata rovinata e non poteva farci nulla. Nell’insieme, tutto sommato, era sempre meglio una taglia ‘large’ che una ‘extra-large’, visto che era quello tutto ciò a cui poteva aspirare. Si era fatta i conti e aveva chiuso la questione. Poi, però, subentrò la curiosità. C’erano articoli sulla possibilità di solle citare il metabolismo mediante I’e f t , e anche informazioni sul rovescia mento psicologico e sulle ‘scelte’. Sapeva che non avrebbe funzionato: non era mai successo. Mettersi a tamburellare sul proprio corpo le sembrava una cosa da perfetti idioti, perciò se lo fece fare da un’amica. Ci vollero venti minuti per ripercorrere undici anni di terapia. I senti menti di rabbia, tristezza e paura cerano ancora, potenti come sempre. Ri cordò tutto: di essere stata prima nutrita in base a una tabella e lasciata a piangere disperata, poi di essere stata forzata a mangiare, e ancora di aver gustato in segreto con l’amato papà frutti proibiti; poi la rabbia furibonda verso la madre ossessionata dal peso, il messaggio che il suo destino era es sere grassa, pigra e sciatta; si rese conto di non essere stata grassa all’inizio, finendo per giungere all’orribile constatazione che forse il suo rifiuto di per dere peso era l’inconscio desiderio di punire la madre... Tutti questi fattori erano fermamente collegati insieme, una successione di eventi, decisioni e
L e esperienze personali d i due terapeu ti
251
dilemmi. Finalmente arrivò al punto più importante: accettare che era stata lei a rifiutare di dimagrire, che la sua mente e il suo corpo semplicemente non lo volevano fare. Da qualche parte, una matassa rimasta imbrogliata per quarantasette anni cominciava lentamente a dipanarsi. Correnti di ener gia cominciarono a rifluire per tutto il corpo. All'interno del cervello vie neurali si ricollegarono. Niente lacrime, nessun isterismo, il dolore scom parve, i ricordi, svuotati del contenuto emotivo, divennero quello che era no... ricordi, album di fotografie riposti negli armadi del passato... Il giorno dopo si sedette per fare colazione. Dimentica della seduta del giorno precedente, mangiò un uovo. Punto. Non riusciva a mangiare più niente. Si disse: “Strano! ”, poi non ci pensò più. Durante il resto della gior nata mangiò qualche boccone, non molto. Il suo appetito si era ricollegato all'atteggiamento alimentare che aveva avuto da neonata: dicevano che “fa ceva storie per mangiare”, ma in realtà era un tipo ‘esigente', ben consape vole di ciò di cui il suo corpo e la sua anima avevano bisogno. Quel senso di consapevolezza era, misteriosamente, ritornato. Attese che sparisse. I colle ghi cominciarono a commentare il suo cambiamento di aspetto. In palestra se ne accorsero. Aspettò ancora che sparisse... e sparì. Tuttavia ricordava quel momento in cui si era sentita responsabile del cambiamento come un periodo così buono che decise di tornare all’EFT e dedusse che ‘quella consapevolezza’ era sparita perché lei aveva voluto che sparisse: a livello profondo, infatti, non era stata pronta a lasciar andare tut ti i ricordi e le emozioni che avevano per tanto tempo fatto parte del suo sé. Ora lo ammetteva. Non aveva mai scoperto esattamente quali fossero que sti ricordi, non era necessario. Quello che importava era che il suo corpo ti rava un sospiro di sollievo e ricominciava a scegliere. Si aspetta ancora che la consapevolezza finisca. Lavoro in corso, lo chia ma. Fa ancora il ta p p in g e raggiunge qualche stupefacente constatazione. Come quando, per capriccio, decise di fare il ta p p in g su “Scelgo di pesare sessanta chili”: solo qualche giorno dopo capì che aveva perso il senso del la consapevolezza, che quello su cui stava effettuando il ta p p in g era il peso che la madre considerava ideale per lei... tossico. Continuò a lavorare e la consapevolezza ritornò. Dimentica, perde la strada e il senso di consapevolezza scompare e ancora c'è da fare un po' di tapping. Di tanto in tanto torna a essere ossessionata dal pensiero di non mangiare, o di quale cibo includere o escludere dalla dieta, della quantità o della qualità di cibo ingerito il giorno prima, ma ogni volta, finora, è riuscita a ritornare al principio... non è una questione di cibo... Baya Sa l m o n -H awk
Bibliografia
A llen , J.
G. (2001), Traumatic Relationships and Serious Mental Disorders, Wiley, Chichester. A nd ra de , J. e F ein ste in , D. (2001), “Energy psychology. Theory, indications, evi dence”, disponibile tramite il sito www.innersource.net; se ne può leggere una re lazione consultando il sito www.energypsich.org; pubblicato anche in D. Fein stem (2004), Energy Psychology Interactive. Rapid Interventions for Lasting Chan ge, Innersource, Ashland, OR. A n d r a d e , J., Kav an ag h , D. e Baddeley , A. (1997), “Eye-movement and visual imagery: a working memory approach to the treatment of post-traumatic stress disorder”, British Journal of Clinical Psychology, 36:209-223. A n t r o bu s , J. S. e S ing er , J. L. (1964), “Eye movements Accompanying daydrea ming, visual imagery, and thought suppression”, Journal of Abnormal and Social Psychology, 69: 244-252. A postolopoulos , A. e Karavi, M. (1996), “Overeating: treatment of obesity and anxiety by auricular acupuncture. An analysis of 800 cases”, Acupuncture in Me dicine, 14: estratto, disponibile tramite il sito http://www.medical-acupuncture.co.uk/journal/novl996/eleven/shtml. A rlow , J. S. (2002), “Transference as defence”, Journal of the American Psychoa nalytic Association, 50(4): 1139-1150. A rm stro ng , M. S. e V a u g h a n , K. (1996), “An orienting response model of eye movement desensitisation”, Journal of Behavior Therapy and Experimental Psy chiatry, 27: 21-32. Ba l in t , M. (1968), “Il difetto fondamentale”, in La regressione, Cortina, Milano 1983. Barrowcliff , A. L., M ac C ullo ch , M. J. e G ray, N. S. (2001), “The de-arousal model of eye movement desensitisation and reprocessing ( em d r ), Part III: Psychophysiological and psychological concomitants of change in the treatment of post-traumatic stress disorder ( pt sd ) and their relation to the em d r protocol”, documento presentato al secondo convegno annuale dell’Europa em d r , Londra. Barrow cliff , A. L., G ray, N. S., F reem an , T. C. A. e M ac C u l lo c h , M. J. (2004), “Eye movements reduce the vividness, emotional valence and electroder-
Bibliografia 253 mal arousal associated with negative autobiographical memories”, proposto per la pubblicazione. Disponibile presso: Alastair Barrowcliff, School of Psychiatry and Behavioural Sciences, Dept. Of Clinical Psychology, Wythenshawe Hospital, Manchester, M2391T. Becker, L. A., Todd-O verm an, A., S to o t h o f f , W. e Law son, T. (1998), “Iro nic memory, PTSD and EMDR: do eye movements hinder the avoidance process leading to greater accessibility of traumatic memories?”, documento presentato al convegno annuale dell’Associazione Internazionale e m d r , luglio, Baltimora. Becker, R. O. (1990), Cross Currents, Plenum, New York. Becker, R. O. e S eld en , G. (1985), The Body Electric, Morrow, New York. B enor, D. (2002), “Self-healing: meridian-based therapies and em dr”, in W. Lammers e B. Kirchner (a cura di), The Energy Odyssey: New Directions in Energy Psychology, DragonRising, Eastbourne. Bergmann, U. (2000), “Further thoughts on the neurobiology of emdr: the role of the cerebellum in accelerated information processing”, Traumatology, VI(3): ot tobre, Articolo 4, http://www.fsu.edu/-trauma/v6i3a4.html. Bergsm an, O. e W o o lle y -H a r t, A. (1973), “Differences in electrical skin con ductivity between acupuncture points and adjacent areas”, American Journal of Acupuncture, 1: 27-32. Bion, W. R. (1970), Attenzione e Interpretazione: una prospettiva scientifica sulla psi coanalisi e sui gruppiyArmando, Roma 1973. B isc h o f, M. (1995), Biphotonon - das Licht in unseren Zellen, Zweitausendeins, Francoforte. Blum, H. P. (2003), “Repression, transference and reconstruction”, International Journal of Psychoanalysis, 84(3): 497-503. Bohm, D. e S h e ld r a k e , R. (1985), “Morphogenetic fields and the implicate or der”, in R. Sheldrake (a cura di), New Science of Life (seconda edizione), Blond, Londra. B o lla s, C. (1989), Forze del destino: psicoanalisi e idioma umano, Boria, Roma 1991. B o lla s, C. (2000), Isteria, Cortina, Milano 2001. B ordin, E. S. (1979), “The generalisability of the concept of the working alliance”, Psychotherapy, Research and Practice, 16: 252-260. Boudew yns, P. A. e H yer, L. A. (1996), “Eye movement desensitisation and re processing (emdr) as a treatment for post-traumatic stress disorder (ptsd)”. Cli nical Psychology and Psychotherapy, 3: 185-195. Breuer, J. e Freud, S. (1895), Studi sull’isteria, in Opere di S. Freud, vol. 1, Boringhieri, Torino 1967. B rew in, C. R. (2001), “A cognitive neuroscience account of posttraumatic stress disorder and its treatment”, Behaviour Research and Therapy, 39: 372-393. B rew in, C. R. (2003), Posttraumatic Stress Disorder, Yale University Press, New Haven, c t.
254 Bibliografia B r o w n , K.
W., M c G oldrick , T. e B uc h a n a n , R. (1997), “Body dysmorphic di sorder: Seven cases treated with eye movement desensitisation and reprocessing”, Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 25: 203-207. B u rr, H. S. (1972), Progetto per l’immortalità: una delle più importanti scoperte del secoloy MEB, Torino 1978. Callahan , R. J. (1981), “Psychological reversal”, documento presentato agli atti dell’incontro invernale dellTnternational College of Applied Kinesiology, Aca pulco, Messico. Callahan , R. J. (1987), “Successful treatment of phobias and anxiety by telephone and radio”, Collected Papers of the International College of applied Kinesiology, ICAK, Shawnee Mission, ks . Callahan , R. J. (1994), “The five minute phobia cure: a reproduible revolutionary experiment in psychology based upon the language of negative emotions”, docu mento presentato allTntemational Association for New Science, Fort Collins, Co lorado. Callahan , R. J. (con T r u bo , R.) (2001a), Tapping the Healer Within, Contempo rary Books, Chicago. Callahan , R. J. (2001b), “The impact of thought field therapy on heart rate varia bility”, Journal of Clinical Psychology, 57(10): 1153-1170. Callahan , R. J. (2001c), “Raising and lowering of heart rate variability. Some clini cal findings of thought field therapy”, Journal of Clinical Psychology, 57 (10): 1175-1186. Callahan , R. J. e Callahan , J. (1996), Thought Field Therapy and Trauma. Treat ment and Theoryypubblicato dall’autore, Indian Wells, ca. Carbonell , J. (1997), “An experimental study of TFT and acrophobia”, The Thou ght Field, 2: 1-6. Carlso n , J. G., C h e m t o b , C , R usnak , K., H e d l u n d , N. L. e M araoka , M. Y. (1998), “Eye movement desensitisation and reprocessing for combat-related po st-traumatic stress disorder”yJournal of Traumatic Stress, 11: 3-24. Carrington , P. (2001), How to Create Positive Choices in Energy Psychology: The Choices Training Manual, Pace Educational Systems, www.eftsuport.com. Carrington , P. e C raig , G. (2000), “A meridian-based intervention for the treat ment of trauma”, Journal of the International Society for the Study of Subtle Ener gies and Energy Medicine, agosto, 148-151. C arroll , R. (2003), “At the border between chaos and order: what psychothe rapy and neuroscience have in common”, in J. Corrigall e H. Wilkinson (a cura di), Revolutionary Connections. Psychotherapy and Neuroscience, Karnac, Lon dra. Caruso , B. e L eism a n , G. (2000), “A forced/displacement analysis of muscle te sting”, Perceptual and Motor Skills, 91: 683-692. Casement , P. (1985), Apprendere dal paziente, Cortina, Milano 1989. C erone , M. R. (2000), “em dr treatment of combat-related guilt: a study of the ef-
Bibliografia 255 fects of eye movements”, documento presentato all’incontro annuale dellTnternational Society for Traumatic Stress Studies, novembre, San Antonio, Texas. Chambless, D. L., Baker, M. J., Baucom, D. H., B e u tle r, L. E., C alh oun , K. S. e C rits-C h ristop h , P. (1998), “Update on empirically validated therapies”, II, The Clinical Psychologist, 51: 3-16. C hem tob, C. M., T o lin , D. F., van d e r K olk , B. A. e Pitm an, R. K. (2000), “Eye movement desensitisation and reprocessing”, in E. A. Foa, T. M. Keane e M. J. Friedman (a cura di), Effective Treatments for PTSD: Practice Guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies (pp. 139-155, pp. 333335), Literature Review, 139-155; Linee-guida al trattamento, 333-335. Chem tob, C. M., Nakashima, J., Hamada, R. S. e C arlson , J. G. (2002), “Brief treatment for elementary school children with disaster-related posttraumatic stress disorder. A field study”, journal of Clinical Psychology, 58: 99-112. C h ia r e llo , C. e R ichards, L. (1992), “Another look at categorical priming in the cerebral hemisphere”, Neuropsychologia, 30: 381-392. C ho, S. e C h u n g, S. (1994), “The basal electrical skin resistance of acupuncture points in normal subjects”, Yonsei Medical Journal, 35: 464-474. Cho , Z. H. (1998), “New findings of the correlation between acupoints and corre sponding brain cortices using functional MRi”, Proceedings of the National Aca demy of Sciences, 95: 2670-2673. C lin to n , A. N. (2002), Seemorg Matrix Work. Basic Manual (terza edizione), Energy Revolution Inc., Princetown, nj. C o n n o lly , M. B., C rits-C h ristop h , P., Shappell, S., Barber, J. P., Luborsky, L. e S h affer, C. (1999), “Relation of transference interpretations to outcome in the early sessions of brief supportive-expressive psychotherapy”. Psychotherapy Research, 9(4): 485-495. C o rtin a , M. e M arron e, M. (2003), Attachment Theory and the Psychoanalytic Process, Whurr, Londra. C ouch, A. S. (2002), “Extra-transference interpretation: a defence of classical tech nique”, The Psychoanalytic Study of the Child, 57: 63-92. C o u rto is, C. A. e B loom , S. L. (2000), “Inpatient treatment”, in E. B. Foa, T. M. Keane e M. J. Friedman (a cura di), Effective Treatments for PTSD. Practice Gui delines from the International Society for Traumatic Stress Studies, Guilford, New York. Crabbe, B. (1996), “Can eye movement therapy improve your riding?”, Dressage Today, novembre: 28-33. Dam asio, A. R. (1994), L'errore di Cartesio: emozione, ragione e cervello umano, Adelphi, Milano 1995. Damasio, A. R. (1999), Emozione e coscienza, Adelphi, Milano 2000. Darby, D. (2001), “The efficacy of thought field therapy as a treatment modality for individuals diagnosed with blood-injection-injury phobia”, tesi di dottorato non pubblicata, Walden University, Minnenapolis, mn.
256 Bibliografia D arras, J. C. (1993), “Nuclear medicine investigation of transmission of acupunc
ture information”, Acupuncture in Medicine: Journal of the British Medical Acu puncture Societyy 11(1): 22-28. Davidson, P. R. e Parker, K. C. H. (2001), “Eye movement desensitisation and reprocessing (emdr): a meta-analysis”, Journal of Consulting and Clinical Psycho logy, 69:305-316. D e Jongh , A. e Ten Broeke, E. (1998), “Treatment of choking phobia by targe ting traumatic memories with emdr: a case study”, Clinical Psychology and Psy chotherapy, 5: 264-269. D e Masi, F. (2003), "On the nature of intuitive and delusional thought”, Interna tional Journal of Psychoanalysis, 84(5): 1149-1169. De Vernejoul, P. (1985), “Etudes des meridians d’acupuncture par les traceurs radioactifs”, Bulletin de 1’Academie Nationale de Medicine, 169(7): 1071-1075. D ennison, P. e D ennison , G. E. (1994), Brain Gym. Teachers Edition, Edu-Kinesthetics Inc., Ventura, CA. D evilly, G. J. e Spence, S. H. (1999), “The relative efficacy and treatment distress of emdr and a cognitive behavioural trauma treatment protocol in the ameliora tion of post-traumatic stress disorder”, Journal of Anxiety Disorders, 13: 131-157. D iamond, J. (1979), Your Body Doesn't Lie. BK - Behavioral Kinesiology, Harper & Row, New York. D iamond, J. (1985), Life Energy, Dodd, Mead & Co., New York. D iamond, J. (1988), Life Energy Analysis. A Way to Cantillation, Archaeus, New York. D iepold, J. (2002), “Touch and Breathe”, in W. Lammers e B. Kircher (a cura di), The Energy Odyssey: New Directions in Energy Psychology, DragonRising, East bourne. D urlacher, J. V. (1995), Freedom from Fear Forever, Van Ness Publishing, Mesa, AZ. Dyck, M. J. (1993), “A proposal for a conditioning model of eye movement desen
sitisation treatment for posttraumatic stress disorder”, Journal of Behavior The rapy and Experimental Psychiatry, 24: 201-210. Eden, D. (1998), Medicina energetica. Riequilibrare le energie del corpo per ritrovare salute, gioia e vitalità, Tecniche Nuove, Milano 2000. Edmond , T., Rubin , A. e Wambach, K. G. (1999), “The effectiveness of emdr with adult female survivors of childhood sexual abuse”, Social Work Research, 23: 103-116. Eysenck, H. (1979), “The conditioning model of neurosis”, Behavioral and Brain Sciences, 2: 155-199. Fairbairn, W. R. D. (1952), Studi psicoanalitici sulla personalità, Boringhieri, Tori no 1970. Feinstein, D. (2004), Energy Psychology Interactive. Rapid Interventions for Lasting Change, Innersource, Ashland, or.
Bibliografia 257 F en sterh eim , H. (1996), “Eye movement desensitisation and reprocessing with
complex personality pathology. An integrative therapy”.Journal of Psychotherapy Integration, 6: 27-38. F igley, C. R. (a cura di) (1978), Stress Disorders Among Vietnam Veterans: Theory, Research and Treatment, Brunner/Mazel, New York. F igley, C. R. (1999), nota editoriale del curatore della collana, in F. P. Gallo (a cu ra di), Energy Psychology. Explorations at the Interface of Energy, Cognition, Beha vior and Health, c r c Press, Boca Raton, f l. F ig ley , C. R. e C a r b o n e ll, J. L. (1995), “Active ingredients project: the syste matic clinical demonstration of the most efficient treatments of p tsd ”, Florida State University Psychosocial Research Program and Clinical Laboratory, ri portato in F. P. Gallo (1999), Energy psychology (pp. 18-25), c r c Press, Boca Raton, f l. F igley, C . R e C a rb o n ell, J. L. (1999), “Promising ptsd treatment approaches. A systematic clinical demonstration”, Traumatology, 5(1), articolo 4, www.fsu.edu/ trauma/promising.html. Fine, C. G. e B erk ow itz, A. S. (2001), “The wreathing protocol. The imbrication of hypnosis and em dr in the treatment of dissociative identity disorder and other
maladaptive dissociative responses”, American Journal of Clinical Hypnosis, 43: 275-290. Flem ing, T. (1999), You Can Heal Now: The Tapas Acupressure Technique (TAT), TAT International, Redondo Beach, ca. Foa, E. B. e M cN ally, R. J. (1996), “Mechanisms of change in exposure therapy”, in R. M. Rapee (a cura di), Current Controversies in the Anxiety Disorders (pp. 329-343), Guilford, New York. Fonagy, P. (1999), “The process of change and the change in processes. What can change in a ‘good' analysis”, discorso pronunciato all’incontro di primavera della divisione 39 dell’American Psychological Association, 16 aprile, New York. Fonagy, P., G e r g e ly , G., J u rist, E. L. e T arget, M. (2002), Affect Regulation, Mentalization, and the Development of the Self, Other Press, New York. F o o te , S. L., B loom , F. E. e A shton-Jones, G. (1983), “Nucleus locus ceruleus: new evidence of anatomical and physiological specificity”, Physiological Review, 63: 844-914. F reud , S. (1894), Le neuropsicosi da difesa, in Opere, Boringhieri, voi. 2, Torino 1968. F reud, S. (1895), Progetto di una psicologia, in Opere, Boringhieri, voi. 2, Torino 1968. Freud, S. (1896a), Nuove osservazioni sulle neuropsicosi da difesa, in Opere, Borin ghieri, voi. 2, Torino 1968. Freud, S. (1896b), Eziologia dell’isteria, in Opere, voi. 2, Boringhieri, Torino 1968. F reud, S. (1899), L’interpretazione dei sogni, in Opere, voi. 3, Boringhieri, Torino 1973.
258 Bibliografia S. (1905), Tre saggi sulla teoria sessuale, in Opere, voi. 4, Boringhieri, Tori no 1970. F r e u d , S. (1909), Cinque conferenze sulla psicoanalisi, in Opere, voi. 6, Boringhieri, Torino 1974. F r e u d , S. (1911), Precisazioni sui due principi dellaccadere psichico, in Opere, voi. 6, Boringhieri, Torino 1974. F r e u d , S. (1912), Dinamica della traslazione, in Opere, voi. 6, Boringhieri, Torino 1974. F r e u d , S. (1914a), Ricordare, ripetere, rielaborare, in Opere, Boringhieri, voi. 7, To rino 1975. F r e u d , S. (1914b), Osservazioni sullamore di traslazione, in Opere, voi. 7, Borin ghieri, Torino 1975. F r e u d , S. (1920), ^4/