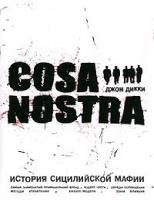La mafia immaginaria. Settant'anni di Cosa Nostra al cinema (1949-2019) 8855220500, 9788855220507
Dal secondo dopoguerra, e ancor più dalla fine degli anni sessanta, la mafia siciliana è stata oggetto di decine di film
301 74 16MB
Italian Pages 350 [59] Year 2020
Polecaj historie
Citation preview
Emiliano Morreale
LA MAFIA IMMAGINARIA Settantanni di Cosa Nostra al cinema (1949-2019)
Indice
Introduzione
I. Le mafie interpretate
il. Le regole del gioco, ovvero: come e quando il mafia movie diventò un
genere in. Uomini e donne iv. Così ridevano V. Western di Cose Nostre: In nome della legge
vi. Anni difficili vii. Verso il genere: l’eccezione e la regola
vili. L’eccezione Salvatore Giuliano
IX. Politica e autori
X. I figliocci del Padrino XI. Dal mafia morie alle agiografie
XII. Prima e dopo La piovra xill. Cosa Nostra d’autore: verso il postmoderno
Xiv. Mafiaworld
XV. La mafia come metafora XVI. Epilogo Cronologia dei film italiani sulla mafia
La mafia immaginaria Ad Alessandro Leogrande, amico dei ventanni
Se la mafia non ci fosse, bisognerebbe inventarla.
on. Andrea finocchiaro Aprile, discorso elettorale tenuto a Bagheria, gennaio 1944
E io non capivo come mai una persona 0 un avvocato 0 un altro
signore che c'era... tutte persone... potessero assistere a questa cerimonia, che mi ricordava tanto un film... quei film che si fanno
sulla Sicilia. Giorgio Puma, commercialista, testimoniando sul battesimo
dei figli di Filippo e Giuseppe Graviano a Nizza, nel 1997
Introduzione
Io le posso dire una cosa, signor presidente: che la rovina dell’umanità sono certi film, film di violenza, film di
pornografia. Perché se Totuccio
Contorno avesse visto Mosè e non II Padrino, non avrebbe calunniato
l’avvocato Chiaracane... Invece Totuccio Contorno, purtroppo, ha visto II Padrino...
Michele Greco, capo della Cupola di
Cosa Nostra,
udienza al maxiprocesso, il giugno 1986
Siepi di fichidindia da cui spuntano canne di lupara. Stranieri che arrivano in villaggi dominati dalla paura. Boss biondi e saggi dall’aria nobile. Vedove sensuali vestite di nero, donne indifese minacciate di stupro. Visioni di Palermo dall’alto, coi nuovi quartieri soffocati dal cemento. Inseguimenti nei mercati, sequenze di omicidi per strada. Giudici che arringano gli astanti (e gli spettatori) spiegando cos’è la mafia. Conversazioni di riepilogo della storia recente, in campagna, con Palermo sullo sfondo. Consessi di potenti che tramano nell’ombra. Dal secondo dopoguerra, e ancor più dalla fine
degli anni sessanta, la mafia siciliana è stata oggetto di un numero enorme di film e fiction televisive, con un corredo riconoscibile di temi, personaggi, ambientazioni. Una produzione ricchissima, basata su una certa rappresentazione letteraria della Sicilia
e che, nonostante evoluzioni e discontinuità, ha costituito un immaginario costante nei decenni, fino a sovrapporsi agli eventi storici e a influenzarne la
percezione: da parte dell’opinione pubblica e anche,
in certi casi, dei mafiosi stessi. Questo libro si muove sulla linea tra realtà e rappresentazione; racconta gli spazi intermedi, le mediazioni comunicative ed estetiche e la loro dimensione in ultima istanza ideologica. La tesi di fondo è che il processo di costruzione dell’immagine cinematografica di Cosa Nostra sia essenzialmente interno alla storia dei media. E la storia del cinema italiano — dei suoi cambiamenti economici e culturali, del suo posizionamento culturale -, più che la storia della mafia o dell’antimafia, a spiegare le scelte tematiche e stilistiche dei film. Quello che chiameremo mafia movie crea, sostanzialmente, un mondo immaginario che non si comprende se lo si considera un «rispecchiamento», un rendiconto della storia della mafia1. Anziché chiederci quanto il
cinema sia stato attendibile nel raccontare Cosa
Nostra (pochissimo, diciamolo subito), si è andati perciò alla ricerca delle regole di funzionamento di un genere, raccontando la sua formazione e il suo senso culturale. In prima istanza il mafia movie è un universo autonomo e autoreferenziale. O meglio, è in dialogo con la storia del paese, ma in maniera imprevista e mediata. Quel che ha da dire sul presente e sul passato lo dice spesso come lapsus, svelando nello stesso tempo qualcosa su di sé, sui propri autori, sulla loro ideologia. Il suo rapporto con la storia
agisce in maniera sottile, non come specchio, bensì come sintomo. Ci si trovano subito sotto gli occhi
paradossi e cortocircuiti: celebrazioni della Legge che sfociano in apologie della «trattativa» tra Stato e mafia, antagonisti oscuri che si impossessano dei film «democratici», rimozioni di dati reali talmente macroscopiche da richiedere di essere interrogate.
Ma soprattutto, i film che parlano di mafia, riletti oggi, non di rado ci raccontano altro: la crisi degli intellettuali e della sinistra negli anni del boom, la
presenza nuova e ingombrante delle donne nella società, le difficoltà a orientarsi nella strategia della tensione o alla fine della I Repubblica. La Sicilia e la mafia sono un luogo in cui dislocare contraddizioni, un dispositivo che opera (come il sogno secondo Freud) per condensazione e spostamento. Quando si trova in difficoltà davanti alle grandi contraddizioni
politiche e sociali, il cinema italiano talvolta sceglie di evadere in quella metafora dell’Italia che è la Sicilia. Il maschilismo si carica allora di spinte
parossistiche, tra compiacimento ed esorcismo; gli arcana imperii della strategia della tensione
trovano una dimensione metafisica nella visione di una Cosa Nostra onnipotente e pervasiva; la sinistra negli anni dell’ulivo cerca di rinnovare l’albero genealogico dal dopoguerra al ’68 con nuovi esempi di militanza; l’ascesa di Berlusconi appare sotto il segno del complotto, all’ombra della trattativa Statomafia. In Sicilia si trova insomma, per citare il motto di Goethe amato dagli intellettuali locali, «la chiave di tutto»: o, quantomeno, una serie di efficaci
scorciatoie ideologiche. 1. Convergenze parallele.
Se la storia del mafia movie scorre parallela alle cronache criminali e politiche, e interagisce col
proprio tempo in maniera più profonda e complessa, le relazioni con gli eventi storici dovranno essere di volta in volta interrogate tenendo conto di una serie di passaggi intermedi.
Non sono mancati tentativi di far risalire all’indietro la rappresentazione cinematografica della mafia e della camorra: i primi esempi si trovano negli Stati Uniti, dove la Mano Nera e una delinquenza italiana etnicamente connotata sono presenti fin dai primi anni del XX secolo2. Il cinema americano di gangster, poi, viene fondato da tre film
(Piccolo Cesare, 1930, di Mervyn LeRoy; Scarface,
1930, di Howard Hawks; Nemico pubblico, 1931, di William A. Wellman), due dei quali caratterizzano in .
.
.
3
maniera decisamente etnica i protagonisti .
Nel cinema italiano però, anche se si sono ricercati spesso incunaboli nella produzione 4
v
d’anteguerra , c’e un terminus a quo indiscutibile: In nome della legge (1949) di Pietro Germi. Il film ha al centro lo scontro tra un emissario dello Stato e
la mafia, vista come rappresentante di un ordine precedente che infine cede le armi. Una visione che in realtà, notarono in molti, era difficile considerare d’attualità in un momento in cui la mafia si trovava
all’interno di un potere nuovo, sostanzialmente come braccio armato nella repressione del movimento contadino. I sindacalisti uccisi erano stati 4 nel 1945, 8 nel 1946,19 nel 1947, 5 nel 19485,
In nome della legge esce meno di due anni dopo la
strage di Portella della Ginestra. Nel film (tratto da un libro ambientato negli anni venti) di questo però non c’è traccia. Da subito, insomma, il cinema italiano costruisce un mondo relativamente autonomo dalla realtà, mosso da esigenze interne al sistema dei media, in questo caso l’ambizione di
creare un western italiano. Per tutti gli anni cinquanta, in concomitanza con un sostanziale silenzio dell’opinione pubblica e dei mezzi di informazione principali, la mafia è assente dagli schermi. Indicativi, in questa fase, sono quindi
paradossalmente non i film che vengono realizzati, ma i numerosi progetti che per vari motivi non giungono a buon fine, a cominciare da quelli relativi alla figura del bandito Salvatore Giuliano e ai suoi
rapporti con mafia e politica.
Nel frattempo la mafia sta cambiando faccia, con la guerra interna ai corleonesi che vede l’affermarsi
del boss Luciano Liggio su Michele Navarra, e il coevo inserimento dei clan all’interno del sistema governativo regionale e della città di Palermo, con le 6
nuove possibilità aperte da un boom del terziario .
Politicamente, la situazione è in forte e contraddittorio movimento: al Comune di Palermo
(con Vito Ciancimino assessore ai Lavori pubblici) il giorno di Ognissanti del 1959 è approvato il piano regolatore che dà il via al sacco della città; alla Regione, dall’autunno 1958 al febbraio i960, è in corso il travagliato esperimento del presidente Silvio Milazzo, fuoriuscito dalla De che fonda un nuovo
partito governando con un appoggio esterno trasversale, dall’estrema destra all’estrema sinistra. È il momento in cui compaiono tre titoli decisivi
per la costruzione di un’immagine della mafia: Salvatore Giuliano (1961) di Francesco Rosi, Il
giorno della civetta (1961) di Leonardo Sciascia e Mafia e politica (1962) di Michele Pantaleone. Un film, un romanzo e un saggio, usciti a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro, che anticipano di poco il clamoroso riemergere di Cosa Nostra. Palermo torna all’attenzione nazionale in occasione della «prima guerra di mafia», avviata dall’omicidio del boss del quartiere Noce Calcedonio Di Pisa (26
dicembre 1962), e che culmina il 30 giugno 7
dell’anno dopo nella strage di Ciaculli . Anche in seguito a ciò viene creata la I Commissione parlamentare antimafia, i cui lavori tortuosi accompagneranno il decennio. Ma anche in questa fase il cinema pare poco interessato al fenomeno. La grande fioritura dei film italiani sulla mafia scorre parallela alla voga del «cinema politico», ed è aperta da due titoli di Damiano Damiani: Il giorno della
civetta (1968) e Confessione di un commissario di polizia al procuratore della Repubblica (1971). Quest’ultimo sposta l’asse dalla campagna alla città
e inaugura (insieme a La polizia ringrazia, 1972, di Stefano Vanzina) anche il genere del «poliziottesco», Faction movie urbano che costituirà uno dei generi più fiorenti del decennio, e che si intreccia con i film sulla mafia fino a coincidervi parzialmente. Nello stesso anno, ulteriore impulso viene dal successo del Padrino di Francis Ford , 8
Coppola .
Lo sceneggiato televisivo La piovra (1984) segna idealmente l’apogeo e la fine del genere, che
attraversa dunque (senza dame conto in maniera diretta) anche la «seconda guerra di mafia» (1978-1984) tra i corleonesi e i clan perdenti di Stefano Bontate, Tano Badalamenti e Salvatore
Inzerillo. Il cinema italiano è ancora più assente negli anni successivi, che segnano lo svolgimento e la conclusione del maxiprocesso. Solo dopo diversi anni le deposizioni di Buscetta e gli interrogatori ampiamente riportati sui media, con lo sguardo interno che gettavano sull’organizzazione mafiosa,
faranno sentire la loro influenza sul cinema, e la narrazione si integrerà in una struttura formale diversa, meno spettacolare e più attenta alla cronaca. Ma anche in questo caso ciò avverrà grazie
a una fase di mutazione dell’industria cinematografica, che in assenza di un cinema di genere (ormai scomparso con l’avvento delle televisioni private) si rifonda in direzione di un «cinema medio d’autore». Dalla fine degli anni novanta, infatti, mentre 9
l’attenzione dei media su Cosa Nostra va scemando , si assiste a una polarizzazione. Da un lato, è la televisione a farsi carico della tradizione del cinema
«impegnato», con biografie di eroi antimafia
concepite secondo una logica celebrativa, agiografica. Dall’altro, le formule del mafia movie appaiono sempre meno utilizzabili in un panorama che vede il declino non solo dei generi popolari ma anche del cinema «impegnato». Il nuovo assetto estetico del cinema italiano sarà sistematizzato nel progetto editoriale di Rai Cinema: l’idea di ricostruire un pubblico puntando su una produzione di qualità ma fortemente comunicativa, rivolta a una fascia medio-alta laureati, over 40, del Centro-nord _
.
_
xi° _
con una certa prevalenza femminile) . H racconto della mafia si aggiorna a questo riposizionamento
del cinema italiano. All’interno del filone «di denuncia» e delle biografie di eroi antimafia vengono riempite le tessere mancanti, da Giuseppe Impastato (/ cento passi, 2000) a don Pino Puglisi (Alla luce del sole, 2005), ma soprattutto, dopo la
strage di Capaci e la fine della prima Repubblica, l’impraticabilità dei vecchi modelli estetici pare evidente. Il folklore è avvertibile da uno spettatore medio più informato, almeno per quanto riguarda la storia recente. Inoltre, per la prima volta una generazione di registi provenienti dalla Sicilia si afferma a livello nazionale: particolannente innovativi due film di Roberta Torre: Tano da morire (1997) e Angela (2002), e soprattutto l’opera di Daniele Cipri e Franco Maresco, in particolare nei
lungometraggi da Lo zio di Brooklyn (1995) in poi. Oggi, per l’industria dello spettacolo, la mafia (e
in particolar modo quella siciliana) continua a essere una delle merci più vendibili nel mondo; forse ancor più della Dolce Vita e della cucina. Sul mercato interno, a fronte di un calo di interesse del cinema , Cosa Nostra rimane un elemento centrale per i prodotti televisivi di finzione, costruiti secondo
schemi ripetibili e con un richiamo a immagini note al pubblico: un universo tutto mediatico, oltre che rivolto quasi esclusivamente al passato. Questo tipo di produzioni andrebbe peraltro analizzato in un
contesto di ricezione più ampio, come parte di un palinsesto basato sulla commemorazione e l’evento, a partire ad esempio dalla programmazione annuale
delle giornate del 23 maggio e 19 luglio, anniversari 12
delle stragi di Capaci e via D’Amelio . Rimangono comunque assenti dagli schermi quella che è stata definita la «borghesia mafiosa» e i
vari cerchi di «zona grigia» che vanno dalla complicità all’indifferenza: un mondo difficile da
raccontare, con i suoi passaggi sottili, mediati, 13
efficienti e poco spettacolari , che rende inservibile l’idea della mafia come altrove 4. Oggi fare un film sulla mafia significa più che mai raccontare qualcosa di simile a noi stessi, raccontarsi in quanto italiani mutati o mutanti. Nel frattempo Cosa Nostra è vista dall’opinione pubblica come un fenomeno consegnato al passato, e perciò le relazioni tra
imprenditoria e politica, il racconto di una borghesia limitrofa alla mafia e i vari strati sociali che con essa hanno a che fare sono stati indagati piuttosto da film che hanno raccontato le altre mafie nazionali: da Galantuomini (2003) di Edoardo Winspeare a Gomorra (2008) di Matteo Garrone e Anime nere (2013) di Francesco Munzi, fino alla serie Suburra (2017-sgg.). Nei primi tre casi, peraltro, si tratta di operazioni estetiche originali e potenti, mentre è
come se il mondo di Cosa Nostra, gravato da una serie di immagini e storie pregresse, possedesse un’inerzia propria, che rende difficile uno sguardo nuovo.
2. Generi coloniali, ovvero l’orientalismo in un solo paese.
Il cinema italiano sulla Sicilia mostra spesso le caratteristiche di uno sguardo in senso lato
coloniale, anzi di quello che è stato efficacemente definito, a proposito della questione meridionale, «l’orientalismo in un solo paese» 5: «La concezione dell’Italia meridionale come zona di frontiera fra Europa e Africa contribuisce al consolidamento della visione eurocentrica del mondo, che caratterizzò il periodo fra il 1750 il 1850», e fa parte non della storia del Grand Tour ma «di un’altra
storia analoga, per i suoi caratteri, alla scoperta della Grecia, delle coste africane, del Mediterraneo 16
.
, ,
,
in genere» . La Sicilia, con i riferimenti alla Magna Grecia, costituisce poi «il luogo in cui le caratteristiche meridionali del Mezzogiorno e dell’Italia raggiungevano la loro espressione più 17
compiuta» . Le Indias de por aca, come scriveva nel 1575 da Messina il missionario spagnolo Michele Navarro. Meridionalisti anglosassoni hanno di recente
utilizzato, con elasticità, il concetto elaborato da Edward Said per spiegare il meccanismo di
costruzione ded’altro da parte della cultura europea dell’ottocento, basando su di esso una lettura della visione del Mezzogiorno a partire dall’unità d’Italia.
Il Sud, sostengono, è contrapposto al Nord e
assimilato ad Africa e Oriente, in un procedimento che introietta lo sguardo dei viaggiatori europei del Grand Tour e si traduce in un «tenace catalogo di stereotipi» che vede i meridionali passionali, indisciplinati, incapaci di solidarietà e «di dare vita alle culture razionali, ordinate e civiche che al Nord
hanno assicurato l’emergere di una società ,
i
.
19
capitalista industriale» . Quel che qui più interessa è anzitutto la connotazione della Sicilia come altrove, cui è da aggiungere però una caratteristica singolare: questo orientalismo è anche, alla base, un auto20
orientalismo . Questo atteggiamento ideologico ha infatti la sua fonte ultima nelle riflessioni di intellettuali locali che hanno assunto, nelle forme più radicali e perverse, i tratti del «sicilianismo»: una visione culturale-etnica che denuncia o rivendica una diversità e unicità e che, invertita di segno, ha fondato anche l’autorappresentazione 21
della mafia . Lontano ma persistente esempio, il grande studioso delle tradizioni popolari Giuseppe Pitrè, che nel 1889, contro la pubblicistica «continentale», rivendicava l’originario significato positivo dei termini «omertà» (da lui ricondotto a «omineità, qualità di essere omu») e «mafia», diffuso nei quartieri popolari come sinonimo di
bellezza e definibile come «l’esagerato concetto della forza individuale», anzi addirittura «coscienza d’essere uomo, sicurtà d’animo, e, in eccesso di questa, baldanza, non mai braveria in cattivo senso, .
.
22
non mai arroganza, non mai tracotanza» . Questa etimologia fantasiosa fornì tra l’altro allo studioso le basi per la difesa dell’onorevole Raffaele Palizzolo, imputato del primo omicidio politico di mafia:
l’assassinio di Emanuele Notarbartolo, ex sindaco e 23
direttore generale del Banco di Sicilia, nel 1893 . Su tale riappropriazione di una prospettiva antropologica si fonda lo sguardo del cinema italiano su Cosa Nostra. Alla base dei film fondanti
del mafia movie, infatti, c’è spesso l’ispirazione, diretta o indiretta, di un autore letterario siciliano. In questo era stato preveggente Leonardo Sciascia,
quando aveva schematizzato il cinema di argomento siciliano in tre filoni, riconducendo ognuno di essi a una fonte letteraria: «mondo offeso» (Vittorini), luogo del mito (Quasimodo), teatro dell’eros 24
(Brancati) . Lo scrittore di Racalmuto non poteva
però immaginare che, per una sorta di ironica nemesi, il quarto e forse più cospicuo filone cinematografico avrebbe avuto proprio in lui la fonte diretta, a partire da A ciascuno il suo di Elio Petri e soprattutto II giorno della civetta di Damiano Damiani.
Già il primo film italiano sulla mafia, In nome della legge, si basava sul romanzo Piccola pretura
del siciliano Guido Lo Schiavo, di cui subito dopo verrà portato sullo schermo anche Gli inesorabili. Il soggetto di Mafioso (1962) di Lattuada è del pittore palermitano Bruno Caruso. La violenza: quinto
potere (1972) di Florestano Vancini e Gente di
rispetto (1975) di Luigi Zampa sono tratti da pièce del giornalista catanese Giuseppe Fava (che sarà ucciso dalla mafia nel 1984); Vittorio Schiraldi (nato a Bergamo ma di origine e formazione siciliana) trae Baciamo le mani (1973) da un suo libro omonimo.
Altrettanto importanti sono le fonti letterarie di non-fiction: il giornalista Orazio Barrese è autore del
libro da cui è tratto Corleone (1978) di Pasquale Squitieri; Michele Pantaleone, oltre a collaborare a
Il sasso in bocca (1970) di Giuseppe Ferrara, è stato l’ispiratore più o meno diretto di una visione della mafia come fenomeno feudale legato al mancato 25
sviluppo economico - una lettura corrente che il cinema italiano ha fatto propria per gran parte della sua storia. Il nome fondamentale però rimane quello di Sciascia, non solo e non tanto come fonte diretta, quanto come ispiratore di una visione di fondo che vede la mafia, e più in generale la Sicilia, come laboratorio (man mano più metafisico) dei mali d’Italia, in un decennio in cui molti snodi decisivi sembrano svolgersi su un piano più o meno occulto:
è questo, ad esempio, il caso di molta produzione di Damiano Damiani, in cui il rapporto con Sciascia
sarà spesso non dichiarato, ma assai evidente (cfr. 26
infra, cap. IX) . Qui tocchiamo un punto decisivo, che spiega anche perché questo libro si occupi essenzialmente della mafia siciliana. Il mafia movie, infatti, è fino a
una certa data, e nella fase più significativa, un capitolo nella storia dell’immagine della Sicilia, e più precisamente della ricezione di stereotipi elaborati dalla letteratura siciliana. Una visione dell’immutabilità della regione che diventa iperbole di un’immutabilità italiana; mali locali che diventano iperbole dei vizi degli italiani.
Se all’origine stessa del termine «mafia» c’era una rielaborazione letteraria (la pièce I mafiusi di la Vicaria, 1863-64, di Rizzotto e Mosca, quasi un prontuario di usi e costumi della malavita
palermitana in carcere), alle radici di ogni rappresentazione della Sicilia c’è la Cavalleria
rusticana (1890) musicata da Pietro Mascagni, su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido 27
.
Menasci, tratto dalla novella di Giovanni Verga : archetipo di un folklore fatto di passioni e violenza,
e già gioco di specchi tra uno scrittore catanese e un musicista livornese che in Sicilia non aveva mai messo piede. Ma bisognerà aspettare II Gattopardo (1958) di Tornasi di Lampedusa (e il film di Luchino Visconti del 1963) perché l’armamentario concettuale del
cinema di mafia sia completo. L’immagine della Sicilia irredimibile del Gattopardo si salda a una visione della mafia come «residuo feudale», e poi a quella di una «mafia imprenditrice» pronta a
trasformarsi. E si potrà notare quanto oggi risultino in fondo congruenti alla prospettiva lampedusiana
quella di Sciascia nel Giorno della civetta (nonostante l’ostilità a quell’epoca manifestata dallo 28
scrittore di Racalmuto per il principe scrittore) , e perfino quella di Mafia e politica di Michele Pantaleone, cioè il libro che fornisce ai ceti colti degli anni sessanta il più efficace schema
interpretativo del fenomeno. L’idea della centralità della mafia nella storia della Sicilia, di un suo fondamento antropologico e (dunque) di una sua fondamentale inestirpabilità diventerà, negli anni settanta, una chiave per leggere i misteri d’Italia, e infine la base di sceneggiati come La piovra. Dopo
le stragi del 1992 questa chiave comincerà a essere incrinata; non solo in direzione di prodotti più sfumati e avveduti, ma anche di una complessiva traslazione al passato di tutto l’armamentario visivo e narrativo. Nel frattempo la mafia diventa, nello scrittore siciliano di maggior successo, Andrea Camilleri, un ingrediente tra gli altri, ma non quello decisivo, e l’isola rivendica una propria natura di fondale basato su un nuovo pittoresco in chiave di commedia. I limiti estetici e culturali del cinema di mafia
italiano risaltano ancor più se messi in parallelo con alcuni grandi esiti del cinema statunitense, che mostrano una conoscenza del fenomeno assai
maggiore, una prospettiva dall’interno sul filo dell’ambiguità. Il padrino, Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, Fratelli di Abel Ferrara, la cui eredità è raccolta dalla serie tv I Soprano, sono opera di autori italo-americani che sentono la
cultura mafiosa come qualcosa di vicino, come una possibilità di mettere in scena una parte di se stessi. Alla produzione americana è dedicato un capitolo di questo libro, non solo per le influenze che Coppola,
Scorsese o Ferrara hanno avuto sui registi italiani, ma anche perché essi hanno incarnato il modello di
ciò che il cinema italiano, per decenni, non ha saputo essere.
3. Se Contorno avesse visto Mosè.
Se il mafia movie è un corpus relativamente impermeabile, che riflette obliquamente il tempo e procede per mezzo di spinte interne, esso però ha
avuto nei decenni effetti profondi sulla rappresentazione del fenomeno criminale. Gli eventi
storici e i fatti di cronaca servono a poco, per capire il mafia movie, ma film e fiction sono molto utili per capire l’immagine pubblica della mafia. E addirittura l’immagine di sé che i mafiosi hanno
elaborato. In esergo a questo capitolo abbiamo riportato le parole di Michele Greco, boss di Ciaculli e a capo della Cupola di Cosa Nostra durante l’ascesa dei
corleonesi. Un’affermazione a effetto, in pieno maxiprocesso - eppure le cose sono più complicate di come don Michele suggeriva. Ad aver visto II padrino e simili, e a lasciarsene influenzare, sono
stati, più che i pentiti, molti mafiosi nell’esercizio delle loro funzioni. È ormai facile notare quanto le immagini dei media, direttamente o indirettamente, contribuiscano a formare l’identità dei criminali. C’è chi sostiene che anche nel passato «la fortuna
dell’organizzazione [sia] stata quella di veder filtrata la propria immagine pubblica (soprattutto quella rivolta ai “non addetti ai lavori”) attraverso forme di rappresentazione dal carattere quasi 29
leggendario» : «Una delle sue [di Cosa Nostra] risorse più micidiali è sempre stata, dalle origini ai giorni nostri, la capacità di produrre e diffondere 30
un’immagine mistificata di sé» . Alcuni testi letterari, cinematografici e televisivi hanno avuto, in
questa produzione e diffusione, un ruolo centrale.
Si tratta di un campo difficile da indagare. Per Cosa Nostra, fino a una certa epoca, le testimonianze sono ovviamente scarse, anche se è noto che i mafiosi hanno considerato, fino ad anni
recenti, I Beati Paoli di Luigi Natoli - romanzo pubblicato a puntate nel 1909-10 - una sorta di .
31
. .
.
x
fondamento letterario mitico . Un punto di svolta è comunque II padrino, prima il libro di Mario Puzo (1969) e poi il film di Coppola: riferimento per la mafia italo-americana, ma anche per quella siciliana.
Lo studioso Federico Varese ha diviso i film sulle mafie internazionali in tre gruppi, a seconda del pubblico di riferimento: film graditi dal pubblico e
sgraditi alle mafie; film di mafia che piacciono solo all’ambiente mafioso; film apprezzati da tutti, come 32
appunto II padrino . Riportando all’Italia le tre categorie, potremmo dire che quella dei film invisi alle mafie è pressoché assente (Cosa Nostra ignora o addirittura apprezza il «cinema antimafia»), e ricchissima è la terza: come vedremo, pubblico «generalista» e subcultura mafiosa apprezzano entrambi (seppure, vogliamo immaginare, per motivi differenti) Gomorra - La serie o II capo dei capi. Più raro il caso dei film che appartengono esclusivamente al mondo della subcultura mafiosa.
Varese, in questo caso, cita i lavori di Giorgio 33
Castellani/Giuseppe Greco . Ossia proprio il figlio di quel Michele che si lamentava dei film di violenza
e di pornografia. Greco/Castellani era estraneo all’attività criminale paterna, ma la sua appartenenza culturale a quell’ambiente, come vedremo, rende la sua testimonianza preziosa, come
uno sguardo gettato in un mondo che, in teoria, non 34
dovrebbe produrre un racconto pubblico di sé . Testimonianze dei pentiti e intercettazioni hanno permesso sempre più di ricostruire quanto
l’immagine di sé anche interna al gruppo, o agli individui, sia stata influenzata dai media. Ma, al di là dei film che li ispirano, la curiosità dei mafiosi per i mafia movie è varia e comprensibile. È noto che Giovanni Brusca, uno degli artefici della strage di Capaci, venne arrestato nel 1996 mentre guardava in
tv il film di Giuseppe Ferrara su Falcone. Stesso destino per Michele Catalano, esponente del clan Lo Piccolo, arrestato nel 2007 mentre guardava la miniserie II capo dei capi. E in certi casi, il carattere ambiguo di molte fiction sulla mafia aiuta. Nel Capo dei capi, Riina e Provenzano sono anti-eroi belli, audaci e innamorati; e se Ninetta Bagarella, moglie di Riina, aveva annunciato una querela per un episodio inventato nella serie, «Totò u curtu» invece
apprezzò. Secondo i suoi avvocati «il signor Riina, avendo avuto modo di seguire la fiction, ha commentato positivamente la figura. Sicuramente ha apprezzato l’impegno che l’attore ha messo nel raffigurare la sua vita, le storie processuali che sono 35
state narrate in questa fiction» .
Ad ogni modo, nessun film o prodotto televisivo ha mai scosso il mondo di Cosa Nostra: l’organizzazione, che ha ucciso e minacciato decine di giornalisti, non si è mai sentita infastidita dal cinema e dalle fiction antimafia; men che meno, poi, negli ultimi anni in cui, perfino in ambienti vicini a
Cosa Nostra, «la mafia fa schifo» è diventata una frase di rito rivolta all’esterno, come un tempo «la mafia non esiste», ed è ben vista la presenza di affiliati e fiancheggiatori dentro organizzazioni antiracket e manifestazioni antimafia. Nel 2003, ricordiamo, gli amministratori comunali del paese di Villabate, alle porte di Palermo, consegnarono a Raul Bova la cittadinanza onoraria destinata al capitano Ultimo, che lui aveva interpretato in una fiction. Il presidente del Consiglio comunale
Francesco Campanella, referente delle cosche locali e poi collaboratore di giustizia, racconta: «Mi resi conto che forse stavamo andando oltre e chiesi a
Mandalà [capomafia di Villabate] il permesso e lui lo chiese a Provenzano. E Provenzano disse ok, perché valutava positivamente di mischiarsi in questa 36
paraculata» . Oltretutto il «cinema di denuncia» può essere
una fonte di affari, che Cosa Nostra ha tutt’altro che ostacolato. La storia del cinema italiano è piena di racconti sulle «autorizzazioni» più o meno indirette 37
.
delle mafie locali alle troupe venute da Roma . Nel
2011 le intercettazioni hanno documentato l’interesse della famiglia di Porta Nuova per la fiction Squadra antimafia, tramite il nipote del capomandamento Calogero Lo Presti che faceva da 38
service per la produzione . Il più importante
organizzatore cinematografico della Sicilia occidentale, Enzo Castagna, fornitore di comparse
per tutto il cinema girato in Sicilia dagli anni settanta ai novanta, accusato di essere vicino alle famiglie mafiose del quartiere Noce, è stato arrestato nel 1995 con l’accusa di aver partecipato a una rapina alle poste per rimpinguare le casse di Cosa Nostra, all’epoca in crisi di liquidità. Per vendicarsi del pentito che lo aveva accusato, Aurelio Neri, Castagna aveva elaborato una vendetta «cinematografica», cioè la produzione di un film che a sua volta attaccava l’accusatore, ma poi rinunciò^9. La sua vicenda è stata raccontata da Cipri e Maresco in Enzo, domani a Palermo! (1999): e proprio i lavori dei due registi (e poi del solo Maresco, con
Belluscone. Una storia siciliana, 2014, e La mafia non è più quella di una volta, 2019) ci ricordano che quando la mafia, tra serie, film d’autore, fumetti, docufiction, diventa un prodotto mediale, il problema non è più l’assenza di informazione ma l’eccesso di rappresentazioni. Le immagini dei telegiornali e le drammatiche scene della storia recente (l’autostrada di Capaci sventrata, il primo
piano della vedova Schifani ai funerali) entrano a far parte di un repertorio di immagini ricevute, esclusivamente figlie dei media, quanto i vecchi stereotipi dei mafiosi con coppola e lupara. La denuncia non basta più: raccontare seriamente le mafie, oggi, implica rimettersi in discussione in
quanto produttori di storie e di immagini, spiazzare gli spettatori rispetto a narrazioni evasive o rassicuranti.
4. Questioni di forma e punti di vista. Questo è sostanzialmente un libro di storia della cultura, che si muove all’interno delle forme e dei
discorsi, non essendo l’autore uno studioso di Cosa Nostra se non dilettante e per casualità geografica. Nelle pagine seguenti avremo a che fare con racconti per immagini. Cercheremo di leggere i contenuti e le forme, i temi e lo stile dei film, facendoli scorrere sullo stesso piano, come strategie
comunicative e spie di un atteggiamento ideologico. Attraverso un’analisi delle strutture formali, del contesto produttivo e politico del cinema, appoggiandoci a ricerche d’archivio e alle riflessioni teoriche sul genere cinematografico e sul gender, cercheremo di mettere a fuoco la dimensione culturale e ideologica di una produzione varia ed estesa nel tempo. Dato il peso ingombrante di frame, personaggi, topoi narrativi, il rischio è di sopravvalutare la narrazione, la costruzione delle storie, a scapito della messa in scena. Nei limiti del possibile,
abbiamo cercato invece di procedere a un’ulteriore
scomposizione dei testi. Oltre alla tensione fra i propositi dichiarati dai film e i racconti che li incarnano, ne esiste infatti anche un’altra fra i racconti medesimi e le scelte di regia: i volti, i luoghi, la recitazione, le musiche, la composizione delle scene, il montaggio. Molto di ciò che i film dicono si manifesta attraverso l’uso, spesso automatico, di un bagaglio retorico e linguistico che ha a che fare con la dimensione visiva (e sonora), con il modo in cui le vicende sono rappresentate. Ma, circolarmente, questa dimensione linguistica
rimanda a sua volta al contesto sociale. Quando
mostra qualcosa in un certo modo, il film di mafia lo fa utilizzando un codice condiviso con un certo pubblico, e retrospettivamente ci può rivelare qualcosa su cosa quel pubblico fosse, o su come lo immaginassero registi, produttori e sceneggiatori. Lo stile dei film è da subito «sociale», frutto di
negoziazioni con uno spettatore più o meno implicito. Per questo abbiamo dato particolare importanza al momento della ricezione, dei discorsi
intorno ai film e dei modi di produzione. Infine, un’ammissione. Questo, sì, è un libro di storia del cinema, in cui si è cercato di ricostruire in maniera documentata una storia lunga settant’anni,
e di trame un modello teorico sensato. Ma la scintilla primaria nasce dal presente, anzi dai molti presenti nei quali la ricerca è stata condotta. Immaginato in Sicilia, negli anni della primavera di Palermo, nel corso di un’attività di impegno .
4°
.
.
culturale, per quanto marginale , cominciato all’indomani dell’affermarsi delle nuove mafie, questo libro si trova, in maniera imprevista, a fare il consuntivo su un rapporto che ormai sembra
consegnato alle rielaborazioni mitiche. Le tragedie e l’impegno si allontanavano nel tempo, e l’antimafia stessa appariva qualcosa di remoto, divenuto perfino ambiguo, consentendo (o forse mestamente imponendo) uno sguardo più amaro sulla storia*24 .
Nato come riepilogo figlio di una certa urgenza, il libro giunge a termine nel disincanto. Essendosi la sua elaborazione protratta per diversi anni, il punto finale di osservazione è diventato un momento storico in cui Cosa Nostra è un luogo di pura reinvenzione volta al passato, sottoinsieme di un modernariato filmico e televisivo d’epoca. Non lo si è notato spesso, infatti, ma negli ultimi ventanni nessun film su Cosa Nostra è ambientato al 42
. .
x
presente . Eppure questa posizione può essere anche, paradossalmente, un momento di verità: una
volta che il racconto è declinato al passato, i suoi caratteri di invenzione emergono più chiari, e illuminano retrospettivamente la dimensione immaginaria, che da sempre ha nutrito il racconto cinematografico della mafia. Nel frattempo le immagini di Cosa Nostra sono
entrate in un circuito in cui convivono il ripetersi dei cerimoniali e l’irrilevanza delle opzioni etiche e storiche: il figlio di Totò Riina presenta in televisione un libro assai indulgente nei riguardi del padre, le cerimonie commemorative si fanno spettacolo autoreferenziale, Internet sancisce la
ripetizione degli eventi tramutati in frammento 43
puramente mediale . La trasformazione della mafia
in immagine, in passato separato dal presente, in vintage, è il presupposto di tutto ciò. Ad ogni modo, è inutile negarlo: man mano che l’analisi si avvicina al presente, la ricostruzione dei discorsi, dei testi e del contesto si fa in questo libro meno neutrale, più coinvolta, da «osservatore partecipante» in senso lato. Il punto da cui si guarda emerge sempre più chiaramente, diventa forse parte
del quadro. Sosteneva un filosofo che «il fatto di esser stati giovani in un’epoca fa parte della sua immagine oggettiva»; spero che sia così, e che
l’ambiguo punto di osservazione sia un’aggiunta, e non una debolezza, di questo lavoro di ricerca. Del resto, non avrei saputo fare altrimenti. 1
Fino ad anni recenti sono mancati studi complessivi sul cinema di
argomento mafioso. Un carattere pionieristico ha il lavoro del critico
cinematografico del quotidiano «L’Ora», V. Albano, La mafia nel cinema siciliano, Barbieri, Mandrina 2003. In Italia le uniche
monografie di rilievo (non limitate però al cinema) sono A. Meccia, Mediamafia, Di Girolamo, Trapani 2014, ® M. Ravveduto, Lo
spettacolo della mafia, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2019. In ambito anglosassone una data importante è segnata dalla
pubblicazione di Mafia Movie. A Reader, a cura di D. Renga, Toronto University Press, Toronto-Buffalo-London 2011 (II ed. ampliata 2019). 2 Il primo titolo di cui si ha notizia è The Black Hand: True Story
of a Recent Occurrence in the Italian Quarter ofNew York (1906),
prodotto dalla Biograph, che ha al centro una «lettera di scrocco». Nel
quindicennio successivo sono numerosi i film sul tema, compresi un paio di titoli di uno dei maggiori registi del periodo, Thomas H. Ince
(The Alien, 1915; The Criminal, 1916), e uno con Mary Pickford, Poor
Little Peppina (1916) di Sidney Olcott. Ma troviamo anche una
biografia del poliziotto italo-americano Joe Petrosino, ucciso a
Palermo, o The Last of the Mafia (1915) di Sidney M. Goldin, prima
occorrenza del termine nella storia del cinema, che racconta invece il percorso inverso, ossia un detective italiano sulle tracce della Mano
Nera in America. Cff. P. Bondanella, Hollywood Italians. Dagos, Palookas, Romeos and Wise Guys, and Sopranos, Continuum, New York-London 2004, pp. 176-81.
3
Sul cinema di mafia americano, da The Black Hand agli anni
trenta, si veda V. Maggitti, Wallace McCutchen’s The Black Hand. A
Different Vision ofBiograph Kidnapping; J. Ruvoli, «Most Thrilling Subjects»: D.W Griffith and the Biograph Revenge Films; N.
Bouchard, Ethnicity and the Classical Gangster Film: Mervyn LeRoy’s Little Caesar and Howard Hawks’ Scarface, tutti in Mafia
Movie. A Reader, a cura di D. Renga, University of Toronto Press,
Toronto-Buffalo-London, pp. 51-75; G. Bertellini, Italy in Early American Cinema, Indiana University Press, BloomingtonIndianapolis 2010, pp. 181-204. 4 Ad esempio Terra di nessuno (1939) di Mario Baffico, da Pirandello (girato a Gubbio e oggi perduto) o La bella addormentata
(1942) di Luigi Chiarini, da Pier Maria Rosso di San Secondo. Cfr. S. Gesù, La mafia sullo schermo. Appunti per una prima ricognizione,
in La Sicilia tra schermo e storia, a cura di S. Gesù, Maimone,
Catania 2008, specie pp. 120-5. H saggio segnala altri titoli del cinema muto, tutti oggi perduti, come La mano nera, La camorra, Omertà, Un dramma alla masseria, La mano nera della «Gloria Film» e La
mano nera della Milano Films. Ma risultano anche le riprese di Gli imponenti funerali del poliziotto americano Joe Petrosino, da parte della «Sicilia Films» di Giuseppe Granielli (ibid., p. 121). 5 U. Santino, Storia del movimento antimafia, Editori Riuniti,
Roma 2000, pp. 155-63. 6 A dame pronta testimonianza, il quotidiano locale «L’Ora» con
una serie di inchieste, che causeranno anche un attentato contro la
tipografia del giornale. Cfr. le memorie dell’allora direttore V. Nisticò, L’Ora dei ricordi, Sellerio, Palermo 2004. Le inchieste di due dei cronisti più valenti sono raccolte in F. Chilanti - M. Farinella,
Rapporto sulla mafia, Flaccovio, Palermo 1964. Per dare un’idea delle nuove opportunità introdotte dalla crescita economica e dalle forme
di sottogoverno regionale, basti ricordare che, delle quasi 9000 assuzioni della Regione Sicilia fra il 1947 e il 1963, il 93% era senza concorso. Cfr. R. Catanzaro, Il delitto come impresa. Storia sociale
della mafia, Liviana, Padova 1988 (Il ed. Rizzoli, Milano 1991), p. 182. 7 Il 30 giugno 1963 una Giulietta imbottita di tritolo, destinata a
quanto pare a un attentato ai danni di un boss di Ciaculli, causa la morte di 7 membri delle forze dell’ordine. Nel 1964 il quotidiano «L’Ora» pubblica il rapporto di polizia giudiziaria a firma del tenente
Mario Malausa (morto nell’attentato), che offre la prima mappa delle
famiglie mafiose di Palermo, e nell’estate di quell’anno un’operazione
di polizia porta all’arresto di 250 presunti mafiosi. In realtà le radici di questo scontro risalivano agli anni precedenti, con gli assestamenti della mafia palermitana, l’ascesa dei La Barbera e i conflitti legati al
traffico di stupefacenti (Catanzaro, Il delitto come impresa cit., pp.
182 sgg.). 8 Cfr. S. Gesù, L’effetto padrino, ibid., pp. 138-40. 9 Cfr. A Dino, Mutazioni. Etnografia del mondo di Cosa Nostra, La Zisa, Palermo 2002, pp. 170-1. 10 Per un’esposizione teorica di questo progetto editoriale si veda
C. Macchitella, Nuovo cinema Italia. Autori, industria, mercato, Marsilio, Venezia 2005. 11. È significativo, però, il recente successo di II traditore (2019) di
Marco Bellocchio, su Tommaso Buscetta: ancora una volta, la chiave è forse nell’evoluzione del sistema dei media, nel riposizionamento del pubblico del cinema d’autore, pronto a riconoscere un sistema
narrativo che viene percepito come prossimo alle strutture delle serie tv «di qualità». 12 Ogni anno nuove produzioni o repliche di vecchie serie generano
un effetto di ritualità, amplificato in occasione di anniversari più
«tondi», come il venticinquennale del 2017, in cui dalle 8 del mattino del 23 maggio si susseguirono una serie di programmi sulla mafia: la
trasmissione Agorà, Gli archivi del Novecento di Paolo Mieli, il film
di Alberto Negrin Paolo Borsellino. 157 giorni, una puntata speciale di Cartabianca con Bianca Berlinguer, fino a Caro Marziano, in prima serata, comprendente una «orazione civile» condotta da Fabio
Fazio, con Roberto Saviano e Pif. 13 Sui limiti del mafia moine italiano e della produzione televisiva contemporanea si veda l’intervento del giudice Roberto Scarpinato,
Mafia in cerca d’autore, in «MicroMega. Almanacco del cinema»,
2014,9, pp. 98-112, che insiste proprio sul silenzio intorno al vasto e
articolato mondo dei «colletti bianchi», sia nei film d’azione che nelle
biografie dei martiri antimafia: «Nell’uno e nell’altro caso il risultato finale [...] è il racconto di una storia semplice che emoziona, indigna e,
tuttavia, ci rassicura nella convinzione che il male è fuori di noi, e
quindi non ci riguarda se non come potenziali vittime» (p. 111). 14 Se fin dall’inizio «la forza del codice culturale mafioso e la sua
persistenza nel tempo dipendono dal fatto che molto spesso, come nel caso della “pedagogia nera”, ogni suo “tassello” è condiviso da altri
codici culturali, quali il borghese-perbenista e il cattolico-moralista» (A. Cavadi, Il Dio dei mafiosi, San Paolo, Cinisello Balsamo 2009, p. 82), oggi Cosa Nostra laica e manageriale ci somiglia forse ancora di
più. 15
J. Schneider (a cura di), Italy’s «Southern Question».
Orientalism in One Country, Berg, Oxford-New York 1998. 16 C. De Seta, L’Italia nello specchio del Grand Tour, in Storia
d’Italia. Annali, V, Il paesaggio, Einaudi, Torino 1982, p. 233. 17 N. Moe, Un paradiso abitato da diavoli. Identità nazionale e immagini del Mezzogiorno, L’ancora del Mediterraneo, Napoli 2004,
PP- 59j 5118 E. W. Said, Orientalismo (1978), Feltrinelli, Milano 2005. Ovviamente il testo si riferisce a luoghi ed epoche assai lontani da
quelli qui esaminati, e le logiche sono applicabili solo in piccola parte
al nostro caso, ma il metodo per la decostruzione dello sguardo
sull’altro ha per noi una certa utilità in molti suggerimenti. Ad esempio: «L’orientalismo corrispondeva più alla cultura in cui si era sviluppato che al proprio supposto oggetto di indagine, anch’esso
creazione occidentale. Così, la storia dell’orientalismo possiede sia
una notevole coerenza interna, sia una serie di legami articolati con gli ambiti limitrofi del sapere occidentale, creando una forte impressione
di oggettività» (p. 31). 19 J. Schneider, Prefazione a Id., Italy’s «Southern Question» cit.,
p. 1. 20
Cfr. Moe, Un paradiso abitato da diavoli cit.; G. D. Basile, Said
«nonostante Said». Il dibattito sull’«orientalism in one country» e i
processi letterari di orientalizzazione del Mezzogiorno italiano, in Identità, migrazioni e postcolonialismo in Italia. A partire da Edward Said, a cura di B. Brunetti e R. Deroberti, Progedit, Bari
2014, pp. 94-110. Sul rapporto tra visione ottocentesca del progresso e cultura siciliana si veda P. Violante, Il disagio del progresso, Edizioni
della battaglia, Palermo 1995. 21 s , «Alla borghesia siciliana (così come, a suo tempo, ai baroni) il
sicilianismo è servito strumentalmente per rivendicare la propria
“autonomia”, il proprio diritto cioè di esercitare nei modi tradizionali il potere locale, e nel rapporto con le masse soggette [...]. Il
sicilianismo è, in ultima analisi, l’ideologia della mafia, se per mafia s’intende, come si deve intendere, la forma specifica, la genesi ed il
modo di essere specifico, della borghesia siciliana» (M. Mineo, La
questione meridionale e le tesi del manifesto [1971], in Id., Scritti sulla Sicilia, Flaccovio, Palermo 1995, p. 207). 22 G. Pitrè, Usi, costumi, usanze e pregiudizi del popolo siciliano, Il Vespro, Palermo 1978, pp. 280-94. 23 S. Lupo, La mafia. Centosessanfanni di storia. Tra Sicilia e
America, Donzelli, Roma 2018, pp. 68-9. Pitrè stese il manifesto del
comitato pro-Palizzolo e fu ascoltato come teste a discarico. Lupo elenca nel suo studio i numerosi riferimenti diretti e indiretti alle sue
tesi da parte di mafiosi, ma anche di studiosi e di sentenze della
magistratura. 24 L. Sciascia, La Sicilia e il cinema, in Film 1963, a cura di V. Spinazzola, Feltrinelli, Milano 1963, poi in Id., La corda pazza.
Scrittori e cose di Sicilia, Einaudi, Torino 1970, ora in Opere, I, 1956-1971, Bompiani, Milano 1987, pp. 1210 sgg. 25 Molto minore l’uso di reportage di autori non siciliani: ad
esempio Arrigo Petacco (Il prefetto di ferro, di Pasquale Squitieri) e Lino Jannuzzi (Lucky Luciano, di Francesco Rosi). 26 . . , . A volte, va aggiunto, nei film verranno convocati nomi
significativi della cultura isolana, in una fase in cui il recupero da
sinistra delle tradizioni popolari ha un forte valore politico: è il caso del poeta Ignazio Buttitta e della cantante Rosa Balistreri
(rispettivamente autore e interprete della Ballata del prefetto Mori
per II prefetto diferro) e del puparo e cuntista Mimmo Cuticchio, autore del lamento funebre che chiude Cento giorni a Palermo (1983) di Giuseppe Ferrara. 27 . . ... Moe, Un paradiso abitato da diavoli cit., pp. 281-3. 28 Sull’ambiguità della posizione di Sciascia nel Giorno della civetta si veda G. Giudice, Leonardo Sciascia. Lo stemma di Racalmuto, L’ancora del Mediterraneo, Napoli 1999, pp. 31-43; sulla
sua posizione come modello interpretativo, anche a confronto con Lampedusa, si veda S. Lupo, Che cos’è la mafia. Sciascia e Andreotti, l’antimafia e l’antipolitica, Donzelli, Roma 2007, pp. 3-36. 29 Dino, Mutazioni cit., p. 150. 30 Cavadi, Il Dio dei mafiosi cit., p. 27. 31 Sull’uso dei Beati Paoli fino a tempi recenti cfr. F. Benigno, La
mala setta. Alle origini di mafia e camorra, 1859-1878, Einaudi, Torino 2015, p. 380. 32 F. Varese, Vita di mafia, Einaudi, Torino 2017, pp. 136-42. 33 Ibid., pp. 147-51. 34
Il gusto della pubblicità era semmai più diffuso tra i boss italo-
americani: Lucky Luciano morì di infarto a Napoli, mentre era
all’appuntamento con il produttore Martin Gosch, che progettava un film su di lui, nonostante vari esponenti della mafia tentassero di
dissuadere il boss dall’idea. Le dichiarazioni di Luciano divennero poi
un libro: M. A. Gosch - R. Hammer, The Last Testament of Lucky Luciano, Little Brown & Co., Boston 1975 (L’ultimo testamento di
Lucky Luciano, Sperling & Kupfer, Milano 1975). Cfr. S. Lupo, Quando la mafia trovò l’America. Storia di un intreccio intercontinentale, 1888-2008, Einaudi, Torino 2008, p. 188. 35 La moglie di Riina chiede i danni. Ma il boss si commuove
davanti alla tv, www.corriere.it(https://www.corriere.it/cronache
/o7_novembre_3o/riina_richiesta_danni_a948be8o-9f5i-ndc88o7-ooo3ba99C53b.shtml). Notiamo che in seguito dalla serie ha
preso il nome un’operazione antimafia dei carabinieri di Agrigento: in questo caso «il boss, un giovane studente universitario [...] coinvolto
nello smercio della droga, cercava in tutti i modi di emulare Totò Riina, atteggiandosi come il protagonista della miniserie televisiva»
(A. Nicaso, Mafia, Bollati Boringhieri, Torino 2016, p. 90). 36 R. Saviano, Il boss mascherato. Ecco perché nessun partito è al riparo da infiltrazioni mafiose, in «la Repubblica», 16 gennaio 2016. 37 Nel 2001, ad esempio, al Festival di Taormina Alberto Sordi
raccontò i contatti avuti con un boss di Belmonte Mezzagno in
occasione delle riprese di Mafioso: «Avevamo fatto i sopralluoghi a Belmonte Mezzagno ma la gente del luogo non collaborava. Eravamo
all’hotel Villa Igiea di Palermo e Dino De Laurentiis stava già pensando di spostare il set in Tunisia. A un tratto si presenta un signore ben vestito e con inconfondibile accento siciliano, ci saluta, ci
riverisce poi gli spieghiamo che a Belmonte la gente si nasconde alla nostra vista. “Ma che dite?”, replica lui, “non ri preoccupate che
domani la gente sarà a vostra disposizione”. E così fu, il giorno dopo
c’era tutto il paese in piazza: stavamo per girare un film chiamato “H mafioso” e avevamo avuto già il nostro incontro ravvicinato» (M.
Lorello, Sordi: «Ero un mafioso finto ma incontrai un boss vero, in «la Repubblica», 7 luglio 2001). 38 R. Marceca - S. Palazzolo, Il pizzo di Cosa Nostra sulla fiction
antimafia, ivi, 15 dicembre 2011. Un tentativo di estorsione è stato segnalato nel 2012 sul set della fiction II segreto dell’acqua-, si veda S.
Palazzolo, I boss sul set delfilm con Scamarcio. «Imponevano mezzi
e comparse», 41 arresti, in «la Repubblica - Palermo», 23 ottobre 2012, https://palermo.repubblica.it/cronaca/2012/10/23/news
/i_boss_sul_set_del_film_con_scamarcio_imponevano_mezzi_e_c
omparse_4o_arresti-45iii7i2/. Sul tema si veda F. R. Massaro, Cinematografia organizzata. La mafia tra fiction e realtà, Ensemble,
Roma 2015, pp. 63-72. 39 A. Bolzoni, Parole d’onore, Rizzoli, Milano 2008, pp. 307-8. 40 I primi germi di questo volume sono nel mio volumetto Lampi
sull’isola. Nuovo cinema siciliano 1988-1996, Edizioni della battaglia, Palermo 1996. Una prima sistemazione nel saggio Mafia movie
all’italiana, in «Lo Straniero», 2007, 82. Altre parti sono comparse,
in versioni differenti, in volumi: il capitolo su In nome della legge, in
Il cinema di Pietro Germi, a cura di L. Malavasi ed E. Morreale, Edizioni Sabinae, Roma 2015; quello su Damiani in Damiano
Damiani: politica di un autore, a cura di C. Uva, Bulzoni, Roma 2014; alcuni passi su Cipri e Maresco e su Giorgio Castellani in
L’immaginario devoto tra mafie e antimafia, a cura di L. Mazzei e D.
Orecchia, Viella, Roma 2018. Una parte del cap. VI è stata letta al convegno La strage di Portello della Ginestra tra storia e memoria, organizzato dall’istituto Gramsci Siciliano (Palermo-Piana degli
Albanesi, 22 aprile 2017). 41 Sulle aporie e le ambiguità di certi settori dell’antimafia negli ultimi anni si vedano F. Forgione, I tragediatori, Rubbettino, Soveria Mannelli 2016; G. Di Girolamo, Contro l’antimafia, H Saggiatore,
Milano 2016. 42 Uniche eccezioni i citati Belluscone e La mafia non è più quella
di una volta (2019) di Franco Maresco. 43 Ravveduto, Lo spettacolo della mafia cit., pp. 151-2.
Hanno riletto il testo, in tutto o in parte, segnalandomi errori, e a volte mettendo in discussione i presupposti, amici e studiosi: Francesco Benigno, Nino Blando, Simone Caputo,
Sara Conforti, Filippo D'Angelo, Goffredo Fofi, Laura
Gaiardoni, Alma Mileto, Nino e Alessandro Morreale, Susanna Nicchiarelli, Paolo Noto, Mariapaola Pierini, Francesco Pitassio, Umberto Santino, Federico Varese.
Mi sono state utili le conversazioni, sui film propri e altrui, con alcuni registi: Gianni Amelio, Roberto Andò, Franco
Maresco, Giuseppe Tornatore. Ringrazio il personale della Biblioteca «Paolo Giuntella»
della Rai (Stefano Nespolesi), dell’Archivio centrale dello
Stato, del Museo nazionale del Cinema di Torino (Claudia Gianetto), della Cineteca del Comune di Bologna (Anna Fiaccarmi) e del Csc-Cineteca nazionale (Sergio Bruno).
Mi hanno fornito libri o film Roberto Curri, Alberto Pezzotta, Pier Luigi Raffaelli, Dana Renga. Infine, un ringraziamento a Carmine e Marta Donzelli,
Marianna Matullo, Simona Santarelli.
i. Le mafie interpretate
i. Le coppie classiche: mafia e sottosviluppo, mafia vecchia e mafia
nuova. Scrivere delle rappresentazioni cinematografiche di Cosa Nostra
significa, indirettamente, confrontarsi con una sterminata bibliografia giornalistica e scientifica sulla mafia, cresciuta soprattutto a partire dagli
anni ottanta del secolo scorso. Dal confronto con i numerosi punti di vista
emerge comunque una relativa impermeabilità del cinema, una sua non comunicazione con le acquisizioni degli studiosi, ma non è da trascurare
l’effetto di alcuni paradigmi influenti che hanno agito soprattutto nei film
di maggiori pretese artistiche o politiche. È il caso della lettura di Michele Pantaleone, che vede imo stretto
legame tra Cosa Nostra e feudo: «La mafia è nata nella zona tipica del feudo, nel cuore dell’isola. Questa zona può tuttora essere individuata;
comprende le province di Palermo, Trapani e Agrigento ed è delimitata verso oriente dai confini delle province di Caltanissetta ed Enna»\
L’interpretazione di Pantaleone è stata dominante per oltre un ventennio,
ed è in parte figlia della stagione delle lotte contadine e delle occupazioni delle terre (l’autore era un militante socialista di Villalba) . Corollario importante è la centralità di boss come don Calogero Vizzini di Villalba o
Giuseppe Genco Russo di Mussomeli, e il loro ruolo attivo nello sbarco alleato del 1943. Questa prospettiva non era in realtà l’unica nemmeno all’epoca , ed è stata messa radicalmente in discussione dagli storici (molti
provenienti dalla scuola di Giuseppe Giarrizzo all’università di Catania)
già dalla metà degli anni ottanta4. Con particolare riguardo alla fase della mafia post-unitaria e del fascismo, Salvatore Lupo e Rosario Mangiameli evidenziano il carattere moderno, urbano della mafia, con un forte
radicamento a Palermo e nei comuni limitrofi, da Castellammare del Golfo alla Conca d’oro3, e la pervicacia di alcuni miti (come il ruolo di Cosa
Nostra nello sbarco alleato); inoltre mostrano attenzione alle differenze
tra singole storie locali, rinunciando a una visione univoca della mafia a
vantaggio della sua differenziazione locale e della sua evoluzione storica. Secondo Mangiameli, al fondo del racconto di Pantaleone c’è
implicitamente l’idea di una mafia mitica e invincibile, e «la fortuna dello stereotipo coniato dall’autore si misura anche dal fatto che ormai pochi tra
quanti lo riprendono si ricordano del suo autore, tanto il cinema, la televisione, le inchieste di tutti i tipi lo hanno oggettivato in una circolarità del discorso pubblico che ha bisogno di miti per suscitare attenzione» .
Nell’ultimo suo studio sull’argomento, Lupo propone un’interpretazione
basata su un parallelismo, già chiaro a fine Ottocento, tra la mafia della
costa palermitana e Cosa Nostra americana, rapporto che spiega passaggi
decisivi fino ai giorni nostri . L’idea della mafia come espressione di «residui feudali» aveva trovato
conferma nelle pagine di illustri storici marxisti come Emilio Sereni o Eric
Hobsbawm, nei quali emerge talvolta anche il sottotesto di un’identità locale forte che non si riesce ad assimilare in uno Stato burocratico g moderno . Un altro testo importante, l’inchiesta del sociologo tedesco Henner Hess (tradotta negli anni settanta con una prefazione di Sciascia), offriva una visione culturalista implicitamente presente nell’immagme
della mafia fin dall’ottocento: essa è indice del fallimento del monopolio
della violenza legittima, e il mafioso nasce come «un’istituzione di
autogiustizia», nelle more tra crisi del feudalesimo e ritardo dello Stato .
Questa visione della mafia come figlia del sottosviluppo, all’interno di una dialettica tra oppressori e oppressi, soggiace ai titoli più politicamente espliciti del cinema degli anni settanta, da II sasso in bocca di Giuseppe
Ferrara a La violenza: quinto potere di Florestano Vancini; ma l’immagine del legame mafia/feudo rimane operante solo nella fase aurorale del genere. Le vicende criminali degli anni settanta rendono infatti influente anche un’altra idea: quella di una radicale opposizione tra
mafia vecchia e mafia nuova, tra mafia del feudo e mafia urbana
imprenditrice. Opposizione che risale addirittura al secolo precedente, ma
che sta al centro di libri come La mafia imprenditrice (1983) di Pino Arlacchi, ed è stata anch’essa ripetutamente messa in discussione10. Al cinema, come abbiamo detto, l’immagine della «mafia del cemento» è
centrale per la prima volta nel 1971 in Confessione di un commissario di polizia al procuratore della Repubblica, con la ridefinizione del mafia
morie da western contemporaneo (come era fino a II giorno della civetta) a variante del poliziesco urbano.
Come hanno ricordato gli storici, la contrapposizione tra una mafia «vecchia» (più o meno buona, o ragionevole) e una «nuova» (cieca e
feroce) attraversa l’intera storia dell’organizzazione, fin dall’ottocento, utilizzata come strumento di lettura da forze dell’ordine, commentatori e criminali stessi11. Notiamo che queste idee (la mafia come figlia del sottosviluppo e figlia del feudo, la contrapposizione tra mafia vecchia e
mafia nuova, la forte connotazione culturalista)
sono in fondo le stesse
che il cinema assume come proprie da subito, e non sono di fatto troppo lontane dalla rappresentazione di sé che i mafiosi davano all’interno e all’esterno: si pensi alle motivazioni del pentimento di Buscetta, che si
voleva orgogliosamente membro della vecchia Cosa Nostra, «tradita» dai corieonesL
2. L'epoca delle interpretazioni
A partire dagli anni ottanta, dopo gli omicidi «eccellenti» che
punteggiano la seconda guerra di mafia (da Cesare Terranova, nel 1979, a Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel 1982), si fa strada una pubblicistica sulla
mafia anche di alto livello, e le rielaborazioni giornalistiche diventano un
genere fiorente. Nel contempo, una serie di iniziative pedagogiche prende
sempre più spazio nelle scuole, e si forma una nuova generazione di sacerdoti e di teologi. Un percorso che porterà a una rilettura, spesso autocritica, dei rapporti tra le chiese e Cosa Nostra.
Umberto Santino ha diviso la storia delle interpretazioni della mafia
secondo le discipline: storia, sociologia, criminologia, economia,
psicoanalisi, e per tutte queste aree un discrimine importante risulta appunto il periodo successivo alla seconda guerra di mafia. Gli antropologi invece, a dispetto di una fiorente scuola nell’università di Palermo (da
Giuseppe Cocchiere ad Antonino Buttitta), hanno indagato poco o nulla il
fenomeno , mentre, sulla scia di studiosi stranieri come Anton Blok e Jane e Peter Schneider, spunti in senso lato antropologici hanno nutrito la
ricerca di sociologi stranieri, a cominciare da Renate Siebert. Se in questa
sede il lavoro dei criminologi e degli economisti (il cui interesse Santino data dal 1992, in occasione di un convegno della Società italiana degli economisti)
interessa meno, vanno invece ricordate alcune
interpretazioni forti che hanno influenzato più di altre la percezione
collettiva del fenomeno. Nel 1992 il libro La mafia siciliana. Un’industria della protezione privata3 del sociologo Diego Gambetta, che sostiene la tesi della mafia
come «industria della protezione», suscita molte polemiche tra storici e sociologi perché sembra mettere la sordina all’elemento della violenza e
appiattire tutto in una spiegazione univoca, derrata dallo schema della «mafia imprenditrice», perdendo di vista la complessità delle relazioni tra criminalità e imprenditoria . Le tesi di Gambetta hanno suscitato una eco
tale che il cattivo di una miniserie televisiva sulla mafia, L’impero (2001), diretta da Lamberto Ba\a, le ripete fedelmente come giustificazione del
proprio operato. Ancora più interessante per il nostro ambito, ma da maneggiare con cura, il lavoro di psicologi e psicoanalisti: come la lontana e fin troppo
suggestiva lettura di Filippo Di Forti, che si rifaceva al mito freudiano
dell’«orda primitiva»
e quella largamente screditata della junghiana
Silvia Di Lorenzo, con Cosa Nostra «grande madre» che si oppone alla
società dei Padri e ha per oggetto d’amore la Grande Madre Terra . Lo sguardo di psicologi e psicoanalisti si è però rivelato utile, anche per il cinema, dopo le rivelazioni dei pentiti, che hanno consentito di gettare imo
sguardo sull’interno dell’organizzazione. Si sono affacciate interpretazioni ardite, come quella di Girolamo Lo Verso
19
che analizza i pentiti in chiave
antropologica, come «vere e proprie narrazioni di una cultura, di uno
schema mentale e di un processo di significazione della realtà». Al di là delle semplificazioni (il sentire mafioso come «sindrome depressiva etnica»)
20
, questa prospettiva «interna» ha influenzato anche molte 21
riflessioni dei magistrati direttamente coinvolti nelle indagini , e per l’opinione pubblica come per gli autori di cinema e tv hanno assunto
importanza figure sfumate, percorsi esemplari di donne (da Felicia Bartolotta a Rita Atria) o di soggetti che secondo i paradigmi precedenti
(ma non, ad esempio, secondo Falcone) erano considerati «marginali», come il primo pentito della nuova mafia, Leonardo Vitale, figura psichicamente instabile e tutfaltro che lineare. Un notevole arricchimento è arrivato dall’emergere di uno sguardo «di
genere» . In questo caso si può dire che l’interesse per le figure femminili di Cosa Nostra sia l’esempio più eloquente di un certo allineamento tra interessi degli studiosi, autori di cinema e attenzione della società civile,
che copre una mezza dozzina d’anni dopo le stragi del 1992 (si pensi a titoli come Angela di Roberta Torre o La siciliana ribelle di Marco
Amenta, ma anche alla figura della madre di Giuseppe Impastato nei Cento passi).
3. Una visione complessa.
Oggi l’impostazione sociologica si innesta volentieri su quella psicologica , in una prospettiva sempre più integrata tra le discipline che non trascura l’elemento della rappresentazione e
dell’autorappresentazione. L’analisi della composizione sociale di Cosa
Nostra, sia nel passato che al presente, è sempre più sfumata. Come ricorda Salvatore Lupo, l’esistenza della mafia «mette in crisi il nostro concetto di modernità [...]. Per troppo tempo ci siamo raccontati la favola
che la mafia fosse figlia del sottosviluppo. Poi abbiamo invertito i termini del discorso, dicendo che il sottosviluppo è figlio della mafia. Entrambe le ...
„
24
proposizioni sono errate» . Umberto Santino ha spesso utilizzato la nozione di «borghesia mafiosa», mutuata dalle analisi di Mario Mineo e del gruppo siciliano del
«manifesto» negli anni settanta, per indicare il ruolo della violenza nei
processi di accumulazione e il sistema relazionale entro cui si muovono i
mafiosi °. Ma gli studiosi ormai concordano sull’idea che «la mafia è un
sistema di mobilità sociale individuale. Lungi dall’essere immobili o statiche, le società in cui si sviluppa [...] sono caratterizzate da elevata instabilità e da processi di mobilità sia ascendente che discendente»
26
. E,
mentre la composizione di Cosa Nostra muta, con personalità manageriali
che un tempo sarebbero stati fiancheggiatori esterni e oggi assumono sempre più posizioni di responsabilità, si espande e articola quella che alcuni hanno definito la «zona grigia» 7 : il concorrente esterno, il
favoreggiatore sporadico, l’imprenditore che non necessariamente subisce l’intimidazione ma collabora in prima persona
2S
.
Nel frattempo, rimangono attivi vecchi paradigmi (si pensi alla lettura dello sbarco in Sicilia offerta da un film come In guerra per amore, di Pif,
ricalcata ancora sul modello di Pantaleone) e, in fondo, le varie aree della
«borghesia mafiosa» non sono mai state raccontate a fondo. Ma ovviamente, altrettanto importante per il cinema è la vasta pubblicistica militante e giornalistica, precorsa dalla serie di volumi pubblicati dalla casa editrice La Luna dagli anni ottanta, insieme ai
documenti prodotti dal Centro Impastato. Le interviste ai pentiti, a
cominciare da Buscetta e Calderone , i volumi basati sulla lettura degli atti giudiziari
e il lavoro dei cronisti hanno costituito una base concreta
di narrazioni già «semi-lavorate». Palermo ha conosciuto generazioni di
cronisti di prim’ordine, allevati nella redazione de «L’Ora» ma non solo, e
i fatti di mafia sono stati seguiti da giornalisti i cui volumi hanno ispirato film, o che hanno spesso prestato la loro attività di consulenza al cinema.
La maggior parte dei film su Cosa Nostra degli ultimi decenni, anche quando è ispirata ad ewenimenti reali, dichiara come fonte diretta il testo
di un giornalista31.
Impressionante, d’altro canto, la completa assenza della narrativa di finzione da questo panorama. Cosa Nostra ha alimentato una pubblicistica sterminata di non-fiction, ma (a differenza del terrorismo politico) non ha
prodotto quasi nessuna rielaborazione letteraria, con qualche eccezione di poca influenza, come Malacarne (1997) di Giosuè Calaciura, forse il miglior romanzo sulla mafia dai tempi del Giorno della civetta . Peraltro,
ricordiamo che il libro del 1961 rimane, con un paio di racconti successivi, l’unico testo narrativo di rilievo esplicitamente dedicato alla mafia da
Sciascia, che l’ha più spesso indagata in veste di saggista. L’Italia non ha in
fondo prodotto nuovi modelli letterari per raccontare Cosa Nostra. Nel frattempo, negli ultimi anni, nuove impostazioni sottolineano come la realtà storica della criminalità organizzata sia difficilmente separabile
dagli strumenti con cui essa è stata «costruita» dalle fonti dell’epoca (giudiziarie ma anche letterarie), e come questa costruzione abbia
retroagito sulle associazioni criminali stesse. Francesco Benigno propone di leggere i rapporti dei prefetti dell’Italia unita, nutriti da fonti letterarie
(dai Misteri di Parigi di Eugène Sue a Dumas padre, che «racconta della camorra come parte della descrizione di un mondo, quello napoletano, delineato come perdutamente esotico»)
e insieme armi di lotta politica
(contro borbonici e repubblicani prima, socialisti e anarchici poi), nella loro dimensione performativa, per cui «il crimine risulta in pratica indistinguibile dalla sua rappresentazione, sorta di fantastico schermo su
cui si proiettano le ansie sociali e le inquietudini culturali di ima società»
. E in particolare il modello della setta, dell’associazione di
malfattori, a venir sospettato da Benigno di essere un’arma di lotta politica, una produzione discorsiva di cui in seguito le organizzazioni
criminali, mafia e camorristi in primis, si riapproprieranno in una sorta di
«invenzione della tradizione» (in alcuni casi rivendicata: si veda l’esempio dei Beati Paoli citato nel capitolo precedente)35. Questo modello, va
aggiunto, impone di leggere insieme, sullo sfondo di un gioco politico nazionale e locale, i discorsi su mafia, camorra e associazioni criminali romagnole, piemontesi e di altre regioni. Si tratta di questioni sottili, che
comunque in uno studio sul cinema (concentrato dunque sulla
dimensione culturale ed estetica) possono fornire spunti suggestivi. In anni recenti, si è affacciato un ultimo filone particolarmente utile per
la prospettiva di questo libro. Si tratta degli studi culturali che hanno
proposto una lettura di Cosa Nostra non semplicemente in chiave di
intreccio con la politica e l’economia, in una prospettica con cui questo libro in parte converge. Una visione assai diversa da quella antropologica e culturalista tradizionale, attenta alla complessità della dimensione
discorsiva e dell’immaginario: Robert Dainotto, ad esempio, in un’analisi
comparata tra Usa e Italia, ha messo al centro l’intersezione con la letteratura e soprattutto con i media; Marco Santoro ha affrontato la produzione culturale e l’autorappresentazione (attraverso le dichiarazioni dei pentiti o le canzoni di mafia)
36
.
Un’ultima precisazione. In questo volume si farà riferimento quasi
esclusivamente alle rappresentazioni della mafia siciliana. Ciò non implica
una unicità, o una impermeabilità della stessa, rispetto alle altre organizzazioni criminali. I contatti tra Cosa Nostra e camorra sono
attestati da lunga data, così come quelli con la ’ndrangheta (per limitarci ad assetti relativamente recenti, siciliani erano i killer della strage di Locri
del 1967, ed esponenti del clan camorristico Nuvoletta erano affiliati a
Cosa Nostra e legati in particolare a Luciano Liggio)
. Dall’altro lato,
analisi comparate tra le organizzazioni criminali italiane e intemazionali
hanno mostrato sempre più una loro validità. Sul tema, del resto, ben
prima che si cominciasse a parlare di globalizzazione, aveva già parole assai ragionevoli Giovanni Falcone:
Il modello criminale mafioso, in quanto connotato da una particolarissima specificità ambientale, a mio avviso non sarebbe traspombfle in altre realtà. (...)
Posto in questi termini, d si accorge subito tuttavia che d si trova di fronte a un falso problema. In realtà, nel panorama criminale intemazionale, le maggiori organizzazioni, anch’esse depurate dalle loro specifiche connotazioni ambientali, presentano caratteristiche non dissimili da quelle della mafia33.
Oggi sono camorra, ’ndrangheta e criminalità organizzata laziale a
fungere da luoghi di rappresentazione del presente, da punto di tensione e di compromesso tra cinema d’autore e creazione di nuovi filoni 39
cinetelevisivi , e da terreno per nuovi modelli estetici (Anime nere, Gomorra film).
Tuttavia quella che raccontiamo è, come detto, la storia di una rappresentazione della Sicilia, di un altrove fortemente connotato da
immagini letterarie e cinematografiche. Salvo poche eccezioni, per il cinema italiano, il modello con cui si è pensata la criminalità organizzata è, per tutto il Novecento, quello della mafia siciliana. E, anzi, proprio la
mutazione e il declino dell’immagine di questa mafia sono eloquenti: dallo strutturarsi di un genere all’integrazione in un discorso «d’autore» più
attento alle specificità storiche, fino alla difficoltà di leggerne le
manifestazioni attuali.
M. Pantaleone, Mafia e politica, Einaudi, Torino 1962, p. 21.
Esemplare l’introduzione di Carlo Levi al volume: «Se io penso alla mafia, alla sua esistenza e
natura, ai mille, complessi problemi che le sono legati, alla molteplicità e oscurità delle sue azioni, alle sue cause lontane e ai suoi motivi recenti, ai suoi rapporti con le strutture dello stato e con quelle della società siciliana, agli anacronismi di cui è espressione alle sue antitesi con quanto vi è
di vivo, di nuovo e di operante nel movimento popolare e contadino, se insomma, mi avviene in
qualche modo di osservare, nelle più minute vicende quotidiane, o nello svolgersi della vita collettiva, o nel suo pesare sulle forze politiche, sul costume della Sicilia e sull’Italia, uno qualunque
dei mille aspetti della mafia (...) sempre mi appare un’immagine che mi sembra riassumere, come una pittura che esprima in modi semplici ed evidenti tutti i sentimenti e i valori di un periodo
storico, la realtà e l’assurdo di quel fenomeno oscuro, come un suo completo equivalente fantastico, una sua forma pura e tuttavia obiettivamente esistente. Questa immagine è la piazza di Villalba,
come io la vidi dalla finestra della casa di Michele Pantaleone, nella prima ora di una mattina di maggio, pochi anni fa» (Pantaleone, Mafia e politica cit, pp. X-xi). 3 II libro di Pantaleone arriva dopo una breve fase in cui gli storici di professione si interessano in maniera particolare alla mafia, prima di un silenzio che durerà fino agli anni ottanta: un esempio
è V. Titone, Storia, mafia e costume in Sicilia (Edizioni del Milione, Milano 1964), che presuppone una mafia come «espressione dell’anima dell’isola» e insieme «come l’esasperazione o il massimo
denominatore comune di certi dati umani in essa quasi universalmente diffusi» (p. 158). (Curioso che Titone utilizzi un termina tipico di quegli anni, specie per via dei film di Antonioni, dichiarando che la mafia, espressione di un popolo chiuso in se stesso, è «il dramma di un’ancestrale
incomunicabilità», p. 290). Tra le opere pionieristiche la più avveduta è S. F. Romano, Storia della mafia (Mondadori, Milano i960), che ribadisce come per mafia non si debba intendere ogni crimine organizzato, ma solo quello caratterizzato dall’alleanza tra gruppi dominanti e gruppi facinorosi per l’egemonia, e si tratti di un fenomeno caratteristico di una società in sviluppo,
divenuto problema non locale ma nazionale. Anche Domenico Novacco (Inchiesta sulla mafia, Feltrinelli, Milano 1963) è molto attento alle figure di mediazione dei gabelloti e ai rapporti con politica e istituzioni. Sulle interpretazioni storiche della mafia fino agli anni ottanta si veda R.
Spampinato, Per una storia della mafia. Interpretazioni e questioni controverse, in Storia d'Italia.
Le regioni dall'unità a oggi. La Sicilia, a cura di M. Aymard e G. Giarrizzo, Einaudi, Torino 1987,
pp. 883-902. 4
Si vedano i saggi di Salvatore Lupo, Giuseppe Giarrizzo, Rosario Mangiameli, Rosario
Spampinato e Paolo Pezzino contenuti in Aymard - Giarrizzo (a cura di), Storia d’Italia. Le regioni
dall'unità a oggi. La Sicilia cit Vari saggi di Rosario Mangiameli sono stati raccolti in Id., La
mafia tra stereotipo e storia, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2000, pp. 23-4. ' II che porta anche a smorzare la tradizionale visione di una «vecchia mafia» urbana di Palermo
sconfìtta dall’ascesa dei corìeonesi: «E sempre esistita una grande provincia maliosa che fa centro sulla città e le sue borgate, che lungo la costa va da Partinico a Bagheria, mentre verso l’interno si
spinge fino a Corleone» (S. Lupo, Potere criminale. Intervista sulla storia della mafia, a cura di G.
Savatteri, Laterza, Roma-Bari 2010, p. 109). 6 Mangiameli, La mafia tra stereotipo e storia dt, pp. 23-4. Lupo, La mafia cit
s
«Prima ancora che un’organizzazione vera e propria, [la mafia è] un modo di vita, comune a
tutta la società siciliana: dove mafioso è chiunque fa rispettare, con violenza o grazie alle aderenze personali di cui egli dispone, quelli che egli reputa i propri diritti» (E. Sereni, Il capitalismo nelle campagne, Einaudi, Torino 1968, p. 160); cfr. anche E. J. Hobsbawm, I ribeffi, Einaudi, Torino 1965; Id., I banditi, Einaudi, Torino 1969.
1 H. Hess, Mafia, Laterza, Roma-Bari 1974, p. 228. 1 Per alcune critiche affinapostazione generale e alle singole analisi di Arìacchi cfr. Catanzaro, Il
delitto come impresa cit, pp. 49-50; Lupo, Storia della mafia cit, p. 248. Un’analisi del periodico riemergere del paradigma è in Lupo, La mafia cit, passim.
Per una critica del paradigma culturalista si veda P. Puzzino, Per una critica dell'onore mafioso. Mafia e codici culturali dal sicilianismo agli scienziati sociali, in Onore e storia nelle
società mediterranee, a cura di G. Fiume, La Luna, Palermo 1989, pp. 229-48. 3 L’olandese Anton Blok (La mafia in un villaggio siciliano (1974), Einaudi, Torino 1986) trae
conclusioni generali dall’analisi di un piccolo comune deffAgrigentino, Contessa Entellina, sempre nella chiave della mafia come mediatrice di potere tra governo e comunità locale, proprietari e
contadini), mentre gli americani Jane e Peter Schneider in Classi sodali, economia e politica in
Sicilia (1976; Rubbettino, Sovexia Mannelli 1989) ricorrono come Blok ai metodi dell’antropologia
partecipativa, integrandola con un’analisi storica con proposte di interpretazione complessiva del
fenomeno. ' Gli atti sono raccolti in S. Zamagni (a cura di), Mercati illegali e mafie. L'economia del crimine organizzato, il Mulino, Bologna 1993
D. Gambetta, La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata, Einaudi, Torino 1992.
’
' Si vedano le riflessioni di Raimondo Catanzaro, esposte in numerosi saggi e sintetizzate in La mafia tra mercato e Stato: una proposta di analisi, in La mafia, le mafie, a cura di G. Fiandaca e
S. Costantino, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 142-8. Cfr. anche U. Santino, La mafia interpretata, Rubbettino, Soveria Mannelli 1995, pp. 29-60. 7
1
F. Di Forti, Le radia profonde della mafia, Silva, Roma 1971.
S. Di Lorenzo, La Grande Madre Mafia. Psicoanalisi delfenomeno mafioso, Pratiche, Parma 1996.
G. Lo Verso (a cura di), La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo, Franco Angeli, Milano 1997. F. De Maria, Identità e sentire mafioso. Percorsi per leggere le trasformazioni, in Lo Verso (a
cura di), La mafia dentro cit, pp. 37-46. * ’ R. Scarpinato, Cosa Nostra e il male oscuro della dispersione del sé, ibid., pp. 78-92. Cfr. anche A. Malinconico - N. Malorni, Psiche mafiosa. Immagini da un carcere, Edizioni Magi, Roma
2012.
Segnaliamo i volumi pubblicati dalla casa editrice La Luna (ad esempio A. Foglisi, Sole contro la mafia, La Luna, Palermo 1990), e della rivista «Mezzodelo», che hanno preceduto testi
importanti come quelli di Renate Siebert (Le donne, la mafia, Il Saggiatore, Milano 1994) e, più di
recente, di Alessandra Dino e Teresa Principato (Mafia donna. Le vestali del sacro e dell’onore,
Flaccovio, Palermo 1997). ' F. Armao, Il sistema mafia. Dall’economia-mondo al dominio locale, Bollati Boringhieri,
Torino 2000. ' Lupo, Potere criminale dt, p. 4. U. Santino, Dalla mafia alle mafie, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, p. 251. AB’intemo dell’area grigia «i mafiosi non occupano sempre e necessariamente una posizione dominante» (p.
12), essa è «un vero e proprio blocco sociale interclassista, che vive di illegalità e considera la mafia l’architrave necessario e ineliminabile» (Id., Il blocco sodale che accetta la mafia, in «la
Repubblica - Palermo», 3 gennaio 2008). 'f> Catanzaro, Il delitto come impresa cit, p. 49. * Cfr. N. Amadore, La zona grigia, La Zisa, Palermo 2007; G. Di Girolamo, Cosa Grigia, Il
Saggiatore, Milano 2012. -•N
R. Sciattone (a cura di), Alleanze neU’ombraMafie ed economie locali in Sicilia e nel
Mezzogiorno, Donzelli, Roma 2011, p. 14 * ' E. Biagi, Il boss è solo, Mondadori, Milano 1986; P. Arìacchi, Gli uomini del disonore, Mondadori, Milano 2004. 3 II primo titolo di rilievo è il fortunato Mafia. L'atto di accusa dei giudici di Palermo, a cura di
Q Stajano, Editori Riuniti, Roma 1987. 3 ' Alla luce del sole di Faenza è tratto da un libro di Bianca StancanelH, Il capo dd capi dal volume omonimo di Attilio Bolzoni e Giuseppe D’Avanzo, L'uomo di vetro da uno di Salvatore Parìagreco. Uno dei primi e più influenti testi di divulgazione giornalistica è S. Lodato, Dieci anni
di mafia, Rizzoli, Milano 1990, poi più volte aggiornato (fino a Trent'annì di mafia, Rizzoli, Milano
2006). '
Sulla narrativa di argomento mafioso si vedano M. Onofri, Tutti a cena da don Mariano,
Bompiani, Milano 1997, e M. Di Gesù, L'invenzione della Sicilia. Letteratura, mafia modernità, Carocci, Roma 2015, entrambi significativamente dedicati alla produzione precedente al 1945,
Sciascia a parte. 3 3 F. Benigno, La mala setta. Alle origini di mafia e camorra, 185^-1878, Einaudi, Torino 2015, P-95u Ibid., p. vn.
3 ’ Ibid., p. 379.
3 M. Santoro, La voce del padrino. Mafia, cultura, politica, ombre corte, Verona 2007; R.
Dainotto, The Mafia. A Cultural History, Reaktion, London 2015. Cfr. anche J. Pine, Transnational Organized Crime and Alternative Culture Industry, in The Routledge Handbook of Transnational Organized Crime, a cura di F. Allum e S. Gilmour, Routledge, New York-London 2011, pp. 335-49. Della prospettiva culturale ù tesoro in più punti anche Varese, Vira di mafia cit 3 L’esempio più radicale e sofisticato di analisi comparata e formale di mafie assai diverse tra
loro (non solo camorra e ’ndrangheta, ma anche Mafia russa e Triadi cinesi), condotto facendone emergere omologie strutturali, è F. Varese, Mafie in movimento, Einaudi, Torino 2011. Una storia comparata delle mafie italiane è L Sales, Storia delTltalia mafiosa, Rubbettino, Soveria Mannelli
2015. e tutti gli altri sottomette e corrompe», «Un’intera
comunità costretta a vivere nella sopraffazione e nella violenza»: si tratta di uno schema oppressi-oppressori, mutuato dalle analisi
progressiste della mafia contadina e applicato per semplificare un 44 sistema di potere che, ovviamente, era ed è assai più articolato .
1 Lodato, Trentanni di mafia dt, pp. 8-9. 2
L’esposizione più completa del modello dei generi che abbiamo preso in considerazione è
S. Neale, Genre and Hollywood, Routledge, London-New York 2000, spede pp. 207-30. R. Altman, Film/Genere (1999), Vita e Pensiero, Milano 2004, P- 25.
«
La trattazione più esaustiva dell’applicabilità del concetto di genere al cinema italiano è
P. Noto, Dal bozzetto ai generi. Il cinema italiano dei primi anni ’50, Kaplan, Torino 2011, pp. 71-128. Cfr. anche G. Pescatore, I generi comeforme seriali, in IIfilm e i suoi multipli, a
cura di A. Antonini, ix Convegno internazionale di studi sul cinema, Forum, Udine 2003, pp. 53-6; A. BeDavuta, H cinema dei mostri, in Gli anni delle cose. Media e società italiana negli
anni settanta, a cura di F. Colombo, pubblicazione dell’Isu Università Cattolica, Milano
2000, pp. 56-7. ° Noto, Dal bozzetto ai generi dt, p. 128. 6 V. Zagarrio, L’isola dei tre cavalieri. I misteri di Mafia, da Pisciotta a II capo dei capi, in Strane storie. Il cinema e i misteri d’Italia, a cura di C. Uva, Rubbettino, Soveria Mannelli
2011, pp. 116-7. U. Santino - G. Chinnid, La violenza programmata. Omicidi e guerre di mafia a
Palermo dagli anni ’60 a oggi, Franco Angeli, Milano 1989. Nel periodo 1981-1983 la cifra dei morti di mafia sta fra i 500 e i 1000 (Lupo, La mafia dt, p. 294).
s
Il 9 marzo del 1979 viene ucciso il segretario provùndale della De di Palermo Michele
Reina, il 21 luglio il commissario Boris Giuliano, il 25 settembre il giudice Cesare Terranova e il maresciallo Lenin Mancuso, il 6 gennaio 1980 il presidente della Regione Sicilia Piersanti
Mattarella, il 4 maggio il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, il 6 agosto il procuratore capo di Palermo Gaetano Costa; nel 1982 cadono il giudice Rocco Chinnid, il segretario regionale del Pd Pio La Torre, il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. q
G. Manzoli, Da Ercole a Fantozzi. Cinema popolare e società italiana dal boom
economico alla neotelevisione (195S-1976), Carocd, Roma 2012, pp. 103-6. IO
Un’eccezione va fatta per i maggiori successi del cinema popolare dell’epoca, ossia i film
di Bud Spencer e Terence Hih (gli unici rivolti anche a un pubblico infantile), che non inaugurano un filone se non sotto forma di sporadici epigoni, e si inseriscono invece nella
coda estrema dello spaghetti western. 11
G. P. Brunetta, Centanni di cinema italiano, n, Dal 1945 ai giorni nostri, Laterza,
Roma-Bari 1998, p. 245. 12
Per una filmografia allargata, che comprende anche titoli in cui la presenza di Cosa
Nostra non è centrale, e i film dedicati alle altre mafie si veda Ravveduto, Lo spettacolo della mafia dt, pp. 175-90. Nel conteggio di Ravveduto i film dedicati alla mafia sono 337, di cui
179 su Cosa Nastra e 119 sulla camorra. Tuttavia la presenza della camorra cresce soprattutto dagli anni novanta e più ancora dal 2006. Nd periodo 2006-2018 la camorra è stata al centro
di 32 film, Cosa Nostra di 18. Il 2006 può essere considerato quindi la data definitiva della fine dell’egemonia di Cosa Nostra nell’immaginario criminale italiano. Negli anni settanta il conto è assai più difficile, data la presenza di numerosi «poliziotteschi» che entrano in
maniera spuria nd conteggio, ma i titoli dedicati a Cosa Nostra sono comunque all’indrca la
metà dd totale. 13
Per «autore impari» Alberto Pezzetta intende una categoria di registi italiani die
esordiscono negli anni sessanta con opere ambiziose, per poi conoscere una rapida decadenza
all’interno dei generi e scomparire con l’avvento delle tv private (tra i quali lo stesso Scavolini, Brunello Rondi, Alberto Cavallone, Eriprando Visconti): «1) L’autore impari inizia con ambizioni alte, è salutato dalla critica come una promessa, e poi man mano decade. [...] 2) Possiede una poetica, anche se spesso non può (o non sa) esprimerla in modo adeguato. (...)
3) Possiede un elemento di follia. Non ama le mezze misure, ignora il buon gusto, sceglie i
temi più controversi. 4) Lo stile dell’autore impari è all’insegna dello spreco. Ossia della sproporzione tra mezzi e risultati. Nel senso, attenzione, che raffinatezze formali vengono
utilizzate in contesti che non lo richiedono. [...] 5) L’autore impari si impossessa con sicurezza e disinvoltura della cultura alta, in un contesto basso. (...) 6) è spesso in anticipo sui tempi, anche se non se ne accorge nessuno. (...) 7) Si autodistrugge con cognizione di causa» (A.
Pezzetta, Alla scoperta dell’autore impari, in «Segnocinema», luglio-agosto 2001,110, pp. 3-8). 14 C. Doglio, recensione a In nome della legge, in «Cinema», ms., 1949,21 (cfr. infra, cap.
v). 15 Alcuni esempi: La legge della mafia, Il giorno della civetta, La violenza: quinto potere,
L'onorata famiglia: uccidere è cosa nostra, Abuso di potere, Il prefetto diferro, Cento giorni a Palermo. Se il protagonista è siciliano, è appena tornato da un lungo soggiorno al Nord che
lo rende parzialmente straniero (Un uomo da bruciare, A suon dì lupara, Il caso Pisdotta) oppure è un figlio di immigrati che torna (Dimenticare Palermo'). Ovviamente, dal nostro punto di vista è secondario che l’eroe straniero sia una figura storica (Mori, Dalla Chiesa), inventata, o vagamente ispirata alla cronaca. if>
Tra gli esempi di questo secondo schema narrativo: Vento del Sud, Gente d’onore, Gli
intoccabili, E venne il giorno dei limoni neri, La mano lunga del padrino, La mala ordina, Afyon Oppio, Il consigliori, Baciamo le mani, Quelli che contano, Tony Arzente, Un tipo con
una faccia strana ti cerca per ucciderti e, con qualche variante, Un uomo in ginocchio. Anche le prime stagioni della Piovra vedono in fondo il passaggio del commissario Cattaui da eroe del primo tipo (eroe venuto da fuori) a esponente del secondo (uomo in lotta privata contro l’organizzazione). 1“
Più rare, all’epoca, le biografìe di boss veri 0 «semi-veri», sulla scia del Padrino: Crazy
Joe, Lucky Luciano, Corleone. 1S
L. Termine, La chiarezzafelice. Il sistema retorico neifilm sulla mafia, in «Nuove
Effemeridi», 1991, 13, pp. 28-9. 19
S. Palazzolo, Ipezzi mancanti. Viaggio nei misteri della mafia, Laterza, Roma-Bari
2010, p. 46. 20
Il trionfo è probabilmente nella scena del summit in E venne il giorno dei limoni neri,
in cui si riconoscono le vod del gotha dei doppiatori tutti impegnati a mimare l’accento
siciliano: Rinaldi, Gaipa, Oreste Lionello, Pino Loccht E. Morricone - G. Tomatore, Ennio. Un maestro, HarperCollins, Milano 2018, pp. 245-7* 22 R. Curii, Italia odia. Il poliziesco italiano, Lindau, Torino 2006, pp. 259-65. 23
F. Rosi, Io lo chiamo cinematografo. Conversazione con Giuseppe Tomatore,
Mondadori, Milano 2012, p. 303. 24
P. Noto, «Una voglia di western sparsa per tutto il corpo»: Germi secondo la critica
dei rotocalchi, in II cinema di Pietro Germi, a cura di L. Malavasi ed E. Morreale, Edizioni di
Bianco & Nero, Roma 2016, pp. 189-96. 25
L. Beatrice, Il western aEitahana, in Storia del cinema italiano, xi, 1965-1969, a cura
di G. Canova, Marsilio-Edizioni di Bianco & Nero, Venezia-Roma 2002, p. 142. E. Biagi, in «L’Europeo», 26 gennaio 1967. 2"
L’episodio è riferito da R. Andò, Lo scrittore e i suoi labirinti, in «Todo Modo. Rivista
internazionale di studi sciaariani», vn, 2017, p. 91. 28
* G. Falcone - M. Padovani, Cose di Cosa Nostra, Bur, Milano 1991. In particolare Falcone
si riferisce allo strangolamento di Santo Inzerillo e al prestigio derivato ai killer dall’omicidio («Misurarsi con una persona di prestigio è fonte di gloria, ucciderla ancora di più, esserne uccisi è onorevole. Trovo in questo una singolare analogia con la storia raccontata nel film
americano Corvo Rosso non avrai il mio scalpo!, che rappresenta lo strano rapporto
instauratosi tra un cacciatore solitario e una tribù a lui ostile», p. 80) e alle radici culturali di alcuni valori traviati da Cosa Nostra («Quante analogie tra gli eroi di Balla coi lupi e i siciliani, anche quando la loro cultura viene esasperata e manipolata da Cosa Nostra!», p. 82). 29
V. Buccheri, I generi cinematogrofìci: lo specchio della mutazione, in Storia del cinema
italiano, xn, 1970-1976, a cura di F. De Bernardinis, Marsilio-Edizioni di Bianco & Nero,
Venezia-Roma 2008, pp. 31-3. 30 Curii, Italia odia dt, p. 148. 21 Tra i tìtoli più indicativi deD’incrodo si veda, fin dal tìtolo, Da Corleone a Brooklyn di
Umberto Lenzi, che parte come un puro mafia movie sulla sda del Padrino ma pieno di elementi che lo collocano su un versante più puramente d’azione, e intrecciato col filone della
dne-sceneggiata di ambientazione criminale di quegli anni: cfr. M. Ravveduto, Napoli... Serenata calibro 9. Storia e immagini della camorra tra cinema, sceneggiata e neomelodici,
Liguori, Napoli 2007. 32
Buccheri, I generi cinematografici: lo specchio della mutazione dt, pp. 31-4.
33
P. Ortoleva, Cinema politico e uso politico del cinema, in Buccheri, I generi
cinematografici: lo specchio della mutazione dt, p. 152. 34
BeHavita, H cinema dei mostri dt, p. 57.
35
Curii, Italia odia, pp. 84-5,90-1. 36 In una fise ulteriore, l’escalation del terrorismo renderà gli stilemi del mafia movie (e
soprattutto la sua visione della politica) direttamente adattabili all’intera Italia: è il caso di Cadaveri eccellenti di Rosi e Todo modo di Petri, tratti dai romanzi di Sdasda, o di Io ho
paura e L’avvertimento di Damiani. 3-
Si veda il polemico elenco dei temi assentì nel cinema politico post-’68, steso all’epoca
da G. Fofi, Il cinema italiano. Servi e padroni, Feltrinelli, Milano 1971, pp. 218-9. Curti, Italia odia dt, p. 104. 39
Cfr. E. Morreale, Complotti, contesti e poliziotti di Dio. Leonardo Sciascia e il poliziesco
degli anni Settanta, in «Bianco e nero», gennaio-aprile 2017,587, pp. 76-87. 40
La storpiatura dei nomi è uno degli aspetti più singolari di questi film: Falco/Fàlcone,
Rizzo/Rizzotto, o «don Calogero Vizzoni» (cioè Vizzini) in E venne il giorno dei limoni neri. 41 Albano, La mafia nel cinema siciliano dt, p. 50. 42
Per una riconsiderazione del concetto di omertà si veda Lupo, Che cose la mafia dt, pp.
101-6; I. Sales, Storia dell’Italia mafiosa, Rubbettino, Soneria Mannelli 2015. 43
Sui rimandi tra il rapporto della Commissione, il film di Vandni e II caso Pisciotta di
Eriprando Visconti si veda A. G. Mancino, 1972. La commissione antimafia al cinema, in
«Quaderni del Csd», 2009,5, p. 49. 44 Notiamo di sfuggita che la riduzione a stereotipo dell’immagine della Sicilia, mafia compresa, era stata compendiata già nel 1995 dal film di montaggio Lo schermo a tre punte di Giuseppe Tomatore, che tra l’altro inseriva un ironico e tragico montage di morti ammazzati-
ni. Uomini e donne
E invece, e avrebbero dovuto darlo come precetto alla polizia, in Sicilia, pensava il capitano, bisognava
non cercare la donna: perché si finiva sempre col trovarla, e a danno della giustizia.
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta
Ma questo è il partouze del sottosviluppo!
Antonia Santilli, a letto con due mafiosi, in II boss di Fernando Di Leo
i. Straniere, vedove e puttane.
È vero che, «se allestissimo una galleria di «corpi» che hanno dato
interpretazione di personaggi mafiosi al cinema, proveremmo forse
un certo stupore nel vedere come sono proprio i corpi, prima ancora delle azioni, che gerarchizzano le figure e i ruoli, differenziano la
psicologia, veicolano idee e modi d’essere» . Più precisamente, salta agli occhi come questi corpi si definiscano in chiave di generi sessuali,
offrendo modelli precisi di maschile e femminile. Per leggere lo schema dei personaggi del mafia movie partiremo proprio da un
2 punto apparentemente secondario: il ruolo dei personaggi femminili .
L’ambigua posizione in cui si trova lo spettatore ideale dei mafia movie è mostrata in maniera eloquente proprio dal ruolo che in questi
film hanno le donne. Il punto debole dei protagonisti è sempre una
donna (moglie, figlia, sorella) che a un certo punto viene minacciata,
stuprata o uccisa. H tema del rapimento, assai frequente, sembra
aggiornare lo schema della «donna in pericolo» tipica dei melodrama t ............... 3 K . cinematografici di inizio secolo . Ed è innegabile che uno dei momenti di massimo piacere dello spettatore sia previsto proprio in queste scene. Il mafia movie è un melodrama per maschi, in cui l’eroina in
pericolo eccita lo spettatore. Si tratta di un elemento che avvicina questi film al cinema erotico
ma anche al poliziottesco, contraddistinto da pruriginose esibizioni di nudi femminili e scene di violenza sessuale . Del resto, lo spazio dedicato all’exploitation dei corpi femminili si apre solo a partire dagli anni settanta, quando si allentano le maglie della censura. Nei primi film di mafia c’è spazio per idilli piuttosto convenzionali (In nome
della legge, Ifuorilegge), con un’eccezione, ancora oggi ignota ai più: Vento del Sud di Enzo Provenzale, su cui è utile spendere qualche parola. In apparenza il protagonista del film è Antonio (Renato
Salvatori), giovane povero educato grazie ai soldi dei mafiosi, dopo che il padre manutengolo era stato ucciso. Ora, in cambio, Cosa
Nostra gli chiede di uccidere un barone che sta per denunciare i mafiosi con cui è stato colluso. L’aristocratico ha due figlie, Claudia
Cardinale (che si sente reclusa e incompresa da quando la madre è morta, e tiene un diario segreto), e la maggiore e più severa Rossella
Falk. Il giovane non riesce a uccidere il barone, e anzi tra lui e Cardinale nasce l’amore: i due si incontrano per caso su un treno,
avendo deciso, ognuno per conto proprio, di lasciare la Sicilia. La novità del film è proprio lo spessore assunto dal personaggio di
Cardinale, al suo primo ruolo da protagonista (il film era prodotto dal suo futuro compagno Franco Cristaldi). Il suo personaggio è
generazionalmente in transizione: sullo sfondo della mafia, viene
raccontato un incontro tra due reietti in fuga dalle rispettive classi
d’origine verso una modernità impossibile, simboleggiata da una
canzone di Miranda Martino che si ascolta al momento del loro addio. La mafia è un ostacolo verso la felicità e l’emancipazione dei due
giovani, agli albori del boom; lo stile del film, del resto, con la
fotografia chiaroscurata di Gianni Di Venanzo e l’uso insistito della profondità di campo, avvicina il film a una serie di esordi «impegnati» del periodo messi in cantiere da Cristaldi, come La sfida di Francesco Rosi, di cui Provenzale era stato direttore di produzione. Il rilievo della figura femminile, però, non sarà in seguito
necessariamente indice di una collocazione highbrow del prodotto. Si
può al contrario ipotizzare che negli anni settanta il rilievo dato alle figure femminili sia inversamente proporzionale alle pretese artistiche
dei progetti: la presenza delle donne, infatti, sposta inevitabilmente i film verso le regioni del melodrammatico e dell’eròtico. In una prospettiva «di denuncia» chercher la femme significa distrarre dalle
radici sociali e politiche dei mali affrontati. Le cose cominceranno a cambiare dagli anni novanta, parallelamente alla sensibilità mostrata
da studiose come Anna Puglisi, Renate Siebert e Alessandra Dino^, e
all’emergere dell’attenzione verso il ruolo delle donne all’interno di Cosa Nostra, come complici o oppositrici. Il mafia movie nella sua epoca d’oro è anche un complesso gioco di
rimozione e sfruttamento dell’immagine femminile, che entra in vario
modo in cortocircuito con il posizionamento dei film stessi come prodotti più o meno artistici, culturali, impegnati. E le figure
femminili si rivelano essenziali al suo funzionamento, non malgrado
ma forse proprio a causa del numero limitato di funzioni narrative loro concesse. Vedove Rispetto ai romanzi di partenza, A ciascuno il suo e II giorno della
civetta riservano uno spazio molto maggiore alle figure femminili.
Irene Papas nel primo film e Claudia Cardinale nel secondo sono vedove (Cardinale, più precisamente, «vedova bianca», perché il cadavere del marito non viene ritrovato) e insieme oggetti del
desiderio. Un topos centrale è stabilito: la vedova è una donna non
più vergine ed è senza uomo, dunque sola e indifesa. Un feticismo delle gramaglie è evidentissimo, fin dal manifesto del film di Petri, che
infatti fu sequestrato e censurato per come esibiva il sollevarsi dalla
veste di Irene Papas. Il doppio volto della vedova, indifesa o infida, è pienamente espresso nei due film, a confronto rispettivamente con un
modello maschile forte da western (Franco Nero) e con uno debole, di
intellettuale in crisi un po’ querulo (Gian Maria Volontà). Ma, nello
stesso anno di Petri, anche il meno nobile Gente d'onore di Folco Lulli presenta già un campionario dell’immaginario femminile del mafia
movie. In un night un po’ psichedelico facciamo la conoscenza di
Rosemarie Dexter, spogliarellista e fidanzata di uno dei protagonisti, cui si contrappone la sensuale vedova Ella Karin: infida la prima,
vindice la seconda. In Baciamo le mani, Agostina Belli diventa il punto di attrazione dell’erotismo: vedova da subito, amante di un
uomo del clan del marito, come gesto di intimidazione le vengono recapitate a casa delle mutande di pizzo («lo sai chi le porta le
mutandine come quelle? Le buttane!»). Straniere L’altra figura centrale è la straniera, che arriva in una Sicilia minacciosa portando con sé i segni della modernità: una figura ben
definita dalla moglie di Alberto Sordi in Mafioso di Lattuada, e già
presente nei Mafiosi (1959) di Roberto Mauri. In A suon di lupara l’estraneità della donna è il cuore del film: un avvocato torna al paese con la moglie francese, che sconta la prevedibile ostilità delle altre
donne della famiglia (e dà scandalo sedendosi col marito al bar, in
pubblico). Una nerovestita sorella del protagonista incarna l’anima sensuale e repressa della Sicilia, e un’altra sorella (invece «moderna»
e lasciva fino alle soglie del lesbismo) ci sposta verso le regioni del
softcore, con ulteriore svolta nel fotoromanzo melo: in un’orgia a Taormina, il fidanzato della sorella «facile» seduce la moglie
dell’avvocato e la ingravida. La mafia diventa mero ingrediente di un dramma erotico in cui il conflitto tra modernità e passato è anche
visivo: riprese documentarie di processioni, campieri con coppola e lupara, ma anche azzardi pop di regia (sdoppiamenti dell’immagine,
primissimi piani e zoom, immagini riflesse su occhiali da sole, riprese di binari ferroviari durante i dialoghi). Risalta invece lo sforzo di Luigi Zampa in Gente di rispetto, che pur muovendosi all’interno delle
convenzioni del genere mette al centro una figura femminile più sfumata. Una maestra «moderna» (Jennifer O’Neill) arriva in un
miserabile paesino siciliano, si trova al centro di misteriose attenzioni e di omaggi da parte di ignoti e viene accolta come una santa dalle donne nel paese. In un Sud faulkneriano, sensuale e pieno di presagi
di morte, l’erotismo passa in secondo piano (appena un ballo della protagonista e di Franco Nero nudi), come a marcare una distanza dal
filone più exploitation. Prostitute, amichette e ballerine In prossimità con il poliziesco urbano, alla vedova e alla straniera si
aggiungono altre figure-tipo. La spogliarellista, la prostituta, l’«amichetta», eredi della «pupa del gangster», sono figure costanti
nel cinema di mafia degli anni settanta. Magnaccia e prostitute sono presenze fisse, specie negli incroci col noir urbano più o meno
«basso» (La mala ordina). Spesso l’amante tradisce (Erika Blanc, generosamente esposta in una scena soft, in La mano lunga del
padrino di Nardo Bonomi), a volte ha il cuore d’oro e può aiutare il protagonista (Carla Gravina in Tony Arzenta) o trovarsi nei guai a causa dei propri scrupoli (Barbara Bouchet in Un tipo con una faccia
strana ti cerca per ucciderti).
Stupri e altre attrazioni I momenti attrazionali, più o meno slegati dalla trama e destinati allo schietto piacere voyeuristico dello spettatore maschio, sono numerosi. Come nella coeva commedia sexy, verso la fine del
decennio abbondano le nudità sotto la doccia (La mano lunga del padrino, Lo sgarbo, con Karin Schubert, futura attrice hard). Tra le
sequenze più significative il ballo in topless di un’altra futura stella del porno, Paola Senatore, in Servo suo, e quelli di L'ammazzatina e La
mano lunga del padrino; l’orgia di Baciamo le mani e quella (coloratissima, con scritte quasi godardiane sui muri) con Francesca Romana Coluzzi in La mala ordina. Il momento attrazionale più forte
è però quello dello stupro, o della sua minaccia: ad esempio in L'amm azza tina, Baciamo le mani, La mano lunga del padrino, La
mano nera o L'onorata famiglia: uccidere è cosa nostra, in cui la fidanzata del commissario viene violentata e uccisa, in una scena con
zoom su quadri e statue, mentre tutto diventa improvvisamente in
bianco e nero. Nelle scene di stupro e di orgia, in genere, lo stile si fa
più «sperimentale» (anche se poi, in questo film, il pendolo passa nuovamente all’arcaico, e lo stupratore viene ucciso a fucilate da una 6 vedova con scialle) . E anche nelle produzioni più ambiziose, da Lucky Luciano al Prefetto di ferro, le scene di nudo più 0 meno giustificato, o di violenze alle donne, non possono mancare.
Donne malmenate, con giustificazioni narrative o per puro piacere visivo dello spettatore, attraversano molti film: nella commedia Cose
di Cosa Nostra Antonio Sabàto e Oreste Lionello picchiano una prostituta per farla parlare; ceffoni a volontà colpiscono donne in La
mala ordina, La mano lunga del padrino e II consigliori; in A suon di lupara la viziosa sorella del protagonista viene schiaffeggiata in un
fienile (location prediletta per questo genere di scene). Il vertice di violenza è Quelli che contano di Andrea Bianchi (che nel decennio
successivo si specializzerà nel pomo), in cui Barbara Bouchet è la
moglie di un boss. Americana e per giunta alcolista ed ex prostituta,
nella sua prima apparizione in masseria si cosparge di latte, poi torna
a vestire i panni della prostituta in un gioco erotico a beneficio del marito, si esibisce in un allusivo numero leccando una banana e viene infine sodomizzata dal killer psicopatico Henry Silva con la testa
infilata in un quarto di maiale sanguinante appeso .
Women in perii A rendere chiaro il carattere cui si accennava, del mafia morie come melodrama per maschi, è proprio il topos della «donna in pericolo», di cui si attende a un certo punto il denudamento e la
minaccia di stupro. Questo aspetto, immancabile nei film più
commerciali, è particolarmente ravvisabile anche nel cinema di
Damiano Damiani. In tutta la sua produzione il corpo femminile è esibito e messo in posizioni di pericolo che stimolano il voyeurismo:
minorenni rapite (La sposa più bella), donne bellissime uccise e calate nude nel cemento (Marilù Tolo in Confessione di un
commissario di polizia al procuratore della Repubblica), vedove
moralmente ambigue (Perché si uccide un magistrato, L’avvertimento), adolescenti torturate o nobili schiave dei loro spacciatori (La piovra), ragazzine del popolo costrette a prostituirsi
(Pizza Connection, Il sole buio).
Il topos della donna in pericolo verrà ereditato, ria La piovra, da
molta produzione televisiva, a cominciare dalle stagioni successive della serie stessa, fino a produzioni di grande successo come Squadra antimafia e L’onore e il rispetto. Nel primo caso, all’inizio è
protagonista una donna (Simona Cavallari), e numerose sono le antagoniste e le aiutanti femminili, finché rapidamente diventa
centrale il personaggio di Rosy Abate (interpretata da Giulia Michelini
e poi eroina eponima di uno spin-off). Rosy, figlia di mafiosi, è di volta in volta cattiva ed eroina, vittima e vendicatrice, doppiamente
irrazionale in quanto siciliana e in quanto donna. Mossa da passioni private (l’amore, la vendetta), assume, in alcuni travestimenti, varie
sembianze dell’immaginario cinematografico ed erotico (dalla
poliziotta alla suora). Un mondo di passioni è anche quello delle
fiction di produzione Ares, come L’onore e il rispetto e Baciamo le
mani, che enfatizzano il versante da feuilleton anche perché più
rivolte al pubblico femminile delle reti Mediaset. Il filone mèlo e quello criminale si intrecciano, con donne soggiogate, vittime, perfide, esplicitamente citando un immaginario cinematografico del tempo che fu. Dagli anni novanta la rappresentazione delle donne ha subito una
mutazione, causata soprattutto dall’appartenenza dei titoli al campo di un cinema d’autore attento ad approfondire le dinamiche tra personaggi e il contesto a scapito dell’azione. A parte un titolo di
confine come II lungo silenzio di Margarethe von Trotta, con
un’alleanza ideologica tra giudice donna e mogli dei criminali (ma non
si tratta propriamente di un mafia morie), figure femminili di rilievo si trovano a fianco degli eroi di II giudice ragazzino (di Alessandro Di Robilant) e Testimone a rischio (di Pasquale Pozzessere), e
ovviamente donne partecipano alle scorte dei giudici (PalermoMilano sola andata, Gli angeli di Borsellino). Il loro ruolo è così
mutato che quando, in Placido Rizzotto di Pasquale Scimeca, vediamo tornare il topos dello stupro (per giunta in una scena in cui la
fidanzata del sindacalista protagonista sembra accettare la violenza da
parte del boss Luciano Liggio), questa verrà avvertita come una stonatura da gran parte della critica. L’unico a utilizzare
tranquillamente gli stereotipi del mafia morie precedente sarà Giorgio Castellani (figlio del boss Michele Greco) in Vite perdute, con un
onorevole che ricatta sessualmente la madre del giovane protagonista
per farlo scarcerare. È Roberta Torre, con Tano da morire e Angela, a cambiare in maniera più radicale la prospettiva, raccontando Cosa Nostra
dall’interno e da un punto di rista femminile. Si tratta di un duplice ribaltamento, che quasi obbliga a un’originalità stilistica: nel primo
caso, il punto di rista femminile serve per smontare ironicamente il
mito virile del boss e il sottofondo mortuario della cultura mafiosa (e la scelta, per contrasto, è di fare un musical colorato e di utilizzare criticamente le canzoni napoletane, appositamente scritte da Nino D’Angelo); in Angela invece la donna è al centro della vicenda e
dell’inquadratura, braccata dalla macchina da presa, e stavolta il punto di vista è ancora più interno, ma anche pervaso di un maggiore
pessimismo sulle possibilità liberatrici della presenza e dello sguardo femminili.
Vicende delle cronache recenti di mafia, in cui le donne hanno un ruolo di rilievo, cominciano a interessare registi e sceneggiatori. Ad
esempio la tragica fine di Rita Atria, giovanissima collaboratrice di giustizia che si uccise dopo la morte di Paolo Borsellino, diventato per lei una sorta di figura paterna (La siciliana ribelle di Marco Amenta);
o la vicenda, più oscura, di Vincenzina Marchese, moglie suicida di Leoluca Bagarella e sorella del pentito Giuseppe (Lo scambio di Salvo
Cuccia). In una dimensione a metà tra cronaca e reinvenzione
fantastica si trovano le protagoniste dei due lungometraggi di Grassadonia e Piazza, Salvo e Sicilian Ghost Story: pura vittima e woman in perii la prima (e addirittura cieca), donna volitiva da manuale la seconda, e adolescente, come in molto cinema d’autore , .. . , ..8 dagli anni duemila .
Per la rappresentazione delle donne e della sessualità nella «stagione d’oro» degli anni settanta, può risultare allora a suo modo
un «momento di verità» il mini-filone pomografico di ambientazione
mafiosa, inaugurato dai tre capitoli della saga di Concetta Licata, firmati da Mario Salieri tra il 1994 e il 1997, e che generarono qualche epigono (La figlia del padrino di Joe D’Amato). Al di là degli intrecci
con altri generi come il prison movie, e del riuso di topoi classici (la
lotta tra clan, il potere pervasivo e l’invincibilità della mafia) è da notare come l’elemento della minaccia e dello stupro, sotterraneo in molto cinema di mafia, qui esca allo scoperto. Come scrive Giovanna
Maina: «Concetta (interpretata da Selen) e le altre donne della saga
sono costantemente forzate a sottoporsi a rapporti sessuali coatti e
umilianti. A ciascuna di loro tocca sempre concedersi controvoglia: che sia per salvare la vita al proprio uomo (...) o al proprio figlio [...],
oppure per non incorrere in pesanti abusi di potere [...], in generale la cifra della sessualità mostrata in questi film è quella della coercizione, del disagio»9.
Una coercizione, aggiungiamo, che proviene non solo dall’organizzazione mafiosa, ma dalle strutture di potere, dalle autorità costituite come il direttore del carcere. Dunque è vero che
«l’esibizione schietta e senza mezzi termini dei rapporti di potere
sotto forma di rapporti carnali si pone qui come figurativizzazione 10 della forza coercitiva che la mafia esercita» ; ma d’altro canto, coerentemente con la visione cupa e violenta del regista, questa
coercizione sembra essere un dato che la mafia condivide con le strutture di potere dell’intera società. Soprattutto, i film della serie di
Concetta Licata sono in fondo anche una brutale e involontaria demistificazione, una reductio ad absurdum, dell’ambiguità del mafia
movie nei confronti delle figure femminili.
2. Omini, mezzi omini, ominicchi, pigliainculo e quaquaraguà. Se abbiamo presentato lo schema dei personaggi in ordine invertito
rispetto alla loro preminenza, partendo dalle figure femminili, è per sottolineare quanto la costruzione delle figure-tipo sia da leggere in
maniera relazionale, come costruzione di un’immagine di virilità. I
protagonisti del mafia movie sono maschi, e il loro essere maschi risalta proprio attraverso lo sguardo che essi gettano sulle donne; o sul loro fantasma. Come ha scritto Barbara Grespi: La donna, nel bene e nel male, è in realtà la grande protagonista dei film
usciti fra il Vo e il ’76, ma è come se il cinema, constatata la sua sparizione, ne
evocasse il fantasma, rinunciando a metterne in scena le metamorfosi. I film si
riempiono di corpi femminili procaci e docili per soddisfare un voyeurismo tutt’altro che elementare: quel che si ama guardare non è tanto la straordinarietà delle forme femminili, quanto il dirompente desiderio 11
maschile .
Il mafia morie in questo è convergente con il cinema italiano
popolare del periodo. Negli anni settanta le «vedove, straniere e
puttane» del cinema di mafia si trovano accanto alle ragazze inseguite
e squartate nel «giallo», alle incarnazioni di un erotismo rétro (e tendenzialmente endogamico) dopo Malizia, alle brutali «lotte dei
sessi» fra Giancarlo Giannini e Mariangela Melato (da Mimi metallurgico in poi), alla virilità ipertrofica o in crisi di Lando Buzzanca. Tutte figure, peraltro, che spesso si nutrono anche del
confronto con la Sicilia. Se il cinema di genere degli anni settanta è, in
maniera più esplicita che nei decenni precedenti, un luogo di 12 contraddizione della virilità , la Sicilia permette ancora una volta di
esorcizzare e semplificare le contraddizioni, concretizza un altrove che
è in realtà il cuore oscuro degli italiani. Anche nel sentire comune, alla nera visione di Cosa Nostra soggiace una nera visione del sesso: «Comandare è meglio che fottere», recita un celebre proverbio
siciliano, e un altro ancor più torvamente elenca i piaceri della vita:
«Mangiare carne, comandare carne, cavalcare carne». I protagonisti dei film di mafia presuppongono un percorso di creazione di
immagini maschili nel periodo successivo al boom, e coevo
all’evoluzione delle leggi e dei costumi. In questa costruzione ha un forte peso la tradizione cinematografica della Sicilia «luogo della commedia erotica», da Brancati a Germi, evidenziata da Leonardo
Sciascia. Il quale, ancora alla fine degli anni settanta, ne faceva un riassunto paradigmatico e ormai quasi allucinato: Buona parte dei sogni dei siciliani continuano a essere accentrati sulla
donna. Un certo comportamento nei confronti della donna resta come un imperativo categorico: si è veri siciliani se si hanno donne, se si è ossessionati da esse, perché questa è la natura del vero uomo. Tormentato da una profonda insicurezza, da un terrore esistenziale, da una fondamentale instabilità, il
siciliano deve per forza rispondere al richiamo del sesso. D’altronde, attorno alla sessualità ruota un’idea, quella religiosa 0 meglio bigotta della famiglia, in
cui il nucleo organizzatore è costituito dalla donna. Così la donna è desiderata
come donna solo in quanto sia altra (0 di un altro 0 di nessuno, ma in ogni caso non di se stessa). (...) Il siciliano è intimamente convinto di essere «il migliore» nelle cose dell’amore e della sessualità, di essere più acuto, più
scaltro, più svelto di ogni altro, e che comunque i siciliani sanno amare le donne e soddisfarle meglio di tutti13. Qualcosa del genere stava anche dietro la celebre tassonomia
esposta da don Mariano Arena al capitano Bellodi nel Giorno della civetta, ripresa con qualche censura nel film di Damiani: Io ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l’umanità [...] la
divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraguà... Pochissimi gli uomini; i mezz’uomini pochi, che mi contenterei l’umanità si fermasse ai mezz’uomini... E invece no, scende ancor più giù, agli ominicchi: che sono come i bambini che
si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi... E ancora più giù: i pigliainculo, che vanno diventando un esercito... E infine i quaquaraquà: che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha
più senso e più espressione di quella delle anatre... Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo14. Insomma, la logica di definizione dei mafiosi e dei loro antagonisti
si basa su una sottintesa idea di virilità e maturità, in un cinema che gli studiosi leggono oggi sempre più come luogo di contraddizioni 15 della masculinity . Il boss e l’eroe, e le figure che li circondano, sono
un luogo in cui i tratti della virilità vengono esasperati, le
contraddizioni esorcizzate e polarizzate in figure nette. È su questo
sfondo che possiamo far sfilare i personaggi maschili del mafia movie, che come quelli femminili si articolano in un teatro di maschere ben
definito. L’eroe/1: l’indagatore Un esponente della legge, poliziotto 0 magistrato, arriva in una terra ostile, dominata dall’omertà, e rompe un equilibrio di poteri, già instabile a causa dell’emergere di interessi economici nuovi, o di
ribellioni individuali. È una situazione ereditata dal western, fissata da In nome della legge e ripresa nel Giorno della civetta. A interpretarlo è spesso un attore famoso, che porta con sé l’alone degli
altri ruoli. Massimo Girotti nel primo film è uno dei grandi divi del
cinema pre-neorealista, nel secondo Franco Nero è all’epoca, per tutti, Django. Mossi da spirito di legalità, gli indagatori però hanno spesso
un deficit di conoscenza e necessitano di una spalla locale che spieghi loro fatti e personaggi, anche quando magari sono siciliani che tornano in patria (il procuratore Tony Musante nel Caso Pisciotta). In
Confessione di un commissario di polizia al procuratore della
Repubblica la «spalla» locale si autonomizza: a Franco Nero, magistrato straniero di nobili principi, si contrappone Martin Balsam,
commissario siciliano che predilige le vie spicce ed extralegali, omicidio compreso.
Questi eroi possono sbagliare, o avere le maniere forti (Giuliano
Gemma, ex Ringo, nel Prefetto di ferro; Frederick Stafford in Abuso
di potere), ma comunque saranno sempre sconfitti. È sul terreno dello
sguardo che si gioca spesso la partita: lo sguardo è, più della lupara, strumento di conoscenza e potere. Nel Giorno della civetta, il
capitano Bellodi e don Mariano Arena si scrutano dai balconi opposti, con o senza protesi binoculari. In mezzo, nella piazza del paese,
passano confidenti, mafiosi, e soprattutto Claudia Cardinale, che in
una scena clou va prima dal carabiniere, ma poi anche dal boss, a
chiedere protezione, e viene dai due osservata in ogni spostamento. Di sessualità limpida e inscalfibile, seduttori loro malgrado quando
non asessuati (Enrico Maria Salerno in La violenza: quinto potere), gli indagatori tengono ferma la barra della narrazione su un versante pubblico, di impegno e d’azione, garantendo che i personaggi
femminili siano mere divagazioni. Solo in un momento successivo,
quando le biografie di giudici e poliziotti si modelleranno sul biopic
all’americana, in cui il versante privato ha un certo spazio, avremo un’attenzione sempre maggiore alla vita privata dei personaggi, coi
loro rapporti con mogli e figli. L’eroe/2: il ribelle L’altro schema fondamentale del mafia morie, ossia la lotta di un «cane sciolto», ribelle e solitario, contro l’organizzazione, vede al centro un eroe in apparenza assai diverso. Solo contro il mondo, con
l’ausilio di donne che possono eventualmente sacrificarsi ma di cui è
sempre bene non fidarsi, il ribelle è al centro di titoli più prossimi al poliziottesco, più identificabili con le logiche del cinema di genere. . s x 16 . L’attore-simbolo e Antonio Sabato , nativo di Montelepre come il bandito Giuliano, truce e inquietante, ma onesto e quindi spesso
bersaglio di infami. Nemico dello spaccio di droga, indignato davanti allo sfruttamento della prostituzione, è coraggioso e invincibile,
uccide solo se provocato, e la sua vendetta sarà terribile: a ben vedere,
è l’esatta incarnazione di come i mafiosi si idealizzano. In una delle storie più estreme, Canne mozze di Mario Imperioli, sequestra una
coppia e si innamora della donna, innescando un cortocircuito di masculinity: il marito di lei è pronto a concedergli la donna per
irretirlo, lui (rude ma di sani principi) la rifiuta, e a quel punto sarà il marito a tentare di stuprare la propria consorte, venendo punito.
Antieroi: gli uomini in ginocchio In alcuni casi il «ribelle», o l’uomo solo, è più debole, e le cose si
complicano: ma proprio alcuni di questi personaggi ci permettono di illuminare lo schema, mostrando ciò che gli eroi-tipo di solito non
devono essere. In A ciascuno il suo, il dramma scatta quando Volonté/Laurana diventa oggetto e non soggetto di sguardo, e si fa, a
causa della tentazione erotica, debole (l’attrazione incontrollata per
la donna minaccia paradossalmente la saldezza della virilità). La mimica quasi infantile, piagnucolosa, di quest’uomo che vive con la madre, lo caratterizza come personaggio poco virile, che ha quasi uno sturbo davanti alle cosce della Papas. La debolezza sentimentale,
sessuale e politica diventerà centrale, con toni grotteschi, in Mimi metallurgico ferito nell’onore, il cui protagonista deve confrontarsi
continuamente con lo spettro della mafia che domina le sorti d’Italia e le sue vicende con le donne. Più complicato un mèlo innestato sul
mafia movie, Gli amici degli amici hanno saputo di Fulvio Marcolin, in cui un giovane sbandato ingenuo emigra a Torino dove finisce
guardaspalle di un estorsore (Pino Caruso). Gelosissimo della sorella,
lo spediscono in Francia, dove una donna lo irretisce mentre la sorella viene traviata, si spoglia nei night e rimane incinta.
Ma in realtà spesso il protagonista, se all’inizio appare debole (Un uomo in ginocchio), rapidamente supera la codardia, magari per salvare la famiglia, e se è addirittura un intellettuale (il professore di Servo suo) è talmente cool da poter agevolmente fronteggiare una
specie di Spectre mafiosa.
Da questa suddivisione, notiamo, appare in una nuova luce il
commissario Cattaui della Piovra, personaggio-spartiacque che attraversa in fondo le tre tipologie di eroe: da straniero senza macchia
nei primi episodi della serie diventa «uomo in ginocchio» ricattabile (tramite sequestro e stupro della figlia, ovviamente) e costretto a inquinare le proprie stesse indagini, e infine risorge come eroe
vendicatore, ormai fuori dagli stretti binari della legge e mosso da
spirito di vendetta. Scagnozzi e vittime Intorno alle due tipologie di eroe ruota un sottobosco lumpen
sempre uguale, con la differenza che l’indagatore se lo trova davanti
come estraneo, mentre il ribelle si confronta con esso all’interno deW’underworld criminale. Sono i «mezzi uomini, ominicchi e pigliainculo» di cui parla don Mariano Arena; il mondo della bassa
manovalanza, dei complici, dei retrobottega e dei garage, degli spacciatori, dei killer, dei confidenti. Sono loro, non i boss, a
minacciare le donne, sono loro a venir umiliati dai cattivi ma anche
dai buoni. Anche gli indigeni che tentano di ribellarsi alla mafia sono per lo più pavidi, con la barba malfatta, tracagnotti, con tratti
lombrosianamente accentuati, come i messicani dello spaghetti western. Comunque irrimediabilmente codardi, ricattabili sul piano
economico o culturale. A volte scatta una linea comica, o grottesca (inaugurata da Tano Cimarosa nel Giorno della civetta), ma almeno
una volta questi personaggi laterali raggiungeranno una dimensione tragica: il prestanome Giacalone interpretato da Ciccio Ingrassia in La
violenza: quinto potere, cui è affidato un memorabile monologo in tribunale. In qualche caso, la debolezza è mostrata non come
grottesca esasperazione di una virilità belluina, ma come immaturità o effeminatezza, già dai tempi del giovane aiutante del pretore di In
nome della legge. Nel Caso Pisciotta un giovane Michele Placido che «ha parlato troppo» viene punito in carcere con un’esemplare
sodomizzazione, così annunciata dal mafioso Saro Urzì: «Chi parla assai comu na fimmina, fimmina havi a essiri. Perciò ti condanno a
fari la fimmina per quanto ci pare e piacerà a noi». Ovviamente, in tutti questi film non c’è traccia di opposizione
organizzata a Cosa Nostra, né politica né sociale. Gli eroi sono soli, e
come loro i giornalisti o poliziotti che momentaneamente li aiutano. Niente trapela di decenni di lotte collettive, impossibili da rendere sullo schermo nei termini derivati dal western e dal poliziesco. E anche in seguito, quando questo accadrà, lo schema dell’«eroe solo»
sarà difficile da sradicare, e si sovrapporrà a biografie di sindacalisti, giornalisti, preti.
Principi mafiosi Il boss o il cattivo è di modi eleganti, talvolta di tratti nordici;
interpretato da un attore noto, si stacca subito dalla massa perché è
(per dirla con Pitrè, o col boss del Giorno della civetta) un uomo: Lee J. Cobb, Gian Maria Volonté, Giuliano Gemma, Gabriele Ferzetti, Joss
Ackland. H capomafia è borghese, con agganci nella politica, fin dai primissimi titoli del genere (Gente d’onore, Il giorno della civetta), e i segreti del potere sono mostrati in consessi privatissimi tra notabili
(La legge della mafia, Il prefetto di ferro). Soprattutto, il mafioso
vede e sa, più dell’eroe. Già in Un uomo da bruciare il boss Turi Ferro è cosciente che il feudo è finito, e lo dice a chiare lettere. Nel cinema
politico italiano sarà spesso così (a cominciare da Queimada di Gillo Pontecorvo): è il cattivo ad avere la coscienza della storia e della
propria inevitabile sconfitta (che i film non mostrano mai ma preconizzano vagamente). Il capomafia saggio, prototipo del «cattivo
consapevole», sarà una costante ineliminabile del mafia movie, da Corleone a Dimenticare Palermo. I film non nascondono la predilezione per queste figure, cui viene concesso non solo un onore
delle armi, ma anche una preminenza intellettuale (Salvo Randone
nel Prefetto di ferro o Philippe Hersent nel precursore I mafiosi). La sua nobiltà ha un’origine precisa: i vecchi boss ieratici, sempre in posizione seduta e dal fototipo normanno, sono figli ideali del
principe Salina del Gattopardo - dapprima il libro e poi
l’incarnazione che ne dà al cinema Burt Lancaster. Come l’idea di una terra irredimibile è la fonte indiretta dell’idea di una mafia invincibile,
così la raffigurazione del principe nel film di Visconti, alto, biondo e
ieratico, è l’antenato di tutti i vecchi boss che sanno e osservano con disincanto i destini della Storia. Compreso II padrino di Coppola, che
ha nel Gattopardo una delle proprie fonti, a cominciare dalla scena del ballo, posta in apertura e non alla fine come nel film di Visconti.
Anche don Vito Corleone potrebbe dire che dopo di lui, «gattopardo», arriveranno le iene e gli sciacalli, pur se Michael Corleone, come Tancredi, saprà salvare per un po’ i destini della Famiglia. Il Boss è in definitiva un’immagine del Padre, e spesso il suo rapporto con l’eroe è
di tipo padre/figlio (entrambi, per inciso, pur nella loro inconcussa straightness, sanno tenere a bada le pericolose tentazioni della U7 carne) .
Post-machismo A partire dagli anni novanta, i protagonisti dei mafia movie,
all’interno di vicende più complesse, si arricchiscono di sfumature. Uno spartiacque è la feroce parodia del mafioso macho in Tano da
morire di Roberta Torre, primo film a raccontare un mafioso dal punto di vista femminile, ma scegliendo inopinatamente la chiave della comicità. Il suo film è esattamente speculare ai lavori di Cipri e
Maresco, che proiettano sullo sfondo dell’universo mafioso una
visione del mondo composta di soli maschi guidati dalle pulsioni primarie del sesso, del cibo, della sopraffazione, e da un istinto di morte. A monte va però ricordata l’evoluzione dello sceneggiato La
piovra, che dalla terza stagione vede emergere il personaggio di Tano
Cariddi (Remo Girone), figura sempre più tragica e tormentata, e in fondo vero protagonista: banchiere, omicida, finto pazzo in
manicomio criminale, alcolista in Africa, rinchiuso nel proprio castello sull’Etna, Cariddi è un personaggio ormai post-Gattopardo,
forse inimmaginabile prima dell’apparizione di Tommaso Buscetta.
Un pubblico diverso è pronto a ricevere vicende di anti-mafiosi
lontani dallo schema dello «straniero che arriva nel villaggio». Peppino Impastato dei Cento passi è figlio e non padre, è un fool, un
intellettuale che legge Pasolini e i «Quaderni Piacentini», un fratello di registi, sceneggiatori e pubblico. In L’uomo di vetro di Stefano Incerti e II dolce e l’amaro di Andrea Porporati, invece, la difficile appartenenza dei personaggi al mondo di Cosa Nostra si manifesta
anche sul piano privato. Il primo film racconta la storia di Leonardo Vitale, pentito di mafia psichicamente instabile, che scopre la propria estraneità al mondo di Cosa Nostra in maniera psicotica, spinto da fantasmi incestuosi e da un’omosessualità repressa. Nel film di
Porporati, il protagonista viene messo in crisi da una coscienza critica
femminile e significativamente il figlio del boss, a lui legato da un
rapporto quasi omo erotico, tenta (fallendo) di violentare una donna: il topos del cinema di genere negli anni settanta non funziona più per
i protagonisti del cinema d’autore. Nell’interesse per questi personaggi ha avuto certo un ruolo anche
una nuova attenzione della pubblicistica per il mondo interiore dei mafiosi, emerso dagli interrogatori giudiziari e dalle interviste con i
pentiti: una dimensione affascinante, tragica, poco indagata in
precedenza nel cinema italiano (ma molto, invece, dai grandi registi americani). Se gli psicoterapeuti hanno notato che, dai colloqui con
mafiosi, emerge spesso un dato «agghiacciante e insolito», ossia
«l’assenza di una vera vita sessuale» intesa come «passione, relazione, condivisione emotiva», questo pare valere anche per le nuove generazioni:
L’anaffetthità rimane la tonalità di fondo: le vecchie generazioni di boss censuravano le pulsioni sessuali e le seppellivano sotto lastre di silenzio tombale secondo il perbenismo sessuofobico dominante, le nuove generazioni
tendono a disperderle in rapporti molteplici e discontinui, in sintonia con la g mitologia delle telenovelas e con il consumismo erotico di moda12 15 14 11 *410 . In questa chiave si possono leggere le strategie narrative di molta
fiction contemporanea, che punta a decifrare (da un punto di rista drammaturgico) l’immagine dei mafiosi, e in particolare dei corleonesi, insistendo sul versante privato e sentimentale. Nel Capo
dei capi, ma anche nel Cacciatore, la coppia Riina/Ninetta Bagarella e quella Leoluca Bagarella/Vincenzina Marchese sono romanticizzate,
fino a creare delle figure di mafiosi che amano. H racconto del
versante privato permette di umanizzare figure difficilmente raccontabili dall’esterno, e di dar loro uno spessore attraverso, ancora
una volta, le regole del genere, in questo caso il biopic all’americana. Non stupisce allora che Tommaso Buscetta abbia affascinato
Marco Bellocchio, nel Traditore, anche per il suo carattere eretico
rispetto alla nera visione del potere e del desiderio di Cosa Nostra: un
mafioso che è anche un viveur, che anzi mette il desiderio per le donne e l’eros forse perfino al di sopra della libido dominandi. Uno
per cui, seppure all’interno di una visione profondamente maschilista e di un sentimento tragico della vita, comunquefottere è meglio che comandare.
1 Termine, La chiarezza felice dt, p. 28. La prospettiva e invece centrale, seppur solo in riferimento alla produzione piu recente,
in D. Renga, Unfinished Business. Screening the Italian Mafia in the New Millennium, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 2013, spede pp. 3-20. 2 Il termine melodrama nella letteratura e nel cinema americani tra Ottocento e Novecento indica una produzione sensazionalistica, a tinte fosche, con donne continuamente minacciate da pericoli incombenti. Cfr. B. Singer, Melodrama and Modernity. Early
Sensational Cinema and Its Contexts, Columbia University Press, New York 2001. 4 Curb, Italia odia dt, p. 91. ° A. Puglisi, Sole contro la mafia, La Luna, Palermo 1990; Siebert, Le donne, la mafia dt; Dino - Prindpato, Mafia donna dt Per un’analisi del complesso ruolo delle donne
nell’organizzazione si vedano A. Dino - A. Meli, Silenzi e parole dall'universo di Cosa Nostra, Rubbettino, Soveria Mannelli 1997 e O. Ingrasd, Donne d’onore. Storie di mafia al
femminile, Bruno Mondadori, Milano 2007.
Da notare che proprio in quel periodo si ha una fioritura del filone rape and revenge, con
titoli assai diversi, come Cane di paglia (1971) di Sam Peckinpah; L'ultima casa a sinistra (1972) di Wes Craven; Stupro (1976) di Lamont Johnson; Non violentate Jennifer (1978) di Meir Zarcht In ogni caso le differenze con il filone statunitense sono molto maggiori delle
possibili affinità. Da notare peraltro che ad esempio uno studio preciso come A. HeDerNicholas, Rape-Revenge Films. A Critical Study, McFarland & Company, Inc-PubEshers
Jefferson, North Carolina-London 2011, presenta una panoramica per nazioni in cui l’Italia non è mai dtata.
' In Bocche cucite di Pino Tosini, invece, le convenzioni del mafia movie sono spostate sul mèlo erotico: la famiglia fa uccidere da un killer un uomo che voleva far prostituire la
cognata, ma lei, disonorata, a quel punto si concede a tutti i parenti maschi del marito. D. Hipkins, Figlie di papà? Adolescent Girls between the «Incestmotif» and Female Friendship in Contemporary Italian Film Comedy, in «The Italianista xxxv, 2015,2, pp.
1-25. q G. Maina, Concetta e le altre. Il pomo siciliano, in «Quaderni del Csci», 2009,5, pp.
84-5 10 Ibid. 11B. Grespi, Cine-femmina: quell’oscuro oggetto del desiderio, in De Bernardinis (a cura
di), Storia del cinema italiano cit, xn, p. 116. Cfr. Manzoli, Da Ercole a Fantozzi dt, pp. 184-91. Come premessa è importante M. Gùnsberg, Italian Cinema. Gender and Genre, Paigrave Macmillan, Basingstoke-New York
2004. L. Sdasda, La Sicilia come metafora, intervista di M. Padovani, Mondadori, Milano
1979, PP-42-314 II giorno della civetta. Su insistenza della Commissione di revisione preventiva, nel film l’espressione «pigliainculo» venne mutata in «ruffiani» (A. Pezzetta, Regia Damiano Damiani, Centro espressioni cinematografiche, Cinemazero-dneteca del Friuli-Csc-Cineteca nazionale, Pordenone 2004, p. 205). 15 Cfr. S. Rigoletto, Masculinity and Italian Cinema. Sexual Politics, Social Conflict and Male Crisis in the 1970s, Edinburgh University Press, Edinburgh 2014.
Intervista di Antonio La Torre Giordano, in «Archivio siciliano del cinema»,
https://www.as-cinema.com/antonio-sabato-attore-genere/. 1 Una versione quasi parodistica del personaggio è in Quando i picciotti sgarrano di Romolo Cappadonia, pieno di scene erotiche spinte e con un boss che afferma senza mezzi
termini il proprio potere appartandosi con la giovane amante dopo aver comandato, e dopo il trionfo finale si allontana con lei annunciando: «Vogghiu futuri». xS
Cavadi, Il Dio dei mafiosi dt, p. 180.
iv. Così ridevano
Nel corso degli anni, periodicamente è riemersa l’idea che «ridere
della mafia» sia di per sé operazione innovativa e dissacrante. In realtà, la mafia è al cinema un tema comico da oltre mezzo secolo, e la
commedia non necessariamente ha svolto un ruolo di conoscenza o demistificazione. A confermare il carattere rigido dell’universo di segni del mafia movie c’è anzi proprio la sua immediata adattabilità in
forme parodistiche. Il siciliano sessuomane, violento e geloso è un numero classico dello spettacolo umoristico (si pensi alla variante che
ne dà Nino Taranto, ad esempio in Tototruffa ’62, di Camillo Mastrocinque). A fornire nuovo impulso all’ambientazione isolana era
stata, negli anni sessanta, la coppia di titoli di Pietro Germi, Divorzio
all’italiana e Sedotta e abbandonata, che puntavano sull’eros e
sull’arretratezza dei costumi per fare della Sicilia un’esasperazione di caratteri nazionali, che si intreccerà sempre più con l’armamentario della rappresentazione di Cosa Nostra, fino a creare un blocco quasi
unico. Gallismo e mafia, esotismo ed erotismo diventano
intercambiabili. Così era stato già nel primo film con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia protagonisti, L’onorata società di Riccardo Pazzaglia, che si apre con la scritta «Questo film è un documento e un atto d’accusa» e
racconta di due sprovveduti, inviati al Nord per uccidere due
fedifraghi, che si trovano alle prese col fascino della donna settentrionale. Il finale vede celebrare congiuntamente ima cerimonia matrimoniale e una funebre, con felicitazioni e condoglianze insieme .
Gli autori più accorti, da subito, compiono un lavoro di secondo grado, che assume lo stereotipo come dato e lo fa reagire contro la
situazione presente. A far esplodere i luoghi comuni pensa precocemente Mafioso (1962) di Alberto Lattuada (su soggetto del
pittore Bruno Caruso e sceneggiatura di Marco Ferreri e Rafael Azcona), che mette in scena l’urto tra un repertorio di stereotipi e
l’Italia del miracolo economico. Alberto Sordi, cronometrista di
un’industria milanese, torna con la moglie (settentrionale) nel paese natio. Lì rende omaggio al capomafia che gli aveva trovato il lavoro e
costui, in cambio, avendo ammirato la sua abilità come cacciatore, gli
chiede di fare da killer occasionale uccidendo un boss rivale negli 2 .. . ... . . .. Usa . Sordi viene spedito in America in una cassa, esegue il suo compito e in poche ore torna in Sicilia con un alibi di ferro, per
riprendere il proprio lavoro nell’industria del Nord. La tesi del film è la perfetta adattabilità della mafia al capitalismo italiano del boom, la doppia faccia dell’italiano di quegli anni. Un’idea
che sconcertò Leonardo Sciascia, il quale si chiedeva:
Di fronte a questo film (...) noi che più volte ci siamo occupati della mafia, in libri ed articoli, siamo stati presi dal dubbio se il continuare a parlarne non finirà col rendere alla mafia quell’utile stesso che prima le rendeva il silenzio.
Nel film di Lattuada tutto è mafia. Vien fatto di pensare che la rivoluzione dei tecnici profetizzata da James Burnham finirà con lo svolgersi sotto i segni della mafia siciliana. Mafioso è il dirigente di una grossa industria del Nord
(...]; di mafia partecipano dogane e compagnie aeree; sicario della mafia è un «cronometrista» di quell’industria del Nord. Per cui lo spettatore è portato a chiedersi non piu che cosa e la mafia, ma che cosa la mafia non e .
Alcune intuizioni di Sciascia sono profetiche nel loro apparente paradosso: anzitutto, che la sovrapproduzione di discorsi sulla mafia,
così come la metafora della «piovra» con tentacoli ovunque, potessero rivelarsi un ostacolo e non un aiuto alla comprensione del fenomeno.
Eppure, il regista milanese vedeva forse più lontano dello scrittore siciliano nel mostrare l’integrazione pacifica tra mafia e società dei consumi; soprattutto, si direbbe, da un punto di vista morale. Se
Sciascia difendeva l’idea di una mafia storicamente e geograficamente determinata, Lattuada suggeriva con malizia l’ipotesi di una sua
esportabilità e di una sua non incompatibilità con le logiche della
società e dell’imprenditoria italiana. La convivenza, nel film, è resa
fisicamente dalla presenza di Sordi, attore-simbolo dell’Italia del boom che si sdoppia nell’efficientissimo tecnico d’industria milanese e in un mafioso con coppola e lupara. Come annota lucidamente il regista:
Il carattere dell’italiano si è indurito nell’egoismo, il tradimento, la viltà, considerate come qualità del «più furbo di tutti». [...] Sordi ha accumulato, in
una filosofia vicina a quella di Guicciardini, tutte le varietà possibili di questa autodifesa a oltranza dell’individuo. (...) Quando, come mafioso, deve digerire, dimenticare, annullare nella sua coscienza il crimine commesso per vigliaccheria (e che resterà per sempre impunito), il suo occhio di controllore diviene più attento, preciso, quasi feroce nei confronti degli operai4. L’operazione di Lattuada non è, in effetti, di evitare lo stereotipo,
ma di caricarlo fino al barocco, anzi al fantastico, già dall’idea della trasferta-lampo, che «sembra troppo. Sembra uno spunto tanto balzano da risultare esagerato» ed è invece «assurdo e • . 5 • • • . s. normalissimo» . Coppole, donne baffute e a lutto, fichidindia sono già così presenti allo spettatore da poter essere oggetto di una «parodia , 6 . . . ... ... della parodia» . Ai margini del film, elementi visivamente inquietanti creano un sottile disagio: le due bambine bionde di Sordi, quasi da
film gotico; il viaggio negli Usa, immerso nel nero della cassa; la visita
al boss nella valla dei Mostri di Bagheria, in mezzo a sculture deformi e grottesche.
Contemporaneamente al film di Lattuada, a ironizzare sulla mafia (non senza conseguenze) è addirittura la controllatissima televisione
pubblica. Nella celebre edizione di Canzonissima del 1962, condotta da Dario Fo e Franca Rame, uno degli sketch dell’ultima puntata
andata in onda (la quinta, del i° novembre), che portano a polemiche,
censure e infine all’abbandono della trasmissione da parte dei conduttori, riguarda appunto la mafia. Il filmato originale è perduto,
ma ecco come ne dà conto un giornale dell’epoca: Franca, vestita di panni neri secondo il costume siculo, viene intervistata da un giornalista. Lui è allibito perché la donna riconosce da un colpo di lupara
chi spara e chi è ucciso: «è questione di orecchio, noi i colpi di lupara ce li impariamo come canzonette». Si sente un botto e lei spiega che è il botto di
mezzogiorno. «Invece che con le campane, voi segnalate il mezzogiorno col cannone?»
chiede l’intervistatore. «No, lupara grossa è!». «E tutti i giorni fanno questo botto?». «No, solo il giovedì. Il sindacalista solo il giovedì passa». Ed intanto lei insiste perché «il continentale» prenda qualcosa, finché non
gli offre «una sparata in du petti» (sic), che non è un dolce ma un colpo di lupara, «perché te convinci che curiosu non devi essere»7. Lo sketch causa tra l’altro un’interrogazione parlamentare
dell’onorevole Malagodi al presidente del Consiglio Fanfani,
presentata il giorno dopo la messa in onda della puntata, «fondata su
una grossolana ed arbitraria denigrazione della vita siciliana, doppiamente riprovevole in un organo statale di informazione ed educazione democratica». E Fo così risponde alle polemiche sui
giornali: «Invito l’on. Malagodi ad andarsi a vedere due film usciti in • • • . . . 8 questi giorni: Un uomo da bruciare e Mafioso» .
Per una curiosa coincidenza, infatti, lo stesso giorno sulla Rai si
ironizza sulla mafia non una ma due volte: alla trasmissione Cinema d’oggi, subito dopo Canzonissima, è ospite Sordi che, per promuovere appunto Mafioso, recita tra l’altro un monologo su Cosa Nostra . Un palinsesto che simboleggia un momento di passaggio: Il giorno della
civetta e Salvatore Giuliano hanno suscitato polemiche e aperto un
fronte presso l’opinione pubblica «colta»; è appena arrivato in libreria Mafia e politica di Pantaleone. Poche settimane dopo, una guerra di
mafia che fa vittime anche tra le forze dell’ordine porta il fenomeno all’attenzione del paese. La parola «mafia» ritorna nel titolo di un film immediatamente
successivo, e proprio sulla scia del successo del film di Lattuada. Si tratta di I due mafiosi di Giorgio C. Simonelli, che lancia in maniera
trionfale la carriera di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Lo spunto
riprende quello di L’onorata società: ma ormai l’organizzazione la si può chiamare «mafia» fin dal titolo, e forse non tanto grazie
all’istituzione della Commissione parlamentare in quello stesso anno, quanto appunto al film con Sordi. Testimoni di omicidio, Franco e Ciccio vengono affiliati al solo scopo essere inviati, inconsapevoli
trasportatori di tritolo, a trovare dei marsigliesi poco rispettosi. Il film, addirittura, si chiude con una sonora pernacchia all’indirizzo del boss don Calogero (Gino Buzzanca).
Nel corso degli anni sessanta sono le commedie a episodi a perpetuare i cliché: in esse non manca mai una sezione siciliana, a volte con scoppio di passioni e delitti: in Se permettete parliamo di
donne, di Ettore Scola, Maria Fiore si concede a Gassman armato di lupara credendo che lui la minacci; Io uccido... tu uccidi di Gianni Puccini aggiorna Cavalleria rusticana ai tempi di Divorzio
all’italiana (Franco e Ciccio uccidono le due donne, anziché uccidersi tra loro, e vanno a spassarsela a Parigi); in Amore all’italiana di
Steno, Raimondo Vianello interpreta un barone paramafioso. A volte, in questi film, al tema erotico-passionale si intreccia esplicitamente il riferimento alla mafia: La moglie degli altri è sempre più bella di
Marino Girolami (annuncia la voce over all’inizio del film) aggiorna I
promessi sposi all’epoca della Cassa per il Mezzogiorno: Ingrassia è
un mafioso che terrorizza il villaggio esigendo, fra le altre cose, lo ius primae noctis sulle donne del paese. In La siciliana di Franco Rossi (nel film collettivo Le streghe), Silvana Mangano scatena una faida tra
famiglie che lascia sul terreno tutti i componenti. In La vedova di
Renato Castellani, episodio di Tre notti d’amore, Catherine Spaak è la vedova straniera di un mafioso che arriva in un paesino e chiunque la
avvicini con intenti che si sospettano irrispettosi viene fatto fuori. Eros e mafia, in questi film, sono sempre accomunati in un’atmosfera
di calda sensualità, come espressioni di un’unica antropologia siciliana, ma anche un’evidente misoginia per la quale la donna è scatenatrice di sesso e morte insieme. A epilogo del filone si trova il
fulmineo episodio di Sessomatto di Dino Risi, in cui la moglie di un mafioso si vendica dell’assassino del marito sfinendolo di sesso, e
riferisce il tutto sulla tomba del coniuge, la cui foto cambia di
espressione man mano che il racconto si fa più piccante.
La componente erotica, col passare degli anni, diventa predominante. In un quasi remake del Mafioso, Cose di Cosa Nostra
di Steno, in cui Carlo Giuffrè viene spedito dagli Usa in Italia, si può notare quanto maggiore sia lo spazio riservato al sesso. Ma l’intreccio è a un certo punto quasi automatico, con l’inserimento di sottotrame
mafiose in commedie erotiche (L'ammazzatind) o di momenti comico-erotici in film di mafia . La commistione è clamorosa in Mimi metallurgico ferito nell'onore di Lina Wertmuller, in cui Giancarlo Giannini emigra a Torino, e si trova diviso tra la coscienza
di classe e una storia d’amore «moderna» da un lato, e dall’altro le spinte dell’onore e della gelosia, della mafia e dell’omertà. H film è
disseminato di personaggi (un boss, un caporale, un magistrato, un vescovo) che hanno in volto tre nèi simbolici, a indicare la loro appartenenza a un unico sistema sotterraneo e invincibile, più
antropologico che sociale, e che addirittura presiede alla «strategia della tensione». Come spiega il boss don Calogero, i padroni servono:
«la gente si sta rivolgendo in massa a chiedere protezione e ordine, e noi glieli daremo». Omertà e crisi della virilità arcaica vanno di pari
passo nel film, come due facce della stessa medaglia; la mafia è lo
sfondo invincibile e pervasive della mancata integrazione del protagonista, in cui l’elemento sessuale rimane però decisivo. L’acre
osservazione sociale di Lattuada si trasforma nella Wertmuller in un
iperbolico qualunquismo: «io ci credevo, in un mondo migliore, ma sono tutti cugini!», esclama Mimi alla fine. Con gli anni queste commedie si spostano sempre più su un
versante schiettamente erotico, transgenerazionale (uomo
maturo/ragazza adolescente o ragazzo adolescente/donna matura) e preferibilmente endogamico, a partire da Malizia di Salvatore
Samperi. In seguito, dalla seconda metà del decennio, l’isola per molto tempo smette di essere un luogo in cui ambientare commedie,
anche perché le ambientazioni stesse si fanno più vaghe, meno caratterizzate, nei titoli di successo con Pozzetto, Celentano o Montesano, e la generazione successiva (Troisi, Nuti, Benigni,
Nichetti) punta su tonalità malinconiche, introspettive, che hanno
meno bisogno del folklore. Forse anche per questo, una grande eco ha,
al momento dell’uscita, Johnny Stecchino (1991) di Roberto Benigni, i cui elementi di novità appaiono invece oggi piuttosto limitati. Il film
cade però nel momento giusto, di grande mobilitazione dei media contro la mafia (la maratona antimafia congiunta tra Samarcanda e il Maurizio Costanzo Show, in occasione dell’omicidio di Libero Grassi,
precede di qualche settimana l’uscita del film). Benigni mette da parte la componente erotica e inserisce alcuni elementi derivanti dalla rinnovata conoscenza pubblica di Cosa Nostra: anzitutto, la correità della borghesia locale, con la figura di un ministro cocainomane e di
un giudice di Cassazione, entrambi conniventi. Una linea che trova la sua massima espressione nella scena all’Opera, in cui Benigni,
scambiato per un pentito, viene segnato a dito dai borghesi presenti, che per protesta abbandonano la sala. Per il resto, il tema dell’ingenuo
sosia del boss, ricavato da Tutta la città nel parla di John Ford (e alla lontana dal classico romanzo di Anthony Hope, Il prigioniero di
Zenda), era stato già utilizzato varie volte, e in particolare in una serie di farse successive al successo del Padrino, come IIfiglioccio del
padrino (di Franco Prosperi, con Alighiero Noschese che imitava Brando) e La mafia mifa un baffo, sottoprodotto diretto da Riccardo Garrone con un attorucolo (Renato Cecilia) costretto a impersonare
un boss defunto cui somiglia in maniera impressionante. Ma il modello diretto è forse soprattutto Fracchia la belva umana di Neri Parenti, in cui è presente tra l’altro l’elemento del mammismo: come
Johnny Stecchino, anche la «belva» è morbosamente devoto alla madre, che nel film con Villaggio è un irresistibile Gigi Reder1*410 11. Il vero cambiamento avverrà negli anni successivi, e sarà basato
sull’avvento di una prospettiva interna, di uno studio delle forme di rappresentazione e di auto-rappresentazione del mondo mafioso, da
parte di autori siciliani. All’epoca di Johnny Stecchino godono già di
una certa popolarità le strisce televisive Cinico Tv di Cipri e Maresco. Come si vedrà nel capitolo a loro dedicato, si tratta dell’uso più radicale del comico mai tentato fino a quel momento, capace non solo
di affrontare in maniera diretta eventi e persone (con attacchi frontali, negli anni, a politici come Salvo Lima o Totò Cuffaro), ma anche di
segnalare precocemente le contraddizioni e le ambiguità del movimento antimafia, e di indicare per la prima volta le
contraddizioni interne al cinema stesso: il suo uso degli stereotipi e delle scorciatoie, le ambiguità del cinema «impegnato» e «di
denuncia», i paradossi del modo di produzione. È una comicità
violenta, mai consolatoria o auto-assolutoria; è Tumor nero implacabile, quasi masochista, di chi è vissuto vicino al mondo
mafioso. Quando l’opinione pubblica perderà interesse a Cosa Nostra, la coppia di registi tornerà alla carica con gli episodi di I migliori nani
della nostra vita e Ai confini della pietà, e il solo Maresco con Belluscone . Dagli anni duemila, di mafia si può ridere anche perché essa non è
più un argomento di tragica attualità. Quando Paolo Sorrentino gira II divo, la stagione dell’emergenza è ormai lontana, e i momenti ironici
non hanno più valore provocatorio, ma di gioco su una serie di immagini ormai lungamente ripercorse dai media. Se lo stile di
Sabina Guzzanti in La trattativa sembra puntare più alla divulgazione
che alla dissacrazione, Pif in La mafia uccide solo d'estate compie un
passo ulteriore: da un lato l’inedito incrocio con la commedia
sentimentale; dall’altro, l’assunzione esplicita della mafia in un universo di maschere, e il suo radicamento nella memoria di una . .... .13 generazione di spettatori televisivi .
1 II film era accompagnato da una canzone di Domenico Modugno, il cui testo diceva: «Su partati tincu cavalli nivuri/ cincu ùcci senza pietà./ Hannu scritta supra i fucili: l’onorata
società./ Su partati armati fina ai denti/ cun lu cori piena d’omertà/ pi partati fina a la
continent!/ l’onorata società./ Mafia è leggi di sangue,/ mafia è leggi d’onori,/ leggi ca spacca lu cori/ senza virtù, pietà» («Sono partiti cinque cavalli neri/ cinque facce senza pietà./ Hanno scritto sopra i fucili: l’onorata società./ Sono partiti armati fino ai denti/ con il cuore pieno di omertà/ per portare fino al continente/ l’onorata società./ Mafia è legge di sangue,/
mafia è legge d’onore/ legge che spacca il cuore/ senza virtù, pietà»).
“ In realtà, pare che la dinamica illustrata nel film di Lattuada sia tutfaltro che fantasiosa,
se non nella rapidità dell’esecuzione: lo scambio di killer tra Cosa Nostra italiana e americana risale addirittura agli anni venti (G. C. Marino, Storia deUa mafia, Newton Compton, Roma
1998, v ed. 2010, p. 134). Sciascia, La Sicilia e il cinema dt, pp. 1220-21. 4 A. Lattuada, Piccolo ritratto di Alberto Sordi, in Id., L’occhio di Dioniso. Racconti,
ricordi, lettere d’amore, La Casa Usher, Firenze 1990, p. 137. ° G. Amelio, Mafioso a chi?, in Id., Unfìbn che si chiama desiderio, Einaudi, Torino 2010,
P.37. Sul film, distribuito con successo nelle sale statunitensi negli anni duemila, si veda N.
Moe, Modernity, Mafia Style: Alberto Lattuada’s II Mafioso, in Renga (a cura di), Mafia Movies. A Reader dt, pp. 2x9-26. Nel successivo Don Giovanni in Sicilia (1967) dello stesso
regista la prospettiva sarà ribaltata: in piena disillusione del boom, la Sicilia erotica appare quasi un paradiso perduto a confronto con la Milano industriale. A. Callotti, Franca Rame mafiosa offre colpi di lupara, in «Carlino Sera», Bologna, i°
novembre 1962, in vvww.archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=S6i2&lDOpera=28.
La rassegna stampa deh’Archivio Franca Rame, allo stesso indirizzo vveb, riporta varie
reazioni allo sketch, dal quotidiano palermitano «Il Semaforo» (3 novembre), che plaude all’uccisione finale del giornalista importuno (Una lupara intelligente, è il titolo dell’articolo), a un’improbabile lettera anonima di minacce di morte firmata «i piedotti» al «Giornale di Sicilia», che titola Unanime indignazione neU’isola per la penosa farsa di Dario Fo, riportando anche una pittoresca lettera del conte Ernesto Perrier de Laconnay.
Particolarmente incisivo il commento in prima pagina dell’«Avanti!» (4 novembre), firmato
da Pietro A. Buttìtta.
g
e. c., Dario Fo: *La mafia me la sono inventata io!», in «L’Unità*, 4 novembre 1962,
www.archivio.francarame.it/scheda.aspx?! DScheda=86i2&IDOpera=28. Analoga interrogazione fu presentata all’Assemblea regionale siciliana da alcuni deputati milazziani:
cfr. «Giornale di Sicilia», 4 novembre 1962.
S. G. Biamonte, La mafia di Fo non è quella di Sordi, in «Il Giornale d’Italia», 3 novembre 1962. Sporadiche occasioni di satira sui rapporti tra mafia e politica saranno
presenti in alcune trasmissioni televisive degli anni settanta. Gli onorevoli democristiani
Salve Urna e Giovanni Gioia furono oggetto di ironia da parte di Pino Caruso nel 1975, nella trasmissione Mazzabubù, scritta da CasteHacd e Pingitore e diretta da Antonello Fàlqui, con il couplet «Venga a prendere il caffè da noi/ Ucdardone cella ventisei/ d saranno tanti amid
miei» (il riferimento era alla morte in carcere di Gaspare Pisdotta). Nello sketch, tra l’altro, un mafioso chiedeva di uscire dal carcere e si informava: «Ma c’è bisogno di lima?». «No, gioia, non c’è bisogno di lima...» gli veniva risposto. 10 Uno dei maggiori successi del genere, Meglio vedova di Ducdo Tessati, ha invece i toni della commedia «rosa», con un inglese inviato in Sicilia per costruire una raffineria che incontra le prevedibili minacce dei mafiosi del luogo, subisce l’altrettanto prevedibile fascino
di Virna Lisi, promessa sposa a un nobile. Tra le curiosità umoristiche si segnala anche Tutti figli di mammasantissima di Alfio Caltabiano, realizzato sulla sda di Anche gli angeli
mangianofagioli di E. B. Clucher. 11 Nel frattempo, è il cinema americano a incrementare i ritratti corniti di gangster italo-
americani, inserendoli (dopo i film di Coppola e Scorsese) in dinamiche sodo-antropologiche
più articolate di quanto non potesse essere ai tempi di A qualcuno piace caldo di Billy Wilder 0 Angeli con Za pistola di Frank Capra: è il caso di L'onore dei Prizzi di John Huston e
tangenzialmente Broadway Danny Rose di Woody Alien. Un paio di film dell’epoca
ironizzano anche sul legame tra mafia e cinema: Pallottole su Broadway di Woody Alien e Get Shorty di Barry Sonnenfeld. Poco dopo, Terapia e pallottole di Harold Ramis, col suo spunto del boss in analisi per gli attacchi di panico antiopa la trama dei Sopranos. Cfr. infra, pp. 299-303. Un’eco forse ancora maggiore ha avuto all’epoca della sua usdta
Tana da morire di Roberta Torre, di cui si parla nel capitolo precedente e più diffusamente
nel cap. xi). Tra le numerose commedie die hanno sullo sfondo la criminalità organizzata,
significativamente, Cosa Nostra perde sempre più terreno, e si preferisce aggiornarsi alle mafie di maggior voga mediatica (i camorristi di Un boss in salotto di Luca Minierò, o Natale col boss di Volfango De Biasi). Ma va ricordata l’eccezione di La matassa di Giambattista Avellino, Ficarra e Picone, che regala una gag memorabile, quella della comunicazione tra i
protagonisti e dei mafiosi che pretendono il «pizzo», che si risolve in un balletto di silenzi e di pizzini.
v. Western di Cose Nostre: In nome della legge
La mia, la nostra vita si era svolta, almeno nella prima
fase, alla Magione, in un quartiere di mafia. Ma questa presenza non l’avevamo mai avvertita. È curioso, ma è così: i padrini li avremmo scoperti dopo. Anche Giovanni, forse. [...] D’altra parte, si può capire: la mafia,
prima, non sapevamo cosa fosse. L’unica volta che ne parlammo in famiglia, quando abitavamo in via Castrofihppo, ricordo che fu in coincidenza dell’uscita del film In nome della legge. Maria Falcone1
i. Idea di un'isola. «Agosto ’48. Finita la sceneggiatura di In nome della legge.
Sopralluoghi in Sicilia per scegliere i posti delle riprese. Non ero mai stato
in Sicilia, e mi preparavo a fare questo film senza una spinta, senza un’emozione. Diciamo pure in malafede. [...] Ora tutto è diverso. Quel
paesaggio! Quell’arsura! Quelle facce! (...) Ora tutti gli elementi del racconto hanno acquistato dimensioni e realtà: la mafia, il barone, i banditi, i poveri, i giardini, le serenate, le schioppettate, l’amicizia, la gentilezza, la crudeltà. Il senso del segreto, della prepotenza, 2
dell’orgoglio» . H racconto di come fu ideato e realizzato In nome della legge, primo film che esplicitamente parla di mafia nel cinema italiano del dopoguerra,
ha un valore esemplare, quasi metaforico. Come ha più volte raccontato,
Pietro Germi scrive il film basandosi su un romanzo di un ex pretore ambientato nei primi anni venti, e solo dopo incontra fisicamente il set Ne ha, in apparenza, un’entusiasmante conferma, anzi quasi ima
moltipEcazione iperbolica del pre-giudizio. La Sicilia è esattamente così come uno se la immagina; anzi, è ancor più così. La triangolazione
rimarrà tipica di molto cinema italiano ambientato nell’isola: testo di
partenza di autore siciliano-progetto cinematografico ideato senza conoscenza diretta di luoghi e persone-riprese (in questo caso effettuate in Sicilia, ma in altri no). L’avventura siciliana di Germi non si concluderà qui. Seguiranno II cammino della speranza, Gelosia, Divorzio all'italiana e Sedotta e abbandonata, tappe di un rapporto di amore-odio inestinguibile da parte
del regista ligure. La fascinazione della Sicilia è in lui di ordine antropologico, tendente al metafisico . Una quintessenza dell’Italia, che
cela nel contempo qualcosa di diverso, ineffabile: il suo cuore di tenebra. Ma c’è dell’altro, più consustanziale all’idea germiana di cinema, che
declina un suo neorealismo all’americana, in maniera meno barocca di Giuseppe De Santis, con modelli legati essenzialmente al western . La seduzione del paesaggio e i modelli del western resteranno fino alla fine
un elemento decisivo della messa in scena di Germi. Il paesaggio è definito da subito come quello del latifondo e dell’intemo: ragion per cui, anche se
gran parte del film è girata in una popolosa cittadina marinara come Sciacca, la macchina da presa dà sempre le spalle al mare, che non si vede
mai per tutto il film, e l’impressione è quella di un villaggio di contadini e zolfatari. Nei film precedenti di Germi (Il testimone, Gioventù perduta),
che narravano fatti di cronaca nera, il modello invece era quello del giallo urbano, di quello che oggi chiameremmo film noir. Ma se la mafia è
fenomeno del latifondo, un film all’americana sulla mafia dovrà, invece,
avere come modello il western3. H riferimento è evàdente fin dall’inizio, nella colonna sonora di Cario
Rustichelli, che alterna una marcia da western e una melodia dagli echi
operistìco-folklorici, nello stile di certi passaggi della Cavalleria rusticana di Mascagni . Nelle stesse scene iniziali evàdente è però anche il modello
neorealista nell’uso della voce over, che all’inizio espone le premesse
socio-ambientali del racconto: Questa terra, questa sconfinata solitudine schiacciata dal sole, è la Sicilia. Che
non è soltanto il ridente giardino, aranci, ulivi, fiori, che voi credete 0 credete di conoscere. Ma è anche terra nuda e bruciata, muri calcinati di un biancore accecante, uomini ermetici dagli antichi costumi, che il forestiero non comprende. Un mondo misterioso e splendido, di una tragica ed aspra bellezza.
H prologo (come sarà poi in moltissimi mafia movie successivi, a
cominciare da II giorno della civetta di Damiani) mostra un agguato campestre in medias res, con una predominanza di piani americani, che
domineranno tutto il film. U protagonista, interpretato da Massimo
Girotti, scende dal treno da solo, in campo lungo. È di Palermo, ma tutti lo
scambiano per straniero («non si direbbe, dall’accento»: del resto, nel film, borghesi e aristocratici non hanno mai accento, che è riservato ai
personaggi secondari e popolari). È il nuovo pretore, vestito in abiti cittadini, da noir potremmo dire; è, soprattutto, un cittadino che arriva in
un villaggio. Dopo essere stato messo sull’avviso dal vecchio pretore, prenderà una corriera-diligenza per raggiungere il paese'. Lì incontriamo le figure comiche dei notabili (il sindaco, il cancelliere, l’avvocato leader
dell’opposizione Spadaro), e il maresciallo, che conosce fatti e persone, e tiene famiglia. La mafia gestisce l’ordine con modi spicci, e il conflitto
principale sarà tra il pretore (la legge dello Stato) e il capomafia (la legge del fucile). Intorno una completa omertà, che rimanda a una visione
decisamente passiva del popolo: la massa dei lavoratori inneggia al protagonista quando questi annuncia la riapertura della zolfara, ma, appena l’apertura ritarda, quasi lo lincia.
2. Piccolo pretore. Da subito In nome della legge fu accusato di offrire una versione
romantica e idealizzata della mafia, che in quel periodo uccideva ogni
anno, tra l’altro, decine di sindacalisti e di militanti socialisti e comunisti (Germi scrive la sceneggiatura nelle settimane successive all’omicidio di
Placido Rizzotto). Per la prima volta l’organizzazione mafiosa viene
esplicitamente mostrata in un film italiano, ma il «cattivo» del film non è
certo il boss, bensì il barone che di lui si serve; il senso finale del film è, se non un’alleanza, una cessione di poteri dalla mafia allo Stato. Come dice il
capomafia, massaro Turi (Charles Vanel):
La legge qui la facciamo noi, secondo le antiche usanze. Siamo in un’isola, qui; il governo è molto lontano. E se non d fossimo noi, con la nostra severità, la malavita finirebbe per guastare ogni cosa, come il loglio nel grano, e nessuno sarebbe più sicuro in casa propria. Non siamo delinquenti, noi: siamo uomini d’onore, liberi e ■
3
indipendenti come gli uccelli nell’aria .
Le ambiguità sono dovute anzitutto all’interazione con l’esplicito
modello western (un mythos di instaurazione della Legge in cui però è necessario il riconoscimento della Legge precedente) e con il testo di partenza. Molti degli elementi, tra l’ambiguo e il folldoristico, che sono
stati discussi nel corso del tempo, si trovano già nel romanzo di Guido Lo
Schiavo, e il film provvede anzi a sfumarli o a smorzarli. Dell’ambiguità del libro gli autori del film (tra gli sceneggiatori c’erano Tullio Pinelli, Federico Fellini e Mario Monicelli) si accorsero subito:
Questo Lo Schiavo in realtà era, sì, un magistrato, ma credo che fosse anche un mafioso. Infatti il film è abbastanza ambiguo, tutto sommato. (...) Il fatto soltanto di raccontare gli intrighi, le bassezze, le collusioni della mafia, era già un fatto talmente esplosivo, per quell’Italia di allora che veniva dal fascismo, che questo finale, in cui la stessa mafia faceva giustizia, non sembrava una cosa così controproducente9. In definitiva il film è assai meno folkloristico del romanzo, e mette in rilievo gli elementi che definiscono e articolano il contesto sociale: il
circolo, il conflitto tra contadini e zolfatari, il proprietario terriero che minaccia di scrivere a Roma quando gli viene intimato di aprire la
miniera: «H mio cliente ha i suoi santi a Palermo, a Roma...», dice il suo avvocato, che aggiunge, mentre appaiono per la prima volta le sagome di
uomini a cavallo in campo lungo, «... e qua. Soprattutto qua». «La mafia», commenta Girotti.
H libro, pubblicato nel 1948, è ambientato nel 1921 nell’immaginario paese di Màrcatobianco, e anche qui, in maniera più evidente, alla mafia
sono attribuite connotazioni positive. Come si dice a un certo punto: «La mafia è finita e c’è il regno dei banditi» (p. 10, nel film la battuta suonerà:
«Dite a massaro Turi che la mafia è finita, ora esiste solo delinquenza»).
Proprio la guerra tra mafia e banditi è il tema esplicito del romanzo, e il
protagonista ci si trova in mezzo. È da notare, al riguardo, che all’inizio il libro mostra, in maniera minuziosa, il rituale dell’affiliazione mafiosa,
ossia la panciuta del dito davanti al santino: solo che la attribuisce ai briganti. Così come sono i briganti, non la mafia, ad attentare alla vita del pretore. Come nel film, l’apparizione del boss Turi Passalacqua, nobile
antagonista, avviene a metà della vicenda, e sono almeno un paio i lunghi
confronti tra i due, con parole a cui la sceneggiatura del film si ispira direttamente .
Nel romanzo, però, viene già descritta l’articolazione politica del paese, tra liberali, popolari e comunisti. Il conflitto tra legge dello Stato e legge
della mafia è esplicito: «Tutti i siciliani [...] sono un po’ mafiosi: hanno nel
sangue qualcuno o molti dei principi di disciplina di cavalleria di rispetto di onore propri della mafia; però c’è un punto in cui, secondo me, la mafia
è in difetto [...]. La mafia è in difetto quando pretende di sostituirsi allo Stato nel fare giustizia!»11. Nella scena finale il pretore riconosce in massaro Turi «il re del paese» e il narratore commenta: «Le due Leggi,
quella dello Stato, la togata, e quella della campagna, avevano fatto 12
armistizio e per la prima era rittoria! » . Nella premessa al libro è esplicita l’idea di offrire una sorta di
introduzione al lettore «continentale», secondo una lettura chiaramente etnica della mafia. Bisogna distinguere, afferma Lo Schiavo, il
«sentimento mafioso» delibazione della mafia». H primo si manifesta con la fedeltà all’amicizia, la solidarietà, il cavalleresco rispetto per la donna, l’ossequio all’autorità dello Stato. (...) Poi... poi gli aggregati cambiarono natura e divennero avversatori dell’Autorità costituita e nelle condizioni fondiarie dell’isola, piena di ex-feudi impervi, con centri abitati distanti l’uno dall’altro, formarono una rete fittissima di affiliati per la custodia delle terre, il locupletamento individuale, la punizione dei loro avversatori13. Forse allora occorre spendere qualche parola su questo Giuseppe Guido
Lo Schiavo, che si racconta mutando appena le proprie generalità in
Piccola pretura. È un magistrato palermitano, «ragazzo del ’99», che aveva esercitato da giovanissimo a Barrafranca, in provincia di Erma,
distinguendosi nell’ondata repressiva della mafia cui aveva dato impulso il prefetto Cesare Mori, e poi era stato pm a Caltanissetta e Palermo, e infine, dal 1933, a Roma. La sua immagine della mafia è dunque quella del
feudo e degli anni venti, e l’impostazione di fondo può essere assunta come esemplare di un atteggiamento piuttosto comune nelle classi dirigenti dell’epoca, e in particolare nella magistratura. Il prefetto Mori al riguardo era stato chiaro: «La omertà ha in se stessa i mezzi specifici per combattere le proprie degenerazioni» .
In alcuni testi non di finzione, Lo Schiavo esporrà ancora più
limpidamente la propria ideologia. Celeberrime, e spesso citate, le sue parole in morte di don Calogero Vizzini, capomafia di Villalba: «Si è detto
che la mafia disprezza polizia e magistratura; è un’inesattezza. La mafia rispetta la magistratura e la giustizia. Nella persecuzione ai banditi e ai
fuorilegge la mafia ha affiancato le forze dell’ordine. Possa l'opera del successore di don Calogero Vizzini essere indirizzata sulla via del rispetto della legge» \ Dal suo saggio storico 100 anni di mafia, pubblicato nel 1962,
apprendiamo che il discorso di massaro Turi era stato rivolto a Lo Schiavo da un omonimo reale (Salvatore Passalacqua), soprastante nei feudi del
conte di Mazzarino, a Barrafranca: «Quando lei, Signor Pretore, sarà vecchio, ed io non sarò più su questa terra, ricordando questo incontro,
vedrà che massaro Passalacqua applicava leggi di natura in buona fede e
assolveva i suoi doveri con coscienza ed onestà... Mi stringa la mano, signor pretore, sono un galantuomo» . A dire il vero, è forte la tentazione
di vedere in questa ricostruzione un effetto retroattivo del libro e del film,
un «vero» capomafia modellato su quello letterario e cinematografico: fenomeno tuttaltro che infrequente nella storia della mafia e delle sue rappresentazioni.
3- Tl giardino delle femmine.
Si può avere l’impressione che dalla struttura del western americano deriri anche la parte sentimentale del film, spuria rispetto al resto, con gli
incontri in giardino tra il pretore e una baronessa, a cui si aggiunge un che
di torbido tipicamente «meridionale»: il personaggio di Bastianedda, che la madre promette in sposa al proprio amante, è un evidente calco dalla
Lupa di Verga. Ma studi più recenti hanno proposto una lettura in chiave di gender per
l’intero film, leggendo le azioni di Guido come sintomi di una crisi della
legge patriarcale:
Il fallimento iniziale di Guido di stabilirsi lui stesso come passaggio chiave nella linea patriarcale di questa città lo apparenta inevitabilmente col femminile, che è
presentato come marginalizzato, rimpiazzante simbolicamente dò che si trova al di fuori del potere. Accettando implicitamente lo status quo, come il film suggerisce che lo Stato stesso potrebbe essere tentato di fare, annichilirebbe la sua appartenenza a ogni linea patriarcale, e con dò l’idea di civiltà a cui la nuova Italia del dopoguerra aspira1.
H conflitto tra Guido e massaro Turi, sostiene Danielle Hipldns, è schiettamente edipico, e per risolverlo Guido deve liberarsi dalla propria
femminilità priva di potere, rappresentata dal personaggio del giovane ed effeminato Paolino, la cui affezione per Guido è comunque mascherata
dalla sua relazione eterosessuale con Teresa. Le scene di idillio tra Paolino
e Teresa sono in questa chiave tutfaltro che irrilevanti, e secondo Hipldns costituiscono uno scarto visivo, dal western al gotico (al melo gotico, potremmo dire, tipico degli anni quaranta). Alla fine, «per Turi
Passalacqua, [il pretore] diventa il figlio che dovrebbe raccogliere la sua eredità; per Paolino, il padre protettivo; per Teresa, il potenziale partner» . Ma in definitiva è la mafia, deus ex madrina, a consentire che
tutto ciò avvenga.
4. Il rimario del cinema di mafia. In nome della legge è uno dei pochi autentici successi di pubblico del neorealismo (forse il maggiore dopo Riso amaro e Roma città aperta'). E
proprio il successo segna, nel bene e nel male, la sua ricezione. È noto il dibattito che si svolse all’interno della critica di sinistra, e specialmente
sulle pagine della rivista «Cinema». Il direttore Guido Aristarco, alfiere dei principi tardo-lukacsiani nella critica cinematografica, difende il film dopo
averlo paragonato ai western di Ford e afferma che esso non andrebbe giudicato, a rigore, in proporzione diretta alla ambientazione siciliana più 0 meno fedele alla realtà, bensì alla verità artistica di una ambientazione universale e personale [...]. La sua Sicilia è più vera della Sicilia stessa19. Discordante è invece la voce di Cario Doglio, di formazione anarchica e
libertaria, e fresco traduttore di From Caligari to Hitler di Siegfried Kracauer. Le obiezioni di Doglio sono di ordine stilistico ma anche morale,
e vertono sull’immaginario insieme derivativo e coloniale del film. Il suo
articolo attacca l’orribile musica «da presentazione della RKO», i
mandolini della baronessa, le ombre della «peggiore tradizione Cines» negli idilli notturni in giardino, e soprattutto l’uso di stereotipi visivi «trapiantati», che nulla hanno a che fare con i luoghi in cui la storia si volge: l’uccisione di Paolino, l’arrivo dei cavalieri all’orizzonte, lo stacco tra
coniglio e cadavere, «Paolino con quell’aria omosessuale (altrimenti, del
resto, non c’è giustificazione emotiva del suo attaccamento al pretore)». La maniera di filmare gli omicidi deriva secondo Doglio dai film di gangster
americani (a loro volta derivati dai reportage di guerra): «Mentre suolo, clima, occasioni e ragioni di omicidio sono, in Sicilia, tutt’altre». Assente la parte economico-sociale (ma è assente perfino il prete), tutto si volge al
caffè o all’emporio . E conclude: «Se esistesse una specie di “rimario” per cinematografari, gran parte della sua merce potremmo giurare di trovarla in questo film. [...] Fortunata Sicilia se i suoi guai fossero tutti qui, e se la mafia rappresentasse nient’altro che “la legge non scritta”!». L’articolo di
Doglio causa diverse lettere di protesta dei lettori , e alle sue posizioni risponde tra l’altro Glauco Viazzi sul numero 29 della rivista.
In quel periodo, in fondo, per gli intellettuali di sinistra Germi è un potenziale compagno di strada; mentre sul versante democristiano si cerca
di non «regalare» alle sinistre un film così popolare. Sulle pagine della «Rivista del cinematografo» Turi Vasile, uomo chiave della De nel mondo
del cinema, legge il film di Germi come correttivo agli eccessi neorealisti di
titoli come Ladri di biciclette e Germania anno zero, che rischierebbero di
disperdere la felice novità di film come Paisà o Sciuscià: «gli occhi aperti sulle vicende del mondo [...] si sono socchiusi, probabilmente per ubbidire all’esigenza di veder meglio, in verità pervadere a una distanza troppo
ravvicinata e descrittiva». Germi invece «supera il neo-realismo e vi
applica una morale, addirittura un imperativo». Nel finale del film il pubblico applaude i tutori dell’ordine, proprio in tempi in cui si
consumano vendette e «le varie “Volanti Rosse” pretendono di giustificare [sic] i loro avversari». Capziosi dunque i tentativi da parte delle sinistre,
prosegue Vasile, di intestarsi il film, magari sfruttando la battuta sul
barone che ha «i suoi santi a Roma», o giocando miseramente sulla
«casuale somiglianza fisionomica del barone con un membro dell’attuale governo»
22
.
H discorso più sottile lo fa però, in Parlamento, Giulio Andreotti, sottosegretario allo Spettacolo, rispondendo all’interrogazione del 9
maggio 1949
di due compagni di partito siciliani che accusano in
maniera colorita il film di denigrare l’isola, e alle controinterrogazioni ^>4 degli onorevoli Nunzio Nasi e Giovanni Leone . Andreotti,
rammaricandosi che la prevista visione del film per i deputati non avesse
avuto luogo a causa dell’inizio della maratona parlamentare per il Patto
Atlantico, snocciola gli incassi del film, gli applausi a ogni proiezione, il plauso della critica. E fa una mossa del cavallo, rivolta forse più contro i
tentativi di appropriazione della sinistra che contro le critiche dei conservatori isolani. Il film, dice, è un atto di fantasia, che non può essere
valutato come opera documentaria (affermazione che vale a disinnescare ogni uso politico da sinistra); il turismo in Sicilia non è in crisi per colpa
della Lux o di Germi; probabilmente, da questa discussione parlamentare, il film otterrà pubblicità ulteriore. L’onorevole Nasi a questo punto
protesta vibratamente: il film racconta purtroppo l’esistenza di un fenomeno reale, e ha invece proprio un valore di documento. Il ragionamento di Andreotti non soddisfa nemmeno Leone, che prova invece a tirare il film dalla sua: «Nel film palpita potente il senso
dell’attaccamento alla legge [...] che si realizza mediante gli strumenti
della legalità...». Una voce dalTestrema sinistra: «La mafia!» (Commenti)20.
In coda, è curioso ricordare anche il destino del severo giudice del film su «Cinema». Doglio, cinefilo ma soprattutto urbanista e sociologo, cresciuto alla scuola del socialismo inglese, all’epoca sta per entrare
nell’orbita di Adriano Olivetti, col quale collaborerà a varie iniziative a Ivrea. Poi, nei primi anni sessanta, si trasferirà in Sicilia, andando a rivere
a Bagheria, nel pieno dell’esplosione dell’abusivismo edilizio e di una 26
rinnovata violenza mafiosa . Forse, alla lontana, potè misurare la
distanza con la mafia contadina e western di Germi; forse, addirittura, l’interesse per la Sicilia ave\ra avuto impulso anche dalla visione di quel film, quindici anni prima.
Intervista in F. La Licata, Storia di Giovanni Falcone, Feltrinelli, Milano 1993, p. 69. * P. Germi, Taccuino segreto, in «Panorama», giugno 1963, ora in Pietro Germi. Viaggio nel
cinema italiano, a cura di S. Carpiced, Cooperativa Massenzio, Roma 1995, p. 115. E ancora, il regista ricorda che all’epoca dei sopralluoghi «il lavoro precedente non ebbe bisogno di essere modificato; quanto avevamo fatto intuitivamente non si rivelò sbagliato, andava bene lo stesso,
però assunse tutta una nuova illuminazione» (intervista in G. Gambetti, a cara di, Sedotta e
abbandonata di Pietro Germi, Cappelli, Bologna 1964, p. 19). 3 «La Sicilia è un modo di vivere, non so se mi spiego, una categoria dello spirito», in
«L’Espresso», 19 marzo 1963, ora in Carpiced (a cura di), Pietro Germi. Viaggio nel cinema italiano cit., p. 116. 4
«Già la premessa di giungere in Sicilia con un copione a stesura definitiva, senza aver mai
messo piede sull’isola e aver mai fatto un sopralluogo, è [...] indicativa di un modo di raccontare
che egli svilupperà per metafore e analogie, riferimenti e mutazioni dai classici del western
americano. (...) Nella sua mente l’isola è un set già predisposto per le riprese, uno spazio scenico già
montato e costruito per la rappresentazione» (S. Carpiced, Hollywood all’italiana, in Id., a cura di,
Pietro Germi. Viaggio nel cinema italiano dt, p. 13). ' V. Capraia, Germi, un'isola nel cinema italiano, propone in maniera dettagliata il paragone con western (Pietro Germi e la Sicilia. Incontri con il cinema, Acicatena, a cura di S. Gesù,
Associazione turistica pro loco, Acicatena 1988, pp. 20-2). ' Sulla colonna sonora «bitematica» con predominanza di una marcia western cfr. E. Comuzio,
Un rapporto semplice cioè un po' complicato, in Gesù (a cura di), Pietro Germi e la Sicilia cit, pp. 29-30.
Che si chiama Capodarso, come una contrada tra Enna e Caltanissetta, non lontana dalla
Barrafranca dove era pretore il Guido Lo Schiavo autore del romanzo.
Lo stesso Germi tornerà più volte su questo tema, in varie interviste successive. Ad esempio,
quindid anni dopo dichiara quanto segue: «La mafia (...) era forse l’occasione per un racconto di tipo avventuroso, ma non era la ragione prindpale del film. (...) Una mafia del tipo arcaico, quasi
nobile, di In nome della legge, certamente nel passato esisteva: e infatti il film nasceva dai ricordi autobiografia di un magistrato. Esisteva forse trenta o quaranta anni fr, ma forse esiste ancora oggi, in un certo luogo. Identificare semplicemente la mafia con un fenomeno delinquenziale mi
sembra molto semplicistico. E il siciliano medio non è così nemico della mafia come si crede: in un
modo 0 nell’altro tende sempre a giustificarla. (...) In In nome della legge c’era l’aspetto delinquenziale, rappresentato da una parte dei mafiosi, c’era l’aspetto di giustizia arcaica,
rappresentato da un’altra parte di mafiosi, c’era la legge, in mezzo, che tendeva ad affermare il proprio predominio, e c’erano gli interessi dei quali la mafia si serviva e che a sua volta servava. Era un quadro che ancora oggi io sostengo essere più vicino alla realtà di quel che non sia un semplicismo frettoloso, anche se può darsi che in questi ultimi anni, per quel tanto di
trasformazione industriale che c’è stato anche in Sicilia, gli interessi concreti di speculazione della
mafia si siano andati gradatamente spostando verso queste zone, strappandola all’ambiente
latifondista in cui era nata» (intervista riportata in Gambetti, a cura di, Sedotta e abbandonata di Pietro Germi dt, p. 21). •)
Testimonianza di Mario Monicelli in A. Apra, M. Armenzoni, P. Pistagnesi (a cura di), Pietro
Germi. Ritratto di un regista all’antica, Pratiche, Parma 1989, pp. 85-6. 1 G. G. Lo Schiavo, Piccola pretura, Colombo, Roma 1948, pp. «5-20.
‘ ' Ibid., p. 118.
' * Ibid., pp. 283-4. 3 Lo Schiavo, Piccola pretura dt, pp. 6-7. 1 Anzi, secondo Salvatore Lupo, i testi di Lo Schiavo nel secondo dopoguerra sono indicativi di
un mutamento dell’opinione pubblica nel quale scompare «Vantìmafia di destra»: Lupo, Storia
della mafia dt, p. 239.
’ G. G. Lo Schiavo, Nel regno della mafia, in «Processi», 5 gennaio 1955. Id., 100 anni di mafia, Vxko Bianco, Roma 1962, p. 35. Di questo massaro Turi si parla alle pp.
161-5, riportandone un ritratto che Lo Schiavo aveva schizzato in uno scritto del 1932. Nello stesso volume troviamo alcuni passi esemplari, anche se piuttosto contorti, di tutta una concezione della
mafia e della Sicilia: «La mafia siciliana è ormai un mito, mito anch’esso al tramonto perché non
glorifica alcuno e quindi è meglio non ricordarlo. In sua vece, in Sicilia, rimane una consorteria criminogena che, quantunque chiamata e intesa mafia, non ha nulla di identico con la mitica
associazione dei cosiddetti uomini d’onore ed è, come suol dirsi con termine militaresco, allineata con tutte le manifestazioni criminose individuali e collettive dei più pericolosi e facinorosi
delinquenti di tutto il mondo» (p. 198). Affermazione parallela a questa, e sempre ricorrente in
tutte le professioni di ideologia sicilianista, è che il cinema fa pubblicità alla mafia, definita «fenomeno criminogeno etnico»: anche se, sorprendentemente, Formai maturo magistrato elogia il
Salvatore Giuliano di Francesco Rosi, all’epoca appena uscito. i— D. Hipkins, Which Law is the Father's? Gender and Generic Oscillation in Pietro Germi’s In the Name of the Law, in Renga (a cura di), Mafia Movie. A Reader cit, p. 205.
Hipkins, Which Law is the Father's? cit, p. 208. «Cinema», n.s., 1949,13. .'■I
Ivi, 21. * ’ Nel numero 26, novembre 1949, dopo un preambolo in cui «Cinema» si dissocia dalle
opinioni «estremistiche» di Doglio, vengono riportate alcune obiezioni di lettori, tra cui «Giorgio Arlorio da Torino» e «Morando Morandini da Como». Delle numerose lettere di protesta, si nota, nessuna è arrivata dalla Sicilia. " In effetti, mi fa notare Paolo Noto, Camillo Mastrocinque che interpreta il barone è identico a
Mario Sceiba, ministro dell’interno e siciliano di Caltagirone. 3 Camera dei deputati, Attività parlamentare, 1949, pp. 8434-40, ora in www.cinecensura.com (http://cinecensura.com/senza-categoria/intenogazioni-parlamentari-e-leggi-sulla-moralitay'). * ' L’interrogazione è presentata dagli onorevoli Fdadelfìo Careniti e Giovanni Battista Adonnino. Virgilio Nasi apparteneva a una frmiglia di notabili del Trapanese, era figlio del ministro
della Pubblica istruzione sotto Zanardelli, Nunzio Nasi, e aveva aderito al Blocco del popolo dopo
essere stato in corsa con Aldisio per la carica di Aho commissario della Sicilia liberata. Giovanni
Leone sarà, tra l’altro, avvocato difensore dei presunti assassini mafiosi del sindacalista Salvatore Carnevale, e poi presidente della Repubblica.
Sulla stessa linea le risposte dell’ambasciata d’Italia al ministero degli Esteri, il 13 aprile 1950, che allega il ritaglio di un settimanale italiano di Philadelphia, «La Ubera parola», in cui si lamenta l’arrivo negli Usa del film di Germi, colà ribattezzato senza esitazioni Mafia. L’ambasciatore
distingue tra il film americano e quello italiano, rassicurando che anche gli italiani d’America non vedono nel film di Germi alcun intento offensivo (il documento è nel fascicolo su In nome della
legge presso l’Archivio centrale dello Stato di Roma, Fondo/Serie Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Direzione generale dello spettacolo, Divisione produzione cinema, Cf 0428 - d’ora in
poi Acs). *f Cfr. gh interventi di Ferdinando Sdanna e Nino Morreale in C. Doglio, Il piano della vita. Scritti di urbanistica e cittadinanza, supplemento a «Lo Straniero», ottobre 2006, pp. 5-14-
vi. Anni difficili
Dopo In nome della legge e i suoi immediati epigoni, di cui parliamo
sotto, nell’Italia degli anni cinquanta la mafia non appare quasi più sugli schermi. Bisognerà aspettare il Salvatore Giuliano di Rosi per un film che,
attraverso il racconto del banditismo, tomi ad affrontare l’intreccio tra
politica e crimine. Il silenzio, peraltro, non riguarda solo il cinema. Come
ha ricordato Salvatore Lupo, che definisce il periodo 1946-1960 «il lungo armistizio», se «in Sicilia di mafia si parla sempre ad abundantiam» l’eccezione sono proprio gli anni cinquanta del Novecento1. In quel periodo arrivano in Italia le prime testimonianze sulla mafia d’oltreoceano
(la traduzione del rapporto Kefauver, il libro di Ed Reid) , ma è
soprattutto il giornalismo locale de «L’Ora», a partire da metà decennio, a tenere la bandiera dell’informazione . Ed è soprattutto la cultura di
sinistra, legata a Pei e Psi, a dar conto della mafia e a rievocare, anche in
chiave di martirologio, i suoi oppositori: gli assassini di militanti, pur decrescendo notevolmente dopo il 1950, continuano per metà del
decennio, fino a quello di Salvatore Carnexrale (1955), immortalato subito nella ballata di Ignazio Buttìtta Lamenta pi la morti di Turiddu
Cornwall , e che poi ispirerà indirettamente Un uomo da bruciare (1962) di Valentino Orsini, Paolo e Vittorio Taviani.
H cinema italiano, d’altronde, in questa fase è in cerca di una propria ridefinizione economica e poetica. Ormai esauritasi la spinta neorealista
(c’è chi sostiene già dal 1949, o almeno dal 1953, data di un convegno a Perugia che mette insieme critici e autori)0, gli autori cercano una chiave
per raccontare la nuova borghesia, mentre i generi evolvono dal mèlo
proletario di Raffaello Matarazzo (Catene, 1949) alle commedie popolane del cosiddetto «neorealismo rosa» (Pane, amore efantasia, 1953, di Luigi
Comencini; Poveri ma belli, 1956, di Dino Risi). Un decennio di transito,
insomma, che approderà a un nuovo pubblico e a un nuovo ruolo del cinema in una società mutata, negli anni del boom. In questo panorama, la mafia e il banditismo (ma anche il defunto separatismo e l’occupazione
delle terre) rappresentano un tema poco appetibile, non solo perché il cinema si ritrova spesso a fare i conti con l’occhio attento della censura governativa, ma anche perché questi temi, agli occhi dei registi più
sensibili, possono sembrare di retroguardia, mentre si cerca di dar conto
di profondi mutamenti sociali e di classi emergenti. Per questi motivi, la storia del rapporto tra cinema e mafia è, negli anni cinquanta, anche e soprattutto storia di film che non si dovevano o
potevano o volevano fare, di film che diventarono tutt’altra cosa da ciò che dovevano essere, o addirittura (vedremo) di film che nessuno si era mai
sognato di fare, e che però produssero paure, lapsus, indizi oggi eloquenti.
Per lo studio di questo periodo risultano decisivi i fascicoli della
cosiddetta Commissione per la revisione cinematografica, presso il sottosegretariato (poi ministero) dello Spettacolo, depositati oggi all’Archivio di Stato . Si tratta dei materiali che venivano sottoposti
preventivamente ai funzionari del ministero per ottenere la cittadinanza italiana, e dunque l’accesso al credito della Bnl e ai premi di legge, senza i
quali era pressoché impossibile mettere in piedi la produzione. Come è ovvio, era una strettoia attraverso cui agire in maniera diretta o indiretta
una censura governativa, anzitutto sul sesso e su temi politici scomodi. Materiali oggi preziosissimi, perché contengono a volte i copioni, i cast, i
piani di lavorazione dei film stessi, e le osservazioni dei funzionari della
censura ministeriale.
i. Intermezzo: un epigono.
H difficile equilibrio, l’ambiguità feconda che In nome della legge riesce
a tenere in piedi, viene meno in un suo istruttivo epigono, adattamento di
un altro romanzo di Lo Schiavo , messo rapidamente in cantiere sull’onda del suo successo. Gli inesorabili, diretto da Camillo Mastrocinque, che nel
film di Germi interpretava il barone, e interpretato ancora una volta da
Charles Vanel, è assai più smaccatamente filomafioso del modello: un film
d’avventura in cui il capomafia protegge i deboli, minaccia gli usurai, uccide i campieri che lasciano degenerare il latifondo. Già nelle prime scene i campieri intimidiscono un bravo fattore, e arrivano i giustizieri mafiosi ad annunciare: «Qui le canaglie non hanno mai comandato. E non
comanderanno mai, finché ci saremo noi a proteggere la gente onesta». La messa in scena di Mastrocinque, con l’accentuazione dell’elemento
esotico e melodrammatico, sposta leggermente i modelli di riferimento
che a tratti sembrano essere i melodrammi messicani alla Emilio Femandez (La vergine indiana, Maria Candelaria; La perla'). La Sicilia
ha un’aria «tex-mex», nei costumi e nelle scenografie, con masseriefazenda inquadrate dal basso e in profondità di campo, come appunto
nella fotografia di Gabriel Figueroa per i film di Femandez. E tornano echi
dell’archetìpica Cavalleria rusticana di Mascagni, compresa la scena del rifiuto del vino da parte di imo dei campieri.
La classica voce over iniziale è esplicita nella contrapposizione tra mafia vecchia e mafia nuova, identificata con il brigantaggio:
Molti anni fa, tra i monti delle Madonie, nel cuore della Sicilia pittoresca e ignorata, si distendere incolto il feudo di Bellolampo, antico dominio dei baroni Occhipinti. Vero padrone però era il fattore, massaro Saverio Luparello, che amava
quella terra ma a modo suo e ad arte la lasciava incolta con il proposito di sostituirsi un giorno al barone. L’abbandono della terra aveva generato la miseria, la delinquenza. Banditi e fuorilegge infestavano la contrada, ma contro di loro si ergeva un potere dalle tradizioni secolari: la vecchia mafia con le sue leggi spietate e e
inesorabili.
Diego Costa coltiva la terra del barone rendendola un giardino, sotto la
protezione del capomafia, e causa l’ostilità dei campieri di massaro Luparello (Giovanni Grasso jr.), che uccidono sua moglie. U figlio di Diego, Sariddu (Rossano Brezzi), viene mandato in America, e quando
toma, da adulto, riprende l’opera del padre, ma ama riamato la figlia di
Luparello, Stellina (Claudine Dupuis). I due giovani innamorati troveranno alleata, contro i riolenti coetanei, la generazione dei padri: il
vecchio mafioso, il barone e il massaro.
Questa idealizzazione della mafia imbarazza, a modo loro, perfino i censori del ministero, i quali, alle prese con la prima stesura del copione (intitolata II segreto delle Madonie), osservano: «Il lavoro presente s’impone, con una veemenza senza precedenti, per l’assoluta carenza dello
Stato di fronte allo strapotere della mafia». In occasione dei vari crimini commessi nel corso del film mai «si leva un richiamo - anche solo di
nome - alla giustizia, alla autorità dello Stato». A dare retta alla presente vicenda, non ri sono nell’ambiente descritto, né forza pubblica, né Magistratura e neppure autorità locali: e la gente sembra ignorare tutto
dò come se queste fossero istituzioni, d si consenta di dirlo, del mondo della luna. Almeno nei film «western», a cui il lavoro vorrebbe rifarsi per un certo piglio avventuroso (ma è proprio un’ossessione questa del «western» italiano!), c’è la figura dello sceriffo a richiamare continuamente l’idea ed il valore della giustizia. Qui l'unica forza, seppure primordialmente costituita, è la mafia.
La produzione recepisce le obiezioni della Direzione Cinema, come si evince dai due appunti successivi che danno il nulla osta ai finanziamenti
per il film. H primo, datato 21 aprile 1950, è cassato da un frego verticale e quindi verosimilmente non spedito, ma assai eloquente:
Ndla versione attuale la mafia secolare rivive, quasi come ricordo, con la rappresentazione di un vecchio capo mafioso [Salvatore Sparado, sic] che, ritenendo esaurita la sua funzione, si è ritirato in quasi conventuale solitudine a dare saggi e pacati consigli come una sorta di santone. La sua comparsa, con nomini armati, avviene solamente nel finale, in via di eccezione, per prevenire un delitto che sta per compiersi contro il suo fighocdo, quando per la repentinità dell’evento non sarebbero state forse in grado di intervenire in tempo le forze legali.
H film, dunque, non rappresenta come In nome della legge il contrasto tra legge arcaica della mafia e nuova legge dello Stato. «Se mai,
nell’impostazione attuale, ri può essere una sorta di contrasto tra la vecchia mafia smobilitata ed elementi faziosi e delinquenti che, sfuggendo abilmente alle maglie della giustizia dello Stato, tentano di imporre alla
popolazione i loro soprusi e le loro violenze». I censori classificano il copione come «accettabile», anche se rimane
l’impressione, nel lettore di oggi, di una certa forzatura, come se il film dovesse passare. Tanto è vero che l’appunto definitivo della Direzione
Cinema, datato 26 aprile, ricopia vari passi del testo precedente e però si
sente di dover aggiungere, proprio sulla contrapposizione tra mafia vecchia e nuova, alcune perplessità. «La mafia, rappresentata com’è nel suo aspetto meno negativo ed animata da ideali di giustizia, potrebbe
generare negli spettatori un’errata valutazione di quelli che effettivamente erano la sua natura ed i suoi scopi». Dubbi esorcizzati nella frase successiva, con un richiamo a una non meglio definita opinione generale, e, a sorpresa, a un testimone
autorevolissimo:
Ma questo nostro dubbio non potrebbe, in ogni caso, essere sopravvalutato, non costituendo più la mafia un problema di attualità [corsivo mio]. È infatti, convinzione quasi generale che i recenti fenomeni di delinquenza in Sicilia hanno ben scarsi legami con quella che era la mafia di un tempo. (Su questo punto d ha dato precisi ragguagli lo stesso Lo Schiavo, alto magistrato ed autore di «In nome della legge» e del racconto, in corso di pubblicazione, dal quale è tratto il presente
lavoro cinematografico).
2. Giuliano prima di Rosi. Anche in Ifuorilegge di Aldo Vergano, che entra in produzione nel pieno del successo di In nome della legge, è evidente l’influsso del film di
Germi. Il tìtolo originale era Montelepre, e in effetti la vicenda del bandito Giuliano vi è chiaramente adombrata (le riprese ebbero luogo in zone
frequentate dal bandito, dalle partì di Piana degli Albanesi). Nonostante l’uso di set reali, però, il film si affida più ai dialoghi che ai paesaggi,
seguendo i binari classici del melo: un reduce di guerra (Vittorio Gassman), appena tornato a casa, scopre che sua sorella è l’amante del
bandito Cosimo (Ermanno Randi), braccato dai carabinieri. Sotto lo schermo del genere, si può ipotizzare, possono però passare
immagini e fatti che al cinema neorealistico «ufficiale» erano forse precluse. Il film allude al bandito Giuliano mentre questi è ancora in
attività, e non solo sono evidenti alcuni agganci all’attualità (la giornalista straniera incuriosita del bandito, ispirata forse al personaggio di Maria
Cyliakus ; il riferimento a una località nominata «Portella dei Giganti»), ma soprattutto si intravedono due vicende mai mostrate nel cinema
dell’epoca: il separatismo e l’occupazione delle terre. Sfogliando le carte della Commissione di revisione relative al film, tra la
prima stesura del copione e la seconda si avvicendano ben dieci nomi di sceneggiatori, tra cui addirittura lo stesso Germi: e il protagonista, che
inizialmente doveva essere Otello Toso (con Pino Mercanti regista), a un
certo punto è indicato in Massimo Girotti. Nella prima stesura, a giudicare dalle osservazioni dei censori, non mancavano i riferimenti diretti a Giuliano3 *10. Il nome di Giuliano e quello di Montelepre saranno infine
cancellati; ma questo, secondo Anton Giulio Mancino, finisce con l’avere
un effetto imprevisto e paradossale: Se nella prima versione Giuliano, nominato appena, poteva ancora dirsi una figura diversa da Cosimo, nella seconda versione, e dunque nel film, venendo meno qualsiasi richiamo esplicito al vero bandito di Montelepre, Cosimo finire per equivalere a Giuliano: a sostituirlo completamente diventando un personaggio «vicario»11*. Nel film non si parla esplicitamente di mafia, come d’altronde non esistono organizzazioni contadine, né lavoratori organizzati. Però, sempre nei toni del romanzo d’appendice, gli odiosi possidenti si lamentano dei «miserabili» che occupano le terre e, anche se questi ultimi non escono
mai dal ruolo di comparse, a un certo punto l’occupazione delle terre si vede, per una manciata di secondi (e forse qualche immagine è di repertorio). A capo della rete di potere locale c’è un avvocato ex
separatista: è lui il vero cattivo del film: prima fa uccidere il possidente che
lo vuole denunciare, e poi vuole sfruttare il buon reduce per uccidere il bandito. Così viene descritto il villain in un dialogo: «Ha fatto collezione
di tessere: destra, sinistra, amico dei tedeschi prima, degli americani poi,
ha fatto anche il separatista». E il separatismo, insieme all’occupazione delle terre, è l’altro grande rimosso del cinema italiano dell’epoca: sul tema c’era un progetto proprio di Germi, Bandiera bianca, che non fu mai 12
realizzato .
Non stupisce dunque che il film venga tenuto d’occhio dalla censura durante tutta la lavorazione, nonostante già alla presentazione del soggetto gli autori mettano le mani avanti premettendo che «la figura di
Giuliano non appare nel film nemmeno indirettamente» e che il film
esalta le forze dell’ordine. Già il 18 agosto, durante la lavorazione, la presidenza della Regione siciliana scrive allarmata alla presidenza del
Consiglio dei ministri e per conoscenza al ministero dell’interno, dopo aver visto alcuni materiali pubblicitari del film sulla rivista «Rassegna dello spettacolo», e dà l’allarme: la rivista
reca in copertina una impressionante illustrazione che può meglio definirsi un manifesto scandalistico sul banditismo in Sicilia, campeggia, infatti, nella illustrazione un bandito armato di mitra; e sullo sfondo le scritte: «nessuno vede, nessuno sente, nessuno paria». [...] Esprimo, pertanto, il reto che il Sottosegretario alla Presidenza, esperita la sua vigile opera di controllo, rifiuti il nulla osta per la distribuzione del film qualora esso risultasse, come si può purtroppo prevedere, opera di denigrazione della Sicilia e della Nazione13. H ministero dell’interno si trova poi direttamente tirato in causa quando i solerti funzionari del sottosegretariato per lo Spettacolo, pur
dopo un parere favorevole, inoltrano ai suoi uffici il copione il 19 dicembre 1949. Il 5 gennaio successivo arriva la risposta:
Si restituisce l’unita copia della sceneggiatura del film «Montelepre», significando che le vicende narrate nel film tra l’impotenza della polizia, le titubanze del parroco, il cinismo dell’avvocato imbroglione e la codardia di un nobile imbelle non sembrano tali da secondare i pretesi buoni intendimenti dei produttori. Ma a parte qualsiasi altra considerazione, non esclusa quella die il film potrebbe apparire privo di interesse al momento della proiezione, sembra a questa Direzione Generale che qualunque film inquadrato nell’ambiente del banditismo - anche se si trattasse di produzione apologetica delle forze dell’ordine - non farebbe in questo momento, che contribuire a «reclamizzare» una situazione locale, che è divenuta così seriamente preoccupante anche per il discorrere che ne hanno fatto scrittori, giornalisti e attori più 0 meno informati. Ciò premesso si esprime parere nettamente contrario alla produzione del film «Montelepre». Ma gli uffici competenti dell’altro ministero, con i toni anche di chi marca il proprio territorio, non terranno conto delle osservazioni della
Direzione generale di Pubblica sicurezza. E, ottenuta il 9 gennaio, dalla casa di produzione, assicurazione che il titolo del film sarà cambiato da
Montelepre inifuorilegge, con un’ambientazione «generica», ritengono venuti meno i motivi che possano turbare l’ordine pubblico: il trattamento
del film è «assolutamente normale». La Direzione di Pubblica sicurezza
contestare il fatto stesso di affrontare il tema del banditismo; ma proibire
un film solo a partire dal tema, osservano sornioni i censori, è illegale. L’appunto del 13 gennaio per S.E. Nicola De Pirro, direttore generale dello
Spettacolo, così conclude: «Non si possono abolire delle categorie di
soggetti, perché la legge non lo consente, e quindi, il farlo è effettivamente andare oltre il disposto della legge». Ovviamente, la realtà dei fatti non era esattamente questa: però i progetti scomodi venivano e verranno dissuasi,
ostacolati, sfiniti per logoramento o per assenza di finanziamenti, ma
raramente bloccati con decisioni nel merito. E dunque, un giorno dopo aver ricevuto riservatamente il parere del ministero dell’interno, la
Direzione per il cinema esplicitamente lo ignora.
Al contrario del passaggio da Montelepre a Ifuorilegge, pochi mesi dopo la Are Film di Roma ribattezza Turri il bandito un film che aveva come titolo di lavorazione L'escluso, avendo però cura di dichiarare alla
Commissione per la revisione preventiva che Turri è semplicemente il cognome del bandito protagonista, il quale di nome fa Pietro. H film, oggi
perduto, a giudicare dal soggetto conservato all’Archivio di Stato è un altro
mèlo dai toni western, con il protagonista che torna dalla prigionia (un altro reduce) intenzionato a vendicarsi del rivale divenuto sindaco del
paese. Accusato di un omicidio, Turri si dà al banditismo, ma una compagnia di guitti scopre per caso la sua innocenza (ovviamente, vero
responsabile è il rivale), e organizza un incontro notturno al teatro della parrocchia, dove il sindaco lo minaccia con la pistola confessando il
proprio crimine: e a quel punto il sipario si apre, mostrando l’intero paese che ha assistito alla confessione. Nulla osta, dice la censura: a patto, ovviamente, che il cattivo non faccia proprio il sindaco. Il personaggio,
dunque, diventerà un generico potente locale14.
3. Intorno a Portello. Anton Giulio Mancino, nel suo volume II processo della verità, ha raccolto i progetti che, prima e durante il film di Francesco Rosi, hanno
tentato di raccontare la vicenda del bandito Giuliano. Oltre a Ifuorilegge e
a un misterioso progetto di cui si trova un accenno proprio nel fascicolo ministeriale relativo allo stesso film15 , l’autore indica altri tre titoli: uno
mai realizzato (di Giuseppe De Santis), uno realizzato ma di cui si sono perse le tracce (Giuseppe Amato), e uno destinato, suggerisce l’autore, a
cambiare pelle.
Si tratta, in quest’ultimo caso, nientemeno che di La terra trema di Luchino Visconti che, secondo la ricostruzione di Mancino, era stato progettato in origine come documentario sulla strage di PorteDa della
Ginestra e che poi divenne una versione contemporanea dei Malavoglia di
Veiga. L’autore ricorda le testimonianze di Franco Zeffirelli e le pagine di appunti pubblicate dal regista su «Bianco e nero» nel febbraio-marzo 1951-
Il film infatti sarebbe dovuto essere una trilogia, che sarebbe sfociata in
un episodio sull’occupazione delle terre (da cui il titolo complessivo, perché «la terra tremava» appunto sotto lo scalpitare delle folle
occupanti). Il fatto che La terra trema fosse girato senza sceneggiatura, allora, potrebbe essere stato anche un metodo per aggirare la censura
preventiva:
A rendere il film da fare un’operazione segreta e semi-clandestina era naturalmente il riferimento alla strage del i° maggio, nientaffatto generico o marginale. Nelle varie stesure del progetto, scritte tra fine dell’estate e l’inizio dell’autunno del 1947, era previsto infatti che le vicende di pescatori, minatori e contadini siciliani, inizialmente dislocate, confluissero nell’eccidio perpetrato dalla mafia - si noti fin d’ora: dalla sola mafia - al servizio dei latifondisti16. Ed ecco, in effetti, come Visconti stesso descriveva la scena
dell’occupazione delle terre e dell’eccidio nel progetto del film, ancora presentato come «documentario sulla Sicilia»:
La festa dei contadini, in una vasta aia in prossimità di una strada, è al culmine. I contadini sono convenuti con le loro bandiere, le bandiere delle leghe, e con le loro famiglie. (...] Ma la gioia più grande è la prospettiva ormai imminente di un gesto ultimo al quale si sono decisi: l’occupazione delle terre incolte del feudo. (...] Mentre la festa è al suo colmo, improvvise tremende raffiche di mitraglia si sgranano sulla folla dei contadini, riempiendo la vallata di echi a cui subito si aggiungono le uria di terrore e di dolore della folla. Le mitragliatrici hanno sparato da tutte le parti, dalle colline che circondano il vasto spiazzo dove si svolgeva la festa. Nel sangue di innocenti donne e bambini 0 di contadini rei di aver alzato la testa dalla loro millenaria schiavitù, la mafia padronale ha lavato l’onta del «tabù» infranto e ha voluto impartire una sanguinosa, tremenda lezione intimidatoria per il futuro. Ma
ha sbagliato i calcoli. Anzi ha affrettato la sua sconfitta . In un appunto di sopralluoghi è citata proprio «Pian della Ginestra»1 , e l’ambientazione a Portella è citata più volte. Oltretutto, c’è il sospetto che
Visconti volesse girare le scene dell’occupazione e della strage a Mussomeli, nel feudo Polizzello realmente occupato: uno dei luoghi simbolici del conflitto tra contadini e mafia agraria (vi aveva grandi interessi uno dei boss più temuti dell’epoca, Giuseppe Genco Russo)1 . Dal brano citato sopra, come responsabile della strage non venivano indicati i
banditi, ma la mafia, il che rendeva il progetto politicamente ancora più pericoloso:
Quello che Msconti proponeva era in effetti un «nuovo alfabeto» politico e rappresentativo: rinunciava a puntare l’indice sul principale imputato del processo, Giuliano, su cui invece si erano volute da subito concentrare le indagini; istituiva un collegamento diretto, politico, tra la strage e le occupazioni contadine; sottolineava i legami stretti tra armi illegali e legali; cercava infine di offrire agli eventuali spettatori cinematografici una dinamica della strage diversa dalla versione ufficiale, 20
moltiplicando le postazioni degli spettatori . Visconti ha ancora in mente il progetto del documentario a riprese
iniziate, ma poi decide di trasformare l’episodio del mare in tutfaltro, e di
abbandonare l’idea della trilogia, anche per ragioni economiche. Vecchio pallino del regista, che già nei primi anni quaranta progettava adattamenti
dalle novelle di Vita dei campi, Verga «poteva diventare - e diventò - un elegante e colto ripiego. Una maniera per rappresentare in valore assoluto conflitti sociali che nella drammatica verità quotidiana della Sicilia in
quegli anni si manifestavano assai più urgentemente, con un carico di complessità che nessuna traccia “verista” avrebbe mai potuto veicolare
meglio»21.
La ricostruzione di Mancino getta nuova luce anche sul coinvolgimento nel film della casa di produzione Universalia di Salvo D’Angelo, legata al
Vaticano, che subentra a un certo punto alla originaria Ar.Te.As., legata al Pei:
D’Angelo fece a Visconti, rimasto senza copertura economica per il film, un’offerta che non poteva essere rifiutata. Per un film che rischiava di andare alla deriva e di restare incompiuto, si trattava di una via d’uscita onorevole e coerente, visto anche lo straordinario risultato, in linea con il vecchio progetto di trasposizione in chiave marxista del capolavoro verghiano. D’Angelo, in veste di produttore del film, ottenne che l’episodio del mare, indissolubile dagli altri due all’interno della precisa struttura progettuale degli Appunti, venisse scorporato, arricchito e trasformato nel film stesso, di cui diventava il sottotitolo esplicativo, garantendo inoltre che La terra trema (Episodio del mare) venisse concluso con calma, e con una nuova scadenza: non più le elezioni del 18 aprile ma la Mostra deli’Arte cinematografica di Venezia del settembre del 1948. Gli altri due episodi 22
erano nel frattempo scomparsi dall’orizzonte**. Qualche anno dopo, sulla strage cerca invano di tornare anche
Giuseppe De Santis, con Portella delle Ginestre, soggetto affidato a Felice
Chilanti, giornalista de «L’Ora», autore di un libro sul processo di Viterbo
e che di lì a poco avrebbe realizzato insieme a Mario Farinella una dirompente inchiesta sulla mafia urbana di Palermo . Il soggetto, in realtà un ampio trattamento di 50 cartelle, si svolge, in assoluta unità di
tempo, nel corso della giornata della strage, mostrata peraltro dal punto di
xista dei banditi, che agiscono in parte attirati in un tranello, perché si aspettano che anche dalla montagna Cometa si spari sulla folla, e alla fine
si trovano invece a essere gli unici responsabili del massacro: Pisdotta: Compare Gnaziu ha tradito. Genovesi: Io non ho tradito nessuno, dero anch’io a sparare. Pisdotta: Solo Montelepre ha sparato. Adesso siamo più soli e maledetti di
prima. Genovesi: C’erano anche gh altri sulla montagna Cometa. Pisdotta: Ma se ne sono andati senza tirare un colpo. Giuliano: Gasparino, intendiamod: abbiamo fatto una grande strage, più grande di tutta Montelepre e di tutta la banda. Ha sparato chi ha sparato: tutta la Sicilia ha fatto questa strage. Adesso li abbiamo legati al carro nostro. Pisdotta: Ma il carro nostro finirà dentro il burrone e proprio loro ve lo spingeranno. Giuliano: Quella gente verrà nel burrone con not Ma poi chi erano quelli là che sono morti? Prendevano troppo piede, invadevano le terre, volevano una buona vita senza rischiare niente. Volevano le terre degli altri e dove arrivavano tutti insieme come cavallette non c’era più posto per not Avevano alzato troppo la testa e noi
gliela abbiamo fatta abbassare. Pisdotta: Ma c’erano donne e bambini Giuliano: Sono anni che le nostre donne, le nostre madri non hanno pace: sempre gli sbirri in casa giorno e notte e sempre dentro e fuori la galera. E poi là in mezzo c’erano gli scomunicati*4. H film si conclude con i banditi che tornano a casa dopo la strage,
perplessi per la china presa da Giuliano che si immischia troppo con la politica. In quel giorno Chilanti e De Santis concentrano insomma le vicende precedenti del bandito, la sua fine e il processo che sarà al centro
della seconda parte del film di Rosi. Il tutto è sintetizzato dalla voce over alla fine del film:
L’anno successivo al processo per la strage di Portela celebrato davanti alla Corte d’Assise di Viterbo Pisdotta accusò mandanti e mafiosi, ma era la denuncia di un
bandito, spesso contraddittoria, non creduta, non credibile; egli trascinò alcuni capimafia davanti alla Corte di Giustizia; colpevoli? Innocenti? Era un bandito l’accusatore! Ed egli stesso tre anni dopo fu avvelenato in carcere25. Ma il regista era già stato già affascinato dal bandito in maniera più
indiretta, meno politica. Se Visconti, partendo da Portella, era giunto ai
Malavoglia, De Santis avrebbe voluto utilizzare le vicende come base per ima nuova versione dei Promessi sposi, scritta insieme al poeta Libero de
Libero, subito dopo aver girato Non c'è pace tra gli ulivi, nel 1950. Ecco come viene presentata l’idea centrale, piuttosto forte, in una premessa alla sceneggiatura, conservata presso il Fondo Giuseppe De Santis del Centro
sperimentale di cinematografia: I riduttori hanno ritenuto logico individuare nd bandito Giuliano, onnipotente su tutte le piccole e grandi mafie della Sicilia, la figura dell’innominato manzoniano. Simile a quest’ultimo per l’oscura illimitata potenza, Giuliano non può, d’altra parte, seguirne le rie dd damoroso pentimento. E dò per due ragioni. Prima di tutto ogni variazione sostanziale al personaggio storico di Giuliano, quale egli è, ce ne farebbe perdere il fascino. Tanto è vero che si è trovato più giusto adeguare il personaggio manzoniano al vivente modello di Giuliano, anziché il contrario. In secondo luogo, un pentimento come quello dell’innominato dovrebbe condurre Giuliano, logicamente, a costituirsi alla giustizia. H che non è pensabile sia per ragioni storiche sia perché d condurrebbe a varianti ancora più serie26.
Contemporaneo al Salvatore Giuliano di Rosi è invece il film diretto dal produttore Giuseppe Amato, Morte di un bandito (1961), oggi introvabile
e del quale sopravvivono pochissime notizie (ne sono recentemente emersi dei materiali di proprietà del produttore). Ispirato a un dramma di
Giuseppe Berto, da quel che se ne può intuire nei fascicoli ministeriali alludeva in termini quasi cristologici al «tradimento» di Giuliano da parte di Pisciotta senza nominarli direttamente, ribattezzando i protagonisti
Vito Ribera e Michele Galardo^ . Ma, prima di tutti, ricordiamo che il fascino di Giuliano aveva lambito
anche un regista lontanissimo dal neorealismo: Orson Welles. Giunto in Italia nel 1947, l’anno dopo l’attore e regista viene intervistato dal giovane
giornalista e futuro regista Sergio Soliima nel camerino di Lea Padovani,
che l’americano sta corteggiando:
Mi domandò cosa facessi. Gli dissi che volevo fare il regista e che stavo scrivendo un soggetto su Salvatore Giuliano. Ne fu solleticato: «Bè, certo, è un personaggio affascinante», mi disse, «sarebbe interessante andare a fare un salto giù a Montelepre». Già d si vedeva dentro, con i doppi e i tripli caratteri che aveva Giuliano. Sarebbe stato bellissimo, ma come tante altre cose poi si è persa: non avemmo piu occasione di incontrarci .
4. Allarme Rossellini.
Le preoccupazioni suscitate dal tema lungo il decennio sono tali da non coinvolgere soltanto i film in atto, ma anche quelli appena immaginati, fino a innescare in un caso un curioso falso allarme che coinvolge i vertici
della pohtica isolana.
H 7 gennaio 1959 il presidente della Regione Sicilia, Silvio Milazzo,
scrive al sottosegretariato allo Spettacolo, allarmato da una notizia che potrebbe, oggi, parere secondaria. Ma forse occorre spiegare intanto che
strano governo è, quello di cui stiamo parlando. Proveniente dalla Democrazia cristiana, Milazzo governa la Regione
Sicilia dal 1958 al i960 (tra i due Gattopardi, si potrebbe dire) scalzando la De con una singolare coalizione composta da un partito di fuoriusciti
dalla De (l’Unione siciliana cristiana sociale), da Psdi, Pri, Pii e addirittura
Msi, con l’appoggio di Psi e Pei. L’esperienza ha importanti ripercussioni sulla politica nazionale e viene da alcuni storici considerata una delle
prime avvisaglie dei futuri governi di centrosinistra. Si tratta di una vicenda su cui ancora oggi le valutazioni sono assai controverse: nato in
opposizione alla De locale, che allora veniva scalata dai fanfaniani contro i vecchi notabili; visto con sospetto dalla Chiesa; sostenuto dagli industriali
siciliani in polemica con Confindustria, da frange monarchiche, e considerato a quanto pare in maniera non univoca dalla mafia (con
interesse si mossero, pare, i La Barbera e imprenditori organici come i cugini Salvo) , il tentativo dura, attraverso varie peripezie, dal 30 ottobre
1958 al 22 febbraio i960. Insediatosi dunque da un paio di mesi, con una maggioranza
traballante e un intrico di poteri e interessi in lotta, il presidente trova
però il tempo di scrivere al sottosegretariato allo Spettacolo in merito alla
notizia, apparsa su alcuni giornali tra cui «Il Tempo», secondo cui Roberto Rossellini starebbe preparando un film sulla mafia. La reazione dei vertici
politici della Regione a questa prospettiva è quasi di panico: Tale annuncio ha suscitato notevoli perplessità tra i siciliani in genere, e
particolarmente negli ambienti politici, in quanto si teme che, con l’intenzione di presentare un quadro realistico della situazione siciliana, si faccia opera di denigrazione e di travisamento della vera realtà esasperando ed amplificando quello che è soltanto un aspetto marginale della vita e dei sentimenti delle nostre
popolazioni. Condividendo, pertanto, e rendendomi anzi interprete delle apprensioni manifestatemi al riguardo, mi permetto richiamare la particolare attenzione di cotesta Onde Presidenza sulla delicata questione e prego vivamente di volere opportunamente interessare, nel caso in cui il film dovesse essere realmente prodotto, la competente Commissione di Censura al fine di evitare che esso suoni 20
offesa ai valori morali, umani e civili della Sicilia . La presidenza della Regione, insomma, mette davvero le mani ax’anti prima del tempo. Il presidente dell’Anica Eitel Monaco svolge una rapida
inchiesta, da cui emerge che la notizia è priva di fondamento. Il 27
febbraio il direttore generale per lo Spettacolo, Nicola De Pirro, manda rassicurazioni ai siciliani: non esiste nessun progetto di Rossellini sulla mafia. Di esso in effetti non rimane alcuna traccia a parte quegli articoli di
giornale: probabilmente si trattava di uno dei numerosi progetti
estemporanei annunciati o accennati dal regista, magari chiacchierando
con un giornalista. Ma la sola notizia di un film sulla mafia pare suscitare
allarme nel mondo politico. E il nome di un regista come Rossellini suona particolarmente minaccioso.
La lettera firmata da Mila zzo, a parte la sfumatura, il riflesso automatico verrebbe da dire, di inserire la mafia nell’ambito della vita e dei «sentimenti» (del sentire, avrebbe detto Pitrè) siciliani, colpisce
proprio per il suo tono di urgenza nel mezzo di un esperimento politico difficilissimo e convulso . Ma i tempi corrono: di lì a poco Francesco Rosi sbarca in Sicilia a fare i sopralluoghi per il suo Salvatore Giuliano; a
Palermo sta per partire una sanguinosa guerra di mafia che non risparmia
vittime tra le forze dell’ordine. Nel marzo 1962 sarà lo stesso Parlamento regionale siciliano a chiedere al governo centrale l’istituzione di una Commissione d’inchiesta sulla mafia .
‘ Lupo, Storia della mafia dt, p. 12; Id., La mafia dt, pp. 201-34. E. Kefauver, Il gangsterismo in America (1951), Einaudi, Torino 19535 E. Reid, La mafia
(1952), Parenti, Firenze 1956. ' L’inchiesta che ùra più scalpore è Tìitro sulla mafia (15 ottobre-15 dicembre 1958): cfr. V. V'asile, Cosa Nostra disvelata: •L’Ora» di Palermo, in Atlante delle mafie, a cara di E. Ciccate, F. Forgiane, L Sales, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 183-97. 4 Edizioni Arti Grafiche Baccaglia, Palermo 1956, poi più volte ristampato (ora in I. Buttitta, La
mia vita vorrei scriverla cantando, Sellerio, Palermo 1999, pp. 133*40). ' Cfr. S. Parigi, Neorealismo. Il nuovo cinema del dopoguerra, Marsilio, Venezia 2014, pp. 216-20.
Una scelta di materiali della cosiddetta «censura preventiva» è sul sito ww.dnecensura.com. Per la fase successiva, del vero e proprio passaggio presso la Commissione di censura, che avx-enh-a
a film realizzato, si vedano R. Curii - A. Di Rocco, Visioni proibite. Ifilm vietati dalla censura
italiana (1947-1968), Lindau, Torino 2014, « il sito
■'■•1tal1atagl1a.it
Ma si tratta probabilmente di un romanzo scritto proprio in vista della realizzazione del film, e sull’onda anch’esso del successo di In nome della legge. Contenuto in Acs, fasdcolo «GÈ inesorabili», Cf 0428. Da qui sono tratte le dtazioni
successh-e. Maria Cyliacus, x-ero nome Karin Lannby, giornalista e attrice svedese, amante di Ingmar
Bergman nei primi anni quaranta e nel dopoguerra spia della da, av^eva intervistato Giuliano per il
settimanale «Oggi» (G. Casarrubea, Storia segreta della Sicilia. Dallo sbarco alleato a Portella della Ginestra, Bompiani, Milano 2005, p. 83). Acs, Cf 0947. Quando una masseria viene bruciata e il proprietario ucciso, su un foglietto
viene scritto: «Così Giuliano punisce i traditori». Dall’altro lato, gli abitanti di Montelepre
ribattono a un certo punto al tenente dei carabinieri: «Se d mettiamo con x*oi, Giuliano spara. Se d mettiamo con Giuliano, x-oi d arrestate». it
A. G. Mancino, Il processo della verità, Kaplan, Torino 2008, pp. 240-1. 1 * Secondo Enrico GùcovelE (Pietro Germi, il Castoro, Milano 1990, p. 25) il progetto era
precedente a In nome della legge, che sarebbe dunque stato una specie di ripiego. >3 il
Acs, Cf 0947.
H film è ammesso a una quota di finanziamenti governativi, nonostante un curioso incidente:
a quanto pare, la copia presentata in censura, che viene respinta, non era quella definitiva (a meno che, viene da pensare, la produzione non sia corsa ai ripari presentando rapidamente una versione che corrispondesse ai desideri della Commissione). Acs, Cf 954. f,
. »
Scrix-e il funzionario della censura, introducendo il parere su Montelepre: «Dopo il fallimento
dell’iniziativa della Soc. Margutta, che, come è noto, aveva progettata la realizzazione di un film sul
banditismo in Sicilia ed il suo maggiore rappresentante, Salvatore Giuliano (“‘Giuliano il bandito*), ecco ora un nuovo progetto di film avente la stessa ambientazione e che tratta lo stesso argomento, i banditi di Giuliano. Qui però a differenza del primo soggetto, nel quale la figura di Giuliano era
presentata in modo da poter riscuotere il favore - se non l’entusiasmo - del pubblico, qui,
dicevamo, nessun accenno è fatto al bandito, il cui nome peraltro non figurerà mai nel film», ivi, Cf 836.
Mancino, Il processo della verità cit, p. 185. ‘ «Bianco e nero», febbraio-marzo 1951, 2-3, pp. 116-7. Mancino, Il processo della verità cit., p. 195.
Ricordiamo che il governo regionale presieduto da Giuseppe Alessi impone nel 1947 lo
sgombero forzato delle terre del feudo occupate dai contadini (Catanzaro, Il delitto come impresa
cit, p. 167). Mancino, Il processo della verità cit, pp. 201-2. •i
Ibid., p. 204.
’* Ibid., p. 212. Parzialmente riportato in Mancino, Il processo della verità cit, pp. 265-75. Cfr. F. Chilanti,
Tre bandiere per Salvatore Giuliano, Il Saggiatore, Milano 19685 Id., Da Montelepre a Viterbo,
Croce, Roma 1952. L’inchiesta su «L’Ora» è stata raccolta in Chilanti - FarineDa, Rapporto sulla mafia dt Acs, Cf 3660, pp. 33-4.
‘ ’ Acs, Cf3Ó6o, pp. 49 50. .ti
Ipromessi sposi in Sicilia. Prefazione, in «Bianco e nero», 2002,3-4, p. 125.
* Acs, cf 3660. A. Anile, Orson Welles in Italia, Il Castoro, Milano 2006, p. 67. .... Su Milazzo si x-eda G. Portatane, Sturzo e l’operazione Milazzo, Olschki, Firenze 2014; A.
Micdché, Sicilia alFaddritta. Le elezioni del 1959, l’autonomismo e le sue narrazioni, in
«Meridiana», 2015,82, pp. 135-54. Assai critico G. Giarrizzo, Sicilia oggi (1959-1986), in Aymard Giarrizzo (a cura di), Storia d’Italia daltUnità a oggi. La Sicilia dt, pp. 603-98. Cfr. anche il
pamphlet di F. Chilanti, Chi è Milazzo. Mezzo barone, mezzo villano, Parenti, Firenze 1959; D.
Grammatico, La rivolta siciliana del 1958. Il primo go verno Milazzo, Sellerio, Palermo 1996; R.
Menighetb - F. Nicastro, L’eresia di Milazzo, Sah-atore Sdasda, Cahanissetta-Roma 2000. Per un’analisi approfondita del ruota del clero nella vicenda cfr. F. M. Stabile, I consoli di Dio,
Sah-atore Sdasda, Caltanissetta-Roma 1999, pp. 215-80. 3 Acs, Cf 3007, fasdcolo «Film sulla mafia in Sicilia». 31
Curiosamente, da uno dei partiti che sostenevano il governo Milazzo arriva invece qualche
mese dopo un contributo filmico politicamente molto esplicito, Sicilia alfaddritta, prodotto dal
Comitato regionale del Pei e diretto da Paolo e Vittorio Taviani come filmato di propaganda per le elezioni regionali del giugno 1959. La voce del poeta Ignazio Buttitta racconta le piaghe dell’isola, lo
sfruttamento dei contadini e Fimpoverimento dei ceti medi, rivendicando l’attività del governo
«unitario» regionale e concludendo con i versi dedicati a Salvatore Carnevale, il sindacalista ucciso
dalla mafia a cui i due registi dedicheranno, insieme a Valentino Orsini, il loro lungometraggio d’esordio, Un uomo da bruciare.
Tra i progetti di film non realizzati ricordiamo anche quello che sarebbe dovuto essere il primo lungometraggio di Vittorio De Seta, già autore di splendidi documentari a colori suIFisola. Del progetto, rimasto allo stato di abbozzo, rimangono tracce in un testo pubblicato su «Cinema Nuovo» (i° dicembre 1956,95), La mafia e i contadini, in cui il regista confessa che, volendo
realizzare un film sulla società contadina che seguisse miticamente il ciclo delle stagioni, aveva compiuto un’approfondita inchiesta sul posto con esiti sconcertanti: «Non mi sarei mai atteso da una attenta indagine sul mondo contadino un così completo, inatteso, incredibile capovolgimento
di tutte le mie opinioni e credenze». In particolare, lo shock viene dall’incontro con i suoi militanti
del movimento contadino, ma anche da testi come Le parole sono pietre di Carlo Levi e il Lamenta pi la morti di Turiddu CamivaH, che gli fanno scoprire la figura del sindacalista di Scia», come si vedrà fn/ra, cap. vn, pp. 106-8.
vii.
Verso il genere: l’eccezione e la regola
i. Miracoli economici, socchi edilizi e guerre di mafia. Dalla fine degli anni cinquanta il potere della De si trova a dover
mediare con nuove spinte sociali e con forti contraddizioni interne,
come mostra, in prima istanza, proprio la Regione Sicilia in cui, come abbiamo visto, un’alleanza trasversale guidata dal transfuga Silvio
Milazzo estromette la De dal governo (1958-1960). Dal i960 al 1963 la cosiddetta «prima guerra di mafia», che si svolge per lo più a
Palermo, porta sotto i riflettori la situazione della mafia urbana, con il nuovo capo Luciano Liggio che ha sostituito Michele Navarra. La città
di Palermo viene ricoperta di cemento sotto l’occhio vigile dell’assessore ai Lavori pubblici Vito Ciancimino; la burocrazia
regionale crea un indotto di migliaia di posti di lavoro per una nuova
piccola e media borghesia, spesso di recente inurbazione, che va ad abitare quei quartieri. Se pensiamo all’interesse occasionale e alle difficoltà del decennio precedente, colpisce la sequela di titoli: a febbraio 1962 esce
Salvatore Giuliano (che l’anno prima era stato rifiutato dalla Mostra di Venezia), a giugno Un uomo da bruciare di Valentino Orsini, Paolo
e Vittorio Taviani, a ottobre Mafioso di Alberto Lattuada. L’interesse del cinema non è isolato: la Commissione parlamentare antimafia viene istituita a dicembre e sarà operativa qualche mese dopo. E si
sono già ricordati, nello stesso giro di anni anzi di mesi, l’uscita presso
Einaudi di due testi fondamentali, Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia e Mafia e politica di Michele Pantaleone. Nell’aprile 1963, con l’esplosione della Giulietta del boss Cesare Manzella e la strage di
Ciaculli, si tocca il culmine di un’emergenza mafiosa. Il quotidiano «L’Ora», pubblica in quel mese un rapporto di polizia che fornisce la
prima mappa delle famiglie mafiose di Palermo.
L’interesse del cinema italiano per la Sicilia, vista come controparte del boom, conosce un grande incremento: Salvatore Giuliano,
Divorzio all’italiana, Mafioso, ma anche L’avventura di Michelangelo
Antonioni, Il Gattopardo, Ifidanzati di Ermanno Olmi. Rispetto a una caduta di interesse nel decennio precedente, l’isola diventa uno dei luoghi fondamentali per interpretare l’Italia del benessere, come Roma e perfino più di Milano (per non parlare di Torino, protagonista
dello sviluppo industriale e dell’emigrazione interna, all’epoca del tutto assente dagli schermi). I film in cui si parla di mafia sono grosso modo una dozzina: il doppio del decennio precedente, ma meno di un quarto di quelli degli
anni settanta. È ancora difficile, e non solo per la scarsità degli esempi, identificare un filone.
2. «Tremate prepotenti: la vera mafia è qua!».
Evidentemente rimane, seppur aggiornato, il modello di In nome della legge, ma intanto è mutato il contesto in cui si può parlare di mafia. Come titolo indicativo delle estreme propaggini germiane, si
può citare nel 19591 mafiosi di Roberto Mauri, forse il titolo in cui la
dimensione mitologica e apologetica del fenomeno arriva al massimo grado, prima dell’inversione di tendenza del decennio successivo. Un
giovane archeologo vuole ritrovare i resti di una città greca nel terreno
paterno; ma del luogo vorrebbe impadronirsi anche un barone, progettando di far ricadere la colpa sulla mafia (sic). L’organizzazione,
sotto la guida del saggio don Calogero Virzì (che parla senza accento e
si raccomanda sempre di «agire nella legalità»), cerca allora di snidare il colpevole dell’omicidio. Ma nella mafia, infiltrato, c’è un
uomo del barone. Infine i mafiosi vanno a uccidere il malvagio
direttore della banca, ma vengono preceduti da un sicario del nobile: sequestrano allora quest’ultimo e lo consegnano, come nel film di Germi, alla legge. In tribunale, a questo punto, ci sarà spazio per
un’esplicita e accorata difesa dei valori mafiosi da parte di don Calogero. Il tutto incorniciato dai versi di una canzone:
Galoppa mio destriero non sei più prigioniero, la vera mafia è qua: giustizia si farà.
[...] Mafioso è il mio cavallo mafioso è il mio fucile mafiosa è la brughiera
in questa terra vera. Tremate prepotenti strozzini e delinquenti la vera mafia è qua: giustizia si farà.
Per la legge ci battiam siamo cavalieri di giustizia alfieri d sentiam.
Il vile umiliar il povero amar l’onor vendicar.
I mafiosi, film di serie C, è un esempio isolato, in controtendenza
rispetto a quanto accade nella società italiana e nel cinema. Ma è
anche un’esplicitazione ingenua del modello western nei film precedenti (e, sotterraneamente, in certi titoli venturi). Ai piani infimi della produzione italiana appartiene ancora di più il semi-amatoriale La legge della mafia (1966) di Mario Bianchi,
ricalcato iconograficamente su In nome della legge ma accentuando gli stereotipi di folklore locale. Un’operazione di livello produttivo infimo, con attori che, come negli spaghetti western, hanno pseudonimi americani. Il film mostra gli stereotipi per così dire automaticamente, in purezza, fin dall’iniziale agguato a lupara in un
viottolo di campagna. Il protagonista è un giovane che non sta con la
mafia né con lo Stato, eroe solitario che si fa giustizia da solo. E sopra la mafia c’è qualcun altro, un super-mafioso occulto: l’idea di un
«terzo livello» (una centrale di potere criminale) è da sempre patrimonio dei media popolari. Rispetto ad altri titoli, però, quello di Bianchi ha un super-io legalitario più forte, enunciato nel finale dal commissario: «La legge dello Stato è più forte di loro e lo sanno, ma
pur di non inchinarsi a essa preferiscono vivere come lupi randagi».
3. Qualche film di serie B (e C).
Nella seconda metà del decennio, coevi ai due adattamenti sciasciani di Petri (1967) e Damiani (1968), troviamo qualche titolo
più interessante, soprattutto per come mette in opera in maniera automatica gli stereotipi. Tratto da un soggetto di Francesco
Crescimene, nativo di Caltagirone che esordirà tardivamente nel lungometraggio con II trittico di Antonello, Gente d’onore è diretto da
uno dei più celebri villain del cinema italiano, Folco Lulli, e utilizza
una struttura da western classico: sette uomini, nascosti nei luoghi
più diversi, devono attraversare la Sicilia (villaggi, canyon ecc.) e mettersi in salvo. Tra loro un americano indesiderabile, un dandy, un
giovane e altri minori muniti di coppola. Oltre alla Sicilia western,
come spesso accade, c’è un versante vagamente psichedelico con night (la fidanzata di uno dei personaggi, Rosemarie Dexter, fa la
spogliarellista) ma anche balli folkloristici e carretti, con forte
predominanza dell’ambiente rurale. Troviamo anche la donna sexy a lutto, la caratterizzazione borghese del capomafia e soprattutto la dialettica tra eroe fuorilegge ribelle e mafia che lo bracca. Lo schema
si ripeterà in più occasioni nonostante il mutare degli sfondi, come mostra Gli intoccabili di Giuliano Montaldo, girato negli Usa con attori italiani e americani (il protagonista è John Cassavetes, il cattivo
Gabriele Ferzetti, il violento Peter Falk), dove un eroe solitario uscito
di galera vuole rapinare un casinò protetto dalla mafia. Uscito subito prima del film di Damiani, A suon di lupara di Luigi Petrini lo anticipa già nella prima scena con l’agguato campestre. Ma
è più chiaro l’intreccio con la commedia erotica (si veda supra, cap. IH, p. 54), con la moglie straniera del protagonista mal vista dalle donne del paese, e le sorelle isolane che scoppiano di sensualità. Mai
come in questo caso l’importanza dell’accoppiata Sedotta e abbandonata-Giorno della civetta è evidente, con elementi mèlo,
erotici e western chiaramente visibili, e una linea comica affidata a Lino Banfi (doppiato da Ferruccio Amendola).
Uno dei più significativi tra i titoli esplicitamente di genere, progettato alla fine degli anni cinquanta, viene realizzato solo sulla
scia del successo del Giorno della civetta e dello stallo in cui si trovava lo spaghetti western. Per la Glomer Film, casa specializzata in cinema
popolare, lo avevano scritto il soggettista Giovanni Addessi e, insieme a lui, Luciano Vincenzoni ed Elio Petri. Il progetto è datato 1959,
dunque antecedente a Giuliano, coevo di Vento del Sud di Provenzale
e dei Mafiosi di Roberto Mauri, che la produzione denuncia con una lettera al ministero chiedendo di bloccarlo . Il titolo del progetto di Addessi, La mafia, è depositato nell’ottobre 1958, e le riprese del film dovrebbero cominciare nell’agosto dell’anno successivo. L’inizio è in puro stile Germi, con la prima inquadratura che dovrebbe essere una
lenta panoramica su «un paesaggio aspro, desolato selvaggio [sic]. Colline aride, sassi calcinati dal sole e, tra i sassi, ciuffi d’erba gialli e
secchi». La voce dello speaker annuncia: «Questo è l’impero della mafia. Dove o si tace 0 si muore. Dove se senti il colpo sordo di una
lupara, o il crepitare di un mitra ti conviene allontanarti in fretta, e se
inciampi su un cadavere steso di traverso sulla tua strada è meglio che prosegui fingendo di non aver visto...» . Tra 1 personaggi, un mafioso
di nome don Vizzoni (evidente il riferimento a don Calogero Vizzini, uno dei boss siciliani più noti), con un fratello candidato alle elezioni:
un camuffamento di personaggi, un ammicco alla realtà storica, che V A 1 3 sara una costante del genere . Il copione narra una Sicilia contadina e arcaica, piena di immagini
folkloristiche: tutti bevono solo limonata, orzata, latte di mandorle; le
riunioni dei mafiosi si svolgono mentre sbucciano e mangiano arance
e dolci tipici col marsala. Per bilanciare quest’aria fuori del tempo, però, vengono inseriti alcuni riferimenti all’attualità: una prostituta
viene minacciata di fare «la fine di Wilma Montesi»; la gente canta
Resta cu ’mme mentre in tv c’è Mario Riva; un mafioso è consigliere della squadra di calcio del Palermo. Il film verrà realizzato, oltre dieci anni dopo, con il titolo E venne il giorno dei limoni neri, per la regia del direttore della fotografia
Camillo Bazzoni, e senza i nomi di Petri e Vincenzoni nei credits. A
parte le ovvie modifiche, lo schema narrativo rimane immutato. Il personaggio femminile, devoto ma ovviamente debole, è affidato a
Florinda Bolkan; la seconda parte (girata a Sabaudia) vede lo scontro con il boss, del quale l’eroe rapisce addirittura il figlio.
Mettendo a confronto la sceneggiatura del 1959 e il film del 1970 si
ha sottocchio quasi in vitro la formazione del mafia movie: il passaggio da un tardo epigono di In nome della legge a un film con alle spalle la lezione dello spaghetti western (come suggerisce il titolo), ma già proteso verso il poliziesco urbano (come annunciano le
musiche di Carlo Rustichelli); e il protagonista Antonio Sabàto, del resto, è in quel momento in transito dal western (Al di là della legge di Giorgio Stegani e I tre che sconvolsero il West di Enzo G. Castellari) verso il poliziesco (L’uomo dagli occhi di ghiaccio di
Alberto De Martino). Alla panoramica sulla Sicilia dell’interno si sostituisce quella sulla città di Palermo, con in bella evidenza i nuovi
quartieri costruiti durante il «sacco». Al posto della corriera-diligenza
si trovano gli aerei e le cave. Al posto della campagna «germiana» del copione, l’inizio del film mostra il rituale dell’affiliazione, la panciuta,
con tanto di bruciatura dei santini, ed è una delle prime volte che questo rituale viene esposto in uno spettacolo di vasta diffusione.
4. «Ci ho il cinematografo qua». Un discorso a parte, nella nascita del cinema di mafia, merita
l’esordio nel lungometraggio di Paolo e Vittorio Taviani e di Valentino Orsini, Un uomo da bruciare. Il suo riferimento infatti non è In nome
della legge (né i recentissimi Salvatore Giuliano e Divorzio
all’italiana, che escono in sala appena qualche mese prima) ma, in
maniera critica, il neorealismo di Visconti e Giuseppe De Santis: anzi, il concetto stesso di neorealismo e il suo ruolo nella «battaglia delle
idee». All’epoca si disse che il film era ispirato all’uccisione del sindacalista Salvatore Carnevale a Sciata, nel 1955: uno degli ultimi omicidi nel periodo delle lotte contadine, qualche anno dopo la
stagione più cruenta dell’immediato dopoguerra (1944-1950). Carnevale e la madre Francesca Serio erano stati immortalati nel libro
di Carlo Levi Le parole sono pietre (1955), e nella ballata di Ignazio Buttitta Lamentu pi la morti di Turiddu Camivali (1956), portata al successo dal cantastorie Ciccio Busacca. Ma i punti di contatto con la
storia di Carnevale sono vaghi, e si limitano quasi solo al nome, che
assume da subito ima valenza letterale, cristologica. L’idea di Salvatore come figura di Cristo era presente nel testo di Buttitta, fin
dalle prime strofe («Turiddu Carnival! nnuminatu/ ca comu Cristu ni muriu ammazzatu»); ma qui la differenza non da poco è che è
Salvatore stesso a enunciarla: «Chi ammazza me è come se
ammazzasse Cristo». «Credo che ci sia bisogno di me, forse della mia morte», dice alla madre, che ribatte appunto: «Chi ti credi di essere, Gesù Cristo?». Insomma, Salvatore è un eroe che si costruisce come
tale, che si immola cercando di costruirsi come personaggio . Lo stile del film dichiara l’adesione ai modelli dell’epoca delle
nouvelle vague, e nei confronti del personaggio centrale oscilla tra immedesimazione e distanza. Salvatore torna in Sicilia da Roma
(forse, suggeriscono alcuni flashback, per una delusione d’amore) e si mette a organizzare i braccianti attraverso occupazioni di terre e scioperi alla rovescia. Fin dalle prime scene ascoltiamo la sua voce
interiore (l’opposto dello speaker dei film neorealisti) che si chiede:
«La mafia. Cosa preparerà per il mio ritorno?». E voci interiori, non
solo di Volonté ma anche della sua amante Barbara (Didi Perego), torneranno in altri momenti. L’occupazione delle terre, invece, è liquidata in poche immagini con un montaggio spezzato e inquadrature brevissime (forse anche per ragioni di costi).
I Taviani insomma inseriscono in una classica vicenda da mafia del
latifondo un eroe problematico, alla Antonioni o alla Resnais, facendo cozzare tra loro un percorso mitico-cristologico e un coacervo di
nevrosi moderne. In questa direzione va anche l’interpretazione di Gian Maria Volonté, al suo primo ruolo di rilievo nel cinema. Una
recitazione anti-naturalista, sopra le righe, che sembra già prefigurare certi suoi ruoli negli spaghetti western imminenti (che Leone lo abbia
scelto anche dopo aver visto questo film?).
Il ritratto che ne risulta è piuttosto sconcertante. I metodi di
Salvatore sono machiavellici, anzi pirandelliani, come quando incastra un mafioso-boxeur tonto (uno dei personaggi più surreali) per fare da apripista all’occupazione delle terre. Per tacere del suo
versante mitomaniacale, anche nel privato (si finge tisico per
richiamare l’attenzione dell’amante; «il male ce l’ha nella testa», dice
un altro personaggio). Successivamente il suo comportamento è ancora più contorto. Si fa assumere nella cava di un mafioso che cerca
gente a 12 ore, lì «fa il satanasso» lavorando come un matto, ma dopo 8 ore se ne va per mettere i lavoratori davanti alla loro codardia. Infine, quella sera stessa, urla in piazza contro i mafiosi, facendo il
verso del lupo. La stessa madre, a un certo punto, sbotta: «Sei lo scherzo del paese, fin da quando eri piccolo, sempre esagerato». A un
certo punto, vediamo la sua morte (mentre fanno saltare la cava, lui
ieratico si abbassa le maniche) ma poi scopriamo che si tratta di una visione: la sua fine sarà meno epica, ucciso lungo una strada.
Con questo alternarsi di gesti plateali e di machiavellismi, non
stupisce che Salvatore sia un isolato. Come leader contadino, in
effetti, sembra stare antipatico a tutti, e non si capisce se sia più pericoloso per la mafia o per i suoi compagni di lotte, che in una assemblea delle leghe contadine, insieme ai compagni di Palermo, lo mettono in ridicolo.
Nella visione della cava e durante le occupazioni delle terre, però,
lo vediamo ergersi come un superuomo socialista alla Jack London,
contornato di personaggi tendenti al grottesco, quasi lombrosiani. E molte parti hanno toni da commedia, nelle figure dei contadini come
in quelle dei borghesi mafiosi. A parte il boss Turi Ferro, che (come molti cattivi cui viene affidata la coscienza storica nel cinema politico
italiano) sa che il feudo è finito e si rivolge ai nuovi appalti: cave e
strade. Il film è insomma un testo di passaggio, sospeso in ambigui equilibri all’interno del cinema italiano, del meridionalismo e del
cinema moderno. Salvatore da un certo punto di vista è troppo indietro, le sue aspirazioni sembrano arretrate. La sua disfatta nel
teatro, con lui che dice «Bisogna tornare alla vecchia masseria» e i compagni che rispondono, sulle note del Quartetto Cetra, «ia... ia... oh», è feroce nei suoi toni grotteschi. Eppure Salvatore è anche
troppo avanti. Viene dal continente, da una Roma mostrata con stilemi esplicitamente nouvelle vague, e il suo immaginario è impastato di mass media: «Ci ho il cinematografo qua io» dice a un
certo punto toccandosi la testa. Televisione, musica pop e cinema ritornano in varie forme, fino
alla scena in cui Salvatore guarda al cinema un immaginario film musicale, girato dai registi per l’occasione (Carmen Villani canta
«Addio, non darmi la mano/ c’è un domani per noi,/ addio, ti vedo
lontano» sulle immagini di un marinaio accoltellato), e ha il presagio (voluttuoso, si direbbe) della propria fine. Sospeso tra vecchio e
nuovo, osservato con uno sguardo esso stesso dimidiate, a disagio nella modernità come tra i propri compagni, Salvatore ci appare
vicino a certi personaggi della sinistra eretica o addirittura di una
ribellione anarchica e generazionale; più che una copia di Turiddu Carnivali, un fratello siciliano dell’Ale dei Pugni in tasca di Marco
Bellocchio.
5- La vedova e il professore. Per un comprensibile errore prospettico, si tende spesso a considerare A ciascuno il suo come un testo sulla mafia. In realtà, sia
nel libro di Sciascia che nel film di Petri, di mafia non si parla mai.
L’errore è ovviamente indotto dalla prossimità con II giorno della civetta che, uscito nel 1961, aveva lanciato il nome dell’autore, e il cui
adattamento cinematografico uscirà poco dopo il film di Petri. Altro elemento di equivoco è il fatto che Sciascia pare si fosse ispirato
all’omicidio nella primavera del i960 del commissario Cataldo Tandoy, capo della squadra mobile di Agrigento, per il quale le indagini si erano dapprima orientate sulla pista passionale (l’amante
della moglie era un esponente assai noto della De siciliana), per poi 5 puntare sui clan mafiosi di Raffadali .
In A ciascuno il suo ci sono un omicidio, un’indagine, intrecci tra
crimine e politica, ma non la mafia. In definitiva si tratta di una black comedy politica sulla borghesia, siciliana e italiana; un tentativo di racconto della borghesia meridionale, come cercava di fare molto
cinema di quegli anni, uscito dalle strettoie del neorealismo (si pensi a Leoni al sole, di Vittorio Caprioli o I basilischi di Lina Wertmuller) .
In fondo, l’equivoco investiva già il romanzo di Sciascia, come
ricordava lo scrittore: «Mi sono detto: voglio scrivere il resoconto di un fallimento storico, il fallimento del centrosinistra. [...] Il libro è stato però interpretato come una storia di mafia» . Il film riveste tuttavia un ruolo importante nella genealogia del film
di mafia, e permette di spiegarne alcuni elementi di fondo: il rapporto con il grottesco, il ruolo delle figure femminili, il tema dello sguardo e
quello del complotto. Il cuore del film, assai più che nel romanzo di
Sciascia, è infatti il rapporto tra il professor Laurana (Volonté) e la vedova Roscio, sulla morte del cui marito Laurana indaga. Come si è detto nell’introduzione, spesso i film di mafia
contengono discorsi su altro. Ma qui siamo di fronte a un caso singolare: un film sugli intellettuali e sul centrosinistra, ambientato in
Sicilia, viene letto come un film di mafia, e involontariamente contribuisce ad aprire la strada a un genere. Il romanzo era in
definitiva una metafora della crisi dell’intellettuale di sinistra: un autoritratto impietoso ed esoreistico, dal quale nasce l’ambiguità del
personaggio Laurana, eroe e vittima. Che Laurana sia «un cretino»,
come vien detto nel finale, è infatti una frase spietata da volgare senso comune; ma è anche, in parte, la verità. Petri aggiunge a questo ambiguo rispecchiamento di Sciascia il suo. Lo mostra leggere il Moby
Dick, storia di un’ossessione autodistruttiva, e in camera gli mette un ritratto di Proust, scrittore detestato da Sciascia; ma poi gli fa spiegare
in classe agli studenti la trama di Morte delPinquisitore, racconto storico di Sciascia medesimo.
Molta parte del versante saggistico-politico del romanzo, ovviamente, si perde nel film. Petri, ricordiamolo, in quel periodo non è ancora approdato al cinema politico, e il film inaugura la collaborazione con lo sceneggiatore Ugo Pirro, dopo molti film scritti
soprattutto con Tonino Guerra. Con l’ombra del neorealismo ancora
presente, il regista oscillava tra tentativi di nouvelle vague «all’italiana» (I giorni contati, L’assassino), commedie all’italiana che
mettevano insieme Sordi e Mastronardi (Il maestro di Vigevano), incursioni sotto pseudonimo nel filone erotico (Nudiper vivere,
insieme a Giuliano Montaldo e Giulio Questi) e una versione popromana della fantascienza anglosassone (La decima vittima). E
proprio sul rapporto con la politica Sciascia, davanti al primo
adattamento di un proprio romanzo, pur mantenendo ottimi rapporti col regista, non nasconde un certo disappunto, testimoniato dalle
lettere raccolte nel Fondo Petri del Museo nazionale del cinema di • 1 *8* Tonno . Petri scrive a Sciascia il 31 agosto 1966; lo scrittore risponde da
Caltanissetta 1’8 settembre e, pur rinnovando la fiducia a Petri,
esprime un dubbio di fondo: Il mio personale rammarico (che tu hai già avvertito e dichiarato: e mi
riferisco all’intervista pubblicata sul Popolo) riguarda soprattutto la tua intenzione di non fare un film politico. Io scrivo soltanto per fare politica: e la notizia che il mio racconto servirà da pretesto a non fame non può, tu capisci
bene, riempirmi di gioia. Petri, il io settembre, da Cefalù, lo rassicura: Non credo che ci sia bisogno di sottolineare che la scelta del tuo romanzo, oggi, per fare un film, è abbastanza coraggiosa. Si potrebbero fare film più
coraggiosi, indubbiamente: sia dal lato politico sia da quello della ricerca attorno agli uomini di questi giorni. Mi accontento di poter fare questo film.
[...] Prima di tutto perché sono interessato fortemente alla natura del tuo
personaggio. Nella scelta di un personaggio si parte - sempre e comunque - da un processo di identificazione: riderai; se ti dico che io mi sento un poco come
Laurana? Volevo, poi, fare un film giallo non convenzionale. E quello che rende la struttura del tuo «giallo» «non convenzionale» - a parte valori di stesura - è l’implicato senso politico della storia. Potrei rovesciare il discorso così: volevo fare un film politico non didascalico, e il tuo libro me ne ha offerta l’occasione proprio perché, pur essendo «politico» dal primo all’ultimo rigo, non lo è mai goffamente. Tu credi che quando sullo schermo appariranno, nella luce obliqua che è nel
libro e che sarà nel film - se riuscirò a lavorare come si deve - i preti, Rosello, l’Oss. R-, tu credi che il film non sarà politico? [...]
[Il tuo libro infatti] si è presentato ai miei occhi come una storia «gialla» [...] con una precisa conclusione politica sulla situazione in Sicilia (e in Italia,
quindi) e sullo stato d’animo degli intellettuali d’Una certa parte.
Ma Sciascia tiene il punto, e il 10 ottobre da Caltanissetta risponde: «Tu devi convenire che - quale che siano la “forma” e le significazioni
del film - io, come autore, non potevo non essere atterrito di fronte a quella sceneggiatura». E il 10 marzo 1967, a film finito, confermerà: La mia previsione che avresti fatto un ottimo film, ma diverso dal libro, si è
avverata. [...] E mi piace riconfermare, in tutta sincerità, che non c’è stato tra noi alcun malinteso, né io ho avuto delusione e amarezza dal fatto di scoprire, nella sceneggiatura e ora nel film, che tu hai fatto un'altra cosa. [...] Il mio
rifiuto di partecipare in qualche modo alla preparazione del film e la mia richiesta del «liberamente ispirato» voleva stabilire la nostra reciproca libertà, e sopratutto [sic] la tua; senz’ombra di risentimento, davvero. [...] E ti dirò che il punto che più mi disturba (come spettatore) è la morte per dinamite del professore; e tanto più che ho sentito a Milano la diversa
reazione dei siciliani (fischiavano) e dei milanesi (applaudivano). La cosa più interessante del film di Petri, e quello che lo rende
prossimo al cinema di mafia a venire, è di ordine formale e
contenutistico insieme, ossia il discorso sullo sguardo. Il suo stile è
nervoso, inquieto, lontano dal realismo: scarta continuamente da una messa in scena «neutra», attraverso inquadrature dall’alto (fin dalla prima partita a carte tra i notabili del circolo), un frequente uso dello
zoom, della macchina a mano (nell’inseguimento in auto a Palermo, ma anche in uno dei primi incontri ravvicinati tra Laurana e la vedova Roscio) o di obiettivi a focale corta (nei dialoghi tra borghesi che
tendono più al grottesco, in piazza o al circolo). La scena della battuta di caccia in cui si consuma un duplice omicidio ha un montaggio a 9 singulti messo a contrasto con l’accompagnamento musicale . La macchina da presa si sofferma su arredi sgargianti, tende viola e gialle, e accanto al telefono del professore il direttore della fotografia
Luigi Kuveiller sistema una irrealistica luce rossa. Nella scena finale con la Papas sulla spiaggia si alternano campi lunghi, inquadrature
dall’alto, macchina a mano.
Soprattutto, Petri insiste sull’uso di dettagli, isolati con primissimi piani: fin dall’inizio in cui vediamo le mani e i piedi di un misterioso
uomo che compra il veleno per topi in farmacia. Un vero e proprio tic registico è lo zoom su un oggetto alla fine della scena (una mosca, un
giornale, un particolare del mobilio, o una persona in un angolo della
scena), come se ogni dettaglio fosse dotato di un senso nascosto e il . . , . . .10 nostro occhio fosse spmto a soffermarvisi .
Ma il polo attorno a cui tutto ruota è il corpo femminile: e la scelta di frammentare, evidenziare, isolare i dettagli qui trionfa. Il film è un monumento all’immagine erotica della vedova, e crea un topos di tutto il cinema di mafia, a cominciare proprio da II giorno della
civetta di Damiani. Il leitmotiv visivo sono le gambe di Irene Papas: la veste si solleva sulle sue gambe calzate di nero già quando sviene al
funerale; all’apparizione successiva la macchina da presa panoramica fino a esse dall’alto in basso; poi isola le mani nella scena
dell’interrogatorio, e ancora tornano le gambe al centro, fino a provocare quasi uno svenimento in Volontà, quando i due si chinano
insieme alla ricerca di alcune lettere. Il professore si strofina pericolosamente contro di lei già in auto, durante la lettura del diario
di Roscio, per poi giungere al momento finale sulla spiaggia, in cui le finisce addosso e vediamo alzarsi pericolosamente la veste11. Il voyeurismo del film, però, è un elemento diffuso, che non appartiene solo al protagonista, e non ha un solo senso. All’inizio, i poliziotti spiano dalla finestra, con la macchina da presa, descrivendo
allo spettatore chi sono i vari personaggi della borghesia cittadina.
Una scena, quella del mondo spiato da dietro gli scuri di una finestra, con cannocchiale o a occhio nudo, che tornerà più volte nel mafia
movie, da II giorno della civetta a Gente di rispetto. Altri personaggi,
invece, si vedono spiare. Mentre Volonté e la Papas girano per Palermo, sono seguiti da qualcuno, e in quel caso lo sguardo appartiene a Ferzetti. Ma quel che più colpisce è una frequente
soggettiva «libera», senza soggetto, uno sguardo occulto su tutti i
personaggi, i quali vengono spesso ripresi con obiettivi a focale lunga, dietro oggetti, come se fossero sempre osservati da qualcuno. In definitiva, tutti sono spiati e spiano. Alcuni hanno il bandolo
dello sguardo, ma nella scena finale del matrimonio tra Ferzetti e la Papas di nuovo non sappiamo chi sia a guardare: le immagini sono
come rubate, i personaggi inquadrati da dietro le sbarre, e l’intera scena è ripresa da lontano. Petri si trova così a preannunciare alcuni tratti della visione totalizzante del potere e dei misteri d’Italia che dominerà il cinema politico negli anni settanta, e che non sarà
estranea nemmeno agli scritti di Sciascia.
1 Acs, C£ 3137. 2
Ivi E prosegue: «Ecco perché gli uomini di queste parti, pur tanto orgogliosi, sono
umiliati e condannati al silenzio. Dominati dalla paura di questa forza antica, terribile e sanguinaria». 3
In una scena «didattica», i boss riuniti devono decidere sul caso di un agrumicultore die
rubava sulle cassette, su uno che vuole importare carne argentina a Palermo («oltre tutto, questa carne congelata, fa schifo. Se la mangino i milanesi», p. 40), su appalti di costruzioni
di silos. 4
La contraddittorietà del personaggio, intesa anche con valore positivo, è sottolineata da
Lino Micdché, che così serbe: «Mitomane, esaltato, sognatore, individualista, il protagonista
di Un uomo da bruciare - proprio per questo coesistere in lui di vistose contraddizioni [...] è un personaggio di rara autenticità e in tale senso profóndamente realistico perché non
retoricamente popolare» (V. Zagarrio, a cura di, Gli «utopisti» e gli «esagerati», in Utopisti, esagerati. II cinema di Paolo e Vittorio Tauiarti, Marsilio, Venezia 2004, p. 24). 5
Cfr. Lupo, Storia della mafia dt, p. 245; voce «Tandoy, Cataldo», in Dizionario
enciclopedico delle mafie in Italia, a cura di C. Camarca, Castelvecchi, Roma 20146
In questa chiave si può leggere la scelta di Gabriele Ferretti, che nel melo degli anni
cinquanta e nel cinema degli anni sessanta interpreta spesso ruoli ambigui, di borghese
cattivo, insensibile, o seduttore: un dettaglio, forse, che mette lo spettatore in una posizione cognitiva lievemente superiore a quella di Laurana, rispetto alle buone intenzioni del personaggio. g
Sciascia, La Sicilia come metafora dt, p. 70. Museo nazionale del cinema, Fondo Elio Petri, fascicolo «A ciascuno il suo». Nello stesso
fondo si trova anche un’interessante lettera del 26 giugno 1966. Petri scrive a Pirro in quanto membro del direttivo dell’Anac (e ai produttori, a De Laurentiis, a Sciascia) per lamentare che
De Laurentiis cerchi di rilevare il film dalla casa di produzione per produrlo lui, appena sentito che d sarà un attore noto, ma a patto di sostituire Petri come regista. Q
A rendere articolato il realismo del film contribuisce anche il fatto che le indagini di
Laurana siano anche due confronti con due celebri attori provenienti dai palcoscenid, Mario Scaccia e Salvo Randone, la cui redtazione è appunto esplicitamente teatrale. IO
In certe scene anche gli inizi sono a effetto, sia che partano dai soliti dettagli (le mani di
Ferzetti che salutano i soci del circolo con buffetti e ammiccamenti) sia che tendano a
scioccare lo spettatore, come l’auto che esplode per strada nella scena in cui Laurana incontra
a Palermo l’amico deputato. 11
Ricordiamo poi che la in Commissione per la revisione cinematografica, riunitasi l’n
febbraio, assegna al film il divieto ai minori di anni 18 con la seguente motivazione: «a
prescindere dagli intenti che il racconto si propone, restano scoperti ed incombenti il comportamento cinico dei protagonisti e la supina complidtà dell’ambiente nonché la
ideazione ed esecuzione diabolica, di tre omicidi, il tutto controindicato alla particolare
sensibilità dell’età evolutiva dei predetti minori» (l’estratto del parere della Commissione è consultabile sul sito www.italiataglia.it). L’11 marzo, ascoltati regista e produttore, viene confermato il parere.
mil
L’eccezione Salvatore Giuliano
Leonardo Sciascia, in conclusione del saggio più volte citato sulla Sicilia e il cinema, racconta di aver visto Salvatore Giuliano in mezzo a contadini analfabeti di un paesino siciliano, accorgendosi con
sorpresa che nei momenti più tragici gli spettatori scoppiavano a ridere: «il pubblico in effetti reagiva come chi non avendo mai visto
uno specchio improvvisamente vi si trova di fronte: lo stupore per la
verità raggiunta, per la “forma” di questa verità, superava la commozione che il “contenuto” indubbiamente comunicava»1.
Altrettanto imprevista è la reazione di questi spettatori nei confronti di una scelta espressiva fondamentale, l’invisibilità del bandito
Giuliano, che come è noto appare nel film solo di sfuggita, in poche immagini: Per Rosi, crediamo, l’invisibilità era una specie di dato immaginifico del
giudizio: non Giuliano contava, ma le forze, gli interessi, le persone che lo muovevano. Per il nostro spettatore l’invisibilità diventava invece un dato mitico: Giuliano come idea della rivolta contro lo Stato, della vendetta sociale,
della redenzione del povero. Un impermeabile bianco e un binocolo, quasi attributi dell’idea: il bianco, la lontananza".
Sulla scia di questa risata e di questa ri-signifìcazione da parte del pubblico siciliano, Sciascia rimprovera al film, che pure considera il migliore realizzato sulla Sicilia, di non essere abbastanza
«brechtiano», di non aver osato la decostruzione stilistica e politica
fino in fondo . Siamo di fronte a un cortocircuito: il massimo dell’impegno civàie e della demistificazione critica, se trascura le
forme di comunicazione e la cultura di appartenenza di ciò che
racconta, rischia di risultare ambiguo e inefficace.
Quello che per lo scrittore è solo un sospetto, una piccola ombra in
un grande film, nel cinema di mafia si dispiegherà completamente. All’epoca di Salvatore Giuliano il mafia movie con le sue formule
drammaturgiche e figurative non esiste ancora: di qui anche la
ricchezza del film e, al di là delle intenzioni dell’autore, la possibilità di letture diverse.
i. Il metodo e la struttura. Il film di Rosi in questo volume rappresenta per più versi
un’eccezione e insieme una sfida che è stata raccolta da pochi registi.
Le scelte stilistiche di Rosi vanno nella doppia direzione di un
incremento vertiginoso del realismo (inteso non solo come ricerca dell’effetto di realtà, ma come metodo, ricerca sul campo), e di una
problematizzazione dei dati visivi, con scarti spesso evàdenti, stremanti, dalla verosimiglianza. Un doppio versante che sarà ugualmente disatteso dal cinema successivo. Non avranno gran
seguito l’impostazione «didattica», le forme di auto-riflessività, e il
rifiuto di «personaggi» tradizionali; e nemmeno la scelta degli attori
non professionisti e la perfetta aderenza del dialetto. Per comprendere un film così stratificato, bisogna intenderlo come
incrocio di una rete di relazioni, di snodi storici decisivi che
riguardano il rapporto con il neorealismo (in particolare con Visconti) e con il cinema americano, e la necessità di operare su quello che Pierre Sorlin chiama il «visibile» di una società (che è qui anche,
letteralmente, il dicibile), ossia «quel che appare fotografabile e 4 presentabile sugli schermi in un’epoca data» . Se si confronta la dichiarazione di metodo di Rosi con quella di
Germi all’epoca di In nome della legge, si misura tutta la distanza fra due idee di cinema. Germi, abbiamo visto, utilizza un testo di un
autore siciliano, lo adatta seguendo i canoni del western, poi arriva in
Sicilia e scopre una «miracolosa» coincidenza tra il pre-giudizio e la realtà dei fatti. Rosi, dall’arrivo in Sicilia, trae la conclusione opposta:
Appena messo piede a Palermo mi resi conto che questo film non si poteva scrivere a Roma. Bisognava documentarsi qui, lavorare qui, e ricominciare tutto da capo. Dall’angolazione di Roma non si potevano capire tante cose, la
prospettiva continentale vieta per storica tradizione l’accesso alle cose di Sicilia. E io volevo fare un film che potesse convincere anche i siciliani
dell’onesta delle nostre intenzioni.
Le due accezioni dell’inchiesta, quella giornalistica e quella sociale,
si mescolano nel film, e la grandezza di Rosi sta, oltre che nel «compiere, finalmente, il gran passo dal sociale al politico e di . 6 collegare direttamente la storia all’attualità» , nel lavorare mettendo in discussione i propri assunti: a confronto non solo con le difficoltà e le ambiguità delle indagini e dei processi, ma soprattutto con la realtà 7 materiale, sociale .
Gli elementi di novità del film, subito colti dalla critica, sono l’invisibilità del bandito e la complicazione dei piani temporali: due stratagemmi che sembrano obbedire a una volontà di distanza critica, di riflessività, dettata innanzitutto da motivazioni politiche.
Invisibilità e confusione dei piani sono la spia del fatto che dietro
Giuliano c’è una storia più grande, che le radici della sua parabola vanno cercate nella Storia. Già la prima inquadratura, con il corpo del bandito rinvenuto nel cortile De Maria a Castelvetrano, funziona sullo spettatore in molti
sensi diversi. È intanto un’immagine-shock che diventa, nel corso del
film, leitmotiv visivo. Ma è un’immagine non meramente «realistica»:
l’inquadratura ha un’angolazione molto espressiva, a un certo punto
addirittura nella classica prospettiva «alla Mantegna» con i piedi in primo piano. All’opposto, in questa scena il suono ci colpisce come
qualcosa di sorprendentemente quotidiano, con rumori di ambiente e clacson, molto accentuati. Il sonoro (per lo più in presa diretta, come
quasi nessuno usava all’epoca) è uno dei campi fondamentali nei quali
Rosi gioca la sua partita. Allo speaker della classica voce fuori campo
si sostituisce la voce del regista, e alle musiche operistico-western alla Germi un tema di Piero Piccioni teso, privo di melodie, e usato con molta parsimonia.
Dopo l’inizio sul cadavere di Giuliano, il film precede con una costruzione a puzzle. A rivederla con attenzione, la struttura a
flashback non è di per sé così acrobatica (come sarà, un anno dopo,
quella di Fellini 8
l’altro grande esempio coevo di frammentazione
cronologica). Possiamo così riassumerla, secondo due linee narrative: Il cadavere di Giuliano, 1950
Giuliano e i separatisti, gli assalti
alle caserme dei carabinieri, 1945 Dopo la morte di Giuliano, i giornalisti al lavoro, 1950 Le vicende dopo la fine dell’Evis
fino alla strage di Portella, 1946-1949 Di nuovo cadavere di Giuliano e
arresto di Pisciotta, 1950
Uno stacco netto, a metà film, separa questa parte dalla seconda, concentrata sul processo: Processo di Viterbo, interrogatorio di Pisciotta, 1950-1951
Tentativi di farsi consegnare
Giuliano, intermediazioni della mafia, 1949 Altri interrogatori e verdetto,
1951~1953 Epilogo. Uno dei mafiosi che aveva
fatto catturare Giuliano viene ucciso, i960 Due elementi spiccano, in questa costruzione. H primo è il carattere
di leitmotiv visivo del cadavere di Giuliano nella prima parte, con cui
si apre ogni ritorno al 1950: una sorta di corpo del reato inquadrato in maniera spesso sacrale, un corpo morto e muto che in qualche modo il film si sforza di far «parlare». Il secondo elemento è il colpo di coda
dell’epilogo, che proietta il film sul presente e lo riapre. Questo schema si traduce sul piano del ritmo in un’alternanza di 8 pause e accelerazioni, di quiete e febbre (ad esempio il passaggio
dalle perquisizioni nelle case di Montelepre alla fuga notturna dei banditi). Le azioni sono sempre raccontate senza suspense, in tempo
reale, dando rilievo a sfondi e dettagli. Questa resa anti-spettacolare ha come conseguenza indiretta un particolare risalto del paesaggio, che a tratti sembra soverchiare le azioni, e diventare protagonista dell’azione a dispetto della cronaca e della storia.
Il carattere mosso, composito del film è sottolineato dal variare delle scelte fotografiche, esplicitamente richiesto da Rosi a Gianni Di
Venanzo: Io vorrei che [il film] avesse tre toni diversi: un tono evocativo per le vicende
del passato, un tono da servizio fotografico per Castelvetrano [le riprese del cadavere], un tono addirittura cronachistico, da servizio televisivo, per le scene del processo. Bisogna aiutare il pubblico a capire la vicenda, che è molto
intricata, anche con la fotografia9.
2. L'uomo invisibile.
Salvatore Giuliano, dopo aver sostato presso la Commissione di
censura per un tempo assai più lungo della media (quaranta giorni, dal novembre 1961 al febbraio 1962)10, esce con alcuni tagli di scarso
rilievo. Anton Giulio Mancino, però, ha ricostruito il lavoro svolto nella fase precedente dalla Commissione di revisione preventiva del ministero sulla sceneggiatura, nella primavera del 1961, segnalando
numerosi passaggi sgraditi che nel film finito spariscono: carabinieri
erano fatti prigionieri e giustiziati dai banditi, così come alcuni
traditori; un dirigente separatista affermava che «le sinistre non avranno mai la maggioranza»; lo speaker ricordava che «sette giorni
soltanto dopo l’eccidio di Portella delle Ginestre [sic], il giornalista
americano Michael Stero e il suo autista» raggiunsero il bandito e rimasero loro ospiti per una settimana, e mentre duemila abitanti della zona venivano interrogati, la giornalista Maria Cyliacus «riesce ad avvicinare Giuliano e, per tre giorni, rive insieme a lui»U. Vengono
eliminati i riferimenti espliciti a nomi (Sceiba, Cyliacus, Stero), i richiami a violenze delle forze di polizia, e i riferimenti in cui si fa più diretto il legame con la politica («Il governo è sotto accusa», Pisciotta
che tira in ballo Sceiba), inoltre nel film finito non verrà chiamato per nome Nitto Minasola, il mafioso che aveva tradito Giuliano e con la
cui morte (ormai a ridosso del presente, nel i960) si chiude il film.
Non viene inoltre mostrata l’accusa diretta di Pisciotta, che chiamava
in correità l’onorevole Tommaso Leone Marchesano, l’onorevole
Bernardo Mattarella, il principe Alliata e l’onorevole Cusumano Geloso: tali accuse erano state dichiarate infondate al processo di 12 Viterbo, e la scena avrebbe potuto causare conseguenze legali .
L’attenzione al ruolo di carabinieri e polizia è uno dei punti più
13 caldi: le forze dell’ordine seguirono da presso la lavorazione del film ,
e gli autori furono messi sull’avviso con una certa preoccupazione
anche da un consulente d’eccezione, interpellato sul copione: nient’altri che Giuseppe Guido Lo Schiavo, autore del romanzo da cui
era tratto In nome della legge, e nel frattempo divenuto procuratore generale alla Corte di cassazione di Roma .
Le richieste di modifica sono un’evidente conseguenza di quel salto
dal sociale al politico di cui parlava Zambetti. Il film decide di soffermarsi sulle dinamiche politiche, a costo di doversi muovere con
mille cautele; questo passaggio, peraltro, implica anche un ideale superamento del neorealismo, e ha potuto far leggere il film come
figlio dello spirito del luglio i960, con i moti di piazza di Roma e Reggio Emilia che causarono la caduta del governo Tambroni15. In questa direzione vanno sia la scelta dell’invisibilità di Giuliano,
sia la rappresentazione della strage di Portella, che diventerà tanto
celebre da essere regolarmente ripresentata, come fosse un’immagine
di repertorio, in ogni servizio televisivo sul tema:
Nessuno, allora, vide i banditi sparare; nessuno vedrà i banditi sparare nel
film. «Il fuoco - ripete Rosi - deve arrivare dalla montagna, inatteso, riolento come una maledizione». E poi la fuga a perdifiato giù per i prati: uomini, donne, bambini, muli, cani, tutti travolti dalla stessa paura. Di Venanzo si muove veloce fra i gruppi con l’Arriflex per riprendere dei particolari. Dopo il
primo dak arriva ansante e sbalordito alla macchina prindpale, accanto alla quale c’è il regista: «Ho ripreso delle cose incredibili. Donne che pregano, nomini che si buttano a terra. Vedrete in proiezione, vedrete». Siamo tutti
emozionati per la straordinaria verosimiglianza della scena. La folla che corre giù per i prati, al secondo dak, travolge addirittura la macchina di Pasqualino De Santis, che stava a livello della strada asfaltata. «Sembravano impazziti -
dice Pasqualino, verificando che non d siano dei danni irrimediabili - mi sono venuti addosso come una mandria di bufali» .
Si tratta di una scena velocissima, quasi coincidente con la durata
reale dell’azione (e non col tempo spettacolare della fiction, che
avrebbe richiesto una maggiore estensione per dispiegare la spettacolarità dell’assalto). La rappresentazione di Portella e l’omissione dei nomi saranno criticate in anni recenti dal regista Paolo
Benvenuti e dallo storico Giuseppe Casarrubea, in occasione del film Segreti di Stato, che tornava a indagare sulla strage1'. Ma qui l’elemento decisivo è chiaramente un altro: da un lato un tentativo di allucinata verosimiglianza, in chiave anti-spettacolare e di
distanziamento riflessivo dello spettatore; dall’altro, un effetto di
transfert, di possessione, di psicodramma. Un movimento tipico di questo film, che si ripete in altri ambiti.
3. Transfert. Personaggi e interpreti. Il film, abbiamo visto, è mosso da un’istanza critica verso la
mitizzazione dell’eroe, nutrita da una serie di rielaborazioni estetiche popolari. Nella sceneggiatura originale, in maniera ancora più chiara,
un cantastorie raccontava la storia di un Giuliano/eroe, che, subito dopo, veniva messo m discussione . Il metodo di Rosi, basato su un lungo lavoro sul campo, trovava il
proprio acme in un tipo particolare di lavoro con gli attori, assai diverso dall’«amalgama»
tra professionisti e non che aveva segnato
l’esperienza neorealista. Qui Rosi agisce creando piuttosto dei veri e
propri happening, in cui viene previsto un certo margine per lo
scatenarsi dello psicodramma, da parte di persone che avevano vissuti o esperienze personali o storiche simili. Intanto, appoggiandosi al
sonoro in presa diretta, il regista gira spiegando ai non-attori i
dialoghi scritti in italiano; essi li re-interpretano in dialetto con parole loro, l’aiuto regista Franco Indovina (palermitano) ritrascrive e su
questa base viene preparata la scena. Ma il risultato finale di questo processo non è la naturalezza, bensì la messa in scena di una rigidezza
anti-naturalistica, di un realismo profondo che è, per così dire, il
contrario della verosimiglianza. «Mi piace vedere continuamente la 20 lotta fra la tecnica e la libertà», dice il regista al riguardo . Una delle scene esteticamente centrali del film è in questo senso il
monologo di uno dei separatisti, interpretato da Pietro Franzone, che era stato davvero tra coloro che avevano accompagnato i capi del movimento al colloquio con Giuliano. La recitazione di questa scena è totalmente anti-realistica, e lo scarto definitivo avviene quando Rosi decide, improvvisando, di far declamare a Franzone l’inno separatista, con una retorica quasi da opera dei pupi:
Ma non poteva andare avanti, gli veniva da piangere, singhiozzava. Davvero non sapevo più che fare, perché Gianni [Di Venanzo, direttore della fotografia, preoccupato dal calar del sole] era nervosissimo: «Dai, fagli dire una cosa qualsiasi!». E io: «Ma come faccio?». Ci salvò lui, don Pietro Franzone.
S’asciugò le lacrime e continuò recitando alla perfezione l’inno dei separatisti: «Rose, rose, rose bianche di Sicilia, diventerete rosse col nostro rosso sangue.
Ma i figli, i figli dei figli, vivranno liberi in terra libera e potranno alzare la fronte al delo e sorriderci nell’avvenire!». Questo modo di girare per me non era proprio nuovo. Avevo l’esperienza con Visconti. Ma sono andato oltre. Era
diventato l’unico modo possibile per raccontare storicamente l’avvenimento. Fu questo il grande passo in avanti'1.
Queste scelte generano, fuori dal film, veri e propri transfert, che vanno ben oltre il riconoscimento, da parte delle persone coinvolte nelle riprese, che «le cose erano andate veramente così». In alcuni
momenti si arriva a una sorta di possessione, di allucinazione della realtà. La verità, in ultima istanza, non può giungere, tantomeno nel
1961, così a ridosso degli eventi, per via giudiziaria né giornalistica,
ma di shock.
Allora assumono un valore più profondo i vari aneddoti sulle
reazioni da parte della gente del luogo, e degli attori non protagonisti, durante le riprese: Pietro Cammarata, l’autista che interpreta
Giuliano, che si identifica col suo personaggio fino a intervenire in un diverbio in un ristorante dicendo: «Se avete qualcosa da dire ditela a me, Giuliano sono»; l’attacco isterico della donna che interpreta la . ... .22 madre del bandito, la quale rivive in scena la morte del figlio reale ;
la ri-messa in scena della strage di Portella, che assume un carattere allucinatorio
. Tutti episodi che già anticipavano, in certo modo, la
scena raccontata da Sciascia, quel riso tra l’imbarazzato e l’euforico dei braccianti davanti al film proiettato: nel riconoscersi, come mai prima e come raramente dopo, veri.
1 Sdasda, La Sicilia e il cinema dt, p. 1220. Questo momento di riso isterico, notiamo, era
già presente negli attori non professionisti del film al momento delle riprese: «Eppure un
segretario dice di aver visto qualcuno ridere. Non d vuole altro per mandare su tutte le furie Aldo Pace, l’ispettore di produzione, che si predpita al microfono per richiamare tutti
all’ordine. “Nu’ ridete! - grida, in perfetto romanesco - Nu’ ridete, che qui so’ cose traggiche. Nele famiglie ano pianto, no dico artro. Nu’ ridete, piagnete piuttosto, pecche si ridete ve foca de arifallo”» (T. Kezich, Salvatore Giuliano. Unfilm di Francesco Rosi, Istituto Luce Cinecittà, Roma 2011, p. 27; 1 ed. Edizioni Fm, Roma 1961). 2 q
Ibid.
«Bisognava didascalicamente, didatticamente, disgregare il mito di Giuliano. E sarebbe
bastato fere di Giuliano un personaggio, un triste e feroce megalomane mosso da mani abili,
da precisi interessi padronali ed elettoralistid: politid, in definitiva. Relegandolo nell’invisibilità, Rosi ha reso più dura l’accusa verso la classe dirigente che lo muoveva; ma al
tempo stesso, per il pubblico siciliano, non faceva che confermare il mito» (Sdasda, La Sicilia e il cinema cit, p. 1221). 4 P. Sorlin, Sociologia del cinema (1977), Garzanti, Milano 1979, p. 69.
° Ovviamente, la scelta di Rosi, pur radicale, non esclude elementi di reinvenzione, come
illustra l’aneddoto riportato da Tullio Kezich: «“Perché pensate che io sia venuto fino a Sàgana per girare questa scena?” chiede Rosi ai picciotti. Nessuno risponde. “Non lo sapete?
Ve lo dico io. Per riprodurre esattamente ciò che accadde in realtà. Se avessi voluto fare una
cosa di fantasia l’avrei girata altrove, vicino a Roma, e sarebbe costata meno. Avrei preso degli attori, li avrei vestiti e truccati. Insomma dovete capire che vi voglio come siete, non
pensate di stare recitando...9. “E la barba?9. La domanda è di Segreto, il ragazzo che ieri era stato rimproverato per essersela rasata. “Quella ci vuole9 taglia netto Rosi; ma ridendo aggiunge: “L’obiezione è giusta. Vi voglio come siete, solo con la barba9» (Kezich, Salvatore Giuliano dt, p. 14).
S. Zambetti - A. G. Mancino, Francesco Rosi, Il Castoro, Milano 1998, pp. 35-6.
All’inizio i flashback partivano con la voce di un giornalista-speaker che ricordava (Museo nazionale del cinema, Fondo Rosi, sceneggiatura del film, p. 19 e passim). H primo
schema del film è intitolato Dagli amici mi guardi Iddio - La morte di Salvatore Giuliano, e
paria della morte e del processo. A matita Rosi aggiunge l’ipotesi di inserire speaker 0 immagini di repertorio per illustrare l’antefatto (p. 8). 8
Lo aveva notato già all’epoca un critico finissimo come Bernard Dort «E forse il pregio
maggiore del film consiste proprio in questa mescolanza di freddezza e passione, di
constatazione e sdegno. Rosi ama la Sicilia e la evoca in un indimenticabile splendore. Le immagini di Gianni Di Venanzo, del quale finora conoscevamo soltanto l’abilità e il gusto (dai film di Antonioni afl’EVa di Losey), sono costruite con calce e sabbia e inscrivono scene di
cronaca in una perfetta architettura di ombra e sole, pietra e cielo. Tuttavia nello stesso
tempo Rosi denuncia questa Sicilia falsamente eterna. Rifiuta la tragedia delle fucilate alla schiena, delle losche trattative maturate nell’ombra delle cantine e risale alle cause: alla mafia
che (ed egli insiste su questo punto) è un fenomeno politico. La sua opera rimane come sospesa tra tragedia e Storia, tra mito e realtà concreta» (B. Dort, in «France Observateur», i° marzo 1963, dt in Kezich, a cura di, Salvatore Giuliano dt, p. 223). Sull’alternanza di buio e luce si veda L. Wittman, The Visible, Unexposed. Francesco Rosi’s Salvatore Giuliano, in
Renga (a cura di), Mafia Movie. A Reader dt, p. 216. q
Ibid., p. 31. H direttore della fotografìa, nel seguire le indicazioni di Rosi, si scontra con il
modus operandi dei laboratori romani: «Te l’ho già detto l’altra volta - insiste Di Venanzo -
con quelli di Roma non d siamo capiti. Stampano tutto troppo chiaro. Gliellio scritto, glielho ripetuto al telefono, non sto facendo una commedia, non m’importa vedere le fecce degli
attori. Il nero dev’essere nero, poi magari d vuole una chiazza hianchiyima. Non voglio grigi,
sfumature, mezze tinte. Questo è un film che dev’essere proprio in bianco e nero» (p. 30). Cfr. la voce relativa al film sul sito www.italiataglia.it, che raccoglie tutti i nulla osta
ministeriali ai film. A. G. Mancino, Schermi d'inchiesta. GH autori delfilm politico-indiziario italiano,
Kaplan, Torino 2012. La sceneggiatura «purgata» viene presentata in Commissione il 17
maggio del 1961. Ecco come la Commissione riassume le modifiche rispetto alla versione precedente: «x. è stata tolta la scena in cui il cap.[itano] Perenze spara sul cadavere di
Giuliano; 2. sono stati alleggeriti alcuni episodi sul separatismo (è stata tolta la scena dell’arresto degli On.[orevo]li F.[inocchiaro] Aprile e Varvaro); 3. con l’innesto di due nuovi episodi sono stati meglio sottolineati: la brutalità di Giuliano e l’eroico sacrifido dei carabinieri; 4. è stato meglio caratterizzato il legame tra Giuliano e la mafia; 5. nelle scene del
processo di Viterbo è stato tolto ogni accenno alle personalità degli avvocati; 6. nella presente
stesura, il film appare come “raccontato9 da un giomalista impegnato a scrivere un artìcolo sulla morte di Giuliano» (il documento, consultabile presso Acs, è riportato integralmente alle pp. 173-80). 12
Le delicate questioni legali del film furono affidate a Nino Sorgi, avvocato socialista
palermitano (V. M. Sorgi, Le sconfitte non contano, Rizzoli, Milano 2013, pp. 14Ù-51). io
«Questo è il primo film - mi spiega Indovina - che viene girato sotto il diretto controllo
della Benemerita. Abbiamo due angeli custodi che stanno qui tutto il giorno per verificare che
i pregiudicati non tocchino le armi automatiche in dotazione alla troupe. Però la sera i carabinieri hanno l’incarico di stendere un rapportino sulle inquadrature girate: che cosa rappresentavano, quali personaggi erano in scena, le battute che pronunciavano eccetera.
Dove finisca questo rapportino e a che cosa serva, nessuno l’ha capito» (ibid., p. 13). 14 Museo nazionale del cinema, Fondo Rosi, fesdcolo «Salvatore Giuliano», p. 30, Lettera
di G. Lo Schiavo. 15 Zambetti - Mancino, Francesco Rosi dt, p. 35.
Kezich, Salvatore Giuliano dt, p. 25. 1—
Sulla polemica si veda infra, cap. xni, p. 238.
" Dal copione originale del film, conservato nel Museo nazionale del cinema, Fondo Rosi,
fesdcolo «Salvatore Giuliano», pp. 12-3. xq
n concetto di amalgama è derivato, con qualche libertà, da celebri passi di A Bazin, U
realismo cinematografico e la scuola italiana della Liberazione (1948), in Id., Che cosa è il
cinema?, Garzanti, Milano 1973, pp. 281-4. 20
21
Kezich, Salvatore Giuliano dt, p. 21. Rosi, Io lo chiamo cinematografi) dt, pp. 169-70. Ibid., pp. 171-2.
23
Quando il regista ordina alle donne di piangere, «dal gruppo delle donne di Piana si alza
un urlo insistito, lacerante, continuo. Rosi fa segno di smettere e si rivolge a uno dei capigruppo: “Ma che sono questi pianti? Sirene?9. Tutto fiero, in un dialetto die ha uno
spiccato accento balcanico, l’albanese risponde: “Così si piange a Piana dei Gred”. Rosi fe un gesto con le due mani come per dire: scusatemi, non lo sapevo; e dà il via. Si gira l'ultimo
quadro della sequenza, la lunga panoramica sui morti e sui feriti dopo la strage, mentre le
donne scatenate piangono i caduti come fossero veri. “Tale e quale9 ripetono tutti» (Kezich, Salvatore Giuliano dt, pp. 25-7).
lx.
Politica e autori
Le somiglianze tra i mafia morie sono, per lo spettatore di oggi, spesso più forti delle individualità registiche, che anzi si possono decifrare meglio proprio in rapporto con «regole del gioco» più o meno accettate o sottaciute. I percorsi dei singoli autori, in questo
modo, appaiono in una luce diversa. Francesco Rosi non è più, con
Salvatore Giuliano, il capofila di un cinema «politico» e «critico», ma il rappresentante di una ria mancata al racconto della Sicilia, e i suoi
film successivi si avvicinano sempre più al cinema di genere: da Lucky
Luciano, in cui l’invisibilità del protagonista ha segno opposto (mitico
e leggendario e non critico) rispetto a quella del bandito nel film del 1961, a Dimenticare Palermo, che gioca sugli stereotipi con largo uso di citazioni e autocitazioni. Giuseppe Ferrara, che si voleva allievo
ideale di Rosi, ha realizzato un film-inchiesta (IZ sasso in bocca) e un
instant morie (Cento giorni a Palermo) nei quali le regole del mafia
morie sono presupposte in molte scelte di messa in scena, e i suoi titoli successivi (Giovanni Falcone, Donne di mafia) sono impostati
secondo le regole del biopic o del film televisivo. Damiano Damiani (il regista più costante e fecondo nel genere) costruisce i suoi film tenendo insieme spettacolo e cronaca, in un dialogo diretto con altri
generi: Il giorno della civetta guarda al western, Confessione di un
commissario di polizia al procuratore della Repubblica fonda un nuovo poliziesco urbano, lo sceneggiato La piovra è un melodramma
che si nutre di intrecci criminali e politici. In Pasquale Squitieri, poi, da II prefetto diferro a Corleone al Pentito, l’appartenenza al film
d’azione e alle forme di spettacolo popolare (la sceneggiata) è rivendicata come strumento comunicativo e addirittura ideologico.
i. Damiano Damiani, democratico inquieto.
Damiano Damiani è di solito considerato un regista tipico del
cinema politico italiano, «civile» e «democratico», con un punto di vista ben definito, solidamente spettacolare e poco problematico nella riflessione sul mezzo-cinema1. Alcuni di questi tratti sono vicini al vero, eppure, se si guarda attentamente il percorso del regista, si può osservare una figura più ambigua, sfumata.
Damiani avere ragione a negare a Quién sabe? la qualifica di 2 western , una qualifica che in realtà si adatta meglio a II giorno della civetta, erede, a vent’anni di distanza, di In nome della legge: ma memore, nel frattempo, della lezione di Sergio Leone . La prima scena
del film gioca consapevolmente su questo ambiguo statuto: vediamo
in campo lungo un agguato con armi da fuoco, e l’assenza di riferimenti precisi, insieme alla musica, per qualche istante lascia credere che si tratti proprio di un western (il 1968 è il culmine del successo del genere in Italia). Nella stessa direzione re la scelta degli
attori: Franco Nero reduce da Django di Sergio Corbucci; Claudia Cardinale, già interprete di Iprofessionisti di Richard Brooks e in
partenza per il set di C’era una volta il West di Leone; Lee J. Cobb, classico «cattivo» non solo di film noir, ma anche di western come
Dove la terra scotta di Anthony Mann. Serge Reggiani, nel ruolo del confidente, richiama invece inevitabilmente II Gattopardo di
Visconti, dove l’attore interpretava don Ciccio Tumeo. La costruzione
spaziale rievoca alcuni elementi del genere: il capitano Bellodi e il mafioso don Mariano Arena che si osservano a distanza, uno in casa e
l’altro nella caserma dei carabinieri; la location è ridotta a pochi elementi essenziali, tutta imperniata sulla piazza con il bar, la chiesa, 4 il salone da barbiere e la sezione della De . Ancora più evidenti i richiami nella colonna sonora di Giovanni Fusco, che inserisce alcuni
classici elementi di riconoscibilità «sicula» ma anche momeoniana,
come il marranzano. Nei primi dieci minuti del film vengono esposti alcuni elementi fondativi del mafia movie: la supremazia del
paesaggio siciliano, con il paesone dell’interno (il film è girato a Partinico), le voci dei doppiatori con un pesante e fittizio accento, la contrapposizione mafia vecchia/mafia nuova con una lunga
spiegazione sui soldi che arrivano per i nuovi appalti; la saggezza del
boss; il tema dell’omertà invincibile; la visita al cantiere; la figura della vedova; la «linea comica» affidata a Tano Cimarosa nel ruolo di
Zecchinetta. Ma II giorno della civetta è altresì l’unico film di Damiani mosso anche da un intento quasi didattico di spiegazione del contesto; un film che esplicitamente si presenta come «novella esemplare» di una situazione criminale e politica.
Tra l’atteggiamento di Germi, di assunzione della Sicilia come
fondale per una visione pre-costituita, e quello di Rosi, di completa messa in discussione in loco del progetto, Damiani assume una posizione intermedia: Feci II giorno della civetta identificandomi nel capitano dei carabinieri del film, un uomo del Nord che, trasferito lì, cerca di capire... Con questa
operazione mi sono sabato da quello che non potevo capire. Il film era la storia di un’incomprensione, di un’ignoranza ed è chiaro che io mi sono salvato dichiarandola0. Il capitano Bellodi, dunque, è esplicitamente un doppio del regista. Tuttavia, rispetto ad altri «stranieri» del mafia movie, il personaggio
sembra piuttosto addentro ai meccanismi su cui indaga. Il gioco di personaggi si traduce, nel film, in un gioco di sguardi: Nero e Cobb si
osservano per tutto il film, e osservano quel che accade nello spazio
intermedio rappresentato dalla piazza; in una scena il capitano dei carabinieri traduce addirittura il significato degli atteggiamenti del
mafioso per strada, compreso il suo ingresso nella sede della De.
Il successivo film di ambientazione siciliana, La moglie più bella, è
un oggetto meno classificabile, che sfiora il filone erotico e soprattutto il fotoromanzo (a cominciare dalle fisionomie degli interpreti, gli
esordienti Ornella Muti e Alessio Orano), forma popolare di cui 6 Damiani era stato tra i fondatori una ventina d’anni prima . Alla base c’è il caso di Franca Viola, che nel 1965 aveva rifiutato, diciottenne, il
«matrimonio riparatore» con il giovane della famiglia mafiosa di 7 Alcamo che l’aveva rapita, e lo aveva denunciato . Ma soprattutto (e questo risalta ancora meglio se si paragona il film a un titolo di non
molti anni prima come Sedotta e abbandonata di Germi), il proposito
di Damiani sembra essere di guardare tra le pieghe della modernità,
identificando personaggi che sono significativi del mutamento sociale con uno sfondo pienamente contemporaneo. Il percorso è
sostanzialmente l’unione tra il mèlo e un mafia movie ormai già
abbastanza definito nei suoi tratti di fondo, e tutto interno al genere è il funzionamento delle dinamiche narrative e delle accensioni visive
del film: come la scena, letteralmente flamboyante, in cui Omelia Muti dà fuoco al casolare dei suoi, o la variazione classica del pranzo
oppressivo-grottesco che schiaccia l’individualità di un personaggio
(già tentato in II giorno della civetta attraverso il grandangolo, e qui invece con l’uso di una tarantella con scacciapensieri che copre il
dialogo). Damiani si direbbe insofferente verso le regole di un genere che lui stesso sta contribuendo a codificare: diffidente verso
un’ipertrofia del versante politico, da subito ripiega sul privato e su figure individuali. Come sarà in altri casi, l’elemento pubblico rimane
sullo sfondo, come una coloritura (qui ci sono le baracche dei . .... . . 8 terremotati e un comizio di comunisti) . Se II giorno della civetta può essere considerato il primo vero
mafia movie, Confessione di un commissario di polizia al procuratore della Repubblica inaugura insieme il poliziesco degli
anni settanta e il mafia movie di ambientazione urbana. Con il suo ampio formato Techniscope, il set cambia, e sarà quello predominante
nel genere: siamo in città, con frequenti puntate nei mercati, e con spostamenti in campagne e cave, e viene stabilito tra l’altro il topos
della città vista dall’alto (reso familiare in altro contesto dalle prime immagini di Le mani sulla città di Francesco Rosi). Si fanno più frequenti, anche se ampiamente romanzati, i
riferimenti alla cronaca: il procuratore Pietro Scaglione e il sindacalista Placido Rizzotto, ma anche il nodo dell’edilizia, la strage
di viale Lazio (evocata in una strage di «via Plebiscito»), la Commissione antimafia, esplicitamente evocata in tv e, secondo lo 9 sceneggiatore Franco Gicca Palli, all’origine del film stesso . Un
commissario (Martin Balsam), ispirato a Scaglione, all’epoca assai
chiacchierato, usa la giustizia a fini personali eppure nobili, per
vendicare l’omicidio di un sindacalista ispirato fin dal nome (Rizzo) a Rizzotto
. A lui si contrappone il procuratore (Franco Nero), che
crede nei metodi democratici per combattere la mafia. Eppure la struttura da noir morale, quasi alla Fritz Lang, già si
muove su un terreno incerto, politicamente complicato, in una
dimensione più morale che socio-politica, che finisce con lo sfumare i contorni tra i personaggi. In questo senso è eloquente un indizio che
lo stesso Damiani inserisce, attraverso la messa in scena, in una scena d’azione: i due personaggi, dopo un drammatico confronto, devono
mettersi in macchina, e inavvertitamente entrano ognuno nell’auto
dell’altro, come a scambiarsi i ruoli. Alla base del film c’è il successo di Indagine su un cittadino al di
sopra di ogni sospetto, a cui Confessione di un commissario di polizia
al procuratore della Repubblica viene accomunato in tutte le recensioni: e infatti il discorso sulla mafia è in ultima istanza
subordinato a quello sui limiti e i doveri della giustizia. E si ha l’impressione di un’atmosfera sciasciana, più che di ispirazione letteraria si dovrebbe parlare di singolare consonanza di interessi, perché il libro in cui il dilemma emerge in maniera più chiara, Il contesto, esce solo alla fine dell’anno.
Un mese e mezzo dopo l’uscita del film (il 5 maggio 1971) Scaglione viene ucciso . Era la prima volta che la mafia colpiva un personaggio
di questa levatura pubblica, e l’eco dell’omicidio contribuì al successo del film. Proprio i contraddittori sentimenti proreti alla morte di Scaglione sono alla base del successivo Perché si uccide un 12 magistrato . Vi si racconta di un regista che in un film (mostrato
all’inizio: con le sue tinte esasperate, lo si direbbe a metà tra Ferrara e Petri) ipotizza l’uccisione di un magistrato dalle discusse
frequentazioni e, quando il magistrato viene ucciso davvero, si mette
alla ricerca della verità scoprendo che si tratta di un delitto passionale. I buoni e i cattivi, le apparenze e la verità si complicano
sempre più. L’indagine, condotta dal regista Solaris (sic), sfocia in un finale paradossale, in cui troviamo spiegazioni dentro spiegazioni:
scoprendo la verità e smontando l’ipotesi del delitto di mafia, Solaris ha fatto però il gioco di Cosa Nostra, e si trova isolato dai suoi amici
giornalisti. La realtà è inafferrabile, e al massimo si può aspirare alla spiegazione offerta dagli schemi del genere. Come se le contraddizioni
del mafia movie fossero drammaturgicamente risolte spostandosi sul piano del melodramma.
Gli elementi di genere si fanno sempre più autosufficienti nei film
successivi. Un uomo in ginocchio (1979) è anzitutto un melo familiare al maschile, con Giuliano Gemma ex detenuto in difficoltà che, per un equivoco, si trova condannato a morte dalla mafia, e deve far fronte a mille difficoltà insieme alla moglie e al figlioletto. Il gusto
dell’intreccio è ormai predominante rispetto alle pretese politiche, così come la creazione di personaggi che obbediscono allo schema del melodramma più che a ogni preoccupazione di rappresentatività. Il
referente reale somiglia a un repertorio di immagini riconoscibili, con i mercati storici (Ballarò e Vucciria) perno visivo dell’intera vicenda. Mentre sale sempre più in primo piano il tema dell’equivoco, della
casualità, quasi speculare a quello di un mondo in cui tutto è 13 governato da qualche potere occulto . Un tema centrale anche nel successivo L’avvertimento, aggiornamento di Confessione di un
commissario di polizia al procuratore della Repubblica, in cui i due protagonisti tentano entrambi di infiltrarsi in una cosca, uno a
insaputa dell’altro, con effetti tragicomici, mentre la raffigurazione della mafia, sempre come in Sciascia, abbandona il colore locale: il film è ambientato a Roma, anche se i personaggi curiosamente hanno
tutti cognomi siciliani (Barresi, Martorana, Laganà, Violante, Lopez,
Vella, Mannino, Puma), come se ormai il «teatro morale» e politico dello scrittore (e di Damiani) fosse migrato fuori dall’isola.
Il titolo che segna il trionfo e la fine del mafia movie, La piovra
(1984), è in parte un ritorno alle origini del genere, come a fame un riepilogo. Lo sceneggiato comincia ancora una volta quasi come un western: non è ambientato a Palermo ma in un anonimo paesone della Sicilia occidentale, fino ad allora immune dalla mafia, in cui è
stato ucciso il commissario. La novità maggiore sta proprio nell’intreccio di globale e locale: La piovra non è più un mafia movie
con parentesi melodrammatiche, ma un melodramma che si nutre di
intrighi criminali e politici. Comunque, è solo dalla seconda Piovra,
diretta da Florestano Vancini, che entreranno in gioco servizi segreti, politica nazionale ecc. (con allusioni, abbastanza coraggiose per la tv,
a P2 e dintorni), e le 48 puntate delle dieci stagioni successive (fino al 2003) si incaricheranno di allargare sempre più lo sguardo, fino al
complotto planetario. In Pizza Connection gli elementi melodrammatici (la prostituta con
la figlia drogata, la giovane innocente, l’amore fraterno) si fanno sempre più smaccati e speculari a un uso ormai quasi meccanico delle situazioni del mafia movie. Si tratta essenzialmente di un dramma di
amore fraterno, con il fratello buono e quello cattivo, e con un’ampia
parte dedicata alla relazione del fratello più giovane con una prostituta adolescente che lui vorrebbe salvare. La costruzione procede per luoghi narrativi e fisici obbligati (il mercato, ovviamente),
facendo tesoro dell’internazionalizzazione del genere ormai consolidata da un decennio di poliziotteschi, con la trama melo che collega momenti attrazionali di vario tipo, dall’inizio in un peep show alle varie sparatorie.
Nel percorso di Damiani si può dunque osservare, dopo un paio di film che definiscono i topoi del mafia movie (Il giorno della civetta e
Confessione di un commissario di polizia al procuratore della
Repubblica), un concentrarsi su dinamiche individuali guidate da
collaudati meccanismi narrativi. In questa chiave appaiono stremanti i riferimenti diretti alla cronaca e ai suoi mutamenti: il terremoto del Belice, l’omicidio Scaglione trasformato in una storia di corna, commissari che vendicano Placido Rizzotto, fino ai riferimenti più
precisi di tutti nel film che più è ossequente alle logiche del genere, H sole buio, in cui troviamo addirittura una fedele replica del discorso di
Michele Greco al maxiprocesso . Nel cinema di Damiani, in fondo, gli elementi di attualità risaltano anche perché sono trasposti in un contesto assolutamente romanzato, del tutto estraneo ai modi
dell’inchiesta alla Rosi o alla Ferrara. In un universo riconoscibile di equivoci, tradimenti, sparatorie, doppi giochi, donne in pericolo,
improvvisamente lampeggiano deformati gli eventi della storia
recente. Damiani però non cerca mai di riscrivere la storia; piuttosto,
fa entrare alcuni grani di realtà in un mondo finzionale che vive di vita propria.
A metterli in fila, i film di Damiani sono insomma tutfaltro che
lineari, e in fondo si riconducono con difficoltà allo schema del
cinema «impegnato». Il suo sguardo si addentra, più di qualunque altro, all’interno del mondo mafioso e dei suoi addentellati, e nelle
zone d’ombra in cui è sempre più difficile distinguere i buoni dai cattivi. Man mano che si inoltra nel mafia movie e si fa più ossequente
ai suoi cliché, il regista complica sempre di più le posizioni, fino a sfociare in un pirandellismo dai tratti disperati. A differenza di Sciascia, però, Damiani non può rifugiarsi «platonicamente» 15 nella verità della letteratura da contrapporre all’opacità della Storia. La sua
unica «verità» è quella delle convenzioni del genere, che garantiscono la comprensibilità di vicende individuali riconducibili a tipi narrativi
più che sociali.
In fondo il cinema di Damiani è leggibile tutto in termini di
melodramma per maschi. Le donne, alla fine, sono protagoniste nella
sua produzione assai più che in quella di qualunque regista di mafia
movie. Pur quando incrocia la storia e la cronaca recente, Damiani va sempre chercher la femme, disubbidendo all’esplicito consiglio di Sciascia quando si parla di mafia. Nei primi due film i personaggi femminili (la Rosa Bellodi del Giorno della civetta e la protagonista di La sposa più bella) sono centrali e attivi, e la loro presenza è di
disturbo e scardinamento a un mondo costruito sulla violenza e su
codici arcaici che sembrano ben integrarsi nella modernità. Nei film successivi la loro posizione sarà piuttosto diversa. In Confessione di
un commissario la sorella (Marilù Tolo) del boss Li Puma, insidiata dai mafiosi e vendicata dal fratello, viene uccisa e calata nuda nel
cemento. In Perché si uccide un magistrato l’ambigua moglie
dell’ucciso (Franchise Fabian) è la chiave di tutto, in L'avvertimento la vedova Laganà è anch’essa figura ambigua e inquietante . Dagli anni ottanta la funzione di vittime (anche e soprattutto potenziali vittime sessuali) è sempre più chiara. In La piovra la figlia del commissario Cattaui (Cariddi Nardulli) viene rapita e violentata, e la
marchesa Titti (Barbara De Rossi) è una tossicodipendente vittima del suo spacciatore. La quindicenne protagonista di Pizza Connection
(Simona Cavallari) è costretta dalla madre a prostituirsi. La
protagonista di H sole buio (Jo Champa) spaccia e ancora una volta si
prostituisce. Nella serie tv Ama il tuo nemico, ambientata a Gaeta, un’altra tossicodipendente (Romina Mondello) diventa arma dei camorristi accusando di stupro l’integerrimo prete (Massimo Ranieri) 17. Deboli, schiave, drogate, ricattabili oppure infide, le donne
del cinema di Damiani sono quasi sempre un elemento di squilibrio,
un punto debole dell’eroe. E cioè, in fondo, il motore dell’azione e un’attrazione per il pubblico (che è soprattutto maschile, almeno prima della televisione).
Ma il rapporto con la mafia, e forse con la Sicilia in generale, mediato in maniera abbastanza evidente da Sciascia, lascia nel cinema
di Damiani tracce più profonde. Il caso più interessante è forse Io ho paura in cui il poliziotto Volonté, scorta di un giudice che viene ucciso, viene riassegnato a un altro giudice (Mario Adorf) che sembra
rivivere lo stesso percorso fatto dal suo predecessore, quasi scena per
scena. In realtà il secondo giudice è a capo di un complotto che coinvolge i servizi segreti, e il poliziotto finisce stritolato in un meccanismo troppo grande. Secondo Anton Giulio Mancino, non solo l’influenza di Sciascia su Damiani è così forte da condurlo a un
pirandellismo di fondo, ma c’è addirittura la possibilità di una
retroazione: «non solo si va da Sciascia a Damiani [...] ma anche da
Damiani a Sciascia: in Io ho paura è Damiani a suggerire a Sciascia, e
non il contrario, la chiave per smascherare il colpevole nel romanzo 1 . ». 18 . T breve Una stona semplice» . Nel successivo Parole e sangue, sceneggiato televisivo in tre puntate, seguiamo il percorso di un
brigatista per caso, che finisce, vittima delle proprie sbruffonate, a guidare un vero nucleo improvvisato di terroristi. Il gruppo sequestra
un giudice intellettuale, garantista e amante della lettura, che si interroga sulla pena di morte e sta progettando un’analisi linguistica
dei gruppuscoli estremisti: una figura di padre/maestro che ricorda da ricino lo scrittore di Racalmuto. Ma soprattutto il procedere della
storia, con colpi di scena tragicomici, ha i tratti inequivocabili della parodia, della sotie (per citare le definizioni che Sciascia dà dei suoi
romanzi). E, come esplicito omaggio, nella scena finale il protagonista, che lavora in una libreria, mette su un espositore alcuni volumi sul terrorismo: l’ultimo è L’affaire Moro.
Parole e sangue e Io ho paura ricordano qualcosa del cinema
americano del complotto e della paranoia. Ma soprattutto ereditano un’amara visione dell’inafferrabilità dell’Italia, della pervasività del
male e perfino di un costernante trionfo della stupidità. Anche se negli ultimi anni il suo percorso successivo lo farà tornare nell’isola applicando schemi meccanicamente di genere, la Sicilia, la mafia e . . , . . . .x , .19 Sciascia hanno insegnato a Damiani piu di quanto sembn .
2. Francesco Rosi dall'inchiesta al genere.
Il formarsi del mafia movie come genere appare evidente se si osserva il percorso di Francesco Rosi dopo Salvatore Giuliano.
L’autore tenterà di replicare lo schema dell’inchiesta con II caso Mattei, ma la differenza tra i due film è evidente, intanto da un punto
di rista visivo. Il caso Mattei è meno solenne ed epico, più immediato. Al fuoricampo si sostituisce un proliferare di immagini di vari formati,
anche per l’influenza che tra i due film ha avuto l’affermarsi del
modello televisivo. E tuttavia la struttura del Caso Mattei, pur così nervosa e moderna, leggera, alla fine è meno dirompente di quanto non fosse quella di Salvatore Giuliano. All’inrisibilità di Giuliano
subentra l’iper-visibilità di Mattei, interpretato da Gian Maria Volonté, da un paio d’anni volto riconoscibile del cinema impegnato.
E, come ha notato Sandro Zambetti, la frammentazione porta non a un distanziamento e a una visione d’assieme, ma piuttosto alla
centralità dell’attentato-incidente, su cui il film toma a più riprese, e . . . . 20 quasi alle dinamiche del giallo . Piuttosto ambiguo, in fondo, è altresì il modo in cui Rosi si mette in
scena esplicitamente, in una problematizzazione che probabilmente è causata anche da un elemento non previsto, ossia l’assassinio del
giornalista de «L’Ora» Mauro De Mauro durante le riprese del film:
De Mauro era stato contattato dal regista per chiedergli un resoconto delle ultime giornate di Mattei in Sicilia, a Gagliano Castelferrato,
dove era stato trovato un giacimento di metano . Rosi nel film interpreta se stesso, nel re-enacting di una telefonata col giornalista,
in cui ripete esattamente ciò che gli aveva chiesto l’ultima volta che lo aveva sentito: una specie di colpo di scena che mette momentaneamente in crisi il rapporto tra realtà e finzione. Un piccolo
cortocircuito, come una deviazione interna, un’inchiesta nell’inchiesta.
La presenza di De Mauro è importante anche perché «apre»
all’ultimo atto del film, in cui arriva la Sicilia come luogo dello scioglimento (0 della definitiva nebbia). In Sicilia c’è la chiave di tutto,
ma è una chiave che non apre nessuna porta, è qualcosa che complica e non risolve: così sarà anche per il successivo Cadaveri eccellenti, tratto dal romanzo II contesto di Sciascia. In questo film - metafora politica e meta-politica, tendente al metafisico - la Sicilia è ormai
pienamente metafora: mai nominata, contaminata a livello di set con pezzi di Napoli, Lecce o Roma, ma chiaramente riconoscibile, è il
fondale di un teatro in cui il Potere è un’entità pervasiva e gli eroi sono sempre più soli (un percorso che, via Sciascia, non è troppo
diverso da quello di Damiani negli stessi anni, fino a Io ho paura). Gli
intrighi del potere, suggerisce una scena, sono ombre cinesi proiettate su un muro, e, come spesso accade in questo genere di film, il
protagonista integerrimo rischia di apparire quasi un ingenuo.
Intorno agli anti-eroi c’è il mondo caotico degli anni della «strategia della tensione», con cieli solcati da rombi d’aereo, televisori
onnipresenti e macchinari della polizia in grado di intercettare chiunque. Il libro, iper-pirandelliano e non dei più lineari di Sciascia, era
ispirato alla lontana, nell’omicidio iniziale di un magistrato che diventa l’inizio di una strage di colleghi, alla morte di Pietro
Scaglione. Ma la mafia c’entra poco nel romanzo, e ancor meno nel film: anzi la pista mafiosa viene esplicitamente messa da parte nel
colloquio con un saggio boss che ha il volto e la voce assai noti di Corrado Gaipa (un riconoscibile elemento «di genere» all’interno del
film). In molti hanno notato come l’ansia di metafora appesantisca la
seconda parte di Cadaveri eccellenti
. Nella prima, invece, è il set
siciliano a dare carne e sangue all’operazione. Sono i momenti in cui
la narrazione si sospende, a contemplare un traghetto o un cantiere, e sembra che guardando i luoghi l’insieme degli intrighi acquisti, se non
un senso, una profondità ulteriore. Insomma, è vero che l’apologo non riguarda Palermo, ma Roma; non la mafia, ma la politica; non Cosa Nostra, ma il compromesso storico. Eppure un occhio allenato alle
cose di Sicilia sembra essere indispensabile per andare oltre le apparenze, come conferma anche l’ultima immagine del film, che contempla Ifunerali di Togliatti di Renato Guttuso. Cadaveri eccellenti dunque non parla di mafia, ma degli anni di piombo e del
compromesso storico visti dalla Sicilia, con il disincanto furente di
Sciascia o quello cinico di Guttuso (i due, peraltro, romperanno la loro
amicizia proprio qualche anno dopo, per una questione di ragion di 23 partito) . Tra II caso Mattei e Cadaveri eccellenti c’era stato però un esplicito mafia morie, anzi a rigore il primo di Rosi: Lucky Luciano; lontanissimo da Salvatore Giuliano e dal Caso Mattei, e più ricino
semmai a Le mani sulla città, film di denuncia ma anche noir. Già il trattamento riservato al personaggio eponimo è eloquente. Giuliano era inrisibile, Lucky Luciano invece è un vero protagonista,
un gigante. A tratti, una sorta di genio del male, che assume una statura drammatica reale, e viene descritto come un deus ex machina
del traffico internazionale di stupefacenti. Davanti ai giornalisti
ostenta elegante sicurezza, in un monologo che è un pezzo di bravura di Volonté. A conti fatti, però, non lo vediamo mai agire; è una specie
di motore immobile che guarda e comprende: in questo è per metà personaggio drammaturgicamente classico, e per metà maschera della Storia, ennesimo don Fabrizio Salina.
Rosi stesso ammette che l’idea, sua e del produttore Cristaldi, era
venuta dopo il successo del Padrino, e che inizialmente era molto perplesso dai rischi di raccontare la mafia dal di dentro, prospettiva . . . . 24 , , che gli era rimasta, e gli rimarrà, estranea . Quando, intervistandolo, Giuseppe Tomatore gli riferirà le reazioni in un cinema siciliano, con
gli spettatori che all’uscita esclamavano: «Chistu è megghiu ni Padrinul», Rosi ricorderà che invece a Napoli, dopo lo stupore per la sparatoria-balletto iniziale, gli spettatori rimanevano interdetti: «Ma 25 qua non si spara più?» . Le due osservazioni indicano bene la natura
anfibia del film, il suo essere un genuino gangster movie volendo
mantenere un super-io di «inchiesta». Al momento dell’uscita, non a
caso, al film venne affiancato un corposo volume a firma di Rosi e del giornalista Lino Jannuzzi, che raccoglieva molti documenti utilizzati per la sceneggiatura, e un ricco apparato iconografico, che mescolava
foto di scena e fotogrammi del film a vere immagini di Luciano e del 26 contrasto storico, finendo col creare un effetto quasi allucinatorio .
Alcune scene rappresentano simbolicamente questa doppia anima, come la visita di Luciano al cimitero in Sicilia, accompagnata da un caratteristico scacciapensieri, ma girata con una macchina a mano
para-documentaria. Il versante da gangster mone prende poi il sopravvento quando entra in scena Gene Giannini (Rod Steiger), il
confidente con la classica bionda nel letto, che svolge anche lei una
funzione di doppiogiochista ben codificata. La struttura a flashback ha una funzione quasi opposta rispetto a quella di Salvatore Giuliano. In alcuni casi, sembra addirittura
partire dal protagonista, dalle sue riflessioni, come nel primo dei salti temporali, dal suo primo piano all’omicidio di Joe Masseria nel 1931 e
alla cosiddetta «notte dei Vespri Siciliani» che segnò l’affermarsi del suo potere nella criminalità americana. Una scena, peraltro, girata in
maniera estremamente spettacolare, al ralenti, accompagnata dal
canto del tenore Luigi Infantino, che sembra esasperare il versante operatic del Padrino (e probabilmente Coppola lo terrà presente per
la scena clou del terzo Padrino sulle note della Cavalleria rusticana
di Mascagni). Gli altri flashback oscillano sempre tra spiegazione storica e mondo interiore del protagonista: quando Luciano mangia
gli spaghetti alla marinara a Napoli ci si sposta al 1952, con l’inchiesta
dell’Onu sul crimine organizzato, poi indietro ancora alla Napoli del
1944 (e qui Rosi in fondo cerca di realizzare uno dei suoi grandi .. . 27 , . progetti mancati, La galleria) , poi si toma di nuovo all’Onu e prende spazio l’antagonista del film, il poliziotto italo-americano
Charles Siragusa, persecutore e in certo modo «doppio» di Luciano. Ma il percorso da Salvatore Giuliano a Lucky Luciano non è un mero adattamento di Rosi a esigenze commerciali; esso libera una
vena «americana» e spettacolare già ben presente in La sfida, e che in alcune occasioni era in sordina o in conflitto dialettico con un lavoro
anti-spettacolare e riflessivo (ma già in Le mani sulla città il referente
diretto, più ancora di Giuliano, era il nuovo cinema realistico
americano nato dalla televisione, da John Frankenheimer a Sidney Lumet). Lo spostamento verso i codici del genere, però, va di pari
passo con un maggiore disincanto, come se il racconto potesse svolgersi ormai secondo un copione riconoscibile. Rispetto ai film
precedenti, infatti, è assai più evidente una vena di amarezza, di
pessimismo nel dipanare i misteri del potere e del crimine. Alla fine dell’inchiesta non restano l’indignazione e la tragedia, come in Giuliano, ma la contemplazione della vanità dei giochi di potere, e
quasi dell’ineluttabilità del male. Come dice il capo della narcotici a Charles Siragusa: «Tu continua a dare la caccia a Luciano. Dewey
continuerà a dare la caccia a noi, Kefauver continuerà a dare la caccia
a Dewey, e alla fine, a furia di girare intorno, ognuno si ritroverà al
posto di prima, e tutto tornerà come sempre». Parole che tornano nell’ultima immagine del film, sul fermo fotogramma di Luciano
morto. Ne risulta, come ha notato la critica, «un’accettazione [...] del
pessimismo della ragione e una certa flessione dell’ottimismo della 28 volontà» . Un atteggiamento comune a molto cinema politico italiano coevo, che spesso isola i suoi eroi e dà il dono della coscienza storica ai personaggi negativi.
L’accettazione del genere sarà ancora più evidente in Dimenticare Palermo col quale, dopo diversi anni, Rosi torna a raccontare la mafia. A questo punto il genere ha ormai le sue regole codificate tra
cinema e televisione, e il modello con cui confrontarsi non è più II padrino, ma i film e gli sceneggiati di Damiani e Squitieri. Lo stesso oscillare tra Usa e Italia è ormai un topos, presente nel poliziottesco
anni settanta, nei film con Mario Merda e Maurizio Merli o in Pizza Connection. A differenza di Damiani, però, Rosi non è un regista di genere, non sa controllare «all’americana» la sua materia, e il risultato è profondamente estraneo alla sua filmografia, almeno quanto è eloquente dell’evoluzione del mafia movie nei decenni. Lo spunto è, in apparenza, d’attualità: il candidato sindaco di New
York va a riscoprire le proprie radici, anche a scopo propagandistico, durante la campagna elettorale, e nel contempo lancia una campagna
anti-proibizionista. In Sicilia, però, viene assalito dal diabolus loci, diventa passionale e geloso, e approfittando di questa sua inevitabile mutazione genetica la mafia lo incastra per ricattarlo e farlo recedere
dai suoi propositi di liberalizzare il commercio di stupefacenti. Si tratta di una vicenda cervellotica e inverosimile, che Rosi, a fine
carriera, fatica a tenere insieme, anche a livello produttivo (il
produttore Mario Cecchi Gori impose come protagonista James Belushi, reduce dal successo di Danko: scelta infelicissima, come più
o meno tutto il cast)
. E stupisce già, in un regista attento alla
verosimiglianza fino all’iperrealismo, il doppiaggio dell’intero film
nella versione italiana, per cui tutti i personaggi, di qualunque
nazionalità, parlano sempre in italiano ma inspiegabilmente scandiscono o ripetono le parole per farsi capire.
Rimane nel complesso l’impressione di un film da esportazione. I
luoghi turistici si susseguono, segnando le tappe del viaggio di nozze della coppia protagonista: santa Rosalia, ’O sole mio cantata da
Caruso, il Grand Hotel delle Palme, la tomba di Federico II nella
cattedrale, il duomo di Monreale, Mondello e il mercato della Vucciria. In alcune scene (come quella in piazza Marina, dove i due
protagonisti pranzano) si ha quasi l’impressione di un film in
costume, ambientato decenni prima (il romanzo di Edmonde CharlesRoux da cui il film è tratto, peraltro, risale agli anni sessanta). Lo
stesso rilievo assegnato al tema della gelosia entra in una retorica della mediterraneità che Rosi aveva esplorato poco prima nella Carmen, da Bizet. La mafia, alla fine, è una delle tante facce di una
città stregata, che con i suoi gelsomini fuori stagione ubriaca il protagonista («Questo posto dà alla testa», dirà). Ma soprattutto, il film scantona sempre più verso il bizzarro e il fantastico, con una galleria di eccentrici (il nobile che non esce dall’hotel a causa di una condanna della mafia; quello che si chiude in casa fino alla morte di Caruso, che gli aveva portato via la moglie) e assume man mano una
dimensione inquietante, quasi gotica. Le bellezze e gli orrori della
città si caricano di una dimensione sinistra accentuata dalla partitura
di Morricone, mentre sempre più crescono immagini di macerie e di degrado. Come se la città fosse un gigantesco maniero abbandonato, popolato di spettri, anche cinematografici. In questo senso, Dimenticare Palermo è il capovolgimento
completo di Salvatore Giuliano. L’appartenenza a un genere è
dichiarata fin dai titoli di testa su Palermo. Quella stessa immagine dall’elicottero che era il simbolo di Le mani sulla città diventa, oltre un quarto di secolo dopo, un segno riconoscibile, già utilizzato in mille film. Come nel mafia movie più ortodosso, tornano i riferimenti alla
realtà camuffati ed esornativi, come la citazione delle foto di Letizia Battaglia (alcuni bambini ne mimano una mentre la moglie del
protagonista a sua volta li ritrae).
A segnalare che si tratta di un gioco cinematografico, interno a un’immagine ormai fissata, abbondano, come mai nel regista, le
citazioni e le auto-citazioni, e il cast richiama titoli recenti. Giacomo Giardina, poeta naìf-futurista, compare come custode di un palazzo,
in un ruolo simile a quello che aveva in Cristo si è fermato a Eboli (dove interpretava un becchino). Joss Ackland interpreta lo stesso ruolo di boss del Siciliano di Cimino, e il venditore di gelsomini è
Marco Leonardi, reduce da Nuovo Cinema Paradiso. Il tutto culmina in una citazione esplicita: la visita a Palazzo Gangi, luogo del ballo del
Gattopardo. Belushi e Mimi Rogers danzano anche loro su quelle note, immaginando la musica, ma Rosi la gira in soggettiva, sul salone
vuoto, senza personaggi in campo. Un valzer di spettri, insomma:
ballato da personaggi che non vediamo, su una musica che, in fondo,
non c’è. Puro segno, calco di immagini ormai depositate e da cui non è possibile liberarsi. A questo punto l’inizio del film, con Mimi Rogers che espone la questione del narcotraffico attraverso una serie di diapositive, appare
come l’ombra lontana dell’« inchiesta». Pur non essendo un film a tesi, Dimenticare Palermo fece discutere per il suo esplicito messaggio antiproibizionista, da parte di un regista vicino al Psi, proprio nel 30 periodo della legge Martelli, che andava in direzione opposta . Ma
alla fine il suo tono è soprattutto quello della disillusione, come a
radicalizzare la linea di amaro scetticismo maturato nei film precedenti di ambientazione variamente siciliana, da Salvatore Giuliano al Caso Mattei, da Lucky Luciano a Cadaveri eccellenti. Ancora una volta sembra che a tirare la morale della storia sia il
vecchio e biondo capomafia, ennesimo Gattopardo. Se la mafia venisse sconfitta, dice, qualcun altro prenderebbe in mano i nostri
affari. «I governi inventano le proibizioni per poter controllare la gente, e allora noi diamo alla gente quello che vuole. Ecco perché noi
serviamo ai governi, e loro a noi. E non c’è niente che potrà far cambiare le cose».
3- Giuseppe Ferrara dal pamphlet al biopic.
Giuseppe Ferrara ha cominciato la propria carriera come discepolo pressoché unico del Rosi di Salvatore Giuliano, estremizzando per certi versi la sua impostazione, ma anche portandola in direzioni più
cruente e sensazionalistiche; poi anche lui ha seguito la torsione
spettacolare del genere, assumendo schemi nel frattempo consolidati del mafia movie. Ma in realtà fin da subito il suo cinema è scisso, anzi , , 31 .......................... spinto in direzioni lontanissime da quelle del suo maestro .
Il sasso in bocca, suo primo lungometraggio, è importante
anzitutto dal punto di vista produttivo. Realizzare un film politico e
documentato sulla mafia si rivelò ben presto impossibile per il disinteresse e le paure dei produttori, assai più ben disposti verso un
cinema politico «metastorico», rivolto al passato, o vagamente terzomondista. Il film fu perciò messo in piedi attraverso la creazione
di una cooperativa, seguendo il consiglio del produttore indipendente
ed ex partigiano Giuliani De Negri. Allo stesso modo, per poter
realizzare un film che fosse anche un esempio di contro-informazione, Ferrara dichiara di aver dovuto fare a meno di una sceneggiatura tradizionale, e di aver costruito molta parte del film al montaggio (cui
collaborava un altro ex partigiano, Franco «Kim» Arcalii). La novità estetica e politica del film, esplicitamente rivendicata e figlia del Salvatore Giuliano rosiano, è evitare la spettacolarizzazione che deriva dall’individuazione, ossia la creazione di personaggi. Qui c’è un solo personaggio, la mafia: un’entità sociale e politica
sovrapersonale che viene seguita attraverso singole azioni collegate 32 dalla voce over e dal montaggio . Secondo Ferrara l’idea «brechtiana» di «eliminare il personaggio principale» porta a
suddividere il film in 117 episodi più o meno di un minuto l’uno
33
.
Ma questo non deve far pensare a una struttura aperta, tuttaltro. Alle spalle di Ferrara c’è una lettura vagamente marxista, alla Hobsbawm, del fenomeno mafioso, e più in dettaglio le ricerche di
Michele Pantaleone, che fece da consulente al film pubblicando anche . . 34 » un libro dallo stesso titolo . La lettura del fenomeno è netta, senza
sfumature: la voce over è apodittica, quasi da cinegiornale, e accumula non solo fatti ma anche interpretazioni o riepiloghi
sommari: «Quando il capitale è in poche mani, esso genera mafia»; in
America, essa «facilmente si unisce allo spirito violento dei pionieri»; «n fascismo, grande mafia, non sopporta una seconda mafia». La
componente problematica e dialettica del film di Rosi insomma si
perde, in un pamphlet militante che funge insieme da esempio di
contro-informazione storica e da bignami. Anche le questioni più dibattute sono risolte a monte: Lucky Luciano viene chiamato per aiutare lo sbarco in Sicilia delle truppe alleate, con tanto di aereo che
lancia l’oggetto di riconoscimento per il capomafia don Calogero
Vizzini (episodi ritenuti fantasiosi da gran parte degli storici), e i soldati americani sul carro armato appena arrivati che chiedono in giro del boss. Viene implicitamente proposta la divisione tra una
mafia urbana in America e una contadina in Italia: Palermo appare a dieci minuti dalla fine del film, per mostrare la trasformazione da
mafia agricola a edilizia. L’asse continuo è con gli Usa, e se uno dei pregi è mostrare da subito il legame tra Cosa Nostra siciliana e americana, il prezzo da pagare è una serie di scene «turistiche» con
spogliarelli e locali di Las Vegas, nello stile dei documentari «sexy»
del decennio precedente. I limiti ideologici dell’operazione sono evidenti nel finale. La voce
narrante dice: «Distruggere la mafia vuol dire isolarla, e isolarla è impossibile. La mafia è la manifestazione criminosa di una più vasta
violenza». Sullo schermo vediamo un montaggio alternato tra i
manifestanti di Avola (dove, il 2 dicembre 1968, la polizia aveva sparato sui braccianti che manifestavano, facendo due morti) e quelli del ghetto nero di Chicago (dove, nello stesso anno, erano scoppiati
tumulti in occasione della convention del Partito democratico), insieme a flash di roulette, grattacieli, processioni di incappucciati, presidenti degli Usa, cardinali, che tutti insieme vengono mostrati
come il nemico da abbattere, che nutre la mafia. Contadini e neri, uniti dal montaggio in una specie di intifada, scagliano le pietre
contro la polizia, al grido di «Siti tutti d’accordu, sbirri! Io vi mettu sta
petra ’mmucca!» (Siete tutti d’accordo, sbirri! Io vi metto questo sasso in bocca!). Lo stile da pseudo-documentario, con macchina a mano e
addirittura finti telegiornali, cozza con un iper-realismo gridato,
simboleggiato dall’uso frequente del grandangolo
. Vengono
utilizzati brani di Salvatore Giuliano, rimontati: ma al contrario che 36 lì, nel film di Ferrara Giuliano si vede ampiamente . Nel seguire
Rosi, però, Ferrara può adesso aggiungere i nomi e i cognomi che
allora non venivano detti, a processo in corso. L’intreccio di momenti di esasperazione stilistica (nelle inquadrature, nel montaggio) e altri di imitazione para-giornalistica chiarisce il senso ultimo del film: una
contro-informazione che raggiunga un pubblico di massa, in un momento in cui l’attenzione dell’opinione pubblica sul fenomeno va
scemando. Il risultato è dunque scisso tra esasperazione e documentario, tra inchiesta e sensazionalismo, fin quasi a lambire il
filone dei finti documentari alla Mondo cane, con accumulo di orrori da ogni parte del mondo (come sarà ancor più con il successivo Faccia
di spia, dedicato alle malefatte planetarie della Cia). I quattordici anni che separano II sasso in bocca da Cento giorni a
Palermo hanno visto il solidificarsi del mafia movie come genere,
anche se questo non è l’unico, e forse nemmeno il più forte, elemento di differenza tra i due film. L’inizio del film del 1984 compone sì un
preambolo, con gli omicidi di mafia del 1979-1982, da Giuliano a La Torre. Ma il racconto si concentra sulla figura di Dalla Chiesa, pur
utilizzandolo come mezzo per interpretare alcuni nodi decisivi, in particolare il rapporto mafia-politica. A esplicitare questi ultimi è
stavolta un personaggio fisico ma senza nome, interpretato da Adalberto Maria Merli, che fa da collegamento tra massoneria e servizi segreti
7
.
Il film è, ricordiamolo, un instant movie, ideato pochi mesi dopo
l’omicidio del generale, ed esce nelle sale mentre la tv trasmette il
nuovo sceneggiato La piovra. E, anche se nessuno ancora lo sa, Tommaso Buscetta ha già cominciato a parlare con i giudici italiani.
L’intera operazione nasce, come quella del Sasso in bocca, in maniera indipendente, con una forma di auto-finanziamento attraverso sottoscrizioni popolari e la formazione di una cooperativa con base a
Palermo, la Clct
. Il che la dice lunga sulla difficoltà di interessare il
mondo del cinema ufficiale. Cento giorni a Palermo è dunque l’ultimo
esempio di un cinema che supplisce a un silenzio e a un disinteresse
dei media, soprattutto riguardo al nodo mafia-politica. Il suo carattere di contro-informazione riguarda proprio questo, a parte alcune
denunce circostanziate che si ascoltano nel film, come il fatto che il
fratello del mafioso Joseph Miceli Crimi lavorasse proprio in prefettura.
Ma c’è dell’altro. La novità del film, che ci appare solo col senno di poi, è la nascita cinematografica dell’eroe storico antimafia, preceduta
solo dal Prefetto diferro di Squitieri, del quale il film di Ferrara è per certi versi l’opposto. Se Squitieri proclama il trionfo del genere (non
solo del poliziesco, ma addirittura del western) come scorciatoia, e la possibilità di modellare un eroe sulle coordinate del genere stesso, il
super-io rosiano di Ferrara impone un personaggio che è anzitutto funzione delle forze politiche e istituzionali in gioco. Tuttavia Ferrara, nella descrizione dei 100 giorni, sembra far
tesoro dell’iconografia del genere come si è manifestato in molti film del decennio precedente: Emanuela Setti Carrara in giro per la
Vucciria, le visioni di Palermo dall’alto e soprattutto le scene d’azione dirette dal regista della II unità, un giovane Giuseppe Tomatore che
ancora si firma Peppuccio. La mano di Ferrara invece si sente in certi montaggi azzardati e accostamenti simbolici, come quello della mosca
sulla bandiera italiana durante l’omicidio di Pio La Torre. Nel finale,
la denuncia cede all’epica e all’elegia, quando dopo l’uccisione del generale (filmata stavolta in campo lungo, dall’alto, in maniera anti spettacolare) si alza la voce del cuntista Mimmo Cuticchio, che
inserisce la vicenda del generale in modalità di racconto popolare e civile, in maniera speculare alla canzone di Ignazio Buttitta e Rosa
Balistreri per II prefetto di ferro. Il nesso mafia-politica, su cui il film insiste, tornerà nel successivo
instant movie, Giovanni Falcone, realizzato nel 1993 con una
produzione assai più solida (Giovanni Di Clemente). Ma in dieci anni molto è cambiato: se per Cento giorni a Palermo vale un discorso di
militanza e di contro-informazione, l’instant movie assume nel caso del film su Falcone un senso assai diverso. Il film si inserisce in una rete di discorsi addirittura intemazionale, e soprattutto in un
momento di crisi politica e in un panorama mediatico assai più articolato. Nel film Falcone parla di «terzo livello» della mafia (nozione che egli usò in modo completamente differente, riferendosi a . . . . . . 39 K . . una categoria di delitti e non di soggetti) ed è insoddisfatto del
verdetto del maxiprocesso perché non crede che i mafiosi siano i mandanti dei grandi omicidi. Ne viene fuori un Falcone ossessionato
dal «cosa c’è dietro la mafia» e dalle «menti raffinatissime», e la competenza specifica su Cosa Nostra passa in secondo piano. Mentre
all’epoca, semmai, Falcone veniva accusato (dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, tra l’altro) di «tenere in un cassetto» i materiali per i
processi, non osando attaccare i politici collusi. Pragmatico e consapevole delle proprie azioni, Falcone era in effetti anzitutto interessato a svelare i meccanismi di Cosa Nostra, senza i quali ogni
analisi dei rapporti con la politica sarebbe stata priva di basi. Invece in questo film la dimensione sociale del fenomeno mafioso salta, a
beneficio di un legame criminalità-politica diretto. Paradossalmente,
insomma, l’accento sulla dimensione politica, forzatamente assente nel cinema di mafia dei decenni precedenti, finisce col creare un’idea parziale del fenomeno.
La maggiore attenzione al nesso mafia-politica provocherà anche,
per questo film, degli strascichi giudiziari. Gli autori sono querelati per diffamazione da Vincenzo Geraci e da Bruno Contrada: il primo per un riferimento al suo mancato appoggio all’elezione di Falcone come capo dell’ufficio istruzione di Palermo nel 1988, il secondo perché riteneva di essersi identificato nell’ambigua figura del
«Dottore», tramite con il mondo dei servizi segreti e delle trame più losche40.
Nel frattempo, si è compiuta l’evoluzione stilistica verso il biopic: messi da parte gli eccessi di montaggio e di costruzione dei due film di
mafia precedenti, Ferrara realizza un lavora più tradizionale, meno
spettacolare e meno azzardato negli incastri di montaggio . Pur nell’urgenza di eventi ancora recenti, al contrario che in Cento giorni
a Palermo il film sembra decantarli su strutture narrative più note, come se ormai il mafia movie fornisse una griglia funzionante ed efficace, in cui inserire vari personaggi e accentuare eventualmente 42 alcuni aspetti; come, in questo caso, il legame con la politica .
4- Gli uominiforti di Pasquale Squitieri. Pasquale Squitieri ha sempre dichiarato di ispirarsi al modello del melodramma (secondo la lezione di Luchino Visconti), ostentando
una disinvoltura «hollywoodiana» verso la materia narrata. Come vedremo, però, l’anti-ideologismo di Squitieri è, ovviamente, esso
stesso un’ideologia, ancorché tutt’altro che compatta. In essa
convivono un populismo libellista (la delinquenza o il banditismo come versione perversa e vitale di lotta di classe) e un’attrazione per legge e ordine (la democrazia da sola non può sconfiggere la mafia:
aporia, questa, che Squitieri espone più compiaciuto che allarmato), mentre il gusto per l’azione si mescola a momenti esplicitamente riconducibili agli stilemi del cinema «impegnato». Il regista sceglie i
propri soggetti, modelli produttivi e formali anche in modo da distinguersi da una produzione che in realtà gli è a tratti
sovrapponibile, quella dei poliziotteschi. I suoi film hanno budget relativamente alti, produttori di nome (Gianni Hecht Lucari o Mario
Cecchi Gori), attori di richiamo; si propongono come riletture della storia recente, condizione fondamentale per essere rubricati nella
categoria del cinema politico. I mafia movie di Squitieri sono due negli anni settanta (Il prefetto
di ferro, Corleone) e uno negli anni ottanta (Il pentito); va però ricordato che il regista era stato, subito prima, uno dei pochi ad affrontare con qualche pretesa anche la storia della camorra
(Camorra, I guappi). Questi ultimi film sono soprattutto tentativi di
ridefinire le estetiche del cinema politico dell’epoca, e il rapporto generi-autori, in un momento di crisi, tra la fine dello spaghetti western e l’affermarsi del poliziottesco. La loro operazione
fondamentale è l’esplicito recupero estetico della sceneggiata e del mèlo. Dai film di mafia, invece, si esige all’epoca quantomeno l’ombra dell’inchiesta e del riferimento alla Storia, magari avallato dal nome di
un giornalista specializzato. I mafia movie di impianto più «investigativo», ricordiamo, spesso sono accompagnati da un volume che certifica la serietà dell’operazione: Il sasso in bocca di Michele
Pantaleone (Cappelli, 1970), Lucky Luciano di Lino Jannuzzi (Bompiani, 1973), mentre altre volte ci sono alle spalle testi letterari 0
teatrali di Sciascia o Giuseppe Fava. I due mafia morie di Squitieri
sono tratti rispettivamente da una biografia romanzata del prefetto Mori scritta da Arrigo Petacco (Mondadori, 1975) e da un libroinchiesta di Orazio Barrese su Luciano Liggio, I complici (Feltrinelli,
1973)Il prefetto di ferro, rispetto alle biografie rosiane, dichiara
esplicitamente la propria natura romanzesca, di racconto popolare e quasi mitico, senza troppo riguardo per la fedeltà ai fatti storici. Cesare Mori, prefetto di Palermo dal 1925 al 1929, era stato autore di
una vastissima e quasi leggendaria opera di repressione della mafia in ... . 43 tutta la Sicilia occidentale . Alle spalle del film c’è anche un certo gusto rétro, che ispirava il
recupero degli anni venti e trenta (da II conformista di Bernardo Bertolucci a Divina creatura di Giuseppe Patroni Griffi), ma
soprattutto il nuovo eroe del poliziesco americano come l’ispettore Callaghan di Clint Eastwood o il Popeye di II braccio violento della
legge di William Friedkin: «Qui lo Stato deve fare più paura della mafia», afferma Mori, che si dichiara altrove «più mafioso dei
mafiosi», si presenta dal boss armato di fucile, minaccia un procuratore quando assolve degli imputati. Dall’altro lato la violenza
dei suoi nemici è particolarmente cruenta: la regia indugia sui
cadaveri, su donne stuprate e uccise (con un carabiniere che vomita) eccetera. Squitieri, peraltro, ricorda di aver accettato la proposta del
produttore dopo il fallimento del progetto di First Blood, ossia il 44 futuro Rambo, per De Laurentiis . Il rimando al western è diretto, con il protagonista Giuliano
Gemma (divo del genere, anche se in prima battuta la scelta di Squitieri era Burt Lancaster) che troneggia a cavallo armato di fucile,
e con ^«arrivano i nostri» quando i campieri attaccano dei manifestanti. E, anche qui, c’è il confronto a distanza con un mafioso
dall’aria nobile, interpretato da Francisco Rabal, che riconosce il prefetto come degno avversario («onore a quest’uomo») e si uccide in
carcere dando testate al muro. Il personaggio interpretato da Claudia Cardinale, donna del popolo
che affascina il prefetto ma gli si mostra ostile, ha sia il ruolo di controparte romantica, sia quello di memento della giustizia sociale,
proprio perché ricorda didascalicamente al prefetto che la sola repressione non basta. «Cause: analfabetismo, latifondo, clientelismo», appunta allora Mori su un’agenda; e in un altro momento, per tagliare le radici di una mafia figlia del sottosviluppo,
scortato dai carabinieri, fa distribuire agli indigeni coperte e
medicinali. Insomma, pur nella sua disinvoltura nell’uso dei fatti storici, Squitieri sente l’esigenza, per situarsi nel sistema dei generi e
degli autori, di un qualche avallo «di sinistra», per una vicenda che politicamente poteva sembrare ambigua. Il versante sociale è affidato in gran parte alla canzone che si ascolta sui titoli di testa e nelle scene delle retate, scritta per l’occasione dal più noto poeta siciliano, il
comunista Ignazio Buttitta, musicata da Ennio Morricone e cantata da
un’istituzione della musica folk, Rosa Balistreri
. Balistreri e Buttitta
erano anche icone della cultura di sinistra, e infatti il testo della
canzone coincide solo in piccola parte con lo spirito del film: «E Mori
partìu... ed arrivau cu un trenu spidali/ senza sapìri ca ci facia lu
senni 6 capitali...» recita un verso, e la descrizione delle retate è a tinte assai più fosche che nel film:
... Di notti ò scura, li sbirri cuminciàru li ritati scassannu ’i porti e tràsinu ’nte casi stracanciati. E sull’istanti curpevuli e nnuccenti a la rinfusa *i tiraru fora e si purtàra chi catini è pusa.
I matri e i figghi currennu appressa ai patri e a li mariti vannu chiancènnu... vannu chiancènmi e chiànciri ’i sintiti46. In realtà, anche se vengono avanzati dubbi sulle radici sociali del
fenomeno, e sui metodi di Mori, il film dà per scontata la colpevolezza
degli arrestati nelle retate (o quantomeno non la rileva come problema)
e la durezza dei metodi di indagine compresa la tortura, e
la scena clou del film non riguarda la lotta alla mafia ma quella al 48 brigantaggio: l’assedio di Gangi (ricostruito nel comune laziale di Artena). Alla fine, Mori sarà sconfitto quando alzerà il tiro («Ora ci occupiamo dei galantuomini») e riconoscerà che «ci siamo dimenticati che la mafia è una puttana che si struscia vicino a chi
detiene il potere». Nella semplificazione è ovvio che figure come quella di Alfredo
Cucco (federale di Palermo, legato all’ala di Farinacci, dapprima a fianco di Mori e poi processato e assolto per illeciti finanziari e per . . x 49 . x contiguità alla mafia) perdano di sfumature. Nel complesso, però, Il
prefetto diferro ci dice anche altro: la sua nostalgia dell’uomo forte si
intende al meglio se la si legge sullo sfondo non della mafia, ma del terrorismo degli anni settanta. Il prefetto «legge e ordine», che viene sconfitto dagli intrighi del potere, mostra non tanto una mafia invincibile, ma una sfiducia verso la politica e la democrazia, 50 diffusissima nel cinema (anche di sinistra) dell’epoca . Come ha
notato Dario Portale, il film cade nel pieno della discussione sulla «legislazione d’emergenza», in cui anche il Pei, che pochi anni prima
si era fatto promotore di mobilitazioni per il disarmo della polizia sulla scia degli eccidi di Avola e di Battipaglia, attenua fortemente la
sua opposizione ponendo la base di un accordo fra tutti i partiti dell’arco costituzionale5* . La prospettiva di Squitieri rimarrà in fondo sempre la stessa: evidenziare le contraddizioni di uno Stato democratico alle prese con
la repressione di un fenomeno criminale, constatare la corruzione
generale, che ispira il desiderio di un uomo forte. Si può dire che
l’ideologia del regista trovi risoluzione nella forma del genere, nella creazione di eroi dell’action movie (urbano o rurale). La loro azione si
giustifica in sé, come evidenza accompagnata da musiche e montaggio, e attorno ad essa le insidie della politica e le debolezze della democrazia trovano visivamente una (almeno momentanea)
soluzione. Il successivo Corleone, come si diceva, risulta «liberamente ispirato» al libro di Orazio Barrese, notista politico e corrispondente
da Roma dell’«Ora» di Palermo
. In realtà si tratta di una filiazione
abusiva, forse ispirata dalla necessità di esibire, per l’appartenenza alla famiglia del cinema politico, una patente di legittimità. I complici è un’attenta ricostruzione delle connivenze e delle ambiguità politiche
nei confronti della mafia dagli anni sessanta in poi, che si concentra in maniera minuziosa sul lavoro della Commissione antimafia; e tra i tanti episodi passati per la Commissione, si parla anche della fuga di Luciano Liggio durante un soggiorno in clinica53. Il film, invece, è
proprio la biografia di uno pseudo-Liggio, che era da una ventina
d’anni uno degli esponenti più famigerati di Cosa Nostra: già
esecutore, fra l’altro, dell’omicidio di Placido Rizzotto, aveva ucciso nell’agosto 1958 il boss di Corleone Michele Navarra, medico e grande
elettore democristiano, prendendone il posto. Arrestato nel 1964, clamorosamente assolto nel processo di Bari del 1969, scappa ed è latitante fino al 1974, quando viene di nuovo arrestato e, pur
rimanendo in carcere fino alla morte, a quanto pare fa in tempo a 54 ordinare, tra l’altro, l’omicidio del giudice Terranova . Il trucco del protagonista Giuliano Gemma lo rende in effetti simile
al boss, e abbondano i riferimenti, alcuni vaghi (l’omicidio del capomafia precedente, i legami con l’edilizia e politica); altri, come i
sequestri di persona, più specifici00. Corleone però, come è chiaro fin
dal titolo, si inserisce anzitutto nella scia del Padrino di Coppola,
esibendone per così dire l’originale storico. Fin dal nome, il protagonista Vito Gargano è un ideale trait d’union tra realtà e finzione, tra Luciano Liggio e Vito Corleone (ma secondo molti Liggio
medesimo, nelle sue apparizioni pubbliche ai processi degli anni settanta, imitava il Brando del film di Coppola). La stessa struttura a
flashback (l’intero film è rivissuto da un pensieroso don Vito alla
vigilia del proprio processo) ricorda il secondo capitolo della saga coppoliana.
Nel racconto dell’ascesa di don Vito, una certa attenzione è posta sui legami con la politica, attraverso la vicenda di Stefano Satta
Flores, politico di governo, mosso dapprima da nobili ideali, poi legatissimo al boss. Ma c’è anche il militante comunista interpretato
da Michele Placido, che arringa contadini e campieri cercando 56 un’alleanza interclassista . Al di là dell’inverosimiglianza, è chiara l’ambizione di affresco storico, tra II padrino parte n e Novecento,
intesa a rileggere il passato in una chiave di un meridionalismo populista che condurrà negli anni il regista a ima coerente apologia
del brigante Carmine Crocco (Li chiamarono... briganti!). Il film racconta in modo schematico la mafia delle campagne, con
tutta Vimagerie del feudo, e poi la mafia della città, con i luoghi
canonici di Palermo (omicidio alla Vucciria, cantieri edili); si
concentra poi sul sacco di Palermo, mostrato in un montage di titoli sul giornale, cantieri al lavoro e rumore di mitra in sottofondo. In
realtà, però, i crimini di don Vito non sono mai mostrati. La sua è l’ascesa di un self-made man, un uomo coraggioso in una giungla in
cui la corruzione dei politici è un dato di fatto. La parte processuale (come quasi sempre nel cinema italiano) è l’esatto contrario di un
modulo per arrivare alla verità, o almeno interrogarsi su di essa:
piuttosto, è uno show-down in cui l’accusa ricostruisce la verità, ma poi le prove arrivano in aula completamente falsificate, segnando il provvisorio trionfo di don Vito. E qui risalta l’ambiguità politica del film: da un lato denuncia della mafia, ma anche epopea di un mafioso-
eroe, senza dimenticare la strizzata d’occhio a sinistra con bandiere rosse e sindacalisti. Il pressbook di Corleone mette a nudo questa ambivalenza, che può
portare, dall’ammirazione degli uomini forti, a capziose deviazioni. Il regista si riferisce in termini molto critici alla sentenza che qualche
anno prima aveva condannato il mafioso: «Una sentenza che
scandalizza almeno quanto la precedente che lo aveva assolto». La conclusione che Squitieri ne trae è che «il sistema dunque ha bisogno di contraddirsi per combattere la mafia»57. Ma, contrariamente ai
dubbi consimili che più volte avanza al riguardo Leonardo Sciascia, in Squitieri c’è più di un’ombra di compiacimento. H compiacimento, verrebbe da dire, del regista d’azione che vede confermata dalla Storia
la giustizia (poetica, ma non solo) di una narrazione improntata al western, al poliziesco e al melodramma. Non stupisce più di tanto che,
a seguire, Squitieri progettasse un nuovo film di Giuliano, una sorta di anti-Rosi in cui si sarebbe data voce al mito del bandito: una specie di
Il siciliano di Cimino ante litteram, pare di capire3 . In questa chiave si può leggere anche II pentito, esempio estremo
del sovrapporsi di realtà e finzione: pamphlet filmato, il film è un instant movie con nomi appena camuffati. Il materiale narrativo del film, recita una didascalia, «viene prevalentemente dagli atti
processuali». Si raccontano le ultime fasi della seconda guerra di mafia, con l’omicidio Ambrosoli (nel film chiamato Pistilli), il finto
sequestro di Sindona (ribattezzato Spinola e interpretato da Max von Sydow), la guerra tra i corleonesi capitanati da Salvo Lercara/Totò
Riina e il boss Vanni Ragusa/Tommaso Buscetta, che scappa in Sud America. Sono riconoscibili i principali fatti di mafia tra anni settanta
e ottanta, alcuni riassunti in dialoghi dai toni quasi surreali, come quello che elenca, con nomi cambiati o perifrasi, gli omicidi del colonnello Russo, del «presidente della regione Sicilia» e del «prefetto
Emanuele Patti» (Dalla Chiesa). Il giudice protagonista, addirittura, si chiama Falco.
Ma situiamo il film nel contesto di quel periodo, in un intenso giro di mesi. Tommaso Buscetta è arrivato in Italia il 15 luglio 1984, e ha
cominciato le proprie rivelazioni nel corso dell’estate. A settembre hanno luogo i primi arresti del «blitz di San Michele», che portano in
carcere centinaia di mafiosi. Durante la preparazione del film di
Squitieri vengono uccisi i commissari Beppe Montana e Ninni Cassarà; durante le riprese, Falcone e Borsellino sono all’Asinara a
lavorare all’istruttoria del maxiprocesso, che viene depositata 1’8 novembre. Esattamente una settimana dopo II pentito è nei cinema. E
prende posizione in maniera nello stesso tempo violenta e ambigua. In attesa che si svolga il maxiprocesso, Squitieri (come molti
all’epoca) non nasconde il timore che si tratterà di una grande farsa;
anche se, a differenza di alcuni, imputa le velleità di Falcone a ingenuo idealismo anziché a malafede e carrierismo59; e ciò facendo, lo iscrive in una classica galleria di perdenti, ultimo della stirpe di Mori. Nel film il pentito, braccato dal clan rivale, si serve di Falco per
vendicarsi e tornare a capo di Cosa Nostra; fa rivelazioni a orologeria
per avere agio di sterminare i corleonesi, protetto dallo Stato. L’ultima immagine ci mostra il giudice, prigioniero più del pentito, mentre alcune porte scorrevoli si chiudono davanti a lui, imprigionandolo nei 60 meandri della giustizia .
Già il fatto che si tratti di un magistrato, dunque non un uomo
d’azione, rende il personaggio di «Falco» lontano dall’ideale di Squitieri. L’impotenza del giudice è un destino fin dall’inizio, e
protagonista del film è in effetti, come da titolo, il pentito (il rapporto col giudice copre gli ultimi 25 minuti). Uno dei nomi che questi fa è
quello di un magistrato colluso, che con fatalistica rassegnazione
accoglie Falco, venuto ad arrestarlo. Prima di gettarsi dalla finestra, il giudice corrotto si lascia andare a un monologo che è la morale della storia: com’è nella tradizione del cinema politico italiano, a
pronunciarlo è chi sta dalla parte del male. Il collega accusa Falco di volersi sostituire alla Storia, e ribadisce la sua sfiducia in uno Stato che ha mandato laggiù il giudice come uno sceriffo, mentre «a Roma» cerca nuovi accordi:
Quando si trascinano in corte d’assise uomini a centinaia, a migliaia, non si tratta più di reati da tribunali: è tutta una società che viene messa sotto processo! E i processi alla società li fa soltanto la storia. La Storia: con le sue rivoluzioni, con le sue guerre; non tu, con i tuoi cancellieri, i tuoi poliziotti, i tuoi pentiti. I pentiti! Queste micce accese che non potrai più spegnere, e che ti scoppieranno fra le mani, un giorno!
1 Per un sommario degli stereotipi sull’opera di Damiani cfr. Pezzetta, Regia Damiano Damiani dt, p. 223. 2
Ibid., p. 66.
3
Cfr. P. Garofalo, Damiano Damiani's The Day of the Owh A Western Flirtation, in
Renga, Mafia Movie. A Reader dt, pp. 252-60, che ricorda anche la somiglianza visiva (il direttore della fotografìa è lo stesso dei film di Leone, Tonino Delli Colli). 4
Sulla lavorazione del film è stato scritto in anni recenti un romanzo (A. La Mattina,
L'incantesimo delle civette, e/o, Roma 2015) che racconta l’impatto della troupe sulla
cittadina di Partinico, con l’ombra della mafia e addirittura un piano per rapire Franco Nero. 5
F. Faldini - G. Fofì, R cinema italiano d’oggi, 19701984, Mondadori, Milano 1984, p. 85.
Curiosità: Franco Nero non conosceva il libro, e fo convinto a redtare nel film da Vanessa
Redgrave, che lo aveva letto in inglese, dove era uscito col titolo The Mafia (Pezzetta, Regia
Damiano Damiani dt, pp. 206-7). 6
A. Bravo, Rfotoromanzo, il Mulino, Bologna 2003, pp. 45-6.
' Si veda la voce «Franca Viola* di Paola Busolo, in www.encidopediadelledonne.it 8
Così osservava all’epoca uno dei critici italiani più noti: «Il tema mafioso è accessorio, fa
da pedale, da atmosfera, come parte integrante del paesaggio siciliano. [...] Impiantano male, come al solito, il landò i pubblicitari che concentrano tutto il senso del film nella mafia, la quale comincia ormai a diventare per gli italiani una odiosa barba [...] mettendo in ombra quella che è l’autentica, grande, viva, inventata parte del film: i due giovani protagonisti» (F.
Sacchi, in «Epoca», i° novembre 1970, dt in Pezzetta, Regia Damiano Damiani dt, p. 223). 9
Intervista di A. Pezzetta, ibid., p. 226.
IO
Indicativo della conoscenza del fenomeno che Ugo Casiraghi, nella sua recensione su
«L’Unità», veda invece in Rizzo una figura ispirata al leader comunista siciliano Girolamo Li Causi, all’epoca assai più noto di Rizzotto (spede in area Pd) ma che però era ancora vivo (la recensione è citata in Pezzetta, Regia Damiano Damiani dt, p. 230). 11
Sulla figura di Scaglione, in effetti sfumata e difficile da definire all’epoca (e non solo) si
veda G. Di Lello, Giudici Cinquantanni di processi di mafia, Sellerie, Palermo 1994, pp.
110-30, che riporta anche stralci delle deposizioni alle Commissioni antimafia e brani della stampa dell’epoca, tra cui una magistrale inchiesta di Giuliana Saladino su «L’Ora». La figura
di Scaglione, sintetizza Di Lello, va inserita nel contesto della magistratura dell’epoca (a cominciare da Emanuele Pili, capo della procura generale di Palermo, di cui erano accertati contatti con la banda Giuliano e con Michele Greco detto «il papa»). «Pietro Scaglione riflette gli orientamenti “operativi’’ degli altri procuratori della repubblica del paese, dimostrando
grande prudenza nei confronti del ceto politico democristiano e ferma determinazione nei confronti di operai, braccianti, contadini e sindacalisti in lotta per la terra, per il lavoro e per
la pace [...). Scaglione è legato da vincoli di amicizia e frequentazione a vari esponenti politici e nei confronti di costoro agisce con intelligente tatticismo perché, non potendone ignorare le malefatte, riesce a coinvolgerli in processi per episodi marginali senza disturbarli per i grossi
affari di speculazione e malgoverno e dò non certo in solitudine, ma con la compiacenza della complessiva struttura giudiziaria: forse, se si facessero delle statistiche, i politici inquisiti in
quell’epoca risulterebbero molto più numerosi a Palermo che altrove, anche se poi, proprio
per l’irrilevanza delle imputazioni e per le conseguenti assoluzioni, venivano rilegittimati nella loro “correttezza”» (pp. 115-6). D’altronde, «la strumentale denigrazione di Scaglione rimarrà un dato costante nella storia giudiziaria palermitana e sarà rilanciata, di volta in
volta, per coprire tutto il resto, che non era certo di minore valenza degenerativa» (p. 127). Con meno ombre, invece, il ritratto fatto da Pietro Grasso, all’epoca in cui era procuratore
della Repubblica a Palermo: «Ricordo le prime campagne di delegittimazione sulla figura del magistrato. Ricordo che circolarono certe vod per gettane ombre sulla sua attività: calunnie
poi categoricamente smentite dalle indagini successive. Scaglione aveva sempre tenuto un
atteggiamento coerente e rigoroso nei confronti di una criminalità che allora era ancora difficilmente decifrabile come mafiosa» (S. Lodato - P. Grasso, La mafia invisibile. La nuova strategia di Cosa Nostra, Mondadori, Milano 2001, p. 91). 12 13
Pezzetta, Regia Damiano Damiani dt, p. 63. Sul tema delle «sviste» nel cinema di Damiani si v’eda Mancino, Schermi d’inchiesta dt,
P. 1O8. 4
I due brevi discorsi sono trascritti e messi a confronto in Mancino, Schermi d’inchiesta
dt, p. 96. Sui temi di attualità nel cinema di Damiani cfr. anche le pp. 105-7. 15
Sul «platonismo» del tardo Sciascia, che vede nella letteratura il luogo in cui la realtà
può trovare un paradossale inveramento, si veda M. Onofri, Storia di Sciascia, Laterza, Roma-Bari 1992. 16
Da notare inoltre, nei film di Damiani fino agli anni settanta, come anche in A ciascuno
il suo di Petri, la centralità visiva, e innegabilmente erotica, della figura della vedova, die accomuna il dnema di mafia alla commedia erotica coeva. Fa eccezione il film per la tv L’angelo con la pistola, in cui Tahnee Welch si trasforma in
giustiziera per vendicare la propria famiglia. Anche qui essa si appoggia a un secondo
personaggio femminile di prostituta succube (Èva Grimaldi), che però riscatta e salva. Sui personaggi femminili nel cinema di Damiani cfr. anche Mancino, Schermi d’inchiesta dt, p.
118. 18
Ibid., p. 121. Mancino nota anche la derivazione sdasdana dei cognomi che finiscono in
«s»: Rogas/Solaris (cui si può aggiungere, in Io ho paura, l’agente dei servizi Rniz, che
rimanda alla passione sdasdana per l’onomastica ispanofona). 19
In questo paragrafo riprendo alcuni spunti del mio Damiani professionista del mafia
movie, in Damiano Damiani. Politica di un autore, a cura di Q Uva, Bulzoni, Roma 2014, pp. 45-54. 20 Zambetti - Mancino, Francesco Rosi dt, p. 99. 21
Sul rapporto con De Mauro si veda Rosi, Io lo chiamo cinematografo dt, pp. 276-82.
L’ultima sentenza sul caso Mattei, emessa nel 2012 dalla Corte d’assise di Palermo,
presieduta da Giancarlo Frizzino, pur assolvendo l’unico imputato Totò Riina, conferma
l’ipotesi dell’attentato e punta sulle responsabilità del segretario regionale della De, Graziano Verzotto, che sarebbe stato coinvolto nella morte di Mattei e si sarebbe reso conto che De
Mauro era venuto a capo della verità. 22
G. Fofi, Dieci anni difficili. Capire con il cinema parte seconda, La Casa Usher, Firenze
1985, pp. 24-6; Zambetti - Mancino, Francesco Rosi dt, p. 118. Si segnala la caustica recensione di Alberto Arbasino, raccolta in Id., Fantasmi italiani, Cooperativa scrittori, Roma
1977, PP- 367^7023
Sull’episodio e sui rapporti dello scrittore col Pd cfr. E. Macaiuso, Sciascia e i
comunisti, Feltrinelli, Milano 2010. 24
Rosi, Io lo chiamo cinematografo dt, p. 303.
25
Ibid., p. 317.
26
Per una riconsiderazione dello spessore di Luciano all’interno dell’organizzazione, sia
negli anni trenta che nel dopoguerra, si vedano invece, di Salvatore Lupo, Quando la mafia trovò l’America dt, pp. 113-20,128-31 e La mafia dt, pp. 168-72,182-4. Lupo chiarisce,
sulla base di fonti attendibili, i presunti servizi resi da Luciano alla patria, che consistevano probabilmente in un controllo della forza-lavoro dei docks, e che comunque già da subito
furono gonfiati da Luciano stesso per ottenerne vantaggi 2” 28
Rosi, Io lo chiamo cinematografo dt, pp. 66-7,314. Zambetti - Mancino, Francesco Rosi dt, p. 106.
29
Rosi, Io lo chiamo cinematografo dt, p. 413.
30
Rosi, Io lo chiamo cinematografo dt, pp. 414-6. Sul dibattito accesosi all’epoca si
vedano la lettera di Antonio GhireUi a Rosi e gli interventi di Rossana Rossanda sul
«manifesto», raccolti anche nel Fondo Rosi del Museo nazionale del cinema di Torino. 31
Cfr. G. Ferrara, Francesco Rosi, Canesi, Roma 1965. Il libro interpreta Rosi come erede
pressoché unico della genuina tradizione neorealista. 32
M. Pantaleone, R sasso in bocca. Mafia e Cosa Nostra, Cappelli, Bologna 1970.
Nell’appendice (Unfenomeno-personaggid) il regista rn-endica l’utilità e la necessità di
rinunciare alla sceneggiatura (ibid., p. 140) anche pervia della lavorazione accidentata, e
l’importanza del montaggio. «Ma il vero rifiuto compiuto da questo tipo di film, per cui non è assolutamente possibile confonderlo con una pellicola a soggetto, è stato il rifiuto dei protagonisti o, come si voglia, del personaggio centrale. (...) Era un film storico, quindi un
film pubblico, dove non d doveva essere nulla di privato, nulla che riguardasse le esperienze personali, esistenziali degli autori. (...) Nel Sasso in bocca i personaggi non d sono, o m^lio c’è un fenomeno sodologico-personaggio, la mafia, che è in tutte le sequenze, ma che non ha una faccia che la mima o la “porta” allo spettatore» (pp. 140-1). 33
Extra del dvd General Video, dt in Mancino, Schermi d’inchiesta dt, p. 141.
34
Pantaleone, R sasso in bocca dt II libro contiene una cavalcata di aneddoti e fotti
minuti, in ordine sparso, seguiti da una sceneggiatura desunta del film. Il diario di
lavorazione riporta piccoli o grandi episodi di ostilità ma una sostanziale tranquillità delle riprese nei veri luoghi, da Villalba a Corleone. La mafia, insomma, non intervenne mai per boicottare questo che pure era il film più esplicito di denuncia del fenomeno fino a quel
momento. Le difficoltà di Ferrara sembrano piuttosto di ordine economico, per le perplessità riguardo alle possibilità di successo del film. L’incasso finale comunque, tutf altro che trascurabile, fo di oltre 300 milioni 35
Mancino elenca i principali metodi usati da Ferrara per stemperare l’effetto
documentaristico dei suoi film; 1) gli sland della macchina da presa a mano che si intrufola
oMmque; 2) gli impeti dello zoom che cattura, isola e chiosa a distanza in modo spudorato qualsiasi particolare degno di nota; 3) le intemperanze di angolazioni vertiginose di ripresa
che denotano situazioni allucinanti (Mancino, Schermi d’inchiesta dt, p. 132). 36
Ferrara ricorda il disappunto di Rosi davanti all’operazione, compiuta da Kim Arcalli,
per adattare il ritmo delle sequenze di Rosi a quelle di Ferrara, più «tambureggiante» ed «ejzenstejniano»: «Rosi se l’è legata al dito, non me l’ha ancora perdonata» (extra del dvd General Video, dt in Mancino, Schermi d'inchiesta dt, p. 134). 3~
11 ruolo di conoscitore siciliano delle cose del mondo è riservato nel film all’agente
Fontana, interpretato da Stefano Satta Flores, die dedama in maniera forse oggi ovvia, allora
un po’ meno: «Il terrorismo era contro lo Stato, invece mafia... potere...». Va detto che Dalla
Chiesa, verosimilmente, sarà stato un po’ meno sprovveduto di quanto appaia nel film, in quanto conosdtore non superficiale del fenomeno, come comandante dell’Anna dei
carabinieri di Corleone all’epoca dell’omiddio Rizzotto e comandante della Legione carabinieri di Palermo dal 1967 al 1973. Si vedano anche le sue dichiarazioni alla 1 Commissione antimafia il 28 marzo 1969, ora in N. Tranfaglia, Mafia, politica e affari, 1943-2000, Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 90-102. 38
Cfr. la brochure promozionale per la raccolta dei fondi curata dalla Cld: Cento giorni a
Palermo. Unfilm contro la mafia, Tipografia Luxograph, Palermo 1983. 39
G. Falcone - G. Turone, Tecniche di indagine in materia di mafia, relazione letta a un
convegno a Castelgandolfo nel giugno 1982, ora in Falcone, La posta in gioco dt, pp. 229-64.
L’intervento si riferiva al tipo di reati: quelli di primo livello sarebbero direttamente legati ad
attività produttive di denaro; i secondi alle guerre fra cosche per il mantenimento dei rispettivi campi di attività; i reati di terzo livello «mirano a salvaguardare il perpetuarsi del sistema mafioso in genere (si pensi ad esempio all’omiddio di un uomo politico, o di altro
rappresentante delle pubbliche istituzioni, considerati pericolosi per l’assetto di potere
mafioso)». Il discorso serve a Falcone per superare l’impostazione che collegava i reati secondo il «tipo d’autore», conducendo inevitabilmente alle grandi assoluzioni per insufficienza di prove, e per aprire concettualmente la strada all’artìcolo 4x6 bis die introdurrà il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Più tardi, Falcone specificherà: «Questa suggestiva ipotesi che vede una struttura come Cosa Nostra agli ordini
di un centro direzionale sottratto al suo controllo è del tutto irreale e rivela una profonda
ignoranza dei rapporti tra mafia e politica. (...) Attraverso un percorso misterioso, per non so quale rozzezza intellettuale, il nastro terzo livello è diventato il “grande vecchio”, il
“burattinaio”, che, dall’alto della sfera politica, tira le fila della mafia» (IdL, Cose di Cosa Nostra dt, p. 169). 40
Dall’edizione finale del film scompaiono sia i riferimenti a Gerad, sia il cartello finale in
cui si ricordava l’arresto di Contrada (Mancino, Schermi d'inchiesta dt, p. 127). Poco
nominato nel film, curiosamente, il nemico numero uno di Falcone in procura, ossia il procuratore capo Pietro Giammancn. Alla proiezione romana il film fo accolto con forti
perplessità, dovute anche ad alcune forzature, come un interrogatorio di Buscetta a New’York
in realtà mai avvenuto, e la stessa data della strage di Capad, che un cartello fissava al 23
aprile anziché 23 maggio (cfr. S. Fumarola, Falcone diventa un film o un ricordo tradito?, in «la Repubblica», 9 ottobre 1993; A. Purgatori, Martelli: unfilm che tradisce Falcone, in
«Corriere della Sera», 8 ottobre 1993). 41 Dal film precedente tornano le immagini dell’omiddio Dalla Chiesa, ma ormai la dimensione di patchwork con un ruolo fortemente creativo affidato al montaggio non c’è più.
Sullo schermo televisivo lampeggiano però talvolta le immagini del Settimo sigillo di Bergman, come una premonizione della morte (elemento che trova riscontro biografico in una effettiva passione del giudice per quel film). 42
A compimento del percorso di Ferrara, va ricordata anche la miniserie in due puntate
Donne di mafia, sottoprodotto televisivo aD’incrodo tra La piovra e Mery per sempre. In I
banchieri di Dio, stanca ripetizione del modello, che si intreccia solo tangenzialmente col tema di questo libro, è ormai evidente la frizione tra l’elemento didascalico (con lunghi
dialoghi esplicativi) e quello spettacolare, con una parata di sosia a interpretare i vari personaggi storia. 43
Dell’efficacia dell’opera di Mori, pur riconoscendone la portata, d fu da subito chi
e\Tdenziò i limiti: è la classica lettura data già nel 1926 dal comunista Ruggero Grieco, secondo cui la lotta alla mafia del fascismo «colpisce la piccola mafia dei funzionari, dei contadini pezzenti, dei piccoli-borghesi poveri, ma non i capi della mafia, legati strettamente
alle forme del feudalesimo» (dt in Santino, Storia del movimento antimafia dt, p. 129). Anche se la difesa del feudo era lo scopo dichiarato di Mori, le successive posizioni sono assai
più sfumate: cfr. l’opera di uno storico e militante comunista come F. Renda, Storia della mafia, Sigma, Palermo 1997, pp. 201-25 («il prefetto Mori ottenne il medesimo risultato che
nella fase liberale: non distrusse la mafia, ma la mise per qualche tempo nella impossibilità di nuocere, facendola rinchiudere nelle carceri o relegandola al confino. (...) Per tutto il ventennio risultarono spezzati i rapporti mafia, politica e istituzioni e reso impraticabile il
controllo mafioso del territorio», p. 225). Per quanto riguarda l’aspetto sodale dell’operato di Mori, Salvatore Lupo parla di un’operazione rivolta soprattutto alle fasce intermedie dei
gabelloti, mentre i proprietari vengono considerati vittime in stato di necessità, «persino quando si prospetta la loro connessione con fatti di sangue». L’operazione Mori è dunque
anche parte di una «revanche agraria» contro un ceto di mediatori politico-criminali (Lupo,
Storia della mefia dt, pp. 214-7): «Mori esibisce compiaciuto i ringraziamenti dei
latifondisti che hanno potuto elevare i canoni d’affitto, in qualche caso anche da 10 a nomila lire annue. (...) Il salvataggio dei latifondisti rappresenta l’elemento comune di tutti i
processi, che per il resto mostrano notevoli differenze tra loro», e ancora: «La discriminante classista esiste, ma divide i latifondisti da tutti gli altri» (p. 225). Importante al riguardo
l’opera di C. Duggan, La mafia sotto ilfascismo, Rubbettino, Soveria Mannelli 1987, pp. 43 sgg. Da ricordare le memorie dello stesso prefetto: C. Mori, Con la mefia aiferri corti, Mondadori, Milano 1932. 44
Intervista a Pasquale Squitieri sul Prefetto di ferro,
www.youtube.com /watch ?v=UioFcjÌ97yQ. 45
H copione è scritto con Ugo Pirro, sceneggiatore-simbolo del dnema impegnato di
sinistra, collaboratore di Elio Petri e già co-autore de I guappi. 46«E Mori parti... e arrivò col treno spedale/ senza sapere che faceva il servo al capitale»;
«Di notte al buio cominciarono le retate/ rompendo le porte ed entrando in casa sconvolti./ E
all’istante colpevoli e innocenti alla rinfusa/ li tirarono fuori e se li portarono con le catene ai polsi./ Le madri e i figli correndo dietro ai padri e ai mariti/ vanno piangendo... vanno
piangendo e piangere li sentite». Gli altri versi sono fotti volti al presente e al futuro, in una chiave assai più «sidlianista» di quella del film: «Mi chiana h cori, ora ca terminavo di cantari/ ’sta storia vara - si penso ca la mafia è na l’altari/ e addisonùra ’sta terra onesta chi
vali/ pani e travagghiu, la libbirtà, giustizia e li scoli» («Mi piange il cuore, ora che ho terminato di cantare/ questa storia vara - se penso che la mafia è sugli altari/ disonora
questa terra onesta che vuole/ pane e libertà, la giustizia e le scuole»). 4~
Il metodo di Mori prevedeva in sostanza la presa di ostaggi (compresi dorme e bambini),
spettacolari arresti di massa, torture. Si paria di 5000 arresti della sola provincia di Palermo
(Duggan, La mafia sotto ilfascismo dt, pp. 66 e 210). Se nei metodi di indagine c’è una certa
continuità con la polizia del periodo pre-fascista, va detto che già all’epoca, pur nell’entusiasmo propagandistico generale, si poterono riscontrare osservazioni quantomeno perplesse. Come sintetizza Lupo, l’operazione «sul piano simbolico e propagandistico, fo un
grande successo. Resta il fatto: alla fine ebbe sulla mafia un impatto minore di quello che d si sarebbe potuto aspettare», perché «già all'inizio degli anni trenta, la mafia fornì non dubbi
segni di vita» (La mafia dt, pp. 142-3)» 48
Sull’assedio di Gangi si veda Duggan, La mafia sotto ilfascismo dt, pp. 61-84. In realtà
la dinamica dell’assedio fo molto diversa da quella narrata nel libro di Petacco (pp. 8-100), a
giudicare da varie testimonianze fra cui quella del commissario Spanò (cfr. le memorie del
figlio A. Spanò, Faccia a faccia con la mafia, Mondadori, Milano 1978, usate dopo il film di Squitieri) che aveva guidato l’operazione: nel film lo interpreta Stefano Satta Flores, ed è un
probo aiutante di Mori. Spanò aveva utilizzato la mediazione del barone Sgadari per ottenere
la consegna degli esponenti della banda Ferrarello già alla fine del novembre 1925, ma Mori impose l’avvio di un’operazione spettacolare il 1? gennaio 1926 (rimanendo egli a Palermo per
curare i rapporti con la stampa, a differenza di quanto si vede nel film). L’ultimo bandito si arrende Fu gennaio; Sgadari sarà poi teste d’accusa contro i banditi, al processo. 49
S. Lupo, L'utopia totalitaria delfascismo, in Aymard - Giarrizzo (a cura di), Storia
d'Italia. Le regioni dall'unità a oggi La Sicilia dt, spede pp. 391-3; Id., La mefia dt, pp.
132-7; M. Di Figlia, Afiredo Cucco. Storia di unfederale, Quaderni di «Mediterranea», Palermo 2008. 50
Piccola curiosità: il film, che era usato nelle sale italiane alla fine di settembre 1977, a
fine aprile dell’anno successivo (quando Aldo Moro è ancora prigioniero delle Br) esce in Francia col titolo L’qffaire Mori. L’qffoàre Moro di Leonardo Sciascia uscirà a settembre. 51
D. Portale, Prefetti difèrro in anni di piombo, in Gesù (a cura di), La Sicilia tra
schermo e storia dt, pp. 211-3. 52
Qualche anno prima del film di Squitieri, era stato progettato un altro film su Liggio,
prodotto dalla Thousand cinematografica, die non fo mai realizzato. La sceneggiatura era di
Duilio Coletti, a cui doveva essere affidata anche la regia. Il fascicolo della revisione preventiva presso i documenti del ministero dello Spettacolo all’Archivio di Stato (Cf 6808)
contiene una denuncia di lavorazione del 20 maggio 1974, e un trattamento che lascia pensare a un film basato in maniera più precisa sui processi e le risultanze della Commissione antimafia. Lo script si apre con Liggio bambino, racconta l’omiddio Rizzotto e la rivalità col boss Michele Navarra, le latitanze e i numerosi processi, per chiudersi sull’omicidio
Scaglione. 53
O. Barrese, I complici, Feltrinelli, Milano 1973, pp. 190-205.
54
Su Navarra e il suo rapporto con liggio si vedano tra l’altro Santino - Chinnid, La
violenza programmata dt, pp. 230-45; G. Q Marino, I padrini, Newton Compton, Roma 2001, pp. 277-96; Lupo, Storia della mafia dt, pp. 234-5. La fuga e la latitanza di Liggio
furono al centro di un’indagine specifica della Commissione antimafia: Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, Relazione sulla indagine svolta
in merito alle vicende connesse alla irreperibilità di Luciano Leggio: comunicata alle Presidenze delle Camere il 26febbraio 1970, Atti parlamentari, v legislatura, Documenti,
disegni di leggi e relazioni, Doc. 23. 55 Si ha l’impressione che il contìnuo tossire di don Vito segnali la tubercolosi: però quella
di Liggio era una tubercolosi ossea, che non produce tosse ma costringeva il boss a portare un busto. 56
«Ci fanno sparare dai fratelli nostri», declama, oppure: «Una lupara ti hanno dato, e tu
l’anima d consegnasti». Mentre i campieri depongono le armi urlando: «trasite, pigghiativi a
terra*. ° D. Monetti (a cura di), Pasquale Squitieri. Un autore di cinema... e non solo, Guida,
Napoli 2009, p. 200. La sentenza cui Squitieri si riferisce è quella emessa dal giudice Terranova (assassinato nel 1979) che condannava Liggio all’ergastolo, mentre il boss era stato
clamorosamente assolto ai processi celebrati a Catanzaro (1968) e Bari (1969). Del primo è
oggi riconosduta l’inadeguatezza nella fase investigativa e istruttoria (cfr. G. Di Lello, Giudici, Sellerio, Palermo 1994, PP- 95-109). °*8 Monetti (a arra di), Pasquale Squitieri dt, pp. 313-4.
Sulle polemiche intorno al maxiprocesso si veda Lupo, La mafia dt, pp. 321-6.
Ma già prima la morale del film era stata esposta in una scena tra Falco e il procuratore capo, davanti a un quadro di Guttuso che raffigura un groviglio di mani Una scena
evidentemente ispirata a Cadaveri eccellenti «Sono mani che cercano di afferrare tutto: e
alla fine restano vuote, inerti», dice Falco. E il procuratore: «Parla delle mani del quadro o di quelle della giustizia, rimaste vuote, le mie, o di quelle della mafia, forti mani, che hanno afferrato la nostra terra, e la tengono ben stretta?».
Secondo Squitieri, il film fo denunciato dall’Assodazione nazionale magistrati. Durante la lavorazione, il regista dichiara di aver incontrato una sola volta Falcone, e di averlo rivisto in occasione della proiezione del film, alla fine del quale il giudice si sarebbe mostrato scosso e impallidito (Monetti, a cura di, Pasquale Squitieri dt, pp. 71-3,226).
x. I figliocci del Padrino
1.1paradossi del Padrino. Il padrino di Francis Ford Coppola è un insieme di paradossi: un film
che salva gli Studios e lancia l’utopia di una leva di registi indipendenti da
Hollywood; un film etnico che racconta American way of life; soprattutto, una clamorosa costruzione ideologica che racconta un mondo con perfetta attendibilità. Esso giunge in un momento di profonda crisi del modo di produzione e contribuisce alla sua rifondazione, salvando la Paramount insieme a Love Story di Arthur Hiller. H film però fa nascere
anche la possibilità (rivelatasi effimera) della supremazia di una generazione di autori nei confronti dei produttori1, e del resto il regista si scontrerà da subito con il producer della Paramount Robert Evans . Coppola accetta l’adattamento del romanzo di Mario Puzo come lavoro su
commissione, dopo il rifiuto di molti nomi, da Richard Brooks a Elia Kazan, da Arthur Perni a Costa-Gavras, ma riesce a trasformarlo in un film del tutto personale, pieno di riferimenti alla propria infanzia a Little
Italy : in breve, quasi un film «etnico», aspetto sottolineato dalla presenza
di attori italo-americani nel cast, assai più numerosi di quanto si fosse mai visto in una produzione mainstream3 4* . Ma II padrino è
contemporaneamente un film «etnico» e un film sull’America. Come dichiarò il regista a «Playboy» in occasione del Padrino parte n: «È un errore pensare che io stessi facendo un film sulla mafia. H padrino era un romance su un re con tre figli. È un film sul potere. Si sarebbe potuto
trattare dei Kennedy»0. L’analisi di rituali e comportamenti degli italoamericani è sì assai precisa, ma anche (e specialmente nel secondo 6
episodio) metafora dell’American way of life . H film rende insomma esplicita una visione che era implicita nella cultura americana. Come
ricorda Nelson Moe, «a partire dagli anni novanta dell’ottocento, l’America ha trovato nel criminale italo-americano una figura etnica che, forse più di ogni altra, è stata fondamentale nell’elaborazione della propria
identità nazionale [...]. Lungi dall’essere la pura antitesi dell’America, il
gangster impersona una versione del sogno americano». H paradosso era stato sottolineato già all’epoca da Fredric Jameson in
termini generali: I gruppi dominanti della classe media bianca, già abbandonati di'anomie e alla frammentazione e atomizzazi one sociale, trovano nei gruppi etnici e razziali che sono oggetto della loro repressione sociale e del disprezzo della loro condizione, nello stesso tempo, l’immagine di un qualche ghetto collettivo 0 di una solidarietà da quartiere etnico; essi provano l’invidia e il ressentiment della Gesellschaft (società) per la più antica Gemrinschaft (comunità), che simultaneamente sfrutta e liquida .
Sulla scia di Jameson, Vera Dika ha ipotizzato che il film possa essere
visto, più che come auto-rappresentazione degli italo-americani, come fantasia di auto-rappresentazione da parte di un gruppo più ampio,
costituito dagli executives della Paramount, attivi già nella fase finale della g
stesura del romanzo . Lo stesso Puzo, nei Diari del Padrino, vede il film
come una riconsiderazione delle radici italiane: a venir rivendicate non
sono più solo quelle «nobili» di Marconi o Meucci: la rievocazione della Sicilia per la prima volta balza in primo piano, e si colora di tinte
nostalgiche . H padrino fu visto anche come un ritorno ai valori della famiglia e dell’ordine patriarcale dopo il ’68, ed è innegabile che il patriarca don Vito Corleone sia il sogno di un ordine perduto. Non bisogna dimenticare tra l’altro che il film non è ambientato nel 1972, ma
nell’immediato dopoguerra, un’«età dell’oro» dell’America, e dunque è da
leggersi anche in relazione al filone dei nostalgia movies del periodo, con il revival degli anni trenta e quaranta: il direttore della fotografia Gordon
VXnilis, e particolarmente per la scena del matrimonio, cerca esplicitamente toni da «Kodachrome del 1942»1O.
Ancora più interessante è la premessa del discorso di Jameson, ossia la compatibilità tra costruzione ideologica e veridicità storica: «l’ideologia
non è necessariamente una questione di falsa coscienza, o la
rappresentazione scorretta e distorta di un “fatto” storico, ma può essere invece del tutto coerente con una fedeltà “realistica” a quest’ultimo»11* . Il padrino insomma racconta fedelmente un mondo, e nello stesso tempo è
una costruzione mitica. Questa intuizione spiega la doppia influenza del film: mito e modello per molti mafiosi, in una specie di effetto rebound, e insieme riferimento imprescindibile per raccontare la mafia dall’interno.
In questo senso, in perfetta buona fede Coppola poteva affermare:
C’è un sacco di materiale nd libro che io considero informativo; per cui questo è, in un certo senso, un film pedagogico. Dopo averio visto, uno dovrebbe «conoscere» un sacco di cose sulla mafia: termini, procedure, fondamenti, segreti. [...] Una delle cose potenti del film è che se ne ricava questa comprensione della mafia, in un senso intimo e apparentemente realistico, e questo è notevole'*.
Le ambiguità del film vengono tematizzate e dialettizzate nel Padrino parte H, che è costruito secondo un doppio binario narrativo, come
prequel e sequel insieme. Da un lato, l’infanzia e la giovinezza di don Vito Corleone, l’arrivo negli Usa e la sua affermazione come capomafia .
Dall’altro, le difficoltà e le contraddizioni del nuovo «padrino» Michael,
dopo la strage che concludeva il primo episodio. I due poli del film precedente (la nostalgia del passato e l’ossessione del potere) vengono
separati in due linee narrative parallele. La solitudine del boss si accentua: è tradito dal fratello Fredo, e abbandonato dalla moglie esasperata (che
abortisce pur di non dare alla luce un figlio in un mondo come quello). E mentre si accentua il versante etnico (e dei meccanismi rappresentativi,
spettacolari) , si fa più chiaro il parallelismo tra Cosa Nostra e America.
Pacino fronteggia una commissione governativa, e poi l’azione si sposta a Cuba un attimo prima della rivoluzione, che travolge gli affari dei mafiosi.
All’ascesa del padrino segue qui la sua solitudine e ossessione, e all’America trionfante del dopoguerra quella degli incipienti anni sessanta.
Questi legami saranno messi in scena a loro volta, in una specie di copertura, nell’ultimo episodio, accettato controvoglia dal regista per
risollevarsi da una serie di rovesci economici. H film, che presenta singolari punti di contatto con il mafia morie italiano, è però anche un
autoritratto: la storia di un boss costretto a rientrare nel «giro», realizzato da un ex «boss» del cinema che ave\ra tentato la scalata a Hollywood, è
stato sconfitto, e proprio per ripianare i propri debiti ha accettato di girare il film.
Assai più che nei due lavori precedenti, però, il cuore del film è iTtalia,
anzi la Sicilia. Nel tempo trascorso dal secondo episodio, ci sono una feroce guerra di mafia, un maxiprocesso di risonanza intemazionale, una
serie di omicidi eclatanti di personaggi noti (da Roberto Calvi a Michele
Sindona). L’Italia non è più il luogo della nostalgia etnica, ma il teatro del potere contemporaneo. Michael Corleone vuole uscire dal giro e mettersi in affari con il Vaticano attraverso una società detta «Immobiliare» 15 . L’escalation finale è un’autentica apocalisse che scorre in parallelo con la rappresentazione, a Palermo, della Cavalleria rusticana di Mascagni16. Un finale che riassume tutto il cinema politico italiano e lo supera
iperbolicamente nelle sue vocazioni «melodrammatiche»: «Siamo in Sicilia. È l’opera», dice un personaggio. In quest’ecatombe sono
riconoscibili la morte per avvelenamento di Giovanni Paolo I (unico chiamato per nome), quelle di Calvi, di un arcivescovo che somiglia molto a Marcinkus e del politico Lucchesi, combinazione di Gelli e Andreotti (e
viene citato il motto «Il potere logora chi non ce l’ha»). La fine del Padrino e la sua vendetta si intrecciano, in un caos assoluto in cui l’unico a restare
in piedi è proprio lui, anche se la sua sopravvivenza è una condanna1 .
2. Padrini veri e immaginari.
Ma il rapporto tra il film di Coppola e Cosa Nostra non si esaurisce nel
testo. Realtà e rappresentazione (e auto-rappresentazione) si intrecciano in un arcipelago che è indispensabile da indagare: i riferimenti alla realtà
di Cosa Nostra americana prima, durante e dopo la realizzazione del film; la reazione delle lobby italo-americane all’epoca; l’identificazione dei veri
mafiosi (anche italiani) con personaggi ed eventi del film; l’influenza sul
cinema e sui media italiani. Sui vari momenti in cui II padrino incrocia la criminalità organizzata 18
reale fiorisce una ricca aneddotica . All’epoca della lavorazione del film uno dei produttori, Al Ruddy, trattò con l’influente Italian-American Civil
Rights League, garantendo che nel film non ci sarebbe stata la parola «Mafia» . A negoziare per l’associazione, rivelò il «New York Times»,
c’era il figlio di Joseph Colombo, fondatore dell’associazione e mafioso appartenente alla famiglia di Joe Profaci
20
. Inoltre Sidney Korshak,
avvocato di molti mafiosi italo-americani, avrebbe «sbloccato» l’ingaggio 21
di Al Pacino
e si narra che l’attore Vie Damone avesse rinunciato al ruolo
del cantante (ispirato a Frank Sinatra) dietro pressione di ambienti legati 22
alla malavita . Il padrino, come detto in precedenza, avrà in Italia un’influenza
immediata. Negli anni dei due film di Coppola escono fra l’altro Crazy Joe di Carlo Lizzani, Lucky Luciano di Francesco Rosi, La padrino di
Giuseppe Vari, Damico del padrino di Frank Agrama (futuro socio di
Silvio Berlusconi e coinvolto nel processo Mediaset), e più avanti Corleone di Pasquale Squitieri, senza contare le parodie (IZfiglioccio del Padrino,
L'altrafaccia del Padrino). Ma l’influenza più consistente si ha forse nel cinema poliziesco, con una nuova ondata di gangster movie a partire da H boss di Fernando Di Leo e II consiglieri di Alberto De Martino. Più duratura è stata però l’influenza del film sull’auto-rappresentazione
di Cosa Nostra. Non si contano le storie di boss che, dopo il film,
ripetevano mosse e atteggiamenti di Marion Brando. H mafioso Salvatore «Bull» Gravano ricorda: «Forse era una finzione, ma non per me: era la
nostra vita... E non solo i delinquenti, gli omicidi e tutte quelle cazzate, ma
quel matrimonio all’inizio, la musica e il ballo, eravamo noi, gli
. Joe Bonanno, nel libro-intervista di Gay Talese Onora il
italiani!»
padre, mostra di apprezzare il libro di Puzo, di cui coglie i riferimenti alla città di Corleone e a don Vito Genovese, e certe somiglianze con un
mafioso di sua conoscenza, Thomas Lucchese . Nel 1976, a Montreal, il mafioso Pietro Sciarpa venne ucciso a San Valentino come la strage di Al
Capone, all’uscita del cinema come Dillinger, guardando per di più Coppola'25 . Un giornalista americano ricorda che dopo il film di Coppola
gli investigatori locali e quelli federali addetti alla sorveglianza dei mafiosi potevano osservare affiliati e aspiranti tati che imitavano le movenze e il linguaggio dei gangster sullo schermo. Alle feste e ai matrimoni suonavano ininterrottamente la colonna sonora del film, come se fosse il loro inno nazionale privato*6* .
Questo vale anche per l’Italia. Luciano Liggio, nelle sue apparizioni ai
processi, assumeva un atteggiamento simile a quello di Brando nel film di 27
28
Coppola . Buscetta stesso pare fosse un fan del film
. Quando Giuseppe
Greco, figlio di Michele Greco «il Papa», offrirà nel film I Grimaldi un idealizzato ritratto del padre, farà truccare l’attore che lo interpreta in maniera identica a don Vito Corleone, e userà lo stesso doppiatore. Una
leggenda locale vuole che il capomafia del mio paese, Antonino Mineo, dopo l’uscita del film di Coppola, avesse preso a farsi chiamare anche lui
«padrino», qualifica fino allora sconosciuta all’interno di Cosa Nostra. Questa retro-azione tutt’altro che occasionale è orgogliosamente confermata da Puzo stesso: «Prima che la usassi io, nessun mafioso aveva
mai usato la parola “padrino” in quel senso. [...] Ora la mafia la usa. La . 29
usano tutti» .
3. H documentario promiscuo di Martin Scorsese. Un anno e mezzo dopo II padrino esce Mean Streets - Domenica in
Chiesa, lunedì all'inferno, piccolo film indipendente di un regista un po’ più giovane di Coppola, Martin Scorsese. Il film ovviamente non ha la
stessa eco, eppure inaugura una modalità di racconto destinata a fare
scuola. Nei suoi film, Scorsese articola una serie di elementi in tensione: uno stile vistoso, barocco, virtuosistico; una cultura cinefila a volte
esplicita, a volte in sottofondo; l’uso continuato e spiazzante della musica
pop e rock; un cattolicesimo con venature quasi esistenzialiste. All’epoca la critica Pauline Kael sintetizzò con intuito fulmineo: «La musica, i film e la chiesa. Una pozione da streghe»
.
In Scorsese la componente autobiografica e la forza di uno sguardo
interno emergono con forza ancora maggiore che in Coppola. La famiglia del regista veniva dalla Sicilia occidentale (padre di Polizzi Generosa, madre di Ciminna), e di origine proletaria, mentre i parenti di Coppola
erano borghesi e artisti lucani, e il nonno era il noto compositore
napoletano Francesco Pennino. Scorsese, insomma, più di Coppola cresce a diretto contatto con la cultura di Little Italy’, e conosce i suoi mafiosi .
Se Coppola arriva a raccontare la mafia italo-americana su commissione, e
solo in un secondo momento la trasforma in una complessa auto
rappresentazione collettiva, Scorsese parte dal proprio vissuto personale, influenzato dalla nuova soggettività delle nouvelle vague.
L’elemento autobiografico è evidente soprattutto in Mean Streets, i cui
personaggi sono costruiti su amici e conoscenti della Little Italy anni
sessanta ; la stessa voce over che ascoltiamo all’inizio appartiene al regista, che compare (come spesso gli capita) in un piccolo ruolo. Pellegrino D’Aciemo, per descrivere l’operazione smitizzante del film
(definito «un intermezzo farsesco tra i primi due magistrali atti della tragedia familiare dei Corleone») , ha efficacemente usato la nozione bachtiniana di carnevalesco e quella di sincope, nel triplice senso narrativo
(ellissi), fisico e musicale. Mean Streets racconta le vite di due giovani di strada a Little Italy, ispirandosi alla storia di alcuni coetanei del regista: lo
sregolato Johnny Boy (Robert De Niro) e Charlie (Harvey Keitel), nipote di un boss, cattolico tormentato e appassionato di cinema, che è quasi un alter ego del regista. La mafia è una presenza laterale ma onnipresente, e
in fondo questa rimarrà una costante nel cinema di Scorsese. I suoi titoli successivi, infatti, utilizzano il mondo mafioso spesso in maniera indiretta, come in Toro scatenato , e quando raccontano le storie di mafia
indugiano sulle figure di semplici soldati (Quei bravi ragazzi), di infiltrati
(The Departed) o di imprenditori collusi (Casinò). Il protagonista-tipo di
Scorsese non è insomma il boss, ma la figura defilata, insieme dentro e fuori. Nei due film di più precisa ambientazione mafiosa, Quei bravi ragazzi e Casinò, anche l’ambiente italo-americano è \dsto come un
ingrediente forte ma insieme ad altri: protagonista del primo film è un «soldato» che non potrà mai diventare boss in quanto mezzo irlandese, nel secondo il gestore ebreo di un casinò di proprietà di mafiosi. Anche
nell’ultimo The Irishman, che pure ha come protagonista un killer, fin dal titolo si sottolinea l’appartenenza solo parziale del protagonista al mondo della mafia italo-americana.
Dopo quasi venfanni, con Quei bravi ragazzi, Scorsese toma comunque ad affrontare, in maniera ancora più diretta che in Mean
Streets, il mondo della mafia italo-americana. Si tratta di un racconto di formazione che attraversa tre decenni, dai cinquanta agli ottanta,
seguendo la traccia del libro di Nicholas Fileggi Wiseguy, basato sulle confessioni di Henry Hill, membro della famiglia mafiosa dei Lucchese °.
All’affresco storico si sostituisce una cavalcata convulsa, esaltata dal progressivo consumo di cocaina. La sincope e la paranoia, presenti fin
dall’inizio, trionfano nella parte finale. Ma è tutto lo stile del film a utilizzare, in maniera sorprendente, lo stile della modernità
cinematografica (da Truffaut a Fellini) per raccontare l’ascesa e la caduta del criminale. Un mondo, quello di Henry- Hill, che non va raccontato più
col passo ieratico di Coppola, ma come un viaggio allucinato: «Scoprii che era possibile comprimere le scene, per cui si poteva assistere a una cerimonia di matrimonio per poi saltare direttamente alle conseguenze
dell’unione [...]. Era un costante accumularsi di questi dettagli, e capii che
se si manteneva questa brevità delle scene, l’impatto dopo un’ora e mezza sarebbe stato devastante»
36
.
La specificità del film consiste nella compresenza tra ima prossimità ai
personaggi e al loro ritmo, e quello che Scorsese ripetutamente definisce
atteggiamento «documentario»: Quei bravi ragazzi in un certo senso è un documentario; e anche Casinò. È questo che li differenzia dal Padrino. Mi piace moltissimo la trilogia del Padrino (soprattutto U padrino parte n), ma lì si tratta di una sorta di epopea mitologica. So che molti gangster sognano di essere come Marion Brando, ma in realtà non sono
affatto cosi . Come sempre desideravo uno stile fluido, ma in più volevo che assomigliasse a un documentario di cinéma-vérité (come quelli di Al e Dave Maysles) su queste persone, lungo un periodo di venticinque anni, con la capacità di entrare e uscire dalle situazioni con le cineprese. [...] L’uso dei fermi-immagine derivava dall’influenza di Jules e Jim per un verso, e per l’altro dall’uso che se ne fa nei documentari . «Documentario» indica in questo caso la precisione nella ricostruzione del dettaglio, e soprattutto una strategia immersiva che garantisce una prospettiva interna, e il confronto con gli strumenti della modernità
filmica. «Documentario» è il contrario di uno sguardo oggettivo: piuttosto, è una prossimità che cerca di rendere la percezione del tempo e dello spazio di un tipo di mafioso (di uomo) contemporaneo. E proprio questa
prossimità rende fondamentale un cambio nella fecalizzazione del racconto. La voce narrante'"9, che dapprima appartiene a Henry Hill, a un
certo punto trovra un elemento di contraddizione interna in quella della moglie Karen. Figura estranea al mondo narrato (donna, e per giunta ebrea), la sua presenza permette di spostare la prospettiva. La voce di
Karen entra in scena a mezz’ora dall’inizio, e costituisce un contrappunto al mondo dei mafiosi italo-americani (come nella scena del matrimonio, in
cui le presentano una serie di parenti che si chiamano tutti Peter e Paulie, o nella descrizione delle altre mogli dei mafiosi). È lei a spiegare
l’articolazione interna della famiglia, a raccontare la quotidianità, a
parlare di vacanze e perquisizioni. In un certo senso, è lei il tramite
decisivo del «documentarismo» di Scorsese. H suo sguardo è particolarmente ricco perché è esterno ma progressivamente si integra, e
dunque permette di avvicinarci gradualmente a una perversa «normalità». Lo stesso uso dell’apparato culturale «diventa accessorio ed
ornamentale: il culto della cucina italiana, l’ossequio alle consuetudini familiari, i doveri stabiliti dai vincoli parentali, la devozione cattolica e la frequentazione parrocchiale. Tutte balle!»40. Il cattolicesimo è più sullo sfondo rispetto a Mean Streets, ma rimane evidente nello schema di
caduta e (beffarda) redenzione. H film, del resto, viene dopo L'ultima
tentazione di Cristo, che, a vederlo oggi, mostra la passione di Gesù come
se la immaginerebbero i mafiosi interpretati da Ray Liotta o Harvey Keitel. Come Quei bravi ragazzi, anche Casinò comincia in medias res, nel 1983, con l’attentato all’auto di Sam Rothstein (De Niro), gestore-ombra
di un casinò di Las Vegas coi soldi della mafia, per poi risalire a dieci anni prima, tornare al punto iniziale, e proseguire verso il delirio finale. H
protagonista è appartenente alla cosiddetta aria grigia dei «concorrenti esterni»41. Anche qui, alla base c’è ima storia vera di Frank «Lefty»
Rosenthal, che collabora alla scrittura del film con Scorsese, De Niro e Fileggi, il quale contemporaneamente ne ha tratto un libro42.
Rispetto a Goodfellas, la mafia è meno centrale, come la religione. Anche se Las Vegas viene paragonata a Lourdes, e all’inizio risuonano le note della Passione secondo Matteo di Bach, si tratta del film più laico e
materialista di Scorsese. Senza romanticismi e mettendo da parte la prospettiva antropologica, qui il regista parla di denaro, di funzionamento
dell’economia. E lo spirito «documentaristico» è ancora più evàdente: i
primi venti minuti di film mostrano quasi didatticamente il funzionamento del microcosmo del casinò, attraverso il consueto incrocio
di voce over, movimenti di macchina, musica e montaggio. Più che negli altri film, la divisione tra mondo legale e criminale sfuma.
Se H padrino parte n descriveva già in maniera chiara la mafia come
allegoria del capitalismo americano, Casino completa in maniera sociologicamente minuta l’analisi. Contemporaneamente, in altri film di
quegli anni Scorsese sta ampliando l’osservazione delle dinamiche, familiari, di clan e criminali italo-americane, sviluppando uno sguardo
archeologico ed etnologico più vasto: e non solo per quell’eziologia delle
gang che è Gangs ofNew York, ma forse ancor di più per quell’analisi dei codici e della violenza sotterranea di un dan al centro del film precedente a Casinò, L'età dell'innocenza. Nel ritorno al mondo della mafia con The Irishman43, i toni si faranno invece crepuscolari. La storia è quella del braccio destro del potente leader
sindacale Jimmy Hoffa (Pacino), il killer Frank (DeNiro). Siamo tra la fine degli anni cinquanta e gli anni novanta, sul consueto tappeto sonoro di canzoni d’epoca e trasportati da movimenti di macchina avvolgenti. Ma la
frenesia dello stile, che esprimeva la prossimità a un mondo, l’identificazione allucinata e la resa da dentro della follia lasciano il posto a
un senso di stanchezza. Gli attori sono ormai anziani e, nonostante la ricostruzione dei volti grazie alla computer graphic, lo si sente quando interpretano i personaggi da giovani, bolsi e affaticati. Il racconto si
amplia, intreccia la Baia dei Porci o la guerra in Kossovo: non autoanalisi, ma Storia. I protagonisti non sono più dei doppi perversi del regista, hanno dismesso il pathos e la paranoia, non hanno neanche più il peso del
rimorso e del pentimento, e le donne si limitano a guardarli capendo e a
volte giudicando. Su tutto aleggia il fantasma della vecchiaia: fin dalla
prima scena, un lungo movimento di macchina in un ospizio sulle note di In the Still of the Night, Scorsese racconta la disillusione, la fine di ogni
epica del crimine, per quanto nevrotica.
Senza lo stile di Scorsese non sarebbero concepibili i primi film di
Quentin Tarantino, e i montage di omicidi e musica sono stati replicati
innumerevoli volte, specie con connotazioni vintage (da Sos Summer of Sam di Spike Lee a Black Mass - L'ultimo gangster, di Scott Cooper). I mafia movie «alla Scorsese» non si contano, e a volte hanno prodotto esiti
molto alti, come Donnie Brasca di Mike Newell, ispirato alla vicenda di Joe Pistone, infiltrato della polizia nella mafia newyorchese, che smonta ogni mitologia eroica o anti-eroica mostrando un mafioso della famiglia
Bonanno (Al Pacino) perdente e in fondo ingenuo, e sul fronte opposto
l’operare cinico delle forze di polizia. Ma Scorsese è anche all’origine della maniera di rappresentare la criminalità organizzata nei media italiani contemporanei. È evidente il calco scorsesiano di produzioni come
Romanzo criminale (film e serie), Gomorra (serie), Suburra (film e serie).
La maggiore novità del mafia movie italiano degli anni novanta sta anzi
proprio nell’abbandono del modello del «cinema politico» nazionale e nell’adozione dello stile del gangster movie americano moderno.
4- H nero di Ferrara.
Assai meno noto dei film di Coppola e Scorsese è un altro titolo
fondamentale, forse il più radicale nella critica al mondo della mafia, il
meno sedotto dal mondo narrato. Fratelli di Abel Ferrara si chiama in originale più coerentemente The Funeral, e si svolge per l’appunto durante la veglia funebre di un mafioso italo-americano, in una New York
dai tratti indefiniti. Anche lo sfondo etnico è in secondo piano, pur se in
più momenti i personaggi parlano in italiano o in dialetti del Sud (siciliano o napoletano), accennano a prodotti tipici (i pinoli) e per tutto fl film echeggia la canzone II primo amore cantata da Carlo Bufi.
In questo film, narrato dall’interno in maniera quasi claustrofobica, l’unica tonalità è quella del tragico. Al posto della molteplicità stilistica di
Scorsese e dell’ampiezza storico-epica di Coppola, si ha la monocromia del nero, la quasi assenza di movimenti di macchina e la progressiva messa fuori campo di gran parte dei dati storici e antropologici
.
Questa scelta permette di isolare un elemento psicologico ed etico: il rapporto non tanto con la religione cattolica, come in Scorsese, ma con
un’ideologia che del cattolicesimo si nutre. Il rapporto tra religione e mafia non era mai stato indagato in così chiaro collegamento con l’aspetto
luttuoso e negatore della vita. Quello di The Funeral è un mondo a lutto, dominato dalla morte. Una bara apre il film, una bara lo chiude.
All’interno, la storia di tre fratelli, piccoli gangster degli anni trenta, e delle loro famiglie. Johnny Tempio (Vincent Gallo) è stato ucciso, e a vegliarlo
sono gli altri due fratelli, Ray (Christopher Walken), deciso a vendicarsi, e
Chez (Chris Perm), osservati con timore e sgomento dalle mogli (Isabella Rossellini e Annabella Sciorra), mentre in flashback ripercorriamo episodi tragici della loro vita. A gestire e patire il lutto sono le donne: ma questo
lutto alla fine si ribalta nel proprio contrario, rivelandosi una (vana) forza
di resistenza al cupio dissolvi maschile. E il finale, con tutti i maschi morti, avrà un paradossale valore catartico . Tanto che alla fine Chez, il fratello
più sensibile anche perché mentalmente più disturbato, non si accontenta di uccidere i riri, ma spara anche al morto, lo ri-uccide simbolicamente;
cerca insomma di uccidere la morte.
Tutte le vicende, nei diversi piani temporali, non ruotano intorno ad altro che alla morte. L’unione tra cultura mafiosa e cultura di morte è stata
spesso affrontata dagli studiosi, magari in chiave antropologico-
psicoanalitica, e con l’evidente rischio di derive interpretative. Ma l’importanza del tema era stata fulmineamente delineata anche da
Giovanni Falcone:
«Fratello, ricordati che devi morire» d insegna la Chiesa cattolica. H catechismo non scritto dei mafiosi suggerisce qualcosa di analogo: il rischio costante della morte, lo scarso valore attribuito alla vita altrui, ma anche alla propria, li costringono a vivere in stato di perenne allerta. [...] La certezza della morte vicina, tra un attimo, una settimana, un anno, pervade del senso di precarietà ogni istante 46
della loro vita . H film si snoda in un incastro di tempi, che si chiudono tutti su un destino presente di morte. H primo flashback arriva dopo un po’ più di
mezz’ora di film, e descrive l’iniziazione all’omicidio del tredicenne Ray, il
fratello maggiore, da parte del padre. Seguono altri quattro salti all’indietro, due dei quali si aprono a loro volta a un ulteriore flashback
Prima vediamo il percorso di sindacalista comunista di Johnny, ma anche la sua vita sregolata di puttaniere e rapinatore; in un altro flashback lo
rivediamo uscire dal cinema; poi c’è una scena al bordello, in cui fra l’altro
il fratello Chris cerca di redimere una prostituta e, davanti alle esitazioni
di questultima, la uccide (e lì vediamo, in un ulteriore salto indietro, il
giovane Chez davanti alla bara del padre). Infine, sul finale, torniamo per la terza volta all’uscita del cinema dove viene ucciso Johnny, e vediamo la
sua morte, per poi tornare all’iniziazione di quest’ultimo, e infine a una 47
scena dei tre fratelli che cantano insieme in un bar . In The Funeral i personaggi si confrontano in maniera diretta con lo sfondo etico che fa da scelta al loro agire. Ferrara e lo sceneggiatore Nicholas St John ci introducono in un mondo di violenza e di morte, che
appare tale anche grazie alle figure femminili. Nei dialoghi, i personaggi
esplicitano il sottofondo di cupa negazione che guida le loro azioni e il loro modo di vita, e questo concetto viene incarnato nel film in una peculiare
scelta visiva che presiede ai controcampi, specie nei dialoghi tra Walken e la moglie Annabella Sciorra: alle spalle di lei c’è una luce calda che
illumina le cose, mentre il volto di lui si staglia come un teschio su un
fondo nerissimo. Quando Sciorra gli chiede di pregare per loro, il prete (interpretato da
un vero sacerdote) ribatte pacatamente: - Sarò sincero: l’unico modo in cui qualcosa possa cambiare, è un completo
capovolgimento della vita di questa famiglia. Non mi riferisco solamente all’andare in Chiesa: è l’ateismo pratico che tutti voi vivete ogni giorno. - La mia famiglia crede in Dio. - Non credo che nessuno di voi sia tanto umile da credere in Dio.
La tragedia dei personaggi si esprime in un paio di scene con
Christopher Walken: il monologo sulla bara del fratello, in cui racconta al defunto di non essere mai riuscito a credere che la gente muoia, e il
dialogo sul libero arbitrio, con Annabella Sciorra (il personaggio femminile più consapevole nella sua opposizione alla logica di morte):
- Se io faccio qualcosa di sbagliato, è perché Dio non mi dato la grazia per fare dò che è giusto. Nulla succede senza il suo permesso, per cui se questo mondo fa schifo... è colpa sua. Io posso lavorare con quello che mi ha dato lui. - Così se uno finisce con tre proiettili nel cranio è colpa di Dio. Ma non ti
vergogni? Dopo l’uscita di scena di Walken, il dialogo prosegue tra Sciorra e la fidanzata del fratello appena morto: - Lo sai che dovremmo dare una festa per te in questa circostanza? Bisognerebbe festeggiare il fatto che non diventerai una delle loro mogli. Ai Tempio piace spacciarsi per dei personaggi unici, tutti d’Un pezzo, e noi d caschiamo. Ma sono criminali. Sono criminali perché non si sono mai tirati fuori dall’ignoranza e dalla ferocia del loro ambiente. E non c’è niente, assolutamente niente di romantico in
tutto questo. Guarda come stanno affrontando la morte di Johnny. Mai un solo pensiero d’amore per il fratello gli è venuto in mente. Anche se ha influenzato direttamente o indirettamente, per loro stessa ammissione, l’estetica di molti registi (Anime nere di Francesco Munzi o
Angela di Roberta Torre), il film non ha avuto particolare risalto in Italia.
Il che è abbastanza sorprendente, se consideriamo che cadeva in un momento di grande attenzione degli studiosi al ruolo delle donne e della
religione all’intemo della mafia. L’omicidio di don Pino Puglisi nel 1993 48
avevra rimesso al centro l’importanza del ruolo della Chiesa
; nel 1994,
era apparso l’importante studio di Renate Siebert Le donne, la mafia,
mentre erano già attive la rivista «Mezzocielo» (dal 1991) e la casa editrice
La Luna (dal 1987), animate da un gruppo di intellettuali e femministe, e la rivista «Segno», diretta dal padre redentorista Nino Fasullo.
Proprio su «Segno», nelle -settimane in cui usciva in Italia il film di Ferrara, Fasullo chiariva in un editoriale (Una religione mafioso) alcuni 49
elementi che illuminano involontariamente il film . «Per un fenomeno
come la mafia - scrive Fasullo - privo di giustificazione intellettuale, la religione può essere considerata l’unico apparato ideologico cui fare
riferimento»5° . La religione dei mafiosi è proprio quella che Ferrara ci racconta nei deliranti monologhi di Chris Perni prima di sodomizzare la
prostituta, e di Walken prima di uccidere il presunto killer del fratello.
Prima di agire, i personaggi di The Funeral riflettono e parlano, ma girando a vuoto. La loro è una hybris nichilista: più che carità, desiderio di salvare una ragazzina debole o un giovane impulsivo, è in azione una
voluttà di essere Dio, una sfrenata volontà di potenza che cela un impotente feticismo di morte. Scrive ancora Fasullo:
Per un mafioso Dio non è un problema. Non trova Dio al termine di una ricerca travagliata. Il mafioso Dio ce l’ha alle spalle. Non arriva ma parte da Dio. (I mafiosi] al Dio della religione credono solo in quanto lo imitano, lo eguagliano, si pongono al
suo livello. Espressioni come «io sono il tuo Dio», «rendi conto a me come rendi conto a Dio» sono rivelatrici Un uomo, infatti, può sopprimere un altro uomo solo perché ritiene che al suo posto Dio farebbe la stessa cosa01. Pistola alla mano, Christopher Walken intima al ragazzino di confessare l’uccisione di suo fratello, proprio come davanti a Dio: «The Way God Sees It». Inconcepibile è in questa prospettiva il Cristo
evangelico, l’idea della redenzione e del perdono. Ferrara, in 71 cattivo
tenente, aveva già mostrato la contraddizione tra logica del perdono e
realtà violenta, ma già King ofNew York seguiva anch’esso un percorso di paradossale ricerca di redenzione. Qui, svanita ogni prospettiva di redenzione, resta la sola logica autodistruttiva, mentre lo stile passa da un
certo barocchismo dei film precedenti a una assoluta imperturbabilità, capace di rendere come mai prima l’aspetto nichilista della cultura mafiosa:
La Wdtanshauung mafiosa - e in essa la Gottanschauung - è immersa in un’atmosfera lugubre. È come se fosse stata battezzata, prima di riemergere, in una pozza nera. Sì: il nero, appena striato di grigio, è il colore dominante di questo scenario senza spiragli di luce sull’oggi né, ancor meno, sul futuro. Uno scenario serioso, non serio; rigido, non rigoroso; luttuoso, non austero. Uno scenario che avverte come inopportuno, peccaminoso, meritevole di divine punizioni ogni atteggiamento - mentale e pratico - di fiducia nella vita e di fruizione dei suoi doni0*.
Se il film sembra vedere nella sceneggiata o nel noir un erede della
tragedia, è perché intuisce che la tragedia moderna può meglio essere tragedia dei criminali e dei reietti che degli intellettuali o della classe media. Il discorso prende forza da una visione più generale, condivisa con
lo sceneggiatore St. John, amico d’infanzia di Ferrara e fervente cattolico. The Funeral è anche un film gemello del precedente, The Addiction, altra diagnosi di un «disagio della civiltà» che addirittura utilizzava le
convenzioni del film di vampiri per discorsi di teologia morale nel tempo di Auschwitz. La precisione, anche antropologica, di Ferrara e St John è sfuggita a molti o è parsa incongrua perché il «sentire mafioso» è in The Funeral anche una forma reale e contemporanea di sentire tragico: il
mondo mafioso, diceva qualche anno prima Gio\ranni Falcone, appunto «è
oscuro e tragico», e le donne hanno qualche possibilità di salvarsi, perché
sono diventate in certo modo «il simbolo di quanto c’è di ritale, gioioso e piacevole nell’esistenza»53. In questo senso il film di Ferrara, in maniera involontaria, dice allo spettatore italiano qualcosa sugli anni novanta,
assai più di quanto non evochi gli anni trenta americani in cui è ambientato.
5. Not with a bang but a whimper. Tony Soprano mafioso postmoderno. Molto si è scritto, fin dalla sua prima stagione, sulla serie televisiva I
e trasmessa dal canale Hbo in sei
Soprano, creata da David Chase
stagioni dal 1999 al 2007. Si tratta di uno dei prodotti più importanti e più analizzati della televisione di ogni tempo, apripista di una ricchissima stagione di serialità che dura ancora oggi. Qui ci limiteremo a chiarire la visione di Cosa Nostra che ne emerge, specie in relazione con la tradizione cinematografica precedente. Salta agli occhi intanto la natura auto-consapevole, metatestuale della mafia: da parte degli autori, ma sinché dei personaggi. Non solo la serie propone in maniera chiara, fin dalla prima puntata, un confronto diretto con vari predecessori cinematografici a cominciare da Martin Scorsese,
ma gli stessi personaggi si rifanno continuamente a modelli precedenti di
rappresentazione della mafia italo-americana. Nel cast sono presenti ben 27 attori che avevano partecipato a Quei bravi ragazzi: nei ruoli principali Lorraine Bracco, Tony Sirico, Frank
Vincent e Michael Imperioli. L’ombra di Scorsese è presente in tutta la serie, fino all’apparizione di un sosia del regista, e il mafioso cinefilo Christopher ne cita un titolo, ma il meno prevedibile: «Kundunl I liked iti» («46 Long», stagione 2, ep. 1). Numerosi i riferimenti a Coppola, fin
dall’episodio pilota in cui Silvio Dante (Steve Van Zandt) imita Al Pacino nel Padrino parte HI («Proprio quando pensavo di esserne fuori... mi rimettono in mezzo»), e più indietro le radici della serie affondano nei
classici gangster morie degli anni trenta, a cominciare da Nemico Pubblico
di William A. Wellman00 e da Scarface di Howard Hawks. Va poi
accennata, alla base della serie, l’importanza di una serie di film che negli anni ottanta e novanta hanno raccontato la mafia in maniera più o meno
smitizzante, senza il pathos epico o tragico di Coppola e Scorsese, e a volte
concentrandosi sui legami familiari e con toni da commedia nera: L'onore dei Prizzi di John Huston, Una vedova allegra... ma non troppo di
Jonathan Demme, ma anche Donnie Brasca di Mike Newell.
L’universo cinematografico in cui sono immersi i personaggi non si
limita però al cinema di gangster. Le citazioni e i riferimenti costituiscono una complessa triangolazione tra autore, spettatori e personaggi; o meglio, tra autore, personaggi e diversi ordini di consapevolezza degli spettatori,
giacché il prodotto si rivolge a un pubblico che può apprezzare a diversi 56
livelli i riferimenti . H culmine della dimensione intertestuale della serie è raggiunto nella sesta stagione, in cui seguiamo il percorso di Chris Moltisanti, ideale
figlioccio di Tony Soprano, che decide di lanciarsi nel mondo del cinema,
trasfigurando il proprio mondo in un horror, Cleaver (La mannaia)
(definito «Saw meets The Godfather n» o «The Ring meets The Godfather»), in cui un mafioso viene fatto fuori dal boss e toma come una
specie di zombi o di Frankenstein per vendicarsi. «Io ti ammazzo. Cosa fai, fai Henry Hill con me? Sai quanta gente della mala vende copioni
mandando tutto a puttane?» minaccia Tony Soprano all’annuncio della sceneggiatura di Christopher, con riferimento al protagonista di Quei bravi ragazzi. Alla fine il cattivo del film risulterà appunto una versione
grottesca di Tony, il quale rimane molto irritato («Stage V», stagione 6, ep.
79). Nella stessa stagione, il figlio di Tony entra a far parte del mondo del .
.
.
.57
cinema attraverso il mafioso Carmine Lupeitazzi . Lo spunto iniziale della serie è il fatto che il boss Tony Soprano (di
nascosto dai suoi sodali) va in analisi per curarsi dei periodici attacchi di panico, sintomi di una vita sull’orlo del collasso. Quasi contemporaneamente, la tro\rata veniva usata in chiave comica da Terapia e pallottole di Harold Ramis (che esce nelle sale americane durante la
messa in onda della prima serie), ma nei Soprano essa diventa il
catalizzatore di un approfondimento psicologico sempre maggiore: il rapporto con la dottoressa Melfi, italiana completamente diversa da Tony,
innesca un complesso incastro di punti di vista, di prossimità e ripulsa, da parte dello spettatore (che si suppone sia più ricino alla dottoressa die al
mafioso). Anche i sogni, presenti in molti episodi (fino al \drtuosistico «Join the Club» e «Mayham», stagione 6, epp. 66-67, lunga visione onirica di Tony Soprano in coma), creano un’atmosfera di instabilità *8
nell’identità del protagonista0 . Una delle innovazioni più importanti della serie è il suo carattere di
narrazione di una crisi. Tradizionalmente quello del gangster era un percorso di rise andfall, e se già 11 padrino correggeva questa prospettiva
in una chiave di trasmissione del potere, di trapasso dal vecchio al nuovo, I Soprano racconta anzitutto la difficoltà di mantenere il potere. In questa chiave, per Tony non vale la definizione classica di Robert Warshow
del
gangster come eroe che, a differenza dell’uomo del West, comincia da
zero, senza passato. Tony deve anzitutto faticosamente tenere insieme i pezzi: della famiglia, dell’organizzazione mafiosa, della propria psiche.
La definizione più precisa di questo percorso è forse lo hollowing, 60
secondo le parole di David Pattie
: un processo in cui le relazioni tra i
personaggi si svuotano e inaridiscono. Il che contribuisce anche a una radicale de-eroicizzazione della figura del criminale. Questo si traduce, dal punto di vista della narrazione, in un aumento della casualità e
dell’imprevisto: «Nei Soprano, gli effetti possono avvenire e avvengono senza cause», cosicché la sua narrazione non porta alla catarsi dei film di
Scorsese e Coppola, ma al «vuoto freddo e silenzioso» . Ugualmente destrutturato e «debole» è il rapporto dei personaggi con le proprie radici etniche, sulle quali si ironizza, anche attraverso il
confronto tra la generazione di Tony, ancora para-scorsesiana nei legami
con la madrepatria, e quella dei figli Meadow e Anthony Jr. I Soprano
faranno a un certo punto un riaggio in un’Italia sognata, da cartolina, che
mostrerà tutta l’artificiosità della costruzione identitaria «italiana» e la 62
loro distanza effettiva da quel mondo .
Ci troviamo dunque a un livello di scomposizione dell’identità del personaggio ulteriore rispetto al cinema di Coppola, Scorsese, Ferrara;
tutti, peraltro, titoli presupposti dalla serie. Dalla saldezza del primo
Padrino al chiarimento di prospettiva storico-politica nel secondo; dal
misto di testimonianza interna e nervosa sensibilità moderna di Scorsese
alla netta condanna della prospettiva tragica di Ferrara: David Chase tira le fila di tutto questo. I personaggi sono letteralmente de-costruiti di
puntata in puntata; il paesaggio mediale compone e popola le loro vite e la
percezione che ne viene offerta allo spettatore. Siamo, si direbbe, in piena
età postmoderna. Ma con la volontà di creare comunque una forma non esplosa, un grande romanzo popolare che agisca all’interno delle
convenzioni. Come trovando, o inventando, nel mezzo televisivo spazi che
un tempo erano stati del sistema hollywoodiano (e in parte della tv anni cinquanta). La famiglia, mito della saga del Padrino, collassa in una serie di
relazioni sadiche, masochistiche, riolente, omicide. Molto approfondita è
anche la scomposizione che Chase opera nell’ambito del gender. Tony è un
maschio italoamericano che si basa apparentemente su vecchi modelli, un patriarca. Ma intorno a lui viene descritto un mondo che lo rende completamente inadatto, sfasato. Si prenda il rapporto sadomasochistic©
con la madre, nutrito di sensi di colpa; quello con lo zio, che insieme alla madre progetta di eliminarlo; l’oppressione complice subita dalla moglie
Carmela; il rapporto di odio ambivalente, sottilmente incestuoso, con la sorella Janice, e quello di devozione, anch’esso attraversato da qualche erotismo, con la figlia Meadow. Ma anche la figura del mafioso
omosessuale Vito Spatafore, la cui esecuzione dà in pratica il ria alla guerra tra le bande, e l’accenno a pratiche poco ortodosse come il pegging
praticato da Janice a Ralph Cifaretto (e, ancora, la presunta omosessualità del figlio di Richie Aprile): tutto questo costituisce una costellazione
complessa, in cui il povero Tony si barcamena con difficoltà.
La struttura sofisticata e interna a una de-costruzione in termini di genre e di gender spiega in parte anche la modesta accoglienza della serie
in Italia, dovuta forse alla difficoltà di situare un prodotto del genere nella struttura della televisione italiana dell’epoca (ossia in una fase aurorale
della pay tv satellitare, e prima dell’arrivo del digitale terrestre). Come ha
ipotizzato il giudice Antonio Ingroia: Gli italiani sono disposti ad ammirare solo padrini forti e arcaid. Il boss mafioso può essere visto solo nella sua sacralità di potente malvagio. In Italia, è impossibile, inaccettabile, mostrarlo come una persona così comune, alle prese con problemi piccoli 0 grandi, familiari e psicologici [...] In Italia, Cosa Nostra è ancora un mondo separato. Gli americani sono diventati immuni dal fascino della mafia; per gli >63 italiani non è ancora così .
Tony Soprano è un eroe, certo: o meglio, è il classico anti-eroe in cui il pubblico americano proietta le proprie paure e i desideri, dal gangster morie classico a quello degli anni settanta. Ma il suo personaggio, grazie anche alle potenzialità offerte dalla lunga serialità, viene man mano smontato, sfumato, nel processo di hollowing.
Ciò crea un’ulteriore evoluzione nel grado di prossimità con il mondo
narrato, punto centrale del mafia movie americano. Tony Soprano è senza dubbio un personaggio col quale scatta l’identificazione da parte del
pubblico. Ma periodicamente si aprono squarci sulle sue debolezze e sui
suoi elementi di violenza e perfino di psicopatologia, veicolate soprattutto
dalle donne. Il personaggio della dottoressa Melfi serve a misurare e calibrare continuamente il rapporto con lo spettatore: attratta, anche
eroticamente, da Tony Soprano, la dottoressa è però soprattutto testimone del carattere squisitamente ideologico della sua visione del mondo, dei
suoi discorsi, di una narrazione di sé che faticosamente procede attraverso negazioni e rimozioni.
Carmela, la moglie di Tony, inizialmente appare come una vittima, e man mano emerge in maniera più ambigua, come donna complice, o
quantomeno in malafede. Ma questa descrizione è ovviamente riduttiva, perché una delle caratteristiche della serie è proprio il procedere avanti e
indietro dei personaggi, attraverso evoluzioni e arretramenti spesso imprevisti. Nel corso della terza stagione uno psicoanalista, il dottor
Krakower (Sully Boyar), analizza spietatamente il comportamento suo e indirettamente del marito: K: Deve fidarsi del suo impulso iniziale e prendere in considerazione l’idea di lasciarlo. Lei non potrà mai stare bene con se stessa. Non riuscirà a placare i sensi di colpa e di vergogna finché è sua complice.
C: Si sbaglia, non sono sua complice. K: Ne è sicura? C: Tutto quello che faccio è assicurarmi che abbia dei vestiti puliti e la cena pronta. K: Allora una definizione più precisa di «complice» sarebbe «assistente». Le chiedo scusa. C: Quindi lei pensa che io debba definire più chiaramente il mio ruolo, mantenere una certa non interiorizzare la mia... K: Cosa le ho appena detto? C: Di lasciarlo. K: Prenda solo i bambini, se non è troppo tardi, e se ne vada. C: Il mio parroco ha detto che io dovrei restare al suo fianco e aiutarlo a migliorare. K: E sta funzionando? Carmela non risponde. K: Ha mai letto Delitto e castigo di Dostoevskij? Non è una lettura facile, paria
della colpa e della redenzione. Penso che se suo marito si consegnasse, leggesse quel libro, riflettesse sui propri crimini per qualche anno in una cella, potrebbe redimersi C: Dovrei trovarmi un avvocato, un appartamento, accordarmi per il mantenimento dei figli... K: Lei non mi sta ascoltando. Non le chiederò dei soldi per questa seduta, perché non voglio prendere dei soldi sporchi di sangue. E non dovrebbe fario neanche lei Ma non potrà dire che nessuno l’aveva avvertita. Da quanto detto sopra, appare coerente, ma non per questo meno
coraggioso, lo sconcertante finale della serie, che sceglie di lasciare in •
•
•
•
•
. .
64
,
sospeso 1 personaggi, seppure m una situazione critica . Chase capovolge le regole del mafia morie e spiazza gli spettatori rifiutando loro ogni
consolazione, negando ogni percorso di redenzione o di apocalisse °. «This is the way the world ends/ This is the way the world ends/ This is the way the world ends/ Not with a bang but a whimper»: così T. S. Eliot
nei celeberrimi versi di (appunto) The Hollow Men .
Dopo II padrino Coppola fonda, insieme a William Friedkin, George Lucas e Peter Bogdanovich, la Directors Company, associata alla Paramount, che ha vita breve. Ma già dal 1969
cerca la propria indipendenza attraverso la American Zoetrope, che inizialmente produce film a basso costo (come L'uomo chefuggì dalfuturo di George Lucas) e poi si lancia in imprese rischiosamente sperimentali come il catastrofico Un sogno lungo un giorno. * J. Lewis, IfHistory Has Taught Us Anything... Francis Ford Coppola, Paramount Studios,
and The Godfather part I, H and m, in Francis Ford Coppola’s The Godfather Trilogy, a cura di N. Browne, Cambridge University Press, Cambridge 2000, pp. 23-35. 3 Nella scena del matrimonio iniziale, ad esempio, il padre di Francis, Cannine Coppola, dirige
l’orchestra, un cugino canta, e numerosi parenti sono usati come comparse (J. M. Jones, a cura di,
The Annotated Godfather. The Complete Screenplaywith Commentary on Every Scene,
Interviews, And Little-Known Facts, Black Dog and Leventhal, New York 2007, p. 40). Numerosi i dettagli, specie gastronomici, che Coppola inserisce nel film e che erano assenti nel romanzo: l’anice bevuto dal padrino, fatto in casa dal regista, i cannoli, o i contenitori di cibo cinese (ibid., pp. 68,98,119). Inoltre la sorella di Michael Corleone è interpretata dalla sorella del regista, Talia Shire. 4 Ricordiamo, oltre ad Al Pacino, Salvatore Corsrtto, Richard Conte, Al Lettieri, John Gazale, Al
Martino, Morgana King, Vito Scotti, Talia Shire, Richard Castellano, Gianni Russo, Lenny Montana
(di questi ultimi due si vociferava che fossero affiliati alla mafia), più Alex Rocco, che interpreta l’ebreo Moe Greene, e tutti gli interpreti della parte italiana del film: Corrado Gaipa, Simonetta
Stefanelli, Saro Urri, Angelo Infanti, Franco Cittì eccetera. La scelta causò proteste presso gli
Studios, e si racconta di manifestazioni del sindacato attori con cartelli recanti la scritta More
Advantages For Italian Actors (acronimo di Mafia)» (Jones, a cura di, The Annotated Godfather dt, pp. 150-1). Ora in Browne (a cura di), Francis Ford Coppola’s The Godfather Trilogy dt, pp. 180 e 181.
N. Moe, Il Padrino, la mafia e l’America, in Traffici criminali. Camorra, mafie e reti intemazionali delTiUegalitò, a cura di G. Gribaudi, Bollati Bc ringhieri, Torino 2009, pp. 325,339.
Cfr. J. Munby, Public Heroes. Screening the Gangsters from Little Caesar to Touch ofEvil, University of Chicago Press, Chicago 1999, pp. 39-65; D. E. Ruth, Inventing the Public Enemy. The
Gangster in American Culture, University of Chicago Press, Chicago 1996.
F. Jameson, Reificazione e utopia nella cultura di massa (1979), poi in Id., Firme del visibile.
Hitchcock, Kubrick, Antonioni (1992), a cura di G. PeduUà, Donzelli, Roma 2003, p. 40. s
V. Dika, The Representation ofEthniticy in The Godfather, in Browne (a cura di), Francis
Ford Coppola’s The Godfather Trilogy dt, spedalmente pp. 80 e 95. 1M. Puzo, I diari del Padrino, Dall’Ogho, Milano 1972, pp. 31-40; cfr. Lupo, Quando la mefia
trovò l’America dt, pp. 202-4. Ibid., p. 93. Sui nostalgia movies americani degli anni settanta si vedano F. La Polla, Il nuovo
cinema americano, Marsilio, Venezia 1975 (spede pp. 134-76); E- Morreale, L’invenzione della nostalgia. Il vintage nel cinema italiano e dintorni, Donzelli, Roma 2009, pp. 101-48.
Jameson, Reificazione e utopia nella cultura di massa dt, p. 37. Jones (a cura di), The Annotated Godfather dt, p. 91. Va ricordato che nella stessa epoca del
romanzo di Puzo un paio di libri piuttosto importanti, in America, avevano raccontato la mafia dal di dentro: le confessioni del pentito Joe Valachi, raccontate nel 1968 da Peter Maas, e in seguito le
memorie di Joe Bonanno raccolte da Gay Talese nel 1971. ' Per lo spettatore siciliano, poi, può avere un effetto spiazzante vedere il film in versione
originale. Il doppiaggio italiano, infatti, uniforma tutte le parlate in un italiano con inflessioni dialettali, mentre la versione americana è parlata in parte in inglese e in parte in un dialetto fedelmente riprodotto (il siciliano di De Niro è assai più verosimile di quello degli attori italiani, da Gemma a Volonté). '1 È molto presente, nella parte dedicata alla giovinezza di don Vito, l’osservazione di rituali e
forme di spettacolo popolare degli italo-americani di inizio secolo, dall’opera dei pupi alla sceneggiata. La canzone che si vede eseguire nel film, Senza mamma, era stata scritta dal nonno
materno di Coppola, Francesco Pennino. Cfr. G. Muscio, Tra nostalgia e memoria: da Francesco
Pennino a Francis Coppola, in La canzone napoletana. Tra memoria e innovazione, a cura di A. Pesce e M. Stazio, Cnr-Issm, Roma 2013, pp. 217-32. 15
L’«Immobiliare» (più precisamente Società Generale Immobiliare) è il vero nome
dell’impresa vaticana rilevata da Michele Sindona nel 1968 e fallita nel 1987 e legata fin dagh anni cinquanta ad alcune delle più famigerate speculazioni edilizie nella capitale (cfr. L Insolera, Roma moderna, nuova ed. Einaudi, Torino 2011, pp. 217-20).
Il Teatro Massimo in realtà era chiuso dal 1974 e ormai assurto a simbolo dell’immobilismo politico della città. Venne riaperto per F occasione, solo per consentire le riprese del film (l’effettiva
riapertura avverrà solo nel 1997). Nel film c’è anche il riferimento alla fosca vicenda della baronessa
di Carini, e tra gli attori compare il puparo Mimmo Cuticchio. 1 Un’altra novità del film è il ruolo da protagonista di una donna all’interno del sistema
mafioso; Connie, la sorella di Michael, che prelude a certi personaggi dei Soprano. Per un efficace riassunto di questi intrecci si veda J. Lewis, The Godfather, Bfì-Palgrave-
MacmiUan, London 2010, pp. 78-89. ’ ' Opposte rimostranze vennero dal senatore dell’italianissima Staten Island, persuaso che il miglior servizio sarebbe stato non l’autocensura ma l’esplicita condanna di una mafia chiamata col
suo nome (Lewis, IfHistory Has Taught Us Anything... cit, p. 38). Jones (a cura di), The Annotated Godfather cit, p. 71. Colombo padre, durante la lavorazione
del film di Coppola, fu gravemente ferito alla testa da un killer, e morirà nel 1978 senza mai essersi ripreso dai gravi danni cerebrali (A. Nicaso, Mafia, Bollati Bo ringhieri, Milano 2016, p. 87).
Sull’associazione fondata (appena l’anno prima) da Colombo si veda Lupo, Quando la mefia trovò l’America dt, p. 194. ‘ ’ R. Evans, The Kid Stays in the Pictures, Hyperion, New York 1994, pp. 222-4.
"* Lewis, IfHistory Has Taught Us Anything... dt, p. 33, ma cfr. Jones (a cura di), The
Annotated Godfather cit, p. 50, secondo cui il rifiuto sarebbe stato dovuto al cachet troppo basso.
Profad, insieme a Vito Genovese (e a Frank Costello, per la voce roca), era probabilmente uno dei due modelli cui si ispirava il personaggio di don Vito Corleone (ibid., p. 182). 5 P. Maas, Underboss. Sammy the Bull Gravano’s Story ofLife in the Mafia, dt in Jones (a
cura di), The Annotated Godfather dt, p. 72. •4
G. Talese, Onora il padre (1971), Rizzoli, Milano 2011, pp. 350-1.
* ’ S. Schneider, Iced. The Story ofOrganized Crime in Canada, Wiley, Mississauga 2009, p. 260.
* S. Raab, Five Families. The Rise, Fall and Resurgence ofAmerica’s Most Powerful Mefia
Empires, St Martin’s Press, New York 2006, p. 196 (dt in Lewis, The Godfather dt, p. 72). Lewis, citando altri studiosi della mafia americana, ricorda come già George Rafi fosse diventato un
modello per i gangster italo-americani, che cercarono di risalire al suo sarto per commissionargli abiti simili.
* *
J. Dickie, Cosa Nostra. Storia della mafia siciliana, Laterza, Roma-Bari 2004, p. 350. s Ibid., p. xxxm.
*
’ Puzo, intervista radiofònica del 1986, ora in Jones (a cura di), The Annotated Godfadier dt.,
p.191. «The New Yorker», 8 ottobre 1973, dt in P. DAderno, Nihilism and mafiosità in Martin Scorsese's Mean Streets, in Renga (a cura di), Mefia Movie. A Reader dt, p. 108. Sul tema si veda
soprattutto R. CasiUo, Gangster Priest. The Italian American Cinema ofMartin Scorsese, University’ of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 2006. 3 «Sono cresdnto nell’East Side, in una chiusissima comunità di siciliani e napoletani, e d ho
messo degli anni per decifrare quello che succedeva tra gli esponenti del crimine organizzato. Però
ero al corrente di questi 'grandi vecchi’ e del potere che esercitavano senza muovere un dito. Appena ti avvicinavi a loro il linguaggio del corpo cambiala, si poteva percepire davvero la potenza che irradiavano queste persone, e poiché ero un bambino ammiravo tutto questo senza
comprenderlo» (cfr. I. Christie - D. Thompson, a cura di, Scorsese secondo Scorsese, Ubùfibri,
Milano 2003, p. 184). «È questo l’ambiente in cui sono cresdnto: i miei genitori non erano così, ma vivevamo circondati dal crimine organizzato. In un certo senso, era come avere a che frre con
un’aristocrazia, era un tipo di sodetà rigidamente divisa in classi. Non che d fosse un omicidio tutti i giorni, ma c’era sempre questa sensazione di pericolo, il timore di spingersi troppo in là...» (M.
Scorsese, Il bello del mio mestiere. Scritti sul cinema, minimum fax, Roma 2002, p. 134). 3 * Cfr. Christie - Thompson (a cura di), Scorsese secondo Scorsese dt, p. 34. 3 5 D’Aderno, NihiKsm and mafiosità in Marrin Scorsese’s Mean Streets dt, p. 102. 31 Sulla presenza del mondo mafioso negli altri film di Scorsese si veda A. G. Mancino, Angeli selvaggi. Martin Scorsese, Jonathan Demme c/o Hollywood, Usa, Metis, Chieti 1995, p. 146.
N. Fileggi, Il delitto paga bene, Rizzoli, Milano 1987. Christie - Thompson (a cura di), Scorsese secondo Scorsese dt, pp. 184-5. Scorsese, Il bello del mio mestiere dt, p. 128. S Christie - Thompson (a cura di), Scorsese secondo Scorsese dt, p. 186.
F. Oràrio, Martin Scorsese's Goodfellas: Hybrid Storytelling between Realism and Formalism, in Renga (a cura di), Mafia Movie. A Reader dt, spedalmente pp. 143-4. ■’° Ibid., p. 147 41 Su questa figura si v*eda R. Sdarrone, Mafie relazioni e affari nell’area grigia, in Id. (a cura
di), Alleanze nell'ombra dt, pp. 12 sgg. N. Fileggi, Las Vegas. Una storia d’amore e di vendetta, Eurodub, Bergamo 1996. 3 The Departed — Tra il bene e il male, remake di un film hongkonghese, è invece più ossequiente alle regole del gangster movie, con le vicende speculari di un poliziotto infiltrato nella
mafia irlandese, e di una «talpa» delle gang all’interno della polizia. A. Pezzetta, Abel Ferrara, Il Castoro, Milano 1997, p. 86.
" Sugli approcd psicoanahtid alla mafia, cfr. irfra, cap. X, pp. 173-4. Falcone - Padovani, Cose di Cosa Nostra dt, p. 72. 4**
Per una ricostruzione delle sequenze si veda G. Nerone, Fratelli di Abel Ferrara. Il vicolo
cieco della morale criminale, Onyx, Roma 2006, pp. 31-2. 4.S
Cfr. A. Cavadi (a cura di), Il Vangelo e la lupara. Materiali su Chiese e mafia, Edizioni
Dehoniane, Bologna 1994. 4«>
I due paragrafi precedenti rielaborano E. Morreale, La teologia mafiosa di Ferrara e St.
John, in Abel Ferrara. La tragedia oltre il noir, a cura di G. A. Nazzaro, Stefano Sorbini editore,
Roma 1997. N. Fasullo, Una religione mafiosa, in «Segno», ottobre 1996,179, p. 39. •3
Fasullo, Una religione mafiosa dt, p. 40.
' Cavadi, Il Dio dei mafiosi dt, p. 132.
Ibid., p. 85 * I
Sulla figura di Chase si veda B. Martin, Difficult Men. Dai Soprano a Breaking Bad, gli
antieroi delle serie Tv, minimum fax, Roma 2018, pp. 64-125. Sulla serie si vedano gli interventi in
Renga (a cura di), Mefia Movies. A Reader dt, pp. 375-86. ” B. Carter, The Roots Of •Sopranos» Grew From Cagney Film, in «The New York Times», 28
ottobre 2001. Una ricerca elenca 182 citazioni cinematografiche esplicite nell’arco delle sei stagioni: S.
Careddu, Il Cinema ne I Soprano: influenze e richiami dal classico al postmoderno, tesi di laurea triennale in Filmologia, Dams, Università degli Studi di Torino, a.a. 2013-14 (relatore E. Morreale).
’ C. Golden, The Producers. The Dangers ofFilmmaking in The Sopranos, in The Essential
Sopranos Reader, a cura di D. Lavery, D. Howard, P. Leidnson, The University Press of Kentucky, Lexington 2011, pp. 128-37. -s „ . ’ Id., •You’re Annette Bening». Dreams and Hollywood as Subtext in The Sopranos, in Lavery, Howard, Levinson (a cura di), The Essential Sopranos Reader dt., parte V («Dreams and
Therapy»). .V
-
V
R. Warshow, The Gangster as a Tragic Hero (1948) e Movie Chronichle: The Westerner
(1954), in Id., The Immediate Experience, Harcard University Press, Cambridge-London 2001, pp.
97-124 (spedalmente pp. 106-7). ho
«lYhatever Happened to Stop and Smell the Roses?». The Sopranos as Anti-therapeutic
Narrative, in Lavery, Howard, Levinson (a cura di), The Essential Sopranos Reader dt, pp. 174
SE& R. Pihiso, •Funny about God, and Fate, and Shit Like That». The Imminent Unexpected in The Sopranos, ibid., pp. 260 e 265. Pattie («Whatever Happened to Stop and Smell the Roses?»
dt, p. 170) nota come anche le singole scene finiscano in modo poco convenzionale, senza battute
condush'e, e a volte incastrate l’uria nell’altra. G Roccia, From Columbus to Gary Cooper, Unmade Men, «AH Caucasians look alike».
Dreams of Whiteness at the End ofThe Sopranos, in Lavery’, Howard, Levinson (a cura di), The
Essential Sopranos Reader dt, pp. 208-18; F. P. Tomasulo, The Guinea as Tragic Hero. The Complex Representation ofItalian Americans in The Sopranos, ibid., pp. 197-206. 3 A. Ingroia, The Price ofStereotype. The Representation of the Mafia in Italy and die United
States in The Sopranos, in Lavery, Howard, Levinson (a cura di), The Essential Sopranos Reader
dt, pp. 244-5. * Sul finale della serie si vedano D. Polan, The Sopranos, Duke University Press, Durham 2009,
pp. 1-16, e G. Lombardi, «Don’t Stop Believin', Don't Stop»: (De)Structuring Expectations in the Final Season o/The Sopranos, in Renga (a cura di), Mafia Movie. A Reader dt, pp. 192-200. 6'’ «Tony Soprano era stato Palter ego della gente. Lo avevano visto allegramente rubare,
uccidere, razziare e mentire. Avevano fatto il tifò per lui. E ora, improvvisamente, volevano vederlo punito per tutto questo. Volevano “giustizia’... La cosa patetica (per me) era quanto volessero il suo
sangue, dopo aver tifato per lui per otto anni» (in B. Martin, The Sopranos Complete Book, Hbo, 2007, p. 184). T. S. Eliot, Gli uomini vuoti, in Poesie, a cura di R. Sanesi, Bompiani, Milano 1999, p. 297.
xi. Dal mafia movie alle agiografìe
1.1figli diMery. Dal 1984 le rivelazioni di Tommaso Buscetta e degli altri pentiti, e
il maxiprocesso che ne segue (la prima seduta è del 10 febbraio 1986),
segnano un punto di svolta fondamentale nella storia della lotta alla mafia. H periodo che va dal 1983 al 1993 è quello in cui Cosa Nostra è
più all’ordine del giorno nell’agenda politica e giornalistica del nostro paese1. Gli anni immediatamente precedenti l’apertura del processo sono segnati dalla «seconda guerra di mafia», con l’eliminazione dei
clan rivali da parte dei corleonesi, i quali prendono in mano il traffico di droga con gli Stati Uniti. Dal 23 aprile 1981 (omicidio di Stefano
Bontate) la guerra, che continua per un paio d’anni, si intreccia a un
attacco senza precedenti a politici e uomini delle istituzioni: tra gli altri il presidente della Regione Piersanti Mattarella, il segretario
regionale del Pei Pio La Torre, il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, l’ex senatore e magistrato Cesare Terranova che aveva appena fatto
domanda per dirigere l’Ufficio istruzione (ucciso insieme al
maresciallo Lenin Mancuso), il procuratore capo di Palermo Gaetano Costa, il commissario Boris Giuliano. Ma nello stesso periodo si diffonde sempre più un’opinione pubblica antimafiosa, specie nelle
scuole e in alcuni settori della Chiesa.
La mafia non è più invisibile: le immagini dei cadaveri insanguinati
diventano un triste patrimonio comune, icone di riferimento
condivise che si sovrappongono, nei telegiornali, a quelle della stagione del terrorismo ormai in via di esaurimento. Dalla metà degli
anni ottanta l’atteggiamento dell’informazione nei confronti della mafia muta radicalmente, facendosi più puntuale, fino a sfociare nella
copertura assegnata al maxiprocesso, integralmente ripreso (anche
per conto del ministero di Grazia e giustizia), grazie a un apposito potenziamento della redazione palermitana e alla costruzione di una . . . 2* . . . sede distaccata a pochi passi dall’aula bunker . Gli spettatori si
abituano a confrontarsi con i racconti, le voci, i fatti che emergono in
tribunale, ripresi spesso in televisione, fino allo speciale di due ore della trasmissione Un giorno in pretura, in onda Fu settembre del 1989. Una conseguenza di questo mutamento è il venir meno, o la
minore urgenza, di quel ruolo di «contro-informazione»
orgogliosamente rivendicato, ad esempio, dai film di Giuseppe Ferrara.
La vera svolta riguarda non solo la quantità, ma anche la qualità delle conoscenze. Per la prima volta è possibile il confronto con una
prospettiva interna, con le voci dei pentiti e dei mafiosi, i gesti e i volti
(o le mani, per quanto riguarda i collaboratori di giustizia non filmabili direttamente). Non solo i fatti, ma le logiche, le cadenze, le retoriche diventano familiari agli italiani. La mafia è, per la prima
volta, un po’ meno straniera.
Sorprende perciò il ritardo del nostro cinema rispetto a ciò che accade, la sua difficoltà a renderne rapidamente conto. Risaltano in questo periodo le contraddizioni del mafia movie, attardato sui
modelli western o polizieschi del decennio precedente, e che quando prova a intrecciare l’eredità del genere e gli spunti di attualità risulta
più forzato del solito. È il caso, ad esempio, dei riferimenti alla cronaca criminale in film come Pizza Connection e II sole buio di
Damiano Damiani, Dimenticare Palermo di Francesco Rosi e soprattutto II pentito di Squitieri: in questi titoli la logica del genere,
che sorreggeva la produzione precedente, con ogni evidenza non basta più. Ma a parte i titoli citati, la verità è che il cinema di mafia tra metà
anni ottanta e primi novanta quasi scompare. È questo, invece, il decennio della Piovra, la cui prima puntata va in onda Fu marzo 1984, appena prima dell’arrivo di Buscetta in Italia.
La serie, che può essere considerata il culmine e la pietra tombale della stagione del mafia movie, continuerà con enorme successo per
altre nove stagioni (fino al 2001), utili proprio come sismografo dell’opinione pubblica (si veda cap. XIII). A fine decennio il cinema scopre poi il mondo del sottoproletariato palermitano. Alla base c’è Fattività culturale di alcuni settori
dell’antimafia, e in particolare il libro Meri per sempre. L'amore la donna il sesso, raccontato dai giovani detenuti del Malaspina di
Palermo, scritto dal giovane maestro Aurelio Grimaldi, che insegnava
al carcere minorile Malaspina . Il volume era pubblicato dalla casa editrice La Luna, sorta per iniziativa di un gruppo di donne
palermitane, che avevano provveduto a offrire una serie di
testimonianze dall’interno del mondo mafioso, tra cui un librointervista alla madre di Peppino Impastato, La mafia in casa mia, e
una raccolta di interviste a vedove, Sole contro la mafia. Meri per sempre derivava da un diario pubblicato dalla rivista «Segno» nel novembre 1984, e poi ripreso dal quotidiano «L’Ora», che aveva 4 suscitato scalpore e addirittura un’interrogazione parlamentare . Il libro dava voce al parlato dei detenuti, raccogliendone i temi scolastici. Qualche spunto che sarà presente nel film si trova anche nel
libro, ma è soprattutto il diario del 1984, pubblicato in appendice al volume, a venir utilizzato per trarne spunti narrativi e personaggi. Il film, scritto da Sandro Petraglia e Stefano Rulli, autori delle ultime serie della Piovra, è diretto da Marco Risi, che con il lavoro precedente (Soldati. 265 giorni all'alba) tentava di uscire dall’ambito
della commedia generazionale in cui aveva esordito. Il racconto segue le vicende di un gruppo di detenuti del carcere di Palermo (il
Malaspina, ribattezzato Rosaspina), utilizzando il punto di rista di un professore venuto dal Nord. A interpretare quest’ultimo è Michele Placido il quale, appena abbattuto davanti a 17 milioni di spettatori nelle vesti del commissario Cattaui (l’ultima puntata della Piovra 4 è
del 20 marzo), risorge dunque a maggio, poche settimane dopo, sul
grande schermo, nelle vesti di pedagogo antimafia. Mery per sempre (nel film la «i» diventa una «y») è, da un certo
punto di vista, l’ultimo esempio della classica triangolazione testo
letterario siciliano-intervento del cinema «romano»-lavorazione in Sicilia. Ma con alcune significative novità, che ne fanno un primo
incerto esempio di un cambiamento. A rivederlo oggi, appaiono evidenti una certa convenzionalità e molti compromessi, a cominciare
da Claudio Amendola ventiseienne che dovrebbe interpretare un
adolescente palermitano. Ma c’è anche qualcosa di vero e di nuovo.
All’epoca l’uso dei set, degli attori locali e soprattutto del dialetto (in presa diretta) era un’assoluta novità audiovisiva. L’importanza del
film è in questo senso enorme. Sulla scia di Mery per sempre vengono realizzati vari lavori, per il cinema e la televisione, fino a dar vita a un
piccolo filone. Il primo è Ragazzifuori, diretto sempre da Risi e sceneggiato da Grimaldi, che segue le vicende dei giovani
sottoproletari una volta usciti dal carcere. Il film mostra anche i limiti del modello, perché sceglie di trascurare la flagranza del mondo che
Mery per sempre aveva scoperto, per affidarsi a una struttura
narrativa più rigida, a storie incrociate. Ne risulta una maggiore
vicinanza a un’«estetica del degrado», con musiche a effetto sulle scene di violenza (ad esempio nel pestaggio del personaggio di
Claudio da parte di un compagno di prigionia che lui ha denunciato). Il film cerca anche un maggiore appiglio alla cronaca, riproducendo in
un episodio la vicenda del sedicenne Stefano Consiglio, attore nel film precedente ucciso il 16 aprile del 1989 da un agente in borghese, che 5 lo aveva visto rubare un’autoradio . Sui titoli di coda, a sottolineare
l’effetto di verità, scorrono le foto e le voci over degli interpreti non
professionisti, che raccontano la loro vita attuale, e la voce del padre di Consiglio.
Come ha sintetizzato Francesco Gas etti:
In Mery per sempre Iseffetto di verità è legato al fatto che in uno schema
narrativo ben collaudato irrompono degli elementi nuovi, che ne disperdono i punti di forza, ne alterano gli equilibri, ne spostano il centro d’attenzione: si ha insomma una rottura per contaminazione, che fa sì che ciò che potrebbe essere totalmente atteso si trova a operare in condizioni nuove. [...] Al
contrario in Ragazzifuori il materiale prelevato direttamente dalla cronaca si trova «ingabbiato» in uno schema narrativo che, più che renderlo meglio riconoscibile, lo impoverisce e lo normalizza. Di qui un effetto finzione, che nasce appunto da una ricomposizione per stereotipi6.
Di lì a poco Grimaldi intraprende la strada della regia, dapprima con una serie di film che prendono le mosse dallo stesso ambiente cercando di smarcarsene per l’ambientazione storica o per la maggior
vistosità dello stile, ma riprendendone i protagonisti adolescenti,
alcuni attori e Fuso del dialetto (l’esordio è La discesa diAclà a Fioristella"). Felice Farina, invece, realizza con alcuni interpreti del
film prima il melo Ultimo respiro, che racconta un’attrazione tra un ladruncolo interpretato da Francesco Benigno e una donna dell’alta borghesia (Federica Moro, ex Miss Italia), poi la miniserie Felipe ha
gli occhi azzurri, su un bambino filippino arrivato clandestinamente a
Palermo. Sulla scia di Ragazzi, fuori, infine, si mette esplicitamente il film d’esordio di Giorgio Castellani, alias Giuseppe Greco, di cui si
dirà più avanti. Questo mini-filone, insieme a La piovra e ai residui del mafia movie del decennio precedente, segna anche il momento di massimo splendore per la scuderia di attori di Enzo Castagna, dalla
quale provenivano tutti gli interpreti (si veda infra, pp. 296-9).
2. Giudici d'autore.
Un’enorme ricaduta avrà invece il trauma provocato dagli attentati di Capaci e ria D’Amelio: da subito cinema e televisione si lanciano
sull’argomento in maniera più 0 meno esplicita. I fatti vengono
rievocati, un anno dopo, da Giuseppe Ferrara in Giovanni Falcone (ottobre 1993), ma già La scorta di Ricky Tognazzi, ispirato alla storia
del magistrato Francesco Taurisano e uscito sei mesi prima, evocava
inevitabilmente le stragi di poco precedenti. Su ima vicenda che
intreccia Mani Pulite e traffico d’armi (con qualche riferimento
all’omicidio di Ilaria Alpi) verte un curioso film, Il lungo silenzio di Margarethe von Trotta, dedicato alla vita dei giudici condizionata dal regime di sorveglianza. Nel febbraio 1994 esce II giudice ragazzino di
Alessandro Di Robilant, sull’omicidio di Rosario Livatino avvenuto tre
anni e mezzo prima. Nel 1995 lambisce la mafia anche Un eroe borghese di Michele Placido sul delitto Ambrosoli, e nel 1997 Testimone a rischio di Pasquale Pozzessere affronta il tema di
straforo, attraverso la vicenda del testimone oculare sempre dell’omicidio Livatino.
Nei primi anni duemila le produzioni cinematografiche sulle
vittime della mafia o sugli eroi antimafia crescono di numero,
intrecciandosi a quelle televisive. Nel 2001, insieme a Placido Rizzotto e I cento passi (infra, pp. 227-33), 6506 I giudici, nel 2003 Gli angeli
di Borsellino, nel 2005 Alla luce del sole, nel 2007 L'uomo di vetro. Nello stesso periodo, mentre si conclude la saga della Piovra (ultime puntate trasmesse a gennaio-febbraio del 2001) arrivano le serie
dedicate a Ultimo (le prime due nel 1998 e nel 1999), Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, l'uomo che sfidò Cosa Nostra, Il
generale Dalla Chiesa, e rivolgendosi all’indietro Joe Petrosino, mentre, forse sulla scia del film Romanzo criminale, vengono prodotte le prime serie con mafiosi protagonisti: L'ultimo dei
Corleonesi, Il capo dei capi, L'ultimo padrino. L’interesse ha una battuta d’arresto con il nuovo decennio, in concomitanza con una generale caduta di attenzione dei media verso la mafia. Negli anni successivi l’unica miniserie storica sulla mafia è Cesare Mori - Il
prefetto diferro, che riguarda vicende di ormai ottantanni prima.
Negli anni più recenti, si è avuto un ritorno di fiamma celebrativo prima con il film televisivo Paolo Borsellino -157 giorni e poi con quelli su Boris Giuliano, Felicia Impastato e Libero Grassi, Rocco
Chinnici e Giuseppe Fava (infra, cap. XII). Se l’atmosfera di Mani Pulite favorisce la denuncia dei rapporti con
la politica, sia in chiave retrospettiva (Un eroe borghese) che da
instant movie (Giovanni Falcone), un altro elemento di novità è il tentativo di sganciare i temi dalle regole del genere, anche per differenziarli dalla produzione televisiva. Questi film si segnalano
come opere «d’autore», attraverso un riposizionamento nel rapporto col pubblico. Linea avviata già da Mery per sempre, ed evidente nei
film di Di Robilant, Pozzessere e Placido: in questo caso soprattutto
attraverso la fotografia di Luca Bigazzi, che con l’uso ridottissimo di luci artificiali raffigura una Milano dai colori freddi e tendenti al blu,
non distante da quella dei primi film di Silvio Soldini. Se il modello di un nuovo «realismo d’autore», più attento all’osservazione della realtà che alle analisi politiche, è II ladro di bambini di Gianni Amelio,
sull’onda di Mery per sempre è cambiato anche il paesaggio del suono, con l’arrivo massiccio della presa diretta e un aggiornamento
delle musiche. In quella di II giudice ragazzino, ad esempio, dominano sonorità
arabeggianti con pochi strumenti, di solito a fiato, come nel film di
Amelio (l’autore delle musiche è lo stesso, Franco Piersanti). Nello schema dei personaggi, al posto di un giustiziere straniero e sconfitto,
troviamo un eroe interno alla comunità: un giudice alle prese con una
cittadina («fine anni ottanta», recita una scritta iniziale, come a storicizzare un passato recentissimo), il cui boss addirittura vive al piano di sopra del suo stesso palazzo. Il giudice è Rosario Livatino, ucciso sulla strada statale da Canicattì ad Agrigento il 21 settembre
del 1990. Nel film lo fronteggia un boss (Renato Carpentieri) che,
come sempre, è a suo modo nobile e saggio, pacato e quasi bonario. La sceneggiatura però, più che sulla forza dell’omertà e del terrore come era in passato, insiste sull’efficacia di un sistema di potere che parte dalla borghesia locale: il giudice viene affrontato con doni e blandizie,
non con minacce. Lo stile è decisamente anti-spettacolare, con un certo interesse per
il versante privato: la vita in famiglia con i genitori, la storia d’amore con la collega interpretata da Sabrina Ferilli. Lo stesso omicidio finale
è inquadrato in maniera distaccata, in campo lungo, con in
dissolvenza incrociata i potenti locali indirettamente correi della morte del protagonista. Rimane invece in ombra il cattolicesimo del
giudice7 (lo si intravede giusto un paio di volte in chiesa), forse poco compatibile con lo schema del cinema civile.
Altro elemento che segnala una prossimità al cinema d’autore sono le citazioni cinematografiche e televisive. La famiglia del giudice
guarda ì'Odissea in tv e Livatino spiega ai genitori i trucchi del cinema, citando I dieci comandamenti e Via col vento; poi trascina la fidanzata a vedere II posto delle fragole di Bergman (forse un
riferimento indiretto al Settimo sigillo, film molto amato da Giovanni
Falcone).
3- Scorta movies e dintorni.
Le stragi del 1992 causano una comprensibile evoluzione
all’interno dei sottogeneri del mafia movie. Il primo gruppo in ordine cronologico è quello dedicato ai poliziotti e alle scorte, soggetto più facilmente utilizzabile in termini di film d’azione. Il titolo fondativo è
La scorta di Ricky Tognazzi: prodotto dallo stesso Claudio Bonivento
di Mery per sempre, presentato in concorso al Festival di Cannes che l’anno prima aveva incoronato II ladro di bambini con il Gran Prix speciale della giuria, il film cerca di mescolare le attrattive dell’action
movie e l’attualità del tema. Dal film di Risi, ad esempio, provengono alcuni attori come Claudio Amendola e Tony Sperandeo (unico
componente siciliano della scorta e unico che alla fine muore). Ma il film ripropone soprattutto la coppia centrale assai romana, Claudio
Amendola-Ricky Memphis, del film precedente di Tognazzi, Ultrà,
Orso d’argento a Berlino nel 1991. È già chiaro il principale esito di questo filone: un aggiornamento del poliziesco anni settanta di area
romana, con l’incubazione di una nuova generazione di attori. La
tradizionale opposizione del genere, tra polizia che rischia in prima persona e magistratura attendista o cavillosa (La polizia incrimina, la
legge assolve, per citare il film del 1973 di Enzo G. Castellari), nel dopo-Capaci va riformulata, e la figura dei poliziotti di scorta è l’ideale. L’opposizione diventa dunque tra poliziotti e magistrati
inquirenti da un lato, e magistratura giudicante e maggioranza del Palazzo di giustizia dall’altro: esemplarmente, la scorta si mette a
indagare a fianco del giudice isolato dai colleghi, che lo diventa ancora di più quando l’indagine tocca la politica. Il finale, come spesso
accade, è amaro: il pentito che stava parlando viene ucciso, e il giudice
è trasferito dal Csm. La natura anfibia del film, che comincia con il più classico degli omicidi con inseguimento, trapela dal doppiaggio vecchio stile,
dall’uso delle musiche di Morricone, dall’alternanza tra inseguimenti con sgommate, parentesi private e vaghi riferimenti all’attualità.
Curioso che al centro di tutto, nel 1993, ci sia una vicenda che riguarda un settore in fondo marginale come la mafia dell’acqua,
legata all’immaginario di una Cosa Nostra d’altri tempi. È chiaro
comunque che il tema delle scorte evoca negli spettatori le recenti stragi di Capaci e via D’Amelio, anche se in questo caso gli autori si
erano ispirati alla lontana al caso di Francesco Taurisano, sostituto procuratore a Trapani che aveva comunicato alla stampa il proprio
disappunto per le difficoltà a portare avanti le indagini su mafia e
politica, e che fu poi sottoposto a un’indagine del Csm in seguito ad . *................................. 8 ~ alcune sue discusse iniziative . Il successo del film è enorme: oltre 8 miliardi di lire di incasso. Ma
più fecondo ancora, specie sul versante televisivo, sarà il modello schiettamente di genere rappresentato da Palermo-Milano sola
andata, che ha anch’esso un ottimo esito commerciale (oltre quattro miliardi di lire) pur non potendo vantare quarti di nobiltà artistica: il
regista Claudio Fragasso infatti proviene dal crepuscolo dei B-movie girati con pseudonimi anglofoni4*9*. La trama diventerà un paradigma per molte produzioni televisive
dell’epoca. Prima del filone dei martiri, infatti, il cinema e la tv italiani
si confrontano con la mafia attraverso due meccanismi narrativi derivati più direttamente dal film di genere: la scorta (l’insieme di personaggi diversi finalizzati a un unico scopo, e soli), e il pentito (del
quale non si sa se fidarsi). Qui un gruppo di poliziotti capitanati da Raul Bova (che aveva appena interpretato in televisione il capitano
Ultimo) deve scortare da Palermo a Milano un ragioniere della mafia. Il modello dichiarato di Palermo-Milano è l’Odissea; ma meglio
ancora, si potrebbe dire, VAnabasi che era alla base dei Guerrieri della notte di Walter Hill. I protagonisti sono subito lasciati soli,
traditi da tutti a cominciare dallo Stato, in un’atmosfera in cui la «trattativa» con la mafia è data per scontata come un elemento tipico
del genere: a livello alto politici e istituzioni sono sempre corrotti e a
risolvere i problemi devono essere i poliziotti di frontiera.
Nel cast si mescolano alcuni attori provenienti da Mery per sempre (a cominciare da Francesco Benigno) e una maggioranza di interpreti
non siciliani che ostentano la vecchia koinè linguistica del mafia movie anni settanta, e a cui si aggiunge Romina Mondello fresca reduce dalla Piovra 7. Ma se la struttura del riaggio in Italia è quella
tipica di molti film dell’epoca che riscoprono la penisola (da II ladro
di bambini, di Gianni Amelio, a Stanno tutti bene, di Giuseppe Tomatore), quello di Fragasso è anzitutto un action morie, in cui i riferimenti alla realtà sono rari e vaghi (vengono nominati di sfuggita il vecchio capomafia di Corleone, Michele Navarra, e in generale «i
corleonesi»).
Palermo-Milano avrà un tardivo sequel nel 2005 (Milano-
Palermo: il ritorno) in cui la squadra si ricompone per salvare il nipotino del ragioniere della mafia. Mal nel frattempo aveva costituito
l’ideale pilot polivalente per una serie di produzioni televisive
trasmesse da Mediaset. La prima a riprenderne lo schema è però una
miniserie Rai, Nessuno escluso, diretta da Massimo Spano, con il consueto commercialista della mafia dall’ambiguo pentimento, il
manipolo di uomini della Dia e le «mele marce». Qualche anno dopo,
una produzione Mediaset avrà una filiazione più diretta dal film: Operazione Odissea, diretto sempre da Fragasso, cita il precedente lavoro del regista fin dal titolo (che era il nome in codice della missione di Palermo-Milano). Il film porta a termine l’incubazione di
una nuova generazione di attori romani in trasferta siciliana: qui ci sono Ricky Memphis, Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Daniele
Leotti ed Edoardo Leo (e a passare idealmente il testimone generazionale, un’icona del cinema e del teatro romani anni settanta,
Victor Cavallo). Sfortunata invece l’ultima miniserie diretta da
Fragasso, Blindati, arrivata troppo tardi o forse troppo presto. La
storia di tre fratelli mafiosi (Paride, Enea ed Ettore) in lotta per la stessa donna, il tono sopra le righe e le ambizioni da tragedia greca,
una dose non consueta di violenza, lo sguardo interno
sull’organizzazione e i risvolti mèlo pongono l’operazione a metà tra le produzioni Ares e i prodotti alla Gomorra. Non a caso le due puntate, di difficile collocazione, furono spostate nella prima serata di
Retequattro, dalla mainstream Canale 5 cui erano inizialmente destinate.
Ma l’operazione più interessante del filone è la miniserie L'impero, diretta da Lamberto Bava e andata in onda su Canale 5 nel marzo 2001. Ancora una volta c’è un commissario alle prese con un mafioso pentito che dovrebbe svelare dei segreti, ma lo scenario si allarga anche (come nelle ultime stagioni della Piovra) all’Est Europa e ai
flussi di rifugiati politici. È quasi acrobatico il tentativo di inserire in
una trama melodrammatica e d’azione tutti i temi dell’attualità e del feuilleton: immigrazione clandestina, mafia siciliana, mafia russa,
belle nigeriane salvate dalla schiavitù. L’elemento più interessante per
lo spirito dei tempi è la figura del cattivo, il professor Dossena, che si direbbe ispirato a Diego Gambetta, sociologo docente a Cambridge e
poi a Oxford, le cui tesi sulla mafia come «industria della protezione» , . . . . .. . .... 10 erano state alcuni anni prima al centro di un vivace dibattito .
Dossena, che cita appunto «i migliori criminologi inglesi», spiega la
mafia attraverso la legge della domanda e dell’offerta, per giustificare il proprio operato: ha fatto soldi con le stock options, ed è una sorta di
dottor Mabuse che utilizza i canali dei rifugiati per creare la manodopera e la classe dirigente di un nuovo Impero romano europeo
(tramite accordi con Russia, Cina ecc.).
Già prima delle serie nate sulla scia di Palermo-Milano era partita
la serie Ultimo, dedicata a Sergio De Caprio, capitano dei Ros a capo del gruppo Crimor, che appunto catturò nel marzo 1993 il latitante
numero 1 di Cosa Nostra. La prima stagione (prodotta da quella Taodue di Pietro Vaisecchi che sarà la principale fabbrica di agiografie
antimafia per la tv, e diretta da Stefano Reali) va in onda nel novembre 1998, e può essere anche letta come prima versione,
«basata su personaggi reali», del filone che abbiamo fin qui visto degli scorta movie, in cui il poliziotto lotta contro l’ostruzionismo dei capi . Il film mostra con adesione la prassi di Ultimo, che agisce secondo il
principio di lasciare che i latitanti conducano ai pesci grossi, con largo uso dei «ritardati arresti». La trama vede un commercialista dei boss
che, in pericolo di vita, si decide a parlare; la squadra di Ultimo è una «sporca dozzina» di reietti che hanno rischiato la carriera o sono
malvisti dai superiori: «Ho scelto gli ultimi», dice, appunto, il capitano Ultimo. Anche se il sottotitolo della serie è L'uomo che
arrestò Totò Riina, i nomi dei personaggi sono cambiati: Riina viene ribattezzato Salvatore Partanna, il figlio del pentito, strangolato e
sciolto nell’acido, diventa Santino Candurra. Il magistrato maestro di Ultimo, che dovrebbe essere Falcone, nella fiction cambia nome di
rapace e si chiama «il Nibbio», forse per via di qualche memoria scolastica dei bravi manzoniani (più malcerto invece il riferimento
all’opera lirica, altro topos del genere: Fiorello, ascoltando pensoso la Cavalcata delle Valchirie, commenta: «Questo è il Parsifal»). Nelle successive stagioni (dirette da Michele Soavi, e coeve alle serie
poliziesche di cui abbiamo parlato prima) il legame con la cronaca si allenta. Ma interessante è l’inizio dell’ultima, costretta ad aggiornarsi
agli sviluppi della cronaca. Il primo episodio comincia con Bova/Ultimo a processo per non aver arrestato subito Partanna/Riina
e per non aver perquisito il covo. Il vero capitano Ultimo era stato rinviato a giudizio nel 2005 per favoreggiamento, e assolto nel 2006
perché «il fatto non costituisce reato», e la serie giustifica
esplicitamente la mancata perquisizione, fondandosi anche sulla logica interna al genere, per cui il poliziotto è quello che rischia e ha . .. . .... 12 ragione, mentre il magistrato sta dietro alla scrivania .
Meno edificante, invece, la «coda» riguardante l’imprevisto destino della serie. Nel 2006 si scopre che l’amministrazione comunale di
Villabate (pesantemente influenzata da Cosa Nostra), nel consegnare cinque anni prima la cittadinanza onoraria a Raul Bova per il ruolo
del capitano Ultimo, aveva avuto il beneplacito delle cosche locali legate a Provenzano, il quale a quanto pare aveva dato il suo benestare 13 alla «paraculata» . Anzi, per essere più precisi: l’amministrazione
comunale aveva offerto la cittadinanza onoraria al capitano, ma a ritirarla era stato invitato il suo interprete televisivo Bova. Un evento
a suo modo illuminante sul ruolo dei film sui poliziotti e giudici nel
sistema dello spettacolo e dell’informazione: «Lo avevano capito in modo lucido: la rappresentazione fantastica della lotta solitaria di
qualche poliziotto contro il sistema di potere mafiosi può distogliere efficacemente l’attenzione dalla necessità reale di un movimento TI • collettivo» .
4. Domani a Palermo. La Primavera e il suo cinema.
Gli anni fra il 1992 e il 1999, fra le stragi di Capaci e via D’Amelio e
i processi ad Andreotti, Contrada e altri rappresentanti di politica e istituzioni, vedono un innegabile, per quanto effimero, risveglio civile e culturale della Sicilia, e di Palermo in particolare. Nel 1992 Leoluca
Orlando, già sindaco della città dal 1985 al 1990, esce dalla De e fonda il movimento La Rete. Entrata in vigore l’elezione diretta del primo
cittadino, viene eletto (novembre 1993) con oltre il 75% dei voti ed è
riconfermato alle elezioni successive, rimanendo in carica fino al dicembre 2000, quando si dimette per candidarsi a presidente della
Regione (verrà sconfitto da Totò Cuffaro). I primi anni della giunta
Orlando sono ricchi di iniziative culturali, simboleggiate dalla
riapertura del Teatro Massimo che si era potuto vedere, negli ultimi . . . . 15 . decenni, solo grazie al Padrino parte m di Coppola . Nel 1995 viene riaperto al pubblico un luogo dimenticato della città, la chiesa di Santa Maria dello Spasimo. Nel 1996, a pochi passi, Carlo Cecchi
inaugura una serie di rappresentazioni shakespeariane al Teatro Garibaldi: altro luogo abbandonato che, con ponteggi allestiti
all’interno, esibisce come un suggestivo set il proprio abbandono. Nello stesso periodo, vengono aperti i capannoni Ducrot, stabilimento
industriale di inizio secolo, uno spazio da 55000 mq che ospiterà varie
attività anche legate al cinema (un corso di formazione, la
preparazione di Sud Side Stori di Roberta Torre, la proiezione di A
memoria di Cipri e Maresco con accompagnamento dal rivo di Steve
Lacy, una mostra dedicata alla coppia di registi). Poco a poco e con lunghe interruzioni, il luogo verrà restaurato, ma anche in questo caso l’impressione generale è, all’epoca, di una rovina riutilizzata da subito
in quanto tale. Di una «estetica delle rovine», o addirittura di una loro estetizzazione, si parla infatti in quel periodo non solo riguardo a certo cinema (Cipri e Maresco anzitutto), ma a una maniera di rivere la città.
Alle attività culturali di forte impegno civile già presenti sul
territorio (La Luna, «Mezzocielo», «Segno», l’unica che sopravvivrà)
si aggiungono nuove iniziative: riviste («Casba», poi «Nino, domani a Palermo», e su un versante più sociale «Il Quartiere Nuovo»), case
editrici (Gelka e soprattutto le Edizioni della battaglia, fondate da Letizia Battaglia proprio nel 1992), manifestazioni e festival di vario tipo, e un forte coinvolgimento delle scuole sostenuto dall’assessore . . 16 all’istruzione Alessandra Siragusa .
Sarebbe troppo lungo dar conto in dettaglio di questa stagione, che ci interessa qui soprattutto per due dati relativi al cinema:
raffermarsi, per la prima volta, di una generazione di registi che vivono in Sicilia, e il loro forte legame con un’attività di
17 organizzazione culturale o di confronto politico con il territorio . Pasquale Scimeca e Aurelio Grimaldi, ad esempio, oltre ai
lungometraggi, firmano in quegli anni alcuni titoli, lunghi o brevi, di
intervento diretto nella città. Il primo realizza la versione filmata di
una sacra rappresentazione, Viaggiu dulurusu di don Cosimo Scordato, animatore della parrocchia dell’Albergheria, musicata da
Vincenzo Mancuso, un reportage televisivo sui sindaci antimafia dei paesi delle Madonie (Nella tana del lupo) e uno sulla campagna
elettorale di Luciano Violante (L’Ulivo nelle Madonie); tutti titoli di diretto uso militante 0 propagandistico, come il «pedagogico» Paolo
Borsellino, cui il regista darà nel 2012 un seguito ideale con Convitto
Falcone: due titoli purtroppo esemplari di una visione semplicistica ed edulcorata della lotta antimafia. Più sottile e morboso, Aurelio
Grimaldi realizza anche lui brevi film di inchiesta, che gli servono più che altro ad approfondire i temi a lui cari della sessualità e
dell’infanzia (Iparrini; Bambini strade Palermo). Nel 1996 si stabilisce a Palermo, con l’intento di cream una scuola di cinema, Paolo Benvenuti, che entra in contatto con gli ambienti legati a Danilo
Dolci (anni dopo, uno dei risultati del soggiorno sarà il film Segreti di Stato). E sono questi gli anni in cui Cipri e Maresco attraversano la
città, specie la periferia est, filmandola in lungo e in largo, e praticando un’intensa attività di organizzazione culturale.
Nello stesso periodo la città di Palermo, tradizionalmente
trascurata, con rare eccezioni, dalla letteratura, viene scoperta da una 18 generazione di scrittori in termini molto simili a quelli del cinema .
Tra i titoli spicca uno dei più bei romanzi sulla mafia, Malacarne
(Baldini e Castoldi, Milano 1996) di Giosuè Calaciura, confessione in prima persona di un pentito davanti a un giudice forse non solo
terreno, scritto in una lingua lussureggiante e carnevalesca.
Documento prezioso di questa stagione è, nelle proprie contraddizioni, Diario senza date di Roberto Andò, film-saggio
19
che
mescola una trama narrativa a brani documentari e parentesi teatrali. Sullo sfondo delle vicende di un regista tedesco (Bruno Ganz) che
arriva a Palermo in cerca di un misterioso diarista (Moni Ovadia) si
dipanano episodi collaterali e materiali di vario tipo che ruotano intorno al tema del Diario e della Città. Una città borghese che sfugge
alla narrazione, e in cui il diario (come chiarisce Andò nel volume 20 omonimo) è una forma di delazione, auto-denuncia di ceto. Si delineano così i due poli del film: la mafia e le rovine. La mafia è un precipitato, una metafora di qualcosa di non narrabile, di presente,
oscuro e malato. E le rovine sono l’aspetto attraverso cui questa città
si manifesta. Mafia e rovine sono luoghi in cui, recita la voce over, «nuove macerie si sono aggiunte alle vecchie, per compiacere
generazioni di necrofìli, appassionati di cinema e di libri gialli».
Alcuni tra i pm antimafia più in rista (Erminio Amelio, Ignazio De Franscisci, Roberto Scarpinato) affidano alla macchina da presa
riflessioni che suonano quasi pirandelliane, mentre Franco Scaldati e il suo sodale Gaspare Cucinella, rappresentanti della città lumpen,
recitano brani della pièce Totò e Vice vagando come Totò e Ninetto Davoli in cerca del set di un film intitolato L’apocalisse (scene che
ricordano da ricino il mondo di Cinico Tv). Evocati (Sciascia, Lucio Piccolo) o messi in scena (Vincenzo Consolo, Michele Penderà) sfilano gli scrittori, ma anche il più celebre esorcista cittadino, padre La Grua. Il film è un vagabondaggio dentro una borghesia mai raccontata, e
come pietrificata. Il regista Ganz fa un tour di lussuose e cadenti case private, con facciate erose, e all’interno smorti bagliori di vita.
Un’anziana nobile parla di Rosi, Visconti, Pasolini che sono venuti da lei: «Ma poi nessuno ha girato niente, nessuno». Un’altra, borghese, racconta divertita della campagna elettorale del 1946 con i mafiosi che
portavano voti al marito, anima per anima. Poi un altro nobile ipotizza: «Finiranno per invocare che la mafia ritorni, purché non si
faccia più cinema. Lei non si annoia? Io mi annoio terribilmente. Si può anche morire di noia, sa?». L’ombra che si proietta su tutto è quella di una lampedusiana stanchezza, di una città già intorpidita a pochi anni dalle stragi, e nel pieno degli arresti dei boss corleonesi: «Ricorda quando uccisero i giudici, quei giudici? La città sembrava
commossa, moriva dalla voglia di essere riva». E poi, invece «cerimonie, solo cerimonie. Autocelebrazioni. Ora sono incredibilmente stanchi, di nuovo rintanati nella stanchezza. L’atto di
dolore è stato inutile». Il riaggio del regista tedesco si concluderà in luoghi che sono
anch’essi, a modo loro, rovine: l’Archirio di Stato, il cimitero di Santa
Maria di Gesù, il tribunale. A Scarpinato vengono affidate le
riflessioni finali, sulla disappartenenza, l’estraneità di tutti a tutti e a se stessi. A cominciare dai mafiosi e dai giudici: «Chi entra in Cosa
Nostra non si appartiene più. Ma anche noi che siamo dall’altra parte della barricata finiamo col non appartenerci». Non appartengono il tempo (sempre occupato), lo spazio (controllato), le persone (non ci si
può fidare), le parole (devono essere soppesate, a Palermo). Non si appartengono i preti, o i giornalisti. E neanche le persone comuni, che vivono a Palermo rimuovendola. Eppure in questa visione desolata, e forse perfino compiaciuta, un finale ottimismo della volontà emerge
dalle parole del magistrato: Palermo è anche il luogo dell’etica, della «verità davanti a se stessi» mentre altrove la differenza tra il bene e il
male sfuma nelle mille tonalità di grigio. Qui la distinzione è netta: ci
sono gli assassini, e ci sono coloro che si oppongono. Scegliere tra il bene e il male è più facile. Il film pare però smentire, col proprio
procedere, con il proprio ovattato caleidoscopio di immagini, con la propria stessa implosione, queste parole di netta separazione tra
«noi» e «loro», che restano utile testimonianza anche perché, solo
una decina d’anni dopo, sarebbero state assai più difficili da . 21 pronunciare . 5. Masculi e Angelesse. Forse il lungometraggio più esemplare del fermento culturale
palermitano degli anni novanta è Tano da morire di Roberta Torre. Il film, presentato alla Mostra di Venezia del 1997 (sezione Settimana della critica), arriva alla fine di un lavoro pluriennale della regista:
stabilitasi a Palermo nel 1990, folgorata dal mondo del
sottoproletariato, Torre vi aveva trovato non solo un universo di storie, ma anche una sfida per nuovi modelli estetici. La svolta nella
sua produzione avviene con Angelesse (1994), film-intervista di
un’ora a varie donne di quartieri popolari e periferici, in cui si intuisce
la ricettività dell’autrice. H film viene distribuito insieme a una rivista dalla vita brevissima, «Casba», diretta da Marcello Benfante. Nel 1995 l’indagine sulla città si approfondisce, con i cortometraggi II cielo sotto Palermo, Angeli dalla faccia storta, Spioni, che da un lato
danno voce a una città refrattaria al cambiamento e imbevuta di cultura mafiosa, dall’altro cominciano a mettere in opera un
linguaggio ibrido e sperimentale: uno stile che risulta ancora più accentuato in Le anime corte, dello stesso anno, su varie forme di
pazzia, eccentricità, leggibile in parallelo con il Repertorio dei pazzi
della città di Palermo di Roberto Alajmo (la cui prima versione esce
per le Edizioni della battaglia nel 1993). Ma nel 1995 c’è anche la prima testimonianza del «progetto Tano». Perché Tano da morire è anche il punto d’arrivo di un lavoro di inchiesta e laboratorio, alla ricerca dell’opzione stilistica più adeguata
per trovare un equilibrio tra autorappresentazione e distanza, fuga dal realismo e veridicità. Il cortometraggio Appunti per un film su Tano è un’intervista a Enzo Paglino, cognato di un piccolo boss della
Vucciria, che dà del parente defunto un ritratto personale. Insieme al film viene pubblicato un volumetto, costituito dalle interviste a Paglino e alla sorella di Tano, Franca, e da appunti di regia che
cercano già un’originale chiave espressiva: il film è definito un 22 «musical-horror» . E a questo punto, infatti, che si fa strada la chiave del musical, come opzione di distanziamento dalla retorica del
mafia movie. Ne danno testimonianza altri due cortometraggi, Verginella, che è appunto un musical girato nei quartieri popolari, e
La vita a volo D’Angelo, film-intervista che sancisce l’incontro con Nino D’Angelo.
La scelta della canzone napoletana è antropologicamente ineccepibile: la canzone pop fruita dal sottoproletariato urbano in
Sicilia è da sempre quella partenopea, sia nei suoi esponenti ufficiali (D’Angelo racconta di aver conosciuto il successo prima a Palermo che a Napoli) sia attraverso una serie di interpreti locali, che cantano comunque tutti nel dialetto napoletano sulla scia di Merola o dei
neomelodici. I casi più noti sono quelli del siracusano Carmelo
Zappulla e del catanese Gianni Celeste, il più tragico quello di Pino Marchese, richiestissimo nelle feste anche di esponenti mafiosi: incauto amante della sorella, sposata, di Giuseppe Lucchese, killer di
Cosa Nostra, fu ucciso e poi evirato nel luglio del 1982.
Tano da morire si presenta anzitutto come un patchwork di stili e di spunti diversissimi: i funerali ripresi in campo lungo vengono da Cipri e Maresco, la parte centrale della cerimonia funebre deve molto
a Fratelli di Abel Ferrara. Tutto ruota infatti intorno al funerale del
boss, e si sposta avanti e indietro nel tempo, nella parruccheria in cui un gruppo di donne di mafia fa da coro, oppure nella macelleria di Tano. A emergere è anzitutto la gelosia maniacale del piccolo mafioso
verso le sorelle e la figlia: ma sarà proprio quest’ultima a tradirlo involontariamente, accettando la corte di un giovane che si rivelerà
essere un killer incaricato di eliminarlo. La storia viene raccontata da
più punti di rista, attraverso interriste frontali che si incastrano in flashback di Tano bambino, sue immagini di sogni, incubi e
premonizioni di morte, puntellata da memorabili numeri musicali di D’Angelo, di estrema varietà: dalla dance alla techno, dal rap al melodico stile Fred Bongusto.
Tano da morire è infatti, come detto, un’opera-laboratorio e anche
un’opera collettiva che utilizza l’apporto di vari collaboratori: Nino D’Angelo, Daniele Cipri che alla prima esperienza come direttore della
fotografia si scatena in un’esplosione di colori opposta al mondo di Cinico Tv, il montatore Giogiò Franchini, che mescola i materiali in
un andirivieni impazzito. Sulla vicenda incombe un destino di morte, che dà conto di «una componente sadomasochistica riciclata in un comportamento ririlistico e consumistico», perché «il valore positivo
che ossessiona il mafioso è la morte»
. Eppure il tono è vivacissimo,
quasi euforico. A rivederlo, Tano trasmette in effetti anche
l’entusiasmo di un momento in cui la mafia appare per la prima volta comprensibile e battitoie: è un film che, in un approccio sostanzialmente antropologico, mostra il carattere di vacuità, di
funerea farsa della mafia (le frasi finali di Tano davanti ai parenti, il suo accorgersi che il suo potere era basato sul nulla). Il continuo
conflitto è tra l’autorappresentazione della mafia e il suo collegamento
a forme infime del pop. Cosa Nostra non è più qualcosa di arretrato,
ma di interno al mondo dei media: solo, più degradato e risibile. La prospettiva femminile diventa il punto da cui scardinare questo
mondo dall’interno, andando anche al di là della cultura mafiosa, se è
vero, come scrive Renate Siebert, che «nella famiglia mafiosa, un
ibrido tra cultura contadina e cultura piccolo-borghese, la donna appare intrappolata negli aspetti peggiori di entrambe le culture: le
viene negato sia il potere de facto che ricopriva nella famiglia
contadina, sia l’accesso all’uguaglianza formale e all’emancipazione, 24 tipica della famiglia piccola e media borghese» . Dopo l’incerto Sud Side Stori, funestato da vicissitudini produttive,
la regista toma a raccontare la mafia in un titolo che ha avuto minore
risonanza ma che è probabilmente uno dei più originali film sul tema realizzati nel nostro paese. Angela parte anch’esso da una storia vera, ed è ambientato nel 1984. Già la costruzione temporale ne segnala la
singolarità: nell’arco di quasi un anno, con lunghe ellissi, seguiamo la
vicenda di Angela, moglie di un grossista di droga per conto di Cosa Nostra. La vediamo nel quotidiano, in una dimensione
antispettacolare, minuziosa, fenomenologica, nel negozio di scarpe che serve anche da base di smistamento, nei rapporti con la rete di complici (tutti signori anonimi, distinti, mostrati non come criminali
ma come grigi collaboratori di questa rete di commercio: personaggi normali, in cui la scelta delle facce da parte della regista è esemplare). Questa routine viene incrinata dall’arrivo di un figlioccio del marito di Angela, Masino, bel giovane donnaiolo, col quale la donna intreccia presto una relazione.
Precorrendo per certi versi Gomorra di Garrone, il film sceglie di raccontare non direttamente la mafia, ma l’indotto, i commercianti,
l’infima borghesia e il sottoproletario che fiancheggiano Cosa Nostra e da essa sono economicamente sostenuti. Andando in direzione
contraria rispetto a Tano da morire, la regista mostra una Palermo notturna, spesso sotto la pioggia, filmata con una macchina a mano che sta addosso ai personaggi e con una musica eseguita da pochi strumenti.
Dopo aver mixato e bruciato allegramente in Tano da morire tutti gli stereotipi, Torre va oltre, e sperimenta un’estetica che toglie di scena ogni folklore. E non per sostituirvi la retorica occulta del cinema d’autore, ma per concentrarsi su un personaggio
. Il film è tutto
fisicamente addosso ad Angela, serrata dalla macchina da presa (è ancora ricino l’esempio di Rosetta dei fratelli Dardenne), e la prospettiva è la sua, tranne i frangenti in cui vediamo i poliziotti che
la intercettano. Ma anche questo momentaneo spostamento conferma, anzi accentua, la dimensione claustrofobica del film, creata assumendo la prospettiva di una donna che insieme spia (le attività
dei maschi che coordinano le attività criminali, spesso da lei sbirciate da dietro gli scaffali e le pile del retrobottega) ed è spiata (dagli
uomini del quartiere, dall’amante che dapprima la vede non risto, dalla polizia che la segue e la fotografa).
La scelta stilistica monocroma, mantenuta rigorosamente, riesce a convogliare in realtà numerosi temi visivi e non solo: una visione
quotidiana e anti-eroica della mafia, minuziosa, credibile; una prospettiva femminile con i temi classicamente femministi dello
sguardo maschile inseriti in una vicenda in cui si configura davvero
una guerra di sguardi (lo sguardo di Angela stretto tra una sequela di sguardi maschili, ma anche il suo guardare nascosta come elemento di 26 .... , ,. disvelamento) ; la contrapposizione visiva tra l’universo di morte della mafia e quello vitale di Angela, espresso attraverso l’erotismo, la
fisicità che la regista asseconda nelle scene di sesso con Masino (un tema appena emerso, all’epoca, nelle ricerche di Renate Siebert, e al
cinema in Fratelli di Ferrara); l’indicazione precisa della dimensione economica (ironicamente sottolineata quando il marito di Angela, a
una visita oculistica, deve leggere sul tabellone un brano di Luigi
Einaudi). Confrontando Angela con Tano, si può vedere retrospettivamente
in controluce la differenza tra due diversi momenti nella coscienza della mafia: da un lato, ima visione interna sempre più precisa, un
assestamento delle opzioni estetiche, sempre più congrue; e dall’altro,
una sempre maggiore amarezza di fondo. In questa chiave va letto
anche l’aggiornamento della prospettiva di gender. Dalla mascherata irridente di Tano da morire, che ironizza sul maschilismo mafioso inscenando una cerimonia di affiliazione come fosse un gay party, si
passa a un gioco sottile sul punto di vista femminile, demistificante
ma privo di sbocco e destinato a un’amara solitudine, da parte della 27 comunità di appartenenza e delle istituzioni . Anche Angela si traveste (da donna d’affari), ma il suo percorso di potere dentro la struttura mafiosa è illusorio, così come la sua fuga, esclusivamente
erotica e sentimentale. Scardinare il maschilismo non sembra bastare più, o quanto meno appaiono sempre più drammatiche le aporie: per 28 le Angele e le Angelesse non sembra esserci speranza .
6. È stato il figlio: ovvero come Giuseppe Greco divenne Giorgio Castellani.
Negli anni novanta, però, il cinema offre anche una testimonianza
diversissima con i due titoli di Giorgio Castellani, pseudonimo dietro cui si nasconde Giuseppe Greco, figlio di Michele detto «il Papa», boss della borgata di Ciaculli e a capo della Cupola di Cosa Nostra negli 29 anni della sanguinosa ascesa dei corleonesi . Proveniente da una
vecchissima famiglia mafiosa di origine contadina, possidenti in una
zona di agrumeti tra le più fiorenti dell’isola, Greco sr. era l’erede di
due dinastie omonime delle borgate orientali di Palermo (Ciaculli e Croceverde-Giardini), che dopo sanguinosi conflitti si erano unificate.
Le sue funzioni di mediatore, hanno ribadito in molti, nascondevano
una completa subordinazione alla scalata di Riina e soci, un costante doppio gioco nei confronti dei suoi alleati delle cosche perdenti (a 30 cominciare da Stefano Bontate) . Greco è stato descritto come una figura grigia, mediocre, a dispetto dell’enorme prestigio della sua carica, sancita anche al maxiprocesso, dove rimangono celebri un paio di sue uscite: una contro i «film di violenza»3 e un minaccioso
augurio finale ai giudici
32
. Il boss, la cui appartenenza a Cosa Nostra
emerse solo negli anni ottanta, amava mostrarsi come possidente legato alla terra, borghese con ottime frequentazioni (anche con
politici e magistrati), e soprattutto uomo di grande religiosità (donde, 33 . . . pare, il soprannome) . Questi dati ideologici (la devozione e la fedeltà ad antichi valori), più ancora del gusto della rispettabilità e del savoir vivre, sono utili per esplorare la versione cinematografica che della sua figura darà il figlio.
Giuseppe Greco, a onta del cognome che portava, risulterà sempre estraneo a qualunque attività criminale, e a quanto si sa non era
affiliato a Cosa Nostra
. Tuttavia, negli anni è coinvolto in due
indagini antimafia, nel 1982 e nel 1992, ma in entrambi i casi viene
scagionato. E a quanto pare, durante l’ascesa sanguinosa dei
corleonesi Badalamenti aveva proposto a Buscetta di vendicarsi dell’omicidio dei suoi figli uccidendo proprio Giuseppe, ma il «boss dei due mondi» aveva rifiutato33. Pur non rinnegando la propria
famiglia e difendendo sempre il padre dalle accuse, Greco jr. è insomma totalmente ai margini delle attività criminali, e mentre esplode il decennio più feroce della storia di Cosa Nostra lui coltiva il suo sogno cinematografico. Appassionato di cinema da sempre, grazie
ai soldi del padre produce e interpreta una commedia sexy, Crema
cioccolata e pa... prika (1981), diretta da Michele Massimo Tarantini e girata a Palermo e dintorni con un cast notevole: Renzo
Montagnani, Barbara Bouchet, Silvia Dionisio, Giorgio Bracardi, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Proprio questo film sarà all’origine del suo secondo arresto, perché la Mercedes che vi compariva era
stata prestata dall’esattore Nino Salvo, grande elettore andreottiano, e
si era sospettato che quell’auto fosse un tramite per il riciclaggio di 36 % denaro sporco . Per il nostro discorso, però, i titoli davvero importanti sono le prime due regie firmate da Greco, quando assume
lo pseudonimo di Castellani (Castellana era il cognome della madre)3. Vite perdute nasce sulla scia di Mery per sempre, anzi più
precisamente di Ragazzifuori, che si svolgeva fuori dal carcere minorile. Dai due film proviene buona parte degli attori: Filippo Genzardi, Maurizio Prollo, Salvatore Termini, Alfredo Li Bassi, Carlo
Berretta. Questi nomi appartenevano all’agenzia di Enzo Castagna, personaggio ben introdotto nei quartieri popolari di Palermo, proprietario di un’impresa di pompe funebri, più volte al centro di
inchieste giudiziarie e poi immortalato in Enzo, domani a Palermo! di Cipri e Maresco. Protagonista è invece Gianni Celeste, emulo catanese
di Nino D’Angelo e idolo delle feste di piazza siciliane. La trama, abbastanza contorta, segue le avventure di un gruppo di criminali di
strada a Palermo. Uno (Genzardi) è innamorato della figlia di un
magistrato, che però lo disprezza. Non rimane che rapirla, ma nel tentativo la ragazza precipita con l’auto e muore, e uno dei complici, Rosario (Celeste), uccide un poliziotto. La banda si dedica allo spaccio
e agli scippi, mentre il povero Scimmietta (Termini), non trovando lavoro, si mette a fare il magnaccia. Di colpo in colpo, entrando e
uscendo di galera, alla fine morirà uno dei ragazzi: Salvatore, che era stato ingiustamente sospettato di essere una spia. Lo schema narrativo oppone rozzamente criminali di strada e
borghesia, per cui politici e avvocati sono i veri cattivi: «La colpa è della società», proclama uno dei personaggi, e a un certo punto
Celeste afferma sarcastico: «Io sugnu comunista». Altro elemento
ideologico di rilievo è un cristallino maschilismo: le donne sono deboli e da proteggere 0© madri e le sorelle), ma anche infide e seduttrici. Quando Salvatore confessa di essere innamorato della sorella
dell’amico Pietro Ca quale ad ogni buon conto gli ha messo nel caffè un filtro d’amore composto dai propri peli pubici), Rosario gli ricorda che la donna allontana da Dio e dagli amici, e anche Adamo si
perdette per colpa sua: «A fimmina all’uomo che ama lo vorrebbe
incatenare, ma il tempo delle catene è passato da un pezzo». Tutti questi dati sono però secondari rispetto al cuore visivo e
ideologico del film, che è l’uso dell’iconografia cattolica, dei testi sacri, delle immagini devozionali, dei riti. Già i titoli di testa mostrano una
statua della Madonna sulle note dei Carmina Burana di Orff, che proseguono arrangiati in una versione rock da Claudio Simonetti. C’è ovviamente una processione con santa Rosalia, e davanti a un crocifisso Rosario si lancia in una preghiera esemplare:
Oh Signore, io veramente non sarei degno di entrare nella tua casa, ma basta che did soltanto una parola e io sarò salvato. Una tua parola passa più di quella dell’onorevole Andreotti. Sì, è vero, sono un po’ delinquente, ma che d posso fare? È la vita. Vuol dire che il destino ha voluto accussì, non è colpa mia.
Io non avrei voluto essere quello che sono, ma essere un altro: un grosso
commerdante, un industriale, e no uno così. [...] Io voglio il tuo aiuto. Ti dico questo perché so che Dio esiste: lo diceva sempre mio patri, e per dirlo lui vuol dire che è sicuro. Anche se non vengo sempre a trovarti, ricordati di mia. Io so molte cose di te, mi informo sempre sul tuo conto, e sai perché? Perché ti
stimo, e forse ti invidio pure. Anche se sei morto a 33 anni, però eri già uno famoso e persino re. Questa sì che è vita. Sei stato tu che hai inventato il
proverbio: meglio un giorno da leone che cent’anni da pecora, non è vero? Ci averi ragione. Anch’io d metterei la firma essere prima re dei giudei e poi
morire a 33 anni crocifisso. Megghiu Crocifissa ca sparata! Il passo è un riassunto della visione mafiosa della religione, come
l’hanno spiegata i teologi negli ultimi decenni, perché, come ricorda
un passo già citato di Nino Fasullo, i mafiosi «al Dio della religione credono solo in quanto lo imitano, lo eguagliano, si pongono al loro 38 livello» . Il loro è un Dio potente, non quello misericordioso né tanto meno quello della kènosis che si spoglia di ogni prerogativa divina.
Riferimenti biblici attraversano tutto il film di Castellani, in una
chiave di superomismo e di identificazione eroica con la parola sacra (non diversa dall’uso dell’immaginario Ezechiele, 25:17 nel venturo
Pulp Fiction di Tarantino). «Di’ solo una parola e io sarò salvato»,
ripetono i ragazzi al magnaccia romano prima di stringergli i testicoli
in una tenaglia, e Rosario, dopo aver parlato con l’onorevole presso cui lavora sua madre (costretta a concedergli favori sessuali) esclama tra sé e sé un mix di passi veterotestamentari (Amos, 3:15 e Naum, 1:
12): «Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e maltrattate gli umili. Demolirò le case d’inverno, andranno in rovina le case d’avorio,
e scompariranno i grandi palazzi. Così dice il signore! Siano pure potenti e forti, siano pure numerosi, ma saranno falciati e spariranno.
Ricordatelo, onorevole dei miei stivali!».
La scena dou è un’ultima cena in cui uno dei componenti della banda, Pietro, è sospettato di tradire Rosario. L’inquadratura
riproduce quella frontale più volte vista al cinema, in variazioni più o meno blasfeme, da Viridiana di Luis Bunuel a Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini. Gianni Celeste/Rosario declama: «Quello che devi
fare, fallo subito», poi dice a Pietro che prima che canti il gallo lui lo tradirà. E conclude così: «Egli prese il salame, u tagghiò, lo diede ai
suoi amici e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il salame...
dell’ultima rapina ai supermercati!». Rosario è il vero protagonista del film, quello di cui il regista
subisce di più il fascino, e che però vede anche come personaggio
autodistruttivo. Alla base del suo comportamento c’è un desiderio di rivalsa, un superomismo che si nutre di citazioni sacre («Ci sono due
categorie di uomini: i vermi, che sanno solo strisciare e leccare i piedi,
che devono ubbidire perché sono senza cervello e senza volontà, e poi ci sono i doni di Dio, quelli superiori, quelli che comandano, i veri
uomini, quelli che hanno potere forza, tutto!»). Per tutto il film si mostrano le intemperanze del personaggio, ma anche la giustezza di fondo che lo sospinge (gli altri sono davvero vermi, deboli, o
profittatori sui quali affermarsi con la violenza).
Gli attori sono tutti doppiati, ma i cattivi (un magnaccia ubriacone,
un onorevole che ricatta la madre di Celeste) vengono da fuori e parlano con accento napoletano o romano: insomma, l’apologià della
piccola criminalità può essere compiuta a patto di rimuovere l’esistenza di Cosa Nostra. La regia mostra improvvise ambizioni
artistiche, come il suicidio finale della sorella di Pietro sulle note
dell’Adac/zo di Albinoni, e la frase di Jung che compare prima dei titoli di coda: «Ogni uomo deve conoscere senza reticenze quanto bene può fare, e di quale infamia è capace, guardandosi dal considerare reale il
primo e illusoria la seconda». Vite perdute è, al di là del suo valore artistico, un documento di
enorme interesse, specie se inserito nel contesto produttivo e
culturale locale e nella sua interazione con modelli nazionali; ma ancora più prezioso è I Grimaldi, seconda regia firmata da Castellani.
Si tratta infatti, esplicitamente, di un ritratto del padre del regista, in cui il quarantatreenne Greco sublima la propria visione di una mafia
arcaica e contadina. Il film, oggi quasi invisibile (ne conserva una copia positiva la
Cineteca nazionale), merita che se ne riepiloghi la trama. Girato in
parte nel vero fondo della Favarella di Greco sr., è la storia di don
Antonio Grimaldi, interpretato (sotto lo pseudonimo di Daniel Romero) dall’attore Adriano Charamida, la cui somiglianza con «il Papa» è impressionante, e che viene doppiato da Peppino Rinaldi,
voce italiana di don Vito Corleone nel Padrino, di cui replica tono e cadenza: unione di reale e immaginario già significativa. L’anziano don Antonio, soprannominato «il patriarca», è un vecchio proprietario terriero legatissimo alle proprie teire e appassionato di
caccia, motivo per cui è molto abile con le armi da fuoco. Quando gli chiedono, al commissariato, la professione, lui risponde: «proprietario».
Il nipote di don Antonio, Rosario, con poca voglia di lavorare e molto desiderio di emanciparsi dal nonno, accetta di custodire alcune
merci per conto di malviventi (è eroina, ma lui non lo sa). Don
Antonio malmena un componente della banda, e quando questi continua incautamente a provocarlo lo sgozzano. Occultato il
cadavere, il Patriarca dà una lezione al nipote con una dose di frustate. Poi accetta un colloquio con un emissario dei narcotrafficanti
che rivogliono indietro la merce; ma, ancora una volta provocato («Se
un bel giorno vi scannano e restano sulu i fìmmini, cosa devono fare per vivere? Le buttane a Milano?»), lo abbatte a bruciapelo, e fa
sparire anche questa nuova salma: vista la situazione, fa poi nascondere il nipote in una grotta. Nel frattempo, i trafficanti sono
messi a loro volta alle strette da un boss (napoletano) che intima di consegnare la droga o i soldi e, per velocizzare l’accordo, fanno rapire
e uccidere il padre di Rosario (genero dunque di don Antonio, che peraltro lo detesta). Viene fissato un appuntamento per la consegna
dell’eroina: la banda progetta di uccidere don Antonio, il quale però tende un contro-agguato e stermina tutti. La polizia scova il nascondiglio di Rosario, ma non avrà da lui alcuna informazione:
«Uno o due giorni al mese volentieri decido di rinchiudermi in un luogo propizio alla meditazione: Gandhi, San Tommaso, Pascal, Marx,
Mao. C’è chi ama andare a puttane, io vado a grotte». Il giudice
capisce che non ne caverà nulla («è gente coriacea questa, di antico
stampo») e dà parere favorevole alla scarcerazione di don Antonio. Rosario dapprima medita di andarsene dalla Sicilia, ma la madre lo
dissuade: «Non è fuggendo che risolverai il tuo destino. Rimani: è il
solo modo perché tutto cambi». Alla fine, dunque, il giovane resta e chiede al nonno di poterlo aiutare in campagna, mentre le donne di casa sorridono, e un’inquadratura dall’alto sancisce l’armonia familiare ritrovata.
Come in Vite perdute, tutto si gioca su un equilibrio parziale tra adesione e distanza da un protagonista, che ha certo tratti discutibili,
ma di cui non si mettono in discussione le basi: la durezza e la rigidità del patriarca scalfiscono solo in parte la sua solidità morale. , 39 Nonostante alcuni personaggi (soprattutto, in questo caso, la figlia)
eccepiscano qualcosa al suo sistema di valori, non c’è dubbio che lo spettatore parteggi per il vecchio. La prima apparizione di don
Antonio è di spalle, davanti al caminetto, mostrato con un movimento di macchina circolare, in penombra, e in seguito verrà spesso inquadrato in primo piano, dal basso.
La sua visione del mondo è una specie di derivazione di quella nota
ai liceali italiani come «ideale dell’ostrica», esposta da Giovanni Verga nella novella Fantasticheria: la dannazione viene dal tentativo di
cambiamento, dalla brama di mobilità sociale che si impossessa della civiltà contadina. Le sentenze del vecchio, che è in effetti una versione contemporanea di padron ’Ntoni Malavoglia (ne ha anche il nome)
sono lapidarie: «Il progresso lo accetto, la merda no»; «Non c’è più
rispetto per certe regole di vita che erano sacre e inviolabili». La sua
visione della famiglia è serrata, a cerchi concentrici di cui lui è il centro: quando suo genero, in riferimento al figlio, dice: «Sono il
padre e ho diritto di sapere», lui ribatte: «E io sono il nonno e ho più
diritto di te».
D’altro canto, pendant della sua limpidezza morale è la completa
estraneità al mondo della droga, anzi perfino l’ignoranza di cosa la droga sia; tanto che quando trova il pacchetto con l’eroina il suo
guardaspalle si sente in dovere di spiegare: «Chista è droga, don Antonio. Eroina. Ciuri di papavero. La usano tanti... e poi li fa nesciri
pazzi!». E, con uguale piglio didattico, i trafficanti preciseranno poco
oltre: «Forse in campagna non lo sapete, ma vale un sacco di
picciuli». Le parole «Cosa Nostra» o «mafia» non vengono mai pronunciate, ma l’opposizione centrale del film è quella classica tra
una vecchia e una nuova mafia. I trafficanti vengono, curiosamente,
definiti «stiddari». La «stidda» da qualche anno era emersa nelle cronache come organizzazione di mafiosi «scissionisti» del Nisseno e dell’Agrigentino, particolarmente legati alla microcriminalità urbana. Il disprezzo del vecchio patriarca («E tu pensi che tuo nonno si faccia
intimorire da quattro stiddari di merda!») è dunque, un certo senso,
comprensibile. A loro volta, gli stiddari fanno capo a dei boss che 40 «vengono da fuori», parlano con accento napoletano e atterrano a Punta Raisi a regolare i loro affari. Quasi una gaffe, quest’ultima: nella realtà era infatti proprio Michele Greco uno dei tramiti più saldi tra Cosa Nostra e la camorra, avendo un legame diretto con il clan . . . 41 Nuvoletta, che secondo alcuni era anzi alle sue dirette dipendenze .
Ma c’è un ulteriore elemento, meno evidente, nel rapporto del protagonista con gli altri personaggi: il parziale autoritratto che il
regista compie attraverso il personaggio di Rosario. Il figlio che ha dirazzato, che rifiuta la campagna, che si è iscritto prima a
Giurisprudenza poi a Belle arti senza concludere niente («Chi ha delle
terre da coltivare e difendere, non studia belle arti. [...] Se deve studiare, studia agraria»), è una versione degradata di Giuseppe
Greco stesso, che aveva anche lui tentato studi giuridici; una versione
autoflagellatoria in cui al posto del cinema ci sono le cattive compagnie e il traffico dell’eroina. Una maniera contorta di mettersi
in scena e si direbbe di punirsi, davanti alla salda seppure un po’ ottusa coerenza paterna. Lo stile del film, pur restando nei limiti di una rozzezza quasi
comica, ha, dato l’argomento, un andamento più ieratico, meno
convulso del giovanilista-metropolitano Vite perdute. Nella memoria
rimane soprattutto la maldestra riuscita della scena in cui per rappresaglia vengono massacrate le pecore di don Antonio: quando questi arriva a controllare la strage, gli orini, pur ricoperti di sangue
finto, in realtà respirano vistosamente, si muovono e addirittura in
qualche caso si sollevano. Dal punto di rista formale, però, l’elemento
più interessante è il doppiaggio. Oltre a don Antonio/Michele Greco che parla con la voce di Vito Corleone, è tutto il film a essere doppiato
da cima a fondo, con effetto stremante. Interpretato quasi esclusivamente da attori palermitani, questo film (come il precedente) era stato integralmente doppiato a Roma, presso una delle più
importanti società del settore, la Pumais. Nel frattempo, invece, il
cinema italiano aveva rinunciato al classico uso del doppiaggio e di un siciliano convenzionale, grazie anche al ricorso sempre più massiccio al sonoro in presa diretta, e all’arrivo di una nuova leva di attori locali.
L’attaccamento del figlio del «Papa» agli schemi formali del mafia morie degli anni settanta conferma dunque la loro completa fungibilità per qualunque scopo, ma anche il ritardo del regista
rispetto ai nuovi modelli estetici e produttivi del cinema italiano. Alla presentazione pubblica dei Grimaldi il regista annunciava una
specie di ampliamento ideale del film: un vero e proprio biopic sul
padre, stavolta senza infingimenti. Così raccontava alla stampa: «Il film comincerà mostrando mio padre bambino e arriverà fino ai giorni nostri. Per questo avrò bisogno di tre protagonisti, un ragazzino, un giovane e
un anziano. Per la parte da giovane mi piacerebbe avere Marco Leonardi, per quella da vecchio bisogna vedere: magari sarà un attore straniero. Voglio fare
un grande affresco, pieno di dramma, di passione, di sentimento». E le disavventure, ovvero l’arresto, il carcere e la condanna? «Parlerò anche di quelle ma senza entrare nei dettagli. A me interessa puntare sui sentimenti e
poi voglio raccontare particolari inediti della vita di mio padre. L’ho informato lunedì scorso di questo progetto ed è molto contento». Greco, che lascia
intendere di avere sottoposto il progetto a una casa di produzione americana, ha già scritto una bozza di soggetto. «Un “malloppo* alto così dal quale basta estrarre cinque 0 sei spunti per ricavare una sceneggiatura di due ore». Ma
come la mettiamo coi crimini del padre? «Io credo nella reincarnazione» azzarda Greco «e dico che mio padre paga colpe non sue perché il destino di ogni uomo è già scritto: mio padre vive la vita di un altro»4*. In realtà questo progetto (che, a sentirlo raccontare così, sembra
una specie di «doppio» malvagio di Boaria di Giuseppe Tomatore,
per giunta con il protagonista di Nuovo Cinema Paradiso) non si farà mai. Greco farà però in tempo a firmare un’ultima regia, dal titolo sorprendente: La mafia dei nuovi padrini. Sorprendente perché in questo film, in realtà, di mafia e di padrini non c’è traccia (si tratta di
una rapina ai danni di un alto funzionario americano). È come se,
avendo taciuto il nome (e in parte la cosa) nei film precedenti, Castellani/Greco avesse infine pronunciato «the M word», addirittura
nel titolo del film, però a sproposito. Eppure questo piccolo dato lessicale ci dice forse qualcosa di utile.
Siamo a metà degli anni duemila, nel pieno delle fiction sugli eroi di
mafia e un attimo prima di quelle sui boss. Cosa Nostra è ormai un Grande Racconto non solo giornalistico e storico, ma anche
spettacolare. I politici, anche i più ambigui, non ne negano più
l’esistenza, ma organizzano manifestazioni antimafia; gli
imprenditori, anche i più collusi, capiscono l’importanza delle sigle
antiracket; le squadre antimafia garantiscono lunga, lunghissima serialità. Si è già ricordata la risposta ironica del boss Luciano Liggio,
alla domanda se esistesse la mafia: «Se esiste la commissione
antimafia, esisterà anche la mafia». Alla metà degli anni duemila, per chi proviene da una cultura mafiosa, la risposta può essere anche ancora più paradossale: «Se esiste il cinema di mafia, forse non esiste
la mafia».
1 In verità una prima svolta avviene già in occasione dell’omicidio Dalla Chiesa: dall’agosto
1980 all’agosto 1983 l’infonnazione sulla mafia raddoppia sui principali organi di
informazione: il 252% su «la Repubblica», il 221% sul Tgi, il 194% sul Tg3, il 186% sul Tg2 (G. lozzia - G. Prillila, Dal silenzio al rumore. L’informazione quotidiana e due delitti di mafia, Rai, Segreteria del Consiglio di amministrazione, Verifica programmi trasmessi, n. 64,
1984). 2
S. Cusimano, La Rai al tempo dell’emergenza. Venticinque anni in prima linea, in
L'isola in onda. Storia della Rai in Sicilia dalla Liberazione ai nuovi orizzonti mediterranei, a cura di S. Cusimano e G. M. Costa, Eri, Roma 2009, pp. 94-5. 3
La Luna, Palermo 1987.
4
In appendice a Meri per sempre dt, pp. 105 sgg. Il volume del 1987 venne segnalato da
una recensione di Goffredo Fofi su «l’unità» del 16 settembre 1987, che contribuì a farlo
circolare al di fuori dell’ambito locale. 5
La madre del giovane, dopo la prima veneziana, chiese il sequestro del film: cfr. U. Rosso,
Sequestrate ilfilm su Palermo. Racconta la morie di miofiglio, in «la Repubblica», 29 settembre 1990. Sull’episodio sono intervenuti lo stesso anno anche i registi Cipri e Maresco,
con il documentario Loro di Palermo (1990), composto di interviste ad amici di Consiglio. 6
F. Casetti, Prima e dopo Palermo, in «Nuove Effemeridi», 1991,13, p. 38.
Nei confronti di Rosario Livatino, definito da papa Wojtyla «martire della giustizia e indirettamente della fede», è in corso la causa di beatificazione. Sulla fortissima ispirazione
religiosa del suo operato si veda la conferenza Fede e diritto, che egli tenne il 30 aprile 1986 a
Canicattì, presso le suore vocazioniste: http://wnv.solfano.it/canicatti/fedeediritto.htm. 8
Tutte le verità di Taurisano davanti ai vertici del Csm, in «la Repubblica», 24 settembre
1991. L’inchiesta di Taurisano lo vedeva tra l’altro contrapposto, per un conflitto di
competenze, alla procura di Marsala allora diretta da Paolo Borsellino. 9
Nel giro di un anno, ad esempio, Fragasso aveva girato ben tre seguiti apocrifi di horror
americani: con il nome di Clyde Anderson La casa 5 e Non aprite quella porta 3/Night Killer
e come Drake Floyd Troll 2. IO li
Si veda supra, p. 25.
Accanto a esponenti del cast di Mery per sempre e della scuderia di Enzo Castagna,
toma il versante romanesco con Bova, Tirabassi, Ricky Memphis, e una sottotrama romana
con un poliziotto ex ladro di auto che va dai suoi vecchi amid e dalla ragazza e viene da questi disprezzato. 12
Nel prosieguo, Ultimo viene inviato in Calabria, e finisce col fondare una casa-famiglia.
Episodio, anche questo, con un riscontro nella realtà: l’Assodazione Volontari Ultimo, che si
occupa di minori e soprattutto di figli di detenuti, esiste veramente, alla periferia est di Roma (www.volontaricapitanoultimo.it). 13
A. Bolzoni, Gli uomini d’onore diventano antimafiosi, in «la Repubblica», 24 giugno
2006. L. Abbate - P. Gomez, I complici. Tutti gli uomini di Provenzano da Corleone al Parlamento, Fazi, Roma 2007, PP- 85-6. La figura centrale per far da tramite tra queste inirtative antimafia di facciata e Prov'enzano medesimo che le autorizza, attraverso il boss
Nicola Mandalà, è il giovane Francesco Campanella, già presidente del consiglio comunale della cittadina e poi segretario nazionale dei giovani delTUdeur. 14 Cavedi, Il Dio dei mafiosi dt, p. 17. 15 Per ima cronaca ironica della vicenda, molto critica verso le politiche culturali di
Orlando, si veda P. Violante, Swinging Palermo, Sellerie, Palermo 2015, pp. 190-206. 16
Cfr. L Azzolina, Governare Palermo. Storia e sociologia di un cambiamento mancato,
Donzelli, Roma 2009, in particolare le pp. 74-7; J. C, Schneider - P. T. Schneider, Un destino
reversibile. Mafia, antimafia e società civile a Palermo (2003), Viella, Roma 2009, spede pp. 207-60. 1 Sull’attività cinematografica dell’epoca si veda E. Morreale, Lampi suR'isola. Nuovo
cinema siciliano, igSS-iggó, Edizioni della battaglia, Palermo 1996. Sul contesto culturale MBenfante, Palermo città aperta, i «cantieri» della cultura, in Palermo città che cambia, a
cura di G. VaiareDi, Argo, Lecce 1998, pp. 23-41. 18
Tra i titoli di quegli anni ricordiamo il romanzo La stanza dei lumini rossi (e/o, Roma
1997) di Domenico Conoscenti e i libri di Roberto Alajmo, da Repertorio dei pazzi della città di Palermo e Almanacco siciliano delle morti presunte (Edizioni della battaglia, Palermo 1993 e 1997) a Le scarpe di Polifemo (Feltrinelli, Milano 1998). 19
Il regista dichiara di aver avuto come modelli AHemagne année go neufzéro di Godard
e i film di Hans-Jùrgen Syberberg: intervista in M. Oliveri, La memoria degli altri II cinema
di Roberto Andò, Kaplan, Torino 2013, p. 120. 20
21
R. Andò, Diario senza date o della delazione, Gea Schirò, Palermo 2008. Andò tornerà a sfiorare la mafia ventitré anni dopo in Una storia senza nome, ispirato al
famigerata furto della Natività di Caravaggio all’oratorio di San Lorenzo di Palermo nel 1969.
Un caso insoluto, riemerso nelle dichiarazioni di vari pentiti (c’è chi sostiene che il quadro esista ancora oggi da qualche parte). Protagonista è una segretaria e ghost writer (Micaela Ramazzotti) di un regista (Alessandro Gassman) a cui un misterioso personaggio (Renato Carpentieri) fornisce racconti stranamente verosimili, per scrivere una sceneggiatura sul
celebre colpo. Ma i racconti sono troppo pericolosamente simili al vero, e si innesca una
spirale su finzione e verità, originale e copia. Alla fine emerge un intrigo che coinvolge anche mafia e politica: lo scetticismo con tonalità tragiche di Diario senza date è declinato ormai in
toni da commedia pirandelliana, in un teatro morale debitore dell’ultimo Sdasda. 22
R. Torre, Tano da morire, Edizioni della battaglia, Palermo 1996. Nel libretto alcune
scene sono già chiaramente delineate, mentre le scelte musicali sono più vaghe: si parla di
«canzoni e musiche originali di Mario Merola, Nino D’Angelo e Renato Carosone». 23
Siebert, Le donne, la mafia dt, p. 50. Ibid., p. 53.
25 £. È
impossibile non ricordare, a margine, l’importanza che ha, per la riuscita del film,
l’interpretazione di Donatella Hnocchiaro, esordiente al cinema e che prorompe con una fisidtà dolorosa e compressa. 26
Questa coerenza di stile fa sì che nelle scene clou Angela si distacchi decisamente dalle
scelte comuni dei mafia movie: è il caso dell’unico omiddio, spiato da Angela con terrore e
disgusto, mostrato in maniera documentaria, antispettacolare, e del finale, tutto in anticlimax, che rifiuta di «chiudere» e lascia la protagonista in attesa dell’amante, sul molo, come un’eroina del melo. 2”
Anche rispetto al coro delle donne di Tano, oscillante tra amplificazione deH’ethos
mafioso e sua messa in crisi (nel numero musicale Femmene sole, che racconta l’omiddio di
un mafioso da parte della sua donna), appare in maniera più chiara un momento successivo, di cui vengono evidenziati gli aspetti più ambigui 28
Questa prospettiva viene notata, con toni implicitamente critici, da Dara Renga
(Unfinished Business dt, pp. 51-64). Renga nota anche come il personaggio di Angela
rimanga per lo spettatore «incomprensibile»: il che è però anche una scelta di mantenere l’effettiva alterità del personaggio, per lo spettatore medio del cinema, rifiutando di favorire un’illusoria identificazione e una trasformazione, in fondo mistificatrice, del personaggio in
eroina. Cfr. anche C. O’Rawe, Roberia Torre’s Angela: The Mafia and the «Woman’s Film», in Renga (a cura di), Mafia Movie. A Reader dt, pp. 329-37. 29
Varese, Vita di mafia dt, pp. 147-51. Al momento, l’indagine più approfondita sulla
figura di Giuseppe Greco sono le due puntate della trasmissione televisiva Ai confini della
pietà di Cipri e Maresco, andate in onda il 7 e il 14 giugno 2007 su La7. Si tratta di un approccio semiserio ma documentato, con l’intervista a un ipotetico Anthony Greco, un paradossale elogio del regista da parte del critico Gregorio Napoli (che lo paragona
fisicamente a Gérard Philipe), e brani di finti super8 western girati dal piccolo Castellani con gli amid del padre; ma anche dichiarazioni perplesse di Paolo Mereghettì, e interviste a
imbarazzati membri del cast di Vite perdute (Giusy Randazzo, Filippo Genzardi). Nella puntata del 14 giugno la parte più surreale è l’interpretazione della figura del regista proposta
dal (vero) psicoanalista Filippo Di Forti, intervistato in una stanza gremita di volatilL 30
Cfr. F. Viviano, Michele Greco. Il memoriale, Aliberti, Roma 2008.
31
Si veda supra, p. 3.
32
«Io desidero fare un augurio. Vi auguro la pace, signor Presidente, a tutti voi auguro la
pace perché la pace è la tranquillità dello spirito e della coscienza e per il compito che vi
aspetta la serenità è la base fondamentale per giudicare. Non sono parole mie, sono parole di nostro Signore che lo raccomandò a Mosè: quando devi giudicare, che d sia la massima
serenità, che è la base fondamentale. Vi auguro ancora, signor Presidente, che questa pace vi accompagnerà per il resto della vostra vita» (il filmato è visibile in decine di video su
Youtube). 33
A. Dino, La mafia devota, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 116-9.
04
Come ricordò il padre, in maniera che potrebbe considerarsi metaforica: «Giuseppe,
mio figlio, non ha mai avuto la tendenza per la campagna come l’ho avuta io e l’ha avuta tutta la mia famiglia da molte generazioni: mai, Giuseppe mai. Ha sempre avuto la tendenza per la
vita artistica, siccome ha talento in merito. Per abbreviare, un giorno si l’enne insieme al
dunque di potere fare un film. Giuseppe partecipò, se la cavò bene al primo impatto con la cinepresa. Ora però, anziché fare la carriera artistica, le calunnie dei pentiti gli hanno fatto
fare anche a lui la carriera carceraria» (dt in Bolzoni, Parole d'onore dt, p. 305). 35
F. Calvi, La vita quotidiana della mafia da.l1.g50 ai nostri giorni, Rizzoli, Milano 1986,
p. 288. 36
37
Massaro, Cinematografia organizzata cit, pp. 6-7.
Quando questo libro era in bozze, è emersa l’esistenza di un lungometraggio in $uper8
girato da Greco, mai distribuito ufficialmente, ma proiettato in pubblico almeno una volta, in una matinée al cinema Ambra di Palermo. Alla proiezione erano presenti, attratti entrambi
dalla singolarità dell’evento, due giovanissimi cinefili e futuri registi, Franco Maresco e Giuseppe Tbrnatore. Sulle base dei loro ricordi l’evento è databile al 1976. 3« 39
Cfr. supra, p. 168, nota 51.
«Non c’è niente di nobile o di grande in quello che fai. Solo follia», gli dice a un certo
punto la figlia, che ribadisce: «Fuggire con Mario era il solo modo di fuggire da te». 40
Questa scelta deriva, ribaltandola, dall’usanza abituale delle sceneggiate anni settanta a
caratterizzare i «cattivi» come criminali che vengono da fuori, con accento siciliano: si veda
Ravveduto, Napoli... serenata calibro g dt, p. 32 (esempio clamoroso I contrabbandieri di
Santa Lucia di Alfonso Brescia). 41L. Galluzzo, F. La Licata, S. Lodato (a cura di), Rapporto sulla mafia degli anni ’So: gli atti dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, Flaccovio, Palermo 1986, pp. 76,120, 126. 42
1997.
M. Di Caro, Un film su mio padre, U boss, in «la Repubblica - Palermo», 21 dicembre
xiL Prima e dopo La piovra
i. Cera una volta la mafia.
L’interesse della televisione italiana nei confronti della mafia è, fino a tutti gli anni settanta, assai sporadico1. Il primo sceneggiato ad avere un’eco rilevante è Joe Petrosino, diretto da Daniele D’Anza e
andato in onda in 5 puntate nell’ottobre 1972. Lo sceneggiato,
ambientato in gran parte negli Stati Uniti, si occupa di fatti avvenuti
all’inizio del secolo, ma incappa ugualmente nella censura interna: certi riferimenti alle relazioni tra politica e mafia, e frasi che
lanciavano dei ponti con l’oggi, vengono eliminati dalla versione
definitiva, tanto che i due sceneggiatori, Luigi Malerba e Fabio Carpi, tolgono la firma utilizzando due ironici pseudonimi, Luigi Guastalla e . . , . .2 . % . Fabio Gualtien . L’operazione e una cunosa commistione tra
inchiesta, codici del genere e spirito pop, come rivendicano i titoli di testa su fumetti stile «Dick Tracy » e musiche dei New Trolls (la
canzone è Black Hand), e quelli di coda cantati da Fred Bongusto. Le ultime due puntate, con l’arrivo in Sicilia del celebre poliziotto, il suo
assassinio e il processo che ne segue, si fanno più pedagogici, tanto che alla fine l’attore che interpreta Petrosino, Adolfo Celi, in abiti contemporanei si rivolge direttamente allo spettatore: «Al di là dei
nomi dei mandanti, dei killers e dei complici, che non conosceremo
mai, c’è una verità che conosciamo. Rincorreva dei delinquenti comuni ed è andato a sfracellarsi contro un ostacolo che non aveva preristo: l’alta mafia. È una risposta, l’unica che si possa dare alla
domanda: chi ha ucciso Petrosino? Ed è la nostra risposta». Quattro anni dopo viene presentata un’operazione culturale progressista tipica della Rai post-rifonna del 1975 (più precisamente
la Rete Due, diretta dal socialista Massimo Fichera). Si tratta di Alle
origini della mafia, di Enzo Muzii, andato in onda dal 19 novembre al 17 dicembre del 1976: una co-produzione intemazionale con
l’Inghilterra, che schiera una lista impressionante di collaboratori
culturali e artistici. Come consulenti troviamo i nomi di Eric J. 3 Hobsbawm, Leonardo Sciascia e Roberto Ciuni , la fotografia e le
musiche sono rispettivamente di Peppino Rotunno e Nino Rota 4 (entrambi collaboratori del Gattopardo di Visconti) . Il cast mette insieme vecchie glorie italiane (Renato Salvatori, Amedeo Nazzari, Massimo Girotti, Valeria Moriconi) e anglo-americane (Joseph
Cotten, Lee J. Cobb, Mel Ferrer, Trevor Howard, James Mason), il bunueliano Fernando Rey, Renzo Montagnani, la Katharine Ross del
Laureato, Laura Troschel (moglie di Pippo Franco), Tony Musante, Giancarlo Sbragia, Leopoldo Trieste, Alessandro Haber, l’imminente
protagonista di Alien Tom Skerritt e il futuro cattivo della Piovra
Remo Girone. Alla base ci sono alcuni concetti storiografici assai fortunati: l’idea
di una «pre-mafia» che affonda le radici in una storia isolana di lunga durata; il legame stretto tra mafia e lotta di classe, con il banditismo
risto (appunto secondo la lezione di Hobsbawm) come ribellione sociale, e la mafia come protezione del latifondo. Il primo episodio («Gli antenati») è addirittura ambientato nel 1556, a Mazara del
Vallo, e ha al centro Lee J. Cobb (già boss in II giorno della civetta di Damiani) monopolista di mulini che fa e disfa tutto in città, mentre
l’inviato del re, Joseph Cotten, non riesce a scalfire il muro di omertà.
Nel secondo («La legge»), ambientato nel 1770, il nobile Della Morra (Ferrer) offre complicità e ricetto ai prepotenti, e a nulla possono le
riforme del viceré Caracciolo: a fare giustizia ci penseranno però i Beati Paoli, mostrati come antenato «giustizialista» della mafia. Lo stile e i tempi distesi sono quelli degli sceneggiati storici
dell’epoca, ma nei limiti del consentito si preme sul pedale del
sensazionalistico, perché il mafia morie sembra far valere le sue regole (ad esempio, nella prima puntata c’è subito uno stupro, poco giustificato dalla trama). La voce narrante, all’inizio e alla fine di ogni
storia, richiude tutto nello schema didattico, con frasi apodittiche,
come questa che apre il primo episodio: «La Sicilia è stata governata da greci arabi spagnoli ecc., mai dai siciliani. [...] Prima di essere
un’organizzazione, la mafia è un modo di pensare che nasce dalla sfiducia verso la legge»0.
L’episodio-cerniera è il terzo, a sua volta diviso in due parti, prima
e dopo l’Unità d’Italia, con la nascita vera e propria della mafia,
collocata a seguito della Costituzione del 1835 (che crea campieri e
gabelloti, «un piccolo esercito di cui ci servono per incutere terrore nei contadini») per spostarsi finalmente a Palermo («La mafia arriva in città»), dove seguiamo l’ascesa di un boss cittadino fino al matrimonio con la figlia di un nobile, una specie di Gattopardo a parti
invertite. H titolo, del resto, «Gli sciacalli», è un’evidente citazione da Tornasi di Lampedusa. L’ultimo episodio è ambientato a fine Ottocento e vede un Amedeo Nazzari a fine carriera nei panni di un
maresciallo venuto da Roma. La trama mostra una faida tra due proprietari, Renzo Montagnani e Claudio Gora. L’avvocato James
Mason indaga sulla morte del primo, ma tutto finirà nel nulla, e alla fine l’avvocato mormora: «La mafia siamo anche noi...». Profezie dell’onomastica, il supertestimone (un servo scemo) si chiama
Biscetta. Lo spazio del mostrabile e del dicibile all’interno della tv di Stato si
allarga nel successivo II delitto Notarbartolo, diretto da Alberto Negrin, andato in onda in tre puntate nel maggio 1979. Anche in questo caso si tratta di un film di ricostruzione storica, relativo a fatti
avvenuti ottantanni prima, che però toccano direttamente l’intreccio
di mafia e politica. Il principale indiziato dell’omicidio di Emanuele
Notarbartolo, già sindaco di Palermo e direttore generale del Banco di
Sicilia, era infatti il deputato Raffaele Palizzolo, che attraverso una serie di processi uscirà assolto nel 1904, dopo la morte di almeno tre
dei testimoni durante la fase dell’istruttoria e del dibattimento. Come ricorda Salvatore Lupo, i tre processi, celebrati a Milano, Bologna e
Firenze dal 1899 al 1904, segnano la prima emergenza nazionale del 6 fenomeno mafioso . Lo sceneggiato, che segue con minuzia i fatti storici, mettendo in
scena esclusivamente personaggi reali, è l’esempio di massima vicinanza della fiction televisiva al modello dell’inchiesta alla Rosi, fin
dall’inizio, in cui le scene dell’omicidio si alternano alle testimonianze rese al processo. Come in Joe Petrosino, al dibattimento è riservata l’intera ultima puntata, e sono mostrate con chiarezza le connivenze
non solo della politica, ma anche di polizia e magistratura. Portavoce
degli autori e guida all’interno della storia è l’avvocato del figlio di Notarbartolo, il socialista Giuseppe Marchesano, che fornisce, oltre
alla ricostruzione dell’omicidio e del movente, un inquadramento storico «di sinistra» a beneficio dello spettatore, biasimando anche le
coeve repressioni dei fasci siciliani e sottolineando il carattere di classe della giustizia. Nel finale il senso di tutto è affidato a un ballo di
chiara matrice lampedusian-viscontiana, ma è la voce narrante a concludere: La mafia è fenomeno di gruppi egemoni, è una particolare forma di dominio
di classe. Per chi detiene il potere economico, la mafia è un modo di esercitare questo potere. L’assoluzione di Palizzolo è stata l’autodifesa di un’intera classe e la riaffermazione del proprio potere. Che cosa fosse la mafia e chi fossero i
mafiosi, a Roma lo sapevano perfettamente. Ma per battere la mafia in Sicilia bisognava modificare la stessa struttura del potere nazionale. Perché la mafia non è una questione circoscritta alla Sicilia, ma è appunto una questione nazionale. E soltanto considerandola come tale si può combattere e si può vincere.
L’unica altra opera di finzione sulla mafia è di cinque anni dopo.
Western di Cose Nostre diretto da Pino Passalacqua è tratto da un brevissimo racconto di Leonardo Sciascia contenuto in II mare colore
del vino, che lo sceneggiatore e futuro scrittore Andrea Camilleri allunga in due puntate da un’ora e mezza («Ho fatto il brodo col
dado», sarà il commento successivo dello stesso Camilleri)2*7*. La trama del racconto è quella, assai nota (da Kurosawa a Per un pugno di
dollari), di uno straniero che fa sterminare tra loro due cosche ri\rali facendo il doppio gioco. Fin dal titolo Sciascia sembra voler giocare
sugli stereotipi, tracciando linee narrative geometriche: le due
famiglie capiscono che due terzi dei morti della faida sono stati
causati da una mano esterna. Dietro a tutto c’è un uomo (un farmacista, nell’adattamento, interpretato da Domenico Modugno)
mosso da intenti di vendetta verso il capomafia, che gli aveva impedito da giovane di sposare la sua amata. Il film può essere
considerato l’ultimo degli sceneggiati vecchio stampo sulla mafia, ambientati in un passato remoto e condotti secondo le regole di una drammaturgia letteraria e teatrale. Le puntate sono trasmesse il 13 e il 20 gennaio 1984. Meno di due mesi dopo, va in onda la prima puntata
della Piovra.
2. La piovra va a nord, a est, a ovest, a sud.
L’importanza dello sceneggiato La piovra nell’immaginario (non
solo italiano) sulla mafia è senza precedenti. Il titolo è diventato 8 9 proverbiale , il commissario Cattaui un eroe mondiale , e le varie stagioni sono rimaste un punto di riferimento, anche polemico, per decenni1 . La prima puntata va in onda l’n marzo del 1984, quando è
ancora forte il ricordo dell’omicidio Dalla Chiesa, e poche settimane prima che negli Usa parta l’operazione «Pizza Connection» che colpisce il traffico intemazionale di droga, portando tra l’altro
all’arresto di Gaetano Badalamenti. A luglio Buscetta arriva in Italia e comincia le deposizioni davanti a Falcone: da lì partirà il
maxiprocesso. Ma lo sceneggiato è importante anche per come
riallaccia il legame della Rai con il pubblico, davanti alla concorrenza sempre più agguerrita delle emittenti private, che in quegli anni hanno scoperto nuove forme di serialità straniera, da Dallas (che
Canale 5 aveva cominciato a trasmettere, dopo la cessione da parte della Rai, nel luglio 1981)11 alle telenovelas latinoamericane (La schiava Isaura arriva nel gennaio 1982). Sulla scia del precedente
sceneggiato Storia d'amore e d'amicizia, Ennio De Concini, grande
creatore di filoni cinematografici e televisivi, viene chiamato a scrivere
un classico mafia movie d’azione, ma sceglie di dargli una forte 12 torsione intimistica . A seguire le stagioni sarà, per la Rai, Sergio Silva, che ha in parte un ruolo da showrunner ante litteram, essendo
«di fatto l’unica presenza costante entro un team autoriale che ha . . , . , . . . . . . 13 visto avvicendarsi nel tempo registi, soggettisti e sceneggiatori» . Il cinema di mafia degli anni settanta è ancora un modello saldo,
anche se non più praticato, ma la novità dello sceneggiato è di innestarvi una struttura esplicitamente da melo, con un forte accento sui dilemmi privati del protagonista . Chiaro l’intento di adattare il
genere al più ampio pubblico televisivo, enunciato anche dai
comunicati stampa dell’epoca che definivano La piovra «una storia di
mafia ma soprattutto un racconto di sentimenti, una storia d’amore 15 totale, di quelle che possono bruciare la vita» . Le scene d’azione sono ridotte, molto fitte le parti dialogate. Eppure i richiami
all’attualità rimangono decisivi per situare il film su uno sfondo di
immagini e di temi che anche al pubblico televisivo cominciano a essere noti: le scene dell’omicidio iniziale richiamano tristemente
quelle dei telegiornali negli anni precedenti, e l’omelia del prete al
funerale ricorda, accentuandone i toni, alcuni discorsi del cardinale di Palermo Salvatore Pappalardo («chiunque si macchia di un delitto
come questo è scomunicato, è fuori dalla Chiesa»). Altri riferimenti
alla storia recente sono il poliziotto che viene ucciso alla vigilia del matrimonio (come Calogero Zucchetto) e una battuta dell’avvocato
Terrasini, membro della «Cupola» locale, che alla domanda
sull’esistenza della mafia così risponde: «Se esiste la commissione antimafia, esisterà anche la mafia» - la già citata battuta di Luciano
Liggio, ripetuta una quindicina d’anni dopo lo sceneggiato anche da
Marcello Dell’Utri in un’intervista a Michele Santoro. Il riferimento
più rilevante però è a una loggia massonica romana, che diventerà centrale nella seconda stagione. È lo stesso De Concini a ricordare
l’importanza di questo elemento per il successo della serie: «L’originalità della Piovra stava nell’idea che Stato e mafia non
fossero due entità separate ma che, a certi livelli, fossero un solo
corpo. Fu questa verità a fare esplodere lo sceneggiato con un successo cosi grandioso»
.
Molto più importante, a rivederlo oggi, è comunque l’insieme di
intrighi che ruotano intorno a sesso, tradimenti coniugali, ricatti.
Damiani, che come abbiamo detto era stato uno degli inventori del fotoromanzo, attinge a un armamentario da feuilleton più nero che
rosa: l’ambigua nobile Florinda Bolkan cerca di sedurre il
commissario, il giornalista Colizzi ne seduce la moglie. Tutto parte dal
suicidio della contessa Pecci Scialoja, madre di Titti (Barbara De Rossi), tossicodipendente succube di un mafioso narcotrafficante; alla
fine ci si trova di fronte a un suicidio che nasconde un omicidio passionale che a sua volta ne nasconde uno di mafia, secondo la logica 17 pirandelliana di specchi cui era giunto Damiani in quel periodo . Il commissario Cattaui è un anti-eroe, uno sconfitto: tradisce la moglie e ne viene tradito; sua figlia viene rapita e lui, ricattato, dovrà depistare
e insabbiare le proprie stesse indagini (ma la ragazzina verrà
comunque violentata). Poco insomma lascia supporre la sua imminente trasformazione in eroe tenebroso e implacabile. Lo sceneggiato si arresta alle soglie di un’alleanza tra mafia e
massoneria, tema che diventa centrale dalla seconda stagione, insieme al ruolo della politica e dei servizi segreti. È in effetti La
piovra 2 (in onda a gennaio 1986), diretto da Florestano Vancini, il vero idealtipo della serie, quello in cui pubblico e privato si saldano e Cattaui assume i tratti di un eroe alla conte di Montecristo che agisce
da solo, mosso dalla vendetta, con un trauma alle spalle, capace di
doppi e tripli giochi. Anche la dimensione politico-didattica viene
accentuata: in una riunione i potenti spiegano il funzionamento del
riciclaggio, e in una lunga tirata si enuncia la morale del film: contro l’avidità, la corruzione, il dominio dell’uomo sull’uomo. Nel
contempo, però, Cattaui è diventato un giustiziere solitario, animato
da spirito di vendetta personale e pericolosamente incline al doppio gioco. Sconvolto dal sequestro della figlia, accetta di tornare a indagare insieme a un probo funzionario dei servizi segreti, ma
rimane inrischiato in una ragnatela che coinvolge ormai anche Roma, con chiari riferimenti alla figura di Michele Sindona e a quella di Mino
Pecorelli.
Nella Piovra 3 (la cui sceneggiatura è firmata per la prima volta da Stefano Rulli e Sandro Petraglia, su soggetto di De Concini) compare
il futuro fulcro della serie, Tano Cariddi, interpretato da Remo
Girone, e si aggiungono sfumature religiose: Cattaui all’inizio è rinchiuso in convento e suo aiutante è un frate (classica figura da
romanzo d’appendice), il quale crede di avere contatti fidati nella De romana (non nominata, ma evidentemente evocata), che si rivelano essere invece uomini della mafia. Finirà col chiedere aiuto a un altro
senatore cattolico, tormentato e probo - un Giampiero Albertini somigliantissimo a Mino Martinazzoli. Intanto si susseguono gli
espedienti da feuilleton: rapimenti, salvataggi di bambine in extremis,
parentesi pruriginose (una donna ricattata per un filmino osé), un MacGuffin che poi sarà utilizzato più volte: il traffico di materiali
radioattivi. Alain Cuny, vecchio patriarca, spiega, circondato da
fichidindia: «Molti credono di avere il potere: uomini politici, qualche direttore di giornale. Ma il vero potere siamo noi, sono i soldi»: un potere che nessuno nomina perché chi lo sa è coinvolto, un «universo segreto che governa i destini della nazione». Cattaui invece, nel suo
discorso finale, parla della «gente comune» che rimane in silenzio,
sgomenta davanti ai grandi scandali, e guardando in macchina
conclude: «Ci vuole molto coraggio per vivere come voi, come tutti voi». Viene così definita la polarizzazione tra la gente comune vittima
e un potere politico-economico invisibile e ramificato. È, anche questa, una novità rispetto al mafia movie, che ha radici in molta
pubblicistica coeva sulla mafia ma anche in certo poliziottesco «di sinistra» degli anni settanta . Nella quarta stagione entra in campo il
giudice Silvia Conti (Patricia Millardet), aumentano i riferimenti alla 19 cronaca , ma anche gli intrecci da romanzo d’appendice con figlie segrete, vendette, isole misteriose e treni con scorie nucleari. La morte del commissario Cattaui avviene nella puntata del 20 marzo 1989,
davanti a 17 milioni di spettatori, record di audience assoluto dalla
fine del monopolio Rai
.
La paradossale enfatizzazione congiunta dei riferimenti all’attualità e del versante feuilletonesco si accentua nella quinta stagione, in cui Cattaui è sostituito da un poliziotto americano richiamato in Italia (Vittorio Mezzogiorno): si parla di un «terzo livello» sopra la mafia,
ma gli escamotage narrativi vedono tra l’altro la solita donna stuprata e filmati nascosti in statuette (come nel Falcone maltese di Dashiell Hammett). Ma è soprattutto la sesta stagione, del 1992, a scatenarsi in
una visione transuazionale, sull’onda del crollo dei paesi comunisti. Pur tornando in Sicilia di tanto in tanto, come fulcro sempre più esotico e manierista, la globalizzazione trionfa: Praga, Medio Oriente, Africa (con un Tano Cariddi alcolizzato dagli echi conradiani) e un
iperbolico finale che fa convogliare tutto nel cuore delle tragedie del
Novecento. Il super-cattivo Litvak, aguzzino di un lager, ha rubato l’identità di un prigioniero del campo, e sui soldi degli ebrei ha costruito le proprie fortune: «Io sono la storia di questo secolo, e lei
non può farci proprio niente», declama al commissario, che alla fine morirà anche lui. Infatti nella settima stagione protagonista è il
giudice Conti, che per indagare sull’omicidio Cattaui torna nella città della prima Piovra, con trasferte nei paesi ex comunisti seguendo il
riciclaggio, mentre le collusioni ormai (siamo nel 1994) toccano i massimi livelli. C’è una super-loggia denominata Extrema Thule
Nostra Salus, e Tano Cariddi alla fine lancia i floppy disk con i segreti d’Italia («i fiori del male», li chiama lui) dentro l’Etna.
L’annuncio della messa in onda della stagione coincide peraltro
con il rinvio a giudizio di Giulio Andreotti per concorso esterno in associazione mafiosa, creando cortocircuiti ormai automatici nei
media, tra realtà e finzione: La triangolazione tra La piovra televisiva, i delitti di mafia e il rinvio a giudizio di Andreotti disegnava i contorni allargati di un'inedita scena
pubblica, dove un autentico dramma della vita sociopolitica italiana veniva rissato, rappresentato, e a sua volta messo in scena; e tutto ciò [...] si prestava ad essere condensato in un unico e risonante riferimento simbolico: la piovra.
Mai si era andati così vicini a una con-fusione tra cronaca e fiction, tra processi reali e processi immaginari (è bene ricordare che La piovra 7 si conclude con il processo a un potente e malefico uomo politico)*1.
Dopo due stagioni con Raoul Bora che sono un prequel sul giovane Cariddi e si ispirano addirittura a In nome della legge, l’ultima, in onda nel gennaio 2001, torna alla morte di Cattaui, e ai misteriosi dischetti posseduti da Tano Cariddi, scatola nera di tutti i segreti
d’Italia. Ma la chiave elettronica per accedere agli archivi la detiene un perfido senatore, ex amico di Cariddi, che si allea con il capo della
massoneria. Come a dire: è la mafia che ha in mano tutte le nequizie del paese, ma la chiave (letteralmente) è in mano alla Politica. Ormai
lo scontro è solo tra poteri oscuri e forti che si vogliono distruggere a vicenda; non c’è più spazio per l’eroe (seppur fosco e tormentato come
Cattaui), la povera giudice Silvia Conti è quasi una mera osservatrice. Tra le ultime scene di rilievo della serie c’è la descrizione di una rifondazione di Cosa Nostra che illustra in pratica la strategia post
stragista di Provenzano. H boss decide di potare dei rami per far rifiorire l’albero: «Noi abbiamo di fronte ima grande occasione, un grande progetto. Per imporlo non serviranno stragi, che non hanno fatto altro che agevolare i nostri nemici. Non ci saranno più leggi da trasgredire perché le leggi saremo noi a farle, a misura dei nostri
interessi». Il percorso delle Piovre si conferma, fino alle sue ultime immagini,
un rilancio della dimensione complottistica e dei meccanismi del romanzo d’appendice. Le due facce tendono a sovrapporsi nella descrizione di un potere tentacolare e intemazionale (una Piovra
mondiale) attraverso continue agnizioni, colpi di scena, fanciulle in
pericolo. Al fondo di tutto rimane un desiderio primario di potere e di
vendetta, contro il quale si ergono eroi solitari la cui strada è 22 inevitabilmente costellata di morti .
3- Intimità.
Negli anni successivi agli arresti dei grandi boss corleonesi e
all’ondata di collaboratori di giustizia, le fiction sulle mafie diventano uno dei filoni più fiorenti della televisione italiana. Nel ventennio
1998-2008 sono 100 le fiction sull’argomento prodotte dalla televisione italiana, il 10% di quelle realizzate in totale. Di queste, più
della metà aveva al centro Cosa Nostra. I motivi però non sono legati
solo agli stimoli della cronaca: Si verifica in quegli anni l’accelerato processo di crescita delle capacità produttive dell’industria italiana, e gli spazi privilegiati del prime time si aprono come non mai alla fiction domestica. (...) In tali circostanze broadcaster e produttori preferiscono fare più intenso affidamento su generi ampiamente canonizzati e contenuti narrativi di sperimentata attrazione ed efficacia. Non
c’è dubbio che la mafia story sia tra questi* . Il filone troverà un assestamento a metà anni duemila con la serie di fiction biografiche, ma negli anni ancora dominati dalle varie
stagioni della Piovra emerge dapprima un gruppo di lavori televisivi che declinano la componente melodrammatica avvicinandosi al
cinema d’autore coevo, attraverso: 1) la centralità dei personaggi femminili (che dunque, da indice di appartenenza all’exploitation come negli anni settanta, diventa segno di pretese autoriali); 2) uno
stile intimista e meno spettacolare; 3) un riferimento più frequente, seppur trasfigurato, alla cronaca.
Già Donna d'onore, scritto da De Concini a partire da un romanzo di Sveva Casati Modignani, e andato in onda nell’aprile 1990 su
Canale 5 (con una seconda stagione tre anni dopo), aveva al centro un personaggio femminile, una giovane donna (Carol Alt) che si innamora, senza saperlo, dell’assassino del padre mafioso (Eric
Roberts). I toni esplicitamente mèlo, gli elementi spettacolari e le
pretese intemazionali (nel cast, insieme a Serena Grandi ed Èva Grimaldi, c’erano Burt Young ed Eli Wallach) ne fanno un precursore delle produzioni Ares come L'onore e il rispetto o Baciamo le mani.
Damiano Damiani, in Un uomo di rispetto, tratto dal romanzo di Enzo Russo, è tra i primi a volgersi a temi più intimi, con una vicenda
che per certi versi ricorda quella del suo Un uomo in ginocchio. Michele Placido è un killer diventato autista e finito in mezzo a una
guerra di mafia, ma soprattutto alle prese con problemi sentimentali e con l’affetto verso un bambino. L’insieme ha una malinconia da polar francese, col vecchio boss Mario Adorf stanco e malato, che finge al
telefono di star facendo un’orgia con tre donne e pontifica su Gola
profonda e sulle misure del pomodivo Harry Reems, ma in realtà alla fine, solo e disperato, si uccide.
Non parlo più, Vite blindate e Una sola debole voce (due stagioni)
raccontano gli effetti della mafia sul privato dei personaggi in maniera
più esclusiva di quanto fosse mai stato fatto prima. Nel primo, basato su un soggetto di Damiani, la vicenda si dipana attraverso un
confronto tra figure femminili (una giovane collaboratrice di giustizia
vagamente ispirata a Rita Atria, la cognata, la madre, una giudice).
Nel secondo le difficoltà della famiglia di un pentito costretto a rifarsi
una vita sono osservate attraverso i rapporti tra la moglie e i figli. Nell’ultimo le caratteristiche del filone sono ulteriormente accentuate:
ispirato forse alle vicende che avevano risto un intreccio tra sanità privata e Cosa Nostra (l’imprenditore Michele Aiello, che era stato al 1 24 centro dell’inchiesta sulle talpe alla Procura di Palermo) , per la prima volta ha al centro la borghesia delle professioni connessa con la
mafia. E ancora una volta la chiave è la centralità del personaggio
femminile (Licia Maglietta, moglie di un medico, che prende
coscienza della colpevolezza del marito). Il lavoro più complesso è Donne di mafia, diretto da Giuseppe
Ferrara, che fino ad allora aveva frequentato in maniera esclusiva i moduli dell’inchiesta e dell’instant morie. Qui siamo davanti a un melodramma femminile a più voci, con, da un lato, la moglie di un
boss che decide di collaborare con la giustizia (Tosca d’Aquino) e i
suoi rapporti con le altre mogli di mafiosi (Mietta e Loredana Marino) e dall’altro il giudice Barbara D’Urso. L’universo femminile è
raccontato con toni esplicitatiri e caricati, e si intreccia ancora una volta a riferimenti precisi alla cronaca, da Buscetta al rapimento di Giuseppe Di Matteo.
Ma a questa fase in cui la fiction si imbeve di riferimenti trasfigurati alla realtà subentra un modello inverso, quello di vicende reali raccontate secondo i moduli del genere. Senza che in fondo il
senso cambi:
Nel corso degli anni la fiction italiana ha elaborato, e pattuito con il proprio pubblico, codici e convenzioni di rappresentazione narrativa che tendono a eludere incontri e confronti troppo ravvicinati con le complessità, le particolarità, le metamorfosi del reale. (...) Per la stragrande maggioranza del pubblico televisivo (...) la criminalità organizzata è letteralmente una fiction, nel senso di appartenere a un mondo possibile ma non direttamente esperibile o esperito (fortunatamente) nelle concrete circostanze della vita quotidiana*25 .
4. Neotelevisivi per Falcone e Borsellino. Preceduto da Brancaccio di Gianfranco Albano, ispirato alla storia 26 di don Puglisi , il ciclo dei biopic antimafia può considerarsi
inaugurato dal Paolo Borsellino di Gian Maria Tavarelli. Accompagnata da polemiche contingenti (ne viene rimandata la
messa in onda perché la sorella del giudice, Rita, era candidata del
centrosinistra alle elezioni regionali contro Totò Cuffaro), la serie ha un enorme successo quando viene trasmessa 1’8 e il 9 novembre su
Canale 5: l’ascolto medio è di 10834000 spettatori (lo share tra il 35,60% e il 41,94%). Il tono è letteralmente commemorativo: quasi
tutto il secondo episodio è ambientato nei giorni tra la morte di
Falcone e quella di Borsellino, con quest’ultimo che indaga sulla
strage (l’ultima ora si svolge tutta il giorno della morte del giudice, il 19 luglio). Nel film, prodotto da Mediaset, non è però nominata
l’intervista in cui Borsellino parlava di Dell’Utri ai giornalisti di Canal
Plus, Fabrizio Calvi e Jean-Pierre Moscardo, il 21 maggio 1992,
pubblicata dall’«Espresso» nel 1994 e parzialmente andata in onda nel 2000. Ovviamente molti passaggi rimangono nel vago, anche perché all’epoca il processo per la strage di ria D’Amelio, basato sulle deposizioni del pentito Vincenzo Scarantino, comincia a mostrare
delle falle (solo nel 2008 sarà riaperto sulla base di nuove dichiarazioni di Gaspare Spatuzza). Il picco dei titoli è raggiunto nel biennio 2006-2008: Petrosino (Rai 1, 24-25 settembre 2006) di Alfredo Peyretti; A voce alta di
Vincenzo Verdecchi (Rai 1,5-6 giugno 2006), ispirato vagamente alla storia di Gioacchino Basile, operaio dei cantieri navali di Palermo che
si era ribellato alla mafia; Giovanni Falcone - L'uomo che sfidò Cosa Nostra (Rai 1,1-2 ottobre 2006) di Andrea e Antonio Frazzi; La vita rubata (Rai 1,10 marzo 2008) di Graziano Diana
; più II generale
Dalla Chiesa di Giorgio Capitani (Canale 5,10-11 settembre 2007, in
realtà incentrato quasi tutto sulla lotta contro le Br). Ad essi è contemporanea la trilogia di biografie dedicate ai boss: L'ultimo dei
corleonesi di Alberto Negrin (Rai 1,14 febbraio 2007), U capo dei capi di Alexis Sweet (Canale 5, ottobre-novembre 2007) e L'ultimo 28 padrino di Marco Risi (Canale 5,13-14 gennaio 2008) . Un corpus abbastanza distinto da quello di una decina d’anni dopo, che
comprende Boris Giuliano (Rai 1, 23-24 maggio 2016), i primi tre episodi della serie Liberi sognatori (Canale 5,14-28 gennaio 2018),
Rocco Chinnid di Michele Soavi (Rai 1, 23 gennaio 2018) e Prima che
la notte (Rai 1,23 maggio 2018) di Daniele Vicari. È interessante,
d’altronde, osservare come la produzione televisiva si intrecci col palinsesto delle reti televisive in occasione degli anniversari delle stragi. Ad esempio, il 23 maggio 2012 (anniversario della strage di
Capaci) Rai 1 in prima serata trasmette, «per non dimenticare», la partita di calcio tra la Nazionale cantanti e quella magistrati; l’anno
dopo Rai 3 manda in onda Fortapàsc di Marco Risi (sul giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra) e Rai 5 II giorno della civetta di Damiani. Nel 2014, su Rai 2, tocca a una replica di Brancaccio, nel
2015 a La mafia uedde solo d'estate (Rai 1). Per il venticinquennale della strage viene presentato invece un film tv in prima visione, Paolo
Borsellino -157 giorni (Rai 1, 22 maggio 2012) di Alberto Negrin, primo titolo del genere prodotto dalla Rai dopo alcuni anni. In una logica simile rientra l’uscita-evento, il 23 maggio 2016, di Era d'estate
di Fiorella Infascelli, produzione Fandango indirizzata poi rapidamente sul piccolo schermo.
Si possono considerare questi prodotti come un unico insieme, di cui sono precursori Giovanni Falcone di Giuseppe Ferrara, I giudici
(titolo americano Excellent Cadavers') di Ricky Tognazzi, prodotto da
Hbo e pensato per il mercato estero, e infatti più disinvolto nell’affrontare la materia storica, Gli angeli di Borsellino di Rocco
Cesareo
e Alla luce del sole di Roberto Faenza.
C’è, nelle miniserie, una forte attenzione al privato e alle dinamiche
famigliali degli eroi, sul modello americano (amori, matrimoni, figli). Altri passaggi obbligati sono il conflitto con gli altri magistrati e
l’incontro con i «salotti» palermitani che fanno ostracismo o
blandiscono l’eroe. Un momento di contatto con il film d’azione è il montage con le rivelazioni dei pentiti alternate agli arresti, ed eventualmente le figure di poliziotti come Montana, Cassarà o
Zucchetto con i loro pedinamenti. Nel film di Ferrara su Falcone, e ancor più nella miniserie dei fratelli Frazzi, il montage è straripante. Ma ovviamente la fiction con più scene d’azione sarà Boris Giuliano,
dedicata a un poliziotto.
Sul versante pedagogico, trionfa lo «spiegone», la tirata esplicativa.
In Paolo Borsellino alcune osservazioni di Falcone raccolte nel librointervista Cose di Cosa Nostra vengono pronunciate direttamente
mentre accadono le cose. Ugo Dighero arringa molto spesso nelle due
miniserie di cui è protagonista, in veste di prete o di operaio. Dalla Chiesa nel biopic omonimo, con Palermo ai suoi piedi, spiega il
legame tra mafia e industria del mattone. In Giovanni Falcone queste scene sono numerosissime, e approdano a un excursus sulle
dominazioni straniere in Sicilia. Nel tardo Rocco Chinnici a far da
tramite per lo spettatore sono la figlia del giudice e poi lo «straniero» Giuseppe Di Lello, che si aggiungono al gruppo di giudici e a cui
vengono pazientemente spiegate le cose. Ma c’è anche una lezione del
giudice in una scuola, che semplifica ancora di più. L’attitudine
pedagogica raggiunge l’ipertrofia in Paolo Borsellino -157 giorni, forse anche perché nel frattempo è passato un quarto di secolo dagli
eventi, non più così noti al grande pubblico
.
Poiché molte indagini sulle stragi erano ancora in corso, però, si ha spesso un curioso camuffamento dell’onomastica, che spinge
involontariamente verso la finzione. In Paolo Borsellino vengono citati con i loro nomi solo i «buoni» e non, ad esempio, i cugini Salvo
o il pm Giammanco con il quale Falcone aveva forti scontri in procura. In compenso, a Borsellino vien detto che lo tradiranno «due Giuda»:
uno della polizia e uno della magistratura. Nel Generale Dalla Chiesa
si parla di un «Banco dell’Etna» che conservava i capitali mafiosi, e Salvo Lima viene ribattezzato Tommaso Sattrino, mentre come
simbolo di Cosa Nostra viene indicato un immaginario pescivendolo della Vucciria di nome Salvo Ficara. In Giovanni Falcone figurano con
i loro nomi Lima, i Salvo, Sindona, il giudice Meli e Spatola, ma la banca «complice» si chiama Sicilcredit e vediamo un immaginario, subdolo oppositore del giudice (che è anche il «Corvo» estensore delle
lettere anonime) chiamato Lo Monaco. In Paolo Borsellino -157
giorni, invece, le ipotesi sono più nette: Borsellino, si suggerisce, viene ucciso perché vuole bloccare la trattativa Stato-mafia, anzi «per fermare il cambiamento»3*.
Ogni tanto riferimenti a film o libri presentano un richiamo «alto»
per distinguersi dai prodotti di genere: in La vita rubata la protagonista legge Menzogna e sortilegio, nel film di TavareUi Paolo Borsellino guarda in tv Cera una volta il West, ma il riferimento più curioso è nella miniserie Giovanni Falcone. Il procuratore generale di Palermo Gaetano Costa, sulle scale del Palazzo di Giustizia, così si
rivolge al più giovane collega: «L’ha letto II contesto di Sciascia? Beh, dovrebbe. E la storia di un giovane investigatore che indaga con
un’ostinazione quasi ossessiva su quello che a prima vista appare un piccolo omicidio di mafia, ma invece nasconde ben altro. Io ho
cominciato a leggerlo con molto divertimento, sa?, ma alla fine non mi divertivo più». Sono quasi le esatte parole usate da Sciascia nella postfazione al libro, ma la trama del Contesto non è proprio come la racconta Costa. Il romanzo (ambientato in un luogo imprecisato) non
parla di mafia, ma del complotto di un giudice che vagheggia poteri assoluti: non esattamente ciò che stanno facendo Costa e Falcone con le indagini sul costruttore Rosario Spatola.
Spettacolarità e valore civile si saldano idealmente nei finali, che compongono sempre un cerimoniale convocando le figure reali, con
scritte che ne mostrano il destino successivo (le più lunghe, per un totale di un paio di minuti, alla fine di A voce alta). Il generale Dalla
Chiesa termina sull’inquadratura della bara con sopra il berretto da carabiniere, e in dissolvenza immagini di repertorio con il feretro. In
Giovanni Falcone, dopo l’esplosione di Capaci si passa all’integrale del discorso straziante di Rosaria Schifani davanti alle bare cui
seguono le foto dei veri protagonisti. Le immagini della vedova Schifani, notiamo per inciso, che ricorrono in quasi tutti i prodotti del genere (Giovanni Falcone di Ferrara, Gli angeli di Borsellino,
L’attentatuni, Liberi sognatori, e già c’era un’allusione nella Piovra
7), caratterizzano la produzione soprattutto popolare e medio-bassa,
come un tempo le riprese del mercato della Vucciria, in un’ideale sostituzione del vintage mediale al folclore. Alla fine di Brancaccio una ragazzina vestita di bianco è montata in campo-controcampo con
i veri funerali di don Puglisi (il montaggio tra filmati di repertorio e personaggi fittizi che vi vengono inseriti a forza è il vero topos di
questi finali, sia al cinema che in televisione). Nel film di Faenza
ispirato alla stessa vicenda, Alla luce del sole, sui banchi della chiesa appare il suo fantasma, che saluta sorridente un bambino prima che questi si allontani al ralenti. Addirittura alla fine di Paolo Borsellino
la figlia del magistrato dà gli esami all’università, poco tempo dopo la morte del padre, e alle sue spalle, sui banchi, incombono e la
benedicono idealmente tutti i morti di mafia
.
L’effetto-routine apparirà evidente alcuni anni dopo in Paolo
Borsellino -157 giorni, in cui la sensazione di déjà-vu è
impressionante. Lo schema della via crucis è ormai rigidissimo; in più si ha un effetto di potenziamento ipermediale dovuto alla presenza come protagonista di Luca Zingaretti, celebre come interprete del commissario Montalbano, il che crea una sorta di sovrapposizione tra
la figura creata da Camilleri e il giudice ucciso dalla mafia, come due figure di «siciliani buoni», lari del pubblico televisivo (il «lato umano» del giudice, che si ferma a comprare il pesce o a giocare con i bambini, è qui molto in evidenza).
Qualche anno dopo, in apparenza cambiano l’atteggiamento nei confronti degli eventi storici e le forme del racconto. In Boris Giuliano
l’atmosfera è quella del modernariato (anche perché le vicende del commissario partono dagli anni sessanta della strage di Ciaculli),
vengono fatti i nomi di Andreotti, dei Salvo, e ricostruite con 33 precisione alcune vicende criminali . Ma le rappresentazioni di alcune figure chiave hanno suscitato polemiche, soprattutto la . . ... 34 .... rivalutazione esplicita di Bruno Contrada . I fratelli Granano, i cui
legami con la politica e l’economia erano solidissimi (erano loro il
punto d’unione tra il mondo della finanza milanese e Cosa Nostra)
sembrano sostanzialmente dei bulli di quartiere. Era d'estate, invece, che esce al cinema lo stesso 23 maggio in cui Boris Giuliano viene trasmesso in tv, punta su una chiave più intimista, riallacciandosi ai
film di mafia collocati nel cinema medio d’autore di qualche tempo
prima. Ci si concentra sulla fase istruttoria del maxiprocesso, con
Falcone e Borsellino all’Asinara, e i toni sono dunque più meditativi, crepuscolari, con particolare accento sulle vite delle famiglie presenti
anch’esse sull’isola (in particolare sui figli di Borsellino), unite a momenti di spiegazione (su La Torre, sul maxiprocesso).
L’ultima ondata di biografie di eroi antimafia, prodotta da Taodue,
è la serie Liberi sognatori, tre lungometraggi dedicati all’imprenditore Libero Grassi, all’agente della scorta di Borsellino Emanuela Loi e al giornalista Mario Francese (unico a non essere mai stato raccontato al cinema o in tv), a cui si aggiunge una quarta puntata dedicata alla salentina Renata Fonte. I film, diretti rispettivamente da Graziano Diana, Michele Alhaique e Stefano
Mordini, hanno pretese «autoriali» evidenti già nella formula del lungometraggio (o nella fotografìa bluastra del film di Alhaique),
senza peraltro dismettere un’attitudine didattica. Il tempo trascorso permette maggiori riferimenti alla politica: nel film su Libero Grassi è
descritta l’ostilità degli industriali palermitani e delle banche, mentre
in quello su Francese i riferimenti alle speculazioni sulla diga Garcia
coinvolgono i nomi di Lima e Ciancimino (ormai pienamente pronunciabili, anzi ingredienti del genere), e una frecciata al
«Giornale di Sicilia». In Francese si sfiora il «Grande Complotto» tipico del filone romanzesco della Piovra e di Squadra antimafia, con
una lunga spiegazione di tutti i misteri d’Italia, «Ustica compresa», su immagini girate col drone (figura stilistica che sostituisce i totali
dall’alto su Palermo). I film puntano su una doppia riconoscibilità: vicende spesso note,
ma più ancora una situazione drammatica identificabile (il martire che lotta da solo), e cast familiari allo spettatore. Il che ripropone un cortocircuito tipico:
Nella produzione audiovisiva [...] i meccanismi stereotipanti trovano potenti alleati nel sistema produttivo, che fra un testo e l’altro offre allo spettatore elementi di familiarità, agganci a volte fuorvianti: possono essere le facce degli
attori, che a distanza di tempo e di atmosfere ricompaiono in modo costante, sempre nel ruolo del cattivo, o più spesso in ruoli alterni o scambiati, qui come capomafia, là come commissario di polizia. [...] Scambi di ruolo che generano una confusione che si riverbera sulle vicende narrate, di per sé complesse, e
che potrebbe suggerire che le vicende di mafia, vere o d’invenzione che siano, siano un canovaccio a disposizione, un genere testuale più italiano degli altri35. Nel complesso, i tre film completano la leggibilità di Cosa Nostra alla luce degli schemi del genere: la mafia (e ancor più l’antimafia)
rientra perfettamente nei format narrativi, ed è qualcosa di individuale e di passato, un insieme di sconfitte individuali con mero
valore di testimonianza da celebrare. Il vero senso del film su Grassi è,
potremmo dire, intramediale: si tratta di un’autoapologia dei media, e della televisione in particolare. Il cuore del film è la trasmissione
Samarcanda, con la diretta cui l’imprenditore partecipò raccontando
la propria storia: sulle sue immagini il film si apre (con un montaggio in campo-controcampo che sostituisce il protagonista Giorgio Tirabassi al vero Grassi, inserendolo tra i partecipanti reali alla
trasmissione) e si chiude. La morale del film è declamata dal protagonista: «Credo nei mass media e nella civiltà della
comunicazione». Anche l’episodio su Emanuela Loi è inevitabilmente il riepilogo di una serie di immagini mediatiche, dall’intervista di
Corrado Augias a Falcone, a Enrico Mentana che annuncia la morte di Borsellino, al pianto della vedova Schifani. Ancora una volta il mafia
movie ha anche un senso ulteriore: in questo caso la creazione di un’immagine idealizzata dei produttori di immagini e di storie, l’affermazione del ruolo dell’informazione (e della narrazione) antimafia.
Un progetto diverso presiede a Prima che la notte, film per la tv
dedicato al giornalista Giuseppe Fava. A partire dal nome del regista
Daniele Vicari, noto per film di impegno sostenuti da un ritmo all’americana (Diaz - Non pulire questo sangue), il film si propone
come ideale trait d’union tra la produzione autoriale e le fiction, prendendo atto della possibilità di un punto d’incontro intermedio,
che consiste nei nuovi modelli di fiction consentiti da broadcaster come Netflix e Sky. Il lontano modello, per l’unione di vintage e
impegno, con protagonista ironico e carismatico, rimane I cento passi (con la radio libera sostituita dal giornale militante, e il gruppo di
ragazzi coraggiosi capeggiati da un leader più anziano). Se ormai è possibile «fare i nomi» (qui quelli dei cavalieri del lavoro di Catania
attaccati da Fava: Costanzo, Finocchiaro, Rendo, Graci), al centro è sempre l’intreccio didattica/vintage: spiegazione di eventi del passato
più rievocazione mediale (a cominciare dalla colonna sonora che va da . . 36 . . Blondie ai Clash) . Torna, come nelle altre fiction coeve, il re enacting del dibattito televisivo con il protagonista Fabrizio Gifuni al
posto di Fava a dialogare con le immagini di Nando Dalla Chiesa e dell’avvocato di Michele Greco in una trasmissione di Enzo Biagi. Sempre più, al di là delle intenzioni, l’effetto non è un’aggiunta di verità da parte della storia raccontata, ma una fìctionalizzazione della
mafia.
5- Mafia reale, antimafia immaginaria.
Può sorprendere che, nel pieno fiorire delle agiografie degli eroi antimafia, a queste si affianchino, spesso prodotte dalle stesse case
(tra cui spicca la Taodue) biografìe idealizzate dei boss più sanguinari. La coincidenza sancisce una sostanziale interdipendenza tra le figure celebri della mafia e quelle dell’antimafia: le raffigurazioni eroiche dei
mafiosi presuppongono, se non altro come alibi, una precedente
giubilazione spettacolare delle figure antimafia, ed entrambe le vie puntano alla personalizzazione, alla riduzione della storia a singole
figure di eroi, in modo da neutralizzare ogni approfondimento sul
contesto e ogni presa di coscienza sugli strumenti del racconto, della
messa in scena e della comunicazione.
Il titolo più interessante, proprio perché il più smaccato nell’impostazione apologetica, è la saga in 6 puntate II capo dei capi. In apparenza, l’idea di raccontare Cosa Nostra dall’interno poteva
rappresentare un passo in avanti, rispetto alla visione ingessata e
monumentale delle biografie degli eroi antimafia. In realtà il progetto è diverso, e quasi opposto. Non c’è alcuna messa in discussione dei modelli del cinema civile e democratico, ma un aggiornamento del
genere. Anziché raccontarli dal di dentro, la serie rende accettabili i mafiosi facendoli corrispondere alle convenzioni del racconto e della
rappresentazione abituali nella fiction televisiva. Come ha scritto Milly Buonanno riguardo alle fiction di mafia in genere:
Il formidabile dispositivo del ritorno del già noto lavora qui, più che altrove, su un terreno di riferimenti autoreferenziali: si tratti di tipi umani, situazioni, azioni, linguaggi, paesaggi, o altro ancora... le cui pretese di verità, o più semplicemente la riconoscibilità o la credibilità, poggiano in larga misura sul
fatto di appartenere a un repertorio di genere già familiarizzato e collaudato attraverso un precedente corpus di storie. La verosimiglianza di un
personaggio di mafioso, di una condotta criminale, di un gergo da affiliati, viene a essere misurata secondo criteri di similarità e di differenze rispetto a personaggi, condotte, modi di espressione che, essendo stati sperimentati in altre fiction, contribuiscono a orientare il sistema di attese degli spettatori verso la riconferma di esperienze simili o poco differenti3 ' .
Oltre alla sceneggiatura (firmata da Stefano Bises, Domenico Stamone e Claudio Fava sotto la supervisione di Stefano Rulli) sono eloquenti le scelte del casting. Già bellissimi da bambini, Riina,
Provenzano e Bagarella da grandi sono interpretati da attori come Claudio Gioè, Francesco Scianna e Marco Leonardi, che nobilitano visivamente gli originali. Bellissima è Ninetta Bagarella (Gioia Spaziani), brutti invece i mafiosi rivali di Riina, a cominciare da
Michele Navarra (Giacinto Ferro). Tratti lombrosiani hanno sia il «cane pazzo» Michele Cavatalo, sia i «perdenti» di Badalamenti e
Bontate. E così anche gli accusatori del boss, come il pentito Maino (ispirato a Luciano Raia), mostrato con tratti infantili, non da «vero uomo». Giovanni Falcone (Andrea Tidona) è molto imbruttito, Boris
Giuliano una figura comica, Lenin Mancuso ha un aspetto losco. In
generale, questi ruoli sono affidati a caratteristi siciliani, messi a
confronto con attori noti che interpretano i mafiosi.
La scansione delle puntate segue i ritmi dell’epica. La prima mostra l’infanzia di Riina, rimasto orfano da bambino, animato da un forte
senso di giustizia: si ribella ai soprusi del boss Navarra che poi,
insieme a Luciano Liggio, scalzerà, diventando il nuovo capo dei corleonesi. La seconda narra l’assalto dei corleonesi a Palermo, il contrabbando, il racket dello scaro (il mercato ortofrutticolo) e la
prima guerra di mafia, in una chiave di lotta di classe dei corleonesi «villani» contro i sofisticati palermitani. Il modello, come già in
Corleone di Squitieri, è evidentemente II padrino parte n. Il primo
episodio è immerso in un mondo contadino rétro che richiama il film
di Coppola (e l’attore che interpreta Navarra imita Brando), Il siciliano di Cimino, i film siciliani di Tornatore ma anche Sergio
Leone (fin dal leitmotiv dell’oggetto infantile, un motociclista di latta,
come l’armonica di Cera una volta il West, o la Rosebud di Quarto potere di Orson Welles). Man mano che ci si avvicina al presente, queste prime puntate gettano la propria ombra sulle vicende più
prossime, che dunque trovano la propria spiegazione, il proprio senso, in una narrazione di tipo epico, legata a un’Italia contadina e
folklorica. La quale permette di recuperare anche un certo
immaginario western: gli scontri a cavallo, il confronto al bar-saloon. Il modello narrativo è l’iconografia popolare del bandito Giuliano, a
cominciare dall’atto iniziale di illegalità causato dalla ribellione
all’ingiustizia (in realtà, come racconta anche il libro cui si ispira il film, si trattava di un diverbio tra bulli, e Riina aveva sparato per
primo)
.
Le scelte di Riina vengono giustificate in chiave di rivalsa sociale («La nostra forza è la fame»). Il primo atto di violenza lo compie
quando gli vogliono sottrarre il frumento e lui per rappresaglia
distrugge le angurie di Navarra e spara al gregge del prepotente; poi sparerà anche al figlio di costui venendo condannato a 12 anni di
carcere. Molte altre scelte di sceneggiatura vanno in questa direzione: nell’attentato di viale Lazio partecipiamo al sincero dolore di «u
Curtu» per la morte del cognato Calogero Bagarella; dopo aver piegato con l’astuzia la Commissione di Cosa Nostra, Totò torna da
Ninetta e noi lo vediamo con gli occhi innamorati di lei; poco prima di
ordinare il massacro dei parenti di Buscetta riappare il pupazzetto del
motociclista, come a ricordarci l’origine privata di tutto il male, e
Provenzano commenta: «Stai cambiando, non ascolti più»
(ipotizzando un Riina buono, ante seconda guerra di mafia). Fino agli anni settanta, la maggior parte dei crimini non viene mostrata (tranne
i regolamenti di conti tra i mafiosi): ad esempio, muoiono fuori campo sia Placido Rizzotto che il pastorello testimone della sua scomparsa. A
conti fatti, il primo atto violento a cui lo spettatore assiste avviene a metà della quarta puntata: è forse l’unica scena in cui Rima appare
vagamente minaccioso, mentre finge di arrabbiarsi con Provenzano (evidente calco di una scena di Joe Pesci in Quei bravi ragazzi). Le poche volte in cui il boss appare violento è quando gli toccano la famiglia: picchierà ad esempio con la vanga un suo uomo che ha
trascurato la custodia di Ninetta. Si perde dunque, rispetto al libro di partenza di Bolzoni e
D’Avanzo, la duplice caratteristica che spiegava l’ascesa di Riina: da
un lato la cieca ferocia, dall’altro l’abilità nel dividere, mettere l’uno contro l’altro gli alleati, nel doppio gioco; la sua arte di tragediatoref
quella stessa che lo faceva sottilmente e paradossalmente definire da
Tommaso Buscetta, con insulto nel codice mafioso, «malato di . . . 39 .... sbirritudine» . Una figura poco narrabile in un tipo di racconto modellato sul Padrino. In questa costruzione, però, si fa comunque vivo il super-io civile,
per cui gli sceneggiatori sono costretti a inventare un antagonista, un eroe dell’antimafia che fronteggiando Riina attraversi la storia
d’Italia. Con la differenza che Riina è un personaggio reale, mentre Biagio Schirò (questo il nome del poliziotto) no. Si tratta di un
personaggio-bignami: amico d’infanzia di Riina, è convinto a studiare da Rizzotto e Dalla Chiesa. Diventato poliziotto, collabora con Montana e Cassarà, indaga sui Salvo, ferma per strada Dalla Chiesa
imbastendo una conversazione sullo Stato, va a prelevare Buscetta in
Brasile (ma è ovviamente assente la notte in cui l’indiziato dell’omicidio di Montana, Salvatore Marino, viene ucciso in questura
durante un interrogatorio), viene messo da Falcone a seguire i soldi delle banche svizzere. Negli episodi che ripercorrono gli anni ottanta, ci si sposta in parte su questo lato della barricata, con l’immaginario
Schirò che si muove tra le figure reali degli eroi antimafia. Rapidamente si ripercorrono il maxiprocesso, la delusione dei boss
nei confronti della De, il fallito attentato a Falcone all’Addaura, i conflitti in procura, gli attentati del 1992, il tentativo di trattativa
(Provenzano in persona va nel covo di Riina a prendere i documenti compromettenti)
. Il figlio di Schirò entrerà anche lui in polizia e
chiederà di essere assegnato alla scorta di Falcone. Il tutto culmina in un montaggio alternato inevitabile quanto approssimativo tra vero e fìnto, tra le immagini dei funerali dei magistrati e Schirò che protesta mentre il figlio cerca di mantenere l’ordine.
Dal punto di rista della narrazione, Schirò è un angelo, uno
spettatore, qualcuno che inevitabilmente (risto che sappiamo come sono andate le cose) si trova sempre accanto agli eventi, al limite affiancato a loro per il tramite di montaggi vistosamente posticci; ma
non potrà in nulla influire sul corso della storia. Involontariamente, dunque, si tratta di una clamorosa metafora dell’impotenza dei «buoni»: la mafia è reale, l’antimafia una fantasia . Lo stesso schema in fondo presiede a L’ultimo padrino e a L’ultimo
dei Corleonesi, miniserie concorrenti su Provenzano messe in cantiere da Rai e Mediaset come era capitato in altre occasioni (caso più celebre, quello di padre Pio). L’ultimo dei Corleonesi, prodotto da
Endemol, ha un’aria più giornalistica, meno spettacolare, quasi da ricostruzione filmata stile Chi l’ha visto?, il che porta a eccessi
didattici: mentre i poliziotti sono in agguato davanti al covo del boss,
l’attore che interpreta Pietro Grasso si prende il tempo di riepilogare
la situazione di Provenzano e di Cosa Nostra a beneficio dello
spettatore. In realtà, per quasi tutto il film protagonisti sono prima Liggio (Stefano Dionisi, ancora una volta assai più bello del modello)
e Riina poi: solo alla fine Provenzano prende spessore, come fautore della «linea morbida» contro Riina. L’ultimo padrino invece si
innesta consapevolmente sulla scia di Squadra antimafia, mettendo in parallelo la latitanza con una squadra di poliziotti romani. Ma soprattutto riprende lo schema poliziotto versus criminale, uno
specchio dell’altro, individualizzando completamente la caccia
all’uomo. Le motivazioni dei due nemici sono altrettanto irrazionali,
come sottolineano i dialoghi: «Io lo devo prendere». «E lui deve comandare». «Io però sto dalla parte giusta». «Anche lui dice la
stessa cosa». Mentre dunque Provenzano viene umanizzato come i classici cattivi del noir (specie tramite il rapporto con la moglie), del poliziotto si sottolinea il carattere ossessivo («Stai attento. Stai
diventando come lui»). Nell’ultima immagine, il poliziotto «eredita» il tic alla mano che aveva Provenzano: i due sono uguali, figure ugualmente immaginarie e riconoscibili attraverso lo stereotipo del
genere. I nomi anche stavolta non sono quelli reali, ma lo scopo, più che di cautela giudiziaria, sembra una riconferma dell’elemento finzionale42. Elemento che trionfa nel finale in cui, come in una specie di excusatio non perita in articulo mortis, vengono richiamate le immagini di repertorio di stragi, processi, omicidi, arresti. Ma stavolta decontestualizzate, astratte: a comporre, insomma, un mosaico che
non si riferisce a nessun evento in particolare, a nessun contesto, ma mostra come archetipi (mitici, narrativi e visivi insieme) il Funerale, il Corteo, la Strage, il Processo. Icone di un rituale, ormai tutto interno
al mondo dei media.
1 Tra le poche inchieste negli anni sessanta ricordiamo Rotocalco n. 1. Rapporto da
Corleone (i960) di Gianni Bisiach. Primo film tv di finzione sul tema è Chi non vuol parlare
(1967) di Giacomo Colli su testo di Giovanni Guaita. 2
Devo I’informazione ad Anna Lapenna, vedova di Luigi Malerba, che conserva una copia
della sceneggiatura originale. 3
Così racconta Sciascia stesso la genesi dello sceneggiato al «Radiocorriere TX7»: «L’idea è
stata di Roberto Ciuni, direttore del «Giornale di Sicilia». Siamo amici ed era naturale che
pensasse a me per una verifica, come dire, storica. Abbiamo buttato giù una prima scaletta di sceneggiatura, utilizzando dieci paginette dello storico inglese Eric Hobsbawm che, secondo me, è quello die ha saputo spiegare meglio e più chiaramente di altri che cosa è la mafia.
Sono stato io stesso a fare il suo nome. [...] Più tardi la televisione inglese, che ha prodotto lo
sceneggiato con la Rai, ha espresso il desiderio di rimaneggiare la sceneggiatura per esigenze di spettacolo. A quel punto la cosa non mi interessò più». Sciascia peraltro contesta l’idea
dello sceneggiato, di una nascita della mafia già nella prima metà dell’ottocento: «Secondo me la mafia è nata con la macchina elettorale, portata in Sicilia con l’unità d’Italia. Il mafioso è nato come grande elettore» (intervista di G. Bocconetti, Se il potere decidesse di
distruggerla, in «Radiocorriere IX7», 1976,47. Il «distruggerla» del titolo è riferito alla mafia, e il sottotitolo prosegue:... si voterebbe al suicidio). 4
Le musiche di Rota ricalcano molto da nòno quelle del film di Visconti, e sui titoli di
testa c’è una canzone di Lanzi-Endrigo-Muzii cantata da Sergio Endrigo. Il iv episodio («La speranza») è fotografato da Pasqualino De Santis, altro nome di primissimo piano. 5
E ancora: «Lo Stato toma a dichiararsi impotente davanti ai privilegi della nobiltà, e a
fronteggiare persone come Della Morra restano i Beati Paoli. La giustizia in Sicilia si
organizza in modo mafioso» (alla fine dell’episodio settecentesco); «Dopo il feudo e i mercati, [la mafia] ha trovato un nuovo modo per prosperare: la politica» (ep. rv). 6
Lupo, Storia della mafia dt, p. 122. Al caso Notarbartolo, inserito in un contesto politico
e di interessi ovviamente assai più ampio di quanto possa trasparire dallo sceneggiato, è
dedicato in pratica l’intero cap. n del volume, pp. 121-74.
Cfr. A. Camilleri; Il quadro delle meraviglie. Scritti per teatro, radio, musica, cinema, Sellerio, Palermo 2015, pp. 344-5» 368. 3
De Concini ricorda che il titolo fu un’idea di Leo Beghin, dirigente Rai (L. Cererìa - G.
Lopez, Il ragazzo sifarà. Storia di Ennio De Concini, Fico-Le Nuvole, Cosenza 2001, p. 100). Il termine però doveva aver già lambito la pubblicistica sulla mafia: di «testa della piovra» si
parla già in copertina di F. Chilanti, La mafia su Roma, Palazzi, Roma 1971. 9 Ricordiamo che in occasione del rapimento della cooperante Clementina Cantoni in
Afghanistan, su richiesta del presidente Hamir Karzai fa girato e trasmesso dalla tv di quel paese un appello di Michele Placido, popolarissimo come commissario Cattaui, per
sollecitarne la liberazione. 10
Il titolo del volume di Luciano Violante, Non è la piovra (Einaudi, Torino 1994) è
evidentemente polemico verso l'immagine trasmessa dallo sceneggiato. Ma, su un fronte politico opposto, ancora nel 2009 e 2010 Berlusconi accomunava La piovra e Gomorra tra le operazioni che «non facevano fare bella figura» all’Italia. li
Il paragone tra le due serie è addirittura al centro di un’indagine commissionata dalla
Rai su un campione di 80 telespettatori, che proclama il maggiore gradimento del prodotto
italiano: *DaHas»-*La piovra». Analogie e differenze nel giudizio del pubblico, Appunto del Servizio Opinioni n. 425, settembre 1986. 12
Anche il soggettista Nicola Badalucco parla di «una storia intimista, pirandelliana», dt
in M. Buonanno, La piovra. Carriera politica di unafiction popolare, Costa Sr Nolan, Genova 1996, p. 20. De Concini, già sceneggiatore del primo peplum italiano, Lefatiche di Ercole di Piero Franasti e del capostipite del fìhn-spogliareHo Europa di notte di Alessandro Blasetti, aveva lavorato anche al film che in effetti inaugura il gotico italiano, La maschera del
demonio di Mario Bara, a un film fondativo del filone resistenziale come La lunga notte del
’43 di Florestano Vancini, e aveva contribuito in maniera decisiva alla commedia all’italiana
con Divorzio alLitaliana di Pietro Germi. Si veda C. Uva (a cura di), Ennio De Concini. Storie di un italiano, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017. 13 14
Buonanno, La piovra dt, p. 22.
Sulle prime stagioni della Piovra come male melodrama si veda R. Bauman,
Masculinity, Melodrama and Quality Tv: Reviewing La piovra, in «Journal of Italian
Cinema & Media Studies», 6,2018,2, pp. 209-22. 15 Comunicato stampa del 7 febbraio 1984 tit in Buonanno, La piovra tit, p. 15. Cereda - Lopez, Il ragazzo sifarà tit, p. 101.
Cfr. supra, pp. 127-32. 18
Morreale, Complotti, contesti e poliziotti di Dio dt, pp. 76-87; A. O’Leary, Moro,
Brescia, Conspiracy. Lo stile paranoico nel cinema italiano, in Uva (a cura di), Strane storie
dt, PP- 63-78. 19
Tra l’altro: un mafioso claudicante come Luciano Liggio, un attentato simile alla fine di
Mattei, un pentito assai simile, a Leonardo Vitale, la parola «Cupola» che fa la sua prima apparizione, e un vecchio boss detto «il Puparo» che ripete la frase di Buscetta a Contorno: «È tutto finito, puoi parlare». 20
Cfr. la cronaca della visione della puntata insieme agli agenti della squadra mobile di Palermo a cui apparteneva il commissario Ninni Cassare, ucciso nel 1985: A. Bolzoni, «È
morto come Cassarà...», in «la Repubblica», 21 marzo 1989. 21
M. Buonanno, La fiction italiana. Narrazioni televisive e identità nazionale, Laterza,
Roma-Bari 2012, pp. 62-3. Buonanno ricorda anche come l’assassinio del nipote di Tommaso
Buscetta, che aveva commentato su «la Repubblica» la prima puntata della stagione, avesse spinto il quotidiano a impaginare la foto del pentito accanto a quella di Ennio Fàntastìchini,
che interpretava un pentito nello sceneggiato, e quella di Cattaui con l’immagine di Gian Cario Caselli, procuratore capo di Palermo. 22
Sulla scia della Piovra vengono realizzati diversi tentativi di serie dedicate alla mafia e
soprattutto alla camorra (Naso di cane di Pasquale Squitieri; Il ricatto di Ruggero Deodato, Tonino Valerii e Vittorio de Sisti). Il cugino americano, ad esempio, va in onda nel 1986 ed è diretto dallo stesso Giacomo Battiate che ha firmato diverse stagioni della Piovra. In questo caso l’elemento di melo famigliare è accentuato, seguendo molto da presso le orme di certi film di Damiani (soprattutto Pizza Connection). Un giovane ingegnere americano, figlio di un
piccolo imprenditore immigrato decenni prima, viene spedito da Cosa Nostra a Palermo per
uccidere il cugino, giudice sotto scorta che viva a Palermo, ma si allea con lui. Banchieri collusi, figlie affascinanti di uomini potenti, ragazze ridotte in schiavitù dalla droga, un
duplice stupro: una specie di riepilogo del genere. 23
M. Buonanno, Storie di mafia tra cronaca e immaginario. Da La piovra a L’ultimo
padrino, in Ead. (a cura di), Se ventanni vi sembran pochi. La fiction italiana, l’Italia nella
fiction. Anni ventesimo e ventunesimo, Eri, Roma 2010.
Cfr. F. Forgio ne, Amici come prima. Storie di mafia e politica nella seconda
Repubblica, Editori Riuniti, Roma 2004, pp. 150-75. 25
26
Buonanno, Storie di mafia tra cronaca e immaginario dt, p. 398. Brancaccio fa parte ancora del filone post-Mery per sempre, con l’educatore
interpretato da un volto noto che agisce tra attori presi dalla strada. 2?
U film si ispira alla vicenda di Graziella Campagna, uccisa a Villafranca Tirrena (Me) il
12 dicembre 1985, per aver accidentalmente scoperto l’identità del latitante Geriando Alberti junior. Il caso, dapprima insoluto, era stato riaperto nel 1996 grazie alla trasmissione Chi t'ha insto? 28
L’attentatuni (Rai 2,18 e 19 aprile 2001) invece mostra in maniera chiara il passaggio
dallo scorta movie (il regista Bo Divento era produttore di Palermo-Milano sola andata) alle
biografie epiche dei boss. Ha luogo qui la più estrema commistione di realtà e funzione: essendo in corso i processi, gli sceneggiatori inventano una trama parallela sullo sfondo delle
vere indagini. Protagonista è la Dia, nei giorni tra le due stragi, con un grappo di poliziotti isolati che, come da prassi, all’inizio si presentano con i loro nomi in codice e alla fine
verranno così salutati: «Anche se nessuno sa chi siete, i veri eroi oggi in Italia siete voi. Non i
politici, non chi ci governa. Voi». Ma in realtà, sono Tony Sperandeo e Gigi Burraano nei ruoli dei mafiosi a rubare la scena, preparando il terreno alla sempre maggiore centralità dei boss nelle fiction successive. 29
Il film Gli angeli di Borsellino, che «brada» di qualche mese la messa in onda della
miniserie tv sul giudice e si concentra soprattutto sulla giovane agente sarda Emanuela Loi
(Brigitta Boccoli), è un esemplare tardo, quasi un compendio, dello scorta movie: le musiche arabeggianti sui titoli (di Elvira e Giovanni Lo Cascio), le vere foto della scorta e il filmato di Rosaria Schifarli ai funerali di Falcone, la ripresa iniziale di Palermo dall’elicottero. Il film, poverissimo, è girato per lo più tra Civitavecchia e Torvaianica. Del film è da rilevare la singolare raffigurazione della scorta. Per stemperare la tensione, gli agenti vengono raffigurati in vari momenti di divertimento, in discoteca 0 mentre rimorchiano turiste sotto
casa del magistrato distraendosi dalla sorveglianza, col risultato di non restituire la tensione della scorta di Borsellino dopo l’attentato a Falcone. Il giudice è mostrato solo di sfuggita, nulla si dice delle sue indagini e in particolare della sua ricerca di depistaggi sulla strage di
Capati. 30
Il film è tutto un chiamarsi per cognome a benefido dello spettatore: «Dottor Aliquò,
dottor Guarnotta, l’umile dottor Ingioia», «Oh, Tinebra!», «Ciao, De Gennaro!», 0 ancora: «Chi è quel signore che parìa con papà?». «È Caponnetto: lui era il suo capo e quello di
Giovanni», fino al ministro che dice al giudice: «Sono il ministro della Difesa Andò: si ricorda
di me?». Borsellino chiede a Ingioia «tutti i fascicoli su mafia e appalti seguiti da Falcone dall’Ss» (come se non avessero istruito insieme il maxiprocesso). 31
La spiegazione viene fornita in maniera quasi virtuosistica, dall’attrice che interpreta
Liliana Ferraro, amica e collaboratrice di Falcone alla Direzione Affari penali del ministero, in
un monologo sulla tomba del giudice che ricorda quelli di John Wayne nei Cavalieri del Nord Ovest di John Ford. 32
Nello stesso film, dalla scena dei funerali sono espunte le contestazioni ai politici (con il
lancio di monetine al ministro dell’interno Nicola Mancino). 33
Ad esempio l’uccisione del colonnello della finanza Giuseppe Russo. «L’avvocato
Battaglia», indicato come pista per l’omiddio del giornalista Mauro De Mauro, allude
all’avvocato Vito Guarrasi, detto «Mister X». Su Guarrasi si veda M. Bartoccelli - F. D’Ayala, L'avvocato dei misteri. Storia segreta di Vito Guarrasi, Castehecchi, Roma 2012. 34
F. Cavallaro, La vedova Giuliano e la fiction Rai: «Cosa c’entra il caso Contrada?», in
«Corriere della Sera», 18 maggio 2016. 35
I. Pezzini, Ibridazioni. I giudici contro la mafia nel cinema italiano contemporaneo, in
«E/C», 17 gennaio 2015,2. 36
Questa impostazione fa passare in secondo piano il fatto che la vicenda sia in certo
modo raccontata in prima persona: tra gli sceneggiatori c’è Claudio Fava, figlio di Giuseppe (e
sceneggiatore anche dei Cento passi), che compare nel film come ideale punto di vista sulla vicenda. Ma questo non aggiunge nulla di sostanziale alle modalità di racconto. 3“
18 39
Buonanno, Storie di mefia tra cronaca e immaginario tit, p. 399. A. Bolzoni - G. D’Avanzo, Il capo dei capi, Mondadori, Milano 1993, p. 24.
Bolzoni - D’Avanzo, Il capo dei capi cit, p. 197. Tra i numerosi esempi di doppiezza
narrati nel libro di Bolzoni e D’Avanzo, particolarmente riferiti alla guerra contro i boss Di Cristina e Badalamenti, si vadano pp. 128,133,171-3,177-8,190-1,196^7. 40
Il film costruisce una speculanti tra le due figure, spede attraverso il versante privato e
il rapporto con le rispettive mogli, Teresa e Ninetta: c’è addirittura un montaggio alternato
delle due gravidanze coeve, con la prima in ospedale mentre l’altra partorisce e, dopo aver visto Ninetta, abortisce per lo spavento. Inversamente, mentre si consuma la strage di viale Lazio nasce il figlio di Stimò. Sia il poliziotto che il boss sono devoti padri di famiglia: Riina
consola la moglie quando lei piange, e sequestra la moglie e il fìgfio di Stimò, ma solo quando viene incriminata Ninetta per stanarlo (azione che viene mostrata come un’ingiustizia intollerabile): poi però grazierà il poliziotto dicendogli di lasciar stare la sua famiglia. Come
nel Padrino (col suo montage tra il battesimo e gli omicidi), il matrimonio di Riina è in parallelo con 1’omiddio del boss Di Cristina, che si era rivolto a Boris Giuliano per coDaborare
con la giustizia e che viene mostrato come il classico infame. .
ritaglio conservato presso il Fondo Rosi del Museo nazionale del cinema di Torino). 42
Mancino, Schermi d’inchiesta dt, p. 171.
43
«Ogni film è definito storicamente e, pertanto, iconograficamente c’è sempre una
relazione stretta tra il periodo in cui il film è ambientato e il riferimento pittorico dell’epoca. In H bacio di Giuda agisce la storia della pittura toscana sino al Rinascimento, da Giotto a
Masacdo, a Piero della Francesca. H Barocco esplode in Corfortorio. (...) Facendo un film
ambientato nell’oscurantismo dello Stato Pontifico, non potevo non fare riferimento a quel
clima culturale: è lì che affondano le radia dell’iconografìa del film. Per Tiburzi, i riferimenti iconografia sono stati i macchiatoli, i pittori di genere della seconda metà deH’800, ma anche
l’iconografia popolare dei tableaux dei cantastorie e degli ex voto. Di più: si ritrovano
riferimenti ai fratelli Alinari che hanno fotografato la Maremma dell’ottocento e ai Lumière. Il 1896 (sic), l’anno dell’ucdsione di Tiburzi, è anche l’anno della nasata del dnema. Ed è da lì die toma Tiburzi ed è come se ne portasse dietro l’eco. Per Gostanza da Libbiano il
discorso si sposta sul manierismo e soprattutto su Angelo Bronzino» (P. Benvenuti,
Trenfanni di cinema, in Fofi, Paolo Benvenuti dt, p. 69). 44 Cfr. Baroni - Benvenuti, Segreti di Stato dt, p. 106; Fofi, Paolo Benvenuti dt, pp. 36-7. 45 Fofi, Paolo Benvenuti dt, p. 40. 46 Come ricordano Jane e Peter Schneider: «1363 testimoni contro Cosa Nostra del 1997 rappresentavano il 6,6% dei órca 5500 affiliati che si presumevano attivi in Sicilia» (Un
destino reversibile dt, p. 112). 47
Sul caso psichico di Vitale si veda G. Lo Verso, Mafia efollia. Il caso Vitale. Uno studio
psicodinamico e psicopatologico, in «Psicoterapia e scienze umane», 1995,29, pp. 99-121, che analizza il «conflitto tra il mondo della madre e quello del padre», le proiezioni
incestuose verso la sorella e l’omosessuahtà repressa. 48
Dana Renga (Unfinished Business dt, pp. 91-8) sottolinea però come la struttura e
l’iconografìa cristologica servano anche a smorzare la complessità, psicologica e sessuale, del personaggio. 49
Si vedano anche G. Montemagno, H sogno spezzato di Rita Atria, Edizioni della
battaglia, Palermo 1992; S. Rizza, Una ragazza contro la mafia, La Luna, Palermo 1993. 50
F. Cavallaro, Film sulla pentita, guerra neU’antimafia, in «Corriere della Sera», 11
marzo 2009. Si veda anche l’intervista a Piera Aiello in Vegna, Donne, mafia e cinema dt, PP. 131-2. 51 Su questo topos cfr. E. Morreale, Bambino, in Lessico del cinema italiano, a cura di R. De Gaetano, Mimesis, Milano 2014» b PP-107-8. 52
Gran parte del film è privo di dialoghi, 0 composto da dialoghi irrilevanti: il protagonista
Saleh Bakri, algerino, paria così poco che non è doppiato. 53
Sull’uso della canzone si veda A. Boylan, Fabio Grassadonia and Antonio Piazza’s
Salvo: The Sound ofRedemption in an Infernal Landscape, in Renga (a cura di) in Mafia
Movies. A Reader dt, pp. 306-11. 54
In occasione della presentazione a Cannes, Grassadonia dichiarava: «L’Italia è diventato
un paese di costanti celebrazioni istituzionali, retoriche. Si continua ad abusare di queste
storie, un abuso che le appiattisce, le rende uguali, interscambiabili. Per questo abbiamo
invece scelto un impianto drammaturgico forte». E Piazza ribadiva: «Abbiamo scelto di raccontare attraverso il genere - storia d’amore, favola, ghost story - per evitare l’etichetta
del “film di mafia”. Il nostro cinema civile nel passato ha esempi alti, da Salvatore Giuliano a Le mani sulla òtta, ma questa dimensione di racconto poi è diventata di maniera, un genere
d’intrattenimento con cui il risveglio delle coscienze non ha nulla a che fare. Perciò l’uso della
favola per noi è atto politico, provocazione». Più avanti il regista accenna alle «fiction sulle vittime di mafia, categoria merceologica battuta da produttori senza scrupoli» (A. Finos, La
Sicilia di Piazza e Grassadonia: •Ecco la nostra favola politica», https://www.repubblica.it /speciali/cinema/cannes/festìval2oi7/2oi7/os/i9/news
/Ia_sicilia_di_piazza_e_grassadonia_ecco_la_nostra_favola_politica_-i6584io86
/?refresh_ce). 55
M. Mancassola, Non saremo confusi per sempre, Einaudi, Torino 2011; n ed. La Nave di
Teseo, Milano 2018, pp. 85-134. 58
Nella chiave del nuovo genere delle co-produzioni da festival si spiega anche la
presenza, altrimenti incomprensibile, della madre svizzera della protagonista, interpretata da
Sabine Timoteo. 57
Sulle vicende delle famiglie mafiose di Bagheria dall’inizio del Novecento agli anni venti
si veda V. Drago, Mattatoio Bagheria. Famiglie, banditi e politica in una capitale di mafia,
Phimelia, Bagheria 2018. 58
Nella vicenda si può forse avvertire ancora una volta l’eco di una figura storica, quella
del barone Giuseppe Di Stefano, morto nel 1998 nella stanza 204 del Grand Hotel et des Palmes di Palermo, dove aveva vissuto da recluso per decenni, si dice dopo essere stato «graziato» ed «esiliato» dalla mafia (la storia è ripresa in molti film: in Dimenticare Palermo un personaggio a lui ispirato è interpretato da Vittorio Gassman). 59
P. Small, No Way Out: Set Design in Mafia Films, in «Italian Studies*, 2011,66, pp.
112-27. 60 M. Wood, Lipstick and Chocolate. Paolo Sorrentino’s Consequences of Love, in Renga (a cura di), Mafia Movie. A Reader cit, pp. 354-62. 61
Sul rapporto col realismo e la politica italiana si veda M. Marcus, The Ironist and the
Author: Post-Realism in Paolo Sorrentino's H Divo, in «The Italianist», 2010,30, pp. 245-57. 62
Su questo topos comincia addirittura il documentario di Mark Cousins, The Story of
Film: an Odyssey, che mette a confronto le scene di IIfuggiasco, Due o tre cose che so di lei e Taxi Driver. 83
«La Storia - in II divo - diventa museo delle cere, defilé di maschere, carnevale del
senso. Dove sono i movimenti, le masse, il Partito Comunista, l’opinione pubblica? Dal punto di vista del Divo, sono solo fòrmiche» (G. Canova, Gnemania. 10 anni 100 film: il cinema
italiano del nuovo millennio, Marsilio, Venezia 2010, p. 250). 84
L’attore «è colto spesso troppo da vicino, 0 lateralmente, 0 per porzioni di volto; allo
stesso tempo lo si mostra e se ne impedisce una vista dalla giusta distanza» (Q Jandelli, I
protagonisti. La recitazione nelfilm contemporaneo, Marsilio, Venezia 2012, p. 112). 65
Sui «fìnti stop-frame* come cifra del Servillo cinematografico si veda M. Guerra,
DirActor’sCut: Toni Servillo, la materia delfilm e il cinema italiano contemporaneo, in
www.arabeschi.it. 66
Dichiarazione citata in G. Fiorito (a cura di), Il divo. Unfilm di Paolo Sorrentino, Dante
& Descartes, Napoli 2008, p. 4. La performance di Servillo è in effetti sotto il segno deD’artifìdo, della distanza dal reale, della maschera-statua: il suo Andreotti è un pupazzo post-umano, con le palpebre perennemente abbassate e una voce da robot, anche quando
pronuncia le celebri battute sarcastiche, che appaiono in tutta la loro tremenda vacuità. Crede di governare la Storia, ma è solo un meccanismo. Questa compressione, in cui la crosta di
trucco di Andreotti sembra doversi rompere a ogni momento per mostrare il Servillo che c’è sotto, esplode nella scena clou del monologo immaginario in cui il protagonista svela,
guardando in macchina, la propria visione del mondo e della Storia. Un monologo filato, senza pause e in crescendo, velocissimo, in cui Andreotti alza la voce, lega le frasi, prende
fiato in controtempo e infine allarga gli occhi e sospira, mentre espone una visione del potere come coscientemente nemico della verità in cui risuonano accenti del Grande Inquisitore
dostoevskijano. 6-
Il cosiddetto «papello» contenente le richieste di Riina, consegnato a Ciancimino
durante le trattative con i Ros, presentava dodici punti: 1) revisione della sentenza del
maxiprocesso di Palermo; 2) annullamento del decreto legge die inaspriva le misure detentive previste dall’articolo 41 bis; 3) revisione dell’associazione di tipo mafioso (il
cosiddetto articolo «416 bis»); 4) riforma della legge sui pentiti; 5) riconoscimento dei benefìci dissociati per i condannati per mafia (come per le Brigate Rosse); 6) arresti
domiciliari dopo i 70 anni di età; 7) chiusura delle super-carceri; 8) carcerazione vicino alle case dei familiari; 9) nessuna censura sulla posta dei familiari; 10) misure di prevenzione e rapporto con i familiari; u) arresto solo in flagranza di reato; 12) defìscalizzazione della
benzina in Sicilia (come per Aosta, sic). Al cosiddetto «papello», ritenuto troppo radicale
nelle richieste, ne subentrò secondo Massimo Ciancimino un altro, redatto dal padre Vito. Salvatore Lupo, il quale fa notare come alcune delle richieste del contropapeUo («riforma
della giustizia all’americana») non siano affatto più moderate di quelle del primo, osserva
che, «in barba a ogni trattativa vera o presunta, per quante bombe siano scoppiate, per
quante promesse siano state fatte perché non scoppiassero più, nessuna delle richieste del
papello è stata accolta. (...) La sentenza del maxiprocesso non è stata aggiustata. Non è stato abolito il 41 bis» (S. Lupo, Lo sguardo dello storico, in G. Fiandaca - S. Lupo, La mafia non
ha vinto. Il labirinto della trattativa, Laterza, Roma-Bari 2014» pp. 38 e 58; dello stesso avviso, nello stesso volume, Giovanni Fiandaca, pp. 90-1). Più sfumata la posizione di Umberto Santino, secondo il quale alarne richieste «in qualche modo, sono state recepite o
attuate 0 poco d mancava che lo fossero» (p. 76): in particolare qualcosa si potrebbe rinvenire in certe norme della legge sul «giusto processo», nella legge che obbliga i pentiti a
completare le proprie dichiarazioni entro sei mesi, negli arresti domiciliari agli anziani (U.
Santino, Don Vito a Gomorra, Editori Riuniti University Press, Roma 2011, pp. 75-80). Si può affermare comunque la debolezza di un legame di causa ed effetto tra la realizzazione
delle richieste di Cosa Nostra e una ipotetica pace tra Stato e mafia. 68
Per una bibliografìa ragionata sul tema (seppure ovviamente ferma al 2011) si veda
Santino, Don Vito a Gomorra dt, pp. 9-120. Le conclusioni dell’accusa sono esposte sinteticamente dallo stesso giudice Ingioia in A. Ingioia, G. Lo Bianco, S. Rizza, Io so,
Chiarelettere, Milano 2012, pp. 28-34. 69
Per un riepilogo e alcune riflessioni sulla sentenza di 1 grado si veda G. C. Caselli - G. Lo
Forte, Lo Stato illegale, Laterza, Roma-Bari 2019, pp. 121-41. ° G. Fiandaca, Lo sguardo del giurista, in Fiandaca - Lupo, Il labirinto della trattativa
dt, pp. 69-135; Id., La trattativa Stato-mcfia tra processo politico e processo penale, in
«Criminaha. Annuario di scienze penalistiche», 2012, pp. 69 sgg. Si tende a dividere la «trattative» in fasi distinte, a partire dall’omiddio di Salvo Lima,
prima e dopo la cattura di Riina, quando essa proseguirebbe con Provenzano (più una
trattative parallela per la restituzione di opere d’arte rubate), per giunta in due binari
paralleli: uno tra Ciandmino e gli affidali del Ros, e l’altro tra Ciandmino e un misterioso «signor Franco» 0 «signor Cario» venuto fuori a più riprese dalle deposizioni di Massimo
Ciandmino. 72
Sulla valutazione complessiva, lo storico è lapidario: «A me sembra evidente: nel ’92-’93
non è cominciata nessuna guerra civile, non c’è stato nessun golpe e nessun progetto di golpe.
Quanto ai complotti, molti ce ne saranno stati in quel cruciale decennio, ma non derivano da
complotti né la grande popolarità di Di Pietro nel ’92-’93, né le vittorie elettorali di Forza Italia nel ’94 e in anni seguenti» (Lupo - Fiandaca, La mafia non ha vinto dt, p. 57). Lo storico sottolinea anche come l’idea totalizzante della Grande Trattativa Riusdta faccia
proprio il mito dell’invindbilità di Cosa Nostra e la visione della politica tipid dell’organizzazione medesima (pp. 53-5). 73
Per capire quanto le storie siano complesse e sfumate, quanto le generalizzazioni, pur
inevitabili, rischino di diventare mistificazioni basterà rileggersi, per limitarci al settore delle forze dell’ordine, le biografìe del generale Mori, del colonnello Riccio e del generale Subranni,
mostrati nel film di Guzzanti, ma anche del cosiddetto capitano Ultimo (processato e assolto
per la mancata perquisizione del covo di Riina, e poi per la mancata cattura di Provenzano), di Giuseppe De Donno (capitano dei Ros, molto considerato da Falcone e tramite con Vito
Ciancimino), Antonino Lombardo (maresciallo di Terrasini accusato di connivenza in diretta tv, suicidatosi pochi giorni dopo), Carmelo Canale (capitano dei carabinieri, il più stretto
collaboratore di Borsellino che si fidava ciecamente di hai, poi indagato per concorso esterno
in associazione mafiosa e assolto), del generale Francesco Delfino (che raccoglie le
confessioni di Di Maggio che porteranno alla cattura di Riina, ma è stato indagato per la
strage di piazza della Loggia e condannato per estorsione ai danni della famiglia Soffiantini,
cui aveva chiesto soldi promettendo la liberazione del figlio), del maresciallo Giuseppe Ciuro della guardia di finanza, collaboratore del pm Ingioia e condannato per l’inchiesta sulle
«talpe» alla Dda: figure diversissime, che d mostrano però una serie di situazioni difficili da districare nettamente. Cfr. E. Deaglio, Raccolto rosso, nuova ed. Il Saggiatore, Milano 2014, sezione «Usi a obbedir tacendo» (pp. 313-21). 74
La situazione, secondo alcuni osservatori, si è invece rivelata col passare del tempo
sempre più opaca: «Di quello che successe in quei terribili anni 1992-1993, le poche verità
raggiunte sono state sostituite da una nessuna verità, sostituita da sospetti e accuse redproche, con processi in corso tanto teatrali quanto macchinosi e destinati al nulla, se non agli scoppiettìi dei media e a qualche ricatto politico. Carabinieri, ministri, giudid, servizi
segreti sono accusati della “trattativa”, una parola dietro cui ormai si immagazzina praticamente tutto» (E. Deaglio, Il mistero di Spatuzza, in «Il Venerdì di Repubblica», 28 giugno 2013). 75
Ad esempio è tutfaltro che ovvio che Martelli, nel 1993, sia stato rimosso come ministro
della Giustizia perché alleato di Falcone, come sostiene il film, e non perché in quel momento tenere alla Giustizia il delfino di Crasi era una scelta impopolare. O ancora: il film, riguardo al
fallito attentato allo stadio Olimpico, suggerisce che fosse arrivato un contrordine dovuto al procedere della Trattativa. Ma va anche considerato che erano appena stati arrestati i fratelli Graviano, ossia coloro che materialmente erano delegati all’organizzazione delle stragi (e ad
esempio la deposizione di Giovanni Brusca riconduce la fine della strategia stragista a dissapori interni a Cosa Nostra, tra BagareDa e i Graviano; dt in Fiandaca - Lupo, La mafia
non ha vinto dt, p. 95). Indubbiamente l’arrivo di Forza Italia può aver messo Cosa Nostra in
una situazione di minore scontro frontale: ma più in ragionevole attesa di qualcosa di positivo che come reazione a qualche benefido già raggiunto. Questa semplificazione, infine, genera anche qualche effetto perverso, come quello di
dipingere Gian Carlo Caselli come uno sprovveduto che, nelle due apparizioni nella vicenda, prima avalla la mancata perquisizione del covo di Riina e poi non verbalizza le dichiarazioni
dell’infiltrato Hardo. Considerazioni caute e ragionate dell’allora procuratore capo riguardo al processo sulla trattativa sono espresse in G. C. Caselli, Tiro aWlngroia sport nazionale, in «Il
Fatto Quotidiano», 15 giugno 1993.
' ' G. Lo Bianco- S. Rizza, L’agenda rossa di Paolo Borsellino, Chiarelettere, Milano 2017,
ricostruisce in maniera minuziosa gli ultimi giorni di Borsellino, tra la strage di Capad e quella di via D’Amelio, cercando anche elementi utili a comprendere le dinamiche che hanno
condotto alla sua uccisione.
xiv. Mafiaworld
i. Ares, Taodue e gli altri.
Per semplificare, due grandi modelli di finzione televisiva hanno costituito il racconto di Cosa Nostra nell’ultimo quindicennio. Li
potremmo definire il modello-Tarallo e il modello-Valsecchi, dal nome dei due produttori più fecondi nel settore1. Come si è accennato nel capitolo XI, Pietro Vaisecchi è il principale
responsabile dell’immaginario diffuso sulla mafia, di una
fictionalizzazione in cui le logiche del genere assorbono i riferimenti
alla realtà. Dopo le miniserie dei primi anni duemila, la produzione della sua Taodue ha virato verso la lunga serialità, per poi diridersi tra serie pluristagionali (Squadra antimafia') e film in uno-due episodi dedicati a biografie di rittime della mafia. Si può vedere una logica
involontaria ma rivelatrice nella polarizzazione tra lunga serialità e miniserie. La prima presuppone una presenza costante del fenomeno
mafioso, il suo carattere eterno e mitico; mentre la seconda, specularmente, è concentrata su una singola biografia esemplare: il mito (con l’accumulo dei colpi di scena che assume vita propria) e la
biografia (costruita per stazioni e passaggi obbligati) sono due rie
possibili per ricondurre la mafia a qualcosa di riconoscibile,
circoscritto, lontano dallo spettatore. Cosa Nostra, col suo portato di stereotipi visivi e narrativi, si offre come «luogo» rassicurante, immaginario, davanti all’emergere di camorra e ’ndrangheta. Subito dopo arriverà la spettacolarizzazione della serie Gomorra, la quale però si propone come «nuova
televisione», contaminata con il cinema, mentre per Squadra antimafia il riferimento diretto non è il mafia morie bensì gli
sceneggiati del passato. Per semplificare: la mafia siciliana negli ultimi anni ha permesso una narrazione familiare del mondo del
crimine. Comincia così l’epoca del Mafiaworld, una Cosa Nostra che è quasi parco a tema, mondo di segni che di volta in volta può
mobilitare le varianti della commemorazione, dell’impegno, del complotto per rafforzare la propria consistenza sulla scena dei media. Squadra antimafia, la cui prima stagione va in onda nella primavera del 2009, nasce idealmente all’incrocio tra Distretto di
polizia, fortunata serie prodotta sempre da Taodue a partire dal 2000, e II capo dei capi, che, con le sue 6 puntate, già tendeva verso la lunga
serialità. Ma segna anche un ritorno al genere delle «scorte» di cui abbiamo parlato nel capitolo XI.
Il ritmo iniziale è quello convulso del poliziesco: il ritmo
dell’emergenza continua, che presuppone l’idea della mafia come problema di cronaca e di ordine pubblico. Uimagerie è riconoscibile, con le visioni dall’alto dei quartieri nuovi, i mercati, le musiche di
riempimento, i dialoghi didascalici e la fotografia piatta. Nella prima stagione, i cui personaggi sono di fantasia, vengono però innestati
vaghi riferimenti all’attualità, secondo il modello della Piovra. Si
parla di «corleonesi», della cattura di Provenzano, del ritorno degli
«scappati». Il prologo non a caso si svolge nel 1992, anno simbolico, anche se nessun evento storico è affrontato direttamente. Poi i
riferimenti si faranno più occasionali, e nelle stagioni successive
scompariranno anche certi riferimenti culturali pretenziosi (nelle prime puntate veniva citato Una storia semplice di Sciascia, e c’erano
visioni oniriche commentate dalla Sinfonia n. 7 di Beethoven). La
vicenda è inizialmente polarizzata su due figure femminili, la poliziotta Claudia Mares interpretata da Simona Cavallari (che porta
con sé appunto l’alone della Piovra) e Rosy Abate (Giulia Michelini), figlia di un mafioso, che la Mares ha salvato da bambina e con la quale
ha un rapporto materno. I rimandi all’attualità sono protetti dall’affidabile schema narrativo
del Complotto, con allusioni di sfuggita a «un nuovo ordine Statomafia»: ma dalla seconda stagione i riferimenti più diretti sono lasciati cadere: il Mafiaworld ha stabilito le proprie caratteristiche, ed
è autosufficiente. Anche le guerre di mafia inventate per l’occasione passano sempre più sullo sfondo, con intrecci sovra-regionali e sovra-
nazionali in cui i singoli clan immaginari (i Mezzanotte, i Ragno, i Maglio) sono più che altro un elemento di colore. Nella seconda stagione compare la decisiva figura di De Silva, uomo dei servizi segreti interpretato da Paolo Pierobon, che riprende la figura di Tano
Cariddi nella Piovra, con i suoi continui passaggi (in fondo intercambiabili) dal Bene al Male e viceversa, da deuteragonista ad antagonista. È De Silva a veicolare il modello narrativo del complotto,
per cui le poste in gioco dei vari episodi (droga, rifiuti tossici, eolico, chiavette usb) sono secondarie, puri MacGuffin rispetto all’obiettivo che è segretamente, come in certi film di spionaggio o fantascientifici, il dominio del pianeta Terra. La sua entrata in scena, non a caso, è
accompagnata dalla metafora dell’opera dei pupi, di qualcuno che «tira i fili». Egli è simile al classico protagonista di quella che
Umberto Eco definiva la «terza stagione» del romanzo d’appendice, in cui, dopo il superuomo eccezionale e l’uomo comune, dominano eroi antisociali «che non vendicano più gli oppressi ma perseguono un
loro pnvato piano di potere», come Fantomas o Arsene Lupm . Convertitosi a Cosa Nostra dopo un’esperienza in Afghanistan, lo
vedremo dalla parte dei buoni come infiltrato, poi colpito da amnesia
per un tumore, morto in un tunnel col gas nendno e ovviamente risorto (questo, solo nelle prime cinque serie).
L’oscillazione del personaggio tra Bene e Male è ancora più
schizofrenica in quella che diventa ben presto la protagonista della serie, Rosy Abate, le cui azioni sono sempre imprevedibili perché
irrazionali, in quanto lei appartiene a due universi che si suppongono
governati dalle passioni: è mafiosa e donna. I suoi moventi sono dunque intimi, legati all’amore o all’odio personale. Nel corso delle
puntate sarà rapita, rapitrice, vittima, erinni, collaboratrice di
giustizia, autoreclusa in convento, seduttrice (a volte con
travestimenti pseudo-sexy da manager, poliziotta, suora); si
innamorerà e farà innamorare di sé criminali e poliziotti: insomma
sarà pura funzione narrativa governata dal piacere dell’afbitrarietà tipico del romanzo d’appendice. Ma altrettanto personali sono i moventi dei suoi avversari-amici nelle forze dell’ordine, Claudia
Mares e i suoi successori, che perseguono i propri scopi di verità e
vendetta sul filo dell’illegalità. La serie è costruita su una serie di opposizioni tra personaggi femminili, che si fanno la guerra mossi da . 3 . passioni private, anzitutto dalla vendetta . Di volta in volta a\iemo
Ilaria La Viola (Serena lansiti), antagonista in una fase in cui Rosy è buona; l’ispettore Francesca Leoni (Greta Scarano); Giulia Platania (Roberta Giarrusso), vedova di un boss; il questore Lara Colombo
(Ana Caterina Morariu), contrapposta alla malvagia sorella Veronica (mafiosa che si allea con un clan appoggiato da De Silva); Rachele Ragno (Francesca Vaitorta), del clan omonimo, cattiva anche lei ma
che odia Veronica e si allea con il poliziotto Calcatemi (ma poi odierà
visceralmente anche quest’ultimo); il vicequestore Anna Cantalupo
(Daniela Marra), ex nuora di un riciclatore, che avrà una storia con Calcaterra, e alla sua morte sarà a capo della squadra antimafia; la lapdancer Patrizia Fiorelli (Caterina Shulha), e si potrebbe
continuare.
Anche lo sfondo sociale è modellato sulla base di questa visione romanzesca e iperbolica, in cui i buoni e i cattivi si scambiano di posto
o sono letteralmente imparentati. Il sindaco antimafia è in realtà un
prestanome, il gestore dei beni confiscati è genero di un boss, il giudice Ferretti è membro della società segreta Crisalide (super
mafia, leitmotiv di alcune serie: «la mafia è Crisalide, quando diventa Stato deviato») ed ex amante di De Silva. L’imprenditore Umberto Nobile (Tommaso Ramenghi) è fratello di Haria La Viola, compagna
di cella di Rosy Abate che si scoprirà essere loro cugina; De Silva scopre che il boss Mazzeo è suo padre; l’ispettore Francesca Leoni è
figlia di un latitante; il vicequestore Anna Cantalupo è l’ex nuora di un
riciclatore; l’ispettrice Rosalia Bettinelli (Silvia D’Amico) scopre di
essere figlia di Nardo Abate, il fratello di Rosy. Si intravede tra l’altro,
in alcune di queste occasioni, un classico topos evidenziato da Eco, quello della «generazione antitetica»: il figlio buono riabilita il padre . . 4 cattivo e viceversa .
Tra la quarta e la quinta stagione la trama accentua la gratuità del meccanismo, Claudia Mares muore, i personaggi femminili si moltiplicano avendo come perno Rosy (il cui figlio viene rapito e poi ucciso, ma si lascia presumere che prima o poi rispunterà in qualche
modo), l’ambientazione si sposta a Catania. La figura maschile
centrale diventa il poliziotto Calcaterra, il quale viene anche lui scisso in buono e cattivo, ma in maniera inconscia: uno sdoppiamento di
personalità lo trasforma in una specie di giustiziere della notte che liquida senza troppi complimenti i cattivi e i collusi. Dopo altre tre
stagioni arriva un altro poliziotto, Tempofosco (Giovanni Scifoni),
sostituito rapidamente da Anna Cantalupo. Ma in genere gli uomini hanno minor rilievo: il perno è sempre più la coppia Rosy Abate/De
Silva, la mafiosa e la spia, buoni o cattivi a seconda delle stagioni o delle puntate (per cui in effetti il titolo Squadra antimafia diventa a
un certo punto sviante).
Sarebbe lungo, e in fondo inutile, seguire i passaggi narrativi all’interno delle centinaia di ore andate in onda. I riferimenti all’attualità sono sempre più subordinati a un mondo fiabesco, di combinazioni più o meno sempre uguali, ritornanti simili per decine
di ore, e dunque rassicuranti: talpa; oggetti misteriosi in gioco
(chiavette usb, anelli, tesori); storia d’amore tra colleghi (in un caso, due colleghe); rapimenti (con tentato stupro) o innocenti in pericolo;
poteri occulti che la fanno franca; passato che ritorna (attraverso flashback in ralenti 0 col flou). Nel corso della serie esplodono decine di bombe in vari attentati, anche i più modesti, perché la bomba ha
ormai superato l’immagine del killer su moto nell’iconografia del mafia movie, e la sua comparsa evoca le stragi del 1992, come le esplosioni alla fine degli anime anni settanta evocavano i funghi
atomici di Hiroshima e Nagasaki. Gli elementi ritornano in modo che in qualunque puntata lo spettatore possa recuperare il filo, tanto
accadranno più o meno le stesse cose (anche gli attori che si susseguono si somigliano tra loro) e sono pochi gli eccessi narrativi e
visivi che sfociano verso il trash0. . . .6 . N . Davanti al calo degli ascolti , la serie è interrotta, ma viene
recuperato il personaggio più caro al pubblico con lo spin-off Rosy
Abate, incentrato sul ritrovamento, da parte della protagonista, del figlio Leonardo, dato per morto nella quinta stagione ma sempre, per il pubblico, in odor di resurrezione (era morto fuori campo: indice
sicuro di possibile ritorno). Rosy infatti lo ritrova a Roma, si fa assumere come sua tata, scopre che la madre adottiva, Regina (il cui
marito gestisce terre confiscate alla mafia), è a sua volta figlia di un
boss, che ricatta il genero. E sullo sfondo del maternal melodrama (più qualche accenno ai recenti eventi dell’inchiesta «Roma capitale»)
si configura un nuovo scontro tra donne. Negli anni successivi, le case di produzione specializzate cercheranno man mano di innestare timidi elementi highbrow nel
mafia morie televisivo. Un processo che si spiega con il riassesto del
sistema mediale e l’emergere di modelli televisivi «di qualità» da parte dei nuovi broadcaster, proprio a partire da una rilettura dei modelli del mafia morie (Romanzo criminale va in onda su Sky dal 2008 al 2010). Il primo tentativo viene proprio da Taodue, con Romanzo siciliano,
esempio di fiction più «nobile», trasmesso con qualche marchio di
autorialità evidente nella presenza di nomi tipici del «cinema medio
d’autore», come Fabrizio Bentivoglio o Sandra Ceccarelli, e dalla maggiore presenza di riferimenti alla politica. Agli ingredienti tipici
del filone (la storia d’amore tra colleghi, la «talpa» e il rapimento) vengono affiancate altre linee narrative che non hanno a che fare con
la mafia (delitti d’onore, regolamenti di conti tra famiglie di nobili)
come a comporre una specie di inventario complessivo della Sicilia
criminale, con l’aggiornamento alle nuove mafie attraverso la presenza marginale della ’ndrangheta. Ma alla fine gli ingredienti di
base rimangono gli stessi, e la rappresentazione di Cosa Nostra
coincide con un supercattivo e un paio di suoi sgherri.
La Rai aveva tentato, all’interno delle miniserie, una strada ancora
più «alta» con II segreto dell'acqua (Rai i, 11 settembre-2 ottobre 2011), prodotto da Magnolia, diretto da Renato De Maria e interpretato da Riccardo Scarnarci©, entrambi reduci da La prima
linea, film sul terrorismo rosso co-prodotto dai fratelli Dardenne. Nonostante una confezione prestigiosa (fotografia di Marco Onorato, che aveva appena firmato Gomorra di Garrone, musiche di Teho Teardo, collaboratore fra l’altro di Paolo Sorrentino), la fiction ha
ascolti non eccezionali (e ne viene realizzata una sola stagione) forse a causa dell’andamento lento e meditativo delle prime puntate, e di un
protagonista con cui è difficile identificarsi, un commissario rude e spigoloso da poliziottesco anni settanta. Fin dall’inizio vengono
disseminate citazioni colte, dalla Casa dei doganieri di Montale a Joseph Roth (e la chiave di tutto sta nella trama del Lungo addio di
Chandler). Ma in realtà i dialoghi didascalici, i flashback sovraesposti, le inverosimiglianze di sceneggiatura e i passaggi obbligati (il fratello
nascosto/cattivo, la talpa, il ricatto, la storia d’amore con la collega)
non differiscono molto da quelli dei prodotti di Taodue. Al centro della trama, che prende spunto da un ipotetico ritrovamento della
Natività di Caravaggio rubata all’Oratorio di San Lorenzo di Palermo nel 1969, c’è una speculazione edilizia, lo scontro tra il feroce nuovo mafioso (Massimiliano Gallo) e il vecchio (Gigi Burruano), in apparenza pentito, che adesso produce vini.
Esempio più interessante di questo filone «alto» è Maltese - Il
romanzo del Commissario (in onda dall’8 al 16 maggio 2017 su Rai 1), diretto da Gianluca Maria Tavarelli e prodotto dalla Palomar che,
dopo la fortunata serie del commissario Montalbano, innesta un personaggio di poliziotto su un terreno televisivo riconoscibile, ma con qualche elemento di novità. La storia del commissario
perseguitato da un trauma infantile che decide di tornare in Sicilia per
vendicare la morte di un amico d’infanzia è un canovaccio noto. Alle spalle sono evidenti i riferimenti di cronaca (la mafia trapanese è
storicamente quella più legata alla massoneria) e la regia si permette delle libertà, con un certo uso della macchina a mano e qualche scena cruenta. Ma a segnalare il riposizionamento di questo prodotto sono soprattutto il cast, di livello superiore a qualunque produzione del genere (Kim Rossi Stuart attorniato da facce cinematografiche più che
televisive: Valeria Solarino, Enrico Lo Verso, Francesco Scianna), e la chiave visiva anni settanta, sul modello dei Cento passi: le scene
d’azione e montaggi con musica d’epoca, o il momento in cui Rossi Stuart canta Sereno è di Drupi. Alle spalle c’è probabilmente l’ipotesi di un nuovo tipo di pubblico, anche sulla tv generalista, dopo il
successo della nuova serialità crime americana. Se II segreto dell'acqua arrivava forse troppo presto, Maltese è
invece già dentro una fase nuova, e la sua eredità viene portata a
compimento non a caso da un prodotto delle nuove piattaforme. Il cacciatore, andato in onda su Amazon Prime nel 2019, apre infatti
una nuova fase. Si tratta del primo incontro compiuto tra lo schema del mafia morie e quello della tv di qualità proposta dai nuovi
operatori audiovisivi, satellitari e poi in streaming. Il crime è stato uno dei modelli di creazione della nuova estetica televisiva, in forme
sempre più articolate (Romanzo criminale, Gomorra, Suburra, Il miracolo). La cosa interessante è che in questo caso, al contrario di
quanto è accaduto per il cinema, si arriva a Cosa Nostra alla fine di un
percorso di esplorazione delle mafie contemporanee. E la chiave scelta è, prevedibilmente, quella del vintage, come in quasi tutta la
produzione cinetelevisiva degli ultimi decenni. La serie racconta la
vicenda del giudice Saverio Barone, riscrivendo liberamente il libro autobiografico di Alfonso Sabella Cacciatore di mafiosi. Il
protagonista è un eroe dai lati oscuri, come impone appunto la nuova
drammaturgia televisiva; la cattura dei mafiosi è per lui un’ossessione, collegata a due fili che attraversano le varie puntate: il rapporto con
un amico di gioventù diventato mafioso, e la disperata ricerca del piccolo Giuseppe Di Matteo, sequestrato dai corleonesi e già al centro di Sicilian Ghost Story. Tipico anche l’equilibrio tra la parte dei
«buoni» e quella dei «cattivi», ovviamente molto umanizzati (il
rapporto tra Leoluca Bagarella e la moglie, il Brusca interpretato da Edoardo Pesce). Anche qui, in maniera più accentuata che nel Capo
dei capi e in altri casi, a essere chiamati con nome e cognome reali sono esclusivamente i mafiosi, mentre giudici e poliziotti sono personaggi di fantasia, pur se ispirati a personaggi reali.
Le differenze con la produzione televisiva generalista sono evidenti. Il risultato è uno spostamento dei modelli, altrettanto meccanicamente assunti che in passato. A uno stile neutro se ne
sostituisce uno molto vistoso: la voce over in prima persona (addirittura all’inizio con una traduzione in siciliano della Divina
Commedia) al posto degli «spiegoni», la luce bluastra o arancione al posto di quella piatta, il drone al posto dei totali dall’alto su Palermo,
moltissimo ralenti (anche metaforico, come in una scena che mostra le onde del mare come simbolo di turbamento) e canzoni d’epoca.
Se le produzioni Taodue nascondono i procedimenti del
melodramma sotto la maschera del film agiografico o dell’action per
famiglie, quelle della Ares di Alberto Tarallo pongono subito
l’elemento erotico-passionale in primo piano, rendendo esplicito che «la presenza della mafia inclina verso il melodramma anche soggetti
la cui base di partenza è il dramma di attualità» . Il primo successo nato dalla collaborazione tra Tarallo e lo sceneggiatore Teodosio . x 8 . , Losito è II bello delle donne (2001-2003) , soap ambientata in un
salone di bellezza, riempita di attrici del presente e del passato (da Vima Lisi, attrice-feticcio del produttore, a Stefania Sandrelli, da
Anita Ekberg a Michèle Mercier, da Florence Guérin ad Antonella
Ponziani), che ruotano intorno a Gabriel Garko, protagonista che la vistosa avvenenza e i limiti di attore hanno reso oggetto di culto camp.
Come del resto tutte le produzioni della Ares (prima Janus), il cui «sdoganamento» cinefilo, già serpeggiante in molti articoli, può 9 essere considerato lo speciale dedicatogli dal settimanale «Film Tv» .
Nella prima stagione di L'onore e il rispetto (settembre-ottobre
2006), diretta da Salvatore Samperi, il mondo mafioso è poco più di una coloritura, su una trama di mèlo in costume che ricalca consapevolmente i modelli cinematografici dell’epoca in cui è ambientato. Nel 1956, una famiglia emigra dalla Sicilia a Torino; c’è il
fratello buono (che diventerà magistrato) e quello cattivo (che diventerà criminale), ci sono la bionda irraggiungibile e la mora
sofferente, anche se la linea narrativa più interessante è Manuela
Arcuri bisessuale incinta, galeotta, carcerata, mater dolorosa, innamorata, prostituta, maitresse, ricattatrice e morta nel giro delle prime puntate. Lo schema estetico fondamentale della serie, il
marchio di fabbrica di Tarallo, è triplice: la costruzione di un mondo parallelo con evidenti richiami al cinema e ai media del passato (in particolare al cinema italiano degli anni cinquanta, nelle trame, e a
quello degli anni sessanta e settanta nel richiamo a vecchie star);
l’innervamento, neanche tanto sotterraneo, di questo universo con un
omoerotismo diffuso e proteiforme (dall’erotizzazione di colpi maschili depilati e scolpiti all’identificazione sadomasochistica con
figure femminili sofferenti); l’accumulo vertiginoso e inverosimile di
colpi di scena. Man mano che le vicende di L'onore e il rispetto si spostano dagli
anni cinquanta agli anni sessanta e settanta, il mafia movie prende il posto del mèlo. E se già nella prima stagione abbiamo una serie di capimafia in funzione di deus ex machina (Giancarlo Giannini, Gigi
Burruano, Pino Caruso), è la seconda (2009) a deviare più decisamente verso il filone Piovra (con spostamento in America e
conseguente cast sempre più internazionale, da Ben Gazzara a Paul Sorvino, a Vincent Spano, cui si aggiungerà Burt Young): troviamo
Burruano pentito, Garko infiltrato, Alessandra Martines sostituto
procuratore, stupri e rapimenti a scopo intimidatorio e così ria. I due filoni, mèlo e criminale, si uniscono nel personaggio interpretato da
Angela Molina, donna di mafia e mater dolorosa con figlio tossicodipendente, che prima cerca di eliminare i nemici con una
cassata avvelenata, e poi vorrebbe suicidarsi, ma il codice mafioso glielo vieta: quindi fa in modo da farsi uccidere fingendo di voler
testimoniare. Nelle stagioni successive questa tendenza a una Piovra iper-mélo (nella quinta arriva anche Barbara De Rossi, proveniente dal cast del vecchio sceneggiato) prosegue e si accentua, con la
comparsa della prostituta Tripolina, interpretata da Giuliana De Sio, del «burattinaio» (Toni Bertorelli), di una madre di mafia (Lina Sastri) alle prese con un figlio omosessuale: come da copione, buoni e
cattivi si riaggregano di continuo scambiandosi le parti, con giravolte
della trama punteggiate da spettacolari scene d’azione (addirittura un elicottero che assalta Eric Roberts dentro un grattacielo). L’ultima
stagione (la quinta, marzo-maggio 2017), riprende il coté Conte di Montecristo, con un Garko barbuto e senza memoria che medita
vendetta, un ministro (Mattia Sbragia) a capo del crimine, e il trionfale ingresso nel cast di una rediviva Bo Derek. Con il loro gusto ormai spinto al massimo dell’eccesso e dello stereotipo, fin oltre le soglie del ridicolo e per un pubblico che tiene
insieme la casalinga di Retequattro e il cultore del camp, le fiction di Tarallo sono a metà tra una telenovela latinoamericana e i video
dell’artista Francesco Vezzoli, con le sue parate di star in versione
kitsch e neo-romantica. A saldare il tutto è anche l’erotismo strisciante, che le rende parenti alla lontana di un immaginario sexy
che nei decenni precedenti ha utilizzato l’iconografia sulla mafia: in particolare i film della serie di Concetta Licata, diretti da Mario
Salieri. Le serie di Tarallo sono insomma una sorta di passaggio ulteriore, di coerente estremizzazione, degli schemi e dell’immaginario feuilletonesco che guidano gran parte della
produzione cinematografica e televisiva sulla mafia. A loro modo, finiscono con il costituire un disvelamento, un’involontaria critica
immanente delle formule estetiche di rappresentazione di Cosa Nostra, un po’ come il filone di Concetta Licata era per il mafia movie
degli anni settanta e ottanta. Ma non è senza significato che questa torsione serenamente exploitation, priva di super-Io ideologici, possa essere possibile solo a metà degli anni duemila, quando l’emergenza
mafia pare in buona parte archiviata (simbolicamente, l’arresto di Provenzano precede di qualche mese la messa in onda della prima stagione). I caratteri si accentuano baroccamente nell’altra produzione Ares
di ambiente mafioso, Baciamo le mani (in onda dal 2 ottobre al 9
novembre 2013), anche per la presenza alla regia di Eros Puglielli, che
spesso si lascia andare ad angolazioni e movimenti di macchina
sontuosi, mentre la musica di Paolo Vivaldi ed Emanuele Bossi
echeggia Ennio Morricone. L’ambientazione è per lo più New York, e fin dall’inizio gli elementi da feuilleton sono onestamente esposti allo
spettatore (la Ferilli, scampata a un incidente ferroviario, assume
l’identità di un’altra donna, che doveva sposare uno sconosciuto a Little Italy). I due elementi fondamentali del mondo Ares sono
osservabili in maniera chiara: l’ambientazione al passato, con il
rimando a un immaginario (specialmente melo) cinematografico e
non solo, ben definito; la predominanza dei personaggi femminili (qui la Ferilli si fa pasionaria dei commercianti italo-americani), inevitabile dato il pubblico di riferimento. I due elementi sono in fondo diversi aspetti del cuore, ideologico e narrativo, di queste serie
come di quelle di Taodue: ossia che la mafia è un mondo di passioni,
di odio e amore, temibile ma affascinante; passioni esotiche, da situare nel passato o in luoghi che appartengono a un mondo rétro.
Ma, verrebbe da dire, la rescissione di ogni legame con l’attualità, la costruzione di un mondo autoreferenziale che sostanzialmente
aggiorna Vimagerie della Cavalleria rusticana di Mascagni sono in fondo ideologicamente ed esteticamente più oneste, meno perniciose
dell’operazione compiuta dalle produzioni di Vaisecchi, che si
propongono come riscritture, a volte addirittura «pedagogiche», della . 10 stona recente .
2. Cera una volta la mafia. La prospettiva di La mafia uccide solo d’estate, primo film di Pierfrancesco Diliberto detto Pif poi trasformato in serie televisiva, è
indicativa di una generazione e di un ceto di sicihani. Nato a Palermo
nel 1972, giornalista di Le iene e poi II testimone su Mtv, celebrità multimediale, a un certo punto Pif sente il bisogno di raccontare l’incontro con la lotta antimafia da parte di una generazione di giovani
borghesi cresciuta negli anni ottanta. Il film racconta di un bambino netta Palermo nel decennio
settanta-ottanta, il cui destino si incrocia in maniera tragicomica con
gh eventi di mafia. Concepito nell’istante della strage di viale Lazio (10
dicembre 1969), il piccolo Arturo fa la dichiarazione d’amore a una compagna di classe su un marciapiede che esplode poco dopo, perché
in quella casa abita il giudice Rocco Chinnici. Alle elementari, il suo piccolo momento di trionfo con la lettura pubbEca di un tema è interrotto dalla notizia dell’uccisione di Pio La Torre, e così via. Arturo
è un piccolo Forrest Gump, cresciuto in una famiglia piccolo-borghese
estranea alla mafia come all’antimafìa: il figlio finisce col portare al
paradosso la loro falsa coscienza, tramutandola in un universo pop. Andreotti e le sue battute diventano quindi la guida spirituale del
ragazzino, e il presidente del Consiglio un’icona (a Carnevale il
bambino si traveste proprio da Andreotti). A far aprire gli occhi al protagonista, ormai adulto e innamorato, sarà l’incontro con la
campagna elettorale di Salvo Lima (per il quale lavora l’amata Flora),
l’assassinio di quest’ultimo e le stragi mafiose del 1992. Decine di figure note della storia recente, da Dalla Chiesa ai vari boss, sono
trasfigurate in immagini da favola morale. Ma quando il protagonista
cresce, subentra un’educazione sentimentale e civile.
Più o meno volontariamente, il film si rivela di grande interesse per capire cosa è diventata la mafia per una generazione di siciliani e di
itaEani. Cosa Nostra è parte di un paesaggio pop dei media, tra Ivana
Spagna («mi fa sangue», dichiara a un certo punto Runa) e Bontà
loro: qualcosa di passato, con i suoi boss latitanti ma pur sempre
riconoscibili, le sue guerre intestine che la rendevano tragicamente visibile. È come una paradossale nostalgia per la fìlmabilità detta
mafia, per quando essa era qualcosa di raccontabile con schemi solidi e collaudati. La scena finale, con l’abbraccio dei due innamorati
montato insieme alle immagini dei funerali di Falcone, sancisce questo ricongiungimento: un romanzo di formazione sullo sfondo di
una «messa al passato» di Cosa Nostra, nell’Olimpo dell’immaginario televisivo, ormai fiaba, luogo lontano nel tempo11. In una scena che è un po’ teorica e un po’ lapsus, il protagonista si trova letteralmente
incastrato, con gli effetti digitali, dentro il video a bassa definizione dell’epoca: non nella storia, ma nella memoria mediale collettiva. A
potenziare questo effetto concorre, lungo tutto il film, la voce over di
Pif medesimo, con un esplicito tono fiabesco. L’idea di una «mafia
mediale» accomuna il film ad altri titoli coevi, che hanno espresso il concetto in maniera più o meno cosciente: più di tutti, ovviamente, Il
divo, anch’esso per tramite di Andreotti che (grazie a una lunga
tradizione televisiva da Noschese al Bagaghno) si conferma icona pop.
Ma c’è dell’altro. La mafia uccide solo d’estate è uno dei primi film a muoversi nell’orbita della piccola e media borghesia né mafiosa né
antimafiosa, tra impiegati e direttori di banca. Soprattutto, è forse
l’unico film a raccontare la «zona grigia» tra mafia e antimafia, quel
settore maggioritario della società isolana che parve prendere consapevolezza dopo l’uccisione di Falcone e Borsettino. La figura del
bambino indica una sorta di infantilismo (e di innocenza, dunque) della borghesia palermitana, e la parabola che mostra è quella di una
presa di coscienza. Andando contro lo spirito del tempo, Pif ricorda la necessità di costruire una memoria pedagogica dell’antimafia. Ma lo stile del film testimonia un processo inverso, e cioè la trasformazione della mafia in immagine mediatica, fiaba. Pif avverte questa
mutazione nella percezione collettiva della mafia, e candidamente la fa sua. La parte più originale è però la prima, da mafia movie postmoderno, che si muove ironicamente in un magma di immagini e
storie: Riina impara a usare il telecomando del condizionatore e il montaggio «stacca» sulla strage di Capaci, Arturo e Flora si baciano
per la prima volta davanti alla bara di Borsellino. Non è un caso che anche nella seconda parte i momenti più nuovi siano dedicati al mondo delle tv private, in cui il protagonista si trova a lavorare. Le stragi del 1992 diventano, paradossalmente, il preludio a un Heto fine,
una catarsi e una presa di coscienza. Le ambizioni politico-pedagogiche diventano espEcite nel successivo lungometraggio dell’attore-regista, In guerra per amore. Il
protagonista è quasi lo stesso del film precedente, e infatti ha lo stesso nome, Arturo Giammarresi. Immigrato negli Usa, innamorato di una
ragazza, si arruola nell’esercito americano per raggiungere in Sicilia i
genitori di lei e chiedere il permesso di sposarla. Indirettamente, il film racconta l’aiuto dato dalla mafia agli americani, secondo la vecchia linea di Michele Pantaleone in Mafia e politica. All’inizio del
film, il governo americano chiede aiuto a Lucky Luciano che fornisce
una Està di personaggi fidati, e il boss don Calò consegna il paese , . . r 12 „ „ . .. _ . . . (chiamato Cnsafullo) agli alleati, per cui 1 mafiosi vengono graziati e messi in posizioni di potere. Lo sfondo storico toma in primo piano alla fine, quando la voce
fuori campo ci ricorda che mafiosi come Giuseppe Genco Russo e
Calogero Vizzini divennero sindaci dei loro paesi, mostra Vito Ciancimino collaboratore di Charles Poletti o un giovane Michele
Sindona. I titoli di coda citano degli estratti del Rapporto Scotten che descrivono la situazione americana. Proprio su questo versante si
sono appuntate te critiche degli storici, in particolare del maggiore studioso dello sbarco in Sicilia, Rosario MangiameE (era stato tra
l’altro lui a pubbEcare per primo il Rapporto):
È roba vecchia, già smentita dagli esiti della commissione statunitense
Kefauver nel 1953, che escludeva qualsiasi aiuto offerto da Lucky Luciano (allora in carcere) all’operazione Husky, anche se affermava che Luciano aveva aiutato il controspionaggio americano a sconfiggere i sabotatori tedeschi attivi
nel porto di New York. Per questo sarebbe stato graziato e liberato alla fine della guerra. Le ricerche più recenti hanno dimostrato che la motivazione patriottica così addotta, altro non era che lo schermo offerto all’opinione
pubblica per mascherare un volgare scambio elettorale. Sulla stessa scia molti mafiosi italo americani offrirono servigi 0 millantarono meriti, non risulta che questo abbia avuto una incidenza sulle decisioni militari e politiche13.
Ma che ruolo gioca questa interpretazione dei fatti storici all’interno del film? In che modo è utilizzata questa vecchia e screditata interpretazione storica? Il film punta sul candido rivelare
verità che si riverberano sull’oggi. Alla fine il boss, nominato sindaco,
si lancia in un appassionato proclama: Quando avevate bisogno di protezione da chi siete andati, da loro 0 da noi? Quando avevate bisogno di un lavoro da chi siete andati, da loro 0 da noi? Quando avevate bisogno di giustizia da chi siete andati? Da noi, siete venuti da
noi! Noi, che siamo sopravvissuti a tutto: alle guerre, ai governi, ai fascisti, ai nazisti e sopravviveremo anche ai comunisti, perché la verità è che in questo paese noi siamo la democrazia! Il tono da fiaba dunque è costruito proprio per strizzare l’occhio al
presente e segnare, in un luogo e un tempo, una sorta di peccato originale: se Arturo Giammarresi fosse riuscito a consegnare il
rapporto a Roosevelt, la storia sarebbe cambiata. I riferimenti narrativi e figurativi del film (il Benigni di La vita è bella, il Tornatore
di Baarìa) segnalano un innalzarsi delle ambizioni, verso una vera e
propria filosofia della storia: ed è proprio come filosofia della storia,
più che nelle singole licenze storiche, che il film mostra un approccio semplicistico, mentre il versante di denuncia confligge con l’effetto
comico. Una democrazia sequestrata, l’innocenza del cittadino
comune, i misteri d’Italia che impediscono la comprensione della realtà e dunque la vittoria dei buoni: come La trattativa di Sabina Guzzanti, In guerra per amore è eloquente più in quanto
autoassoluzione della cultura e dello spettacolo di sinistra che come
resoconto sulla mafia. Diverso, anche per la collocazione nel sistema dei media, il discorso
da fare per la serie televisiva tratta dal film precedente di Pif. All’interno dello schema tradizionale delle serie family, e
accentuando, come vogliono le regole della fiction televisiva, i tratti vantage (sin dalle prime scene, con superò, immagini di repertorio e la
canzone Figli delle stelle di Alan Sorrenti in sottofondo), La mafia uccide solo d’estate - la serie elimina la parte con Arturo (che qui si chiama Salvatore) adulto. La famiglia diventa il luogo centrale, e i
caratteri sono funzionali a un intrattenimento pedagogico: il padre (Claudio Gioè) è un impiegato dell’anagrafe, la madre (Anna
Foglietta) un’insegnante precaria in attesa del posto, lo zio (Francesco Scianna) un forestale fannullone simpaticissimo ma dai giri sempre
più loschi, la sorella una femminista che legge Porci con le ali.
Viene mostrata in dettaglio al pubblico televisivo una famiglia della piccola borghesia simile a quella del film, e i momenti in cui essa
sfiora pericolosamente Cosa Nostra: Buscetta (come capita allo zio), un prestanome di Badalamenti che è il padre di un compagno di
scuola della sorella, il direttore del «Banco di Trinacria» padre della ragazzina amata da Arturo, o uno psichiatra che risita Salvatore e fa
usualmente finte perizie per i mafiosi. Sullo sfondo Lima, Ciancimino
e i Salvo (ormai presenze abituali della fiction televisiva nel ruolo di villain rappresentanti della politica), e poi Riina. Nella seconda
stagione si parlerà dei tentativi di riforma della regione da parte di
Piersanti Mattarella, delle raffinerie di eroina con i chimici francesi, della seconda guerra di mafia e del narcotraffico con gli Usa in alcuni dischi pop (episodio ispirato alle vicende della cantante Esmeralda Ferrara). Tra i fatti storici e la famiglia Giammarresi ci sono una serie
di passaggi diretti: la casa nuova diventa improvvisamente disponibile con mutui vantaggiosi quando il padre fa un piccolo favore a dei
galoppini della De, a sua volta legata saldamente a Cosa Nostra. Se lo stile rimane sostanzialmente modellato sul vintage che
garantisce un canale comunicativo a metà tra grande pubblico e fascia
di pubblico alta, in questo schema la serie riesce a far passare un
discorso a tratti non scontato, che si riverbera anche su alcuni episodi citati di sfuggita (l’arrivo delle tv private di Berlusconi, la descrizione dell’omicidio del giornalista Mario Francese, la descrizione della
Regione Sicilia come luogo di clientelismi e di imboscati). Lo schema
è il romanzo di formazione, in cui il passaggio dalle scuole elementari alle medie coincide con l’avvento degli anni ottanta. Alla fine della prima serie, quando il padre finalmente decide di testimoniare di aver
visto l’assassino del commissario Boris Giuliano, a Salvatore tornano
in mente tutte le cose brutte accadute in quei mesi (omicidi, sventramenti di parchi), «e finalmente ho capito cos’era la mafia, chi
erano i mafiosi, e quello che giorno dopo giorno ci stavano portando via». Il quaderno del bambino si riempie di domande senza risposte, e
la sua vita sentimentale di occasioni mancate. Ma a fianco a questo versante «educativo», quel che passa attraverso le immagini è abbastanza imprevisto, e in fondo contraddittorio. Il vintage ormai dispiegato, con la patina dolceamara posta sul passato, coopera con
una Enea farsesca evidente dall’inizio alla fine, a dare l’impressione di una Cosa Nostra famihare, buffa, in fondo innocua, proprio perché riemerge come reperto di media, e le tragedie evocate con le immagini
di repertorio vengono esorcizzate in un gioco tutto interno al sistema
dello spettacolo: il family assorbe e sublima le immagini dei tg. Questa rappresentazione farsesca del mafia morie (tutti compresi:
magistrati, mafiosi, «zona grigia») finisce con l’illuminare
involontariamente la produzione televisiva contemporanea. In fondo, la rappresentazione sopra le righe, colorata di Pif non è diversa da queUa degli sceneggiati di Taodue. Il suo tono rivendicato da teatro
dei pupi non è che il passo definitivo (ma ironico) verso la trasformazione della storia di Cosa Nostra in qualcosa di
appartenente al passato, anzi al passato dei media.
1 Sul contesto della televisione attuale, con particolare riferimento alle due case di produzione, si veda L. Barra - M. Scaglioni, Saints, Cops and Camorristi. Editorial Policies
and Production Models ofItalian Tv Fiction, in «Series», r, primax-era 2015, pp. 65-76. Oltre
alle produzioni Rai, dai tratti più inclusivi, gli autori identificano due poli deD’entertamment una spettacolarità pura sul modello americano (Canale 5 e le produzioni come Squadra
antimafia) e un modello più complesso nelle televisioni per abbonamento come Sky e poi le
piattaforme streaming (inaugurato da Romanzo criminale). 2
U. Eco, H superuomo di massa. Retorica e ideologia del romanzo popolare, Bompiani,
Milano 1976, pp. 76 e passim. 3
Su questo tema si x^eda l’ampia ricognizione di M. Buonanno, Donne al comandofra
action e melodramma. Il caso di Squadra antimafia, in II prisma dei generi. Immagini di
donne in tv, a cura di Id., Franco Angeli, Milano 2014, PP- 49-774
Eco, Il superuomo di massa dt, p. 80.
5
Fà eccezione, sul versante outré, il killer down Nerone (Luca Lionello), appassionato di
canarini. Curiosa invece, a volte, la toponomastica, con nomi della mitologia classica (Oreste 0 Achille) e altri che sembrano strizzatine d’occhio: un piccolo spacciatore si chiama Lorenzo
Miele (quasi omonimo di Lorenzo Mieli, produttore di Wildside, casa rivale più highbrow),
un mafioso si chiama Sfuriale (come il presidente di Rai Cinema), mentre in Rosy Abate la famiglia adottiva del figlio di Rosi si chiama Mainetti, come il regista Gabriele, rivelazione del dnema italiano l’anno precedente con Lo chiamavano Jeeg Robot. 6
Gh ascolti di Squadra antimafia, che rimangono sostanzialmente costanti per le prime
quattro stagioni (quasi sempre sopra i cinque milioni e mezzo di spettatori), a partire dalla
quinta conoscono una lieve flessione che si accentua sempre più, fino a scendere sotto i 3
milioni in molti casi nell’ultima stagione. L’anno dopo, Rosy Abate - La serie fa registrare un balzo negli ascolti, che si assestano di solito intorno ai quattro milioni e mezzo, con 5,3
milioni per la puntata condusix'a (fonte: Anditel). ' F. Lucherini, Un genere strategico a rischio di marginaHzzazione, in Di necessità virtù.
25° rapporto annuale sulla fiction televisiva italiana, a cura di Osservatorio Fiction Italiana, Roma 2014, P- 26. § Si xeda l’interxista a Losito di S. Fumarola, Lasito: «Fiction trash? Sto dalla parte del
pubblico», in «la Repubblica», 29 settembre 2010. «Film Txt», 25,27 dicembre 2017,52. Curato da Rocco Moccagatta, il dossier contiene un’intervista a Tarallo e le schede di dieci serie commentate da lui stesso. IO
Che il modello vincente, tra i due, sia quello delle fiction di Vaisecchi, è confermato dai
diversi esiti: la Taodue prosegue felicemente le produzioni commemorative (cfr. cap. xi),
mentre il pubblico delle produzioni Arcs si è mostrato sempre più residuale e, come spesso accade, insieme alle prime avvisaglie di recupero cinefilo si è vista la crisi della sua effettiva collocazione popolare, con ascolti sempre in calo e la fine del contratto con Mediaset
In definitiva l’uso dei materiali di repertorio nel film mi pare l’esatto contrario di ciò che
vi vede M. Marcus (From Comedy to Commemoration: Pierfrancesco Diliberto's La mafia uccide solo d’estate, in Renga, a cura di, Mafia Movie. A Reader dt, pp. 302-4), che lo intende come un’inserzione di verità e come un coinvolgimento critico dello spettatore. 12
Il nome si riferisce al politico Vladimiro Crisafulli, esponente del Pd siciliano al centro di
inchieste per scambio di voti e «bestia nera» di Pif in molti suoi interventi pubblici, anche alla Leopolda (cfr. https://^s^s-.youtube.com/watch71v=bS25.A.imFENA ** ** ** Il *** ). 13
R. Mangiameli, Se Pf banalizza lo sbarco in Sicilia, in «La Sicilia», 8 novembre 2016.
La polemica è continuata con una videolettera dell’attore e regista, cui è seguita una replica
dello storico (https://\vvvvv\youtube.com/watchTx -tVbgesZsCCQ). Mangiameli è tornato sul film di Pif e sui nodi storiografici ex-ocati nel saggio «In guerra con la storia». La mafia al
cinema e altri racconti, in «Meridiana», 2016,87, PP- 231-43-
xv. La mafia come metafora
All’epoca, negli anni di Brancaccio, anch’io leggevo
la Bibbia, e la leggevo da credente. Mi appassionava la vita di Gesù: però non ho mai capito perché ha
voluto morire lui per noi. Salvatore Grigoli, assassino di padre Pino Puglisi
1
i. Fascia preserale. Il giorno della strage di Capaci, il 23 maggio 1992, è un sabato
pomeriggio. Il lunedì dopo, gli spettatori della fascia preserale di Rai 3 sono fissati da un signore magrissimo, a torso nudo, inquadrato in primo piano. Dopo minuti di immobilità, l’uomo sputa in aria e lo sputo, come è ovvio, gli ricade sulla testa. Infine una voce chiede: «Che cosa prova, signor Giordano?». «Un forte disgusto». «E per
chi?». «Per me stesso».
Tra il 6 aprile e il 26 giugno 1992, poco prima delle 20, su RaiTre
arrivano da Palermo altre immagini come queste, mai viste né immaginabili fino allora sulla televisione nazionale. Inquadrature
spesso fisse, in bianco e nero, di un’umanità desolata, sullo sfondo di
interni fatiscenti o skyline della periferia est di Palermo. Personaggi
che parlano in dialetto palermitano, strisce di pochi minuti, un umorismo nerissimo. Sono le 49 puntate di Blob Cinico Tu, che
sostituiscono in quella fascia oraria II Portalettere di Piero Chiambretti, uno dei programmi-simbolo della fine della cosiddetta
«prima Repubblica». Ma le immagini di Cinico vengono da un altro universo. Una voce fuori campo incalza poveri cristi preda di terribili tic nervosi, o sgomenti davanti alla pervicacia delle domande. Gli autori di queste strisce, Daniele Cipri (30 anni) e Franco Maresco (34)
spediscono man mano le cassette con i materiali dall’antro in cui
montano, m un laboratorio presso l’emittente palermitana Tvm . I due, nati e cresciuti a Palermo, si conoscono alla fine degli anni ottanta e cominciano a fare piccoli esperimenti in video. Intorno, una
corte di attori non professionisti diventa quasi la loro famiglia: Marcello Miranda l’Ecce Homo, il ciclista Francesco Tirone, il soave petomane Giuseppe Paviglianiti, il cantante fallito Giovanni Lo
Giudice. La voce fuori campo che a volte li intervista è di Maresco;
all’inizio, lo scopo è anche di estremizzare parodisticamente la «tv del
dolore» (Maurizio Costanzo, Giovanni Minoli) che comincia a dilagare. Ma ben presto apparirà chiaro agli spettatori più attenti
come la tragicomica desolazione messa in scena in Cinico Tv non sia parodistica o satirica, bensì proponga un’idea del mondo e del cinema che, per qualche tempo, entra in cortocircuito con il mezzo televisivo. Il mondo di Cipri e Maresco appare da subito definito nei suoi
tratti essenziali: lunghe inquadrature fisse in bianco e nero con un filtro dégradé che crea una minacciosa striscia scura al bordo
superiore dell’inquadratura; un paesaggio orizzontale, con immagini della città sullo sfondo che mostrano degrado e insieme la sublime
potenza di cieli e nuvole; oppure muri erosi, di tufo, tipici dei firriati 3 di campagna inglobati nel centro abitato . I lavori di Cinico Tv vengono scoperti nel 1989 dai giornalisti Didi Gnocchi e Mimmo Lombezzi, che li mandano in onda all’interno del
programma Isole comprese (Italia 1), dedicato alle emittenti locali. La collaborazione con Italia 1 finisce presto, anche a causa di uno sketch
che, con candida provocazione, i due inviano alla redazione: un lungo,
sognante, profetico monologo del ciclista Tirone dedicato a Berlusconi (proprietario dell’emittente che ospitava la trasmissione), nel quale si immagina che l’imprenditore compri la Sicilia, fondi un partito politico e infine si trovi letteralmente in cielo, in terra e in ogni luogo.
Lombezzi passa allora il contatto a Enrico Ghezzi, e Cinico Tv
comincia a far parte della programmazione della Rai 3 di Angelo Guglielmi, all’interno di programmi come Avanzi, Cielito Lindo e
Pubblimania. La consacrazione avviene proprio nella primavera del 1992, con le 49 puntate trasmesse prima di Blob.
Parallelamente, i due registi realizzano ima serie di cortometraggi (provvisti di titolo, a differenza delle strisce di Cinico Tv) che
presentano in vari festival (vincendo ad esempio quello di Bellaria nel
1990 con Illuminati). E il versante sperimentale della loro opera,
anche se distinguerlo da quello più «comico» è praticamente impossibile: stessi personaggi, stessi luoghi, stessi ritmi, stessa
visione del mondo, stesso umorismo, stesso bianco e nero. In molti cortometraggi, come nelle «strisce» di Cinico, la scelta di ridurre la
rappresentazione a pochissimi elementi corrisponde a una riduzione
dell’umanità ai suoi elementi di base. Davanti a un orizzonte deserto o a distese di macerie, pochi personaggi si aggirano come dopo la fine
del mondo, e i cortometraggi hanno titoli come La Madonna
dell’Oreto, La provvidenza, Venerdì Santo-Sabato Santo-Domenica
di Pasqua. I lavori dei due autori affrontano allegramente i massimi sistemi, sostenuti da riferimenti all’iconografia cattolica e da un uso quasi fumettistico della storia del cinema, che si incarna in titoli
eloquenti: La tombola di Ligeia, L’invasione degli ultrastorpi...
2. Ieri a Palermo.
Cipri e Maresco hanno girato a Palermo la quasi totalità delle loro
opere, e hanno lavorato in maniera molteplice e concreta sul territorio. All’opposto dei vecchi moduli operativi del cinema italiano
girato in Sicilia (scrittura di un copione, rapidi sopralluoghi sul set, contatti con operatori del luogo, riprese in loco, ritorno a Roma per la
post-produzione), l’opera dei due registi si è articolata a partire da
luoghi a loro familiari, in relazione con attori non professionisti che hanno finito col costituire, anch’essi, una specie di comunità, pronta a
girare brevi filmati in maniera veloce e anche improvvisata, come in veri e propri momenti di performance urbana. La Palermo di Cinico Tv e dei film successivi è una mappa di
quartieri ben precisi, con un certo tipo di storia alle spalle. Si tratta della periferia est, con i dintorni del fiume Oreto, il quartiere
Brancaccio, il lungomare che da Palermo conduce ai primi comuni dell’hinterland, Villabate e Ficarazzi, attraverso le borgate di Romagnolo, Bandita, Acqua dei Corsari, lungo la statale 113 per
Messina. Zone che avevano conosciuto un certo sviluppo industriale (specie nel settore agro-alimentare o dell’edilizia) ed erano state anzi
indirizzate proprio a polo produttivo della città. Di questo sviluppo
mancato Cipri e Maresco contemplano letteralmente le macerie. La Palermo mostrata al cinema, invece, era fino a quel momento
concentrata su due direttrici: da un lato, i luoghi canonici del centro storico (piazza Marina, il Cassato, la Vucciria) o la cripta dei Cappuccini; dall’altro, i nuovi quartieri residenziali per la media e alta borghesia nella zona sud-ovest, costruiti durante il cosiddetto sacco di
Palermo degli anni cinquanta e sessanta, da riale Lazio a ria Belgio,
verso Mondello e l’aeroporto. Tipica era, nei film «di denuncia», la veduta dall’alto di questa città, dall’elicottero o dai terrazzi delle case. La città di Cipri e Maresco è lontana da luoghi comuni, priva di elementi troppo riconoscibili, e mostra una sostanziale indistinzione
tra città e campagna: questultima è stata inglobata nella prima a causa di uno sviluppo disordinato, oltre che di processi di vera e propria ruderizzazione4. I due registi, però, hanno anche agito in quei luoghi come operatori
culturali, con una ostinazione che sembra smentire l’apocalittico
pessimismo delle loro immagini. Maresco proviene dall’esperienza del cineclub Nuovo Brancaccio, in un quartiere ad altissima concentrazione mafiosa (e nel pieno della «seconda guerra di mafia»),
e i due, insieme a Paolo Greco e altri soci, fondano nel 1999 il cinema
Lubitsch in un quartiere-dormitorio, Bonagia, letteralmente fuori
dalle mappe urbane, nella zona sud-est della città. Il loro lavoro artistico coincide in gran parte con la nascita, il dispiegarsi e la fine della cosiddetta primavera di Palermo, di cui costituisce un 5 controcanto . Tuttavia, la città di Cipri e Maresco, se non coincide con i luoghi
canonici del cinema ambientato a Palermo, non si identifica
nemmeno con i luoghi-simbolo della Palermo rilanciata da Orlando: i Cantieri culturali, lo Spasimo (chiesa tardo-gotica di cui si era
addirittura dimenticata l’esistenza, e che viene restaurata e aperta al
pubblico), il Teatro Massimo (riaperto dopo 25 anni di chiusura
causati da lavori di manutenzione ordinaria). La Palermo di Cinico Tv ha una fisionomia propria, astratta, che punta essenzialmente su
alcuni elementi di privazione: non ci sono automobili, le presenze
umane sono ridotte al minimo; non ci sono donne, ma nemmeno passanti o persone ai balconi delle case. Non bisogna cedere alla
tentazione di vedere, nella Palermo raffigurata da Cipri e Maresco,
preoccupazioni di denuncia immediata o, peggio, di satira. Concetti
come «degrado» o «emarginazione» sono poco significativi nella loro antropologia. È, semmai, la loro, una paradossale apologia, intrisa di
umor nero e di umanesimo cristiano: i mostri (vale a dire, i poveri e
coloro che recano traccia della congenita imperfezione dell’umano) sono l’ultima umanità possibile in mezzo a corpi mutanti, così come le
rovine sono il segno dell’agonia, ma anche della vita residua, di un
luogo. La riscoperta di Palermo nel cinema degli anni novanta si inserisce in un generale cambiamento di sguardo nei confronti dell’Italia, tipico
del cinema a cavallo tra Mani pulite e le elezioni del 1994. A un tipo di
produzione minimalista e di interni si sostituisce ora una nuova generazione di autori, che fanno del lavoro sul paesaggio il loro punto
di forza. È soprattutto il Sud a dare questa impressione, nei film di
Gianni Amelio (IZ ladro di bambini), Mario Martone (L’amore molesto), Pasquale Pozzessere (Verso Sud), Antonio Capuano (Vito e gli altri) e altri, ma il fenomeno comprende più o meno tutta l’Italia, a cominciare dalla Milano del precursore Silvio Soldini (L’aria serena dell’Ovest). La fase successiva segnerà, per molti autori, un ritrarsi
verso una maggiore astrazione o un deciso rifiuto della flagranza dei
luoghi: la Napoli in interni di Teatro di guerra di Martone, il Sud per 6 metafora e in assenza nei film di Amelio (Lamerica; Così ridevano) , le no man’s land di Pappi Corsicato (Chimera). Cipri e Maresco fanno
anche loro parte di questo percorso: la Palermo esplorata ed esaltata nelle inquadrature di Cinico Tv e del lungometraggio d’esordio Lo zio
di Brooklyn cede il posto a una ricostruzione per frammenti, più
fantastica, e che si apre anche ad altri luoghi dell’interno: Se nello Zio di Brooklyn prevale la periferia di quartieri derelitti come Zen 0
Brancaccio, in Totò che visse due volte si guarda più al centro storico e
soprattutto alla campagna. Il paesaggio dello Zio di Brooklyn richiama maggiormente quegli elementi che Cervellati riscontra nelle campagne, colline
e pianure diventate ormai periferie del Bel Paese, «lordate di cave, di discariche, di porcilaie, di stalle [...], di un reticolo impressionante di inutili strade, stradine e stradone, asfaltate, bitumate, cementate»7.
La loro visione può essere illustrata attraverso la prospettiva archeologica e allegorica di Walter Benjamin, con la consapevolezza
che a essere contemplate sono anche le rovine della modernità stessa; il cinema stesso è maceria, sopravvivenza in un mondo di immagini
altre. Non è più nemmeno la flagranza del set a essere veicolo della poesia delle macerie, ma la sua stessa sostanza, le immagini in pellicola. Come ha scritto Gilles Deleuze riguardo al cinema di Jean-
Marie Straub e Danièle Huillet, «l’immagine visiva diventa archeologica, stratigrafica, tettonica. Non che si rinvii alla preistoria
(esiste un’archeologia del presente), ma agli strati deserti del nostro v • . . .£ .8 tempo che ricoprono 1 nostri stessi fantasmi» . In una tappa successiva, Il ritorno di Cagliostro, girato per lo più
in interni, Palermo sarà quasi solo allusa. Così Maresco spiega questo passaggio:
Lo spirito che avevamo quando abbiamo girato questo film era di grande
delusione nei confronti di Palermo. In questo film claustrofobico ti rimanda a Palermo solo il dialetto. Ma è una scelta consapevole: Palermo è una città molto cambiata, dove è difficile muoversi, girare, una città che non ha più
fascino proprio dal punto di vista fisico. E poi è una città che non ti dà più
stimoli, l’umanità che a noi interessa è sempre più in via di estinzione, assimilata, contaminata. (...) La cultura è anestetizzata, innocua, si parla di
mafia astrattamente, senza disturbare nessuno. [...] Intanto Palermo non ha più neanche le rovine. Esteticamente è un orrore. Una volta c’erano da un lato quartieri e rovine, e una Palermo borghese schifosa dall’altra parte. Ora è una Milano 3 in cui dilaga una mentalità manageriale, nel senso di arraffare i soldi della Comunità Europea .
3. Più liberi con la mafia. Partendo da un’immersione profonda nelle viscere della città, da
una coscienza della storia del cinema e da un sentimento tragicomico della vita, Cosa Nostra entra nel mondo di Cinico Tv in maniera
singolare. Inizialmente, appare pochissimo, come se l’inflazione di
immagini cinematografiche e televisive (siamo all’epoca del maxiprocesso) causasse nei due registi un fastidio ad affrontarla direttamente. Eppure, come ricorda Antonio Ingroia: Nella Palermo di Cosa Nostra padrona del territorio, dell’attentato
all’Addaura e delle stragi del ’92 la grande maggioranza dei palermitani conviveva benissimo con la mafia. (...) Paradossalmente, negli anni in cui questa realtà mafiosa pesante non trova rappresentazione, Cinico Tv diventò l’unico modo di rappresentarla, con il tono del grottesco, dell’iperrealismo; ma fu il modo di far conoscere all’altra Italia questa Palermo a cielo basso controllata da Cosa Nostra10. In un secondo momento, progressivamente, Cipri e Maresco danno corpo a una delle rappresentazioni più preziose dell’universo mafioso.
Uno sguardo che unisce quasi spontaneamente analisi politica e
antropologica, e che ha il vantaggio (forse più compiutamente apprezzabile oggi) di un’assoluta politically uncorrectness e insieme
di una totale assenza di ambiguità. Insomma, da una prospettiva interna, quasi viscerale, viene fuori, allegramente e senza sforzo, la condanna meno moralistica e più inappellabile dell’universo di Cosa
Nostra. Cipri e Maresco sono, nella storia del cinema italiano, i registi che
meglio conoscono la cultura mafiosa: nati e cresciuti a Palermo,
curiosi di un mondo popolare e in costante polemica con la città «bianca», il loro lavoro fa risaltare per contrasto i limiti di quasi tutto il mafia morie italiano. Senza pretese di esaustività, visto che si parla
di un universo dai confini inafferrabili, fatto da materiali che si aggregano a volte in contenitori diversi, si possono ricordare le
principali emersioni di Cosa Nostra nel paesaggio di Cinico Tv:
- alcuni monologhi del ciclista Tirone, che descrive viaggi e picnic turistici organizzati dalla mafia, o si lancia in un surreale elogio di Ciancimino («è persona seria e onesta») parlando in maniera incomprensibile dell’«umorismo della mafia»11;
- due spot paradossali che mostrano l’avanzare euforico dei
personaggi su uno stradone di periferia lastricato di rifiuti, finché non
appaiono rispettivamente le scritte La mafia. Con i siciliani da . . 12 sempre... e Più liberi con la mafia ;
- un tableau vivant in interni, con personaggi, desolati mentre in sottofondo passa la musica del Padrino, e la voce di Maresco propone: «Adotta anche tu un siciliano»;
- Mafiatour: immagini fisse ispirate agli Intervalli Rai, con luoghi tristemente noti alle cronache nella storia della città;
- L’alba del killer: tre personaggi imparano l’uso della pistola come le scimmie di 2001. Odissea nello spazio imparavano a uccidere;
- La famiglia Ciancimino: alcuni personaggi si immaginano parenti dell’omonimo politico colluso con la mafia, e forniscono tra
l’altro una definizione della mafia come «situazione di chiarimenti di opere di bene»;
- la serie di episodi di Mafiaman, «il supereroe di Cosa Nostra»,
ossia il solito Tirone che aiuta criminali imbranati in difficoltà a compiere le loro malefatte, e alla fine esclama: «Ha! Ha! Siamo
davvero pietosi!»; - il montaggio Don Blob, andato in onda all’interno della
trasmissione Blob, che presentava scene di morti ammazzati sulle note di Smoke Gets in Your Eyes nella versione dei Platters.
All’epoca delle stragi del 1992, pressati dagli eventi, Cipri e
Maresco reagiscono quasi «in diretta», creando all’impronta siparietti surreali che inviano per posta a Roma, con Pietro Giordano che
interpreta una bomba inesplosa. Keller si svolge nei luoghi dell’ex fabbrica omonima, ma uno dei personaggi, in piedi, forma una «I»
umana tramutando la scritta sul muro nella parola «Killer». 23 maggio 1999 mostra la città squassata da esplosioni, delle quali viene sospettato il povero petomane Paviglianiti. Nella seconda fase di Cinico Tv, quella che segue Lo zio di
Brooklyn e Totò che visse due volte, con l’arrivo di nuovi personaggi,
arriveranno altri sketch: i fratelli Abbate chiedono a Pietro Giordano di diventare killer, e poi si professano ammiratori di Riina; Tirone
delira in forma di preghiera (un «Ora pro nobis » con nomi di mafiosi,
ma anche di politici e di pentiti) o con sproloqui sul sindaco Orlando, la mafia e la polizia, in cui i soggetti si confondono in un unico flusso di coscienza.
4- Ormai solo un Zio ci può salvare. La chiave scelta da Cipri e Maresco non è il realismo, ma la metafora, la visione surreale, il paradosso, la mascherata. Tra afasia e giochi di parole, orizzonti sconfinati e macerie, iconografìa cattolica e
rumori intestinali, il loro mondo è una specie di incrocio tra il carnevalesco teorizzato da Michail Bachtin (ma nella sua variante
funerea, tipica dell’età contemporanea) e il legame tra violenza e sacro su cui ha riflettuto René Girard. Lo studioso russo ricordava,
prendendo a esempio alcuni racconti di Poe, come gli elementi del
carnevalesco rinascimentale (il riso, il cibo, il sesso) perdessero nella
letteratura successiva ogni valenza liberatoria e positiva: «la chiave
aurea di questo complesso è perduta: la sana totalità
onnicomprensiva della vita trionfante è assente e rimangono i 13 contrasti nudi e disperati e quindi atroci» . Dall’altro lato, i primi lungometraggi dei registi, Lo zio di Brooklyn e Totò che visse due
volte, sembrano un amaro corollario alle teorie di René Girard, sulle
origini del sacro nell’assassinio rituale, in cui il ruolo della vittima viene ribaltato positivamente con l’avvento del cristianesimo, che 14 rende esplicita l’innocenza del capro espiatorio . I loro film sembrano aggiungere un capitolo tragico alla storia del capro espiatorio, mostrando la vanità della sua testimonianza nel mondo
contemporaneo.
Tra le macerie che contempliamo sono rimasti gli impulsi primari, e tra questi una violenza che regola barlumi di rapporti umani. Le
rovine che il film contempla sono quelle di un’umanità che ha scelto
un destino di morte. In questo senso, quel che vediamo è un nostro
passato (in volti sottoproletari arcaici) ma anche il nostro futuro.
L’ambiguità del cinema di Cipri e Maresco è proprio questa: nel fatto che loro amano le rovine e non possono impedirsi di amare gli
sconfitti, e dunque anche i piccoli mafiosi, perché sono il contrario del
potere. Ma uno dei pregi del loro sguardo su Cosa Nostra è che, pur partendo dall’interno (e dunque senza alcun sospetto di folclorismo), esso è esente da ogni fascino del male, da ogni ipotesi di onnipotenza
di Cosa Nostra. La Cosa Nostra di Cipri e Maresco può essere sì legata
alla politica (così è, farsescamente, nel Ritorno di Cagliostro, così sarà in Belluscone), ma perché politica e mafia sono ugualmente miserabili. Il loro cinema non si fa beffe semplicemente della mafia,
ma di una pulsione all’accumulo (di cibo, sesso, dominio) che è anche la nostra (senza, si potrebbe aggiungere, il nudo candore di quei personaggi), e di cui la mafia è esempio, luogo perfetto di
osservazione. È sbagliato vedere i personaggi di Cinico Tv come
qualcosa di lontano da noi, che viene denunciato, o addirittura schernito o sfruttato. Rocco Cane non è lontano dai fruitori della pornografìa di massa che siamo, il maschilismo dei fratelli Abbate è la
radice estrema di quello corrente, il «santo folle» ciclista nei suoi
deliqui giunge a verità ilari e sconcertanti. I «mostri» di Cinico Tv e dei lavori successivi somigliano ai loro spettatori, o rivelano, in
maniera spiazzante, aspetti del loro mondo. E così, anche il lato
ridicolo della mafia la rende non solo più vulnerabile, meno mitizzabile, ma anche meno lontana e dunque consolatoria, radicata
in qualcosa di umano: i mafiosi, per vie traverse e quasi metastoriche,
ci somigliano. Nella creazione di questo universo risulta decisivo il rapporto tra
mafia e religione; non come collegamento esterno, legame storico (fino al Ritorno di Cagliostro nel loro cinema quasi non ci sono preti),
ma come rapporto dialettico tra due aspetti di una cultura tragica. La religione, paradossalmente, appare come aspetto del materialismo di fondo, che tra gli altri Leonardo Sciascia, in un testo noto e discusso, attribuiva alla religiosità popolare siciliana15. Il rapporto col sacro
primario nei personaggi è paragonabile a quelli con il cibo, il sesso, la morte.
Eppure il cinema di Cipri e Maresco si nutre nello stesso tempo di
una tensione quasi violenta verso il sacro. Le Madonne, le processioni, le bestemmie, gli angeli e le apparizioni di Cinico Tv e poi dei
lungometraggi sono inscindibili, in maniera contraddittoria, da una
logica di violenza e sopraffazione, di maschilismo, di morte, che è . 16 . , . quella da cui nasce Cosa Nostra . La visione tragica che nutre il
pessimismo degli autori a tratti ne è il corrispettivo visivo e ideologico, a tratti invece segna una disperata, irriducibile estraneità, destinata alla sconfitta. C’è infatti in loro anche una sconfinata carità
per le vittime, per i «poveri Cristi», che germoglia da una visione
apocalittica del presente. Accanto al riferimento figurativo e devozionale a un cattolicesimo di stampo mafioso, troviamo una
tensione trascendente e uno spirito cristiano che si manifestano soprattutto attraverso l’assenza, la bestemmia, la nostalgia. Non è forse azzardato, allora, vedere il lavoro dei due palermitani come una delle opzioni estetiche di raffigurazione della trascendenza nel 17
cinema, secondo la classica formulazione di Paul Schrader . E
proprio il cortocircuito tra visione del mondo tragica e religiosa, e uso della simbologia e dell’iconografia cattoliche, è uno dei fili che si
possono seguire nei loro lavori, per dipanare la visione della cultura mafiosa che da essi emerge.
Lo zio di Brooklyn è concepito secondo l’andamento di una
processione, ma una processione che gira su se stessa mentre il
mondo sta finendo. Tutto il film è punteggiato da elementi di estetica e liturgia popolare, travestita carnevalescamente: un santo con un
occhio solo; un funerale che va avanti e indietro creando scompiglio;
una festa di ringraziamento per lo scampato omicidio del fratello di un boss; una veglia funebre. Su questo tappeto di riti officiati da un’umanità stremata, composta ovviamente solo da maschi, il filo
narrativo segue l’arrivo di un vecchio ieratico dalla barba bianca, che non parla mai: un’evidente figura divina per quanto degradata,
affidata a una famiglia di disperati da due nani mafiosi. In realtà, a parte due piccoli prodigi (ammansire uno scemo e far addormentare un custode per poter scappare) questo personaggio non fa
assolutamente nulla. Sennonché, nel finale, i corpi risorgono, vestiti da angeli come nel sogno del Monello di Chaplin, accompagnati da
una banda musicale. Ma quando lo zio/Dio si avvicina alla macchina
da presa, viene accolto da una sonora pernacchia. Il primo e il terzo episodio di Totò che visse due volte, in questo
senso, sono l’esperimento più estremo. Nel primo, un povero sessuomane ruba la colonna da un’edicola votiva per andare a
puttane; ma il boss di quartiere, assai devoto, lo condanna a rimanere murato lui nell’edicola, come un Ecce Homo vivente. L’ultimo
episodio, che racconta la discesa di Cristo in una Palermo dilaniata
dalle guerre di mafia, è concepito come una sacra rappresentazione. Un vecchio con la barba bianca arriva tra le borgate, ma la sua venuta
è un fallimento: sale sulla Montagna ma tace davanti alla folla che attende («H discorso? Ma andatevene a casa!»); fa risorgere il mafioso Lazzaro, ma questi ha come primo pensiero quello di vendicarsi del
clan rivale. Infine, Gesù viene sciolto nell’acido e al suo posto, in
croce, finisce un ritardato. Come si è detto, le immagini e i riti appartenenti alla religione cattolica sono visti sarcasticamente come il lessico, la logica cui si
conformano le azioni del mondo mafioso, e contemporaneamente implicano il riferimento a qualcosa di irriducibile a esso, senza che ciò porti però una speranza: l’antropologia e, per così dire, la teologia
morale di Cipri e Maresco sono rigorosamente negative. Il sacro, nei loro film, vive in continuo scambio/opposizione con la violenza primaria, ma anche con dinamiche storiche e concrete di potere e di sopraffazione. La mafia è un mondo in cui regnano allo stato puro
potere e violenza, una logica maschile di morte, e Gesù Cristo è
impotente, tanto che la vittoria sulla morte non fa uscire dalla spirale di violenza e vendetta (Lazzaro, risorto, pensa solo a vendicarsi). Più che tre stazioni di una Via Crucis, dunque, rispetto alle quali non c’è progressione, non ci sono misteri gaudiosi né dolorosi, quelle di Totò
che visse due volte sono tre pale d’altare; meglio ancora, esse
costituiscono un percorso orizzontale in cui il racconto non sembra procedere in linea retta ma a cerchi concentrici, dalla novella del
primo episodio fino a una visione d’insieme cosmica. Come ha scritto Nicola Lagioia, in Totò «i clan mafiosi non si limitano a rappresentare
il problema storico o sociale della Sicilia, ma personificano il potere e
la violenza che stringono il mondo intero sin dalla notte dei tempi e prima ancora della caduta dell’uomo edenico - gli Avversari per . 18 antonomasia» . Il ritorno di Cagliostro sostituisce alla vocazione monumentale e
tragica dei lungometraggi precedenti una leggerezza disincantata, una stoica desolazione. H film comincia come un finto documentario sul
ritrovamento di leggendari film della Trinacria cinematografica, immaginaria casa di produzione attiva nella Palermo del dopoguerra.
Attraverso flashback in bianco e nero, seguiamo le vicende dei fratelli La Marca (Franco Scaldati e Luigi Burruano), improvvisati produttori grazie ai buoni uffici del cardinale Sucato, che si imbarcano in imprese una più disastrosa dell’altra, fino a un ambizioso Cagliostro
per il quale reclutano una star sul viale del tramonto, Erroll Douglas (Robert Englund), che a, causa dell’inettitudine della troupe, finirà prima paralizzato e poi pazzo. A questo punto, il film sembra finire,
ma una voce nel buio lo fa ricominciare. Un nano dall’accento napoletano mette in discussione tutto quel che abbiamo visto finora e,
proiettando le immagini su uno specchio, spiega la sua versione dei fatti: dietro la Trinacria, spiega, c’era la mafia. Il cardinale Sucato era
un uomo di Lucky Luciano, i fratelli La Marca stessi erano uomini d’onore, il manager di Douglas era nipote del luogotenente di Luciano. Il manager finirà incaprettato nel bagagliaio di un’auto, e i
La Marca e il regista Grisanti lo aspetteranno invano mentre cresce
loro una lunga barba. Tutti morti, disperati o in manicomio, insomma: e i La Marca, addirittura, probabilmente murati vivi, dentro statue a loro somiglianza, ritenute poi miracolosissime. Il film fu presentato a Venezia lo stesso anno di Segreti di Stato di
Benvenuti, e involontariamente ne costituiva un’estremizzazione
parodistica: misteri e segreti d’Italia si incrociano nelle vicende di una coppia di poveracci, in una farsa generale che segna anzitutto un trionfo della stupidità umana.
5. Latitanti, presidenti e sciacalli.
Dopo anni di assenza, e poco prima di separarsi, Cipri e Maresco tornano in tv su Lay, nel 2006 e nel 2007, con due trasmissioni: I
migliori nani della nostra vita e Ai confini della pietà. Se del secondo di questi programmi vanno ricordate soprattutto le prime due puntate
dedicate a Giorgio Castellani/Giuseppe Greco, è il primo a interessarci
per come la mafia vi diventa centrale. In maniera sorprendente: perché le strisce dei due autori non erano mai state così direttamente
collegate all’attualità di cronaca, mentre in quel momento l’attenzione dei media nei confronti di Cosa Nostra giungeva ai minimi storici
degli ultimi decenni, e parallelamente si assisteva alla sua assunzione nell’Olimpo dei mondi mediatici, con le serie televisive su martiri e
boss. Ed è proprio la rimozione e sublimazione della mafia a stimolare il sarcasmo della coppia. Due sono le linee narrative che attraverso le puntate si inseguono e
si intrecciano: da un lato, l’inafferrabile latitante Bernardo Provenzano (che viene catturato Pii aprile, giorno in cui va in onda la tredicesima puntata della trasmissione), dall’altro il presidente della
Regione Sicilia Totò Cuffaro, simbolo del potere politico-mafioso nell’isola. Mentre si era formato nell’aprile del 2005 con un rimpasto,
e sarà in carica fino a maggio 2006, il terzo governo Berlusconi, sono infatti imminenti le elezioni regionali, nelle quali Cuffaro sarà rieletto
contro Rita Borsellino, anche se dovrà dimettersi meno di due anni
dopo, a seguito della condanna per concorso esterno in associazione mafiosa.
Sul presidente della Regione, fin dalla prima puntata, gli sketch insistono pesantemente. Pietro Giordano fa lezione di educazione
civica al farfugliante bimbo/vecchio Cirrincione: «Qual è il nome del presidente della Regione Sicilia, scimunito? Ti aiuto. Totò...?».
«... Schillaci!». «Acqua! Scimunito! Totò...? ». «... Riina!». «Fuocherello... Te lo dico io, Totò Cuffaro!». Di Cuffaro viene messo in ridicolo nella puntata successiva lo
slogan che campeggiava sui manifesti con cui aveva tappezzato
Palermo, «La mafia fa schifo», con il compito Maurizio Laudicina che in carcere grida «W la mafia» accompagnato dal rutto di un detenuto. Seguono, nel corso delle puntate, una serie di «inviti al voto» («Alle prossime elezioni vota Totò Cuddaro perché è un amico»), in cui
personaggi dediti a incaprettamenti o torture, ergastolani con palla al piede, e addirittura due cadaveri coperti da un lenzuolo, tessono
l’elogio del presidente della Regione, confondendo talvolta il suo
cognome con quello di Riina, o dicendo che votano Cuddaro perché gliel’ha detto «zio Bernardo». I titoli di coda della sedicesima puntata sono un montaggio di immagini del presidente della Regione (noto
anche come vasavasa, «bacia bacia», per le sue calorose effusioni di saluto) con in sottofondo la celebre Baci cantata da Remo Germani.
Intrecciata a quella di Cuffaro («Nel covo di Cuddaro sono stati ritrovati dei volantini elettorali di Provenzano»), si dipana la saga di Provenzano. Nella quarta puntata la mamma del superlatitante (un vecchio travestito da donna) reclama il figlio assente da 43 anni «per motivi di lavoro», mentre un coretto intona: Toma, sta casa aspietta
a te... Nelle settimane successive, vedremo Provenzano nel suo covo giocare a moscacieca con alcuni carabinieri e, dopo l’arresto
(interpretato da Pietro Giordano, e munito di pannolone), asfissiato dalla ripugnante madre, preda di problemi intestinali. In carcere, si
gioca a tombola con i numeri declamati secondo una ipotetica «smorfia» mafiosa: il Nano, lo Stalliere, e ovviamente Totò Cuddaro («tombola!»). La quindicesima puntata è dedicata al tema dell’omertà
(l’anima di Lo Giudice, ucciso da un killer, nega di conoscere perfino il
proprio corpo riverso), la sedicesima è quasi monografica su Provenzano, con ipotesi zoofile su come i mafiosi affrontino il
problema del sesso durante la latitanza: dopo gli accoppiamenti con
un ovino, nasce un agnellino con la coppola.
Attraverso le puntate si fa strada anche l’ossessione che condurrà Maresco a Belluscone. All’allora presidente del Consiglio, due ubriaconi (Peppuccio Abbate e Vincenzo Minnelli, a quanto pare cugino dell’omonimo regista) chiedono ripetutamente la birra (e
continueranno dopo le sue dimissioni: «Signo’ Belluscone, adesso che è più libero...»). L’orchestra dei Poveri Cristi esegue disastrosamente
l’inno di Forza Italia, un altro personaggio lo fa a suon di peti, e dai vecchi materiali di Cinico Tu rispunta il sessuomane Natale Lauria
con il suo «Viva Berlusconi» punteggiato da pernacchie e sputi. C’è
poi un gruppo di preghiera denominato P2 (ossia Preghiera 2), che
prega «perché tutto rimanga com’è», davanti all’effigie di Berlusconi,
e non manca l’affondo contro «Mistiche» di «Sporca Italia», con riferimenti al consumo di cocaina. La violenza del sarcasmo di Cipri e Maresco è senza precedenti nella televisione nazionale, fa impallidire ogni forma di mafia movie
comico (da Benigni al venturo Pif) e ha come unico punto di paragone i violentissimi sfottò radiofonici di Giuseppe Impastato contro politici
e mafiosi del suo paese. Secondo il giornalista Giuseppe Lo Bianco, quelle trasmissioni viste da pochissimi, in un’epoca in cui in tv di
mafia pochissimo si parlava, «non solo anticiparono alcuni temi, ma hanno fornito una lettura in tempo reale che neanche il giornalismo di
quegli anni era riuscito a fornire», a cominciare dai dubbi sulla 19 K cattura di Riina e poi di Provenzano . Ma è ancora più importante il discorso che la trasmissione porta a compimento, sulla
rappresentazione di Cosa Nostra. La novità di Cipri e Maresco consiste nel porsi davanti alla mafia, per la prima volta, come un
insieme di rappresentazioni (e di auto-rappresentazioni), nel lavorare sarcasticamente a una critica del linguaggio e dell’immagine. I neomelodici, le coppole e i baffoni, le emittenti locali, i film di Giuseppe Greco e i retroscena del mondo delle comparse: tutto questo
smaschera la malafede di un sistema di immagini, nell’informazione e nella fiction, che in quegli anni si mostrava sempre più ambiguo nella
spettacolarizzazione e/o nella riduzione alla logica dell’emergenza. Nei Migliori nani della nostra vita c’è infatti anche un attacco frontale al cinema di mafia. Dopo l’arresto di Provenzano, arriva la
notizia dell’imminente lavorazione di due serie sul boss, che seguiranno quelle sul «capo dei capi» Riina. Prontamente, Cipri e
Maresco mostrano all’opera il regista Tony Brunello (che in dialetto indica una persona dappoco, un quaquaraguà insomma) intento a dirigere, per la casa di produzione «Sciacallo associati» del produttore
Pietro Valmerda, una serie interpretata da «Michele Rancido». I riferimenti non sono troppo mascherati, come si vede. Nella puntata 17, ad ogni buon conto, sarà Binno in persona (che il regista Brunello
chiama «Bingo» Provenzano) a interrompere la lavorazione,
ricoprendo la troupe di contumelie.
6. Il cinema secondo Enzo.
Nel pieno del processo per vilipendio della religione e oscenità a Totò che visse due volte
, e dopo aver chiuso sostanzialmente le loro
collaborazioni televisive, Cipri e Maresco riemergono con Enzo, domani a Palermo!, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 1999 in una sezione collaterale. Pur nella sua brevità (circa un’ora) e
nel suo aspetto quasi estemporaneo, si tratta di uno dei più importanti film sulla mafia nella storia del cinema italiano. Accantonati momentaneamente i personaggi-interpreti di Cinico Tv le vittime Giordano, Tirone, Miranda ecc. - ci spostiamo da nudi
corpi-vittime a un personaggio in grado di fornire
un’autorappresentazione di sé. E il senso del film, la sua comicità, vengono proprio dall’assunzione delirante e paradossale di questo punto di vista, per irrigidirlo e ribaltarlo nel pirandelliano
«sentimento del contrario». Enzo Castagna è un personaggio centrale nella storia del mafia movie: proprietario di un’agenzia di pompe funebri, si autodefinisce
(stuzzicato da Maresco) «il più grande organizzatore cinematografico del mondo». Gestisce il giro delle comparse cinematografiche di Palermo (trentamila, secondo lui) e quindi, a suo dire, ha avuto un ruolo centrale nella storia del cinema: da Mery per sempre al Ladro
di bambini, da Nuovo Cinema Paradiso al Padrino parte n, dai
Racconti di Canterbury (il cui titolo non riesce a pronunciare) alle Piovre e ai film di Castellani/Greco: tutti questi titoli, lascia
intendere, non esisterebbero senza di lui. Il film si compone per un terzo di brani provenienti da Sicilia da
Oscar, che sei anni prima seguiva in diretta i preparativi dell’Oscar siciliano, manifestazione organizzata da Castagna nel suo quartiere,
mescolandoli a personaggi pittoreschi delle tv private siciliane come il mago Atanus o il venditore di dischi Sebastiano Marino detto «zu
Bastiano». Parte di quel film era stata rimontata in un altro
mediometraggio, I Castagna sono buoni. Ora le stesse immagini (le riprese della sala trattenimenti La Cupola, con in sottofondo Everyboy Loves Somebody Sometime e That’s Amore) aprono e chiudono il film, ma in mezzo si ricostruiscono le vicissitudini di
Castagna negli ultimi anni, e si segue la festa in piazza per il suo
ritorno, che lui organizza per forza di cose dal balcone di casa. Castagna infatti si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di aver partecipato a una rapina alle poste (per rimpinguare le casse di Cosa Nostra, in crisi di liquidità’), e risponde alle domande di Maresco con
tetragona sicurezza. Il comico scaturisce insomma dallo squilibrio tra il delirio di un mafioso di piccolo cabotaggio, o meglio di un
personaggio «di sentire mafioso» (Castagna non è in effetti un affiliato di Cosa Nostra, e forse anche per questo ne esprime così
candidamente l’ideologia), e la realtà di un mondo che va per conto
suo: alla fine Castagna appare, contro le parole e contro/grazie alle immagini, un perdente. Se il delirio di onnipotenza del mafioso Christopher Walken con i suoi monologhi, in Fratelli di Abel Ferrara,
descriveva un mondo tragico, gli sproloqui di Castagna sono una sorta di ribaltamento della laconicità di don Vito Corleone e di mille altri mafiosi di celluloide. Nel contempo, però, il film prende
profeticamente in giro alcuni settori della società civile, con 21 un’intervista alla presidente del Coordinamento Antimafia Angela Lo Canto, che in polemica con Castagna aveva offerto l’appoggio al regista Aurelio Grimaldi per la produzione dei suoi film.
Tutto il film può leggersi come una comica controstoria del cinema italiano «dal basso», con una specie di Danny Rose che compare al
fianco di registi e attori. Forse, addirittura, la verità sul cinema italiano, la metafora della sua gloria e miseria: davanti alle gaffe e
all’imperizia del piccolo organizzatore palermitano, si ride come a un’iperbolica messa in scena della megalomania e del cinismo dei produttori e registi italiani.
Dopo la struttura ieratica e monumentale di Totò che visse due
volte, i registi recuperano una leggerezza che guarda ironicamente
all’estetica delle tv private e dei filmini di matrimonio. Ma Enzo, domani a Palermo! è anzitutto un patetico compianto funebre, un film di soffusa e acre malinconia. Castagna non lo sa, ma è la
sopravvivenza un po’ goffa e un po’ proterva di un mondo destinato
alla fine. Il suo piccolo mondo (enfatizzato dalla cattività domiciliare, da quel balcone dal quale dirige la festa rionale, dal cucinino in cui la organizza nei dettagli) nel suo meschino delirio è già morto.
Il cinema di Cipri e Maresco conferma con Enzo la propria
vocazione malinconica e archeologica. Da questo punto di vista è fondamentale il ritratto di Saverio, l’assistente di Castagna dal piglio
pateticamente manageriale, che parla in un italiano semi-dialettale,
ma sforzandosi di cadenzarlo su toni da piazziste televisivo del Nord o da sottobosco di Forza Italia. Un italiano televisivo, ma da tivù miserrima, che spinge al riso, poi al disagio, infine alla pietà. Le ultime immagini del film (che concludevano già I Castagna sono
buoni) assumono ora, incorniciate come in un ideale flashback del
«piccolo grande uomo» chiuso in una riserva indiana dalla magistratura ma anche da un mondo che cambia, una coloritura da
funerale più che da festa: la macchina da presa sembra non volersi staccare da volti scavati o gonfi, ottusi, cisposi, aridi o smarriti, una
galleria goyesca e troppo umana. L’atroce futuro è nello sguardo
spento e nel fraseggiare atono di Saverio: e allora meglio rallentare lo . . . .. 22 sguardo su questi resti di umanità, un attimo prima del nulla . Un percorso che Maresco, nei film successivi, proseguirà trovandosi ad
adottare di nuovo, per forza o per necessità, la forma documentaria.
7. Una storia italiana.
Nel 2008 Cipri e Maresco si separano. Il primo intraprende una carriera di direttore della fotografia
, e come regista affronta progetti
maggiormente inseriti in un cinema industriale: il suo esordio da solo, È stato il figlio, tratto da un romanzo di Roberto Alajmo, è un viaggio, colorato e grottesco, nella linea di confine tra sottoproletariato e
infima borghesia, in cui gli echi del lavoro con Maresco e con Torre si
intrecciano a ricordi della commedia all’italiana anni settanta e del teatro di De Filippo.
Maresco invece porta a termine il documentario Io sono Tony Scott
- ovvero come l’Italia fece fuori il più grande clarinettista deljazz,
sull’omonimo jazzista italo-americano, e poi si imbarca nell’impresa di un film su Silvio Berlusconi e Palermo. Il progetto attraversa tre anni di gestazione a dir poco laboriosa, segnata da sventure di vario tipo, tanto che se ne comincia a parlare come di un candidato alla ideale cineteca dei titoli incompiuti e maledetti. Invece verrà ultimato
e (assente il regista) presentato alla Mostra di Venezia del 2014 nella sezione Orizzonti, dove vincerà il premio speciale della giuria (tra i sostenitori, il giurato David Chase, showrunner dei Sopranos). Ma nel
frattempo il film, intitolato Belluscone - Una storia siciliana, è diventato assai diverso dal progetto di partenza, come peraltro era
accaduto anche agli ultimi lungometraggi della coppia e al documentario su Scott.
Berlusconi era un tema presente fin dai primi video di Cipri e Maresco, come il citato monologo A Silvio che aveva causato il primo esempio di censura nei loro confronti: Tirone immaginava non solo
un’entrata in politica del magnate televisivo, ma anche un futuro in cui lui si trovasse dovunque, come un Grande Fratello più dickiano
che orwelliano. La figura di Berlusconi torna poi spesso in Cinico Tv, in varie versioni dell’inno di Forza Italia (sotto forma di peti, pernacchie, scalcinato duo di orchestrali) o nelle continue richieste di
una coppia di disperati: «Signo’ Belluscone, non è che ci avrebbe un poco di bbirra, che siamo rimasti all’asciutto? GRAZIE!». La nascita di Forza Italia, intorno a cui si riaggrega buona parte del ceto politico più compromesso con la mafia, era stato un trauma e una
conferma per chi, come Maresco, pur animato da incrollabile pessimismo, aveva comunque partecipato alla rinascita della città in reazione alle stragi del 1992. In Sicilia, Forza Italia è egemone per
quasi un ventennio, nonostante la vittoria di Orlando al Comune di
Palermo nel 1997, e il «ribaltone» che porta per tre anni al governo
della Regione il centrosinistra. Alle elezioni del 2001 tutti i seggi di
Camera e Senato saranno conquistati dal centrodestra.
Belluscone, va. detto, non solo arriva dopo una già cospicua
filmografia sul Cavaliere, culminata nel Caimano di Nanni Moretti
24
,
ma è anche in ritardo sulla sua parabola storica. Quando Maresco si mette all’opera, Berlusconi ha già rassegnato le dimissioni da presidente del Consiglio: nel corso della lavorazione si susseguiranno i
governi Monti, Letta e infine Renzi (ma anche la sorprendente
rimonta e il quasi-pareggio con Bersani alle elezioni del 2013, e il cosiddetto «patto del Nazareno» con il segretario del Pd). Proprio
l’apparente inattualità del tema, come vedremo, diventa però uno dei punti di forza del film.
Partito come documentario sul rapporto tra Berlusconi e Cosa Nostra, il film deria in un riaggio tra i cantanti neomelodici al seguito
dell’irresistibile impresario Ciccio Mira. Ma ben presto tutto si interrompe e collassa: Maresco, ci rien detto dopo una decina di
minuti, è sparito, forse vittima del proprio film, e sulle sue tracce
parte il critico Tatti Sanguineti. Quello che alla fine emerge è un film a strati. Un primo strato politico è l’indagine diretta sulle origini «siciliane» del progetto di Forza Italia, gli intrecci tra il capomafia Stefano Bontate, il manager di Publitalia Marcello Dell’Utri, il mafioso 25 Vittorio Mangano, assunto come stalliere ad Arcore . Parallelo a
questa linea narrativa, un viaggio tra i cantanti di piazza delle borgate palermitane, tra Brancaccio e Villagrazia (terre dei Bontate e dei
Grariano, ancora): un mondo di spettacolo lumpen già raccontato in Enzo, domani a Palermo!, e posseduto oggi da una sorta di transfert
per il Cavaliere. Berlusconi come «autobiografia di una regione», più lampedusiana che gobettiana? Ma anche l’inverso: una torsione
sarcastica del citatissimo motto di Goethe, secondo cui «in Sicilia c’è la chiave di tutto». E c’è infine un terzo strato (un «terzo livello», verrebbe da dire), misterioso e forse inevitabile: il racconto del film
stesso, la sua mise en abyme, con Sanguineti un po’ Caronte un po’
Philip Marlowe, che traghetta nei misteri della scomparsa di Maresco. Dalle macerie di un fallimento, Maresco fa risorgere il suo film sul film, creando con frammenti sparpagliati un insieme di coerenza
musicale. Belluscone è dunque il racconto di come il film stesso non si
è fatto e non si poteva fare, anche per i limiti strutturali del comico e
dell’inchiesta; perché, man mano che l’orizzonte si allarga, la cupezza dello sguardo coinvolge il senso del fare cinema. L’elemento di critica
delle immagini, sempre presente nei lavori di Cipri e Maresco (e
centrale anche nella loro maniera di raccontare la mafia) diventa qui vertiginoso. H percorso che aveva portato a un parziale disamore
verso corpi e luoghi, verso la possibilità di una loro flagranza sublime
e orrida, diventa una messa in discussione del senso del proprio operato e una presa di distanza da uno sfondo mediale ormai
accecante. Il film è profondamente politico per la visione di fondo
complessiva, che inserisce Berlusconi tra gli elementi illuminanti ma
non come origine di tutti i mali, bensì come elemento rivelatore, perno attorno a cui ruotano una miriade di personaggi, e con un tono
che spiazza continuamente lo spettatore, fino a un omaggio sulla tomba di Stefano Bontate, visto come un «padre della Patria», della
nuova Italia di Berlusconi, Renzi, e dei reality e talent show.
Ma più ancora, Belluscone è un film meta-politico, o un meta-film politico, sulla difficoltà di dar conto in termini esclusivamente politici
di una mutazione che è anche antropologica e che coinvolge il ruolo
stesso del regista e il suo rapporto col pubblico. Questo spiega lo spiazzamento che causa nello spettatore, il quale deve continuamente
interrogarsi sullo statuto di verità di ciò che vede, sul suo essere
fotografia o parodia. Al di là di una cornice (parzialmente) di fantasia, quasi tutto quel che si vede nel film è vero, e gli avvenimenti
raccontati sono accaduti: i telegiornali con un tizio che fa esplodere la casa terrorizzato all’idea di perdere la pensione dopo le dimissioni di
Berlusconi; le intercettazioni dei boss di Porta Nuova che cantano con Mira; le denunce di un cantante neomelodico contro Maresco stesso;
il microfono che si rompe durante un’intervista a Marcello Dell’Utri,
dominus siciliano del partito-azienda e tramite, in tempi lontani, con il mondo mafioso. La verità di cui parla Maresco è paradossale, mediata, messa in scena, eppure non riducibile al gioco cinefilo e
narcisista, o alla moda del mockumentary. E magari, le parti che appariranno più inverosimili e folli saranno proprio quelle che più
semplicemente mostrano la realtà. Come scriveva Flannery O’Connor, parlando della letteratura del Sud degli Stati Uniti: «Ho scoperto che
ogni opera narrativa che viene dal Sud è considerata grottesca dai
critici del Nord; a meno che sia veramente grottesca, nel qual caso X ., ... 26 sara considerata realistica» .
La stessa esitazione, la stessa angoscia che si hanno davanti
all’effetto di realtà, il film le comunica riguardo al riso. Si ride, certo,
ma il sentimento finale è straziante. Perché Maresco in fondo ha
grande pietà per il mondo terribile che narra: il vero orrore gli sembra piuttosto il volto dell’Italia di oggi, quello delle interviste ai giovani
borghesi sui titoli di coda. Belluscone è in questo senso anzitutto un film moralista, un melanconico grido di estraneità nei confronti del
presente (nel finale appaiono, con agghiacciante continuità antropologica rispetto alla storia raccontata, Matteo Renzi ad Amici e le gare di XFactor). Cade in maniera definitiva ogni possibilità di
equivoco, di sentire il mondo di Maresco «lontano da noi».
L’insistenza sui neomelodici fa emergere una cultura lumpen che si salda in un «tuttodentro», come ha scritto Giorgio Vasta, a una borghesia immemore e gaudente2 . Ogni volta che Ciccio Mira appare
in scena, il bianco e nero invade lo schermo. La trovata segnala l’ironico irrompere di un passato - un passato che non ha nulla di glorioso, ma a differenza del presente ha comunque una faccia (per
quanto ridicola) e una storia (per quanto miserabile). Al riguardo ha dichiarato il regista:
Simenon fa un romanzo meraviglioso di Maigret su un tipo che ha il labbro leporino, ma in una società in cui a tutti cresceranno i capelli, nessuno starnutirà più (penso a Cechov), i labbri leporini non esisteranno più, i gobbi nemmeno, che cosa si racconterà? Gli uomini che potranno programmarsi 0 essere intelligenti potenziati come meglio credono, potranno capire qualunque cosa attraverso strumenti. In un mondo [...] in cui c’è il cervello artificiale, il
sangue artificiale, gli organi che ricrescono, l’intelligenza potenziata, una cosa è chiara: che un mondo, che sia Dostoevskij 0 che sia Liala, è finito. In questo film [...] ho cercato di far venire fuori la tristissima e però al tempo stesso
eroica vitalità di Mira e del suo rapporto con gli uomini della sua scuderia, che sa che sono cose inutili, perché per quanto lui sia musicista non eccelso è
tuttavia dotato di orecchio e di gusto, e sa che Vittorio Ricciardi (un giovane neomelodico] è scarso. Questo contrasto in quel mondo, il rapporto tra lui e un tipo tatuato che parla di cose come Facebook che Ciccio Mira non riesce neanche a nominare: mi è troppo simpatico, è straordinario. E poi a un certo punto arriva l’Italia perfetta, quella post-berlusconiana, quella che si accende nel finale con appena due tocchi di pennello: Renzi e la suora [Cristina Scuccia,
la suora canterina della trasmissione X Factor], l’orrore eccetera. Ancora una volta nei Mira e nelle borgate trovi residui di un’umanità che è infinitamente
più umana e infinitamente meno mostruosa di quella che poi si vede per tre secondi nel finale*8. Quel che si ha davanti è un doppio apocalittico del cinema
d’inchiesta, come un Caso Mattei in cui la ricerca della verità collassi e ceda il posto alla melanconia, alla bile nera. Insomma, qualcosa che
si lascia alle spalle il cinema di denuncia o l’inchiesta televisiva, rappresentate, alla stessa Mostra del Cinema, dal film La trattativa di
Sabina Guzzanti (supra, cap. XIII). Nello stesso tempo Belluscone è un
autoritratto, come in fondo, a pensarci, erano stati, per gradi, molti film di Maresco, compresi quelli col sodale di un tempo Cipri: i
disastrosi fratelli La Marca di II ritorno di Cagliostro, Franchi e Ingrassia di Come inguaiammo il cinema italiano, il jazzista psicotico Tony Scott. Tutti perdenti siciliani, vittime del proprio tempo e di se
stessi. Da un lato, Maresco è giunto al capitolo finale di un’ossessione
per Berlusconi; dall’altro, si è rimesso in gioco con radicalità e lucida follia. È arrivato a un film «sporco», lontano dalla monumentalità dei lungometraggi precedenti, dalle loro inquadrature composte e
ieratiche, dalle lunghe inquadrature fisse. Qui è il montaggio a ricreare il film, trattando tutto il girato comefoundfootage, come immagini trovate in una bottiglia. «Il contemporaneo è l’intempestivo», dice un celebre aforisma di
Nietzsche. Parole che si adattano perfettamente a Belluscone. Ed è
impressionante come questo film, fatto quasi contro il proprio tempo, su un obiettivo che poteva sembrare scontato o sorpassato, sia
diventato il lavoro più utile a capire due decenni di Berlusconi, della Sicilia, di Cosa Nostra e dell’Italia; e magari la premonizione allucinata e ilare di qualcosa di là da venire.
8. Filmare la battaglia. Durante e dopo Belluscone, Maresco continua ad accarezzare numerosi progetti che, in chiave più o meno ironica e sempre a cavallo tra finzione e realtà, hanno a che fare con i paradossi della
rappresentazione di Cosa Nostra, con la sua rimozione o con la mistificazione dei media. Un film, che riprendeva comicamente lo 29 spunto di un libro di Giuseppe Casarrubea e Mario Cereghino , immaginava che al posto di Salvatore Giuliano fosse stato ucciso un sosia, e seguiva la vita del bandito sotto falso nome, attraversando
cinquantanni di vita italiana. Un altro personaggio che suscita l’interesse del regista è un poco appariscente protagonista del maxiprocesso a Cosa Nostra, il presidente Alfonso Giordano, mite e
minuto ultraottantenne presidente della Corte che emise la sentenza di primo grado contro i vertici di Cosa Nostra. Ma l’ispirazione malinconica del suo cinema si accentua anche nel ritratto del
drammaturgo e attore Franco Scaldati (Gli uomini di questa città io non li conosco), altra occasione per un viaggio nel passato di Palermo,
città che al regista sembra apparire sempre più luogo di fantasmi. In questo filone dei film-intervista, che Cipri e Maresco hanno . 3° praticato assiduamente fin dagli inizi , un tassello innovativo è
l’incontro con la fotografa Letizia Battaglia, reporter del giornale «L’Ora» e pertanto testimone delle più efferate stagioni di delitti di
mafia negli anni settanta e ottanta, ma anche anima di un irriducibile impegno civile nella città. Negli anni, l’attività politica e quella di
fotografa si intrecciano nel suo lavoro: le immagini delle guerre di mafia, l’attività di documentazione all’Ospedale psichiatrico di Palermo, la formazione di una vera e propria «bottega» di giovani
fotografi, la rivista femminista «Mezzocielo» fondata insieme a un gruppo di attive intellettuali; negli anni novanta, infine, la politica diretta (come deputato regionale con i Verdi e assessore all’Ambiente in una delle giunte Orlando) e la fondazione di una casa editrice, le Edizioni della battaglia.
Realizzato in occasione della mostra di Battaglia al MaXXI di Roma
(che riprende quella ai Cantieri culturali della Zisa di Palermo), La mia battaglia è un documentario di 20 minuti che segna il primo
incontro «ufficiale» tra due personaggi rilevanti della cultura siciliana
degli ultimi decenni. Battaglia e Maresco si erano incontrati
direttamente solo negli anni novanta grazie a Goffredo Fofi, ma non avevano mai collaborato. Gli anni duemila avevano segnato per
entrambi una profonda disillusione: Maresco si fa esule in città, e il
sodalizio con Cipri si scioglie; Battaglia abbandona Palermo e si trasferisce a Parigi, ma non resiste e toma dopo un paio d’anni.
La mia battaglia è il primo film di Maresco dedicato a una donna,
e soprattutto (di conseguenza?) la prima volta che l’intervistatorefilmatore non può rispecchiarsi nell’oggetto della propria indagine. Come abbiamo detto, c’è un po’ di Maresco in Enzo Castagna e in Tony Scott, in Franchi e Ingrassia, in Scaldati o in Ciccio Mira. Tutti
autoritratti, in fondo; e qualcosa di Maresco si proiettava perfino nei personaggi di Cinico Tv. Qui invece Letizia resta Letizia, e il Franco
che ne viene fuori è, come e più del solito, un intervistatore che si mette in gioco, una persona che parla di memorie comuni con
qualcuno diversissimo nell’atteggiamento verso la Storia e la cronaca. Battaglia è stata una testimone e una protagonista generosa,
entusiasta, pronta ad accendere le speranze nella Palermo degli anni
novanta; Maresco parte da un invincibile pessimismo sugli esseri
umani, smentito spesso, negli stessi anni, dal suo impegno controvoglia. E proprio la speranza quella che divide i due, ma la cosa che sorprende è il rispetto, l’ascolto del regista per questa donna che è, in tutto e per tutto, il suo negativo (o piuttosto il suo positivo). La
differenza di stile (appassionata e sincera retorica lei, sarcastico lui)
trova un punto d’incontro nel gusto del paradosso, nella comune
attrazione per il mondo lumpen, per la follia; nella sensibilità per le ingiustizie e nella capacità di indignazione.
«Io penso che tu mi voglia fare dire che non c’è speranza. Dimmelo
che non lo vuoi dire questo»: queste le prime parole della fotografa,
nel film. E Maresco:
«No, non te lo voglio dire». Battaglia: «Che mi vuoi dire tu?». Maresco: «No, io voglio... confrontarmi oon te, e... mettere dubbi... Forse siamo complementari: tu da un lato hai la speranza con un po’ di dubbio, io il
dubbio con un po’ di speranza». Battaglia: «Ma io penso che la mia speranza sia fallace. Io me la invento, la
mia speranza».
Così l’attacco del film, con la fotografa che di Palermo ama in fondo le stesse cose del regista, seppure in maniera diversa, e tira in mezzo
l’intervistatore, per una volta compiacente e quasi esitante. Intorno
appaiono non solo le foto dei morti ammazzati, ma immagini di repertorio, filmini familiari e super8 girati da Battaglia stessa, che nei film di Maresco sembrano, cullati dalle note di Bill Evans o Chet
Baker, carichi di una commozione non tanto repressa. Nella complicità che si crea tra i due, fino alle ultime battute del breve film (Lei: «Io ti uccido». Lui: «E io mi faccio ammazzare. E poi mi fotografi». Lei: «No, non ti fotografo») si entra con divertimento e
perfino un po’ consolati dalla loro compagnia.
Questo regista che non ha mai filmato le donne (forse per una sorta
di sacro terrore isolano, forse per la loro incongnienza con una nerissima visione del mondo) dà dunque per una volta un ritratto femminile della sua città. Come ancora una volta ipotizza l’intervistata: «Nei tuoi film non ho notato l’assenza del pensiero
femminile. Era tutto un gioco, una disperazione, quello che era, ma a me andava benissimo, non mi mancava che non ci fossero le donne.
Credo che tu sia un poco femminile, nonostante quello che si può pensare perché non ci sono donne in scena». «E così mi hai rovinato
per sempre, cara Letizia», ribatte ancora una volta complice il regista. Paola Malanga, una quindicina d’anni fa, in uno dei saggi più originali su Cipri e Maresco 31 , aveva scritto che in fondo nel loro cinema una donna c’era: la macchina da presa. Forse parente non troppo lontana
della macchina fotografica di Letizia Battaglia.
1 E. Bellavia - S. Palazzolo, Voglia di mafia. Le metamorfosi di Cosa nostra da Capaci a
oggi, Carocd, Roma 2004, p. 187. 2
Questo capitolo nasce anche dalla diretta esperienza personale del lavoro dei due registi»
che ho seguito nella lavorazione di film e in varie iniziative, culturali Nell’arco di oltre ventanni, ho scritto su di loro una cinquantina di articoli, saggi, interriste, contributi vari. In questo capitolo si trovano spunti e un paio di paragrafi riadattati dai seguenti testi a mia firma: Cipri e Maresco, Falsopiano, Alessandria 2003; «Neanche le rovine». Cipri e Maresco
a Palermo, in Metropoli e nuovi consumi culturali. Performance urbane deWidentità, a cura
di F. Deriu, L. Esposito, A. Ruggiero, Carocci, Roma 2010; Ideologia mafiosa e devozione cattolica nel cinema degli anni Novanta, in L’immaginario devoto tra mafie e antimafia, a
cura di L. Mazzei e D. Orecchia, VieUa, Roma 2018, pp. 79-82. 3
Per un’introduzione ai primi lavori della coppia si vedano A. Earassino, Cast e credits per
Cipri e Maresco (1993), raccolto tra l’altro in E1 sentimiento cinico de la vida. Il cinema, i
video, la televisione di Cipri e Maresco da «Cinico Tv» a «Totò che visse due volte», a cura di
E. Morreale e V. Valentini, Ed. Il Genio, Comune di Palermo 1999, pp. 107-12; B. Fornata,
Uomini e zìi tra terra e cielo, in «Cinefonim», marzo 1998,372, pp. 5-8. 4
Cfr. A. Longo, Palermo neifilm di Cipri e Moresco, in Le città visibili. Spazi urbani in
Italia, culture e trasformanoni dal dopoguerra a oggi, a cura di J. Foot e R. Lumie}-, Il
Saggiatore, Milano 2007, P- 225 (ed. or. Italian Cityscapes. Culture and Urban Change in Contemporary Italy, University of Exeter Press, Exeter 2004). 5 Cfr. Azzolina, Governare Palermo dt Su questi passaggi cfr. E. Morreale, Sud, in La «scuola» italiana. Storia, strutture e immaginario di un altro cinema (1988-1996), a cura di M. Sesti, Marsilio, Venezia 1996; Id., Paesaggio con mutazioni, in La meglio gioventù. Nuovo cinema italiano, 2000-2006, a cura
di V. Zagarrio, Marsilio, Venezia 2006, pp. 154-60. Longo, Palermo neifilm di Cipri e Maresco dt, p. 224. o
G. Deleuze, L’immagine-tempo, Ubuhbri, Milano 1989, p. 269. q
Morreale, Opri e Maresco dt, pp. 47-9.
10
Intervista contenuta negli extra del dvd Cinico Tv. Volume primo, 1989-1992, Cineteca
di Bologna, Bologna 2010. 11
I due cortometraggi, entrambi del 1990, sono contenuti nel citato dvd Cinico Tv
1988-1992.
I due spot sono ispirati alle proteste dei lavoratori della ditta Cassina, che in quel
periodo avevano sfilato per le vie di Palermo portando due bare e scritte «W la mafia». Cfr. G. Lo Bianco, Alieni in Tv, l’occhio surreale sulla mafia chefa schifo, nel booklet del dvd Cinico
Tv. Volume primo, 1989-1992 dt, pp. 30-2. 13
M. Bachtìn, Leforme del tempo e del cronotopo nel romanzo, in Id., Estetica e
romanzo, Einaudi, Torino 1979, pp. 346-8. 14
Mi riferisco a vari volumi dell’autore, a cominciare da La violenza e il sacro (1972),
Adelphi, Milano 1980. Lo stesso Girard allude alla possibilità di rinvenire la figura del capro
espiatorio in coloro che stanno ai margini della società (Il capro espiatorio [1982], Adelphi, Milano 1987, p. 38) e per la diversità fisica, la deformità e la malattia: «Se un’infermità, anche accidentale, inquieta, è perché dà un’impressione di dinamismo destabilizzante. Sembra minacciare il sistema in quanto tale. Si cerca di circoscriverla, ma non si può; essa sconvolge
intorno a sé le differenze, che diventano mostruose, precipitano, si comprimono, si
mescolano e, al limite, minacciano di abolirsi» (ibid., p. 42). Così commenta Riccardo De Benedetti: «L’accusa ipermoderna che si muove al capro espiatorio di turno, oggi, non è la
stessa mossa a Giobbe, cioè quella di aver avuto tanto successo nella vita da risultare intollerabile, ma il contrario, di avere una vita che non vale più la pena vivere. È l'ostilità universale dovuta alla rappresentazione che certe categorie di persone forniscono della condizione reale della vita umana, con le sue imperfezioni e le sue radicali limitatezze. In un
mondo in cui la performance del corpo deve essere assoluta, sicura, senza sbavature [...] ogni segno di decadimento deve essere estirpato. Ecco, il generalizzato miglioramento della vita
sembra sempre e ancora avvenire a spese di qualcuno, del più debole. Se questo è vero, allora
non siamo affatto sicuri die si sia posto termine alla visione persecutoria della società» (Introduzione ad Aa.W, Oltre il sacrificio. Conversazioni con René Girard, Medusa, Milano 2017, p. 10). Sarebbe interessante leggere in chiave girardiana (U capro espiatorio dt, pp.
83-6) anche la presenza delle forme animali, spesso non prive di echi biblid, nei lungometraggi della coppia: asini e cani (Lo zio di Brooklyn), maiali, topi e galline (Totò che xjisse due volte), e persino il versante scatologico della produzione di Cipri e Maresco: «i
mammìferi marcano i confini territoriali con i propri escrementi, e per lungo tempo gli
uomini hanno fitto lo stesso oon quella forma particolare di escrementi che sono per loro i capri espiatori» (Id., Vedo Satana cadere come la folgore [1999], Adelphi, Milano 2001, p.
221).
L. Sciascia, Feste religiose in Sicilia, Leonardo da Vind, Bari 1965, con fotografìe di F.
■Scanna; poi in id., La corda pazza, Einaudi, Torino 1970. 16
Sull’importanza dell’elemento devozionale nella costruzione della subcultura mafiosa si
veda Dino, La mafia devota dt 1 P. Schrader, Il trascendente nel cinema. Ozu, Bresson, Dreyer (1972), Donzelli, Roma
2002. iS N. Lagioia, Il cinema e la televisione di Cipri e Maresco, in «Quaderni del Csci», 2009,
5, pp. 80-x. 19
«Ci sono tutti i temi che poi verranno sviluppati dalle indagini successive che
porteranno al processo della “trattativa0 e cioè il rapporto tra Provenzano e il mondo di Totò
Cuffaro, tra Provenzano e il mondo di una parte dei carabinieri, anticipando temi che sono tuttora oggetto di indagini giudiziarie, ancora lunghe e complesse» (G. Lo Bianco, intervista
nel booklet Cinico Tv. Volume terzo, 1996-2007, a cura di E. Morreale, Cineteca di Bologna,
Bologna 2016). 20
Sulle vicissitudini di Totò die visse due volte, proibito in prima istanza dalla censura e
al centro di due processi, si veda l’approfondimento sul sito dnecensura.com: http://cinecensura.com/sesso/toto-che-visse-due-volte/. 21
Sulle vicende del coordinamento antimafia a partire dagli anni ottanta si veda U.
Santino, Storia della mafia e dell'antimafia, Editori Riuniti, Roma 2000, pp. 22
In quel periodo, sulla scia dell’incontro con Castagna, altri progetti non realizzati hanno
a che fine con il mondo di Cosa Nostra. Ricordiamo almeno La Madonna della Mercedes, una specie di heist movie che avrebbe dovuto trasformare in racconto di fiction molti spunti
reali della vicenda di Castagna. Il trattamento è stato pubblicato sulla rivista «Brancaleone»,
2007,2, pp. 135-62. 23
Tra i titoli principali di cui Cipri firma la fotografia ricordiamo i film di Marco
Bellocchio da Vincere in poi, ma anche quelli di Claudio Giovannesi (fili ha gli occhi azzurri-,
Fiore), Salvo di Piazza e Grassadonia e La trattativa di Sabina Guzzanti. 24
Cfr. N. Marini Maio, A Very Seductive Body Politic. Silvio Berlusconi in Cinema,
Mimesis, Milano 2015. Noto che anche II Caimano racconta Berlusconi attraverso la crisi di un film impossibile da fire su di lui. 25 Sulle indagini che hanno esplorato i legami tra Cosa Nostra e la nascita di Forza Italia si
veda Abbate - Gomez, I complici dt, pp. 217-40. 26
Cit in R. Lunghi, la spada e le magnolie. Il Sud nella storia degli Stati Uniti, Donzelli,
Roma 2007, p. 181. 2 -
G. Vasta, Belluscone visto da Palermo, in «Lo Straniero», ottobre 2014,173, pp. 139-44.
28
* A. InzeriHo, Conversazione con Franco Maresco, in «Rapporto confidenziale», 25 agosto 2014, https://www.rapportoconfidenziale.org/?p=3i935. 29
La scomparsa di Salvatore Giuliano, Bompiani, Milano 20x3.
30
Ricordiamo almeno, oltre ai ritratti di jazzisti, i brevi film-intervista a Martin Scorsese
(Martin a little...), Samuel Fuller (Il corridore della paura), Vittorio De Seta (Vittorio De Seta: lo sguardo in ascolto), Peter Bogdanovich (F.), Mario Martone ed Enzo Moscato
(Aspettando Totò), e, più interessante per questo libro, il cronista e drammaturgo
palermitano Salvo Licata (La ballata di Salvo). 31
P. Malanga, L’occhio di Polifemo e lo sguardo di Cassandra, in Morreale - Valentini (a
cura di), E1 sentimiento cinico de la vida dt, pp. 58-67.
xvi. Epilogo
Non amo parlare di me stesso e poi ormai è da
anni che sono gli altri a parlare di me... credo, mio malgrado, di essere diventato il Malaussène di tutti e di tutto... ma va bene così... sono un fatalista. So di avere vissuto da uomo vero e tanto mi basta [...]. Jorge Amado diceva che non c’è cosa più infima della
giustizia quando va a braccetto con la politica e io sono d’accordo con lui.
Alessio (alias Matteo Messina Denaro), lettera a
Svetonio (alias Antonio Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano), ottobre 200412 34 La tendenza del mondo occidentale, europeo in particolare, è quella di esorcizzare il male proiettandolo su etnie e su comportamenti che d
appaiono diversi dai nostri Ma se vogliamo
combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una piovra 0 un cancro. Dobbiamo riconoscere che d
rassomiglia. Giovanni Falcone^
1. Tragedia delle immagini. In una fase in cui il cinema pare disinteressarsi a Cosa Nostra,
attratto dal racconto di ’ndrangheta, camorra e mafie laziali, Il
traditore di Marco Bellocchio sembra andare in controtendenza. Il regista piacentino ripercorre le vicende del pentimento di Buscetta e del maxiprocesso concentrandosi soprattutto sulla mutazione del personaggio, sulla sua tragedia umana, intuendo che (come già
sapevano Scorsese e Ferrara) i mafiosi sono figure tragiche del nostro
tempo. Per far questo, però, dà nella prima mezz’ora molto spazio alla spiegazione degli eventi, sicché il film è preceduto da un prologo che
riepiloga gli eventi della seconda guerra di mafia. Non stupisce che
proprio questa parte iniziale abbia suscitato i maggiori entusiasmi della critica e del pubblico, anche se si tratta di una premessa
strettamente funzionale a spiegare gli eventi prima di entrare nel vivo della vicenda che al regista interessa. Il traditore, infatti, è stato fruito soprattutto come una specie di action movie non troppo distante dalla
produzione Netflix, come una dimostrazione che il cinema d’autore
può aggiornarsi confrontandosi con i modelli della quality tv . 3 americana . In realtà quello che sembra aver interessato Bellocchio è un doppio
binario: da un lato la dimensione tragica, dall’altro la critica alle immagini. Sul primo versante c’è il tentativo di de-romanticizzare la figura del mafioso, con un personaggio tormentato ma subito perdente e cupo come il suo mondo. La scena iniziale è ancora una
volta un ballo, che è però una versione lugubre e spenta di quello del Padrino, e per tutto il film domina il buio, con i volti dei personaggi
divisi a metà fra la luce e l’ombra. Come abbiamo detto, Bellocchio deve essere stato attratto da un
personaggio che mette in crisi la legge mafiosa attraverso il tradimento, che è anche un esponente della forza del desiderio, uno
per cui, al contrario che nel motto siciliano, «fottere è meglio di comandare». Nella prima parte del film forza visualizzando, in
maniera anche stridente, il suo mondo interiore, con l’inserimento di
visioni oniriche (apparizioni di fantasmi, la visualizzazione della sua stessa morte). In questo ambito il regista mostra un rispetto per la materia che gli impedisce sia di prendersi eccessive libertà con la
storia (si pensi per contrasto al finale di Buongiorno, notte) sia di capovolgere l’assunto di partenza del progetto come aveva fatto in
passato, fosse esso il film di genere (Sbatti il mostro in prima pagina) o un libro di successo (Fai bei sogni). Al rispetto per il tema si contrappone l’inerzia rappresentata dalle
forme visive e narrative del mafia movie contemporaneo, specie nella
versione proposta dalla serialità italiana e straniera (da Romanzo criminale a Narcos), repertorio di immagini contro cui l’autore deve battersi. In scene come quelle della strage di Capaci, girata
dall’intemo dell’automobile, si avverte che il problema di Bellocchio è
anche come dire qualcosa di nuovo: oggi il problema del mafia movie è l’opposto della denuncia, è la lotta contro immagini ricevute e
pesanti. La sfida del regista trova infine il centro nelle scene del processo e appunto nelle rielaborazioni di un repertorio di immagini:
Va'pensiero di Verdi che commenta la sentenza, le riprese dei monitor con le celle di mafiosi alternati al discorso della vedova
Schifani (topos della rappresentazione cinetelevisiva di Cosa Nostra),
e soprattutto la trasformazione del maxiprocesso in una specie di «teatro dei nervi» sopra le righe, grazie anche alla prova magistrale di 4 Fabrizio Ferracane nei panni di Pippo Calò .
Più di altri registi, dunque, Bellocchio sente l’esigenza di confrontarsi con il racconto di Cosa Nostra non solo in maniera
storicamente precisa e scrupolosa, ma tenendo conto che essa è già un
prodotto «semilavorato» dai media, e che confrontarsi con essa vuol dire interrogarsi sugli spazi del cinema, e del cinema d’autore in
particolare. Lo fa sfidando la quality tv sul suo terreno, per poi cercare uno scarto estetico, e la creazione di un anti-eroe tragico, che
scorre accanto alla Storia e alle sue immagini come un garante di senso.
2. La società dello spettacolo.
Ovviamente, durante la stesura di questo libro, era impossibile immaginarsi il punto d’arrivo cronologico. In un fenomeno in
costante evoluzione, con film e serie sempre in cantiere, qualunque finale sarebbe stato arbitrario. Per puro caso, però, un film uscito
qualche mese prima che il volume fosse dato alle stampe ha offerto la conclusione forse più congrua, certo più desolata.
Nell’ultimo lavoro di Franco Maresco, La mafia non è più quella di
una volta, vincitore del premio speciale della giuria alla Mostra di Venezia 2019, alcune tendenze che abbiamo individuato nell’analisi
del mafia movie contemporaneo e nella funzione sociale
dell’antimafia, appaiono esposte in maniera chiara, e sottoposte a una critica tanto definitiva da superare i limiti dell’argomento per farsi amara considerazione sui destini dell’Italia, e del ruolo del cinema. Il film è in pratica un incrocio tra i due lavori precedenti del
regista, Belluscone e La mia Battaglia. Dal primo preleva Ciccio Mira, l’impresario di cantanti di piazza imbevuto di cultura mafiosa, e lo mette a confronto con la coraggiosa fotografa e militante antimafia al
centro del documentario del 2018. Lei, pur sconvolta dalle celebrazioni per il venticinquennale della strage di Capaci,
trasformate in gigantesca sagra, e dall’indifferenza del popolo palermitano verso la memoria di Falcone e Borsellino, rivendica la speranza. Maresco, disilluso e sarcastico, le racconta una storia
parallela: quella di Mira che, fiutando il vento che tira, organizza allo Zen una serata canora di «Neomelodici per Falcone e Borsellino».
Perché ormai gridare «la mafia fa schifo» non richiede coraggio, e Cosa Nostra anzi asseconda un’antimafia mediatica e di facciata.
L’impresario è in fondo una versione cialtrona e simpatica dei creatori di fiction tv su giudici e boss, ma appartiene a un mondo scomparso
(lo si vede sempre in bianco e nero, come in Belluscone), e rimane guardingo: sarà poi vero che ormai si può dire tutto senza che «loro»
si arrabbino? L’organizzazione della festa canora procede tra mille intoppi e scivola, come il precedente Ritorno di Cagliostro, verso la follia e il nulla: una quieta, amara apocalisse. Mira scompare, il suo
produttore Matteo Mannino diventa pazzo, e il film finisce con
un’altra festa di piazza, stavolta in onore del presidente Mattarella, in
una piazza deserta dello Zen, mentre risuona una versione techno dell’inno nazionale. Maresco, in maniera radicale, lega la critica delle immagini a una
visione di svuotamento di senso, di follia. Se Bellocchio, volgendosi al passato, cerca scampoli di tragedia nei destini dei mafiosi, Maresco (unico regista italiano che negli ultimi trent’anni abbia ambientato un
film sulla mafia ai giorni nostri) lo utilizza come rabbiosa visione dell’insensatezza di ogni impegno, di ogni discorso, di ogni pratica artistica in un mondo in cui impegno e farsa si equivalgono. La forma
del suo film è espressione, vittima perfino, di questa prospettiva: esploso, rapsodico, senza centro. Il racconto svaria, ricomincia e
divaga, forse senza nemmeno cercare un senso nel caos; fa ridere e mette implacabilmente a disagio, con un percorso in apparenza
documentario, ma in cui è impossibile capire cosa è vero e cosa è
inventato. Il pessimismo di Maresco non riguarda solo la politica ma l’antropologia del nostro paese e del nostro tempo: partendo dalla cronaca, arriva a una nerissima visione del mondo e della storia. Cosa Nostra, che nel cinema e nella televisione contemporanei sembra il
luogo perfetto di una narrazione conclusa e riconoscibile (con i suoi
personaggi, le sue stazioni obbligate, le sue immagini topiche) si ribalta nel proprio contrario. Non qualcosa di lineare, ma il perfetto
simbolo dell’assenza di bussole storiche e morali; non qualcosa di già risto da rinarrare, ma qualcosa che rende vano il racconto.
Maresco conferma la sua scelta radicale: in una società delle immagini, un film sulla mafia è anzitutto una critica delle immagini.
E il ruolo di un film su Cosa Nostra si amplia, diventa esempio di una critica a ogni retorica celebrativa e a ogni facile apologia della
comunicazione, delle immagini, a ogni ideologia delle narrazioni. La
mossa preliminare del film, creare un finto documentario in cui lo spettatore deve chiedersi continuamente chiedersi cosa è vero e cosa è
falso (e forse alla fine rinunciare a darsi una risposta), si accompagna a una precisa messa in scena del regista stesso, continuamente contraddetto dall’antagonista femminile, che afferma nonostante
tutto le ragioni dell’impegno. Maresco si mette in discussione, rivendicando la propria alterità dal sistema delle immagini, e insieme
ammettendo l’inanità dei propri sforzi. Come ha dichiarato il regista stesso all’uscita del film: È un film abbastanza nichilista, una versione molto per i poveri della
Società dello spettacolo di Guy Debord, un mondo dove tutto si è azzerato. È
un film su una tragedia in corso, la mafia, di cui non si parla più, se non nelle fiction: nella più felice delle ipotesi (ti prego di cogliere l’ironia) l’antimafia ha il volto di Pif. L’idea, insomma, è che tutto si può fare, tutto è allo stesso livello: le fiction, le cerimonie istituzionali, i neomelodici. Nel film precedente,
Belluscone, raccontavo i giovani sottoproletari che intendevano la parola «carabiniere» come un insulto. Oggi non c’è nemmeno più questo problema. E non perché sia penetrata chissà quale cultura della legalità. I ragazzi ti rispondono: «Mi piacerebbe fare il killer, ma se non posso, anche il carabiniere va bene». Tanto sono comunque eroi da fiction, di un super-Blob5.
1 Cit in Dino, La mafia devota dt, p. 75. 2
Falcone - Padovani, Cose di Cosa Nostra dt, p. 83. 3 Si vedano, come esempi di questo stile, i numeri che appaiono accanto agli omicidi a mo’
di contatore, le scene di pestaggio con Historia de un amor in sottofondo, e lo stesso finale
che conclude un flashback visto in precedenza, accentuandone la carica simbolica. 4 Più in generale, il casting e la direzione degli attori si pongono anch’essi il problema di un difficile equilibrio tra modelli logori, imitarione della realtà e scarto dal realismo: Luigi Lo
Casdo nei panni di Contorno apre una sorta di «linea comica», mentre Pierfrancesco Favino interpreta Buscetta in maniera iper-mimetica, con un dialetto fra i più credibili che si siano visti sullo schermo (meno la pronuncia dell’italiano con cadenze dialettali).
Intervista di E. Normale, «I mieifilm non servono a niente. Solo alle mie neurosi», in
«la Repubblica», 10 settembre 2019.
Cronologia dei film italiani sulla mafia
1949
In nome della legge (Pietro Germi)
1950
Gli inesorabili (Camillo Mastrocinque)
Turi il bandito (Enzo Trapani) I fuorilegge (Aldo Vergano)
1959
Vento del Sud (Enzo Provenzale) I mafiosi (Roberto Mauri)
1961
L’onorata società (Riccardo Pazzaglia)
Salvatore Giuliano (Francesco Rosi)
Morte di un bandito (Giuseppe Amato) 1962
Mafioso (Alberto Lattuada) Un uomo da bruciare (Valentino Orsini - Paolo e Vittorio Taviani)
1963
I due mafiosi (Giorgio C. SimoneDi)
La moglie degli altri è sempre più bella (1 ep.) (Marino Girolami) 1964
Se permetette parliamo di donne (1 ep.) (Ettore Scola)
19Ó5
Tre notti d’amore (ep. La vedova (Renato Castellani)
Io uccido... tu uccidi (1 ep.) (Gianni Puccini) 1966
La legge della mafia (Mario Bianchi) Amore all’italiana (1 ep.) (Steno)
19^7
A ciascuno il suo (Elio Petri)
Gente d’onore (Folco Lulli)
Le streghe (ep. La siciliana) (Franco Rossi) 1968
Il giorno della civetta (Damiano Damiani) A suon di lupara (Luigi Petrini)
Meglio vedova (Duccio Tessati) 19Ó9
Gli intoccabili (Giuliano Montaldo)
1970
E venne il giorno dei limoni neri (Camillo Bazzoni) Bocche cucite (Pino Tosini)
Il sasso in bocca (Giuseppe Ferrara) La sposa più bella (Damiano Damiani)
1971
Confessione di un commissario di polizia al procuratore della repubblica (Damiano
Damiani) Cose di Cosa Nostra (Steno)
1972
La mala ordina (Fernando Di Leo) Abuso di potere (Camillo Bazzoni) Afyon Oppio (Ferdinando Baldi) I parenti delle vittime non saranno avvertiti (Alberto De Martino)
La violenza: quinto potere (Florestano Vancini)
Il caso Pisdotta (Eriprando Visconti)
L’amico del Padrino (Frank Agrama) La mano lunga del Padrino (Nardo Bonomi)
Il caso Mattei (Francesco Rosi) Joe Petrosino (Daniele D’Anza) (tv)
1973
L’onorata famiglia: uccidere è Cosa Nostra (Tonino Ricd) Tony Arzenta (Duccio Tessati)
Servo suo (Romano Scavolini) Lucky Luciano (Francesco Rosi)
Il boss (Fernando Di Leo) Gli amid degli amid hanno saputo (Fulvio Marcolin)
Baciamo le mani (Vittorio Schiraldi)
Il figliocdo del padrino (Mariano Laurenti) Il consiglieri (Alberto De Martino) La mano nera - Prima della mafia... più della mafia! (Antonio Radoppi) L’altra faccia del padrino (Franco Prosperi)
La padana (Giuseppe Vari)
Mimi metallurgico ferito nell’onore (Lina Wertmuller) Un tipo con una faccia strana ti cerca per ucciderti (Tullio Demicheli)
Sessomatto (1 ep.) (Dino Risi) Scacco alla mafia (Lorenzo Sabatini)
1974
Crazy Joe (Cario Lizzani) Quelli che contano (Andrea Bianchi) La mafia mi fa un baffo (Riccardo Garrone)
1975
Perché si uedde un magistrato (Damiano Damiani) L’ammazzatina (Ignazio Dolce)
Gente di rispetto (Luigi Zampa) Lo sgarbo (Marino Girolami)
197Ó
Cadaveri eccellenti (Francesco Rosi) Alle origini della mafia (Enzo Muzii) (tv)
1977
Il prefetto di ferro (Pasquale Squitieri)
Canne mozze (Mario Imperioli) 1978
Corleone (Pasquale Squitieri)
Quando i piedotti sgarrano (Romolo Cappadonia)
1979
Un uomo in ginocchio (Damiano Damiani) Da Corleone a Brooklyn (Umberto Lenzi) H delitto Notarbartolo (Alberto Negrin) (tv)
1980
L’avvertimento (Damiano Damiani)
1981
Il cappotto di legno (Gianni Manera)
1984
Cento giorni a Palermo (Giuseppe Ferrara) Western di Cose Nostre (Pino Passalacqua) (Tv)
La piovra (Damiano Damiani) (Tv) 1985
Pizza connection (Damiano Damiani) Il pentito (Pasquale Squitieri)
1986
Il cugino americano (Giacomo Battiate) (tv) La piovra 2 (Florestano Vancini) (tv)
1987
La piovra 3 (Luigi Perelli) (tv)
1989
Mery per sempre (Marco Risi)
La piovra 4 (Luigi Perelli) (tv)
1990
Il sole buio (Damiano Damiani)
Dimenticare Palermo (Francesco Rosi) La piovra 5- Il cuore del problema (Luigi Perelli) (tv)
Donna d’onore (Stuart Margolin) (tv) Ragazzi fuori (Marco Risi) 1991
Johnny Stecchino (Roberto Benigni)
1992
La piovra 6 - L’ultimo segreto (Luigi Perelli) (tv)
Vite perdute (Giorgio Castellani) 1993
La scorta (Ricky Tognazzi)
Giovanni Falcone (Giuseppe Ferrara) Un uomo di rispetto (Damiano Damiani) (tv) Il lungo silenzio (Margarethe von Trotta) 1994
Il giudice ragazzino (Alkessandro Di Robilant) Concetta Licata (Mario Salieri)
1995
Lo zio di Brooklyn (Daniele Cipri e Franco Maresco)
Diario senza date (Roberto Andò) Un eroe borghese (Michele Pladdo) Palermo-Milano sola andata (Claudio Fragasso)
Concetta Licata 2 (Mario Salieri)
Non parlo più (Vittorio Nevano) (tv) La piovra 7 - Indagine sulla morte del commissario Cattaui (Luigi Perelli) (tv) 1997
Testimone a rischio (Pasquale Pozzessere)
Tano da morire (Roberta Torre) Nessuno escluso (Massimo Spano) (tv) Concetta Licata 3 (Mario Salieri)
I Grimaldi (Giorgio Castellani)
La piovra 8 - Lo scandalo (Giacomo Battiate) (tv)
1998
Totò che visse due volte (Daniele Cipri e Franco Maresco) Vite blindate (Alessandro Di Robilant) La piovra 9 - Il patto (Giacomo Battiate) (tv*) La figlia del padrino (Joe D’Amato)
Ultimo (Stefano Reali) (tv) Una sola debole voce (Alberto Sironi) (tv)
Ultimo- la sfida (Michele Soavi) (ti7) 1999
Operazione Odissea di Claudio Fragasso (tv) I giudici (Ricky Tognazzi)
2000 I cento passi (Marco Tullio Giordana) Pladdo Rizzotto (Pasquale Sdmeca)
Prime lud dell’alba (Ludo Caudino)
L’impero (Lamberto Bava) (tv)
Operazione Odissea (Claudio Fragasso) (tv)
2001
Donne di mafia (Giuseppe Ferrara) (tv)
L’attentatuni (Claudio Bonivento) (tv)
Brancacao (Gianfranco Albano) (tv) 2002
I banchieri di Dio (Giuseppe Ferrara)
Angela (Roberta Torre) La piovra 10 (Luigi Perelli) (tv)
2003 Segreti di Stato (Paolo Benvenuti) Il ritorno di Cagliostro (Daniele Cipri e Franco Maresco) Gli indesiderabili (Pasquale Sdmeca) Gli angeli di Borsellino (Rocco Cesareo) Blindati (Claudio Fragasso) (tv, 2 puntate)
2004
Paolo Borsellino (Gianluca Maria Tavarelli) (tv) Le conseguenze dell’amore (Paolo Sorrentino)
2005 Alla luce del sole (Roberto Faenza) 2000 Joe Petrosino (Alfredo Peyretti) (tv) A voce alta (Vincenzo Verdecchi) (tv)
L’onore e il rispetto (Salvatore Samperi) (tv)
Giovanni Falcone - L’uomo che sfidò Cosa Nostra (Andrea e Antonio Frazzi) (tv) 2007
Il dolce e l’amaro (Andrea Porporati) La siciliana ribelle (Marco Amenta)
L’ultimo dei Corleonesi (Alberto Negrin) (tv)
Il capo dei capi (Enzo Monteleone, Alexis Sweet) (tv) H generale Dalla Chiesa (Giorgio Capitani) (tv) 2008
H divo (Paolo Sorrentino) L’ultimo padrino (Marco Risi) (tv)
Baciamo le mani (Eros Pughelli) (tv)
La vita rubata (Graziano Diana) (tv)
2009
Baarìa (Giuseppe Tomatore)
La matassa (Giambattista Avellino- Salvo Ficarra- Valentino Picone) Squadra antimafia (Aa.Vv.) (tv)
L’onore e il rispetto 2 (Salvatore Samperi e Luigi Parisi) (tv) 2010
Squadra antimafia (AaJVv.) (tv), stagione 2
2011
Squadra antimafia (Aa.Vv.) (tv), stagione 3
Il segreto dell’acqua (Renato De Maria) (tv)
2012
Cesare Mori - Il prefetto di ferro (Gianni Lepre) (tv) Squadra antimafia (Aa.Vv.) (tv), stagione 4
L’onore e il rispetto 3 (Luigi Parisi e Alessio Intimi) (tv)
Paolo Borsellino -157 giorni (Alberto Negrin) (tv) 2013
La mafia uccide solo d’estate (Pierfrancesco Diliberto)
Salvo (Fabio Grassadonia e Antonio Piazza) Squadra antimafia (Aa.Vv.) (tv), stagione 5
2014
La trattativa (Sabina Guzzanti) Belluscone- Una storia siciliana (Franco Maresco) Squadra antimafia (Aa.Vv.) (tv), stagione 6
2015
Lo scambio (Salvo Cuccia)
H bambino di vetro (Federico Crudani)
Era d’estate (Fiorella Infascili) Squadra antimafia (Aa.W.) (tv), stagione 7
L’onore e il rispetto 4 (Luigi Parisi e Alessio Intimi) (tv)
2016
In guerra per amore (Pierfrancesco Diliberto) Boris Giuliano (tv) Squadra antimafia (Aa.Vv.) (tv), stagione 8
Romanzo siciliano (Ludo Pellegrini) (tv)
La mafia uccide solo d’estate - la serie (Luca Ribuoli) (tv)
2017
Sicilian Ghost Story (Fabio Grassadonia e Antonio Piazza) L’onore e il rispetto 5 (Luigi Parisi e Alessio Intimi) (tv) Maltese- il romanzo del commissario (Gianluca Maria Tavarelli) (tv) Rosy Abate- la serie (Beniamino Catena) (tv)
2018
Prima che la notte (Daniele Vicari) (tv) Rocco Chinnid - È così lieve il bado sulla tua fronte (Michele Soavi) (tv) La mafia uccide solo d’estate 2 (Luca Ribuoli) (ti7)
Il cacciatore (Stefano Lodovichi, Davide Marengo) (tv) A testa alta - Libero Grassi (Graziano Diana) (ti7)
Delitto di mafia - Mario Francese (Michele Alhaique) (ti-) La scorta di Borsellino - Emanuela Loi (Stefano Mordini) (tv) I topi (Antonio Albanese) (ti7)
2019
Il traditore (Marco Bellocchio) La mafia non è più quella di una volta (Franco Maresco) Rosy Abate 2 (Giacomo Martelli) (ti7)



![La mafia devota. Chiesa, religione, Cosa Nostra [2 ed.]
8842092312, 9788842092315](https://dokumen.pub/img/200x200/la-mafia-devota-chiesa-religione-cosa-nostra-2nbsped-8842092312-9788842092315.jpg)