Che cosa sa fare l'Italia. La nostra economia dopo la grande crisi [4 ed.] 8858126777, 9788858126776
L'economia del nostro paese sembra avere smarrito la capacità di accrescere reddito ed efficienza produttiva. Perch
393 110 2MB
Italian Pages 230 [241] Year 2017
Polecaj historie
Citation preview
Ultimi volumi pubblicati in questa collana
34
JOCELYN MACLURE - CHARLES TAYLOR LA SCOMMESSA DEL LAICO
35
WENDY BROWN STATI MURATI, SOVRANITÀ IN DECLINO
36
BERNARDO SECCHI LA CITTÀ DEI RICCHI E LA CITTÀ DEI POVERI
37
KAUSHIK BASU OLTRE LA MANO INVISIBILE Ripensare l’economia per una società giusta
38
ULRICH BECK EUROPA TEDESCA La nuova geografia del potere
39
PIERO CALAMANDREI NON C’È LIBERTÀ SENZA LEGALITÀ
40
MAURIZIO FRANZINI DISUGUAGLIANZE INACCETTABILI L’immobilità economica in Italia
41 IGNAZIO MASULLI CHI HA CAMBIATO IL MONDO? La ristrutturazione tardocapitalista. 1970-2012 42
JÜRGEN HABERMAS NELLA SPIRALE TECNOCRATICA Un’arringa per la solidarietà europea
43
MARIANA MAZZUCATO LO STATO INNOVATORE Sfatare il mito del pubblico contro il privato
44
COLIN CROUCH QUANTO CAPITALISMO PUÒ SOPPORTARE LA SOCIETÀ
45
WILLIAM EASTERLY LA TIRANNIA DEGLI ESPERTI Economisti, dittatori e diritti negati dei poveri
46
DANI RODRIK LA GLOBALIZZAZIONE INTELLIGENTE
47 JAN ZIELONKA DISINTEGRAZIONE Come salvare l’Europa dall’Unione europea 48
GAETANO AZZARITI CONTRO IL REVISIONISMO COSTITUZIONALE
49
MAURIZIO FERRERA ROTTA DI COLLISIONE Euro contro welfare?
50
VALERIO CASTRONOVO L’EUROPA E LA RINASCITA DEI NAZIONALISMI
ANNA GIUNTA SALVATORE ROSSI Che cosa sa fare l’Italia
LA NOSTRA ECONOMIA DOPO LA GRANDE CRISI
Editori Laterza
© 2017, Gius. Laterza & Figli www.laterza.it Progetto grafico di Raffaella Ottaviani Prima edizione gennaio 2017
1 2017
2018
2
2019
3 2020
4 2021
Edizione 5 6 Anno 2022
Proprietà letteraria riservata Gius. Laterza & Figli Spa, Bari-Roma Questo libro è stampato su carta amica delle foreste Stampato da SEDIT - Bari (Italy) per conto della Gius. Laterza & Figli Spa ISBN 978-88-581-2677-6 È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico. Per la legge italiana la fotocopia è lecita solo per uso personale purché non danneggi l’autore. Quindi ogni fotocopia che eviti l’acquisto di un libro è illecita e minaccia la sopravvivenza di un modo di trasmettere la conoscenza. Chi fotocopia un libro, chi mette a disposizione i mezzi per fotocopiare, chi comunque favorisce questa pratica commette un furto e opera ai danni della cultura.
INDICE DEL VOLUME
Prologo Ringraziamenti, p. ix I. L’importanza del saper fare per una nazione 1. Chi genera la ricchezza nazionale, p. 3 - 2. Un contro-esempio: l’Italia non è la Grecia, p. 6 - Note, p. 15
vii
3
II. Come è cambiata l’economia italiana nel tempo 1. Miracoli e cadute dell’economia italiana nella storia moderna, p. 16 - 2. Le imprese manifatturiere italiane: un dramma in tre atti, p. 29 - Note, p. 47
16
III. Che cosa si produce e a chi si vende 1. Manifattura o servizi? Una domanda ormai irrilevante, p. 50 - 2. I settori produttivi delle grandi imprese, p. 61 3. La competizione internazionale, p. 68 - Note, p. 90
50
IV. Come si produce 1. La dominanza delle imprese “familiari”, p. 93 - 2. Il difetto di produttività, p. 104 - 3. Il difetto di innovazione, ricerca e sviluppo, p. 120 - Note, p. 133
93
VI
Indice del volume
V. Tre casi, per esempio 1. Ah, se ci fosse la finanza giusta!, p. 136 - 2. Per crescere mi vendo a metà, p. 141 - 3. “Al comando occorre essere in un numero dispari minore di tre”, p. 144
136
VI. I “fattori abilitanti” 1. Ordinamento giuridico, legalità, efficienza, p. 150 - 2. L’istruzione, p. 159 - Note, p. 166
149
VII. La finanza 1. La struttura finanziaria delle imprese e del paese, p. 169 - 2. Le banche, p. 179 - Note, p. 205
168
Epilogo 206 1. La vecchia ipotesi del “declino”, p. 206 - 2. Conferme di una diagnosi nota, p. 209 - 3. Il “grande golfo”, p. 211 - 4. Chi sta in mezzo. Le catene globali del valore, p. 213 - 5. Lo standard mancante, p. 215 - 6. Far leva sull’Europa? No, p. 217 - 7. Che fare, dunque, p. 220 - Note, p. 226
Indice dei nomi
227
PROLOGO
Questo libro racconta la storia recente delle cose che l’Italia sa fare, dei prodotti che ogni anno sa mettere insieme, delle imprese che a quella ricchezza concorrono. È importante raccontare questa storia? Certamente sì. Perché un popolo, un paese, è in larga parte ciò che sa fare. Gli italiani, in alcuni periodi aurei della loro storia, prima di unirsi in uno Stato nazionale, ma anche in tempi non così remoti, hanno saputo eccellere, in paragone ai popoli coevi. Oggi il confronto è meno favorevole, il genius loci si è appannato: vale la pena di capire come è potuto accadere, se e in quali modi si può rimediare. “Fare cose” vuol dire inventare e realizzare valore. A produrre questo valore possono essere delle imprese in concorrenza su un libero mercato; oppure un apparato pubblico; o un’organizzazione privata di volontari; o, ancora, un padre o una madre che si prendono cura della propria famiglia. Lo Stato, gli enti pubblici locali, le economie domestiche, le Onlus sono politicamente e socialmente rilevanti: è tuttavia fuori discussione che, in un’economia di mercato, il grosso della produzione nazionale origina dalle imprese. È qui che risiede la motivazione di queste pagine: nella scelta di concentrarsi sull’offerta produttiva del paese e sulle sue protagoniste, le imprese, guardando in faccia gli anni
VIII
Prologo
terribili della grande crisi che è divampata in tutto il mondo dopo il 2008 e che ha colpito gravemente le economie più fragili, come quella italiana. Terremo nella dovuta considerazione il nostro passato remoto per approdare al presente. Ci addentreremo nelle trasformazioni del nostro apparato produttivo nell’ultimo quarto di secolo, gettando luce sugli aspetti che lo caratterizzano: la dimensione, la ricerca e sviluppo, la produttività, la competitività sui mercati internazionali, gli assetti organizzativi. Analizzeremo, poi, tre casi singoli, paradigmatici della congiuntura presente del sistema delle nostre imprese medio-piccole da cui dovrebbe venire lo scatto di reni che può portarci fuori dalle secche. Esamineremo, successivamente, ciò che sta intorno alle imprese, i “fattori abilitanti” che potrebbero metterle finalmente in condizione di elevare lo standard produttivo del nostro paese. Ne identificheremo tre, come fondamentali: l’ambiente giuridico (ordinamento, legalità, tutela della concorrenza, efficienza delle amministrazioni pubbliche); il sistema di istruzione; la finanza, che è, insieme, fattore abilitante nonché parte del sistema produttivo stesso. Proveremo anche ad offrire alcune indicazioni per le politiche pubbliche. Nell’Epilogo tireremo le fila della nostra analisi, nel tentativo di disegnare scenari plausibili per l’economia italiana, per il suo “saper fare”, basandosi sull’analisi di quello che è accaduto finora. Non ci proietteremo nel futuro. Nessuno sa veramente che cosa riservi il futuro, al mondo intero e all’Italia. Che cosa riservi, in particolare, al produrre cose, al “fare” delle nazioni. Parliamo di quel futuro che non è già scritto nell’applicazione di tecnologie già esistenti ma che discenderà da tecnologie al momento neanche concepibili. Esso è nascosto dietro un sipario imperscrutabile. Un’ultima annotazione. Senza mai perdere di vista il rigore dell’analisi economica, la storia che ci apprestiamo a raccontare ambisce ad essere comprensibile da molti. Il nostro desiderio è
Prologo
IX
di attrarre una vasta platea di lettori non specialistici nelle maglie della comprensione di ciò che da vicino riguarda e interessa tutti noi: l’economia del nostro paese, il suo destino. RINGRAZIAMENTI Abbiamo un grande debito di riconoscenza verso molti per incoraggiamenti, aiuti, commenti e suggerimenti. Della Banca d’Italia ci hanno aiutato: Ugo Albertazzi, Monica Amici, Paolo Angelini, Carmelo Barbagallo, Emmanuele Bobbio, Rita Cappariello, Luisa Carpinelli, Marco Chiurato, Emanuela Ciapanna, Fabrizio Colonna, Alessio De Vincenzo, Silvia Fabiani, Stefano Federico, Alberto Felettigh, Silvia Giacomelli, Alfredo Gigliobianco, Federico Giorgi, Giorgio Gobbi, Matteo Gomellini, Andrea Linarello, Francesca Lotti, Maurizio Lozzi, Marco Magnani, Silvia Magri, Francesco Palazzo, Giuliana Palumbo, Francesco Piersante, Paola Rossi, Stefano Siviero, Roberto Torrini, Francesco Zollino. Un ringraziamento speciale va a Matteo Bugamelli che ha letto l’intera bozza. Infine, per la paziente assistenza editoriale ringraziamo Alba Guidi e Paola Tomei. Gli imprenditori Giovanni Anzani, Mariarita Costanza, Nicola Lavenuta, Michele e Daniela Vinci ci hanno accolto generosamente nei loro stabilimenti, hanno discusso con noi e ci hanno infine consentito di raccontare la storia delle loro aziende. A loro pure va la nostra riconoscenza. Ringraziamo Marianna Mantuano per l’attenta lettura. E ancora. Grazie a: Elena Granaglia, Stefano Costa, Livio Romano. Un ringraziamento particolare va a Gino Ventriglia. Gli autori restano i soli responsabili dei contenuti del volume. Gli eventuali proventi a titolo di diritto di autore saranno devoluti all’organizzazione Save the Children. Anna Giunta Salvatore Rossi
CHE COSA SA FARE L’ITALIA La nostra economia dopo la grande crisi
Avvertenza
In questo libro sono state utilizzate, a volte con adattamenti e integrazioni, a
volte verbatim, parti di discorsi pubblici tenuti da Salvatore Rossi negli ultimi anni, i cui testi originari sono tutti reperibili sul sito www.bancaditalia.it. Si tratta in particolare di: Artigiani o scienziati? Capitale umano e crescita economica, intervento al IX Simposio Internazionale dei Docenti Universitari in Roma, 21 giugno 2012; Liberalizzazioni in Italia: un processo infinito?, intervento alla presentazione del Laboratorio sulle Liberalizzazioni LabLib presso la Luiss Guido Carli, 15 maggio 2013; Finanza e crescita dopo la crisi, intervento tenuto presso la CommunityCib della Sda Bocconi di Milano, 14 novembre 2013; Alle radici dello sviluppo: demografia, istituzioni, politica, V Lezione Onorato Castellino, Moncalieri, 29 novembre 2013; Stato, mercato, sviluppo, lezione magistrale in occasione della consegna del Premio Donato Menichella in Roma, 5 febbraio 2014; Una finanza per lo sviluppo, conferenza presso la Banca Popolare di Sondrio, 12 settembre 2014; L’innovazione nelle imprese italiane, lezione tenuta presso la Fondazione Einaudi Onlus a Torino, 15 ottobre 2014; Costruire il domani dell’economia italiana, intervento all’inaugurazione dell’anno accademico 2014-2015 dell’Università di Udine, 15 gennaio 2015; Conoscenza, innovazione, rilancio dell’economia, lezione magistrale all’Almo Collegio Borromeo di Pavia, 17 marzo 2015; Istruzione, legalità, sviluppo economico, lezione magistrale presso la Lumsa nella Sede di Palermo, 29 aprile 2015; L’Unione Bancaria nel processo di integrazione europea, intervento presso la Cuoa Business School di Altavilla Vicentina, 7 aprile 2016.
capitolo primo
L’IMPORTANZA DEL SAPER FARE PER UNA NAZIONE
1. CHI GENERA LA RICCHEZZA NAZIONALE
A generare il grosso della ricchezza nazionale sono le imprese. Questa affermazione apparentemente apodittica ha bisogno tuttavia di importanti qualificazioni. Innanzitutto, stiamo escludendo di trovarci in una economia socialista, ovvero “di comando”. In una tale economia non vi sarebbero imprese, ma organizzazioni produttive (fabbriche, uffici) poste sotto il diretto comando dell’autorità politica centrale. Inoltre, alcuni beni tangibili o servizi a cui viene comunemente attribuito un valore – anche se non necessariamente monetario – vengono prodotti dal lavoro volontario o all’interno della famiglia. Ma essendo assai difficilmente misurabili, essi trovano poco posto nelle statistiche ufficiali sulla produzione. Ora, in una economia “di mercato”, quale è l’Italia e quali sono tutti i paesi con cui essa si confronta, è una molteplicità di imprese a essere al centro del sistema produttivo. La proprietà di alcune di queste imprese può anche non essere privata, ma pubblica, in tutto o in una parte preponderante: in Italia è il caso dell’Eni, dell’Enel, di Poste italiane. Ma ciò che conta è
4
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
che esse siano organizzate come un’impresa e operino in un mercato almeno in parte concorrenziale. Ciò che intendiamo per impresa sarà detto più precisamente nel prosieguo, qui importa per il momento dire che la dimensione di un’impresa può andare dal gigantismo di una multinazionale al nanismo di una impresa monocellulare; in quest’ultima categoria ricadono molti artigiani o professionisti (medici, avvocati, ecc.). E lo Stato? Il settore pubblico (Stato ed enti locali) produce molti servizi per la cittadinanza, alcuni essenziali per la vita civile e presenti in ogni paese, come la difesa, l’ordine pubblico, la giustizia. Servizi che sarebbe molto difficile immaginare forniti da imprese private, in concorrenza fra loro, con l’impegno e l’equità necessari. Altri, come la sanità e l’istruzione, per i quali le ragioni per ritenere indispensabile un’offerta pubblica sono meno cogenti e più discutibili. Tuttavia, si tratta in ogni caso di valori che accrescono la ricchezza nazionale. Infatti, nella contabilità di tutti i paesi che usano gli standard statistici dell’Onu il prodotto della nazione include i servizi pubblici. Ma vi sono due importanti considerazioni da fare. La prima è questa. I servizi pubblici non hanno un prezzo determinato dal libero incontrarsi di domanda e offerta, sono erogati ai cittadini di fatto obbligatoriamente; anche quando un cittadino può acquistare, in alternativa a quelli pubblici, dei servizi offerti privatamente sul mercato – da una clinica, da una scuola, da una guardia giurata – sarà comunque obbligato a pagare i corrispondenti servizi pubblici che non sta usando, con le imposte; ciò, in molti casi, lo scoraggerà dal ricorrere all’alternativa privata. Il valore che, in assenza di un prezzo di mercato, viene convenzionalmente attribuito ai servizi pubblici nei conti nazionali, così contribuendo a formare il Prodotto interno lordo (Pil) nominale totale, è semplicemente pari a quanto essi vengono a costare, quindi coincide prevalentemente con
capitolo primo L’importanza del saper fare per una nazione
5
la somma degli stipendi degli impiegati pubblici. È evidente come questa misura sia estremamente aleatoria e renda particolarmente incerti i confronti internazionali. S’immagini un paese fortemente burocratizzato, con pubbliche amministrazioni ipertrofiche e invadenti, con un ceto politico incline a favorire i dipendenti pubblici, sia nella numerosità sia nelle retribuzioni, per motivi di raccolta del consenso e per collusioni con sindacati del pubblico impiego corporativi e aggressivi. Ebbene, un tal paese si ritrova conteggiati nel suo Pil servizi pubblici con un valore, basato sui costi, che è probabilmente il doppio o il triplo di quello effettivo, cioè di quello che i cittadini sarebbero disposti a pagare se fossero liberi di scegliere quei servizi su un mercato concorrenziale senza doverli pagare due volte, perché il fornitore pubblico inefficiente andrà comunque finanziato con le imposte. Talvolta quei cosiddetti servizi hanno addirittura un valore effettivo negativo, nel senso che, lungi dal fornire ai cittadini un servizio utile, impongono loro balzelli o ostacoli alla libera attività economica che sono totalmente immotivati secondo corretti principi di interesse pubblico, giustificati solo dal potere che conferiscono a chi li maneggia. Essi impediscono alla parte sana dell’economia di sviluppare tutto il suo potenziale produttivo, dunque deprimono il Pil, lungi dall’aumentarlo. Il Pil, in un paese così, è chiaramente sopravvalutato. Naturalmente non bisogna generalizzare. In paesi come la Germania o i paesi scandinavi i servizi pubblici possono valere molto, forse addirittura più della somma conteggiata nel Pil. Anche in Italia, ad esempio, l’istruzione pubblica che viene impartita in molte scuole e università ha probabilmente un valore almeno pari a quello dell’istruzione fornita dai migliori istituti privati del paese; la stessa sanità pubblica possiamo pensare che accresca in media il benessere in Italia più
6
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
di quanto faccia la sanità privata negli Usa, pur con una forte dispersione di risultati nelle diverse aree territoriali. L’ideale sarebbe poter eliminare soltanto l’elemento di rendita improduttiva presente, in misura diversa, nel settore pubblico di tutti i paesi. Ma lo stato attuale delle statistiche non ce lo consente, almeno non facilmente. È un buon filone di ricerca per il futuro. La seconda considerazione è che i servizi pubblici non cadono come manna dal cielo, sono pagati con le imposte prelevate ai cittadini-produttori. Il settore pubblico agisce da intermediario: sottrae risorse al settore privato, che quest’ultimo altrimenti userebbe per consumare o per investire, e gli fornisce in cambio servizi pubblici. La loro indispensabilità, insostituibilità e qualità devono essere tali da almeno compensare la sottrazione di reddito operata attraverso le imposte. Dunque ci sembra ampiamente giustificata l’enfasi che porremo in questo libro sulle imprese operanti sul mercato come motore primo della ricchezza nazionale. 2. UN CONTRO-ESEMPIO: L’ITALIA NON È LA GRECIA
Il sistema delle imprese di una nazione è importante perché il benessere materiale dell’intera popolazione coincide con i frutti dell’impegno delle persone che fanno parte di quel sistema. Per illustrare questo punto ricorreremo a un contro-esempio. Nella prima metà del 2015, per mesi e mesi, tutto il mondo è rimasto col fiato sospeso per le sorti della Grecia e del suo dissidio con il resto dell’Unione europea. Nel momento in cui scriviamo (novembre del 2016) la Grecia è quasi scomparsa dai radar dei media internazionali, ma tutti ancora ricordiamo
capitolo primo L’importanza del saper fare per una nazione
7
il clamore davvero mondiale della vicenda, l’angoscia, i timori di contagio e di sfascio dell’Unione che taluni nutrivano. Perché tirare in ballo proprio la Grecia in un libro dedicato al sistema produttivo italiano? Che cosa c’entra la Grecia con l’Italia? Vorremmo forse sostenere che l’Italia correva o corre lo stesso rischio fronteggiato allora dalla Grecia? No, al contrario. Ciò su cui vogliamo attrarre l’attenzione è che gli osservatori, gli analisti di tutto il mondo giravano attorno al problema greco sviscerandone ogni aspetto, politico, macroeconomico, finanziario, monetario, ma si occupavano poco di un aspetto che era invece centrale e spiegava tutto: l’inadeguatezza del sistema produttivo greco. Una inadeguatezza cronica, storica, addirittura aggravata – come vedremo – dall’ingresso nel mercato comune europeo, poi nascosta dalla bonanza dei debiti consentiti dallo scudo dell’euro. In questo senso, per l’Italia la Grecia è un vero contro-esempio. Proprio perché il nostro paese dispone di un sistema produttivo più robusto e sofisticato di quello greco, come il resto di questo libro proverà a mostrare. Peraltro, il contro-esempio serve anche a far suonare dei campanelli d’allarme. Vedremo come l’Italia (ma anche la Spagna, fra i maggiori paesi europei) presenti alcune caratteristiche che la distanziano dai casi tedesco e francese, i due paesi guida dell’Eurozona, proprio in termini di sistema produttivo e di politiche atte a influenzarne le prestazioni. Non certo al punto da farci assomigliare alla Grecia, sia chiaro. Ma comunque impedendoci di annoverarci del tutto nella serie superiore. È su queste caratteristiche che il discorso pubblico dovrebbe incentrarsi in Italia, per capire come correggerle. Per capire a fondo il caso greco è necessaria un po’ di storia.
8
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Prima data: 28 maggio 1979, Atene Il governo greco firma il trattato di adesione alle Comunità europee, come al tempo si chiamava quella che oggi è l’Unione europea. Quattro giorni prima il Consiglio delle Comunità aveva approvato l’adesione, dopo un negoziato durato poco meno di tre anni. La Grecia entra effettivamente a far parte del club europeo il 1º gennaio del 1981. È il secondo “allargamento” della costruzione europea rispetto alla compagine dei sei paesi fondatori, dopo quello che nel 1973 aveva incluso la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito. Perché far entrare la Grecia prima di paesi come la Spagna o il Portogallo o l’Austria? Per ragioni squisitamente politiche e geostrategiche. La Grecia uscita dalla seconda guerra mondiale è una terra di confine fra l’Est del socialismo reale e l’Ovest dell’alleanza atlantica, con un sistema politico fragile. Nel 1967 un colpo di Stato militare l’assoggetta alla “dittatura dei colonnelli”, un regime dichiaratamente anti-comunista, quindi anti-sovietico, che abolisce con la forza le libertà civili e politiche. Nel 1974 viene ristabilita la democrazia formale e abrogata la monarchia. L’Occidente vuole, da un lato, premiare il ritorno alla democrazia della Grecia, dall’altro seguitare a mantenere il paese fuori dell’influenza sovietica anche in assenza del tallone dittatoriale. Nasce così l’idea di avviare un negoziato di adesione alla Comunità economica europea, per dare al popolo greco una prospettiva di prosperità e stimolare in lui attrazione per l’Occidente. Analogo negoziato di adesione all’Europa si avvierà poco più tardi con la Spagna e il Portogallo, dopo la fine dei rispettivi regimi dittatoriali di stampo fascista. A favore della precedenza accordata alla Grecia gioca certamente il tempo lievemente anticipato della transizione alla democrazia, con in più la preoccupazione geopolitica suscitata dalla stessa collo-
capitolo primo L’importanza del saper fare per una nazione
9
cazione di quel paese sulle mappe, ai bordi meridionali della Cortina di ferro. Ma la Comunità economica europea è, appunto, economica, non è un’alleanza militare. Ha senso associarvi la Grecia, come si decise in quella storica giornata di trentasette anni fa? Senso economico? Se guardiamo alla struttura dell’economia greca, cioè alla composizione e ai risultati del suo sistema produttivo, e la mettiamo a confronto con quella dei paesi che a quel tempo facevano già parte della Comunità, più di un dubbio è lecito. L’opinione che la Commissione europea rilascia nel gennaio del 1976 nel suo Bollettino riguardo alla domanda di piena adesione avanzata dal governo greco riflette molti di questi dubbi: l’economia greca è ancora sostanzialmente agricola, la base industriale è debole, il settore dei servizi è dominato da quelli pubblici o comunque sostanzialmente sottratti al libero mercato. Tuttavia, se crediamo alle statistiche ufficiali, nel 1980, l’anno precedente l’entrata in vigore dell’adesione, la Grecia produce beni e servizi il cui valore, ai prezzi e ai tassi di cambio del momento, è di 6.500 dollari per abitante, un livello pari alla metà di quello tedesco e francese, ma non poi tanto più basso degli 8.400 dollari dell’Italia, addirittura superiore ai 6.200 dollari della Spagna. Al netto dei servizi pubblici, sulla base di stime assai approssimative, il prodotto pro capite della Grecia si riduce nell’intorno dei 5.500 dollari, quello tedesco e francese a poco meno di 12.000, quello italiano a circa 8.000, quello spagnolo a poco meno di 6.000. Le distanze dunque aumentano, data l’ipertrofia del settore pubblico greco, ma con l’Italia e la Spagna restano contenute: un terzo in meno dell’Italia, solo di poco sotto la Spagna. Ciò che è davvero stupefacente è quel che succede dopo
10
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
l’adesione. Entrare nel mercato unico europeo fa all’economia greca l’effetto di una secchiata d’acqua gelata che, anziché fortificarla, le fa prendere la polmonite. Il prodotto pro capite ristagna per un quindicennio dopo l’ingresso nella Comunità, mentre quello degli altri paesi che già vi appartengono, e soprattutto di quelli che via via entrano, aumenta molto1. Il sistema produttivo greco, esposto alla più intensa concorrenza del mercato comune europeo, anziché trarne stimolo per accrescere la sua competitività strutturale – organizzazione e livello tecnologico delle imprese, qualità e varietà dei prodotti –, subisce erosioni di quote di mercato; ricerca illusorie compensazioni in ripetute svalutazioni della dracma che si risolvono solo in fiammate inflazionistiche. Anziché prodursi una fruttuosa convergenza col resto d’Europa, si allarga la divergenza. Seconda data: 19 giugno 2000, Bruxelles Il Consiglio europeo delibera di consentire alla Grecia l’ingresso nel più ristretto club dell’area dell’euro. Per essere ammessi occorre superare una serie di esami di convergenza monetaria e finanziaria con le altre economie dell’area: inflazione, tassi d’interesse e di cambio, bilancio pubblico. Anni dopo si dirà che i dati erano stati artatamente falsificati dal governo greco del tempo per rientrare nei limiti di ammissione, ma tralasciamo questo aspetto. Quel che importa è che l’adozione dell’euro come moneta nazionale, formalmente a partire dal 1º gennaio 2001, abbatte negli anni successivi in Grecia l’inflazione e i tassi di interesse, regalando al governo una molto più comoda possibilità di indebitarsi, sia con i propri stessi cittadini sia con creditori di altri paesi, facilmente e a costi bassi. Con le risorse ottenute in prestito si può aumentare la spesa pubblica e mantenere bassa l’imposizione fiscale, in altri termini si può consentire ai propri cittadini di innalzare il proprio tenore di vita al di là di quanto sarebbe consentito dalla loro autonoma
capitolo primo L’importanza del saper fare per una nazione
11
capacità di produrre reddito. La polmonite resta, ma la si cura con il Prozac anziché con l’antibiotico. Terza data: 13 luglio 2015, Bruxelles Dopo mesi e mesi di tira e molla il governo greco, sostenuto da un’anomala coalizione di forze di estrema sinistra ed estrema destra, si piega alle condizioni imposte dal Consiglio dei primi ministri dell’Eurozona perché sia rinnovato e rafforzato il programma di prestiti, da parte degli Stati dell’area e degli organismi internazionali, che consente alla Grecia di restare parte dell’Eurozona. Il consesso dei paesi creditori propone a sua volta questo accordo, anziché tentare la strada, per quanto legalmente ardua, di forzare un’uscita della Grecia dall’Eurozona, per ragioni in cui taluni osservatori di nuovo intravedono preoccupazioni geopolitiche, tali da trascendere i ragionamenti tecnici economico-finanziari. L’accordo giunge come l’ultima tappa di un percorso accidentato iniziato nel 2010, allorché si scopre che il governo greco del tempo ha (di nuovo!) grossolanamente falsificato i dati sul proprio bilancio pubblico per non incorrere nelle procedure di infrazione previste dai trattati europei. Quella scoperta ha estese e gravi ripercussioni in tutta Europa, innescando la “crisi dei debiti sovrani”: l’acquisita consapevolezza da parte dei mercati e degli investitori internazionali che l’euro possa non essere un monolite perenne, come sempre affermato ufficialmente, ma possano staccarsene dei pezzi, ha portato per un lungo periodo a ridurre prudenzialmente la valutazione dei titoli pubblici (emessi, cioè, da “sovrani”) dei paesi percepiti come finanziariamente più deboli: la Grecia innanzitutto, ma anche la Spagna, il Portogallo, l’Italia. Il germe del dubbio sulla irreversibilità dell’euro si è poi attenuato, ma non è più scomparso del tutto. Non ripercorreremo le vicende e il contrasto di opinioni riguardo alla crisi del 2015: torti e ragioni dei contendenti,
12
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
il ruolo delle banche tedesche e francesi, il dibattito sul senso storico e sui destini dell’Unione europea. Quel che rileva rammentare qui è che durante l’aspro confronto si sono levate a un certo punto voci autorevoli, anche da parte di insigni economisti americani, a indicare la necessità per la Grecia di abbandonare l’euro e tornare a una moneta nazionale svalutabile a piacere, in modo da dare sollievo competitivo all’esausto sistema produttivo greco. Queste opinioni soffrono innanzitutto di una grave sottovalutazione delle conseguenze devastanti di un cambio di segno monetario in una economia d’oggi. Non esiste niente di vagamente somigliante a una “uscita ordinata” dall’euro: la complessità tecnologica del sistema finanziario e contabile di una economia moderna è tale da richiedere molti mesi per portare a termine un cambio di moneta; un lungo tempo durante il quale l’incertezza sul valore futuro dei propri risparmi divora ogni singolo cittadino e disgrega l’economia e la società, portandole indietro di decenni. Il sistema bancario e dei pagamenti è per un paese come il sistema circolatorio per un organismo umano: se lo si paralizza per più di qualche giorno il paese/organismo deperisce e muore. Quel che è successo in Grecia nel giugno-luglio del 2015, con le code ai bancomat, le importazioni bloccate dalla impossibilità tecnica di pagarle, le imprese paralizzate, ne è stato un piccolo trailer. Con buona pace di certe anime belle che vivono in un mondo di favole e pensano che banche e finanza siano un fungo velenoso da estirpare, anziché le arterie e le vene che tengono in vita l’economia cosiddetta reale. Ma invocare per la Grecia il sollievo di un tasso di cambio svalutabile è sbagliato anche per un’altra ragione, più di fondo. La Grecia non dispone di un sistema produttivo evoluto e strutturalmente competitivo. Non l’ha mai avuto, continua a non averlo. Prima dell’adozione dell’euro, negli anni Ottanta
capitolo primo L’importanza del saper fare per una nazione
13
e Novanta, allorché tanti paesi europei coglievano i benefici dell’appartenenza al grande mercato comune, la Grecia non era in grado di coglierli nonostante la valvola di sfogo delle svalutazioni. Non c’è ragione di pensare che ne sarebbe capace oggi: nulla di fondamentale pare essere mutato nel funzionamento di quella società. Per valutare il grado di modernità, o evoluzione, o sofisticazione – chiamiamola come vogliamo – del sistema produttivo greco possiamo fare ricorso a un confronto di composizione con i principali paesi europei, utilizzando criteri di classificazione e dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e della Commissione europea. Purtroppo non possiamo farlo sinteticamente per l’intero settore produttivo, ma dobbiamo tenere distinta l’industria manifatturiera dai servizi, a causa della persistenza, nelle statistiche internazionali e nazionali, di questa distinzione. La manifattura (dati Eurostat sul 2010) pesa in Grecia per l’8% del prodotto totale, contro l’11 della Francia, il 13 della Spagna, il 16 dell’Italia, il 22 della Germania; di questo già magro settore i prodotti a bassa tecnologia occupano quasi la metà, contro il 37% della Spagna, il 33 dell’Italia, il 30 della Francia e il 18 della Germania. Nella grande galassia dei servizi, i cosiddetti Knowledge Intensive Business Services (Kibs), cioè servizi per il mercato ad alta intensità di conoscenza, sono solo il 24% in Grecia, il 33 in Spagna, il 36 in Italia, il 42 in Francia e in Germania. Questi dati illustrano con chiarezza la classifica dei paesi europei per robustezza dell’apparato produttivo. In questa classifica l’ultimo posto, con distacco, della Grecia è un fatto acquisito e costante nel tempo: risalendo indietro coi dati finché possibile si osserva una desolante persistenza del fenomeno. Che cosa scambia con il resto del mondo l’economia greca? Nel 2013, ultimo anno per il quale sono disponibili dati
14
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Eurostat completi, la Grecia esportava beni e servizi per 56 miliardi di euro, ne importava per 58; vendeva all’estero, prevalentemente: servizi di trasporto marittimo (i famosi armatori greci), per 12 miliardi; servizi di accoglienza turistica, per altri 12 miliardi; prodotti agricoli e dell’industria alimentare (olive e olio d’oliva, yoghurt e formaggi, pesci), per 5 miliardi. Le esportazioni servivano a pagare importazioni di una gran varietà di prodotti necessari o desiderati dai cittadini ma che il sistema produttivo greco non offriva e non offre, come materie prime ed energetiche, medicinali, computer e altre apparecchiature elettroniche e digitali. Parte importante del petrolio grezzo importato viene lavorato in raffinerie locali (una lavorazione in sé con scarso valore aggiunto) e riesportato in forma di benzina e altri prodotti raffinati, ma è quasi una partita di giro dal punto di vista della bilancia dei pagamenti. Tornando all’indicatore riassuntivo per eccellenza dei risultati economici di una nazione, il prodotto pro capite, le distanze fra la Grecia e gli altri paesi europei sono oggi tutte accresciute rispetto all’inizio della sua avventura europea, trentasette anni fa, soprattutto quando misurate al netto dei servizi pubblici, il cui valore si è in Grecia ulteriormente gonfiato nel corso di questi anni: il prodotto “privato” pro capite greco è solo poco più di metà di quello italiano, meno di metà di quello francese, inferiore del 60% a quello tedesco; rispetto alla Spagna, a cui era quasi appaiata un quarto di secolo fa, la Grecia è ormai indietro di un terzo. Il caso della Grecia, in sé piccolo per le dimensioni di quella economia ma esemplare per le vicissitudini che l’hanno portato in primo piano sulla stampa internazionale per molti mesi, dimostra con lampante evidenza quanto in una nazione ciò che davvero conta è quel che vi si sa fare. Se una nazione sa sviluppare conoscenza, esprimere idee, coltivare il coraggio imprenditoriale, produrre beni e servizi scambiabili con
capitolo primo L’importanza del saper fare per una nazione
15
successo col resto del mondo, che arricchiscano e facciano evolvere la società, tutto il resto viene da sé: la domanda aggregata fiorisce insieme con i redditi dei lavoratori, le banche sono sane, il bilancio pubblico può riequilibrarsi, i creditori internazionali dormono sonni tranquilli. Si tratta di una verità elementare che i macroeconomisti tendono a volte ad accantonare, presi come sono dall’analisi della dinamica della domanda aggregata: consumi, investimenti. Questioni di grande importanza, intendiamoci, soprattutto in tempi di recessione, allorché la domanda rallenta o si contrae per circoli viziosi innescati da una caduta generalizzata della fiducia e occorre allora supplire con le leve della politica economica per evitare spirali depressive. Ma nel medio-lungo periodo la microeconomia si prende la sua rivincita. È una lezione preziosa, quella che viene dal caso greco, per il nostro paese. Ed è la ragione per cui studiare il sistema produttivo italiano è cruciale, soprattutto in questa fase storica. NOTE 1 N.F. Campos, F. Coricelli, L. Moretti, Economic Growth and Political Integration: Estimating the Benefits from Membership in the European Union Using the Synthetic Counterfactuals Method, in «CEPR Discussion Papers», 9968, 2014.
capitolo secondo
COME È CAMBIATA L’ECONOMIA ITALIANA NEL TEMPO
1. MIRACOLI E CADUTE DELL’ECONOMIA ITALIANA NELLA STORIA MODERNA
Il territorio italiano ha messo in scena nel corso dei secoli episodi alternati di sviluppo e declino della sua economia. Nel Rinascimento l’Italia era la punta di eccellenza della capacità produttiva e del benessere nel mondo. Tre secoli dopo, nella prima metà dell’Ottocento, la penisola era povera e arretrata secondo ogni parametro e confronto. Sul finire del XIX secolo l’unità politica del paese innescò un processo di amalgama istituzionale e di parziale integrazione. Dopo avere stentato ad avanzare per tre decenni, sfociò nel quindicennio “d’oro” 1898-1913, in cui si avviò l’industrializzazione del paese: l’industria divenne, pur tardivamente rispetto a paesi più avanzati come l’Inghilterra, il piccolo motore pulsante di un sistema produttivo ancora quasi del tutto agricolo e statico. Le energie sprigionate in quegli anni permisero all’Italia di colmare parte del divario rispetto ai paesi-guida1. Mezzo secolo più tardi, quello che fu chiamato il “miracolo economico” del secondo dopoguerra diede un secondo potente impulso alla rincorsa italiana nei confronti del mondo avanzato.
capitolo secondo Come è cambiata l’economia italiana nel tempo
17
Alimentata dall’improvviso spalancarsi dei mercati di esportazione (il fenomeno noto come globalizzazione) e dall’irrompere di nuove tecnologie (in particolare quelle dell’informazione e della comunicazione, Ict nell’acronimo inglese) foriere di efficienza, vent’anni fa, alla fine del secolo XX, ci saremmo aspettati una terza fase di propulsione dello sviluppo. Invece, iniziava allora un lungo periodo di crescita stentata, di ristagno, di affanno competitivo e produttivo, che sarebbe stato poi approfondito dalla lunga recessione economica seguita alla crisi finanziaria globale del 2007-2008. Mettere a confronto questi tre episodi – due successi e una delusione – può servire a capire l’oggi, a discernere i rischi e le opportunità del domani. Useremo per questo confronto una duplice chiave interpretativa: quella della demografia, primo fattore dinamico di una società; quella delle istituzioni, che forgiano la fibra della società. La “belle époque” Nel quindicennio 1898-1913 il tasso medio annuo di crescita del Prodotto interno lordo per abitante fu dell’1,7%, più che raddoppiato rispetto ai decenni precedenti. Di più: tra la fine del XIX secolo e la prima guerra mondiale, l’Italia, sotto la guida di Giovanni Giolitti, attraversò una profonda trasformazione demografica, istituzionale, politica, quindi economica2. Sotto il profilo demografico, fu quello il periodo clou dell’emigrazione dal nostro paese. Tra il 1901 e il 1913 lasciarono l’Italia oltre 8 milioni di uomini, donne e bambini. Al netto dei rimpatri, l’emigrazione di quel periodo equivalse a oltre il 15% della popolazione residente alla vigilia della prima guerra mondiale, con un forte effetto di attenuazione di una pressione demografica che stava diventando intensa. Si stima che senza quelle migrazioni il Pil pro capite italiano nel 1910 sarebbe stato, a seconda di varie possibili ipotesi sul funzionamento del
18
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
mercato del lavoro e sugli usi delle rimesse, tra il 2,4 e il 5,6% più basso del suo livello effettivo. I 700.000 giovani uomini uccisi durante la Grande Guerra avrebbero poi dato un altro tragico colpo di freno alla pressione demografica3. Cambiarono in quel torno di tempo le istituzioni della società e della politica. Nel 1902 fu fissata a dodici anni l’età minima per il lavoro industriale, a quindici quella per il lavoro notturno; si vietò il lavoro di donne e bambini nelle miniere; si limitò a un massimo di dodici ore il lavoro femminile e di undici ore quello dei minori di sedici anni. Si decretò in tal modo l’uscita da un costume di schiavismo infantile che la coscienza sociale si accorgeva di giudicare intollerabile. Tra il 1904 e il 1911 venne innalzata a 12 anni l’età dell’obbligo scolare e fu profondamente rivisto, ampliandolo, il ruolo dello Stato centrale nel finanziamento del sistema scolastico. Nei primi vent’anni del secolo scorso il tasso di analfabetismo si dimezzò. Nel 1912 venne esteso il diritto di voto a tutti i cittadini maschi, dando così rappresentanza politica a vaste masse popolari fino a quel momento escluse. S’iniziò a riconoscere il diritto di sciopero. La distribuzione personale del reddito mostrò qualche segno di attenuazione delle enormi sperequazioni che l’avevano fino ad allora caratterizzata4. L’economia compì un balzo in avanti. Fra i tanti indicatori quantitativi utili a illustrare il progresso compiuto ne scegliamo uno dal forte valore simbolico. Nel 1913 la produzione nazionale di locomotive giunse a coprire due terzi della domanda interna, mostrando una sofisticazione tecnica paragonabile, quando non superiore, a quella che potevano vantare i prodotti dei paesi di più antica industrializzazione5. La locomotiva era il simbolo del progresso tecnico dell’epoca; come stava per diventare l’automobile; come sarebbe diventato il computer. Proprio ai trasporti era stata dedicata
capitolo secondo Come è cambiata l’economia italiana nel tempo
19
l’esposizione internazionale di Milano del 1906, l’antenata del moderno Expo, lo stesso anno in cui fu ufficialmente inaugurato il traforo del Sempione. Il paradigma tecnologico generale e dominante che si andava allora affermando nel mondo avanzato era però l’elettricità. Fu un mutamento talmente pervasivo che per vedere scalzata la supremazia del paradigma elettrico il mondo dovette poi attendere gli anni Novanta del secolo scorso, allorché un nuovo paradigma, centrato sulle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, sancì il proprio dominio, a tutt’oggi incontrastato. In un paese quasi del tutto privo di combustibili fossili, s’impose così all’attenzione il problema dell’energia. Diverse componenti della società, coordinate dalla politica, lavorarono insieme per produrre una esemplare storia di successo, il sistema idroelettrico italiano, che garantì oltre metà dell’approvvigionamento di elettricità fino agli anni Sessanta del Novecento. Il Parlamento e il governo produssero leggi chiare e semplici sulla derivazione delle acque e sul passaggio degli elettrodotti; il sistema educativo creò nuovi corsi per ingegneri e tecnici; le banche e la borsa convogliarono il risparmio alle imprese, le quali realizzarono impianti produttivi e reti di distribuzione all’avanguardia nel mondo. Fu la modernizzazione dell’industria il perno dell’accelerazione di un secolo fa. Si diffuse la meccanizzazione, aumentò la scala produttiva delle aziende, s’intensificò l’utilizzo nei processi produttivi dell’energia e del capitale. L’industria ricevette un forte impulso anche dalle esternalità positive scaturite dalla sua nuova dimensione urbana. Nel quindicennio 1898-1913 il prodotto complessivo aumentò in media del 2,5% all’anno, la produttività del lavoro dell’1,6, con guadagni concentrati soprattutto nell’industria. La produttività totale dei fattori – una misura che approssima
20
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
il progresso tecnico e organizzativo – iniziò a segnare anch’essa tassi di crescita positivi, dello 0,7% all’anno, anche se fu l’accumulazione di capitale fisico il principale motore della crescita6. Dall’Italietta all’Italia La storia fu in parte diversa negli anni del “miracolo economico”, in cui la pur straordinaria vicenda dell’Italietta giolittiana fu surclassata. La demografia giocò ancora un ruolo importante. Riprese l’emigrazione all’estero: dal 1948 al 1973 lasciarono l’Italia 7 milioni di persone; il flusso fu, in proporzione alla popolazione residente, decisamente meno intenso di quello al volgere del secolo: poco più di 5‰ abitanti l’anno, contro 18 nel periodo prima discusso. Stavolta vi si unì un vistoso fenomeno di migrazione interna, da Sud a Nord. La struttura dell’occupazione mutò radicalmente: l’Italia perse definitivamente la sua connotazione di paese contadino, la quota degli addetti agricoli crollò dal 44 al 16%, a vantaggio dell’industria ma anche del settore terziario, che divenne da allora predominante nell’economia italiana. La produttività del lavoro salì sia nell’agricoltura, sia nell’industria: l’abbondante forza-lavoro a bassa specializzazione e a basso costo proveniente dalle campagne, specie meridionali, era particolarmente adatta al modello fordista di produzione ormai diffuso nelle fabbriche italiane, concentrate al Nord. Tra il 1951 e il 1973 il prodotto pro capite aumentò in media ogni anno di oltre il 5%, la produttività del lavoro di quasi il 6. Sono i migliori risultati di sempre nella storia postunitaria del nostro paese. Stavolta a sospingere la crescita fu la dinamica della produttività totale dei fattori, più che l’accumulazione dei fattori produttivi: con un aumento medio annuo del 3,3%, la prima spiega oltre metà della crescita del prodotto italiano
capitolo secondo Come è cambiata l’economia italiana nel tempo
21
in quei fatidici ventidue anni, l’età dell’oro dello sviluppo economico del secolo scorso, in Italia e in Europa7. I guadagni di efficienza derivanti dal progresso tecnico e organizzativo scaturirono soprattutto dallo sfruttamento delle economie di scala e dall’adattamento di tecnologie in larga parte importate dagli Stati Uniti. Un tale processo storico in due stadi – dapprima dotarsi di capitale e lavoro adatti e sufficienti a far decollare lo sviluppo, poi puntare sugli incrementi di efficienza dei fattori produttivi – lo si ritrova in molte altre economie avanzate. In Italia, negli anni del “miracolo” si stabilì anche una proficua interazione tra l’importazione di conoscenza tecnologica dai paesi in cui essa si formava e la capacità di tradurla in innovazioni domestiche, a beneficio della produttività. L’assetto istituzionale interno e internazionale emerso dalla guerra fu particolarmente propizio al catching-up della nostra economia, cioè a quel processo di inseguimento e di progressivo avvicinamento ai paesi più avanzati che è tipico di quelli in ritardo di sviluppo in cui si riesce a innescare un circolo virtuoso di crescita. L’apertura al commercio internazionale, sancita in particolare dall’adesione al Mercato europeo comune nel 1957, spalancava i mercati esteri a un’industria manifatturiera favorita dai bassi salari. L’adesione al sistema monetario internazionale detto di Bretton Woods (dal nome della località americana in cui fu firmato l’accordo), istituito subito dopo la guerra dalle potenze vincitrici e basato sullo standard del dollaro statunitense, avvenne a una parità fra la lira e il dollaro che favoriva la competitività dei produttori nazionali e il trasferimento di risorse dai settori più tradizionali verso quelli che producevano beni esportabili nel resto del mondo8. L’isolamento del più forte partito comunista occidentale, fino alla fine degli anni Sessanta, frenava le rivendicazioni operaie.
22
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
La stagnazione degli ultimi vent’anni Negli ultimi vent’anni, invece, il Prodotto interno lordo per abitante è cresciuto di meno di mezzo punto percentuale l’anno, un tasso che supera di poco l’1% se anche si esclude l’ultimo lungo periodo di recessione. È venuto soprattutto a mancare il contributo del progresso tecnologico. Il tasso medio annuo di crescita della produttività totale dei fattori, rimasto superiore a un punto percentuale negli anni Novanta, è sceso allo 0,3% nel periodo 2000-2007, fino a divenire negativo durante la crisi recente (-0,8%). Sono evidenze note, su cui si dibatte da anni. Una linea interpretativa da tempo avanzata le fa risalire al mancato adeguamento della nostra struttura produttiva ai radicali cambiamenti intervenuti nel mondo. Fra le due ultime recessioni – quelle del 1992-1993 e del 2008-2014 – è successo qualcosa di fondamentale intorno alla nostra economia: è cambiata la tecnologia dominante nel mondo, facendo accelerare la globalizzazione dei mercati; inoltre, è stato creato l’euro. Il cambio di paradigma tecnologico avvenuto negli anni Novanta, dall’elettricità alle Ict, a cui prima si accennava, fu colto dai sistemi di produzione di molti paesi come l’occasione di un salto di efficienza e di internazionalizzazione. Non così il nostro sistema, se non in parte e tardivamente. Gran parte del sistema produttivo italiano ha reagito con lentezza all’opportunità di sfruttare le nuove tecnologie per accrescere l’efficienza; non ha subito compreso che l’assuefazione alle continue svalutazioni della lira tipiche degli anni Settanta e Ottanta, dai guadagni competitivi temporanei ma dalle conseguenze inflazionistiche durature, doveva venir meno e che occorreva rafforzare strutturalmente la capacità competitiva. Come mai? Perché il nostro sistema di imprese ereditava dal suo pas-
capitolo secondo Come è cambiata l’economia italiana nel tempo
23
sato prossimo talune caratteristiche − di diffusione di modelli di proprietà e gestione familiari, di dimensione mediamente piccola, di renitenza alla crescita anche in presenza di concrete occasioni di espansione − che lo rendevano inadatto al mondo nuovo. Quelle caratteristiche non si erano formate per caso: per dirla in termini evoluzionistici, erano il risultato di un retaggio culturale familistico, ma anche di mutazioni genetiche indotte nei due decenni precedenti dalla necessità di adattarsi a un habitat trasformato. Un habitat sociale divenuto ostile all’impresa e all’economia di mercato, in cui sopravviveva meglio chi si faceva e restava piccolo, chi meglio metteva al riparo il patrimonio di famiglia. Una reazione che aveva consentito a molte imprese di sopravvivere, unita agli effimeri ma reiterati benefici delle svalutazioni valutarie. L’Italia è, tra i principali paesi europei, quello dove il divario di produttività tra imprese piccole e medio-grandi è più ampio. Le imprese nascono piccole ovunque, ma poi o muoiono o crescono in fretta. In Italia, se non muoiono, quasi sempre restano indefinitamente nel limbo della piccola dimensione. In un mondo nuovo, di tecnologie che richiedono la grande dimensione per esplicare tutto il loro potenziale di generazione di efficienza, di mercati enormi e lontani che richiedono anch’essi la grande dimensione per consentire accessi e presenze stabili, quello star nascosti negli interstizi di un ambiente domestico ritenuto infido si è trasformato in un freno al nuovo adattamento richiesto alle nostre imprese dall’ambiente circostante. Le tendenze demografiche dell’ultimo ventennio, dal canto loro, ci hanno aiutati a mantenere l’esistente, non hanno costituito uno stimolo propulsivo. Sappiamo di essere una società che invecchia. Secondo le proiezioni dell’Istat, il rapporto tra la popolazione di 65 e più anni di età e quella tra i 15 e i 64 anni raggiungerà il 55% nel
24
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
2040, dal 31 del 2011; nell’Unione europea solo la Germania avrà un indice di dipendenza degli anziani più alto di quello italiano. Il tempo dedicato al lavoro nel ciclo di vita è anche radicalmente mutato. Si inizia a lavorare più tardi: l’età media d’inizio della vita lavorativa era di 16 anni per i nati prima del 1925, è stata di 20 per i nati negli anni Settanta. Si smette prima: il tasso effettivo medio di pensionamento degli uomini è diminuito da 65 anni nel 1970 a meno di 60 alla metà degli anni Novanta, anche se è recentemente risalito a quasi 61. Tuttavia, la quota di occupati tra coloro che hanno, statisticamente, altri 20 anni di vita davanti a sé è scesa drammaticamente, dal 78% del 1980 al 25 del 2009, grazie all’aumento della speranza di vita. Alla riduzione delle forze di lavoro attive abbiamo sopperito con l’immigrazione. Gli immigrati sono oggi il 7,5% della popolazione residente; secondo le proiezioni – che assumono costanza dei fenomeni globali e delle legislazioni nazionali – ne rappresenteranno oltre un sesto nel 2040. Le evidenze empiriche disponibili sembrano finora indicare una prevalente complementarità tra forze di lavoro italiane e straniere, almeno nelle fasce più istruite. Essa emerge particolarmente per le donne: la presenza straniera attenua i vincoli familiari alla partecipazione delle donne italiane al mercato del lavoro. L’immigrazione in Italia, comunque ancora minore di quella osservata negli altri principali paesi, ci ha aiutati a mantenere la scala delle nostre produzioni, rimediando alla mancanza di manodopera nazionale in posizioni vitali dell’industria e dei servizi, ma si è caratterizzata per un livello di istruzione più basso di quello dei migranti verso gli altri principali paesi. Alla difficoltà di attrarre manodopera straniera dotata di qualifiche elevate si somma la partenza dall’Italia di molti gio-
capitolo secondo Come è cambiata l’economia italiana nel tempo
25
vani con livelli alti di istruzione. Nonostante le difficoltà di misurazione del fenomeno, è viva la preoccupazione per l’apparente incapacità italiana di ben utilizzare il capitale umano che, pur con difficoltà, riesce a creare. Nel frattempo il tema è divenuto caldissimo in tutti i paesi avanzati; è entrato di prepotenza fra le questioni più dibattute dai politici, per la sua rilevanza negli equilibri sociali. Questo non aiuta a ragionarne in termini di costi e benefici, men che meno in un paese come l’Italia. Se la demografia non ci ha aiutati, la debolezza delle istituzioni ha pesato come un macigno. Gli enzimi della crescita di un’economia sono diversi a seconda della fase di sviluppo e del contesto esterno. Intendiamo il capitale fisico, quello umano, la capacità di innovare, l’organizzazione dei mercati, il grado di concorrenza, le norme, le istituzioni; in ultima analisi, la cultura. Questa mutevolezza è particolarmente rilevante per le economie in fase di catching-up, in cui cambia progressivamente la struttura stessa dell’economia e i fattori che sospingono la crescita possono volgersi in fattori d’instabilità; nell’Italia dei primi anni Sessanta il livello comparativamente basso dei salari divenne insostenibile allorché, con il boom economico, cambiò il modello dei consumi. I cambiamenti generali richiesti ai sistemi economici devono essere più intensi quando intervengono mutamenti radicali nello scenario mondiale, come nei passati vent’anni di globalizzazione dei mercati e di affermazione delle Ict quale tratto costitutivo del funzionamento dell’economia. Disboscare le rendite monopolistiche, le clientele, le corporazioni che da sempre frenano – pur non sempre impedendo – la crescita della nostra economia è oggi la precondizione per non scivolare tutti all’indietro nei livelli di benessere. Gli obiettivi da cogliere sono sempre gli stessi: piena concorrenza in tutti i
26
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
mercati; servizi pubblici essenziali di qualità; amministrazioni pubbliche snelle e incentivate a porsi al servizio dei cittadini anziché di se stesse e dei propri referenti; soprattutto, rispetto dei contratti, leggi chiare e fatte osservare con decisione e celerità. Esamineremo brevemente questi temi alla fine del libro. Ora esaminiamo l’epilogo, fino a oggi, del confronto fra i tre episodi storici che abbiamo appena tratteggiato. La Guerra dei Sette Anni A metà del passato decennio avevamo iniziato a osservare i segni di una positiva evoluzione di alcune parti del nostro sistema produttivo. Non poche aziende medie si ponevano un problema di aggiornamento tecnologico, d’internazionalizzazione, di crescita. La crisi finanziaria mondiale che ci ha investiti nel 2008-2009 ha inferto un duro colpo a quel processo. L’economia italiana si è ritrovata nel 2015, primo anno di ripresa (una recentissima revisione dei dati effettuata dall’Istat qualifica il 2014 come già non più di recessione, ma ai fini di questo libro conserveremo la periodizzazione consueta), come dopo una guerra. Non una guerra del passato, per nostra fortuna, di quelle con spargimenti di sangue e distruzioni. Ma una di queste guerre moderne, virtuali, in cui capannoni, uffici, posti di lavoro possono vaporizzarsi con il click di un mouse. Rispetto a sette anni prima producevamo quasi un decimo in meno. Nell’industria la contrazione era del 17%, nelle costruzioni di oltre il 30. Si stima che l’apparato manifatturiero abbia visto scomparire in quegli anni un sesto della sua capacità produttiva. La distruzione netta di posti di lavoro è stata di quasi un milione. Il complesso delle imprese italiane ha investito nel 2014 un terzo in meno che sette anni prima. Le famiglie, considerate anch’esse nel loro insieme, hanno speso,
capitolo secondo Come è cambiata l’economia italiana nel tempo
27
in termini reali, l’8% in meno. Le esportazioni sono a stento rimaste costanti. I sette anni di crisi hanno raddoppiato la disoccupazione ed eroso il Pil pro capite di 11 punti percentuali. Ma i nostri problemi sono di più antica data: nel 2008, alla vigilia della crisi, la quantità di beni e servizi prodotta mediamente da un occupato italiano era sostanzialmente la stessa del 1995. Altri paesi, sull’onda del cambio dell’avvento del paradigma tecnologico delle Ict, avevano visto la loro produttività compiere dei veri e propri balzi. La pur forte crescita dell’occupazione che vi era stata in Italia in quegli anni, favorita dall’introduzione di forme d’impiego più flessibili, non era stata sufficiente a controbilanciare il ristagno della produttività nel sostenere il reddito disponibile delle famiglie. All’avvio della crisi quest’ultimo era uguale, per la famiglia media, a quello della metà degli anni Novanta e solo la progressiva compressione del saggio di risparmio aveva consentito di accrescere un po’ i consumi. L’indebolirsi della capacità di creare reddito prefigura un arretramento delle condizioni di vita, rispetto sia al nostro stesso passato sia ai principali attori mondiali. La preoccupazione è ancor più viva se si tiene conto che fra quarant’anni il rapporto tra le persone in età da lavoro (20-69) e gli anziani inattivi si sarà dimezzato, da 4 a 2. Anche il solo mantenimento degli standard di vita pro capite attuali richiederebbe un aumento della produttività del lavoro del 25%. Questi danni inferti all’economia italiana dalla crisi finanziaria globale del 2007-2008, poi dalla crisi europea dei debiti sovrani del 2010-2011, in assoluto ingenti, sono stati anche molto maggiori di quelli subiti dagli altri principali paesi avanzati. Notiamo subito però che i dati aggregati nascondono forti disomogeneità. Sia fra le imprese sia fra le famiglie è aumen-
28
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
tata la diseguaglianza (per le imprese torneremo più volte su questo importante fenomeno). Ad esempio, la caduta dei consumi nei sette anni, vista nell’aggregato, è stata anomala rispetto ad altre fasi cicliche negative del passato. Normalmente ci si aspetta che durante una recessione i consumatori cerchino di mantenere il tenore di vita a dispetto di una riduzione del loro reddito disponibile, perché la giudicano temporanea. Stavolta è successo il contrario: si è tirata la cinghia più che proporzionalmente alla caduta del reddito. Questa è stata quindi intesa come permanente, anzi, in aggravamento permanente, sicché si è pensato bene di aumentare il risparmio precauzionale. Tutte le famiglie italiane hanno fatto questo ragionamento? No, fra loro si è aperto un divario con un discrimine generazionale. L’abbassamento del tenore di vita, sia nelle quantità consumate sia nella selezione dei consumi, è stato vistoso nelle famiglie più giovani, e non solo in quelle col capo famiglia disoccupato: ha pesato sui giovani lavoratori dipendenti la diffusa precarietà dei rapporti di lavoro; su quelli autonomi, in specie se titolari di piccole e piccolissime aziende, la necessità di sovvenire col proprio reddito ai problemi dell’azienda. Fra le classi di reddito più alte, dove le famiglie giovani sono poco presenti, si è osservata invece, ad esempio, una crescita dei consumi “voluttuari”. I danni della Guerra dei Sette Anni sono permanenti? Dipende. Siamo scesi di alcuni scalini nella condizione economica e nessuno ci ridarà quello che abbiamo perso. Però possiamo ripartire, sia pure da una posizione più bassa di quella che occupavamo sette anni fa; possiamo magari rimetterci a salire con una velocità maggiore di quella che avevamo prima di essere travolti dalla duplice crisi. I presupposti di una ripartenza ci sono tutti. Il mercato delle fonti di energia, da cui siamo così dipendenti, offre di
capitolo secondo Come è cambiata l’economia italiana nel tempo
29
nuovo prezzi relativamente bassi. La politica monetaria fortemente accomodante nell’area dell’euro ci sta portando un tasso di cambio favorevole alle nostre imprese, sui mercati esteri come su quello interno, e tassi d’interesse bassissimi nel confronto storico. L’impegno a riformare la struttura economica e sociale del nostro paese è crescente e apprezzato nelle sedi internazionali, anche se è contrastato all’interno da divisioni e resistenze. La ripartenza è tuttavia ancora timorosa, incerta, va incoraggiata. Molte imprese che potrebbero rilanciare gli investimenti esitano a farlo. Se le loro decisioni saranno positive ne discenderà un aumento dell’occupazione e la ritrovata fiducia si trasmetterà anche alle famiglie consumatrici. 2. LE IMPRESE MANIFATTURIERE ITALIANE: UN DRAMMA IN TRE ATTI
La frammentazione del sistema produttivo è una peculiarità della nostra economia, che conta moltissime imprese con, in media, pochi addetti ciascuna: oltre 4.426.000 imprese dell’industria e dei servizi, con una media di 3,7 addetti (9,2 nel settore manifatturiero)9. Questa peculiarità del sistema italiano emerge nitidamente dal confronto con le dimensioni aziendali prevalenti nei paesi con cui siamo soliti confrontarci: Germania, Francia, Regno Unito, Usa. Ad esempio, in Germania le microimprese (fino a 9 addetti) sono l’84% del totale, in Italia il 95%; il 39% degli occupati nell’industria tedesca lavora in grandi imprese (250 e più addetti), in Italia il 22%. Ci porremo tre quesiti, per i quali anticipiamo in sintesi le risposte. 1) È stato sempre così? La struttura industriale italiana è sempre stata così polverizzata, sin dall’affermarsi del paese nel nove-
30
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
ro delle economie industrializzate? No, non è stato sempre così. La grande impresa, in particolare la grande impresa pubblica, è stata tra i principali attori del sostenuto processo di crescita dell’economia italiana negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. La preminenza della grande impresa italiana si colloca proprio durante quella età dell’oro del nostro sviluppo capitalistico10. Negli anni Sessanta, nel manifatturiero, le grandi imprese (con 500 e più addetti) erano quasi 700 e impiegavano circa il 28% dell’occupazione del settore. Oggi sono 471 e impiegano il 16,2% del totale dell’occupazione11. 2) In che periodo cambia la dimensione prevalente nell’industria italiana? Nella seconda metà degli anni Settanta si verifica una vera e propria discontinuità, un’inversione di tendenza, peraltro osservabile anche in altri paesi sviluppati: le piccole e medie imprese diventano sensibilmente più numerose. È una vera e propria cesura con il passato assetto organizzativo delle imprese. A differenza che negli altri paesi industriali, in Italia è persistita nel tempo, fino ai nostri giorni. 3) Nuove tecnologie, globalizzazione, unione monetaria europea: la dimensione media delle imprese italiane è adeguata? Dalla seconda metà degli anni Novanta, il contesto operativo cambia radicalmente per il verificarsi di shock esogeni ed endogeni. Nel mutato scenario, la frammentazione e l’organizzazione della struttura produttiva diventano freni a una crescita sostenuta del sistema economico italiano. I tre quesiti scandiscono un dramma in tre atti. Lo metteremo ora in scena per raccontare tre diverse stagioni dell’industria manifatturiera, attraverso i filtri della dimensione e dell’organizzazione delle imprese, assai efficaci per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza del nostro sistema produttivo oggi. Ci concentriamo qui sulle imprese manifatturiere perché esse hanno a lungo guidato lo sviluppo economico del nostro paese.
capitolo secondo Come è cambiata l’economia italiana nel tempo
31
Primo atto: la grande impresa ai tempi del miracolo economico Negli anni del “miracolo” si assiste in Italia alla trasformazione strutturale del sistema economico, con il passaggio in massa di forza lavoro dall’agricoltura, settore arretrato a bassa o addirittura negativa produttività marginale, all’industria, settore a più elevata produttività grazie all’impiego di capitale fisico e di tecniche più avanzate12. I numeri del travaso da un settore all’altro negli anni Cinquanta e Sessanta sono impressionanti: dal 1951 al 1971 oltre 5 milioni di lavoratori13. Il differenziale salariale che rende conveniente lo spostamento della forza lavoro dall’agricoltura all’industria è comunque contenuto. Un dato lo mostra chiaramente: fra il 1953 e il 1961, all’incremento dell’84% della produttività nell’industria corrisponde solo un 47% di aumento del salario operaio14. I salari sono bassi e crescono meno della produttività per l’abbondanza di manodopera e la debolezza dei sindacati. L’aumento dei profitti consente investimenti in capitale fisico (macchinari, impianti, capannoni) che stimolano ulteriormente la produttività, allargano e rafforzano la base industriale. Questo processo circolare va avanti finché permane l’eccesso di manodopera disponibile nelle campagne per un reimpiego nell’industria15. La prima battuta di arresto si registra con la crisi congiunturale del 1963, la quale altro non è che la manifestazione del fatto che “l’Italia era rimasta priva della sua eccedenza di mano d’opera”16. L’industria manifatturiera è quindi fonte di gran parte della sostenuta crescita economica del paese: il Pil pro capite cresce del 5,4% l’anno negli anni Cinquanta, del 5,1% negli anni Sessanta. Nei due decenni anche Francia, Germania e Regno Unito – i paesi i cui più elevati standard di vita l’Italia inseguiva – crescono a tassi sostenuti. La potente avanzata è resa possibile da un contesto di eccezionale stabilità, contrassegnato dalla certezza dei cambi fissi, dalla poca variabilità dei tassi di
32
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
interesse, dalla bassa crescita dei prezzi delle materie prime e da una forte espansione della domanda interna, incoraggiata anche dall’espansione del Welfare State. È l’età dell’oro del capitalismo17. Protagonista indiscussa della Golden Age in tutti i paesi, a economia di mercato o pianificata, è la grande impresa: “La struttura dei paesi industrialmente avanzati dei due campi era, infatti, caratterizzata dalla marcia trionfale della grande dimensione – una grande dimensione che era quasi sinonimo di produzione di massa e di organizzazione scientifica del lavoro, ad Ovest come ad Est – in quasi tutta l’area industriale”18. In Italia, la grande dimensione si ritrova innanzitutto nell’impresa a partecipazione statale. Lo Stato imprenditore, attraverso le finanziarie dell’Iri – il Fondo per il finanziamento dell’industria meccanica (1947), Finmeccanica (1948), Finelettrica (1952), Eni (1953), Fincantieri (1959), Efim (1962) – assume un ruolo preminente nell’indirizzo e nella promozione dello sviluppo economico italiano19. L’originaria funzione delle imprese a partecipazione statale è di “mettere nelle mani di imprenditori capaci di un disegno industriale di medio e lungo periodo i mezzi che un sistema finanziario carente non avrebbe saputo mobilitare”20. Grazie a un modello intensivo di accumulazione, la grande impresa pubblica rafforza il settore più avanzato dell’economia, favorendo la trasformazione strutturale di quest’ultima e traghettandola verso la modernità. Alla grande impresa pubblica viene inoltre affidato il riequilibrio del divario territoriale tra il Nord e il Sud del paese: all’inizio degli anni Cinquanta il Pil pro capite delle regioni meridionali era ancora la metà di quello del Centro-Nord. Alla fine di quel decennio, dopo la stagione degli interventi infrastrutturali e della riforma agraria, prende avvio la politica di industrializzazione del Mezzogiorno. Sono in voga a quel
capitolo secondo Come è cambiata l’economia italiana nel tempo
33
tempo modelli teorici detti di “crescita squilibrata” e in particolare il paradigma dei “collegamenti all’indietro” (backward linkages) di Hirschman21: in parole povere, si ritiene che una politica di industrializzazione debba privilegiare settori e dimensioni d’impresa che causino ricadute a cascata sulle economie locali. In accordo con quei modelli, sono le grandi imprese, prima pubbliche e poi private (queste ultime sostenute da un generoso schema di incentivazione), le principali protagoniste del “miracolo economico meridionale”22. In quella breve stagione, durata poco più di un decennio, il Sud consegue un saggio di crescita del prodotto industriale particolarmente elevato, addirittura maggiore di quello del Centro-Nord. Il reddito pro capite del Mezzogiorno d’Italia giunge a sfiorare i due terzi di quello del Centro-Nord alla metà degli anni Settanta. L’intervento nel Mezzogiorno si articola in due fasi: nel periodo 1959-1963 gli investimenti si concentrano soprattutto nelle industrie di base – chimica e siderurgia – e le imprese pubbliche ne sono i principali attori; nel quinquennio dal 1969 al 1974, si inaugura la politica di diversificazione settoriale degli investimenti che vede, accanto ai grandi gruppi pubblici, l’impegno del capitale privato nei settori delle telecomunicazioni, dell’elettronica, dei trasporti, della meccanica23. Negli stessi anni, in Italia, svettano anche grandi figure di imprenditori privati, come il tecnocrate Vittorio Valletta alla Fiat e, con una visione del tutto opposta, l’umanista Adriano Olivetti nella omonima azienda di macchine per ufficio. L’entusiasmo acceso della crescita economica accelerata di quegli anni contagia anche imprenditori che provengono dal mondo dell’artigianato, come Aristide Merloni, Lino Zanussi, Giovanni Borghi, per parlare solo del settore degli elettrodomestici. Proprio gli elettrodomestici assurgono, infatti, a simbolo, insieme alle autovetture, del miracolo economico. L’aumento dei
34
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
consumi porta con sé una espansione senza precedenti del settore alimentare e delle sue imprese (Peroni, Galbani, Ferrero). Il sistema economico italiano di quella età dell’oro mostra caratteri organizzativi e dimensionali profondamente diversi dal quadro attuale. L’organizzazione delle imprese ai tempi del miracolo economico Dal punto di vista dell’assetto organizzativo, pur nelle peculiarità tecnologiche dei diversi settori, la principale caratteristica del sistema di produzione degli anni Cinquanta e Sessanta è l’elevato grado di integrazione verticale: larga parte delle fasi che permettono la produzione del bene finito, pronto per il consumo, sono svolte all’interno della fabbrica. Per provarlo si può ad esempio guardare a un semplice indicatore24 che mette in rapporto il valore aggiunto di un’impresa (essenzialmente, retribuzioni e rendimento del capitale investito) al fatturato: più l’impresa è integrata verticalmente, meno materie e beni intermedi acquista all’esterno, più il valore aggiunto tende a coincidere col fatturato e l’indicatore si avvicina a 1. Si tratta di un aspetto estremamente rilevante, come vedremo meglio più avanti, per il destino futuro del nostro sistema produttivo, diffusamente trattato dagli studiosi di economia dell’impresa. Ma prima di arrivare agli aspetti teorici, soffermiamoci sul comportamento rivelatore di Henry Ford, precursore dell’industria automobilistica di massa, di cui si è detto: “Ford era più che altro un assemblatore quando aprì lo stabilimento di Highland Park. Comprava i motori e i telai dai fratelli Dodge e aggiungeva varie parti ordinate ad altre aziende per completare il veicolo. Entro il 1915, tuttavia, egli aveva riportato in casa tutte queste produzioni ed era a un passo da una completa integrazione verticale (cioè fabbricare da sé qualunque cosa facesse parte delle sue automobili, dalle materie prime in su). Ford per-
capitolo secondo Come è cambiata l’economia italiana nel tempo
35
seguiva l’integrazione verticale anche perché aveva piena padronanza delle tecniche di produzione di massa, e poteva realizzare sostanziali risparmi di costi facendo tutto da sé. Aveva anche un altro movente: il suo carattere peculiare che lo portava a nutrire una profonda sfiducia in chiunque fuor che se stesso”25. Ciò che può sembrare solo un tratto peculiare della personalità di un imprenditore è in realtà, nel contempo, un aspetto qualificante dell’assetto organizzativo della grande impresa degli anni Cinquanta e Sessanta, negli Stati Uniti come in Unione Sovietica, e una delle intuizioni più fruttuose della letteratura neo-istituzionalista dell’impresa. Nella teoria neoclassica, la dimensione dell’impresa e quindi il suo livello di integrazione verticale sono determinati esclusivamente dalle caratteristiche tecnologiche. Ciò potrebbe certo spiegare perché nelle industrie a ciclo continuo si riscontri un elevato grado di integrazione verticale (per esempio, nella produzione di acciaio, il tenere tutte le fasi produttive all’interno evita di riscaldare il metallo in ogni fase con evidenti risparmi sul costo del combustibile), mentre invece potrebbe non spiegare quanto accade in un’impresa, per esempio, del settore calzaturiero, il cui processo produttivo è scomponibile in diverse fasi, che potrebbero essere svolte all’esterno dell’impresa. La teoria neo-istituzionalista dell’impresa propone una nuova lettura dei fatti, profonda e molto più realistica. Ronald Coase, in un suo importante articolo del 1937, The Nature of the Firm (La natura dell’impresa), sostiene che un’impresa nasce per economizzare i costi di uso del mercato, cioè per ovviare a un fondamentale inconveniente di un’economia atomistica in cui ciascuno svolge un singolo compito produttivo e c’è qualcuno che li mette poi insieme per realizzare il prodotto finito. Tali costi sono definiti “costi di transazione”. L’informazione è difficile e costosa da reperire: ad esempio,
36
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
se io fabbrico automobili, sapere qual è il miglior fornitore di scocche, il più affidabile a parità di costo, richiede tempo e fatica. Inoltre, una volta trovato il fornitore più adatto, occorrerebbe stilare con lui un contratto che sia quanto più possibile “completo”, cioè che stabilisca, per ogni singola evenienza futura, i reciproci obblighi delle parti rispetto alle prestazioni e ai pagamenti, il cui rispetto possa essere assicurato da un’autorità esterna (ad esempio un tribunale), con sanzioni per le parti inadempienti. Ovviamente un tale tipo di contratto quasi mai si ritrova nella realtà, o per scarsità di conoscenze o per razionalità limitata delle parti contraenti; nella realtà i contratti sono spesso incompleti. Inoltre, una volta che il fornitore abbia eseguito l’ordine, l’impresa committente deve verificare che il lavoro corrisponda alle proprie iniziali richieste e, se così non fosse, affrontare e sostenere un procedimento di risoluzione dell’inevitabile controversia che ne deriverebbe. Tutti questi costi di transazione (ex ante ed ex post) possono essere molto elevati; ancor più in assenza di tecnologie che agevolino gli scambi; oppure in presenza di comportamento opportunistico in una delle due parti: il comportamento di chi giunge fino a “mentire, rubare, fuorviare, travisare, oscurare, fingere, distorcere e confondere”26 pur di avvantaggiarsi di una informazione privilegiata o di una incompletezza contrattuale. Per evitare tali costi, un imprenditore può preferire svolgere una certa fase della produzione in casa piuttosto che affidarla a un fornitore esterno. Un esempio ormai classico è quello della fornitura di scocche chiuse della Fisher Body alla General Motors agli inizi del secolo scorso. Dopo cinque anni dalla stesura di un contratto che risaliva al 1919, l’improvviso aumento della domanda di automobili (non previsto nell’accordo originario, un esempio di incompletezza contrattuale) richiese una rivisitazione delle intese. La revisione del contrat-
capitolo secondo Come è cambiata l’economia italiana nel tempo
37
to non condusse a una soluzione soddisfacente per le parti e alla fine Fisher Body fu incorporata nella General Motors27. L’impresa committente, la General Motors nel caso in questione, ricorre così al “principio di gerarchia”: dà ordine a un suo specifico reparto di procedere alla produzione di scocche da ultimare in un tempo prefissato. Il costo di transazione è azzerato e al suo posto subentra un costo di coordinamento interno. La mano invisibile del mercato lascia il posto alla “mano visibile” della gerarchia. In altre parole, l’impresa esiste, secondo Ronald Coase, perché i costi complessivi (costo di produzione e di coordinamento interno) risultano più bassi di quelli che sopporterebbe se si affidasse al mercato. Ecco perché Henry Ford, e con lui la gran parte degli imprenditori di quel periodo, “non si fida”; ed ecco perché le imprese dell’età dell’oro svolgono all’interno tutte o gran parti delle fasi, anche quelle tecnicamente scomponibili e che potrebbero dunque uscire dalla fabbrica per poi rientrare per la fase finale dell’assemblaggio. Spesso un’integrazione verticale spinta si accompagna con una elevata dimensione di impresa, per consentire alle economie di scala di dispiegare tutta la loro potenza e operare per la riduzione del costo medio di produzione del bene. Rammentiamo che, dati i costi dei macchinari, del lavoro e degli input, le economie di scala abbassano il costo medio di produzione all’aumentare dei volumi prodotti. Raggiunta una certa dimensione, i costi possono smettere di diminuire o cominciare ad aumentare (diseconomie di scala). In altri casi, raggiunto il livello minimo, i costi possono rimanere costanti, all’aumentare del volume di produzione. La produzione di ampi volumi di beni standardizzati (la Ford modello T, disponibile “in qualsiasi colore purché nero”,
38
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
come diceva Henry Ford), richiesti dal consumatore in quella stagione dello sviluppo capitalistico, ben si prestava. Negli anni Cinquanta la domanda interna per consumi e, dal 1958 al 1963, anche quella estera assumono in Italia proporzioni tali da rendere economicamente conveniente la produzione standardizzata di ampi volumi di beni. Gli stabilimenti produttivi sono ripartiti con criteri di funzionalità, ogni compito localizzato in un’area separata. La produzione di massa richiede impianti dedicati a un unico tipo di prodotto, appunto standardizzato (con limitata scelta di gamma) e una divisione del lavoro estremamente parcellizzata. Gli incrementi di produttività (output per unità di input) registrati nel periodo sono notevoli. In Italia, la produttività del lavoro cresce ad un mai più eguagliato tasso medio di circa il 6% annuo (dal 1951 al 1970) nell’industria manifatturiera; un vero e proprio “boom della produttività”28. Ne esce così confermata la fondamentale intuizione di Adam Smith, secondo cui gli aumenti di produttività scaturiscono da un uso più specializzato delle risorse, cioè un uso specifico per quel prodotto. Secondo atto: tutto cambia. L’inversione di tendenza La fine dell’età dell’oro del capitalismo viene decretata, per tutti i paesi industriali, all’inizio degli anni Settanta. Il contesto cambia radicalmente, smantellando il quadro di certezze in cui aveva operato la grande impresa e in cui era prosperato lo standard di vita dei paesi industrializzati. La crisi del modello di accumulazione fondato sulla grande impresa è riconducibile innanzitutto a due fattori esogeni: le crisi petrolifere del 1973 e del 1979, che innescano rincari vertiginosi delle fonti di energia, e la fine del regime dei cambi fissi, sancita nel 1973. Sono anche rilevanti altri fattori endogeni di instabilità: la richiesta di beni più diversificati da parte di consumatori di-
capitolo secondo Come è cambiata l’economia italiana nel tempo
39
venuti ormai sofisticati; la maggiore integrazione commerciale tra paesi, che comporta un forte aumento della concorrenza sui mercati internazionali; l’introduzione della microelettronica, che attenua i vantaggi tecnici delle economie di scala; la maggiore conflittualità nelle relazioni industriali, che accresce sensibilmente i costi interni di coordinamento. “A partire dalla fine degli anni Settanta, nei paesi sviluppati, le condizioni di mercato assomigliano sempre meno a quelle che avevano favorito l’estendersi della grande impresa come forma organizzativa tipica del sistema industriale”29. La seconda metà degli anni Settanta segna anche una discontinuità teorica. Fino ad allora è stato egemone il paradigma dell’impresa manageriale di Chandler30. Nonostante le straordinarie intuizioni di Ronald Coase, risalenti alla fine degli anni Trenta, la teoria dell’impresa continua a muoversi all’interno dell’approccio neoclassico, il quale, in sostanza, identifica l’impresa con una funzione di produzione. Nella seconda metà degli anni Settanta il tema delle relazioni tra imprese comincia a suscitare l’interesse della comunità scientifica, in singolare rispondenza e sincronia con quanto va maturando, nello stesso periodo, negli assetti organizzativi delle imprese. In questo periodo si consuma quello che è stato definito il “second industrial divide”31, un vero e proprio spartiacque che segna il passaggio da un assetto organizzativo egemonizzato dalle grandi imprese a uno che vede la preminenza delle piccole e medie imprese. La mutazione dimensionale è particolarmente pronunciata in Italia e, fatto decisivo, è destinata a permanere nel tempo fino a configurarsi come una peculiarità del sistema produttivo nazionale. Il mutamento di tendenza in Italia emerge con chiarezza sia dall’analisi della variazione del peso delle piccole e medie
40
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
imprese, sia dell’incidenza occupazionale delle classi dimensionali più piccole dell’industria manifatturiera. Nel decennio 1971-1981, la grande impresa manifatturiera italiana perde 160.000 addetti, le piccolissime imprese ne guadagnano 144.000; nelle regioni del Nord-Est-Centro (Nec) si ha un incremento sensibile dell’occupazione, di 470.000 addetti, mentre nell’area del tradizionale triangolo industriale (Milano-Torino-Genova) l’incremento di occupazione è molto più contenuto (35.000). Questi dati ci dicono che è in opera un decentramento produttivo delle grandi imprese, le quali esternalizzano lavorazioni non essenziali e a più alto contenuto di lavoro. A fronte di un aumentato costo di coordinamento interno (è una stagione di alta conflittualità sindacale), le grandi imprese fanno maggiore ricorso al mercato e creano un indotto di piccole e medie imprese. Eppure, fermarsi al solo fenomeno del decentramento produttivo sarebbe fuorviante per comprendere la profonda riorganizzazione degli assetti produttivi. I dati ci parlano, infatti, anche di una redistribuzione territoriale dello sviluppo: dal triangolo industriale a favore della Terza Italia, cioè delle regioni del Nord-Est-Centro. Una Terza Italia “diversa”, per condizioni strutturali e sociali, sia dal triangolo industriale che dal Mezzogiorno. È piuttosto rivelatore delle novità del periodo l’andamento del livello di integrazione verticale32. Negli anni del boom economico, metà della produzione veniva mediamente realizzata all’interno delle imprese; nel 1991, il valore scende al 30%. La deverticalizzazione comporta la diminuzione della dimensione media delle imprese manifatturiere italiane, che ha origine proprio in quel periodo. La dimensione media delle imprese manifatturiere passa da 10,6 addetti del 1971 a 9 nel 2001. Gli imprenditori italiani degli anni Ottanta e Novanta sembrano fidarsi di più di quanto non facesse Ford, tanto da de-
capitolo secondo Come è cambiata l’economia italiana nel tempo
41
legare al mercato, cioè ad altre imprese, mediamente il 70% delle fasi della produzione che, in epoca fordista, sarebbero state realizzate all’interno di un’unica impresa. L’analisi congiunta di tre variabili – dimensione-organizzazione-localizzazione territoriale – rivela il tratto caratterizzante del periodo, vale a dire la divisione del lavoro tra piccole e medie imprese per produrre un bene finito, in particolare nei settori dell’arredo-casa, degli apparecchi e della meccanica strumentali, della moda33. Il modello diventa quello dei distretti industriali e l’insieme dei beni prodotti va sotto il nome di “Made in Italy”: si configura, così, lo spostamento dell’asse di specializzazione dell’industria italiana. Per essere precisi, dobbiamo parlare di distretti industriali cosiddetti marshalliani e ripercorrere la “cronaca di un ritrovamento”34. I distretti industriali marshalliani: breve cronaca di un ritrovamento Alla fine del secolo XIX, nel pieno dell’affermarsi della teorizzazione sui vantaggi delle economie di scala, Alfred Marshall aveva dedicato un capitolo dei suoi Principi di economia35 all’analisi della efficienza che mostravano certi gruppi di imprese specializzate nello stesso settore e insediati in località geografiche circoscritte, località che egli definì “distretti industriali”36. I più noti erano quelli metallurgici di Sheffield e Solingen, quelli tessili del Lancashire. Nell’analisi di Marshall, dato un processo produttivo scomponibile, i vantaggi della produzione su larga scala possono essere conseguiti anche attraverso la divisione del lavoro tra un gran numero di piccoli produttori che operano all’interno di uno stesso distretto. Grazie alla localizzazione contigua, si generano, infatti, alcune economie esterne di agglomerazione di cui si avvantaggiano le piccole imprese. Le economie
42
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
esterne marshalliane si sostanziano nel risparmio dei costi di informazione, negli aumenti di produttività che derivano dalla divisione del lavoro tra le imprese, nella possibilità di attingere a un bacino di forza lavoro specializzata in quella peculiare produzione che caratterizza il distretto. Dunque – sostiene Marshall – i vantaggi di efficienza possono conseguirsi attraverso economie interne di scala (tipiche della grande impresa) oppure attraverso economie esterne all’impresa, ma interne al distretto. Nel corso degli anni Settanta, un gruppo di economisti italiani, in primis Sebastiano Brusco e Giorgio Fuà, e di sociologi come Arnaldo Bagnasco, avanzano una diversa interpretazione delle direttrici dello sviluppo economico italiano. La loro intuizione è che nelle regioni Nec si vada affermando un modello di organizzazione il cui punto di forza risiede nel gioco “tra pari” tra piccole imprese specializzate, singolare blend di competizione e di collaborazione, e nella interazione di queste imprese con il territorio. Giacomo Becattini trova che l’apparato analitico più appropriato per spiegare questo peculiare assetto organizzativo sia proprio il distretto industriale marshalliano. Nasce così, e non senza difficoltà di affermazione nella letteratura economica italiana, la stagione dei distretti industriali in Italia. Becattini ricostruisce, nel saggio del 1987, le resistenze sia della comunità scientifica sia del sindacato ad accogliere le tesi della “via italiana” allo sviluppo, avanzate dall’Istituto regionale di programmazione economica della Toscana (Irpet) nei lavori del 1969 e del 1975. La fase successiva al “ritrovamento” dei distretti industriali è quella della identificazione statistica degli stessi, fondata sui lavori pionieristici di Sforzi37, dell’Irpet e dell’Istat. Si arriva così, sulla base dei dati del censimento del 1991, alla individuazione di circa 200 distretti industriali che spiegano oltre il
capitolo secondo Come è cambiata l’economia italiana nel tempo
43
40% dell’occupazione nella industria manifatturiera italiana, concentrati prevalentemente nella Terza Italia. Dopo la prova dell’esistenza del distretto, la ricerca punta alla misurazione dell’eventuale “effetto distretto”: verificare, con analisi su campioni rappresentativi, se le imprese che operano in un distretto mostrino effettivamente una performance superiore rispetto a imprese di pari taglia (dimensione) che operano, invece, isolatamente e che dunque non traggono vantaggio “dall’atmosfera industriale”, dalle esternalità marshalliane. La prima evidenza (quantitativa) dell’effetto distretto viene da una ricerca della Banca d’Italia38: viene così provato che l’appartenenza a un distretto riduce l’inefficienza tecnica e aumenta significativamente la proiezione internazionale delle imprese distrettuali. L’effetto distretto si traduce, come abbiamo detto prima, nel “miracolo del Made in Italy”39, nel successo dei prodotti italiani nei settori dell’arredo-casa, nel sistema moda e nella meccanica strumentale. I vantaggi competitivi del nostro paese maturano in quei settori, popolati da piccole e medie imprese che intessono fitte relazioni di scambi di mercato, all’interno di un territorio circoscritto. Terzo atto. L’epoca della nuova globalizzazione I limiti di questo modello emergono nitidamente e drammaticamente nella seconda metà degli anni Novanta a seguito di shock che si producono nel mondo e in Europa e che provocano una profonda mutazione dell’ambiente competitivo in cui operano le imprese italiane: in primo luogo, l’avvento delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict), che richiedono radicali mutamenti organizzativi nelle imprese per sfruttare appieno gli incrementi di produttività che
44
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
le Ict consentono40; quindi, una maggiore integrazione commerciale dei mercati (globalizzazione), con la conseguente crescente pressione concorrenziale dei paesi asiatici (soprattutto della Cina), che colpisce severamente il “Made in Italy”; infine, la nuova disciplina del tasso di cambio in Europa, avviata già dalla metà degli anni Novanta in vista dell’adesione all’euro, che priva le imprese italiane, per lo più esportatrici sui mercati europei, della scorciatoia delle svalutazioni. Dunque, il modello di industrializzazione diffusa, fondato in alcune parti d’Italia sui distretti industriali, che ha saputo affermarsi con i prodotti del “Made in Italy” sui mercati esteri fino a conquistare la ribalta della scena internazionale, sembra avere esaurito, con la seconda metà degli anni Novanta, la propria forza propulsiva41. Le difficoltà del sistema produttivo italiano a fronteggiare un’arena divenuta via via meno favorevole alla piccola dimensione maturano nello stesso periodo in cui nel resto del mondo industriale si manifestano segnali di nuovi mutamenti strutturali nell’organizzazione della produzione. Una letteratura in forte espansione da venti anni documenta la riorganizzazione spaziale dei sistemi produttivi, come ulteriore conseguenza della rivoluzione tecnologica delle Ict, della progressiva riduzione delle barriere commerciali e dei costi di trasporto. Diverse denominazioni sono state coniate per coglierne gli aspetti essenziali: frammentazione, dispersione internazionale della produzione, catene globali del valore (Cgv). Si viene a determinare un nuovo assetto della divisione internazionale del lavoro, in cui molti beni divengono il risultato di lunghe Cgv alle quali imprese di paesi diversi aggiungono via via frammenti di valore. Secondo questa interpretazione, si può guardare al processo produttivo di un dato bene come a un continuum di compiti affidati ai vari fattori della produzione, compiti che possono essere svolti in diversi possibili luoghi del
capitolo secondo Come è cambiata l’economia italiana nel tempo
45
mondo; l’organizzazione della produzione varia continuamente, delocalizzando (offshoring) ogni compito nel paese in cui risultino minori i costi di produzione e di transazione internazionale. Viene dunque affermandosi un nuovo paradigma per l’analisi dell’organizzazione internazionale della produzione, dove al centro dell’attenzione sono gli scambi fra nazioni di compiti produttivi, e non più i tradizionali scambi di beni. La teoria classica del commercio internazionale, elaborata originariamente da Ricardo nel 1817, si fondava invece sulla categoria del vantaggio comparato nello scambio tra paesi (Inghilterra e Portogallo nel suo esempio) di beni finiti (tessuti e vino). In quel modello, Inghilterra e Portogallo effettuavano al loro interno tutte le fasi della produzione. Con le Cgv le singole fasi della produzione sono frammentate e realizzate in molti luoghi diversi. Il fenomeno assume tutte le caratteristiche di un mutamento destinato a perdurare perché produce un effetto di “ispessimento del mercato”. La crescente integrazione tra le economie sembra favorire la nascita e la crescita di più produttori specializzati, con il risultato di abbassare sensibilmente i costi di uso del mercato, in particolare quella categoria di costi sopportati dalle imprese che effettuano investimenti specifici (quelli per i quali è minore il rendimento che si ottiene al di fuori della transazione per la quale essi sono stati originariamente progettati). Secondo McLaren42, la presenza di più opzioni di scelta offerte dal mercato globale, riducendo i rischi di holdup (quella situazione in cui, avendo una delle parti effettuato un investimento specifico, l’altra potrebbe appropriarsi di una parte del rendimento), renderebbe le relazioni tra le imprese la soluzione più efficiente, con la conseguenza che i sistemi di approvvigionamento dei singoli paesi tenderebbero a convergere via via che aumenta l’integrazione commerciale. Il fenomeno coinvolge sia le imprese dei paesi in via di sviluppo, dove la partecipazione alle Cgv costituisce una chance
46
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
di industrializzazione per compiti ad alto contenuto di lavoro, sia le imprese dei paesi sviluppati, che operano di frequente nei segmenti ritenuti più remunerativi delle Cgv, ossia a monte (nelle funzioni di ricerca e sviluppo, ingegnerizzazione, design) e a valle (logistica, vendita, marketing) del processo produttivo. Quali prospettive hanno le imprese italiane in questo nuovo quadro? Dall’aver prima praticato il decentramento (seconda metà degli anni Settanta) e poi consolidato i distretti industriali (anni Ottanta), è derivato, in Italia, un diffuso ricorso a relazioni di scambio. Le imprese fornitrici, cioè le imprese che vendono ad altre imprese e non ai consumatori, sono in Italia particolarmente numerose. Secondo i dati Unicredit, il numero di imprese fornitrici è il 70% del totale del campione. Valori più bassi ma comunque rilevanti pari al 64% delle imprese manifatturiere emergono dalla base dati Efige (European Firms in a Global Economy) e dall’ultimo censimento Istat (57%)43. Per i dati Unicredit ed Efige ci si riferisce a imprese manifatturiere che vendono il 100% del loro fatturato ad altre imprese; i dati censuari indicano invece la quota di imprese manifatturiere e dei servizi (sul totale di quelle con almeno tre addetti) che dichiarano di avere svolto attività di fornitura. D’altro canto, nell’epoca delle Cgv, ciò che caratterizza i nuovi assetti produttivi delle imprese è proprio la divisione del lavoro, vale a dire quella caratteristica che è stata fonte del vantaggio competitivo delle imprese distrettuali negli anni Ottanta e per parte degli anni Novanta. Le economie dinamiche di specializzazione si dispiegavano, come abbiamo visto, all’interno di un’area geografica circoscritta ed erano di natura domestica, trattenute all’interno del territorio di localizzazione. Qual è allora l’elemento di discontinuità che mette in dif-
capitolo secondo Come è cambiata l’economia italiana nel tempo
47
ficoltà le piccole e medie imprese italiane? È che l’attuale dispersione della produzione implica, invece, la dislocazione su scala potenzialmente globale di quella divisione del lavoro, e richiede di operare sui mercati internazionali dei beni intermedi, pressati da concorrenti molto più numerosi e con costi del lavoro di gran lunga più bassi. Il fatto che la maggioranza delle imprese italiane siano fornitrici e non finali (cioè non vendano direttamente ai consumatori beni finiti) non stupisce date le caratteristiche frammentate della nostra struttura industriale. Per vendere direttamente al consumatore finale dei propri prodotti, su mercati globalizzati e quindi su una scala di massa, occorre una potenza di fuoco che una piccola impresa in genere non ha: bisogna saper ricercare e progettare (funzioni a monte), curare il marketing e l’assistenza alla clientela (funzioni a valle), sopportare costi a fondo perduto (sunk costs) per acquisire informazioni sui committenti esteri, per adattare le lavorazioni alle specifiche richieste della clientela, agli standard di produzione e di qualità vigenti negli altri paesi. Ne consegue che, a causa della limitata dimensione prevalente e dell’esigua presenza di grandi imprese italiane e multinazionali, l’industria italiana, nella larga parte, sembra poco attrezzata a fronteggiare la nuova divisione internazionale della produzione, soprattutto nei segmenti più remunerativi. NOTE 1 S. Fenoaltea, L’economia italiana dall’Unità alla grande guerra, Laterza, Roma-Bari 2006; G. Toniolo (a cura di), L’Italia e l’economia mondiale. Dall’Unità a oggi, Collana storica della Banca d’Italia, Marsilio, Venezia 2013; A. Baffigi, Il Pil per la storia d’Italia. Istruzioni per l’uso, Collana storica della Banca d’Italia, Marsilio, Venezia 2015. 2 A. Baffigi, I conti nazionali, in Toniolo (a cura di), L’Italia e l’economia mondiale cit., pp. 215-255. 3 M. Gomellini, C. Ó Gráda, Le Migrazioni, ivi, pp. 375-421. 4 G. Bertola, P. Sestito, Il Capitale umano, ivi, pp. 343-374.
48
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
5 C. Ciccarelli, A. Nuvolari, Technical Change, Non-Tariff Barriers, and the Development of the Italian Locomotive Industry, 1850-1913, in «The Journal of Economic History», 3, 75, 2015, pp. 860-888. 6 S.N. Broadberry, C. Giordano, F. Zollino, La produttività, in Toniolo (a cura di), L’Italia e l’economia mondiale cit., pp. 257-311. 7 Ibid. 8 V. Di Nino, B. Eichengreen, M. Sbracia, Tasso di cambio reale, commercio internazionale e crescita, in Toniolo (a cura di), L’Italia e l’economia mondiale cit., pp. 487-523. 9 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi, Istat, Roma 2012. 10 A. Glyn, A. Hughes, A. Lipietz, A. Singh, The rise and fall of the golden age, in S.A. Marglin, J.B. Schor (a cura di), The golden age of capitalism. Reinterpreting the Post-War experience, Clarendon Press, Oxford 1990. 11 I dati forniscono solo un ordine di grandezza, non sono perfettamente comparabili, a causa delle modifiche intervenute, nel corso del tempo, nella classificazione delle attività manifatturiere. Sulla grande impresa in Italia, cfr. P. Frigero, Evoluzione della grande impresa: evidenze dalle classifiche Ceris e Mediobanca, in Evoluzione della grande impresa e catene globali del valore, Fondazione Ansaldo, Recco 2014. Sulla frammentazione industriale in Italia, cfr. F. Onida, Se il piccolo non cresce, il Mulino, Bologna 2004. 12 W.A. Lewis, Economic development with unlimited supplies of labour, in «The Manchester School», 2, 22, 1954, pp. 139-191. 13 V. Daniele, P. Malanima, Il divario nord-sud in Italia, 1861-2011, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011. 14 F. Amatori, A. Colli, Impresa e industria in Italia dall’Unità a oggi, Marsilio, Venezia 1999. 15 Lewis, Economic development cit. 16 C.P. Kindleberger, Europe’s postwar growth. The role of labour supply, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1967 (Lo sviluppo economico e il mercato del lavoro, trad. di G. Pelizzola, Etas Kompass, Milano 1968, p. 53). 17 A. Glyn, A. Hughes, A. Lipietz, A. Singh, The rise and fall of the golden age, in Marglin, Schor (a cura di), The golden age of capitalism cit. 18 G. Becattini, Introduzione, in J. Steindl, Piccola e grande impresa, Franco Angeli, Milano 1991, p. 7. 19 La letteratura sul ruolo dello Stato nello sviluppo economico italiano è molto vasta. Tra gli altri lavori, si rimanda a: F. Barca (a cura di), Storia del capitalismo italiano, Donzelli, Roma 1997; P. Ciocca, L’Iri nell’economia italiana, Laterza, Roma-Bari 2014. 20 F. Barca, S. Trento, La parabola delle partecipazioni statali: una missione tradita, in Barca (a cura di), Storia del capitalismo italiano cit., p. 185. 21 A.O. Hirschman, The strategy of economic development, Yale University Press, New Haven 1958. 22 G. Iuzzolino, I divari territoriali di sviluppo in Italia nel confronto internazionale, in Mezzogiorno e politiche regionali, vol. 2, Banca d’Italia, Roma 2009, p. 428. 23 La letteratura sulla questione meridionale è molto ampia. Si vedano i lavori che seguono e la bibliografia ivi citata, A. Del Monte, A. Giannola, Il Mezzogiorno nell’economia italiana, il Mulino, Bologna 1978; C. Trigilia, Sviluppo senza autonomia. Effetti perversi delle politiche nel Mezzogiorno, il Mulino, Bologna 1992; A. Giunta, Grandi imprese e Mezzogiorno: attualità del pensiero di Salvatore Cafiero, in «QA – La questione agraria», 2, 2002, pp. 17-44; G. Iuzzolino, G. Pellegrini, G. Viesti, Regional convergence, in G. Toniolo (a cura di), The Oxford Handbook of the Italian Economy since Unification, Oxford University Press, Oxford 2013. 24 M.A. Adelman, Business concentration and price policy, Princeton University Press, Princeton 1955.
capitolo secondo Come è cambiata l’economia italiana nel tempo
49
25 J.P. Womack, D.T. Jones, D. Roos, The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production, HarperCollins, New York 1991, p. 33 (trad. nostra). 26 O.E. Williamson, The economic institutions of capitalism, The Free Press, New York 1985, p. 134. 27 B. Klein, R. Crawford, A. Alchian, Vertical integration, appropriable rents and the competitive contracting process, in «The journal of law and economics», 21, 1978, pp. 297-326. 28 S.N. Broadberry, C. Giordano, F. Zollino et al., Productivity, in Toniolo (a cura di), The Oxford Handbook cit., p. 195 (trad. nostra). 29 F. Traù, La discontinuità del pattern di sviluppo dimensionale delle imprese nei paesi industriali: fattori endogeni ed esogeni di mutamento dell’ambiente competitivo, in «CSC Working Paper», 19, 1999, p. 23. 30 A.D. Chandler, The visible hand. The managerial revolution in American business, Harvard University Press, Harvard 1977. 31 M.J. Piore, C.F. Sabel, The second industrial divide, Basic Books, New York 1984. 32 A. Arrighetti, Integrazione verticale in Italia e in Europa: tendenze e ipotesi interpretative, in F. Traù (a cura di), La «questione dimensionale» nell’industria italiana, il Mulino, Bologna 1999. 33 Sulla divisione del lavoro tra le imprese, il riferimento d’obbligo è G. Stigler, The division of labor is limited by the extent of the market, in «The Journal of Political Economy», 3, 59, 1951, pp. 185-193. 34 G. Becattini, Introduzione. Il distretto industriale marshalliano: cronaca di un ritrovamento, in G. Becattini (a cura di), Mercato e forze locali: il distretto industriale, il Mulino, Bologna 1987, p. 7. 35 A. Marshall, Principles of Economics, MacMillan, Londra 1966. 36 M. Bellandi, La formulazione originaria, in Becattini (a cura di), Mercato e forze locali cit., pp. 49-67. 37 F. Sforzi, L’identificazione spaziale, ivi, pp. 143-167. 38 L.F. Signorini (a cura di), Lo sviluppo locale, Donzelli, Roma 2000. 39 G. Nardozzi, Miracolo e declino, Laterza, Roma-Bari 2004. 40 S. Rossi, La nuova economia. I fatti dietro il mito, il Mulino, Bologna 2003. 41 In parziale disaccordo con questa tesi S. De Nardis, F. Traù, Il modello che non c’era, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005. 42 J. McLaren, Globalization and vertical structure, in «American economic review», 90, 2000, pp. 1239-1254. 43 Il database Unicredit è costituito dall’universo delle imprese manifatturiere con 500 e più addetti e da un campione rappresentativo di imprese manifatturiere della classe da 11 a 499 addetti; Efige comprende un campione rappresentativo di imprese manifatturiere con più di 10 addetti.
capitolo terzo
CHE COSA SI PRODUCE E A CHI SI VENDE
1. MANIFATTURA O SERVIZI? UNA DOMANDA ORMAI IRRILEVANTE
Nel capitolo precedente ci siamo occupati di imprese manifatturiere. Tuttavia, la distinzione fra manufatti e servizi sta sfumando: un manufatto è sempre più spesso un mero contenitore di servizi, senza i quali non avrebbe valore. Sono i servizi che ne determinano l’evoluzione qualitativa. L’esempio degli smartphone è lampante. Il Rapporto sulla competitività dei settori produttivi dell’Istat del 2015 lo documenta in modo esauriente, incentrando l’analisi sulla terziarizzazione dell’industria e sulla interconnessione tra industria e servizi, fenomeni definiti come “il tratto distintivo dell’evoluzione economica degli ultimi decenni”1. Essi sono attribuiti soprattutto alla frammentazione internazionale delle produzioni e alla loro riorganizzazione secondo catene globali del valore, di cui abbiamo parlato e parleremo in ancora maggiore dettaglio più avanti. Noi però preferiamo illustrarli qui attraverso un racconto tratto dalla storia del cinema. Nel 1936, ottant’anni fa, uscì nelle sale un film di Charlie Chaplin intitolato Tempi moderni (Modern Times). Era, tra l’altro, una rappresentazione grottesco-satirica del “taylorismo”
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
51
o “fordismo”, cioè della tipica organizzazione del lavoro degli opifici meccanici del tempo, basata sulla catena di montaggio. Il termine “taylorismo” si rifà a Frederick Taylor, fondatore dello Scientific Management; “fordismo” fa invece riferimento a Henry Ford, fondatore della omonima casa automobilistica che agli albori dell’altro secolo avviò la prima produzione di massa nella storia dell’automobile, con il celeberrimo Modello T. Ford pagava molto i suoi operai per gli standard del tempo, 5 dollari al giorno, il doppio dei concorrenti, per fidelizzarli e innalzarne il tenore di vita al punto da potersi permettere di comprare un Modello T: l’embrione del consumismo. La fabbrica del film Tempi moderni ha un nome di fantasia, Electro-Steel, che combina i due elementi su cui si riteneva basato il progresso di quell’epoca, l’elettricità e l’acciaio. In una delle tante scene memorabili di quel capolavoro assoluto della cinematografia mondiale si vede Charlot, protagonista del film e usuale maschera tragicomica di Chaplin, accanto a una delle catene di montaggio della Electro-Steel. La sua mansione consiste nello stringere con due tenaglie, una per mano, coppie di bulloni che la catena di montaggio, scorrendo sotto i suoi occhi, incessantemente gli mette davanti. Sempre lo stesso movimento, ruotando gomiti e polsi, ripetuto centinaia, migliaia di volte. L’operaio appena dietro di lui ha il compito di piantare i perni attorno a cui vanno stretti i bulloni, con un martellaccio. Anche lui è condannato a una eterna ripetizione dello stesso gesto: picchiare il martello sui perni. Charlot, con le sue movenze maldestre, perde spesso il ritmo ed è costretto ad arretrare finendo addosso al suo compagno di catena, che lo respinge a calcioni. A un certo punto l’inquadratura cambia e mostra il presidente della società seduto alla sua sontuosa scrivania, intento a giocare con un puzzle; all’ingresso di una bionda e sussiegosa segretaria fa finta di sfogliare un giornale. Infine, stanco di
52
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
oziare, accende degli schermi dietro di lui, che gli consentono di controllare, attraverso videocamere (a quel tempo una pura fantasia, non ancora realizzata), ogni angolo della fabbrica. Dà un ordine secco a una specie di giovane dio Vulcano a torso nudo, incaricato di manovrare il gigantesco macchinario che muove le catene di montaggio, perché aumenti la velocità proprio di quella a cui è adibito il povero Charlot. I disastri che combina Charlot si moltiplicano, in un fuoco d’artificio di gag comiche. Non sappiamo che cosa mai quella mostruosa fabbrica produca. Sappiamo per certo che si tratta di attività manifatturiera. Vengono di sicuro prodotti degli oggetti tangibili, con l’intervento decisivo delle mani degli operai: le mani di Charlot e del suo baffuto compagno di fatica sono costantemente in primo piano. L’intero processo produttivo è descritto come infinitamente ripetitivo. Il capitalista, l’ozioso presidente, ha evidentemente investito i suoi capitali finanziari all’inizio di questa storia, acquistando l’enorme capannone e il madornale macchinario, progettato e costruito una tantum da qualcuno; quindi ha assunto migliaia di manovali generici e intercambiabili, qualche capetto per controllarne la solerzia, un singolo manovratore della macchina (il giovane Vulcano). La produzione è stata impostata una volta per tutte, ora procede ad libitum, il presidente-manager deve solo buttarci un occhio di tanto in tanto per decidere il ritmo di produzione, scegliendo un punto di equilibrio fra la resistenza psicofisica degli operai e la sua avidità di guadagno. Inutile dire che la resistenza di Charlot crolla ben presto, gli viene un esaurimento nervoso che lo porta a gesti inconsulti tali da bloccare l’intera fabbrica, sicché viene cacciato via e da lì si dipana una storia tortuosa e appassionante che ci conduce per mano all’interno dell’America che si dibatte per uscire dalla Grande Depressione.
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
53
Chiediamoci: vi sono in quel processo produttivo degli input “di servizio”, che non si limitino all’interazione macchinamani? Non da parte del management: non vi sono apparentemente decisioni da prendere, solo verificare che le macchine vadano, vadano, vadano, tutt’al più stabilirne la velocità. Non da parte dei tecnici: ve ne è uno solo, Vulcano, che esegue gli ordini del padrone in modo meccanico, secondo procedure prestabilite, di fatto è un “manovale” anche lui, solo lievemente più addestrato. A somigliare a un “servizio” vi è solo l’odioso compito di controllo degli operai-schiavi svolto dalla sparuta pattuglia di capetti. Il valore del loro lavoro sarà tuttavia, possiamo immaginare, una percentuale infima di quello della produzione. Ora cambiamo film. Quattro anni prima, nel 1932, era uscito negli Stati Uniti, per diventare rapidamente un blockbuster mondiale, Grand Hotel: il capostipite di tutte le megaproduzioni hollywoodiane, zeppo di celebrità, a cominciare da Greta Garbo. Ambientato in una Berlino non ancora nazista, in piena Repubblica di Weimar. Gente che va, gente che viene, tante storie che s’intrecciano, tutte di gente ricca, naturalmente. Fra le molte, due sequenze notevoli: Greta Garbo, famosa ballerina, pensa di essere sul viale del tramonto e medita il suicidio (“I want to be alone”); al bancone del bar dell’albergo una giovane donna e due gentiluomini chiacchierano, la donna chiede dell’assenzio (scandalo!), si vede la schiena bianca del barman che le porge un calice pieno. La ballerina, il barman. Un’artista, un servitore. Le due fattispecie tipiche in cui a quel tempo si poteva concepire un’attività “terziaria”. Il servizio reso dalla ballerina è totalmente intangibile, aereo. Quello reso dal barman ha un minimo di manualità, ma non ritmata da una catena di montaggio. I fatti e i personaggi descritti in questi due film cristallizzano, naturalmente in modo estremo, quasi caricaturale, i due
54
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
concetti di attività manifatturiera (industriale) e di attività terziaria. Ma il modo in cui ancora oggi pensiamo a questi due tipi di attività non è poi tanto dissimile da quegli stereotipi. Se qualcuno dice “industria”, pensiamo a un capannone con dentro macchine e operai. Se dice “servizi” o “terziario”, pensiamo a un bar, a un teatro, tutt’al più a una linea ferroviaria o aerea. Bisogna risalire indietro nel tempo di qualche secolo, al tempo delle prime riflessioni moderne sul funzionamento delle economie (fisiocrazia, mercantilismo), per ritrovare il momento in cui si delineò la tripartizione dell’attività economica nei tre settori canonici, così come si configuravano allora: l’agricoltura, regina incontrastata dell’economia; l’industria, in realtà puro e semplice artigianato; i commerci. Nel corso del tempo una simile tripartizione ha continuato a essere giudicata utile, dapprima in occasione dell’affermarsi della rivoluzione industriale e del capitalismo, nei secoli XVIII e XIX; più tardi, nel secolo scorso, quando il variegato coacervo dei servizi iniziò a profilarsi come il vero, grosso baricentro delle economie sviluppate. La classica tripartizione settoriale è stata, ed è tuttora, al centro di analisi teoriche e di dibattiti di politica economica. Si è discusso a lungo sui meriti e sulla ineluttabilità di una transizione progressiva dal primario al secondario, poi al terziario, man mano che il grado di sviluppo di un’economia salisse. Si è lungamente ed estesamente studiata la produttività relativa dei tre settori, in genere per affermare la supremazia dell’industria. Nei manuali di economia aziendale si descrivono varie caratteristiche che aiutano a distinguere un manufatto da un servizio. Citiamo le principali: 1) se sia tangibile (manufatto) o no (servizio); 2) se possa essere prodotto e poi immagazzinato per essere venduto in un momento successivo e in un
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
55
luogo diverso da quello di produzione (manufatto) o se richieda prossimità fisica al cliente e simultaneità rispetto alla richiesta di quest’ultimo (servizio); 3) se possa essere adattato alle esigenze del singolo cliente (servizio) o no (manufatto); 4) se il processo produttivo possa essere largamente automatizzato (manufatto) o richieda invece sempre un’alta intensità di lavoro (servizio); 5) se richieda necessariamente un luogo fisico di produzione (manufatto) o no (servizio); 6) se serva a trasformare una materia prima (manufatto) o no (servizio). Nessuno di questi sei criteri ci appare ormai decisivo. Iniziamo dalla tangibilità. Che cos’è un film, un manufatto o un servizio? La domanda non suoni retorica, o banale. Non ci riferiamo qui al fatto che il prodotto finale assume l’aspetto di un oggetto fisico: una vecchia “pizza” cinematografica, o un dvd, o un qualunque altro supporto di registrazione. Ci riferiamo al fatto che un film è fatto non solo di ideazione e recitazione, ma anche di scenografie, mezzi tecnici di ripresa, impianti di illuminazione, effetti speciali creati da/con un computer. Cose che lo spettatore non tocca, ma che vede o sente: comunque delle esperienze sensoriali. Che cos’è uno smartphone, un manufatto o un servizio? Qui la risposta sembrerebbe più sicura: è un manufatto, si tocca. Ma uno smartphone è un mero contenitore di servizi, senza i quali non avrebbe quasi valore: il sistema operativo che lo fa funzionare, le app che gli danno vita. Sono quei servizi che ne determinano l’evoluzione qualitativa. Veniamo alla questione della prossimità/simultaneità. È vero, un taglio di capelli o un massaggio possono essere offerti a un cliente solo nel momento in cui vengono richiesti e nel luogo in cui si trova il parrucchiere o il massaggiatore. Ma per un numero crescente di servizi questo non è più vero. Un software può essere realizzato e immagazzinato per un uso successivo, anche se non nel senso che comunemente si
56
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
attribuisce alla alimentazione delle “scorte di magazzino” in una fabbrica manifatturiera. Perfino i servizi di un chirurgo possono essere svolti a distanza, attraverso un robot. La possibilità di personalizzare l’offerta, tipica qualità di un servizio, è ormai diffusa e presente in molti comparti manifatturieri e si combina con l’estrema rapidità della consegna, grazie a processi produttivi just-in-time, una duratura rivoluzione organizzativa portata dall’industria giapponese negli anni Ottanta. Forme di automazione iniziano a comparire anche in branche dei servizi che ne sembravano immuni. Un esempio viene dalla finanza e prende il nome di “fintech”, un neologismo contrazione di financial technology che sta a designare l’insieme delle aziende nate negli ultimi anni, prevalentemente negli Stati Uniti, con l’intento di scalzare i tradizionali intermediari finanziari, in particolare le banche, dalle loro posizioni dominanti. Si tratta di piattaforme digitali per il credito peer-to-peer (dal singolo piccolo investitore al singolo piccolo imprenditore, senza intermediari), il crowdfunding (raccolta al dettaglio di fondi per finanziare un progetto da una platea anche vasta di investitori, sempre senza intermediari), l’automated wealth management (gestione automatizzata di risparmi, senza intervento umano). L’ammontare globale di fondi intercettati dal mondo fintech è ancora esiguo, circa 12 miliardi di dollari nel 2014, rispetto ai 4,7 trilioni che costituiscono il mercato potenziale di questi soggetti; ma la crescita è esponenziale. Il dispositivo comune di cui la finanza tecnologica si serve è la sostituzione dell’intervento umano con algoritmi. La cosa ci può far rabbrividire, ma va considerato un punto importante: il vanto di queste aziende non è solo e tanto ottenere risparmi di costo, quanto guadagni di efficacia. È molto più probabile – sostengono gli operatori fintech
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
57
– che una piccola impresa meritevole ottenga credito attraverso una piattaforma peer-to-peer piuttosto che da una banca: per una banca il costo dello screening necessario a concludere che quella certa impresa restituirà con ragionevole certezza il prestito domandato è molto alto, perché ad alta intensità di capitale umano, e non copre il guadagno potenziale. Una piattaforma peer-to-peer è in grado di processare ogni informazione disponibile su quella piccola impresa e sui suoi titolari con appositi algoritmi proprietari, il cui esercizio ha costi quasi nulli, e ricavarne un rating; il risparmiatore che direttamente concede credito a quella impresa, assumendosene il rischio, lo fa perché si fida dell’accuratezza dell’indagine automatica. Non dobbiamo pensare che il futuribile sia già fra noi. La storia ci insegna che l’evoluzione tecnologica e quella umana possono prendere direzioni impreviste, anche regressive. Ma ciò che già osserviamo è abbastanza da farci prendere in seria considerazione l’ipotesi che la finanza retail – creditizia, assicurativa e previdenziale – sarà soggetta a forti sostituzioni di capitale informatico a lavoro. Insomma, una importante porzione del settore terziario rischia di finire “industrializzata”. Se saranno gli intermediari tradizionali a cambiare se stessi per accomodare queste tendenze, o si faranno invece spiazzare da soggetti emergenti, ce lo diranno gli anni a venire. Ora il luogo di produzione. Questione del tutto anacronistica. Le imprese di servizi hanno bisogno di luoghi di produzione tanto quanto le industrie manifatturiere. Saranno uffici, laboratori, pensatoi, alberghi, anziché capannoni, ma l’importanza della localizzazione, anche dal punto di vista della visibilità e della reputazione, è la stessa: basta pensare a che cosa significhi Cupertino per la Apple, o Seattle per Microsoft. Infine, la capacità trasformatrice di materie prime. È un criterio decisivo? Dipende dalla definizione di materia prima. Per creare una poesia non ho bisogno di metalli. Forse ho
58
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
bisogno di energia per riscaldarmi. Certamente ho bisogno della inventività e della sensibilità artistica che sono riposte nella mia mente. Ci pare indubbio che sia una materia prima, come il ferro o l’uranio. I sistemi statistici nazionali che descrivono e misurano le attività economiche sono però ancora oggi saldamente organizzati in accordo con la tripartizione primario-secondario-terziario, come vedremo fra poco. Essi guardano inoltre, nel classificare un’attività, alla natura del bene fisico o del servizio, non anche a cose come: se l’attività si rivolga a un mercato oppure no; quale sia il mercato di riferimento; quali le caratteristiche tecnologiche, il processo produttivo, la governance d’impresa. Vediamo come si fa in Italia. Nella nomenclatura adoperata dall’Istat (Ateco, adattamento della Nace fissata dall’Eurostat, l’agenzia statistica dell’Unione, a sua volta adattamento di Isic delle Nazioni Unite), i grandi raggruppamenti di attività produttive, designati da lettere dell’alfabeto (le “Sezioni”), sono descritti così: A) agricoltura, silvicoltura e pesca, B) estrazione di minerali da cave e miniere, C) attività manifatturiere, D) fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, E) fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, F) costruzioni, G) commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, H) trasporto e magazzinaggio, I) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, J) servizi di informazione e di comunicazione, K) attività finanziarie e assicurative,
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
59
L) attività immobiliari, M) attività professionali, scientifiche e tecniche, N) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, O) amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, P) istruzione, Q) sanità e assistenza sociale, R) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, S) altre attività di servizi. Seguono due gruppi minori (T e U) irrilevanti nel conteggio totale del reddito nazionale. I gruppi A e B costituiscono l’insieme di ciò che si ricava dalla terra, cioè il settore primario. Questa qualità – ricavare beni dalla terra – era esattamente ciò che faceva sostenere ai fisiocratici, e al loro più illustre esponente Quesnay, come coloro che vi lavoravano fossero gli unici lavoratori “produttivi”, mentre artigiani e mercanti erano “sterili”, in quanto meri trasformatori di beni esistenti. I gruppi da C a F costituiscono l’industria, il settore secondario. Tutto il resto, da G a U, è terziario. La nomenclatura Ateco in vigore, il cui ultimo aggiornamento è del 2007, offre a una pur rapida e superficiale osservazione alcune caratteristiche interessanti. Innanzitutto un certo oscuro burocratismo semantico: ad esempio, è difficile capire, nella lunga elencazione di sottovoci delle attività commerciali, le ragioni per cui a volte si usa il termine “agenti e rappresentanti”, a volte “mediatori”, a volte “procacciatori d’affari”, a volte “intermediari del commercio”. In secondo luogo, si percepisce il retaggio di luoghi comuni del passato, mantenuti anche per ragioni di comparabilità
60
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
nel tempo. Alle automobili viene riservata un’enfasi privilegiata: oltre a godere di una sottovoce dedicata all’interno del raggruppamento manifatturiero (C), e va bene, nel raggruppamento commerciale (G) le automobili vengono puntigliosamente distinte da qualunque altro bene commerciato, sia nella sottovoce “all’ingrosso” sia in quella “al dettaglio”. La centralità dell’automobile nel sistema produttivo italiano, resistente nell’immaginario economico e testimoniata da Ateco, è in realtà scomparsa da tempo. In terzo luogo, colpiscono taluni curiosi accostamenti o mancati accostamenti. Vediamone un esempio particolarmente significativo. Il gruppo J, “servizi di informazione e comunicazione”, mette insieme contenuti editoriali e mezzi per la loro diffusione. Già questo è strano: non esistono mestieri e mercati più diversi di quelli di un editore che pubblica un libro – poniamo, la casa Laterza che ospita queste nostre riflessioni – e di un’impresa di telecomunicazioni, come ad esempio il colosso mondiale Vodafone che fa funzionare molti nostri telefoni cellulari. Inoltre, nella sottovoce “attività editoriali” del gruppo J sono ricompresi tutti i programmi tv – incluse, per dire, le serie di fiction – e tutti i film, che invece ci si aspetterebbe di trovare nel gruppo R, “attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”. Il gruppo R include teatri, musei, biblioteche, eventi sportivi, lotterie, discoteche, stabilimenti balneari, ma non Un medico in famiglia o i film di Checco Zalone. La realtà sta correndo più veloce della fantasia dei classificatori statistici, che pure la inseguono come possono. Vi è ormai nel mondo un grande raggruppamento di attività produttive che va comunemente sotto il nome di “intrattenimento (entertainment)” e che include qualunque prodotto o evento sia destinato a intrattenere e divertire il pubblico (vastissima nozione, ormai coincidente con quella di popolo, o cittadinanza). In prima fila vi sono programmi pensati per essere visti su
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
61
un qualunque tipo di schermo: tv, cinema, computer, tablet, smartphone. Resiste, è vero, una distinzione rispetto ai prodotti di “informazione”, i cui capostipiti/antenati sono l’articolo di giornale e il telegiornale. Ma la distinzione va sfumando, al punto da avere generato il neologismo “infotainment”. 2. I SETTORI PRODUTTIVI DELLE GRANDI IMPRESE
C’è un modo semplice e diretto per intuire il senso di marcia del sistema produttivo, quello del mondo intero come quello di ogni singolo paese: censire e analizzare le grandi imprese. Quante sono, che cosa vendono, quanto vendono, quante persone impiegano, quanto guadagnano, quanto le valutano gli investitori. Perché è solo la grande dimensione che consente a un’impresa di generare i due fattori determinanti per il successo duraturo suo proprio e del paese in cui è basata: capacità innovativa costante, che assicuri e alimenti nel tempo il vantaggio competitivo, e non solo l’abilità estemporanea di accendere il fuoco di paglia di una singola idea una tantum; capacità di aggredire il mercato globale con la forza di un marchio riconosciuto da tutto il mondo e di una organizzazione capillare. La forza di un’economia sta nel numero e nella forza delle sue grandi e grandissime imprese. Ci aiutano a ragionare sulle grandi imprese globali le classifiche internazionali che alcune importanti riviste dedicate al mondo degli affari stilano periodicamente. Le più famose sono le americane «Fortune» e «Forbes»2. La prima compila una lista delle prime 500 aziende del mondo per fatturato (ovvero per ricavi totali): Global500. La seconda costruisce una classifica fatta solo di aziende quotate in borsa, ma ne ammette ben 2.000 e le colloca in ordine dimensionale secondo un metodo più complesso, che tiene conto non solo del fatturato (sales)
62
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
ma anche dei profitti che realizzano, dei cespiti che possiedono (assets), della valutazione di borsa: Global2000. Prime impressioni che si ricavano dalle due classifiche riguardano il modo in cui la produzione su larga scala del mondo intero si suddivide fra i diversi settori. Ma prima qualche avvertenza metodologica. Entrambe le liste classificano le imprese anche per settore di appartenenza. La nomenclatura settoriale differisce un po’ fra le due liste, ma in entrambi i casi è riconducibile agli standard statistici ufficiali internazionali. Salta subito all’occhio come le prime posizioni siano prevalentemente occupate da compagnie petrolifere (sei delle prime dieci posizioni per «Fortune») e da banche (sei delle prime dieci posizioni per «Forbes»). Si tratta in entrambi i casi di intermediari, la cui attività si può semplicisticamente descrivere come l’approvvigionarsi di una materia che vale molto (il petrolio in un caso, il denaro dei risparmiatori nell’altro) e il distribuirla al dettaglio ricavandone un margine commerciale. Naturalmente una Shell fa anche altro che distribuire carburanti agli automobilisti: ricerca ed estrae il petrolio, lo raffina, ecc.; così come una Bank of America fa anche altro che intermediazione creditizia tradizionale: gestisce sistemi di pagamenti, vende servizi di investimento o di consulenza, ecc. Tuttavia sorge il dubbio che le cifre del loro fatturato siano gonfiate dall’alto valore intrinseco della materia che maneggiano: il petrolio, il denaro. Nella classifica di «Fortune» questo sospetto è particolarmente fastidioso, dato che il fatturato è l’unica metrica usata per valutare la dimensione. Una metrica migliore per tutte le aziende sarebbe stata il “valore aggiunto”: esso misura solo il valore che l’impresa, appunto, aggiunge con la sua attività a quello degli input produttivi che acquista. Ma si tratta di dati più difficili da reperire nei conti aziendali o da calcolare, sicché «Fortune» e «Forbes» hanno en-
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
63
trambe scelto, per semplicità, di usare variabili come i ricavi (revenues) o le vendite (sales) per misurare il volume d’affari. Nel caso delle banche, che vendono servizi connessi con il denaro, non il denaro stesso, entrambe le classifiche hanno l’accortezza di considerare solo i redditi che quegli intermediari incassano ogni anno come corrispettivo dei servizi che erogano, non anche i flussi annui di depositi. Quindi il loro “fatturato” può essere confrontato con quello di aziende di altro tipo senza troppe distorsioni. Nel caso delle compagnie petrolifere il sospetto di una loro sovrarappresentazione rimane. Potremmo escluderle dalla nostra analisi, ma non lo faremo, consapevoli della grande importanza e potenza che esse comunque rivestono. In ogni caso entrambe le classifiche riportano, per ciascuna azienda, il numero di dipendenti: una misura forse arcaica della dimensione di un’azienda, a sua volta distorta dal fatto che una certa attività può essere a bassa intensità di lavoro e tuttavia importante e lucrativa; ma sarà almeno un utile parametro di controllo. Nel prosieguo faremo riferimento alla sola lista di «Forbes», perché più lunga e completa, anche se limitata alle aziende “public”, come dicono gli angloamericani, cioè quotate in borsa e con azionariato diffuso. D’altro canto, quella è la forma tipica della grande impresa capitalistica. Segnaleremo peraltro qualche caso rilevante di aziende non quotate, tratto dalla lista di «Fortune». Secondo «Forbes» nelle prime 100 posizioni vi sono innanzitutto ben 32 banche (in senso lato, incluse 3 imprese classificate come erogatrici di servizi di investimento, come Goldman Sachs), 6 delle quali sono addensate nelle prime 10 posizioni. Le cinesi sono 10, a iniziare da Icbc, prima impresa nella classifica assoluta, un colosso che ha asset per 3,3 trilioni di dollari, macina 45 miliardi di profitti l’anno, dà lavoro a mezzo milione di persone. Le americane sono 7 (la maggiore è JPMorgan Chase); 4 le australiane; Giappone, Regno Unito,
64
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Canada e Brasile ne hanno 2 a testa; infine, 1 spagnola, 1 olandese e 1 svizzera. Poi vi sono le 10 principali compagnie gaspetrolifere del mondo, 3 americane, 2 cinesi, 1 ciascuna per Olanda, Russia e Francia. Sono marchi noti da tempo ai consumatori occidentali, come Exxon, Chevron, Shell, Total, a cui si aggiungono i nuovi arrivati russi (Gazprom) e cinesi (Petrochina). Le società di telecomunicazioni sono 8: 2 americane, 2 giapponesi, 1 ciascuno per Cina (peraltro la più grande: China Mobile), Regno Unito, Germania e Spagna. Sono anch’esse note. Fra le maggiori: Verizon, AT&T, Vodafone. Le grandi compagnie di assicurazione e riassicurazione sono 8: 2 americane, 2 cinesi e 1 ciascuno per Regno Unito, Germania, Francia, Svizzera. A noi italiani sono note MetLife, Prudential, Allianz, Axa. Fin qui abbiamo contato 58 aziende su 100. Nessuna delle quali ha a che fare con la manifattura in senso tradizionale. Sono imprese che producono servizi; in qualche caso – come per le compagnie petrolifere e di telecomunicazioni – con una qualche materialità “industriale”. La vecchia industria fatta di fabbriche e ciminiere è dunque scomparsa dal panorama delle grandi organizzazioni produttive? Naturalmente no. Nelle prime 100 posizioni di «Forbes» ritroviamo anche i vecchi marchi industriali e i tradizionali settori manifatturieri ereditati dal passato, a iniziare dai produttori di automobili; in ordine decrescente di posizione in classifica vediamo Toyota, Volkswagen, Daimler (Mercedes), Bmw, Honda, General Motors, Ford, Nissan, dunque 3 giapponesi, 3 tedesche e 2 americane. Troviamo la chimica per usi familiari, come le americane Procter&Gamble e Johnson&Johnson, ma soprattutto la farmaceutica, con 5 aziende, 2 americane, 2 svizzere e 1 francese; nomi risonanti, come Pfizer, Novartis, Roche. Troviamo anche l’industria alimentare: la più grande scala produt-
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
65
tiva si raggiunge nelle bevande, dove spiccano il gigante belga Anheuser-Busch InBev – un nome sconosciuto ai consumatori ma detentore di marchi celeberrimi di birra, come Corona, Budweiser, Beck’s – e i classici Coca Cola e PespiCo. Troviamo anche marchi industriali storici come l’americana General Electric e la tedesca Siemens, che si sono però trasformate in conglomerati industrial-terziari: ora fanno di tutto, dai motori d’aereo alle apparecchiature di risonanza magnetica, fino ai servizi finanziari puri. Nel complesso, ricaviamo da questa panoramica di grandi imprese globali la conferma della sparizione di ogni confine netto fra manifattura e servizi; comunque, della dominanza assoluta dei servizi, senza il cui spirito vivificante qualsivoglia manufatto puro e semplice giacerebbe muto e inerte in un magazzino. Ulteriore conferma viene dalla presenza nella parte alta della classifica di altre aziende puramente terziarie: una catena di supermercati discount (Walmart: 2,2 milioni di dipendenti); tre fornitori di servizi web (Apple, Microsoft e Google), i quali vendono col proprio marchio anche degli oggetti tangibili, tablet e smartphone, che hanno però un valore, come abbiamo visto prima, quasi integralmente costituito da servizi. E l’Italia? Finora il nome Italia non lo abbiamo trovato da nessuna parte. Infatti fra le prime 100 non c’è nessuna impresa italiana, mentre ve ne sono di tedesche, francesi, spagnole, olandesi, belghe, per limitarci all’area dell’euro. Nell’intero panel di 2.000 grandi imprese globali le italiane sono 30, l’1,5%. Le tedesche sono 53, di cui 7 nelle prime 100 posizioni. Le francesi sono 61, di cui 5 nelle prime 100 posizioni. Le spagnole sono solo 27, ma 2 nelle prime 100 posizioni. Una curiosità: e le imprese greche? Ne compaiono 8, la maggioranza (5) banche, con i problemi di sopravvivenza di cui le cronache sono state piene nel 2015, e comunque tutte oltre la millesima posizione.
66
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Che imprese sono le 30 grandi italiane? La maggiore secondo il criterio di «Forbes» è l’Eni, una compagnia petrolifera, al 121esimo posto. Segue un’assicurazione, Generali, al 129esimo, e due banche, Unicredit e Intesa Sanpaolo, rispettivamente al 138esimo e 142esimo posto. Le banche sono in tutto 13, le assicurazioni 4. Poi vi sono 4 utilities (cioè imprese che distribuiscono energia o acqua o altre materie di utilità generale che transitano su reti fisiche, o che gestiscono le reti): 2 elettriche (Enel e Terna), 1 del gas (Snam) e 1 mista (A2A); 1 società di telecomunicazioni (Telecom Italia); 1 gestore di autostrade e aeroporti (Atlantia); 1 società di servizi per le imprese (Seat-Pagine Gialle). Delle altre 5, una è la società di investimento finanziario controllata dalla famiglia Agnelli, Exor; un’altra, l’occhialeria Luxottica, è considerata da «Forbes» appartenente non al settore manifatturiero ma a quello dei “negozi specializzati”, poiché la sua principale attività è la gestione di negozi monomarca. Solo le altre 3 sono imprese industriali nella vecchia accezione: Finmeccanica, settore “aerospazio e difesa”; Prada, settore “abbigliamento e accessori”; Pirelli, settore “parti per auto” (il controllo di quest’ultima è peraltro recentemente passato in mani cinesi). Il lettore non giovanissimo potrebbe a questo punto chiedersi: ma dov’è la Fiat? Non c’è. Sappiamo che la Fiat è stata assorbita da una entità più grande, la Fiat Chrysler Automobiles (Fca), che è in realtà presente nella classifica «Forbes», al 289esimo posto, preceduta, oltre che dai già citati primi dieci costruttori di auto, dalla coreana Hyundai, dalla francese Renault, dalla cinese Saic e dall’indiana Tata. Il punto è che Fca è un’azienda inglese, non italiana, avendo stabilito la propria sede legale a Slough nel Regno Unito. Quindi «Forbes» la include fra le 95 imprese inglesi. Potremmo considerare ingiusta quest’attribuzione di nazionalità, ritenendo che si tratti di un’azienda sostanzialmente
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
67
italiana. In realtà, se proprio Fca dovesse essere attribuita a un paese sulla base delle sue localizzazioni produttive, allora sarebbe tutt’al più americana, non italiana. Ma è giusto che sia considerata inglese. Una grande multinazionale può e deve scegliersi il proprio paese di riferimento, anche se continua ad avere stabilimenti produttivi in una molteplicità di paesi. La scelta sarà motivata dall’intero ecosistema giuridico-amministrativo che il paese prescelto offre alle imprese che lo eleggono come il “proprio” paese. E non ci pare che vi siano dubbi su quale dei due, il Regno Unito e l’Italia, offra i tribunali più trasparenti e rapidi, l’amministrazione pubblica più efficiente. La scelta dell’elettorato del Regno Unito in favore dell’uscita dalla Unione europea può far mutare questa scelta, ma difficilmente a favore dell’Italia. Se diamo ora per curiosità un’occhiata alla classifica di «Fortune», vi vediamo 10 imprese italiane sulle 500 elencate, il 2%. Di esse 9 sono incluse anche nella classifica «Forbes», pur in ordine diverso; 1 compare solo in «Fortune», Poste italiane, poiché nel 2014 non era quotata in borsa; lo è diventata nel 2016. A questo proposito, va notata una particolarità delle grandi imprese italiane: la persistente presenza dello Stato nel loro azionariato anche quando sono quotate. Lo Stato detiene il controllo, in misura tale da consentirgli di nominare i vertici aziendali, di Eni, Enel, Finmeccanica, Terna, oltre che di Poste; A2A è controllata da enti pubblici locali; nell’azionariato delle due grandi banche Unicredit e Intesa Sanpaolo resta importante la presenza di fondazioni, enti formalmente privati ma di fatto a loro volta controllati o influenzati da enti pubblici locali. Tutto questo è il residuo della stagione della grande impresa pubblica italiana, di cui abbiamo trattato nel par. 2 del capitolo secondo. Ricapitoliamo. Dal punto di vista della composizione settoriale, la compagine delle grandi imprese italiane non si di-
68
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
scosta dalla norma globale della dominanza del terziario, in particolare delle imprese finanziarie. Sono però più netti in Italia i confini fra servizi e industria di quanto non appaiano in altri paesi, perché non sono rappresentati i settori nei quali sono più intrecciati gli anelli tangibili e intangibili della catena del valore, come il mondo web, le biotecnologie, il sistema salute e benessere. Proprio quei settori che fanno da convoglio alla grande innovazione. La differenza maggiore sta, com’era da aspettarsi, nello sparuto numero di grandi imprese e nell’assenza totale di grandissime imprese rispetto ai paesi con i quali dovremmo confrontarci. La solita, vecchia storia. 3. LA COMPETIZIONE INTERNAZIONALE
Il terreno più significativo per misurare ciò che l’Italia sa fare è quello internazionale. Quanto di quello che le imprese italiane producono è gradito dai consumatori stranieri, tanto da preferirlo a beni analoghi ma prodotti, per esempio, dalle imprese tedesche, francesi, americane o spagnole, vale a dire i nostri principali mercati di esportazione? Quanto le imprese italiane riescono a reggere la crescente pressione concorrenziale delle imprese dei paesi emergenti tanto da mantenere o addirittura ampliare la propria quota di esportazioni sul mercato mondiale? Di questa materia è fatta la competitività internazionale di un paese, che suscita sorpresa quando viene declinata per l’Italia. L’associazione tra “competitività” e “Italia” desta infatti più di una meraviglia sia nella pubblicistica che negli articoli accademici, fino a sfociare in titoli come The Italian Competitiveness Puzzle, che si potrebbe tradurre come “lo strano caso della competitività italiana”. E il cui sottotesto si potrebbe così
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
69
formulare: dai dati l’Italia risulta essere un paese competitivo sul mercato mondiale e ciò sorprende alla luce delle criticità accusate su più fronti, dal versante strettamente economico a quello sociale e istituzionale. L’internazionalizzazione di un paese si compone di un insieme di attività solitamente suddivise in due ampie categorie: a) l’internazionalizzazione commerciale, cioè le importazioni, le esportazioni, la penetrazione commerciale, gli accordi di fornitura; b) l’internazionalizzazione produttiva, ossia gli investimenti delle imprese estere nel nostro paese (attrazione passiva) e quelli effettuati dalle nostre imprese all’estero (attrazione attiva). Con l’intento di fornire qualche elemento di analisi che permetta di orientarsi nello “strano caso della competitività italiana”, l’attenzione sarà focalizzata sull’internazionalizzazione commerciale e, in particolar modo, sulle esportazioni, le cui tenuta e dinamica, strettamente legate ai livelli di produttività delle imprese, costituiscono il riflesso più forte della competitività generale del nostro paese. Partiamo dal modello di specializzazione italiano. La specializzazione di un paese riflette la natura dei suoi vantaggi comparati, indica cioè quali beni (finiti o intermedi) ha maggiore convenienza a produrre, offrendoli in cambio di beni (finiti o intermedi) dove la convenienza risulta minore. Per misurare la specializzazione di un paese si utilizzano diversi indicatori, uno tra i quali è l’indice di vantaggio comparato rivelato di Balassa (1965), basato sulle esportazioni; esso, seppure non esente da critiche, rimane tra i più ampiamente utilizzati3. Valori dell’indice maggiori di 1 segnalano una specializzazione del paese in un dato settore; di converso, valori dell’indice inferiori a 1 indicano una despecializzazione del paese in una specifica produzione, dunque uno svantaggio comparato rivelato.
70
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Come è noto, ne abbiamo già parlato nei parr. 1 e 2 del capitolo secondo, la specializzazione produttiva italiana è concentrata nei settori tradizionali (il “Made in Italy”, cioè prodotti tessili, abbigliamento, pellami e manufatti in pelle, arredamento, mobili, gioielleria) che incidono nel 2015 per il 23% sul totale delle esportazioni di merci. Il settore meccanico, altro elemento di punta del nostro modello di specializzazione, spiega, invece, il 18% del totale. La specializzazione del Belpaese è andata maturando dall’inizio degli anni Ottanta (si veda il par. 2 del capitolo secondo) per poi cristallizzarsi nel tempo, tanto da configurarsi come una anomalia tutta italiana in quanto significativamente differente da quella degli altri paesi avanzati, specializzati, invece, in settori con economie di scala e/o ad alta tecnologia e intensità di ricerca nei quali l’Italia risulta despecializzata. La specializzazione italiana, d’altro canto, è pericolosamente simile a quella dei paesi emergenti, in primis la Cina, assai temibili sul versante della competitività di prezzo, dovuta al minore costo del lavoro nelle imprese di quei paesi, la cui concorrenza si è infatti sensibilmente avvertita a partire dagli anni Novanta. Tuttavia, numerosi studi4 dimostrano che la similarità tra il modello di specializzazione italiano e quello dei paesi emergenti è diventata, nel corso del tempo, più sfumata, in quanto le nostre imprese, pur rimanendo all’interno dei settori tradizionali, si sono spostate, via via, su prodotti di elevata qualità, smarcandosi così dall’assedio dei concorrenti low cost, relegati a prodotti posizionati su fasce di prezzo più basso. Come segnalato dall’aumento dei valori medi unitari dei beni tradizionali esportati, le imprese italiane hanno infatti puntato, nel corso del tempo, su fattori di competitività diversi dal prezzo, quali alta qualità, reputazione del brand, differenziazione del prodotto.
71
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
Tabella 1. Trade Performance Index per settori e paesi, 2014 Posizione Settori
Italia
Germania
Francia
Spagna
33
26
25
1
6
1
3
5
25
1
30
11
1
2
19
16
Prodotti chimici
28
1
2
20
Prodotti in cuoio
1
14
17
10
Manufatti di base
2
1
25
5
Prodotti alimentari freschi Prodotti alimentari trasformati Prodotti in legno Tessile
Meccanica non elettronica
2
1
11
9
24
11
20
27
Componenti elettronici
2
1
21
25
Mezzi di trasporto
2
1
16
8
Abbigliamento
1
18
14
16
Altri manufatti
2
1
25
35
48
30
25
22
Elettronica IT e di consumo
Minerali Fonte: International Trade Center, 2016.
In numeri (cfr. tabella 1), l’upgrading di prodotto si traduce in un piazzamento settoriale di tutto rispetto delle imprese italiane, che, secondo il Trade Performance Index (elaborato dall’International Trade Center), risultano al primo posto nella classifica mondiale in tre settori: tessile; abbigliamento e prodotti in cuoio, dove non è difficile immaginare il pregio dell’alta gamma italiana. Le imprese italiane si collocano, invece, al secondo posto dopo la Germania, in cinque altri settori: manufatti di base, meccanica non elettronica, componenti elettronici, mezzi di trasporto e manufatti diversi (tra questi, articoli in plastica, occhiali, gioielleria).
72
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Il modello di specializzazione nei settori tradizionali rimane dunque confermato e manifesta un’apprezzabile competitività. Di nuovo rispetto agli anni Novanta, c’è che lo sfondamento nell’alta gamma (elevata qualità e lusso) potrebbe, in un prossimo futuro, soddisfare la domanda di consumatori diversi da quelli occidentali, le classi medie dei paesi emergenti, le cui possibilità di spesa si vanno facendo sempre più consistenti. Tracce di questi mercati potenzialmente forti, capaci di condurre a una diversa composizione della domanda estera dei nostri prodotti, sono già ben visibili. Le esportazioni italiane verso tali paesi sono aumentate da poco meno di 8 miliardi di euro del 1990 a circa 73 miliardi nel 2015; apprezzabili risultati si sono conseguiti soprattutto nei beni destinati alla casa e alla persona, più precisamente prodotti di cuoio e pelli, borse, tappeti, tessuti, indumenti e calzature, orologi e gioielli, macchine e apparecchi elettrici, mobili e oggetti d’arte5. Naturalmente, resta da verificare quanto ci si riuscirà a consolidare, o addirittura ad espandere, su questi mercati. Infatti, “consumatori dei paesi emergenti” significano spesso mercati lontani, come la Cina, l’India, il Sud Africa – per fare qualche esempio; mercati dove i costi fissi della penetrazione commerciale sono elevati e dove la capacità di presidio richiede una scala dimensionale delle imprese ben più alta della nostra media italiana. Al netto dei molteplici elementi decisamente positivi, sul versante occidentale dei nostri scambi (mercato tedesco, francese, nord-americano), il maggiore elemento di criticità rimane la sostenibilità futura di un modello che vive di nicchie popolate da beni di lusso in mercati, come quello europeo, caratterizzati da una bassa crescita della domanda. “Eppur si muove”, verrebbe da aggiungere. Segnali di un’auspicabile trasformazione del modello di specializzazione dell’economia italiana provengono, infatti, dall’andamento di
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
73
medio periodo delle industrie dell’elettronica, della farmaceutica e dei mezzi di trasporto, che si sono dimostrate particolarmente dinamiche nel periodo 2011-2015. Si tratta di settori ad alto contenuto innovativo, in cui le imprese italiane possono senz’altro puntare a guadagnare migliori quote di mercato, in virtù di una dimensione media di impresa e un livello di produttività sensibilmente più elevati della media del manifatturiero e una significativa presenza di multinazionali operanti nel nostro territorio (è il caso, per esempio, del farmaceutico). Le esportazioni: i dati e la teoria Un potente alleato nel contenere i danni ingenti causati dalla Guerra dei Sette Anni (2008-2014) precedentemente evocata, è intervenuto dal fronte esterno. La domanda estera è stata, infatti, nel 2008 e, successivamente, a partire dal 2011 (con l’eccezione del 2015), l’unica voce dei conti nazionali con dinamica positiva, mentre crollavano i consumi e gli investimenti interni, e, di conseguenza, aumentava la disoccupazione. Dopo la crisi, l’Italia si colloca al decimo posto nel ranking dei primi venti esportatori mondiali di merci, con una quota sul totale del commercio mondiale pari a 2,8%; ben al di sotto dell’8,1% della Germania, al terzo posto della classifica, con il primo detenuto dalla Cina e il secondo dagli Stati Uniti6. Sebbene l’Italia abbia perso in qualche modo terreno – è scesa dal 2010 di due posizioni, con una quota di mercato allora leggermente superiore e pari al 2,9% (quota a prezzi correnti) – i dati recenti interrompono la tendenza in discesa in atto dal 2006. In uno scenario di persistente riduzione della domanda interna, l’operatività sui mercati esteri, ossia la capacità delle nostre imprese di vendere beni intermedi e/o prodotti finiti ai consumatori tedeschi, francesi, nord-americani, spagnoli, inglesi, ha parzialmente contrastato l’erosione del numero di imprese manifatturiere che si è acuita sotto i colpi della grande
74
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Tabella 2. Rapporti caratteristici delle imprese manifatturiere esportatrici e non esportatrici per classi di addetti, 2012 Classi dimensionali
% di imprese
Addetti (mediana)
Esportatrici
Non esportatrici
Esportatrici
Non esportatrici
0-9
12,6
87,4
4,0
2,0,
10-49
55,7
44,3
17,2
13,7
50-249
88,8
11,2
81,8
70,5
250 e oltre
97,4
2,6
419,1
356,6
Totale
20,8
79,2
9,5
2,0
Fonte: R. Monducci, Nuove informazioni statistiche sulle imprese, paper presentato alla dodicesima Conferenza nazionale di statistica, Istat, Roma, 22-24 giugno 2016.
recessione: tra il 2008 e il 2012, le imprese sono diminuite del 2,4% (-10.600 imprese all’anno)7. Come si spiega la maggiore resilienza della larga parte delle imprese che si proiettano sui mercati internazionali rispetto alle imprese confinate ad uno sbocco domestico dei propri prodotti? Uno sguardo ai dati relativi al 2012 su alcuni indicatori ci aiuta a comprendere la “diversa natura” delle imprese esportatrici8. La carenza di dati sull’intera economia italiana ci obbliga a focalizzare l’attenzione sul manifatturiero che, d’altro canto, è il comparto economico da cui si origina la maggior parte delle esportazioni di merci (l’84%)9. Innanzitutto, quante sono le imprese che esportano10? Circa 190mila, di cui approssimativamente 90mila nella manifattura, il 22% del totale delle imprese manifatturiere. Relativamente poche, in effetti, ma di elevato contributo, visto che incidono per l’82% del valore aggiunto manifatturiero. Inoltre, le imprese esportatrici (cfr. tabella 2): a) sono mediamente più grandi (la metà delle esportatrici
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
Produttività mediana (migliaia)
Imprese ad alto rapporto impiegati operai (%)
75
Imprese ad elevata retribuzione (%)
Esportatrici
Non esportatrici
Esportatrici
Non esportatrici
Esportatrici
Non esportatrici
29,8
17,3
59,0
30,9
40,7
35,7
45,6
32,1
82,8
61,7
59,0
48,5
57,6
39,2
89,0
75,1
84,0
79,3
68,1
32,7
88,4
75,8
87,9
76,9
39,6
18,4
73,1
35,9
57,3
41,1
impiega almeno 9,5 addetti, di contro ai 2 addetti delle imprese non-esportatrici); b) sono più produttive (la metà delle imprese ha una produttività del lavoro di circa 40mila euro, contro i 18mila euro delle imprese non-esportatrici); c) presentano un più elevato rapporto tra impiegati e operai, che segnala una maggiore articolazione delle funzioni aziendali e un più alto livello del capitale umano impiegato, da cui ne consegue che le imprese esportatrici corrispondono salari significativamente più elevati. Oltre il 57% delle esportatrici offre salari “elevati” (la remunerazione media del lavoratore dipendente è superiore al valore mediano del settore di appartenenza), contro il 41,1% delle imprese che non esportano. Secondo diversi indicatori (dimensione, produttività, articolazione funzionale, salari), le imprese esportatrici appaiono dunque di superiore qualità e su ciò si fonda la loro maggiore resilienza. Un altro dato interessante riguarda la polarizzazione delle
76
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
imprese esportatrici: un numero relativamente esiguo di imprese, il 6,4% delle esportatrici – si tratta di imprese mediograndi, da 50 ad oltre 249 addetti – genera il 75,1% delle esportazioni11. Tale concentrazione, per una volta, non è una peculiarità esclusivamente italiana, ma comune alla maggior parte dei paesi europei, dove, in media, l’80% delle esportazioni è effettuato dal 10% delle imprese esportatrici. Si tratta di un club esclusivo (the happy few, i pochi eletti)12. Il numero di imprese che esportano (si parla di margine estensivo13) è, di conseguenza, esiguo ma ad alta capacità di traino, visto che esse spiegano una quota maggioritaria delle esportazioni totali. Di fatto, la competitività internazionale di un paese è affidata ad un gruppo relativamente esiguo di imprese. L’esclusività del club costituisce ulteriore prova del fatto che abbiamo a che fare con una tipologia di impresa significativamente e sistematicamente diversa dalle imprese che vendono esclusivamente sul mercato interno, come prima testimoniato dai dati. Guardando al lungo periodo, il numero di imprese italiane che esportano è aumentato del 3,5% negli ultimi dieci anni14. L’ampliamento del margine estensivo è sicuramente una buona notizia. L’incremento si registra tra le imprese di più piccole dimensioni, e tuttavia la loro incidenza sul totale del valore delle esportazioni è bassa15, ben al di sotto della possibilità di modificare significativamente la performance aggregata del paese, che rimane pertanto ancora affidata ai “pochi eletti”. Veniamo ora alla teoria. La diversa natura e rilevanza dell’impresa esportatrice è un’acquisizione relativamente recente, che risale alla fine degli anni Novanta. Secondo un nuovo e ricco filone di letteratura sull’internazionalizzazione delle imprese16, ciò che rende l’impresa esportatrice diversa è il suo superiore livello di produttività, che consente, differentemente dalle imprese domestiche, di affrontare i costi fissi dell’internazionalizzazione, quali ad esempio ricerche di mercato,
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
77
dei canali distributivi, di adeguamento dei prodotti17. Si tratta di un processo di autoselezione che determina una forma di ordinamento gerarchico fra tre classi di imprese: in basso, le meno produttive orientate al mercato interno; più su, le imprese che esportano e, ancora più su, quelle con produttività più elevata, che effettuano investimenti diretti, producendo anche al di fuori del paese d’origine. Dunque, ciò che in ultima analisi determina la capacità di esportare sono le caratteristiche specifiche di ogni singola impresa e, in particolare, quella soglia di produttività oltre la quale le imprese riescono a fronteggiare agevolmente l’arena globale. Ne consegue che nella competitività esterna non contano tanto le caratteristiche del paese e del settore – come si è pensato per lunghissimo tempo, quando si ipotizzava che imprese appartenenti a uno stesso settore fossero omogenee, avessero, cioè, un identico livello di produttività. All’interno di ogni settore, l’eterogeneità delle imprese è, invece, piuttosto elevata; questo riscontro fa saltare l’assunzione della cosiddetta impresa rappresentativa e, al tempo stesso, presenta implicazioni non banali anche per il corretto disegno delle misure di policy. Infatti, l’approccio del tipo one size fits all, appropriato nel caso di imprese omogenee, metterebbe a serio rischio proprio l’efficacia delle misure di policy18. Al di là del processo di autoselezione, che si opera ex ante e attraverso il quale solo le imprese più produttive riescono a fronteggiare i costi fissi della esposizione sui mercati esteri, diversi lavori teorici ed empirici19 hanno messo in luce che alcuni miglioramenti della produttività potrebbero provenire, ex post, dalla stessa attività di esportazione attraverso un processo di apprendimento, una sorta di “learning by exporting”. Qui il processo di causazione procede secondo una direzione inversa rispetto a quella precedentemente considerata, poiché muove dall’attività di esportazione alla produttività. Secondo
78
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
il “learning by exporting”, un’impresa che comincia ad esportare “impara” dall’operatività sui mercati esteri: il confronto con i clienti esteri induce, ad esempio, un ampliamento nella gamma dei prodotti, e l’apprendimento genera un miglioramento nella performance d’impresa, ne accresce la dimensione e ne innalza la produttività. La competitività internazionale ai tempi delle catene globali del valore Finora, per valutare la competitività internazionale dell’Italia abbiamo fatto ricorso alle analisi basate sul modello di specializzazione e i vantaggi comparati rivelati, sulle quote di mercato, sul margine intensivo ed estensivo delle esportazioni. Ma quanto cambia il quadro, se analizzato inforcando le lenti delle catene globali del valore (Cgv), cioè incorporando nell’analisi il processo della divisione internazionale del lavoro così come si è andato riconfigurando negli ultimi venticinque anni? Con le Cgv, il processo produttivo di gran parte dei beni viene suddiviso in diverse fasi di produzioni o funzioni allocate a singole imprese, localizzate in paesi diversi, ognuna delle quali aggiunge incrementi di valore fino ad arrivare all’assemblaggio e alla susseguente vendita ai consumatori. Con le Cgv, le imprese sviluppano e combinano forme più complesse di internazionalizzazione. Due prodotti simbolo della frammentazione internazionale della produzione sono la bambola Barbie della Mattel (multinazionale americana fondata nel 1945, in piena epoca fordista!) e l’iPhone della Apple, prodotti tipici di due brand americani, diremmo, ma in effetti “made in the world”. La plastica e i capelli di Barbie sono forniti dal Giappone e da Taiwan, i vestiti di Barbie, realizzati con cotone cinese, sono in parte anche cuciti in Cina, su modelli disegnati negli Stati Uniti.
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
79
Il design dell’iPhone è messo a punto dalla Apple negli Stati Uniti, la produzione avviene, però, per la maggior parte al di fuori degli Stati Uniti e arriva a coinvolgere ben nove imprese, localizzate in Cina, Corea, Giappone, Germania e Stati Uniti. Tutte le diverse componenti realizzate da queste imprese sono poi spedite per l’assemblaggio finale a Foxconn, un’impresa cinese, che, dalla propria sede di Shenzen, esporta l’iPhone negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Infine, per fare un esempio che ci riguarda più da vicino, consideriamo il Dreamliner 787, l’aereo a lungo raggio assemblato dall’americana Boeing e alla cui produzione, fra le altre imprese, partecipa anche l’italiana Alenia, che realizza la sezione centrale della fusoliera, avvalendosi a sua volta di imprese fornitrici localizzate in Piemonte, Puglia e Campania. Questi tre esempi ci mostrano che, a livello di scambi globali, le importazioni dei beni intermedi sono diventate via via sempre più consistenti, tanto da arrivare a coprire la metà delle importazioni mondiali di manufatti20. Ci mostrano anche che i beni intermedi, a causa della frammentazione internazionale della produzione, varcano le frontiere numerose volte. Tenendo questi esempi bene a mente, la questione diventa se sia corretto ragionare ancora avendo presente unicamente il valore lordo del bene finale esportato, senza distinguere quanto è stato effettivamente generato nel paese esportatore. Insomma, la specializzazione di un paese all’interno della Cgv potrebbe essere addirittura più rilevante di quello che esporta? In effetti, la Cina non compete con gli altri paesi sulle esportazioni dell’iPhone, ma unicamente sull’assemblaggio delle singole componenti, in cui esibisce un vantaggio comparato. Abbiamo già parlato di Cgv nel par. 2 del capitolo secondo, delineando quali sono le opportunità e le difficoltà fronteggiate dalle imprese italiane nel nuovo contesto di dispersione
80
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
internazionale della produzione. Proseguiamo ora nell’esplorazione delle implicazioni delle Cgv, integrando ulteriori elementi di analisi che consentiranno di mettere meglio a fuoco la questione della competitività internazionale del nostro paese, per come si riconfigura ai tempi delle Cgv. Una premessa da sottolineare: mancano a tutt’oggi dati di buona qualità che permettano di analizzare a fondo i molteplici aspetti, macro e micro, connessi al fenomeno delle Cgv. A livello macro, qualche significativo passo in avanti è stato fatto con il data base Wiod (World Input – Output Database)21. Attraverso le matrici input-output, relative alle esportazioni di 40 paesi per il periodo 1995-2011, le esportazioni lorde di un paese (ossia, quelle prese a riferimento finora nelle statistiche ufficiali, per l’Italia pari al valore di circa 493 miliardi nel 2015, di cui 405 miliardi in esportazione di beni e 88 miliardi in esportazione di servizi22) possono essere scomposte in tre parti: a) il valore aggiunto generato internamente; b) il valore aggiunto estero; c) una componente residuale, associata al valore aggiunto interno o esterno che è stato già contato. Per i dati a livello di impresa, invece, la carenza informativa è profonda, con la conseguenza che spesso si utilizzano dati subottimali per analizzare questioni rilevanti e di interesse vitale per il corretto disegno delle misure di policy. L’Italia nelle Cgv Al pari di altri paesi come la Germania e la Francia, l’Italia si è caratterizzata per una crescente integrazione nelle Cgv attraverso l’intenso ricorso a fornitori esteri. Infatti, la quota di valore aggiunto generato all’estero e inglobato, per mezzo di importazioni di prodotti intermedi, nelle esportazioni italiane del manifatturiero è cresciuta significativamente. In partico-
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
81
lare, “i settori le cui esportazioni sono cresciute di più della media nazionale negli ultimi quindici anni sono anche quelli dove l’intensità del valore aggiunto interno contenuta nelle esportazioni si è ridotta maggiormente”23. C’è stato dunque un “effetto Cgv” che ha esercitato un impatto positivo sulle esportazioni24. Quanto cambia il modello di specializzazione italiano quando lo calcoliamo prendendo in considerazione le esportazioni in valore aggiunto? Cambia poco: sono infatti confermati tutti i settori di specializzazione commerciale, quali articoli in pelle e calzature, prodotti tessili e abbigliamento, mobili, macchinari e attrezzature. La specializzazione appare solo meno marcata rispetto a quanto emerge considerando le esportazioni lorde25. Dal livello macro, l’Italia, restringiamo il focus alle imprese, di fatto le vere protagoniste delle Cgv. Come si misura la partecipazione ad una Cgv? Non c’è ad oggi un indicatore comunemente accettato, e questo è principalmente dovuto alla carenza di microdati (per non menzionarne l’ardua accessibilità) nelle statistiche correnti. Tipicamente, un’impresa che importa beni intermedi, esporta beni intermedi o finali e/o organizza la sua produzione all’estero, partecipa a pieno titolo ad una Cgv26. Certo, c’è anche una questione di intensità della partecipazione alla Cgv, che può essere misurata attraverso la combinazione di due variabili: 1) l’ammontare delle importazioni, delle esportazioni, degli investimenti all’estero; 2) il numero di modalità di partecipazione. Un’impresa potrebbe scegliere di importare beni intermedi che saranno poi utilizzati per produrre un bene destinato al mercato locale. In un’occorrenza del genere, l’impresa partecipa alla Cgv attraverso una sola modalità, quella della importazione dei beni intermedi. Oltre alla partecipazione e alle modalità di coinvolgimen-
82
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
to, un altro indicatore di grande significatività concerne il posizionamento dell’impresa lungo la Cgv. Per tornare all’esempio precedente, qual è la differenza, in termini di posizionamento lungo la Cgv, tra Boeing ed Alenia? Alenia è un’impresa intermedia, mentre Boeing è un’impresa finale, in quanto assembla le diverse parti dell’aereo che vende poi alle compagnie aeree dei diversi paesi. Intermedie sono le imprese che vendono ad altre imprese, finali le imprese che vendono ai consumatori. Le imprese intermedie rappresentano il necessario complemento dell’attività dei grandi attori delle Cgv (assemblatori e distributori) e sono, a loro volta, coprotagonisti delle nuove forme di specializzazione e partecipazione alla divisione internazionale del lavoro che si definiscono attraverso le Cgv. Come messo in evidenza nel par. 2 del capitolo secondo, la maggioranza delle imprese italiane sono imprese intermedie. Non c’è da stupirsi, date le caratteristiche della struttura industriale italiana, dove il 98% del manifatturiero è costituto da unità con meno di 50 addetti. Infatti, le funzioni a valle (la vendita del prodotto finale) e a monte (la ricerca e/o il design del prodotto), a causa della presenza delle economie di scala e dei costi fissi della internazionalizzazione, sono in genere appannaggio delle grandi imprese, quasi sempre multinazionali. Due tipologie di impresa poco presenti in Italia27. Quanto rileva questo peculiare posizionamento rispetto alla performance aziendale e, in ultima istanza, come incide sul posizionamento del paese nella divisione internazionale del lavoro, sulla sua competitività? Una parziale risposta agli interrogativi viene dal lavoro di Richard Baldwin del 2012, che rappresenta con una curva a U (l’indovinata Smile Curve inventata da Stan Shih, fondatore dell’Acer) l’apporto di valore aggiunto di ogni specifica funzione aziendale, di ogni compito svolto dall’impresa.
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
83
Rendimenti delle diverse attività
Figura 1. La “Smile Curve”
R&S
Servizi
Design
Marketing
Logistica: Acquisti
Logistica: Distribuzione Produzione
Attività intangibili a monte
Produzione – Attività tangibili
Attività intangibili a valle
Nella Smile Curve, le funzioni più remunerative si collocano a monte (ricerca e sviluppo, design del prodotto) e a valle (assemblaggio, marketing, diffusione del brand). Nel punto di minimo della curva e nel suo intorno si colloca la manifattura vera e propria: una fase spesso standardizzata, mediamente ad alta intensità di lavoro, soggetta a forte pressione competitiva, dove le imprese sono facilmente fungibili e lo spiazzamento da parte delle imprese dei paesi emergenti altamente probabile. Dalle evidenze empiriche emerge come le imprese italiane si collochino, nella maggior parte, proprio nell’intorno del punto di minimo della curva a U. Secondo alcuni, tale posizionamento riflette uno svantaggio competitivo derivante da minore dimensione, caratterizzata quindi da scarsa capacità sia di penetrazione sui mercati esteri, sia di capacità innovativa28. Inoltre, la più alta incidenza di imprese intermedie rispetto a quelle finali ha spiegato, in parte, la minore capacità del sistema produttivo italiano di fronteggiare e superare i contraccolpi della grande recessione, rispetto al sistema tedesco, che possiede una più alta percentuale di imprese finali29.
84
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Secondo altri, quella porzione della curva è popolata, anche in questo caso, da imprese piuttosto eterogenee, una popolazione, cioè, in cui imprese intermedie “marginali” coesistono con imprese intermedie “avanzate”. Queste ultime mostrano un’alta propensione a esportare e a innovare30, i propri lavoratori sono mediamente in possesso di un livello elevato di capitale umano. La propensione all’esportazione, all’innovazione e alla formazione del personale sono particolarmente importanti per le imprese intermedie avanzate al fine di conseguire i vantaggi derivanti dall’apertura internazionale. Sono proprio queste le caratteristiche che consentono alle imprese intermedie di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla frammentazione internazionale della produzione e raggiungere, nel tempo, più elevati guadagni di produttività. Gli stessi studi fanno emergere, infatti, un dato rilevante, e cioè che la performance delle imprese intermedie avanzate non risulta statisticamente differente da quella delle imprese finali. Dunque, dall’essere impresa intermedia non consegue necessariamente un indistinto tratto peggiorativo delle imprese italiane coinvolte nelle Cgv, che getterebbe un’ombra lunga sulla collocazione del paese nella divisione internazionale del lavoro. Tenendo nel dovuto conto l’eterogeneità delle imprese intermedie, il dato preoccupante è che le imprese intermedie evolute sono relativamente poche: nel Centro-Nord il 30% del totale delle imprese intermedie. E sono ancor meno nel Mezzogiorno, solo il 14%31. Tirando le fila. Le Cgv costituiscono un’indubbia opportunità di agganciare mercati più grandi e di scambiare beni intermedi con imprese più avanzate, come per esempio le imprese multinazionali, spesso agenti coordinatori delle Cgv. Le Cgv consentono, inoltre, alle imprese di avvantaggiarsi, nella loro operatività, delle esternalità che si generano lungo le Cgv32, nonché di accedere, attraverso le importazioni di beni inter-
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
85
medi, a tecnologie più avanzate e a un’ampia varietà di beni intermedi33, oltre che di sfruttare vantaggi di costo. E tuttavia la capacità di cogliere una tale opportunità sembra essere territorialmente concentrata e appannaggio di pochi. Se, da un lato, con le Cgv si manifesta un’ulteriore preoccupante declinazione del divario tra la struttura produttiva meridionale e quella centro-settentrionale34, dall’altro, il numero delle imprese intermedie avanzate del Centro-Nord è ancora troppo esiguo per potere sostenere al meglio la competitività internazionale che appare, anche per le Cgv, appoggiata solo sulle spalle dei “pochi eletti”. Quali politiche? La scala delle politiche necessarie per diffondere al meglio le opportunità offerte dalle Cgv travalica i confini nazionali. A differenza del passato in cui la politica commerciale insisteva unicamente sui beni finiti che attraversavano i confini nazionali, la stretta compenetrazione dei sistemi produttivi comporta un ampliamento della stessa nozione di commercio internazionale, richiede un mutamento delle politiche commerciali, induce una trasformazione della governance a livello mondiale. Soffiano venti protezionistici in questa stagione di bassa crescita e di difesa strenua degli interessi nazionali, dunque il rischio – e lo si sta correndo in questi mesi con il fallimento del Ttip, l’accordo commerciale tra gli Stati Uniti e l’Unione europea – è di imporre restrizioni al libero commercio. Laddove la piena operatività delle Cgv richiederebbe, invece, la facilitazione degli scambi di beni intermedi tra le imprese dei diversi paesi, un potente canale che “trasmette” la tecnologia incorporata nei beni intermedi. L’imposizione di tariffe ed altre misure protezionistiche causano, infatti, un aumento dei costi delle importazioni dei beni intermedi e, di conseguenza, l’incremento dei costi di
86
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
produzione. Su un diverso versante, qualsiasi intervento di svalutazione competitiva è destinato ad essere di breve respiro perché il vantaggio di prezzo che si consegue rischia di essere eroso dal maggiore costo delle importazioni dei beni intermedi. A questo livello di scala, le principali implicazioni di policy sono di una piena liberalizzazione unitamente a misure che facilitino le procedure amministrative di passaggio ai confini e rendano più efficiente la logistica degli scambi. Per quanto concerne il livello nazionale, si riscontrano almeno tre ambiti in cui politiche correttamente disegnate potrebbero contribuire ad una migliore competitività internazionale del paese. In primo luogo, l’ampliamento del numero delle imprese capaci di cogliere a pieno le opportunità offerte dalle Cgv. Come si è visto, il sistema industriale è polarizzato (il club dei pochi eletti) e ripropone la stessa concentrazione anche nel caso delle imprese intermedie, le imprese al centro della fitta rete di scambi, che vivono di vendite ad altre imprese. Nel complesso, i costi della partecipazione alle Cgv sono amplificati rispetto a quelli tipici della sola attività di esportazione (quelli che vengono denominati sunk costs). A questi si sommano infatti anche i costi informativi relativi all’attività delle importazioni, per esempio, l’individuazione delle imprese da cui approvvigionarsi, la conoscenza degli standard produttivi, la normativa che regola gli scambi con paesi diversi. L’insieme di questi costi costituisce spesso un vincolo alla piena partecipazione alle Cgv, un ostacolo avvertito soprattutto dalle imprese di minore dimensione, la cui produttività è al di sotto di quella necessaria per coprire i costi informativi relativi alla partecipazione alle Cgv. Politiche che riducano i costi internazionali di transazione, che forniscano, con efficienza, “servizi reali” come informazioni sui mercati di esportazione e di importazione, potreb-
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
87
bero costituire una leva per quel salto di produttività oltre il quale la partecipazione delle imprese si fa più ampia35. La rimozione delle barriere informative potrebbe attenuare la polarizzazione che caratterizza attualmente il sistema economico italiano. Politiche di questa natura, orizzontali e non distorsive, se ben amministrate, potrebbero infatti concorrere ad elevare lo standard di partecipazione alle Cgv, a somiglianza di quanto si verifica in paesi come la Francia e la Germania. Un secondo intervento concerne il miglioramento del funzionamento dei mercati. Significativi passi avanti sono stati fatti già prima della grande crisi del 2008, come documentato da un recente lavoro36. È auspicabile continuare su questo percorso per eliminare i vincoli che ostacolano lo spostamento delle risorse verso impieghi più produttivi. Residuali inefficienze nell’allocazione del lavoro e, soprattutto, del capitale impediscono alle imprese di spostarsi al di sopra di quella soglia di produttività richiesta per una piena partecipazione alle Cgv con conseguenze negative sulla performance dell’impresa stessa, che si riverberano in una minore competitività a livello aggregato37. Un terzo aspetto concerne il drammatico ritardo di informazione statistica, più acutamente avvertita a livello micro, sui dati di impresa. Il buon disegno delle politiche e, di non minore importanza, la corretta e indipendente valutazione ex post della loro efficacia richiedono dati appropriati alla conoscenza del fenomeno, ricchi dal punto di vista informativo, facilmente accessibili agli studiosi e ai decisori pubblici. Su questo versante si accusa un serio ritardo delle istituzioni che hanno il compito di misurare i fenomeni economici della dimensione e rilevanza delle Cgv. C’è da augurarsi che vi si ponga prontamente rimedio. Al grande storico economico italiano Carlo Cipolla viene spesso attribuita la frase “missione dell’Italia è produrre
88
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
all’ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo”. Non vi è dibattito sulla competitività e sulle sorti italiane che non citi quella frase. Non ci sottraiamo a quest’obbligo, dobbiamo però avvertire che la citazione è falsa. Cipolla scrisse in realtà38: “siamo un popolo che non può permettersi di fermarsi [...] dobbiamo sempre inventare cose nuove che piacciano e che [...] si vendano fuori dei confini”. Dell’ombra dei campanili neanche l’ombra. L’aggiunta apocrifa è singolare, ma indicativa di una mentalità. È chiaro che cosa l’anonimo ermeneuta avesse in mente: l’Italia delle botteghe e degli opifici medievali e rinascimentali, l’epoca dei pannilana e delle sete, ma anche della nostra dominanza mercantile e finanziaria. Quell’epoca d’oro in cui, pur nella divisione politica, ogni campanile italiano proiettava la sua ombra benevola su coloro che, ciascuno al modo del suo territorio, facevano fiorire lo stile, l’abilità, l’ideazione. Costoro diedero al complesso dei campanili italiani, al Nord e al Sud, l’egemonia economica nel mondo occidentale conosciuto, per tre secoli; un’egemonia poi perduta nei tre secoli successivi, in cui l’economia italiana rovinò, fino alla metà dell’Ottocento. La capacità di produrre in modo competitivo con le maggiori economie fu in parte ritrovata al volgere dell’Ottocento nel Novecento, poi ancora nella breve stagione del “miracolo economico” terminata mezzo secolo fa. In entrambe le fasi i campanili non furono granché rilevanti, soprattutto nella industrializzazione dell’età giolittiana. Venivano fondate e fatte sviluppare grandi industrie, a volte con grandi capitali esteri, nella siderurgia, nella chimica di base, settori allora al centro del mondo avanzato. I campanili tornarono importanti negli scorsi anni Ottanta con i distretti industriali – la via italiana di conciliare piccola dimensione con le esigenze di una produzione moderna; i
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
89
campanili sono stati fondamentali, perché un distretto può solo prosperare in territori circoscritti, ad alto capitale sociale. Che futuro può avere un’economia avanzata che metta localismo e familismo al centro del suo modo d’essere? Un futuro assai incerto, negli scenari che abbiamo prima evocato. Per inventare e vendere cose nuove che piacciano, occorre oggi una capacità organizzativa, una padronanza delle tecnologie via via che si succedono l’una all’altra, un’inventiva non occasionale ma sistematica, una forza di penetrazione in mercati distanti per geografia e per cultura, che solo la dimensione medio-grande e la crescita aziendale continua possono dare. Le poche cifre che abbiamo prima rammentato sulla polarizzazione del sistema produttivo italiano parlano chiaro. La porzione frammentata e debole del sistema deve rafforzarsi attraverso consolidamenti, fusioni, acquisizioni, che consentano ad un numero maggiore di imprese di accrescere la propria competitività. Potrà succedere solo se crescerà il numero di quegli imprenditori illuminati che preferiscono alla leadership della propria famiglia nell’azienda quella dell’azienda sul mercato. Ma non basta. Perché la nostra struttura produttiva si trasformi nel senso indicato dalla storia occorre che si diffonda un costume, una cultura, a favore dell’impresa innovativa e della sua rapida crescita. Le politiche pubbliche sono in questo molto importanti. Ne abbiamo prima parlato. Devono essere ben informate e contribuire ad allievare i costi informativi della internazionalizzazione. Devono assicurare le premesse della trasformazione: un ambiente normativo e amministrativo favorevole, anziché ostile, al libero mercato e all’impresa; un sistema di istruzione che metta a disposizione delle imprese innovative dei giovani con le conoscenze e le abilità più adatte. Per avanzare in entrambe le direzioni bisogna battere localismi e familismi.
90
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
NOTE 1 Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, Istat, Roma 2015, p. 5, www. istat.it/archivio/150332. 2 http://beta.fortune.com/fortune500; http://www.forbes.com/global2000. 3 B. Balassa, Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage, in «Manchester School of Economic and Social Studies», 33, 1965, pp. 99-123; L. Iapadre, Measuring international specialization, in «International Advances in Economic Research», 2, 7, 2001, pp. 173-183; L. De Benedictis, Three decades of Italian comparative advantage, in «The world economy», 11, 28, 2005, pp. 1679-1709; Oecd, Handbook on Economic Globalisation Indicators, Oecd, Parigi 2005. 4 S. De Nardis, F. Traù, Il modello che non c’era, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005; A. Lanza, B. Quintieri, Eppur si muove. Come cambia l’export italiano, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007. 5 D. Langiu, G. Marciante, Nuovi spazi per le esportazioni italiane? La crescente domanda di beni di consumo nei mercati emergenti, in Rapporto Ice 2015-16. L’Italia nell’economia internazionale, Ice, Roma 2016, www.ice.gov.it. Nel lavoro vengono considerati un sottoinsieme dei paesi emergenti, rispetto al gruppo Emerging markets and developing economies, come definito dal Fondo monetario internazionale. 6 Rapporto Ice 2015-16 cit. 7 S. De Nardis, Potenziale Manifatturiero, in Nomisma, Scenario, 11 febbraio 2015, http://www.nomisma.it/index.php/it/newsletter. 8 S. Costa, F. Luchetti, D. Zurlo, Esportare crea occupazione? La domanda di lavoro delle imprese manifatturiere esportatrici nel periodo 2014-15, in Rapporto Ice 2015-16 cit. 9 E. Mazzeo, L’internazionalizzazione commerciale delle imprese italiane, in Rapporto Ice 2015-16 cit. 10 R. Monducci, Nuove informazioni statistiche sulle imprese: coerenza micro-macro, multidimensionalità, integrazioni tra fonti, intervento alla XII Conferenza nazionale di statistica “Più forza ai dati: un valore per il Paese”, Roma, 22-24 giugno 2016. 11 Mazzeo, L’internazionalizzazione commerciale cit. 12 T. Mayer, G.I.P. Ottaviano, I pochi eletti: nuovi fatti sull’internazionalizzazione delle imprese europee, in «L’Industria», 2, 2008, pp. 211-244. 13 Il margine intensivo denota invece l’ammontare delle esportazioni per ogni singola impresa. 14 In questo caso, il dato si riferisce al numero di operatori economici, cioè coloro che hanno effettuato almeno una transazione commerciale con l’estero nel periodo considerato. 15 Mazzeo, L’internazionalizzazione commerciale cit. 16 A.B. Bernard, J.B. Jensen, Exceptional exporter performance: cause, effect, or both?, in «Journal of international economics», 1, 47, 1999, pp. 1-25; M.J. Melitz, The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity, in «Econometrica», 6, 71, 2003, pp. 1695-1725; A.B. Bernard, J.B. Jensen, Why Some Firms Export, in «The Review of Economics and Statistics», 2, 86, 2004, pp. 561-569; E. Helpman, M. Melitz, S. Yeaple, Exports versus FDI with Heterogeneous Firms, in «American Economic Review», 94, 2004, pp. 300-316. 17 M. Bugamelli, L. Infante, Sunk costs of exports, in «Temi di discussione (Working Papers)», 469, 2003. 18 Sulla eterogeneità delle imprese italiane, cfr. D. Castellani, F. Serti, C. Tomasi, Firms in international trade: importers and exporters heterogeneity in Italian manufacturing industry, in «The World Economy», 3, 33, 2010, pp. 424-457. 19 S. Clerides, S. Lach, J. Tybout, Is learning by exporting important? Micro-dynamic
capitolo terzo Che cosa si produce e a chi si vende
91
evidence from Colombia, Mexico, and Morocco, in «Quarterly Journal of Economics», 3, 113, 1998, pp. 903-948; A. Lileeva, D. Trefler, Improved access to foreign markets raises plant-level productivity, NBER Working Paper 13297, National Bureau of Economic Research, Cambridge (Mass.) 2007. Per l’Italia, si rimanda a F. Serti, C. Tomasi, Selfselection and post-entry effects of exports. Evidence from Italian manufacturing firms, in «Review of World Economics», 4, 144, 2008, pp. 660-694. 20 K. De Backer, S. Miroudot, Mapping global value chains, «European Central Bank – Working Paper Series», 1677, 2014. 21 Per la metodologia di scomposizione, si rimanda a Z. Wang, S. Wei, K. Zhu, Quantifying International production sharing at the bilateral and sector levels, Nber working paper, 2013; R. Koopman, Z. Wang, S. Wei, Tracing value-added and double counting in gross exports, in «American economic review», 2, 104, 2014, pp. 459-494. 22 Dati di contabilità nazionale. 23 A. Felettigh, G. Oddo, Quote di mercato sul valore aggiunto e catene globali del valore, in Rapporto Ice 2015-16 cit. 24 J. Amador, R. Cappariello, R. Stehrer, Global value chains: a view from the euro area, Working Paper Series 1761, European Central Bank, 2015; R. Cappariello, A. Felettigh, How does foreign demand activate domestic value added? A comparison among the largest euro-area economies, in «Temi di discussione (Working Papers)», 1001, 2015. 25 L. Dell’Agostino, S. Nenci, Il modello di specializzazione della manifattura italiana alla luce dei nuovi dati in valore aggiunto, in Rapporto Ice 2015-16 cit. 26 R. Veugelers (a cura di), Manufacturing Europe’s future, Bruegel, Brussels 2013; J. Baldwin, B. Yan, Global value chains and the productivity of Canadian manufacturing firms, in «Economic Analysis – Research Paper Series», March 2014. 27 Sul ruolo delle multinazionali, cfr. G. Barba Navaretti, A.J. Venables et al., Multinational Firms in the World Economy, Princeton University Press, Princeton 2006. 28 S. Federico, Outsourcing versus integration at home or abroad and firm heterogeneity, in «Empirica», 37, 2010, pp. 47-63; T. Razzolini, D. Vannoni, Export premia and subcontracting discount: passive strategies and performance in domestic and foreign markets, in «World Economy» 6, 34, 2011, pp. 984-1013; R. Veugelers (a cura di), Manufacturing Europe’s future, Bruegel blueprint, Bruegel 2013. 29 A. Accetturo, A. Giunta, Value chains and the great recession: evidence from Italian and German firms, in «Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)», 304, 2016. 30 A. Accetturo, A. Giunta, S. Rossi, Le imprese italiane tra crisi e nuova globalizzazione, in «Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)», 86, 2011; R. Veugelers, F. Barbiero, M. Blanga-Gubbay, Meeting the manufacturing firms involved in GVCs, in Veugelers (a cura di), Manufacturing Europe’s future cit.; M. Agostino, A. Giunta, J.B. Nugent, D. Scalera, F. Trivieri, The importance of being a capable supplier: Italian industrial firms in global value chains, in «International small business journal», 7, 33, 2015, pp. 708-730; Accetturo, Giunta, Value chains and the great recession cit. 31 R. Bronzini, L. Cannari, A. Staderini, L’industria meridionale e la crisi, in «Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)», 194, 2013. 32 G. Giovannetti, E. Marvasi, M. Sanfilippo, Supply chains and the internationalization of SMEs: evidence from Italy, in «Small Business Economics», 44, 2015, pp. 845-865. 33 M. Agostino, A. Giunta, D. Scalera, F. Trivieri, Importazioni, produttività e catene globali del valore: un’analisi sulle imprese europee, in Rapporto Ice 2015-16 cit. 34 A. Giunta, A. Nifo, D. Scalera, Subcontracting in Italian Industry. Labour division, firm growth and the North-South divide, in «Regional Studies», 8, 46, 2012, pp. 1067-1083; Svimez, Rapporto Svimez 2016 sull’economia del Mezzogiorno, il Mulino, Bologna 2016.
92
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
35 Come per altri ambiti di intervento pubblico in Italia, si accusa una ridondanza e frammentazione normativa, solo parzialmente attenuata di recente, che incide negativamente sulla efficacia delle politiche a sostegno della internazionalizzazione, cfr. F. Vergara Caffarelli, G. Veronese, Il Sistema Paese a supporto dell’internazionalizzazione, in «Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)», 196, 2013. 36 A. Linarello, A. Petrella, Productivity and reallocation: evidence from the universe of Italian firms, in «Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)», 353, 2016. 37 Per una evidenza parzialmente diversa su questi aspetti, cfr. S. Calligaris, M. Del Gatto, F. Hassan, G.I.P. Ottaviano, F. Schivardi, Italy’s productivity conundrum: the role of resource misallocation, in «VoxEu», June 28, 2016. 38 C.M. Cipolla, Storia facile dell’economia italiana dal Medioevo a oggi, Mondadori, Milano 2007, p. xv.
capitolo quarto
COME SI PRODUCE
1. LA DOMINANZA DELLE IMPRESE “FAMILIARI”
L’impresa familiare svolge nell’economia italiana un ruolo centrale. Al punto da essere a volte considerata un’anomalia del nostro paese, in passato ritenuta un punto di forza, può oggi contribuire a tenerne bloccata la crescita. Il concetto economico di impresa familiare non è definibile facilmente. Il fenomeno è straordinariamente eterogeneo: si va dalla bottega di quartiere alla grande multinazionale quotata in Borsa; fra questi due estremi c’è un infinito ventaglio di forme intermedie. Tra i molti criteri definitori utilizzati nella letteratura economica quello prevalente fa riferimento al grado di coinvolgimento di una famiglia in un’azienda, nella proprietà e nella gestione; vi si può aggiungere un criterio dinastico, misurando l’inclinazione della famiglia proprietaria/ controllante a tenere confinato all’interno della famiglia il trasferimento del controllo dell’impresa e a rendere esplicite le preferenze successorie del capo-azienda. Le definizioni possibili sono dunque varie: quelle più ampie richiedono quote anche non maggioritarie di proprietà dell’impresa, purché la famiglia ne eserciti, sia pure solo indirettamente, il controllo. Definizioni più strette richiedono un
94
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
controllo proprietario diretto e tengono in conto se la famiglia proprietaria rivesta o no ruoli rilevanti nel management e nella gestione dell’impresa. Una definizione ancora più ristretta richiede la proprietà totalitaria, ruoli nella gestione per i familiari e una forte motivazione dinastica. Qualunque sia la definizione adottata a fini di misurazione del fenomeno, la teoria economica che giudizio dà dell’impresa familiare? Un giudizio icastico, del tipo: l’impresa familiare è sempre un bene, oppure è sempre un male? No, ovviamente. Il tema non può essere analizzato in astratto: va affrontato empiricamente e calato in una data realtà storica e istituzionale; è impossibile esprimere delle massime che siano valide in tutti i paesi e in ogni fase storica. Intanto, il punto di vista può variare: se è microeconomico si volgerà a misurare la performance dell’impresa (profittabilità, espansione, crescita dimensionale, competitività internazionale, ecc.); se è macroeconomico si volgerà invece a valutare i riflessi sul benessere della comunità nazionale in cui l’impresa opera. Tuttavia, in quasi tutti i casi pratici le due ottiche sono connesse: una impresa dà il miglior contributo possibile al benessere collettivo se è dinamica e profittevole. Ciò detto per doverosa cautela metodologica, è ben vero che emergono, nel corpus di studi teorici dedicati all’argomento, due classi di giudizio sull’impresa familiare. Una prima guarda alla famiglia imprenditrice in modo molto positivo, considerandola un dispositivo efficiente che consente all’impresa una performance migliore: l’orizzonte temporale di una famiglia proprietaria sarebbe per definizione più lungo, le sue strategie più lungimiranti, il suo comportamento meno concentrato sugli accadimenti di breve periodo, meno ossessionato dal risultato delle “quadrimestrali”. In una impresa familiare sarebbero maggiori gli incentivi a una supervisione attenta del management (naturalmente lì dove il management
capitolo quarto Come si produce
95
sia terzo rispetto alla famiglia); maggiore l’allineamento degli interessi fra proprietà e management; migliore la trasmissione della conoscenza tra appartenenti alla stessa famiglia, soprattutto in quei settori produttivi in cui la conoscenza è impalpabile, fatta ad esempio di alta sapienza artigiana. Una ulteriore ragione per cui questa scuola di pensiero guarda con favore all’impresa familiare è che essa saprebbe in genere resistere meglio nelle fasi di crisi: una guida salda e lungimirante, tipica dell’imprenditore familiare, la renderebbe meno preda del panico. In un’altra parte della letteratura teorica prevalgono invece considerazioni critiche. La principale è che certi valori, o disvalori, sedimentati in una famiglia controllante possono spingerne i componenti a estrarre dal controllo dell’impresa benefici di breve-medio periodo per sé soli (“benefici privati del controllo”), con conseguenze spiacevoli o nefaste per l’impresa nel suo insieme. Ad esempio: una tendenza a mantenere il controllo dell’impresa anche quando ciò non sia più produttivo in termini di performance della stessa; l’ostinazione a far sopravvivere l’impresa nella sua forma originaria, impedendone l’evoluzione, anche quando ciò non risulti più vantaggioso; una selezione inefficiente o addirittura controproducente dei dirigenti e dei successori; una eccessiva avversione al rischio – soprattutto nei casi in cui buona parte della ricchezza familiare sia concentrata nell’impresa – che mortifichi gli animal spirits, ingrediente essenziale di qualunque avventura imprenditoriale di successo. Ma questa è ancora e solo teoria. Come si avvertiva prima, il tema va affrontato empiricamente. Dalla letteratura empirica, prevalentemente basata su campioni di imprese quotate nei principali paesi avanzati, emerge chiaramente come gli effetti del controllo familiare sulla performance dell’impresa non dipendano tanto dal fatto in sé, quanto dal modo in cui l’impresa
96
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
è controllata: se il controllo è diretto, la performance risulta in genere migliore rispetto a quella di una impresa non familiare comparabile; se è esercitato attraverso strutture piramidali, la performance risulta mediamente peggiore. In particolare, alcuni studi mostrano un deciso vantaggio relativo dell’impresa familiare quando il controllo è esercitato dal fondatore. Nelle imprese controllate da generazioni successive il vantaggio tende ad attenuarsi, fino a rovesciarsi, a far prevalere cioè i casi di sfruttamento di benefici privati per i controllanti. Gioca a favore delle imprese familiari ancora controllate dal fondatore anche il fatto che, di fronte a uno shock negativo, esse appaio no reagire meglio rispetto a quelle già passate ai successori. Queste ultime tendono inoltre a essere più piccole delle non familiari comparabili. Dalla letteratura empirica dedicata specificatamente al caso italiano si ricavano alcune interessanti caratteristiche del nostro sistema1: il mantenimento ostinato del controllo nel lungo periodo, a scapito di profittabilità e crescita, porta a una minore capacità di sfruttare le opportunità di mercato; una minore diversificazione del portafoglio dei proprietari, quindi una concentrazione della ricchezza familiare nella proprietà dell’impresa, porta a una maggiore avversione al rischio e, di conseguenza, a investimenti più influenzati dall’incertezza delle condizioni di contesto; nei momenti storici in cui l’incertezza diventa molto acuta, le imprese familiari nella cui proprietà è maggiore la concentrazione della ricchezza familiare sono decisamente meno propense all’investimento; una maggiore avversione al rischio normalmente implica anche una minore propensione all’esportazione, perché l’affacciarsi su mercati lontani è attività intrinsecamente più rischiosa e più incerta; un management familiare ha effetti negativi sulla propensione a esportare e a innovare; è inoltre documentata una tendenza, allorché si debba assumere un manager e fissarne gli incentivi,
capitolo quarto Come si produce
97
a valorizzare la vicinanza o la fedeltà, caratteristiche spesso nocive alla crescita e alla redditività. Queste caratteristiche, rilevate studiando empiricamente le nostre imprese, non bastano a configurare un’anomalia italiana: mancano confronti internazionali che ne dimostrino l’unicità. I confronti internazionali sono in genere resi ardui dalle incertezze definitorie e dalla mancanza di dati omogenei. La disponibilità della banca dati Efige ce ne consente alcuni, a cominciare dal peso che le imprese familiari hanno nelle rispettive economie. I dati Efige ci permettono di usare una definizione molto ampia di impresa familiare (“impresa controllata direttamente o indirettamente da un individuo o da più individui uniti da legami familiari”, dunque anche una microimpresa o un’impresa individuale) e di confrontare con sufficiente omogeneità i casi di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna. Consideriamo due diversi indicatori di “peso” nell’economia delle imprese familiari, uno di diffusione (numero di imprese familiari in rapporto al numero totale di imprese presenti in ciascuna economia) e uno di rilevanza macroeconomica (percentuale di occupati in imprese familiari sul totale degli occupati nell’intera economia). La diffusione delle imprese familiari è molto alta e piuttosto uniforme nei cinque paesi considerati: in tutti è superiore all’80%, in Germania sfiora il 90%; in Italia è dell’86%. La rilevanza macro (occupazione) è più bassa, data la prevalenza fra le imprese familiari della piccola dimensione (nel Regno Unito si scende al 41%, in Germania al 77%, in Italia al 70%), ma si tratta comunque di dati consistenti. In Italia appare alto (84%) il numero di imprese in cui non soltanto la proprietà o il controllo sono familiari, ma lo è anche la figura dell’amministratore delegato. Non è ancora
98
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
un’anomalia vistosa, anche in Germania questo dato è cospicuo (85%). La peculiarità del caso italiano inizia a emergere quando contiamo le imprese familiari in cui tutto il management è di famiglia: in Italia due terzi, in Spagna un terzo, in Germania e in Francia poco più di un quarto, nel Regno Unito addirittura solo un decimo. Se collochiamo le imprese del campione Efige in tre classi dimensionali (meno di 50 dipendenti; fra i 50 e i 250; oltre i 250), l’anomalia italiana si precisa ancora meglio proprio nella classe dimensionale più alta, in cui ci si aspetterebbe un rarefarsi del peso delle imprese familiari. Guardando a quelle il cui amministratore delegato è un membro della famiglia, l’Italia appare significativamente fuori linea, con una incidenza del 75% (sebbene non troppo distante dalla Germania, al 71%). Ma sono le imprese in cui tutto il management è di famiglia ad avere una presenza straordinariamente più alta in Italia che negli altri paesi nella classe dimensionale over 250: un quarto delle imprese familiari italiane di quella dimensione hanno il management interamente familiare, contro incidenze fra il 3 e il 7% negli altri paesi. Per illustrare il punto, valga un aneddoto. Qualche anno fa alcuni ricercatori della Banca d’Italia, fra cui uno degli autori di questo libro, visitarono un’impresa lombarda di circa cinquecento dipendenti, operante in un settore ad altissima tecnologia. Il fondatore dell’impresa, un signore sui settantacinque anni, ricevette il gruppo ed esordì: “questa impresa l’ho fondata io e l’ho diretta per molti anni. Quando ho deciso di passare la mano, perché diventavo troppo anziano, ho guardato in faccia tutti i miei figli e ho capito che nessuno di loro sarebbe stato in grado di prendere il mio posto come leader dell’impresa. Mi sono detto: basta, quoto in borsa l’azienda e seleziono un amministratore delegato sul mercato
capitolo quarto Come si produce
99
dei manager. Così ho fatto: vi sto ricevendo io in qualità di fondatore e presidente onorario, però ora andiamo di là, in sala riunioni, dove ci attendono l’amministratore delegato e i capi delle diverse divisioni, loro vi spiegheranno tutto”. Si andò di là, lui presentò gli astanti senza indicarne i nomi, solo le funzioni (capo del personale, capo del marketing, ecc.). Ci si aspettava che passasse la parola all’amministratore delegato, seduto accanto a lui; invece, continuò a parlare lui per due ore consecutive, senza che gli altri potessero aprire bocca. Alla fine si scoprì che il capo del marketing, il capo del personale, ecc., erano tutti suoi figli, quelli cioè che non aveva reputato in grado di prendere il suo posto; ma li aveva sistemati tutti in azienda come manager. Il povero amministratore delegato si ritrovava schiacciato fra il padrone sopra di lui e i figli del padrone, nominalmente alle sue dipendenze. Non sappiamo che fine abbia fatto quell’amministratore delegato, ma è probabile che poco dopo se ne sia andato. Dunque, un’anomalia italiana c’è, ma non sta nella grande diffusione delle imprese familiari, sta nella combinazione di proprietà, gestione (soprattutto nella forma estrema di un intero management composto da membri della famiglia controllante) e dimensione dell’impresa: l’abnorme presenza di imprese “integralmente” familiari (dal controllo proprietario al management) nella classe over 250 si accompagna col fatto che in quella classe dimensionale “alta” le imprese italiane sono comunque mediamente più piccole di quelle degli altri pae si avanzati (poco più di 700 addetti, contro i 900 di Germania e Francia). È legittimo chiedersi se vi sia un nesso causa-effetto fra i due fenomeni e se ciò concorra a spiegare la difficoltà dell’economia italiana nell’essere competitiva e dinamica. La prolungata quasi-stagnazione della nostra economia viene spesso imputata, almeno in parte, a una troppo piccola dimensione media delle imprese. È sempre bene rammentare
100
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
che l’analisi di questo fenomeno va fatta in termini dinamici, non statici: non è l’istantanea della struttura produttiva italiana scattata oggi a doverci preoccupare, ma il film degli ultimi vent’anni, che mostra come questa struttura non si sia evoluta nel tempo. Supponiamo che per far crescere la dimensione della propria azienda un imprenditore debba prendere un metaforico ascensore. A un certo punto della vita di ogni piccola impresa italiana di successo accade che le porte dell’ascensore improvvisamente si aprano e che i proprietari/manager siano invitati a entrarvi per salire; in Italia, molto più spesso che in altri paesi, accade che, o i proprietari/manager esitano e le porte si chiudono, cosicché l’occasione sfuma, oppure essi entrano nell’ascensore, ma pigiano il pulsante del secondo piano, anziché, come pure potrebbero, quello del trentesimo. Se si tratta comunque di imprese di successo potremmo in fin dei conti pensare che lasciarle nella loro piccola dimensione sia un bene per loro e, di riflesso, anche per il paese. Ma se questo poteva essere sostenibile fino agli anni Ottanta non lo è più dopo di allora, perché il mondo è nel frattempo cambiato, sotto i due fondamentali profili tecnologico (Ict) e di dimensione dei mercati rilevanti (globalizzazione). Il nuovo mondo è molto meno ospitale di quello precedente per imprese piccole e semplici. I nuovi paradigmi tecnologico e di mercato avrebbero dovuto sbloccare l’ascensore dimensionale in Italia, inducendo una ristrutturazione delle aziende e un aumento della loro dimensione media. Questa ristrutturazione l’abbiamo vista cominciare a metà del passato decennio, in ritardo rispetto ad altri paesi e solo a macchia di leopardo. Poi è arrivata la crisi, di fronte alla cui acutezza e vastità le imprese che finalmente si erano decise a riorganizzarsi in funzione delle nuove tecnologie e a estendere la loro presenza sui mercati interna-
capitolo quarto Come si produce
101
zionali, cercando vie di accrescimento dimensionale, si sono fermate. Che ruolo ha giocato la proprietà familiare in tutto questo? Soltanto il 10% delle imprese familiari italiane supera i 500 addetti, contro il 20% di quelle non familiari; le imprese familiari fanno più fatica a “prendere l’ascensore” verso una dimensione più grande. Inoltre, esse hanno in media più debito, soprattutto bancario, delle non familiari e sono quindi più esposte a razionamenti del credito. Questo aspetto è cruciale: sia la teoria economica sia l’evidenza empirica suggeriscono che, per sostenere l’innovazione e la crescita nel lungo periodo, occorre più capitale che debito. La domanda cruciale diviene allora: perché le famiglie proprietarie, ancor più se esprimono anche il management, non prendono volentieri l’ascensore dimensionale? Qui ci inoltriamo in un territorio di confine fra l’analisi economica e quella sociologica. Un primo fattore riguarda le motivazioni soggettive: nel linguaggio degli economisti, la funzione di utilità individuale del proprietario o del manager familiare attribuisce talvolta all’ambizione personale meno peso che al movente dinastico; oppure attribuisce alla salvaguardia del patrimonio di famiglia più peso che al potenziamento del capitale dell’impresa. L’età media dei capi-azienda italiani è elevata; se il ricambio al vertice procederà come nell’ultimo decennio, fra qualche anno un quarto delle imprese familiari sarà guidato da ultrasettantenni, con performance mediamente peggiori di quelle delle imprese guidate dai giovani e un rafforzamento del movente di consolidamento patrimoniale e successorio della famiglia. Un secondo e decisivo fattore sta nella interazione fra gli animal spirits dell’imprenditore e l’ambiente circostante. Le imprese vivono in un “ecosistema” fatto di ordinamento giuri-
102
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
dico, funzionamento della macchina giudiziaria, fisco, relazioni industriali, funzionalità e costo dei servizi pubblici e tanto altro; un ambiente che sappiamo essere in Italia particolarmente ostile all’impresa e alla sua vita. L’impresa familiare può allora offrire tutele maggiori di fronte all’ostilità dell’ambiente, ad esempio di fronte a un enforcement debole delle norme di legge e regolamentari. Che fare, dunque? Innanzitutto bonificare al più presto l’“ecosistema” normativo-istituzionale-amministrativo: una giu stizia civile inefficiente limita le possibilità di crescita delle imprese; oneri burocratici impropri costituiscono uno svantaggio competitivo; possono indurre a non sfruttare opportunità di investimento e di espansione. Occorre agire su una molteplicità di leve, sì da modificare gli incentivi degli imprenditori, stimolandoli all’innovazione, alla crescita, al rischio. Per favorire il capitale rispetto al debito occorre stimolare, anche fiscalmente, lo sviluppo degli intermediari specializzati proprio nello spingere le imprese a salire sull’ascensore dimensionale: fondi di venture capital per le imprese nascenti, fondi di private equity per quelle già cresciute che vogliano ulteriormente espandersi. Anche in questo caso vanno modificati gli incentivi per gli agenti economici: da un lato, è carente la domanda da parte delle imprese di servizi finanziari di quel tipo, per la loro scarsa voglia di “mettersi estranei in casa” (un fondo inserisce propri emissari nei consigli di amministrazione per influenzare la gestione); dall’altro, è carente l’offerta, poiché la piccolezza delle imprese italiane le rende poco appetibili a un intermediario di quel tipo, per la relativa modestia degli affari potenziali. È un cane che si morde la coda. Incentivi fiscali agli aumenti di capitale (nella forma dell’allowance for corporate equity, Ace) sono stati previsti dal decreto legge 201 del dicembre 2011.
capitolo quarto Come si produce
103
Resta un problema più ampio, di costume nazionale, di capitale sociale. Alcuni studi suggeriscono che le imprese familiari sono più diffuse nei paesi in cui il capitale sociale è più basso e, corrispondentemente, i valori familiari sono più forti. Risultati analoghi si trovano in Italia confrontando Nord e Sud. Ricapitoliamo. L’economia del nostro paese sembra avere smarrito la capacità di accrescere il reddito e l’efficienza produttiva. Perché l’Italia si trova in queste condizioni da così tanto tempo? Fra le tante ragioni ne spicca una: una struttura produttiva che non riesce a evolvere né nella sua articolazione dimensionale né, di conseguenza, in quella settoriale. Da noi non avviene quanto altrove invece succede regolarmente, cioè che dalla sterminata platea delle piccole e piccolissime imprese si stacchi periodicamente un gruppo che sale alla media dimensione, e che dal plotone delle imprese medie se ne stacchi al tempo stesso un certo numero (anche piccolo) che sale alla grande o grandissima dimensione. Perché ciò non accade? Per la presenza di tante imprese familiari? Abbiamo visto che queste non sono una peculiarità italiana. L’anomalia risiede nella maggior frequenza con cui da noi le imprese familiari affidano posizioni dirigenziali a componenti della famiglia. Vi sono elementi per ritenere che, almeno in certe realtà, questo danneggi sia la performance dell’azienda, sia soprattutto la sua capacità di cogliere le opportunità necessarie per compiere un salto dimensionale quando queste si presentino sul mercato. Da qui l’esigenza di studiare nuovi modi per conciliare gli interessi dei gruppi familiari proprietari, che non possono certo essere ignorati, con le esigenze di crescita. Non basta, non serve, esortare moralisticamente le famiglie proprietarie delle imprese a cederne il controllo nell’interesse superiore dell’economia nazionale. Serve piuttosto uno schema appropriato di incentivi
104
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
e disincentivi. C’è spazio per interventi di politica economica volti a orientare i comportamenti degli imprenditori e dei proprietari familiari delle imprese verso soluzioni che vadano sì a vantaggio della famiglia, ma anche della collettività. 2. IL DIFETTO DI PRODUTTIVITÀ
Nel 2005, l’Italia conquista il poco ambito rango di “the real sick man of Europe”. L’espressione pare sia stata coniata dallo zar Nicola I di Russia a proposito delle difficoltà dell’impero ottomano nella metà del Novecento. Viene ripresa figurativamente dall’autorevole periodico inglese «The Economist» nel 19 maggio del 2005 (l’immagine in copertina è quella dello “stivale” italiano sorretto da stampelle), il settimanale aveva usato, qualche anno prima, quella stessa metafora per la Germania. L’immagine trova immediata eco nel dibattito, accademico e pubblicistico, sul declino dell’Italia. Che cosa stava accadendo in quel periodo tanto da decretare che il paese stesse, ineluttabilmente, scivolando lungo il tratto discendente di una parabola? Dopo un periodo di deludente crescita di alcuni paesi europei, negli anni 20012005, la Francia (Pil +1,6%) e la Spagna (+3,1%) si staccano dal gruppo per agganciarsi alla ripresa mondiale in corso (la grande crisi arriverà nel 2008), mentre il Pil italiano arranca vistosamente (la variazione del Pil italiano è pari allo 0,7%). In difficoltà appare anche la Germania, che tuttavia sarà il primo paese europeo a riprendersi brillantemente dalla crisi. In realtà, segnali di rallentamento dell’economia italiana erano già emersi nella seconda metà degli anni Novanta, per accentuarsi marcatamente con l’inizio degli anni Duemila. Questo trend discendente è ciò che fa pensare al declino, cioè alla incapacità del sistema produttivo di fronteggiare le mutate
capitolo quarto Come si produce
105
condizioni di contesto, dovute alla introduzione, a metà degli anni Novanta, delle tecnologie della informazione e della comunicazione (Ict), all’accentuarsi dell’integrazione commerciale e produttiva (si pensi alle catene globali del valore), alla crescente competizione delle imprese dei paesi emergenti (la Cina aderisce al Wto nel 2000), all’introduzione della moneta unica in Europa. Questi shock colpiscono tutti i paesi industrializzati, ma l’Italia è il paese che ne risente più acutamente e negativamente. Tra i tanti, il segnale più forte delle difficoltà del sistema produttivo italiano è rappresentato dal cattivo andamento della produttività del lavoro e della produttività totale dei fattori (Ptf). La produttività del lavoro è data dal rapporto tra il valore della produzione di beni e servizi di un paese, di una regione, di una impresa in un anno e il numero di occupati (o delle ore lavorate: in questo caso si parlerà di produttività oraria). La Ptf è un indicatore più complesso che misura l’efficienza con cui sono combinati i fattori produttivi, il lavoro e il capitale. Il motore di una economia è, infatti, soprattutto nella produttività, il cui incremento genera un aumento della ricchezza di un paese e dei suoi abitanti. È la dinamica della produttività che principalmente spiega il miracolo economico italiano degli anni Sessanta e la crescita degli anni successivi; è il suo rallentamento (seconda metà degli anni Novanta) e successiva stagnazione (dagli anni Duemila fino al 2014) che causano la deludente performance dell’economia italiana, quelle che si potrebbero etichettare come “due decadi perdute”. Prima della crisi Vediamo in maggiore dettaglio il ruolo giocato dalla produttività del lavoro nella crescita del paese. A questo fine, analizziamo brevemente le principali componenti in cui si può scomporre il tasso di crescita del Pil e suddividiamo la nostra analisi in
106
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
due sottoperiodi: dal 1995 al 2008, cioè prima della crisi ma quando già si avvistano i primi segnali di arretramento del Pil, e il periodo successivo 2008-2014. L’analisi sarà comparativa, confronteremo cioè gli andamenti dell’Italia con quelli di Francia e Germania. Aritmeticamente, il tasso di crescita del Pil si può scomporre in quattro tassi di variazione2: 1. della popolazione complessiva; 2. della quota della popolazione complessiva che ha un’età da lavoro (15-64 anni, secondo gli standard statistici internazionali); 3. della quota di popolazione in età da lavoro che è effettivamente occupata; 4. del prodotto per occupato, cioè la produttività del lavoro. I primi due addendi sono squisitamente demografici e dipendono da variabili quali le scelte procreative delle generazioni feconde e lo stato di salute della popolazione, che si riflette sulla mortalità infantile e sulla sopravvivenza in età senile. Tali variabili sono, a loro volta, profondamente influenzate dalla situazione economica generale e dalle scelte di politica economica. Il terzo addendo (tasso di occupazione) dipende dalla capacità del sistema produttivo di creare posti di lavoro aggiuntivi (dunque, in ultima analisi dipende dalla stessa capacità di crescita dell’economia) e dal funzionamento del mercato del lavoro, cioè di quella peculiare istituzione che è preposta a far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro. Il quarto addendo (la produttività del lavoro) dipende dalle abilità professionali dei lavoratori, a loro volta influenzate dall’istruzione e dall’addestramento ricevuti, dall’ammontare di apparecchiature e macchinari, dalla qualità tecnologica degli strumenti (in altre parole dal capitale fisico). Guardiamo ai dati della tabella 3, in cui si mette a fuoco
107
capitolo quarto Come si produce
Tabella 3. Pil e componenti demo-economiche (variazioni cumulate percentuali dal 1995 al 2008, differenza logaritmica) 1995-2008
Italia
Germania
Francia
Pil
17
20,2
27,4
Popolazione totale
4,1
0,6
7,8
Quota della popolazione in età da lavoro
-4,5
-3,2
-0,3
Tasso di occupazione
14,9
10
6,2
2,4
12,9
13,7
-2,7
-7,4
-6,3
5,1
20,3
20
Produttività media del lavoro di cui: – Ore lavorate pro capite – Produttività oraria Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat.
il confronto fra i tre maggiori paesi dell’Europa continentale, l’Italia, la Germania e la Francia. Per ciascuno di essi è riportata innanzitutto la crescita complessiva del Pil nel periodo 1995-2008. Rileviamo in questi dati l’inaspettata somiglianza fra i casi italiano e tedesco (una crescita in dieci anni rispettivamente del 17% e del 20%) a confronto con la ben più brillante performance francese (oltre il 27%). Analizziamo il comportamento delle diverse variabili. Con riferimento al primo addendo, la crescita della popolazione complessiva dal 1995 al 2008 è stata in Germania decisamente più lenta che in Italia e in Francia (Germania 0,6%, Italia 4,1%, Francia 7,8%). Circa quattro dei dieci punti che segnano il divario di crescita economica tra Italia e Francia sono spiegati così. Il secondo addendo inizia a mettere in luce la particolarità italiana. Da noi la quota della popolazione complessiva che ha un’età da lavoro è diminuita di oltre quattro punti percentuali; anche in Germania è scesa significativamente, di circa il 3%;
108
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
in Francia è rimasta più o meno stabile. Le diminuzioni sono il riflesso del progressivo invecchiamento della popolazione, fenomeno particolarmente accentuato, come è noto, in Italia e in Germania. Una dinamica demografica sfavorevole come quella italiana (e anche, sebbene in misura inferiore, tedesca) non solo si riflette aritmeticamente in minore crescita produttiva, ma mette a repentaglio la sostenibilità finanziaria del Welfare State, asse portante delle scelte sociali in Europa. O si riesce a invertirla, con l’immigrazione o con politiche d’incentivazione della natalità, come è stato fatto per esempio in Francia, oppure la si deve compensare con aumenti del reddito pro capite. Tuttavia, come si è già messo in evidenza poco sopra, il nesso demografia-sviluppo è dinamicamente biunivoco, nel senso che se la crescita economica dipende dalla popolazione, la dinamica di quest’ultima dipende a sua volta dalle prospettive di sviluppo economico, che influenzano le scelte di procreazione delle giovani generazioni. Dunque, non possiamo fermarci all’indicatore demografico; occorre andare avanti nella ricerca delle determinanti ultime dell’arresto del processo di crescita economica. Il terzo addendo (la variazione del tasso di occupazione) non segnala più somiglianze, ogni paese fa storia a sé. L’Italia accresce il suo tasso di occupazione di circa il 15%, la Francia di circa il 6%, la Germania del 10%. Nel valutare questi risultati, non si può prescindere dai punti di partenza: in Italia il tasso di occupazione a metà degli anni Novanta era un misero 51%, a confronto del 60% francese e del 65% tedesco. Negli Stati Uniti, a quella data era occupato addirittura il 73% della popolazione in età da lavoro. Nei successivi quattordici anni il nostro paese ha compiuto una parziale rimonta, in connessione con una stagione di notevole moderazione salariale e con una serie di misure di flessibilizzazione del mercato del lavoro che
capitolo quarto Come si produce
109
sono state introdotte con la Riforma Treu del 1997, nei campi del lavoro a tempo parziale, di quello a tempo determinato, del lavoro “interinale”. L’incremento occupazionale complessivo ha, inoltre, beneficiato in misura determinante della crescita della partecipazione femminile al mercato del lavoro, in aumento tra il 1995 e il 2008 (dal 51,2% al 58,6%). La rimonta, da lungo tempo attesa, fa registrare un tasso di occupazione nel 2008 pari al 58,6%, comunque minore rispetto alla Germania e alla Francia (rispettivamente 70,1 e 64,9%). C’è un altro profilo sotto il quale occorre valutare l’aumento dell’occupazione registrato in Italia negli anni 1995-2008. Ce lo suggerisce il quarto addendo preso in considerazione nella tabella 3, la produttività. La produttività è l’altra faccia della medaglia rispetto all’occupazione. Per aumentare la produzione, un’impresa ha tre strade: a) accrescere il numero dei posti di lavoro, lasciando che ciascun lavoratore continui a produrre lo stesso valore economico di ieri; b) lasciare immutata la compagine lavorativa, mettendo però ciascun lavoratore in condizione di produrre più di ieri, dotando l’impresa di un maggiore capitale fisico (beni strumentali, macchinari e attrezzature) e organizzativo; c) accrescere sia il numero di lavoratori sia la loro produttività. La tabella 3 mostra come il caso italiano rientri nel primo dei tre casi sopra elencati. L’accrescimento di circa il 15% nel periodo pre-crisi del numero di occupati (in rapporto alla popolazione in età da lavoro) si è accompagnato a un progresso trascurabile della produttività (2,4% in 14 anni!). Il caso tedesco e quello francese mostrano che la crescita del tasso di occupazione si è, invece, accompagnata ad un sensibile incremento della produttività del lavoro, rispettivamente di circa il 13% e di oltre il 13%. Si consideri che i dati sulla produttività media del lavoro fin qui commentati sono a loro volta scomponibili in due
110
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
componenti: il numero di ore lavorate e la produttività per ora lavorata, e che tale scomposizione, pure presente nella tabella, rafforza l’evidenza che il problema è puramente di produttività: il numero di ore lavorate per occupato in Italia è diminuito (-2,7%) meno che in Francia (-6,3%), dove nel 1998 viene introdotta la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore, e in Germania (-7,4%). Tiriamo le fila di quanto emerge dal confronto tra paesi del diverso andamento delle variabili demografiche e socio-economiche. L’Italia accentua la peculiarità del suo caso: alla fine dei conti, l’intero suo divario di crescita rispetto alla Francia si spiega in termini di minore incremento della produttività; gli andamenti demografici e quelli dell’occupazione si compensano fra loro. Il deficit di crescita tedesco rispetto alla Francia si spiega invece prevalentemente con un maggiore invecchiamento della popolazione. Insomma, il confronto a tre paesi si chiude con una diagnosi di cattiva performance dell’Italia, soprattutto nei risultati di produttività. Come si spiega il sensibile divario e il declino di produttività accusato dal sistema economico italiano, quando solo nel 1995 la produttività per ora lavorata raggiunge il 90% della produttività oraria negli Stati Uniti?3 Quali sono le ragioni di una tale crisi della produttività? Due sono state le spiegazioni avanzate: a) la relativa bassa produttività del lavoro temporaneo immesso nel sistema economico, a seguito della flessibilizzazione del mercato del lavoro; b) l’incapacità delle imprese di mettere a frutto l’avanzamento tecnologico delle Ict. Analizziamo entrambe le spiegazioni in un qualche dettaglio. Occupazione e produttività Nei decenni precedenti gli anni Novanta, la crescita del paese è stata riconducibile soprattutto all’aumento della produttività, la variazione dell’occupazione ha svolto un ruolo secondario.
capitolo quarto Come si produce
111
Figura 2. Stock di capitale per addetto in Francia, Germania e Italia 115 110 105 100 95 90 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Francia
Germania
Italia
Fonte: nostre elaborazioni su dati Ameco.
A partire dalla seconda metà degli anni Novanta e fino al 2008 si assiste ad un rovesciamento della rilevanza delle due variabili: l’aumento dell’occupazione spiega l’88% della crescita del Pil nel periodo, mentre la produttività del lavoro circa il 14%. Come già menzionato, l’aumento della occupazione è stato soprattutto determinato dall’incremento del lavoro temporaneo, nelle forme del lavoro a tempo parziale, di quello a tempo determinato, del lavoro “interinale”, che hanno, a loro volta, comportato una sensibile riduzione del costo del lavoro. Ciò ha, da un lato, sgombrato il campo dalle polemiche sulla rigidità del mercato italiano del lavoro. Secondo una fonte autorevole, l’indice sintetico dell’Ocse sull’entità della protezione del mercato del lavoro, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, la rigidità del mercato italiano del lavoro è andata progressivamente attenuandosi fino a risultare, nel 2007, più bassa di quella registrata per Francia e Germania4. Dall’altro lato, la dotazione di capitale per lavoratore è rimasta negli stessi anni sostanzialmente invariata, con la conseguenza che, a fronte
112
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
dell’aumento della occupazione, ogni lavoratore ha avuto a disposizione una minore dotazione di macchinari, di attrezzature, di capitale fisico, in senso più generale (cfr. figura 2). La parziale sostituzione di capitale fisico (impianti, equipaggiamenti materiali e immateriali) con il lavoro ha ridotto il contenuto tecnologico delle attività produttive, con effetti negativi sulla produttività media del sistema economico5. Va inoltre considerato che i nuovi lavoratori (cui si aggiunge l’offerta di lavoro degli immigrati che cresce proprio negli anni Novanta), data la natura del contratto, potrebbero essere in possesso di un minore capitale umano, vale a dire, capacità, esperienza e abilità e ciò potrebbe essere un ulteriore fattore che ha concorso alla bassa produttività del lavoro, per un effetto di composizione. Ict e produttività Intorno alla metà degli anni Novanta, prende piede la “rivoluzione” delle Ict, che modificano radicalmente l’assetto produttivo e distributivo. L’adozione capillare delle Ict nel sistema produttivo è stata estesamente visibile negli Stati Uniti, dove l’effetto del progresso tecnologico attribuibile alle Ict ha consentito di ottenere maggiori volumi di produzione a parità di altri fattori. Il guadagno di produttività è stato minore in Europa e lo è stato ancor meno in Italia, a causa di una minore adozione delle Ict nelle imprese. Perché? Varie ipotesi sono state avanzate per spiegare il ritardo europeo-italiano, ma nel caso italiano l’ostacolo principale pare innanzitutto consistere nella ridotta dimensione media delle imprese6. La diffusione delle Ict nel sistema produttivo è modesta nelle piccole imprese poiché solo in organizzazioni grandi e complesse quelle tecnologie possono sviluppare appieno tutto il loro potenziale razionalizzatore. In questo caso, si può parlare di un effetto “schumpeteriano”: le imprese più grandi
capitolo quarto Come si produce
113
possiedono maggiori risorse da investire in innovazioni tecnologiche e, grazie ad una più alta capacità di assorbimento, presentano una maggiore capacità di appropriarsi dei rendimenti che ne derivano. Un’impresa piccola non è in condizione di trarre rilevanti vantaggi di efficienza dall’adozione di un software gestionale di tipo Erp che, per sua natura, rende più precisi ed efficienti i flussi informativi tanto più incisivamente quanto più l’organismo a cui si applica è grande, complesso, sofisticato. Gioca, inoltre, a favore della grande dimensione il fatto che l’utilizzo delle Ict richieda un’elevata formalizzazione delle procedure e dei sistemi informativi e di comunicazione, solitamente poco presente nelle piccole imprese, i cui scambi sono piuttosto improntati all’informalità. Un ulteriore ostacolo alla diffusione delle Ict consiste nella relativa specializzazione in settori “tradizionali” del sistema industriale italiano, settori che meno si prestano a guadagni di efficienza derivanti da una razionalizzazione dei flussi informativi intra ed extra-aziendali del tipo di quelli indotti dalle tecnologie digitali. Inoltre, una relativa scarsità di imprese non tradizionali, segnatamente di imprese produttrici di Ict, fa venire meno l’interazione ravvicinata fra imprese produttrici e utilizzatrici di queste tecnologie, che gioca un ruolo importante nel determinarne l’utilizzo efficiente nel sistema. Se poi un’impresa è piccola e tradizionale, gli effetti negativi si cumulano. Esiste, infine, una relazione stretta e inscindibile tra l’adozione delle Ict e i mutamenti organizzativi, una micro-complementarità, come viene messo in luce da alcuni lavori7. I processi di riorganizzazione (all’interno e all’esterno dell’impresa, nel ricorso a scambi con altre imprese, per esempio, per l’approvvigionamento di beni intermedi) si rendono necessari perché, con le nuove tecnologie, cambiano la modalità e la
114
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
velocità di trasmissione delle informazioni e, d’altro canto, essi costituiscono la via obbligata per incassare appieno gli incrementi di produttività consentiti dalle Ict. I lavoratori con un livello significativo di capitale umano costituiscono la tipologia che facilita siffatti processi grazie alla loro capacità di “assorbimento”. Ne consegue un mutamento nella composizione funzionale degli occupati, con una incidenza minore degli addetti alle funzioni strettamente produttive (sostituzione di operai con impiegati). In questo consiste la connotazione delle Ict come mutamento tecnologico skill biased. Dopo la crisi La crisi finanziaria, deflagrata negli Stati Uniti nel 2007, ha repentinamente attaccato le componenti reali come investimenti, occupazione, consumo. Vi si è aggiunta in Europa la crisi dei debiti sovrani, scoppiata in Grecia nel 2010 e propagatasi successivamente all’area dell’euro. Gli anni successivi al 2008 sono quelli della Grande Recessione, il cui impatto sulla produttività e sulla crescita dei paesi dell’euro è stato particolarmente avvertito. In Italia il danno è stato enorme, tanto da mettere a repentaglio il futuro potenziale produttivo. Si stima che l’apparato manifatturiero abbia visto scomparire in questi sette anni un sesto della sua capacità produttiva. La distruzione netta di posti di lavoro è stata di quasi un milione. Il complesso delle imprese italiane ha investito, nel 2014, un terzo in meno rispetto a sette anni prima. In analogia al procedimento prima adottato, guardiamo agli effetti della crisi sulle variabili di interesse (cfr. tabella 4). L’impatto della crisi è stato particolarmente duro in Italia, il Pil è diminuito dal 2008 al 2014 dell’8,4%; la Germania, al contrario, si è ripresa abbastanza rapidamente, è il paese che mostra in assoluto la performance migliore nell’area dell’Euro nel dopo-crisi; più stentata la dinamica del Pil in Francia.
115
capitolo quarto Come si produce
Tabella 4. Pil e componenti demo-economiche (variazioni cumulate percentuali dal 2008 al 2014, differenza logaritmica) 2008-2014
Italia
Germania
-8,4
4,1
2
2,6
0,3
2,8
Quota della popolazione in età da lavoro
-1,6
-0,2
-2,6
Tasso di occupazione
-5,1
4,4
0,2
Produttività media del lavoro
-4,4
-0,3
1,6
-4,9
-3,7
-2,3
0,5
3,4
3,9
Pil Popolazione totale
Francia
di cui: – Ore lavorate pro capite – Produttività oraria Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat.
A differenza della Germania, dove la popolazione è rimasta stabile, in Francia e in Italia è cresciuta con tassi simili. In tutti e tre i paesi è diminuita la quota della popolazione in età da lavoro, in misura maggiore in Francia e in Italia. Al contrario del periodo precedente – ed è qui che si avverte il primo impatto della crisi sulle variabili reali – in Italia il tasso di occupazione è sensibilmente diminuito (-5,1%), è rimasto stabile in Francia (0,2%) ed è aumentato in Germania (4,4%). L’impatto più forte della crisi si registra sulla produttività del lavoro che in Italia, dal 2008 al 2014, diminuisce del 4,4%, rimane pressappoco stazionaria in Germania (-0,3%), cresce di un esiguo 1,6% in Francia. Le due cause principali della sensibile caduta del Pil nel periodo successivo alla Grande Recessione sono dunque la significativa flessione del tasso di occupazione, vale a dire la espulsione dei nuovi occupati, ingaggiati nel periodo precedente con contratti di tipo temporaneo, e la persistente flessione della produttività del sistema economico nel suo complesso8.
116
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Inoltre, un lascito della grande recessione di più lunga durata potrebbe essere un abbassamento del tasso di crescita del prodotto potenziale, a causa del declino degli investimenti e della crescita dei livelli di disoccupazione9. Questa ipotesi è condivisa da un recente studio dell’Ocse10 sul futuro della produttività. I danni di lungo periodo potrebbero essere causati da fattori diversi. In primo luogo, la sensibile riduzione delle risorse finanziare per gli investimenti, soprattutto di quelli in Ricerca e Sviluppo; in secondo luogo, dal mancato recupero dei posti di lavoro distrutti dalla grande recessione. La bassa crescita della produttività: un problema solo italiano o solo più acutamente avvertito in Italia? Il rallentamento della produttività del lavoro e della Tfp è acuto in Italia e, tuttavia, avvertito anche nel resto dei paesi industrializzati. Il rallentamento della Tfp (che, lo ripetiamo, riflette l’efficienza con cui i diversi input sono utilizzati/combinati nel processo produttivo) precede l’esplosione della Grande Recessione e si acuisce negli anni più recenti: nel 2013 in media il 2% più bassa del livello pre-crisi del 200711. Analogo andamento si ha per la produttività del lavoro: nel periodo che va dal 2004 al 2013, nei paesi industrializzati, la crescita è stata la più bassa mai registrata dal 1950. Come bisogna valutare questo rallentamento? È di natura temporanea o è destinato a permanere nel tempo? Secondo un lavoro recente12, il rallentamento della produttività è destinato ad essere permanente: le innovazioni non sembrano essere più quelle di un tempo! Secondo questo studio, infatti, le innovazioni correnti e future non avranno lo stesso respiro e la stessa portata di quelle a cui abbiamo assistito in passato come, per esempio, l’elettricità o il motore a scoppio; secondo altri13, il pessimismo è ingiustificato, non ci sarebbe alcuna stagnazio-
capitolo quarto Come si produce
117
ne tecnologica; il rallentamento della produttività sarebbe di natura transitoria, in particolare perché le Ict non sembrano avere ancora dispiegato tutto il proprio potenziale innovativo e di trasformazione della struttura delle economie, senza menzionare gli impatti futuri della intelligenza artificiale, delle biotecnologie, della robotica. Quali che siano gli sviluppi, sperabilmente positivi, a cui assisteremo nel corso del tempo, rimane da spiegare quali siano le altre cause del progressivo rallentamento della produttività che stiamo registrando. In questo ambito, la ricerca è in pieno corso. Un’ipotesi suggestiva è stata avanzata da alcuni recenti lavori14, centrati, appunto, sul futuro della produttività. Secondo tali studi, il rallentamento della produttività è riconducibile a un “ingripparsi” dei processi di diffusione dell’innovazione, a una strozzatura della macchina della diffusione. In particolare, si nota che la produttività del lavoro è cresciuta sensibilmente (+3,5% in media annua) nelle imprese che si collocano sulla “frontiera globale della produttività”, mentre nelle imprese al di sotto della frontiera la crescita della produttività del lavoro si è attestata su una media annua dello 0,5%. Le imprese di frontiera sono definite come unità che mostrano il livello più alto di produttività in 23 paesi. Questo divario di produttività si spiegherebbe appunto con il rallentamento o la stasi del processo di diffusione dell’innovazione: le imprese al di sotto della frontiera non sembrano essere in grado di assorbire e capitalizzare quanto viene innovato dalle imprese alla frontiera. Come si può rimettere in moto il processo di diffusione? Innanzitutto, con l’apertura al commercio internazionale e il potenziamento della connessione produttiva e commerciale tra i diversi paesi. Su questo versante, l’attuale organizzazione della produzione nella forma delle catene globali del valore si rivela essere un potente canale che “trasmette” la tecnologia incorpo-
118
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
rata nei beni intermedi che vengono scambiati tra le imprese. Diversi studi15 dimostrano che l’effetto positivo esercitato dalle importazioni di beni intermedi sulla produttività delle imprese è maggiore quando le importazioni dei beni intermedi provengono dai paesi sviluppati e quanto più l’impresa è innovativa. In altre parole, la tecnologia incorporata nei beni intermedi scambiati si trasferisce attraverso le relazioni tra le imprese e viene “assorbita” in misura maggiore da quelle imprese che mostrano una più alta attitudine all’innovazione. Se il commercio facilita la penetrazione e la diffusione della tecnologia, tuttavia aprirsi al mercato internazionale non è alla portata di tutte le imprese. Anche su questo versante, esiste una consolidata mole di risultati empirici secondo i quali vale l’ipotesi di auto-selezione. Sono solo le imprese più produttive che riescono a fronteggiare i costi della penetrazione dei mercati esteri. Poiché esiste una correlazione diretta tra dimensione di impresa e produttività, ne consegue che solo le imprese di adeguate dimensioni saranno capaci di affrontare il mare aperto della competizione internazionale. In secondo luogo, un ruolo rilevante nella diffusione dell’innovazione è giocato anche dalla capacità manageriale, vale a dire dall’abilità dei manager che conducono un’azienda di favorire la corretta allocazione delle risorse umane a loro disposizione. Questa capacità si dimostra ancora più indispensabile nel caso in cui i manager debbano favorire l’adozione e lo sfruttamento di processi innovativi; valga per tutti l’adozione e l’assorbimento delle Ict. Un’altra spiegazione avanzata concerne, invece, il basso livello degli investimenti, una delle variabili che spiega la dinamica della produttività. Il problema starebbe dunque nella scarsa accumulazione di capitale fisico (gli investimenti privati stanno calando persino in paesi come la Cina!), esacerbata dalla esangue domanda che ha caratterizzato gli
capitolo quarto Come si produce
119
anni successivi alla grande recessione16. Un problema acutamente avvertito in Italia dove gli investimenti sono crollati del 29% dal 2008 al 2015. D’altro canto, perché le imprese dovrebbero investire in nuovi macchinari e tecnologie se non si profilano significative e ragionevolmente certe prospettive di vendita dei loro prodotti? Dunque, ritorna sul tappetto la keynesiana questione del rilancio della domanda aggregata, che potrebbe conseguirsi attraverso, per esempio, un aumento degli investimenti pubblici. Si metterebbe in moto il noto meccanismo dell’acceleratore con effetti moltiplicativi sulla occupazione e sui salari e quindi di miglioramento delle prospettive delle imprese in termini di vendita dei propri prodotti, a cui farebbe seguito un aumento degli investimenti privati. Per un paese come l’Italia, ad alto debito pubblico (nel 2016, 133% del Pil), i margini di manovra sono stretti, lo sono ancor di più in presenza di una governance europea tutta focalizzata sul breve termine degli aggiustamenti di bilancio e dei negoziati sulla flessibilità. In conclusione. Lo status di “sick man of Europe” attribuito all’Italia dall’«Economist» nel 2005 era stato negli anni precedenti, dal 1999 al 2004, appannaggio – incredibile ma vero – della Germania, la cui crescita appariva lenta e debole (in media l’1,2% all’anno dal 1998 al 2005). Successivamente alla Grande Recessione (dopo il 2008), la Germania assurge al ruolo di superstar dell’economia europea17. Nel giro di meno di un decennio, la Germania ritorna sul sentiero di crescita. I motivi della trasformazione sono oggetto di un controverso dibattito ma l’evidenza è inequivocabile. Al contrario, la deludente performance della produttività non consente all’Italia la fuoriuscita dalla metafora. Gioca indubbiamente un ruolo la polverizzazione del sistema produttivo italiano. L’Italia è, tra i principali paesi europei, quello dove il divario di produttività tra imprese piccole e medio-grandi è
120
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
il più ampio. La flessibilità e precarizzazione del mercato del lavoro hanno causato una sostituzione del capitale con il lavoro con un impatto negativo sulla produttività dell’impresa. Senza dubbio la dominanza e l’anomalia tutta italiana delle imprese familiari, che affidano il complesso delle posizioni dirigenziali preferibilmente a componenti della famiglia, generano “cattive” pratiche manageriali, all’insegna della scarsa propensione ad innovare, con manager inadeguati a cogliere le potenzialità delle nuove tecnologie e dell’aumento di produttività che esse frutterebbero. E tuttavia, come abbiamo visto, il problema del rallentamento della produttività, certamente più acuto in Italia, non è solo italiano. Il male oscuro, oscuro perché se ne conoscono solo in parte le cause, affligge tutti i paesi industrializzati, già da prima della grande crisi, per diventare sensibilmente più drammatico negli anni successivi, intrappolando le economie in un circolo vizioso di bassa produttività, bassa crescita, aumento delle disuguaglianze. Il male si è fatto contagioso, le diagnosi sono molteplici, la risoluzione di molte cause sono, potenzialmente, sotto il controllo dei decisori pubblici, a cui spetta di agire tempestivamente per scongiurare il rischio, da più parti ventilato, di ristagno secolare. 3. IL DIFETTO DI INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO
Uno scenario pessimistico per l’economia mondiale di cui si discute da qualche tempo è noto come “ristagno secolare”. Lo menzioniamo per la suggestione che ha esercitato su molti osservatori, oggi soprattutto con riferimento all’Europa. L’ipotesi venne avanzata nel 2014 dall’economista americano Lawrence Summers per gli Stati Uniti.
capitolo quarto Come si produce
121
Il punto debole di questa ipotesi è la natura esclusivamente macro del ragionamento, tutto dal lato della domanda. Sappiamo in realtà che l’innovazione tecnologica fa nascere la domanda di prodotti prima inesistenti; a parità di investimenti richiede, come sostiene Summers, meno risorse finanziarie. Tuttavia, l’ipotesi di parità è fallace, l’innovazione fa aumentare anche gli investimenti perché rende i nuovi beni capitali meno cari e accessibili a una platea molto più vasta di potenziali imprenditori. Sappiamo inoltre che il formarsi di nuove bolle finanziarie può essere prevenuto da appositi strumenti di vigilanza macroprudenziale. Lo spettro di un ristagno secolare non può naturalmente essere scacciato del tutto, ma è certo da ridimensionare. Quali altri scenari possiamo disegnare? L’approccio più interessante rimane quello che guarda alle imprese, all’offerta produttiva. È nelle imprese, lo abbiamo più volte ripetuto, che si genera lo sviluppo economico, che si produce il reddito e il benessere poi distribuito a tutta la nazione attraverso imposte, profitti, stipendi, salari. È nelle imprese che si creano i prodotti nuovi, o rinnovati, che alimentano la domanda dei consumatori e degli stessi investitori, mostrando loro bisogni, desideri, opportunità, che prima non vedevano. L’innovazione incessante è il tratto distintivo del tempo moderno. Un secolo fa accadeva sovente a chi produceva o commerciava di trascorrere una intera esistenza trattando sempre lo stesso bene o servizio, con immutate caratteristiche, che i clienti domandavano in misura maggiore o minore solo a seconda delle alterne vicende della loro condizione economica. Oggi un bene o un servizio non può restare identico a se stesso se non per breve tempo, poi deve essere rinnovato, nella sostanza o almeno nella presentazione, pena l’uscita dal mercato. I consumatori attendono di essere continuamente sorpresi da qualcosa di cui non sospettavano l’esistenza. I beni
122
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
capitali devono cambiare anch’essi per accomodare e sospingere l’innovazione nei beni finali. Erano capaci gli italiani del passato di fare innovazione nelle imprese? Risaliamo fino al tempo della nostra, tardiva, rivoluzione industriale, tornando sui passi già percorsi in precedenza. Nell’era giolittiana l’innovazione fu alimentata soprattutto dagli investimenti diretti esteri in Italia, dalle importazioni di attrezzature prodotte all’estero, da accordi di licenza con imprese straniere. L’Italia era dipendente dall’innovazione straniera in particolare nelle industrie più avanzate, con la rilevante eccezione dell’industria ferroviaria (locomotive). Erano le industrie chimiche tedesche e quelle elettrotecniche tedesche e statunitensi a essere all’avanguardia nella ricerca scientifica e nel suo sfruttamento industriale; le italiane erano intrappolate in un circolo vizioso di tecnologia inferiore, più bassa qualità e minore domanda. Negli anni tra le due guerre proseguì l’importazione di tecnologia nell’industria tessile e in quella dell’acciaio, mentre nei settori chimico e metalmeccanico si ebbero primi significativi investimenti in attività innovative autonome. Negli anni Trenta, seppure su scala limitata, prese avvio l’attività di ricerca sistematica e la creazione di laboratori nelle maggiori imprese dell’industria chimica e della gomma. Dopo la seconda guerra mondiale, il Piano Marshall rese disponibili alle imprese italiane ingenti fondi che furono massicciamente impiegati nell’acquisto di macchinari americani. Riprese e accelerò il catching-up dell’economia italiana. Gli esercizi di contabilità della crescita mostrano che i progressi italiani furono dovuti, più che all’aumento dell’intensità di capitale, al passaggio di milioni di lavoratori dall’agricoltura all’industria e, soprattutto, all’innovazione e ai guadagni di ef-
capitolo quarto Come si produce
123
ficienza nelle imprese: negli anni del miracolo economico, la produttività totale dei fattori (Ptf) spiega ben oltre metà della crescita del Pil. Restarono importanti il trasferimento internazionale di tecnologia e l’abilità dell’industria italiana di diffondere la conoscenza tecnologica imitando, reingegnerizzando e adattando le migliori esperienze altrui, specie nell’industria dei macchinari che si andava nel frattempo sviluppando. Fu cruciale l’abbondante disponibilità di mano d’opera formatasi negli istituti tecnici industriali. Crebbe però in quegli anni anche un’autonoma capacità di fare innovazione nelle imprese, soprattutto nelle industrie a tecnologia intermedia e nella modalità incrementale, di processo, piuttosto che basata su ricerca e sviluppo (R&S). Essa si combinò virtuosamente con l’importazione di tecnologia nell’aumentare la produttività. Certo, guardando ai dati che comunemente si adoperano per studiare lo sviluppo economico endogeno, balza agli occhi il divario negli anni del “miracolo” fra l’impetuoso progresso della Ptf italiana e la relativa pochezza della R&S che si andava conducendo. Le statistiche sulla spesa per R&S e sui brevetti originati nelle imprese non colgono i miglioramenti incrementali nei processi produttivi che sono tipici delle piccole imprese italiane. Guardando in particolare ai brevetti, che misurano il flusso di innovazioni di prodotto basate sulla ricerca scientifica, notiamo un infiammarsi fino alla metà degli anni Sessanta: nel 1963 oltre il 4% del totale dei brevetti rilasciati a stranieri negli Usa fu italiano. Ma fu un fuoco di paglia: da allora iniziò una progressiva caduta. Un’esperienza, quindi, tutta diversa da quella, quasi contemporanea, del Giappone (e poi più tardi, negli anni Novanta, della Corea del Sud).
124
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Ricerca, sviluppo e innovazione oggi Guardiamo all’oggi. Il complesso delle imprese italiane mostra un forte divario di capacità innovativa rispetto ad altri sistemi avanzati. Esso è riconducibile al basso livello di R&S. Secondo i dati più recenti, del 2013, la spesa per R&S del complesso delle imprese, istituzioni pubbliche e private si aggira intorno ai 21 miliardi di euro, pari all’1,3% del Pil, rispetto al 2,1 della media dell’Unione europea, al 2,9 della Germania (cfr. tabella 5). Livello ancora ben distante dal conseguimento dell’obiettivo, forse irrealistico, auspicato per l’Italia nel programma Europa 2020, pari all’1,5% del Pil (l’obiettivo per l’Europa essendo fissato al 3% del Pil). È un dato molto noto e discusso, così come lo è il fatto che il differenziale tra l’Italia e la media europea si forma, più che nella spesa pubblica, in quella delle imprese private: lo 0,7% del Pil, meno della metà dell’1,6 dei paesi Ocse. In Italia la quota delle imprese sul totale della spesa in R&S è pari a circa il 58%, contro una media europea del 62%. Il maggiore apporto proviene dal settore manifatturiero, che incide per circa il 70%, e ciò spiega la perdurante centralità dell’industria nella dinamica innovativa del nostro paese. A differenza del passato, in cui è prevalso un modello di innovazione senza ricerca, che richiedeva un impegno, finanziario e organizzativo, inferiore a quello richiesto dall’attività formale di R&S, oggi un’esplicita attività di R&S è condizione necessaria per aumentare la capacità delle imprese di registrare brevetti, disegni industriali, marchi o diritti di autore; incrementare la quota di fatturato realizzato con prodotti innovativi; aumentare la probabilità di produrre beni che siano nuovi per il mercato, non solamente per l’impresa, contribuire ad innalzare la produttività. Restringendo l’attenzione all’output innovativo, vale a dire alle innovazioni di prodotto e di processo, secondo i dati più
capitolo quarto Come si produce
125
Tabella 5. Principali indicatori della spesa in Ricerca e Sviluppo (R&S), 2013 Spesa per R&S (valori in migliaia di euro)
Totale della spesa per R&S Rapporto sul Pil (valore %)
20.983.102 1,31
Spesa per R&S per settore istituzionale Imprese
11.480.390
Università
5.938.235
Istituzioni pubbliche
2.937.418
Istituzioni private non profit
627.059
Fonte: Istat, 2013.
recenti nel 2010-2012, dunque ancora in piena crisi, solo il 35,5% delle imprese ha svolto attività innovativa di questa natura, anche se la maggior parte di queste ha introdotto con successo nel mercato almeno una innovazione di prodotto o di processo18. È noto, inoltre, che le imprese perseguono simultaneamente più forme di innovazione: l’innovazione di prodotto richiede spesso innovazioni nel processo produttivo e si accompagna ad altre nella organizzazione e nel marketing del nuovo prodotto. L’attività innovativa tende dunque ad essere di tipo cumulativo e questo potrebbe spiegare perché, in Italia, l’intrapresa è appannaggio di una quota ristretta e selezionata di aziende. Di nuovo, questa propensione alla complementarità delle innovazioni è più diffusa nell’industria, rispetto al settore dei servizi e delle costruzioni19. Se guardiamo all’attività innovativa per eccellenza, i brevetti, la quota del flusso annuo di brevetti italiani è decisamente inadeguata al peso economico del paese: presso lo United
126
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
States Patent and Trademark Office, l’Italia ha un settimo dei brevetti della Germania; presso lo European Patent Office circa un sesto20. Rispetto alla media dei paesi avanzati, o rispetto alla Germania – che condivide con l’Italia il peso rilevante del manifatturiero, in cui come si è visto si annida la maggiore propensione alla R&S e quindi alla innovazione – che cosa frena le imprese italiane? Le spiegazioni possono essere diverse. In primis, alcune caratteristiche strutturali, intrinseche, del sistema produttivo italiano, quale l’eccessiva frammentazione del sistema in milioni di piccole imprese. La dimensione media delle imprese nel settore manifatturiero italiano è di 9,2 addetti, in Germania è 3 volte e mezza più grande. La frammentazione viene più volte chiamata in causa in ragione sia della relazione positiva che esiste tra dimensione a attività di R&S, sia della scarsa presenza in Italia di grandi imprese che rivestono un ruolo cruciale e non fungibile nella formazione del capitale cognitivo, uno dei fattori più rilevanti per la crescita di un paese21. Su questo fronte, i dati recenti sono allarmanti in quanto mostrano, a fronte di un aumento della spesa in R&S nelle medie imprese (fra i 50 e i 249 addetti), una diminuzione della stessa proprio nelle imprese più grandi (con 250 e più addetti)22. Vale la pena di ricordare che la distribuzione degli investimenti in R&S è molto concentrata: nel 2013 alle prime tre imprese per livello di spesa faceva capo il 53% della spesa privata totale, a fronte del 41% in Germania23. A questo riscontro negativo, si aggiunge il progressivo disimpegno delle multinazionali estere, tra i maggiori investitori in R&S in Italia. Quest’ultimo potrebbe segnalare il pericolo di uno “svuotamento tecnologico”24 del sistema produttivo italiano, cui contribuiscono soprattutto le imprese estere con sempre minori investimenti in R&S: la spesa in R&S per addetto passa infatti dai 30mila euro del 2001 a valori sistemati-
capitolo quarto Come si produce
127
camente inferiori ai 20mila euro negli ultimi anni (all’incirca dal 2008 al 2010). Ed è evidente che la pur maggiore e benvenuta vitalità delle imprese più piccole, già messa in luce anche da alcuni centri di ricerca25, non possa compensare il disimpegno progressivo dei principali attori che rivestono, in Italia come nei maggiori paesi avanzati, il ruolo preminente nel sistema nazionale di innovazione. La frammentazione si accompagna ad una specializzazione produttiva sbilanciata verso i settori tradizionali a basso contenuto tecnologico. Il nesso dimensione-specializzazione ritorna come un refrain ossessivo, qualificandosi tra i principali ostacoli ad una sostenuta dinamica innovativa. Se la specializzazione settoriale italiana fosse uguale a quella tedesca, il divario in termini di quota di imprese innovative rispetto alla Germania si ridurrebbe del 10%; inoltre, se anche la struttura dimensionale fosse la stessa, il divario si ridurrebbe di un altro 30%26. E tuttavia, se anche l’Italia avesse la stessa struttura settoriale della Germania, rimarrebbe il problema che, finanche nei settori tecnologicamente più avanzati (dove tradizionalmente si rileva la maggiore incidenza della attività di R&S), le imprese italiane investono di meno in R&S, circa la metà di quelle tedesche27. Quali altre spiegazioni vengono avanzate oltre quelle riconducibili al nodo dimensione-specializzazione? C’è un’altra caratteristica delle imprese italiane che gioca, la governance familiare delle imprese: non solo nella proprietà (le imprese a controllo familiare sono diffusissime anche in Germania), ma soprattutto nel management (ne abbiamo parlato prima). La presenza di esponenti della famiglia controllante nelle prime linee di gestione dell’impresa è in Italia doppia rispetto alla Germania. La gestione familiare, in combinazione con una classe imprenditoriale relativamente anzia-
128
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
na, rende carenti l’organizzazione, la capacità innovativa e la propensione all’internazionalizzazione. Se l’impresa è familiare e piccola, è ancora più difficile l’accesso al credito bancario e al mercato dei capitali, in particolare se si tratta di finanziare innovazioni, cioè attività rischiose su cui le imprese preferiscono mantenere riservatezza. Poiché le asimmetrie informative sono elevate, le risorse finanziarie interne rappresentano di solito la fonte di finanziamento principale della R&S; ma è una fonte dipendente dal ciclo economico e indisponibile nelle startup28. Un’altra criticità si rileva sul fronte della debole cooperazione nella attività innovativa delle imprese con soggetti esterni, quali: fornitori, istituti di ricerca pubblici e privati, Università. Quest’ultima è tra i principali produttori di conoscenza e la collaborazione tra università e imprese potrebbe giocare un ruolo rilevante nel promuovere il propagarsi della conoscenza e della innovazione. Secondo i dati più recenti29, solo il 12,5% delle imprese innovatrici ha instaurato forme di collaborazioni, perlopiù confinate all’interno dei confini nazionali, con soggetti esterni, un valore significativamente inferiore a quanto si rileva per la Francia e ancor più per la Germania. Che fare? Vi è un ruolo specifico delle politiche pubbliche nel potenziare la capacità innovativa delle imprese? Sì, in almeno tre campi: disciplina dei mercati dei prodotti e del lavoro; ricerca scientifica e sistema educativo; politiche di incentivazione monetaria e fiscale all’innovazione delle imprese. Disegnare buone regole, tenendo conto delle loro ripercussioni anche indirette, è la prima e la migliore delle regole. La disciplina dei mercati dei prodotti e del lavoro, che ha il suo fondamento in importanti obiettivi di efficienza e di equità, produce effetti indiretti sulla riallocazione di risorse dalle imprese meno produttive ad altre che lo sono di più: se è male impostata, per difetto o per eccesso, comprime la produttività
capitolo quarto Come si produce
129
del sistema, in particolare quando colpisce settori a elevata intensità brevettuale, poiché le imprese innovative sono più sensibili delle altre alla rigidità nella riallocazione delle risorse30. Progressi significativi sul versante della regolamentazione del prodotto così come sul mercato del lavoro sono stati fatti negli ultimi anni, anche durante il periodo della crisi, come riconosciuto da molti31. Un secondo campo di possibile azione pubblica riguarda la ricerca e il sistema educativo. La ricerca di base è lontana dal mercato e quindi poco appetibile per le imprese, soprattutto medio-piccole, sicché un sistema pubblico che se ne prenda cura ha la sua ragion d’essere. Il sistema della ricerca pubblica in Italia, in cui si investe l’1% del Pil a fronte di una media europea dell’1,5%, appare però frammentato, riflettendo anche la proliferazione degli atenei, dove essa prevalentemente si concentra. La produzione scientifica si colloca in complesso su buoni livelli, non distanti da quelli di altri importanti paesi europei, tuttavia le decantate relazioni università-imprese appaiono, come abbiamo appena visto dai dati, sporadiche ed esili. “La motivazione può risiedere in una certa resistenza della ricerca pubblica italiana ad adottare nuovi modelli organizzativi e nuovi meccanismi di incentivazione, come invece accade in altri paesi, ma anche negli scarsi investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle imprese italiane”32. Una cosa è indubitabile: proprio dal punto di vista della ricerca e della innovazione appare esiziale il taglio al finanziamento delle università (oltre l’11%) che ha avuto luogo dal 2008 al 2013. La riduzione non appare coerente con gli impegni presi in sede europea di espansione della quota dei laureati italiani né sembra muoversi nella direzione di una strategia che potenzi, appunto, la ricerca e l’innovazione33. Il terzo campo d’azione, le politiche di sussidio, è il più delicato dei tre. In generale, l’attività di R&S può soffrire di un
130
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
“fallimento del mercato”, dovuto alla natura di bene pubblico della conoscenza e dunque alla evenienza che chi vi investe possa appropriarsi solo di una parte dei benefici dell’investimento a causa degli spill overs di conoscenza. Ne consegue che l’investimento privato può rimanere al di sotto del livello socialmente desiderabile: i sussidi alle imprese, accrescendo gli investimenti in R&S, possono quindi migliorare il benessere collettivo34. Stabilita la fondatezza dell’intervento pubblico, la questione rilevante diventa: sono effettivamente efficaci gli incentivi erogati alle imprese e finalizzati ad aumentare l’investimento in R&S? O vengono piuttosto finanziati investimenti in R&S che le imprese avrebbero comunque effettuato, anche in assenza dell’incentivo? La questione si sposta dunque su un terreno diverso: si tratta di effettuare una valutazione ex post della efficacia della misura di policy. Su questo versante, e in armonia con quanto richiesto dalla Commissione europea, la cultura della valutazione (indipendente e non) ha fatto molti e significativi progressi: avvalendosi di tecniche controfattuali, gli studi empirici hanno messo sotto scrutinio quanto bene sono spesi i soldi pubblici quando allocati al finanziamento della R&S. Restringendo le nostre osservazioni agli studi che hanno per oggetto i finanziamenti erogati alle imprese italiane, sono interessanti i risultati di un lavoro recente35 che passa in rassegna 43 esercizi di valutazione effettuati ex post. Emerge che i sussidi pubblici alle imprese risultano efficaci quando concorrono due condizioni: a) l’incentivo è finalizzato ad accrescere l’input innovativo (quali: spese in R&S; occupati alla funzione di R&S; capitale investito) piuttosto che variabili di performance (fatturato, per esempio); b) i finanziamenti sono erogati dalle Regioni, perché hanno più probabilità di conseguire l’obiettivo di policy rispetto ai livelli centrali dell’am-
capitolo quarto Come si produce
131
ministrazione. Il punto b) non sorprende: le amministrazioni regionali sono in possesso di una base informativa più ricca sulle imprese e sul contesto in cui operano, il che dovrebbe, in linea di principio, garantire un migliore disegno della misura di policy, selezionando i progetti che presentano maggiore addizionalità36. Gli aiuti pubblici alla R&S sono in Italia pari solo a due terzi della media europea, dunque insufficienti ad avere un impatto significativo sul sistema economico. Ma ciò che più rileva è la qualità della governance. Il successo degli interventi pubblici dipende molto dal loro timing, e noi sappiamo quanto poco prevedibili siano gli iter parlamentari di qualsiasi riforma, e quanto ancor meno prevedibili siano gli iter amministrativi di attuazione. L’esperienza e la storia, non meno della teoria, ci portano a individuare almeno un fattore di successo: la semplicità. La semplicità aiuta gli attori – imprenditori, insegnanti, studenti – a prevedere e a fare piani. Purtroppo la semplicità ha un nemico nel processo decisionale politico, che è additivo, per la necessità di comporre molteplici istanze e pressioni di interessi di parte e anche nell’eccessiva frammentazione delle iniziative37. Anche se è ancora presto per una valutazione dell’efficacia, la recente istituzione del credito d’imposta per la R&S, diventato operativo solo nel 2015, a due anni dal decreto legge istitutivo, sembra andare nella giusta direzione. Un altro motivo che giustifica l’intervento pubblico risiede nelle imperfezioni del mercato dei capitali che rendono difficile e costoso, soprattutto per le imprese innovative e di piccole dimensioni, assicurarsi il finanziamento necessario a sostegno del progetto innovativo. Infatti, le banche – canale quasi unico di indebitamento per le imprese medio-piccole – si azzardano a finanziare l’innovazione solo se hanno una relazione di lungo periodo con il cliente, in cui la reputazione dell’impresa compensi le scarse informazioni sul progetto. Si è stimato che un
132
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
aumento della durata della relazione tra banca e impresa, da tre a sei anni, aumenti, ceteris paribus, la probabilità di effettuare attività di R&S di oltre il 10%38. Le imprese di nuova costituzione non possono che appoggiarsi a un “capitalista di ventura”. Tuttavia il mercato del venture capital, la modalità di finanziamento specializzata nel favorire la crescita rapida di startup innovative, è ancora poco sviluppato in Italia39. A questo fine di recente è stata introdotta una normativa (la legge n. 221/2012) il cui obiettivo è proprio di sostenere il processo di crescita delle startup innovative, sulla cui efficacia non esistono però ancora studi affidabili, dato il ristretto periodo di operatività della norma. Non dobbiamo dimenticare tuttavia che le politiche sono solo una parte di ciò che occorre fare. Gran parte dell’attività di innovazione scaturisce dal rischio libero, non assicurato, che ogni imprenditore corre quando sperimenta un nuovo procedimento o un nuovo prodotto. È nostro dovere e nostro interesse che questa fonte di progresso, di mobilità del corpo sociale, non sia disseccata. Diceva Luigi Einaudi nel suo profetico saggio In lode del profitto, poi raccolto nelle Prediche inutili40 che, nella generale tendenza assicurativa delle società moderne, il profitto rimane uno dei pochi elementi di reddito flessibili, che garantiscono l’assorbimento del rischio. “La tecnica e l’economia comandano di mutare; l’uomo vuole essere ancorato a qualcosa di fisso. Legislatori e governanti moltiplicano i legami, i vincoli perché anch’essi sono uomini e sentono il bisogno umano della certezza [...]. In tal modo, vincolando ed irrigidendo, scema l’elasticità del meccanismo economico, crescono i punti di rottura, aumentano le probabilità di crisi e di rivoluzioni. Se le giunture elastiche vengono meno; se le ossa si irrigidiscono saldandosi insieme, come può l’uomo muoversi, mutare, adattarsi alle esigenze mutevoli delle nuove invenzioni le quali si incalzano senza tregua?” E
capitolo quarto Come si produce
133
conclude mettendo giustamente in parallelo l’innovazione degli imprenditori e quella degli scienziati, degli indagatori: “Il profitto è il prezzo che si deve pagare perché il pensiero possa liberamente avanzare alla conquista della verità, perché gli innovatori mettano alla prova le loro scoperte, perché gli uomini intraprendenti possano continuamente rompere la frontiera del noto, del già sperimentato, e muovere verso l’ignoto, verso il mondo ancora aperto all’avanzamento materiale e morale dell’umanità”. NOTE 1 M. Bugamelli, L. Cannari, F. Lotti, S. Magri, Il gap innovativo del sistema produttivo italiano: radici e possibili rimedi, in «Questioni di economia e finanza (Occasional Papers)», 121, 2012. C. Michelacci, F. Schivardi, Does Idiosyncratic Business Risk Matter for Growth?, in «Journal of the European Economic Association», 11, 2013, pp. 343368. 2 Per un esercizio aritmetico del genere, si veda S. Rossi, La regina e il cavallo, Laterza, Roma-Bari 2006. 3 S.N. Broadberry, C. Giordano, F. Zollino, Productivity, in G. Toniolo (a cura di), The Oxford Handbook of the Italian Economy since Unification, Oxford University Press, Oxford 2013. 4 F. Hassan, G.I.P. Ottaviano, Productivity in Italy: the great unlearning, in «VoxEu», 2013, http://voxeu.org/article/productivity-italy-great-unlearning. 5 P. Liberati, G. Travaglini, Riforme senza politica industriale: l’Italia negli ultimi venti anni, in «La Rivista delle Politiche Sociali», 4, 2014, pp. 109-130. 6 T.F. Bresnahan, E. Brynjolfsson, L.M. Hitt, Information technology, workplace organization, and the demand of skilled labor: firm-level evidence, in «Quarterly Journal of Economics», 117, 2002, pp. 339-376; S. Fabiani, F. Schivardi, S. Trento, Quale impresa italiana investe in tecnologie digitali?, in S. Rossi (a cura di), La nuova economia. I fatti dietro il mito, il Mulino, Bologna 2003; M. Bugamelli, P. Pagano, Barriers to investments, in «Applied Economics», 36, 2004, pp. 2275-2286; A. Giunta, F. Trivieri, Understanding the determinants of information technology adoption: evidence from Italian manufacturing firms, in «Applied Economics», 39, 2007, pp. 1325-1334. 7 E. Brynjolfsson, M.L. Hitt, Beyond computation: information technology, organization transformation and business performance, in «Journal of Economic Perspectives», 14, 2000, pp. 23-48; Bresnahan, Brynjolfsson, Hitt, Information technology cit. 8 Per una analisi della scomposizione della dinamica della produttività aggregata nel sistema economico italiano dal 2005 al 2013 si rimanda a A. Linarello, A. Petrella, Productivity and reallocation: evidence from the universe of Italian firms, in «Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)», 353, 2016. 9 I. Visco, Perché i tempi stanno cambiando, il Mulino, Bologna 2015. 10 Oecd, The future of productivity, Oecd Publishing, Paris 2015, http://dx.doi. org/10.1787/9789264248533-en.
134
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
11 Ibid. 12 R. Gordon, The Rise and Fall of American Growth, Princeton University Press, Princeton 2016. 13 E. Brynjolfsson, A. McAfee, Race against the machine: how the digital revolution is accelerating innovation, driving productivity, and irreversibly transforming employment and the economy, Digital Frontier Press, Lexington (Mass.) 2011. 14 D. Andrews, C. Criscuolo, P. Gal, Frontier firms, technology diffusion and public policy: micro evidence from Oecd Countries, Oecd Productivity Working Papers, 201502, Oecd Publishing, Paris 2015, www.oecd.org/eco/growth/Frontier-firmstechnologydiffusion-and-public-policy-oecd-productivity-working-papers.pdf.; Oecd, The future of productivity cit. 15 G. Blalock, F.M. Veloso, Imports, productivity growth and supply chain learning, in «World Development», 35, 2007, pp. 1134-1151; M. Andersson, S. Johansson, H. Loof, Productivity and international trade: firm level evidence from a small open economy, in «Review of World Economics», 4, 144, 2008, pp. 774-801; D. Castellani, F. Serti, C. Tomasi, Firms in international trade: importers and exporters heterogeneity in Italian manufacturing industry, in «The World Economy», 3, 33, 2010, pp. 424-457. P. Augier, O. Cadot, M. Dovis, Imports and TFP at the firm level: the role of absorptive capacity, in «Canadian Journal of Economics», 3, 46, 2013, pp. 956-981. M. Bas, V. Strauss-Kahn, Does importing more inputs raise exports? Firm-level evidence from France, in «Review of World Economics», 2, 150, 2014, pp. 241-475. M. Agostino, A. Giunta, D. Scalera, F. Trivieri, Importazioni, produttività e catene globali del valore: un’analisi sulle imprese europee, in Rapporto Ice 2015-16. L’Italia nell’economia internazionale, Ice, Roma 2016, www.ice.gov.it. 16 E. Pinto, S. Tevlin, Perspectives on the recent weakness in investment, FEDS Notes, 2014, (Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, 21 maggio), www.federalreserve.gov/econresdata/notes/feds-notes/2014/perspectives-on-therecent-weakness-in-investments-20140521.html. 17 C. Dustmann, B. Fizenberger, U. Schonberg, A. Spitz-Oener, From sick man of Europe to economic superstar: Germany’s resurgent economy, in «Journal of Economic Perspectives», 1, 28, 2014, pp. 167-188. 18 L’innovazione nelle imprese, Istat, Roma 2014. 19 B.H. Hall, F. Lotti, J. Mairesse, Evidence on the impact of R&D and ICT investments on innovation and productivity in Italian firms, in «Economics of Innovation and New Technology», 3, 22, 2013, pp. 300-328. 20 EPO Statistics, European patent applications 2006-2015 per country of residence of the applicant, 2016, https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics.html. 21 Bugamelli, Cannari, Lotti, Magri, Il gap innovativo del sistema produttivo italiano cit.; A. Sterlacchini, Il capitale tecnologico delle grandi imprese e la politica industriale, in R. Cappellin, E. Rullani, A. Sterlacchini (a cura di), Il ruolo delle politiche industriali e regionali, 2014, www.rivistasr.it. 22 Rossi, L’innovazione nelle imprese cit. 23 Commissione europea, The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, 2014, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html. 24 C. Cozza, A. Zanfei, Multinazionali e creazione di legami con imprese e università in Italia, in Rapporto ICE 2015-16 cit. 25 R. Brancati (a cura di), Le strategie per la crescita. Rapporto Met 2015, Donzelli, Roma 2015; L. Romano, Industria italiana con alta propensione ad investire e innovare, Nota CSC numero 15-7, 7 marzo 2015. 26 Bugamelli, Cannari, Lotti, Magri, Il gap innovativo del sistema produttivo italiano cit. 27 A. Sterlacchini, F. Venturini, Boosting manufacturing productivity through R&D:
capitolo quarto Come si produce
135
international comparison with special focus on Italy, in «Journal of Industry, Competition and Trade», 2, 13, 2013, pp. 187-208. 28 Bugamelli, Cannari, Lotti, Magri, Il gap innovativo del sistema produttivo italiano cit. 29 Rossi, L’innovazione nelle imprese cit. 30 Bugamelli, Cannari, Lotti, Magri, Il gap innovativo del sistema produttivo italiano cit. 31 Oecd, Product market competition in the Oecd countries. Taking stock and moving forward, Economics department working paper, n. 575, Parigi 2007; F. Hassan, G.I.P. Ottaviano, Productivity in Italy: the great unlearning, in «VoxEu», November 30, 2013; A. Linarello, A. Petrella, Produttività e riallocazione: evidenza empirica dall’universo delle imprese italiane, in «Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)», 353, 2016. 32 P. Montanaro, R. Torrini, Il sistema della ricerca pubblica in Italia, in «Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)», 219, 2013, p. 5. 33 L. Nascia, M. Pianta, Rio Country Report, Commissione europea, Lussemburgo 2015. Cfr. anche G. Viesti, Università in declino. Un’indagine degli Atenei da Nord a Sud, Donzelli, Roma 2016. 34 R.R. Nelson, The simple economics of basic science research, in «Journal of Political Economy», 67, 1959, pp. 297-306; K. Arrow, The economic implications of learning by doing, in «The Review of Economic Studies», 3, 29, 1962, pp. 155-173. 35 A. Caloffi, M. Mariani, A. Sterlacchini et al., Evaluating public supports to the investment activities of business firms: a meta-regression analysis of Italian studies, in «CREI Working Papers», 1, 2016. 36 S. Roper, N. Hewitt-Dundas, J.H. Love, An ex ante evaluation framework for the regional benefits of publicly supported R&D projects, in «Research Policy», 3, 33, 2004, pp. 487-509; M.P. Feldman, M.R. Kelley, The ex ante assessment of knowledge spillovers: government R&D policy, economic incentives and private firm behavior, in «Research Policy», 10, 35, 2006, pp. 1509-1521; R. Bronzini, E. Iachini, Are incentives for R&D effective? Evidence from a regression discontinuity approach, in «American Economic Journal: Economic Policy», 4, 6, 2014, pp. 100-134. 37 F. Lotti, M.L. Stefani, L. Aimone Gigio, E. Gennari, D. Liberati, M. Lozzi, M. Marinucci, R. Rassu, Le iniziative regionali per favorire l’innovazione nelle imprese, in «Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)», 246, 2014. 38 G. Micucci, P. Rossi, Financing R&D investments, in «Journal of Industrial and Business Economics», 2016 i.c.s. 39 V. Vacca, Financing innovation in Italy: an analysis of venture capital and private equity investments, in «Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)», 209, 2013. 40 L. Einaudi, Prediche inutili, in Opere di Luigi Einaudi, volume II, Einaudi, Torino 1964, p. 193.
capitolo quinto
TRE CASI, PER ESEMPIO
In questo capitolo raccontiamo tre storie vere. Sono casi di aziende italiane che abbiamo visitato nell’autunno del 2015, una al Nord, due al Sud. Sono casi di relativo successo. Crediamo che queste aziende siano abbastanza esemplari di talune importanti modalità di funzionamento del nostro sistema produttivo. Sono imprese familiari, pur con schemi di governance diversi. Due sono classificabili come manifatturiere, ma con una forte componente terziaria, l’altra è classificabile come terziaria ma con una fondamentale componente manifatturiera. Nessuna è grande, una è molto piccola. Tutte avrebbero opportunità di crescita, ma queste sono in parte non sfruttate, anche per vincoli posti dal contesto generale. 1. AH, SE CI FOSSE LA FINANZA GIUSTA!
Attraversiamo la zona industriale di Modugno, un vecchio pae sone alle porte di Bari ormai quasi inglobato dalla città, a formare un’area vasta e densa di insediamenti produttivi. Entriamo in un ampio parcheggio, la scritta Masmec si staglia su un capannone. Tutto moderno, nuovo, senza fronzoli. Il fondatore
capitolo quinto Tre casi, per esempio
137
dell’azienda, una laurea in ingegneria al Politecnico di Torino presa mezzo secolo fa, cavaliere del lavoro, ci scorta con piglio sbrigativo. Dalla città in cui si è laureato ha assorbito il fastidio per le ostentazioni (“non esageriamo” è una sua espressione preferita, i torinesi amano dire “esageruma nen”) e la prudenza nel guidare l’azienda. Iniziamo la nostra visita dalla più recente attività aziendale, biomedicale, che si è andata ad aggiungere all’attività tradizionale di produzione di macchinario industriale per imprese dell’automotive. Siamo accompagnati anche dalla figlia del fondatore, Daniela, amministratore delegato (l’altro amministratore delegato è l’ingegnere). La Masmec fattura in complesso 19 milioni di euro nel 2014 con 140 dipendenti, ma solo il 2% del fatturato viene dall’attività biomedicale: loro definiscono questa divisione (non è una società separata) niente più che una startup, ma credono che possa rappresentare il futuro dell’azienda. La divisione biomedicale nasce quasi per caso, all’inizio degli anni Duemila, da una chiacchierata dell’ingegnere con un amico oncologo, da cui emergono analogie tecnologiche dei suoi dispositivi per l’automotive con certa strumentazione per usi medici. Oggi la divisione produce “navigatori” all’interno del corpo umano, per guidare manovre di ago aspirato o per tecniche di microchirurgia. Stanno anche sviluppando, con istituzioni accademiche cittadine, un progetto innovativo per l’imaging (apparecchi diagnostici tipo Tac o Rmn, per intenderci). La visita, guidata dal responsabile della divisione, persona di grande competenza e chiarezza espositiva, è straordinariamente interessante. Il problema principale emerge subito nel corso dell’intervista con i Vinci padre e figlia: non riescono a trovare, per crescere, un partner che sia al tempo stesso industriale e finanziario. Insomma, un venture capitalist degno di questo nome, un sog-
138
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
getto che non si limiti cioè a fornire fondi finanziari attraverso una partecipazione azionaria, ma apporti conoscenza dello specifico mercato, che loro conoscono poco, per far affermare rapidamente tecnologie che ritengono fortemente innovative. I contatti avuti sono stati deludenti: si sono visti offrire dei soldi, non expertise. A quel punto, diciamo noi, converrebbe piuttosto indebitarsi, con banche o anche sul mercato finanziario. Ma, come subito ci viene chiarito, nella storia aziendale e familiare il debito è visto come un male, a volte necessario, altrimenti da evitare. Una mentalità fortemente radicata nel fondatore, sebbene la giovane figlia sembrerebbe lievemente più incline a correre rischi anche sul fronte finanziario. Ci trasferiamo nell’altro capannone, quello storico dedicato all’automotive. La storia della Masmec assomiglia a tante altre della più recente industrializzazione italiana, quella degli anni Sessanta e Settanta: un dipendente che si mette in proprio. Nel 1979 l’ing. Vinci e un suo amico e collega, dipendenti di una grande azienda meccanica del Nord che aveva aperto uno stabilimento a Bari, decidono di tentare l’avventura da soli, come progettisti di macchine industriali. Rapidamente comprendono che i loro clienti non si accontentano del solo progetto, vogliono la macchina chiavi in mano; allora, con pochi soldi racimolati in famiglia, mettono su uno spazio in cui assemblare le macchine meccaniche che progettano, distribuendo la fabbricazione dei singoli componenti a una manciata di piccole officine del circondario. Con l’avvento dell’elettronica, che trasforma il loro settore da meccanico a meccatronico, l’azienda, acquisendo tempestivamente le necessarie competenze, si espande. Il socio muore prematuramente, gli eredi si staccano. La modalità produttiva originaria è rimasta immutata: in azienda si concepisce, si disegna, si progetta la macchina, si fa
capitolo quinto Tre casi, per esempio
139
l’elenco dei componenti, se ne commissiona la realizzazione a svariate ditte subfornitrici – ne hanno circa mille, le principali in zona ma tante sparse per l’Italia – e si assembla il tutto in casa. Tutte le funzioni diverse dalla produzione in senso stretto – marketing, assistenza tecnica, logistica, amministrazione e altro – sono pure accentrate, con l’ausilio di un software gestionale di tipo Erp, cioè un sistema digitale integrato che filtra e gestisce tutte le informazioni rilevanti per ogni aspetto della gestione. In altri termini, la Masmec è alla testa di una “catena del valore”. Una catena non globale, tutta italiana, e anche parziale, perché a essere esternalizzata è la sola produzione dei componenti, non anche le funzioni di servizio. Tuttavia la frammentazione (unbundling) e la esternalizzazione (outsourcing) della produzione sono totali. In realtà la Masmec è un segmento di una più lunga catena del valore: le loro macchine servono a loro volta a produrre componenti di automobili e di altri veicoli a motore. La Masmec è quindi inserita in quattro o cinque catene globali del valore, tante quanti sono i produttori finali che utilizzano i componenti prodotti dalle loro macchine, globali in quanto fortemente internazionali. Di quelle catene l’azienda occupa un segmento intermedio, con una posizione di forza relativa, non essendo tributari di un unico committente. I rapporti con i committenti sono improntanti allo scambio continuo, al co-engineering. Sembrerebbe trattarsi di quella che in letteratura viene etichettata come “relational value chain”. Durante la visita ci viene orgogliosamente mostrato il loro ultimo prodotto: un gigantesco dinosauro lungo 65 metri, irto di robot antropomorfi, di cavi, di pannelli multicolori, che si snoda avvolgendo la coda a formare una U, perché il capannone non è grande abbastanza da contenerlo disteso (qualcuno avrà detto: allunghiamo il capannone, l’ing. Vinci avrà risposto: non esageriamo). Questo immenso, smisurato macchina-
140
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
rio serve a produrre un oggetto molto piccolo rispetto alle dimensioni della macchina che lo sforna, un motore elettrico per auto ibride. Quando ci mostrano il topolino sputato fuori dal dinosauro l’incredulità si dipinge sui nostri volti. Ci viene spiegato che dimensione e complessità dell’apparato produttivo sono proporzionali non alla dimensione del prodotto ma alla sua “esattezza”. Quel motore deve essere perfetto in ogni suo minimo dettaglio, con tolleranze dell’ordine di un micron. Per ottenere quell’esattezza occorrono manipolazioni e prove ripetute, effettuate da dispositivi meccanici ed elettronici allineati per decine di metri. Un altro macchinario, nell’ambiente accanto, è un po’ meno enorme, pur misurando almeno sei o sette metri di lunghezza e pesando chissà quante tonnellate. La sproporzione col prodotto, una specie di spillo, è tuttavia ancora più impressionante. In entrambi i casi i committenti dei macchinari sono grandi aziende, una italiana, l’altra tedesca, che a loro volta forniscono componenti più complesse alle maggiori case automobilistiche del mondo. Vediamo di ricapitolare. L’azienda è sana e robusta, il fatturato è cresciuto ininterrottamente anche negli anni della crisi; solo nel 2009 la Masmec, essendo integrata nel business globale dell’automotive, ha risentito della crisi del comparto registrando un notevole calo degli ordinativi. Più di recente, il valore aggiunto è passato dai 5,2 milioni del 2012 agli 8,6 milioni del 2013, ai 10,3 milioni del 2014 (dati aziendali). L’attività tradizionale può crescere ancora, ai ritmi prudenti che piacciono al fondatore, anche se dallo scorso anno la capacità produttiva è saturata per i limiti fisici del capannone, il che ha portato a rinunciare a degli ordini. L’attività biomedicale, se il contenuto innovativo fosse davvero dirompente, potrebbe crescere in modo esponenziale, ma farlo per linee interne, cioè senza farsi acquistare da un concorrente più grosso, richiede-
capitolo quinto Tre casi, per esempio
141
rebbe comunque un supporto finanziario e di advicing che non riescono a trovare. Per entrambe le linee di business è stato molto importante il ruolo svolto dai contributi della Regione alla spesa in ricerca e sviluppo e lo stretto rapporto di collaborazione con università e con centri di ricerca: un caso di interazione virtuosa pubblico-privato, fonte di occupazione e di trasferimento tecnologico. 2. PER CRESCERE MI VENDO A METÀ
Siamo in auto diretti a Gravina di Puglia, grosso centro agricolo della provincia di Bari, sull’altopiano della Murgia (terra elettiva del fungo cardoncello, una vera prelibatezza), dove ha sede la Macnil. L’azienda è stata fondata esattamente quindici anni fa da una giovane coppia di coniugi, Mariarita Costanza e Nicola Lavenuta, le cui iniziali formano il marchio aziendale. Abbiamo conosciuto la coppia qualche giorno prima, in video conferenza, perché il giorno fissato per l’intervista sarebbero dovuti essere a Barcellona per un incontro di lavoro: in realtà poi è partito solo Nicola, sicché abbiamo potuto beneficiare della guida anche di Mariarita durante la nostra visita, non solo del loro direttore marketing, come in origine previsto. L’azienda, nata nel 2000 come piccola fornitrice della Telecom, è ancora molto piccola: 3 milioni di fatturato per 35 dipendenti. Ma fa un sacco di utili, quasi un milione nel 2014, un terzo del fatturato. È un’azienda puramente terziaria: rea lizza software per dispositivi di localizzazione satellitare per flotte aziendali e applicazioni per facilitare la mobilità cittadina. Diversamente dalla Masmec, i cui prodotti inglobano forti dosi di innovazione propriamente scientifico-tecnologica, la Macnil innova più che altro nelle modalità di commercializza-
142
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
zione. Non si intenda questa distinzione come riduttiva per la Macnil: basti pensare che giganti globali come Amazon, Ikea, eBay, Uber hanno sfruttato appunto idee nuove in fatto di logistica e marketing, usando tecnologie già disponibili sul mercato. In ogni caso anche loro, come la Masmec, hanno sviluppato il software originale, con la collaborazione delle università baresi. La sede aziendale è davvero strana. È un vecchio palazzetto cinquecentesco nel centro storico di Gravina, che si sviluppa intorno a una corte stretta, tutta scale e scalette asimmetriche, quasi un quadro di Escher. L’azienda è nata in una stanza affacciata sulla corte, pian piano ha occupato tutto il palazzetto. Per passare da una stanza all’altra bisogna quasi sempre ripassare per la corte e salire o scendere gradini. Se piove, come nel giorno della nostra visita, la cosa non è banale, la corte è a cielo aperto. Una nuova sede è ora in progetto nella zona industriale di Gravina, con i contributi regionali: si perderà in charme, si guadagnerà in comodità. In una di queste anguste stanze lavorano i commerciali. Un ragazzo alto e barbuto scandaglia i social network, Facebook in particolare, alla caccia di potenziali clienti: ditte anche piccole che abbiano una flotta di veicoli commerciali, camion o furgoni. Macnil fornisce scatolette dotate di carta sim che si montano sui veicoli e un abbonamento a un servizio di localizzazione via satellite, con rilevazioni di vari parametri di viaggio: il tutto consente alla ditta abbonata, per meno di 30 euro al mese, di ottimizzare sicurezza e costi della propria flotta. Individuato, grazie a statistiche che Facebook fornisce a pagamento, un potenziale cliente, il giovane barbuto spedisce sulla pagina Facebook del medesimo un “post”, cioè una locandina pubblicitaria con annesso modulo da inviare per email per maggiori informazioni. Non appena arriva l’email, il che accade in due casi su tre (evidentemente il post è molto convin-
capitolo quinto Tre casi, per esempio
143
cente), nel giro di tre minuti (tre!) parte una telefonata da uno fra i sei ragazzi e ragazze addetti, che con altissima frequenza riescono a spuntare un contratto firmato in pochi minuti. Ciascuno di loro ha una minipostazione con telefono e computer, una addossata all’altra come in un tipico call center. Notiamo che hanno tutti uno specchio davanti a sé: ci viene spiegato che serve a ricordare loro di sorridere mentre parlano, perché così anche il loro eloquio in qualche modo “sorride”. Hanno, ci tengono a dirci, un rapporto speciale con i clienti anche una volta allacciato il vincolo contrattuale, offrono un’assistenza a due livelli, amministrativa e tecnica, molto accurata. L’aspetto interessante della storia Macnil è la soluzione di governance trovata due anni fa per poter crescere: scartata l’ipotesi di una crescita per linee interne, perché troppo lenta e accidentata (stesso problema della divisione biomedicale della Masmec?), si sono fatti mangiare da un pesce molto più grosso, il gruppo Zucchetti, la più grande software house italiana, 360 milioni di fatturato e 2.800 dipendenti. La formula è intelligente: hanno ceduto il 51% delle azioni, conservando l’autonomia societaria e la gestione; alcune funzioni gestionali sono già in comune, per sfruttare economie di scopo e di scala, per altre la cosa è programmata. Sono ora una delle tante società del gruppo Zucchetti, certo, ma sentono di avere le spalle molto più larghe, di avere una sponda sia finanziaria sia tecnologica. È strano anche il modo in cui sono entrati in contatto con i Zucchetti: grazie a Bruno Vespa. Mariarita (cioè l’ing. Costanza) partecipa una sera alla trasmissione “Porta a Porta” come esemplare di imprenditrice meridionale di successo. Nonostante l’ora tardissima, il presidente della Zucchetti assiste alla trasmissione, si entusiasma, l’indomani fa cercare la giovane imprenditrice e dopo poco tempo l’affare è fatto. Insomma, i due coniugi imprenditori non si sono limitati a farsi acquisire, monetizzando il successo e comprandosi con
144
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
quei soldi una qualche rendita, come hanno fatto parecchi startupper italiani con scarso spirito imprenditoriale. Sono ancora lì a combattere per la loro creatura. Potrebbero disporre di idee sfruttabili su vasta scala, ma devono ancora trovare la strada per farlo; stare nella grande scatola Zucchetti offre intanto il vantaggio di farli sentire “protetti” e di potersi affacciare su mercati esteri: la Zucchetti già opera in Brasile e Romania, ha aiutato la Macnil a fare un’acquisizione in Spagna. Un’altra acquisizione molto recente, quella della Getronic di Varese, potrebbe farli diventare leader nel loro segmento di mercato in Italia e forse in Europa. Nel portafoglio prodotti hanno anche le app per le smart city che vendono ai Comuni e offrono informazioni su viabilità e mezzi pubblici. Intendono sviluppare tale segmento verso il comparto business proponendo la pubblicità degli esercizi commerciali agli utenti delle app. Hanno intenzione inoltre di proporsi anche come aggregatori di app di alcuni servizi, tipo quello del car sharing. Ricapitolando, è la soluzione di governance il tratto caratteristico di questo caso: per crescere, anziché affidarsi a un venture capitalist che li conduca alla quotazione in borsa, la famiglia fondatrice ha (rocambolescamente) trovato un socio “paterno”, scambiando con lui una presenza redditizia su un mercato promettente contro l’ombrello del grande gruppo. 3. “AL COMANDO OCCORRE ESSERE IN UN NUMERO DISPARI MINORE DI TRE”
L’intervista al cofondatore e comproprietario della Poliform ha luogo presso il centro espositivo e di formazione dell’azienda (PoliformLab), a Inverigo (Como). L’azienda ha 6 stabilimenti produttivi, in comuni che fanno tutti parte dello storico distret-
capitolo quinto Tre casi, per esempio
145
to del mobile della Brianza. La produzione, realizzata esclusivamente in Italia, si orienta alla fascia alta del mercato. L’azienda è stata fondata, ed è attualmente ancora guidata, dai tre cugini Spinelli-Anzani che nel 1970 hanno assunto le redini dell’impresa artigiana avviata nel 1942 dai rispettivi genitori. Per facilitare il prossimo passaggio generazionale è stata modificata la governance aziendale: nel 2005 sono state costituite tre holding di controllo (una per famiglia) a cui partecipano anche i figli degli attuali proprietari (ma non i loro coniugi), in tutto 8 persone che lavorano tutte in azienda. La Poliform ha cambiato radicalmente mercati di sbocco in questi anni di crisi economica: nel 2008 esportavano solo un quarto del fatturato, è arrivata oggi a esportarne i tre quarti. Una manovra audace, che ha compresso gli utili ma ha salvato le vendite. Il 2015 è stato un anno brillante: fatturato in crescita del 10%, di un terzo quello esportato, raddoppio negli Usa. Attualmente, il problema principale è rispettare i tempi di consegna concordati con i clienti. L’organizzazione interna fa perno su 4 divisioni: sistemi d’arredo, imbottiti, cucine (marchio Varenna) e Contract. La produzione delle prime 3 divisioni, orientate alla clientela retail, è tutta interna all’azienda. La divisione Contract segue invece i grandi progetti internazionali (grandi alberghi, zone residenziali, ecc.); produce “custom”, cioè apposta per il singolo cliente, per mezzo di una rete di artigiani della zona, che vi hanno trovato la loro sopravvivenza durante la Grande Recessione: il distretto brianzolo ha perso un gran numero di aziende e, in qualche caso, ha visto l’ingresso di grandi aziende estere (Frau Group, che controlla i marchi Poltrona Frau, Cassina e Cappellini, è stato acquisito nel 2014 da Haworth). La scelta strategica di internazionalizzazione commerciale si regge su un portafoglio di prodotti di alta gamma, sull’attenzione al design e alla personalizzazione.
146
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Per espandere le vendite all’estero (oltre agli Stati Uniti, l’Asia e anche il Nord Africa) l’azienda ha instaurato contatti con architetti che operano in tutto il mondo seguendo progetti internazionali e arredando le abitazioni della clientela abbiente. Il network di relazioni con questi professionisti viene seguito dagli export manager dell’azienda. Questi individuano gli architetti più conosciuti tramite contatti in loco o seguendo le riviste specializzate, li invitano in Italia (specie in occasione del Salone del mobile) per far loro conoscere i prodotti Poliform. Ogni settimana in media 50-60 persone tra venditori e architetti sono ospiti di PoliformLab: corsi di aggiornamento, visione delle collezioni, analisi delle caratteristiche dei prodotti, nonché grande cucina. La “mensa” aziendale, così chiamata con sublime modestia, è un ristorante di alto livello, che serve a immergere il visitatore in un’atmosfera di raffinatezza italiana, serve a trasmettere il concetto che il Made in Italy è bellezza pura, è stile nazionale, dal design, al cibo, ai vini. L’azienda può contare inoltre su una rete di 82 negozi monomarca in tutto il mondo, nella maggior parte dei casi autonomi (si tratta di contratti in esclusiva, diversi da paese a paese, ma mai di negozi in franchising), a cui si affiancano alcuni negozi “bandiera” in posizioni di rappresentanza (ad esempio sulla Madison Avenue a New York). La stessa produzione si avvale di architetti di fama mondiale, tra cui Daniel Libeskind, Jean-Marie Massaud, Soo Chan. Sul fronte della personalizzazione, il caso delle cucine è illuminante: si tratta di oltre 5.000 pezzi l’anno, tutti con caratteristiche diverse. Per poterlo fare, oltre ai più moderni sistemi Cad-Cam di progettazione computerizzata, l’azienda utilizza macchinari realizzati ad hoc, costruiti su commessa da aziende tedesche. Questi investimenti hanno consentito anche innovazioni di prodotto, come ad esempio una particolare verniciatu-
capitolo quinto Tre casi, per esempio
147
ra “al naturale” del legno, che ne esalta l’essenza, e l’utilizzo di materiali nuovi, come certe resine indeformabili. La forza lavoro è altamente specializzata; la conoscenza di diverse lingue estere è diffusa; vi è un forte legame con il territorio ed è rarissimo che un dipendente lasci l’impresa. La Poliform ha inoltre contribuito a fondare, nel 2011, una scuola tecnica di formazione a Cantù, gestita dalla Federlegno, con l’obiettivo di coltivare l’arte della falegnameria, da affiancare alle conoscenze necessarie per operare sui mercati esteri (capacità commerciali, conoscenze linguistiche, ecc.). Sotto il profilo finanziario, l’impresa opera normalmente con 6-7 banche. La crisi finanziaria internazionale ha colpito l’azienda in un momento in cui aveva intrapreso importanti investimenti (PoliformLab, un nuovo stabilimento, la nuova divisione imbottiti). Nondimeno, già nell’estate del 2009 i proprietari hanno deciso di chiudere i mutui in essere per evitare i rischi connessi con un possibile rialzo dei tassi applicati dalle banche. Solo nel 2011 sono tornati al finanziamento bancario, inizialmente ricorrendo a prestiti a breve termine e, dall’anno passato, a crediti a medio e a lungo termine. Nel 2012, per segnalare la determinazione a continuare a investire nell’azienda, è stato emesso un prestito obbligazionario convertibile (7,5 milioni di euro), integralmente sottoscritto dai tre soci. Le relazioni con le banche sono buone, nessuna difficoltà, anzi!, ad accedere al credito. Il nostro intervistato ritiene che la capacità delle banche di seguire le esigenze del mondo imprenditoriale sia strettamente legata alle persone: alcuni esponenti bancari sono più attenti e capaci di entrare in sintonia e sinergia con l’impresa, altri sono più distanti e legati alle procedure. L’azienda finora è cresciuta essenzialmente per via interna. Unica eccezione è stato l’acquisto del marchio e di alcune attività di “Varenna”, nell’ambito di una procedura fallimentare.
148
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
È stato tuttavia espresso l’interesse a crescere anche per vie esterne, con aziende che abbiano un profilo produttivo e target di mercato simili alla Poliform. La consapevolezza di dover fare un salto dimensionale per essere competitivi a livello globale si scontra però con la volontà di non perdere il controllo dell’azienda ed evitare azzardi: nelle parole dell’imprenditore, al comando “bisogna essere un numero dispari inferiore a tre”. L’acquisizione negli Stati Uniti di una quota minoritaria (37%) di una azienda locale si è rivelata problematica: la mancanza di controllo ha reso difficile individuarne le carenze gestionali, venute alla luce solo in un secondo momento. L’azienda è stata quindi ristrutturata e risanata, ma la vicenda ha dato ancor più valore alla politica dei piccoli passi seguita storicamente. La crescita dimensionale è tuttavia resa necessaria anche dall’allargamento della base sociale, con l’ingresso in azienda della terza generazione. Un bel dilemma, per i gestori attuali, tutti sulla settantina!
capitolo sesto
I “FATTORI ABILITANTI”
Quali siano le determinanti dello sviluppo nel lungo periodo di un’economia, quindi del suo sistema produttivo, è un tema al centro dell’analisi economica da che essa esiste come disciplina autonoma. Oltre mezzo secolo fa si concentrò l’attenzione sulla produttività e sul progresso tecnico quali fattori decisivi dello sviluppo, retrocedendo in secondo piano l’accumulazione di capitale fisico, prima considerata invece il motore dello sviluppo capitalistico. Oggi si tenta un nuovo salto concettuale, risalendo nella scala delle cause e degli effetti; andando quindi alla ricerca di ciò che a sua volta determina la produttività e il progresso tecnico; trovandole nella capacità di un’impresa, di un’economia, di una società, di “imparare” continuamente, nel dinamismo, nell’inventiva endogena, nel gusto della sfida intellettuale e imprenditoriale1. Una tale capacità si può ritrovare inscritta nella cultura e nei costumi di una nazione, per una favorevole congiuntura storica. Oppure può essere costruita, alimentata, da una ragionata azione politica, oltre che dall’impulso creativo degli imprenditori. Al punto da creare dei veri e propri “fattori abilitanti”. Secondo noi i più importanti sono l’ordinamento giuridico, con le sue implicazioni in termini di legalità ed efficienza, e il sistema educativo.
150
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
1. ORDINAMENTO GIURIDICO, LEGALITÀ, EFFICIENZA
Un grosso problema per l’Italia, da sempre, sta nel suo peculiare ordinamento giuridico, che definire ostile ai concetti di efficienza e di impresa sarebbe improprio: semplicemente, li ignora. Dopo il rivolgimento mondiale causato dal nuovo paradigma tecnologico – le Ict – e dalla globalizzazione dei mercati questa peculiarità è balzata in primo piano come ostacolo alla modernizzazione del paese, finendo col costituire un peso che lo fa scivolare indietro. Il sistema di norme e istituzioni di un paese influenza costi e competitività delle imprese, le loro decisioni d’investimento, le modalità di allocazione delle risorse, l’entrata e l’uscita delle imprese dal mercato. Se le norme sono farraginose e instabili, i cittadini, le imprese non possono prevedere le conseguenze delle loro azioni e le loro iniziative economiche sono frenate; si diffondono la corruzione e l’economia sommersa, a vantaggio dei disonesti. Una legislazione troppo complessa induce incertezze interpretative, favorisce le liti, ingolfa l’amministrazione della giustizia. In Italia per molti anni la giurisdizione non è stata intesa come “servizio” ai cittadini ma come valore trascendente da affermare a qualunque costo e in qualunque tempo. Qualche timido avanzamento rispetto a questo immutabile paradigma è molto recente. Al contrario, in una nazione che adotti i principi della libertà economica e abbia davvero a cuore il benessere dei suoi cittadini, la giurisdizione è la fabbrica di un servizio pubblico. Ha una funzione di produzione, dei costi, una tecnologia. I consumatori di quel servizio, cioè i cittadini, desiderano che giustizia sia fatta, sì, ma quando davvero serve, rapidamente, efficacemente, a un prezzo ragionevole. Considerazioni di questo tipo sono state a suo tempo svolte da uno degli autori di questo libro2 e non vi torneremo ulte-
capitolo sesto I “fattori abilitanti”
151
riormente sopra. Ci limitiamo qui a ripetere che il problema è talmente profondo da richiedere un’autentica rivoluzione culturale, che solo alcuni giuristi illuminati, dall’interno della disciplina, possono compiere. In questo capitolo esamineremo tre conseguenze dirette e cruciali di tale peculiarità, sulle quali è in corso uno sforzo di consapevolezza e di correzione, pur con esiti vari e incerti: la legalità nei comportamenti pubblici e privati, la concorrenza nei mercati dei beni – dunque l’efficienza delle relative produzioni – e il funzionamento dell’amministrazione pubblica –, ancora l’efficienza, quindi, ma nella produzione di beni pubblici. La sequela di cronache da cui siamo quasi quotidianamente colpiti ci trasmette, con angosciosa evidenza, il senso di una perdita diffusa, nella società italiana, del rispetto per la legalità; più in generale, di spirito civico. La nevrosi mediatica non deve farci perdere il senso delle proporzioni: gran parte della società italiana è sana, ciascuno di noi è circondato da tante brave persone nella vita familiare e nel lavoro e ne fa ogni giorno esperienza, magari senza troppo badarci, perché il buono non fa notizia. Tuttavia, è ormai diffusa la precisa percezione che l’Italia soffra in misura accentuata di questa patologia sociale: comportamenti micro-illegali dei cittadini, fenomeni più gravi di corruzione di chi ha responsabilità pubbliche, fino alla grande criminalità organizzata. Purtroppo analoga percezione è diffusa all’estero: le classifiche internazionali in questo campo ci collocano sempre in posizioni basse, a volte più da paese in ritardo di sviluppo che da paese avanzato. Ma la legalità è “conveniente” per una collettività (nazione, regione) in termini di benessere materiale complessivo e di traiettoria di sviluppo economico. Lo prova, non senza difficoltà empiriche ma alla fine in modo convincente, l’analisi scientifica del fenomeno.
152
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
I canali di trasmissione che portano da maggiore legalità a maggiore sviluppo sono quelli intuitivi: le imprese produttive subiscono costi aggiuntivi se operano in un ambiente a bassa legalità, costi che le rendono meno efficienti e competitive e si riverberano quindi sulla performance macroeconomica del paese. Questi costi si dividono in almeno tre categorie: costi di prevenzione (ad esempio per assicurazioni e sicurezza); costi diretti (come il “pizzo”); partecipazione ai costi sostenuti da tutta la collettività in relazione alle indagini giudiziarie e alla esecuzione delle pene. Vi si aggiunge, a livello dell’intera società, una distrazione di risorse pubbliche da utilizzi volti ad accrescere la ricchezza nazionale verso usi di pura difesa della integrità della macchina sociale (polizia, giustizia, ecc.). Vi si aggiunge ancora la distorsione del mercato che le interferenze della criminalità inducono nel funzionamento dell’economia, in particolare nella libera concorrenza. Quest’ultimo è fenomeno particolarmente insidioso. Esso è indubbiamente fonte di perdite macroeconomiche, ma può paradossalmente essere percepito da alcune imprese come benefico dal loro punto di vista microeconomico: un commerciante che si veda imporre il pizzo può riceverne in cambio l’assicurazione non solo di non subire violenze, ma anche di essere protetto dall’arrivo di concorrenti in prossimità della sua bottega, a questo fine opportunamente intimiditi. Spesso anche la corruzione di chi ha pubbliche funzioni ha lo scopo di impedire la concorrenza per avvantaggiare il corruttore. Analisi con dati italiani3 hanno confermato la correlazione negativa tra corruzione (misurata dal numero di consiglieri regionali indagati per reati contro la pubblica amministrazione) e crescita economica nelle regioni italiane, negli anni 1980-2004. Un’altra evidenza empirica convincente si è ottenuta mettendo a confronto quanto è successo negli anni successivi ai due disastrosi terremoti in Friuli e in Irpinia4:
capitolo sesto I “fattori abilitanti”
153
l’afflusso di trasferimenti finanziari pubblici ha sortito effetti opposti, di crescita in Friuli (oltre 20 punti percentuali in più rispetto al potenziale nell’arco di un ventennio) e di decrescita in Irpinia (oltre 10 punti in meno), a causa del ruolo svolto in Irpinia dalla criminalità organizzata, che ha distratto i fondi pubblici corrompendo i gestori locali, e più in generale dalla minore qualità e integrità delle istituzioni. Un altro studio5 si è dedicato a investigare l’influenza della criminalità organizzata, sempre per via corruttiva, sull’attribuzione degli incentivi pubblici alle imprese offerti dalla legge 488/92. Classificando i vari comuni italiani per presenza criminale, rilevando i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e i casi di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione della criminalità organizzata, si è trovato che, a parità di altre condizioni, più criminalità è presente e più incentivi pubblici arrivano: non per maggior merito delle imprese riceventi, ma per cattive decisioni pubbliche, presumibilmente orientate da fenomeni corruttivi. È stato fatto qualcosa negli ultimi anni per attenuare questi fenomeni diffusi di mancanza di legalità? Passi avanti se ne sono compiuti, ma molti altri sono da fare. Fra i passi avanti già compiuti vanno citati la legge Severino nel 2012, che introduce un mutamento di approccio al contrasto affrontato non solo mediante il rafforzamento dell’impianto repressivo, ma anche e soprattutto attraverso misure organizzative di prevenzione; la creazione dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nel 2014; il nuovo codice degli appalti nel 2016. Fra quelli ancora da compiere, soprattutto lo sveltimento del processo penale. Sarà importante procedere contemporaneamente sull’amministrazione pubblica e sulle imprese private, adeguando e rendendo certe le sanzioni.
154
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Veniamo alla concorrenza. Essa è alla base della capacità di un sistema economico di valorizzare le sue risorse, di attrarne di nuove e di generare ricchezza. Secondo la teoria economica neoclassica la concorrenza perfetta è il meccanismo ottimale per l’allocazione efficiente di date risorse. Sul nesso tra legalità e concorrenza ci siamo già soffermati, soprattutto in presenza della concorrenza sleale di chi non rispetta le regole o dell’inefficienza di imprese che mantengono un forte livello di informalità per evitare visibilità e controlli. Più in generale, il grado di concorrenza nei vari mercati dei beni dipende dalle norme che la regolano e queste, a loro volta, dipendono dall’ordinamento giuridico e dalle prassi politiche. Quando il libero mercato fallisce nel suo compito di allocare efficientemente le risorse è necessario concedere potere di mercato o rendite agli attori coinvolti. L’azione congiunta di regole e di autorità indipendenti di regolazione limita queste rendite. Mettere l’accento sulle regole per tutelare il libero funzionamento del mercato, e al tempo stesso per ovviare ai suoi fallimenti, non è un precetto da economia pianificata: è un caposaldo del pensiero liberale. I veri liberali pensano, sì, che il libero mercato perfettamente concorrenziale sia la modalità organizzativa più efficiente per rendere massimo il benessere materiale di tutti; ma sono da sempre convinti che si tratti di una modalità non esistente in natura, che sia invece una creazione artificiale dell’uomo evoluto. Un mercato non sottoposto a regole e a controlli finisce con l’autosmantellarsi a causa della endemica tendenza dei soggetti che vi operano come venditori a ridurre la concorrenza o a collocare il mercato stesso su traiettorie esplosive. È, questa sì, una legge di natura. In Italia veniamo da un passato di sensibilità pubbliche poco amiche della concorrenza. Ci eravamo certamente spinti troppo oltre nell’assicurare rendite anche là dove il fallimento
capitolo sesto I “fattori abilitanti”
155
del mercato fosse manifestamente assente o comunque non dimostrato. Faticosamente abbiamo intrapreso negli anni passati un percorso di liberalizzazione, in diversi settori. Fondamentale è stato l’impulso europeo. In materia di servizi, che sono i quattro quinti dell’economia, abbiamo ridotto il divario che ci separava dalla media dei paesi avanzati. Restano i disservizi burocratici, il debole enforcement dei contratti causato dalle inadeguatezze del sistema giudiziario. Sono fattori che, oltre ad accrescere i costi per le imprese, ostacolano l’innovazione, che è invece stimolata da una maggiore concorrenza. Alcuni studi empirici hanno provato a stimare la maggior crescita del Pil e della produttività ottenibile nel nostro paese attraverso un aumento della concorrenza nei mercati dei servizi. Come per tutte le simulazioni basate su modelli occorre cautela e più di un grano di sale nel valutarne i risultati. Tuttavia se ne possono ricavare utili indicazioni, almeno qualitative, per orientare la politica economica. Un lavoro condotto da economisti dell’Ocse6 ad esempio mostra (fra l’altro) che se l’Italia avesse allineato all’inizio del passato decennio la sua regolamentazione dei servizi a quella dei paesi più virtuosi si sarebbe ritrovata alla vigilia della crisi con un livello della produttività totale dei fattori di dieci punti più alta di quella effettivamente osservata. Uno studio condotto in Banca d’Italia7 si concentra sulla performance dei settori manifatturieri che utilizzano input di servizi, mettendo in rilievo come essa risenta, in termini di produttività, competitività internazionale e valore aggiunto, degli extra costi che le imprese devono sopportare a causa delle rendite consentite ai produttori di servizi da una regolamentazione imperfetta. Ma gli stessi settori da liberalizzare possono ricavare benefici da incisive misure di deregolamentazione, che ne favo-
156
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
riscono la capacità d’innovazione, di prodotto e di processo, e stimolano la ricerca della competitività lungo dimensioni diverse dal prezzo, come la qualità e lo spingersi verso nuovi prodotti e mercati. Il cammino resta impervio. È esemplare la vicenda della cosiddetta Legge sulla concorrenza. Il Parlamento fin dal 2009 aveva chiesto al governo di predisporre annualmente un disegno di legge sulla concorrenza, recependo le indicazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm). Finalmente il governo, nel febbraio del 2015, ha messo in cantiere la prima di queste leggi. La proposta governativa si è inabissata però in Parlamento, soffocata dall’azione di mille lobbies. Nonostante l’impegno del governo non si sa se e quando vedrà la luce. L’Ocse da tempo addita con chiarezza la spiegazione di fenomeni di questo tipo: da noi un disegno regolatorio settoriale anche ben fatto – almeno nel confronto internazionale – si cala in un contesto istituzionale e di norme generali ostile alla effettiva applicazione di quelle regole. Il più recente rapporto dell’Ocse su questi temi riassume la questione nel concetto di governance pubblica: le modalità con cui le leggi vengono predisposte e scritte; le procedure di stesura e approvazione dei regolamenti attuativi; le prassi amministrative; la capacità del sistema di far rispettare le leggi; le ampie sacche di evasione e corruzione. Norme primarie chiare e stabili sarebbero la prima esigenza; ne deriverebbero regole del gioco certe, non ambigue, poco suscettibili di contenzioso sul piano attuativo e interpretativo. Ma la buona legislazione non basta, bisogna che le amministrazioni pubbliche collaborino, innanzitutto semplificando la loro azione complessiva. La stratificazione dei livelli decisionali non aiuta: molte analisi anche empiriche da tempo sottolineano come la creazione di plurimi livelli di governo concorra a creare occasioni di corruzione, alterando la concor-
capitolo sesto I “fattori abilitanti”
157
renza. Aiutano invece una maggior trasparenza degli atti, una estesa informatizzazione dei rapporti con i cittadini che sono clienti dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche. Questo ci porta alla vexata quaestio dell’efficienza dell’amministrazione pubblica. È fresca d’inchiostro la riforma generale delle amministrazioni pubbliche centrali e locali apprestata dal governo, che va sotto il nome del ministro proponente, Marianna Madia. La legge è in vigore dall’agosto del 2015, ma fissa solo i principi, delegandone l’attuazione a numerosi decreti ministeriali. È su questi che si è combattuta la vera battaglia con i diversi portatori di interessi e di responsabilità. Nel momento in cui scriviamo molti decreti sono stati emessi, sebbene alcuni siano ancora in attesa dei relativi pareri per divenire operativi. Due pezzi importanti della riforma sono ancora da attuare: quello sul pubblico impiego e quello sulla riorganizzazione delle articolazioni periferiche. Da ultimo una sentenza della Corte Costituzionale ha smontato pezzi importanti. È una vera riforma? È presto per dirlo. Molti osservatori qualificati, fra cui economisti e giuristi della Banca d’Italia, l’hanno esaminata nel suo farsi8. La valutazione di sintesi è che essa fa fare numerosi passi avanti rispetto ai vari tentativi di riforma dell’ultimo quarto di secolo. Resta però un problema di fondo, emerso durante l’iter di scrittura dei decreti delegati: è molto difficile venire a patti con le capacità delle lobbies di influire sia sul livello politico (ministeriale e parlamentare) sia su quello amministrativo; più in generale misurarsi con la cultura giuridica degli enti di controllo e con la giurisprudenza amministrativa. Questi sono esattamente i principali problemi all’origine dell’inefficacia dei conati di riforma degli anni passati. Il reclutamento degli impiegati pubblici è un esempio chiaro. Pre-
158
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
vale tuttora un modello di funzionario e dirigente pubblico a cui sono richieste prevalentemente competenze generiche di carattere giuridico. Sono pochi gli economisti e gli ingegneri. Sono pochi i veri esperti dei temi trattati. Non aiuta il fatto che del tema si occupino in Italia quasi esclusivamente esperti di diritto amministrativo, tra l’altro con scarsissima esperienza di gestione e consapevolezza della rilevanza dell’efficacia dell’azione amministrativa, tra i principi generali il più negletto. Prima ancora della legge Madia, in tema di semplificazione amministrativa e normativa sono stati fatti progressi negli ultimi anni, ad esempio con la segnalazione certificata d’inizio attività (Scia), con i programmi di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese (Moa), con gli sportelli unici. Non si è ancora modificata, tuttavia, la percezione negativa che gli imprenditori italiani e stranieri hanno del funzionamento dell’apparato amministrativo. A radicarla contribuiscono la tortuosità e la lentezza dei processi di riforma: si pensi proprio al caso dello sportello unico per le attività produttive, istituito nel 1998 e non ancora pienamente efficace. La legge Madia rappresenta un avanzamento considerevole, ma lo sforzo va continuato. Rendere efficiente l’amministrazione pubblica, a tutti i livelli, dev’essere la prima preoccupazione di chiunque abbia responsabilità politiche. È difficilissimo, perché per farlo occorre battere decenni di cultura giuridica e sindacale. Le resistenze di ampie parti dell’amministrazione sono fortissime. Ci si può riuscire facendo leva su coloro che dall’interno dell’amministrazione e della professione giuridica pensano che efficienza non sia una parola volgare estranea al ragionamento giuridico ma la pietra angolare su cui si regge qualunque società moderna.
capitolo sesto I “fattori abilitanti”
159
2. L’ISTRUZIONE
È intuitivo che i lavoratori più istruiti abbiano una maggiore capacità di produrre innovazione e di adattarsi ai cambiamenti organizzativi. La correlazione tra quota di addetti laureati e capacità innovativa di un’impresa è alta: dove questa quota è superiore a una certa soglia, la probabilità per l’impresa di investire in ricerca e sviluppo è maggiore. Se vi sono pochi dubbi sui benefici di una forza lavoro più qualificata, meno ovvio è individuare le qualifiche necessarie. L’informatizzazione dei processi produttivi già attuata ha valorizzato le funzioni manageriali e intellettuali e ha reso sostituibili con un computer molte funzioni, anche intermedie, fortemente ripetitive. Internet e il cloud computing permettono di fare a meno della contiguità fisica delle persone che collaborano a un progetto: molte delle attività legate alla conoscenza possono essere svolte con un’interazione remota; l’unbundling delle funzioni produttive rende possibile delocalizzarne alcune, come la progettazione, anche all’altro capo del mondo. Sono fenomeni che hanno portato, in molti paesi, a una crescita pronunciata delle professioni a più alta qualificazione, a scapito di quelle intermedie; molti lavoratori impiegati in queste ultime sono stati forzati ad accettare compiti meno qualificati e meno retribuiti; ne è conseguita una polarizzazione delle retribuzioni. In Italia il fenomeno è più indietro: in particolare la crescita della parte alta della distribuzione retributiva dei dipendenti è dubbia. Ma la tendenza è chiara anche da noi: sono sempre più a rischio i compiti dove non è richiesto un intervento cognitivo umano. Il problema non riguarda solo poche figure professionali, ma la generalità dei lavori. La pervasiva influenza, su tutte le attività lavorative, della connettività mobile alla Rete richiede nuove abilità professio-
160
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
nali, come quella di raccogliere, selezionare e analizzare tempestivamente i dati presenti in Rete. Ma distinguere fulminea mente l’informazione giusta da quella sbagliata e presentata come giusta, è essenziale; la capacità di calcolo va economizzata e orientata. Per fare ciò bisogna disporre di un robusto equipaggiamento di competenze, che vanno però continuamente aggiornate per tenere il passo di cambiamenti spesso imprevedibili. Per sviluppare il capitale umano di un paese non basta più fornire a un numero elevato di studenti un bagaglio di nozioni da applicare in modo standard durante la loro vita lavorativa. È necessaria quella che gli educatori chiamano appunto la “competenza”, cioè la capacità di mobilitare risorse personali – saperi, saper fare, atteggiamenti – e risorse informative esterne per rispondere in modo efficace a situazioni spesso inedite. Su questo terreno, l’Italia non è necessariamente svantaggiata. Se si discute dei problemi e delle prospettive del nostro sistema produttivo con imprenditori e manager, emerge costantemente una caratteristica che contraddistingue le imprese italiane di successo, piccole e grandi: la capacità di adattare i propri prodotti alle diverse esigenze dei clienti, discostandosi dai modelli standard. Esiste una “flessibilità” italiana spesso vista come la risposta all’“affidabilità” tedesca. Il caso prima analizzato della Poliform dimostra proprio questo: comprano affidabilissimi macchinari tedeschi, se ne servono per fabbricare oggetti ad personam. Il sostrato di competenze artigianali e abilità professionali su cui si è costruita la fortuna di gran parte dell’industria italiana porta in modo naturale a favorire un’attitudine basata sulle competenze rispetto a una che privilegi la meccanica applicazione di nozioni preconfezionate. Non sembra qui esservi uno svantaggio italiano. Perché allora non siamo riusciti a sfruttare
capitolo sesto I “fattori abilitanti”
161
maggiormente questa predisposizione innata degli imprenditori e dei lavoratori italiani? Perché un’ampia disponibilità di competenze non è sufficiente. Occorre, come osserva lo storico economico Mokyr per il caso inglese, la giusta combinazione tra le abilità artigianali e la conoscenza scientifica più strutturata9: “Una società in cui la conoscenza è puramente artigianale è destinata a ripiegarsi su un dato equilibrio tecnologico, diversamente da una società in cui il mondo degli artigiani è costantemente pungolato da iniezioni di nuova conoscenza dall’esterno”. Serve una conoscenza scientifica di alto livello, per essere alla frontiera della ricerca, di base e applicata; ma serve anche sviluppare uno scambio costruttivo tra artigiani e scienziati. Il futuro pone sfide difficili. Il progresso tecnologico si è sempre lasciato alle spalle intere categorie di lavori, presto sostituiti da altri. Stavolta il fenomeno può essere molto intenso e complesso da governare. Negli Stati Uniti come nei principali paesi europei, Italia inclusa, uno su due degli attuali posti di lavoro sarebbe a rischio di essere automatizzato nell’arco di uno o due decenni10. Non c’è mai stato un momento migliore come oggi per un lavoratore con abilità speciali o semplicemente con la giusta istruzione, perché egli sia in grado di utilizzare la tecnologia per creare valore. Simmetricamente, non c’è mai stato un momento peggiore come oggi per un lavoratore con abilità solo ordinarie, perché sta avanzando a passi spediti un replicante che lo rimpiazzerà e non vi saranno blade runners a impedirlo. Ma qual è la giusta istruzione, quella necessaria per non essere spazzati via dalla rivoluzione digitale? Secondo taluni11 il lavoro può essere classificato secondo una matrice due per due: cognitivo o manuale, di routine o no. La domanda di lavoro sembra in calo tendenziale per tutte le attività di routine, anche per quelle cognitive. La categoria dei lavori cognitivi
162
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
ma di routine è molto affollata nelle nostre società terziarie, impiegatizie; ospita gran parte del ceto medio, su cui, quindi, grava la minaccia maggiore. Come si cala tutto questo nella realtà italiana d’oggi, messa a confronto con quella degli altri paesi avanzati? Il tema che balza all’attenzione è quello dell’incontro fra “offerta formativa” delle scuole e delle università e la “domanda di competenze” da parte delle imprese. La prima cosa da dire è che il sistema educativo italiano ha cominciato a porsi questo problema solo poco tempo fa, risentendo a lungo dell’impostazione idealistica dei suoi normatori pubblici, per i quali il compito di fornire maestranze alle imprese sembrava del tutto secondario, limitato nei decenni passati agli istituti professionali. Si trattava di una visione ottocentesca, che per “impresa” intendeva un capannone industriale fordista e comunque una realtà meno nobile dello “studio”. Parte di quella mentalità sopravvive nella scuola italiana di oggi. Gli istituti tecnici sono dei licei di serie B. Gli istituti professionali sono stati reintrodotti qualche anno fa dalla riforma Gelmini (dal nome di un passato ministro dell’Istruzione) e sono concepiti più come sbocco obbligato per chi non è in grado di accedere a un liceo o a un istituto tecnico. Sono molto noti i risultati del test Pisa (Programme for International Student Assessment) condotto ogni tre anni dall’Ocse (nel dicembre 2016 saranno pubblicati i risultati relativi al 2015): i quindicenni italiani vanno peggio della media Ocse, anche se la tendenza 2009-2012 è in lieve miglioramento. Dove la situazione si fa preoccupante è però all’università, luogo in cui si “fabbricano” la conoscenza scientifica e il corredo di competenze dei lavoratori più qualificati. Nei paesi avanzati chi lavora in un’azienda, dunque chiunque non sia un
capitolo sesto I “fattori abilitanti”
163
impiegato pubblico, spesso ha un diploma universitario tagliato sulle esigenze dell’azienda stessa. È il titolo di studio che nel mondo moderno delle competenze ha sostituito il diploma di scuola secondaria. Ma non si tratta di un “dottore” all’italiana, si tratta di una persona dotata, appunto, di competenze ingegneristiche o aziendalistiche che vanno al di là del possesso di una tecnica. In Germania a rilasciare questo tipo di diploma universitario sono ad esempio le Fachhochschulen, cioè le facoltà di scienze applicate; in Francia gli Istituti universitari tecnologici (Iut) o quelli professionali (Iup). In Italia sono stati recentemente creati gli Istituti tecnici superiori (Its), proprio a imitazione delle esperienze franco-tedesche, ma l’iniziativa è troppo recente perché se ne possa dare un giudizio. Per il momento il confronto fra la realtà italiana e quella degli altri paesi avanzati presenta un’anomalia forte nella congiunzione fra istruzione secondaria e terziaria, cioè fra scuola e università, e la natura dell’anomalia sta proprio nella mancanza di uno strato formativo superiore, quindi universitario, adatto ai bisogni della generalità delle imprese. Volevano forse esserlo le lauree brevi: in parte hanno effettivamente migliorato le cose, ma non hanno risolto in modo convincente il problema. Da ciò dipendono essenzialmente i macro fenomeni che vengono normalmente discussi quando si parla dell’università italiana: il basso numero di laureati e l’alto tasso di abbandono: solo il 24% dei giovani fra i 25 e i 34 anni è in possesso di un titolo assimilabile alla laurea, contro il 41 della media Ocse; meno di 60 giovani su 100 che tentano gli studi universitari arrivano alla laurea contro i 70 della media Ocse12. L’università italiana funziona meglio nel segmento immediatamente successivo a quello delle competenze che abilitano al lavoro normale nelle imprese, il segmento delle lauree magistrali. Non a caso gli studenti italiani nelle scuole di dottorato straniere sono fra i migliori del mondo.
164
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Dove tornano i problemi è nel segmento ancora successivo, quello, appunto, delle scuole di dottorato. Qui la distinzione fra discipline diviene però cruciale. Le difficoltà maggiori nel confronto internazionale le riscontriamo nei dottorati giuridico-umanistici e in quelli socio-economici. I dottorati ingegneristici e scientifici reggono meglio la competizione internazionale, dato il carattere naturalmente cosmopolita delle discipline scientifiche13. Sta di fatto che ai vertici delle nostre grandi imprese ci sono persone che hanno spesso completato gli studi all’estero. Se si pensa alle graduate schools tedesche o alle grandes écoles francesi, sembra quasi che l’Italia abbia rinunciato a formare in casa propria la sua élite professionale, lasciando che a svolgere questo compito siano istituzioni universitarie di altri paesi. Tutto questo solo a causa dell’inadeguatezza dell’offerta? No, vi è anche un problema di domanda, che riguarda innanzitutto le imprese. Si è creato un circolo vizioso tra offerta e domanda: se il sistema universitario italiano non è del tutto in grado di produrre capitale umano adeguato a un’economia moderna e avanzata, le imprese che dovrebbero domandarlo non sono, dal canto loro, in realtà quasi mai attrezzate a riconoscerne i diversi gradi di qualità, a richiederlo, ad assegnargli il prezzo giusto. Si determina spesso quello che Ignazio Visco ha chiamato “paradosso”14: dal punto di vista della teoria economica a un basso numero di lavoratori con più elevata istruzione dovrebbe corrispondere ceteris paribus un rendimento molto maggiore di questa, mentre in Italia un dipendente laureato guadagna non il 45% in più di un diplomato, come nella media europea, ma solo il 30; nella fascia d’età 25-34 il divario fra il dato italiano e la media europea si allarga a 20 punti. Torna quella che è la madre di tutte le anomalie, la patologica diffusione fra le nostre imprese della piccola o piccolissima dimensione, della bassa inclinazione alla globaliz-
capitolo sesto I “fattori abilitanti”
165
zazione, del carattere familiare fin nel management, del basso livello d’istruzione dei componenti della famiglia proprietaria e gestrice15. Tutte caratteristiche che ostacolano lo sviluppo di una domanda di personale più istruito. Rispetto agli altri principali paesi europei, molti lavori ad alta qualità sono svolti da lavoratori con al più un diploma di scuola superiore. Tale particolarità si è acuita nell’ultimo decennio: nonostante la percentuale di lavoratori laureati sia aumentata sensibilmente, la loro incidenza nelle occupazioni più qualificate è rimasta sostanzialmente stabile. In Francia e in Germania è successo il contrario: nei lavori di qualità più alta, i livelli d’istruzione universitaria sono cresciuti più che proporzionalmente16. Da ultimo affrontiamo il tema dolente delle risorse pubbliche. L’Italia si caratterizza per un livello d’investimento pubblico in istruzione tra i più bassi tra i paesi Ocse. Il livello delle sue rette universitarie (circa 1.000 euro l’anno in media) è ormai il secondo nell’Europa continentale dietro l’Olanda ma non è in grado di compensare il basso livello di finanziamento pubblico. Come spesso accade, l’Italia non ha fatto una vera scelta; ha tagliato i finanziamenti pubblici, senza ammettere che ciò avrebbe richiesto uno spostamento a carico delle famiglie del costo degli studi universitari ancora più sostanzioso. Le entrate per le rette sono invece ancorate al finanziamento pubblico: se questo cade (-11% dal 2008) devono cadere anch’esse, perché non possono superare il 20% del primo. Alcuni passi avanti sono stati fatti: una quota del finanziamento dipende oggi dalla valutazione nella ricerca e dal numero degli studenti che l’ateneo attrae. Proprio la carenza di fondi pubblici sta però ostacolando l’entrata a regime del nuovo modello, data anche la difficoltà politica di operare grandi redistribuzioni tra atenei. Più in generale, il sistema italiano d’istruzione ha intrapreso un percorso di cambiamento, pur faticoso e lento.
166
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Abbiamo troppe piccole università, così come abbiamo troppe piccole imprese e piccole banche? Forse, soprattutto se ogni università pretende di coprire tutti i campi del sapere: questo è certo il risultato di spinte localistiche e di costumi familiari che inducono a mantenere i propri figli il più possibile vicini durante gli studi, diversamente da quanto accade, ad esempio, nel mondo angloamericano. Il problema è però più generale, a nostro avviso. Sta di fatto che nell’arco degli ultimi venti anni, in rapporto al Pil, la spesa delle famiglie (al netto dei sussidi pubblici) è raddoppiata, mentre quella pubblica è rimasta costante in complesso, diminuendo per studente. Non è così che si progetta il futuro, né dei singoli né del paese. NOTE 1 E. Phelps, Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change, Princeton University Press, Princeton 2013. 2 S. Rossi, Controtempo. L’Italia nella crisi mondiale, Laterza, Roma-Bari 2009. 3 N. Fiorino, E. Galli, I. Petrarca, Corruption and Growth: Evidence from the Italian Regions, in «European Journal of Government and Economics», 2, 1, 2012. A. Del Monte, M. Marrelli, Tax Evasion and Strategic Behaviour of the Firms, in «Journal of Public Economics», 37, 1, 1988, pp. 55-69. 4 G. Barone, S. Mocetti, Natural disasters, growth and institutions: A tale of two earthquakes, in «Journal of Urban Economics», C, 84, 2014, pp. 52-66. 5 G. Barone, G. Narciso, Organized crime and business subsidies: Where does the money go?, in «Journal of Urban Economics», C, 86, 2015, pp. 98-110. 6 R. Bourlès, G. Cette, J. Lopez, J. Mairesse, G. Nicoletti, Do product market regulations in upstream sectors curb productivity growth? Panel data evidence for Oecd countries, in «Economics Department Working Paper», 791, 2010. 7 G. Barone, F. Cingano, Service Regulation and Growth: Evidence from Oecd Countries, in «The Economic Journal», 555, 121, 2011, pp. 931-957. 8 C. Giorgiantonio, T. Orlando, G. Palumbo, L. Rizzica, Incentivi e selezione nel pubblico impiego, in «Questioni di economia e Finanza (Occasional Papers)», 342, 2016; R. Occhilupo, L. Rizzica, Incentivi e valutazione dei dirigenti pubblici, in «Questioni di economia e Finanza (Occasional Papers)», 310, 2016. 9 J. Mokyr, The enlightened economy. An economic History of Britain 1700-1850, Yale University Press, New Haven 2009, p. 116 (trad. nostra). 10 I. Visco, Perché i tempi stanno cambiando, il Mulino, Bologna 2015. 11 D. Acemoglu, D.H. Autor, Skills, tasks and technologies: implications for employment and earnings, in «Handbook of labour economics», 4, 2011, pp. 1053-1171.
capitolo sesto I “fattori abilitanti”
167
12 Ocse, Education at a glance 2015: Oecd indicators, Paris 2015; Anvur, Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca, Roma 2016. 13 Ibid. 14 I. Visco, Investire in conoscenza. Crescita economica e competenze per il XXI secolo, il Mulino, Bologna 2014. 15 Su quest’ultimo aspetto si vedano F. Schivardi, R. Torrini, Cambiamenti strutturali e capitale umano nel sistema produttivo italiano, Banca d’Italia, Roma 2011. 16 D. Depalo, Return on education around Europe: where do we stand? Where do we go?, mimeo, Banca d’Italia, Roma 2016.
capitolo settimo
LA FINANZA
Se vi sia un nesso tra sviluppo finanziario e sviluppo economico e quale ne sia la direzione di causalità è tema che anima da anni nel mondo un dibattito vivacissimo. La sfida è empirica: trovare evidenza, nei dati e nei fatti storici, dell’ipotesi teorica che un più alto grado di sviluppo del sistema finanziario favorisca una maggior crescita economica generale. La letteratura empirica disponibile, pur orientata a sostenere quell’assunto, non è conclusiva. Ci può soccorrere l’analisi storica: una finanza sviluppata è centrale per far funzionare e crescere le economie moderne, per aumentare le opportunità di benessere di tutti. Purché si riesca a controllarne l’intrinseca instabilità. In questa sezione guarderemo alla finanza sotto il suo duplice aspetto, quello di settore produttivo molto importante per il “saper fare” dell’Italia ma anche, e forse soprattutto, quello di fattore abilitante di crescita della produttività e di sviluppo per tutti gli altri settori. Tratteremo prima il tema generale della struttura finanziaria delle imprese italiane e del paese, poi quello specifico delle sue banche.
capitolo settimo La finanza
169
1. LA STRUTTURA FINANZIARIA DELLE IMPRESE E DEL PAESE
Nel momento in cui i postumi della crisi finanziaria globale si attenuano, alcune economie sembrano avviate a una nuova stagione di sviluppo, altre vi aspirano, in tutto il mondo si fronteggia lo stesso problema: come finanziare gli investimenti di lungo termine, in particolare i progetti innovativi. In nove grandi paesi, avanzati ed emergenti, che nel complesso rappresentano il 60% del Pil mondiale, nel 2010 la spesa per investimenti ammontava a quasi 12 trilioni di dollari; entro il 2020 se ne attende un aumento a 19. Per finanziare le grandi opere pubbliche, anche alla luce delle crescenti tensioni di finanza pubblica generate dalla crisi, è essenziale attrarre capitali privati. Sono per questo fondamentali una buona programmazione delle iniziative e piena trasparenza su modi e tempi. Agli investitori istituzionali (fondi pensione, compagnie di assicurazione, fondi sovrani) va offerta l’opportunità di diversificare i rischi ottenendo flussi stabili di reddito su orizzonti temporali lunghi. La disponibilità di risorse finanziarie a lungo termine è precondizione per gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) e per la promozione di progetti imprenditoriali innovativi. Ma finanziare l’attività innovativa è arduo. I progetti sono molto rischiosi e spesso difficili da spiegare a investitori esterni; le imprese preferiscono mantenere riservatezza sulle attività svolte per evitare che i concorrenti si approprino dell’idea. Le risorse interne costituiscono la principale fonte di finanziamento della R&S nella gran parte dei paesi. Si tratta però di una forma di finanziamento condizionata dal ciclo economico e indisponibile alle imprese di nuova costituzione, che spesso sono proprio quelle che sviluppano le innovazioni di frontiera.
170
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Quando l’impresa che innova ha bisogno di risorse esterne, il ricorso al capitale azionario è preferibile a quello di debito. Il capitale azionario non richiede garanzie e consente agli investitori di beneficiare interamente dei rendimenti dei progetti in caso di successo; il problema delle forti asimmetrie informative è attenuato dalla presenza attiva di investitori in capitale di rischio. Numerosi studi mostrano come il ricorso al capitale azionario aumenti considerevolmente l’attività innovativa delle imprese1. Analisi recenti condotte in Banca d’Italia2 confermano questo risultato nel nostro paese: l’emissione di azioni accresce di circa un terzo la probabilità di svolgere attività di R&S nelle imprese high-tech. Il sistema finanziario italiano è però peculiare fra quelli dei paesi avanzati a causa della maggiore dominanza del credito bancario tra le fonti di finanziamento delle imprese. Guardiamo alcuni dati rilevanti, iniziando dalla struttura finanziaria delle imprese. Rispetto a tutti gli altri principali paesi europei, le imprese italiane si distinguono per avere meno capitale e più debito bancario. Nel 2015 in Italia erano quotate 256 aziende non finanziarie, contro le oltre 700 di Francia e Germania; il valore di mercato complessivo delle società non finanziarie quotate era di poco superiore da noi al 20% del prodotto interno, a fronte del 47 e del 69%, rispettivamente, in Germania e in Francia. Anche il mercato obbligazionario, nonostante la rilevante espansione osservata durante la crisi, resta meno sviluppato rispetto alla Francia e ai paesi anglosassoni. La vulnerabilità delle imprese italiane si era già accentuata negli anni precedenti la crisi. Il calo della competitività e la difficoltà di adattamento ai cambiamenti dell’economia mondiale negli ultimi due decenni si riflettevano in una progressiva riduzione della redditività operativa. Il rapporto tra margine
capitolo settimo La finanza
171
operativo lordo e valore aggiunto si riduceva da circa il 40% alla metà degli anni Novanta al 36 nel 2008. La spesa per investimenti, tuttavia, rimaneva elevata grazie a un forte ricorso al debito, sospinto da condizioni di mercato favorevoli. Tra il 2000 e il 2008 il credito bancario alle imprese cresceva in media a un ritmo di oltre l’8% l’anno, più del 12% nel solo 2007; i tassi di interesse bancari si riducevano gradualmente, dopo l’adozione dell’euro, fino al 4,2% nel 2005; il differenziale con i corrispondenti tassi medi europei si annullava. Secondo l’indagine Invind condotta dalla Banca d’Italia la percentuale di imprese “razionate”, quelle che chiedevano ma non ottenevano finanziamenti dalle banche, si riduceva a meno del 3% in media tra il 2006 e il 2008. In quegli anni il grado di copertura degli investimenti con fonti interne si dimezzava, raggiungendo nel 2008 il minimo storico del 36%. Negli anni precedenti il grande collasso due peculiarità del rapporto banca-impresa in Italia raggiunsero la massima evidenza. Si tratta di caratteristiche ancora presenti, sia pure in misura decrescente, nel nostro sistema. Innanzitutto, il credito bancario concesso alla stragrande maggioranza delle aziende italiane, abbondante e facile, era per di più assai frazionato fra diverse banche. In media una grande impresa italiana aveva debiti a vario titolo con 15 banche, contro le 11 delle imprese francesi e le 8 delle tedesche3. Il cosiddetto “affidamento multiplo” era caratteristico delle imprese del nostro paese, anche di quelle più piccole. Lo spiegava il desiderio delle imprese, in particolare di quelle medie, di non dire troppo di sé a nessuna banca in particolare, unito al desiderio delle banche di diversificare il rischio di credito in un ambiente giuridico nominalmente favorevole ai debitori. Peccato che tutto questo fosse il contrario di quanto prescritto dal paradigma del relationship banking, cioè del rapporto
172
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
privilegiato con una banca che sa tutto dell’impresa affidata, anche per canali non tradizionali. Inoltre, buona parte del credito bancario veniva concesso nella forma tecnica dello “scoperto di conto corrente”. In altri termini, l’impresa teneva presso la banca un conto che poteva in linea di principio anche presentare saldi positivi, ma che di fatto li presentava sempre negativi: contrattualmente la banca autorizzava l’impresa, se e quando volesse, ad andare “in rosso” entro un certo massimale concordato. Gli interessi venivano conteggiati all’evenienza. Una forma tecnica assai diversa dal tradizionale mutuo a rate fisse e interessi predeterminati. Essa era molto più diffusa in Italia che in altri paesi, come ad esempio la Francia e la Germania: la quota di scoperto in conto corrente sul totale dei prestiti alla fine del 2008 ammontava al 33% in Italia, contro il 9 e il 12% in Germania e Francia, rispettivamente. La ragione stava essenzialmente nella combinazione fra la volontà delle imprese di farsi fare dalle banche la gestione di tesoreria e quella delle banche di ottenere informazioni e mezzi di controllo sulla gestione quotidiana dell’impresa. Come dicevamo, queste due caratteristiche del rapporto banca-impresa in Italia sono ancora largamente presenti, pur dopo gli sconvolgimenti portati dalla duplice crisi di questi anni. In particolare, la prassi tutta italiana della predominanza dell’anticipazione di conto corrente è di fatto all’origine di tutte le vicende giudiziarie, anch’esse tipicamente italiane, sull’anatocismo (interessi sugli interessi) e sull’usura bancaria, demagogicamente considerati reati da noi, ma non nella stragrande parte degli altri paesi. Se per incanto gli scoperti di conto corrente sparissero e fossero sostituiti da prestiti di durata e costo predeterminati, quelle vicende svanirebbero come neve al sole. Si perderebbe anche, com’è ovvio, la fonte di informazioni e di pressioni sull’impresa che altrimenti la banca
capitolo settimo La finanza
173
trova difficile ottenere. Ma, certe volte, è necessario andare à là guerre comme à la guerre. L’alta intensità di debito bancario che caratterizzava, e tuttora caratterizza, le imprese italiane riflette anche loro specifici tratti strutturali. Le imprese sono da sempre riluttanti ad accrescere il capitale di rischio, in particolare ad allargare l’azionariato, per la natura familiare non solo dei loro assetti proprietari ma anche di quelli gestionali. Il ricorso al mercato dei capitali e la quotazione in borsa implicano costi di trasparenza elevati e permanenti, sostenibili solo da aziende mediograndi. Il sistema tributario ha poi storicamente assegnato un largo vantaggio al debito rispetto al capitale di rischio, per tutte le imprese. Questo modello presenta due rilevanti debolezze. La prima, sotto i nostri occhi da che è divampata la crisi finanziaria globale, è che rende vulnerabili le imprese nelle fasi negative del ciclo o nel caso di uno shock che colpisca il sistema bancario. Tensioni nei bilanci degli intermediari si traducono in peggiori condizioni di offerta del credito, che pesano su imprese già provate dalla recessione; ne consegue una loro minore capacità di ripagare i debiti, che mina a sua volta gli equilibri dei bilanci bancari. È un circolo vizioso dal quale si esce con difficoltà. Il flusso annuo di nuove sofferenze delle imprese era alla fine del 2015 vicino al 4%, la consistenza dei prestiti con rimborsi non regolari il 18% del totale. L’aumento dei rischi non può non tradursi in maggiore prudenza da parte delle banche nella selezione del merito di credito. La seconda debolezza di questo modello è che limita la capacità del sistema finanziario nel suo complesso di destinare risorse alle imprese dal potenziale più alto, in particolare a quelle in prima linea nel generare innovazione. Veniamo all’oggi. La duplice crisi e la duplice, quasi ininterrotta, recessione che ne è conseguita, hanno determinato
174
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
una forte polarizzazione delle imprese, come abbiamo visto. Di questa polarizzazione anche la finanza è, allo stesso tempo, testimone/vittima e concausa. Le imprese della pattuglia di testa sono anche quelle con meno debito bancario e con maggiore capacità di autofinanziamento o di ricorso a canali di finanziamento diversi dalle banche: altri intermediari finanziari, come il venture capital e il private equity, o direttamente i mercati dove collocare i propri titoli di debito. Queste aziende sono spesso “inseguite” dalle banche che offrono loro credito, a condizioni a volte sottocosto. All’altro estremo si collocano imprese, se non già uscite dal mercato, in grave difficoltà; esse sono più un problema di ordine politico e sociale che produttivo, oltre che un problema per le banche che hanno fatto loro credito in passato e che ora devono classificare quel credito fra gli “incagli” o addirittura fra le “sofferenze”. In mezzo c’è una zona grigia, la cui estensione è difficile da misurare. È a questa zona grigia che le considerazioni che seguono, pur espresse in generale per tutte le imprese, sono prevalentemente rivolte. Il percorso verso una struttura finanziaria più equilibrata deve iniziare da un rafforzamento patrimoniale delle imprese, che ne porti il grado di leverage – oggi al 44% – più vicino a quello delle maggiori economie dell’area dell’euro (34% in Francia, 39 in Germania). Passati interventi volti a favorire la quotazione in borsa delle imprese italiane hanno avuto scarso successo. Ridurre i costi della quotazione attraverso la creazione di mercati dedicati alle piccole e medie imprese, semplificare gli oneri amministrativi, introdurre sgravi fiscali per la quotazione o l’emissione di azioni, tutto questo non è bastato a controbilanciare il principale onere della quotazione dal punto di vista delle
capitolo settimo La finanza
175
imprese: la trasparenza, nei confronti del fisco, delle autorità di controllo, degli azionisti di minoranza. Negli ultimi anni sono stati adottati alcuni interventi potenzialmente più efficaci per aumentare il capitale proprio delle imprese: la deduzione dal reddito imponibile del rendimento figurativo dei nuovi apporti di capitale, secondo il modello dell’allowance for corporate equity (Ace); misure per incoraggiare l’investimento in capitale di rischio, tramite fondi di venture capital, e nelle startup, che hanno avvicinato la normativa italiana a quella degli altri paesi europei; incentivi di natura fiscale e regolamentare alla quotazione, come la possibilità di emettere “azioni a voto plurimo” che consentono di esercitare il controllo con un impegno finanziario limitato. La minore disponibilità di credito bancario sta ora spingendo alcune aziende a ricercare nuove soluzioni di finanza esterna. Il Fondo italiano di investimento, costituito nel 2010 su iniziativa del ministero dell’Economia e delle Finanze con l’adesione delle principali istituzioni finanziarie e imprenditoriali nazionali, tra cui la Cassa depositi e prestiti, ha intercettato parte di questa nuova domanda. La stessa Cassa aveva promosso al costituzione del Fondo strategico italiano, con funzioni di private equity per le medie aziende di successo, in particolare al fine di facilitare il ricambio generazionale; l’ha ora trasformato in Cdp Equity, con la missione di detenere partecipazioni in grandi aziende ritenute strategiche per il paese come Ansaldo Energia, e ha costituito ex novo il Fsi Sgr, a cui ha affidato le funzioni prima di Fsi. Il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese implica anche una maggiore diversificazione del debito, attraverso il collocamento di obbligazioni e il coinvolgimento di finanziatori diversi dalle banche. Recenti interventi normativi hanno mirato a questi obiettivi, eliminando ostacoli fiscali e regolamentari all’emissione di obbligazioni da parte di imprese
176
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
non quotate ed estendendo ad assicurazioni e ad altri investitori la facoltà di finanziare direttamente le imprese. Ma il cambiamento rimane lento. Il mercato del private equity è ancora piccolo: 4,6 miliardi nel 2015, secondo i dati dell’Aifi. Gli investimenti in imprese neonate (early stage) in rapporto al Pil sono molto limitati nel confronto con le altre economie avanzate. Continua a essere vero che la scarsa offerta riflette la domanda. Private equity, venture capital, obbligazioni, collocamenti privati di quote di prestiti (private placement) sono mercati e strumenti indispensabili per accompagnare l’evoluzione della struttura produttiva italiana: consentire alle idee innovative di incardinarsi in un’impresa nascente; far crescere nella dimensione quelle imprese piccole e medie che ne hanno l’opportunità tecnologica e di mercato. Non è sempre mestiere per banche. Occorrono competenze speciali e, spesso, una inclinazione al rischio che le banche tradizionali, puramente commerciali come quelle diffuse in Italia, è bene non abbiano. Per sviluppare mercati e strumenti non bancari è necessario l’appoggio di investitori istituzionali robusti e dallo sguardo lungo: assicurazioni, fondi pensione, fondi di investimento. Essi vi troveranno utili fonti di diversificazione dei loro portafogli. Si troveranno ad assumere più rischi: dovranno saperli controllare e gestire, con assetti di governance adeguati, capacità professionali, presidi organizzativi e una buona vigilanza specifica. La crisi finanziaria globale aveva suscitato generali anatemi contro le cartolarizzazioni. Ma si tratta di uno strumento utile, se si riesce a evitarne l’abuso. Le recenti vicende dei “crediti deteriorati” bancari e del fondo Atlante lo dimostrano. Esse liberano risorse nelle banche per originare nuovi prestiti, riducono la concentrazione del rischio di credito, favoriscono lo sviluppo dei mercati obbligazionari.
capitolo settimo La finanza
177
Negli ultimi tempi, anche per effetto delle misure adottate durante la crisi, abbiamo iniziato ad osservare segnali di un rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese, in termini di una riduzione dell’indebitamento e di un maggiore ricorso al mercato dei capitali. Il leverage delle imprese si è ridotto di circa quattro punti percentuali in tre anni, anche per il contributo di incrementi patrimoniali da parte di imprese in utile. È in crescita il numero di società che decidono di raccogliere fondi sul mercato, attraverso la quotazione in borsa o l’emissione di titoli obbligazionari. Non è facile, in questa fase congiunturale, capire se questi segnali rappresentano i primi passi di un cambiamento strutturale nelle scelte di finanziamento delle imprese oppure se si tratta di dinamiche sollecitate esclusivamente dalle difficoltà di accesso al credito. In quest’ultimo caso il miglioramento del ciclo e delle condizioni di offerta dei prestiti che già stiamo osservando potrebbe indurre gli operatori a interrompere questo processo virtuoso di riequilibrio della struttura finanziaria. Non sarebbe la prima volta che ciò accade. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del decennio successivo crebbero rapidamente il numero di imprese quotate, il ricorso alla finanza di mercato e gli investimenti (diretti o indiretti tramite gestioni patrimoniali) delle famiglie in titoli emessi da società non finanziarie. Fu, purtroppo, un fenomeno temporaneo: bastarono alcuni default (tra i principali: Parmalat, Cirio, i titoli obbligazionari argentini) per far evaporare rapidamente la fiducia di molti risparmiatori; essi tornarono rapidamente indietro sul sentiero di una finanza tradizionale essenzialmente basata sull’intermediazione del sistema bancario. L’esperienza passata insegna che è necessario perseguire con costanza e coerenza gli obiettivi di politica economica prefissati: solo in questo modo si riesce a modificare in profondità i connotati strutturali di un sistema finanziario, di superare le resistenze al
178
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
cambiamento. Va coltivata e tutelata la fiducia degli operatori in un processo di trasformazione del sistema finanziario che deve essere condiviso e percepito come necessario e ineluttabile. Si devono rendere economicamente convenienti le scelte finanziarie considerate più virtuose. Nel 2014 è stato pubblicato un libro che ha avuto grande diffusione in tutto il mondo e ha suscitato accese discussioni: Why Nations Fail (Perché le nazioni falliscono), di due studiosi americani, Daron Acemoglu e Jim Robinson4. Il libro ambisce a fornire la spiegazione ultima del perché, nel corso dell’intera vicenda umana, alcune comunità o nazioni abbiano prosperato economicamente e altre no, anche a parità di caratteristiche geografiche e di dotazioni naturali. La spiegazione offerta sta nella qualità delle istituzioni nazionali costruite nel tempo e dei processi politici che le hanno generate. In un capitolo del loro libro Acemoglu e Robinson descrivono l’essenza dello sviluppo economico. Il titolo stesso del capitolo la riassume così: “come farsi venire un’idea, fondare un’impresa e ottenere un prestito”. In Italia la principale fabbrica delle idee innovative (l’università) è appesantita, come abbiamo visto, da scelte punitive di allocazione delle risorse pubbliche, da vincoli legali, da gravami burocratici e ideologici; la fabbrica delle nuove imprese è ostacolata innanzitutto da ritardi culturali, nell’ordinamento giuridico e nel costume nazionale; la fabbrica della finanza non bancaria per le imprese (soprattutto quelle nascenti) è strutturalmente piccola e risente pesantemente della crisi. Usciti dalla crisi, bisogna pensare al futuro, pensare il futuro. In questa riflessione deve trovare un posto centrale il sistema finanziario, essenziale alla vita economica come il sistema circolatorio lo è alla vita umana. Un sistema finanziario da mantenere stabile, tenendo a bada la sua naturale tendenza alla instabilità; ma da far evolvere per renderlo più adatto
capitolo settimo La finanza
179
a sostenere il rinnovo della struttura produttiva, vitale per il nostro paese. 2. LE BANCHE
Veniamo ora alle banche, una cui trattazione specifica è resa necessaria se non altro dalle controversie di cui esse sono fatte oggetto in tutta Europa e in particolare in Italia. Nel momento in cui scriviamo le banche italiane sono additate dalla stampa internazionale come il maggior pericolo d’Europa, perché minacciano di causare l’uscita dall’euro, quindi dall’Unione europea, dell’Italia, il che genererebbe onde d’urto molto maggiori di quelle che possono essere originate da paesi come la Grecia o come lo stesso Regno Unito. La causa di questo starebbe nella montagna di crediti deteriorati, che ossessivamente viene quantificata in 360 miliardi. Questa rappresentazione delle cose è largamente strumentale, quando non falsa, e diremo perché. Tuttavia non può essere dismessa con un’alzata di spalle, non foss’altro che per la sua diffusione e insistenza. Un problema c’è con le banche italiane. Tuttavia, esso non sta tanto nei crediti deteriorati, di cui anche le banche più gravate potrebbero gradualmente disfarsi se l’economia proseguisse nella sua ripresa, per quanto lenta, e se le nuove regole e istituzioni europee non le ostacolassero; tutto questo sarà da noi analizzato più avanti. Il problema vero, di lungo periodo, sta nella loro incapacità media, come le banche europee ma ancor più di esse (e fatte le debite eccezioni), di fare profitti sufficienti a causa di un modello di business inadatto. Vediamo meglio come mai. Consideriamo le banche italiane innanzitutto come imprese di servizi, dunque come contributori alla torta del Prodotto interno lordo della nazione. In Italia il settore bancario produ-
180
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
ce il 5,5% del Pil (dati del 2013), in Francia il 5, in Germania il 6,5. Da noi (ma ancora di più in Germania) la struttura del settore è molto più frammentata che in Francia e in Spagna: le prime cinque aziende di credito italiane coprono il 41% del mercato nazionale, negli altri due paesi i campioni nazionali coprono rispettivamente il 47 e il 60% del mercato interno. Questo è in parte il riflesso della frammentazione del sistema delle imprese, quelle che prendono il denaro in prestito dalle banche. Naturalmente il numero relativamente alto di banche non è garanzia di concorrenza, perché questa dipende dalla dimensione del mercato rilevante, che in paesi localistici come l’Italia e la Germania può essere a volte piccola. Il problema principale di questo settore dell’economia italiana, come dicevamo, è che è diventato maturo, non fa più profitti: almeno non abbastanza da remunerare secondo i loro desideri coloro che ci investono dei soldi sopra. Di nuovo, fatte le debite eccezioni. È un problema più vecchio delle crisi esogene di questi anni – la crisi finanziaria globale e la crisi dei debiti sovrani in Europa – emerso già negli anni precedenti. Le crisi lo hanno solo esacerbato. Quanto è rilevante la scarsa redditività delle nostre banche? Non è facile rispondere a questa domanda; a dispetto del profluvio di dati da cui siamo quotidianamente tramortiti, confronti internazionali omogenei fra banche sono ardui, per mille diversità contabili e istituzionali. Ci sovvengono alcuni studi empirici particolarmente accurati, fra cui uno recentemente prodotto da economisti della Banca d’Italia5: quest’ultimo si concentra su un confronto di redditività fra i 50 principali gruppi bancari europei, valutati tali per totale consolidato delle attività. I paesi considerati sono quelli dell’area dell’euro più il Regno Unito, la Svezia e la Svizzera. La fonte primaria è la banca dati BankScope e i dati coprono dieci anni, terminan-
capitolo settimo La finanza
181
do con la fine del 2015. Per l’Italia sono considerate le prime cinque banche, da Unicredit (la più grande) alla Banca Popolare di Milano (la più piccola), ammontanti a poco più del 40% delle attività del sistema bancario italiano complessivo e al 7% del campione. I risultati sono chiari. Anche escludendo dal confronto gli altri paesi “periferici” dell’area dell’euro (Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia), la redditività delle banche italiane, misurata dal Roe (Return on equity, cioè rendimento del capitale) era decisamente più bassa di quella media negli altri paesi prima della doppia crisi: intorno al 10%, contro oltre il 15%. La ragione principale è semplice: le banche italiane prendevano meno rischi di quelle di altri paesi, profittavano meno dell’euforia finanziaria generalizzata. Se perché erano più furbe o perché i loro amministratori delegati “non parlavano l’inglese” è questione buona per gli storici. La crisi ha ulteriormente depresso la profittabilità delle banche italiane, stavolta per ragioni di ordine macroeconomico, e il divario con la media degli altri paesi ha raggiunto i 10 punti nel 2013. Nel 2015 si è però avuto da noi un recupero, mentre gli altri arretravano. Il risultato finale è che la redditività delle banche italiane è ora sempre più bassa ma meno distante di quella degli altri paesi; tutti sono parecchio sotto i livelli pre-crisi: 3% in Italia, contro 7 nella media degli altri sette paesi. Come gli stessi autori dello studio avvertono, il differenziale di redditività a sfavore dell’Italia nell’arco dell’intero periodo potrebbe essere sovrastimato da questi dati. In molti paesi, Germania in testa, lo Stato è intervenuto dopo la crisi finanziaria globale con ampie ricapitalizzazioni di banche in difficoltà, facilitando il loro compito di generare profitti. Questa circostanza è documentata dalle fonti ufficiali europee, pur con marginali differenze definitorie. L’Eurostat misura, usan-
182
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
do dati di fonte nazionale, l’effetto finale sul debito pubblico delle varie misure a favore delle banche nazionali, trovando che dal 2009 alla fine del 2015 in Germania il debito pubblico è aumentato di 225 miliardi per interventi a favore di banche nazionali in difficoltà, in Italia solo di 2, anche se, a dispetto di questo ingente ammontare di fondi pubblici, le banche tedesche vengono tuttora considerate anch’esse problematiche, sia pure per ragioni diverse da quelle italiane6. A che si deve questa diversità di approccio alla ricapitalizzazione pubblica di banche in difficoltà da parte degli Stati tedesco e italiano, per restare nell’esempio? Oltre al fatto ovvio che lo Stato tedesco se lo poteva permettere mentre quello italiano no? La ragione sostanziale era questa: il problema delle banche italiane non era la presenza nei loro attivi di strumenti “tossici”, come nel caso di quelle tedesche, ma il deteriorarsi di molti prestiti per la difficoltà crescente dei relativi creditori, imprese e famiglie, a causa della doppia recessione: questo specifico problema (certo aggravato dalla gestione cattiva o criminale di alcune banche) è emerso gradualmente e con ritardo rispetto agli attivi intossicati delle banche tedesche, che sono invece apparsi in tutta la loro pericolosità immediatamente dopo lo scoppio della crisi finanziaria globale, nel 2008-2009. I salvataggi con denaro pubblico delle banche tedesche in condizioni più critiche si sono infatti concentrati negli anni immediatamente successivi, così come, d’altro canto, quelli delle banche di altri paesi europei che pure versavano in difficoltà per gli strumenti finanziari tossici diffusi nei loro attivi. Lo studio della Banca d’Italia si sofferma sulla quantificazione, grazie a esercizi controfattuali consentiti dal modello econometrico della Banca, delle quattro principali cause del differenziale medio di redditività nel decennio fra banche italiane e banche degli altri paesi europei considerati: il quadro
capitolo settimo La finanza
183
macroeconomico, le tasse sulle attività finanziarie, i costi operativi del settore, le politiche di distribuzione dei dividendi. Trova, come c’era da aspettarsi, che la causa principale della più scarsa redditività media è il peggiore andamento della macroeconomia, soprattutto negli anni della crisi, ma che un ruolo non trascurabile è giocato dagli altri tre fattori. Su un’altra differenza gli autori dello studio non si soffermano, una differenza che nell’ottica di questo libro è invece molto importante: quella nella capitalizzazione di borsa. Limitiamo ulteriormente, per semplicità, il confronto alle cinque più grandi banche nei tre principali paesi dell’area dell’euro, Italia, Francia e Germania, e facciamo riferimento ai dati di metà 2016; vediamo che la capitalizzazione di borsa è in tutti e tre i paesi inferiore al “capitale tangibile” delle aziende in questione, cioè al loro patrimonio investito in cespiti tangibili, ma in Italia il rapporto tra le due variabili è particolarmente basso. Poiché il valore di borsa di un’azienda quotata, come ci insegnano i manuali di finanza, coincide con il flusso futuro (idealmente infinito) dei profitti attesi, il mercato azionario si aspetta in altri termini che le quindici banche in questione facciano in media delle perdite in futuro, erodendo il patrimonio, ma che questo generale fenomeno sia più forte in Italia. Insomma, secondo l’opinione del mercato azionario, pur avendo tutte le banche in Europa continentale un problema prospettico di redditività, questo problema è da noi molto maggiore. È un’opinione fondata? Qui bisogna distinguere almeno due possibili moventi delle attese degli operatori di mercato. Questo ci porterà a ripercorrere per sommi capi tutta la vicenda delle banche italiane dallo scoppio delle due crisi e addirittura a una divagazione sui destini d’Europa. Tuttavia si tratta di una parentesi necessaria per la comprensione delle cose.
184
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Una prima determinante delle aspettative dei mercati è perfettamente comprensibile e riguarda le effettive prospettive di mercato delle aziende considerate: il modo in cui sono gestite, il loro modello di business, le tendenze della tecnologia e della domanda dei servizi offerti, e così via. Sotto questo profilo, la posizione delle banche italiane non è certo lusinghiera, data la loro concentrazione nel segmento “tradizionale” del mercato bancario: raccolgono denaro presso una vasta platea di piccoli risparmiatori e lo prestano a una platea più ristretta ma comunque vasta di famiglie e imprese piccolo-medie. La tecnologia mette in crisi questo modello, soprattutto se si pretende di continuare a fare affari alla vecchia maniera, con un sacco di sportelli e di mano d’opera. È giusto pensare che, soprattutto in tempi di tassi d’interesse molto bassi, banche cosiffatte guadagnino poco o addirittura finiscano in perdita. Questo modello non è tuttavia un’esclusiva delle banche italiane. E allora? Allora bisogna far ricorso alla seconda determinante delle aspettative dei mercati, più sfuggente e paradossale, ma importantissima in tempi di accresciuta incertezza: essa riguarda l’opinione che di ciascuna banca ha il “regolatore”, cioè l’autorità pubblica che ha una responsabilità di regolazione e di supervisione nei confronti di quella banca; di conseguenza, il favore o il disfavore con cui il regolatore agirà nei confronti di essa. Già, perché non stiamo parlando di aziende qualsiasi, sottoposte alle sole leggi del mercato, ma di aziende considerate “speciali”, tali da dover essere sottoposte da autorità pubbliche appositamente create a speciale sorveglianza. A che scopo? Affinché esse non tradiscano la fiducia del pubblico nel fatto che il risparmio di tutti, loro affidato, sia amministrato, come recita la legge italiana, in modo “sano e prudente”. La fiducia collettiva, della cittadinanza tutta, nella fonda-
capitolo settimo La finanza
185
mentale robustezza del sistema bancario, e la sua tutela, sono ciò che giustifica l’esistenza di un sorvegliante pubblico ad hoc, settoriale, in aggiunta a quelli comuni a tutti i settori, che si occupano di aspetti specifici di pubblico interesse, come la concorrenza, la condotta di mercato (trasparenza, correttezza, ecc.), la privacy, la salute pubblica e così via. Queste speciali caratteristiche sono ciò che va sotto l’etichetta di “stabilità finanziaria”. Di sorveglianti pubblici possono esservene uno o più, può essere la banca centrale oppure un’autorità separata, le competenze territoriali possono essere ripartite oppure unitarie, a seconda delle specificità istituzionali di ciascun paese o area. In Italia per molti anni la “vigilanza” sul sistema bancario è stata svolta dalla Banca d’Italia, quindi da una banca centrale, da un’autorità unica, con una competenza esclusiva sul sistema bancario nazionale. L’atteggiamento della Banca d’Italia nei confronti di ciascuna banca sottoposta alla sua vigilanza era abbastanza perscrutabile da parte dei mercati, essendo la “cultura di vigilanza” relativamente stabile nel tempo e nota. Solo i dati di fatto potevano essere ignoti ai mercati in casi di crisi latenti, a volte tenuti appositamente segreti, efficacemente, per evitare situazioni di panico prima che una soluzione fosse stata trovata. E la si trovava sempre. Il successo di questa vigilanza nel non turbare i sonni dei depositanti, quindi nell’assicurare la stabilità finanziaria, è testimoniata da un indicatore principe: la quantità di denaro dei contribuenti impiegato nel salvataggio di banche fallite. Non è facile mettere insieme dati confrontabili: ci hanno provato due ricercatori del Fondo monetario internazionale per gli anni dal 1970 al 20117, poi l’Eurostat per gli anni dell’ultima crisi, pur con differenze metodologiche che rendono le due analisi non sommabili. Se facciamo riferimento agli anni più lonta-
186
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
ni, l’Italia emerge comunque come il paese più virtuoso, con interventi pubblici (includendo i casi dei banchi meridionali negli anni Novanta) inferiori cumulativamente all’1% del Pil, contro percentuali molto maggiori negli altri paesi. Il successo relativo della vigilanza bancaria italiana, indubitabile, non è stato ovviamente esente da costi: il principale potrebbe averlo patito la concorrenza nel settore, le cui esigenze potrebbero essere state a volte compresse da un’altra esigenza, ritenuta più pressante, quella di accollare una banca in difficoltà a un’altra più robusta, al fine di evitare fenomeni di panico contagioso fra risparmiatori. Le sacre regole della concorrenza avrebbero voluto invece che la banca in difficoltà fallisse e uscisse dal mercato, per consentire alle banche robuste, tutte, di ereditarne la clientela buona, senza tenere in alcun conto il possibile panico di tutti i risparmiatori. Il trade-off fra concorrenza e stabilità finanziaria è stato per lunghi anni in Italia ritenuto bilanciato, dai regolatori e dai politici. È vero che la nostra società tendenzialmente corporativa non ha mai annoverato la concorrenza fra i suoi valori supremi, ma questa situazione è andata certo cambiando nel corso degli anni, rispetto al tempo in cui le banche italiane erano una “foresta pietrificata” fatta di istituti quasi tutti pubblici, che la clientela dei depositanti vedeva essenzialmente come delle agenzie pubbliche, non dissimili da un ministero o da un comune. Tuttavia anche ai giorni nostri, anche dopo che la competenza antitrust nel settore bancario è passata dal vigilante di settore (la Banca d’Italia, a cui era stata originariamente affidata in quanto si riteneva quella funzione implicitamente subordinata alla stabilità) all’autorità trasversale (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Agcm), i princìpi del libero mercato e della concorrenza non si sono granché radicati nell’opinione pubblica. Lo ha dimostrato l’indignazione
capitolo settimo La finanza
187
seguita all’avvio della nuova “procedura di risoluzione” a carico delle quattro banche in procinto di fallire nel novembre del 2015. A nessuno è venuto in mente di commentare: meno male, leviamo di mezzo quattro banche malate, facciamo pagare il fio di una fiducia malriposta ai sottoscrittori di azioni e di obbligazioni subordinate, e lasciamo che i depositanti e i prenditori di prestiti siano liberi di scegliere banche più affidabili, evviva la concorrenza! Non è questa la sede per spiegare il comportamento della Banca d’Italia in quella vicenda, come in altre di banche entrate in questi anni in grave difficoltà. Lo ha fatto la stessa Banca, con analisi e documenti messi a disposizione sul suo sito e con interventi pubblici del governatore e di altri suoi esponenti. Da un punto di vista tecnico, date le norme nazionali e internazionali vigenti, la posizione della Banca d’Italia è ineccepibile, a dispetto delle critiche ricevute, spesso disinformate, a volte sguaiate o interessate. Ma la questione vera è un’altra: si può dire lo stesso da un punto di vista più politico? La Banca d’Italia, se da un lato gestiva la vigilanza bancaria nel modo a volte “dirigistico” che dicevamo, dall’altro si poneva negli anni Ottanta alla testa del fronte liberale che voleva la privatizzazione e la concorrenzialità del sistema bancario, soprattutto con le figure di Carlo Azeglio Ciampi e di Tommaso Padoa-Schioppa. Il governatore Fazio, succeduto a Ciampi nel 1993, pur ostile al disegno liberale ormai vittorioso, non vi si oppose apertamente. Il corollario di quel disegno nella mente dei propugnatori – la crescente integrazione finanziaria in Europa – lo vide parimenti ostile ma parimenti incapace di una vera opposizione, essendo tra l’altro personalmente a disagio nei consessi comunitari, per formazione e per convinzioni. PadoaSchioppa uscì dalla Banca quattro anni dopo la nomina di
188
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Fazio a governatore, per diventare presidente della Consob. Il governatore Draghi, succeduto a Fazio in modo drammatico alla fine del 2005, fece riprendere alla Banca d’Italia la leadership nazionale del liberalismo finanziario e dell’integrazione europea, sebbene con prudenza e pragmatismo. Draghi ascese poi alla guida della Banca centrale europea nel 2011, quando gli effetti della crisi finanziaria globale non erano ancora passati e già pienamente divampava la crisi europea dei “debiti sovrani”. Il governatore Visco, suo successore, apparve fin da subito deciso nella difesa delle ragioni di una graduale transizione del sistema finanziario italiano verso un assetto più moderno, meno legato ai localismi deteriori, più competitivo. Egli vi univa la convinzione che per una duratura prospettiva di sviluppo dell’Italia fosse necessaria una integrazione sempre maggiore in Europa. La crisi dei debiti sovrani aveva però cambiato i termini del problema. La crisi greca, con la scoperta che un governo dell’area dell’euro aveva truccato nientemeno che la contabilità nazionale per acquietare i paesi partner, infliggeva all’area, all’Europa tutta, un trauma da cui non ci si è più ripresi; apriva un vaso di Pandora da cui fuoriuscivano i veleni del nazionalismo. In particolare, nei paesi del Nord Europa sia l’establishment politico sia l’opinione pubblica iniziavano a vedere i paesi “periferici”, segnatamente l’Italia, come colpevoli di intendere l’integrazione europea solo come una scusa per accollare alle virtuose formiche del Nord il costo dei lassismi e delle pigrizie delle cicale del Sud. Questo è un fatto, che raccontiamo come tale, senza entrare nel merito della fondatezza di tali giudizi. Effettivamente è difficile distinguere i torti dalle ragioni. Analizziamo la questione più importante, quella della percezione incrociata dei tedeschi e degli italiani. Il popolo tedesco percepisce confusamente, con malcelata
capitolo settimo La finanza
189
invidia mista a rabbiosa indignazione, un “bel vivere” italiano, fatto di buon clima, buona cucina, e difesa strenua dei “diritti” individualistici di ciascuno, per quanto corporativi: dal diritto acquisito all’evasione fiscale a quello della protezione di un qualche sindacato, da quello di non avere senso civico da parte della gente a quello di essere neghittosi e noncuranti da parte degli impiegati pubblici, da quello dei comuni cittadini di avviare una lite giudiziaria per futili motivi a quello dell’amministrazione giudiziaria di perseguire con studiata lentezza un ideale astratto di giustizia lontano dai bisogni di una società moderna. In questa percezione c’è una mescolanza inestricabile di verità storica e di mito, di critica sociale giusta e di invettiva caricaturale. A loro volta, gli italiani percepiscono, anche in tal caso con invidia (almeno da parte di certi) oltre che con incredulo scandalo, una inesplicabile rigidità teutonica nel popolo tedesco, uno stare attaccati alle “regole” chiunque le abbia fissate e per quanto stupide si rivelino dopo un certo tempo, un sentirsi parte del “popolo tedesco” prima ancora di sentirsi individui, un sacrificare il benessere di sé e della propria famiglia alla competitività generale del paese. Anche qui si mescolano inestricabilmente verità e mito, evidenza storica e pregiudizio. In entrambi i sensi, queste percezioni possono venarsi di razzismo. Niente di nuovo sotto il sole, qualcuno dirà, si tratta di stereotipi nazionali presenti da sempre negli immaginari collettivi dei due popoli, da ben prima che i rispettivi paesi conquistassero l’unità politica un secolo e mezzo fa, quasi simultaneamente tra l’altro. Il grande progetto di Unione europea serviva essenzialmente a questo, a disciogliere questi stereotipi nel primigenio afflato dell’identità europea, del sentirsi europei prima ancora che tedeschi o italiani, così come ci si sente italiani o tedeschi prima ancora che siciliani o lombardi, bavaresi o sassoni.
190
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Questo è proprio il punto. La crisi dei debiti sovrani ha dato avvio a uno sgretolamento dell’identità europea. Un fenomeno che era forse maturo, chissà. Sta di fatto che cinque o sei anni fa, in coincidenza con quella crisi, sono nati ovunque, in Italia e in Germania come in tanti altri paesi europei del Nord e del Sud, movimenti politici anti-establishment e anti-europei. Incrociando umori di sinistra contro la globalizzazione e le disuguaglianze con umori di destra contro le immigrazioni e finendo così con l’oscurare la vecchia, tradizionale distinzione destra-sinistra. In questo clima da “tana libera tutti” i vecchi stereotipi hanno ripreso importanza. Vi gioca una insofferenza crescente verso il “politicamente corretto”, di cui la ricorrente, accorata perorazione europeista è divenuta inesorabilmente parte. Ma lasciamo il terreno dell’analisi sociopolitica per tornare alle banche. Il 2011, l’anno del passaggio di testimone fra Draghi e Visco alla guida della Banca d’Italia, fu anche l’anno della caduta del governo Berlusconi e dell’avvento del governo tecnico presieduto da Mario Monti. In quell’anno la Spagna, che vedeva alcune sue grandi banche (Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia e Banco de Valencia) in grave difficoltà a causa dello scoppio della gigantesca bolla immobiliare da queste finanziata negli anni passati, si assoggettò a un salvataggio europeo, attraverso il Meccanismo europeo di stabilità (il cosiddetto fondo “salva Stati” o European Stability Mechanism, Esm), accettando il sindacato della cosiddetta “Troika”, costituita da funzionari della Commissione europea, della Banca centrale europea e del Fondo monetario internazionale. L’Esm fornì al governo spagnolo oltre 40 miliardi di euro affinché questo li usasse per ricapitalizzare le sue banche in pericolo. Per la costituzione del capitale del fondo Esm, pari a 80 miliardi, l’Italia diede la quota di sua spettanza di 14 miliardi, caricandola sul debito pubblico.
capitolo settimo La finanza
191
Taluni oggi lamentano che anche l’Italia non abbia chiesto l’intervento dell’Esm e della Troika per salvare le sue banche dal loro specifico problema, il deterioramento dei prestiti alla generalità della clientela, imprese e famiglie, causato dalla recessione in corso. La risposta che ha dato il presidente Monti recentemente è che la cosa non era lontanamente concepibile. Da un lato l’Italia era considerata dal resto del mondo e dai mercati sull’orlo di un default che avrebbe assunto dimensioni enormemente più drammatiche che nel caso greco e che sarebbe sicuramente stato innescato da una richiesta del genere; dall’altro l’ammontare dei crediti deteriorati delle sue banche era in complesso una quota ancora limitata dei crediti totali (11% alla fine del 2011). Su questo secondo punto è opportuno un approfondimento. È vero che ancora alla fine del 2011 i crediti bancari deteriorati non avevano raggiunto livelli drammatici, ma non era difficile prevedere che questo sarebbe successo in futuro, sulla base del consolidato rapporto empirico con gli andamenti macroeconomici: dato il solo ritardo con cui tradizionalmente i primi seguono i secondi, circa un anno, il modello econometrico della Banca d’Italia stimava che il flusso di crediti bancari deteriorati avrebbero raggiunto alla fine del 2013 il 2,5% dei crediti totali, col Pil stagnante; ma in realtà già nel quarto trimestre del 2011 il Pil aveva preso a cadere di nuovo, sospinto verso la recessione proprio dalla crisi dei debiti sovrani. La Banca d’Italia avvertì di questo rischio nei suoi bollettini. Ma la verità è che l’intera classe politica e la stessa Banca d’Italia confidavano in una ripresa macroeconomica imminente, confortati dall’opinione di tutti i previsori internazionali; osservavano che le banche italiane erano relativamente immuni dalla tossicodipendenza da derivati sviluppata da altri sistemi bancari; pensavano che un aumento dei crediti deteriorati, certo pericoloso per alcune banche, potesse essere gestito con
192
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
gli strumenti di vigilanza a disposizione, ordinari e straordinari. Nel corso del 2012 prese corpo il progetto di Unione bancaria europea, come risposta a quello che era parso fin da subito il principale problema della crisi dei debiti sovrani: il nesso perverso fra Stati sovrani dalle finanze fragili – quelli della periferia europea, soprattutto l’Italia – e loro sistemi bancari. Il Rapporto dei Quattro Presidenti (Consiglio europeo, Commissione europea, Eurogruppo, Banca centrale europea) gettò le basi del progetto, incentrato sulla costituzione di un fondo comune di garanzia dei depositanti bancari e di uno schema comune di “risoluzione” delle crisi bancarie, cui avrebbe fatto da collante un sistema unico di vigilanza bancaria nell’area. Per quest’ultimo si indicava la Banca centrale europea come sede naturale, dato che l’art. 127 del Trattato europeo già assegnava alla Bce funzioni di vigilanza bancaria. Toccherà agli storici della politica internazionale e dell’economia spiegare che cosa maturò nelle cancellerie europee nel 2012 e nel 2013. Il risultato finale fu un rovesciamento di priorità: prima si procedette affrettatamente alla costituzione del Meccanismo unico di vigilanza (Single Supervisory Mechanism, Ssm, creato presso la Bce ma sostanzialmente indipendente da questa) e subito dopo alla messa a punto di un sistema di “risoluzione” delle crisi bancarie alquanto diverso dalle premesse. Si mise cioè in piedi un sistema vincolante per impedire che ulteriori crisi bancarie potessero essere ancora risolte con interventi pubblici, basato sul combinato disposto di un’apposita Direttiva europea (la Bank Recovery and Resolution Directive, Brrd) e di una mutata e più stringente interpretazione delle norme antitrust vigenti in Europa quando applicate alle banche, interpretazione di cui la Direzione generale concorrenza della Commissione dell’Unione europea si fece paladina, annunciandola con la Comunicazione della
capitolo settimo La finanza
193
Commissione del luglio 2013 (cosiddetta Banking Communication). Il previsto sistema unico di garanzia dei depositanti bancari venne rinviato sine die, bloccato dall’opposizione del governo tedesco, che voleva, e vuole, prima vedere ridursi la quota dei titoli pubblici nazionali negli attivi delle banche dei paesi del Sud (segnatamente, di nuovo, in Italia). Esso ritiene quella quota, se più alta della media europea, un indicatore di rischiosità degli attivi bancari, a dispetto di una regolamentazione vigente che considera i titoli di Stato privi di rischio dal punto di vista del capitale proprio. Al centro del nuovo sistema di “risoluzione” vi era l’idea che i salvataggi con denaro pubblico di una banca, denaro nazionale s’intende (quello europeo non si poteva neanche nominare), fossero di fatto esclusi per sempre, sostituiti, ove proprio si volesse evitare la liquidazione, dal coinvolgimento nelle perdite di tutti i creditori della banca (esclusi i soli depositanti garantiti dallo schema assicurativo nazionale, finanziato da tutte le banche del paese): l’ormai famigerato bail-in, salvataggio dall’interno, da contrapporre al bail-out, salvataggio dall’esterno, cioè a carico dei contribuenti. Va notata la coincidenza temporale degli eventi. La Banking Communication della Commissione che diede avvio al nuovo mondo fu adottata nel luglio del 2013. L’ultimo salvataggio pubblico del vecchio mondo avvenne appunto nel luglio del 2013, a opera del governo francese a favore del Crédit Immobilier de France e del governo olandese a favore di Sns Reaal. L’ironia della storia ha poi voluto che l’Italia fosse, con la Slovenia, fra i primi paesi a sperimentare le nuove norme sul bail-in dei creditori di una banca in difficoltà, sia pure nella versione temporaneamente attenuata del burden-sharing, che limita il coinvolgimento dei creditori agli obbligazionisti subordinati. La perversione del nuovo sistema si spingeva fino
194
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
a mettere la decisione sul prezzo da attribuire ai “crediti in sofferenza” delle banche da porre “in risoluzione” nelle mani di alcuni funzionari della Commissione, senza il cui via libera la procedura si sarebbe bloccata. Nel caso delle quattro banche italiane “risolte” secondo i dettami della Banking Communication il prezzo fu fissato da quei funzionari a un livello irragionevolmente basso, meno del 18% in media del valore di libro, utilizzando come benchmark per le poste più significative dati del mercato sloveno, l’unico precedente a portata di mano; quella decisione fu tale da condizionare tutto il mercato italiano dei crediti deteriorati nei mesi successivi. La Banca d’Italia offrì sulle prime la sua aperta e piena collaborazione al progetto di Unione bancaria, nel solco di una tradizione di adesione integrale agli ideali europeisti. Lo fece anche quando fu chiaro che i paesi core d’Europa, Germania in testa, esigevano la preliminare creazione della vigilanza bancaria unica, la quale avrebbe implicato l’eutanasia almeno parziale delle vigilanze nazionali. Lo fece nel profondo convincimento che la superiorità del modello italiano di vigilanza, provata dalla superiore performance dei passati decenni, avrebbe prevalso, fertilizzando il costituendo modello europeo. È andata così solo in parte. Il modello di vigilanza che si va affermando a Francoforte, pur ancora confuso e oscillante, è per alcuni aspetti distante dai parametri della vigilanza italiana: è al tempo stesso più discrezionale negli interventi preventivi sulle banche e meno nei provvedimenti formali, dove prevale la conformità letterale alle norme per annullare i rischi legali. Un modello, da quel che si capisce, meno funzionale di quello italiano nell’evitare crisi bancarie, come abbiamo poc’anzi ricordato, ma che appare più accigliato in questa fase di “nuovo inizio” e più a favore della concorrenza nel momento in cui i salvataggi pubblici sono di fatto esclusi. La Bce volle, in preparazione della creazione presso di lei
capitolo settimo La finanza
195
dell’Ssm, operativo dal 4 novembre 2014, fare un check dello stato di salute delle banche su cui si apprestava ad assumere la vigilanza, conducendo con le autorità nazionali di vigilanza fra il 2013 e il 2014 una “valutazione onnicomprensiva” delle banche in questione e in particolare della loro robustezza patrimoniale. Concordò in questo ambito con l’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, Eba) uno stress test a imitazione di quello condotto tempo prima dalle autorità americane presso le banche di quel paese. La Banca d’Italia a sua volta, convinta della opportunità di questi esercizi e in loro preparazione, volle assicurarsi che le banche italiane innalzassero l’asticella del capitale al livello più alto ora voluto dai regolatori internazionali. Incontrò in questo notevoli resistenze, data la governance peculiare di molte banche italiane, strette fra la forma cooperativa delle popolari e quella, per le banche costituite in forma di società per azioni, di un azionariato comunque poco contendibile sul mercato, anche a causa della presenza di Fondazioni. Alcune banche, per ottemperare all’insieme delle prescrizioni dei regolatori (quelle del Comitato di Basilea e dell’Eba, il regolamento Crr dell’Unione europea), proseguirono nella vecchia prassi di rafforzare il patrimonio di vigilanza anche emettendo obbligazioni “subordinate”, cioè titoli assimilabili alle azioni in caso di liquidazione e ammessi dalle norme di vigilanza come capitale, sia pure di minor qualità. Alcune banche popolari le vendettero insieme alle proprie azioni ai piccoli risparmiatori, clienti o soci della banca. Va ricordato che nello spirito originario delle banche cooperative vi era proprio il canone del fare credito “solo” ai soci, per cui il concetto di cliente (depositante o beneficiario di un prestito) e quello di socio (azionista) venivano a coincidere. Le grandi banche popolari erano ormai banche commerciali a tutti gli effetti ma conservavano questa commistione.
196
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
La Banca d’Italia, responsabile della vigilanza “di stabilità”, ritenne che fosse la Consob, responsabile di quella sulla trasparenza e correttezza degli emittenti di strumenti finanziari, a dover obiettare in caso di vendite scorrette allo sportello, né sarebbe potuta intervenire se pure si fosse fatta venire dei sospetti di scorrettezza, pena l’essere chiamata in giudizio a rifondere i danni per abuso di potere. La Consob dal canto suo non trovò nelle norme a cui era assoggettata ragioni per opporsi: l’apparato della Mifid dovrebbe in teoria far comprendere a qualunque cliente di una banca, anche al più sprovveduto, quali rischi corre. Ma evidentemente non è sempre così. Forse col senno di poi, verificata una volta di più la sensibilità dell’opinione pubblica italiana al tema della difesa del risparmio, elementi almeno di un pubblico allarme sarebbero stati trovati. Nel caso di banche non cooperative, come peraltro tutte le grandi popolari si apprestano a diventare, si potrebbe giungere fino a vietare per legge la vendita allo sportello di propri strumenti di capitale, incluse le obbligazioni subordinate. L’adesione della Banca d’Italia al progetto di Unione bancaria così come si andava profilando divenne via via più critica e punteggiata da riserve a partire dall’estate del 2013. Già nel corso delle discussioni tecniche sulla bozza di Brrd presso il Comitato economico e finanziario dell’Unione, appunto nel 2013, erano state avanzate dai tecnici della Banca d’Italia e del governo italiano obiezioni al bail-in così come veniva prospettato: immediato e retroattivo. Le obiezioni presero la forma di un documento scritto fatto circolare fra le delegazioni nazionali. Il Consiglio dei ministri finanziari e poi il Consiglio europeo non le considerarono. Un anno dopo la Banca, insieme con il governo, venne colta di sorpresa dal ruolo che la Commissione, e per essa la Direzione generale sulla concorrenza, decise di giocare nella
capitolo settimo La finanza
197
partita. A iniziare con Tercas (una piccola banca del teramano entrata in grave difficoltà e alla fine acquisita dalla Banca Popolare di Bari) e a proseguire con le quattro banche infine poste “in risoluzione” (Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti), la Banca d’Italia e il governo ritenevano naturale che il Fondo interbancario di tutela dei depositi intervenisse nel capitale delle banche in questione per agevolarne la cessione sul mercato. Non si vedeva alcun profilo di violazione delle regole sugli aiuti di Stato, essendo il Fondo un ente costituito da tutte le banche del sistema e da queste finanziato, che interveniva per un interesse privato, ossia per scongiurare l’onere sicuramente maggiore che sarebbe caduto su di esso, e dunque ancora su tutte le banche del sistema, se le banche in difficoltà fossero state liquidate e avesse dovuto rimborsare tutti i depositi garantiti. La Commissione non fu di questo parere, invocando il cambio d’interpretazione delle regole sugli aiuti di Stato nel frattempo segnalato con la propria Comunicazione del luglio 2013 e un presunto ruolo di direzione della Banca d’Italia nell’attività del Fondo. Questo, ad avviso della Commissione, soltanto costituendo una propria sezione esplicitamente “volontaria” poteva intervenire nel capitale di una banca in difficoltà, come poi gioco forza ha fatto. Nel caso Tercas, per il quale l’intervento del Fondo era solo di facilitazione della cessione alla Popolare di Bari, la questione è stata infine portata dal governo italiano di fronte alla Corte europea di giustizia di Lussemburgo. In tutti gli altri casi ci si è dovuti piegare alla volontà della Commissione, per una ragione assai semplice, sebbene negletta nel dibattito mediatico: in caso di contenzioso giudiziario davanti alla Corte di Lussemburgo le norme contabili internazionali prevedono che i fondi apportati dal
198
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
soggetto in odore di “statualità” vengano coperti da appositi accantonamenti, rendendoli quindi del tutto inutili. Nel frattempo si svolse coi medesimi uffici della Dg Concorrenza della Commissione europea un altro defatigante confronto. Esso ebbe per oggetto la creazione di una cosiddetta “bad bank di sistema”, cioè di un ente pubblico-privato, assistito dalla garanzia dello Stato, incaricato di acquisire da tutte le banche una trentina di miliardi circa di sofferenze nette. Anche in questo caso fu obiettato che si viveva in un mondo nuovo, regolato da una diversa e più stringente interpretazione delle norme sugli aiuti di Stato, e che tutto ruotava attorno alla definizione di un “prezzo di mercato” o simile per la cessione delle sofferenze, sul cui livello gli uffici in questione continuarono per mesi e mesi a chiedere alle strutture del Mef, assistite dalla Banca d’Italia e da vari consulenti di mercato, approfondimenti tecnici, finché la “risoluzione” delle 4 banche non fece tramontare del tutto l’idea. La consapevolezza che le regole del gioco fossero cambiate, e non per l’approvazione politica e pubblica della Brrd ma per decisioni tecniche di apparati europei come alcuni uffici della Commissione, decisioni invece non portate all’attenzione delle opinioni pubbliche, si fece apertamente strada all’interno del governo italiano e della Banca d’Italia solo nel corso del 2015. Era troppo tardi per studiare un’alternativa alla crisi delle quattro banche. È abbastanza per gridare al complotto anti-italiano da parte di una santa alleanza di governi nordici e tecnocrazie europee? No. Non è abbastanza, e non serve neanche. Da un lato basta immaginarsi un’oggettiva convergenza di culture e di convincimenti da parte di politici e funzionari del Nord Europa, spalleggiati da paesi del Sud in preda a forti convulsioni sociali e politiche e quindi impauriti o distratti (come la Spagna e la Francia), senza dover ricorrere a nessuna ipotesi
capitolo settimo La finanza
199
di esplicito complotto. Dall’altro, come abbiamo già notato, i torti e le ragioni sono distribuiti. Noi italiani abbiamo molto da farci perdonare, tutta la nostra storia repubblicana è venata di furbizie, di comportamenti da free rider nel contesto europeo. Non siamo stati gli unici però. I più ingenui forse, alternando entusiasmi europeisti ad azzardi morali non giustificati da un peso geopolitico corrispondente. Siamo giunti così al termine della divagazione originata dalla vicenda europea degli ultimi anni. Possiamo riprendere il filo del ragionamento che stavamo facendo sui moventi delle aspettative dei mercati quando fissano il prezzo di borsa di una banca europea. Dicevamo che un secondo movente, oltre quello ovvio della oggettiva performance prospettica della singola banca (per quanto sia possibile dedurla dalle informazioni disponibili), sta nel cercare di indovinare che cosa pensi di quella banca il “regolatore”. Come ha formato queste aspettative il mercato nell’ultimo periodo? Alla base c’è sempre stato il calcolo del valore dei crediti deteriorati, sulla base di regole e definizioni sostanzialmente immutate rispetto al vecchio mondo italiano di vigilanza: “credito deteriorato” (non performing loan, Npl) è la categoria generale, all’interno della quale stanno svariatissime fattispecie, dai semplici sconfinamenti sugli scoperti ammessi di conto corrente fino ai crediti “in sofferenza” veri e propri, cioè a crediti concessi ad imprese e famiglie che certo non pagheranno più, perché sono imprese fallite o famiglie divenute nullatenenti. Nel vecchio mondo di vigilanza la Banca d’Italia prestava la sua attenzione soprattutto alle sofferenze, perché gli altri crediti deteriorati, detti “incagliati”, venivano considerati comunque crediti con una certa probabilità di tornare in bonis. Nel nuovo mondo di vigilanza la distinzione tipicamente italiana tra incagli e sofferenze tende invece a scomparire,
200
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
nella prassi dei regolatori e di conseguenza nella percezione dei mercati. La macroeconomia dovrebbe aiutare a distinguere, poiché in un’economia in ripresa il flusso di nuove sofferenze diminui sce, come abbiamo visto in precedenza, e la probabilità media di un incaglio di tornare in bonis aumenta. L’economia italiana è in ripresa? Lo è certamente stata per tutto il 2015 e ancora nei primi tre trimestri del 2016. Ma la ripresa è lenta, stentata. Insieme alle incertezze politiche che si vanno addensando verso la fine del 2016 questo fa temere, a regolatori e mercati insieme, che molti incagli si trasformeranno in sofferenze. Da qui l’enfasi crescente sul totale dei crediti deteriorati, anziché sulle sole sofferenze. Seguiamo allora questo ragionamento. I più recenti dati di bilancio sui crediti deteriorati delle banche italiane (giugno 2016) sono i seguenti: 191 miliardi al netto degli accantonamenti già spesati in bilancio (che sono soldi sonanti, disponibili, non tenerne conto è un errore grave), a fronte dei quali stanno 161 miliardi di garanzie immobiliari e 51 di garanzie personali. Quanto valgano realmente sul mercato tali crediti e le garanzie da cui sono assistiti dipende essenzialmente da due variabili: il tempo a disposizione per gestire i crediti in questione e quello occorrente per escutere le garanzie. La prima variabile è di fatto nelle mani del regolatore, la seconda in quelle del sistema giudiziario. Se, all’estremo, il primo decide che il tempo di gestione è già scaduto e per il secondo il tempo di escussione tende invece all’infinito, allora il valore di mercato di entrambi è zero. Conseguentemente sarebbe necessario innalzare il capitale delle banche dell’intera cifra di 191 miliardi. La situazione italiana reale non coincide affatto con questa ipotesi estrema, anche se all’inizio della vicenda vi si avvicinava. Le norme nazionali vigenti, a favore del debitore almeno negli intenti, unite alla tradizionale lentezza dei tribunali
capitolo settimo La finanza
201
italiani, allungavano a dismisura il tempo di escussione delle garanzie. Soprattutto, il nuovo regolatore – includendo nel concetto, sebbene del tutto impropriamente, la Commissione europea con la sua nuova interpretazione delle norme sugli aiuti di Stato nel settore bancario – aveva dato da pensare ai mercati di voler esigere la cessione immediata sul mercato di tutti i crediti deteriorati, usando come riferimento il prezzo molto basso fissato dirigisticamente dai funzionari della Dg Concorrenza della Commissione per le sofferenze delle quattro banche da mettere “in risoluzione” e ormai ritenuto quello giusto da molti operatori del mercato. Entrambe le circostanze sono alquanto cambiate nel frattempo. Sui tempi di escussione delle garanzie è intervenuto il governo italiano in due distinte riprese fra il 2015 e il 2016, compatibilmente con un ordinamento che resta molto garantista a favore del debitore. Le aspettative dei mercati quanto all’atteggiamento del nuovo regolatore sono dal canto loro diventate almeno più incerte, poiché sia l’Ssm sia la Commissione hanno dato più di recente segni di tenere in maggiore considerazione la stabilità finanziaria, almeno nelle dichiarazioni dei loro esponenti di vertice, anche alla luce di quanto accaduto in Italia con le quattro banche e in Portogallo col Novo Banco. Rimane il convincimento dei mercati che il nuovo regolatore sia orientato a risolvere il problema dei crediti deteriorati, tipici del sistema bancario italiano, prima e più del problema dei derivati, che invece affigge diverse banche tedesche e francesi. Questo contribuisce a spiegare il differenziale di capitalizzazione di borsa che penalizza fortemente le banche italiane, al di là delle loro specifiche prospettive di redditività. Tutte le banche europee hanno un grave problema di redditività nel futuro, come abbiamo visto, ma le banche italiane sono viste dai mercati appesantite da una maggiore carenza di capitale.
202
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Questo è in parte un dato di fatto, intendiamoci, data la quasi assenza da noi di ricapitalizzazioni pubbliche. Se hanno bisogno di più capitale, le banche italiane dovrebbero fare profitti per remunerarlo e invece non ci riescono. Quindi il loro valore di borsa scende di più. Dobbiamo però aggiungere un terzo movente alle aspettative dei mercati nel determinare il prezzo di borsa delle banche italiane, che nulla ha a che vedere con le prestazioni attese delle banche stesse né con l’opinione che ne possa avere il regolatore: il rischio Italia. Si tratta di una valutazione onnicomprensiva della performance del paese, che va dalla politica all’economia tutta. È qualcosa di non dissimile da ciò che accadde nel 2011, e che prese la forma di un rialzo brusco e fortissimo del differenziale (spread) fra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e dei paesi core europei, soprattutto la Germania. Con una grande differenza: di mezzo c’è stato il “whatever it takes” di Mario Draghi e la sua declinazione operativa, il programma di (eventuali) acquisti illimitati di titoli di Stato di un paese sotto attacco speculativo da parte della Bce (Outright Monetary Transactions, Omt); illimitato perché realizzato con mezzi illimitati, gli euro “stampabili” dalla Bce. Un programma mai attivato ma che sta là, come un bazooka pronto a sparare, e viene creduto e temuto dai mercati. Se il giudizio dei mercati su un paese volge verso il negativo, come è il caso dell’Italia questa seconda parte del 2016, non sono i titoli di Stato italiani a essere venduti nell’aspettativa di guadagnare da un ribasso del loro prezzo, perché interverrebbe la Bce a stabilizzarlo. Vengono venduti invece i titoli azionari delle aziende ritenute più fragili, le banche, che tra l’altro nel listino azionario italiano sono molto più presenti che in altri principali mercati europei (21% contro una media del 6 in Francia e Germania) a causa della rarefatta quotazione delle altre imprese. Questo pure contribuisce a spiegare
capitolo settimo La finanza
203
il differenziale di valutazione borsistica delle banche italiane rispetto alla media europea. Tutta questa analisi non va intesa come una minimizzazione del problema dei crediti deteriorati nelle banche italiane, intendiamoci. Serve solo a dire che “il campo da gioco non è livellato”, come amano dire i regolatori finanziari di tutto il mondo. Le banche italiane hanno, sì, un problema, e con questo torniamo all’inizio: ma più che dei crediti deteriorati si tratta di un modello di business che fatica a funzionare ancora, più di quanto accada in altri paesi europei pure afflitti dal medesimo problema. E sempre fatte le debite eccezioni. I legami delle banche italiane con molte imprese, non necessariamente piccole, sono stati distorti sia dalla pratica del multiaffidamento – che conviene alle imprese per i motivi di riservatezza a cui abbiamo accennato, ma anche alle banche per diversificare il rischio – sia dal localismo di molte di esse. Questo ha a che vedere con il modello di business e di governance. Tuttavia la sorte delle banche in Italia, ancor più che nel resto d’Europa, è legata a un generale ridimensionamento del ruolo del credito bancario nel finanziamento dell’economia. Le imprese nuove e innovative dovranno imparare a fare a meno del credito bancario, rivolgendosi ad altri intermediari o direttamente al mercato del risparmio. Invece, le imprese che stanno nella zona grigia di cui prima parlavamo continueranno a rivolgersi alle banche; queste si devono attrezzare più di quanto non lo siano oggi a distinguere il grano dal loglio, cioè le imprese che davvero hanno un potenziale, al di là di temporanee difficoltà, da quelle che sono dei veri e propri zombie. Solo le prime meritano credito, le seconde no. Che ruolo potranno allora giocare le banche italiane in una struttura finanziaria che ne veda ridotta la dominanza nel fi-
204
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
nanziamento dell’economia? Un ruolo ancora importante se affronteranno i necessari cambiamenti. Esse possiedono strutture, conoscenze e competenze tali da consentire loro di compensare le elevate asimmetrie informative rispetto alle imprese, soprattutto le più piccole. Ma la capacità delle banche di “leggere” il potenziale di crescita di un’azienda, captando anche i segnali deboli della cosiddetta soft information, sembra essersi indebolita durante la crisi: analisi della Banca d’Italia8 suggeriscono che le difficoltà di accesso al credito delle imprese più vulnerabili si sarebbero estese anche ad alcune aziende dalle buone potenzialità. Saper valutare le opportunità di crescita delle piccole e medie aziende è un’abilità che va pienamente recuperata nelle nostre banche. Lo può favorire un rapporto più solido fra ciascuna banca e ciascuna impresa. Le relazioni bancarie in Italia sono caratterizzate, come abbiamo detto più volte, da un’alta frammentazione; durante la crisi, questa ha acuito i problemi di finanziamento delle imprese. Ridurre quella frammentazione va a vantaggio, in particolare, delle imprese innovative, la cui valutazione da parte di finanziatori esterni è tipicamente molto più difficile. Vi è evidenza empirica del fatto che una relazione di lungo periodo con una banca accresca la probabilità che un’impresa svolga attività innovativa, in particolare di R&S9. Le banche possono conservare un ruolo importante anche nel sostegno di imprese di dimensioni medio-grandi che intendano diversificare le proprie fonti di finanziamento accedendo direttamente al mercato dei capitali. L’offerta delle banche va spostata, dal credito tradizionale verso quei servizi ad alto valore aggiunto che preparano e assistono le imprese nel collocare titoli sul mercato. Le relazioni con le imprese potrebbero alla fine uscirne rafforzate anziché indebolite. Ogni politica pubblica indirizzata a questo fine è benve-
capitolo settimo La finanza
205
nuta. Disporre di un sistema bancario sano e adatto al tempo moderno è nell’interesse di tutto il paese. I localismi, quando sono deteriori, vanno contrastati, come con la riforma delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo. Eccessi nelle remunerazioni dei vertici delle banche, concentrati nelle banche piccole dove non sono giustificati dalla concorrenza internazionale, vanno tagliati. Va invece avversata ogni proposta demagogica che ingenuamente punti alla liquidazione o ripubblicizzazione del sistema bancario, come se la Storia potesse tornare indietro. NOTE 1 J. Atanassov, V. Nanda, A. Seru, Finance and Innovation: the Case of Publicly Traded Firms, in «Ross School of Business Paper», 970, 2007; J. Brown, S. Fazzari, B. Petersen, Financing Innovation and Growth: Cash-flow, External Equity and the 1990s R&D boom, in «The Journal of Finance», 1, 64, 2009. 2 S. Magri, Does Issuing Equity Help R&D Activity? Evidence From Unlisted Italian High-tech Manufacturing Firms, in «Economics of Innovation and New Technology», 8, 23, 2014, pp. 825-854. 3 S. Ongena, D.C. Smith, What Determines the Number of Bank Relationships? Cross-Country Evidence, in «Journal of Financial Intermediation», 1, 9, 2000, pp. 26-56. 4 D. Acemoglu, J.A. Robinson, Why Nations fail. The origins of power, prosperity, and poverty, Crown Publishers, New York 2014. 5 U. Albertazzi, A. Notarpietro, S. Siviero, An inquiry into the determinants of the profitability of Italian banks, in «Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)», i.c.s. 6 Importi molto rilevanti si registrano in numerosi altri paesi europei, come il Regno Unito, la Spagna, l’Olanda, l’Irlanda, il Belgio. 7 L. Laeven, F. Valencia, Systemic Banking Crises Database: An Update, in «IMF Economic Review», 2, 61, 2012. 8 G. Albareto, P. Finaldi Russo, Fragilità finanziaria e prospettive di crescita: il razionamento del credito alle imprese durante la crisi, in «Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)», 127, 2012. 9 A.M. Herrera, R. Minetti, Informed finance and technological change: evidence from credit relationships, in «Journal of Financial Economics», 83, 2007.
EPILOGO
Eccoci giunti al termine della nostra analisi. Siamo partiti dall’assunto che l’identità di una comunità radunata attorno a una bandiera consista in ciò che essa sa fare, nel prodotto che ogni anno essa sa mettere insieme: nel suo valore, nella sua qualità, nella sua originalità, nella sua appetibilità da parte dei potenziali destinatari, innanzitutto i concittadini ma più in generale gli abitanti del mondo. Da questo punto di vista, abbiamo sostenuto con forza, l’Italia non è la Grecia. Abbiamo inoltre tenuto nel debito conto il nostro passato più remoto. Era importante stabilire da dove venissimo e abbiamo dedicato due densi capitoli alla storia più antica dell’economia italiana, con un approfondimento speciale sulla sua manifattura. Ma abbiamo poi guardato prevalentemente agli anni più recenti: quelli immediatamente precedenti e quelli successivi alla grande crisi mondiale iniziata nel 2007-2008. 1. LA VECCHIA IPOTESI DEL “DECLINO”
A metà del primo decennio degli anni Duemila s’iniziò a parlare del “declino” economico del paese in un numero sorpren-
Epilogo
207
dentemente alto di convegni, libri, saggi accademici, articoli di giornali, italiani ed esteri. Tanto da indurre il compianto Luigi Spaventa a chiosare, scrivendo sulle afflizioni dell’economia italiana: “quella delle diagnosi e prescrizioni per contrastare l’arretratezza è un’industria – forse la sola – in rapida crescita”1. Che cosa induceva tanti a parlare di declino? Molte storie sono state raccontate per spiegare come, a partire dagli anni Novanta, l’economia italiana avesse rallentato la sua crescita, fin quasi a fermarsi: dal crollo della “prima repubblica” agli sforzi per entrare nell’area dell’euro. Una delle spiegazioni da noi avanzate era riassumibile così: il mondo cambiava e l’Italia non se ne accorgeva2. Il mondo cambiava per due ragioni. La prima è che mutava la tecnologia dominante: dall’elettricità, che aveva prevalso per un secolo, alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict). La seconda è che, conseguentemente, partiva una nuova ondata di globalizzazione delle società e dei mercati, che vedeva protagonisti i paesi emergenti, in particolare la Cina. L’Italia non approfittava né dell’uno né dell’altro fenomeno, perché la sua struttura produttiva si era, da lungo tempo, frammentata. Tante piccole imprese non potevano essere capaci di trarre tutti i frutti di innovazione e di produttività offerti dalle nuove tecnologie e dall’avventurarsi su mercati lontani. Gli anni Duemila fino alla grande crisi mondiale furono inoltre segnati in Italia dalla crisi di grandi imprese, a cominciare dalla Fiat (sull’orlo del fallimento dopo la rinuncia da parte della General Motors ad esercitare l’opzione di acquisto), e da scandali in settori rilevanti dell’economia nazionale, “preda dell’arbitrio, dell’interesse, delle trame di pochi individui”3. Ma il peggio doveva ancora arrivare, e ancora dal di fuori dei nostri confini. Dopo il 2007 si è avuto nel mondo un “decennio breve”,
208
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
denso di accadimenti, tutti ruotanti intorno allo scoppio della gigantesca bolla finanziaria che si è prodotta negli Stati Uniti e che ha contagiato il pianeta, con la recessione mondiale che ne è seguita. Ne sono stati rallentati gli scambi commerciali globali, sono molto aumentate le disuguaglianze nei paesi avanzati, è stata compromessa l’Unione europea. È stata minata la fiducia nel futuro, alimentando, in alcuni paesi, una specie di cupio dissolvi, in altri come minimo l’ipotesi di una “stagnazione secolare”4. Da ultimo sono emersi e si vanno rafforzando rischi geopolitici: il terrorismo, le grandi ondate migratorie, l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea. La nostra economia, pur incolpevole delle cause della crisi mondiale, ne ha pagato un prezzo molto alto, proprio in ragione di una fibra produttiva indebolita dalla frammentazione e dalla staticità delle sue imprese. Al culmine della crisi, la produzione complessiva era diminuita di quasi un decimo, l’apparato manifatturiero aveva visto scomparire un sesto della sua capacità, la distruzione netta di posti di lavoro era stata di quasi un milione. Per effetto della recessione, la più acuta e lunga dal dopoguerra, la disuguaglianza dei redditi è sia pur lievemente aumentata e rimane superiore a quella di Germania e Francia, il dualismo tra Nord e Sud si è accentuato, il debito pubblico è aumentato dal 100 a oltre il 130% del Pil, le banche si sono caricate di un considerevole ammontare di crediti deteriorati, alcune di loro entrando in seria difficoltà. Il “rischio Italia” sui mercati internazionali è aumentato. Non potendo scaricarsi sullo spread fra i titoli dello Stato italiano e quelli degli Stati forti (la Germania in primo luogo), a causa dello scudo frapposto dalla Bce, ha colpito le quotazioni azionarie delle banche, tradizionali portatrici dei titoli pubblici nazionali. Insomma, nel corso del quarto di secolo trascorso da quando il nuovo paradigma tecnologico e la globalizzazione sono
Epilogo
209
divenuti manifesti, il Pil reale annuale del nostro paese è aumentato solo di 17 punti, mentre quelli francese e tedesco di oltre il 45%! Quasi tre volte di più, una differenza enorme. Da qui partiamo. Possiamo naturalmente ancora peggiorare; oppure possiamo restare stazionari in termini relativi, quindi tenerci per sempre l’arretramento fin qui accusato; oppure ancora possiamo tentare di migliorare, di recuperare. Come farlo è la grande questione. 2. CONFERME DI UNA DIAGNOSI NOTA
Per cercare una riposta abbiamo analizzato in questo libro l’economia italiana dal lato dell’offerta produttiva, cioè del “saper fare” e del “saper vendere”, nella convinzione profonda che nel lungo periodo l’offerta crei la sua propria domanda e determini la traiettoria di sviluppo economico di un paese. Il cuore del libro analizza che cosa si produce, a chi si vende quello che si produce (se a connazionali o a stranieri), come le imprese italiane producono e vendono. Abbiamo ragionato, in prima approssimazione, in modo uniforme sull’intero sistema produttivo. Ebbene, che cosa si produce? In larga prevalenza servizi, come, ormai, in tutti i paesi avanzati. La manifattura resta tuttavia importante, intanto nell’opinione degli addetti ai lavori, per almeno due motivi: 1) rappresenta oltre quattro quinti delle esportazioni complessive; 2) rimane il settore di punta della nostra economia produttiva, quello dove si concentra l’innovazione. Anche l’opinione pubblica è affezionata all’idea di manifattura. Lo è per ragioni sentimentali, perché non ci si può innamorare di aziende come Eni, o Enel o Poste, che sono fra le nostre uniche grandi aziende: le si dà per scontate, per sostanzialmente pubbliche, anche se sono ormai quasi del
210
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
tutto private. Non è nata in Italia nessuna Microsoft, nessuna Google, nessuna Amazon, nessuna Ikea, aziende che invece hanno conquistato l’immaginazione del mondo. Però, attenzione: quanto c’è nella ricchezza dei paesi avanzati, quindi anche in Italia, che venga fatto con le sole mani? Ormai davvero poco. In quella che si continua a chiamare manifattura, trattandola separatamente nelle statistiche, il contenuto di servizi è grande e crescente, sia fra gli input produttivi sia fra le stesse funzioni aziendali. Quindi parliamo di un unico mondo produttivo ibrido e indistinto, che abbraccia i tre tradizionali comparti produttivi, primario, secondario e terziario. Inoltre, a chi si vende? Il grosso è naturalmente destinato al mercato interno; in qualche caso in competizione con imprese estere, in molti casi senza che la concorrenza internazionale agisca, perché i beni o servizi venduti hanno un vantaggio di “prossimità” comunque alto (pensiamo a un parrucchiere o a una piccola banca). Tuttavia, specie per quelli che continuiamo a definire beni manufatti, la competitività internazionale dei prodotti italiani resta forte e le esportazioni sui mercati esteri sono una quota relativamente alta della produzione totale. Infine, come le imprese italiane producono e vendono? In altri termini, come sono fatte? Qui ci avviciniamo al centro del problema. Emergono, o più correttamente dovremmo dire si confermano, tre peculiarità delle nostre imprese: sono troppo “familiari” nella gestione (oltre che nella proprietà); la loro produttività cresce troppo poco (se mai cresce); fanno troppo poca innovazione formalizzata (cioè Ricerca & Sviluppo). In particolare, il segnale più forte delle difficoltà del sistema produttivo italiano è rappresentato, fin dagli anni Novanta, dal cattivo andamento della produttività del lavoro e della produttività totale dei fattori (cioè dall’efficienza con cui il lavoro e il capitale sono combinati nel processo produttivo). È la dinamica della produttività che principalmente spiegava
Epilogo
211
il miracolo economico italiano degli anni Sessanta e la crescita degli anni successivi, ed è il suo rallentamento (seconda metà degli anni Novanta) e la sua successiva stagnazione (dagli anni Duemila fino al 2014) che causano il peggioramento dell’economia italiana. Un rallentamento della produttività del lavoro e della produttività totale dei fattori è avvertito anche nel resto dei paesi industrializzati, è un male oscuro che affligge tutti già da prima della grande crisi, determinando bassa crescita e un aumento delle disuguaglianze. Tuttavia, in Italia il problema è decisamente più acuto. Le tre caratteristiche delle imprese che abbiamo menzionato (familismo, bassa produttività, scarsa innovazione) si tengono l’una con l’altra. Tutte e tre sono riconducibili alla dimensione troppo piccola delle nostre imprese. Questa è la ragione principale del mancato aggancio alla nuova fase storica planetaria segnata dal paradigma tecnologico incentrato sulle Ict e dalla globalizzazione. La frammentazione dell’apparato produttivo italiano si ripercuote sull’innovatività, sulla qualità del management, sull’apertura dell’impresa familiare al controllo esterno, sulla capacità di affrontare i costi fissi della internazionalizzazione, sulla domanda di elevato capitale umano, sui canali di finanziamento, sulla specializzazione produttiva, sulla produttività. Tutte queste variabili sono negativamente correlate con la dimensione di impresa. 3. IL “GRANDE GOLFO”
Ma la crisi degli scorsi anni ha portato con sé un fenomeno relativamente nuovo: il sistema si è sempre più polarizzato. Si è aperto un “grande golfo” fra imprese vincenti e perdenti: in tutta l’economia, non solo nella manifattura. Le generalizzazio-
212
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
ni del tipo “le imprese italiane” ormai non valgono più, dopo quasi un decennio di crisi. Il dibattito sulle vicende economiche del paese che si svolge sui media fa invece normalmente ricorso ai concetti di media o mediana. È una scelta di comunicazione quasi obbligata, il cui scopo è mettere a disposizione dell’opinione pubblica e del policy maker dei numeri semplici, rappresentativi di grandi moltitudini di soggetti, siano essi individui o imprese. È una scelta che volutamente trascura le differenze tra i vari soggetti, la loro eterogeneità. L’idea di base è che ciò che li unisce sia più importante di ciò che li divide. Un esempio lampante è l’occupazione. Il dibattito ruota intorno al tasso nazionale di occupazione, cioè a quante persone hanno un’occupazione sul totale della popolazione in età da lavoro. Molte distinzioni sarebbero interessanti: tra maschi e femmine, tra regioni e comuni, tra settori. La distinzione tra livelli di inquadramento (operai, impiegati, quadri, dirigenti, lavoratori autonomi per dimensione della loro impresa), potrebbe dare dettagli sulle disuguaglianze di reddito. Usare invece un solo numero aggregato va bene finché esso contiene il grosso dell’informazione sul lavoro nel paese. Comincia ad andare meno bene quando il fenomeno del lavoro si sfrangia in molteplici fattispecie (precari, semiautonomi, ecc.) o la disuguaglianza retributiva aumenta molto, sicché l’eterogeneità rischia di prendere il sopravvento. Analoghe considerazioni possono farsi per ciò che viene prodotto e venduto. Sui media troviamo il più delle volte riportata e commentata solo la variazione da un periodo all’altro del Pil nazionale. Esse mette insieme tutto, dal prodotto delle imprese (grandi e piccole) del terziario, a quelle delle imprese (grandi e piccole) della manifattura, a quello delle amministrazioni pubbliche. Ma siamo sicuri che questo dato rappresenti tutto l’apparato produttivo italiano? Ormai no.
Epilogo
213
Ne abbiamo evidenze dirette, a cominciare dalle esportazioni. La competitività italiana all’estero si regge sulle spalle di un nucleo limitato d’imprese manifatturiere, un quinto del totale, che però producono i quattro quinti del valore aggiunto manifatturiero. Queste imprese sono fatte di una diversa materia dalle altre, sono di natura speciale, secondo vari parametri (dimensione, produttività, articolazione funzionale, salari). Sono capaci di resistere ai contraccolpi di una crisi. Ne abbiamo anche evidenze indirette, ad esempio guardando a cosa succede nella loro relazione con le banche: le imprese vincenti hanno ormai imparato a fare a meno delle banche. Se hanno bisogno di finanza esterna per fare investimenti, essendo prevalentemente medie o grandi si rivolgono direttamente al mercato, sempre che non facciano da sé con l’autofinanziamento. Le perdenti si aggrappano disperatamente al credito bancario, che viene loro lesinato o negato. 4. CHI STA IN MEZZO. LE CATENE GLOBALI DEL VALORE
In mezzo al golfo c’è una varietà di natanti, da piccoli barchini pericolanti a grandi navi un po’ ansimanti. Un tertium genus di imprese che rappresenta una sfida nella sfida, in quanto costringe chiunque se ne occupi – analista, policy maker o banca – a fare delle valutazioni caso per caso, per capire la probabilità che il singolo natante se ne vada verso un braccio o l’altro del golfo; fuor di metafora, che la singola azienda sia attratta dal polo dei vincenti o da quello dei perdenti. Siamo andati a visitare tre aziende vere, scegliendole perché fossero il più possibile esemplari di questa flottiglia intermedia. Sono aziende che hanno attraversato la crisi senza troppi danni, una media (Poliform), una medio-piccola (Masmec) e una piccola (Macnil). Sono imprese familiari, pur con
214
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
schemi diversi di governance. Le prime due sono classificabili come manifatturiere, ma con una forte componente terziaria, l’altra è classificabile come terziaria ma con una fondamentale componente manifatturiera. Le abbiamo visitate nell’autunno del 2015, una al Nord, due al Sud. Sono casi di relativo successo ma tutte e tre fronteggiano lo stesso problema, mutatis mutandis: le loro opportunità di crescita sono in parte non sfruttate. Di queste tre aziende siamo in particolare andati a guardare se facevano parte di una catena globale del valore (Cgv) e in che posizione si collocavano. Le catene del valore, come abbiamo spiegato nelle pagine precedenti, riflettono il nuovo assetto della organizzazione produttiva mondiale, rappresentano il nerbo di quella che abbiamo chiamato la “nuova globalizzazione”. Abbiamo cercato di capire se la tradizione tutta italiana della subfornitura potesse offrire alle piccole imprese italiane una scappatoia moderna, appunto attraverso le Cgv. La conclusione è chiara: bisogna “ben posizionarsi” in una Cgv, mostrando un’elevata propensione alla innovazione e alla internazionalizzazione. Solo così si sfruttano le opportunità della divisione internazionale del lavoro: penetrare mercati più grandi, scambiare beni intermedi con imprese più avanzate, anche multinazionali; sfruttare le esternalità. I pochi dati disponibili (le statistiche ufficiali dovrebbero adeguarsi presto!) mostrano che anche l’Italia, oltre alla Germania e alla Francia, ha aumentato la sua presenza nelle Cgv, ampliando la platea dei fornitori esteri. E tuttavia abbiamo poche imprese alla testa di una Cgv. Rispetto a Germania e Francia abbiamo meno aziende grandi e multinazionali e non disponiamo ancora di una politica efficace di attrazione di investimenti esteri. Abbiamo molte, moltissime imprese che operano come imprese intermedie, che vendono i loro prodot-
Epilogo
215
ti ad altre imprese, con un posizionamento mediamente meno vantaggioso delle francesi e tedesche. Le nostre tre aziende mostrano sotto questo punto di vista condizioni diverse. La Poliform è alla testa di una catena del valore solo locale, che somiglia più alla vecchia subfornitura. La Macnil è troppo piccola, il problema neanche se lo pone. Il caso più interessante è quello della Masmec. Essa è inserita in una Cgv in posizione intermedia: guida una pattuglia di imprese locali, che però non lavorano solo per lei; fornisce i suoi prodotti intermedi, molto sofisticati, ad aziende più grandi che, a loro volta, riforniscono grandissimi produttori finali nel mondo. È un’impresa fortemente innovativa, fa molta Ricerca & Sviluppo insieme con centri di ricerca pugliesi, un caso di interazione virtuosa pubblico-privato fonte di occupazione e di trasferimento tecnologico. 5. LO STANDARD MANCANTE
Quante Masmec ci sono in Italia? Non abbastanza. Le opportunità offerte dall’appartenenza a una Cgv sembrano essere territorialmente concentrate al Centro-Nord e appannaggio di poche imprese. Più in generale, il numero di imprese intermedie avanzate è ancora troppo esiguo per potere sostenere la competitività internazionale del paese, che poggia solo sulle spalle dei “pochi eletti”5. Va bene questa situazione? Possiamo contentarcene, come facemmo negli anni Ottanta quando le grandi imprese cominciarono a restringersi e la parte buona del nostro sistema produttivo, ancora stretto attorno alla pattuglia avanzata delle imprese manifatturiere, iniziò a rifugiarsi nei recinti dei distretti industriali? No che non va bene, perché non è così che un paese avanzato prospera nel mondo moderno.
216
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Questo è il nostro problema. Non è una incapacità assoluta, storica, connaturata al carattere nazionale, di stare all’avanguardia produttiva del mondo; è che questa capacità è limitata solo a poche imprese vincenti. Manca uno standard diffuso di alta qualità e di competitività. Portiamo un esempio assai chiaro, la Germania. È un paese pieno di problemi, con diverse rigidità corporative. Ad alcuni di questi problemi, riguardanti il suo sistema bancario, abbiamo accennato nel capitolo precedente. Tuttavia, non vi è dubbio che la prestazione complessiva di quell’economia sia stata incomparabilmente superiore a quella italiana sia negli anni immediatamente precedenti la grande crisi globale sia dopo. Essa ha attraversato, attorno agli anni di passaggio fra il secolo passato e il nuovo, una breve fase di difficoltà, quella che spinse «The Economist» a chiamarla il malato d’Europa (prima di scoprire l’Italia). Ma se ne è ripresa rapidamente, grazie a riforme di struttura, attribuite al cancelliere Schröder, che ne hanno attenuato il carattere di società corporativa. La Germania, pur nella grande eterogeneità delle sue imprese, ha uno “standard” produttivo elevato, lo ha sempre avuto. Nella convinzione profonda degli acquirenti dei suoi beni e servizi, siano essi dei connazionali o dei soggetti esteri, i prodotti tedeschi sono, appunto, tedeschi. Vengono attribuiti al paese prima ancora che alle singole aziende. In Italia questo è vero solo per il sistema-moda e per il cibo, che incidono, però, una frazione piccola del Pil. E da che dipende questa identità nazionale dei prodotti, dunque questo standard produttivo del paese? Dal sistema-paese, appunto. Se appuntiamo la nostra attenzione sulla Germania, la morfologia azienda per azienda dell’apparato produttivo non è molto dissimile da quella italiana: sì, sono imprese un po’ più grandi, sono ugualmente familiari nella proprietà ma un po’
Epilogo
217
meno “familiste” nella scelta del management, sono un po’ più esportatrici, un po’ più manifatturiere. Per ogni caratteristica strutturale la differenza è poca, non tanta. Dove la differenza diventa enorme è nel sistema-paese, come viene giornalisticamente definito, cioè nell’insieme di quelli che abbiamo chiamato “fattori abilitanti” e che abbiamo sommariamente passato in rassegna nei capitoli 6 e 7 (la struttura finanziaria è infatti anch’essa in parte un fattore abilitante, anche se essa stessa produce una frazione del valore aggiunto privato nazionale e per questo l’abbiamo trattata separatamente nel capitolo 7). Nell’Italia polarizzata di oggi, quella del “grande golfo”, le imprese vincenti hanno imparato come fare a meno dei fattori abilitanti di sistema, o come ovviare ai fattori disabilitanti. Ma bisogna davvero essere bravi e avere molte frecce al proprio arco. Imprese non, o non ancora, così brave (perché più piccole, più familiste, meno tecnologiche, a questo punto poco importa) fanno una fatica enorme a sopravvivere. 6. FAR LEVA SULL’EUROPA? NO
Prima di esaminare il possibile da farsi, togliamoci subito un’illusione. Non potrebbe essere “più Europa” la chiave di volta della nostra rinascita, come altre volte abbiamo pensato in passato? Ragioniamo freddamente. Il problema non è solo italiano ma è di quasi tutti i paesi dell’Europa continentale, quindi potrebbe effettivamente esservi un ruolo per l’Europa, ad esempio attraverso un “rules compact” che stabilisca un quadro di regole certe per le imprese, anche di natura fiscale, che sospenda e sorpassi le regole nazionali nel medio periodo. Ma in questa congiuntura difficilissima per l’idea europea è bene non inseguire disegni irrealistici.
218
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Il sogno europeo come metodo anti-nazionalistico nacque mentre ancora gli europei si combattevano sanguinosamente fra loro dietro bandiere nazionali. A combattersi più “identitariamente” nell’Europa continentale erano soprattutto tedeschi e francesi. Prese corpo non tanto a opera degli iniziali sognatori italiani – gli Spinelli, i Colorni, i Rossi – ma grazie al pragmatismo di altri padri fondatori – gli Adenauer, gli Schumann, i De Gasperi – che fecero avanzare il progetto sul terreno economico, non su quello più ovvio della difesa comune e della sicurezza interna. Essi erano europei continentali, fra loro non vi era nessun inglese, se si fa eccezione per qualche roboante dichiarazione pubblica di Winston Churchill, ricordiamocelo bene in tempi di Brexit. Fu così che si creò la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, poi quella economica, alla fine sfociata nell’Unione europea, con la mutazione genetica finale dell’euro. L’idea di fondo non era quella di sostituire alle identità nazionali una europea, perché l’identità di un popolo si fonda innanzitutto su una lingua comune, poi anche su cultura e miti popolari stratificati nei secoli, e non poteva essere questo il caso dell’Europa. L’idea era invece quella di far superare le identità nazionali, radicate appunto nella storia e quindi destinate a restare, da un superiore sentimento di appartenenza al più grande contenitore europeo, identificato dall’interesse prima ancora che dall’ideale. Quest’idea ha funzionato bene o male per sessant’anni, prima di essere incrinata dalla crisi cosiddetta dei “debiti sovrani”, esplosa nel 2010. Ma forse, come abbiamo accennato parlando di banche, quell’evento è stato solo un detonatore e l’idea era già in crisi latente. Essa era sottoposta a due logoramenti: il passare delle generazioni con l’allontanarsi del ricordo della guerra; l’assedio crescente dei migranti, in particolare dai paesi islamici. La reazione naturale di una vasta porzione
Epilogo
219
di popolazione, e di loro rappresentanti politici, è stata finora la chiusura nell’identità nazionale, il ritorno in auge dei vecchi stereotipi Nord-Sud. La costruzione europea è tuttavia andata troppo oltre perché possa essere smontata senza colpo ferire. Prendiamo l’euro: parlare con leggerezza di una sua esplosione o di un suo abbandono da parte di un singolo paese è molto pericoloso, per usare un eufemismo. L’euro è un mastice inesorabile, per staccare i pezzi così incollati occorre rompere tutto, compresa la coesione sociale e la pace civile delle popolazioni coinvolte. Crearlo è stato un errore? Può darsi, anche se gli autori di questo libro ci hanno creduto e continuano a crederci. Ma ragionare intorno a un impossibile ritorno al passato serve solo a perdere tempo, bisogna ragionare piuttosto freddamente su come andare avanti, possibilmente meglio di quanto fatto finora; ed è possibile. Crediamo che sia arrivato il momento di rilanciare il progetto europeo intorno a bandiere che non siano più economico-monetarie, ma che siano squisitamente politiche e che dovevano essere poste alla base della costruzione europea all’inizio della sua avventura, perché intimamente connesse con la ragione fondante: difesa e sicurezza. Non lo furono perché si ritenne che fosse troppo presto, che si trattasse di temi che la sensibilità popolare ancora vedeva appannaggio della propria comunità nazionale, che fosse comunque meglio agire per il tramite degli obiettivi di benessere materiale, prioritari dopo le distruzioni della guerra. Sono passate almeno due generazioni da allora, è tempo di tornare alle origini se si vuole, e si deve, salvare il progetto e dare ai popoli europei una nuova bandiera identitaria, che esalti i valori democratici e culturali del nostro continente. I pilastri economico-monetari su cui è fondata l’Europa non vanno abbandonati, vanno solo messi in secondo piano nell’attenzione delle opinioni pubbliche, non è più su di loro
220
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
che può essere edificato quello spirito di appartenenza europea di cui prima parlavamo. Le politiche per rilanciare lo sviluppo economico delle comunità nazionali siano pertanto nazionali. 7. CHE FARE, DUNQUE
Per far recuperare all’economia italiana le posizioni perdute, bisogna innanzitutto mettere le nostre imprese nelle condizioni di aumentare la loro dimensione media. Che non significa che tutte debbano farlo, chiariamo subito. Alcune di loro, quelle che ne hanno la concreta possibilità di mercato, devono poter crescere molto, saltando nella categoria dimensionale superiore: grande, se stanno nella media; media, se stanno nella piccola. Questo al momento non avviene, o avviene in misura insufficiente. Ma perché la dimensione media delle imprese italiane è asfittica e statica? Sono fenomeni connaturati col paese, con la sua società, con la sua storia? Forse no, visto che sono relativamente recenti: fino a tutti gli anni Sessanta l’Italia vantava numerose grandi imprese, che sono poi morte o si sono rimpicciolite. Forse, invece, dipende da fattori che stanno intorno alle imprese, questi sì parte integrante della storia nazionale: l’ordinamento giuridico e le condizioni che ne discendono (legalità, concorrenza, efficienza della pubblica amministrazione); il sistema d’istruzione. E forse dipende anche dalla struttura finanziaria del paese, con la forte dominanza delle banche. Sono, come dicevamo poc’anzi, conferme di situazioni già osservate e dibattute in passato, anche se noi le scioriniamo tutte insieme in modo che formino un quadro organico. Ma la novità relativa è che, nella lunga recessione nel frattempo intervenuta, un pezzo della nostra economia ha incredibilmente retto sotto il fuoco incrociato e talvolta amico, internalizzando
Epilogo
221
le diseconomie di un paese senza: senza fattori abilitanti di sistema. È la nostra eccellenza, ma un’eccellenza parziale e confinata, che non fa “standard”. Le imprese vincenti sono diventate tali nonostante il paese, le perdenti a causa di esso. La novità è relativa perché parliamo di fenomeni già emersi prima della crisi, proprio per l’agire selettivo dai “fattori abilitanti”. Ma la lunga recessione li ha fatti esplodere, per l’operare di una classica selezione darwiniana: le imprese meno produttive sono uscite dal mercato, sono sopravvissuti i migliori. Veniamo allora al ruolo delle politiche pubbliche. È un ruolo davvero importante, val la pena di ripeterlo. Un’importanza che va al di là della superficiale convinzione che pure c’è nell’opinione pubblica. Il fatto è che a impedire alle imprese, o almeno a quelle che già potrebbero, di fare un salto dimensionale, quindi di diventare meno familiste, più produttive, più innovative, sono fattori in larga parte sotto il controllo delle autorità pubbliche. Fattori abilitanti di sistema, ma anche incentivi/disincentivi che influiscono sul comportamento dei singoli imprenditori. In altri termini ci vuole quella che J.F. Kennedy in un suo discorso di oltre mezzo secolo fa definì “l’onda che solleva tutte le barche”6: trasposto nell’Italia di oggi, una politica organica che migliori il clima generale entro cui gli imprenditori e le imprese vivono. La prima e più importante riforma riguarda l’ordinamento giuridico. Essa non concerne solo le norme che regolano il funzionamento della macchina giudiziaria o anche tutta la pubblica amministrazione, ma proprio l’intero impianto giuridico. Che va reso più coerente con il funzionamento di un’economia moderna, delle imprese, dell’efficienza. È una riforma che non costa nulla alla finanza pubblica, anzi probabilmente consente sostanziosi risparmi di spesa pubblica. Eppure è una
222
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
riforma difficilissima in questa fase storica di riflusso oscurantista anti-mercato e anti-efficienza. Vi si oppongono non solo la maggioranza degli addetti ai lavori – avvocati, magistrati, operatori del diritto di ogni specie – ma vasti strati di popolazione, ciascuno badando alla protezione che a volte un tale ordinamento gli offre, ma senza affatto tenere in considerazione i costi che esso impone a tutti. Una riforma possibile solo dall’interno della professione giuridica, a opera di persone illuminate, che certo non mancano. Qualche calcinaccio del vecchio intonaco è caduto in questi ultimi anni, con le faticose e pur incomplete riforme della giustizia e della pubblica amministrazione; questo dà speranza per il futuro. Ne discenderebbe ogni progresso possibile sui fronti della legalità, della concorrenza fra i produttori e i distributori privati sul mercato, della efficienza delle amministrazioni pubbliche. Il sistema che produce le norme e la loro applicazione è l’istituzione-chiave di un paese moderno e avanzato. Ma viene costruito nel corso di secoli, sicché farlo evolvere in accordo coi tempi è difficile, il peso delle decisioni collettive del passato è gravoso, vi si frappongono inerzie culturali e ideologiche, resistenze psicologiche, la difesa di interessi soggettivi. Si tende a restare sul sentiero conosciuto (path-dependence), almeno finché l’occorrere, o il timore, di una catastrofe non faccia coagulare le energie della società e le convogli verso la scoperta di un sentiero nuovo. La seconda riforma che invochiamo riguarda il sistema di istruzione. L’Italia si caratterizza per un livello d’investimento pubblico in istruzione tra i più bassi tra i paesi Ocse. Anche da tale sottoinvestimento dipendono i macrofenomeni che vengono normalmente discussi quando si parla dell’università italiana: il basso numero di laureati e l’alto tasso di abbandono. Questi determinano una parziale inadeguatezza dell’offerta di lavoro, in termini di capitale umano
Epilogo
223
idoneo per un’economia moderna e avanzata. D’altro canto, le imprese che dovrebbero domandarlo non sono, in realtà, quasi mai attrezzate a riconoscerne i diversi gradi di qualità, a richiederlo, ad assegnargli il giusto compenso. Occorre dunque investire in istruzione, adottando una visione lunga, ma occorre anche intervenire su quelle caratteristiche di impresa che ostacolano lo sviluppo di una domanda di personale più istruito. E qui veniamo a quell’insieme di politiche che un tempo si sarebbero dette “industriali”, larga parte delle quali di carattere orizzontale. Sono politiche quasi tutte costose per l’erario, quindi esigono uno spostamento di risorse pubbliche da altri usi meno produttivi, il che non è politicamente banale. Sono misure volte a favorire la Ricerca & Sviluppo nelle imprese, ad attenuare i costi di transazione internazionale, a incentivare gli investimenti privati e l’attrazione di investimenti esteri, ad agevolare l’apertura al controllo esterno delle imprese familiari, a favorire lo spostamento del lavoro, ma soprattutto del capitale, verso impieghi più efficienti; di quest’ultimo capitolo fanno parte misure per migliorare la governance nelle banche e per favorire la presenza nella struttura finanziaria di intermediari diversi dalle banche, più adatti a far crescere le imprese. Alcune di queste misure sono state già parzialmente prese, si tratta innanzitutto di sospingerne l’attuazione. Gli errori, quando non i fallimenti, di attuazione svuotano di efficacia anche il migliore degli interventi pubblici. Perché essi abbiano un impatto adeguato sul sistema economico occorre ciò che da tempo si sa e si auspica e, purtroppo, non si pratica: obiettivi ben definiti (soggetti dunque alla possibilità di valutazione ex post della propria efficacia); un assetto istituzionale che garantisca un congruo stanziamento di risorse; un orizzonte temporale di medio periodo; regole semplici e certe per le imprese; pochi e stabili interlocutori istituzionali.
224
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
Poi bisogna proseguire lungo la direzione intrapresa. L’effetto congiunto di politiche nazionali ed europee (i fondi strutturali europei di Horizon 2020, il programma Cosme di sostegno alle piccole e medie imprese, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, il Piano Junker) può davvero contribuire ad alzare lo standard produttivo della nostra economia. Naturalmente, per ottenere risultati concreti occorre una maggioranza politica stabile, un governo nella pienezza dei suoi poteri, un programma di governo chiaro e organico. Il referendum popolare del 4 dicembre 2016, che ha rigettato la riforma costituzionale a suo tempo approvata dal Parlamento, ha reso ancora più problematico raggiungere pienamente quelle condizioni, almeno per quanto ci è dato capire in questo scorcio del 2016. In futuro, qualunque cosa succeda, si confermerà la centralità dell’evoluzione tecnologica. Ne è esempio l’annunciata quarta rivoluzione industriale, detta Industria 4.0. Anche in Italia una strada è stata tracciata: nell’autunno del 2016 è stato presentato dal governo un piano nazionale per la digitalizzazione del sistema produttivo italiano attraverso interventi infrastrutturali e incentivi agli investimenti, proprio per non mancare l’occasione della quarta rivoluzione industriale avendo perso, nella seconda metà degli anni Novanta, le opportunità della terza, quella delle tecnologie della informazione e della comunicazione. Ciascuna nazione ha un volto preciso nell’immaginario collettivo del mondo. Un volto modellato nei secoli, a volte deformato dagli stereotipi, ma fondamentalmente corrispondente a ciò che quella nazione ha saputo fare fino a quel momento. Il volto dell’Italia è bello, sorridente, ma un po’ fané, un po’ flaccido. È sempre stato così nei secoli, almeno dal Ri-
Epilogo
225
nascimento. Non è l’età a renderlo poco tonico, non c’entra l’invecchiamento demografico che è fenomeno al massimo dell’ultimo mezzo secolo. È il buon vivere, almeno quello che ci viene attribuito. Il clima dolce, la buona cucina, l’abitudine alla bellezza. Non sono qualità che aiutano un volto a mantenersi fresco e volitivo, ma lo rendono certo seduttivo. Anche le cose che l’Italia sa fare o sa vendere sono così, nella convinzione profonda del mondo che le compra: belle, affascinanti, poetiche, non sempre affidabili, a volte un po’ fané. Auto, moda, cibo, film (negli anni Sessanta), luoghi. Se un emiro mediorientale vuole un’auto di lusso confortevole e affidabile compra una macchina tedesca, se vuole togliersi uno sfizio compra una Ferrari. Se un’infermiera slovacca vuole migliorare il suo tenore di vita compra un elettrodomestico tedesco, se sogna un momento di spensieratezza pensa a una vacanza in Italia. Come si confronta questo riflesso condizionato di psicologia collettiva con la realtà dei fatti? I soggetti privati italiani che producono e vendono sul mercato beni e servizi, cioè le imprese, da quelle micro fatte di una persona sola a quelle macro con centinaia di migliaia di dipendenti, che cosa sanno fare? Soddisfano i desideri degli acquirenti, innanzitutto dei loro connazionali, poi dei clienti di tutto il mondo? A questi interrogativi ha cercato di rispondere questo libro, con analisi, fatti, dati. Metodi da economisti, quindi, i più rigorosi possibili, ma usati alla fine per rispondere a una domanda che trascende l’economia: perché il nostro paese si è come ripiegato su se stesso da un quarto di secolo e che prospettive ci sono di rimetterlo in carreggiata? La risposta che abbiamo dato è che l’Italia sa ancora “inventare cose nuove che piacciano [...] e che si vendano fuori dei confini”, per dirla con Cipolla7, ma questa capacità si è ristretta a un pugno di imprese di avanguardia. Si è aperto un
226
CHE COSA SA FARE L’ITALIA. La nostra economia dopo la grande crisi
“grande golfo” fra imprese vincenti e perdenti. Manca uno standard diffuso di buona qualità, innovatività, appetibilità dei beni e dei servizi prodotti, come quello che viene attribuito, ad esempio, alla Germania. Per crearlo, o ricrearlo, bisogna che un numero non piccolo di imprese venga messo nelle migliori condizioni ambientali possibili per crescere e trasformarsi. Questa è l’agenda necessitata di qualunque governo si ponga il problema di scongiurare il declino storico della nazione. Far nascere nuovi imprenditori, convincere quelli che ci sono a far crescere le loro imprese, separandole dai destini della famiglia, premiare il coraggio e l’inventiva, disincentivare le rendite di posizione, questo è l’impegno prioritario della politica economica oggi nel nostro paese. Sgonfiare l’ipertrofia fiscale e normativa, raddrizzare i labirinti procedurali di cui è disseminato il cammino di chi intraprende, ci farebbe scalare tante posizioni nelle classifiche internazionali del “fare impresa”; avvierebbe un circuito di attese favorevoli che poi si autorealizzano; libererebbe le energie di cui il nostro paese resta ricco. NOTE 1 L. Spaventa, Commento in T. Boeri, R. Faini, A. Ichino, G. Pisauro, C. Scarpa (a cura di), Oltre il declino, il Mulino, Bologna 2005, p. 72. Fra i primi a parlare del possibile declino dell’economia italiana ci fu Ignazio Visco, con È veramente in declino l’economia italiana?, in «Aspenia», 21, giugno 2003. 2 S. Rossi, La nuova economia. I fatti dietro il mito, il Mulino, Bologna 2003. 3 Considerazioni finali del Governatore sul 2005, Banca d’Italia, Roma 2006; si veda anche M. Franzini, A. Giunta, Ripensare il declino, in «Meridiana», 54, 2005, pp. 9-29; G. Berta, La Fiat dopo la Fiat. Storia di una crisi, 2004-05, Mondadori, Milano 2006. 4 L. Summers, The age of secular stagnation, in «Foreign Affairs», February 15, 2016, https://www.foreignaffairs.com. 5 T. Mayer, G.I.P. Ottaviano, I pochi eletti: nuovi fatti sull’internazionalizzazione delle imprese europee, in «L’Industria», 2, 2008, pp. 211-244. 6 J.F. Kennedy, Remarks in Heber Springs, Arkansas, at the Dedication of Grers Ferry Dam, 3 ottobre 1963. 7 C.M. Cipolla, Storia facile dell’economia italiana dal Medioevo a oggi, Mondadori, Milano 2007, p. xv.
INDICE DEI NOMI
Accetturo, Antonio, 91. Acemoglu, Daron, 166, 178, 205. Adelman, Morris A., 48. Adenauer, Konrad, 218. Agostino, Mariarosaria, 91, 134. Aimone Gigio, Luciana, 135. Albareto, Giorgio, 205. Albertazzi, Ugo, 205. Alchian, Armen, 49. Amador, João, 91. Amatori, Franco, 48. Andersson, Martin, 134. Andrews, Dan, 134. Anzani, Giovanni, 145. Arrighetti, Alessandro, 49. Arrow, Kenneth, 135. Atanassov, Julian, 205. Augier, Patricia, 134. Autor, David H., 166. Baffigi, Alberto, 47. Bagnasco, Arnaldo, 42. Balassa, Béla, 69, 90. Baldwin, John, 91. Baldwin, Richard, 82. Barba Navaretti, Giorgio, 91. Barbiero, Francesca, 91. Barca, Fabrizio, 48. Barone, Guglielmo, 166. Bas, Maria, 134. Becattini, Giacomo, 42, 48-49. Bellandi, Marco, 49. Berlusconi, Silvio, 190. Bernard, Andrew B., 90. Berta, Giuseppe, 226.
Bertola, Giuseppe, 47. Blalock, Garrick, 134. Blanga-Gubbay, Michael, 91. Boeri, Tito, 226. Borghi, Giovanni, 33. Bourlès, Renaud, 166. Brancati, Raffaele, 134. Bresnahan, Timothy F., 133. Broadberry, Stephen N., 48-49, 133. Bronzini, Raffaello, 91, 135. Brown, James, 205. Brusco, Sebastiano, 42. Brynjolfsson, Erik, 133-134. Bugamelli, Matteo, 90, 133-135. Cadot, Olivier, 134. Calligaris, Sara, 92. Caloffi, Annalisa, 135. Campos, Nauro F., 15. Cannari, Luigi, 91, 133-135. Cappariello, Rita, 91. Cappellin, Riccardo, 134. Castellani, Davide, 90, 134. Cette, Gilbert, 166. Chan, Soo, 146. Chandler, Alfred D., 39, 49. Chaplin, Charlie, 50-51. Churchill, Winston, 218. Ciampi, Carlo Azeglio, 187. Ciccarelli, Carlo, 48. Cingano, Federico, 166. Ciocca, Pierluigi, 48. Cipolla, Carlo Maria, 87-88, 92, 225-226. Clerides, Sofronis, 90. Coase, Ronald, 35, 37, 39.
228
Indice dei nomi
Colli, Andrea, 48. Colorni, Eugenio, 218. Coricelli, Fabrizio, 15. Costa, Stefano, 90. Costanza, Mariarita, 141, 143. Cozza, Claudio, 134. Crawford, Robert, 49. Criscuolo, Chiara, 134. Daniele, Vittorio, 48. De Backer, Koen, 91. De Benedictis, Luca, 90. De Gasperi, Alcide, 218. Del Gatto, Massimo, 92. Dell’Agostino, Laura, 91. Del Monte, Alfredo, 48, 166. De Nardis, Sergio, 49, 90. Depalo, Domenico, 167. Di Nino, Virginia, 48. Dodge, fratelli, 34. Dovis, Marion, 134. Draghi, Mario, 188, 190, 202. Dustmann, Christian, 134. Eichengreen, Barry, 48. Einaudi, Luigi, 132, 135. Escher, Maurits Cornelis, 142. Fabiani, Silvia, 133. Faini, Riccardo, 226. Fazio, Antonio, 187-188. Fazzari, Steven, 205. Federico, Stefano, 91. Feldman, Maryann P., 135. Felettigh, Alberto, 91. Fenoaltea, Stefano, 47. Finaldi Russo, Paolo, 205. Fiorino, Nadia, 166. Fizenberger, Bernd, 134. Ford, Henry, 34, 37-38, 40, 51. Franzini, Maurizio, 226. Frigero, Piercarlo, 48. Fuà, Giorgio, 42. Gal, Peter, 134. Galli, Emma, 166. Garbo, Greta, 53. Gennari, Elena, 135. Giannola, Adriano, 48. Giolitti, Giovanni, 17. Giordano, Claire, 48-49, 133. Giorgiantonio, Cristina, 166.
Giovannetti, Giorgia, 91. Giunta, Anna, 48, 91, 133-134, 226. Glyn, Andrew, 48. Gomellini, Matteo, 47. Gordon, Robert, 134. Hall, Bronwyn H., 134. Hassan, Fadi, 92, 133, 135. Helpman, Elhanan, 90. Herrera, Ana Maria, 205. Hewitt-Dundas, Nola, 135. Hirschman, Albert O., 33, 48. Hitt, Lorin M., 133. Hughes, Alan, 48. Iachini, Eleonora, 135. Iapadre, Lelio, 90. Ichino, Andrea, 226. Infante, Luigi, 90. Iuzzolino, Giovanni, 48. Jensen, J. Bradford, 90. Johansson, Sara, 134. Jones, Daniel T., 49. Kelley, Maryellen R., 135. Kennedy, John Fitzgerald, 221, 225. Kindleberger, Charles P., 48. Klein, Benjamin, 49. Koopman, Robert, 91. Lach, Saul, 90. Laeven, Luc, 205. Langiu, Daniele, 90. Lanza, Alessandra, 90. Lavenuta, Nicola, 141. Lewis, W. Arthur, 48. Liberati, Danilo, 135. Liberati, Paolo, 133. Libeskind, Daniel, 146. Lileeva, Alla, 91. Linarello, Andrea, 92, 133, 135. Lipietz, Alain, 48. Loof, Hans, 134. Lopez, Jimmy, 166. Lotti, Francesca, 133-135. Love, James H., 135. Lozzi, Maurizio, 135. Luchetti, Francesca, 90. Madia, Marianna, 157. Magri, Silvia, 133-135, 205.
Mairesse, Jacques, 134, 166. Malanima, Paolo, 48. Marciante, Gianni, 90. Marglin, Stephen A., 48. Mariani, Marco, 135. Marinucci, Marco, 135. Marrelli, Massimo, 166. Marshall, Alfred, 41-42, 49. Marvasi, Enrico, 91. Massaud, Jean-Marie, 146. Mayer, Thierry, 90, 226. Mazzeo, Elena, 90. McAfee, Andrew, 134. McLaren, John, 45, 49. Melitz, Marc J., 90. Merloni, Aristide, 33. Michelacci, Claudio, 133. Micucci, Giacinto, 135. Minetti, Raoul, 205. Miroudot, Sébastien, 91. Mocetti, Sauro, 166. Mokyr, Joel, 161, 166. Monducci, Roberto, 74, 90. Montanaro, Pasqualino, 135. Monti, Mario, 190-191. Moretti, Luigi, 15. Nanda, Vikram, 205. Narciso, Gaia, 166. Nardozzi, Giangiacomo, 49. Nascia, Leopoldo, 135. Nelson, Richard R., 135. Nenci, Silvia, 91. Nicola I Romanov, zar di Russia, 104. Nicoletti, Giuseppe, 166. Nifo, Annamaria, 91. Notarpietro, Alessandro, 205. Nugent, Jeffrey B., 91. Nuvolari, Alessandro, 48. Occhilupo, Roberta, 166. Oddo, Giacomo, 91. Ó Gráda, Cormac, 47. Olivetti, Adriano, 33. Ongena, Steven, 205. Onida, Fabrizio, 48. Orlando, Tommaso, 166. Ottaviano, Gianmarco I.P., 90, 92, 133, 135, 226. Padoa-Schioppa, Tommaso, 187. Pagano, Patrizio, 133.
Indice dei nomi
229
Palumbo, Giuliana, 166. Pelizzola, Giorgio, 48. Pellegrini, Guido, 48. Petersen, Bruce, 205. Petrarca, Ilaria, 166. Petrella, Andrea, 92, 133, 135. Phelps, Edmund, 166. Pianta, Mario, 135. Pinto, Eugenio, 134. Piore, Michael J., 49. Pisauro, Giuseppe, 226. Quesnay, François, 59. Quintieri, Beniamino, 90. Rassu, Roberto, 135. Razzolini, Tiziano, 91. Ricardo, David, 45. Rizzica, Lucia, 166. Robinson, Jim, 178, 205. Romano, Livio, 134. Roos, Daniel, 49. Roper, Stephen, 135. Rossi, Ernesto, 218. Rossi, Paola, 135. Rossi, Salvatore, 2, 49, 91, 133, 166, 226. Rullani, Enzo, 134. Sabel, Charles F., 49. Sanfilippo, Marco, 91. Sbracia, Massimo, 48. Scalera, Domenico, 91, 134. Scarpa, Carlo, 226. Schivardi, Fabiano, 92, 133, 167. Schonberg, Uta, 134. Schor, Juliet B., 48. Schröder, Gerhard, 216. Schumann, Robert, 218. Serti, Francesco, 90-91, 134. Seru, Amit, 205. Sestito, Paolo, 47. Sforzi, Fabio, 42, 49. Shih, Stan, 82. Signorini, L. Federico, 49. Singh, Ajit, 48. Siviero, Stefano, 205. Smith, Adam, 38. Smith, David C., 205. Spaventa, Luigi, 207, 225. Spinelli, Alberto, 145. Spinelli, Aldo, 145. Spinelli, Altiero, 218.
230
Indice dei nomi
Spitz-Oener, Alexandra, 134. Staderini, Alessandra, 91. Stefani, Maria Lucia, 135. Stehrer, Robert, 91. Steindl, Joseph, 48. Sterlacchini, Alessandro, 134-135. Stigler, George, 49. Strauss-Kahn, Vanessa, 134. Summers, Lawrence, 120-121, 226. Taylor, Frederick, 51. Tevlin, Stacey, 134. Tomasi, Chiara, 90-91, 134. Toniolo, Gianni, 47-49, 133. Torrini, Roberto, 135, 167. Traù, Fabrizio, 49, 90. Travaglini, Giuseppe, 133. Trefler, Daniel, 91. Trento, Sandro, 48, 133. Trigilia, Carlo, 48. Trivieri, Francesco, 91, 133-134. Tybout, James, 90. Vacca, Valerio, 135. Valencia, Fabián, 205. Valletta, Vittorio, 33. Vannoni, Davide, 91. Veloso, Francisco M., 134.
Venables, Anthony J., 91. Venturini, Francesco, 134. Vergara Caffarelli, Filippo, 92. Veronese, Giovanni, 92. Vespa, Bruno, 143. Veugelers, Reinhilde, 91. Viesti, Gianfranco, 48, 135. Vinci, Daniela, 137. Vinci, Michele, 138-139. Visco, Ignazio, 133, 164, 166-167, 188, 190, 226. Wang, Zhi, 91. Wei, Shang-Jin, 91. Williamson, Oliver E., 49. Womack, James P., 49. Yan, Beiling, 91. Yeaple, Stephen, 90. Zalone, Checco, 60. Zanfei, Antonello, 134. Zanussi, Lino, 33. Zhu, Kunfu, 91. Zollino, Francesco, 48-49, 133. Zucchetti, famiglia, 143. Zurlo, Davide, 90.







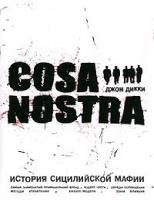


![Che cosa sa fare l'Italia. La nostra economia dopo la grande crisi [4 ed.]
8858126777, 9788858126776](https://dokumen.pub/img/200x200/che-cosa-sa-fare-litalia-la-nostra-economia-dopo-la-grande-crisi-4nbsped-8858126777-9788858126776.jpg)